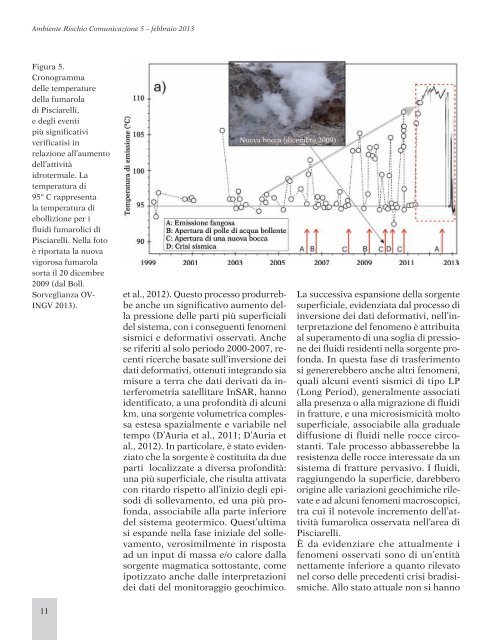scarica l'ultimo numero "Che succede ai Campi Flegrei?" - Amra
scarica l'ultimo numero "Che succede ai Campi Flegrei?" - Amra
scarica l'ultimo numero "Che succede ai Campi Flegrei?" - Amra
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Ambiente Rischio Comunicazione 5 – febbr<strong>ai</strong>o 2013<br />
Figura 5.<br />
Cronogramma<br />
delle temperature<br />
della fumarola<br />
di Pisciarelli,<br />
e degli eventi<br />
più significativi<br />
verificatisi in<br />
relazione all’aumento<br />
dell’attività<br />
idrotermale. La<br />
temperatura di<br />
95° C rappresenta<br />
la temperatura di<br />
ebollizione per i<br />
fluidi fumarolici di<br />
Pisciarelli. Nella foto<br />
è riportata la nuova<br />
vigorosa fumarola<br />
sorta il 20 dicembre<br />
2009 (dal Boll.<br />
Sorveglianza OV-<br />
INGV 2013).<br />
11<br />
et al., 2012). Questo processo produrrebbe<br />
anche un significativo aumento della<br />
pressione delle parti più superficiali<br />
del sistema, con i conseguenti fenomeni<br />
sismici e deformativi osservati. Anche<br />
se riferiti al solo periodo 2000-2007, recenti<br />
ricerche basate sull’inversione dei<br />
dati deformativi, ottenuti integrando sia<br />
misure a terra che dati derivati da interferometria<br />
satellitare InSAR, hanno<br />
identificato, a una profondità di alcuni<br />
km, una sorgente volumetrica complessa<br />
estesa spazialmente e variabile nel<br />
tempo (D’Auria et al., 2011; D’Auria et<br />
al., 2012). In particolare, è stato evidenziato<br />
che la sorgente è costituita da due<br />
parti localizzate a diversa profondità:<br />
una più superficiale, che risulta attivata<br />
con ritardo rispetto all’inizio degli episodi<br />
di sollevamento, ed una più profonda,<br />
associabile alla parte inferiore<br />
del sistema geotermico. Quest’ultima<br />
si espande nella fase iniziale del sollevamento,<br />
verosimilmente in risposta<br />
ad un input di massa e/o calore dalla<br />
sorgente magmatica sottostante, come<br />
ipotizzato anche dalle interpretazioni<br />
dei dati del monitoraggio geochimico.<br />
La successiva espansione della sorgente<br />
superficiale, evidenziata dal processo di<br />
inversione dei dati deformativi, nell’interpretazione<br />
del fenomeno è attribuita<br />
al superamento di una soglia di pressione<br />
dei fluidi residenti nella sorgente profonda.<br />
In questa fase di trasferimento<br />
si genererebbero anche altri fenomeni,<br />
quali alcuni eventi sismici di tipo LP<br />
(Long Period), generalmente associati<br />
alla presenza o alla migrazione di fluidi<br />
in fratture, e una microsismicità molto<br />
superficiale, associabile alla graduale<br />
diffusione di fluidi nelle rocce circostanti.<br />
Tale processo abbasserebbe la<br />
resistenza delle rocce interessate da un<br />
sistema di fratture pervasivo. I fluidi,<br />
raggiungendo la superficie, darebbero<br />
origine alle variazioni geochimiche rilevate<br />
e ad alcuni fenomeni macroscopici,<br />
tra cui il notevole incremento dell’attività<br />
fumarolica osservata nell’area di<br />
Pisciarelli.<br />
È da evidenziare che attualmente i<br />
fenomeni osservati sono di un’entità<br />
nettamente inferiore a quanto rilevato<br />
nel corso delle precedenti crisi bradisismiche.<br />
Allo stato attuale non si hanno