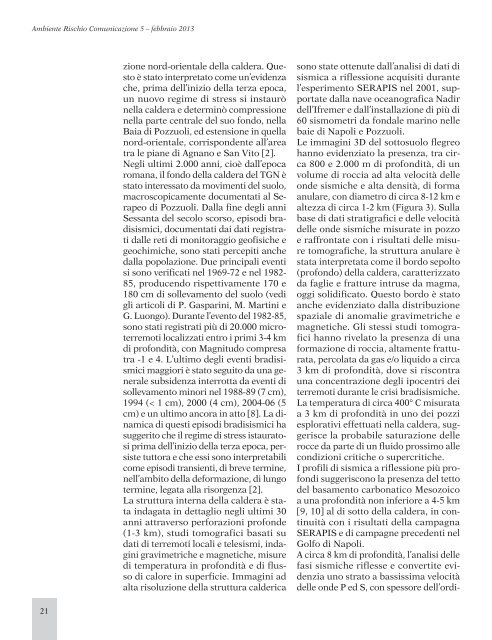scarica l'ultimo numero "Che succede ai Campi Flegrei?" - Amra
scarica l'ultimo numero "Che succede ai Campi Flegrei?" - Amra
scarica l'ultimo numero "Che succede ai Campi Flegrei?" - Amra
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Ambiente Rischio Comunicazione 5 – febbr<strong>ai</strong>o 2013<br />
21<br />
zione nord-orientale della caldera. Questo<br />
è stato interpretato come un’evidenza<br />
che, prima dell’inizio della terza epoca,<br />
un nuovo regime di stress si instaurò<br />
nella caldera e determinò compressione<br />
nella parte centrale del suo fondo, nella<br />
B<strong>ai</strong>a di Pozzuoli, ed estensione in quella<br />
nord-orientale, corrispondente all’area<br />
tra le piane di Agnano e San Vito [2].<br />
Negli ultimi 2.000 anni, cioè dall’epoca<br />
romana, il fondo della caldera del TGN è<br />
stato interessato da movimenti del suolo,<br />
macroscopicamente documentati al Serapeo<br />
di Pozzuoli. Dalla fine degli anni<br />
Sessanta del secolo scorso, episodi bradisismici,<br />
documentati d<strong>ai</strong> dati registrati<br />
dalle reti di monitoraggio geofisiche e<br />
geochimiche, sono stati percepiti anche<br />
dalla popolazione. Due principali eventi<br />
si sono verificati nel 1969-72 e nel 1982-<br />
85, producendo rispettivamente 170 e<br />
180 cm di sollevamento del suolo (vedi<br />
gli articoli di P. Gasparini, M. Martini e<br />
G. Luongo). Durante l’evento del 1982-85,<br />
sono stati registrati più di 20.000 microterremoti<br />
localizzati entro i primi 3-4 km<br />
di profondità, con Magnitudo compresa<br />
tra -1 e 4. L’ultimo degli eventi bradisismici<br />
maggiori è stato seguito da una generale<br />
subsidenza interrotta da eventi di<br />
sollevamento minori nel 1988-89 (7 cm),<br />
1994 (< 1 cm), 2000 (4 cm), 2004-06 (5<br />
cm) e un ultimo ancora in atto [8]. La dinamica<br />
di questi episodi bradisismici ha<br />
suggerito che il regime di stress istauratosi<br />
prima dell’inizio della terza epoca, persiste<br />
tuttora e che essi sono interpretabili<br />
come episodi transienti, di breve termine,<br />
nell’ambito della deformazione, di lungo<br />
termine, legata alla risorgenza [2].<br />
La struttura interna della caldera è stata<br />
indagata in dettaglio negli ultimi 30<br />
anni attraverso perforazioni profonde<br />
(1-3 km), studi tomografici basati su<br />
dati di terremoti locali e telesismi, indagini<br />
gravimetriche e magnetiche, misure<br />
di temperatura in profondità e di flusso<br />
di calore in superficie. Immagini ad<br />
alta risoluzione della struttura calderica<br />
sono state ottenute dall’analisi di dati di<br />
sismica a riflessione acquisiti durante<br />
l’esperimento SERAPIS nel 2001, supportate<br />
dalla nave oceanografica Nadir<br />
dell’Ifremer e dall’installazione di più di<br />
60 sismometri da fondale marino nelle<br />
b<strong>ai</strong>e di Napoli e Pozzuoli.<br />
Le immagini 3D del sottosuolo flegreo<br />
hanno evidenziato la presenza, tra circa<br />
800 e 2.000 m di profondità, di un<br />
volume di roccia ad alta velocità delle<br />
onde sismiche e alta densità, di forma<br />
anulare, con diametro di circa 8-12 km e<br />
altezza di circa 1-2 km (Figura 3). Sulla<br />
base di dati stratigrafici e delle velocità<br />
delle onde sismiche misurate in pozzo<br />
e raffrontate con i risultati delle misure<br />
tomografiche, la struttura anulare è<br />
stata interpretata come il bordo sepolto<br />
(profondo) della caldera, caratterizzato<br />
da faglie e fratture intruse da magma,<br />
oggi solidificato. Questo bordo è stato<br />
anche evidenziato dalla distribuzione<br />
spaziale di anomalie gravimetriche e<br />
magnetiche. Gli stessi studi tomografici<br />
hanno rivelato la presenza di una<br />
formazione di roccia, altamente fratturata,<br />
percolata da gas e/o liquido a circa<br />
3 km di profondità, dove si riscontra<br />
una concentrazione degli ipocentri dei<br />
terremoti durante le crisi bradisismiche.<br />
La temperatura di circa 400° C misurata<br />
a 3 km di profondità in uno dei pozzi<br />
esplorativi effettuati nella caldera, suggerisce<br />
la probabile saturazione delle<br />
rocce da parte di un fluido prossimo alle<br />
condizioni critiche o supercritiche.<br />
I profili di sismica a riflessione più profondi<br />
suggeriscono la presenza del tetto<br />
del basamento carbonatico Mesozoico<br />
a una profondità non inferiore a 4-5 km<br />
[9, 10] al di sotto della caldera, in continuità<br />
con i risultati della campagna<br />
SERAPIS e di campagne precedenti nel<br />
Golfo di Napoli.<br />
A circa 8 km di profondità, l’analisi delle<br />
fasi sismiche riflesse e convertite evidenzia<br />
uno strato a bassissima velocità<br />
delle onde P ed S, con spessore dell’ordi-