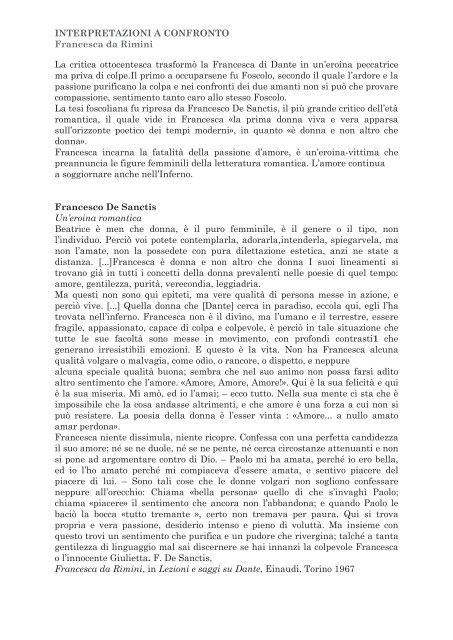INTERPRETAZIONI A CONFRONTO Francesca da Rimini La critica ...
INTERPRETAZIONI A CONFRONTO Francesca da Rimini La critica ...
INTERPRETAZIONI A CONFRONTO Francesca da Rimini La critica ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>INTERPRETAZIONI</strong> A <strong>CONFRONTO</strong><br />
<strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong><br />
<strong>La</strong> <strong>critica</strong> ottocentesca trasformò la <strong>Francesca</strong> di Dante in un’eroina peccatrice<br />
ma priva di colpe.Il primo a occuparsene fu Foscolo, secondo il quale l’ardore e la<br />
passione purificano la colpa e nei confronti dei due amanti non si può che provare<br />
compassione, sentimento tanto caro allo stesso Foscolo.<br />
<strong>La</strong> tesi foscoliana fu ripresa <strong>da</strong> Francesco De Sanctis, il più grande critico dell’età<br />
romantica, il quale vide in <strong>Francesca</strong> «la prima donna viva e vera apparsa<br />
sull’orizzonte poetico dei tempi moderni», in quanto «è donna e non altro che<br />
donna».<br />
<strong>Francesca</strong> incarna la fatalità della passione d’amore, è un’eroina-vittima che<br />
preannuncia le figure femminili della letteratura romantica. L’amore continua<br />
a soggiornare anche nell’Inferno.<br />
Francesco De Sanctis<br />
Un’eroina romantica<br />
Beatrice è men che donna, è il puro femminile, è il genere o il tipo, non<br />
l’individuo. Perciò voi potete contemplarla, adorarla,intenderla, spiegarvela, ma<br />
non l’amate, non la possedete con pura dilettazione estetica, anzi ne state a<br />
distanza. [...]<strong>Francesca</strong> è donna e non altro che donna I suoi lineamenti si<br />
trovano già in tutti i concetti della donna prevalenti nelle poesie di quel tempo:<br />
amore, gentilezza, purità, verecondia, leggiadria.<br />
Ma questi non sono qui epiteti, ma vere qualità di persona messe in azione, e<br />
perciò vive. [...] Quella donna che [Dante] cerca in paradiso, eccola qui, egli l’ha<br />
trovata nell’inferno. <strong>Francesca</strong> non è il divino, ma l’umano e il terrestre, essere<br />
fragile, appassionato, capace di colpa e colpevole, è perciò in tale situazione che<br />
tutte le sue facoltà sono messe in movimento, con profondi contrasti1 che<br />
generano irresistibili emozioni. E questo è la vita. Non ha <strong>Francesca</strong> alcuna<br />
qualità volgare o malvagia, come odio, o rancore, o dispetto, e neppure<br />
alcuna speciale qualità buona; sembra che nel suo animo non possa farsi adito<br />
altro sentimento che l’amore. «Amore, Amore, Amore!». Qui è la sua felicità e qui<br />
è la sua miseria. Mi amò, ed io l’amai; – ecco tutto. Nella sua mente ci sta che è<br />
impossibile che la cosa an<strong>da</strong>sse altrimenti, e che amore è una forza a cui non si<br />
può resistere. <strong>La</strong> poesia della donna è l’esser vinta : «Amore... a nullo amato<br />
amar perdona».<br />
<strong>Francesca</strong> niente dissimula, niente ricopre. Confessa con una perfetta candidezza<br />
il suo amore; né se ne duole, né se ne pente, né cerca circostanze attenuanti e non<br />
si pone ad argomentare contro di Dio. – Paolo mi ha amata, perché io ero bella,<br />
ed io l’ho amato perché mi compiaceva d’essere amata, e sentivo piacere del<br />
piacere di lui. – Sono tali cose che le donne volgari non sogliono confessare<br />
neppure all’orecchio: Chiama «bella persona» quello di che s’invaghì Paolo;<br />
chiama «piacere» il sentimento che ancora non l’abbandona; e quando Paolo le<br />
baciò la bocca «tutto tremante », certo non tremava per paura. Qui si trova<br />
propria e vera passione, desiderio intenso e pieno di voluttà. Ma insieme con<br />
questo trovi un sentimento che purifica e un pudore che rivergina; talché a tanta<br />
gentilezza di linguaggio mal sai discernere se hai innanzi la colpevole <strong>Francesca</strong><br />
o l’innocente Giulietta. F. De Sanctis,<br />
<strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong>, in Lezioni e saggi su Dante, Einaudi, Torino 1967
Edoardo Sanguineti <strong>Francesca</strong> come Bovary<br />
Rilievi piuttosto severi nei confronti della <strong>critica</strong> precedente sono quelli di<br />
Edoardo Sanguineti, critico di formazione marxista nonché scrittore e poeta<br />
aperto alla sperimentazione, il quale vede in <strong>Francesca</strong> una Ma<strong>da</strong>me Bovary del<br />
Duecento: la giovane donna sogna i baci di <strong>La</strong>ncillotto e deve accontentarsi di<br />
quelli più modesti del cognato, cercando poi di giustificarsi col ricorso alle teorie<br />
stilnovistiche. Nella creazione del personaggio <strong>da</strong>ntesco, il critico vede la<br />
sconfessione e il rifiuto della donna cavalcantiana passionale e insieme<br />
angelicata.<br />
R. Montano. Dante autore e Dante personaggio<br />
L'incontro drammatico con il male, con <strong>Francesca</strong>, che ne è l'incarnazione<br />
infernale, coinvolge non il poeta ma il viaggiatore Dante.<br />
L'autore della Commedia respinge senza esitazioni, con<strong>da</strong>nnandola, la<br />
letteratura peccaminosa dell'epopea erotica accarezzata in gioventù sotto<br />
l'influenza del Guinizzelli e del Cavalcanti, quel mondo leggen<strong>da</strong>rio e falsamente<br />
ideale di cui F. è vittima e nel quale ella continua a credere come a una vali<strong>da</strong><br />
scusante della colpa commessa.<br />
Di fronte a <strong>Francesca</strong>, creatura della gentilezza, vittima e insieme simbolo di<br />
un mondo d'amore e cortesia, d'illusione che è perdizione, proprio quando ella<br />
addita nella letteratura cavalleresca l'origine e la causa del suo tragico destino, il<br />
pellegrino sviene perché il poeta intende farlo rinascere a nuova vita. (R.<br />
Montano. Scritti <strong>da</strong>nteschi)<br />
E. Malato- Dottrina e poesia nel canto di <strong>Francesca</strong><br />
Siede la terra dove nata fui<br />
su la marina dove ’l Po discende<br />
per aver pace co’ seguaci sui.<br />
Amor, ch’al cor gentil ratto s’apprende,<br />
prese costui de la bella persona,<br />
che mi fu tolta, e ’l modo ancor m’offende.<br />
Amor, ch’a nullo amato amar perdona,<br />
mi prese del costui piacer sí forte,<br />
che, come vedi, ancor non m’abbandona.<br />
Amor condusse noi ad una morte.<br />
Caina attende chi a vita ci spense.<br />
Il discorso, costruito – non senza deliberato artificio – secondo i moduli<br />
della tradizione letteraria cortese, evita in questa prima parte<br />
ogni riferimento specifico, ogni indicazione di dettaglio ai fatti che la<br />
ebbero protagonista. Il quadro è disegnato con pochi tratti rapidi, essenziali,<br />
che a quei fatti soltanto alludono, offrendone al tempo stesso<br />
una motivazione e implicitamente – ma solo implicitamente – una<br />
giustificazione. Anche il nome è taciuto, e la presentazione di sé è fatta<br />
indirettamente, attraverso un nostalgico richiamo alla « terra » natale,<br />
la città della fanciullezza serena: è Ravenna, quietamente a<strong>da</strong>giata<br />
(« siede ») « su la marina » romagnola, dove « discende » il Po, concludendo<br />
il suo corso – « vario e laborioso come un’esistenza combattuta<br />
», nota Caretti –,43 « per aver pace co’ seguaci sui ». Un’immagine su<br />
cui vario è il giudizio dei critici (« lirismo e fiorettatura » la definí Momigliano),<br />
44 che offre quasi una nuova inespressa similitudine per contrasto con la<br />
condizione di quelle anime <strong>da</strong>nnate cui non arride e non arriderà mai pace: « in<br />
questo cerchio di eterna guerra – nota ancora Caretti – quella parola pace,<br />
ricuperata a breve distanza <strong>da</strong>l v. 92, veramente si colora di struggente
impianto ».45 Ma è l’esordio appropriato – tra il lirico e il solenne, venato di<br />
rassegnata mestizia – al discorso che <strong>Francesca</strong> si prepara a fare.46 Un discorso<br />
aulico e quasi grave, benché permeato <strong>da</strong> una profon<strong>da</strong> commozione, essenziale<br />
nella narrazione della sua vicen<strong>da</strong> di amore e di morte, esaurito in quelle tre<br />
terzine scandite <strong>da</strong>lla martellante ripresa anaforica (« Amor…Amor…Amor).<br />
Sono forse i versi piú famosi del canto e dell’intera Commedia, sui quali sono<br />
stati versati <strong>da</strong>i commentatori i proverbiali fiumi d’inchiostro. Riprendendo temi<br />
e motivi ampiamente accreditati nella tradizione cortese e stilnovistica,<br />
addirittura teorizzati e in certo modo istituzionalizzati in trattati, come il<br />
famigerato De amore di Andrea Cappellano – e variamente ribaditi anche <strong>da</strong><br />
Dante in alcune rime e altrove –, <strong>Francesca</strong> comincia con l’enunciare una “legge”:<br />
«Amor, ch’al cor gentil ratto s’apprende ». L’iniziativa, e perciò la responsabilità,<br />
non è dunque dell’uno o l’altro degli amanti, ma di Amore.<br />
E una secon<strong>da</strong>:<br />
« Amor, ch’a nullo amato amar perdona »: è quello stesso Amore,<br />
ancora, che non consente ad alcuno, che sia amato, di non corrispondere<br />
all’amante.<br />
L’esegesi ha ricostruito con molta precisione la fitta trama di riferimenti<br />
letterari e dottrinali che è sottesa a questi enunciati: <strong>da</strong>l guinizzelliano<br />
famosissimo incipit, Al cor gentil rempaira sempre amore, “coniugato”<br />
con il v. 11 della stessa canzone, iniziale della secon<strong>da</strong> stanza,<br />
« Foco d’amore in gentil cor s’aprende »,48 al <strong>da</strong>ntesco «Amore e ’l cor<br />
gentil sono una cosa » (Vita nuova, xx 3-5; Rime, xvi 1),<br />
Al di là dei rimandi letterari, importa rilevare che tutta una civiltà letteraria<br />
sta dietro il parlare sentenzioso di <strong>Francesca</strong>, nella sua elaborazione<br />
formale come nei suoi postulati dottrinali: la stessa che ella ha creduto di<br />
ravvisare nell’« affettuoso grido » di Dante, <strong>da</strong>l quale, in forza della comune<br />
radice culturale, si è sentita autorizzata a pronunciarsi in questo modo. È la<br />
civiltà cortese, quella che ha assunto come fon<strong>da</strong>mentale l’esperienza amorosa<br />
vissuta in modo totalizzante, quale è rappresentata, oltre che negli innumerevoli<br />
romanzi d’amore circolanti fra il XII e il XIII secolo, nel ricor<strong>da</strong>to De amore del<br />
Cappellano com’è dietro tutta la tradizione poetica italiana del Duecento, <strong>da</strong>i<br />
siciliani a Guinizzelli a Dante,<br />
In questa vasta e varia problematica, <strong>Francesca</strong> – « colta lettrice » o «<br />
intellettuale di provincia », secondo l’impietosa ma pertinente definizione di<br />
Contini – coglie quanto torna piú utile al suo caso.<br />
<strong>Francesca</strong> dichiara che proprio la sua bellezza, « la bella persona », insieme con il<br />
« cor gentil » di Paolo, fu il punto d’incontro e di sal<strong>da</strong>tura della loro passione.<br />
Paolo s’innamorò di lei; <strong>Francesca</strong>, per quella legge della reciprocità di amore che<br />
ha enunciato “ Amor ch’a nullo amato amar perdona »,<br />
fu presa « del costui piacer sí forte, / che, come vedi, ancor non m’abbandona “<br />
È il « diffamatissimo » ma mai rinnegato fon<strong>da</strong>mento di tutte le teoriche d’amore,<br />
ed è l’inconfessato modello, il codice di comportamento di <strong>Francesca</strong>: la quale non<br />
porta giustificazioni, se non implicite, alle sue azioni, preoccupandosi soltanto di<br />
metterne in evidenza l’ineccepibile coerenza con quanto a lei era stato insegnato.<br />
Ciò che tuttavia non la salva <strong>da</strong>lla <strong>da</strong>nnazione eterna, dimostrazione della<br />
erroneità di quei principî. (Dottrina e poesia nel canto di <strong>Francesca</strong> di<br />
Enrico Malato Lectura Dantis Modenese », 20 febbraio 1986)<br />
<strong>Francesca</strong> ha ceduto alle suggestioni di tale letteratura, abbandonandosi ad un<br />
amore peccaminoso, teorizzandone la giustezza in nome di una presunta etica<br />
cortese, ma Dante, che pure ha condiviso le dottrine neoplatoniche dell'amore<br />
come via di perfezione, idoleggiando la donna, e conferendo nobiltà alla passione
amorosa, ormai ne ha preso le distanze, e il distacco <strong>da</strong> quel mondo avviene<br />
attraverso un modo fisico, la perdita di sé, e cade, come corpo morto cade. <strong>La</strong><br />
pietà provata <strong>da</strong> Dante verso di loro non è dunque una generica compassione né<br />
la riabilitazione del loro amore clandestino ma è il turbamento angoscioso di uno<br />
scrittore che prende coscienza della pericolosità della poesia amorosa <strong>da</strong> lui<br />
prodotta in passato.