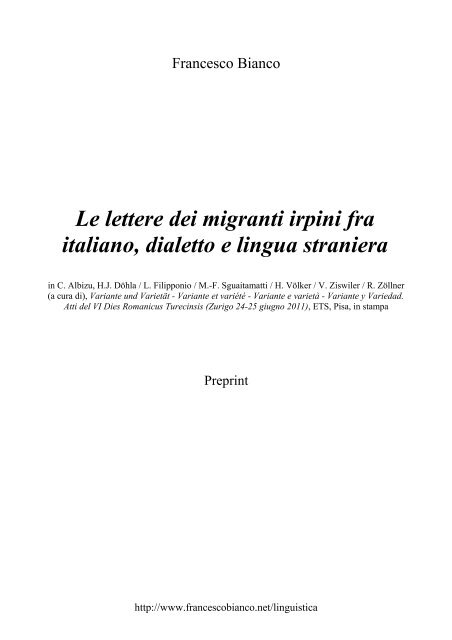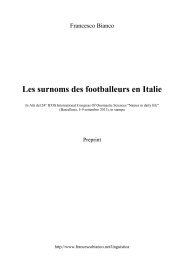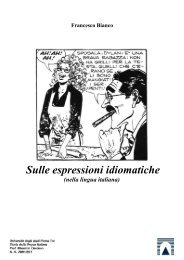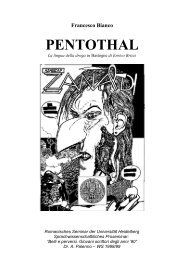Le lettere dei migranti irpini fra italiano, dialetto ... - Francesco Bianco
Le lettere dei migranti irpini fra italiano, dialetto ... - Francesco Bianco
Le lettere dei migranti irpini fra italiano, dialetto ... - Francesco Bianco
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Francesco</strong> <strong>Bianco</strong><br />
<strong>Le</strong> <strong>lettere</strong> <strong>dei</strong> <strong>migranti</strong> <strong>irpini</strong> <strong>fra</strong><br />
<strong>italiano</strong>, <strong>dialetto</strong> e lingua straniera<br />
in C. Albizu, H.J. Döhla / L. Filipponio / M.-F. Sguaitamatti / H. Völker / V. Ziswiler / R. Zöllner<br />
(a cura di), Variante und Varietät - Variante et variété - Variante e varietà - Variante y Variedad.<br />
Atti del VI Dies Romanicus Turecinsis (Zurigo 24-25 giugno 2011), ETS, Pisa, in stampa<br />
Preprint<br />
http://www.<strong>fra</strong>ncescobianco.net/linguistica
LE LETTERE DEI MIGRANTI IRPINI FRA ITALIANO,<br />
1. Introduzione<br />
DIALETTO E LINGUA STRANIERA<br />
Una ventina di anni fa, in occasione di un convegno sull’emigrazione svoltosi a Biella,<br />
Corrado Grassi (1991, 321) affermava che «la situazione migratoria costituisce da tempo, in<br />
quanto caso limite di contatti tra sistemi linguistici geograficamente e spesso<br />
genealogicamente diversi, un’area privilegiata di osservazione per i linguisti».<br />
L’intreccio di variabili sociolinguistiche coinvolte nel fenomeno migratorio è tanto più<br />
complesso nel caso del nostro Paese. Ha scritto Luca Lorenzetti (1994, 627):<br />
In un territorio come quello <strong>italiano</strong>, la cui permeabilità agli spostamenti di popoli e alle correnti demografiche e<br />
culturali, esogene o interne, è quasi un topos storiografico, e in una storia linguistica come quella italiana,<br />
dominata nella massima parte e fino a tempi molto recenti dalla dimensione geografica, l’importanza linguistica<br />
della mobilità migratoria è enorme.<br />
La secolare <strong>fra</strong>mmentazione politica della penisola italiana ha dato origine a grandi differenze<br />
di ordine socioeconomico, ma ha anche favorito il proliferare delle parlate dialettali le quali,<br />
al momento dell’Unità d’Italia, costituivano l’unica varietà nel repertorio linguistico della<br />
maggior parte degli italiani. 1 Senza conoscere tale contesto di scarsa alfabetizzazione, di<br />
diffusa <strong>dialetto</strong>fonia e di depressione economica è impossibile capire un fenomeno migratorio<br />
della portata di quello <strong>italiano</strong>. 2<br />
Oggetto del presente contributo è la corrispondenza epistolare di alcuni <strong>migranti</strong> orginari di<br />
Guardia Lombardi, borgo montano situato nella provincia di Avellino (Campania).<br />
1 Come è noto, il numero degli italiani alfabetizzati nel 1861 è stato oggetto di un vivace dibattito, avviato da<br />
Tullio De Mauro (1963, 43) e Arrigo Castellani (1982). Il primo ha stimato che a saper leggere e scrivere,<br />
centocinquant’anni fa, fosse il 2,5% <strong>dei</strong> cittadini del neonato Regno d’Italia. Il secondo, accordando maggior<br />
fiducia ai nostri antenati, ha alzato tale stima al 10%. Tornando sull’argomento, De Mauro (1989, XVII-XIX,<br />
nota 6) ha spiegato la differenza <strong>fra</strong> le due stime come dovuta a diversi criteri di definizione dell’analfabetismo e<br />
dell’italofonia. Per una sintesi sugli sviluppi ulteriori del dibattito cf. Trifone (2010, 94-97). Come rileva lo<br />
studioso, pur estendendo la patente di italofonia ad una percentuale più alta di quelle ipotizzate da De Mauro e<br />
anche da Castellani, «il freddo rilievo statistico acquista drammatica evidenza dal confronto con la situazione di<br />
altri paesi europei» (Trifone 2010, 97), nei confronti <strong>dei</strong> quali l’Italia unificata denunciava un notevole ritardo.<br />
2 Si calcola che «l’emigrazione [abbia] portato all’estero quasi 27 milioni di italiani tra il 1876 (anno della prima<br />
rilevazione ufficiale degli espatriati) e il 1988» (Golini/Amato 2001, 48). È impossibile rendere conto in modo<br />
anche solo parziale della bibliografia relativa all’emigrazione italiana <strong>fra</strong> Otto- e Novecento. Un quadro storico<br />
d’insieme, sufficientemente recente, è contenuto nei volumi curati da Bevilacqua et al. (2001/2002). Una recente<br />
sintesi degli aspetti storico-linguistici e sociolinguistici del fenomeno migratorio <strong>italiano</strong> è offerta dai saggi<br />
raccolti in Vedovelli (2011).
Fig. 1: Posizione di Guardia Lombardi (AV) rispetto ai capoluoghi campani (Google © 2012)<br />
Nel corso di svariati decenni lo studioso locale Salvatore Boniello 3 ha raccolto circa 140<br />
<strong>lettere</strong> di suoi compaesani trasferitisi all’estero, per lo più in Svizzera e in Nord America 4 .<br />
Questi documenti, che coprono un arco cronologico di circa un secolo (dal 1911 ai nostri<br />
giorni), sono attualmente conservati presso la Biblioteca comunale associata UNLA, sotto<br />
l’attenta custodia di Giovanna e Rina Boniello, figlie di Salvatore. 5<br />
Si tratta per lo più di corrispondenza privata, prodotta per mantenere i contatti con la terra<br />
d’origine, secondo dinamiche ben note agli studiosi di questo tipo di testi. Gli argomenti<br />
trattati offrono uno spaccato storico, sociologico e psicologico del fenomeno migratorio<br />
<strong>italiano</strong>, trovando precise rispondenze nei contenuti di altri epistolari simili; salute,<br />
informazioni su nascite e morti, matrimoni e altre tappe fondamentali nella vita <strong>dei</strong> nuclei<br />
familiari sono temi ricorrenti<br />
3 Un breve cenno biografico è doveroso (una biografia più estesa è offerta dalla scheda di Wikipedia:<br />
http://it.wikipedia.org/wiki/Salvatore_Boniello, consultata il 10.8.2012): nato nel 1928, egli ha esercitato fin dai<br />
primi anni del secondo dopoguerra la professione di insegnante elementare. Parallelamente ha svolto un’intensa<br />
attività nell’ambito dell’Unione Nazionale per la Lotta contro l’Analfabetismo (UNLA), ente di cui ha anche<br />
ricoperto l’incarico di vicepresidente nazionale. A margine di questi impegni, Boniello si è dedicato allo studio e<br />
alla conservazione della cultura locale, fondando a Guardia Lombardi il Museo delle Tecnologie, della Cultura e<br />
della Civiltà Contadina dell’Alta Irpinia (1981) e dando alla luce alcune pubblicazioni di carattere storico e<br />
linguistico (cf. la bibliografia del presente contributo). Al momento della morte, sopraggiunta nell’autunno del<br />
2010, due erano i più importanti filoni di ricerca aperti: uno legato alla figura di Carmine Crocco (1830-1905) e<br />
al fenomeno del brigantaggio nel Mezzogiorno; l’altro, appunto, all’emigrazione. Alla memoria di Boniello è<br />
dedicato il presente articolo.<br />
4 Negli USA l’emigrazione guardiese si è concentrata soprattutto in Pennsylvania. Cf. Longo (2004).<br />
5 Alla fiducia accordatami da costoro e da <strong>Francesco</strong> Magnotta (figlio di Giovanna) debbo la possibilità di aver<br />
cominciato questo studio. A tutti loro e ai loro famigliari, eredi materiali e spirituali di Salvatore Boniello, va la<br />
mia più sincera gratitudine.
Da tanto tempo voleva scriverti ma sono stato ammalato e non ti ho scritto; essendo che e sgravata ad ma però<br />
ha fatto una bambina morta essa stava bene ma però stava dispiaciuta; Cara commara fammi sapere voi come<br />
state credo che godete in buona salute assieme a tutti di famiglia.<br />
Salute, malattia e morte sono spesso interpretate alla luce di una vigorosa fede nella Divina<br />
Provvidenza<br />
Grazie Iddio stiamo tutti e due alquando bene; Con sommo dispiacere ti annunzio la morte del tuo <strong>fra</strong>tello X1<br />
[...]. adesso caro cognato non resta altro che la rassegnazione verso la volontà di Dio con la morte non ce che<br />
fare siamo nati e dobbiamo morire. 6<br />
Un altro tema ricorrente è il denaro<br />
Laffari vanno troppo male; quanta anni ci vuole per quadagnare quelle soldi ma noi scriveremo a X2 se deve<br />
moderare il prezzo.<br />
L’attenzione verso il denaro e i beni materiali è di facile comprensione, considerando lo<br />
sfondo sociale che caratterizza e causa il fenomeno migratorio. Stessa matrice psicologica<br />
hanno le minuziose descrizioni delle merci che accompagnano talune missive, allo scopo di<br />
evidenziarne il valore e verificarne il corretto arrivo a destinazione:<br />
Mando una camicetta di seta alla tua figlia [...] dunque la camicetta e molto bella e credo che la ragazza deve<br />
rimane re contenta e per segno vicino alla camicetta alla parte di nanzi da sotto alla piega gli ho fatto un segno<br />
col cotone rosso per motivo che tante volte la dovessero campiare perciò scrivetemi subito se questi oggetti l’hai<br />
ricevuti<br />
L’epistolografia migrante non può sottrarsi alla narrazione del viaggio. «La traversata<br />
[oceanica] assume spesso i tratti dell’esperienza memorabile» (Gibelli/Caffarena 2001, 569),<br />
dando luogo a veri topoi narrativi. Nel brano che segue sono descritti i malori dovuti alla<br />
navigazione<br />
Il mare sempre in tempesta fino ad ora, non si mangia e ne si dorme tante cose che si perdono ma nesiuno<br />
mangia, tutti che rovesiano li vedi chi a una parte e chi a un’altra tutti mezzi morti per terra, se ci vedete come<br />
abbiamo fatto ancora con due giorni e mezzo di viaggio, mimaggino finché si arriva a destinazione spero di<br />
arrivare presto, se no proprio mi sfastidio non tanto per me ma per X3, che rovescia pure<br />
Non siamo affatto lontani, né per contenuto né per toni, dal passo seguente, proveniente da<br />
un’altra raccolta<br />
6 Per ragioni di riservatezza e di rispetto nei confronti degli scriventi (o, se questi ultimi sono deceduti, <strong>dei</strong> loro<br />
famigliari), <strong>dei</strong> destinatari delle <strong>lettere</strong> e delle persone ivi citate, mi è stato chiesto di omettere i nomi propri<br />
(compresi soprannomi e ipocoristici) presenti nei testi. Questi ultimi sono sostituiti dalla lettera X, seguita da un<br />
deponente diverso per ciascun nome omesso (X1, X2, X3, etc.).
Avevo sentito parlare di Oceano in burrasca ma non mi figuravo che fosse così [...] pei corridoi pareva di<br />
essere in una casa di matti; da una parte si vedeva uno che cercava di arrivare fino al cesso per fare i ...gattini 7<br />
Nelle pagine che seguono si illustreranno alcuni caratteri linguistici di questi documenti,<br />
ricavati dall’analisi di cinque <strong>lettere</strong> di guardiesi emigrati in negli Stati Uniti 8 . L’ipotesi di<br />
partenza è che nell’<strong>italiano</strong> di tali scriventi possano confluire elementi provenienti da diverse<br />
varietà: su tutte, la varietà dialettale dello scrivente e la lingua del paese di accoglienza<br />
(l’inglese).<br />
2. Analisi linguistica<br />
2.1. Grafia<br />
Si osservano innanzi tutto frequenti errori di segmentazione. Il caso più frequente è<br />
l’univerbazione di un sintagma (agglutinazione), in particolar modo allorquando sono<br />
coinvolte particelle proclitiche (preposizioni e articoli) o parole elise, che vengono a formare<br />
un’unità fonica e grafica con il vocabolo seguente: 9 attè ← a te; mimaggino ← m’immagino;<br />
mialettera ← mia lettera; lai ← l’hai; ce ← ci è; ammezzo ← a mezzo; tela ← te la; laffari ←<br />
gli affari; allinpiedi ← all’in piedi; salza ← si alza; questoggi ← quest’oggi; unaltra ←<br />
un’altra; inquanto ← in quanto; incittà ← in città; perme ← per me; Initalia ← in Italia. 10<br />
Fenomeno collegato, ma di segno opposto, è la deglutinazione in esempi come di nanzi ←<br />
dinanzi; al meno ← almeno. 11 È dovuta a errata segmentazione anche l’aferesi della vocale di<br />
7 Fare i gattini ‘vomitare’. La lettera, recante l’intestazione Oceano 14-2-26, è riprodotta (con alcune omissioni)<br />
in Gibelli/Caffarena (2001, 570).<br />
8 Non è stato ancora possibile, fino ad oggi, esaminare tutto il materiale. <strong>Le</strong> cinque <strong>lettere</strong> considerate nel<br />
presente studio appartengono al primo nucleo di documenti che mi sono stati messi a disposizione già nella<br />
primavera del 2011: si tratta, <strong>fra</strong> questi, di quelli meglio conservati e leggibili. Tre <strong>lettere</strong> provengono da<br />
Scranton (PA, USA) e risalgono agli anni ‘20 dello scorso secolo; una è stata inviata da Gibilterra, durante un<br />
viaggio in nave, nel 1937; una quinta, non datata, è giunta a destinazione a gennaio del 1976 e riporta un<br />
indirizzo di White Plains (NY, USA). Tutte e cinque sono indirizzate a persone residenti a Guardia Lombardi<br />
(AV). Il testo delle <strong>lettere</strong> è riprodotto, per intero, nell'Appendice (pp. 12-14).<br />
9 Cf. D’Achille (1994, 68): «agglutinazioni e deagglutinazioni sono [...] causate dalla scarsa percezione <strong>dei</strong><br />
confini della parola nel continuum fonico». Cf. anche Berruto (1998, 136). Analoghi fenomeni di agglutinazione<br />
sono registrati, in scritture di semicolti ispanofoni, anche da Michela Giovannini (cf. il contributo nel presente<br />
volume).<br />
10 In quest’ultimo esempio lo spostamento della maiuscola conferma che il sintagma è percepito come unità<br />
lessicale.<br />
11 Al meno e inquanto sono forme registrate dai dizionari, ma assai rare nell’uso moderno. È poco plausibile<br />
pensare ad una scelta consapevole, da parte degli scriventi, di arcaismi grafici. Stesso discorso può valere per<br />
tenpo ← tempo, grafia attestata in <strong>italiano</strong> antico ma probabilmente dovuta, nelle <strong>lettere</strong> <strong>dei</strong> <strong>migranti</strong>, a semplice<br />
errore ortografico (cfr. più avanti, p. , nota 31).
un sostantivo, che viene reinterpretata come appartenente all’articolo determinativo: lo<br />
perazione ← l’operazione. 12<br />
L’uso <strong>dei</strong> segni diacritici è incerto: 13 del tutto normale è l’assenza dell’accento nella terza<br />
persona dell’indicativo di essere (e ← è), ma anche in altri vocaboli: ne ← né; piu ← più. Al<br />
contrario, l’accento è impropriamente presente in attè ← a te, probabilmente come<br />
conseguenza all’univerbazione del sintagma.<br />
L’incertezza nell’uso dell’apostrofo, già riscontrata in alcuni casi di agglutinazione, è<br />
testimoniata anche da un esempio contrario: in’America ← in America.<br />
Un errore meramente grafico è pure la mancanza dell’h diacritica nelle voci del verbo avere<br />
che la prevedono: o ← ho.<br />
Alla scarsa scolarizzazione è imputabile la caratteristica grafica più evidente, ovvero<br />
l’impiego improprio o mancato dell’interpunzione. Quest'ultima è usata sporadicamente e in<br />
modo malcerto, più per assecondare la prosodia che per strutturare gerarchicamente i<br />
periodi. 14<br />
2.2. Fonetica<br />
La provenienza centromeridionale degli scriventi è segnalata da alcuni tratti: i) la presenza del<br />
raddoppiamento sintattico, visibile nelle forme univerbate (attè ← a te), o di altri<br />
rafforzamenti consonantici all’interno della parola: subbito ← subito; ristabbilisce ←<br />
ristabilisce, mimaggino ← m’immagino (in cui <strong>fra</strong> l’altro non è raddoppiata la seconda<br />
bilabiale nasale; probabilmente per ipercorrettismo); ii) la lenizione della consonante dopo<br />
nasale: bottongini ← bottoncini, inquando ← in quanto, manga ← manca, mangare ←<br />
mancare. 15 Per converso, si registra una realizzazione sorda, forse ipercorretta, in campiare ←<br />
cambiare e risponto ← rispondo. Potrebbe spiegarsi in modo analogo anche l’assordamento<br />
della labiovelare in riquardo ← riguardo e quadagnare ← guadagnare. 16<br />
Tra i fenomeni generali va segnalata l’aferesi in sagerato ← esagerato, iuto ← aiuto e in [lo]<br />
perazione ← [l’]operazione, di cui si è già detto.<br />
12 Si tratta dello stesso fenomeno che, nel lungo corso, ha portato alla formazione di parole come it. scuro ← lat.<br />
obscūru(m). Cf. Rohlfs (1966/1969, §§ 341-342, vol. 1, 477-480) e Cortelazzo (1972, 119-121).<br />
13 Cf. D’Achille (1994, 68-69).<br />
14 Cf. D’Achille (1994, 68). Talora, mancando il punto fermo, è addirittura difficile (e forse improprio) parlare di<br />
veri e propri ‘periodi’.<br />
15 «[I]l raddoppiamento della -g- e della -b- intervocaliche, la sonorizzazione della sorda postnasale, la<br />
problematica resa grafica della finale indistinta, ecc., caratterizzano in genere i testi [semicolti]<br />
centromeridionali» (D’Achille 1994, 69). Cf. anche Cortelazzo (1972, 123-126) e Berruto (1998, 136).<br />
16 Se non pronuncia, è grafia ipercorretta abbastansa ← abbastanza.
2.3. Morfologia<br />
Nell’ambito della morfologia nominale si registrano frequenti metaplasmi: Signoro ←<br />
Signore; commara ← commare; saluta ← salute; liri ← lire. Potrebbero giocare un ruolo due<br />
fattori: da un lato l'indebolimento delle vocali finali (che può portare alla neutralizzazione in<br />
[ə]); 17 dall’altro la tendenza a marcare il genere, tipica di numerose parlate italoromanze. 18<br />
In quanta ← quanti entra in gioco il contesto sintagmatico (quanta anni): la pronuncia<br />
meridionale /kwant'anni/, con caduta della -i finale, favorisce il ripristino di una vocale<br />
anetimologica di timbro uguale all'iniziale della parola seguente (anni). 19<br />
Fig. 2.<br />
Interessante è il caso di noto ← nota, nella locuzione dare noto ‘dare nota’ [di qualcosa], per<br />
il quale è ipotizzabile una confusione con l’aggettivo noto. L’errore sarebbe dovuto<br />
all’interferenza di un’altra locuzione quasi sinonimica, rendere noto, come suggerisce la<br />
cancellazione dell’articolo determinativo il, marca di oggetto diretto, sostituito dalla<br />
preposizione del, che introduce un complemento di argomento (cf. Fig. 2). Ci troviamo di<br />
fronte a un mutamento di progetto che lascia la sua traccia nel messaggio, in modo non<br />
dissimile da quanto accade nella lingua parlata. È questo uno <strong>dei</strong> tratti principali dell’<strong>italiano</strong><br />
<strong>dei</strong> semicolti, varietà che assomma caratteristiche del parlato e dello scritto (D'Achille 1994,<br />
17 Come osserva Loporcaro (2009, 145), «il vocalismo finale atono rientra <strong>fra</strong> le principali isoglosse definitorie<br />
per la classificazione <strong>dei</strong> dialetti italiani, <strong>fra</strong> i quali gli alto-meridionali sono caratterizzati dalla neutralizzazione<br />
di tutti i timbri vocalici in [ə]. Alcune aree dell'alto Meridione mantengono tuttavia un vocalismo finale<br />
contraddistinto da una o più opposizioni». Il fenomeno, come argomentano in modo convincente<br />
Cangemi/Delucchi/Loporcaro/Schmid (2010), rappresenta una fase conservativa rispetto alla centralizzazione<br />
delle vocali finali, il cui centro irradiatore sarebbe Napoli; ciò ben si accorda con la perifericità di Avellino e<br />
soprattutto dell'Alta Irpinia, i cui collegamenti con i centri più importanti sono stati a lungo difficoltosi (Cf.<br />
l'appassionato racconto di De Sanctis [1876] 2003). Per Montella (AV), così come per la stessa Avellino,<br />
Marano Festa (1928-1933, § 16, n. 4, p. 173) segnala la resistenza di tutti i timbri vocalici. In una nota al<br />
medesimo articolo Clemente Merlo, sulla scorta delle risposte di un insegnante locale, afferma che «a Montella,<br />
come nella stessa Avellino, a Chiusano, a Solo<strong>fra</strong>, ecc. le vocali finali, e in ispecie l'-a, non perdono interamente<br />
la loro natura» (Marano Festa 1928-1933, § 16, n. 4, p. 173, nota 5); dove è implicita, in parziale contrasto con<br />
l'autrice del contributo, una differenza nel trattamento <strong>dei</strong> diversi timbri vocalici, pur nel contesto di un loro<br />
generale mantenimento. Mancano, a tutt'oggi, esplorazioni scientifiche della parlata di Guardia Lombardi,<br />
previste in seno al progetto dell'Atlante Linguistico della Campania (www.alcam.de). Una piccola inchiesta,<br />
condotta dal sottoscritto alcuni anni fa, sembrerebbe confermare la resistenza delle vocali finali (Cf. <strong>Bianco</strong><br />
1999), sempre che il parlato elicitato ivi trascritto non sia viziato da sforzi iperarticolatori.<br />
18 Cf. Rohlfs (1966/1969, § 353, vol. 2, 14-16) e D’Achille (1994, 70).<br />
19 Conforta questa ipotesi la conoscenza della prassi scrittoria <strong>dei</strong> semicolti, nei cui testi si riscontrano spesso<br />
esempi di questo fenomeno: ti lo vena aresstare 'te lo vengo ad arrestare'; tutta alla Vostra Signoria 'tutto (il<br />
terreno) alla Vostra Signoria'. Sono brani tratti da scritture (inedite) di briganti abruzzesi dell'800, riportati e<br />
analizzati da Mililli (in preparazione). Ringrazio l'autrice per avermi messo a disposizione i suoi materiali.
41). Nel passaggio dal primo al secondo, alcune marche diamesiche e diafasiche si convertono<br />
in marche diastratiche.<br />
Fra i pronomi personali si segnala l’uso di essa per referenti umani.<br />
Nell’ambito della morfologia verbale le forme [non mi] serva ← serve, stati ← state [bene] e<br />
voleva ← volevo possono essere variamente spiegate: può trattarsi di un’errata ricostruzione<br />
della vocale finale, dell’influsso di un modello dialettale soggiacente o di semplici incertezze<br />
grafiche.<br />
Di sicura provenienza regionale è la quarta persona del presente indicativo di potere: potemo<br />
← possiamo.<br />
Altro fenomeno riconducibile all’area geografica è la generalizzazione dell’ausiliare avere,<br />
tipica di molte parlate meridionali: avrebbe stato un’iuto ← sarebbe stato un/d'aiuto. 20<br />
2.4. <strong>Le</strong>ssico<br />
Più che veri dialettismi, sono presenti alcuni regionalismi, che confermano la provenienza<br />
meridionale degli scriventi: 21 commare/-a ‘madrina di battesimo di cresima; testimone di<br />
nozze; amante’ 22 ; sfastidiarsi ‘annoiarsi; provare fastidio, rabbia o dispiacere per qualcosa’;<br />
sgravare ‘partorire’. Anche moneta potrebbe essere un prestito semantico dal <strong>dialetto</strong>, col<br />
significato di ‘somma ingente di denaro’, come rileva Cortelazzo (1972, 42). È normale stare<br />
per essere in sta ammalata, sta pure ammalato.<br />
Interessante la locuzione traslata tenere le pietre al fegato, forse riconducibile ad<br />
un’espressione idiomatica locale e riferibile alla patologia comunemente nota come calcoli<br />
del fegato. 23 Andrà in ogni caso osservata la presenza del meridionalismo tenere per avere,<br />
tratto che Cortelazzo (1972, 33-34) annovera <strong>fra</strong> i regionalismi capaci di superare (attraverso<br />
l’<strong>italiano</strong> popolare) i confini tradizionali, potendosi trovare, ad esempio, nella corrispondenza<br />
<strong>dei</strong> militari settentrionali.<br />
Oltre alla marcatezza diatopica di alcuni elementi, il lessico fa registrare la presenza di parole<br />
di basso uso, non meglio riconducibili né a una varietà locale, né a una varietà diastratica o<br />
diafasica basse: rigo per ‘riga’, tardanza 24 per ‘ritardo’, oltre a una serie di locuzioni e<br />
formule che fanno pensare all’<strong>italiano</strong> burocratico: presente ‘questa’ (come <strong>dei</strong>ttico testuale);<br />
20 Cf. Rohlfs (1966/1969, § 729, vol. 3, 122-123).<br />
21 Come osserva D’Achille (1994, 72), concorde con Cortelazzo (1972: 25), «[n]el campo lessicale la presenza di<br />
voci dialettali nei testi <strong>dei</strong> semicolti è, naturalmente, diffusa, ma meno di quanto forse ci si attenderebbe».<br />
22 A proposito del significato di commare/-a a Guardia Lombardi ringrazio il puntuale aiuto di Menina Troiano,<br />
Gerardo Di Paola e Domenico Cipriano.<br />
23 Per un'espressione simile in español popular cf. il contributo di Michela Giovannini nel presente volume.<br />
24 Il GDLI (vol. 20, 731, s.v.) classifica tardanza come voce antiquata e letteraria.
ammezzo di ‘per mezzo di, attraverso, tramite’, rimanere offeso; ricevi sentite condoglianze.<br />
Caratteristiche della varietà burocratica sono pure le abbreviazioni, come appun. ←<br />
appuntato, aff. ← affezionato/-a. Ha il tipico sapore del burocratese la <strong>fra</strong>se Spero che al<br />
ricevere la presente stati tutti bene. 25<br />
Il ricorso a risorse linguistiche e stilistiche poco comuni, di reminiscenza scolastica o di altra<br />
provenienza, può essere interpretato come un segnale della scarsa fiducia che lo scrivente<br />
ripone nei propri mezzi, nonché della volontà di accordare al proprio scritto un certo decoro.<br />
Come ricorda (D'Achille 1994, 73), «[l]a componente costituita da termini aulici, burocratici,<br />
tecnici appartiene da sempre ai testi <strong>dei</strong> semicolti». È interessante osservare che i documenti<br />
qui considerati veicolano una comunicazione <strong>fra</strong> pari: il ricorso a elementi “marcati” verso<br />
l'alto non è finalizzato a colmare la distanza <strong>fra</strong> soggetti che godono di prestigio sociale<br />
differente e la presenza di questi elementi pare contrastare con l’emotività <strong>dei</strong> contenuti delle<br />
<strong>lettere</strong>, che ben si ritrova in altre scelte linguistiche. 26<br />
2.5. Sintassi e testualità<br />
Tre sono i fenomeni di rilievo nel campo della microsintassi: i) l’uso non standard delle<br />
preposizioni (godete in buona salute, siamo contenti a rivederlo) 27 ; ii) il che polivalente (cf.<br />
Cortelazzo 1972, 93-98 e D’Achille 1994, 72), usato in luogo di congiunzioni subordinanti<br />
più specifiche: mi dispiace che non può venire in’America che se no avrebbe stato un’iuto per<br />
voi; iii) la confusione <strong>fra</strong> tempi e <strong>fra</strong> modi del verbo: Vi ho voluto scrivere questi pochi righi<br />
tanto per darvi notizie se no non avesse scritto [‘non avrei scritto’], ho scritto proprio a forza<br />
a mio marito.<br />
Netta è la prevalenza per la paratassi; la subordinazione, poco frequente, supera raramente il<br />
primo grado. 28<br />
La testualità è forse il settore in cui il carattere popolare di queste <strong>lettere</strong> emerge con maggior<br />
forza: è evidente la difficoltà degli scriventi nel pianificare il discorso e nel disporre in modo<br />
gerarchicamente ordinato i contenuti (cf. anche Bertini Malgarini 1998, 120). A quest’ultima<br />
carenza contribuisce la scarsa o nulla padronanza della punteggiatura, cui si è già fatto<br />
accenno in § 2.1.<br />
25 Cf. Cortelazzo (1972, 44-47) e D’Achille (1994, 73-74).<br />
26 Per esempio, il frequente ricorso a diminutivi (merlettino, bottongini), vezzeggiativi e ipocoristici. Questi<br />
ultimi sono stati espunti sia dagli esempi sia dalla trascrizione delle <strong>lettere</strong>, per le ragioni illustrate a p. 3, nota 6.<br />
Sugli ipocoristici in uso a Guardia Lombardi può essere interessante la lettura del volume di Giordano (2001),<br />
realizzato sotto la supervisione di Salvatore Boniello.<br />
27 Cf. D’Achille (1994, 71). Su queste deviazioni dalla norma potrebbero influire anche il sostrato dialettale o il<br />
„superstrato“ alloglotto.<br />
28 Cf. il brano sulla navigazione citato in § 1.
La coesione testuale è assicurata per lo più da riprese lessicali, che denunciano la scarsa<br />
disponibilità di strategie pronominali, così come la povertà del vocabolario<br />
Scrivo questa mia lettera facendovi sapere che adesso grazie Iddio stiamo tutti e due alquando bene ti scrissi<br />
un’altra mia lettera e non ho ricevuto nessuna tua risposta non so se la mia lettera lai ricevuta<br />
Per coerenza tematica questi documenti ricordano il parlato: 29 non di rado un argomento è<br />
abbandonato per essere ripreso in seguito, come accade nella conversazione spontanea 30<br />
Ti fo sapere che ammezzo di X1 mando una camicetta di seta alla tua figlia X2 e di più mando una machinetta al<br />
tuo figlio X3 per farsi la barba tutti mi dicono che si e fatto un pezzo di giovane mi dispiace che non può venire<br />
in’America che se no avrebbe stato un’iuto per voi dunque la camicetta e molto bella<br />
3. Conclusioni<br />
«Tra i testi prodotti dalla gente comune in ambiti caratterizzati dal predominio dell’oralità, i<br />
carteggi degli e<strong>migranti</strong> occupano un posto di assoluto rilievo» (Gibelli/Caffarena 2001, 564),<br />
quale che sia il punto di vista dal quale li si osservi e li si prenda in considerazione.<br />
L’indagine condotta sulle missive inviate in patria dai <strong>migranti</strong> guardiesi sembra confermare<br />
tale diffusa opinione.<br />
La base di queste <strong>lettere</strong> è l’<strong>italiano</strong> popolare: una varietà mescidata, «dove maldestramente<br />
amalgamati si allineano elementi delle più varie provenienze» (Cortelazzo 1972, 43). I<br />
regionalismi accolti da questa varietà di <strong>italiano</strong> si concentrano soprattutto nei settori del<br />
lessico e della fonetica, con con qualche riflesso di carattere morfologico. Non si tratta di<br />
influssi diretti del <strong>dialetto</strong> locale, quanto di elementi attinti o mediati da una koinè regionale o<br />
sovraregionale. Si tratta di elementi riconducibili alla macroarea del Mezzogiorno o, tutt’al<br />
più, alla Campania.<br />
Nonostante il carattere privato della corrispondenza, è evidente il tentativo di elevare la lingua<br />
e lo stile evitando, per quanto possibile, i tratti più vernacolari e attingendo ad un bagaglio di<br />
risorse ‘alte’ costituito da reminiscenze scolastiche, burocratismi di vario genere e altri<br />
elementi acquisiti in modo più o meno casuale da varietà cui è attribuito un certo prestigio<br />
sociale. Questo carattere si collega alla «tendenza [dell’<strong>italiano</strong> <strong>dei</strong> semicolti] all’arcaismo,<br />
29 «La testualità dell’it. popolare è fondamentalmente una testualità del parlato spontaneo, non pianificato, con<br />
scarsa esplicitazione <strong>dei</strong> rapporti inter<strong>fra</strong>sali, struttura del periodo spesso giustappositiva, sviluppo tematico<br />
caratterizzato da bruschi cambiamenti di topic discorsivo e da altrettanto brusche riprese del topic precedente<br />
[...]: i parlanti <strong>italiano</strong> popolare tendono nettamente a ‘scrivere come si parla’» (Berruto 1998, 137).<br />
30 Cf. D’Achille (1994, 74).
che si ravvisa nel mantenimento di grafie, forme e costrutti che la lingua standard ha<br />
abbandonato» (D’Achille 1994, 66). 31<br />
Manca, nei documenti che abbiamo analizzato, un significativo apporto della L2, 32 cioè la<br />
lingua parlata nel paese d’accoglienza dell’emigrante (l’angloamericano). L’unico esempio<br />
che potrebbe essere riconducibile a tale influenza è il sintagma in tua famiglia (senza<br />
preposizione articolata; cf. anche p. , nota 27), per cui è plausibile l'ipotesi del modello<br />
inglese in your family. 33 Sulle ragioni di questo mancato influsso, per ora, non ci si può<br />
pronunciare. Innanzi tutto è necessario ricostruire, per quanto possibile, il background<br />
personale e sociale degli scriventi, scoprendo (tra le altre cose) a quando risale il loro primo<br />
contatto con la L2 rispetto alla data di stesura della lettera: 34 numerose testimonianze di<br />
<strong>migranti</strong> confermano la difficoltà nell’approccio con la lingua straniera, che in molti casi entra<br />
a far parte del repertorio solo dopo un lungo, faticoso e irregolare apprendistato. 35<br />
Non va trascurato un altro aspetto: sebbene alcuni importanti obiettivi siano stati raggiunti, la<br />
conoscenza <strong>dei</strong> dialetti campani (ma il discorso potrebbe valere anche per altre aree) è ancora<br />
insoddisfacente. Se il napoletano, tanto nelle sue manifestazioni più spontanee, quanto nei<br />
suoi riflessi letterari, è stato oggetto di ampi e approfonditi studi accademici, lo stesso non<br />
può dirsi delle parlate di altre zone. Per avere notizie <strong>dei</strong> dialetti <strong>irpini</strong> ci si rifà ancora oggi a<br />
contributi datati e non sistematici, 36 oppure si ripiega su studi concepiti fuori dal contesto<br />
accademico, come le pubblicazioni dello stesso Boniello per il guardiese. 37 Tale quadro delle<br />
31 versa origine hanno, a mio parere, le grafie segnalate a p. 4, nota 11, che non elevano affatto il tono del<br />
discorso e che possono essere facilmente interpretabili come errori di segmentazione piuttosto che come arcaismi<br />
consapevoli.<br />
32 L’ipotesi di lavoro enunciata in § 1, rispetto a queste cinque <strong>lettere</strong>, non può dirsi del tutto verificata. Si tratta,<br />
tuttavia, di un ulteriore stimolo a proseguire la ricerca, estendendo l’analisi all’intera raccolta e definendo i<br />
contesti di produzione delle <strong>lettere</strong>. La presenza di significativi fenomeni interlinguistici legati alla migrazione,<br />
con tracce evidenti negli scritti degli e<strong>migranti</strong> (italiani), sembra essere infatti un dato acquisito. Cf. Berruto<br />
(1998, 183-186) e Gibelli/Caffarena (2001, 570-571).<br />
33 Si tratta di una pura ipotesi che avanzo con estrema cautela, dati l'unicità e lo scarso rilievo dell'esempio.<br />
Registro infatti l'assenza dell'articolo determinativo anche in una lettera spedita dall'Italia (Sale Castelnuovo, TO,<br />
1927) a piemontesi emigrati in California, per la cui riproduzione fotografica cf. Rosso (1990, 26): sono lieto e<br />
contento al sentire che sei in ottima salute te e tutta tua famiglia. Difficile pensare che il costrutto, in questo<br />
caso, sia stato sollecitato da un modello anglofono.<br />
34 Per esempio, è ben plausibile che la lettera inviata da Gibilterra, scritta durante un tragitto in nave, risalga al<br />
viaggio di andata dello scrivente verso la terra d’accoglienza; in una fase, dunque, in cui la varietà alloglotta non<br />
può ancora aver esercitato alcun influsso significativo sul suo modo di parlare e di scrivere.<br />
35 Assai significative, a questo proposito, sono alcune delle testimonianze raccolte da Pautasso (1991). Cf. anche<br />
Grassi/Pautasso (1989).<br />
36 Cf., per esempio, Marano Festa (1928-1933) per il <strong>dialetto</strong> di Montella.<br />
37 Il valore di questi contributi, specie in assenza di ricerche sistematiche condotte in ambito accademico, non va<br />
per altro sottovalutato. Significative sono le parole di De Mauro (1991, 10-11): «Anche di qui la<br />
raccomandazione rivolta a cultori locali perché vincano le esitazioni e facciano presto. Ovviamente, per certi<br />
aspetti, sarebbe desiderabile che l’accademia scientificamente più qualificata desse mano a un vasto piano<br />
nazionale di rilevazione delle parlate dialettali ancora vigoreggianti. Ma troppe esperienze dicono che queste<br />
‘grandi imprese’ non hanno vita troppo felice nella nostra tradizione di studi linguistici. E a me è parso e pare più<br />
realistico e prudente raccomandare che chi può, perché a stretto, affettuoso contatto con la realtà d’una parlata<br />
locale, dia mano a raccoglierne forme e valori di cultura in opere che sono e saranno base documentale preziosa
conoscenze non può non influire sulla valutazione linguistica di testi prodotti da parlanti (e<br />
scriventi) campani. Allo stesso tempo le <strong>lettere</strong> <strong>dei</strong> <strong>migranti</strong> <strong>irpini</strong> si offrono come fonte per<br />
arricchire e meglio articolare questo quadro della Campania linguistica.<br />
L’ambizione di questo primo sondaggio è quella di dare un’idea dell’interesse che i dati<br />
contenuti nelle <strong>lettere</strong> <strong>dei</strong> <strong>migranti</strong> guardiesi presentano. La prospettiva del Dies Romanicus<br />
Turicensis ha ovviamente spinto a privilegiare un’attenzione (socio)linguistica, ma è evidente,<br />
già ad una prima lettura, il rilievo storico e sociologico di questi testi. «Anche grazie al loro<br />
carattere ibrido, al confine tra oralità e scrittura, tra cultura alta e formale e culture basse e<br />
popolari [...], le <strong>lettere</strong> d’emigrazione possono dire molto sull’evento che le ha determinate, di<br />
cui cercano di essere in qualche modo testimoni e rimedio, nonché sul soggetto che ne fu<br />
protagonista» (Gibelli/Caffarena 2001, 565).<br />
Non da ultimo, in prospettiva editoriale, è l’interesse narrativo e perfino stilistico che<br />
presentano documenti <strong>fra</strong> le cui righe si sente ‘pulsare la vita’. Valgano le parole di Manlio<br />
Cortelazzo (1972, 132): «Lo stile popolare può essere o sembrare a volte piatto, monotono,<br />
banale, perché, non sorretto da un pensiero profondo, manca di una articolazione complessa.<br />
Ma l’espressione delicata <strong>dei</strong> sentimenti, amorosi o dolorosi, di affetto o di odio, che siano, è<br />
lo stesso efficacemente raggiunta con i poveri mezzi a disposizione».<br />
L’augurio è che il prossimo futuro of<strong>fra</strong> le risorse per pubblicare l’intera raccolta di <strong>lettere</strong>,<br />
affinché il prezioso lavoro di Salvatore Boniello sia portato a termine e la comunità locale<br />
nonché quella scientifica possano giovarsene.<br />
per ulteriori indagini».<br />
<strong>Francesco</strong> <strong>Bianco</strong><br />
Università degli Studi di Macerata
Appendice<br />
Si riporta, di seguito, il testo integrale delle <strong>lettere</strong> analizzate per il presente contributo.<br />
Laddove la grafia o lo stato di conservazione delle <strong>lettere</strong> non consentano la lettura, si segnala<br />
la lacuna con la crux desperationis filologica (†). Gli accapo sono segnalati per mezzo della<br />
lineetta obliqua (/).<br />
* * *<br />
Screnton 13 Novembre 1926. / Mio caro <strong>fra</strong>tello / Scrivo questa mia lettera facendovi sapere<br />
che adesso grazie Iddio stiamo tutti e due alquando bene ti scrissi un'altra mia lettera e non ho<br />
ricevuto nessuna tua risposta non so se la mia lettera lai ricevuta fatemi sapere tutti in tua<br />
famiglia come state dunque ti fo sapere che ammezzo di X1 mando una camicetta di seta alla<br />
tua figlia X2 e di più mando una machinetta al tuo figlio X3 per farsi la barba tutti mi dicono<br />
che si e fatto un pezzo di giovane mi dispiace che non può venire in'America che se no<br />
avrebbe stato un'iuto per voi dunque la camicetta e molto bella e credo che la ragazza deve<br />
rimanere contenta e per segno vicino alla camicetta alla parte di nanzi da sotto alla piega gli<br />
ho fatto un segno col cotone rosso per motivo che tante volte la dovessero campiare perciò<br />
scrivetemi subito se questi oggetti l'hai ricevuti † io ti ho scritto la camicetta e di colore di<br />
rosa montata' di merlettino e bottongini bianchi spero di riceverla † altro ieri † sono stata a<br />
trovare alla tua cognata X4 essendo che e sgravata ad ma però ha fatto una bambina morta<br />
essa stava bene ma però stava dispiaciuta non ho altro nostro <strong>fra</strong>tello † che sta bene insieme<br />
con la famiglia spesso ci vediamo e vi mandono tanti saluti saluti da mio marito tanti saluti<br />
mando a tua moglie bacio a tutti i vostri figli e † tanti saluti da tutti i parenti saluti da tua<br />
cognata † e tua cognata X4 a te ti saluto caramente saluto a tutti i nostri parenti si saluto di<br />
nuovo tua aff.ma sorella / X5<br />
* * *<br />
[Scranton, 28.7.1927] Carissimo cognato / da tanto tempo voleva scriverti ma sono stato<br />
ammalato e non ti ho scritto, ora sto al quanto bene. Spero che al ricevere la presente stati tutti<br />
bene. / Con sommo dispiacere ti annunzio la morte del tuo <strong>fra</strong>tello X1 avvenuta questoggi<br />
dopo una lunga malattia poveretto e morto dopo di aver lavorato fino agli ultimi giorni, uomo<br />
stimato e voluto bene da tutti americani e italiani che lo conoscevanoe compiangono la sua<br />
perdita, perché troppo buono con tutti. adesso caro cognato non resta altro che la<br />
rassegnazione verso la volontà di Dio con la morte non ce che fare siamo nati e dobbiamo<br />
morire. Come puro tua sorella sta ammalata e avuto una scossa di tono ma leggermente non e<br />
rimasta offesa per nulla speriamo che presto si ristabbilisce. Non prolungo tanti saluti a tutti di<br />
mia famiglia e parenti tutti, bacio tutti i tuoi figli, ed attè e tuo moglie i miei più cari ed
affettuosi saluti credimi L'appun. Cognato X2 / P.S.: Ricevi le più sentite condoglianze dal<br />
<strong>fra</strong>tello alfonso e famiglia, come anche da mio figlio.<br />
* * *<br />
Darai questa foglietta alla zia X2 / Scranton 24 1931 / Carissima sorella / Con ritardo rispondo<br />
alla tua lettera la tardanza di questa mia e stata che voleva mettere qualche cosa e tela voleva<br />
mandare non o potuto proprio che laffari vanno troppo male piu in appresso † le cose ti<br />
mando qualche cosa nella tua cara sorella assieme a mio marito e figli siamo contenti che stai<br />
bene con tuo marito e figli lo stesso sia di noi tutti cara sorella per la morte di X 3 non ti feci<br />
sapere niente subbito sai cara sorella come rimanemmo dispiaciuti della sua morte che dopo<br />
una lunga malattia non ci fu nessun rimedio di poterla salvare o ricevuto il ritratto del tuo<br />
figlio non puoi credere come siamo contenti a rivederlo appena ricevuta la tua lettera subbito<br />
andai a trovare a tua cognata X4 e sta ammalata un giorno a letto e un giorno allinpiedi tiene le<br />
pietre al fegato lo perazione non sene puo fare salvatore come sai che si fece loperazione sta<br />
pure ammalato a giorni salza e giorni sta coricato così gli dici a tuo marito inquando alle<br />
scosse di terremoto che fece ci dispiace immensamente non ti scrisse quando fece la scossa<br />
credendoci che non era niente i giornali parlavano degli altri paesi e di Guardia niente ora si<br />
dice che cie stata unaltra volta la scossa fammi sapere sie fatto piu danno o no non ti dico altro<br />
ricevi i saluti dalla sorella X5 e suo marito e figli dal <strong>fra</strong>tello X6 e moglie e figli assieme a mio<br />
marito e figli tanti saluti a X7 e X8 e concettella con tutti i loro figli tanti baci ai tuoi figli tanti<br />
saluti a tuo marito a te ti bacio di cuore tua aff sorella X9<br />
* * *<br />
Cibiltera 8/12/37 / Carissima commare X1 / e commare X2. / Vi scrivo questi pochi righi per<br />
darvi noto il del cattivo viaggio che all abbiamo, il mare sempre in tempesta fino ad ora, non si<br />
mangia e ne si dorme tante cose che si perdono ma nessuno mangia, tutti che rovesiano li vedi<br />
chi a una parte e chi a un'altra tutti mezzi morti per terra, se ci vedete come abbiamo fatto<br />
ancora con due giorni e mezzo di viaggio, mimaggino finché si arriva a destinazione spero di<br />
arrivare presto, se no proprio mi sfastidio non tanto per me ma per X3, che rovescia pure. /<br />
Cara commara fammi sapere voi come state credo che godete in buona salute assieme a tutti<br />
di famiglia. A Napoli ci fecerino [non sono sicuro della parola] le fotografia, ma non siamo<br />
venuti tante bene ma non fa niente, tanto per ricordo, ve la fate dare una da X4 se non se l'ha<br />
data. Cara commara smetto di scrivere perché mi sento male. Scusate la calligrafia e gli errori,<br />
Vi ho voluto scrivere questi pochi righi tanto per darvi notizie se no non avesse scritto, ho
scritto proprio a forza a mio marito e X5 / baci cari dalla piccola X3 che vi nomina sempre, e io<br />
vi 38 abbraccio e vi bacio caramente vostra commare X5 satuti da parte a tuo marito e a X6.<br />
* * *<br />
Caro X1 / Subito risponto la tua lettera siamo contenti che tutti voi stati bene † vi dico di noi<br />
tutti fino oggi bene. Inquanto mi parli nella tua lettera tutto ho capito riquardo alla † oramai †<br />
fatto il Signoro gli la faccia godere con una buona saluta a tua sorella e famiglia per la moneta<br />
ai fatto bene a metterla sul mio libretto postale per questo momento non mi serva non †<br />
nessuno fastidio e abbastansa quello che fai poi a riquardo per accomodare la casa X 2 deve<br />
diminuari il prezzo perche e troppo sagerato 3.800 milioni e ottocento mila liri quanto poi<br />
abbiamo spesi tutti questi soldi se noi non potemo viviri ritrovo al meno affittarla quanta anni<br />
ci vuole per quadagnare quelle soldi ma noi scriveremo a X2 se deve moderare il prezzo seno<br />
pensiamo di † veramente si vende tutta la casa e quei soldi che dobbiamo spendere per<br />
accomodarla ci compremo una casa incittà perche i figli non voncono piu Initalia a vivere<br />
perme e [nome di persona che non si capisce] non posso scrivere a lungo che il tenpo manga<br />
non voglio mangare l'agurio di Santa Pasqua a tutti di famiglia ricevi saluti da noi tutti saluti<br />
cari la tua famiglia † X3 e X4 i più cari baci e saluti tuoi vicini X5 39<br />
Bibliografia<br />
BERRUTO, Gaetano, Sociolinguistica dell’<strong>italiano</strong> contemporaneo, Roma, Carocci, 1998.<br />
BERTINI MALGARINI, Patrizia, «Scritture di periferia: i testi dell’emigrazione nel Victoria e la<br />
ricostruzione della storia linguistico-culturale italiana», in: Vanvolsem, Serge et al. (ed.),<br />
L’<strong>italiano</strong> oltre frontiera, <strong>Le</strong>uven/Firenze, <strong>Le</strong>uven University Press/Cesati, vol. 1, 1998, 113-<br />
130.<br />
BEVILACQUA, Piero et al. (ed.) Storia dell’emigrazione italiana, 2 vol., Roma, Donzelli,<br />
2001/2002.<br />
BIANCO, <strong>Francesco</strong>, «<strong>Le</strong>ssico dialettale guardiese», Roma, Università degli Studi Roma Tre,<br />
1999, in: www.<strong>fra</strong>ncescobianco.net/linguistica/LDG.pdf (24.6.2012).<br />
BONIELLO, Salvatore, Dizionario dialettale della lingua di Guardia Lombardi, Lioni, 1994.<br />
BONIELLO, Salvatore, Viaggio nella memoria, Lioni, 1995.<br />
BONIELLO, Salvatore, Milleuno Detti e Proverbi di Guardia <strong>dei</strong> Lombardi e dell’Alta Irpinia,<br />
Lioni, 1999.<br />
BONIELLO, Salvatore, Sulle orme del passato, Lioni, 2001.<br />
CANGEMI, <strong>Francesco</strong> – DELUCCHI, Rachele – LOPORCARO, Michele – SCHMID, Stephan,<br />
«Vocalismo finale atono “toscano” nei dialetti del Vallo di Diano (Salerno)», in: Cutugno,<br />
38 Corretto su un precedente ti o viceversa.<br />
39 Sopra il margine alto della seconda facciata del foglio è vergata la seguente <strong>fra</strong>se: cludo 5 dolliri vi fati un<br />
caffe per mio ricordo Buona Pasqua
<strong>Francesco</strong> et al. (ed.), Parlare con le persone, parlare alle macchine. Atti del VI Convegno<br />
Nazionale dell'AISV, Napoli, 3-5 febbraio 2010, Torriana (RN), EDK, 2010, 477-490.<br />
CASTELLANI, Arrigo (1982), «Quanti erano gli italofoni nel 1861?», in: Studi linguistici italiani<br />
8, 3-26.<br />
CORTELAZZO, Manlio, Avviamento critico allo studio della <strong>dialetto</strong>logia italiana. Vol. 3,<br />
Lineamenti di <strong>italiano</strong> popolare, Pisa, Pacini, 1972.<br />
D’ACHILLE, Paolo, «L’<strong>italiano</strong> <strong>dei</strong> semicolti», in: Serianni – Trifone, cit., vol. 2, 1994, 41-79.<br />
DE MAURO, Tullio, Storia linguistica dell’Italia unita, 2 vol., Roma/Bari, Laterza, 1979.<br />
DE MAURO, Tullio, «Per una storia linguistica della città di Roma», in: De Mauro, Tullio (ed.),<br />
Il romanesco ieri e oggi. Atti del convegno del Centro Romanesco Trilussa e del<br />
Dipartimento di Scienze del linguaggio dell’Università di Roma «La Sapienza» [Roma, 12-13<br />
ottobre 1984], Roma, Bulzoni, 1989, XIII-XXXVII.<br />
DE MAURO, Tullio, «Prefazione», in: Iacoviello, Giuseppe, Baronia. Linguaggio usi e costumi,<br />
Lioni, Poligrafica Irpina, 1991, 9-11.<br />
DE SANCTIS, <strong>Francesco</strong>, Un viaggio elettorale, Cava de' Tirreni, Avagliano [1876] 2003 [ed.<br />
critica a cura di Toni Iermano].<br />
GDLI = BATTAGLIA, Salvatore et al. (ed.), Grande dizionario della lingua italiana, 24 vol.,<br />
Torino, Utet, 1961-2009.<br />
GIBELLI, Antonio – CAFFARENA, Fabio, «<strong>Le</strong> <strong>lettere</strong> degli e<strong>migranti</strong>», in: Bevilacqua et al.<br />
(2001/2002), cit., vol. 1, 2001, 563-574.<br />
GIORDANO, Stefania, Antica funzione storica, sociale e legale <strong>dei</strong> soprannomi dialettali di<br />
Guardia <strong>dei</strong> Lombardi, Lioni, 2001.<br />
GOLINI, Antonio – AMATO, Flavia, «Uno sguardo a un secolo e mezzo di emigrazione italiana»,<br />
in: Bevilacqua et alii (2001/2002), cit., vol. 1, 2001, 45-60.<br />
GRASSI, Corrado, «Nuove competenze linguistiche e uso stilistico-funzionale delle varietà del<br />
repertorio nel linguaggio degli emigrati», in: Ostuni (1991), cit., 321-328.<br />
GRASSI, Corrado - PAUTASSO, Mariella (ed.), Prima roba il parlare... Lingue e dialetti<br />
dell'emigrazione biellese, Milano, Electa, 1989.<br />
LONGO, Stephanie, Italians of Northeastern Pennsylvania,<br />
Charleston/Chicago/Portsmouth/San Francisco, Arcadia Publishing, 2004.<br />
LOPORCARO, Michele, Profilo linguistico <strong>dei</strong> dialetti italiani, Laterza, Roma-Bari, 2009.<br />
LORENZETTI, Luca, «I movimenti migratori», in: Serianni – Trifone (1993/1994), cit., vol. 3,<br />
1994, 626-668.<br />
MARANO FESTA, Olga, «Il <strong>dialetto</strong> irpino di Montella», in: L’Italia dialettale 4, 1928, 168-185;<br />
5, 1929, 95-128; 8, 87-116, 1932; 9, 172-202, 1933.<br />
MILILLI, Elisa, <strong>Le</strong> scritture di briganti nell'Ottocento abruzzese, tesi di dottorato [tutori:<br />
Patrizia Bertini Malgarini e Luca Lorenzetti], Roma, Sapienza Università di Roma, in<br />
preparazione.<br />
OSTUNI, Maria Rosaria (ed.), Studi sull’emigrazione. Un’analisi comparata. Atti del Convegno<br />
storico internazionale sull’emigrazione (Biella, Palazzo La Marmora, 25-27 settembre 1989),<br />
Milano, Electa, 1991.
PAUTASSO, Mariella, «La lingua del paese ospite: atteggiamennti e parole chiave nelle<br />
testimonianze di alcuni biellesi emigrati», in: Ostuni (1991), cit., 329-341.<br />
ROHLFS, Gerhard, Grammatica storica della lingua italiana e <strong>dei</strong> suoi dialetti, 3 vol., Torino,<br />
Einaudi, 1966/1969 [trad. it. di Temistocle Franceschi].<br />
ROSSO, Maurizio, Piemontesi nel Far West. Studi e testimonianze sull'emigrazione piemontese<br />
in California, Cavallermaggiore, Gribaudo 1990.<br />
SERIANNI, Luca – TRIFONE, Pietro (ed.), Storia della lingua italiana, 3 vol., Torino, Einaudi,<br />
1993/1994.<br />
TRIFONE, Pietro, Storia linguistica dell’Italia disunita, Bologna, Il Mulino, 2010.<br />
VEDOVELLI, Massimo (ed.), Storia linguistica dell’emigrazione italiana nel mondo, Roma,<br />
Carocci, 2011.