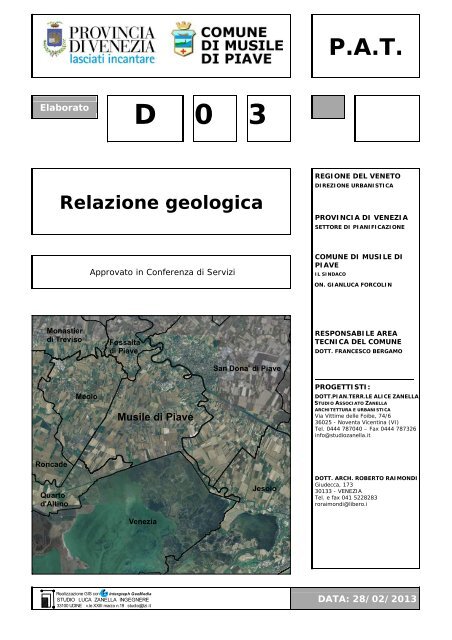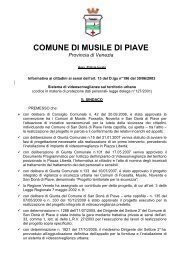Anteprima - Comune di Musile di Piave
Anteprima - Comune di Musile di Piave
Anteprima - Comune di Musile di Piave
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Elaborato<br />
D<br />
0<br />
3<br />
Relazione geologica<br />
Monastier<br />
<strong>di</strong> Treviso<br />
Roncade<br />
Quarto<br />
d'Altino<br />
Meolo<br />
Approvato in Conferenza <strong>di</strong> Servizi<br />
Fossalta<br />
<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
Realizzazione GIS con Intergraph GeoMe<strong>di</strong>a<br />
STUDIO LUCA ZANELLA INGEGNERE<br />
33100 UDINE v.le XXIII marzo n.19 stu<strong>di</strong>o@lzi.it<br />
<strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
Venezia<br />
San Dona' <strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
Jesolo<br />
P.A.T.<br />
REGIONE DEL VENETO<br />
DIREZIONE URBANISTICA<br />
PROVINCIA DI VENEZIA<br />
SETTORE DI PIANIFICAZIONE<br />
COMUNE DI MUSILE DI<br />
PIAVE<br />
IL SINDACO<br />
ON. GIANLUCA FORCOLIN<br />
RESPONSABILE AREA<br />
TECNICA DEL COMUNE<br />
DOTT. FRANCESCO BERGAMO<br />
PROGETTISTI:<br />
DOTT.PIAN.TERR.LE ALICE ZANELLA<br />
STUDIO ASSOCIATO ZANELLA<br />
ARCHITETTURA E URBANISTICA<br />
Via Vittime delle Foibe, 74/6<br />
36025 - Noventa Vicentina (VI)<br />
Tel. 0444 787040 – Fax 0444 787326<br />
info@stu<strong>di</strong>ozanella.it<br />
DOTT. ARCH. ROBERTO RAIMONDI<br />
Giudecca, 173<br />
30133 - VENEZIA<br />
Tel. e fax 041 5228283<br />
roraimon<strong>di</strong>@libero.i<br />
DATA: 28/02/2013
COMUNE DI MUSILE DI PIAVE<br />
PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO<br />
RELAZIONE GEOLOGICA<br />
Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura geologica, Compatibilità<br />
geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico<br />
INDICE<br />
1 INTRODUZIONE ...................................................................................................................................................... 3<br />
2 GEOLOGIA DEL TERRITORIO DI MUSILE DI PIAVE ............................................................................................ 5<br />
2.1 LA SINTESI EVOLUTIVA DELLA PIANURA TRA SILE E PIAVE .................................................................................... 5<br />
2.2 LE UNITÀ GEOLOGICHE NEL COMUNE DI MUSILE DI PIAVE .................................................................................... 8<br />
2.3 IL PALEOSUOLO DENOMINATO “CARANTO” ......................................................................................................... 18<br />
3 CARTA LITOLOGICA ............................................................................................................................................. 20<br />
3.1 DATI DI PARTENZA E METODOLOGIA DI REALIZZAZIONE ...................................................................................... 20<br />
3.2 LITOTIPI PREVALENTI ....................................................................................................................................... 21<br />
3.3 ELABORAZIONE DELLA CARTA LITOLOGICA ....................................................................................................... 22<br />
4 CARTA IDROGEOLOGICA .................................................................................................................................... 25<br />
4.1 IDROLOGIA DI SUPERFICIE ................................................................................................................................ 25<br />
4.1.1 Il bacino idrografico del fiume Sile .................................................................................................................................. 26<br />
4.1.2 Il bacino idrografico del fiume <strong>Piave</strong> ............................................................................................................................... 29<br />
4.2 INSUFFICIENZA IDRAULICA DEL PIAVE NEL TRATTO ARGINATO TRA NERVESA E IL MARE ....................................... 33<br />
4.3 ACQUE SOTTERRANEE..................................................................................................................................... 38<br />
4.4 ANALISI DEL RISCHIO IDRAULICO NEL BACINO DEL SILE ...................................................................................... 41<br />
4.5 VULNERABILITÀ DELLE RISORSE IDRICHE SOTTERRANEE ................................................................................... 43<br />
4.6 ELABORAZIONE DELLA CARTA IDROGEOLOGICA ................................................................................................ 44<br />
5 CARTA GEOMORFOLOGICA ............................................................................................................................... 46<br />
5.1 INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO .............................................................................................................. 47<br />
5.1.1 Lineamenti generali .......................................................................................................................................................... 47<br />
5.2 ELABORAZIONE DELLA CARTA GEOMORFOLOGICA ............................................................................................ 55<br />
6 FRAGILITÀ DERIVANTI DALL’ANALISI GEOLOGICA.......................................................................................... 61<br />
6.1 COMPATIBILITÀ GEOLOGICA AI FINI URBANISTICI ................................................................................................ 62<br />
6.2 AREE SOGGETTE A DISSESTO IDROGEOLOGICO ................................................................................................ 74<br />
7 GEOSITI ................................................................................................................................................................. 79<br />
7.1 MEANDRO ABBANDONATO DEL PIAVE ............................................................................................................... 79<br />
7.2 PALEOCANALI LAGUNARI .................................................................................................................................. 80<br />
1 <strong>di</strong> 83
Progetto: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio – RELAZIONE GEOLOGICA Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura<br />
geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico – Rev.:01<br />
Data: 28‐02‐2013 – Estensori: Prof. Geol. A. Bondesan, Dott.ssa S. Primon, Dott.ssa C. Levorato [Adastra srl]‐ Committente: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
INDICE ALLEGATI<br />
Allegato 1 Elaborazioni Cartografiche<br />
Allegato 2 Schede Geositi<br />
Allegato 3 Stratigrafie (allegato <strong>di</strong>gitale presente nel CD)<br />
Tavola c0501 Carta Litologica 1:15.000<br />
Tavola c0502 Carta Idrogeologica 1:15.000<br />
Tavola c0503 Carta Geomorfologica 1:15.000<br />
Tavola b0103 Compatibilità geologica 1:15.000<br />
LISTA DI DISTRIBUZIONE<br />
TAVOLE<br />
Nominativo Azienda Copie a<br />
stampa<br />
Copia ufficio Adastra srl = <br />
Dr. Francesco Bergamo <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> 3 <br />
2 <strong>di</strong> 83<br />
Copie<br />
<strong>di</strong>gitali<br />
Rev. Emissione Data Riesame Verifica Approvazione<br />
01 Relazione geologica 28/02/2013 FB GR AB<br />
00 Relazione geologica 19/12/2011 FB GR AB
Progetto: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio – RELAZIONE GEOLOGICA Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura<br />
geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico – Rev.:01<br />
Data: 28‐02‐2013 – Estensori: Prof. Geol. A. Bondesan, Dott.ssa S. Primon, Dott.ssa C. Levorato [Adastra srl]‐ Committente: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
1 Introduzione<br />
Nell’ambito del proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> redazione del Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio del <strong>Comune</strong> <strong>di</strong><br />
<strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong>, ai sensi della L. R. 23 aprile 2004, n.11 “Norme per il governo del territorio”, le attività a<br />
carattere geologico svolte possono essere sud<strong>di</strong>vise in due fasi:<br />
a. Quadro Conoscitivo<br />
b. Progetto<br />
Il quadro conoscitivo, Art.10 L.R. 11/2004, è il sistema integrato delle informazioni e dei dati<br />
necessari alla comprensione delle tematiche svolte dagli strumenti <strong>di</strong> pianificazione territoriale ed<br />
urbanistica e si compone <strong>di</strong> dati ed informazioni già in possesso delle Amministrazioni procedenti, <strong>di</strong><br />
nuove informazioni acquisite ed elaborate nella fase <strong>di</strong> formazione del Piano e <strong>di</strong> dati in possesso <strong>di</strong> altri<br />
Enti. La formazione del quadro conoscitivo deve intendersi come la costruzione <strong>di</strong> un catalogo <strong>di</strong><br />
informazioni sud<strong>di</strong>vise in ambiti tematici denominati Matrici, sud<strong>di</strong>vise a loro volta in livelli sempre più<br />
specifici: i Temi e i Sottotemi, comprensivi <strong>di</strong> Banche dati associate.<br />
Nell’ambito delle attribuzioni professionali <strong>di</strong> carattere geologico sono state portate a termine<br />
le seguenti elaborazioni:<br />
i. Matrice 05 Suolo e Sottosuolo;<br />
ii. Tema 0501‐Litologia, Sottotemi Litologia del substrato, Materiali della copertura colluviale ed<br />
eluviale, Materiali degli accumuli <strong>di</strong> frana, Materiali alluvionali, morenici fluvioglaciali,<br />
lacustri, palustri e litorali, Punti <strong>di</strong> indagine geognostica e geofisica;<br />
iii. Tema 0502‐Idrogeologia, Sottotema Idrologia <strong>di</strong> superficie e Acque sotterranee;<br />
iv. Tema 0503‐Geomorfologia, Sottotema Forme strutturali e vulcaniche, Forme <strong>di</strong> versante<br />
dovute alla gravità, Forme fluviali, Forme carsiche, Forme glaciali e forme crionivali, Forme<br />
eoliche, Forme <strong>di</strong> origine marina, lagunare e lacustre e Forme artificiali;<br />
v. Tema 0508‐Rischi Naturali.<br />
Per la definizione delle <strong>di</strong>verse voci dei sottotemi e per la restituzione grafica dei contenuti si è<br />
fatto riferimento al documento “Grafie Unificate per gli strumenti urbanistici comunali” <strong>di</strong> cui alla D.G.R.<br />
n. 615/1996.<br />
3 <strong>di</strong> 83
Progetto: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio – RELAZIONE GEOLOGICA Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura<br />
geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico – Rev.:01<br />
Data: 28‐02‐2013 – Estensori: Prof. Geol. A. Bondesan, Dott.ssa S. Primon, Dott.ssa C. Levorato [Adastra srl]‐ Committente: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
Il progetto rappresenta il riesame degli elementi strutturali contenuti nel quadro conoscitivo e<br />
si esplica nella creazione <strong>di</strong> elaborati cartografici <strong>di</strong> sintesi quali la Carta dei Vincoli, la Carta delle<br />
Invarianti, la Carta delle Fragilità e la Carta delle Trasformabilità.<br />
Sono state condotte le seguenti attività:<br />
i. in<strong>di</strong>viduazione, a partire dall’analisi geologica effettuata nel quadro conoscitivo, delle<br />
invarianti <strong>di</strong> natura litologica, geomorfologica e idrogeologica e dei geositi presenti nel<br />
territorio comunale;<br />
ii. analisi <strong>di</strong> Compatibilità geologica con sud<strong>di</strong>visione del territorio comunale in aree idonee,<br />
aree idonee a con<strong>di</strong>zione e aree non idonee, e perimetrazione delle aree soggette a <strong>di</strong>ssesto<br />
idrogeologico.<br />
Nell’ambito della redazione del quadro conoscitivo sono stati raccolti, catalogati e verificati i<br />
dati e le informazioni appartenenti a relazioni geologico‐tecniche, bibliografia scientifica e progetti <strong>di</strong><br />
analisi territoriale svolti da vari enti, quali ad esempio Consorzi <strong>di</strong> Bonifica, Autorità <strong>di</strong> Bacino, Regione,<br />
Provincia e dallo stesso <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> creando un archivio informatico <strong>di</strong> tutta la<br />
documentazione utilizzata denominato: DB_PAT_MUS.<br />
A tutti i documenti inseriti nel DB_PAT_MUS è stato associato un ID <strong>di</strong> riferimento composto<br />
dalla lettera D (documento) seguita da un numero progressivo (il primo documento inserito nell’archivio<br />
ha co<strong>di</strong>ce identificativo DB_PAT_MUS_D1 e così <strong>di</strong> seguito); all’allegato 1 è riportato il catalogo<br />
completo della documentazione con associati gli ID per facilitare la lettura e la comprensione delle<br />
banche dati.<br />
Per la matrice Suolo e Sottosuolo e i relativi temi sviluppati, nonché per le elaborazioni <strong>di</strong><br />
progetto quali vincoli, invarianti e fragilità sono stati redatti i metadati riferiti ai livelli informativi<br />
utilizzando la maschera <strong>di</strong> compilazione, standard ISO 19115 Ver 3.1 giugno 2007, in formato. xls fornita<br />
dalla Regione Veneto; i metadati sono dei documenti <strong>di</strong> identificazione e descrizione del contenuto <strong>di</strong> un<br />
insieme <strong>di</strong> dati che descrivono in maniera inequivocabile le informazioni temporali, qualitative, spaziali e<br />
gestionali <strong>di</strong> ciascun livello.<br />
Per lo svolgimento delle attività <strong>di</strong> analisi geologica e <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduazione degli elementi <strong>di</strong><br />
progetto del piano <strong>di</strong> assetto del territorio è stato istituito un gruppo <strong>di</strong> lavoro costituito da tecnici e<br />
professionisti <strong>di</strong> comprovata esperienza specifica.<br />
Tutti i dati sono stati elaborati me<strong>di</strong>ante l’utilizzo <strong>di</strong> software GIS, sono stati forniti in formato<br />
<strong>di</strong> interscambio shape e sono stati organizzati in classi (file shape) <strong>di</strong>stinte in base alla tipologia della<br />
primitiva geometrica (punto, linea, area), in riferimento agli Atti <strong>di</strong> In<strong>di</strong>rizzo relativi alla L.R. 11/2004.<br />
4 <strong>di</strong> 83
Progetto: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio – RELAZIONE GEOLOGICA Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura<br />
geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico – Rev.:01<br />
Data: 28‐02‐2013 – Estensori: Prof. Geol. A. Bondesan, Dott.ssa S. Primon, Dott.ssa C. Levorato [Adastra srl]‐ Committente: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
Sono stati stampati e forniti in formato cartaceo alla scala 1:10.000 i seguenti elaborati:<br />
i. c0501 Carta Litologica;<br />
ii. c0502 Carta Idrogeologica;<br />
iii. c0503 Carta Geomorfologica.<br />
iv. b0103 Carta della Compatibilità geologica.<br />
2 Geologia del territorio <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
[fonti principali: Bondesan & Meneghel (a cura <strong>di</strong>), (2004) Carta Geomorfologica della Provincia <strong>di</strong><br />
Venezia; Bondesan et alii, (2008) Carta delle Unità Geologiche della Provincia <strong>di</strong> Venezia]<br />
2.1 LA SINTESI EVOLUTIVA DELLA PIANURA TRA SILE E PIAVE<br />
Sulla scorta del quadro geologico generale e delle ricerche condotte nel tratto <strong>di</strong> pianura<br />
compreso tra Sile e <strong>Piave</strong> è possibile comporre una sintesi evolutiva dall’Ultimo Massimo Glaciale (LGM)<br />
a oggi.<br />
Ultimo Massimo Glaciale (22.000–15.000 anni a 14 C BP) – Durante l’ultimo massimo glaciale<br />
questo tratto <strong>di</strong> pianura era in accrescimento per effetto dei depositi abbandonati dal <strong>Piave</strong> che<br />
costruiva il megafan <strong>di</strong> Nervesa. Come è noto, la linea <strong>di</strong> costa si trovava in Adriatico in una posizione<br />
nettamente avanzata, tra Ancona e Pescara, a una quota <strong>di</strong> circa 120 m più bassa rispetto a oggi. I fiumi<br />
alpini possedevano portate molto più elevate <strong>di</strong> oggi a causa della grande <strong>di</strong>sponibilità dell’acqua <strong>di</strong><br />
fusione glaciale.<br />
La <strong>di</strong>sattivazione della pianura alluvionale probabilmente ebbe luogo alla fine del LGM. I<br />
principali elementi geomorfologici sussistono ancora oggi nel paesaggio attuale come forme relitte.<br />
Gli stu<strong>di</strong> paleobotanici condotti nell’area del Basso <strong>Piave</strong> (MIOLA et alii, 2003) e, in particolare,<br />
in un’area situata a ovest del territorio comunale (tenuta <strong>di</strong> Ca’ Tron) ha in<strong>di</strong>viduato un paesaggio a<br />
steppa (Poaceae, Artemisia, Chenopo<strong>di</strong>aceae, Caryophyllaceae) con scarsa copertura arborea (Pinus,<br />
Betula). Vaste torbiere ricoprivano la pianura per decine <strong>di</strong> chilometri quadrati, venendo<br />
perio<strong>di</strong>camente seppellite da eventi alluvionali. Nell’area <strong>di</strong> Ca’ Tron sembra essere documentato il<br />
succedersi <strong>di</strong> almeno quattro eventi se<strong>di</strong>mentari principali, intervallati da episo<strong>di</strong> <strong>di</strong> formazione <strong>di</strong> torbe,<br />
in un arco cronologico compreso tra 22.000 e 16.000 anni BP, che hanno portato alla deposizione <strong>di</strong><br />
oltre 15 m <strong>di</strong> se<strong>di</strong>menti. Questo meccanismo <strong>di</strong> aggradazione della pianura sembra essersi sviluppato<br />
durante il pleniglaciale con modalità molto simili in tutta la pianura veneto‐friulana.<br />
5 <strong>di</strong> 83
Progetto: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio – RELAZIONE GEOLOGICA Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura<br />
geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico – Rev.:01<br />
Data: 28‐02‐2013 – Estensori: Prof. Geol. A. Bondesan, Dott.ssa S. Primon, Dott.ssa C. Levorato [Adastra srl]‐ Committente: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
Quel che accadde tra il Pleistocene superiore e l’Olocene fino all’incirca al periodo Atlantico<br />
non è testimoniato dalle forme presenti in quest’area. Non sono stati riconosciuti infatti né eventi <strong>di</strong><br />
aggradazione, né <strong>di</strong> incisione, il che fa propendere per una sorta <strong>di</strong> stasi nei processi geomorfologici.<br />
Siamo del resto in una posizione molto marginale, al limite estremo dei due sistemi del Brenta e del<br />
<strong>Piave</strong>. Il primo non è più attivo dalla fine del Pleistocene, il secondo è in una fase <strong>di</strong> aggradazione che<br />
interessa maggiormente i tratti della pianura più orientali e più prossimi all’apice della conoide<br />
(BONDESAN A. & MOZZI, 2002).<br />
Olocene me<strong>di</strong>o: Atlantico e Sub–boreale (8000–2500 anni a 14 C BP) – La laguna <strong>di</strong> Venezia inizia<br />
a formarsi in seguito alla trasgressione flandriana che raggiunge il suo acme attorno a 6–5000 anni a 14 C<br />
BP. Il <strong>Piave</strong> scorreva da Caposile verso il Cenesa in un alveo incassato all’incirca 3000 anni a 14 C BP. Più o<br />
meno nello stesso periodo un ramo del <strong>Piave</strong> scendeva da Nervesa in destra idrografica, seguiva<br />
l’incisione dell’attuale Sile e confluiva nella laguna <strong>di</strong> Venezia. Dopo la <strong>di</strong>sattivazione, quin<strong>di</strong> a partire dal<br />
primo millennio a.C., il Sile assumeva l’attuale connotazione <strong>di</strong> fiume <strong>di</strong> risorgiva e costruiva il proprio<br />
dosso fluviale e il delta endolagunare.<br />
Il Cenesa, che è oggi uno dei principali canali lagunari presenti nella laguna settentrionale <strong>di</strong><br />
Venezia probabilmente drenava le acque dell’intero sistema idrografico compreso tra Sile e <strong>Piave</strong>.<br />
Dall’area tra Meolo e Sile si raccoglievano le acque dei fiumi Vallio e Meolo, lungo percorsi in parte<br />
<strong>di</strong>fferenti dagli attuali. I se<strong>di</strong>menti appartenenti a questo periodo prelevati presso l’attuale margine<br />
perilagunare sono <strong>di</strong> origine fluviale, ed è quin<strong>di</strong> molto probabile che la laguna nord <strong>di</strong> Venezia fosse<br />
almeno parzialmente emersa e occupata da una pianura alluvionale costiera. Sulle superfici planiziali del<br />
LGM la pedogenesi progre<strong>di</strong>va determinando la formazione <strong>di</strong> calcisuoli.<br />
La prima presenza umana risale al Mesolitico con i cacciatori–raccoglitori del Sauvetteriano e<br />
del Castelnoviano, con ritrovamenti che si estendono al neolitico e all’eneolitico (BROGLIO, FAVERO &<br />
MARSALE, 1987).<br />
Le datazioni al carbonio 14 relative al ponte ligneo rinvenuto lungo il ramo più antico della via<br />
Annia suggeriscono la presenza <strong>di</strong> strutture <strong>di</strong> attraversamento dell’alveo già durante l’età del Bronzo<br />
finale e <strong>di</strong>mostrano la probabile esistenza <strong>di</strong> una viabilità strutturata nel periodo veneto antico.<br />
Olocene superiore: Subatlantico (2500–0 anni a 14 C BP) – Si forma un reticolo idrografico minore<br />
alimentato dalle risorgive e dalle acque <strong>di</strong> ruscellamento. L’attività geomorfologica è limitata ed è<br />
improntata sulla morfologia pleistocenica ere<strong>di</strong>tata. L’aumento eustatico del livello del mare e la<br />
subsidenza producono una generale retrocessione verso la terraferma del margine lagunare. Dal I<br />
millennio a.C. all’età romana la pianura era attraversata da fiumi <strong>di</strong> risorgiva dei quali è rimasta oggi<br />
traccia sulla superficie della pianura. Il Musestre poteva deviare verso il paleoalveo della Canna, seguire<br />
6 <strong>di</strong> 83
Progetto: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio – RELAZIONE GEOLOGICA Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura<br />
geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico – Rev.:01<br />
Data: 28‐02‐2013 – Estensori: Prof. Geol. A. Bondesan, Dott.ssa S. Primon, Dott.ssa C. Levorato [Adastra srl]‐ Committente: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
il canale Fossonetto, il canale Fosson e il canale Lanzoni; il Vallio poteva essere collegato allo scolo<br />
Arnasa e all’attuale Vallio a ovest <strong>di</strong> Meolo. L’Arnasa nasceva probabilmente a sud del paleoalveo San<br />
Cipriano–Meolo, dove anche oggi il microrilievo ci mostra l’esistenza <strong>di</strong> una depressione nella pianura<br />
aperta verso sud–est che poteva incanalare anche in passato le acque superficiali. Il paleo–Vallio doveva<br />
proseguire verso Marteggia e collegarsi al Lanzoni attraverso il canale Canellara, dopo aver superato il<br />
ponte sull’Annia; il Meolo, come è testimoniato dai due ponti sull’Annia, proveniva dall’abitato <strong>di</strong><br />
Meolo, seguiva il Colatore e a La Fossetta si collegava anch’esso al reticolo del Lanzoni (BONDESAN A. &<br />
MOZZI, 2002c). I ponti romani sono descritti in Croce da Villa (a cura <strong>di</strong>, 1990).<br />
La presenza umana nell’età del Ferro è confermata dalla locale deforestazione. Il mancato<br />
ritrovamento nei campioni analizzati <strong>di</strong> pollini <strong>di</strong> vegetazione ripariale (bosco idrofilo, canna palustre)<br />
potrebbe essere imputata sia alla presenza <strong>di</strong> suoli ben drenati che alla manutenzione degli alvei da<br />
parte dell’uomo. Gli spettri pollinici confermano la presenza <strong>di</strong> pratiche agricole e <strong>di</strong> allevamento.<br />
In età romana la costruzione della via Annia nel 153 a.C. (o 131 a.C., la data non è certa)<br />
probabilmente lungo un antico tracciato viario dell’età del Bronzo e successivamente del Ferro<br />
determina un aumento della pressione antropica e del governo idraulico e agricolo del territorio. Le<br />
tracce geometriche attribuibili a lineamenti antropici che hanno lasciato la loro impronta sul terreno<br />
sono molto numerose e sono probabilmente in connessione con l’uso antico del territorio.<br />
Nel I secolo d.C. il ricoprimento della via Annia esterna da parte <strong>di</strong> se<strong>di</strong>menti lagunari consente<br />
<strong>di</strong> stabilire un evento <strong>di</strong> risalita relativa del livello marino che probabilmente è la causa della costruzione<br />
successiva della variante stradale più interna nella seconda metà del I secolo a.C. Se la strada<br />
precedente era <strong>di</strong> terra battuta (sfruttando il caranto abbondantemente presente nell’area), il nuovo<br />
tracciato viene realizzato in rilevato, con sede stradale inghiaiata e ponti in pietra in corrispondenza<br />
degli attraversamenti fluviali.<br />
Me<strong>di</strong>o Evo e Rinascimento – Gli spettri pollinici stu<strong>di</strong>ati in<strong>di</strong>cano una progressiva riduzione dei<br />
boschi a quercia e un contemporaneo aumento dell’agricoltura (orzo, avena e frumento) e<br />
dell’allevamento <strong>di</strong> bestiame. A partire dal IV secolo d.C. vi sono testimonianze geologiche e<br />
archeologiche <strong>di</strong> una ingressione lagunare avvenuta in età me<strong>di</strong>evale. I campioni <strong>di</strong> se<strong>di</strong>menti lagunari<br />
confermano questa ingressione che ha caratterizzato l’intero tratto costiero alto adriatico. Gli alvei<br />
fluviali vengono occupati dalle acque lagunari e costituiscono delle vie preferenziali <strong>di</strong> ingressione.<br />
Età Moderna – Questo tratto <strong>di</strong> pianura è stato interessato da deviazioni fluviali e da<br />
trasformazioni delle rete idraulica molto consistenti. Il primo intervento risale al progetto della Fossetta<br />
che, dal 1441, metteva in comunicazione Sile e <strong>Piave</strong>, collegando Fossalta <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> al Meolo, al Vallio e al<br />
Sile attraverso il quale gli idraulici veneziani estromisero nel 1683 le acque del fiume dalla laguna,<br />
7 <strong>di</strong> 83
Progetto: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio – RELAZIONE GEOLOGICA Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura<br />
geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico – Rev.:01<br />
Data: 28‐02‐2013 – Estensori: Prof. Geol. A. Bondesan, Dott.ssa S. Primon, Dott.ssa C. Levorato [Adastra srl]‐ Committente: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
inalveando artificialmente il corso d’acqua nella <strong>Piave</strong> Vecchia. Questo intervento fu accompagnato<br />
anche da un rior<strong>di</strong>no della rete idrografica minore attraverso la costruzione <strong>di</strong> manufatti idraulici e<br />
l’esecuzione <strong>di</strong> interventi non coor<strong>di</strong>nati che hanno mo<strong>di</strong>ficato nel tempo l’assetto idraulico. Il XIX e il XX<br />
secolo sono gli anni delle gran<strong>di</strong> bonifiche idrauliche che consentono <strong>di</strong> recuperare per scopi agricoli<br />
vaste porzioni del territorio oggi al <strong>di</strong> sotto del livello del mare. La falda freatica viene mantenuta<br />
artificialmente depressa attraverso il sollevamento idraulico a opera degli impianti idrovori, ma il<br />
carattere anfibio della gronda lagunare rimane ancora molto evidente dalle tessiture, dall’altimetria e<br />
dal reticolo dei paleoalvei rappresentati nella carta geomorfologica.<br />
2.2 LE UNITÀ GEOLOGICHE NEL COMUNE DI MUSILE DI PIAVE<br />
L’assetto geologico del comune <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> è strettamente connesso alla storia<br />
quaternaria e alla successione deposizionale recente. In figura 1 sono riportate le unità geologiche che<br />
caratterizzano questa porzione <strong>di</strong> territorio, tratte dalla Carta delle Unità Geologiche della Provincia <strong>di</strong><br />
Venezia (Bondesan et alii, 2008). Il territorio comunale <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> è costituito dalle unità<br />
geologiche <strong>di</strong> Meolo, S. Donà <strong>di</strong> <strong>Piave</strong>, Caposile e Montiron.<br />
Figura 1: Unità geologiche nel <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong>.<br />
8 <strong>di</strong> 83
Progetto: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio – RELAZIONE GEOLOGICA Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura<br />
geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico – Rev.:01<br />
Data: 28‐02‐2013 – Estensori: Prof. Geol. A. Bondesan, Dott.ssa S. Primon, Dott.ssa C. Levorato [Adastra srl]‐ Committente: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
In particolare, il tratto <strong>di</strong> pianura esaminato è interessato dai depositi alluvionali del <strong>Piave</strong><br />
pertinenti all’ala destra del megafan <strong>di</strong> Nervesa (figura 2). L’età della pianura è relativamente antica con<br />
terreni appartenenti al Pleistocene superiore (unità <strong>di</strong> Meolo), ai quali sono sovrapposti lembi ristretti<br />
ed esigui <strong>di</strong> coperture più recenti deposte dallo stesso <strong>Piave</strong> (unità <strong>di</strong> Losson, Caposile, Cittanova e S.<br />
Donà <strong>di</strong> <strong>Piave</strong>) e dai fiumi <strong>di</strong> risorgiva, in particolare Musestre, Vallio e Meolo. La morfogenesi è stata<br />
controllata dalle oscillazioni relative del livello marino che hanno comportato avanzamenti e<br />
arretramenti del margine interno delle lagune (unità <strong>di</strong> Montiron e Caorle) e dalle fasi <strong>di</strong> incisione o<br />
deposizione fluviale, legate sia alle variazioni del livello <strong>di</strong> base che alla <strong>di</strong>namica se<strong>di</strong>mentaria del<br />
bacino. Verranno <strong>di</strong> seguito descritte le unità geologiche affioranti all’interno del territorio comunale <strong>di</strong><br />
<strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong>.<br />
Figura 2: Stralcio della Carta delle Unità Geologiche della Provincia <strong>di</strong> Venezia (Bondesan et alii, 2008). Di seguito è riportata la legenda.<br />
9 <strong>di</strong> 83
Progetto: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio – RELAZIONE GEOLOGICA Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura<br />
geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico – Rev.:01<br />
Data: 28‐02‐2013 – Estensori: Prof. Geol. A. Bondesan, Dott.ssa S. Primon, Dott.ssa C. Levorato [Adastra srl]‐ Committente: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
10 <strong>di</strong> 83
Progetto: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio – RELAZIONE GEOLOGICA Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura<br />
geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico – Rev.:01<br />
Data: 28‐02‐2013 – Estensori: Prof. Geol. A. Bondesan, Dott.ssa S. Primon, Dott.ssa C. Levorato [Adastra srl]‐ Committente: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
L’unità <strong>di</strong> Meolo corrisponde alla porzione <strong>di</strong> pianura collocata tra i dossi del Sile e del <strong>Piave</strong>,<br />
all’interno della quale il dosso <strong>di</strong> Meolo costituisce l’elemento maggiormente rilevato. Si tratta <strong>di</strong> una<br />
culminazione poco pronunciata, orientata in senso NW‐SE, isolata, che manifesta una prosecuzione da<br />
monte attraverso l’affioramento <strong>di</strong> sabbie, mentre si apre a valle in un ventaglio generato<br />
probabilmente dagli spostamenti laterali <strong>di</strong> antichi corsi fluviali. Alcune tracce allungate e ben definite<br />
proseguono verso est, oltre La Fossetta e potrebbero essere collegate agli antichi percorsi del Meolo.<br />
L’origine del dosso <strong>di</strong> Meolo è collegata a un’importante <strong>di</strong>ramazione <strong>di</strong> un <strong>Piave</strong> pleistocenico<br />
o olocenico antico che già si era <strong>di</strong>sattivato almeno 8000 anni fa; Castiglioni & Favero (1987) lo collegano<br />
alle tracce <strong>di</strong> Rovarè e Monastier. In superficie si osservano dossi fluviali generalmente molto blan<strong>di</strong>,<br />
sabbiosi, separati da piane alluvionali a tessitura prevalentemente limoso argillosa.<br />
Figura 3: transetto n.17 Cà Tron.<br />
Nel sottosuolo l’unità <strong>di</strong> Meolo è caratterizzata dalla presenza <strong>di</strong> numerosi corpi <strong>di</strong> canale (ve<strong>di</strong><br />
transetto Cà Tron, n.17 nella Carta delle Unità Geologiche della Provincia <strong>di</strong> Venezia, figura 3)<br />
riconoscibili attraverso la presenza <strong>di</strong> lenti sabbiose o sabbioso‐limose, solitamente spesse 2‐3 m,<br />
scarsamente interconnesse e separate da se<strong>di</strong>menti limoso‐argillosi <strong>di</strong> piana <strong>di</strong>stale. Tale architettura<br />
11 <strong>di</strong> 83
Progetto: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio – RELAZIONE GEOLOGICA Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura<br />
geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico – Rev.:01<br />
Data: 28‐02‐2013 – Estensori: Prof. Geol. A. Bondesan, Dott.ssa S. Primon, Dott.ssa C. Levorato [Adastra srl]‐ Committente: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
se<strong>di</strong>mentaria corrisponde ad un sistema deposizionale generatosi per successive avulsioni a monte dei<br />
corsi fluviali antichi. Una caratteristica interessante è la grande abbondanza <strong>di</strong> sottili livelli torbosi che<br />
<strong>di</strong>mostrano una elevata estensione laterale. Essi sono stati generati, con ogni probabilità, durante il<br />
Pleistocene quando le piene dei fiumi pensili, alimentati dalle acque glaciali, erano in grado <strong>di</strong><br />
mantenere elevata la falda superficiale generando in tal modo estese torbiere all’interno delle<br />
depressioni mal drenate della pianura. A causa degli elevati ratei <strong>di</strong> aggradazione, alcune torbiere furono<br />
attive solo per pochi secoli, prima <strong>di</strong> essere sepolte dai depositi alluvionali. Tali torbiere sono note in<br />
tutta la pianura veneta su estensioni che superano anche le decine <strong>di</strong> chilometri quadrati. Le numerose<br />
ra<strong>di</strong>odatazioni <strong>di</strong>sponibili <strong>di</strong>mostrano che i depositi si sono formati nell’Ultimo Massimo Glaciale (LGM)<br />
con spessore compresi generalmente tra 15 e 30 m e con tassi <strong>di</strong> accrescimento pari a 2‐3 mm/anno con<br />
picchi <strong>di</strong> 10 mm/anno (Bondesan et al., 2002, 2004a; Bondesan & Meneghel, 2004, Fontana et al., 2008).<br />
L’unità <strong>di</strong> S. Donà <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> fa capo principalmente all’ampio dosso del <strong>Piave</strong> e a due sue<br />
principali <strong>di</strong>ramazioni che si <strong>di</strong>partono dal centro abitato <strong>di</strong> S. Donà. La più orientale è costituita dal<br />
Taglio <strong>di</strong> Cortellazzo (alla quale è aggregata la <strong>di</strong>rettrice del Taglio da Re) e la più occidentale dalla <strong>Piave</strong><br />
Vecchia (ora alveo del Sile).<br />
Le età, e conseguentemente lo spessore dei depositi superficiali afferenti al dosso, sono<br />
<strong>di</strong>verse. Risulta molto più antico il tratto a monte <strong>di</strong> S. Donà <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> (almeno pre‐romano), mentre risale<br />
al VI sec. d.C. l’inizio della formazione del ramo della <strong>Piave</strong> Vecchia, forse in conseguenza <strong>di</strong> una rotta. La<br />
torba, datata alla base del dosso in prossimità <strong>di</strong> Caposile, ha fornito un’età calibrata pari a 530‐680 d.C.<br />
Il Taglio da Re si colloca tra <strong>Piave</strong> Vecchia e <strong>Piave</strong> <strong>di</strong> Cortellazzo e corrisponde al <strong>di</strong>versivo realizzato nel<br />
1534; del vecchio alveo rimane traccia in un modesto canale <strong>di</strong> bonifica. All’altezza <strong>di</strong> Eraclea il dosso si<br />
appiattisce, mentre prosegue la fascia sabbiosa corrispondente alla <strong>di</strong>rettrice fluviale.<br />
L’alveo attuale del <strong>Piave</strong>, terminato <strong>di</strong> scavare nel 1664, scorre rettilineo fino ad Eraclea, dove il<br />
tracciato si inserisce in un più antico percorso a meandri. Il dosso risulta ampio 2‐3 km e alto circa 3 m<br />
sui terreni circostanti; risulta ben elevato fino a Eraclea, per poi decrescere da lì fino alla foce.<br />
Il modello geologico generale prevede un corpo dossivo sabbioso‐limoso, <strong>di</strong> spessore e<br />
ampiezza variabili, allineato lungo le <strong>di</strong>rettrici fluviali. In profon<strong>di</strong>tà, dove si incontrano le unità <strong>di</strong> Caorle<br />
e <strong>di</strong> Meolo, più corpi <strong>di</strong> canale si alternano a se<strong>di</strong>menti fini <strong>di</strong> piana alluvionale, con i quali mostrano una<br />
eteropia laterale; orizzonti centimetrici suborizzontali testimoniano paleo superfici correlabili<br />
lateralmente anche per alcuni chilometri.<br />
12 <strong>di</strong> 83
Progetto: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio – RELAZIONE GEOLOGICA Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura<br />
geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico – Rev.:01<br />
Data: 28‐02‐2013 – Estensori: Prof. Geol. A. Bondesan, Dott.ssa S. Primon, Dott.ssa C. Levorato [Adastra srl]‐ Committente: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
Figura 4: transetto n.10 Ferrovia.<br />
Transetto n. 10 (Ferrovia), figura 4 ‐ In corrispondenza dell’attraversamento dell’alveo attuale a<br />
San Donà <strong>di</strong> <strong>Piave</strong>, a partire da almeno ‐35 m s.l.m., sono presenti sequenze <strong>di</strong> corpi <strong>di</strong> canale costituiti<br />
da sabbie me<strong>di</strong>e e fini con spessori fino a 10 m circa e sviluppo laterale superiore ai 100 m (unità <strong>di</strong><br />
Meolo e <strong>di</strong> Caorle). In profili vicini (non rappresentati in questo volume) si sono osservati spessori delle<br />
sabbie fino a 20 m). Talora sono segnalati alla base elementi ghiaiosi. I depositi sabbiosi sono intercalati<br />
da orizzonti sottili, decimetrici, prevalentemente limoso‐argillosi. Lateralmente, sequenze <strong>di</strong> se<strong>di</strong>menti<br />
fini, prevalentemente argilloso‐limose, danno luogo a depositi <strong>di</strong> piana alluvionale che sono in eteropia<br />
con i corpi <strong>di</strong> canale al <strong>di</strong> sotto dell’attuale tracciato fluviale, suggerendo una possibile stabilità (o<br />
ricorrenza) del percorso del <strong>Piave</strong> nel corso dell’Olocene e, probabilmente, <strong>di</strong> parte del Pleistocene<br />
superiore. A ‐33 m si osservano orizzonti torbosi centimetrici che fungono da marker stratigrafico<br />
correlato ai vicini transetti stratigrafici (n. 11 e 12), probabilmente <strong>di</strong> età pre‐LGM.<br />
13 <strong>di</strong> 83
Progetto: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio – RELAZIONE GEOLOGICA Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura<br />
geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico – Rev.:01<br />
Data: 28‐02‐2013 – Estensori: Prof. Geol. A. Bondesan, Dott.ssa S. Primon, Dott.ssa C. Levorato [Adastra srl]‐ Committente: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
Transetto n. 11 (Taglio della <strong>Piave</strong>), figura 5 ‐ I depositi superficiali corrispondenti agli o<strong>di</strong>erni<br />
dossi del <strong>Piave</strong> <strong>di</strong> Cortellazzo e del Canale Taglio da Re sono costituiti da riporti artificiali e depositi<br />
sabbiosi, talora limosi, debolmente sviluppati (1‐2 m). I se<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> argine risultano essere rimaneggiati<br />
in virtù della loro origine antropica. Durante il XVI e il XVII secolo il Taglio da Re prima, e il Taglio <strong>di</strong><br />
Cortellazzo poi, <strong>di</strong>vennero infatti i nuovi percorsi del <strong>Piave</strong> che, escluso dall’alveo della <strong>Piave</strong> Vecchia,<br />
venne portato a defluire nel Gran Lago della <strong>Piave</strong> e quin<strong>di</strong>, dopo la rotta della Landrona (1683), presso<br />
l’attuale foce <strong>di</strong> Cortellazzo. I nuovi alvei, con i relativi rilevati arginali, furono creati ex‐novo, tagliando<br />
la piana paludosa che si estendeva a valle <strong>di</strong> S. Donà, come si evince dalle torbe e dai depositi fini. Le<br />
sequenze se<strong>di</strong>mentarie mostrano anche l’unità <strong>di</strong> Caorle e la sottostante unità <strong>di</strong> Meolo che sono<br />
caratterizzate dalla presenza <strong>di</strong> corpi <strong>di</strong> canale che si sono accresciuti sia al <strong>di</strong> sotto del tracciato attuale,<br />
che più a est. Il grande deposito sabbioso tra i ‐14 e i ‐26 m (unità <strong>di</strong> Meolo) potrebbe essere generato<br />
dalla coalescenza <strong>di</strong> più rami fluviali o dalla migrazione laterale dell’alveo in fase <strong>di</strong> accrescimento. La<br />
maggior estensione del profilo consente <strong>di</strong> definire meglio le tipiche architetture se<strong>di</strong>mentarie date da<br />
corpi <strong>di</strong> canale prevalentemente sabbiosi e sabbioso‐limosi passanti lateralmente a sequenze <strong>di</strong> piana<br />
alluvionale a tessitura prevalentemente fine. I sottili livelli torbosi sono parte <strong>di</strong> orizzonti facilmente<br />
correlabili data la loro notevole estensione laterale.<br />
14 <strong>di</strong> 83
Progetto: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio – RELAZIONE GEOLOGICA Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura<br />
geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico – Rev.:01<br />
Data: 28‐02‐2013 – Estensori: Prof. Geol. A. Bondesan, Dott.ssa S. Primon, Dott.ssa C. Levorato [Adastra srl]‐ Committente: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
Figura 5: transetto n.11 Taglio della <strong>Piave</strong> (legenda in fig. 4).<br />
Transetto n. 12 (<strong>Piave</strong> Vecchia), figura 6 ‐ Il dosso sabbioso della <strong>Piave</strong> Vecchia mostra spessori<br />
fino a 8 m, estendendosi lateralmente per più <strong>di</strong> un chilometro. Il deposito pertinente al dosso si colloca<br />
al <strong>di</strong> sopra <strong>di</strong> se<strong>di</strong>menti fini <strong>di</strong> piana alluvionale fino a ‐10/‐12 m. Sequenze sabbiose <strong>di</strong> corpi <strong>di</strong> canale si<br />
susseguono più in basso, secondo lo schema deposizionale già descritto, intervallati da depositi torbosi<br />
centimetrici/decimetrici. Le sabbie risultano percentualmente più abbondanti rispetto al settore<br />
rappresentato dal transetto n. 11.<br />
15 <strong>di</strong> 83
Progetto: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio – RELAZIONE GEOLOGICA Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura<br />
geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico – Rev.:01<br />
Data: 28‐02‐2013 – Estensori: Prof. Geol. A. Bondesan, Dott.ssa S. Primon, Dott.ssa C. Levorato [Adastra srl]‐ Committente: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
Figura 6: transetto n.12 <strong>Piave</strong> Vecchia (legenda in fig. 4).<br />
Figura 7: transetto n.13 CPS (legenda in fig. 4).<br />
16 <strong>di</strong> 83
Progetto: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio – RELAZIONE GEOLOGICA Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura<br />
geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico – Rev.:01<br />
Data: 28‐02‐2013 – Estensori: Prof. Geol. A. Bondesan, Dott.ssa S. Primon, Dott.ssa C. Levorato [Adastra srl]‐ Committente: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
L’unità <strong>di</strong> Caposile è caratterizzata da depositi alluvionali costituiti da sabbie e sabbie limose <strong>di</strong><br />
canale con spessore <strong>di</strong> almeno 3 m; al tetto sono presenti limi, limi argillosi e argille limose, talora con<br />
sostanza organica e livelli <strong>di</strong> torba, che corrispondono a facies <strong>di</strong> canale abbandonato e <strong>di</strong> piana<br />
inondabile. A partire da Caposile si osserva un paleoalveo molto evidente <strong>di</strong>staccarsi dal dosso della<br />
<strong>Piave</strong> Vecchia. Tale antico percorso non conserva alcun rilievo morfologico, ma la sua connessione<br />
genetica con l’alveo della <strong>Piave</strong> Vecchia sembra essere suggerita dallo sviluppo planimetrico dei due<br />
rami.<br />
Attraverso le fotografie aeree, si osserva come la fascia del paleoalveo sia solcata all’interno da<br />
una traccia più scura, che tipicamente è connessa alla <strong>di</strong>sattivazione e conseguente chiusura del sistema<br />
(“tappo argilloso”). I carotaggi condotti in sito, che hanno consentito <strong>di</strong> ricostruire il transetto n. 13<br />
(Transetto CPS), figura 7, confermano l’osservazione.<br />
Il corpo sabbioso, largo più <strong>di</strong> 100 m, taglia due orizzonti torbosi sub orizzontali. Il livello<br />
inferiore <strong>di</strong> torba è stato datato con il metodo del ra<strong>di</strong>ocarbonio e ha fornito un’età calibrata <strong>di</strong> 1390‐<br />
1540 anni a.C. (3200±50 anni BP). I depositi argillosi e limoso‐argillosi che ospitano il riempimento<br />
d’alveo risultano ricchi <strong>di</strong> sostanza organica e <strong>di</strong> resti conchigliari.<br />
L’ipotesi più atten<strong>di</strong>bile è che si tratti <strong>di</strong> un antico percorso, attivatosi nel secondo millennio<br />
a.C., che poneva in connessione le acque del <strong>Piave</strong> con l’apparato del canale lagunare Cenesa. Tale<br />
ipotesi pare del resto confermata dalla presenza <strong>di</strong> corpi sabbiosi riconducibili al <strong>Piave</strong> in<strong>di</strong>viduati da E.<br />
Canal alla base dello stesso Canale Cenesa (Bondesan & Meneghel, 2004). Le <strong>di</strong>mensioni dell’alveo<br />
potevano essere comparabili con l’o<strong>di</strong>erno percorso fluviale.<br />
L’unità <strong>di</strong> Montiron è formata da depositi lagunari caratterizzati prevalentemente da facies <strong>di</strong><br />
fondo lagunare ‐ piana intertidale e <strong>di</strong> palude salmastra (barene/salt marsh), con evidenza <strong>di</strong> fluttuazioni<br />
nella salinità dell’acqua legate all’alterno influsso dei fiumi che sfociavano in laguna.<br />
All’interno dell’unità <strong>di</strong> Montiron, il settore compreso tra il Canale Fossetta e il Taglio del Sile è<br />
caratterizzato dalla presenza <strong>di</strong> numerosi paleocanali lagunari che in alcuni casi, hanno riutilizzato gli<br />
alvei dei fiumi provenienti da NW (Vallio e Meolo), risalendo così l’entroterra attraverso percorsi<br />
predefiniti. In questo settore i se<strong>di</strong>menti lagunari raggiungono lo spessore <strong>di</strong> qualche metro solo<br />
all’interno degli alvei fluviali, mentre esternamente lo spessore dei se<strong>di</strong>menti è molto ridotto (massimo<br />
1‐2 m). L’ingressione lagunare in quest’area viene fatta risalire all’età alto me<strong>di</strong>evale (Bondesan &<br />
Mozzi, 2002).<br />
17 <strong>di</strong> 83
Progetto: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio – RELAZIONE GEOLOGICA Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura<br />
geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico – Rev.:01<br />
Data: 28‐02‐2013 – Estensori: Prof. Geol. A. Bondesan, Dott.ssa S. Primon, Dott.ssa C. Levorato [Adastra srl]‐ Committente: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
2.3 IL PALEOSUOLO DENOMINATO “CARANTO”<br />
Alla luce degli stu<strong>di</strong> effettuati (Matteotti, 1962; Gatto & Previatello, 1974; Gatto, 1980; 1984;<br />
Mozzi et al., 2003), si può affermare che con il termine caranto nell’area lagunare veneziana si identifica<br />
un livello ubicato alla base dei depositi lagunari, posto al tetto della sottostante serie alluvionale. Questo<br />
intervallo, me<strong>di</strong>amente spesso 1‐2 m, è costituito da limi argillosi e argille notevolmente compatti, con<br />
colorazioni screziate dall’ocra al grigio e comuni noduli carbonatici duri con <strong>di</strong>ametro da pochi millimetri<br />
a 1–2 cm. La sua tipica sovraconsolidazione è da imputarsi alla pedogenesi.<br />
I tempi <strong>di</strong>sponibili per la formazione del caranto vanno dalla <strong>di</strong>sattivazione del sistema fluviale,<br />
presumibilmente avvenuta tra 14.500 e 10.000 a 14 C BP, e l’arrivo dell’ingressione marina. Quest’ultima<br />
avvenne precocemente (6000 – 5000 a 14 C BP) nei settori litoranei, e solo successivamente in quelli più<br />
interni; anche le zone dell’alto morfologico pleistocenico, segnalato nel sottosuolo del Lido, potrebbero<br />
essere state raggiunte tar<strong>di</strong>vamente dalla trasgressione rispetto alle aree depresse circostanti. Il caranto<br />
è dunque un marker stratigrafico del limite Pleistocene/Olocene, ma la lacuna se<strong>di</strong>mentaria che<br />
rappresenta copre ambiti temporali <strong>di</strong>versi a seconda delle località considerate.<br />
Le interruzioni nell’estensione delle aree a caranto sono interpretabili in termini <strong>di</strong> variazioni<br />
delle caratteristiche geopedologiche del substrato alluvionale pleistocenico, su cui si è sviluppata la<br />
medesima fase pedogenetica. Non è necessario ipotizzare episo<strong>di</strong> <strong>di</strong> incassamento del reticolo fluviale e<br />
conseguente erosione localizzata del caranto per spiegare la sua <strong>di</strong>scontinua <strong>di</strong>stribuzione areale.<br />
Ovviamente, dove si fossero effettivamente verificati questi processi <strong>di</strong> incassamento l'erosione ha<br />
asportato l'eventuale orizzonte <strong>di</strong> caranto.<br />
In ultimo, si ricorda che il vocabolo caranto non è <strong>di</strong> estrazione scientifica, e il suo utilizzo non si<br />
limita all’area lagunare. Infatti, si tratta <strong>di</strong> un termine tra<strong>di</strong>zionale che, nelle campagne venete, in<strong>di</strong>ca<br />
suoli agrari <strong>di</strong> <strong>di</strong>fficile arabilità, solitamente a causa <strong>di</strong> noduli e croste carbonatiche. Questo a volte può<br />
generare una certa confusione, essendo il termine caranto riferito a suoli o paleosuoli <strong>di</strong> età e origine<br />
anche molto <strong>di</strong>versa.<br />
Infatti, in tutta la pianura veneto‐friulana i suoli sviluppatisi sulla pianura LGM e ancora<br />
affioranti, o coperti dai se<strong>di</strong>menti costieri e alluvionali durante l'Olocene possiedono caratteristiche<br />
comparabili con quelle del caranto del sottosuolo della laguna <strong>di</strong> Venezia e, ormai, è <strong>di</strong>venuta prassi<br />
definire questi profili pedologici o i loro orizzonti carbonatici con il termine caranto. Agronomi, pedologi,<br />
ma anche geologi e archeologi, operanti nella pianura veneta spesso lo usano nelle loro relazioni, per<br />
in<strong>di</strong>care genericamente la presenza <strong>di</strong> orizzonti <strong>di</strong> accumulo dei carbonati e in vari casi anche per suoli<br />
meno sviluppati <strong>di</strong> quelli presenti al top della sequenza alluvionale LGM.<br />
18 <strong>di</strong> 83
Progetto: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio – RELAZIONE GEOLOGICA Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura<br />
geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico – Rev.:01<br />
Data: 28‐02‐2013 – Estensori: Prof. Geol. A. Bondesan, Dott.ssa S. Primon, Dott.ssa C. Levorato [Adastra srl]‐ Committente: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
Il livello denominato caranto inteso come marker stratigrafico del limite Pleistocene/Olocene, è<br />
rappresentato nella carta della quota della base dei depositi post‐LGM (Bondesan et alii, 2008, figura 8).<br />
Questa carta è stata realizzata interpolando manualmente i dati relativi alla profon<strong>di</strong>tà, riferita al livello<br />
me<strong>di</strong>o mare, della base dei depositi post‐LGM prendendo in considerazione tutte le in<strong>di</strong>cazioni che<br />
mettono in evidenza il limite tra i depositi pleistocenici e i sovrastanti depositi olocenici. In particolare<br />
sono stati selezionati e analizzati tutti i sondaggi con in<strong>di</strong>cata la presenza del caranto (inteso come<br />
paleosuolo pleistocenico) e, inoltre, sono state utilizzate tutte le datazioni ra<strong>di</strong>ometriche che<br />
evidenziano il contatto tra depositi <strong>di</strong> età pleistocenica e depositi <strong>di</strong> età olocenica.<br />
Per il settore del territorio provinciale veneziano che ricade in terraferma sono stati analizzati i<br />
dati stratigrafici inseriti nella banca dati delle indagini geognostiche della provincia <strong>di</strong> Venezia, mentre<br />
per l’area del Portogruarese i dati sono stati confrontati e integrati con quelli relativi alla profon<strong>di</strong>tà<br />
della base del Sintema del Po riportati nel foglio CARG 107 “Portogruaro” (Bondesan et al., in stampa).<br />
In sintesi, la superficie rappresentata nella carta riflette le caratteristiche topografiche della<br />
pianura tardo‐pleistocenica al momento della <strong>di</strong>sattivazione dei processi fluviali, in parte rimodellata<br />
dalla successiva trasgressione marina e dai processi <strong>di</strong> subsidenza ancora in atto. Il settore contrad<strong>di</strong>sto<br />
in giallo rappresenta la pianura pleistocenica affiorante e nel caso della porzione compresa nel territorio<br />
comunale <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong>, corrisponde all’unità <strong>di</strong> Meolo.<br />
Figura 8: Stralcio della Carta della quota della base dei depositi post-LGM (Bondesan et alii, 2008).<br />
19 <strong>di</strong> 83
Progetto: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio – RELAZIONE GEOLOGICA Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura<br />
geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico – Rev.:01<br />
Data: 28‐02‐2013 – Estensori: Prof. Geol. A. Bondesan, Dott.ssa S. Primon, Dott.ssa C. Levorato [Adastra srl]‐ Committente: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
La base dei depositi post‐LGM all’interno del territorio provinciale si trova a una quota sul<br />
livello me<strong>di</strong>o mare che varia da un massimo <strong>di</strong> +8 m nell’area centrale nei pressi <strong>di</strong> Stra, fino a un<br />
minimo <strong>di</strong> –26 m nel settore meri<strong>di</strong>onale a nord <strong>di</strong> Cavanella d’A<strong>di</strong>ge. In generale si osserva una<br />
pendenza <strong>di</strong> questa superficie orientata da NW verso SE nel settore centro‐meri<strong>di</strong>onale, mentre la<br />
<strong>di</strong>rezione della pendenza cambia da N verso S nel settore nord‐orientale.<br />
Dall'analisi della carta risultano particolarmente evidenti le incisioni fluviali del settore <strong>di</strong>stale<br />
del megafan del Tagliamento formatesi tra il Tardoglaciale e l'Olocene iniziale. Due <strong>di</strong> queste incisioni<br />
coincidono con le bassure occupate dagli attuali corsi <strong>di</strong> Reghena e Lemene, mentre quelle più orientali<br />
sono state completamente riempite dalla se<strong>di</strong>mentazione successiva e sono state riconosciute grazie ai<br />
carotaggi stratigrafici. Anche in altri settori più sud‐occidentali della provincia si osserva la presenza <strong>di</strong><br />
incisioni fluviali <strong>di</strong> una certa importanza, ma il dettaglio con cui si è potuto seguire il loro andamento è<br />
notevolmente inferiore a quello raggiunto nel Portogruarese; tale minor risoluzione è dovuta alla<br />
<strong>di</strong>versità delle geometrie dei corpi e alla minor densità <strong>di</strong> sondaggi <strong>di</strong>sponibili. Nel settore <strong>di</strong> terraferma<br />
le più significative sono quelle coincidenti con l’attuale corso del fiume <strong>Piave</strong> e del Sile, e quella situata<br />
nell’area meri<strong>di</strong>onale a sud dell’attuale alveo del Brenta.<br />
3 Carta Litologica<br />
La Carta Litologica deriva dall’analisi del tema c0501‐Litologia e dei suoi relativi sottotemi; le<br />
voci <strong>di</strong> legenda derivano dal documento “Grafie Unificate per gli strumenti urbanistici comunali” <strong>di</strong> cui<br />
alla D.G.R. n. 615/1996. In tale documento sono rappresentate le litologie caratteristiche del primo<br />
metro <strong>di</strong> profon<strong>di</strong>tà dal piano campagna; le coperture sono classificate in riferimento al processo <strong>di</strong><br />
messa in posto del deposito o dell’accumulo, allo stato <strong>di</strong> addensamento e alla tessitura dei materiali<br />
costituenti.<br />
I dati elaborati sono stati restituiti in formato. shp nelle seguenti classi:<br />
i. c0501011_CartaLitologicaA.shp (aree);<br />
ii. c0501013_CartaLitologicaP.shp (punti).<br />
3.1 DATI DI PARTENZA E METODOLOGIA DI REALIZZAZIONE<br />
Il documento è stato pre<strong>di</strong>sposto “ex novo” sulla scorta delle personali conoscenze del<br />
territorio e grazie all’esame <strong>di</strong> un congruo numero <strong>di</strong> prove geognostiche <strong>di</strong>stribuite in tutto il <strong>Comune</strong>.<br />
Sulla Carta Litologica sono riportate le posizioni delle varie indagini con vicino il co<strong>di</strong>ce identificativo del<br />
sondaggio attribuito dalla Provincia <strong>di</strong> Venezia, tale co<strong>di</strong>ce è stato inserito in un apposito campo<br />
attributi della classe c0501013_CartaLitologicaP denominato ID_DATO; è stato inserito, inoltre, il campo<br />
20 <strong>di</strong> 83
Progetto: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio – RELAZIONE GEOLOGICA Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura<br />
geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico – Rev.:01<br />
Data: 28‐02‐2013 – Estensori: Prof. Geol. A. Bondesan, Dott.ssa S. Primon, Dott.ssa C. Levorato [Adastra srl]‐ Committente: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
PROFONDITA’ con riportata la profon<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> perforazione raggiunta in ciascuna indagine. Si tratta dei<br />
sondaggi a carotaggio continuo e delle trivellate della Provincia <strong>di</strong> Venezia. Le stratigrafie sono proposte<br />
in versione informatica all’Allegato 1 Stratigrafie (presente nel CD allegato).<br />
Nel caso, peraltro piuttosto frequente, in cui nell’intervallo in esame (da ‐1 a ‐4 m dal p.c.) fosse<br />
stata rilevata un’alternanza <strong>di</strong> strati con caratteristiche litologiche <strong>di</strong>verse è stato selezionato il litotipo<br />
prevalente.<br />
3.2 LITOTIPI PREVALENTI<br />
Lo schema geologico dell’area del comune <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> prevede un sequenza<br />
deposizionale che può essere sintetizzata come segue:<br />
1) DEPOSITI ALLUVIONALI PLEISTOCENICI: si tratta <strong>di</strong> depositi alluvionali costituiti<br />
prevalentemente da limi e limi argillosi <strong>di</strong> piana <strong>di</strong> esondazione, talvolta alternati a livelli <strong>di</strong><br />
sabbie e sabbie limose. In profon<strong>di</strong>tà sono presenti i depositi <strong>di</strong> ambienti <strong>di</strong>versi: dalle sabbie<br />
limose e limi sabbiosi <strong>di</strong> canale, <strong>di</strong> argine e <strong>di</strong> ventaglio <strong>di</strong> rotta fluviale alle sabbie <strong>di</strong> canali<br />
braided sabbiosi fino ai se<strong>di</strong>menti fini <strong>di</strong> piana <strong>di</strong>stale. Spesso i se<strong>di</strong>menti fini sono intercalati<br />
da orizzonti pluricentimetrici <strong>di</strong> argille organiche e torbe. Lo spessore dei se<strong>di</strong>menti<br />
dell’Ultimo Massimo Glaciale ha un valore me<strong>di</strong>o <strong>di</strong> circa 20 m ma può raggiungere anche i<br />
30 m.<br />
2) DEPOSITI ALLUVIONALI OLOCENICI: sono depositi alluvionali legati ai dossi delle <strong>di</strong>rettrici<br />
moderne e attuale del <strong>Piave</strong> e, in minor misura, del Sile. Le tessiture prevalenti sono sabbie,<br />
sabbie limose, limi sabbioso‐argillosi e limi corrispondenti a depositi <strong>di</strong> canale (spessi fino a<br />
10‐20 m), argine e ventaglio <strong>di</strong> rotta fluviale. La presenza <strong>di</strong> argille e argille limose, talora con<br />
sostanza organica, è connessa ai depositi <strong>di</strong> piana <strong>di</strong> esondazione.<br />
3) DEPOSITI LAGUNARI/PALUSTRI: questi depositi sono costituiti da limo argilloso e argilla<br />
limosa, talora ricchi in sostanza organica, e da alternanze centimetriche e decimetriche <strong>di</strong><br />
sabbia fine, con percentuali variabili <strong>di</strong> limo e argilla, e <strong>di</strong> argilla limosa, finemente laminate.<br />
Nei depositi prettamente lagunari si rinvengono abbondanti molluschi frammentati o interi<br />
(Cerastoderma, Loripes, Bittium).<br />
21 <strong>di</strong> 83
Progetto: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio – RELAZIONE GEOLOGICA Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura<br />
geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico – Rev.:01<br />
Data: 28‐02‐2013 – Estensori: Prof. Geol. A. Bondesan, Dott.ssa S. Primon, Dott.ssa C. Levorato [Adastra srl]‐ Committente: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
3.3 ELABORAZIONE DELLA CARTA LITOLOGICA<br />
Nel seguente paragrafo sono descritti i dati e le fonti reperiti per l’elaborazione della Carta<br />
Litologica (figura 9) ed è illustrata la metodologia <strong>di</strong> analisi e <strong>di</strong> elaborazione che ha portato alla<br />
redazione della Carta seguendo le voci <strong>di</strong> legenda derivanti dal documento “Grafie Unificate per gli<br />
strumenti urbanistici comunali” <strong>di</strong> cui alla D.G.R. n. 615/1996. La tipologia <strong>di</strong> dati e le fonti utilizzate<br />
sono descritti prendendo in analisi ad una ad una le voci presenti nella legenda della Carta stessa e<br />
analizzando <strong>di</strong> volta in volta il processo <strong>di</strong> elaborazione svolto.<br />
Figura 9: Carta litologica del comune <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
MATERIALI ALLUVIONALI, LACUSTRI, PALUSTRI E LITORALI<br />
L‐ALL‐05 “materiali alluvionali, fluvioglaciali, morenici o lacustri a tessitura<br />
prevalentemente limo‐argillosa” (DGR 615/1996).<br />
22 <strong>di</strong> 83
Progetto: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio – RELAZIONE GEOLOGICA Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura<br />
geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico – Rev.:01<br />
Data: 28‐02‐2013 – Estensori: Prof. Geol. A. Bondesan, Dott.ssa S. Primon, Dott.ssa C. Levorato [Adastra srl]‐ Committente: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
Sono stati associati a questa voce i terreni alluvionali <strong>di</strong> natura limosa e argillosa<br />
derivanti dalle antiche <strong>di</strong>vagazioni del fiume <strong>Piave</strong>. I limiti sono stati ricavati unendo i<br />
poligoni limo fluviale e argilla dal file tessitura_terraferma.shp tratto da Bondesan A.,<br />
Meneghel M., Rosselli R. e Vitturi A. (a cura <strong>di</strong>), Progetto DOGE, Carta Geomorfologia<br />
della Provincia <strong>di</strong> Venezia, Venezia, 2004 e sono stati validati tramite le informazioni<br />
puntuali provenienti dalle stratigrafie ricavate da relazioni geologico tecniche elaborate<br />
per aree appartenenti al comune <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> e dalla banca dati della Provincia <strong>di</strong><br />
Venezia.<br />
Primitiva geometrica: Area<br />
L‐ALL‐06 “materiali alluvionali, fluvioglaciali, morenici o lacustri a tessitura<br />
prevalentemente sabbiosa” (DGR 615/1996).<br />
Sono stati associati a questa voce i depositi sabbiosi appartenenti al dosso entro cui<br />
scorre attualmente il fiume <strong>Piave</strong> e quelli appartenenti al dosso della <strong>Piave</strong> Vecchia, ora<br />
occupato dal Sile dalla confluenza presso Caposile fino alla foce. Si osservano inoltre, a<br />
ovest <strong>di</strong> Millepertiche, le sabbie <strong>di</strong> un antico dosso attribuito al <strong>Piave</strong> (dosso della<br />
Fossetta).<br />
I limiti sono stati ricavati dai poligoni sabbia fluviale del file tessitura_terraferma.shp<br />
tratto da Bondesan A., Meneghel M., Rosselli R. e Vitturi A. (a cura <strong>di</strong>), Progetto DOGE,<br />
Carta Geomorfologia della Provincia <strong>di</strong> Venezia, Venezia, 2004 e sono stati validati<br />
tramite le informazioni puntuali provenienti dalle stratigrafie ricavate da relazioni<br />
geologico tecniche elaborate per aree appartenenti al comune <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> e dalla<br />
banca dati della Provincia <strong>di</strong> Venezia.<br />
Primitiva geometrica: Area<br />
L‐ALL‐09 “materiali <strong>di</strong> deposito palustre a tessitura fine e torbiere” (DGR 615/1996).<br />
Sono stati associati a questa voce i depositi palustri a tessitura fine (limoso‐argillosa)<br />
talora torbosi, corrispondenti all’area affiorante nel settore meri<strong>di</strong>onale del territorio<br />
comunale.<br />
I limiti sono stati validati tramite le informazioni puntuali provenienti dalle stratigrafie<br />
ricavate da relazioni geologico tecniche elaborate per aree appartenenti al comune <strong>di</strong><br />
<strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> e dalla banca dati della Provincia <strong>di</strong> Venezia.<br />
23 <strong>di</strong> 83
Progetto: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio – RELAZIONE GEOLOGICA Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura<br />
geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico – Rev.:01<br />
Data: 28‐02‐2013 – Estensori: Prof. Geol. A. Bondesan, Dott.ssa S. Primon, Dott.ssa C. Levorato [Adastra srl]‐ Committente: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
Primitiva geometrica: Area<br />
PUNTI DI INDAGINE GEOGNOSTICA E GEOFISICA<br />
Per la redazione del quadro conoscitivo è stata effettuata una raccolta, una catalogazione e una<br />
georeferenziazione <strong>di</strong> tutte le informazioni stratigrafiche puntuali, derivanti da relazioni geologico<br />
tecniche fornite dal <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> e dalla Provincia <strong>di</strong> Venezia, integrate con le stratigrafie<br />
della Banca Dati della Provincia <strong>di</strong> Venezia.<br />
Sono state catalogate indagini penetrometriche e sondaggi e ad ognuna è stato associato il co<strong>di</strong>ce<br />
identificativo della fonte <strong>di</strong> appartenenza.<br />
Tutte le indagini provenienti dalla Banca Dati della Provincia <strong>di</strong> Venezia si trovano raccolte nell’allegato 4<br />
Stratigrafie presente nel CD allegato alla presente relazione.<br />
L‐IND‐01 “prova penetrometrica” (615/1996).<br />
Le prove penetrometriche raccolte derivano da relazioni geologico‐tecniche <strong>di</strong> autori<br />
vari: Vidali 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, Gennari 2009, 2007, 2005, 2003,<br />
Berlanda 2008, Bonetto 2008, Geoservizi s.r.l., Giara Engineering s.r.l., Stu<strong>di</strong>o Geologos,<br />
Stu<strong>di</strong>o Geotest, Stu<strong>di</strong>o Tecnico Conte & Pegorer, Stu<strong>di</strong>o Geologico‐Geotecnico Bernar<strong>di</strong>,<br />
Tecnogeo S.a.s.<br />
Informazioni dettagliate sulle fonti e sulle relazioni <strong>di</strong> provenienza si trovano nell’<br />
Allegato 1 Catalogo della documentazione raccolta per la redazione del PAT.<br />
Primitiva geometrica: Punto<br />
L‐IND‐02 “sondaggio” (615/1996).<br />
I sondaggi raccolti derivano dalla Banca Dati della Provincia <strong>di</strong> Venezia e da relazioni<br />
geologico‐tecniche <strong>di</strong> autori vari (Stu<strong>di</strong>o Caturani & Mariani).<br />
Informazioni dettagliate sulle fonti e sulle relazioni <strong>di</strong> provenienza si trovano<br />
nell’Allegato 1 Catalogo della documentazione raccolta per la redazione del PAT.<br />
Primitiva geometrica: Punto<br />
24 <strong>di</strong> 83
Progetto: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio – RELAZIONE GEOLOGICA Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura<br />
geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico – Rev.:01<br />
Data: 28‐02‐2013 – Estensori: Prof. Geol. A. Bondesan, Dott.ssa S. Primon, Dott.ssa C. Levorato [Adastra srl]‐ Committente: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
Di seguito si riporta la collocazione dei file shape, e i rispettivi nomi dei metadati associati:<br />
PERCORSO: PAT<strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong>\c_QuadroConoscitivo\c05_SuoloSottosuolo\ c0501_Litologia<br />
METADATO: c0501011_CartaLitologicaA<br />
METADATO: c0501013_CartaLitologicaP<br />
4 Carta Idrogeologica<br />
[fonti principali: Autorità <strong>di</strong> bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, <strong>Piave</strong>, Brenta‐Bacchiglione,<br />
(2007) Piano Stralcio per la gestione delle risorse idriche;<br />
Autorità <strong>di</strong> bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, <strong>Piave</strong>, Brenta‐Bacchiglione, (2007) Piano Stralcio<br />
per l’assetto Idrogeologico, prima variante;<br />
Autorità <strong>di</strong> bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, <strong>Piave</strong>, Brenta‐Bacchiglione, (2009) Piano Stralcio<br />
per la la sicurezza idrulica del me<strong>di</strong>o e basso corso;<br />
Autorità <strong>di</strong> bacino del Sile e della pianura tra <strong>Piave</strong> e Livenza, (2007) Piano ai Assetto idrogeologico;<br />
La Carta Idrogeologica deriva dall’analisi del tema c0502‐Idrogeologia e dei suoi relativi<br />
sottotemi; le voci <strong>di</strong> legenda derivano dal documento “Grafie Unificate per gli strumenti urbanistici<br />
comunali” <strong>di</strong> cui alla D.G.R. n. 615/1996. In tale documento le voci <strong>di</strong> legenda interessano sia temi<br />
puramente idrogeologici, come la soggiacenza del livello <strong>di</strong> falda e la presenza <strong>di</strong> pozzi, con una voce<br />
specifica per i pozzi ad uso acquedottistico, sia temi riguardanti l’idrologia <strong>di</strong> superficie, come la<br />
rappresentazione dell’idrografia superficiale, la presenza <strong>di</strong> idrovore, botti e sifoni e l’in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong><br />
aree paludose.<br />
I dati elaborati sono stati restituiti in formato. shp nelle seguenti classi:<br />
i. c0502011_CartaIdrogeologicaA.shp (aree);<br />
ii. c0502012_CartaIdrogeologicaL.shp (linee);<br />
iii. c0502013_CartaIdrogeologicaP.shp (punti).<br />
4.1 IDROLOGIA DI SUPERFICIE<br />
L’ambito territoriale esaminato è dal punto <strong>di</strong> vista geografico e idrografico formato da due<br />
zone <strong>di</strong>stinte: alla prima porzione <strong>di</strong> territorio appartengono il bacino idrografico del Sile e le aree <strong>di</strong><br />
bonifica che a valle <strong>di</strong> Portegran<strong>di</strong> si collocano in sinistra idrografica tra Sile e <strong>Piave</strong> e recapitano le loro<br />
acque nel fiume grazie ad una serie <strong>di</strong> impianti idrovori (figura 10). La seconda delle zone considerate è<br />
25 <strong>di</strong> 83
Progetto: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio – RELAZIONE GEOLOGICA Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura<br />
geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico – Rev.:01<br />
Data: 28‐02‐2013 – Estensori: Prof. Geol. A. Bondesan, Dott.ssa S. Primon, Dott.ssa C. Levorato [Adastra srl]‐ Committente: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
costituita, invece, dal corso del fiume <strong>Piave</strong>, che limita per un breve tratto il territorio comunale <strong>di</strong><br />
<strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong>.<br />
Figura 10: Carta delle reti <strong>di</strong> bonifica e <strong>di</strong> irrigazione del bacino <strong>di</strong> Caposile<br />
Volendo brevemente inquadrare le caratteristiche della rete idrografica conviene trattare<br />
separatamente le due zone sopra in<strong>di</strong>cate.<br />
4.1.1 Il bacino idrografico del fiume Sile<br />
Il Sile è un fiume <strong>di</strong> risorgiva alimentato da acque perenni che affiorano a giorno al piede del<br />
grande materasso alluvionale formato dalle conoi<strong>di</strong> del <strong>Piave</strong> e del Brenta e che occupa gran parte<br />
dell'alta pianura veneta. Il suo bacino apparente, che ha una superficie <strong>di</strong> circa 800 km 2<br />
, si estende dal<br />
sistema collinare pedemontano fino alla fascia dei fontanili, che non è lateralmente ben definita, ma che<br />
si <strong>di</strong>spone, con un andamento da occidente ad oriente, tra i bacini del Brenta e del <strong>Piave</strong>. In questo<br />
26 <strong>di</strong> 83
Progetto: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio – RELAZIONE GEOLOGICA Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura<br />
geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico – Rev.:01<br />
Data: 28‐02‐2013 – Estensori: Prof. Geol. A. Bondesan, Dott.ssa S. Primon, Dott.ssa C. Levorato [Adastra srl]‐ Committente: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
territorio alla rete idrografica naturale si sovrappone ora una estesa rete <strong>di</strong> canali artificiali <strong>di</strong> scolo e <strong>di</strong><br />
irrigazione, con molti punti <strong>di</strong> connessione con la rete idrografica naturale. L’influenza <strong>di</strong> questa rete <strong>di</strong><br />
canali artificiali sul regime del Sile è rilevante, potendo mo<strong>di</strong>ficare sensibilmente le portate proprie del<br />
fiume provenienti dagli affioramenti <strong>di</strong> falda, soprattutto durante gli stati <strong>di</strong> piena.<br />
In sinistra idrografica la rete naturale è costituita da un insieme <strong>di</strong> affluenti <strong>di</strong>sposti con un<br />
andamento da Nord a Sud, i maggiori dei quali sono il Giavera‐Botteniga, alimentato nel tratto iniziale<br />
del suo corso da acque <strong>di</strong> origine carsica affioranti al piede del Montello; il Musestre, a sua volta<br />
alimentato alle sue origini da acque <strong>di</strong> risorgiva, che confluisce in Sile poco a monte del Taglio, ed altri<br />
affluenti minori come il Limbraga, il Nerbon ed il Melma. Molto meno importanti sono altri corsi naturali<br />
ed in particolare gli affluenti <strong>di</strong> destra, come il Canale Dosson e gli Scoli Bigonzo e Serva, che a sud del<br />
fiume drenano la zona <strong>di</strong> pianura compresa tra lo Zero‐Dese e il Sile.<br />
Tralasciando qui <strong>di</strong> parlare delle antiche evoluzioni del <strong>Piave</strong> e delle sue ipotetiche connessioni<br />
con le acque del Sile, sulle quali molto si è scritto, ci si limita a ricordare i maggiori interventi avvenuti in<br />
epoca storica, che hanno mo<strong>di</strong>ficato il corso del Sile e variato la struttura della rete idrografica<br />
superficiale del suo bacino, con effetti che ancor oggi si riflettono sul funzionamento idraulico dell’intero<br />
sistema.<br />
Nel bacino a monte <strong>di</strong> Treviso sono innanzitutto da ricordare gli interventi attuati in questo<br />
secolo con mo<strong>di</strong>fiche rilevanti della rete soprattutto nella zona delle sorgenti, me<strong>di</strong>ante nuove<br />
inalveazioni e l'eliminazione delle vaste aree paludose un tempo esistenti e ora ridotte a poche decine <strong>di</strong><br />
ettari. Alle appen<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> questa rete giungono le acque dell'estesa rete <strong>di</strong> canali artificiali, <strong>di</strong> scolo e <strong>di</strong><br />
irrigazione, i cui assi portanti sono costituiti dai gran<strong>di</strong> canali irrigui alimentati con acque del <strong>Piave</strong>,<br />
attraverso le derivazioni <strong>di</strong> Pederobba e <strong>di</strong> Nervesa. Si tratta <strong>di</strong> un grande sistema <strong>di</strong> canali artificiali<br />
chiuso ad oriente dal Canale <strong>Piave</strong>sella, il quale ha origini antiche ed è anch'esso alimentato con acque<br />
del <strong>Piave</strong> dalla derivazione <strong>di</strong> Nervesa e confluisce nel Giavera‐Botteniga alle porte <strong>di</strong> Treviso. Qui la<br />
portata del fiume in con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> regime normale è <strong>di</strong> circa 25‐30 m 3<br />
/s, cui si aggiungono in Treviso circa<br />
10‐15 m 3<br />
/s del sistema Giavera‐Botteniga‐<strong>Piave</strong>sella.<br />
Le utilizzazioni idroelettriche che si sono aggiunte alle più antiche utilizzazioni dei mulini, ora in<br />
gran parte scomparsi, hanno comportato tagli <strong>di</strong> anse a valle <strong>di</strong> Treviso, con la costruzione in particolare<br />
<strong>di</strong> un tratto d'alveo rettilineo tra la città e Silea.<br />
Sostegni <strong>di</strong> minore importanza <strong>di</strong> quelli delle centrali idroelettriche e salti <strong>di</strong> fondo fissano<br />
l'alveo del Sile e <strong>di</strong> alcuni dei suoi principali affluenti, sostenendone il profilo liquido durante gli stati <strong>di</strong><br />
regime normale, ma influenzando, talora in senso negativo, anche le quote massime <strong>di</strong> piena. Non<br />
infrequentemente si tratta <strong>di</strong> strutture antiche, come nel caso dei canali in attraversamento a Treviso,<br />
27 <strong>di</strong> 83
Progetto: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio – RELAZIONE GEOLOGICA Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura<br />
geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico – Rev.:01<br />
Data: 28‐02‐2013 – Estensori: Prof. Geol. A. Bondesan, Dott.ssa S. Primon, Dott.ssa C. Levorato [Adastra srl]‐ Committente: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
strettamente connesse con il tessuto urbano e dalle quali non è agevole prescindere per i complessi<br />
problemi igienico‐ambientali che la loro eliminazione comporterebbe.<br />
Dopo aver raccolto ulteriori acque <strong>di</strong> affluenti e <strong>di</strong> risorgive, a Casier, superata la centrale <strong>di</strong><br />
Silea, la portata me<strong>di</strong>a del fiume sale a circa 50‐55 m 3<br />
/s.<br />
Più a valle, oltre Portegran<strong>di</strong> ove un tempo il Sile scaricava in Laguna, le acque del fiume<br />
fluiscono lungo il Taglio, scavato più <strong>di</strong> trecento anni or sono dai Veneziani, per poi immettersi<br />
nell'antico alveo del <strong>Piave</strong>, fiume a sua volta deviato nel tentativo <strong>di</strong> contrastare l’interrimento delle<br />
bocche <strong>di</strong> porto della Laguna <strong>di</strong> Venezia ed in particolare della bocca <strong>di</strong> S. Nicolò, attraverso la quale un<br />
tempo si accedeva al Bacino <strong>di</strong> S. Marco.<br />
La costruzione del Taglio fu un provve<strong>di</strong>mento attuato con il preciso scopo <strong>di</strong> <strong>di</strong>fendere la<br />
Laguna, che ha però avuto riflessi negativi, come peraltro altri importanti interventi realizzati dalla<br />
Serenissima, sia sul regime del Sile, sia sullo scolo dei terreni a<strong>di</strong>acenti.<br />
Agli effetti negativi derivanti dalla costruzione del Taglio, soprattutto per lo scolo delle<br />
campagne del Trevigiano, si tentò <strong>di</strong> ovviare con la costruzione del Businello, manufatto che consentiva<br />
<strong>di</strong> immettere in laguna nei pressi <strong>di</strong> Portegran<strong>di</strong> parte delle acque del Sile, mentre per migliorare lo scolo<br />
delle campagne a<strong>di</strong>acenti al Taglio si intervenne alla fine dell'ottocento con la costruzione della botte<br />
delle Trezze e, negli anni successivi, con la realizzazione dei molti impianti idrovori. Il più importante <strong>di</strong><br />
tali impianti è l’idrovora <strong>di</strong> Portesine, che garantisce lo scolo delle acque <strong>di</strong> un ampio comprensorio<br />
situato tra Biancade – Roncade e il Sile. Il comprensorio <strong>di</strong> bonifica <strong>di</strong> Portesine è tagliato in <strong>di</strong>rezione N‐<br />
S dal Vallio, che raccoglie le acque della parte alta del territorio e le convoglia a gravità, attraverso il<br />
Canale della Vela, nella Laguna <strong>di</strong> Venezia.<br />
Tutti questi interventi furono integrati, da ultimo, con la realizzazione in destra idrografica,<br />
poco a valle <strong>di</strong> Portegran<strong>di</strong>, <strong>di</strong> un ampio varco nel corpo arginale, attuato come provve<strong>di</strong>mento<br />
provvisionale in occasione della ormai famosa piena del novembre 1966 e non più richiuso per gli<br />
evidenti benefici <strong>di</strong> contenimento dei livelli <strong>di</strong> massima piena del fiume e per i trascurabili effetti<br />
negativi che esso comporta sulla qualità delle acque in Laguna.<br />
Lungo il Taglio ed il successivo corso <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Vecchia, il Sile, dapprima solo in sinistra e poi<br />
anche in destra, riceve le acque <strong>di</strong> numerosi impianti idrovori, il più importante dei quali è, come si è<br />
detto, l'impianto <strong>di</strong> Portesine <strong>di</strong> cui è stato da tempo proposto, ma non ancora attuato, il potenziamento<br />
dagli attuali 15 m 3<br />
/s a ben 35 m 3<br />
/s.<br />
Tali impianti incrementano sensibilmente le portate <strong>di</strong> piena del Sile potendo attualmente il<br />
loro contributo complessivo superare i 60 m 3<br />
/s.<br />
28 <strong>di</strong> 83
Progetto: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio – RELAZIONE GEOLOGICA Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura<br />
geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico – Rev.:01<br />
Data: 28‐02‐2013 – Estensori: Prof. Geol. A. Bondesan, Dott.ssa S. Primon, Dott.ssa C. Levorato [Adastra srl]‐ Committente: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
A Jesolo si stacca dal Sile il canale Cavetta, che convoglia verso la foce del <strong>Piave</strong> a Cortellazzo<br />
una frazione non trascurabile delle portate in arrivo da monte (circa il 20‐25%). Superato Jesolo, il Sile<br />
giunge al mare in corrispondenza alla foce <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Vecchia, dopo un percorso complessivo <strong>di</strong> oltre 80<br />
km.<br />
Le portate <strong>di</strong> massima piena del Sile a Casier, determinate su base statistica, sono dell'or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong><br />
140 m 3<br />
/s circa per un evento centenario, da cui si può risalire a portate massime <strong>di</strong> piena <strong>di</strong> circa 55‐60<br />
m 3<br />
/s a monte <strong>di</strong> Treviso e <strong>di</strong> circa 85‐90 m 3<br />
/s a valle della città. Si tratta <strong>di</strong> portate <strong>di</strong> non molto superiori<br />
a quelle proprie del regime normale del fiume, in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> un notevole grado <strong>di</strong> perennità che conferma,<br />
una volta <strong>di</strong> più, la particolare natura <strong>di</strong> questo corso d’acqua.<br />
Usuali per un territorio <strong>di</strong> bonifica ed ovviamente del tutto artificiali sono, infine, le<br />
caratteristiche della rete <strong>di</strong> canali che garantisce lo scolo delle acque della parte più bassa del territorio<br />
compreso tra il Taglio del Sile, l’alveo <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Vecchia e l’attuale alveo del <strong>Piave</strong>. Tra i corsi d’acqua <strong>di</strong><br />
questa parte del bacino vale la pena, forse, citare il relitto del vecchio alveo del <strong>Piave</strong> tra Intestadura e<br />
Caposile, che si <strong>di</strong>spone lungo una <strong>di</strong>rettrice leggermente dominante per quote rispetto al territorio<br />
circostante.<br />
In esso si scaricano normalmente, sollevate dall’impianto idrovoro <strong>di</strong> Croce, le acque <strong>di</strong> una<br />
parte del bacino <strong>di</strong> Caposile e a gravità quelle drenate dal canale <strong>di</strong> Marezzana, <strong>di</strong>sposto con andamento<br />
sub‐parallelo all’alveo del <strong>Piave</strong>. Quasi in testa al vecchio alveo del <strong>Piave</strong> si immettono anche gli scarichi<br />
dell’idrovora Chiesanuova, che può, in determinate situazioni, entrare in funzione per facilitare il<br />
funzionamento della rete <strong>di</strong> bonifica del Comprensorio <strong>di</strong> Cavazuccherina.<br />
Dal punto <strong>di</strong> vista idrologico, il ruolo del vecchio alveo del <strong>Piave</strong>, se è <strong>di</strong> nessun rilievo in<br />
con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> regime normale, potrebbe mo<strong>di</strong>ficarsi ra<strong>di</strong>calmente nel caso <strong>di</strong> piena eccezionale del <strong>Piave</strong>.<br />
Qualora si producessero esondazioni dal fiume o scarichi anomali per il malfunzionamento delle<br />
strutture che dall’Intestadura consentono <strong>di</strong> isolare il vecchio alveo del <strong>Piave</strong> dal suo corso attuale,<br />
potrebbero concentrasi lungo questo elemento della rete idrografica le acque fuoriuscite dal <strong>Piave</strong><br />
stesso, determinando situazioni <strong>di</strong>fficilmente controllabili dal punto <strong>di</strong> vista idraulico.<br />
4.1.2 Il bacino idrografico del fiume <strong>Piave</strong><br />
Il fiume <strong>Piave</strong> nasce sul versante meri<strong>di</strong>onale del Monte Peralba e confluisce nel mare Adriatico<br />
presso il porto <strong>di</strong> Cortellazzo, al limite orientale della Laguna <strong>di</strong> Venezia, dopo 222 km <strong>di</strong> percorso, con<br />
un'area tributaria alla foce valutabile in circa 4.100 kmq.<br />
29 <strong>di</strong> 83
Progetto: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio – RELAZIONE GEOLOGICA Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura<br />
geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico – Rev.:01<br />
Data: 28‐02‐2013 – Estensori: Prof. Geol. A. Bondesan, Dott.ssa S. Primon, Dott.ssa C. Levorato [Adastra srl]‐ Committente: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
La rete idrografica del <strong>Piave</strong> presenta uno sviluppo asimmetrico che localizza gli affluenti e<br />
subaffluenti più importanti, il Padola, l'Ansiei, il Boite, il Maé, il Cordevole con il Mis, il Sonna, sulla<br />
destra dell'asta principale.<br />
L'innesto sul bacino montano del <strong>Piave</strong> <strong>di</strong> un articolato sistema <strong>di</strong> sfruttamento idroelettrico,<br />
sviluppatosi tra gli anni '20 e '60, ma che è tutt'oggi in espansione soprattutto per quanto riguarda i<br />
piccoli impianti che sfruttano le risorse potenziali negli affluenti anche minori del bacino, ha<br />
profondamente mo<strong>di</strong>ficato il regime idrologico del <strong>Piave</strong> alterando con questo anche la <strong>di</strong>namica<br />
fluviale, il trasporto solido, il paesaggio stesso <strong>di</strong>segnato dal corso d'acqua.<br />
La morfologia dell’alveo del <strong>Piave</strong> si è mo<strong>di</strong>ficata notevolmente, in particolar modo negli ultimi<br />
decenni. La larghezza me<strong>di</strong>a dell’alveo è attualmente meno della metà rispetto all’inizio del secolo (260<br />
m nel 1997 contro 610 m all’inizio del secolo) e il fondo dell’alveo ha subito generalmente un<br />
abbassamento valutato, nel tratto <strong>di</strong> pianura, dell’or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> 2‐3 m. Queste mo<strong>di</strong>ficazioni, ossia l’incisione<br />
ed il restringimento dell’alveo, sono imputabili principalmente alla drastica <strong>di</strong>minuzione nell’apporto <strong>di</strong><br />
se<strong>di</strong>menti al corso d’acqua dovuta agli sbarramenti (<strong>di</strong>ghe e traverse) presenti lungo il <strong>Piave</strong> ed i suoi<br />
affluenti e all’estrazione <strong>di</strong> ghiaie dall’alveo.<br />
3<br />
A fronte <strong>di</strong> una portata me<strong>di</strong>a annua <strong>di</strong> circa 130 m /s (Nervesa), nel 1966 a Ponte della Priula<br />
3<br />
(Nervesa) venne stimata una porta massima <strong>di</strong> 5000 m /s.<br />
Nel tratto <strong>di</strong> bassa pianura, il fiume é obbligato a fluire in alvei <strong>di</strong> limitata capacità o peggio<br />
costretti da arginature normalmente pensili sul piano <strong>di</strong> campagna, manifestamente non adeguati al<br />
transito <strong>di</strong> eventuali fenomeni <strong>di</strong> piena.<br />
Ne consegue che numerose aree della bassa pianura del bacino sono, seppure in relazione ad<br />
eccezionali episo<strong>di</strong> <strong>di</strong> piena, potenzialmente suscettibili <strong>di</strong> allagamento.<br />
Con riguardo alla caratterizzazione morfologica della rete idrica del bacino, è utile <strong>di</strong>stinguere<br />
tra l’asta principale del <strong>Piave</strong>, le reti fluviali <strong>di</strong> montagna e <strong>di</strong> pianura, quelle artificiali dei consorzi <strong>di</strong><br />
bonifica ed i numerosi invasi naturali ed artificiali.<br />
L’ASTA PRINCIPALE<br />
Il <strong>Piave</strong> si può <strong>di</strong>videre in tre tronchi, cioè il torrente, il fiume torrentizio ed il fiume<br />
propriamente detto. Nel tronco superiore del Cadore e <strong>di</strong> Belluno esso è un vero e proprio torrente, con<br />
alveo relativamente stretto, racchiuso tra alti monti e <strong>di</strong>scende rapi<strong>di</strong>ssimo. A valle <strong>di</strong> Longarone, pur<br />
non cambiando la morfologia delle due pareti, l’alveo si espande ed è generalmente <strong>di</strong> grande ampiezza<br />
con imponenti masse ghiaiose, responsabili <strong>di</strong> un notevole deflusso subalveo. La pendenza del letto<br />
raggiunge tra Longarone e Fener delle punte del 5 ‰.<br />
30 <strong>di</strong> 83
Progetto: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio – RELAZIONE GEOLOGICA Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura<br />
geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico – Rev.:01<br />
Data: 28‐02‐2013 – Estensori: Prof. Geol. A. Bondesan, Dott.ssa S. Primon, Dott.ssa C. Levorato [Adastra srl]‐ Committente: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
Il <strong>Piave</strong> subisce una brusca deviazione a Ponte nelle Alpi: tuttavia il tronco a monte trova la sua<br />
continuazione morfologica e geologica nella stessa <strong>di</strong>rezione generale N‐S dalla parte settentrionale del<br />
solco dei laghi Lapisini. Questo antico letto fluvio‐glaciale fu interrotto dalla antica frana <strong>di</strong> Fadalto. In<br />
seguito a tale interruzione le acque, affluenti alla parte settentrionale del solco, da Ponte nelle Alpi fino<br />
alla Sella <strong>di</strong> Fadalto, hanno invertito la <strong>di</strong>rezione del loro corso a mezzo del lago <strong>di</strong> S. Croce e del suo<br />
emissario Rai.<br />
Il tronco interme<strong>di</strong>o del <strong>Piave</strong> con caratteristiche <strong>di</strong> fiume torrentizio, va grosso modo da Fener<br />
a Zenson, conservando delle pendenze rilevanti: da Fener a Ponte Priula circa 3.5‰, a Boccatallata<br />
1.8‰, e <strong>di</strong> qua fino a Zenson <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> circa 1.2‰. Anche in questo tratto interme<strong>di</strong>o scorre con forte<br />
velocità su un vasto letto <strong>di</strong> ciottoli e ghiaie, sud<strong>di</strong>viso in rami che mutano spesso il loro corso. La<br />
larghezza del letto supera i 3000 m.<br />
Infine poco a monte <strong>di</strong> Zenson scompaiono le ghiaie ed il carattere torrentizio, ed il <strong>Piave</strong><br />
assume la natura propria del fiume <strong>di</strong> pianura: scorre cioè entro un alveo largo in me<strong>di</strong>a circa 100 m,<br />
incassato a sponde fisse, elevate sopra il segno <strong>di</strong> guar<strong>di</strong>a e sulle quali stanno, più o meno in ritiro, le<br />
arginature <strong>di</strong> contenimento delle piene. In quest’ultimo tronco le pendenze <strong>di</strong>vengono assai miti, tanto<br />
che in prossimità della foce scendono anche al <strong>di</strong> sotto <strong>di</strong> 0.1‰.<br />
Il profilo longitu<strong>di</strong>nale del fondo è costituito da una curva concava verso l’alto che termina<br />
verso la foce con una linea quasi orizzontale. In funzione delle pendenze stanno le velocità del corso<br />
d’acqua, le quali, mentre sono dell’or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> più m/s nei tronchi montani, <strong>di</strong>minuiscono gradatamente<br />
verso la foce fino a ridursi, in con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> magra or<strong>di</strong>naria a 0.2‐0.3 m/s. A tale <strong>di</strong>minuzione<br />
contribuisce anche il flusso <strong>di</strong> marea, la cui influenza si fa sentire fino a Zenson a circa 30 km dalla foce.<br />
LA RETE FLUVIALE DI PIANURA<br />
Come si è detto in precedenza il bacino del <strong>Piave</strong> ha uno sviluppo prevalentemente montano;<br />
in questa parte del bacino le caratteristiche idrologiche sono <strong>di</strong>rettamente correlate alle caratteristiche<br />
del bacino imbrifero. Nel tratto <strong>di</strong> pianura invece sono preponderanti i fenomeni propagatori. Si<br />
considera come tratto <strong>di</strong> pianura il corso del fiume <strong>Piave</strong> da Nervesa della Battaglia (78 m s.l.m.) alla<br />
foce. Tale tratto ha una lunghezza complessiva <strong>di</strong> circa 64 km. Nella prima parte <strong>di</strong> questo tratto, fino a<br />
Ponte <strong>di</strong> <strong>Piave</strong>, il fiume presenta un carattere torrentizio con alveo a morfologia ampia e ramificata,<br />
costituito prevalentemente da ciottoli e ghiaie. Nella parte terminale del percorso <strong>di</strong> pianura,<br />
approssimativamente da Zenson, il <strong>Piave</strong> assume la caratteristica morfologia del fiume <strong>di</strong> pianura, con<br />
alveo sabbioso racchiuso entro elevate arginature costruite allo scopo <strong>di</strong> <strong>di</strong>fendere i territori circostanti<br />
dalle esondazioni. Il <strong>Piave</strong> ha una larghezza d’alveo variabile fra 1 e 2 km tra Ponte della Priula e Ponte <strong>di</strong><br />
<strong>Piave</strong>, che si riduce a 80 m per l’alveo <strong>di</strong> magra e a 120 m, come <strong>di</strong>stanza tra le arginature <strong>di</strong><br />
contenimento, all’altezza <strong>di</strong> Zenson <strong>di</strong> <strong>Piave</strong>, che si trova a soli 10 km a valle <strong>di</strong> Ponte <strong>di</strong> <strong>Piave</strong>.<br />
31 <strong>di</strong> 83
Progetto: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio – RELAZIONE GEOLOGICA Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura<br />
geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico – Rev.:01<br />
Data: 28‐02‐2013 – Estensori: Prof. Geol. A. Bondesan, Dott.ssa S. Primon, Dott.ssa C. Levorato [Adastra srl]‐ Committente: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
La portata me<strong>di</strong>a, basata su molti anni <strong>di</strong> osservazione, era <strong>di</strong> circa 130 m 3 /s all’inizio del secolo,<br />
con portate per la magra dell’or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> 40‐50 m 3 /s alla sezione <strong>di</strong> chiusura del bacino montano (Nervesa<br />
della Battaglia). Attualmente per lunghi perio<strong>di</strong> nella stagione estiva si stenta a mantenere<br />
artificialmente una portata a Nervesa dell’or<strong>di</strong>ne dei 5 m 3 /s; foto aeree dell’alveo del <strong>Piave</strong> riprese oggi<br />
e subito dopo la piena del 1966 <strong>di</strong>mostrano un notevolissimo aumento della vegetazione all’interno del<br />
letto del fiume.<br />
Nel tratto imme<strong>di</strong>atamente a valle <strong>di</strong> Nervesa della Battaglia l’alveo del fiume <strong>di</strong>sperde una<br />
frazione considerevole delle acque nelle alluvioni ghiaiose, contribuendo all’alimentazione delle falde <strong>di</strong><br />
pianura.<br />
L’andamento planimetrico è caratterizzato da una notevole tortuosità che si interrompe solo<br />
per alcuni chilometri a valle <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong>, in corrispondenza del Taglio Nuovo <strong>di</strong> <strong>Piave</strong>, che è stato<br />
realizzato attraverso una serie <strong>di</strong> interventi operati sotto la Repubblica <strong>di</strong> Venezia, allo scopo <strong>di</strong> evitare<br />
l’interrimento del porto <strong>di</strong> Venezia e del bacino Nord della laguna.<br />
La profon<strong>di</strong>tà me<strong>di</strong>a del <strong>Piave</strong> nel tratto tra Zenson <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> ed Eraclea è <strong>di</strong> circa 5 m. La<br />
morfologia del fondo è piuttosto accidentata con frequenti e repentini abbassamenti del fondale (fino a<br />
profon<strong>di</strong>tà superiori ai 10 m) non solo nella parte esterna dei meandri, ma anche nel tratto rettilineo.<br />
Tale variabilità è dovuta non solo a processi erosivi legati alla <strong>di</strong>namica del corso d’acqua, ma anche<br />
presumibilmente a causa dell’estrazione <strong>di</strong> inerti in alveo (attività che appare oggi cessata in questo<br />
tratto del fiume). L’alveo è prevalentemente costituito da sabbie fini e limo. Nella parte superiore fino a<br />
Fossalta sono presenti dei tratti a ghiaie. Nei perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> magra questi materiali sono ricoperti da depositi<br />
<strong>di</strong> limo fine‐argilla che vengono rimossi e trasportati a mare in occasione delle piene. Nei tratti rettilinei<br />
la forma dell’alveo è trapezoidale.<br />
Nessun impianto idrovoro scarica <strong>di</strong>rettamente nel tratto <strong>di</strong> pianura del <strong>Piave</strong>; il fiume è in<br />
comunicazione con il Sile attraverso due canali <strong>di</strong> collegamento: il primo è il vecchio alveo situato fra le<br />
località <strong>di</strong> Intestadura (San Donà <strong>di</strong> <strong>Piave</strong>) e la frazione Caposile (<strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong>); il secondo è il canale<br />
Cavetta che unisce i due fiumi fra Jesolo Paese e la località <strong>di</strong> Cortellazzo presso la foce del <strong>Piave</strong>. Nel<br />
primo collegamento scaricano tre impianti idrovori del Consorzio <strong>di</strong> Bonifica Basso <strong>Piave</strong>, Croce Nord e<br />
Croce Sud (Bacino Caposile 6750 l/s, 1474 ha) e l’impiantino denominato Postazione Chiesanuova<br />
(Bacino Cavazuccherina, 1000 l/s, 185 ha). Tuttavia questi impianti sono tributari del Sile in quanto il<br />
livello normale del <strong>Piave</strong> all’Intestadura è superiore a quello del Sile a Caposile (infatti si tratta <strong>di</strong> una<br />
parte del vecchio alveo) ed inoltre l’ingresso delle acque del <strong>Piave</strong> è regimato attraverso porte vinciane<br />
in fregio ad una vecchia conca <strong>di</strong> navigazione non più utilizzata. Tali porte vengono aperte solo per<br />
consentire l’immissione <strong>di</strong> acque del <strong>Piave</strong> sufficiente a mantenere un flusso ridotto nel vecchio alveo ed<br />
in caso <strong>di</strong> piena del fiume vengono chiuse per eliminare il collegamento con il Sile. Anche sul secondo<br />
32 <strong>di</strong> 83
Progetto: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio – RELAZIONE GEOLOGICA Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura<br />
geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico – Rev.:01<br />
Data: 28‐02‐2013 – Estensori: Prof. Geol. A. Bondesan, Dott.ssa S. Primon, Dott.ssa C. Levorato [Adastra srl]‐ Committente: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
collegamento, il canale Cavetta, presso la foce del <strong>Piave</strong> esiste una conca <strong>di</strong> navigazione che impe<strong>di</strong>sce<br />
alle acque del fiume <strong>di</strong> raggiungere il Canale. Sempre presso la foce in località Revedoli presso l’argine<br />
sinistro del <strong>Piave</strong> si apre la Litoranea Veneta, che collega il fiume Livenza, previo presi<strong>di</strong>o <strong>di</strong> una conca.<br />
Il flusso delle acque nel Canale Revedoli, primo tratto della Litoranea che si <strong>di</strong>parte dal <strong>Piave</strong>,<br />
avviene in <strong>di</strong>rezione della foce del Livenza. La foce è esposta al rigurgito provocato dall’anomalo<br />
aumento del livello <strong>di</strong> marea che si instaura quando vigono alte pressioni sul basso Adriatico e basse<br />
pressioni sul golfo <strong>di</strong> Venezia per effetto <strong>di</strong> una sessa. Poiché le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> alta marea eccezionale<br />
possono coincidere con il colmo delle piene in quanto generate dalla stessa perturbazione, le con<strong>di</strong>zioni<br />
<strong>di</strong> deflusso possono risultare gravemente pregiu<strong>di</strong>cate. Il <strong>Piave</strong> risulta arginato da <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> alla<br />
foce e pensile rispetto al piano <strong>di</strong> campagna.<br />
4.2 INSUFFICIENZA IDRAULICA DEL PIAVE NEL TRATTO ARGINATO TRA NERVESA E IL MARE<br />
Le attività <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o promosse dall’Autorità <strong>di</strong> bacino nel quadro delle attività propedeutiche<br />
alla redazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico hanno sviluppato un’analisi attenta ed<br />
approfon<strong>di</strong>ta della <strong>di</strong>namica delle acque <strong>di</strong> piena a valle della chiusura del bacino montano, cioè nel<br />
tratto arginato che va da Nervesa della Battaglia al mare. Si tratta del segmento <strong>di</strong> fiume che è stato più<br />
frequentemente assoggettato alle esondazioni del <strong>Piave</strong>, come testimonia un’analisi storica<br />
dettagliatamente sviluppata.<br />
Nel merito della caratterizzazione dello stato <strong>di</strong> pericolosità in cui attualmente versa il basso<br />
corso, l’Autorità <strong>di</strong> bacino ha sviluppato due <strong>di</strong>stinti segmenti <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o. Il primo, perfezionato nel 1993,<br />
ha considerato e valutato la propagazione dell’onda <strong>di</strong> piena, con riguardo ad eventi <strong>di</strong> <strong>di</strong>verso tempo <strong>di</strong><br />
ritorno, me<strong>di</strong>ante applicazione <strong>di</strong> un modello matematico mono<strong>di</strong>mensionale. Il secondo, messo a<br />
punto successivamente, ha indagato ulteriormente me<strong>di</strong>ante un modello idraulico bi<strong>di</strong>mensionale ad<br />
elementi finiti anche l’area potenzialmente allagabile in relazione ad eventi <strong>di</strong> piena <strong>di</strong> assegnato tempo<br />
<strong>di</strong> ritorno.<br />
In relazione alle risultanze degli stu<strong>di</strong> il tratto <strong>di</strong> pianura, a valle <strong>di</strong> Nervesa, dal punto <strong>di</strong> vista<br />
della <strong>di</strong>namica idraulica è sud<strong>di</strong>visibile sostanzialmente in tre <strong>di</strong>stinte sub‐tratte.<br />
La prima tratta, tra Nervesa e Candelù, caratterizzata da un ampio alveo pluricursale in alluvioni<br />
ghiaioso‐sabbiose, da un’elevata pendenza del fondo (3,8 per mille) e da altezze arginali molto<br />
contenute (da 2 a 3 m) con una capacità <strong>di</strong> portata dell’or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> 4500‐5000 m 3 /s.<br />
La seconda tratta tra Candelù e Zenson, caratterizzata da pendenze, altezze arginali e caratteri<br />
morfologici interme<strong>di</strong> rispetto alle sub‐tratte a monte e a valle, con capacità <strong>di</strong> portata dell’or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong><br />
2500‐3000 m 3 /s.<br />
33 <strong>di</strong> 83
Progetto: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio – RELAZIONE GEOLOGICA Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura<br />
geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico – Rev.:01<br />
Data: 28‐02‐2013 – Estensori: Prof. Geol. A. Bondesan, Dott.ssa S. Primon, Dott.ssa C. Levorato [Adastra srl]‐ Committente: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
La terza tratta tra Zenson ed il mare, caratterizzata da un alveo decisamente più ristretto inciso<br />
nelle alluvioni sottili della bassa pianura a debole pendenza del fondo (0,25 per mille) e argini<br />
<strong>di</strong>scretamente elevati (da 4 m a 7 m circa), con un primo percorso a meandri tra argini alquanto<br />
ravvicinati e un percorso finale canalizzato e rettilineo, con una capacità <strong>di</strong> portata dell'or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> 2500‐<br />
3000 m 3 /s.<br />
La seconda tratta tra Candelù e Zenson, caratterizzata da pendenze, altezze arginali e caratteri<br />
morfologici interme<strong>di</strong> rispetto a quelli delle altre due tratte, ha una capacità <strong>di</strong> portata analoga alla terza<br />
tratta.<br />
La tratta tra Candelù e Zenson, che inizia laddove il profilo manifesta un'improvvisa riduzione <strong>di</strong><br />
pendenza, essendo per prima investita dalle intumescenze <strong>di</strong> piena si configura come la naturale sede<br />
delle rotte. In questa tratta, definibile come "sede delle rotte", i fenomeni <strong>di</strong> esondazione si verificano<br />
con modalità tale da consentire <strong>di</strong> rilasciare oltre le rotte una portata residua proprio dell'or<strong>di</strong>ne della<br />
massima capacità <strong>di</strong> portata dell'intera estesa a valle. In questo modo l'estesa <strong>di</strong> valle risulta presi<strong>di</strong>ata,<br />
evitando pericolose rotte che investirebbero <strong>di</strong>rettamente gli importanti centri abitati della pianura, e<br />
contemporaneamente consentendo <strong>di</strong> versare in mare una porzione importante delle onde <strong>di</strong> piena. Ciò<br />
si verificò nella piena del 1966 quando, a valle delle rotte, l'intero volume <strong>di</strong> piena al <strong>di</strong> sotto <strong>di</strong> 2500‐<br />
3000 m 3 /s defluì regolarmente sino al mare.<br />
La localizzazione sistematica delle rotte tra Candelù e Ponte <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> non esclude che non si<br />
possano verificare esondazioni nella estesa <strong>di</strong> monte tra Nervesa della Battaglia e Candelù e in quella <strong>di</strong><br />
valle tra Zenson ed il mare, ma solo in relazione a carenze locali, in<strong>di</strong>pendenti dalla rilevante <strong>di</strong>fferenza<br />
capacità <strong>di</strong> portata tra monte e valle.<br />
A valle i possibili fattori <strong>di</strong> criticità per il contenimento delle portate residue dopo le rotte sono<br />
in usuale relazione alle irregolarità del profilo delle sommità arginali o alle inidoneità strutturali e <strong>di</strong><br />
tenuta degli argini. Nella tratta <strong>di</strong> monte, invece, oltre ai suddetti fattori <strong>di</strong> criticità sono anche da<br />
considerare la mobilità dell'alveo e le relative conseguenti variazioni <strong>di</strong> livelli <strong>di</strong> piena a parità <strong>di</strong> portata.<br />
Per quanto riguarda il sistema arginale a valle <strong>di</strong> Zenson, le indagini eseguite nel primo<br />
segmento <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o con il supporto <strong>di</strong> un modello <strong>di</strong> propagazione delle piene mono<strong>di</strong>mensionale, hanno<br />
evidenziato come i profili <strong>di</strong> sommità, le strutture, e le tenute idrauliche, per quanto accertabile,<br />
appaiono adeguate. Gli stati <strong>di</strong> criticità sono limitati a situazioni locali; come, ad esempio,<br />
all'interferenza <strong>di</strong> una banchina portuale a Ponte <strong>di</strong> <strong>Piave</strong>, a punti <strong>di</strong> infiltrazione in località Intestadura,<br />
ad erosioni <strong>di</strong> sponda per effetto <strong>di</strong> un manufatto in località Lampoli. Altre insufficienze riguardano la<br />
foce (località Revedoli e Cortellazzo) per insufficienze arginali nei riguar<strong>di</strong> delle maree eccezionali.<br />
34 <strong>di</strong> 83
Progetto: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio – RELAZIONE GEOLOGICA Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura<br />
geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico – Rev.:01<br />
Data: 28‐02‐2013 – Estensori: Prof. Geol. A. Bondesan, Dott.ssa S. Primon, Dott.ssa C. Levorato [Adastra srl]‐ Committente: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
Per quanto riguarda l'estesa a monte <strong>di</strong> Candelù, lo stesso modello, in modo in<strong>di</strong>retto, in<strong>di</strong>cava<br />
la presenza <strong>di</strong> influenze della mobilità dell'alveo e le carenze <strong>di</strong>mensionali delle sommità degli argini,<br />
con conseguenti valori del franco arginale molto variabili lungo il percorso. Raffrontando peli liberi<br />
calcolati e sommità arginali, lo stu<strong>di</strong>o rilevava andamenti non congruenti: ad esempio un andamento a<br />
corda molla delle sommità arginali, laddove il profilo dei livelli d'acqua calcolati risulta concavo e<br />
viceversa.<br />
Ulteriori fattori <strong>di</strong> criticità, tipici dei sistemi pluricursali in alluvioni ghiaioso‐sabbiose sono<br />
relativi alle <strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong> controllo delle corrosioni ed erosioni <strong>di</strong> sponda, anche se nel <strong>Piave</strong> sono già state<br />
in gran parte affrontate e risolte con importanti opere <strong>di</strong>rezionali. Le tracimazioni che nella piena del<br />
1966 si verificarono a Palazzon, <strong>di</strong> fronte a Spresiano, per una lunghezza <strong>di</strong> ben 1700 m sono un esempio<br />
degli effetti combinati dei vari fattori <strong>di</strong> criticità menzionati. Un aspetto attiene anche alle <strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong><br />
valutazione preventiva dei livelli d'acqua massimi in corrispondenza degli argini, dato che il tracciato<br />
degli argini segue percorsi anche molto <strong>di</strong>versi da quelli dell'alveo attivo, e che la corrente interessa<br />
ampie golene caratterizzate da una propria, seppure limitata, capacità <strong>di</strong> portata.<br />
Utile risulta peraltro considerare come la <strong>di</strong>namica delle rotte si sia evoluta nel tempo,<br />
confrontando l’ubicazione <strong>di</strong> quelle accadute nel settembre 1882 e nell'ottobre 1903 con quelle<br />
dell'evento del 1966.<br />
Le rotte del 1882 e del 1903 iniziarono non a Candelù ma più a valle, dopo Zenson e si<br />
manifestarono lungo tutta l'intera estesa dell'alveo sin presso Eraclea. In particolare nel 1882 le rotte ed<br />
i sormonti interessarono un'estensione <strong>di</strong> ben 30 km <strong>di</strong> argini, con allagamenti <strong>di</strong> 550 kmq. Tali rotte<br />
<strong>di</strong>pesero dalle insufficienze delle sommità degli argini, allora assai più gravi <strong>di</strong> adesso, e dalle infiltrazioni<br />
e sifonamenti che si verificarono un po' dovunque da Zenson al mare. Ciò fa ritenere che allora la<br />
capacità <strong>di</strong> portata tra Zenson ed il mare fosse inferiore a quella della tratta interme<strong>di</strong>a fra Candelù e<br />
Zenson dove, in base alla documentazione reperita, non si verificarono rotte, ed anche che i valori al<br />
colmo fossero presumibilmente inferiori alla piena del 1966. E' proprio a seguito degli eventi del 1882 e<br />
del 1903 che si <strong>di</strong>ede inizio ad un piano generale <strong>di</strong> rior<strong>di</strong>namento, consolidamento e <strong>di</strong> sovralzi arginali<br />
che proseguì anche dopo le piene del 1926 e 1928, e che portò alla situazione attuale, <strong>di</strong> alveo calibrato<br />
a monte <strong>di</strong> Candelù per 4500‐5000 m 3 /s e, a valle <strong>di</strong> Zenson, per 2500‐3000 m 3 /s, con inevitabile<br />
squilibrio nella tratta interme<strong>di</strong>a, <strong>di</strong> raccordo tra i due, sede delle rotte.<br />
Osservato che gli interventi operati tra Zenson ed il mare hanno determinato in questa tratta<br />
un aumento della capacità <strong>di</strong> contenimento delle portate nell'or<strong>di</strong>ne della portata residua a valle della<br />
zona delle rotte tra Candelù e Zenson, quegli stessi interventi hanno anche così determinato una sorta <strong>di</strong><br />
apparato <strong>di</strong> scolmo delle portate eccedenti non contenibili a valle a presi<strong>di</strong>o del tratto terminale <strong>di</strong><br />
pianura e canalizzato dell'alveo. Nel 1966 questo apparato <strong>di</strong> scolmo naturale, versante sia a sinistra che<br />
35 <strong>di</strong> 83
Progetto: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio – RELAZIONE GEOLOGICA Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura<br />
geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico – Rev.:01<br />
Data: 28‐02‐2013 – Estensori: Prof. Geol. A. Bondesan, Dott.ssa S. Primon, Dott.ssa C. Levorato [Adastra srl]‐ Committente: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
a destra degli argini, riversò a campagna l'intero volume dell'onda <strong>di</strong> piena almeno oltre i 2500‐3000<br />
m 3 /s ed allagò un territorio <strong>di</strong> 450 kmq (con superficie dello stesso or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> quella della piena del 1882)<br />
con un presumibile volume <strong>di</strong> esondazione compreso tra 100 e 200 milioni <strong>di</strong> m 3 .<br />
Dopo la piena del 1966 furono eseguiti dal Magistrato alle Acque <strong>di</strong> Venezia lavori <strong>di</strong> sovralzo<br />
degli argini, sia in destra che in sinistra, nella tratta fra S. Donà <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> e Ponte <strong>di</strong> <strong>Piave</strong>, con sovralzi<br />
compresi tra 60 a 80 cm. Il sovralzo fu contenuto, e ben a ragione, poiché è chiaro che rafforzando<br />
eccessivamente le <strong>di</strong>fese nella sede delle rotte le esondazioni si trasferirebbero a valle <strong>di</strong> Zenson, dove<br />
potrebbero conseguire maggiori danni.<br />
Gli stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> bacino hanno valutato che, con riferimento alle onde <strong>di</strong> piena ricostruite per vari<br />
tempi <strong>di</strong> ritorno e varie durate <strong>di</strong> precipitazione, le esondazioni nella tratta delle rotte assumerebbero<br />
volumi <strong>di</strong> 115 milioni <strong>di</strong> m 3 e 52 milioni <strong>di</strong> m 3 rispettivamente per le piene centenarie e durata <strong>di</strong><br />
precipitazione <strong>di</strong> 24 e 48 ore, e volumi <strong>di</strong> 60 milioni <strong>di</strong> m 3 e 30 milioni <strong>di</strong> m 3 rispettivamente per le piene<br />
con tempo <strong>di</strong> ritorno <strong>di</strong> 50 anni e durata <strong>di</strong> precipitazione <strong>di</strong> 24 e 48 ore.<br />
Il modello matematico uni‐bi<strong>di</strong>mensionale messo successivamente a punto per lo stu<strong>di</strong>o della<br />
propagazione delle piene del <strong>Piave</strong> nel tratto compreso tra Nervesa e la foce ha dettagliatamente<br />
esaminato, accanto alle situazioni che si stabiliscono nell’alveo vero e proprio del corso d’acqua, anche<br />
gli eventuali fenomeni <strong>di</strong> sormonto e tracimazione delle arginature, seguendo poi la <strong>di</strong>ffusione sul<br />
territorio circostante delle acque esondate.<br />
Le simulazioni effettuate hanno sostanzialmente confermato le considerazioni già sopra<br />
esposte nel merito della <strong>di</strong>namica fluviale del tratto terminale, ma hanno altresì evidenziato i limiti<br />
dell’approccio modellistico, i cui risultati sono inevitabilmente con<strong>di</strong>zionati dalle scelte <strong>di</strong> taratura dei<br />
modelli stessi, e, non ultimo, dalle assunzioni poste sui coefficienti <strong>di</strong> scabrezza. Prova ne è il fatto che le<br />
risultanze <strong>di</strong> questo secondo segmento <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o conducono a valutazioni più ottimistiche circa la<br />
massima portata <strong>di</strong> piena sostenibile dal <strong>Piave</strong> nel suo tratto terminale. Le conclusioni cui perviene sono<br />
in estrema sintesi le seguenti:<br />
l’attuale capacità <strong>di</strong> portata dell’alveo a valle <strong>di</strong> San Donà con altezze idrometriche al<br />
limite delle quote delle sommità arginali è <strong>di</strong> 3000‐3200 m 3 /s, ben inferiore quin<strong>di</strong> alle<br />
portate massime delle probabili piene in arrivo da monte;<br />
la propagazione lungo l’ampio letto ghiaioso tra Nervesa e Candelù comporta<br />
modestissime riduzioni delle portate al colmo che, allo stato attuale, sono destinate ad<br />
esondare a monte e a valle <strong>di</strong> Ponte <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> interessando, sia in destra che in sinistra,<br />
ampie superfici della pianura posta in a<strong>di</strong>acenza al fiume; essendo l’alveo leggermente<br />
36 <strong>di</strong> 83
Progetto: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio – RELAZIONE GEOLOGICA Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura<br />
geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico – Rev.:01<br />
Data: 28‐02‐2013 – Estensori: Prof. Geol. A. Bondesan, Dott.ssa S. Primon, Dott.ssa C. Levorato [Adastra srl]‐ Committente: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
pensile, le acque esondanti sarebbero destinate a spingersi a considerevole <strong>di</strong>stanza<br />
dall’alveo;<br />
con riguardo alla piena centenaria, critica risulta la con<strong>di</strong>zione delle arginature in tutto<br />
il tratto da Roncadelle a Salgareda in sinistra e da Candelù a S. Andrea <strong>di</strong> Barbarana, a<br />
monte <strong>di</strong> Zenson, in destra. Egualmente critica è la con<strong>di</strong>zione degli argini a valle <strong>di</strong><br />
San Donà e particolarmente nel tratto posto nelle imme<strong>di</strong>ate vicinanze <strong>di</strong> Intestadura;<br />
le quote idrometriche, soprattutto nei tratti dove l’alveo è canalizzato, sono<br />
influenzate dalla scelta adottata per i coefficienti <strong>di</strong> scabrezza. Questo aspetto è<br />
meritevole <strong>di</strong> un ulteriore approfon<strong>di</strong>mento sperimentale specifico.<br />
Sulla base <strong>di</strong> nuovi rilievi geometrici dell’alveo e <strong>di</strong> nuove ipotesi circa i coefficienti <strong>di</strong> scabrezza,<br />
il tratto terminale del <strong>Piave</strong> è stato nel 1998 oggetto <strong>di</strong> ulteriori stu<strong>di</strong> che hanno in sostanza risviluppato<br />
nuove simulazioni modellistiche sia a moto vario che a moto permanente.<br />
Le prove hanno riguardato l’insieme dei profili a moto permanente per portate comprese tra<br />
1500 m 3 /s e 3500 m 3 /s, ipotizzando un livello <strong>di</strong> massima marea posto a 1,90 m.s.m. Il raffronto tra i<br />
profili a moto permanente così ottenuti ed il profilo delle sommità arginali evidenzia significative criticità<br />
dovute ad un irregolare andamento delle sommità stesse.<br />
In particolare è stata rilevata una marcata depressione delle sommità arginali tra San Donà ed<br />
Eraclea ed in corrispondenza <strong>di</strong> Ponte <strong>di</strong> <strong>Piave</strong>, nonché una sensibile <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> quota tra le sommità<br />
arginali destra e sinistra nella tratta che va dal ponte <strong>di</strong> San Donà ed il ponte autostradale A4 Venezia‐<br />
Trieste.<br />
La depressione arginale che determina i limiti della capacità <strong>di</strong> portata a moto permanente è<br />
quella corrispondente alla tratta fluviale aventi estremi <strong>di</strong> progressiva pari a 12 e 18 km dal mare.<br />
All’interno <strong>di</strong> essa, la tratta <strong>di</strong> massima depressione arginale, compresa tra le progressive <strong>di</strong> 13,8 km e<br />
14,8 km, presenta capacità <strong>di</strong> portata, con l’adozione <strong>di</strong> un franco <strong>di</strong> 1 m, <strong>di</strong> appena 1700 m 3 /s. Detto<br />
valore è tuttavia decisamente cautelativo, in quanto riferito a con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> livello <strong>di</strong> mare eccezionali ed<br />
in presenza <strong>di</strong> barre <strong>di</strong> foce; appare pertanto ragionevole assumere la capacità massima nell’intera<br />
tratta terminale pari a 2100 m 3 /s.<br />
La tratta valliva in esame non presenta particolari singolarità che possano determinare marcate<br />
ostruzioni; ne consegue che l’insufficienza dell’attuale capacità <strong>di</strong> portata rispetto ai valori al colmo delle<br />
massime piene appare quin<strong>di</strong>, in generale, per insufficienza della sezione idraulica.<br />
La simulazione in ipotesi <strong>di</strong> moto vario ha inoltre consentito <strong>di</strong> valutare gli effetti <strong>di</strong> laminazione<br />
prodotti tra la fine delle Grave <strong>di</strong> Papadopoli e Zenson. Il profilo <strong>di</strong> inviluppo dei colmi relativo all’evento<br />
37 <strong>di</strong> 83
Progetto: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio – RELAZIONE GEOLOGICA Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura<br />
geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico – Rev.:01<br />
Data: 28‐02‐2013 – Estensori: Prof. Geol. A. Bondesan, Dott.ssa S. Primon, Dott.ssa C. Levorato [Adastra srl]‐ Committente: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
centenario si <strong>di</strong>spone grosso modo lungo il profilo permanente corrispondente a 3300 m 3 /s, anche<br />
laddove il valore al colmo del pletogramma sono alquanto superiori a detto valore, in relazione ai<br />
rilevanti effetti <strong>di</strong> laminazione dell’alveo.<br />
Non va peraltro <strong>di</strong>menticato come nel tratto compreso tra ponte <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> e San Donà sono<br />
presenti cinque importanti attraversamenti stradali o ferroviari: i ponti delle FF.SS. e dell’Anas a Ponte <strong>di</strong><br />
<strong>Piave</strong>, il ponte dell’autostrada A4 Venezia‐Trieste a monte <strong>di</strong> Noventa <strong>di</strong> <strong>Piave</strong>, il ponte delle FF.SS. a<br />
monte <strong>di</strong> San Donà ed il ponte <strong>di</strong> San Donà <strong>di</strong> <strong>Piave</strong>.<br />
Tutti i cinque ponti citati hanno l’intradosso posto a quota inferiore a quella massima raggiunta<br />
dalla piena centenaria e costituiscono pertanto non solo un serio ostacolo al deflusso della piena ma<br />
anche il rischio <strong>di</strong> sostenuti rigurgiti nelle sezioni imme<strong>di</strong>atamente a valle.<br />
4.3 ACQUE SOTTERRANEE<br />
Il bacino del <strong>Piave</strong> fa parte <strong>di</strong> un complesso sistema idrogeologico, comprendente gli acquiferi<br />
della zona <strong>di</strong> montagna, che hanno sede in formazioni <strong>di</strong> natura calcareo‐dolomitica, e gli acquiferi della<br />
zona <strong>di</strong> pianura, reperibili nei livelli ghiaiosi e/o sabbiosi, a geometria semplice.<br />
Gli acquiferi della zona <strong>di</strong> montagna, <strong>di</strong> notevole potenza, sono <strong>di</strong>stribuiti in ammassi rocciosi a<br />
bassa o elevata permeabilità per fratturazione.<br />
La ricarica è dovuta in massima parte alla infiltrazione <strong>di</strong>retta delle precipitazioni meteoriche e,<br />
in minor misura, ai corsi d'acqua, specialmente in corrispondenza ai perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> piena. La <strong>di</strong>scarica ha<br />
luogo attraverso le sorgenti <strong>di</strong> vario tipo, come ricarica dei corsi d'acqua nei tratti in cui questi ultimi<br />
esercitano una funzione drenante degli acquiferi, e, infine, come alimentazione dell'acquifero della<br />
fascia pedemontana della pianura, laddove si determinano situazioni <strong>di</strong> continuità idraulica.<br />
Il limite montagna‐pianura è caratterizzato da <strong>di</strong>fferenti con<strong>di</strong>zioni geolitologiche e strutturali.<br />
Nella zona <strong>di</strong> pianura, si può riscontrare:<br />
− un materasso ghiaioso grossolano nella zona pedemontana, riconducibile alle attività dell’asta<br />
principale, sede <strong>di</strong> un acquifero freatico in<strong>di</strong>fferenziato reperibile a quote decrescenti dal piede dei<br />
monti verso sud, fino ad affiorare nella fascia delle risorgive;<br />
− una alternanza <strong>di</strong> litotipi sabbiosi e litotipi argillosi‐limosi nella me<strong>di</strong>a e bassa pianura. Nei<br />
primi 30‐50 m è reperibile un acquifero freatico, piuttosto esteso ma non continuo, seguito in<br />
profon<strong>di</strong>tà da un altro acquifero, costituenti insieme un complesso superficiale <strong>di</strong> falde, <strong>di</strong> seguito<br />
in<strong>di</strong>cato come "acquifero superiore".<br />
38 <strong>di</strong> 83
Progetto: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio – RELAZIONE GEOLOGICA Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura<br />
geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico – Rev.:01<br />
Data: 28‐02‐2013 – Estensori: Prof. Geol. A. Bondesan, Dott.ssa S. Primon, Dott.ssa C. Levorato [Adastra srl]‐ Committente: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
Nella parte sottostante, fino alla profon<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> 300‐350 m, sono in<strong>di</strong>viduabili alcune falde in<br />
pressione costituenti il sistema dell’acquifero Inferiore‐falde confinate. Oltre tale profon<strong>di</strong>tà si riscontra<br />
la presenza persistente <strong>di</strong> acque salmastre. La ricarica dell'acquifero freatico in<strong>di</strong>fferenziato è dovuta<br />
alla infiltrazione <strong>di</strong>retta delle precipitazioni meteoriche dove le ghiaie, molto permeabili, sono coperte<br />
solo da un sottile strato <strong>di</strong> terreno vegetale, alla infiltrazione dall'alveo e dal subalveo dei fiumi<br />
principali, agli afflussi laterali dal substrato roccioso, almeno nei tratti in cui quest'ultimo è costituito da<br />
acquiferi calcarei, alla infiltrazione derivante dall’irrigazione. La <strong>di</strong>scarica naturale dell'acquifero freatico<br />
in<strong>di</strong>fferenziato ha luogo attraverso le risorgive e come ricarica degli acquiferi della me<strong>di</strong>a e bassa<br />
pianura. La ricarica dell'acquifero superiore è dovuta alla infiltrazione delle precipitazioni, relativamente<br />
modesta sia perché l'acquifero freatico vero e proprio non esiste in certe aree, sia perché i terreni<br />
affioranti non hanno una permeabilità elevata, ai contributi della irrigazione e, localmente, dei corsi<br />
d'acqua, nonché ai flussi laterali provenienti dall'acquifero freatico in<strong>di</strong>fferenziato. La <strong>di</strong>scarica naturale<br />
ha luogo lungo la linea <strong>di</strong> costa, attraverso i depositi sabbiosi litorali. La ricarica dell'acquifero inferiore‐<br />
falde confinate è determinata dagli afflussi laterali dell'acquifero freatico in<strong>di</strong>fferenziato. La <strong>di</strong>scarica<br />
artificiale degli acquiferi è invece rappresentata dai prelievi per vari scopi ed usi.<br />
Le con<strong>di</strong>zioni piezometriche degli acquiferi e le loro variazioni nel tempo, che costituiscono un<br />
elemento importante sia nella pianificazione territoriale sia nel quadro <strong>di</strong> una corretta gestione delle<br />
risorse, sono state più volte verificate con misure <strong>di</strong>rette a partire dall'ottobre 1981, utilizzando una rete<br />
<strong>di</strong> controllo costituita complessivamente da 220 pozzi freatici ed artesiani, quotati ex novo e<br />
uniformemente <strong>di</strong>stribuiti nel territorio.<br />
Per quanto riguarda l'acquifero freatico in<strong>di</strong>fferenziato a nord delle risorgive, si può<br />
considerare quanto segue:<br />
− in corrispondenza dell’asta principale e per tratti rilevanti del suo corso sono presenti dorsali<br />
molto pronunciate, con <strong>di</strong>rezioni <strong>di</strong> deflusso <strong>di</strong>vergenti dalle aste fluviali, a confermare il processo <strong>di</strong><br />
alimentazione e <strong>di</strong> <strong>di</strong>spersione in falda;<br />
− imme<strong>di</strong>atamente a monte della fascia delle risorgive l'andamento delle linee isofreatiche<br />
suggerisce il fenomeno inverso e cioè il drenaggio della falda da parte dei corsi d'acqua.<br />
La profon<strong>di</strong>tà della falda è molto variabile a seconda delle zone considerate: i valori maggiori si<br />
misurano a ridosso dei rilievi prealpini; da questi ultimi la profon<strong>di</strong>tà decresce gradualmente fino alle<br />
risorgive, dove la falda affiora in superficie. Le variazioni nel tempo del livello freatico assumono valori<br />
<strong>di</strong>versi in <strong>di</strong>pendenza della ubicazione dei pozzi rispetto alle aree <strong>di</strong> alimentazione: in prossimità delle<br />
risorgive le oscillazioni sono molto modeste, dell'or<strong>di</strong>ne, generalmente, <strong>di</strong> qualche decimetro; variazioni<br />
più accentuate si misurano al piede dei monti e in prossimità dei tratti <strong>di</strong>sperdenti dei corsi d'acqua; le<br />
39 <strong>di</strong> 83
Progetto: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio – RELAZIONE GEOLOGICA Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura<br />
geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico – Rev.:01<br />
Data: 28‐02‐2013 – Estensori: Prof. Geol. A. Bondesan, Dott.ssa S. Primon, Dott.ssa C. Levorato [Adastra srl]‐ Committente: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
oscillazioni minori si rilevano nelle aree <strong>di</strong> interfiume. Con<strong>di</strong>zioni particolari <strong>di</strong> deflusso si rilevano, come<br />
già precedentemente descritto, in corrispondenza dei tratti <strong>di</strong>sperdenti dei corsi d'acqua e dei più o<br />
meno marcati assi <strong>di</strong> drenaggio.<br />
Differentemente da quelle superficiali, le acque sotterranee non sempre risultano <strong>di</strong>sponibili in<br />
quantità sufficiente e, comunque, per renderle utilizzabili, spesso è necessario provvedere ad onerosi<br />
interventi <strong>di</strong> terebrazione, quali l'esecuzione <strong>di</strong> pozzi molto profon<strong>di</strong> e, talvolta, anche in notevole<br />
numero, in relazione alla potenzialità della falda ed alle caratteristiche fisiche dei terreni attraversati.<br />
Inoltre, non sempre i pozzi sono salienti, pertanto si rende in<strong>di</strong>spensabile procedere al sollevamento<br />
delle acque profonde me<strong>di</strong>ante consistenti opere <strong>di</strong> pompaggio.<br />
Dal punto <strong>di</strong> vista quantitativo la risorsa massima <strong>di</strong>sponibile era ed è rappresentata dalla<br />
<strong>di</strong>scarica delle risorgive, essendo inopportuno attingere dalla riserva regolatrice a monte delle risorgive<br />
stesse, per non alterare l'equilibrio <strong>di</strong>namico del complesso delle falde artesiane.<br />
Queste risorse risultano esuberanti rispetto agli utilizzi previsti, anche a lungo termine,<br />
offrendo quin<strong>di</strong> ampio spazio per una programmazione rispettosa delle esigenze idrografiche,<br />
ecologiche e <strong>di</strong> conservazione del suolo.<br />
Idrogeologicamente la zona più favorevole per i prelievi è la fascia a cavallo della linea delle<br />
risorgive, in considerazione:<br />
− della natura del serbatoio, ciottoloso e caratterizzato da alte trasmissività, che consente forti<br />
produzioni unitarie nei pozzi <strong>di</strong> sfruttamento;<br />
− delle alte portate specifiche che rendono relativamente modesto l'abbassamento della<br />
piezometrica, e cioè la riduzione <strong>di</strong> carico del sistema delle falde artesiane;<br />
− della minore <strong>di</strong>stanza delle zone <strong>di</strong> ricarica sotterranea che facilita un incremento<br />
dell'apporto in seguito alla <strong>di</strong>minuzione del carico idrostatico;<br />
grossolani;<br />
− del minore pericolo <strong>di</strong> fenomeni <strong>di</strong> subsidenza, che sono praticamente inesistenti in depositi<br />
− della quota più elevata rispetto alla pianura che favorisce un trasporto per gravità nella rete<br />
<strong>di</strong> adduzione e riduce i costi <strong>di</strong> gestione.<br />
La qualità delle acque sotterranee è generalmente adeguata all'uso potabile, in special modo<br />
quella delle aree montane.<br />
falde confinate.<br />
Parimenti adeguata risulta la qualità delle acque contenute all'interno dell'acquifero inferiore‐<br />
40 <strong>di</strong> 83
Progetto: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio – RELAZIONE GEOLOGICA Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura<br />
geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico – Rev.:01<br />
Data: 28‐02‐2013 – Estensori: Prof. Geol. A. Bondesan, Dott.ssa S. Primon, Dott.ssa C. Levorato [Adastra srl]‐ Committente: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
Tali acque, in considerazione della notevole estensione areale dell'acquifero, costituiscono<br />
senza dubbio la risorsa idrica <strong>di</strong> maggior interesse per l'uso potabile. Pur tuttavia esse presentano un<br />
consistente grado <strong>di</strong> vulnerabilità che certamente non può essere trascurato nell'ambito dell'analisi<br />
delle possibili fonti <strong>di</strong> approvvigionamento idropotabile. Tale vulnerabilità e in <strong>di</strong>retta <strong>di</strong>pendenza della<br />
vastità dell'area degli acquiferi e della sua indeterminatezza fisica. Per questo motivo la Giunta<br />
Regionale del Veneto, me<strong>di</strong>ante il Piano <strong>di</strong> Risanamento delle Acque (PRRA), ha in<strong>di</strong>viduato fra gli<br />
obiettivi primari <strong>di</strong> intervento il <strong>di</strong>sinquinamento delle acque nella zona <strong>di</strong> ricarica delle falde,<br />
in<strong>di</strong>rizzando verso tali zone una parte cospicua dei futuri interventi.<br />
Inoltre, mentre per le acque superficiali gli effetti dell'eventuale contaminazione risultano<br />
generalmente temporanei e comunque verificabili e controllabili in maniera sufficientemente agevole,<br />
ciò non si verifica per le acque sotterranee, per le quali le sorgenti <strong>di</strong> inquinamento sono sempre <strong>di</strong><br />
incerta in<strong>di</strong>viduazione e gli effetti, peraltro <strong>di</strong>fficilmente definibili e controllabili, si prolungano nel<br />
tempo a causa dei modesti valori delle velocità <strong>di</strong> filtrazione anche in mezzi notevolmente porosi.<br />
4.4 ANALISI DEL RISCHIO IDRAULICO NEL BACINO DEL SILE<br />
PERICOLOSITÀ IDRAULICA<br />
Dalle elaborazioni condotte tramite le simulazioni matematiche e dalle procedure e criteri per<br />
la definizione delle aree pericolose è stato possibile giungere ad una valutazione della pericolosità<br />
esistente nel territorio del bacino del Sile.<br />
A questo proposito si ricorda che i parametri considerati nella determinazione della pericolosità<br />
dovuta al fenomeno <strong>di</strong> allagamento sono stati l’altezza dell’acqua ed il tempo <strong>di</strong> ritorno e che la<br />
pericolosità è stata quin<strong>di</strong> <strong>di</strong>stinta in tre classi:<br />
‐pericolosità P1 ‐ moderata: il territorio è soggetto ad allagamenti per eventi con tempo <strong>di</strong><br />
ritorno pari a 100 anni;<br />
‐pericolosità P2 ‐me<strong>di</strong>a: il territorio è soggetto ad allagamenti caratterizzati da un altezza<br />
dell’acqua inferiore al metro per eventi con tempo <strong>di</strong> ritorno pari a 50 anni;<br />
‐pericolosità P3 ‐ elevata: il territorio è soggetto ad allagamenti caratterizzati da un altezza<br />
dell’acqua superiore al metro per eventi con tempo <strong>di</strong> ritorno pari a 50 anni.<br />
I risultati ottenuti da queste elaborazioni sono rappresentati nella Carta della pericolosità<br />
idraulica (figura 11) con una scala a colori simboleggianti i livelli <strong>di</strong> pericolosità.<br />
E’ da osservare che le aree allagate risultanti dalle simulazioni matematiche sono state estese<br />
portando, in alcuni casi, il limite dell’allagamento all’elemento morfologico (strada, canale, rilevati in<br />
genere) più vicino.<br />
41 <strong>di</strong> 83
Progetto: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio – RELAZIONE GEOLOGICA Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura<br />
geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico – Rev.:01<br />
Data: 28‐02‐2013 – Estensori: Prof. Geol. A. Bondesan, Dott.ssa S. Primon, Dott.ssa C. Levorato [Adastra srl]‐ Committente: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
RISCHIO IDRAULICO<br />
A valle della confluenza con il Musestre, in sinistra Sile, zone molto estese <strong>di</strong> tipo R1<br />
coinvolgono il bacino <strong>di</strong> Portesine e <strong>di</strong> Caposile, dove sono però presenti anche modeste estensioni<br />
classificate come R2 (figura 12). Da citare, tra queste ultime, un’area periferica dell’abitato <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> ed<br />
un’altra area posta in corrispondenza della strada statale n. 14 Venezia‐Giulia.<br />
A valle <strong>di</strong> Caposile ampie zone risultano classificate come R1 sia in sinistra che in destra fino alla<br />
foce. Sul lato laguna sono coinvolti i terreni situati tra il fiume Sile e la laguna stessa, dove ampie aree<br />
sono classificate <strong>di</strong> tipo R2, tra Caposile e Jesolo.<br />
Figura 11: Carta della pericolosità idraulica<br />
42 <strong>di</strong> 83
Progetto: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio – RELAZIONE GEOLOGICA Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura<br />
geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico – Rev.:01<br />
Data: 28‐02‐2013 – Estensori: Prof. Geol. A. Bondesan, Dott.ssa S. Primon, Dott.ssa C. Levorato [Adastra srl]‐ Committente: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
Figura 12: Carta del rischio idraulico<br />
4.5 VULNERABILITÀ DELLE RISORSE IDRICHE SOTTERRANEE<br />
[fonte: Carta della vulnerabilita’ degli acquiferi della Provincia <strong>di</strong> Venezia: Metodo SINTACS]<br />
I dati provengono dalla carta della vulnerabilità intrinseca degli acquiferi all’inquinamento della<br />
Provincia <strong>di</strong> Venezia. La carta è stata realizzata applicando il “Point Count System Model” (SINTACS).<br />
Data la densità <strong>di</strong> dati <strong>di</strong>sponibili la carta ha scala nominale <strong>di</strong> 1:50.000, che è una tipica scala adatta alla<br />
pianificazione territoriale. Di questo bisogna tenerne conto nelle applicazioni per elaborazioni a scale <strong>di</strong><br />
maggiore dettaglio.<br />
In questo lavoro, come viene fatto usualmente nelle cartografie <strong>di</strong> vulnerabilità idrogeologica,<br />
l'acquifero analizzato è il primo (falda freatica o debolmente confinata).<br />
Si tratta del primo corpo idrico sotterraneo a partire dal piano campagna che sia alloggiato in<br />
materiali con sufficiente grado <strong>di</strong> permeabilità e <strong>di</strong> porosità efficace che consentono una significativa<br />
portata estraibile (terreni da limoso‐sabbiosi a ghiaiosi). Non si considerano quin<strong>di</strong> come falda i corpi<br />
idrici sotterranei inclusi nei terreni poco permeabili o prevalentemente impermeabili.<br />
43 <strong>di</strong> 83
Progetto: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio – RELAZIONE GEOLOGICA Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura<br />
geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico – Rev.:01<br />
Data: 28‐02‐2013 – Estensori: Prof. Geol. A. Bondesan, Dott.ssa S. Primon, Dott.ssa C. Levorato [Adastra srl]‐ Committente: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
La vulnerabilità intrinseca delle acque sotterranee in<strong>di</strong>ca la naturale facilità con cui le stesse<br />
possono essere interessate da fenomeni <strong>di</strong> contaminazione causati da interventi antropici, me<strong>di</strong>ante<br />
infiltrazione, propagazione e trasporto <strong>di</strong> inquinanti.<br />
L'interesse per la vulnerabilità intrinseca della prima falda, nella specifica situazione ambientale<br />
del territorio veneziano deriva in particolare dal fatto che si tratta della falda <strong>di</strong>rettamente in contatto<br />
con molte attiviità antropiche ed in comunicazione con la rete scolante superficiale.<br />
La carta è stata prodotta utilizzando il Metodo Sintacs che prevede:<br />
la realizzazione <strong>di</strong> una serie <strong>di</strong> carte tematiche interme<strong>di</strong>e<br />
realizzazione della cartografia <strong>di</strong> sintesi con la zonazione del territorio secondo la<br />
classificazione Sintacs (6 classi <strong>di</strong> vulnerabilità).<br />
classi <strong>di</strong> vulnerabilità intervallo sintacs intervallo sintacs<br />
normalizzato<br />
Bassissima 0 ‐ 80 0 ‐ 24<br />
Bassa 81 ‐ 105 25 ‐ 35<br />
Me<strong>di</strong>a 106 ‐ 140 36 ‐ 49<br />
Alta 141 ‐ 186 50 ‐ 69<br />
Elevata 187 ‐ 210 70 ‐ 79<br />
Elevatissima 211 ‐ 260 80 ‐ 100<br />
Tabella – Classi <strong>di</strong> vulnerabilità e punteggi previsti dal metodo SINTACS.<br />
4.6 ELABORAZIONE DELLA CARTA IDROGEOLOGICA<br />
Nel seguente paragrafo sono descritti i dati e le fonti reperiti per l’elaborazione della Carta<br />
Idrogeologica ed è illustrata la metodologia <strong>di</strong> analisi e <strong>di</strong> elaborazione che ha portato alla redazione<br />
della Carta seguendo le voci <strong>di</strong> legenda derivanti dal documento “Grafie Unificate per gli strumenti<br />
urbanistici comunali” <strong>di</strong> cui alla D.G.R. n. 615/1996. La tipologia <strong>di</strong> dati e le fonti utilizzate sono descritti<br />
prendendo in analisi ad una ad una le voci presenti nella legenda della Carta stessa e analizzando <strong>di</strong><br />
volta in volta il processo <strong>di</strong> elaborazione svolto.<br />
IDROLOGIA DI SUPERFICIE<br />
I‐SUP‐01 “limite <strong>di</strong> bacino idrografico e spartiacque locali” (DGR 615/1996).<br />
Il territorio comunale <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> è limitato a nord‐est dal fiume <strong>Piave</strong> lungo la cui<br />
44 <strong>di</strong> 83
Progetto: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio – RELAZIONE GEOLOGICA Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura<br />
geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico – Rev.:01<br />
Data: 28‐02‐2013 – Estensori: Prof. Geol. A. Bondesan, Dott.ssa S. Primon, Dott.ssa C. Levorato [Adastra srl]‐ Committente: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
RETE IDROGRAFICA<br />
asta si sviluppa il tratto terminale del Bacino Idrografico. Il territorio che si sviluppa a<br />
sud‐ovest del <strong>Piave</strong> rientra nel Bacino idrografico del fiume Sile.<br />
I limiti sono stati ricavati dal file c0401091_BaciniIdrograficiPTA.shp fornito dalla<br />
Regione Veneto per la compilazione delle banche dati del Quadro Conoscitivo.<br />
Primitiva geometrica: Linea<br />
La rappresentazione della rete idrografica nella cartografia idrogeologica secondo la classificazione<br />
presente nel DGR 915/1996 è stata eseguita a partire dal file idrograf.shp appartenente al pacchetto <strong>di</strong><br />
file della C.T.R. La quasi totalità dei corsi d’acqua è stata classificata come canale artificiale, mentre solo<br />
il fiume <strong>Piave</strong> e la <strong>Piave</strong> Vecchia sono stati in<strong>di</strong>cati come corsi d’acqua permanente.<br />
I‐SUP‐02 “corso d'acqua permanente” (DGR 615/1996).<br />
Primitiva geometrica: Linea<br />
I‐SUP‐04 “canale artificiale” (DGR 615/1996).<br />
Primitiva geometrica: Linea<br />
I‐SUP‐10 “idrovora” (DGR 615/1996).<br />
Le idrovore presenti nel <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> sono state rilevate grazie ai dati<br />
forniti dal Consorzio <strong>di</strong> Bonifica Basso <strong>Piave</strong>.<br />
Nel <strong>Comune</strong> sono risultate le seguenti Idrovore: 1. Lanzoni, 2. Croce N.1, 3. Croce N.2, 4.<br />
Capodargine, 5. S. Marco, 6. Case Bianche.<br />
Primitiva geometrica: Punto<br />
I‐SUP‐11 “botte o sifone” (DGR 615/1996).<br />
I sifoni o botte presenti nel <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> sono stati rilevati grazie ai dati.<br />
45 <strong>di</strong> 83
Progetto: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio – RELAZIONE GEOLOGICA Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura<br />
geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico – Rev.:01<br />
Data: 28‐02‐2013 – Estensori: Prof. Geol. A. Bondesan, Dott.ssa S. Primon, Dott.ssa C. Levorato [Adastra srl]‐ Committente: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
ACQUE SOTTERRANEE<br />
shp forniti dalla Provincia <strong>di</strong> Venezia.<br />
Nel <strong>Comune</strong> è presente un unico sifone o botte: 1. Varrotte.<br />
Primitiva geometrica: Punto<br />
I‐SOT‐06 “pozzo freatico” (DGR 615/1996).<br />
E’ stata in<strong>di</strong>cata con questa voce la quasi totalità dei pozzi in<strong>di</strong>viduati nel territorio<br />
comunale, con profon<strong>di</strong>tà comprese tra 10 e 170 m dal p.c., a partire dalle banche dati<br />
fornite dalla Regione Veneto e dalla Provincia <strong>di</strong> Venezia per la redazione del Quadro<br />
Conoscitivo.<br />
Il posizionamento corretto dei pozzi è presente nella Carta Idrogeologica mentre nel<br />
file. dbf c0502013_CartaIdrogeologicaP sono riportate tutte le informazioni raccolte per<br />
ogni pozzo (profon<strong>di</strong>tà, lotto, località, anno, <strong>di</strong>ametro, attività, uso, consumo annuo,<br />
presenza <strong>di</strong> analisi chimiche e <strong>di</strong> stratigrafia, portate spontanee, presenza <strong>di</strong> un<br />
<strong>di</strong>spositivo <strong>di</strong> sollevamento).<br />
Primitiva geometrica: Punto<br />
Di seguito si riporta la collocazione dei file shape, e i rispettivi nomi dei metadati associati:<br />
PERCORSO: PAT<strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong>\c_QuadroConoscitivo\c05_SuoloSottosuolo\ c0502_Idrogeologia<br />
METADATO: c0502011_CartaIdrogeologicaA<br />
METADATO: c0502012_CartaIdrogeologicaL<br />
METADATO: c0502013_CartaIdrogeologicaP<br />
5 Carta Geomorfologica<br />
La Carta Geomorfologica è il frutto dell’analisi del tema c0503‐Geomorfologia e dei suoi relativi<br />
sottotemi; le voci <strong>di</strong> legenda derivano dal documento “Grafie Unificate per gli strumenti urbanistici<br />
comunali” <strong>di</strong> cui alla D.G.R. n. 615/1996. In tale documento le voci <strong>di</strong> legenda sono state selezionate<br />
46 <strong>di</strong> 83
Progetto: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio – RELAZIONE GEOLOGICA Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura<br />
geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico – Rev.:01<br />
Data: 28‐02‐2013 – Estensori: Prof. Geol. A. Bondesan, Dott.ssa S. Primon, Dott.ssa C. Levorato [Adastra srl]‐ Committente: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
dalla legenda pre<strong>di</strong>sposta dal Servizio Geologico Nazionale per la Carta Geomorfologica d’Italia alla scala<br />
1:50.000, che riprende i criteri per il rilevamento delle unità geomorfologiche per la rappresentazione<br />
delle forme e dei processi geomorfologici me<strong>di</strong>ante apposita simbologia derivante dai risultati del lavoro<br />
<strong>di</strong> una specifica Commissione regionale pubblicati sulla Rivista del Centro Interregionale per la<br />
Documentazione e le Informazioni Territoriali n. 15‐16 del 1989.<br />
I dati elaborati sono stati restituiti in formato. shp nelle seguenti classi:<br />
i. c0503011_CartaGeomorfologicaA.shp (aree);<br />
ii. c0503012_CartaGeomorfologicaL.shp (linee);<br />
iii. c0503013_CartaGeomorfologicaP.shp (punti).<br />
5.1 INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO<br />
5.1.1 Lineamenti generali<br />
Al margine orientale dell’area descritta (figura 13) domina la presenza del grande dosso del<br />
<strong>Piave</strong> attuale. A Fossalta <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> un ventaglio <strong>di</strong> rotta si apre verso sud‐ovest prolungandosi in un<br />
blando dosso che continua nella Fossetta. Non vi è traccia <strong>di</strong> collegamenti con altri elementi<br />
paleoidrografici e l’origine è probabilmente connessa con una rotta sulla sponda <strong>di</strong> bótta del meandro.<br />
Ai pie<strong>di</strong> del dosso del <strong>Piave</strong>, in destra idrografica, non si osservano tracce fluviali o lagunari<br />
particolarmente rilevanti.<br />
47 <strong>di</strong> 83
Progetto: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio – RELAZIONE GEOLOGICA Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura<br />
geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico – Rev.:01<br />
Data: 28‐02‐2013 – Estensori: Prof. Geol. A. Bondesan, Dott.ssa S. Primon, Dott.ssa C. Levorato [Adastra srl]‐ Committente: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
Figura 13: Stralcio della Carta geomorfologica della Provincia <strong>di</strong> Venezia, Bondesan & Meneghel (a cura <strong>di</strong>) - 2004.<br />
Più a ovest, il dosso <strong>di</strong> Meolo costituisce l’elemento maggiormente rilevato sulla pianura. Si<br />
tratta <strong>di</strong> una culminazione poco pronunciata, orientata in senso NO‐SE, isolata, che manifesta una<br />
prosecuzione da monte attraverso l’affioramento <strong>di</strong> sabbie, mentre si apre a valle in un ventaglio<br />
generato probabilmente dagli spostamenti laterali <strong>di</strong> antichi corsi fluviali. Alcune tracce allungate e ben<br />
definite proseguono verso est, oltre La Fossetta e potrebbero essere collegate agli antichi percorsi del<br />
Meolo. Il dosso, segnalato a est de La Fossetta, è stato in tempi recenti spianato in seguito a opere <strong>di</strong><br />
miglioria fon<strong>di</strong>aria e ha quin<strong>di</strong> perso la sua elevazione, ma è descritto in letteratura nelle sue con<strong>di</strong>zioni<br />
originarie (FAVERO, 1992). L’origine del dosso <strong>di</strong> Meolo è collegata a una importante <strong>di</strong>ramazione <strong>di</strong> un<br />
<strong>Piave</strong> pleistocenico o olocenico antico che già si era <strong>di</strong>sattivato almeno 8000 anni fa; CASTIGLIONI & FAVERO<br />
(1987) lo collegano alle tracce <strong>di</strong> Rovarè e Monastier. Indagini archeologiche <strong>di</strong> superficie (BROGLIO,<br />
FAVERO & MARSALE, 1987) hanno in<strong>di</strong>viduato siti mesolitici presenti sulla superficie del dosso, fatto che<br />
consente <strong>di</strong> stabilire una data ante‐quem <strong>di</strong> <strong>di</strong>sattivazione del dosso.<br />
48 <strong>di</strong> 83
Progetto: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio – RELAZIONE GEOLOGICA Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura<br />
geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico – Rev.:01<br />
Data: 28‐02‐2013 – Estensori: Prof. Geol. A. Bondesan, Dott.ssa S. Primon, Dott.ssa C. Levorato [Adastra srl]‐ Committente: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
Tra Meolo e Losson della Battaglia è ben visibile il paleoalveo del Fosso <strong>di</strong> Losson, conosciuto<br />
anche come Meolo Vecchio. Il paleoalveo, con la sua fascia <strong>di</strong> <strong>di</strong>vagazione, risulta inciso sulla pianura<br />
pleistocenica e non ha dato luogo alla formazione <strong>di</strong> un dosso, essendo la sua origine legata a una fase <strong>di</strong><br />
incisione fluviale plavense. Un campione <strong>di</strong> torba prelevato al fondo dei depositi <strong>di</strong> riempimento del<br />
paleo‐canale, ha permesso <strong>di</strong> datare l’inizio della fase <strong>di</strong> chiusura del sistema attorno ai 5280±45 anni<br />
14 C B.P. Questo antico percorso è stato successivamente ripreso da un corso d’acqua minore,<br />
probabilmente il Meolo, ancora attivo in età moderna come si evince dalle numerose rappresentazioni<br />
nella cartografia storica.<br />
Più a ovest, la successiva <strong>di</strong>rettrice plavense è data dal Musestre che collega Biancade, Roncade<br />
e San Cipriano. Si osserva una lingua sabbiosa all’interno della quale si in<strong>di</strong>vidua un paleoalveo<br />
delimitato da una depressione allungata. A valle <strong>di</strong> San Cipriano mancano le evidenze geomorfologiche<br />
<strong>di</strong> un collegamento con altri rami fluviali, anche se il corso attuale del Musestre prosegue in linea retta<br />
fino a raggiungere il Sile presso la località omonima <strong>di</strong> Musestre.<br />
Tra Sile e Musestre si osserva un paleoalveo inciso che all’incirca da San Cipriano raggiunge<br />
l’attuale alveo del Sile; a oriente del centro <strong>di</strong> Santa Lucia è evidente una depressione allungata e ben<br />
definita, connessa con ogni evidenza a una fase <strong>di</strong> incisione fluviale la cui origine è problematica.<br />
Una grande traccia <strong>di</strong> paleoalveo dal letto largo circa 250 m e con raggio <strong>di</strong> curvatura superiore<br />
al chilometro si in<strong>di</strong>vidua tra San Cipriano e Meolo. Esso scorre all’incirca in <strong>di</strong>rezione ovest‐est e pare<br />
possedere una tipologia a canali intrecciati. La traccia possiede <strong>di</strong>mensioni e caratteristiche tali da<br />
poterla ascrivere a un corso d’acqua pleistocenico attivo probabilmente durante la fase <strong>di</strong> low stand del<br />
livello marino e in ogni caso alimentato da elevate portate liquide e solide. La sua <strong>di</strong>rezione potrebbe far<br />
pensare a un’enclave del Brenta all’interno della megaconoide del <strong>Piave</strong>: tale ipotesi dovrà essere<br />
confermata da ulteriori indagini <strong>di</strong> campagna.<br />
Spostandosi verso sud, nel settore più prossimo al corso del Sile, si osservano numerose tracce<br />
fluviali <strong>di</strong> origine ed età <strong>di</strong>versa; le datazioni eseguite su torbe presenti negli orizzonti superficiali della<br />
piana <strong>di</strong> esondazione hanno fornito un’età tra i 21.000 e i 16.000 anni 14 C B.P. (Bondesan & Mozzi,<br />
2002). Più interessanti per la loro connessione con il tracciato della via Annia, sono gli elementi<br />
paleoidrografici minori che si rinvengono nell’area a sud <strong>di</strong> Cà Tron verso il margine lagunare. Tra questi<br />
si evidenzia il paleoalveo della Canna, ampiamente descritto in Bondesan et al. (2004), un corso d’acqua<br />
alimentato sia dalle acque <strong>di</strong> risorgiva sia da quelle <strong>di</strong> ruscellamento superficiale, che ha sfruttato il solco<br />
preesistente <strong>di</strong> una <strong>di</strong>rettrice pleistocenica plavense. Il paleoalveo attraversa due tracciati alternativi<br />
della via Annia in corrispondenza dei quali sono stati rinvenuti i resti <strong>di</strong> due ponti (Busana & Ghe<strong>di</strong>ni,<br />
2004). Lungo il percorso della via Annia più prossimo al margine lagunare (tracciato più “esterno”),<br />
datazioni al ra<strong>di</strong>ocarbonio effettuate su elementi lignei fanno risalire il ponte <strong>di</strong> legno al 1000 a.C. circa,<br />
49 <strong>di</strong> 83
Progetto: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio – RELAZIONE GEOLOGICA Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura<br />
geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico – Rev.:01<br />
Data: 28‐02‐2013 – Estensori: Prof. Geol. A. Bondesan, Dott.ssa S. Primon, Dott.ssa C. Levorato [Adastra srl]‐ Committente: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
mentre il ponte rinvenuto sul percorso più “interno” è stato utilizzato dalla fine del I sec. a.C. fino al<br />
Rinascimento. I depositi pleistocenici, all’interno dei quali il paleoalveo della Canna è inciso, hanno<br />
fornito un’età <strong>di</strong> 16.190±50 anni 14 C B.P., alla profon<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> 2,7 m dal piano campagna. I se<strong>di</strong>menti<br />
organici prelevati all’interno dell’alveo, hanno stabilito invece un’età pari a 795‐390 anni a.C. (2460±70<br />
anni 14 C B.P.) alla base del riempimento, mentre in posizione me<strong>di</strong>ana sono stati datati a 420‐200 anni<br />
a.C. (a –1,95 m dal p.c.) e a 160 a.C.‐40 d.C. (a –1,65 m dal p.c.).<br />
Superata l’area del ponte interno, non è del tutto chiara la prosecuzione verso valle del<br />
tracciato del paleoalveo della Canna. L’osservazione delle immagini telerilevate sembrerebbe in<strong>di</strong>care<br />
un collegamento con il paleoalveo del Fosson, ma non si può escludere una prosecuzione verso<br />
Portegran<strong>di</strong>, oltre il Fossetta, dove si osserva una traccia che per morfometria e <strong>di</strong>mensioni risulta<br />
essere compatibile con il tracciato del paleoalveo della Canna.<br />
Un altro sistema <strong>di</strong> paleoalvei è dato dalle tracce <strong>di</strong> Marteggia. Si tratta <strong>di</strong> elementi<br />
paleoidrografici meno evidenti, orientati in senso ovest–est. Una <strong>di</strong> queste tracce mostra un netto<br />
collegamento col paleoalveo del canale Canellara oltre al Fossetta e, in corrispondenza<br />
dell’attraversamento dell’Annia scorreva sotto un ponte <strong>di</strong> età romana (CROCE DA VILLA 1991; CROCE DA<br />
VILLA, 2003).<br />
La presenza del ponte permette <strong>di</strong> stabilire come il corso d’acqua fosse attivo durante le fasi<br />
d’uso della strada. Questa traccia, corrispondente al “Vallio <strong>di</strong> Marteggia”, configura una situazione<br />
paleoambientale del tutto analoga al paleoalveo della Canna: il paleoalveo ha un debole risalto (stessa<br />
riflettanza nelle foto aeree), rivela un’analoga sezione trasversale ed è superato dall’Annia da un ponte<br />
<strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni limitate. (BONDESAN A. & MOZZI, 2002b). Le datazioni eseguite sui campioni prelevati tra i 3<br />
e i 4 m <strong>di</strong> profon<strong>di</strong>tà hanno fornito una data superiore ai 20.000 anni a 14 C BP, confermando il modello<br />
proposto <strong>di</strong> una pianura pleistocenica incisa da corsi d’acqua attivi circa duemila anni fa.<br />
Nel settore compreso all’incirca tra il Taglio del Sile e il Fossetta, a ridosso del tracciato della via<br />
Annia, si osserva un reticolo dendritico che per la sua geometria può essere identificato come un<br />
sistema <strong>di</strong> paleo–canali lagunari. Le indagini <strong>di</strong> campagna (BONDESAN A. & MOZZI, 2002a) hanno<br />
confermato la presenza <strong>di</strong> se<strong>di</strong>menti lagunari all’interno degli alvei che risultano a loro volta incisi sulla<br />
pianura alluvionale. Ciò significa che i canali lagunari hanno risalito i precedenti corsi fluviali<br />
ere<strong>di</strong>tandone il tracciato principale. Dai rami più gran<strong>di</strong> si <strong>di</strong>partono tuttavia altri canali minori, meno<br />
definiti, la cui genesi è strettamente lagunare. Il dosso della Fossetta (conosciuto anche come dosso <strong>di</strong><br />
Millepertiche) sembra bordare a nord l’ingressione lagunare, mentre l’insieme delle tracce è confinato<br />
all’interno dell’isoipsa –1 nell’intero tratto compreso tra Portegran<strong>di</strong> e Caposile, occupando la<br />
depressione definita con l’apposito simbolo. Mentre tale reticolo appare organizzato e gerarchizzato sul<br />
50 <strong>di</strong> 83
Progetto: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio – RELAZIONE GEOLOGICA Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura<br />
geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico – Rev.:01<br />
Data: 28‐02‐2013 – Estensori: Prof. Geol. A. Bondesan, Dott.ssa S. Primon, Dott.ssa C. Levorato [Adastra srl]‐ Committente: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
canale Lanzoni, più a oriente le tracce sono <strong>di</strong>scontinue, sparse e afferenti a una <strong>di</strong>namica idraulica <strong>di</strong><br />
origine marcatamente palustre e lagunare.<br />
Facendo riferimento al reticolo confluente nel Lanzoni e quin<strong>di</strong> nel Cenesa, in laguna <strong>di</strong> Venezia<br />
(figura 14), si possono riconoscere <strong>di</strong>verse <strong>di</strong>rettrici <strong>di</strong> drenaggio. Tre sono i rami principali: il Canellara, il<br />
Fossonetto e il Fosson. Partendo dal settentrionale Canellara, si osserva a sud–ovest del dosso <strong>di</strong> Meolo<br />
una rete <strong>di</strong> drenaggio naturale costituita da fiumi come il Variol, il Vallio e il suo affluente Arnasa, che<br />
defluendo verso le bassure drenano la vasta area compresa tra Roncade e Meolo. Tutti questi fiumi<br />
hanno lasciato una traccia, anche se spesso debole, dei loro antichi percorsi, in particolare il Vallio, che<br />
dopo la confluenza con l'Arnasa si <strong>di</strong>vide in due rami: l'o<strong>di</strong>erno fiume Vallio e il Colatore Vallio. Tra la<br />
località <strong>di</strong> Marteggia e il Taglio del Sile si possono in<strong>di</strong>viduare alcuni paleoalvei che aiutano a ricostruire<br />
gli originari tracciati <strong>di</strong> questi corsi d'acqua: il fiume Vallio si immetteva nel canale Fosson, mentre l'altro<br />
ramo (l'o<strong>di</strong>erno Colatore Vallio) si univa, percorrendo in parte il canale ora chiamato Canellara, al Vallio<br />
nel canale Lanzoni. Quest'ultimo, infine, riceveva le acque <strong>di</strong> un ramo del Sile, il Siletto, e insieme<br />
formavano il canale Cenesa. Anche il Meolo probabilmente confluiva nel canale Lanzoni. Infatti A. COMEL<br />
in<strong>di</strong>ca l'attuale Colatore Meolo come percorso originario <strong>di</strong> questo fiume e cita una mappa del 1547 in<br />
cui si vedono chiaramente l'affluire del Meolo nella Fossetta e il suo successivo <strong>di</strong>stacco per proseguire a<br />
oriente fino a raggiungere l'attuale canale Lanzoni. Nelle fotografie aeree tutti questi paleoalvei si<br />
presentano poco marcati (sono caratterizzati da tracce che hanno un colore molto simile a quello dei<br />
terreni circostanti) e spesso sono <strong>di</strong> <strong>di</strong>fficile lettura.<br />
51 <strong>di</strong> 83
Progetto: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio – RELAZIONE GEOLOGICA Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura<br />
geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico – Rev.:01<br />
Data: 28‐02‐2013 – Estensori: Prof. Geol. A. Bondesan, Dott.ssa S. Primon, Dott.ssa C. Levorato [Adastra srl]‐ Committente: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
Figura 14: Principali <strong>di</strong>rettrici <strong>di</strong> deflusso tra Sile e <strong>Piave</strong>.<br />
Questo, probabilmente, è dovuto al fatto che si tratta <strong>di</strong> percorsi legati a fiumi <strong>di</strong> risorgiva con<br />
portate modeste e scarso potere <strong>di</strong> incisione, che hanno quin<strong>di</strong> lasciato una debole traccia del loro<br />
passaggio in questa parte <strong>di</strong> territorio (PRIMON, 2002). Il paleoalveo del Cannellara è stato stu<strong>di</strong>ato in<br />
sezione e datato. Due campioni prelevati a circa 1,5–2 m <strong>di</strong> profon<strong>di</strong>tà hanno fornito le date <strong>di</strong> 1650–<br />
1110 a.C. e 1440–1100 a.C., mentre lo strato imme<strong>di</strong>atamente superiore, ricco <strong>di</strong> resti <strong>di</strong> canna palustre<br />
e con caratteri tali da attribuirne un’origine lagunare, è stato datato nell’intervallo 1040–1290 d.C. Esiste<br />
quin<strong>di</strong> una <strong>di</strong>scontinuità nella serie se<strong>di</strong>mentaria, che interessa un intervallo cronologico superiore ai<br />
duemila anni. I depositi inferiori datati a più <strong>di</strong> 3000 anni fa sono con ogni probabilità se<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> tipo<br />
fluviale, quin<strong>di</strong> continentali, mentre il successivo riempimento me<strong>di</strong>oevale è dato da se<strong>di</strong>menti lagunari.<br />
52 <strong>di</strong> 83
Progetto: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio – RELAZIONE GEOLOGICA Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura<br />
geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico – Rev.:01<br />
Data: 28‐02‐2013 – Estensori: Prof. Geol. A. Bondesan, Dott.ssa S. Primon, Dott.ssa C. Levorato [Adastra srl]‐ Committente: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
Questa osservazione può essere estesa all’intero comparto: la rete <strong>di</strong> paleoalvei che si osserva è data da<br />
incisioni fluviali su una piana alluvionale, solo successivamente occupata da acque lagunari (BONDESAN A.,<br />
MOZZI 2002b).<br />
Il ramo centrale del Fossonetto è stato anch’esso analizzato in sezione trasversale confermando<br />
il quadro stratigrafico descritto sopra. I se<strong>di</strong>menti continentali prelevati a circa 3 m <strong>di</strong> profon<strong>di</strong>tà hanno<br />
fornito una datazione pari a 3940–3620 anni a.C. (4920±80 a 14 C BP) che rappresenta la data olocenica<br />
più antica dell’intero tratto <strong>di</strong> pianura. Appena più a monte, sono state datate le torbe ricche <strong>di</strong> resti<br />
vegetali rinvenute all’interno del paleo–canale lagunare ricavando una data <strong>di</strong> 440–720 anni a.C.<br />
(1430±80 a 14 C BP).<br />
Il Sile costituisce con il suo dosso l’elemento morfologico <strong>di</strong> maggior spicco elevandosi fino alla<br />
quota <strong>di</strong> 7 m s.l.m. in corrispondenza del margine occidentale della carta geomorfologica. I suoi depositi<br />
costituiscono l’unità del Sile (BONDESAN, CALDERONI & MOZZI, 2002) impostatasi sulla giunzione tra la<br />
porzione me<strong>di</strong>o–<strong>di</strong>stale dell’unità <strong>di</strong> Bassano e le unità <strong>di</strong> Montebelluna e <strong>di</strong> Nervesa. Tale unità occupa<br />
a monte la depressione posta tra i conoi<strong>di</strong> <strong>di</strong> Bassano e <strong>di</strong> Montebelluna, una bassura <strong>di</strong> risorgiva<br />
allungata in senso ovest‐est, che a valle <strong>di</strong> Treviso si incunea tra i conoi<strong>di</strong> <strong>di</strong> Bassano e <strong>di</strong> Nervesa. Si ha<br />
testimonianza <strong>di</strong> una prima fase <strong>di</strong> riempimento <strong>di</strong> quest’ultimo segmento <strong>di</strong> depressione <strong>di</strong><br />
interconoide, protrattosi fino a oltre 7475240 a 14 C BP (MOZZI, 1998); segue un momento <strong>di</strong> incisione,<br />
che porta la piana <strong>di</strong> <strong>di</strong>vagazione del Sile a essere confinata all’interno <strong>di</strong> un avvallamento incassato<br />
alcuni metri rispetto alla circostante pianura. In prossimità del margine lagunare l’unità del Sile cessa <strong>di</strong><br />
essere incassata nelle unità <strong>di</strong> Bassano e <strong>di</strong> Nervesa per ricoprirle, costituendo anche un piccolo delta<br />
endolagunare.<br />
Il dosso del Sile rappresentato nella carta geomorfologica è stretto e allungato ed è marcato<br />
dalla presenza delle sabbie che seguono tutto il corso fluviale in destra e in sinistra. I se<strong>di</strong>menti post‐<br />
romani deposti dal Sile hanno uno spessore <strong>di</strong> circa un metro e mezzo in prossimità dell’alveo attuale e<br />
sembrano ricoprire le superfici più antiche <strong>di</strong> età pleistocenica. Il superamento del Sile da parte della via<br />
Annia e la scoperta dei resti <strong>di</strong> un ponte romano in corrispondenza dell’attraversamento depongono a<br />
favore <strong>di</strong> una sostanziale stabilità del tracciato fluviale. Il fatto che la via Annia sia visibile anche sopra i<br />
se<strong>di</strong>menti del dosso potrebbe essere imputato alla continuità d’uso della strada fino a qualche secolo fa.<br />
Un carotaggio condotto in prossimità dell’argine sinistro ha consentito <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare depositi<br />
sabbiosi (figura 3) collegabili a una occupazione dell’alveo da parte del <strong>Piave</strong> durante l’Olocene. I<br />
se<strong>di</strong>menti occupano un’incisione profonda circa 12 m rispetto alla circostante piana pleistocenica e larga<br />
meno <strong>di</strong> 600 m. L’età dei se<strong>di</strong>menti pleistocenici nei quali si sviluppa l’incisione fluviale data a<br />
20.300±220 a 14 C BP (profon<strong>di</strong>tà pari a 14,4 m dal piano campagna) mentre il riempimento sabbioso è<br />
stato datato al tetto 2140–1910 a.C. (3650±40 a 14 C BP, profon<strong>di</strong>tà pari a 5,1 m dal piano campagna); più<br />
53 <strong>di</strong> 83
Progetto: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio – RELAZIONE GEOLOGICA Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura<br />
geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico – Rev.:01<br />
Data: 28‐02‐2013 – Estensori: Prof. Geol. A. Bondesan, Dott.ssa S. Primon, Dott.ssa C. Levorato [Adastra srl]‐ Committente: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
a monte, nei pressi <strong>di</strong> Casier (TV), MOZZI (1995, 1998) segnala la deposizione ancora attiva delle ghiaie<br />
del <strong>Piave</strong> almeno fino a 3275±135 a 14 C BP come si evince dalla datazione 14 C eseguita su <strong>di</strong> una ceppaia<br />
seppellita all’interno dei depositi ghiaiosi. Pertanto, sembra provato che tra la fine del III e l’inizio del II<br />
millennio a.C. il <strong>Piave</strong> sia defluito all’interno del Sile, mentre l’ipotesi che il <strong>Piave</strong> seguisse questo<br />
percorso anche in epoca Romana non trova per ora un riscontro nei dati stratigrafici.<br />
I meandri del Sile o<strong>di</strong>erno sono accompagnati da tracce poco marcate la cui origine è<br />
probabilmente legata a fasce <strong>di</strong> maggior umi<strong>di</strong>tà. Nel tratto più vicino a Portegran<strong>di</strong> il dosso assume una<br />
maggior evidenza anche a causa delle aree depresse poste sotto il livello del mare, che bordano il<br />
margine interno della laguna. Queste bassure <strong>di</strong> fatto in<strong>di</strong>viduano l’estensione verso l’interno delle<br />
antiche lagune. L’antica foce del Sile si ubica all’interno della laguna in corrispondenza del delta<br />
endolagunare in<strong>di</strong>cato in carta. La traccia desunta da cartografia storica mostra l’andamento del corso<br />
d’acqua precedente la sua inalveazione artificiale nel Taglio del Sile.<br />
Dal punto <strong>di</strong> vista altimetrico la pianura assume una generale blanda inclinazione verso sud e<br />
verso sud–est in accordo con la geometria dell’ala destra della megaconoide <strong>di</strong> Nervesa. Le emergenze<br />
sono date dai dossi <strong>di</strong> Meolo e <strong>di</strong> Millepertiche, mentre le forme negative si in<strong>di</strong>viduano in<br />
corrispondenza dell’incisione del Musestre e <strong>di</strong> Sant’Elena. Lo scolo Arnasa mostra inoltre alla sua<br />
testata un’incisione da erosione regressiva. La più ampia forma negativa è data dalla bassura che segue<br />
il Taglio del Sile, oggi maggiormente enfatizzata dai processi <strong>di</strong> subsidenza superficiale legati alla bonifica<br />
idraulica. È infatti marcata la <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> quota tra il fondo della laguna attuale e i terreni a nord del<br />
Taglio del Sile, i quali si trovano a quote relativamente più basse proprio per l’effetto della costipazione<br />
dei se<strong>di</strong>menti a causa della <strong>di</strong>minuita controspinta idrostatica e della <strong>di</strong>ssoluzione della sostanza<br />
organica un tempo presente nei se<strong>di</strong>menti bonificati. L’isoipsa zero segue all’incirca il tracciato della via<br />
Annia.<br />
I se<strong>di</strong>menti superficiali sono essenzialmente limosi, mentre la sabbia affiora in corrispondenza<br />
dei principali percorsi fluviali quali il Sile, il Musestre, il Meolo e il <strong>Piave</strong>. Plaghe sabbiose si trovano poi<br />
isolate nella pianura. Le argille sono essenzialmente concentrate lungo il margine lagunare e nell’area<br />
compresa tra La Fossetta (Colatore Principale) e la <strong>Piave</strong> Vecchia.<br />
Le sabbie sono state analizzate in profon<strong>di</strong>tà in occasione <strong>di</strong> uno stu<strong>di</strong>o condotto su un<br />
transetto <strong>di</strong> carotaggi eseguito perpen<strong>di</strong>colarmente al Sile su una <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> circa 5 km, finanziato dalla<br />
Fondazione Cassamarca (rapporto interno, ine<strong>di</strong>to). Le sabbie sono state analizzate dal punto <strong>di</strong> vista<br />
mineralogico e petrografico e hanno permesso <strong>di</strong> stabilire una commistione <strong>di</strong> contributi del Brenta e<br />
del <strong>Piave</strong> in profon<strong>di</strong>tà (i campioni analizzati sono stati prelevati a profon<strong>di</strong>tà comprese tra zero e 20 m)<br />
e una prevalenza <strong>di</strong> apporti plavensi in superficie. Questo significa che durante l’attività fluviale tardo–<br />
pleistocenica Brenta e <strong>Piave</strong> si contendevano lo spazio e mescolavano le proprie alluvioni, mentre in<br />
54 <strong>di</strong> 83
Progetto: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio – RELAZIONE GEOLOGICA Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura<br />
geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico – Rev.:01<br />
Data: 28‐02‐2013 – Estensori: Prof. Geol. A. Bondesan, Dott.ssa S. Primon, Dott.ssa C. Levorato [Adastra srl]‐ Committente: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
seguito alla <strong>di</strong>sattivazione del ramo pleistocenico del Brenta, i depositi plavensi sono <strong>di</strong>ventati il solo<br />
fattore <strong>di</strong> aggradazione della Pianura.<br />
5.2 ELABORAZIONE DELLA CARTA GEOMORFOLOGICA<br />
Nel seguente paragrafo sono descritti i dati e le fonti reperiti per l’elaborazione della Carta<br />
Geomorfologica ed è illustrata la metodologia <strong>di</strong> analisi e <strong>di</strong> elaborazione che ha portato alla redazione<br />
della Carta seguendo le voci <strong>di</strong> legenda derivanti dal documento “Grafie Unificate per gli strumenti<br />
urbanistici comunali” <strong>di</strong> cui alla D.G.R. n. 615/1996. La tipologia <strong>di</strong> dati e le fonti utilizzate sono descritti<br />
prendendo in analisi ad una ad una le voci presenti nella legenda della Carta stessa e descrivendo <strong>di</strong><br />
volta in volta il processo <strong>di</strong> elaborazione svolto.<br />
Figura 15: Carta della rilevanza della subsidenza<br />
55 <strong>di</strong> 83
Progetto: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio – RELAZIONE GEOLOGICA Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura<br />
geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico – Rev.:01<br />
Data: 28‐02‐2013 – Estensori: Prof. Geol. A. Bondesan, Dott.ssa S. Primon, Dott.ssa C. Levorato [Adastra srl]‐ Committente: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
FORME STRUTTURALI E VULCANICHE<br />
Figura 16: Carta della velocità <strong>di</strong> subsidenza<br />
M‐STR‐03“limite <strong>di</strong> area <strong>di</strong> subsidenza o sprofondamento” (DGR 615/1996).<br />
Sono state segnalate come “aree <strong>di</strong> subsidenza”, ovvero come aree in cui si registra<br />
annualmente un abbassamento <strong>di</strong> quota del piano campagna, le aree in cui, sulla base<br />
dei dati forniti dalla Provincia <strong>di</strong> Venezia, il fenomeno presenta una rilevanza<br />
principalmente da MEDIA ad ALTA (vd. Allegato 3 Tavola 03/B‐03, figura 15).<br />
Coincidono con queste aree le aree caratterizzate da velocità <strong>di</strong> subsidenza variabile<br />
da 1 a 3 mm/anno (vd. Allegato 3 Tavola 03/A‐03, figura 16).<br />
Le aree <strong>di</strong> subsidenza si trovano principalmente nelle zone meri<strong>di</strong>onali e centrali del<br />
<strong>Comune</strong>, nelle quali prevalgono le tessiture fini e i suoli organici.<br />
Primitiva geometrica: Linea<br />
M‐STR‐18 “isoipse del microrilievo con in<strong>di</strong>cazione della quota” (DGR 615/1996).<br />
I dati per lo sviluppo <strong>di</strong> questa voce sono stati ricavati da “Bondesan A., Meneghel M.<br />
56 <strong>di</strong> 83
Progetto: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio – RELAZIONE GEOLOGICA Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura<br />
geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico – Rev.:01<br />
Data: 28‐02‐2013 – Estensori: Prof. Geol. A. Bondesan, Dott.ssa S. Primon, Dott.ssa C. Levorato [Adastra srl]‐ Committente: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
(a cura <strong>di</strong>), Geomorfologia della Provincia <strong>di</strong> Venezia, Esedra E<strong>di</strong>trice, Padova, 2004”.<br />
Per la rappresentazione delle isoipse è stato utilizzato il microrilievo della Provincia <strong>di</strong><br />
Venezia costruito sugli elementi alla scala 1:5000 della CTRN e realizzato per classi <strong>di</strong><br />
0,5 metri (figura 17).<br />
Primitiva geometrica: Linea<br />
Figura 17: Modello <strong>di</strong>gitale del terreno<br />
FORME FLUVIALI E DI VERSANTE DOVUTE AL DILAVAMENTO<br />
TRACCIA DI CORSO FLUVIALE ESTINTO, A LIVELLO DI PIANURA O LEGGERMENTE INCASSATO<br />
Si tratta <strong>di</strong> alvei relitti che hanno risalto morfologico o evidenza all’osservazione in quanto luoghi a<br />
se<strong>di</strong>mentazione <strong>di</strong>fferenziata. La loro presenza è in<strong>di</strong>cata dal fatto che i se<strong>di</strong>menti che occludono il vecchio<br />
alveo o i suoli che si sviluppano in superficie hanno caratteristiche <strong>di</strong>verse rispetto ai terreni circostanti;<br />
57 <strong>di</strong> 83
Progetto: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio – RELAZIONE GEOLOGICA Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura<br />
geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico – Rev.:01<br />
Data: 28‐02‐2013 – Estensori: Prof. Geol. A. Bondesan, Dott.ssa S. Primon, Dott.ssa C. Levorato [Adastra srl]‐ Committente: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
essi vengono riconosciuti, in modo <strong>di</strong>retto o in<strong>di</strong>retto, nelle immagini telerilevate per il contrasto che<br />
presentano con il terreno che attraversano. Hanno generalmente una forma allungata, nastriforme con<br />
limiti da netti a lineari a sfumati.<br />
I dati per lo sviluppo <strong>di</strong> questa voce sono stati ricavati da “Bondesan A., Meneghel M. (a cura <strong>di</strong>),<br />
Geomorfologia della Provincia <strong>di</strong> Venezia, Esedra E<strong>di</strong>trice, Padova, 2004”, e sono stati <strong>di</strong>stinti, in tracce<br />
certe e incerte:<br />
M‐FLU‐06 “traccia <strong>di</strong> corso fluviale estinto, a livello <strong>di</strong> pianura o leggermente incassato<br />
” (DGR 615/1996).<br />
Primitiva geometrica: Linea<br />
M‐FLU‐07 “traccia <strong>di</strong> corso fluviale estinto, a livello <strong>di</strong> pianura o leggermente<br />
incassato, incerto ” (DGR 615/1996).<br />
Primitiva geometrica: Linea<br />
M‐FLU‐13 “<strong>di</strong> esondazione” (DGR 615/1996).<br />
I ventagli <strong>di</strong> esondazione sono corpi se<strong>di</strong>mentari che si formano ad opera <strong>di</strong> acque che<br />
fuoriescono da un alveo fluviale in occasione <strong>di</strong> piene con tracimazione dell’argine o<br />
per la rottura dell’argine stesso. I se<strong>di</strong>menti vengono deposti a ventaglio, in forma <strong>di</strong><br />
conoide irregolare; i più grossolani nelle vicinanze della rotta, i più fini in posizione<br />
<strong>di</strong>stale.<br />
L’unica traccia presente all’interno del territorio comunale è quella del ventaglio <strong>di</strong><br />
esondazione <strong>di</strong> Fossalta <strong>di</strong> <strong>Piave</strong>, <strong>di</strong> cui si osserva un piccolo lembo a ridosso del dosso<br />
attuale del fiume <strong>Piave</strong>.<br />
I dati per lo sviluppo <strong>di</strong> questa voce sono stati ricavati da “Bondesan A., Meneghel M.<br />
(a cura <strong>di</strong>), Geomorfologia della Provincia <strong>di</strong> Venezia, Esedra E<strong>di</strong>trice, Padova, 2004”.<br />
Primitiva geometrica: Area<br />
M‐FLU‐33 “area depressa in pianura alluvionale; conca <strong>di</strong> decantazione” (DGR<br />
58 <strong>di</strong> 83
Progetto: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio – RELAZIONE GEOLOGICA Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura<br />
geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico – Rev.:01<br />
Data: 28‐02‐2013 – Estensori: Prof. Geol. A. Bondesan, Dott.ssa S. Primon, Dott.ssa C. Levorato [Adastra srl]‐ Committente: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
615/1996).<br />
Ambienti depressi sono caratteristici delle pianure fluviali e costiere dove il modello è<br />
quello <strong>di</strong> fiumi che elevano argini naturali, mentre le zone più <strong>di</strong>stali <strong>di</strong>vengono aree<br />
umide a drenaggio <strong>di</strong>fficile. Le aree depresse sono tali sia perché la se<strong>di</strong>mentazione è<br />
ridotta, trovandosi in posizione marginale rispetto alle aste fluviali, sia perché gli scarsi<br />
se<strong>di</strong>menti che si depongono sono ricchi <strong>di</strong> sostanza organica, che tende a compattarsi<br />
e ossidarsi, dando luogo a subsidenza. Si vengono così a creare <strong>di</strong>slivelli anche <strong>di</strong><br />
parecchi metri tra i dossi fluviali e il fondo delle depressioni marginali. Un ruolo<br />
importante nella formazione delle aree depresse è rivestito dalle aree soggette a<br />
bonifica idraulica.<br />
Si rimanda, per una miglior comprensione della <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> tali aree, oltre che alla<br />
Carta Geomorfologica, al Modello Digitale del Terreno riportato all’Allegato 3 Tavola<br />
01/A‐03.<br />
I dati per lo sviluppo <strong>di</strong> questa voce sono stati ricavati da “Bondesan A., Meneghel M.<br />
(a cura <strong>di</strong>), Geomorfologia della Provincia <strong>di</strong> Venezia, Esedra E<strong>di</strong>trice, Padova, 2004”.<br />
Primitiva geometrica: Area<br />
M‐FLU‐35 “dosso fluviale” (DGR 615/1996).<br />
I dossi fluviali sono rilievi, elevati da pochi decimetri a parecchi metri sulla pianura<br />
circostante, ampi da qualche centinaio <strong>di</strong> metri a più <strong>di</strong> un chilometro e lunghi anche<br />
decine <strong>di</strong> chilometri. Sono formati dalla deposizione <strong>di</strong> se<strong>di</strong>menti grossolani, spesso<br />
sabbie, ai lati dell’alveo <strong>di</strong> fiumi che formano argini naturali e che, durante la<br />
formazione del dosso, scorrono alla sommità dello stesso. Quando il fiume abbandona<br />
il tracciato in seguito a una deviazione, i se<strong>di</strong>menti si assestano formando una dorsale<br />
appiattita, al centro della quale in qualche caso si conserva la traccia dell’alveo,<br />
frequentemente riempito <strong>di</strong> se<strong>di</strong>menti fini.<br />
Al territorio comunale <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> appartiene il settore situato in destra<br />
idrografica dell’attuale dosso del fiume <strong>Piave</strong> e del ramo della <strong>Piave</strong> Vecchia. Il dosso<br />
segnalato a est de La Fossetta, è stato in tempi recenti spianato in seguito a opere <strong>di</strong><br />
miglioria fon<strong>di</strong>aria e ha quin<strong>di</strong> perso la sua elevazione.<br />
I dati per lo sviluppo <strong>di</strong> questa voce sono stati ricavati da “Bondesan A., Meneghel M.<br />
59 <strong>di</strong> 83
Progetto: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio – RELAZIONE GEOLOGICA Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura<br />
geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico – Rev.:01<br />
Data: 28‐02‐2013 – Estensori: Prof. Geol. A. Bondesan, Dott.ssa S. Primon, Dott.ssa C. Levorato [Adastra srl]‐ Committente: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
FORME ARTIFICIALI<br />
(a cura <strong>di</strong>), Geomorfologia della Provincia <strong>di</strong> Venezia, Esedra E<strong>di</strong>trice, Padova, 2004”.<br />
Primitiva geometrica: Linea<br />
M‐MAR‐08 “traccia <strong>di</strong> canale lagunare in piana bonificata” (DGR 615/1996).<br />
Tutto il territorio comunale presenta <strong>di</strong>ffuse tracce <strong>di</strong> paleoalvei che <strong>di</strong>segnano una<br />
rete <strong>di</strong> corsi d’acqua ben evidenziata soprattutto nel settore meri<strong>di</strong>onale.<br />
Particolarmente interessante è infatti la fascia compresa tra il Taglio del Sile e via<br />
Millepertiche, dove si osserva un fitto intreccio <strong>di</strong> paleoalvei ben delineati<br />
corrispondenti ad antichi canali lagunari.<br />
I dati per lo sviluppo <strong>di</strong> questa voce sono stati ricavati da “Bondesan A., Meneghel M.<br />
(a cura <strong>di</strong>), Geomorfologia della Provincia <strong>di</strong> Venezia, Esedra E<strong>di</strong>trice, Padova, 2004”.<br />
Primitiva geometrica: Linea<br />
M‐ART‐18 “<strong>di</strong>scarica, terrapieno” (DGR 615/1996).<br />
E’ stata in<strong>di</strong>viduata come cava abbandonata o <strong>di</strong>smessa l’ex <strong>di</strong>scarica <strong>di</strong> via Caposile,<br />
conosciuta anche con il nome <strong>di</strong> Case Bianche.<br />
Primitiva geometrica: Area<br />
M‐ART‐21 “alveo <strong>di</strong> corso d’acqua pensile” (DGR 615/1996).<br />
È in<strong>di</strong>cato con questa caratteristica l’alveo del fiume <strong>Piave</strong>. Un alveo presenta caratteri<br />
<strong>di</strong> pensilità quando le sue acque scorrono ad una quota superiore a quella del piano<br />
campagna.<br />
I dati per lo sviluppo <strong>di</strong> questa voce sono stati ricavati da “Bondesan A., Meneghel M.<br />
(a cura <strong>di</strong>), Geomorfologia della Provincia <strong>di</strong> Venezia, Esedra E<strong>di</strong>trice, Padova, 2004”.<br />
Primitiva geometrica: Linea<br />
60 <strong>di</strong> 83
Progetto: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio – RELAZIONE GEOLOGICA Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura<br />
geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico – Rev.:01<br />
Data: 28‐02‐2013 – Estensori: Prof. Geol. A. Bondesan, Dott.ssa S. Primon, Dott.ssa C. Levorato [Adastra srl]‐ Committente: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
M‐ART‐25 “argini principali” (DGR 615/1996).<br />
I dati per lo sviluppo <strong>di</strong> questa voce sono stati ricavati da “Bondesan A., Meneghel M.<br />
(a cura <strong>di</strong>), Geomorfologia della Provincia <strong>di</strong> Venezia, Esedra E<strong>di</strong>trice, Padova, 2004”.<br />
Primitiva geometrica: Linea<br />
Di seguito si riporta la collocazione dei file shape, e i rispettivi nomi dei metadati associati:<br />
PERCORSO: PAT<strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong>\c_QuadroConoscitivo\c05_SuoloSottosuolo\ c0503_Geomorfologia<br />
METADATO: c0503011_CartaGeomorfologicaA<br />
METADATO: c0503012_CartaGeomorfologicaL<br />
METADATO: c0503013_CartaGeomorfologicaP<br />
6 Fragilità derivanti dall’analisi geologica<br />
La Carta delle Fragilità è una carta <strong>di</strong> progetto del PAT che nasce <strong>di</strong>rettamente dall’elaborazione<br />
e dall’intersezione delle informazioni ricavate dall’analisi della matrice 05 Suolo e Sottosuolo effettuata<br />
per la creazione del quadro conoscitivo.<br />
In questa Carta, ai sensi degli atti <strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzo della L.R. 11/2004 e dei successivi aggiornamenti<br />
pubblicati nel sito della Regione Veneto www.regione.veneto.it, il territorio viene sud<strong>di</strong>viso in base alle<br />
voci <strong>di</strong> legenda del tema “Compatibilità geologica ai fini urbanistici” in tre zone: Aree idonee, Aree<br />
idonee a con<strong>di</strong>zione e Aree non idonee.<br />
Le precedenti “Penalità ai fini e<strong>di</strong>ficatori” che sud<strong>di</strong>videvano i terreni in cinque classi (terreno<br />
ottimo, buono, me<strong>di</strong>ocre, scadente e pessimo) in base alle caratteristiche del substrato, delle pendenze,<br />
<strong>di</strong> drenaggio e <strong>di</strong> caratteristiche geomeccaniche, vengono in questa carta sostituite dalla “Compatibilità<br />
geologica ai fini urbanistici” che, oltre a presentare una nuova sud<strong>di</strong>visione del terreno in tre classi<br />
denominate Area idonea, Area idonea a con<strong>di</strong>zione e Area non idonea, permette una definizione <strong>di</strong><br />
61 <strong>di</strong> 83
Progetto: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio – RELAZIONE GEOLOGICA Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura<br />
geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico – Rev.:01<br />
Data: 28‐02‐2013 – Estensori: Prof. Geol. A. Bondesan, Dott.ssa S. Primon, Dott.ssa C. Levorato [Adastra srl]‐ Committente: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
compatibilità dell’uso del territorio anche per aspetti <strong>di</strong>versi da quello dell’e<strong>di</strong>ficabilità, come ad<br />
esempio la tutela delle risorse geologiche ed idrogeologiche e la vulnerabilità degli acquiferi.<br />
La normativa, inoltre, prevede una <strong>di</strong>stinzione delle aree idonee a con<strong>di</strong>zione, in base alle<br />
problematiche presenti, e prevede che per ogni tipologia d’area siano redatte specifiche norme tecniche<br />
nelle quali, oltre a descrivere le caratteristiche dell’area, vengano in<strong>di</strong>cate le indagini e le valutazioni che<br />
devono essere condotte per ogni singolo caso.<br />
Il territorio comunale <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> complessivamente è stato sud<strong>di</strong>viso in 10 zone, e<br />
precisamente sono state in<strong>di</strong>cate le aree idonee e 9 <strong>di</strong>verse aree idonee a con<strong>di</strong>zione.<br />
Infine è stata segnalata una tipologia <strong>di</strong> aree soggette a <strong>di</strong>ssesto idrogeologico: aree esondabili<br />
o a ristagno idrico.<br />
6.1 COMPATIBILITÀ GEOLOGICA AI FINI URBANISTICI<br />
In questo paragrafo vengono descritte ad una ad una le <strong>di</strong>verse zone in cui è stato sud<strong>di</strong>viso il<br />
comune, a partire dall’analisi geologica (figura 18).<br />
6.1.1 AREE IDONEE<br />
Sono state valutate idonee all’utilizzazione urbanistica le aree del territorio che si estendono<br />
lungo le arginature naturali del fiume <strong>Piave</strong> e della <strong>Piave</strong> Vecchia e una fascia allungata da ovest<br />
verso est riferibile ad un’antica via <strong>di</strong> deflusso del fiume <strong>Piave</strong>. Entrambe queste aree,<br />
sviluppate in senso longitu<strong>di</strong>nale lungo attuali ed antiche <strong>di</strong>rettrici fluviali, appaiono costituite<br />
in prevalenza da materiali sabbiosi deposti dall’attività dei fiumi stessi (vd. Allegato 3 Tavola<br />
06/A‐03 “Carta della compatibilità geologica”).<br />
I terreni costituiti dai depositi del <strong>Piave</strong> attuale, oltre ad avere una tessitura sabbiosa e<br />
sabbioso‐limosa (con spessori che possono anche superare i 10 m <strong>di</strong> profon<strong>di</strong>tà) sono ubicati<br />
anche in una posizione topograficamente rilevata rispetto al resto del territorio (da +4 a 0 m<br />
s.l.m.), trovandosi in con<strong>di</strong>zioni favorevoli per la presenza <strong>di</strong> un <strong>di</strong>screto drenaggio delle acque<br />
sia superficiali che profonde grazie ad una permeabilità me<strong>di</strong>a (vd Allegato 3 Tavola 01/A‐03<br />
“Modello <strong>di</strong>gitale del terreno”).<br />
Mentre la fascia <strong>di</strong> territorio in località Millepertiche, pur non trovandosi in con<strong>di</strong>zioni<br />
topograficamente rilevate è costituita da depositi sabbiosi che in corrispondenza del<br />
paleodosso raggiungono spessori <strong>di</strong> pochi metri.<br />
62 <strong>di</strong> 83
Progetto: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio – RELAZIONE GEOLOGICA Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura<br />
geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico – Rev.:01<br />
Data: 28‐02‐2013 – Estensori: Prof. Geol. A. Bondesan, Dott.ssa S. Primon, Dott.ssa C. Levorato [Adastra srl]‐ Committente: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
Per tali aree, quin<strong>di</strong>, data la loro idoneità geologica, non vengono date particolari specifiche<br />
tecniche, ma si ricorda che qualsiasi progetto, la cui realizzazione preveda una interazione con i<br />
terreni è sottoposto alle <strong>di</strong>sposizioni presenti nelle vigenti “Nuove norme tecniche per le<br />
costruzioni” DM Infrastrutture 14 gennaio 2008 pubblicato su S.O. n. 30 alla G.U. 4 febbraio<br />
2008, n. 29, Cap. 6 “Progettazione geotecnica”, e eventuali successivi aggiornamenti o<br />
mo<strong>di</strong>fiche.<br />
Per tali aree, quin<strong>di</strong>, data la loro idoneità geologica, non vengono date particolari specifiche<br />
tecniche, ma si ricorda che qualsiasi progetto, la cui realizzazione preveda una interazione con i<br />
terreni è sottoposto alle <strong>di</strong>sposizioni presenti nelle vigenti “Nuove norme tecniche per le<br />
costruzioni” DM Infrastrutture 14 gennaio 2008 pubblicato su S.O. n. 30 alla G.U. 4 febbraio<br />
2008, n. 29, Cap. 6 “Progettazione geotecnica”, e eventuali successivi aggiornamenti o<br />
mo<strong>di</strong>fiche.<br />
6.1.2 AREE IDONEE A CONDIZIONE<br />
CONDIZIONE: A “Aree <strong>di</strong> piana alluvionale in<strong>di</strong>stinta”<br />
AREE:<br />
SPECIFICHE<br />
TECNICHE:<br />
Rientrano in questa categoria tutti i terreni che occupano la maggior<br />
parte dei territori centrali del comune <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong>. Si tratta <strong>di</strong><br />
zone con caratteristiche litologiche molto variabili sia in senso laterale<br />
che in senso verticale. Queste aree, infatti, sono state interessate<br />
dall’evoluzione dell’antica idrografia superficiale minore o sono state<br />
generate dall’aggradazione <strong>di</strong> alluvioni come conseguenza dalle<br />
frequenti esondazioni. Queste aree sono costituite in buona parte da<br />
depositi alluvionali fini, in prevalenza limo‐argillosi, argillosi con<br />
presenza <strong>di</strong> strati sabbiosi a <strong>di</strong>verse profon<strong>di</strong>tà e livelli torbosi con<br />
spessori anche <strong>di</strong> qualche metro rilevati sia in superficie che in<br />
profon<strong>di</strong>tà.<br />
Le quote <strong>di</strong> queste aree, per la gran parte sotto il livello del mare, sono<br />
interessate da un modello <strong>di</strong> drenaggio artificiale <strong>di</strong> canali e scoli <strong>di</strong><br />
bonifica; la permeabilità e da me<strong>di</strong>a a me<strong>di</strong>o‐bassa.<br />
In queste aree devono essere condotte specifiche indagini geologiche<br />
per poter generare al meglio il modello geologico del sito, orientato alla<br />
ricostruzione dei caratteri stratigrafici, tessiturali e geomorfologici del<br />
63 <strong>di</strong> 83
Progetto: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio – RELAZIONE GEOLOGICA Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura<br />
geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico – Rev.:01<br />
Data: 28‐02‐2013 – Estensori: Prof. Geol. A. Bondesan, Dott.ssa S. Primon, Dott.ssa C. Levorato [Adastra srl]‐ Committente: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
territorio. Esso deve essere realizzato in modo da poter <strong>di</strong>stinguere le<br />
aree nelle quali prevalgono i se<strong>di</strong>menti fini da quelle in cui sono<br />
presenti orizzonti sabbiosi più superficiali e per valutare con precisione<br />
la profon<strong>di</strong>tà alla quale compaiono strati sabbiosi con spessori tali da<br />
poter rappresentare una base adeguata per eventuali opere <strong>di</strong><br />
fondazione; il modello geologico così costituito <strong>di</strong>venta un<br />
fondamentale elemento <strong>di</strong> riferimento per l’inquadramento, da parte<br />
del progettista, delle problematiche geotecniche presenti, ovvero le<br />
verifiche <strong>di</strong> sicurezza relative agli stati limite ultimi SLU che<br />
rappresentano le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> rottura del terreno, e agli stati limite <strong>di</strong><br />
esercizio SLE, che rappresentano la valutazione dell’entità delle<br />
deformazioni intese come ce<strong>di</strong>menti del terreno su cui insiste l’opera<br />
stessa (riferimento normativo: “Nuove norme tecniche per le<br />
costruzioni” DM Infrastrutture 14 gennaio 2008 pubblicato su S.O. n. 30<br />
alla G.U. 4 febbraio 2008, n. 29, Cap. 6 “Progettazione geotecnica”, e<br />
eventuali successivi aggiornamenti o mo<strong>di</strong>fiche”).<br />
Nella aree a con<strong>di</strong>zione A è richiesto <strong>di</strong> porre particolare attenzione alla<br />
valutazione degli stati limite <strong>di</strong> esercizio, in quanto nella con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong><br />
forte alternanza sia verticale che laterale <strong>di</strong> terreni sabbiosi e terreni<br />
fini organici potrebbero verificarsi sia ce<strong>di</strong>menti eccessivi nelle aree in<br />
cui prevalgono i materiali fini che ce<strong>di</strong>menti <strong>di</strong>fferenziali nelle aree in<br />
cui si presentano entrambi i materiali, che potrebbero in ugual misura<br />
compromettere la stabilità delle strutture.<br />
Data l’alternanza <strong>di</strong> strati granulari e strati più coesivi, ma soprattutto<br />
data la presenza <strong>di</strong> <strong>di</strong>rettrici sabbiose che più facilmente possono<br />
drenare e incanalare le acque <strong>di</strong> falda rispetto ai depositi fini che le<br />
ospitano, è richiesta anche particolare attenzione al problema della<br />
tenuta dei fronti <strong>di</strong> scavo: la capacità della parete <strong>di</strong> scavo <strong>di</strong><br />
autosostenersi in assenza <strong>di</strong> opere <strong>di</strong> stabilizzazione deve essere<br />
valutata in sede progettuale in modo rigoroso. Nel caso in esame data<br />
la possibilità che si verifichino sifonamenti per annullamento delle<br />
tensioni efficaci nelle sabbie, vanno definite le con<strong>di</strong>zioni geologiche e<br />
idrogeologiche, le caratteristiche geometriche dello scavo, le<br />
caratteristiche geotecniche del terreno (angolo d’attrito e coesione) e le<br />
64 <strong>di</strong> 83
Progetto: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio – RELAZIONE GEOLOGICA Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura<br />
geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico – Rev.:01<br />
Data: 28‐02‐2013 – Estensori: Prof. Geol. A. Bondesan, Dott.ssa S. Primon, Dott.ssa C. Levorato [Adastra srl]‐ Committente: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
con<strong>di</strong>zioni al contorno dello scavo (presenza <strong>di</strong> sovraccarichi in<br />
prossimità della parete <strong>di</strong> scavo, quali costruzioni, e<strong>di</strong>fici, …).<br />
Date le con<strong>di</strong>zioni stratigrafiche <strong>di</strong> tali terreni, ad eccezioni <strong>di</strong> situazioni<br />
che potranno essere particolarmente favorevoli, è possibile che le<br />
fondazioni superficiali non siano adeguate per opere tipo e<strong>di</strong>fici ad uso<br />
residenziale o similari, tenendo presente i bassi valori <strong>di</strong> capacità<br />
portante e <strong>di</strong> elevata compressibilità che potrebbero presentare i<br />
terreni fini in sito. In tali zone dovrà essere valutata la possibilità <strong>di</strong><br />
ricorrere all’impiego <strong>di</strong> fondazioni <strong>di</strong> tipo profondo che dovranno essere<br />
opportunamente attestate su uno strato sabbioso <strong>di</strong> adeguate<br />
caratteristiche meccaniche.<br />
Il tipo <strong>di</strong> palo più opportuno per la situazione che si presenterà sarà da<br />
valutare in sede esecutiva e <strong>di</strong> conseguenza anche i valori <strong>di</strong> portata<br />
andranno tarati in funzione del palo scelto e dell’esperienza della <strong>di</strong>tta<br />
esecutrice, che dovrà verificare attentamente la possibilità <strong>di</strong> infiggere i<br />
pali alla profon<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> progetto senza arrecare <strong>di</strong>sturbo alle strutture<br />
limitrofe, eventualmente presenti.<br />
Andranno inoltre valutati attentamente i fenomeni <strong>di</strong> attrito negativo in<br />
caso <strong>di</strong> realizzazione <strong>di</strong> strutture con fondazioni superficiali e carichi<br />
<strong>di</strong>ffusi nell’intorno della palificata (l’attrito negativo, infatti è una forza<br />
trasmessa dal terreno al palo che tende a spingerlo verso il basso; esso<br />
si manifesta prevalentemente in terreni coesivi e le principali cause<br />
sono: l’assestamento naturale <strong>di</strong> stati molto compressibili, assestamenti<br />
per carichi superficiali nelle vicinanze dei pali, consolidamento degli<br />
strati dovuto all’abbassamento della falda e <strong>di</strong>sturbo al terreno<br />
provocato dall’infissione nel caso <strong>di</strong> pali battuti in terreni molli).<br />
Per le verifiche <strong>di</strong> sicurezza e per ulteriori specifiche si rimanda alle<br />
“Nuove norme tecniche per le costruzioni” DM Infrastrutture 14<br />
gennaio 2008 pubblicato su S.O. n. 30 alla G.U. 4 febbraio 2008, n. 29,<br />
Cap. 6 “Progettazione geotecnica”, paragrafo 6.4 “Opere <strong>di</strong><br />
fondazione”, ed eventuali successivi aggiornamenti o mo<strong>di</strong>fiche.<br />
CONDIZIONE: B “ Aree a topografia depressa costituite da depositi fini e<br />
65 <strong>di</strong> 83
AREE:<br />
SPECIFICHE<br />
TECNICHE:<br />
Progetto: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio – RELAZIONE GEOLOGICA Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura<br />
geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico – Rev.:01<br />
Data: 28‐02‐2013 – Estensori: Prof. Geol. A. Bondesan, Dott.ssa S. Primon, Dott.ssa C. Levorato [Adastra srl]‐ Committente: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
organici”<br />
Sono identificati in questa categoria tutti i territori comunali<br />
caratterizzati da substrato fine argilloso e con un elevato contenuto in<br />
materia organica (torba).<br />
Rientrano in questa definizione i terreni posti nella porzione più<br />
meri<strong>di</strong>onale del territorio comunale.<br />
Si tratta <strong>di</strong> aree abbastanza estese del territorio, sede <strong>di</strong> prolungata<br />
se<strong>di</strong>mentazione palustre, con quote che sono le più basse <strong>di</strong> tutto il<br />
comune (fino a ‐2 m s.l.m.) e soggette a fenomeni <strong>di</strong> subsidenza<br />
generale molto rilevante (da 2 a 3 mm/anno) per la presenza <strong>di</strong><br />
materiale torboso (vd Allegato 3 Tavola 03/B‐03 “Subsidenza ‐ Velocità<br />
(mm/anno)).<br />
Le argille assumono, per ossidazione in superficie, un colore nerastro,<br />
ed il loro comportamento geotecnico è quello <strong>di</strong> depositi ad alta<br />
compressibilità.<br />
In queste aree devono essere condotte specifiche indagini geologiche<br />
per poter realizzare al meglio il modello geologico del sito, orientato<br />
alla ricostruzione dei caratteri stratigrafici, tessiturali e geomorfologici<br />
del territorio. Esso deve essere creato in modo da poter valutare con<br />
precisione la profon<strong>di</strong>tà alla quale compaiono strati sabbiosi con<br />
spessori tali da poter rappresentare una buona base per eventuali<br />
opere <strong>di</strong> fondazione, e costituire quin<strong>di</strong> un fondamentale elemento <strong>di</strong><br />
riferimento per l’inquadramento, da parte del progettista, delle<br />
problematiche geotecniche presenti. Dovranno essere condotte le<br />
verifiche <strong>di</strong> sicurezza relative agli stati limite ultimi SLU che<br />
rappresentano le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> rottura del terreno, e agli stati limite <strong>di</strong><br />
esercizio SLE, che rappresentano la valutazione dell’entità delle<br />
deformazioni intese come ce<strong>di</strong>menti del terreno su cui insiste l’opera<br />
stessa (riferimento normativo: “Nuove norme tecniche per le<br />
costruzioni” DM Infrastrutture 14 gennaio 2008 pubblicato su S.O. n. 30<br />
alla G.U. 4 febbraio 2008, n. 29, Cap. 6 “Progettazione geotecnica”, e<br />
eventuali successivi aggiornamenti o mo<strong>di</strong>fiche”). Nella aree a<br />
con<strong>di</strong>zione B è richiesto <strong>di</strong> porre particolare attenzione alla valutazione<br />
66 <strong>di</strong> 83
Progetto: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio – RELAZIONE GEOLOGICA Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura<br />
geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico – Rev.:01<br />
Data: 28‐02‐2013 – Estensori: Prof. Geol. A. Bondesan, Dott.ssa S. Primon, Dott.ssa C. Levorato [Adastra srl]‐ Committente: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
degli stati limite <strong>di</strong> esercizio, in quanto a causa della presenza <strong>di</strong> forti<br />
spessori <strong>di</strong> materiale fine organico la stabilità delle strutture può essere<br />
compromessa soprattutto dal verificarsi <strong>di</strong> ce<strong>di</strong>menti eccessivi a causa<br />
della forte compressibilità delle argille organiche (CC argille organiche<br />
>4; CC torbe 10‐15).<br />
Date le con<strong>di</strong>zioni stratigrafiche <strong>di</strong> tali terreni, ad eccezioni <strong>di</strong> situazioni<br />
che potranno essere particolarmente favorevoli, si ritiene che<br />
fondazioni superficiali non siano in generale adeguate per opere tipo<br />
e<strong>di</strong>fici ad uso residenziale o similari, tenendo presenti i bassi valori <strong>di</strong><br />
capacità portante e <strong>di</strong> elevata compressibilità che potrebbero<br />
presentare i terreni fini in sito. In tali zone è pertanto consigliato l’uso <strong>di</strong><br />
fondazioni <strong>di</strong> tipo profondo che dovranno essere opportunamente<br />
attestate su uno strato sabbioso <strong>di</strong> adeguate caratteristiche<br />
meccaniche.<br />
Il tipo <strong>di</strong> palo più opportuno per la situazione che si presenterà sarà da<br />
valutare in sede esecutiva e <strong>di</strong> conseguenza anche i valori <strong>di</strong> portata<br />
andranno tarati in funzione del palo scelto e dell’esperienza della <strong>di</strong>tta<br />
esecutrice, che dovrà verificare attentamente la possibilità <strong>di</strong> infiggere i<br />
pali alla profon<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> progetto senza arrecare <strong>di</strong>sturbo alle strutture<br />
limitrofe, eventualmente presenti.<br />
Andranno inoltre valutati attentamente i fenomeni <strong>di</strong> attrito negativo in<br />
caso <strong>di</strong> realizzazione <strong>di</strong> strutture con fondazioni superficiali e carichi<br />
<strong>di</strong>ffusi nell’intorno della palificata (l’attrito negativo, infatti è una forza<br />
trasmessa dal terreno al palo che tende a spingerlo verso il basso; esso<br />
si manifesta prevalentemente in terreni coesivi e le principali cause<br />
sono: l’assestamento naturale <strong>di</strong> stati molto compressibili, assestamenti<br />
per carichi superficiali nelle vicinanze dei pali, consolidamento degli<br />
strati dovuto all’abbassamento della falda e <strong>di</strong>sturbo al terreno<br />
provocato dall’infissione nel caso <strong>di</strong> pali battuti in terreni molli).<br />
Per le verifiche <strong>di</strong> sicurezza e per ulteriori specifiche si rimanda alle<br />
“Nuove norme tecniche per le costruzioni” DM Infrastrutture 14<br />
gennaio 2008 pubblicato su S.O. n. 30 alla G.U. 4 febbraio 2008, n. 29,<br />
Cap. 6 “Progettazione geotecnica”, paragrafo 6.4 “Opere <strong>di</strong><br />
67 <strong>di</strong> 83
Progetto: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio – RELAZIONE GEOLOGICA Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura<br />
geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico – Rev.:01<br />
Data: 28‐02‐2013 – Estensori: Prof. Geol. A. Bondesan, Dott.ssa S. Primon, Dott.ssa C. Levorato [Adastra srl]‐ Committente: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
fondazione”, ed eventuali successivi aggiornamenti o mo<strong>di</strong>fiche.<br />
CONDIZIONE: C “Aree <strong>di</strong> dosso fluviale a pericolosità idraulica e geologica<br />
AREE:<br />
SPECIFICHE<br />
TECNICHE:<br />
da moderata a me<strong>di</strong>a”<br />
Si tratta <strong>di</strong> aree essenzialmente idonee dal punto <strong>di</strong> vista strettamente<br />
geologico‐geotecnico alle quali sono state associate le zone a<br />
PERICOLOSITA’ IDRAULICA P1 e P2 definite dal Progetto <strong>di</strong> Piano<br />
Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume<br />
<strong>Piave</strong> e dal Piano <strong>di</strong> Assetto Idrogeologico redatto dall’Autorità <strong>di</strong><br />
Bacino del Sile e della pianura tra <strong>Piave</strong> e Livenza.<br />
Per tali aree si rimanda alle Norme <strong>di</strong> Attuazione del Progetto <strong>di</strong> Piano<br />
Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume<br />
<strong>Piave</strong> adottato con Delibera n. 3 del 09.11.2012 e a quelle del Piano <strong>di</strong><br />
Assetto Idrogeologico redatto dall’Autorità <strong>di</strong> Bacino del Sile e della<br />
pianura tra <strong>Piave</strong> e Livenza ed in particolare, rispettivamente, all’art. 11<br />
(per le aree classificate P2) e art.12 (per le aree classificate P1) del<br />
Piano Stralcio del fiume <strong>Piave</strong> e all’art.12 (per le aree classificate P2) e<br />
art.13 (per le aree classificate P1) del Piano <strong>di</strong> Assetto Idrogeologico del<br />
Sile Negli articoli elencati sono riportate le azioni consentite in tali zone.<br />
Si dovrà inoltre fare riferimento alle Specifiche Tecniche previste per le<br />
Aree idonee.<br />
CONDIZIONE: D “Aree <strong>di</strong> piana alluvionale in<strong>di</strong>stinta a pericolosità idraulica e<br />
AREE:<br />
SPECIFICHE<br />
geologica da moderata a me<strong>di</strong>a”<br />
Si tratta <strong>di</strong> aree costituite da depositi alluvionali fini, in prevalenza limo‐argillosi,<br />
argillosi con presenza <strong>di</strong> strati sabbiosi a <strong>di</strong>verse profon<strong>di</strong>tà e livelli torbosi che<br />
sono state associate alle zone a PERICOLOSITA’ IDRAULICA P1 e P2 definite dal<br />
Progetto <strong>di</strong> Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del<br />
fiume <strong>Piave</strong> e dal Piano <strong>di</strong> Assetto Idrogeologico redatto dall’Autorità <strong>di</strong> Bacino<br />
del Sile e della pianura tra <strong>Piave</strong> e Livenza.<br />
Per tali aree si rimanda alle Norme <strong>di</strong> Attuazione del Progetto <strong>di</strong> Piano Stralcio<br />
68 <strong>di</strong> 83
TECNICHE:<br />
Progetto: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio – RELAZIONE GEOLOGICA Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura<br />
geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico – Rev.:01<br />
Data: 28‐02‐2013 – Estensori: Prof. Geol. A. Bondesan, Dott.ssa S. Primon, Dott.ssa C. Levorato [Adastra srl]‐ Committente: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume <strong>Piave</strong> adottato con<br />
Delibera n. 3 del 09.11.2012, e a quelle del Piano <strong>di</strong> Assetto Idrogeologico<br />
redatto dall’Autorità <strong>di</strong> Bacino del Sile e della pianura tra <strong>Piave</strong> e Livenza, ed in<br />
particolare rispettivamente, all’art. 11 (per le aree classificate P2) e art.12 (per le<br />
aree classificate P1) del Piano Stralcio del fiume <strong>Piave</strong> e all’art.12 (per le aree<br />
classificate P2) e art.13 (per le aree classificate P1) del Piano <strong>di</strong> Assetto<br />
Idrogeologico del Sile. Negli articoli elencati sono riportate le azioni consentite in<br />
tali zone.<br />
Si dovrà inoltre fare riferimento alle Specifiche Tecniche previste per le Aree a<br />
con<strong>di</strong>zione A.<br />
CONDIZIONE: E “Aree a topografia depressa costituite da depositi fini e organici a<br />
AREE:<br />
SPECIFICHE<br />
TECNICHE:<br />
pericolosità idraulica e geologica da moderata a me<strong>di</strong>a”<br />
Appartengono a questa categoria le aree caratterizzate da substrato fine<br />
argilloso e con un elevato contenuto in materia organica (torba) alle quali sono<br />
state associate le zone a PERICOLOSITA’ IDRAULICA P1 e P2 definite dal Progetto<br />
<strong>di</strong> Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume<br />
<strong>Piave</strong> e dal Piano <strong>di</strong> Assetto Idrogeologico redatto dall’Autorità <strong>di</strong> Bacino del Sile<br />
e della pianura tra <strong>Piave</strong> e Livenza.<br />
Per tali aree si rimanda alle Norme <strong>di</strong> Attuazione del Progetto <strong>di</strong> Piano Stralcio<br />
per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume <strong>Piave</strong> adottato con<br />
Delibera n. 3 del 09.11.2012, ed in particolare, rispettivamente, all’art. 11 (per le<br />
aree classificate P2) e art.12 (per le aree classificate P1) del Piano Stralcio del<br />
fiume <strong>Piave</strong> e all’art.12 (per le aree classificate P2) e art.13 (per le aree<br />
classificate P1) del Piano <strong>di</strong> Assetto Idrogeologico del Sile Negli articoli elencati<br />
sono riportate le azioni consentite in tali zone.<br />
Si dovrà inoltre fare riferimento alle Specifiche Tecniche previste per le Aree a<br />
con<strong>di</strong>zione A.<br />
CONDIZIONE: F “Aree <strong>di</strong> dosso fluviale a pericolosità geologica elevata”<br />
AREE:<br />
Si tratta <strong>di</strong> aree essenzialmente idonee dal punto <strong>di</strong> vista strettamente<br />
69 <strong>di</strong> 83
SPECIFICHE<br />
TECNICHE:<br />
Progetto: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio – RELAZIONE GEOLOGICA Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura<br />
geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico – Rev.:01<br />
Data: 28‐02‐2013 – Estensori: Prof. Geol. A. Bondesan, Dott.ssa S. Primon, Dott.ssa C. Levorato [Adastra srl]‐ Committente: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
geologico‐geotecnico alle quali sono state associate le zone a PERICOLOSITA’<br />
IDRAULICA P3 definite dal Progetto <strong>di</strong> Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico<br />
del bacino idrografico del fiume <strong>Piave</strong>.<br />
Si tratta <strong>di</strong> un’unica area che si estende lungo l’arginatura naturale del fiume<br />
<strong>Piave</strong> e appare costituita in prevalenza da materiali sabbiosi deposti dall’attività<br />
del fiume stesso.<br />
Per tali aree si rimanda alle Norme <strong>di</strong> Attuazione del Progetto <strong>di</strong> Piano Stralcio<br />
per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume <strong>Piave</strong> adottato con<br />
Delibera n. 3 del 09.11.2012, ed in particolare all’art.10 (Disciplina degli<br />
interventi nelle aree classificate a pericolosità elevata P3) e alle Norme <strong>di</strong><br />
Attuazione del Piano <strong>di</strong> Assetto Idrogeologico redatto dall’Autorità <strong>di</strong> Bacino del<br />
Sile e della pianura tra <strong>Piave</strong> e Livenza, ed in particolare all’art. 13 (Azioni ed<br />
interventi ammisibili nelle aree classificate a pericolosità moderata – P1). Negli<br />
articoli elencati sono riportate le azioni consentite in tali zone.<br />
Si precisa inoltre che ai sensi dell'art. 8 (Disposizioni comuni per le aree a<br />
pericolosità idraulica, geologica, valanghiva e per le zone <strong>di</strong> attenzione), comma<br />
2, delle NTA del PAI <strong>Piave</strong>: “Possono essere portati a conclusione tutti i piani e gli<br />
interventi i cui provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> approvazione, autorizzazione, concessione,<br />
permessi <strong>di</strong> costruire od equivalenti previsti dalle norme vigenti, siano stati<br />
rilasciati prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’avvenuta<br />
adozione del presente Piano, fatti salvi gli effetti delle misure <strong>di</strong> salvaguar<strong>di</strong>a<br />
precedentemente in vigore.”<br />
Si dovrà inoltre fare riferimento alle Specifiche Tecniche previste per le Aree a<br />
con<strong>di</strong>zione A.<br />
CONDIZIONE: G AREE BONIFICATE CON LIMITAZIONI D’USO<br />
AREE:<br />
SPECIFICHE<br />
TECNICHE:<br />
Si tratta <strong>di</strong> aree bonificate con le limitazioni d’uso previste nei relativi certificati<br />
<strong>di</strong> avvenuta bonifica rilasciati dalla Provincia ex art. 248 c. 7 del Testo Unico<br />
Ambientale (D.Lgs 152/2006 e s.m.i.).<br />
Si dovrà fare riferimento alle specifiche limitazioni d’uso previste nei relativi<br />
certificati <strong>di</strong> avvenuta bonifica.<br />
CONDIZIONE: H “Aree caratterizzate da particolari evidenze ed unicità<br />
70 <strong>di</strong> 83
AREE:<br />
Progetto: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio – RELAZIONE GEOLOGICA Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura<br />
geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico – Rev.:01<br />
Data: 28‐02‐2013 – Estensori: Prof. Geol. A. Bondesan, Dott.ssa S. Primon, Dott.ssa C. Levorato [Adastra srl]‐ Committente: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
geologiche riconosciute come geositi”<br />
Si tratta <strong>di</strong> aree che ricadono in un ambito territoriale caratterizzato da<br />
particolari evidenze ed unicità geologiche, nel quale non vanno previsti<br />
interventi <strong>di</strong> trasformazione se non per la loro conservazione, valorizzazione e<br />
tutela. Nel medesimo sito non vanno effettuate mo<strong>di</strong>fiche morfologiche ed<br />
idrogeologiche, se non per motivi <strong>di</strong> stabilizzazione dei pen<strong>di</strong>i e bonifica dei<br />
terreni.<br />
Sono riportati quin<strong>di</strong>, tra tutti gli elementi geologici rilevati nello sviluppo del<br />
Quadro Conoscitivo, solo quelli che presentano le caratteristiche <strong>di</strong> cui sopra e<br />
che, per particolare pregio e interesse, sono stati in<strong>di</strong>viduati come “geositi”.<br />
Nel caso specifico del <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong>, nell’ambito del proce<strong>di</strong>mento<br />
<strong>di</strong> redazione del PAT, sono state rilevate due aree che per caratteristiche<br />
paesaggistiche e geologiche sono state co<strong>di</strong>ficate come “geosito”, <strong>di</strong> concerto<br />
con il <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> e la Regione Veneto. Tali geositi sono anche<br />
inclusi nel PTCP della Provincia <strong>di</strong> Venezia.<br />
Le aree in<strong>di</strong>viduate riguardano il Meandro abbandonato del <strong>Piave</strong> (incluso per la<br />
sua ubicazione topografica nella categoria Aree non idonee) e i Paleocanali<br />
lagunari del settore sudoccidentale del comune. Per tali aree, come in<strong>di</strong>cato<br />
negli atti <strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzo della L.R. 11/2004, è stata compilata e consegnata alla<br />
Regione Veneto la “Scheda per l’inventario dei Geositi”, a cui è seguito da parte<br />
della Regione stessa l’accettazione della proposta e la co<strong>di</strong>fica <strong>di</strong> tale area come<br />
geosito<br />
In generale, l’in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong> un geosito può sottendere una valenza <strong>di</strong> natura<br />
<strong>di</strong>versa a seconda del luogo e del contesto nel quale esso si colloca: l’interesse<br />
della comunità può infatti essere rivolto agli aspetti paesaggistici secondo la<br />
concezione più comune <strong>di</strong> monumento naturale oppure su altre caratteristiche<br />
<strong>di</strong> tipo <strong>di</strong>dattico, scientifico o anche solo esemplificativo dell’elemento geologico<br />
considerato. E’ innegabile che i geositi che ricadono nella vecchia accezione <strong>di</strong><br />
monumenti geologici, intesi quin<strong>di</strong> come singolarità del paesaggio uniche per le<br />
loro caratteristiche intriseche, vadano tutelati integralmente ed esclusi da<br />
qualunque intervento che non sia mirato alla loro preservazione e valorizzazione<br />
(e quin<strong>di</strong> definiti integralmente come Invarianti). Diverso è il caso <strong>di</strong> elementi<br />
arealmente estesi, come sono in particolare i geositi del <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong><br />
71 <strong>di</strong> 83
SPECIFICHE<br />
TECNICHE:<br />
Progetto: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio – RELAZIONE GEOLOGICA Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura<br />
geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico – Rev.:01<br />
Data: 28‐02‐2013 – Estensori: Prof. Geol. A. Bondesan, Dott.ssa S. Primon, Dott.ssa C. Levorato [Adastra srl]‐ Committente: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
CONDIZIONE:<br />
AREE:<br />
<strong>Piave</strong>, i quali, pur importanti per la loro rappresentatività culturale e<br />
testimonianza della storia geologica, si trovano in con<strong>di</strong>zioni del tutto particolari<br />
essendo non facilmente delimitabili e particolarmente estesi arealmente. In<br />
particolare, si ritiene che il geosito Paleocanali lagunari debba essere oggetto <strong>di</strong><br />
attenzione da parte dell’Amministrazione Comunale, specialmente in termini <strong>di</strong><br />
valorizzazione e <strong>di</strong>vulgazione del suo valore scientifico‐culturale, ma che<br />
nell’ambito del PAT, per ragioni che si possono ricondurre sostanzialmente alla<br />
sua conformazione geologica ed alla notevole estensione territoriale, non sia da<br />
perimetrare integralmente come “area idonea a con<strong>di</strong>zione”, considerando<br />
anche il fatto che non si tratta <strong>di</strong> un elemento puntuale che una normale<br />
espansione urbanistica possa obliterare. Nel caso particolare relativo al geosito<br />
“Paleocanali lagunari”, eventuali opere o interventi realizzati sulla superficie,<br />
non altererebbero in maniera significativa l’assetto del sottosuolo e dei corpi<br />
se<strong>di</strong>mentari che nel loro insieme definiscono il carattere del geosito.<br />
Per questi motivi, è stata proposta una riperimetrazione del geosito sulla scorta<br />
<strong>di</strong> un esame specifico delle immagini telerilevate e dei dati <strong>di</strong> campagna,<br />
compatibile con l’attuale presenza antropica nella località.<br />
Il <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> dovrà farsi parte attiva nel mettere in atto tutte le<br />
forme <strong>di</strong> valorizzazione e <strong>di</strong>ffusione delle conoscenze sui geositi presenti nel<br />
proprio territorio, nei mo<strong>di</strong> ritenuti più appropriati (cartellonistica, attività <strong>di</strong><br />
educazione ambientale, itinerari <strong>di</strong>dattici, pubblicistica, ecc.) e <strong>di</strong> conservazione<br />
sotto idonee forme (archivi de<strong>di</strong>cati, banche dati ecc.) dei dati conoscitivi via via<br />
acquisiti (dati riferiti al geosito derivanti da carotaggi, penetrometrie, descrizioni<br />
<strong>di</strong> sezioni, progetti, cartografie, foto aeree, ecc.).<br />
Per l’area relativa al geosito “Paleocanali lagunari” si dovrà fare riferimento alle<br />
Specifiche Tecniche previste per le Aree a con<strong>di</strong>zione E, mentre per l’area<br />
relativa al “Meandro abbandonato del <strong>Piave</strong>” si dovrà fare riferimento alle<br />
Specifiche Tecniche previste per le Aree non idonee (art. 16.3), mettendo in atto<br />
tutte le iniziative <strong>di</strong> valorizzazione proprie dei geositi.<br />
I “Area ex <strong>di</strong>scarica <strong>di</strong> via Caposile‐case Bianche”<br />
L’area in<strong>di</strong>vidua il se<strong>di</strong>me relativo alla <strong>di</strong>scarica <strong>di</strong> via Caposile‐case Bianche,<br />
oggi non più attiva.<br />
72 <strong>di</strong> 83
SPECIFICHE<br />
TECNICHE:<br />
Progetto: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio – RELAZIONE GEOLOGICA Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura<br />
geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico – Rev.:01<br />
Data: 28‐02‐2013 – Estensori: Prof. Geol. A. Bondesan, Dott.ssa S. Primon, Dott.ssa C. Levorato [Adastra srl]‐ Committente: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
6.1.3 AREA NON IDONEA<br />
in genere.<br />
Si tratta <strong>di</strong> un’unica area localizzata a sud <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> nei pressi <strong>di</strong> via<br />
Caposile.<br />
Per tali aree si dovrà fare riferimento alle Specifiche Tecniche previste per le<br />
Aree a con<strong>di</strong>zione A.<br />
Qualsiasi ipotesi <strong>di</strong> riutilizzo della presente area non deve prescindere dalla<br />
valutazione dell’interferenza con la <strong>di</strong>scarica, con riferimento sia ai rifiuti<br />
abbancati che alle opere <strong>di</strong> contenimento e ricopertura superficiale, valutazione<br />
che potrà essere effettuata nell’ambito del progetto <strong>di</strong> adeguamento ai sensi<br />
della vigente normativa ambientale.<br />
A norma della L.R. Veneto 11/2004 nelle zone classificate “non idonee” è preclusa l’e<strong>di</strong>ficazione<br />
Tale area segue la delimitazione del nuovo PAI del Bacino Idrografico del fiume <strong>Piave</strong> adottato<br />
con Delibera n. 3 del 09.11.2012. Il nuovo PAI, rispetto a quello <strong>di</strong> luglio 2007, in<strong>di</strong>ca la precedente area<br />
P4 come “F–Area Fluviale”, pertanto per tale area vale quanto previsto dalle Norme <strong>di</strong> Attuazione del<br />
PAI del Bacino Idrografico del fiume <strong>Piave</strong>. In tale area è compreso anche il geosito: Meandro<br />
abbandonato del <strong>Piave</strong>.<br />
La sud<strong>di</strong>visone del territorio in base alla Compatibilità geologica ai fini urbanistici è stata fornita<br />
in formato <strong>di</strong> interscambio esri. shp:<br />
PERCORSO: PAT<strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong>\b_Progetto\ b03_Fragilita\ b0301_CompatGeologica\<br />
b0301011_CompatGeologica<br />
METADATO: b0301011_CompatGeologica<br />
73 <strong>di</strong> 83
Progetto: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio – RELAZIONE GEOLOGICA Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura<br />
geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico – Rev.:01<br />
Data: 28‐02‐2013 – Estensori: Prof. Geol. A. Bondesan, Dott.ssa S. Primon, Dott.ssa C. Levorato [Adastra srl]‐ Committente: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
Figura 18: Carta della compatibilità geologica<br />
6.2 AREE SOGGETTE A DISSESTO IDROGEOLOGICO<br />
Le aree soggette a <strong>di</strong>ssesto idrogeologico sono state delimitate in base alle voci <strong>di</strong> legenda<br />
pubblicata tra gli aggiornamenti presenti nel sito internet della Regione Veneto degli atti <strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzo<br />
della L.R. 11/2004.<br />
Nel territorio comunale sono state definite unicamente le aree esondabili o a ristagno idrico<br />
identificate come tali dal Consorzio <strong>di</strong> Bonifica ex Basso <strong>Piave</strong> e dalla Provincia <strong>di</strong> Venezia nella<br />
specifica tavola del PTCP. Si tratta <strong>di</strong> aree per le quali i reali fenomeni <strong>di</strong> allagamento non risultano<br />
sempre verificati dall’esperienza <strong>di</strong>retta dei tecnici comunali.<br />
Il P.I., in armonia con il piano per la tutela dal rischio idrogeologico approvato dall'Autorità <strong>di</strong><br />
Bacino, provvederà a porre norme <strong>di</strong> tutela e valorizzazione. Il P.I. recepisce, integra e dettaglia i<br />
74 <strong>di</strong> 83
Progetto: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio – RELAZIONE GEOLOGICA Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura<br />
geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico – Rev.:01<br />
Data: 28‐02‐2013 – Estensori: Prof. Geol. A. Bondesan, Dott.ssa S. Primon, Dott.ssa C. Levorato [Adastra srl]‐ Committente: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
<strong>di</strong>sposti <strong>di</strong> cui al presente articolo relativamente Tutela idraulica; e rispetta le in<strong>di</strong>cazioni e<br />
prescrizioni fornite dalla Valutazione <strong>di</strong> Compatibilità Idraulica.<br />
Prescrizioni e vincoli<br />
In via preliminare si prescrive per tali aree <strong>di</strong> condurre una valutazione <strong>di</strong> compatibilità idraulica; in<br />
alternativa dovranno essere <strong>di</strong>sponibili altri stu<strong>di</strong> inerenti, sufficienti a comprendere i rischi <strong>di</strong><br />
esondabilità e/o <strong>di</strong> ristagno e a mettere in atto le misure per contrastare e mitigare gli effetti. Le<br />
indagini dovranno prevedere un’adeguata conoscenza delle falde e del loro regime idrogeologico,<br />
delle con<strong>di</strong>zioni topografiche locali, della soggiacenza rispetto ai canali e ai corsi d’acqua, <strong>di</strong><br />
eventuali insufficienze legate alla rete <strong>di</strong> scolo artificiale e delle relazioni funzionali con i manufatti<br />
idraulici che possono interagire con il sito.<br />
a) Interventi <strong>di</strong> trasformazione dell’uso del suolo<br />
‐ Tutti gli interventi <strong>di</strong> trasformazione dell’uso del suolo che provocano una variazione <strong>di</strong><br />
permeabilità superficiale devono comprendere misure compensative volte e mantenere<br />
costante il coefficiente udometrico secondo il principio “dell'invarianza idraulica”: pertanto<br />
l’assetto idraulico dovrà essere adeguatamente stu<strong>di</strong>ato adottando tecniche costruttive atte a<br />
migliorare la sicurezza ed al contempo <strong>di</strong>minuire i coefficienti <strong>di</strong> deflusso con accorgimenti<br />
vali<strong>di</strong> sia per le urbanizzazioni che per i singoli fabbricati;<br />
‐ Ad intervento eseguito, ed a parità <strong>di</strong> evento <strong>di</strong> pioggia, la rete <strong>di</strong> smaltimento delle acque<br />
piovane deve prevedere valori <strong>di</strong> portata massima non superiori al quelle stimabili nella<br />
situazione ante intervento. A questo fine, si potranno mettere in atto le opere <strong>di</strong> mitigazione<br />
idraulica più adeguate alla specifica situazione.<br />
b) Opere <strong>di</strong> mitigazione idraulica Gli interventi <strong>di</strong> trasformazione dell’uso del suolo sono subor<strong>di</strong>nati<br />
alla realizzazione <strong>di</strong> opere <strong>di</strong> mitigazione idraulica, che vanno definite per ciascun progetto con la<br />
procedura <strong>di</strong> calcolo e le modalità operative descritte nella Valutazione <strong>di</strong> Compatibilità Idraulica<br />
allegata al P.A.T.. In ogni caso la tipologia specifica, caratteristiche, <strong>di</strong>mensioni e localizzazione <strong>di</strong><br />
tali opere vanno selezionate e misurate in maniera adeguata rispetto:<br />
‐ alla tipologia ed entità dell’intervento;<br />
‐ all’obiettivo <strong>di</strong> una reale efficacia;<br />
‐ al contesto ambientale e geologico‐idraulico.<br />
75 <strong>di</strong> 83
Progetto: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio – RELAZIONE GEOLOGICA Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura<br />
geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico – Rev.:01<br />
Data: 28‐02‐2013 – Estensori: Prof. Geol. A. Bondesan, Dott.ssa S. Primon, Dott.ssa C. Levorato [Adastra srl]‐ Committente: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
In<strong>di</strong>cativamente, le opere <strong>di</strong> mitigazione idraulica possono consistere in: Nelle aree a perio<strong>di</strong>co<br />
ristagno idrico, in tutto il territorio comunale si applicano le seguenti norme <strong>di</strong> salvaguar<strong>di</strong>a dal<br />
rischio idrogeologico:<br />
a) Le superfici pavimentate <strong>di</strong>verse dai piazzali pertinenziali degli inse<strong>di</strong>amenti<br />
produttivi prive <strong>di</strong> costruzioni sottostanti dovranno essere realizzate con<br />
pavimentazioni che permettano il drenaggio dell'acqua e l'inerbimento;<br />
b) Le superfici pavimentate sovrastanti costruzioni interrate e piazzali pertinenziali ad<br />
inse<strong>di</strong>amenti produttivi, dovranno essere provviste <strong>di</strong> canalizzazioni ed opere <strong>di</strong><br />
drenaggio che provvedano a restituire le acque meteoriche alla falda o, se<br />
tecnicamente impossibile, dotate <strong>di</strong> vasche <strong>di</strong> raccolta con rilascio lento delle acque<br />
nelle fognature comunali o negli scoli, al fine <strong>di</strong> ritardarne la velocità <strong>di</strong> deflusso;<br />
c) Le precedenti prescrizioni non si applicano alle superfici pavimentate ove si<br />
raccolgano acque meteoriche <strong>di</strong> <strong>di</strong>lavamento o <strong>di</strong> prima pioggia <strong>di</strong>sciplinate dall'art.<br />
113 del D. Leg.vo 152/06, per le quali si applicheranno le speciali <strong>di</strong>sposizioni regionali<br />
e comunali <strong>di</strong> attuazione;<br />
d) le canalizzazioni e tutte le opere <strong>di</strong> drenaggio devono essere <strong>di</strong>mensionate<br />
utilizzando un tempo <strong>di</strong> ritorno ed un tempo <strong>di</strong> pioggia critico adeguato all'opera<br />
stessa ed al bacino, secondo quanto riportato nella normativa vigente;<br />
e) in caso <strong>di</strong> nuove lottizzazioni, prevedere dei volumi <strong>di</strong> invaso(con un volume minimo<br />
determinato dalla normativa vigente e comunque concordato con i consorzi/enti<br />
competenti) per la raccolta delle acque piovane (bacino <strong>di</strong> laminazione) per evitare <strong>di</strong><br />
sovraccaricare la rete superficiale <strong>di</strong> scolo con i maggiori picchi <strong>di</strong> piena dovuti alla<br />
ridotta permeabilità del suolo;<br />
f) nella rete <strong>di</strong> smaltimento delle acque pre<strong>di</strong>ligere, nella progettazione dei collettori <strong>di</strong><br />
drenaggi gran<strong>di</strong> <strong>di</strong>ametri;<br />
g) le tubazioni in cls o ca a servizio dei sistemi <strong>di</strong> collettamento delle acque, nel caso in<br />
cui presentino pendenze inferiori allo 0.5%, dovranno essere obbligatoriamente posate<br />
su letto in calcestruzzo armato <strong>di</strong> idonea rigi<strong>di</strong>tà per evitare ce<strong>di</strong>menti delle stesse;<br />
h) valutare l’opportunità <strong>di</strong> impiego <strong>di</strong> perdenti delle acque piovane nel primo<br />
sottosuolo e tubazioni della rete acque bianche del tipo drenante.<br />
Il P.I. <strong>di</strong>sciplina le aree in oggetto in coerenza con le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> seguito elencate:<br />
76 <strong>di</strong> 83
Progetto: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio – RELAZIONE GEOLOGICA Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura<br />
geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico – Rev.:01<br />
Data: 28‐02‐2013 – Estensori: Prof. Geol. A. Bondesan, Dott.ssa S. Primon, Dott.ssa C. Levorato [Adastra srl]‐ Committente: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
‐ salvaguar<strong>di</strong>a dei caratteri <strong>di</strong>mensionali e morfologici che garantiscono la funzionalità idraulica dei<br />
corpi idrici;<br />
‐ mantenimento, per i fossati, scoli esistenti, dei profili naturali del terreno evitando l'occlusione,<br />
l’impermeabilizzazione del fondo e delle loro sponde, preservando le <strong>di</strong>mensioni <strong>di</strong> ampia sicurezza<br />
e il relativo corredo <strong>di</strong> alberature e siepi;<br />
‐ <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> tombamento o <strong>di</strong> chiusura <strong>di</strong> fossati esistenti, anche privati, a meno <strong>di</strong> evidenti necessità<br />
attinenti la pubblica o privata sicurezza; in caso <strong>di</strong> tombinamento occorrerà provvedere alla<br />
ricostruzione planoaltimetrica delle sezioni idriche perse secondo configurazioni che ripristinino la<br />
funzione iniziale sia in termini <strong>di</strong> volumi che <strong>di</strong> smaltimento delle portate defluenti;<br />
‐ eventuali ponticelli, tombinamenti, o tombotti interrati, devono garantire una luce <strong>di</strong> passaggio<br />
mai inferiore a quella maggiore fra la sezione imme<strong>di</strong>atamente a monte e quella imme<strong>di</strong>atamente a<br />
valle della parte <strong>di</strong> fossato a pelo libero;<br />
‐ rivestire imbocco e sbocco dei manufatti <strong>di</strong> attraversamento (tombini, sifoni) e le immissioni <strong>di</strong><br />
tubazioni in fossi naturali con massi cementati o cemento armato: questo per evitare erosioni in<br />
caso <strong>di</strong> piena e per mantenere liberi da infestanti questi punti <strong>di</strong> connessione idraulica;<br />
‐ la continuità idraulica dei fossati me<strong>di</strong>ante tombinamenti deve avvenire in con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> deflusso a<br />
superficie libera, eventualmente aumentando la quota del piano campagna o <strong>di</strong> progetto in<br />
corrispondenza dell'opera <strong>di</strong> attraversamento; nel caso questo non sia possibile, dovrà essere<br />
comunque garantita la connessione me<strong>di</strong>ante tubazioni sifonate aventi alle estremità pozzetti e<br />
griglie per impe<strong>di</strong>re l'ingresso <strong>di</strong> persone, animali o <strong>di</strong> oggetti flottanti. Questi sifoni (e comunque in<br />
generale tutti gli attraversamenti), nel caso siano posizionati su alvei non demaniali, dovranno<br />
essere perio<strong>di</strong>camente ispezionati e ripuliti dai proprietari;<br />
‐ negli interventi <strong>di</strong> nuova e<strong>di</strong>ficazione il piano <strong>di</strong> imposta dei fabbricati dovrà essere fissato ad una<br />
quota superiore al piano <strong>di</strong> campagna me<strong>di</strong>o circostante, per una quantità da precisarsi attraverso<br />
un’analisi della situazione morfologica circostante, e comunque non inferiore ai 30cm;<br />
‐ negli interventi <strong>di</strong> nuova e<strong>di</strong>ficazione per i volumi interrati, vanno previsti adeguati sistemi <strong>di</strong><br />
impermeabilizzazione e drenaggio, e quanto necessario per impe<strong>di</strong>re allagamenti dei locali, sono<br />
vietati gli scivoli esterni per accesso ai garages, inoltre bocche <strong>di</strong> lupo, sfiati ecc. vanno <strong>di</strong>sposti<br />
sempre con apertura superiore a una quota come definita al punto precedente;<br />
‐ per le aree a <strong>di</strong>fficoltà drenaggio, in particolare, salvaguar<strong>di</strong>a/ripristino delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong>:<br />
‐ funzionalità della rete idrica, attraverso la ripresa <strong>di</strong> eventuali punti critici strutturali (in particolare<br />
delle parti intubate);<br />
77 <strong>di</strong> 83
Progetto: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio – RELAZIONE GEOLOGICA Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura<br />
geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico – Rev.:01<br />
Data: 28‐02‐2013 – Estensori: Prof. Geol. A. Bondesan, Dott.ssa S. Primon, Dott.ssa C. Levorato [Adastra srl]‐ Committente: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
‐ accessibilità ai corpi idrici, per assolvere alle necessarie operazioni <strong>di</strong> pulizia e manutenzione.<br />
Il P.I. sulla base <strong>di</strong> analisi geologico – idrauliche puntuali, o su ulteriori in<strong>di</strong>cazioni dei consorzi <strong>di</strong><br />
bonifica e della Autorità <strong>di</strong> Bacino, si potrà ridefinire i limiti delle aree con perio<strong>di</strong>co ristagno idrico<br />
rappresentati nella tav. 3, giustificando le <strong>di</strong>versità me<strong>di</strong>ante adeguata documentazione geologico –<br />
tecnica allegata al P.I. Il PI in<strong>di</strong>viduerà, con idonea destinazione urbanistica, appositi invasi, sia locali<br />
che <strong>di</strong>ffusi, per il drenaggio, la raccolta e lo scarico controllato delle piogge più intense, o per la<br />
laminazione delle portate <strong>di</strong> piena dei corsi d’acqua a rischio <strong>di</strong> esondazione. Per gli interventi<br />
finalizzati a contenere o risolvere le situazioni critiche <strong>di</strong>sciplinate dal presente articolo, il PI valuta<br />
anche le possibilità <strong>di</strong> operare con programmi complessi, o <strong>di</strong> applicare gli strumenti della<br />
perequazione urbanistica, del cre<strong>di</strong>to e<strong>di</strong>lizio e della compensazione urbanistica, definendone gli<br />
ambiti e i contenuti. Devono essere comunque rispettate le in<strong>di</strong>cazioni e prescrizioni fornite dalla<br />
Valutazione <strong>di</strong> Compatibilità idraulica e le <strong>di</strong>sposizioni date per i singoli ATO. Il PI in<strong>di</strong>vidua e<br />
perimetra l’ambito soggetto a erosione e ricompreso nel bacino idrogeologico degli scaranti. Per<br />
tale ambito il P.I. dovrà prevedere, in accordo con gli Enti competenti, un’opportuna rete <strong>di</strong><br />
smaltimento delle acque bianche nella sezione <strong>di</strong> chiusura del bacino stesso e prevedere le seguenti<br />
attività:<br />
a) precludere movimentazione <strong>di</strong> terra nelle sistemazioni agrarie all’interno dell’area che vada a<br />
cambiare e mo<strong>di</strong>ficare il profilo morfologico;<br />
b) vietare movimentazione <strong>di</strong> terreni agricoli nelle sistemazioni agrarie che vada a mo<strong>di</strong>ficare la<br />
permeabilità dei suoli;<br />
c) sistemazioni agrarie;<br />
d) vietare il taglio del bosco senza precisa e opportuna autorizzazione forestale che vada a<br />
incrementare il <strong>di</strong>ssesto idrogeologico;<br />
e) pre<strong>di</strong>sporre un monitoraggio perio<strong>di</strong>co dei letti degli scaranti stessi al fine <strong>di</strong> prevenire il naturale<br />
formarsi <strong>di</strong> temporanei sbarramenti che potrebbero dare origine a pericolose inondazioni.<br />
La perimetrazione delle aree soggette a <strong>di</strong>ssesto idrogeologico è stata fornita in formato <strong>di</strong><br />
interscambio esri. shp:<br />
PERCORSO: PAT<strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong>\b_Progetto\ b03_Fragilita\ b0302_DissestoIdrogeologico \<br />
b0302011_DissestoIdrogeol<br />
METADATO: b0302011_DissestoIdrogeol<br />
78 <strong>di</strong> 83
7 Geositi<br />
Progetto: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio – RELAZIONE GEOLOGICA Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura<br />
geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico – Rev.:01<br />
Data: 28‐02‐2013 – Estensori: Prof. Geol. A. Bondesan, Dott.ssa S. Primon, Dott.ssa C. Levorato [Adastra srl]‐ Committente: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
7.1 MEANDRO ABBANDONATO DEL PIAVE<br />
Si tratta della traccia molto evidente <strong>di</strong> un’ansa fluviale che è rimasta isolata in seguito alla<br />
rettifica del tratto del <strong>Piave</strong> in corrispondenza <strong>di</strong> S. Donà <strong>di</strong> <strong>Piave</strong>. Il meandro abbandonato, oggi<br />
completamente interrato, si sviluppa in destra idrografica ed è racchiuso negli argini del fiume che qui si<br />
allargano ad includere la traccia relitta (figura 16). La parcellizzazione agraria enfatizza il <strong>di</strong>segno<br />
geometrico del paleoalveo consentendo <strong>di</strong> <strong>di</strong>stinguere agevolmente l’antico lago <strong>di</strong> meandro, ben<br />
riconoscibile anche nella cartografia dell’Istituto Geografico Militare dei primi decenni del secolo scorso.<br />
Un nucleo <strong>di</strong> abitazioni occupa oggi il lobo del meandro.<br />
forniti:<br />
Figura 16: Foto panoramica del meandro abbandonato del <strong>Piave</strong>..<br />
Di seguito si riporta la collocazione dei file shape, e i rispettivi nomi dei metadati dei file. shp<br />
79 <strong>di</strong> 83
Progetto: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio – RELAZIONE GEOLOGICA Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura<br />
geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico – Rev.:01<br />
Data: 28‐02‐2013 – Estensori: Prof. Geol. A. Bondesan, Dott.ssa S. Primon, Dott.ssa C. Levorato [Adastra srl]‐ Committente: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
PERCORSO: PAT<strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong>\b_Progetto\ b02_Invarianti\ b0201_InvGeologiche\b0201021_GeositiA<br />
METADATO: b0201021_GeositiA<br />
7.2 PALEOCANALI LAGUNARI<br />
Nella zona situata tra il canale Fossetta e il Taglio del Sile si in<strong>di</strong>vidua un’area interessata da<br />
canali derivanti dall’azione <strong>di</strong> flusso e riflusso delle maree in aree lagunari.<br />
I canali <strong>di</strong> marea hanno in parte riutilizzato i corsi d’acqua provenienti da nord‐ovest, risalendo<br />
così l’entroterra attraverso percorsi predefiniti, in parte hanno lasciato evidenti tracce della loro<br />
presenza nella fitta rete <strong>di</strong> sottili ramificazioni che si <strong>di</strong>partono dalle aste fluviali principali.<br />
La larghezza dei canali <strong>di</strong> marea si riduce rapidamente da valori massimi a partire dalla bocca a<br />
mare fino a arrivare a valori minimi nelle parti terminali delle varie ramificazioni (canali e ghebi). Si tratta<br />
comunque <strong>di</strong> tracce dal corso breve, spesso sottile, <strong>di</strong> colore chiaro rispetto ai terreni circostanti più<br />
scuri rappresentanti l’antico fondo lagunare (figura 17). Solitamente si <strong>di</strong>stinguono dai paleoalvei <strong>di</strong><br />
origine fluviale per l’assenza della traccia più chiara degli argini naturali. La presenza degli argini ai lati<br />
dei canali interpretati come lagunari, deriva talora dal riutilizzo da parte dei canali mareali <strong>di</strong> precedenti<br />
percorsi fluviali.<br />
L’attribuzione, quin<strong>di</strong>, dei paleoalvei a forme <strong>di</strong> tipo fluviale o <strong>di</strong> tipo lagunare rappresenta in<br />
alcuni casi un problema a causa dell’interazione tra uno e l’altro ambiente, della sovrapposizione <strong>di</strong><br />
forme derivanti da processi <strong>di</strong> natura <strong>di</strong>versa e dalla variazione <strong>di</strong> tipo paleoambientale che le varie aree<br />
hanno subito nel tempo.<br />
80 <strong>di</strong> 83
forniti:<br />
Progetto: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio – RELAZIONE GEOLOGICA Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura<br />
geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico – Rev.:01<br />
Data: 28‐02‐2013 – Estensori: Prof. Geol. A. Bondesan, Dott.ssa S. Primon, Dott.ssa C. Levorato [Adastra srl]‐ Committente: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
Figura 17: I paleocanali lagunari tra il canale Fossetta e il Taglio del Sile (Volo GAI 55, str. 16°, n. 721, anno 1955, IGM)<br />
Di seguito si riporta la collocazione dei file shape, e i rispettivi nomi dei metadati dei file. shp<br />
PERCORSO: PAT<strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong>\b_Progetto\ b02_Invarianti\ b0201_InvGeologiche\b0201021_GeositiA<br />
METADATO: b0201021_GeositiA<br />
81 <strong>di</strong> 83
Bibliografia<br />
Progetto: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio – RELAZIONE GEOLOGICA Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura<br />
geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico – Rev.:01<br />
Data: 28‐02‐2013 – Estensori: Prof. Geol. A. Bondesan, Dott.ssa S. Primon, Dott.ssa C. Levorato [Adastra srl]‐ Committente: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
BONDESAN A. & MENEGHEL M. (a cura <strong>di</strong>) 2004a - Geomorfologia della provincia <strong>di</strong> Venezia.<br />
Esedra, Padova, 516 pp.<br />
BONDESAN A. & MENEGHEL M. (a cura <strong>di</strong>), 2004b - Carta geomorfologica della Provincia <strong>di</strong><br />
Venezia, scala 1:50.000. LAC, Firenze, 4 fogli.<br />
BONDESAN A. & MOZZI P., 2002a - La geomorfologia dell’area del Basso Sile. In: GHEDINI F.,<br />
BONDESAN A.., BUSANA M.S., La tenuta <strong>di</strong> Ca’ Tron. Ambiente e Storia nella terra dei Dogi,<br />
Cierre, Verona, 57-61.<br />
BONDESAN A. & MOZZI P., 2002b - Aspetti geomorfologici della tenuta <strong>di</strong> Ca’ Tron. In: GHEDINI F.,<br />
BONDESAN A., BUSANA M.S., La tenuta <strong>di</strong> Ca’ Tron. Ambiente e Storia nella terra dei Dogi,<br />
Cierre, Verona, 61-68.<br />
BONDESAN A. & MOZZI P., 2002c - La paleogeografia della pianura in sinistra Sile. In: GHEDINI F.,<br />
BONDESAN A., BUSANA M.S., La tenuta <strong>di</strong> Ca’ Tron. Ambiente e Storia nella terra dei Dogi,<br />
Cierre, Verona, 68-71.<br />
BONDESAN A., CALDERONI G. & MOZZI P., 2002 – L’assetto geomorfologico della pianura veneta<br />
centro-orientale: stato delle conoscenze e nuovi dati. In: VAROTTO M. & ZUNICA M. (a cura <strong>di</strong>),<br />
Scritti in ricordo <strong>di</strong> Giovanna Brunetta, Università degli Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> Padova, Dipartimento <strong>di</strong><br />
Geografia “Giuseppe Moran<strong>di</strong>ni”, Padova, 19-38.<br />
BONDESAN A., FINZI E., FONTANA A., FRANCESE R., MAGRI S., MOZZI P., PRIMON S. & ZAMBONI C.,<br />
2004 - La Via Annia a Ca’ Tron: nuovi contributi della geomorfologia, della geofisica e del<br />
telerilevamento. In: Busana M.S., Ghe<strong>di</strong>ni F. (Eds.), La via Annia e le sue infrastrutture, Atti<br />
delle Giornate <strong>di</strong> Stu<strong>di</strong>o (Ca’ Tron, Roncade, 6 – 7 novembre 2003), Grafiche Antiga,<br />
Cornuda (Treviso), pp. 109-146.<br />
BONDESAN A., FONTANA A., BASSAN V., CAMPANA R., MENEGHEL M., TOFFOLETTO F. & VITTURI A.<br />
(in stampa). Note illustrative della Carta Geologica d'Italia alla scala 1:50.000. 107 –<br />
Portogruaro. ISPRA-Regione del Veneto, Roma.<br />
BONDESAN A., PRIMON S., BASSAN V. & VITTURI A. (a cura <strong>di</strong>), 2008 – Le unità geologiche della<br />
provincia <strong>di</strong> Venezia. Cierre Grafica, Caselle <strong>di</strong> Sommacampagna (Verona).<br />
BROGLIO A., FAVERO V. & MARSALE S., 1987 - Ritrovamenti mesolitici attorno alla laguna <strong>di</strong><br />
Venezia. Istituto Veneto <strong>di</strong> Scienze Lettere ed Arti, Commissione <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o dei provve<strong>di</strong>menti<br />
per la conservazione e <strong>di</strong>fesa della laguna e della città <strong>di</strong> Venezia. Venezia, Rapporti e<br />
Stu<strong>di</strong>, 10, 195-231.<br />
BUSANA M.S. & GHEDINI F. (a cura <strong>di</strong>), 2003 - La via Annia e le sue infrastrutture, Atti delle<br />
Giornate <strong>di</strong> Stu<strong>di</strong>o (Ca’ Tron, Roncade, 6 – 7 novembre 2003), Grafiche Antiga, Cornuda<br />
(Treviso), pp. 109-146.<br />
CASTIGLIONI G.B. & FAVERO V., 1987 – Linee <strong>di</strong> costa antiche ai margini orientali della laguna <strong>di</strong><br />
Venezia e ai lati della foce attuale del <strong>Piave</strong>. Istituto Veneto <strong>di</strong> Scienze Lettere ed Arti,<br />
Commissione <strong>di</strong> Stu<strong>di</strong>o dei Provve<strong>di</strong>menti per la Conservazione e Difesa della Laguna e<br />
della Città <strong>di</strong> Venezia. Rapporti e Stu<strong>di</strong>, 10, 17-30.<br />
CASTIGLIONI G.B., GIRARDI A. & RODOLFI G., 1987 – Le tracce degli antichi percorsi del Brenta<br />
per Montà e Arcella nei pressi <strong>di</strong> Padova: stu<strong>di</strong>o geomorfologico. Memorie Scienze<br />
Geologiche, 39, 29-149.<br />
CROCE DA VILLA P. (a cura <strong>di</strong>), 1990 - <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong>: ponte romano lungo l’Annia. Quaderni <strong>di</strong><br />
Archeologia del Veneto, VI, 165-188.<br />
82 <strong>di</strong> 83
Progetto: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio – RELAZIONE GEOLOGICA Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura<br />
geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico – Rev.:01<br />
Data: 28‐02‐2013 – Estensori: Prof. Geol. A. Bondesan, Dott.ssa S. Primon, Dott.ssa C. Levorato [Adastra srl]‐ Committente: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
CROCE DA VILLA P., 1991 - Le vie <strong>di</strong> comunicazione. Organizzazione del territorio. Gli<br />
inse<strong>di</strong>amenti rustici. Le schede. In: La pianura tra Sile e <strong>Piave</strong> nell’antichità, Provincia <strong>di</strong><br />
Venezia, 15, 4/6, 10- 32.<br />
CROCE DA VILLA P., 2003 - Giussago. In: TASCA G. (a cura <strong>di</strong>), Giornata <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o sull’archeologi<br />
del Me<strong>di</strong>o e Basso Tagliamento “in ricordo <strong>di</strong> G. Cordenos”, S. Vito al Tagliamento, 127-139.<br />
FAVERO V., 1992 - Evoluzione morfologica e trasformazioni ambientali dalla conterminazione<br />
lagunare al nostro secolo. In: Istituto Veneto <strong>di</strong> Scienze Lettere ed Arti, Atti del Convegno <strong>di</strong><br />
Stu<strong>di</strong>o nel Bicentenario della Conterminazione lagunare: storia, ingegneria, politica e <strong>di</strong>ritto<br />
nella Laguna <strong>di</strong> Venezia, Venezia, 1991, 165-184.<br />
FONTANA A., MOZZI P. & BONDESAN A., 2008 - Alluvial megafans in the Venetian-Friulian Plain<br />
(North-eastern Italy): evidence of aggra<strong>di</strong>ng and erosive phases during Late Pleistocene and<br />
Holocene. Quaternary International, 189, 71-90.<br />
GATTO P., 1980 - Il sottosuolo del litorale veneziano. C.N.R., Istituto per lo stu<strong>di</strong>o della Dinamica<br />
delle Gran<strong>di</strong> Masse, Rapporto Tecnico 108, Venezia.<br />
GATTO P., 1984 - Il cordone litoraneo della laguna <strong>di</strong> Venezia e le cause del suo degrado. Istituto<br />
Veneto <strong>di</strong> Scienze, Lettere e Arti, Rapporti e Stu<strong>di</strong>, IX, 163-193.<br />
GATTO P. & PREVIATELLO P., 1974 - Significato stratigrafico, comportamento meccanico e<br />
<strong>di</strong>stribuzione nella laguna <strong>di</strong> Venezia <strong>di</strong> un'argilla sovraconsolidata nota come "caranto".<br />
C.N.R., Istituto per lo Stu<strong>di</strong>o Dinamica Gran<strong>di</strong> Masse, Rapporto Tecnico 70, Venezia, 45 pp.<br />
MATTEOTTI G., 1962 - Sulle caratteristiche dell'argilla precompressa esistente nel sottosuolo dei<br />
Venezia - Marghera. Notiziario dell'Or<strong>di</strong>ne degli Ingegneri della Provincia <strong>di</strong> Padova, 6,<br />
Padova.<br />
MIOLA A., ALBANESE D., VALENTINI G. & CORAIN L., 2003 – Pollen data for a biostratigraphy of<br />
LGM in the Venetian Po Plain. Il Quaternario, 16, 21-25.<br />
MOZZI P., 1995 - Evoluzione geomorfologica della pianura veneta centrale. Tesi <strong>di</strong> dottorato<br />
ine<strong>di</strong>ta, Università <strong>di</strong> Padova, Dipartimento <strong>di</strong> Geografia.<br />
MOZZI P., 1998 – Nascita e trasformazione della pianura del Sile. In: BONDESAN A., CANIATO G.,<br />
VALLERANI F. & ZANETTI M. (a cura <strong>di</strong>), Il Sile, Cierre, Verona, 40-51.<br />
MOZZI P., BINI C., ZILOCCHI L., BECATTINI R & MARIOTTI LIPPI M., 2003 - Stratigraphy,<br />
palaeopedology and palinology of late Pleistocene and Holocene deposits in the landward<br />
sector of the lagoon of Venice (Italy), in relation to caranto level. Il Quaternario, 16 (1bis),<br />
193-210.<br />
PRIMON S., 2002 - Le evidenze naturali dell’ immagine telerilevata e il confronto con gli stu<strong>di</strong><br />
precedenti. In: GHEDINI F., BONDESAN A. & BUSANA M.S. (a cura <strong>di</strong>), La tenuta <strong>di</strong> Ca’ Tron.<br />
Ambiente e storia nella terra dei Dogi, Cierre, Verona, 41-45.<br />
83 <strong>di</strong> 83
Legenda<br />
Quota (m s.l.m.)<br />
High : 4.3273<br />
Low : -2.00005<br />
0 1.000 2.000<br />
Metri<br />
Trezze<br />
<strong>Comune</strong>:<br />
Provincia:<br />
Millepertiche<br />
<strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
Venezia<br />
Croce<br />
Lazzaretto<br />
Modello <strong>di</strong>gitale del terreno<br />
Piano <strong>di</strong> assetto del territorio<br />
<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
Località:<br />
Elaborato: CL Controllato: FB Approvato: AB Tavola: 01 / A-03<br />
Data: Agosto 2010 Scala: 1:52.000 Commessa: 9687<br />
File: Estensori: Prof. Geol. Al<strong>di</strong>no Bondesan<br />
9687_Tav01_A_03 Rev.: 00<br />
1<br />
Dott.ssa Chiara Levorato 1<br />
1 - Adastra s.r.l.<br />
Committente:<br />
Caposile<br />
<strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
Piazza XVIII giugno, 1 - 30024 <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> (Venezia)<br />
0421 - 5921<br />
info@comune.musile.ve.it www.comune.musile<strong>di</strong>piave.ve.it
Legenda<br />
Unità <strong>di</strong> San Donà <strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
Unità <strong>di</strong> Meolo<br />
Unità <strong>di</strong> Montiron<br />
Unità <strong>di</strong> Caposile<br />
0 1.000 2.000<br />
Metri<br />
Trezze<br />
<strong>Comune</strong>:<br />
Provincia:<br />
Millepertiche<br />
<strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
Venezia<br />
Croce<br />
Lazzaretto<br />
Unità geologiche<br />
Piano <strong>di</strong> assetto del territorio<br />
<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
Località:<br />
Elaborato: CL Controllato: FB Approvato: AB Tavola: 02 / A-03<br />
Data: Agosto 2010 Scala: 1:52.000 Commessa: 9687<br />
File: Estensori:<br />
Prof. Geol. Al<strong>di</strong>no Bondesan<br />
9687_Tav02_A_03 Rev.: 00<br />
1<br />
Dott.ssa Chiara Levorato 1<br />
1 - Adastra s.r.l.<br />
Committente:<br />
Caposile<br />
<strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
Piazza XVIII giugno, 1 - 30024 <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> (Venezia)<br />
0421 - 5921<br />
info@comune.musile.ve.it www.comune.musile<strong>di</strong>piave.ve.it
Legenda<br />
Rilevanza del fenomeno<br />
alta<br />
me<strong>di</strong>a<br />
minima<br />
molto alta<br />
0 1.000 2.000<br />
Metri<br />
Trezze<br />
<strong>Comune</strong>:<br />
Provincia:<br />
Millepertiche<br />
<strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
Venezia<br />
Croce<br />
Lazzaretto<br />
Subsidenza - Rilevanza del fenomeno<br />
Piano <strong>di</strong> assetto del territorio<br />
<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
Località:<br />
Elaborato: CL Controllato: FB Approvato: AB Tavola: 03 / A-03<br />
Data: Agosto 2010 Scala: 1:52.000 Commessa: 9687<br />
File: Estensori: Prof. Geol. Al<strong>di</strong>no Bondesan<br />
9687_Tav03_A_03 Rev.: 00<br />
1<br />
Dott.ssa Chiara Levorato 1<br />
1 - Adastra s.r.l.<br />
Committente:<br />
Caposile<br />
<strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
Piazza XVIII giugno, 1 - 30024 <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> (Venezia)<br />
0421 - 5921<br />
info@comune.musile.ve.it www.comune.musile<strong>di</strong>piave.ve.it<br />
Fonte: Provincia <strong>di</strong> Venezia
Legenda<br />
Velocità (mm/anno)<br />
da 1 a 2<br />
da 2 a 3<br />
da 3 a 5<br />
0 1.000 2.000<br />
Metri<br />
Trezze<br />
<strong>Comune</strong>:<br />
Provincia:<br />
Millepertiche<br />
<strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
Venezia<br />
Croce<br />
Subsidenza - Velocità (mm/anno)<br />
Piano <strong>di</strong> assetto del territorio<br />
<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
Località:<br />
Elaborato: CL Controllato: FB Approvato: AB Tavola: 03 / B-03<br />
Data: Agosto 2010 Scala: 1:52.000 Commessa: 9687<br />
File: Estensori: Prof. Geol. Al<strong>di</strong>no Bondesan<br />
9687_Tav03_B_03 Rev.: 00<br />
1<br />
Dott.ssa Chiara Levorato 1<br />
1 - Adastra s.r.l.<br />
Committente:<br />
Lazzaretto<br />
Caposile<br />
<strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
Piazza XVIII giugno, 1 - 30024 <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> (Venezia)<br />
0421 - 5921<br />
info@comune.musile.ve.it www.comune.musile<strong>di</strong>piave.ve.it<br />
Fonte: Provincia <strong>di</strong> Venezia
Legenda<br />
rischio idraulico R1<br />
rischio idraulico R2<br />
rischio idraulico R3<br />
0 1.000 2.000<br />
Metri<br />
Trezze<br />
<strong>Comune</strong>:<br />
Provincia:<br />
Millepertiche<br />
Croce<br />
<strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
Venezia<br />
Lazzaretto<br />
Carta del rischio idraulico<br />
Piano <strong>di</strong> assetto del territorio<br />
<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
Località:<br />
Elaborato: CL Controllato: FB Approvato: AB Tavola: 04 / A-03<br />
Data: Agosto2010 Scala: 1:52.000 Commessa: 9687<br />
File: Estensori:<br />
Prof. Geol. Al<strong>di</strong>no Bondesan<br />
9687_Tav04_A_03 Rev.: 00<br />
1<br />
Dott.ssa Chiara Levorato 1<br />
1 - Adastra s.r.l.<br />
Committente:<br />
Caposile<br />
<strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
Piazza XVIII giugno, 1 - 30024 <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> (Venezia)<br />
0421 - 5921<br />
info@comune.musile.ve.it www.comune.musile<strong>di</strong>piave.ve.it
Legenda<br />
pericolosità idraulica P1/P2<br />
pericolosità idraulica P3<br />
0 1.000 2.000<br />
Metri<br />
Trezze<br />
<strong>Comune</strong>:<br />
Provincia:<br />
Millepertiche<br />
Croce<br />
<strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
Venezia<br />
Lazzaretto<br />
Carta della pericolosità idraulica<br />
Piano <strong>di</strong> assetto del territorio<br />
<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
Località:<br />
Elaborato: CL Controllato: FB Approvato: AB Tavola: 04 / B-03<br />
Data: Agosto 2010 Scala: 1:52.000 Commessa: 9687<br />
File: Estensori:<br />
Prof. Geol. Al<strong>di</strong>no Bondesan<br />
9687_Tav04_B_03 Rev.: 00<br />
1<br />
Dott.ssa Chiara Levorato 1<br />
1 - Adastra s.r.l.<br />
Committente:<br />
Caposile<br />
<strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
Piazza XVIII giugno, 1 - 30024 <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> (Venezia)<br />
0421 - 5921<br />
info@comune.musile.ve.it www.comune.musile<strong>di</strong>piave.ve.it
IDENTIFICATIVO<br />
SCHEDA<br />
NOME DEL GEOSITO<br />
SCHEDA PER L’INVENTARIO DEI GEOSITI<br />
SERVIZIO<br />
GEOLOGIA<br />
COMPILATORE/ENTE CODICE SCHEDA DATA SCHEDA<br />
ALDINO BONDESAN/ UNIVERSITA’ DI PADOVA 19 GENNAIO ’10<br />
MEANDRO ABBANDONATO DEL PIAVE<br />
UBICAZIONE COORDINATE GEOGRAFICHE - GAUSS-BOAGA<br />
PROVINCIA VENEZIA LONGITUDINE 5055400<br />
COMUNE MUSILE DI PIAVE LATITUDINE 2329500<br />
TOPONIMO/LOCALITÀ<br />
QUOTA 4,25 M S.L.M.<br />
RIFERIMENTO CARTOGRAFICO<br />
TAV. I.G.M. 1:25.000:<br />
C.T.R.: 106150<br />
SCALA: 1:10000<br />
DENOMINAZIONE: SAN DONA’ DI PIAVE<br />
DESCRIZIONE DELL’OGGETTO<br />
SI TRATTA DELLA TRACCIA MOLTO EVIDENTE DI UN’ANSA FLUVIALE CHE È RIMASTA ISOLATA IN SEGUITO ALLA<br />
RETTIFICA DEL TRATTO DEL PIAVE IN CORRISPONDENZA DI S. DONÀ DI PIAVE. IL MEANDRO ABBANDONATO, OGGI<br />
COMPLETAMENTE INTERRATO, SI SVILUPPA IN DESTRA IDROGRAFICA ED È RACCHIUSO NEGLI ARGINI DEL FIUME CHE<br />
QUI SI ALLARGANO AD INCLUDERE LA TRACCIA RELITTA. LA PARCELLIZZAZIONE AGRARIA ENFATIZZA IL DISEGNO<br />
GEOMETRICO DEL PALEOALVEO CONSENTENDO DI DISTINGUERE AGEVOLMENTE L’ANTICO LAGO DI MEANDRO, BEN<br />
RICONOSCIBILE ANCHE NELLA CARTOGRAFIA DELL’ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE DEI PRIMI DECENNI DEL SECOLO<br />
SCORSO. UN NUCLEO DI ABITAZIONI OCCUPA OGGI IL LOBO DEL MEANDRO.<br />
LITOLOGIA CARATTERIZZANTE<br />
SABBIA<br />
ETÀ DEL PROCESSO GENETICO<br />
OLOCENE<br />
INTERESSE<br />
GEOGRAFICO IDROGEOLOGICO ARCHEOLOGICO<br />
GEOLOGIA MARINA MINERALOGICO SEDIMENTOLOGICO<br />
GEOLOGIA STRATIGRAFICA NATURALISTICO GEOMORFOLOGICO X
GEOLOGIA STRUTTURALE PAESAGGISTICO PEDOLOGICO<br />
GEOMINERARIO FOSSILIFERO ESCURSIONISTICO<br />
CULTURALE X DIDATTICO X<br />
STORICO ………………………… …………………………<br />
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA<br />
SE NON ORIGINALE SPECIFICARE FONTE/AUTORE:<br />
PROVINCIA DI VENEZIA, BONDESAN A., 2004<br />
VINCOLI TERRITORIALI INSISTENTI SULL’AREA<br />
IL SITO RIENTRA IN UN’AREA PROTETTA? SI X NO<br />
PARCHI NAZIONALI<br />
DEFINIZIONE ALTRI TIPI DI VINCOLO TERRITORIALE<br />
RISERVE NATURALI STATALI VINCOLO PAESISTICO-AMBIENTALE<br />
PARCHI NATURALI REGIONALI VINCOLO AI SENSI D. LGS 431/75<br />
RISERVE NATURALI REGIONALI AMBITI NATURALISTICI A LIVELLO REGIONALE X<br />
ZUI VINCOLO ARCHEOLOGICO<br />
ZPS BIOTOPI<br />
ZSC<br />
SIC<br />
AREE BOSCATE E ZONE CON PRIORITÀ DI<br />
RIFORESTAZIONE<br />
PTRC ART. 33-34-35<br />
X<br />
X<br />
ALTRE AREE PROTETTE ……………………………………<br />
FRUIZIONE DELL’OGGETTO E/O DELL’AREA<br />
ACCESSIBILITÀ’<br />
EMERSO<br />
A PIEDI X IN AUTO ASFALTO IN BARCA MOUNTAIN<br />
BIKE<br />
SOMMERSO<br />
SOTTERRANEO<br />
STERRATA<br />
VISIBILE DA<br />
SUPERFICIE<br />
VISIBILE IN<br />
IMMERSIONE<br />
X
CARATTERI SALIENTI<br />
PUNTO PANORAMICO X<br />
PUNTO VISIBILE DA LONTANO X<br />
SITO DI ITINERARIO GEOLOGICO- NATURALISTICO X BIBLIOGRAFIA<br />
NOTE:<br />
SI NO<br />
PROPRIETÀ DEMANIALE X<br />
PROPRIETÀ’ PRIVATA X<br />
AREA ATTREZZATA X<br />
PRESENZA DI STRUTTURE ALBERGHIERE X ENTRO 1 KM<br />
POSSIBILITÀ DI CAMPEGGIO X<br />
PRESENZA DI ACQUA POTABILE X<br />
USO DEL SUOLO SI NO<br />
SI NO STAGIONE CONSIGLIATA I P E A<br />
SE SÌ, ENTRO KM<br />
TERRAZZATO X ROCCIA AFFIORANTE<br />
BONDESAN A., MENEGHEL M.<br />
(a cura <strong>di</strong>), 2004, "Geomorfologia<br />
della provincia <strong>di</strong> Venezia. Note<br />
illustrative della Carta<br />
geomorfologica della provincia <strong>di</strong><br />
Venezia", Esedra, Padova, 516.<br />
SIMONELLA I. (a cura <strong>di</strong>), 2005,<br />
"Atlante degli ambiti <strong>di</strong> interesse<br />
naturalistico della provincia <strong>di</strong><br />
Venezia". Provincia <strong>di</strong> Venezia,<br />
Cicero, Venezia, 138-139.<br />
COLTIVATO X SE COLTIVATO SPECIFICARE : FRUMENTO, VITIGNI<br />
INCOLTO X
IDENTIFICATIVO<br />
SCHEDA<br />
NOME DEL GEOSITO<br />
SCHEDA PER L’INVENTARIO DEI GEOSITI<br />
SERVIZIO<br />
GEOLOGIA<br />
COMPILATORE/ENTE CODICE SCHEDA DATA SCHEDA<br />
PAOLO MOZZI/ UNIVERSITA’ DI PADOVA 19 GENNAIO ’10<br />
PALEOCANALI LAGUNARI<br />
UBICAZIONE COORDINATE GEOGRAFICHE - GAUSS-BOAGA<br />
PROVINCIA VENEZIA LONGITUDINE 5050500<br />
COMUNE MUSILE DI PIAVE LATITUDINE 2324000<br />
TOPONIMO/LOCALITÀ<br />
QUOTA -1,6 M S.L.M.<br />
RIFERIMENTO CARTOGRAFICO<br />
TAV. I.G.M. 1:25.000:<br />
C.T.R.: 128020<br />
SCALA: 1:10000<br />
DENOMINAZIONE: PORTEGRANDI<br />
DESCRIZIONE DELL’OGGETTO<br />
NELLA ZONA SITUATA TRA IL CANALE FOSSETTA E IL TAGLIO DEL SILE SI INDIVIDUA UN’AREA INTERESSATA DA CANALI<br />
DERIVANTI DALL’AZIONE DI FLUSSO E RIFLUSSO DELLE MAREE IN AREE LAGUNARI. IN QUESTO CASO I CANALI DI MAREA<br />
IN PARTE HANNO RIUTILIZZATO I CORSI D’ACQUA PROVENIENTI DA NORD-OVEST RISALENDO COSÌ L’ENTROTERRA<br />
ATTRAVERSO PERCORSI PREDEFINITI, IN PARTE HANNO LASCIATO EVIDENTI TRACCE DELLA LORO PRESENZA NELLA<br />
FITTA RETE DI SOTTILI RAMIFICAZIONI CHE SI DIPARTONO DALLE ASTE FLUVIALI PRINCIPALI. LA LARGHEZZA DEI<br />
CANALI DI MAREA SI RIDUCE RAPIDAMENTE DA VALORI MASSIMI A PARTIRE DALLA BOCCA A MARE FINO A ARRIVARE A<br />
VALORI MINIMI NELLE PARTI TERMINALI DELLE VARIE RAMIFICAZIONI (CANALI E GHEBI)<br />
LITOLOGIA CARATTERIZZANTE<br />
LIMO<br />
ETÀ DEL PROCESSO GENETICO<br />
OLOCENE<br />
INTERESSE<br />
GEOGRAFICO IDROGEOLOGICO ARCHEOLOGICO<br />
GEOLOGIA MARINA MINERALOGICO SEDIMENTOLOGICO X<br />
GEOLOGIA STRATIGRAFICA NATURALISTICO GEOMORFOLOGICO X
GEOLOGIA STRUTTURALE PAESAGGISTICO PEDOLOGICO<br />
GEOMINERARIO FOSSILIFERO ESCURSIONISTICO<br />
CULTURALE X DIDATTICO X<br />
STORICO ………………………… …………………………<br />
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA<br />
SE NON ORIGINALE SPECIFICARE FONTE/AUTORE:<br />
foto Bondesan A. - Provincia <strong>di</strong> Venezia, 16/12/2003).<br />
VINCOLI TERRITORIALI INSISTENTI SULL’AREA<br />
IL SITO RIENTRA IN UN’AREA PROTETTA? SI X NO<br />
PARCHI NAZIONALI<br />
DEFINIZIONE ALTRI TIPI DI VINCOLO TERRITORIALE<br />
RISERVE NATURALI STATALI VINCOLO PAESISTICO-AMBIENTALE<br />
PARCHI NATURALI REGIONALI VINCOLO AI SENSI D. LGS 431/75<br />
RISERVE NATURALI REGIONALI AMBITI NATURALISTICI A LIVELLO REGIONALE X<br />
ZUI VINCOLO ARCHEOLOGICO<br />
ZPS BIOTOPI<br />
ZSC<br />
SIC<br />
AREE BOSCATE E ZONE CON PRIORITÀ DI<br />
RIFORESTAZIONE<br />
PTRC ART. 33-34-35<br />
X<br />
X<br />
ALTRE AREE PROTETTE<br />
FRUIZIONE DELL’OGGETTO E/O DELL’AREA<br />
ACCESSIBILITÀ’<br />
AMBITI EX 1497/39 EX 431/85<br />
PALAV ART.21 INTERESSE PAESISTICO-<br />
AMBIENTALE<br />
EMERSO<br />
A PIEDI X IN AUTO ASFALTO IN BARCA MOUNTAIN<br />
BIKE<br />
SOMMERSO<br />
SOTTERRANEO<br />
STERRATA<br />
VISIBILE DA<br />
SUPERFICIE<br />
VISIBILE IN<br />
IMMERSIONE<br />
X<br />
X<br />
X
CARATTERI SALIENTI<br />
SI NO STAGIONE CONSIGLIATA I P E A<br />
PUNTO PANORAMICO X<br />
PUNTO VISIBILE DA LONTANO X<br />
SITO DI ITINERARIO GEOLOGICO- NATURALISTICO X BIBLIOGRAFIA GHEDINI F. et alii, 2002, "La tenuta<br />
<strong>di</strong> Ca' Tron. Ambiente e Storia nella<br />
terra dei Dogi", Cierre, Verona.<br />
MOZZI P., 1998, "Nascita e<br />
trasformazione della pianura del<br />
Sile". In: Bondesan A. et alii (a cura<br />
<strong>di</strong>), Il Sile, Cierre, Verona, 40-51.<br />
NOTE:<br />
PROPRIETÀ DEMANIALE<br />
PROPRIETÀ’ PRIVATA<br />
AREA ATTREZZATA<br />
PRESENZA DI STRUTTURE ALBERGHIERE<br />
POSSIBILITÀ DI CAMPEGGIO<br />
PRESENZA DI ACQUA POTABILE<br />
USO DEL SUOLO SI NO<br />
SI NO<br />
SE SÌ, ENTRO KM<br />
TERRAZZATO X ROCCIA AFFIORANTE<br />
COLTIVATO X SE COLTIVATO SPECIFICARE : MAIS, SOIA, FRUMENTO<br />
INCOLTO X
2011<br />
P.A.T.<br />
Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio<br />
ALLEGATO 3<br />
<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> MUSILE DI PIAVE<br />
Piazza XVIII giugno, 1 - 30024 - <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />
Tel. 0421.5921 Fax.0421.52385<br />
info@comune.musile.ve.it; comune.musile<strong>di</strong>piave.ve@pecveneto.it<br />
Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura geologica, Compatibilità geologica<br />
ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico<br />
STRATIGRAFIE<br />
Data:<br />
14 Febbraio 2011<br />
Commessa:<br />
9687 PAT MUSILE DI PIAVE<br />
ADASTRA srl - sede legale: v. Xola, 41b 30020 Torre <strong>di</strong> Mosto (Ve) - sede operativa: v. Confin, 87b 30020 Torre <strong>di</strong> Mosto (Ve)<br />
tel. 0421-325683 fax 0421-326532 www.adastra.it - c.f. p. iva - reg. impr. ve 03528210275 - n° rea cciaa 315799<br />
AZIENDA CERTIFICATA CON SISTEMA DI QUALITÀ UNI EN ISO 9001/2008