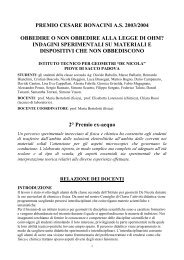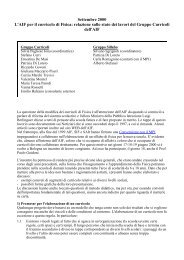You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>AIF</strong><br />
<strong>F=ma</strong><br />
Ma cosa è F?<br />
Cosa è m? Cosa è a?<br />
Pietro Cerreta<br />
<strong>AIF</strong> & Associazione ScienzaViva<br />
Calitri
Breve raccolta antologica di risposte fornite da<br />
scienziati famosi e da esperti in didattica della<br />
fisica
Lo spazio<br />
Lo spazio assoluto, per sua natura senza relazione ad<br />
alcunché di esterno, rimane sempre uguale ed<br />
immobile;<br />
Lo spazio relativo è una dimensione mobile o misura<br />
dello spazio assoluto, che i nostri sensi definiscono in<br />
relazione alla sua posizione rispetto ai corpi, ed è<br />
comunemente preso al posto dello spazio immobile …
La prima legge del movimento<br />
Ciascun corpo persevera nel proprio stato di<br />
quiete o di moto rettilineo uniforme, a meno<br />
che non sia costretto a mutare quello stato<br />
da forze impresse
La prima legge del<br />
movimento o<br />
Principio d'inerzia<br />
Quiete o moto<br />
rettilineo<br />
Nessuna causa<br />
di variazione di<br />
quiete o di<br />
moto uniforme<br />
Circolo vizioso<br />
Sistema di<br />
riferimento inerziale<br />
Se la forza è nulla<br />
forza<br />
nulla
«Ogni corpo persevera in uno stato di<br />
quiete o di moto uniforme, eccetto<br />
quando non lo fa» (Eddington, 1929)
Il significato della prima legge ( dal PPC, 1986)<br />
Può darsi che l'esperimento ideale di Galileo vi abbia<br />
convinto della validità del principio d'inerzia. Sarebbe<br />
tuttavia importante elaborare un metodo per verificarlo<br />
sperimentalmente.<br />
Potreste mettere in moto un oggetto (forse anche un<br />
disco di ghiaccio secco) in condizioni tali da essere sicuri<br />
che la forza risultante agente su di esso è zero, per poi<br />
vedere se esso continua a muoversi di moto rettilineo<br />
uniforme, come prevede la prima legge.
L'esperimento non è così semplice come potrebbe<br />
sembrare: in realtà scopriamo che l'unico modo per<br />
affermare con certezza che la risultante è zero è quello<br />
di constatare che il corpo si muove con velocità<br />
costante!<br />
Il circolo vizioso così ottenuto deriva dal fatto che le leggi<br />
di Newton non sono descrizioni dirette di risultati<br />
sperimentali, ma sono ipotesi che, nel loro complesso,<br />
formano la base di una nuova spiegazione del moto.<br />
Come per l'ipotesi di Galileo sul moto di caduta libera,<br />
noi non possiamo verificare le ipotesi di partenza, ma<br />
solo le deduzioni matematiche che riusciamo a trarne.»<br />
Dal PPC, Progetto Fisica, Zanichelli, 1986, pag. 4-17<br />
e 18
La seconda<br />
legge del movimento<br />
Il cambiamento di moto è proporzionale alla<br />
forza motrice impressa ed avviene lungo la<br />
linea retta secondo la quale la forza è stata<br />
impressa<br />
Δ (mv) ~ F<br />
d(mv) / dt ~ F?<br />
F= ma ?
Nei Principia non vi sono né equazioni del<br />
moto né tantomeno le leggi del moto come<br />
noi siamo abituati a considerarle; la<br />
seconda legge del moto in forma moderna<br />
fu enunciata per la prima volta nel 1750 da<br />
Eulero.<br />
Da G. Maltese, La storia di «<strong>F=ma</strong>». La<br />
seconda legge del moto nel XVIII<br />
secolo, L.S. Olschki, Firenze, 1992
F = m . a<br />
Newton non fornisce una teoria delle forze in<br />
modo indipendente dalle leggi del moto.<br />
In quali circostanze possiamo affermare che<br />
delle forze vengono impresse sui corpi, senza<br />
considerare il loro moto?
La terza<br />
legge del movimento<br />
Ad ogni azione corrisponde una reazione<br />
uguale e contraria: ossia, le azioni di due<br />
corpi sono sempre uguali fra loro e dirette<br />
verso parti opposte.
Terza legge del moto<br />
Si aggiunge che vale in un sistema isolato ( Ma<br />
quando un sistema è isolato? Se manca la<br />
definizione di forza nulla?)<br />
Essa afferma<br />
f 1 =-f 2<br />
Se non so - per altra via - cosa vuol dire forza, cosa<br />
concludo da essa?<br />
[ Concluderei<br />
m 1 a 1 = - m 2 a 2<br />
solo se assumo f= m.a per definizione ]
La legge dell'accelerazione, la regola di<br />
composizione delle forze, non sono, dunque, che<br />
convenzioni arbitrarie?<br />
Convenzioni, si; arbitrarie, no .<br />
Lo sarebbero se si perdessero di vista gli<br />
esperimenti che hanno indotto i fondatori della<br />
scienza ad adottarle, e che, per quanto imperfetti<br />
siano, bastano a giustificarle. È utile, di tanto in<br />
tanto, riportare la nostra attenzione sull'origine<br />
sperimentale delle convenzioni.<br />
J.H. Poincaré: La scienza e l'ipotesi, Edizioni<br />
Dedalo, 1989, p.123
Da J.R. Zacharias,<br />
"Curriculum reform<br />
in U.S.A.", in<br />
S.C.Brown (ed.),<br />
Why teach<br />
Physics?, MIT 1963<br />
E' anche necessario sapere<br />
perché si crede nella<br />
meccanica newtoniana.<br />
Si crede nella meccanica<br />
newtoniana per la<br />
meccanica celeste, non per<br />
i blocchi di legno sui tavoli.<br />
Si crede ad essa per la sua<br />
universalità e non per la<br />
sua evidenza<br />
sperimentale….
Per non farci abbandonare dalle<br />
studentesse, abbiamo cambiato l'ordine degli<br />
argomenti, e iniziamo sostanzialmente con<br />
onde ed ottica invece di iniziare -a freddo -<br />
con la meccanica newtoniana! E ha<br />
funzionato.
Per lo studente quattordicenne che si accosta a<br />
questo studio [della meccanica], la risoluzione delle<br />
ambiguità che nascono - contemporaneamente -<br />
dall'uso nella teoria di termini impiegati anche nel<br />
linguaggio comune (con un facile trasferimento di<br />
significati) e dalle difficoltà logiche insite nel tipo di<br />
formalizzazione (assiomaticamente non completa)<br />
della meccanica newtoniana, è decisamente troppo<br />
impegnativa.<br />
Da S. Sgrignoli, Insegnare la fisica senza partire<br />
dalla meccanica, Epsilon, Paravia, ott. 1988
«Anche se non capirete completamente<br />
ciò che le leggi della dinamica dicono,<br />
disponetevi a risolvere il vostro problema<br />
nella maniera approvata e tutto andrà<br />
bene»<br />
D. Halliday e R. Resnick, Physics,<br />
Wiley &Sons, New York, 1960 p.<br />
88-89.
Si vede subito che la prima e la seconda<br />
legge sono già contenute nella definizione<br />
della forza, secondo la quale senza forza<br />
non si verifica accelerazione, e quindi non si<br />
verifica quiete o moto rettilineo uniforme.<br />
Dire che la variazione del moto è<br />
proporzionale alla forza, dopo che<br />
l'accelerazione è stata definita come misura<br />
della forza, significa cadere in una<br />
tautologia inutile. Per evitarla sarebbe stato<br />
sufficiente chiarire che le definizioni<br />
premesse non sono definizioni matematiche<br />
arbitrarie, ma proprietà dei corpi date<br />
dall'esperienza.<br />
Da E. Mach, La meccanica nel suo sviluppo<br />
storico-critico, Boringhieri, p.262
La riformulazione di Mach<br />
Proposizione sperimentale. Corpi posti<br />
l'uno in presenza dell'altro determinano,<br />
in circostanze che devono venire<br />
stabilite dalla fisica sperimentale,<br />
accelerazioni opposte l'una all'altra nella<br />
direzione della loro linea di unione. (La<br />
legge d'inerzia è già contenuta in questa<br />
proposizione.)<br />
Definizione. Il rapporto delle masse dei<br />
due corpi è il rapporto inverso delle loro<br />
rispettive accelerazioni preso con segno<br />
negativo.<br />
m1/m2=-a2/a1 mk=-a1/ak
• Proposizione sperimentale. I rapporti delle masse<br />
sono indipendenti dallo stato fisico dei corpi che<br />
determinano le accelerazioni mutue (cioè dall'essere<br />
essi elettrici, magnetici ecc.), e restano gli stessi tanto<br />
se queste sono impresse direttamente quanto se lo<br />
sono indirettamente.<br />
• Proposizione sperimentale. Le accelerazioni che più<br />
corpi A, B, C... imprimono a un corpo K sono<br />
indipendenti l'una dall'altra. (Da questa proposizione<br />
segue immediatamente il teorema del<br />
parallelogramma delle forze.)<br />
• Definizione. Una forza motrice è il prodotto della<br />
massa di un corpo per l'accelerazione impressagli.
Schema di Arons
Conclusioni<br />
Le difficoltà incontrate possono essere<br />
classificate come di tipo:<br />
• Cognitivo (misconcezioni degli studenti )<br />
• Didattico ( chiarezza e ordine nella sequenza dei<br />
concetti e degli esperimenti )<br />
• Logico-formale (coerenza interna della teoria o<br />
incoerenza empirico-convenzionale)<br />
• Epistemologico (sviluppo storico e significato<br />
attuale dei concetti presenti dei Principi della<br />
dinamica e loro riformulazione)