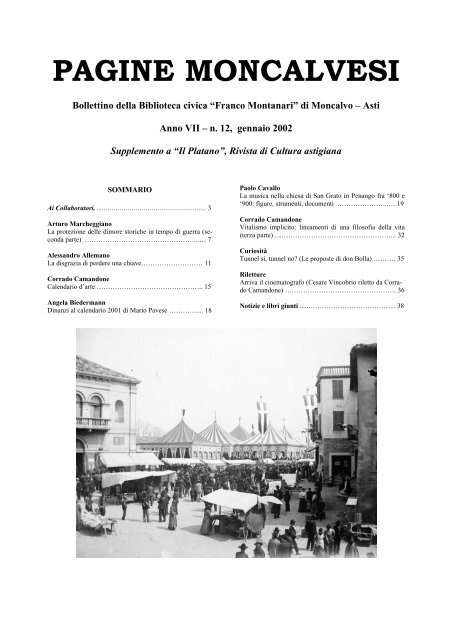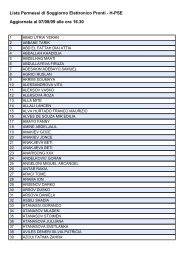Pagine Moncalvesi - Anno VII - n. 12, gennaio 2002 - Provincia di Asti
Pagine Moncalvesi - Anno VII - n. 12, gennaio 2002 - Provincia di Asti
Pagine Moncalvesi - Anno VII - n. 12, gennaio 2002 - Provincia di Asti
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
PAGINE MONCALVESI<br />
Bollettino della Biblioteca civica “Franco Montanari” <strong>di</strong> Moncalvo – <strong>Asti</strong><br />
<strong>Anno</strong> <strong>VII</strong> – n. <strong>12</strong>, <strong>gennaio</strong> <strong>2002</strong><br />
Supplemento a “Il Platano”, Rivista <strong>di</strong> Cultura astigiana<br />
SOMMARIO<br />
Ai Collaboratori. .....………………………………………….. 3<br />
Arturo Marcheggiano<br />
La protezione delle <strong>di</strong>more storiche in tempo <strong>di</strong> guerra (seconda<br />
parte) …………………………………………...… 7<br />
Alessandro Allemano<br />
La <strong>di</strong>sgrazia <strong>di</strong> perdere una chiave……………………… 11<br />
Corrado Camandone<br />
Calendario d’arte ……………………………………….. 15<br />
Angela Biedermann<br />
Dinanzi al calendario 2001 <strong>di</strong> Mario Pavese ………….... 18<br />
Paolo Cavallo<br />
La musica nella chiesa <strong>di</strong> San Grato in Penango fra ‘800 e<br />
‘900: figure, strumenti, documenti …………………..… 19<br />
Corrado Camandone<br />
Vitalismo implicito: lineamenti <strong>di</strong> una filosofia della vita<br />
(terza parte) ....…………………………………………... 32<br />
Curiosità<br />
Tunnel si, tunnel no? (Le proposte <strong>di</strong> don Bolla) ………. 35<br />
Riletture<br />
Arriva il cinematografo (Cesare Vincobrio riletto da Corrado<br />
Camandone) …………………………………………. 36<br />
Notizie e libri giunti .....………………………………... 38
Ai sensi della legge 675/96, “Tutela delle persone e <strong>di</strong> altri soggetti rispetto al trattamento<br />
<strong>di</strong> dati personali” (legge sulla privacy), chiunque NON desideri che il proprio nome<br />
compaia tra gli aderenti a questo Bollettino potrà comunicarlo per iscritto alla redazione.<br />
Chi non esegue alcuna comunicazione in tal senso, si intenderà consenziente. Si<br />
garantisce inoltre la riservatezza dell’in<strong>di</strong>rizzario completo, cui si potrà attingere per formulare<br />
inviti a manifestazioni <strong>di</strong> carattere esclusivamente culturale. Tali dati non saranno<br />
comunque trasmessi a terzi.<br />
In copertina<br />
La piazza del Mercato (dal 1907, piazza Garibal<strong>di</strong>) con baracconi e banchi allestiti per la<br />
fiera patronale <strong>di</strong> Sant’Antonino.<br />
La fotografia, risalente all’inizio del secolo XX, appartiene alla collezione Rosinganna del<br />
fondo fotografico Verdelli - Parva Lux; si ringrazia la maestra Paola Bertone Bianco per<br />
la gentile concessione alla Biblioteca civica.
“Il leggere rende un uomo completo;<br />
il parlare lo rende pronto; lo scrivere lo rende preciso”<br />
Francis Bacon (1561 - 1626) “Essays”, 50, Of stu<strong>di</strong>es<br />
AI COLLABORATORI<br />
Il “Bollettino” è giunto al suo settimo anno <strong>di</strong> vita e al do<strong>di</strong>cesimo numero: oltre a fare gli<br />
auguri <strong>di</strong> buon anno ai sempre più numerosi Lettori, riproponiamo le norme <strong>di</strong> collaborazione<br />
già pubblicate sul precedente numero.<br />
1) La collaborazione al semestrale “<strong>Pagine</strong> <strong>Moncalvesi</strong>” è gratuita: i Collaboratori potranno,<br />
su richiesta e senza spesa, ottenere alcune copie della rivista, secondo <strong>di</strong>sponibilità.<br />
2) Si accettano <strong>di</strong> preferenza articoli che abbiano attinenza con la storia locale monferrina.<br />
3) A giu<strong>di</strong>zio insindacabile della redazione, potranno essere pubblicati anche interventi<br />
che trattino più in generale temi legati alla <strong>di</strong>ffusione della cultura in tutti gli ambiti<br />
della vita sociale.<br />
4) Adeguandosi alle <strong>di</strong>rettive <strong>di</strong> gestione della Biblioteca civica <strong>di</strong> Moncalvo, ogni numero<br />
della rivista pubblicherà un articolo riguardante la protezione dei beni culturali nelle<br />
più svariate circostanze (nei conflitti armati, nelle calamità naturali, in caso <strong>di</strong> furto,<br />
etc.).<br />
5) La redazione, pur apprezzando e caldeggiando la collaborazione <strong>di</strong> tutti quanti fossero<br />
interessati, si riserva, a suo insindacabile giu<strong>di</strong>zio, <strong>di</strong> scegliere gli interventi da<br />
pubblicare su ciascun numero del bollettino, tenuto conto dello spazio <strong>di</strong>sponibile e<br />
della necessaria varietà <strong>di</strong> argomenti da trattare.<br />
6) Il contenuto degli articoli rispecchiano esclusivamente l’opinione dei rispettivi autori.<br />
7) Sarà particolarmente gra<strong>di</strong>ta la fornitura degli articoli su supporto magnetico (<strong>di</strong>schetto),<br />
con memorizzazione in formato “solo testo” oppure in formato WORD per<br />
Windows.<br />
8) Ciascun Collaboratore potrà fornire anche un certo numero <strong>di</strong> immagini da inserire a<br />
corredo dello scritto; in caso contrario, l’articolo sarà illustrato a cura della redazione.<br />
Con ciò terminiamo, ed auguriamo a tutti una piacevole lettura.<br />
Alessandro Allemano Antonio Barbato<br />
Presidente della Biblioteca Direttore della Biblioteca<br />
3
ADESIONI AL BOLLETTINO “PAGINE MONCALVESI”<br />
Elenco aggiornato al 31 <strong>di</strong>cembre 2001<br />
Aldo <strong>di</strong> Ricaldone – Ottiglio (AL)<br />
Giuseppe Alessio – Montemagno (AT)<br />
Carlo Aletto – Rosignano Monf. (AL)<br />
Rita Allara – Grazzano B. (AT)<br />
Gaetano Amante – Penango (AT)<br />
Irene Amarotto – Genova<br />
Rosanna Amerio - Grazzano Badoglio (AT)<br />
Antonino Angelino – Casale Monf. (AL)<br />
Rosalba Ansal<strong>di</strong> – Moncalvo (AT)<br />
Giovanni Ar<strong>di</strong>zzone – Moncalvo (AT)<br />
Associazione culturale “Aquesana” – Acqui Terme<br />
(AL)<br />
Archivio storico <strong>di</strong>ocesano – Casale Monf. (AL)<br />
Giuseppe Arrobbio - Grana (AT)<br />
Associazione Casalese Arte e Storia – Casale Monf.<br />
(AL)<br />
Associazione nazionale Combattenti e Reduci – Moncalvo<br />
(AT)<br />
Cristina Bacco - Moncalvo (AT)<br />
Stefano Bal<strong>di</strong> - Torino<br />
Enrica Baralis Coppa - Moncalvo (AT)<br />
Roberto Barberis – San Salvatore Monf. (AL)<br />
Amilcare Barbero – Ponzano (AL)<br />
Simona Bargero – Moncalvo (AT)<br />
Clelia Beccaris – Moncalvo (AT)<br />
Stefano Beccaris – Moncalvo (AT)<br />
Adriana Bechis Piacenza – Torino<br />
Ezio Belforte – Torino<br />
Cinzia Bendanti – Imola (BO)<br />
Clara Bergamin - Montechiaro (AT)<br />
Alberto Berliat - Penango (AT)<br />
Cesare Berruti – Calliano (AT)<br />
Gianni Berta – Alessandria<br />
Mario Bertana – Moncalvo (AT)<br />
Ugo Bertana – Castelletto Merli (AL)<br />
Clara Besso – Moncalvo (AT)<br />
Clau<strong>di</strong>o Bestente - Moncalvo (AT)<br />
Daria Bianco - Moncalvo (AT)<br />
Paola Bianco - Moncalvo (AT)<br />
Biblioteca civica “G. Canna” – Casale Monf. (AL)<br />
Biblioteca civica – Moncucco Torinese (AT)<br />
Biblioteca comunale – Calamandrana (AT)<br />
Biblioteca comunale – Calliano (AT)<br />
Biblioteca comunale – Castelletto Merli (AL)<br />
Biblioteca comunale – Grazzano Badoglio (AT)<br />
Biblioteca del Seminario vescovile – <strong>Asti</strong><br />
Biblioteca del Seminario vescovile – Casale Monf.<br />
(AL)<br />
Biblioteca nazionale centrale – Firenze<br />
Biblioteca storica della <strong>Provincia</strong> <strong>di</strong> Torino – Torino<br />
Biblioteche civiche e Raccolte storiche – Torino<br />
Angela Biedermann – Andora (SV)<br />
Anna Maria Biginelli - Moncalvo (AT)<br />
Raimondo Biglione <strong>di</strong> Viarigi – Brescia<br />
Alessandro Biletta - Moncalvo (AT)<br />
Fernando Biletta - Milano<br />
Guido Boano – Moncalvo (AT)<br />
Ida Boggio - Moncalvo (AT)<br />
Alfio Bonelli – Calliano (AT)<br />
Maria Bonzano Strona – <strong>Asti</strong><br />
4<br />
Alberto Borghini – Massa<br />
Fernanda Borio - Milano<br />
Elio Botto - Casale Monf. (AL)<br />
Mauro Bosco – Casale Monf. (AL)<br />
Pier Giuseppe Bosco - Montalero (AL)<br />
Enrichetta Bosia – Torino<br />
Vittorio Bran<strong>di</strong> - <strong>Asti</strong><br />
Francesco Brignoglio - Moncalvo (AT)<br />
Armando Brignolo – <strong>Asti</strong><br />
Ermanno Briola - <strong>Asti</strong><br />
Francesco Broda - Moncalvo<br />
Luigi Broda – <strong>Asti</strong><br />
Luisa Brovero – Casale Monf. (AL)<br />
Franco Buano – Moncalvo (AT)<br />
Maria Pia Buronzo - Torino<br />
Domenico Bussi – <strong>Asti</strong><br />
Luigi Caligaris – Roma<br />
Corrado Camandone – Andora (SV)<br />
Marcello Cambiaso – Moncalvo (AT)<br />
Felice Camerano – Moncalvo (AT)<br />
Marco Canepa – Alessandria<br />
Maria Capra - Moncalvo (AT)<br />
Pierina Capra - Moncalvo (AT)<br />
Gaia Caramellino – Torino<br />
Giancarlo Caramellino - Odalengo Piccolo (AL)<br />
Massimo Carcione – <strong>Asti</strong><br />
Vittorio Giovanni Car<strong>di</strong>nali – Torino<br />
Dina Cariola – Moncalvo (AT)<br />
Mario Casalone - Torino<br />
don Gian Paolo Cassano – Occimiano (AL)<br />
Ugo Cassina - Moncalvo (AT)<br />
Luigi Castagnone - Moncalvo (AT)<br />
Maria Castellano – Torino<br />
Alba Cattaneo – Casale Monf. (AL)<br />
Carlo Cavalla - Villafranca d’<strong>Asti</strong> (AT)<br />
Giuseppe Cavalli - Beinasco (TO)<br />
Angela Cavallito – Moncalvo (AT)<br />
Paolo Cavallo – Pinerolo (TO)<br />
Luigi Cavallotto – Moncalvo (AT)<br />
Carla Cavanna Broda – Moncalvo (AT)<br />
Luciano Cecca - Moncalvo (AT)<br />
Centro Stu<strong>di</strong> Piemontesi – Torino<br />
Centro UNESCO <strong>di</strong> Firenze – Firenze<br />
Centro UNESCO <strong>di</strong> Torino – Torino<br />
Mario Cerrano - Moncalvo (AT)<br />
Annalisa Cerruti – Moncalvo (AT)<br />
don Clau<strong>di</strong>o Cipriani – Casale Monf. (AL)<br />
Clara Cisi - Alfiano Natta (AL)<br />
Maria Clerici – Pino Torinese (TO)<br />
Comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri – <strong>Asti</strong><br />
Comando Stazione Carabinieri – Moncalvo (AT)<br />
Commissione nazionale della CRI per la Diffusione<br />
del Diritto Internazionale Umanitario – Roma<br />
Consorzio per la gestione della Biblioteca Astense –<br />
<strong>Asti</strong><br />
Carla Coppo Sorba - Moncalvo (AT)<br />
Giuseppe Coppo - Casorzo (AT)<br />
Giuseppe Coppo – Moncalvo (AT)<br />
Enrico Corzino – Moncalvo (AT)
Giuseppe Cova – Alessandria<br />
Luigi Cravino - Frassinello Monf. (AL)<br />
Maria Eleonora Cravino – Torino<br />
Mario Cravino – Casale Monf. (AL)<br />
Graziella Crosetto - Arese (MI)<br />
Elisabetta Cuniberti - Torino<br />
Piergiuseppe Cuniberti – Calliano (AT)<br />
suor Elsa Cuppini – Torino<br />
Franca Dagnino - Genova Sestri Ponente<br />
Santina Dattrino - Sanremo (IM)<br />
Carlo Debernar<strong>di</strong> - Moncalvo (AT)<br />
Patrizia Debernar<strong>di</strong> - Moncalvo (AT)<br />
Armando De Coppi – Milano<br />
Carlotta Della Sala Spada Lombar<strong>di</strong> – Quattor<strong>di</strong>o<br />
(AL)<br />
Maria Cristina Della Sala Spada - <strong>Asti</strong><br />
Aldo Demaria - <strong>Asti</strong><br />
Direzione <strong>di</strong>dattica – Moncalvo (AT)<br />
Antonio Dogliani – Bra (CN)<br />
Marco Dolermo – Acqui Terme (AL)<br />
Elèna Dolino – Torino<br />
Diana Donna - Moncalvo (AT)<br />
Na<strong>di</strong>a Durante - Ponzano (AL)<br />
Gigi Efisio - Casale Monf. (AL)<br />
Emeroteca Storica Italiana – Verona<br />
Tino Evaso – Casale Monf. (AL)<br />
don Cesare Falaguerra - Calliano (AT)<br />
Aldo Fara - Moncalvo (AT)<br />
Cesare Fara – Sanremo (IM)<br />
Giovanni Fara – Torino<br />
Luca Farotto - Moncalvo (AT)<br />
Gianpaolo Fassino - Moncucco Torinese (AT)<br />
Franco Fassio – Moncalvo (AT)<br />
Romano Fea - Torino<br />
don Vincenzo Ferraris - Grazzano Badoglio (AT)<br />
Giovanna Ferraro - Moncalvo (AT)<br />
Marco Ferrero – Vicenza<br />
Ornella Fino – <strong>Asti</strong><br />
Gennaro Fiscariello - Napoli<br />
Alessandro Fisso - Torino<br />
Fondazione San Vincenzo - Mirabello Monf. (AL)<br />
Lorenzo Fornaca – <strong>Asti</strong><br />
Renzo Fracchia – Casale Monf. (AL)<br />
Giuseppe Franco - Penango (AT)<br />
Marta Franzoso – <strong>Asti</strong><br />
Iraide Gabiano - Moncalvo (AT)<br />
Carla Galetto Broglia - S. Marcherita Ligure (GE)<br />
Bruna Gallone Cavanna - Pontestura (AL)<br />
Bruno Gallo – Buenos Ayres (Argentina)<br />
Ugo Gallo – Casale Monf. (AL)<br />
Francesca Gamba – Moncalvo (AT)<br />
Fiorenzo Gambino – Monale (AT)<br />
Marisa Garino Perissinotto - Moncalvo (AT)<br />
Maria Teresa Gavazza - Quargnento (AL)<br />
Renato Gendre – Villafranca (AT)<br />
Carlo Francesco Genta – <strong>Asti</strong><br />
Cleto Girino – Torino<br />
Mario Andrea Gerbi – Roma<br />
Fiorenza Gherlone – Revigliasco (AT)<br />
Rosanna Gherlone – Moncalvo (AT)<br />
Luigi Ghezzi - Vercelli<br />
Bruno Giordano - Moncalvo (AT)<br />
Giorgio Gonella - Moncalvo (AT)<br />
Teresio Gonella - Moncalvo (AT)<br />
5<br />
Vittorio Graziano – Ponzano (AL)<br />
Stefano Grillo – Casale Monf. (AL)<br />
Walter Haberstumpf – Torino<br />
Josette Hallet – Limal (Belgio)<br />
Marco Illengo – Serralunga <strong>di</strong> Crea (AL)<br />
Michele Isacco – Trino (VC)<br />
Istituto Internazionale <strong>di</strong> Diritto Umanitario – Sanremo<br />
(IM)<br />
Pietro La Barbiera “Labar” - Villadeati (AL)<br />
Maria Rita Laio Cerruti - Moncalvo (AT)<br />
Clau<strong>di</strong>o Lamberti Corbella - Moncalvo (AT)<br />
Angela Laurella - Torino<br />
Roberto Laurella - Moncalvo (AT)<br />
Silvio Lavagnino – <strong>Asti</strong><br />
Emma Lazzarini Delponte - Alessandria<br />
Carlo Leoncini – Casale Monf. (AL)<br />
Giancarlo Libert – Torino<br />
Liceo Ginnasio “V. Alfieri” – <strong>Asti</strong><br />
Elisa Ludergnani Magnani - Moncalvo (AT)<br />
Alberto Lupano - Torino<br />
Americo Luparia – Moncalvo (AT)<br />
Giovanni Macagno – <strong>Asti</strong><br />
Lorenzo Magrassi – Mombello (AL)<br />
Giampiero Maio – Moncalvo (AT)<br />
Teresio Malpassuto – Casale Monf. (AL)<br />
Giuseppe Mantelli – Casale Monf. (AL)<br />
Arturo Marcheggiano – Pitigliano (GR)<br />
Carlo Antonio Marchesi - Milano<br />
Giuseppandrea Martinetti – Moncalvo (AT)<br />
Aldo Marzano – Moncalvo (AT)<br />
Rita Marzano – Moncalvo (AT)<br />
Rita Marzola - Moncalvo (AT)<br />
Marco Massaglia – Moncalvo (AT)<br />
Giorgio Massola – Casale Monf. (AL)<br />
Alfredo Matuonto – Milano<br />
Ferruccio Mazzariol – Treviso<br />
Oreste Mazzucco – Torino<br />
Roberto Mercuri – Viterbo<br />
Rinaldo Merlone – Piobesi (TO)<br />
Giovanni Minoglio Chionio – Torino<br />
Olga Miravalle - Moncalvo (AT)<br />
Aldo Alessandro Mola – Torre San Giorgio (CN)<br />
Renzo Mombellardo - Moncalvo (AT)<br />
Roberto Mombellardo – Moncalvo (AT)<br />
Elda Mongar<strong>di</strong> – Imola (BO)<br />
Nancy Montanari - Palermo<br />
Wendy Montanari - Alexandria, Va. - U.S.A.<br />
Orazia Montiglio – Moncalvo (AT)<br />
Paola Monzeglio - Grazzano Badoglio (AT)<br />
Luigina Morando Cavallo - Grana (AT)<br />
Marco Morra – <strong>Asti</strong><br />
Mirella Mortarotti - Moncalvo (AT)<br />
Lyda Mosca – <strong>Asti</strong><br />
Pier Luigi Muggiati – Casale Monf. (AL)<br />
Olimpio Musso - Colle Val d’Elsa (SI)<br />
Angelo Muzio – Casale Monf. (AL)<br />
Giovanni Navazzotti – Villanova Monf. (AL)<br />
Gino Nebiolo – Roma<br />
Ignazio Nebiolo - <strong>Asti</strong><br />
Vincenzo Nebiolo – <strong>Asti</strong><br />
Donatella Nebiolo Sacco – <strong>Asti</strong><br />
Pierina Nicolini - Mombello Monf. (AL)<br />
Livia Novelli – Borgo San Martino (AL)<br />
Nevilda Oddone - Grana (AT)
Giuseppe Opezzo – Omegna (VB)<br />
Oscar Ottone – Moncalvo<br />
Monica Parola – Portacomaro (AT)<br />
Parrocchia <strong>di</strong> S. Antonio <strong>di</strong> Padova – Moncalvo (AT)<br />
Parrocchia del S. Nome <strong>di</strong> Maria – Calliano (AT)<br />
Vittorio Pasteris - Moncalvo (AT)<br />
Mario Pavese – Torino<br />
Renato Peirone – Penango (AT)<br />
Fratelli Pelazza – Milano<br />
Romolo Penacca – Casale Monf. (AL)<br />
Marcello Peola - Castellero (AT)<br />
Marcella Perotti - Quattor<strong>di</strong>o (AL)<br />
Franco Piacenza – Torino<br />
Gino Piacenza – Torino<br />
Giulia Piacenza Amerio – Torino<br />
Alfredo Poli – Calliano (AT)<br />
Stu<strong>di</strong>o Poli - Sanremo (IM)<br />
Francesco Porcellana – <strong>Asti</strong><br />
Pontificio Consiglio per la Cultura – Città del Vaticano<br />
Anna Prato Sarzano - Torino<br />
Rodolfo Prosio – <strong>Asti</strong><br />
Carlo Prosperi – Acqui Terme (AL)<br />
Luciana Rabbezzana - Torino<br />
Achille Raimondo – Moncalvo (AT)<br />
don Severino Ramello – Agliano Terme (AT)<br />
Gian Luigi Rapetti Bovio Della Torre – Strevi (AL)<br />
Alice Raviola – <strong>Asti</strong><br />
Carlo Raviola – <strong>Asti</strong><br />
Pierantonia Raviola - Moncalvo (AT)<br />
Giovanni Rebora – Acqui Terme (AL)<br />
Giuseppina Redoglia Sarzano - Moncalvo (AT)<br />
Piera Redoglia – Grazzano Badoglio (AT)<br />
Pia Re Ombra – Casale Monf. (AL)<br />
don Francesco Ricossa – Verrua Savoia (TO)<br />
Alberto Rissone – <strong>Asti</strong><br />
Graziella Riviera - Torino<br />
Luigi Rizzo – Lecce<br />
Mario Andrea Rocco – Castell’Alfero (AT)<br />
Dionigi Roggero – Casale Monf. (AL)<br />
Giovanni Roggero – <strong>Asti</strong><br />
Rubèn Darío Romani Ferreira – Mendoza (Argentina)<br />
Riccardo Romano – Venezia Lido<br />
Giuseppe Rosina – Moncalvo (AT)<br />
Enrica Rossetti Rampi - Alessandria<br />
Antonio Rossi - Torino<br />
Renato Rossi – Moncalvo (AT)<br />
Giuliana Rota - Grana (AT)<br />
Learco San<strong>di</strong> – Milano<br />
Paolo Santoro – Firenze<br />
Raffaele Santoro – Roma<br />
Laura Santoro Ragaini – Milano<br />
Clau<strong>di</strong>o Saporetti – Roma<br />
Mariella Sarzano – Vinchio (AT)<br />
6<br />
Simonetta Satragni Petruzzi - Torino<br />
Silvia Save Ferrari – Fubine (AL)<br />
Romano Scagliola - Neive (CN)<br />
Giovanni Scaiola – Moncalvo (AT)<br />
Massimo Scaglione – Torino<br />
Mariangela Scarsi Barberis – Moncalvo (AT)<br />
Scuola elementare “Ten. Riva” – Montemagno (AT)<br />
Scuola me<strong>di</strong>a statale “G. Capello” – Moncalvo (AT)<br />
“Segusium” - Società <strong>di</strong> ricerche e stu<strong>di</strong> valsusini -<br />
Susa (TO)<br />
Carlo Serra – Moncalvo (AT)<br />
Elisabetta Serra – Torino<br />
Mirella Simoni Locatelli - Piacenza<br />
Società Piemontese <strong>di</strong> Archeologia e Belle Arti – Torino<br />
Fernando Sorisio – <strong>Asti</strong><br />
Roberto Sorisio - <strong>Asti</strong><br />
Sovrintendenza archivistica – Torino<br />
Sovrintendenza ai beni artistici e storici - Torino<br />
Emilio Spallicci – Alessandria<br />
Giuseppe Spina – Treville (AL)<br />
Maria Spinoglio – Moncalvo (AT)<br />
Angela Strona – Moncalvo (AT)<br />
Vincenzo Strona – Moncalvo (AT)<br />
Stu<strong>di</strong>o Poli - Sanremo (IM)<br />
Giorgio Tacchini - Vercelli<br />
Marco Tappa - Moncalvo (AT)<br />
Giuseppe Tar<strong>di</strong>to – Moncalvo (AT)<br />
Mario Testa – Torino<br />
“Tri<strong>di</strong>num” – Società per l’Archeologia, la Storia e le<br />
Belle Arti – Trino (VC)<br />
Pierluigi Truffa – Gabiano (AL)<br />
Ufficio Storico Stato Maggiore Esercito – Roma<br />
UTEA (Università Terza Età) – <strong>Asti</strong><br />
Francesco Vaglio- Givoletto (TO)<br />
Giuseppe Vaglio – Torino<br />
Anna Varvelli – Castelletto Merli (AL)<br />
Laura Venesio – Moncalvo (AT)<br />
Elena Verrua – Moncalvo (AT)<br />
Alberto Verdelli – Moncalvo (AT)<br />
Sergio Vi<strong>di</strong>nich – Genova<br />
Aldo Vigna - <strong>Asti</strong><br />
Mario Villata - Torino<br />
“Villaviva” – Società culturale – Villanova Monf.<br />
(AL)<br />
Anna Visca Martinotti – Moncalvo (AT)<br />
Luisa Volta – Moncalvo (AT)<br />
Franco Zampicinini – Cocconato (AT)<br />
Giuseppe Zanello – Penango (AT)<br />
Igor Zanzottera – Alessandria<br />
Domenico Zoccola – Lecco<br />
Mario Zonca – Moncalvo (AT)<br />
Carlo Zucchelli - Milano
Arturo Marcheggiano<br />
LA PROTEZIONE DELLE DIMORE STORICHE IN TEMPO DI GUERRA<br />
(seconda parte)<br />
(La prima parte dell’intervento è stata pubblicata<br />
sul n. 11 - luglio 2001)<br />
5. LA SOCIETÀ ITALIANA PER<br />
LA PROTEZIONE DEI BENI<br />
CULTURALI E LA “LEGA”<br />
INTERNAZIONALE DELLE SOCIETA’<br />
NAZIONALI<br />
La Società Italiana per la Protezione dei Beni<br />
Culturali in tempo <strong>di</strong> guerra (SIFPBC) è nata<br />
nel 1996 e, in un certo senso, ha raccolto<br />
l’ere<strong>di</strong>tà in fatto <strong>di</strong> beni culturali dell’Istituto<br />
Internazionale <strong>di</strong> Diritto Umanitario <strong>di</strong> Sanremo<br />
(Commissione beni Culturali retta dal<br />
Prof. Giuseppe Costantino Dragan), che della<br />
SIPBC è socio e mecenate. La Società italiana<br />
ha sede presso l’Istituto e come tutte le altre<br />
Società nazionali ha lo scopo <strong>di</strong> concorrere<br />
alla <strong>di</strong>ffusione della Convenzione del 1954<br />
(e sue successive mo<strong>di</strong>ficazioni, compreso il<br />
Protocollo del 1999) tra gli attori della Convenzione<br />
stessa, cioè le autorità militari e civili<br />
che operino in territorio occupato dalle<br />
Forze Armate italiane, anche se l’Italia spera<br />
<strong>di</strong> non dover mai più gestire un “territorio<br />
occupato”. Il Protocollo del 1999, tra l’altro<br />
non ancora ratificato dall’Italia, ma già applicato<br />
dalle sue Forze Armate in missione <strong>di</strong><br />
pace all’estero, per <strong>di</strong>sposizione del Capo <strong>di</strong><br />
Stato Maggiore della Difesa, consentirebbe<br />
<strong>di</strong> estendere la vali<strong>di</strong>tà della Convenzione<br />
dell’Aja anche ai gran<strong>di</strong> <strong>di</strong>sastri naturali, che<br />
si presentassero in ogni tempo, dettando le<br />
norme (segnatamente variato l’elenco) dei<br />
beni culturali sotto protezione speciale, i cui<br />
dettati erano farraginosi e <strong>di</strong> <strong>di</strong>fficile applicazione<br />
nella precedente stesura della Convenzione.<br />
Vi sono anche altri scopi non esplicitati,<br />
quale quello <strong>di</strong> costituire elemento <strong>di</strong> pressione,<br />
nel caso che l’Italia fosse non completamente<br />
adempiente agli impegni liberamente<br />
assunti in ambito internazionale con la preparazione<br />
delle Forze Armate o nel campo<br />
7<br />
delle pre<strong>di</strong>sposizioni tipiche del tempo <strong>di</strong> pace.<br />
La SIBPC non è una società qualunque, anche<br />
in campo europeo è una società altamente<br />
selezionata, composta <strong>di</strong> or<strong>di</strong>nari universitari<br />
<strong>di</strong> Diritto Internazionale e <strong>di</strong> materie <strong>di</strong>verse,<br />
da tecnici militari <strong>di</strong> Diritto Umanitario,<br />
da Comandanti o membri <strong>di</strong> contingenti<br />
<strong>di</strong> pace che hanno operato all’estero, da <strong>di</strong>ffusori<br />
<strong>di</strong> Diritto Umanitario delle Forze Armate,<br />
della Croce Rossa Italiana e del Sovrano<br />
Militare Or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> Malta e da consiglieri<br />
giuri<strong>di</strong>ci in materia <strong>di</strong> Diritto Umanitario,<br />
formati secondo i dettati dell’art. 82 del Primo<br />
Protocollo Aggiuntivo <strong>di</strong> Ginevra. È intenzione<br />
della SIPBC <strong>di</strong> dare vita ed impulso<br />
ad una organizzazione che deve nascere <strong>di</strong><br />
“scudo blu” italiano e a questo titolo saranno<br />
presi dei contatti con la Croce Rossa italiana,<br />
<strong>di</strong> cui l’organizzazione relativa alla <strong>di</strong>ffusione<br />
del <strong>di</strong>ritto umanitario, oltre naturalmente a<br />
noi e nell’ignavia delle autorità competenti,<br />
assicura la <strong>di</strong>ffusione della Convenzione del<br />
1954 tra la popolazione civile, e l’ICOM italiana<br />
(il Concilio internazionale dei Musei).<br />
Le altre società mon<strong>di</strong>ali sono tutte europee:<br />
quella svizzera (Società Svizzera per la Protezioni<br />
del Beni Culturali — SSPBC) ha più<br />
<strong>di</strong> trent’anni; quella austriaca (Österreichische<br />
Gesellschaft für Kulturgüterschutz) ha<br />
compiuto recentemente vent’anni; le società<br />
tedesche (due: Germania dell’Ovest, subito<br />
copiata dalla Germania dell’Est, l’una ad impostazione<br />
prevalentemente militare, l’altra<br />
prevalentemente accademica) hanno già più<br />
<strong>di</strong> <strong>di</strong>eci anni (e quasi un decennio ci è voluto<br />
per la riunificazione: le due società sono oggi<br />
riunite nella Deutsche Gesellschaft für Kulturgutschutz<br />
e. V.). Sono più recenti la società<br />
rumena e la società spagnola e stanno per<br />
nascere una società francese, una greca ed<br />
una portoghese, mentre sembrano interessati<br />
al lavoro comune gli osservatori olandesi,<br />
sloveni e, in genere, dei paesi della<br />
NATO.
Le società nazionali sorelle (hanno anche uno<br />
statuto analogo, mutuato, con le particolarità<br />
nazionali, dalla società svizzera), su iniziativa<br />
comune, a Friburgo nel 1996, hanno dato<br />
vita ad una “Lega Internazionale”, che è ancora<br />
molto giovane per dare dei frutti e che,<br />
risentendo delle <strong>di</strong>verse filosofie e delle <strong>di</strong>verse<br />
delle società nazionali, sta cercando da<br />
una parte <strong>di</strong> dare vita ad un progetto comune<br />
e, dall’altra, <strong>di</strong> <strong>di</strong>ventare “consulente”<br />
dell’UNESCO sulla fattibilità delle regole<br />
della guerra come lo era la Commissione Beni<br />
Culturali dell’istituto Internazionale <strong>di</strong> Diritto<br />
Umanitario <strong>di</strong> Sanremo.<br />
6. GLI OBIETTIVI DELLA “LEGA”<br />
Gli obiettivi prioritari della “Lega” sono<br />
quelli <strong>di</strong> <strong>di</strong>ffondere i tutti gli Stati i dettati,<br />
cioè le “regole” della guerra nei conflitti armati<br />
internazionali, <strong>di</strong> applicare possibilmente<br />
tali “regole” nei conflitti interni (conflitti<br />
non internazionali), <strong>di</strong> armonizzare, se possibile,<br />
le politiche nazionali nei confronti della<br />
Convenzione dell’Aja e <strong>di</strong> attuare possibilmente<br />
degli obiettivi comuni e dei progetti<br />
comuni, che siano finanziati se possibile dalla<br />
Comunità Europea, almeno per quei paesi<br />
che ne fanno parte.<br />
Allo stato attuale c’è da notare che la “Lega”<br />
è ancora troppo giovane e che è poco incisiva<br />
anche sul piano internazionale, perché le varie<br />
società nazionali sono <strong>di</strong>versamente sostenute<br />
ed aiutate dagli organi istituzionali <strong>di</strong><br />
ciascuno Stato (Presidenza del Consiglio dei<br />
Ministri, Ministero della Difesa, Ministero<br />
dei Beni Culturali, Ministero della Pubblica<br />
istruzione e dell’Università, Ministero<br />
dell’Interno, organizzazioni <strong>di</strong> protezione civile,<br />
organizzazioni <strong>di</strong> Croce Rossa, ecc.). I<br />
conseguenti progetti comuni presentati risentono<br />
troppo delle <strong>di</strong>verse filosofie delle società<br />
nazionali (prevalentemente civile, accademica<br />
e pacifista quella tedesca; civile e militare<br />
quella austriaca, con una Costituzione<br />
<strong>di</strong> neutralità; prevalentemente militare quelle<br />
italiana e svizzera, pur non essendovi possibilità<br />
<strong>di</strong> un comune finanziamento) anche se<br />
non escludono che si possa arrivare a progetti<br />
8<br />
sostanzialmente identici, presentati da almeno<br />
cinque Nazioni.<br />
In ogni caso sembra che un finanziamento<br />
comunitario debba essere appoggiato ad un<br />
ente della Difesa o a una facoltà universitaria<br />
piuttosto che non ad una società nazionale<br />
per le ovvie <strong>di</strong>verse capacità amministrative<br />
istituzionali.<br />
7. LA POSIZIONE DELLA SOCIETÀ<br />
ITALIANA ED IL PROGETTO<br />
NAZIONALE<br />
La Società italiana intanto constata che la<br />
Convenzione internazionale del 1954 riguarda<br />
essenzialmente la guerra, ed i conflitti internazionali,<br />
che erano il preve<strong>di</strong>bile sviluppo<br />
strategico (quando la strategia riguardava<br />
un mondo essenzialmente bipolare, con i due<br />
blocchi contrapposti, e la grande probabilità<br />
dei conflitti era solo quella dei “conflitti internazionali”).<br />
Il Protocollo 2 dell’Aja del 1999 consentirebbe<br />
<strong>di</strong> allargare ai gran<strong>di</strong> <strong>di</strong>sastri naturali<br />
l’impiego della Convenzione, ma non è ancora<br />
stato ratificato dai vari paesi, e poi a noi<br />
sembra che sia maggiormente riferibile alle<br />
Forze Armate, che operino in un paese straniero<br />
e amico, o come aliquota <strong>di</strong> un contingente<br />
multinazionale <strong>di</strong> pace, o per concorrere<br />
a dare un aiuto in caso <strong>di</strong> grande catastrofe<br />
naturale, in cui sia chiaro che gli uomini ed i<br />
mezzi del Ministero dell’Interno o della Protezione<br />
Civile o dei bene culturali non abbiano<br />
possibilità <strong>di</strong> farcela da soli.<br />
In pratica si tratta <strong>di</strong> interventi fuori area delle<br />
Forze Armate, o <strong>di</strong> interventi interni, in caso<br />
<strong>di</strong> gravi calamità naturali. In sostanza, si<br />
tratta <strong>di</strong> imballare e trasportare sugli autocarri<br />
militari, da parte <strong>di</strong> una minima aliquota<br />
del contingente o del reparto, specializzata, i<br />
beni culturali lesionati o in parte <strong>di</strong>strutti,<br />
dove i tecnici civili della Soprintendenza li<br />
restaureranno e li sistemeranno definitivamente<br />
dove vorranno, o dove erano o in un<br />
museo.<br />
Si tratta quin<strong>di</strong> <strong>di</strong> formare dei tecnici militari<br />
sia per la salvaguar<strong>di</strong>a sul posto (guar<strong>di</strong>a armata),<br />
sia per l’imballaggio ed il trasporto<br />
dei beni culturali là dove <strong>di</strong>ce il comando del
contingente, se si opera all’estero, o dove <strong>di</strong>cono<br />
i tecnici civili del restauro, se si opera<br />
in patria.<br />
Il progetto italiano (in bozza), da eventualmente<br />
stu<strong>di</strong>are in comune con le altre società<br />
analoghe, è stato consegnato al Comandante<br />
della Scuola Sottufficiali <strong>di</strong> Viterbo, e sarebbe<br />
il seguente:<br />
CARATTERISTICHE DEL<br />
PROGETTO: misto (un Ente della Difesa<br />
ed una Università. L’Ente della Difesa darebbe<br />
solo gli input, come nel caso degli armamenti<br />
— caratteristiche tecniche). La<br />
SIPBC sarebbe <strong>di</strong>sposta a collaborare gratuitamente<br />
con la Facoltà universitaria, qualora<br />
non fosse <strong>di</strong>sponibile il docente <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto internazionale.<br />
SCOPO: formare gli specialisti militari<br />
ai più bassi livelli (Comandanti <strong>di</strong> squadra e<br />
<strong>di</strong> plotone PBC — a livello Brigata, da impiegare<br />
sempre nelle missioni <strong>di</strong> pace — sarebbe<br />
dato in rinforzo al reggimento o battaglione.<br />
Qualora il contingente nazionale fosse<br />
<strong>di</strong> livello inferiore alla Brigata - e nei <strong>di</strong>sastri<br />
o pubbliche gran<strong>di</strong> calamità) per la movimentazione<br />
eventuale — recupero, imballaggio,<br />
carico e scarico, trasporto normale o<br />
sotto protezione - dei Beni Culturali lesionati<br />
dalla guerra o dalle pubbliche gran<strong>di</strong> calamità,<br />
dove sarà in<strong>di</strong>cato dal Comando del contingente<br />
all’estero o dal Ministero dei Beni<br />
Culturali in Italia, per la concentrazione o il<br />
restauro<br />
INTERESSE: interministeriale<br />
PARTECIPANTI: Ufficiali subalterni e<br />
Sottufficiali (destinati a comandare il plotone<br />
e ad assicurare una lunga permanenza nel<br />
grado e nell‘incarico) delle Forze Armate<br />
(Carabinieri, Esercito, Marina, Aeronautica,<br />
Guar<strong>di</strong>a <strong>di</strong> Finanza).<br />
ENTE PILOTA: Scuola Sottufficiali<br />
dell’Esercito <strong>di</strong> Viterbo (potrebbe tra l’altro<br />
appoggiare e seguire i pochi frequentatori),<br />
che piloterebbe la Facoltà <strong>di</strong> Beni Culturali a<br />
cui darebbe gli input relativi al prodotto finito<br />
che si vuole (Università della Tuscia —<br />
Facoltà <strong>di</strong> Beni Culturali: sarebbe una Facol-<br />
9<br />
tà non sovraffollata, la più antica d’Italia e<br />
sarebbe anche vicina al Centro per i relativi<br />
controlli)<br />
PROGRAMMA: concordato, della durata<br />
sperimentale <strong>di</strong> 1-2 settimane (pari a quella<br />
dei Consiglieri Giuri<strong>di</strong>ci in materia <strong>di</strong> Diritto<br />
Umanitario)<br />
FINANZIAMENTO: nazionale: costerebbe<br />
poco! Dovrebbe essere finanziato in<br />
parte dal Ministero della Difesa in accordo<br />
con il Ministero dei Beni Culturali,<br />
dell’Interno, degli Esteri e della Protezione<br />
Civile.<br />
Rimane da esplorare la possibilità <strong>di</strong> un finanziamento<br />
fisso comunitario (Comunità<br />
Europea).<br />
DURATA: 1-2 settimane. Trattasi <strong>di</strong> un<br />
corso <strong>di</strong> tipo “master” a livello postuniversitario<br />
(frequenza: una volta all’anno<br />
oppure ogni due anni).<br />
NOTE (Per notizia: obiettivi nel campo professionale<br />
del Diritto Umanitario cui tende la<br />
SIPBC:<br />
- avere un solo tipo <strong>di</strong> conflitti (internazionali)<br />
allo scopo <strong>di</strong> avere sempre regole<br />
uguali e sicure da applicare, internazionalizzando<br />
tutti i conflitti intervenendo subito da<br />
parte della Comunità Internazionale, con aliquota<br />
<strong>di</strong> forze minima ed internazionale, secondo<br />
il concetto dell’equa rappresentanza<br />
geografica;<br />
- il soldato non è un leguleio e<br />
l’addestramento deve essere sempre uguale,<br />
senza casi e sottocasi da dover applicare nelle<br />
missioni <strong>di</strong> pace e/o nelle pubbliche calamità,<br />
in Italia ed all’estero;<br />
- avere tribunali internazionali permanenti<br />
e non “ad hoc”, che giu<strong>di</strong>chino tutti i<br />
crimini <strong>di</strong> guerra comunque commessi, compresi<br />
i crimini riguardanti i Beni Culturali.<br />
Il progetto è stato illustrato al Comandante<br />
della Scuola Sottufficiali dell’Esercito, che<br />
ne avvierà la fase <strong>di</strong> “fattibilità” con la facoltà<br />
<strong>di</strong> beni culturali dell’Università <strong>di</strong> Viterbo.
8. CONCLUSIONI<br />
Serve in guerra, in tutti i tipi <strong>di</strong> conflitto, che<br />
i combattenti contrapposti Siano uomini leali,<br />
colti e <strong>di</strong> buona volontà, come quelli che, durante<br />
la II Guerra Mon<strong>di</strong>ale, salvarono dalla<br />
<strong>di</strong>struzione Parigi o la biblioteca<br />
dell’Abbazia <strong>di</strong> Montecassino. D’altra parte<br />
le regole della guerra devono essere sempre<br />
le stesse, chiare, perché il soldato non è un<br />
leguleio, ma necessita <strong>di</strong> un addestramento il<br />
più possibile uniforme ed uguale a sé stesso,<br />
senza casi e sottocasi.<br />
Mentre per la protezione dei beni culturali<br />
nei conflitti armati internazionali ci sono<br />
chiare norme abbastanza precise (la Convenzione<br />
del 1954 e sue mo<strong>di</strong>fiche), le stesse<br />
mancano o sono vaghe nei conflitti armati<br />
non internazionali, soprattutto per la protezione<br />
speciale o rinforzata. Il guaio è che a<br />
maggior parte dei conflitti che avvengono<br />
oggigiorno sono conflitti armati non internazionali<br />
o interni, per i quali non esistono regole<br />
precise, semplici e fattibili, che possano<br />
essere applicabili da tutti. Per poter applicare<br />
regole uniche, è necessario “internazionalizzare”<br />
tutti i conflitti, non appena questi si<br />
manifestino.<br />
A mio avviso, una strada perché ciò accada,<br />
potrebbe essere quella dell’imme<strong>di</strong>ato intervento<br />
della comunità Internazionale in ogni<br />
tipo <strong>di</strong> conflitto, con forze anche esigue (a<br />
livello <strong>di</strong> plotone o <strong>di</strong> compagnia), purché<br />
multinazionali e rappresentative dei vari Stati.<br />
Se poi per salvaguardare la pace mon<strong>di</strong>ale<br />
interviene, come contingente multinazionale,<br />
un reparto <strong>di</strong> livello battaglione o reggimento<br />
per ciascuna nazione, il contingente stesso<br />
abbia i suoi specializzati per tutelare i beni<br />
culturali, che, come si è già detto, appartengono<br />
non agli Stati ed agli in<strong>di</strong>vidui, ma<br />
all’intera umanità nel suo complesso. Non è<br />
più tollerabile che avvengano le <strong>di</strong>struzioni e<br />
le per<strong>di</strong>te <strong>di</strong> beni culturali per l’umanità della<br />
II Guerra Mon<strong>di</strong>ale con i bombardamenti a<br />
tappeto o con lo sgancio <strong>di</strong> or<strong>di</strong>gni li <strong>di</strong>struzione<br />
<strong>di</strong> massa come Hiroshima e Nagasaki.<br />
Inoltre, devono sedere dei tribunali internazionali<br />
permanenti per giu<strong>di</strong>care tutti i crimini<br />
<strong>di</strong> guerra (anche quelli contro i beni culturali,<br />
guardati come “vittime <strong>di</strong> guerra”), co-<br />
10<br />
munque e dovunque commessi, con il giusto<br />
rigore, senza ricorrere alla pena <strong>di</strong> morte. Col<br />
terzo millennio sembrano essere finiti i tempi<br />
dei tribunali “ad hoc”, che si creano <strong>di</strong> volta<br />
in volta, a volte e a volte no, secondo i casi, e<br />
che hanno il sapore dell’ingiustizia o dei tribunali<br />
dei vincitori.<br />
Infine, la Comunità Internazionale deve intervenire<br />
sempre, il più presto possibile, e<br />
senza guardare in faccia nessuno, perché cominci<br />
una nuova era, sia per limitare i possibili<br />
danni della guerra, che hanno ripercussioni<br />
notevoli sui beni culturali, specie quando<br />
questi assurgono al valore d’immagine del<br />
nemico, sia per non lasciare incancrenire gli<br />
o<strong>di</strong> tra coloro che si combattono.<br />
Per quanto riguarda le “<strong>di</strong>more storiche”, che<br />
in Italia pullulano, come i resti dei forti <strong>di</strong><br />
Venezia (tutta la città è un insieme <strong>di</strong> “<strong>di</strong>more<br />
storiche” tanto da rendere unica la città al<br />
mondo e da giustificare l’esistenza <strong>di</strong> un comitato<br />
internazionale per la sopravvivenza <strong>di</strong><br />
Venezia) <strong>di</strong>rei che occorre che i proprietari<br />
espongano ben visibile il simbolo fin dal<br />
tempo <strong>di</strong> pace. Poi, per <strong>di</strong>struggere o bombardare<br />
la casa, ci vorrà quanto meno il consenso<br />
<strong>di</strong> un colonnello, cosa <strong>di</strong>fficile, dato<br />
l’elevato grado <strong>di</strong> professionalità o<strong>di</strong>erna,<br />
anche considerando il deterrente che semina<br />
il giu<strong>di</strong>cato <strong>di</strong> un tribunale internazionale del<br />
tipo <strong>di</strong> quello <strong>di</strong> Roma, che sta per entrare in<br />
vigore anche se l’Italia non lo ancora ratificato.<br />
Ma ognuno ha i governanti che si merita,<br />
dato che li eleggono la maggioranza dei popoli;<br />
ed i popoli o aliquota <strong>di</strong> essi sono sempre<br />
più avanti dei loro governanti!
Alessandro Allemano<br />
LA DISGRAZIA DI PERDERE UNA CHIAVE<br />
na delle attività più tipiche della vita<br />
<strong>di</strong> relazione è sempre stata la litigiosità.<br />
Lo testimoniano, a livelli<br />
estremi, i conflitti <strong>di</strong> cui è costellata la storia<br />
dell’umanità, fin dai tempi più remoti, sorti<br />
per cause svariatissime ma sempre caratterizzate<br />
dalla costante conflittualità tra due in<strong>di</strong>vidui,<br />
due gruppi <strong>di</strong> persone, due popoli.<br />
In forme meno eclatanti e tragiche, anche<br />
l’esistenza nei nostri piccoli paesi non è scevra<br />
da casi anche curiosi <strong>di</strong> ricorso all’umana<br />
giustizia in seguito a litigi - per fortuna solo<br />
<strong>di</strong> rado cruenti - sorti per cause che sovente si<br />
rivelano <strong>di</strong> una banalità <strong>di</strong>sarmante.<br />
Nell’archivio storico del Comune <strong>di</strong> Sala<br />
Monferrato, in corso <strong>di</strong> rior<strong>di</strong>no, sono conservati<br />
ad esempio gli atti <strong>di</strong> una causa intentata<br />
nel 1757 da un garzone contro il padrone,<br />
accusato <strong>di</strong> averlo ferito: la ragione scatenante<br />
della lite fu nientemeno che lo smarrimento<br />
<strong>di</strong> una … chiave. 1<br />
U<br />
Leggere le carte ed immaginarsi come si potrebbero<br />
essere svolti i fatti è oggi gradevole<br />
e stimolante, seppure con un pensiero <strong>di</strong> riguardo<br />
al povero Comolo, colpito al capo<br />
dall’irascibile padrone.<br />
Ecco i fatti.<br />
La notizia del reato<br />
Verso le otto <strong>di</strong> sera 2 <strong>di</strong> domenica 20 febbraio<br />
1757 Angelo Maria De Regibus,<br />
1 Il documento <strong>di</strong> cui si tratta è conservato tra gli atti<br />
- interessantissimi - dell’antica Giu<strong>di</strong>catura <strong>di</strong> Sala: è<br />
una filza, composta <strong>di</strong> 14 carte. Sulla prima, che fa da<br />
copertina, si legge: “N. undecimo del triennio. 1757<br />
Fisco della Sala in causa <strong>di</strong> mastro Francesco Comolo<br />
contro mastro Gioanni Mozzone”.<br />
2 Testualmente si afferma che la chiamata avvenne<br />
“circa le ore due della notte”, ma va considerato che<br />
prima della Rivoluzione Francese il tempo veniva misurato<br />
secondo il sistema italiano, secondo cui il giorno<br />
iniziava alle attuali sei <strong>di</strong> sera. Pertanto le due <strong>di</strong><br />
notte corrispondevano alle ore venti contate secondo il<br />
sistema francese poi universalmente adottato.<br />
11<br />
“chirurgo approvato” 3 del luogo <strong>di</strong> Sala, viene<br />
urgentemente chiamato da un tale Filippo<br />
Pastore a recarsi presso la casa <strong>di</strong> suo cugino<br />
Carlo Antonio. Qui, nella stalla, il sanitario<br />
trova un uomo “ferito a parte destra lateralmente,<br />
dalla qual ferita usciva gran quantità<br />
<strong>di</strong> sangue”. Innanzitutto si tenta <strong>di</strong> fermare<br />
l’emorragia, e quin<strong>di</strong> l’in<strong>di</strong>viduo, secondo la<br />
dottrina me<strong>di</strong>ca empirica allora in uso viene<br />
sottoposto ad una bella “cavata <strong>di</strong> sangue”<br />
dal braccio sinistro.<br />
Avendo capito che l’uomo è stato ferito dolosamente,<br />
il De Regibus si affretta a darne<br />
comunicazione all’autorità locale <strong>di</strong> pubblica<br />
sicurezza e <strong>di</strong> giustizia, in persona del vicepodestà<br />
<strong>di</strong> Sala, “nodaro piazzato” Giovanni<br />
Giacomo Raselli, che faceva le veci del podestà<br />
Carlo Corsi, egli pure notaio.<br />
Costui dunque il giorno successivo al fatto<br />
istruisce d’ufficio una causa penale, assistito<br />
dal vice procuratore fiscale Giovanni Battista<br />
Bonello, che rappresenta la pubblica accusa. 4<br />
3 La figura del chirurgo, o cerusico o flebotomo, era<br />
assai <strong>di</strong>ffusa nei paesi nelle epoche in cui la me<strong>di</strong>cina<br />
laureata non era che privilegio <strong>di</strong> pochi. A questo sanitario<br />
empirico, che spesso era il barbiere del luogo,<br />
toccava me<strong>di</strong>care le piccole ferite, eseguire i salassi e<br />
svolgere le pratiche chirurgiche, quando la chirurgia<br />
non era ancora assurta a specialità me<strong>di</strong>ca <strong>di</strong> alta professionalità.<br />
4 Nell’intestazione della causa si parla <strong>di</strong> “Fisco”: si<br />
intende con questo termine appunto l’ufficio che attualmente<br />
è ricoperto dal Pubblico ministero, il quale<br />
precisamente sostiene la pubblica accusa nelle cause<br />
penali. In maniera analoga va inteso il termine “vice<br />
procuratore fiscale”. Il Podestà era invece il rappresentante<br />
del feudatario locale: altrove poteva assumere<br />
altre denominazione, quali Gius<strong>di</strong>cente, Castellano,<br />
Luogotenente, ed era assistito sovente da un Vicepodestà.<br />
Il Consiglio comunale ogni tre anni proponeva<br />
al feudatario una rosa (detta “rotolo”) <strong>di</strong> tre personaggi<br />
scelti tra i notai e gli avvocati; a sua volta il signore<br />
locale nominava tra questi il proprio rappresentante,<br />
che aveva in particolare l'importante compito <strong>di</strong> amministrare<br />
la giustizia.
L’interrogatorio dell’offeso<br />
Il vicepodestà Raselli trasferisce il proprio<br />
ufficio nella stalla <strong>di</strong> Carlo Antonio Pastore,<br />
nella contrada <strong>di</strong> Borgoratto, dove su <strong>di</strong> un<br />
giaciglio “sopra poca paglia, coperto d’un<br />
lenzuolo” è ancora ricoverato il ferito: costui<br />
porta “un vestito <strong>di</strong> color rossetto sopra, e<br />
berettino in testa”. Preventivamente ammonito<br />
dell’importanza <strong>di</strong> una testimonianza<br />
giurata, l’uomo declina finalmente le proprie<br />
generalità.<br />
“Io mi chiamo per nome Francesco e per cognome<br />
Comolo, figlio <strong>di</strong> Mattheo, del luogo<br />
d’Arcisato 5 , mandamento <strong>di</strong> Milano”.<br />
Si tratta dunque <strong>di</strong> un brianzolo ventunenne,<br />
giunto in Monferrato da sei mesi per svolgere<br />
il mestiere <strong>di</strong> muratore come garzone <strong>di</strong> un<br />
capomastro salese, come si leggerà poco dopo.<br />
Intanto passa ad esporre i fatti accaduti la sera<br />
prima.<br />
Verso l’una <strong>di</strong> notte (le nostre sette pomeri<strong>di</strong>ane)<br />
il Comolo veniva avvertito <strong>di</strong> portarsi<br />
alla casa <strong>di</strong> Giovanni Mozzone, figlio del suo<br />
padrone, capomastro anch’egli <strong>di</strong> nome Giovanni,<br />
al quale avrebbe dovuto portare la<br />
chiave <strong>di</strong> casa. Senonchè sfortunatamente<br />
nel tragitto Francesco perdeva la chiave.<br />
Subito tornava in<strong>di</strong>etro e si procurava un lume<br />
“per poter meglio rinvenirla”, ma, colmo<br />
della malasorte, il lume si era spento e proprio<br />
in quel mentre il giovane veniva aggre<strong>di</strong>to<br />
da uno sconosciuto “nella parte destra<br />
nelle coste”.<br />
“A questo fatto mi posi a gridare aiutto, aiutto<br />
e confessione; a quali grida accorsero da<br />
lì a qualche pocho <strong>di</strong> tempo Filippo Pastore<br />
e Clara pure Pastore, figlia <strong>di</strong> Carl’Antonio<br />
<strong>di</strong> questo luogo, quali vedendomi cossì ferito<br />
e maltrattato, coll’aiuto anche <strong>di</strong> Antonio<br />
Francesco Pastore figlio del sudetto<br />
Carl’Antonio, e <strong>di</strong> Gioanni Massa servo del<br />
sudetto signor chirurgo De Regibus mi condussero<br />
per sua bontà ove <strong>di</strong> presente ancor<br />
mi ritrovo”.<br />
5 Leggasi, più correttamente, Arcisate, paese dell’alta<br />
Valle Ceresio in provincia <strong>di</strong> Varese, quasi ai confini<br />
con quella <strong>di</strong> Como. Nei secoli passati molti erano gli<br />
artigiani e<strong>di</strong>li che dall’Alta Lombar<strong>di</strong>a e dalla Svizzera<br />
italiana emigravano in Piemonte per esercitare il<br />
loro mestiere.<br />
<strong>12</strong><br />
Pur non avendo visto in volto l’aggressore,<br />
Francesco Comolo non esita ad identificarlo<br />
nel figlio del capomastro Giovanni Mozzone.<br />
Da che cosa deriva in lui tanta sicurezza?<br />
Dal fatto che mentre il garzone cercava la<br />
famosa chiave si era sentito apostrofare dal<br />
Mozzone: Eh perché stai tanto tempo a portarmi<br />
la mia chiave ?” Avendogli ribattuto<br />
che l’aveva smarrita e la stava cercando, per<br />
tutta risposta si sentiva <strong>di</strong>re: “Oh stampa<br />
becc: sempre fate cossì” e dopo pochi istanti<br />
seguiva l’aggressione.<br />
Il referto me<strong>di</strong>co<br />
Terminato l’interrogatorio del ferito, il Vicepodestà<br />
dovrebbe passare all’escussione dei<br />
testi.<br />
Prima però il chirurgo De Regibus è pregato<br />
<strong>di</strong> visitare attentamente il giovane muratore<br />
per constatarne le con<strong>di</strong>zioni.<br />
Il suo referto è che la ferita, inferta “a parte<br />
destra, tra la quinta costa vera e falsa”, ha<br />
offeso i muscoli intercostali esterni “con<br />
grande effusione <strong>di</strong> sangue”; la ferita è definita<br />
“pericolosa”, cioè tale da pregiu<strong>di</strong>care la<br />
vita del Comolo. Tuttavia il sanitario, che<br />
precisa <strong>di</strong> avere già curato casi analoghi, si<br />
riserva <strong>di</strong> “dar maggior giu<strong>di</strong>zio in progresso<br />
<strong>di</strong> cura, e salvo anche ogni accidente in contrario<br />
che potesse occorrere nel progresso<br />
della mede[si]ma spezialmente durante li<br />
giorni critici”.
Le testimonianze<br />
Il 24 febbraio, <strong>di</strong>etro citazione fatta dal serviente<br />
comunale Giuseppe Viola, inizia<br />
l’esame dei testimoni.<br />
Tocca per primo a Filippo Pastore, 45 anni,<br />
conta<strong>di</strong>no, analfabeta e possidente per oltre<br />
cento doppie.<br />
Egli racconta che la sera del 20, verso le due<br />
<strong>di</strong> notte, mentre stava in casa del prevosto<br />
Anselmi a <strong>di</strong>scorrere “<strong>di</strong> varie cose”, sentiva<br />
una persona che gridava “Aiutto, oh me, pover<br />
homo”. A queste invocazioni “parte per<br />
curiosità, parte anche per soccorrere, ove<br />
fosse stato <strong>di</strong> bisogno ad ogni accidente che<br />
fosse occorso”, accesa una lanterna, scendeva<br />
in strada e trovava <strong>di</strong>steso per terra il Comolo:<br />
“Avendo io interrogato il mede[si]mo cosa<br />
gli fosse occorso, egli mi rispose che era<br />
stato ferito, ed io gli risposi che ciò non poteva<br />
essere, ma che più tosto lui fosse caduto<br />
e si fosse fatto qualche male”. Finalmente<br />
decideva <strong>di</strong> soccorrerlo con l’aiuto <strong>di</strong> altri parenti<br />
che nel frattempo erano usciti anch’essi<br />
in strada ed il ferito veniva portato prima in<br />
casa <strong>di</strong> Carlo Antonio Pastore e poi, su consiglio<br />
del chirurgo, nella stalla.<br />
Il testimone non ha sospetti sull’identità del<br />
feritore, ma si limita a confermare che la voce<br />
pubblica accusa del fatto il mastro Giovanni<br />
Mozzone: ad ogni buon conto egli non<br />
esterna alcun giu<strong>di</strong>zio su <strong>di</strong> costui “siccome<br />
non ho mai sentito a <strong>di</strong>scorrerne del mede[si]mo<br />
né bene né male”.<br />
Dopo <strong>di</strong> lui viene sentito Giovanni Battista<br />
Massa fu Giacomo Francesco, nativo <strong>di</strong><br />
Mombello. 6<br />
Quella famosa domenica sera egli si trovava<br />
in casa <strong>di</strong> don Antonio Maria De Franciscis<br />
in compagnia del chirurgo De Regibus,<br />
quando giungeva Filippo Pastore a richiedere<br />
l’opera del sanitario. Accompagnatolo a casa<br />
Pastore, qui vedeva il Comolo “sedente sovra<br />
una cadrega”: subito De Regibus tentava <strong>di</strong><br />
fermargli l’emorragia e lo faceva trasportare<br />
nella stalla, incaricando anzi il servitore <strong>di</strong><br />
6 Anche questo teste si <strong>di</strong>chiara illetterato, ha<br />
vent’anni, si trova a Sala da circa un anno ed è a servizio<br />
del chirurgo De Regibus. Possiede <strong>di</strong> proprio il<br />
valore <strong>di</strong> circa <strong>di</strong>eci doppie.<br />
13<br />
andare a casa a prendergli “li ferri, o sian instromenti<br />
<strong>di</strong> chirurgia”.<br />
Ritornato nella stalla, sentiva i presenti <strong>di</strong>re<br />
che il muratore era stato ferito con un coltello<br />
muto dal Mozzone “per causa <strong>di</strong> una chiave”.<br />
Tuttavia, anche da questo testimone il<br />
presunto feritore è definito “un galant’homo”.<br />
Tra quelli che accusavano il Mozzone c’era<br />
Pietro Giacomo Beltrame, che il Vicepodestà<br />
fa citare per il 13 marzo.<br />
Egli, soldato nel Reggimento Nazionale <strong>di</strong><br />
Casale, ha vent’anni, svolge “l’arte <strong>di</strong> ferraro”<br />
7 e possiede sole <strong>di</strong>eci doppie, per <strong>di</strong> più<br />
in comunione con i fratelli.<br />
L’ultima domenica <strong>di</strong> Carnevale, il 20 febbraio<br />
appunto, stava andando a casa De<br />
Franciscis dove si teneva una festa da ballo 8<br />
e cammin facendo u<strong>di</strong>va “una voce lamentevole<br />
<strong>di</strong> un uomo, quale gridava aiutto, confessione”.<br />
Né lui né il suo compare Giovanni<br />
Battista Massa davano peso alle invocazioni<br />
(!) e tiravano dritto per la loro strada. In casa<br />
De Franciscis, dove con balli e musiche si<br />
stava festeggiando la fine del Carnevale, trovava<br />
anche il chirurgo De Regibus “che suonava<br />
in detta conversazione col violino”.<br />
Dopo qualche tempo però il sanitario, “tralasciando<br />
<strong>di</strong> suonare dal violino”, veniva richiesto<br />
<strong>di</strong> andare a casa Pastore per curare<br />
una ferita. Anche il teste “per curiosità” lo<br />
seguiva e vedeva il Comolo nelle con<strong>di</strong>zioni<br />
già descritte. 9<br />
Anche il giovane Beltrame ha sentito <strong>di</strong>re che<br />
il feritore sia il mastro Mozzone, ma stanta a<br />
dar cre<strong>di</strong>to alla voce pubblica, dati i buoni<br />
rapporti esistenti tra i due e <strong>di</strong>chiara<br />
all’interrogante: “Anzi le <strong>di</strong>rò che credo fossero<br />
più tosto amici che inimici prima del<br />
fatto da me sovra deposto, perché li vedevo<br />
sempre a travagliare <strong>di</strong> buona compania da<br />
muratori”.<br />
7 “Ferraro” = “fabbro ferraio”.<br />
8 Il teste, per maggior prudenza, afferma che si recava<br />
colà non per prendere parte attiva al ballo, ma solo<br />
“a titolo <strong>di</strong> conversazione”!<br />
9 Il Comolo era “sedente sovra una cadrega, o scagno,<br />
tutto insangiunato dalla parte destra nel fianco”.
È quin<strong>di</strong> la volta <strong>di</strong> Carlo Bonello, trentasettenne<br />
conta<strong>di</strong>no, nullatenente, il quale <strong>di</strong>chiara<br />
che la sera <strong>di</strong> domenica grassa 20 febbraio<br />
stava cenando con Filippo Pastore in casa del<br />
Parroco, quando “si sentì pocho <strong>di</strong>stante dalla<br />
casa parocchiale una voce d’uomo che<br />
fortemente si lamentava”; mentre il Pastore<br />
scendeva a vedere, egli si rimetteva “<strong>di</strong> nuovo<br />
<strong>di</strong> compania del signor Preposto a tavola<br />
per continuare la cena”, ma ancora una volta<br />
il pranzo doveva interrompersi perché il sacerdote<br />
veniva richiesto <strong>di</strong> confessare il mastro<br />
Francesco “<strong>di</strong>cendo che gli avevano dato”.<br />
Nella stalla dei Pastore trovavano il Comolo<br />
tutto insanguinato: don Anselmi lo invitava a<br />
perdonare il proprio aggressore, che tutti ormai<br />
identificano in Giovanni Mozzone, ma<br />
Francesco Comolo, poco evangelicamente,<br />
gli rispondeva: “Non voglio perdonar minga<br />
minga”.<br />
L’ultima perizia me<strong>di</strong>ca<br />
Si arriva così all’11 maggio, quando si tratta<br />
<strong>di</strong> concludere l’istruttoria e ancora una volta<br />
viene chiesta una perizia al chirurgo De Regibus,<br />
sebbene un po’ in ritardo, “attese le<br />
sue continue occupazioni”. D’altra parte<br />
sembra che il ferito si sia perfettamente ripreso,<br />
dato che “giorni sono si è absentato da<br />
questo luogo”.<br />
Secondo il chirurgo dunque le cose si sareb-<br />
14<br />
bero messe per il meglio, nonostante che il<br />
Comolo “siasi partito da questo luogo senza<br />
mia saputa pria che essa ferita fossesi cicatrizata”.<br />
Le conclusioni<br />
Il 9 luglio 1757 l’Avvocato fiscale <strong>di</strong> Casale,<br />
preso atto <strong>di</strong> quanto emerso dalle indagini,<br />
conclude essere abbastanza provato che il feritore<br />
sia stato Giovanni Mozzone, “risultando<br />
parimenti della causa procedente<br />
dall’avere il ferito perduta la chiave <strong>di</strong> casa<br />
del Mozzone” e <strong>di</strong>chiara la colpevolezza del<br />
mastro da muro.<br />
Sebbene citato a comparire, Giovanni Mozzone<br />
non si fa vivo per <strong>di</strong>scolparsi delle accuse<br />
rivoltegli: una ad una vengono compilate<br />
le tre fe<strong>di</strong> contumaciali previste dall’allora<br />
vigente procedura penale, scadute le quali il<br />
30 ottobre 1757, otto mesi dopo il fatto,<br />
l’inquisito è condannato alla pena pecuniaria<br />
<strong>di</strong> scu<strong>di</strong> due d’oro, oltre all’indennizzo del<br />
ferito e alle spese <strong>di</strong> giustizia.
Corrado Camandone<br />
CALENDARIO D’ARTE<br />
I<br />
l calendario <strong>di</strong>ffuso a Moncalvo nel<br />
2001, pubblicato per iniziativa del<br />
Parroco D. Angelo Francia, ci ha tenuto<br />
compagnia per do<strong>di</strong>ci mesi. Una splen<strong>di</strong>da<br />
tempera del nostro Mario Pavese è stata<br />
da noi vista, contemplata, goduta durante ciascun<br />
mese. È stata come una piccola mostra<br />
d’arte allestita in casa nostra per un anno intero.<br />
Ogni anno comincia a mezzanotte e giustamente<br />
il calendario si presenta con un bellissimo<br />
notturno. Solo un artista può, con tanta<br />
sicurezza, usare blu scuro, violetto e nero per<br />
rappresentare un paese. Ma questo artificio<br />
dà risalto alle luci calde delle finestrine e alle<br />
pennellate <strong>di</strong> luce delle vie illuminate. Il<br />
quadro è ricchissimo <strong>di</strong> <strong>di</strong>segno: alberi, tetti,<br />
comignoli, finestre, campanili, tutti <strong>di</strong>versi e<br />
rifiniti nei particolari. L’e<strong>di</strong>cola della Madonnina<br />
è come una miniatura. In questa<br />
tempera ci sono quasi tutte le caratteristiche<br />
dell’arte <strong>di</strong> Mario Pavese: <strong>di</strong>segno ricco, preciso,<br />
onesto; capacità <strong>di</strong> creare una precisa<br />
atmosfera in ogni opera, con una tonalità<br />
dominante calda o fredda, e con la rara capacità<br />
<strong>di</strong> rappresentare la luce.<br />
In <strong>gennaio</strong> sono protagoniste quelle due<br />
mantelline nere, agitate dal vento che crea folate<br />
<strong>di</strong> neve ben visibili sull’arco nero. Lo<br />
sfondo è una prospettiva ricca e ar<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> case<br />
allineate a destra e a sinistra, con porte, gra<strong>di</strong>ni<br />
e balconi filettati <strong>di</strong> bianco. Sullo sfondo<br />
la chiesa <strong>di</strong> S. Marco, con il suo arco e il suo<br />
orologio che segna le otto del mattino. I due<br />
uomini affondano il passo nel tappeto <strong>di</strong> neve,<br />
senza rompere il silenzio. Pittura morbida<br />
anche se precisa come una fotografia e che<br />
rappresenta il movimento come in un film.<br />
Febbraio ci presenta la chiesa della Madonna,<br />
che mostra da secoli la sua imponente<br />
bellezza. I suoi mattoni rosati, in un mattino<br />
15<br />
d’inverno, col cielo grigio, non possono cantare<br />
come quando c’è il sole. Sono grigi, scuri,<br />
con gli occhi chiusi, in attesa della grande<br />
luce. Ma questa tonalità bassa permette alla<br />
neve <strong>di</strong> <strong>di</strong>segnare con un filo <strong>di</strong> luce tutti i<br />
particolari della ricca architettura: timpani,<br />
cornicioni, basamenti e i capitelli delle colonne.<br />
Sulla piazzetta, bianca <strong>di</strong> neve, tre bambini in<br />
atteggiamenti vivaci si lanciano palle <strong>di</strong> neve.<br />
Sono il simbolo delle generazioni che come<br />
un fiume passano davanti alle opere d’arte,<br />
che restano, e ancor più davanti ai valori<br />
permanenti che quelle opere rappresentano.<br />
Marzo. La piazza del mercato è un allegro<br />
annuncio <strong>di</strong> primavera. Le tende hanno il colore<br />
delle prime foglie tenere che rispuntano<br />
sugli alberi. Il conta<strong>di</strong>no che lavora tanti<br />
giorni da solo, qui si sente membro della società<br />
a cui può dare e chiedere qualcosa. I<br />
progetti e i calcoli, fatti durante le lunghe serate<br />
d’inverno, qui <strong>di</strong>ventano incontri, proposte,<br />
trattative, affari.<br />
Il giorno <strong>di</strong> mercato che è “a metà strada<br />
tra il lavoro e la festa”, come ha ben detto<br />
Gigi Sarzano, riattiva il meccanismo della<br />
parola, della logica, del tentativo <strong>di</strong> convincere<br />
qualcuno a vendere o comperare qualcosa.<br />
È occasione d’incontro con parenti e amici<br />
e voglia <strong>di</strong> mostrare il bue ingrassato con<br />
mille artifici. È un’accolta <strong>di</strong> cappelli, mantelli,<br />
bastoni, carretti e bancarelle, immersa in<br />
un concerto <strong>di</strong> voci dai mille toni. In alto, a<br />
destra sotto il pennone coi colori del Comune,<br />
un gruppetto <strong>di</strong> gente partecipa forse a un<br />
comizio. Il giorno del mercato è atteso e colora<br />
tutta la settimana.<br />
Aprile è ritratto in un giorno <strong>di</strong> pioggia. La<br />
stra<strong>di</strong>na del Fosso (Via Roma). lucida, riflette<br />
le immagini degli omini, delle donnette,<br />
della carrozza che sale verso S. Francesco. A
sinistra si vedono i campanili della Madonna<br />
e <strong>di</strong> S. Antonio. Le vecchie mura accompagnano<br />
decisamente lo sguardo verso l’alto,<br />
dominato dal campanile della chiesa parrocchiale.<br />
Gli orti in primo piano, con le loro<br />
scalette, le aiuole dei primi ortaggi e la massa<br />
splen<strong>di</strong>da del pesco in fiore, sono come un<br />
immenso tappeto festoso steso ai pie<strong>di</strong> del<br />
paese.<br />
È una decorazione che non può avere nessuna<br />
Via Roma delle gran<strong>di</strong> città. I tetti delle<br />
case sono come un antico mosaico.<br />
Maggio. I bambini giocano alle birille col<br />
naturale impegno dell’età; l’occhio attento e<br />
il <strong>di</strong>to che sta per scattare sono <strong>di</strong> una precisione<br />
vivente. Il compagno con le mani sulle<br />
ginocchia spera e teme qualcosa. Il bambino<br />
appoggiato al lampione, con sguardo furbetto<br />
e maturo, ci guarda come per <strong>di</strong>re: “Anche tu<br />
hai giocato quando avevi la mia età, no?”.<br />
L’altro bambino corre chissà dove.<br />
Il sole inonda <strong>di</strong> luce la piazza; dà alla casa e<br />
al campanile una pennellata chiara, sapientemente<br />
accostata alla grande massa delle<br />
facciate del palazzo e della Sinagoga, ritratte<br />
con un raffinato grigio-violetto e toni trasportati.<br />
Anche nell’ombra si vedono cornicioni,<br />
porte, persiane: artifici <strong>di</strong> un esperto pittorefotografo.<br />
Giugno ci porta la processione del Corpus<br />
Domini, mentre scende dalla Fracia:<br />
è una visione precisa degli anni ‘50. Fanno<br />
tenerezza le Figlie <strong>di</strong> Maria col loro stendardo<br />
in primo piano, le suore ancora “Cappellone”,<br />
il baldacchino, poi lo stendardo del<br />
Comune e il seguito degli uomini. Balconi<br />
con coperte esposte e gente che guarda con<br />
atteggiamento devoto.<br />
È senza dubbio grande qui l’arte <strong>di</strong> rappresentare<br />
l’espressione dei sentimenti con pochissimi<br />
tratti. Protagonisti dell’avvenimento<br />
sono le persone umane, ma protagonisti del<br />
quadro sono i tetti delle vecchie case, le tegole,<br />
<strong>di</strong>segnate una per una, come tante persone,<br />
quelle intere, quelle mezze, con leggere<br />
variazioni <strong>di</strong> tinta, più o meno cotte, più o<br />
meno giovani. Le tegole sono come le mani<br />
che proteggono e tengono al caldo la casa,<br />
nido <strong>di</strong> tutti i sogni, rifugio <strong>di</strong> tutti i segreti,<br />
oggetto del ricordo e della nostalgia.<br />
16<br />
La piena estate è ritratta nel quadro <strong>di</strong> luglio:<br />
campi <strong>di</strong> grano in collina, dopo la mietitura.<br />
Il colore scuro e caldo è quello della buona<br />
terra. Le stoppie gialle ricordano le vigorose<br />
pennellate <strong>di</strong> Van Gogh. La stra<strong>di</strong>na polverosa<br />
ci porta fino al crinale della collina, dove<br />
sta quasi in bilico un carro colino <strong>di</strong> covoni<br />
<strong>di</strong> grano, su cui è seduta una donna con la sua<br />
cappellina. A terra c’è l’uomo col bastone e<br />
tra le ruote del carro si vedono le gambe del<br />
bue che sembrano in movimento.<br />
La piccola <strong>di</strong>mensione del carro mette in risalto<br />
l’immensità del cielo azzurro, su cui<br />
trionfa una enorme nuvola bianca. Luce e calore<br />
nel <strong>di</strong>segno e nelle tinte.<br />
La stra<strong>di</strong>na ci porta su al cascinotto, che veglia<br />
dall’alto su vigneti e campi. È il momento<br />
della vendemmia, tanto attesa e tanto minacciata<br />
da pericoli <strong>di</strong> vario genere. Però,<br />
quando va bene, è il momento più bello per<br />
l’uomo <strong>di</strong> campagna.<br />
Agosto ci presenta una sera d’estate a Moncalvo.<br />
La Fracia, l’antica via me<strong>di</strong>oevale<br />
conduce alla Piazza Garibal<strong>di</strong>. Dopo una<br />
giornata <strong>di</strong> caldo afoso il fresco della sera invoglia<br />
la gente a fare due passi e due chiacchiere.<br />
Anche qui le fortissime tinte dei tetti<br />
sono necessarie per far brillare le luci delle<br />
finestrine e dei lampioni. Le tegole e i comignoli<br />
sono <strong>di</strong>segnati con amore e anche<br />
nell’oscurità si nota la varietà dei loro colori.<br />
Settembre è illustrato con una scena della<br />
vendemmia, avvolta nella luce calda delle<br />
foglie <strong>di</strong> vite che maturano insieme ai grappoli<br />
e si vestono dei colori più allegri:<br />
giallo, arancio, rosso. Caldo il colore del carro,<br />
della bigoncia, della terra. Protagonista, in<br />
primo piano, la “barosa”, con le ruote, i ferri,<br />
i chio<strong>di</strong>, le corde e il timone ben evidenti; poi<br />
la bigoncia vecchia e robusta su cui si china<br />
l’uomo per vuotare la “brenta” colma <strong>di</strong><br />
grappoli maturi. Con una mano si tiene alla<br />
scaletta e con l’altra alza il fondo della brenta,<br />
mentre piega fortemente la schiena; gesto<br />
faticoso ripetuto mille volte da tante generazioni<br />
qui fissato come in un monumento.<br />
Ottobre. Le castagne arrivano anche a Moncalvo.<br />
Una vecchina, una specie <strong>di</strong> befana
anzitempo, prepara le caldarroste su un braciere<br />
all’aperto. Il suo profilo, una se<strong>di</strong>a, un<br />
sacco e un ombrellone spiccano ben <strong>di</strong>segnati<br />
sulla colonna <strong>di</strong> fumo bianco che sale dal<br />
braciere. Sullo sfondo le alte case della piazza,<br />
<strong>di</strong> colore austero, ma schiarito da una<br />
nebbiolina autunnale, che rafforza in modo<br />
misurato la prospettiva aerea, ben nota ai pittori<br />
esperti.<br />
Si nota, a sinistra, l’arco ogivale della casa<br />
più antica <strong>di</strong> Moncalvo. Un comignolo, una<br />
grondaia, una persiana aperta, una mensola<br />
dei fili elettrici ci assicurano dell’assoluta fedeltà<br />
dell’ambientazione. Dolce scenetta <strong>di</strong><br />
paese.<br />
Novembre. Giornate più corte, voglia <strong>di</strong> casa<br />
e <strong>di</strong> tepore: il tutto rappresentato in un caminetto<br />
che è una poesia. Sono prevalenti le tonalità<br />
scure che mettono in risalto le lingue<br />
della fiamma e le “monachine” che salgono<br />
su per la cappa. Sulla mensola del camino<br />
stanno tranquilli e orgogliosi i simboli della<br />
civiltà conta<strong>di</strong>na: le candele per scendere in<br />
cantina, le lettere che sono forse l’unica biblioteca<br />
della casa e l’archivio delle notizie e<br />
degli affetti; macinino, scatola e caffettiera<br />
per il rito quoti<strong>di</strong>ano, la statuetta della Madonna<br />
per confidare in un aiuto dall’alto, il<br />
ferro da stiro per le camicie delle feste e la<br />
sveglia per non perdere tempo—Gli attrezzi<br />
da cucina si fanno belli con i loro riflessi <strong>di</strong><br />
rame.<br />
La legna in basso e lo sportello nero non possono<br />
essere <strong>di</strong>segnati meglio.<br />
17<br />
Questo caminetto, specchio della civiltà conta<strong>di</strong>na<br />
non vale meno dei gran<strong>di</strong> archi <strong>di</strong><br />
trionfo eretti in tante città del mondo.<br />
Dicembre ha il suo momento più bello nella<br />
notte <strong>di</strong> Natale. Uomini e donne spiccano<br />
scuri sulla piazzetta imbiancata dalla neve e<br />
camminano verso S. Francesco, che campeggia<br />
solenne con le finestre illuminate. Dietro<br />
quella porta <strong>di</strong>segnata dalla luce, c’è la bellezza<br />
dell’arte, i documenti della storia, il<br />
profumo dell’incenso, la cattedra della “Parola”,<br />
la pratica dell’esame <strong>di</strong> coscienza, il Pane<br />
dell’anima, lo spazio che accoglie i nati,<br />
gli sposi, i morti. È la magnifica sede <strong>di</strong> una<br />
scuola sempre antica e sempre nuova, aperta<br />
a tutti.<br />
A Natale l’austerità della Legge si addolcisce<br />
nella figura <strong>di</strong> un tenero Bambino che invita<br />
e incoraggia.<br />
Tutto questo viene in mente osservando i<br />
passi, le scarpe, i mantelli che Mario Pavese,<br />
col suo <strong>di</strong>segno magico, ha messo in movimento<br />
verso la luce.<br />
Terminato l’anno 2001, le immagini del calendario<br />
che abbiamo scoperto e amato, devono<br />
essere conservate in una cartellina e<br />
collocate nella nostra biblioteca, insieme alle<br />
pubblicazioni <strong>di</strong> storia dell’arte, perché sono<br />
vere preziose opere d’arte, insieme classica e<br />
moderna, per tutti, ma in modo specialissimo<br />
per noi moncalvesi.
Angela Biedermann<br />
DINANZI AL CALENDARIO 2001 DI MARIO PAVESE<br />
GENNAIO - Invano cerco nella neve le impronte<br />
lasciate dai due passanti intabarrati.<br />
Già sono scomparse sotto altra neve. Come le<br />
ore nella vita.<br />
FEBBRAIO - Mi colpisce il colore forte,<br />
l’architettura pesante della chiesa. Mattoni su<br />
mattoni e un leggero cordolo <strong>di</strong> neve. Ma ai<br />
pie<strong>di</strong>, macchie <strong>di</strong> colore richiamano innocenti<br />
giochi <strong>di</strong> bimbi. Mi auguro che anche nelle<br />
ore buie della vita, ci sia sempre un filo <strong>di</strong><br />
speranza.<br />
MARZO - Al mercato, spaesata tra la folla,<br />
anche pensieri, desideri e sogni si evolvono.<br />
Come quei buoi che in ven<strong>di</strong>ta sulla piazza,<br />
sognano la stalla.<br />
APRILE - Sembra primavera, ma gli ombrelli<br />
aperti e le pozzanghere sull’asfalto mi fanno<br />
pensare agli inganni latenti negli avvenimenti<br />
della vita.<br />
MAGGIO - Il violento contrasto fra l’azzurro<br />
pallido del cielo e il blu notte della casa mi<br />
richiama l’alternarsi degli avvenimenti nella<br />
vita e mi suggerisce <strong>di</strong> guardare sempre in<br />
alto, oltre le nubi. Troverà il sereno.<br />
18<br />
GIUGNO - Vorrei anch’io poter esporre alla<br />
finestra il can<strong>di</strong>do lenzuolo d’una vita senza<br />
macchia.<br />
LUGLIO - Quando m’imbatto in una salita<br />
<strong>di</strong>fficile mi auguro <strong>di</strong> poter sempre ricorrere<br />
al sostegno della volontà.<br />
AGOSTO - Le finestre illuminate, nel cuore<br />
della notte, mi fanno pensare al mistero della<br />
vita.<br />
SETTEMBRE - La vite cede i grappoli maturi,<br />
pronta a ricominciare il ciclo. Non così per<br />
l’uomo.<br />
OTTOBRE - L’amore, come il profumo delle<br />
caldarroste, solletica l’appetito anche quando<br />
ogni desiderio sembra spento.<br />
NOVEMBRE - Un vecchio camino in una<br />
vecchia casa. Un orologio fermo su <strong>di</strong> un’ora<br />
ben precisa: l’ultima.<br />
DICEMBRE - Ma forse c’è ancora una speranza.<br />
Una luce alla quale approdare: la fede.
Paolo Cavallo<br />
LA MUSICA NELLA CHIESA DI SAN GRATO IN PENANGO FRA ‘800 e ‘900:<br />
FIGURE, STRUMENTI, DOCUMENTI<br />
“ […]<br />
Di labile materia fui costrutto, <strong>di</strong> misterioso tempo<br />
È in me forse la fonte.<br />
Forse dalla mia ombra<br />
Nascono i giorni fatali e illusori.”<br />
[Jorge Luis Borges, Eraclito, da Elogio dell’ombra]<br />
Le origini dell’organo <strong>di</strong> Penango.<br />
Riflessioni per un’attribuzione ragionata.<br />
La volontà <strong>di</strong> rendere perspicua la storia della<br />
musica sacra prodotta dal contado moncalvese<br />
nei secoli X<strong>VII</strong>I e XIX attraverso<br />
l’esame del contesto sociale ed artistico in<br />
cui la stessa maturò conduce il ricercatore ed<br />
i suoi eventuali lettori, dopo le <strong>di</strong>samine de<strong>di</strong>cate<br />
alle chiese parrocchiali <strong>di</strong> Calliano e <strong>di</strong><br />
Scandeluzza, ad una nuova tappa<br />
d’indagine 10 .<br />
Territorialmente confinante con i comuni <strong>di</strong><br />
Calliano e Moncalvo, il paese <strong>di</strong> Penango cela<br />
probabilmente il caso <strong>di</strong> più intricata soluzione<br />
della storia organaria <strong>di</strong> questo lembo<br />
<strong>di</strong> Monferrato. Ciò si verifica in quanto<br />
l’organo ubicato nella locale parrocchiale,<br />
de<strong>di</strong>cata a San Grato, non ha ancora, a<br />
tutt’oggi, un autore né una comprovata provenienza<br />
geografica.<br />
Poiché tali vuoti storici non sono stati confutati<br />
che da dati acefali (la data <strong>di</strong> costruzione<br />
della cassa lignea dello strumento - che reca<br />
impresso, sotto la campata centrale, l’anno<br />
1754-) oppure mai compiutamente suffragati<br />
(l’attribuzione della stessa, secondo Giuseppe<br />
Niccolini, al minusiere autoctono Giovanni<br />
Battista Allemano 11 ), l’unica certezza <strong>di</strong><br />
10 I dati che vengono qui <strong>di</strong> seguito esposti debbono il<br />
loro reperimento e la loro riproduzione alla cortesia <strong>di</strong><br />
tre persone: don Cesare Falaguerra e Giuseppe Franco<br />
per l’archivio parrocchiale <strong>di</strong> Penango, il prof. Alessandro<br />
Allemano per quello comunale. A loro sia in<strong>di</strong>rizzato<br />
il mio più sentito ringraziamento.<br />
11 “Si ammirano inoltre in questa chiesa il pulpito e la<br />
cassa dell’organo. Entrambe sono <strong>di</strong>ligentissime opere<br />
19<br />
cui si correda questo strumento è la seguente:<br />
esso nacque per un tempio <strong>di</strong>verso rispetto a<br />
quello che oggi lo ospita (anche perché<br />
l’attuale chiesa sarebbe stata ricostruita solo<br />
a partire dal 1755 <strong>12</strong> ). In<strong>di</strong>viduare qual esso<br />
fosse, per quanto sia ancor obbligatoria la<br />
prudenza, non è oggi più impossibile: dalla<br />
visita pastorale compiuta dal vescovo casalese<br />
nel 1873 risultava sussistente nella parrocchiale<br />
penanghese un<br />
“organo ristorato or son quattro anni [sic] a spese del<br />
Comune, a richiesta dei Fabbricieri della Chiesa che<br />
n’è la proprietaria” etichettato come “l’antico organo<br />
della Chiesa <strong>di</strong> Calliano” 13 .<br />
La scrupolosità dell’esplicazione ed il tono<br />
confidenziale con cui, quattro anni dopo, essa<br />
si riversò nelle pagine de<strong>di</strong>cate dal Niccolini<br />
a Penango parrebbero provenire da una stessa<br />
persona, forse il parroco del paese: a riprova<br />
che l’evento che i precari elementi contabili<br />
conservati nell’archivio parrocchiale situano<br />
negli anni imme<strong>di</strong>atamente precedenti il<br />
1856 14 doveva essersi impresso indelebilmente<br />
nella memoria popolare dei borghigiani.<br />
Dinanzi ad uno spaccato così lacunoso <strong>di</strong><br />
certezze va da sé che risalire alla situazione<br />
ab ovo sia un miraggio. Anche in virtù della<br />
pervicace omertà delle fonti: presenti e completi<br />
per il periodo 1726-1763 15 , i conti spese<br />
del falegname Penanghese il fu Gioanni Alemanno,<br />
autore del rinomatissimo coro della Cattedrale <strong>di</strong> Saluzzo.”,<br />
cit. da G. NICCOLINI, A zonzo per il Monferrato,<br />
Torino 1877 ( la presente citazione è tolta da [A.<br />
ALLEMANO], Giuseppe Niccolini visita Penango in<br />
“<strong>Pagine</strong> <strong>Moncalvesi</strong>”, III, 4 [1998], p. 54).<br />
<strong>12</strong><br />
Cfr. A. ROSSO- I. MAESTRI, L’opera dell’architetto<br />
Magnocavallo in Piemonte, Politecnico <strong>di</strong> Torino, Tesi<br />
<strong>di</strong> laurea in Storia dell’Architettura, rel. Daria De<br />
Bernar<strong>di</strong> Ferrero, a.a. 1975-76, pp. 71 sgg.; A.<br />
MERLETTO, La figura del Conte Magnocavalli e<br />
l’attività e<strong>di</strong>lizia nella Moncalvo del ‘700, Politecnico<br />
<strong>di</strong> Torino, Tesi <strong>di</strong> laurea in Storia dell’Architettura,<br />
rel. Laura Palmucci, a. a. 1986-87, p. <strong>12</strong>1.<br />
13<br />
Vd. Appen<strong>di</strong>ce, Doc. 7.<br />
14<br />
Ibid., Doc. 1.<br />
15<br />
APP, Libro Mastro della Reggenza della Chiesa<br />
Parrocchiale <strong>di</strong> Penango [contiene le entrate e le uscite<br />
comprese nel lasso 1726-1763 e 1856-1857].
della fabbriceria parrocchiale <strong>di</strong> Penango sono<br />
del tutto assenti sino alla seconda metà<br />
dell’Ottocento 16 . Non essendovi così modo <strong>di</strong><br />
appurare l’esatta data dell’acquisizione dello<br />
strumento lasciamo spazio alle congetture<br />
sulle sue origine e struttura fonica.<br />
La data sul frontalino (1754) e l’acclarata derivazione<br />
geografica obbligano ad una sola<br />
supposizione: che il suo costruttore sia stato<br />
l’organaro napoletano residente in <strong>Asti</strong> Liborio<br />
Grisanti. Questi, infatti, a cavallo fra il<br />
1753 ed il 1754, stava portando a termine lo<br />
strumento commissionatogli dalla fabbriceria<br />
e dalle tre compagnie residenti nella Chiesa<br />
del SS.mo Nome <strong>di</strong> Maria <strong>di</strong> Calliano 17 . Anche<br />
se l’organo in questione non è fisicamente<br />
riconducibile, come vorrebbe il succitato<br />
documento penanghese, a quello - che è<br />
tutt’ora esistente - della parrocchiale callianese,<br />
in questo comune esistevano due ulteriori<br />
luoghi <strong>di</strong> culto dotati <strong>di</strong> una base <strong>di</strong> affiliati<br />
così considerevole da rendere concretizzabile<br />
un progetto <strong>di</strong> tal onere finanziario: le<br />
confraternite de<strong>di</strong>cate alla SS.ma Annunziata<br />
ed a San Michele.<br />
Purtroppo, il mutamento <strong>di</strong> prospettiva e <strong>di</strong><br />
località non indulge a risultanze documentarie<br />
più significative e cospicue: se nella prima<br />
si ritrova menzione <strong>di</strong> uno strumento a<br />
canne a partire dal 1857, nella seconda un<br />
inventario datato 1833 lasciava invece trapelare<br />
l’esistenza <strong>di</strong> un anonimo “Organo a cilindri”<br />
18 . Procede da sé che l’appaltatura <strong>di</strong><br />
uno strumento legato a doppia mandata con<br />
la corografia devozionale <strong>di</strong> una comunità<br />
costituì grave motivo <strong>di</strong> frizione per coloro<br />
che <strong>di</strong> tal mondo erano parte. Ma poiché lo<br />
scontro fra parrocchia e chiese confraternite<br />
fu un evento affatto inconsueto nella storia<br />
religiosa piemontese dell’età moderna, si impone<br />
la convinzione che i confratelli <strong>di</strong> San<br />
Michele, per controbattere all’offensiva decorativa<br />
or<strong>di</strong>ta dai concorrenti parrocchiani,<br />
16<br />
Cfr. Ibi, Libro dell’uscita Uscita della Chiesa Parrocchiale,<br />
ad annum.<br />
17<br />
Cfr. (anche per la bibliografia su Grisanti) P.<br />
CAVALLO, Da Grisanti a Gan<strong>di</strong>ni. 160 anni <strong>di</strong> organari<br />
e organisti nella Parrocchia SS:mo Nome <strong>di</strong> Maria<br />
<strong>di</strong> Calliano, in “<strong>Pagine</strong> <strong>Moncalvesi</strong>”, III, 4 [1998],<br />
pp. 32-41.<br />
18<br />
Ibid., in <strong>Pagine</strong> <strong>Moncalvesi</strong>”, III, 5 (1998), pp. 21-<br />
37: 22.<br />
20<br />
assoldarono lo stesso organaro <strong>di</strong> questi ultimi<br />
e, obbedendo ai criteri dell’oculatezza e<br />
del rispetto delle con<strong>di</strong>zioni acustiche <strong>di</strong> un<br />
vano più limitato, gli fecero erigere uno<br />
strumento in base sì <strong>di</strong> otto pie<strong>di</strong> ma con una<br />
cornice più <strong>di</strong>sadorna ed un materiale fonico<br />
più ridotto. Sapendo infatti che l’organo Grisanti<br />
della parrocchiale <strong>di</strong> Calliano doveva<br />
possedere all’incirca <strong>di</strong>eci/do<strong>di</strong>ci registri non<br />
si errerà a ritenere che il suo probabile omologo<br />
ne rappresentasse un ricalco in scala<br />
(con l’unico dubbio legato alla presenza del<br />
flauto in quinta, registro che Grisanti non<br />
sempre inseriva nei suoi strumenti degli anni<br />
‘50-’60 19 ).<br />
Una volta resa cre<strong>di</strong>bile questa commissione<br />
occorre però chiederci a che cosa servisse<br />
uno strumento <strong>di</strong> tal fatta ai confratelli <strong>di</strong> S.<br />
Michele.<br />
19 A quell’arco temporale può essere infatti riferito<br />
l’organo della chiesa parrocchiale <strong>di</strong> Cocconato, che, a<br />
detta dell’allora locale parroco Francesco Borgogna<br />
era uno strumento “ […] costrutto dal Sig.r Liborio<br />
d’<strong>Asti</strong> […] perfettissimo nel suo essere <strong>di</strong> ondeci registri<br />
[…] avendo però l’avvertenza volendo far la spesa<br />
<strong>di</strong> farle aggiungere il duodecimo registro del flauto in<br />
quinta, qual nel notro vien suplito dal Cornetto”<br />
(Arch. Parr. <strong>di</strong> Murisengo, Cart. “Chiesa Parr.”, fald.<br />
“Organo-Campane”, lettera del 11 <strong>di</strong>cembre 1772).
Pronta la risposta: dei rarissimi atti amministrativi<br />
e finanziari 20 <strong>di</strong> questa associazione<br />
devozionale che ci sono stati conservati, un<br />
documento (che però non si trova custo<strong>di</strong>to<br />
nell’archivio parrocchiale callianese) è <strong>di</strong><br />
chiara natura musicale. Nel fondo <strong>di</strong> una non<br />
meglio in<strong>di</strong>cata confraternita callianese (che<br />
può essere solo quella <strong>di</strong> San Michele, visto<br />
che il progressivo stato <strong>di</strong> degrado del tempio<br />
dell’Annunziata ha determinato anche la <strong>di</strong>spersione<br />
del suo archivio), lo stu<strong>di</strong>oso Carlo<br />
Caramellino ha segnalato recentemente il ritrovamento<br />
<strong>di</strong> una copia manoscritta della<br />
Missa trompette / Dite de Bordeaux. Modulanda<br />
Cantantibus Organis, databile attorno<br />
al quinto decennio dell’Ottocento 21 .<br />
L’esistenza <strong>di</strong> un repertorio necessitante <strong>di</strong><br />
cantori semiprofessionisti e <strong>di</strong> accompagnamento<br />
strumentale sembrerebbe confermare<br />
che l’utilizzo <strong>di</strong> questo piccolo organo si protrasse<br />
almeno sino agli anni ’40 del XIX secolo.<br />
Poiché oggi nella chiesa <strong>di</strong> San Michele<br />
non rimane più alcuna traccia dell’esistenza<br />
<strong>di</strong> uno strumento a canne (e si potrebbe perciò<br />
opinare che dopo la sua cessione esso non<br />
venne più sostituito), la misconoscenza delle<br />
motivazioni economiche e sociali che furono<br />
a monte <strong>di</strong> questa misura costringe a soffermarsi<br />
sul suo più palmare effetto oggettivo:<br />
la <strong>di</strong>cotomia fra un fiorente sistema <strong>di</strong> produzione<br />
e <strong>di</strong>ffusione musicale endogeno (che, a<br />
breve, avrebbe fecondato anche la chiesa parrocchiale<br />
callianese 22 ) e la coeva <strong>di</strong>smissione<br />
20 Vd. M. PAROLA, Inventari delle associazioni devozionali,<br />
in A. TORRE (a cura <strong>di</strong>), Confraternite. Archivi,<br />
e<strong>di</strong>fici, arre<strong>di</strong> nell’<strong>Asti</strong>giano dal X<strong>VII</strong> al XX secolo,<br />
<strong>Asti</strong> 1999, pp. 45-46.<br />
21 Cfr. N. GALLINO, Per honor della sua Collegiata.<br />
Musica e spazio urbano. Rivoli XIV-XX secolo, Torino<br />
1996 [Il Gridelino, 16], p. 130, n. 54.<br />
22 Nell’Arch. Parr. <strong>di</strong> Calliano si trovano infatti, assieme<br />
a due e<strong>di</strong>zioni del Missale Romanum (la prima<br />
recante la marca tipografica “Venetiis, apud Johannem<br />
Manfré, 1764”, la seconda “[Torino], Marietti, 1893”)<br />
ad un Graduale Romanum (Venetiis, [?], 176[…]) e<br />
ad un Antiphonarium Romanum/ de tempore et Sanctis<br />
(Venetiis, ex Typographia Balleoniana, 1776), tre libri<br />
corali manoscritti: Libro / contenente / la / messa / per<br />
li /Defunti Manoscritto in / Calliano Li 20 <strong>di</strong>cembre /<br />
l’anno 1869 [8 cc.]; Libro pei Vespri / delle / Solennità<br />
dall’anno / Scritto in Tonco anno 1870 / Sampietro<br />
Pietro Libraio [16 cc.]; un libro, s. d., contenente <strong>12</strong><br />
Messe per voci e organo ad libitum [fra cui la “Messa<br />
a due voci del M.° Nat.le Paoletti”; 35 cc.]. Cfr., per<br />
21<br />
del me<strong>di</strong>um atto a sorreggerlo. Una <strong>di</strong>cotomia<br />
che, emergendo decontestualizzata dalla<br />
sua prospettiva originaria, potrebbe apparire<br />
una volontaria quanto immotivata autocastrazione<br />
della simbologia devozionale dei confratelli<br />
riuniti sotto l’invocazione <strong>di</strong> San Michele.<br />
Il trapianto <strong>di</strong> un organo a metà Ottocento:<br />
piccole (e sparute) vicende organarie e<br />
organistiche <strong>di</strong> una comunità rurale.<br />
Giunto a Penango dopo il 1833 e prima del<br />
1856, lo strumento a canne <strong>di</strong> Calliano subì<br />
quasi sicuramente, anche se indocumentata,<br />
una generale revisione fonica all’atto del suo<br />
posizionamento. I circa <strong>di</strong>eci anni che decorrono<br />
dalla primitiva menzione dello strumento<br />
sino al riattamento attuato da Giuseppe<br />
Vittino nel 1865 risultano infatti eccessivi<br />
per un somiere ed un sistema meccanico ormai<br />
centenari. Per non parlare <strong>di</strong> una prassi<br />
organistica che pre<strong>di</strong>ligeva i registri in grado<br />
<strong>di</strong> riprodurre le voci degli strumenti ban<strong>di</strong>stici<br />
e da concerto (soprattutto quelli ad ancia,<br />
<strong>di</strong> cui lo strumento <strong>di</strong> Grisanti era del tutto<br />
sprovvisto) e la tastiera spezzata in bassi e<br />
soprani.<br />
I documenti consultati asseconderebbero<br />
l’impressione che soltanto con l’avvento<br />
dell’artigiano astigiano, che era all’epoca uno<br />
dei più attivi in Monferrato 23 , l’organo <strong>di</strong> San<br />
Grato subì una sostanziale revisione fonica e<br />
tecnologica che lo adeguò ai desiderata timbrici<br />
peculiari della letteratura tastieristica<br />
ottocentesca 24 : dando finalmente modo<br />
all’organista incaricato dal Comune <strong>di</strong> Penango<br />
nel 1860, il flebotomo autoctono Gio-<br />
una ricognizione dei testi musicali contenuti in tal<br />
fondo, il mio articolo Alla scoperta dei fon<strong>di</strong> musicali<br />
nel Monferrato moncalvese, in “<strong>Pagine</strong> <strong>Moncalvesi</strong>”,<br />
VI, 11 (2001), pp. 34-35.<br />
23 Cfr. l’anonimo Vittino che lavorò sull’organo Grisanti<br />
della Chiesa Parrocchiale <strong>di</strong> Calliano nel 1858<br />
(P. CAVALLO, Da Grisanti a Gan<strong>di</strong>ni cit., p. 24).<br />
24 APP, Inventario Dei beni della Chiesa parr.le e Del<br />
Benefizio e rispettive Carte <strong>di</strong> pagine 99 [Inventario<br />
Degli Arre<strong>di</strong> e Mobili appartenenti alla Chiesa Parr.le<br />
<strong>di</strong> S. Grato in Penango compilato Nel Giugno 1872],<br />
c. 62:<br />
“6. Organo, Cassa e Tribuna in buon stato: l’organo <strong>di</strong><br />
recente fu ridotto a nuovo coi campanelli”.
vanni Occhiale 25 , <strong>di</strong> servirsi <strong>di</strong> una pedaliera<br />
equiparata al gusto contemporaneo 26 .<br />
La notevole mole <strong>di</strong> lavoro svolta da Vittino<br />
oltrepassò <strong>di</strong> molto l’emolumento <strong>di</strong> 250 lire<br />
che, preventivamente, era stato deliberato<br />
come equo ed iscritto a bilancio dal consiglio<br />
comunale così da rendere necessario il reperimento<br />
<strong>di</strong> ulteriori fon<strong>di</strong> nelle casse parrocchiali.<br />
27<br />
Una volta portato a compimento, il rinnovamento<br />
del ‘65 fu vagliato criticamente da uno<br />
dei principali estimatori locali del Vittino:<br />
l’organista della chiesa prepositurale <strong>di</strong> Murisengo<br />
Secondo Rolfo. Egli, dopo aver procacciato<br />
negli anni ’40 del secolo la manodopera<br />
dell’organaro aronese Felice Silvera<br />
per la costruzione del suo nuovo organo in<br />
Sant’Antonio Abate, aveva esperito <strong>di</strong>rettamente<br />
nel 1857 l’arte del figlio <strong>di</strong> Melchiorre<br />
Vittino, 28 <strong>di</strong>venendone un fervido mentore,<br />
come si desume dall’accettazione del compito<br />
censorio penanghese.<br />
È infatti <strong>di</strong>fficile ritenere casuale la preferenza<br />
che venne accordata al Rolfo in quel frangente<br />
viste la <strong>di</strong>sponibilità e la prossimità territoriale<br />
<strong>di</strong> un organista stimato qual era don<br />
Edoardo Bassi, 29 il sacerdote titolare del Serassi<br />
della chiesa <strong>di</strong> San Francesco in Moncalvo<br />
(che, fra l’altro, era anche uno dei collaudatori<br />
più richiesti della zona, essendo stato<br />
padrino dello strumento Silvera <strong>di</strong> Muri-<br />
25<br />
Devo l’informazione al prof. Alessandro Allemano<br />
che ha curato il rior<strong>di</strong>no e la catalogazione del materiale<br />
archivistico del comune <strong>di</strong> Penango.<br />
26<br />
Cfr. Appen<strong>di</strong>ce, Doc. 6.<br />
27<br />
Ibid., Doc. 5.<br />
28<br />
Arch. Parr. Murisengo, Fald. “Chiesa Parr.”, Cart.<br />
“Organo-Campane”, Capitolazione del 2 settembre<br />
1857:<br />
“Dovrà pure [Giuseppe Vittino] adattarsi ai suggerimenti<br />
dell’attuale organista Sig.r Secondo Rolfo in<br />
tutto ciò che ragionevolmente e secondo le regole della<br />
musica e meccanica dovrà ripararsi o cangiarsi”.<br />
29<br />
Già vice parroco <strong>di</strong> Cuccaro Monferrato, questi intraprese<br />
l’officio organistico nelle chiese moncalvesi<br />
<strong>di</strong> San Francesco e Sant’Antonio nel 1840, <strong>di</strong>venendo<br />
successivamente anche <strong>di</strong>rettore spirituale del ginnasio<br />
citta<strong>di</strong>no (cfr. l’atto <strong>di</strong> congrega del 17 novembre<br />
1840 contenuto in Arch. Parr. Moncalvo, Corrispondenza<br />
parrocchiale 1825-1840, e il verbale del consiglio<br />
comunale <strong>di</strong> Moncalvo del 29 agosto 1862 conservato<br />
in Arch. Comunale Moncalvo, Cart. 45, fasc.<br />
319/bis).<br />
22<br />
sengo 30 e, probabilmente, dei due organi eretti<br />
da Luigi Lingiar<strong>di</strong> per le chiese parrocchiali<br />
<strong>di</strong> Alfiano Natta nel 1845 e <strong>di</strong> Grazzano<br />
Badoglio nel 1860 31 ).<br />
Attuato l’intervento <strong>di</strong> Giuseppe Vittino e ottenuto<br />
il conforto del parere tecnico <strong>di</strong> Rolfo,<br />
l’amministrazione comunale sembrerebbe<br />
non essersi più interessata allo strumento a<br />
canne della chiesa <strong>di</strong> San Grato.<br />
Ma il con<strong>di</strong>zionale è d’obbligo. Logica avrebbe<br />
preteso che, trattandosi <strong>di</strong> stanziamento<br />
occasionale l’esborso municipale del<br />
‘65, le successive spese <strong>di</strong> or<strong>di</strong>naria manutenzione<br />
venissero a ricadere sulla fabbriceria<br />
parrocchiale: ragionamento che i fatti<br />
smentiscono. Fatto salvo, nel 1870,<br />
l’adeguamento sperequativo della retribuzione<br />
annua dell’organista Occhiale, 32 i conti<br />
dell’ente religioso non contengono più alcun<br />
accenno a revisioni, ripuliture o accordature<br />
commissionate all’organo: e questo sino<br />
all’abboccamento ed al conseguente carteggio<br />
del 1897 con Carlo Vegezzi Bossi. Il trapasso<br />
da una realtà pulsante - qual poteva essere<br />
quella della confraternita <strong>di</strong> San Michele<br />
<strong>di</strong> Calliano - ad una più sclerotizzata e fissa -<br />
perché imperniata sull’accompagnamento<br />
delle sole principali festività del calendario<br />
liturgico 33 - fu dunque protetto (e non solo per<br />
l’o<strong>di</strong>erna mancanza <strong>di</strong> documentazione) da<br />
un paio <strong>di</strong> fattori <strong>di</strong> carattere generale che si<br />
riflessero su scala locale: un contesto musicale<br />
attestato su un lessico organistico ormai<br />
30<br />
Arch. Parr. Murisengo Fald. “Chiesa Parr.”, Cart.<br />
“Organo-Campane”, documento del 6 ottobre 1842:<br />
“ La Reggenza <strong>di</strong> Chiesa Parrocchiale […] inteso il<br />
giu<strong>di</strong>zio formatone dal Sig.r D. Bassi Organista <strong>di</strong><br />
Moncalvo, vista la buona qualità de materiali,<br />
l’esatezza osservata nell’or<strong>di</strong>tura degl’ingre<strong>di</strong>enti, ed<br />
appoggiata alla probità, ed onestà del Sig.r Fabbricatore<br />
Felice Silvera, rinunzia alla riserva fatta <strong>di</strong> sottoporre<br />
alla Collodazione l’organo da esso Lui costrutto.”.<br />
31<br />
Cfr. O. MISCHIATI, Repertorio toponomastico dei<br />
cataloghi degli organari italiani 1587-1930, Bologna<br />
1995, pp. 5 e 86.<br />
32<br />
APP, Libro dell’Uscita Uscita della Chiesa Parrocchiale,<br />
c. 53 [1870]:<br />
“£160 per lo Stipen<strong>di</strong>o dell’Organista degli anni 1868<br />
e 1869 fissato a £ 80 all’anno 160”.<br />
33<br />
Ibi, ibi,: cfr. i pagamenti all’imme<strong>di</strong>ato successore<br />
<strong>di</strong> Giovanni Occhiale (retribuito sino al 1886, c. <strong>12</strong>5)<br />
Eugenio Zabagliati nel 1887 (“ nelle feste del SS. Natale<br />
e 40 Ore £ 3”, c. 130) e nel 1888 (“Per aver<br />
suonato l’organo nelle feste <strong>di</strong> Pasqua 2”, c. 145).
canonizzato 34 (non <strong>di</strong>mentichiamo che Giovanni<br />
Occhiale esercitò ininterrottamente le<br />
proprie mansioni musicali per più <strong>di</strong> venticinque<br />
anni) e su una tecnologia organaria<br />
all’apice del suo bioritmo. Che tuttavia <strong>di</strong>etro<br />
la canonizzazione del primo e l’apogeo della<br />
seconda si celassero, dal punto <strong>di</strong> vista storico,<br />
i germi delle rispettive future <strong>di</strong>ssoluzioni<br />
violente sarebbe toccato <strong>di</strong>mostrarlo, <strong>di</strong> lì a<br />
poco, agli adepti <strong>di</strong> uno dei più facinorosi<br />
movimenti della storia musicale europea: il<br />
cecilianesimo.<br />
Fra tra<strong>di</strong>zioni ataviche e velleità riformistiche:<br />
le parrocchie <strong>di</strong> campagna<br />
“nelle quali volsi nei suoni molta vivacità”.<br />
Specchio <strong>di</strong> un contesto storico e culturale<br />
sempre più attento agli stimoli provenienti<br />
dall’estero, le tre tappe istituzionali costituite<br />
dal Regolamento promulgato dalla Sacra<br />
Congregazione dei Riti (1884), dal suo nuovo<br />
Decreto a <strong>di</strong>eci anni <strong>di</strong> <strong>di</strong>stanza (1894) e<br />
dal definitivo Motu Proprio <strong>di</strong> Pio X (1903)<br />
costituirono un imprescin<strong>di</strong>bile corpus normativo<br />
per la musica chiesastica italiana <strong>di</strong><br />
fine Ottocento e per il sostrato umano (organisti,<br />
strumentisti <strong>di</strong> banda, coristi e semplici<br />
u<strong>di</strong>tori) che le ruotava intorno.<br />
Dall’esautoramento del canto fratto, repertorio<br />
<strong>di</strong> spiccata tendenza localistica, alla progressiva<br />
adozione del repertorio gregoriano<br />
normalizzato sul modello paleografico della<br />
scuola <strong>di</strong> Solesmes, 35 dall’estromissione delle<br />
ripetizioni testuali nella musica vocale,<br />
contaminazione fraseologica <strong>di</strong> chiara marca<br />
operistica, all’auspicio <strong>di</strong> esecuzioni polifoniche<br />
dell’epoca palestriniana, dalla condan-<br />
34 Ma rapportato con l’esterno, come <strong>di</strong>mostra<br />
l’affidamento all’organista Ferraris (probabilmente<br />
Giuseppe, il titolare dell’organo della cattedrale <strong>di</strong> <strong>Asti</strong>)<br />
dell’accompagnamento musicale per il solenne<br />
funerale <strong>di</strong> Umberto I nel 1900 (cfr. A. ALLEMANO,<br />
Ancora un secolo al 2000. Uomini e cose <strong>di</strong> cent’anni<br />
fa nel mondo, in Italia, nel Monferrato, Santa Maria <strong>di</strong><br />
Moncalvo 2000, p. 35).<br />
35 Per una sintesi della questione cfr. E. VALENTINI,<br />
Don Giovanni Pagella, il più grande musica salesiano,<br />
in “Salesianum”, 42 (1980), pp. 351-354; G.<br />
CATTIN, La mono<strong>di</strong>a nel Me<strong>di</strong>oevo, [Storia della musica<br />
a cura della Società Italiana <strong>di</strong> Musicologia, 2],<br />
Torino 1991², pp. 117-<strong>12</strong>1.<br />
23<br />
na della tastiera spezzata fra soprani e bassi<br />
degli organi ottocenteschi all’esaltazione acritica<br />
<strong>di</strong> un piano fonico il più possibile “liturgico”<br />
(cioè grigio e stereotipato per fattura<br />
<strong>di</strong> canne e proce<strong>di</strong>mento costruttivo), 36 le tipologie<br />
<strong>di</strong> produzione e recezione musicali<br />
coinvolte dalla riforma ceciliana furono plurime.<br />
Il rovente <strong>di</strong>battito ideologico che si<br />
innescò all’epoca nel nostro paese tra i (pochi)<br />
cultori <strong>di</strong> questo genere più castigato ed i<br />
(molti) fautori della tra<strong>di</strong>zione ottocentesca 37<br />
cagionò, all’atto pratico, un recepimento assai<br />
<strong>di</strong>versificato e geograficamente <strong>di</strong>somogeneo<br />
delle succitate normative ecclesiali 38<br />
(che valide universalmente - persino nello<br />
stesso ambiente clericale - non furono mai,<br />
perlomeno sino al 1925-30).<br />
Le eclatanti anticipazioni che si riscontrarono<br />
nell’ultimo quin<strong>di</strong>cennio dell’Ottocento 39 <strong>di</strong>pesero<br />
essenzialmente, visto lo stato ancor<br />
embrionale del supporto della pubblicistica<br />
partigiana (eccettuato il perio<strong>di</strong>co Musica<br />
Sacra <strong>di</strong> Milano, attivo dal 1877), dal peso<br />
specifico esercitato sia nelle metropoli che<br />
nei piccoli centri <strong>di</strong> campagna da alcune personalità<br />
<strong>di</strong> spicco del movimento ceciliano.<br />
In Piemonte, abiurati gli atavici connubi con<br />
gli autori chiesastici <strong>di</strong> stile operistico, fra i<br />
campioni della <strong>di</strong>vulgazione della nuova estetica<br />
si imposero i salesiani: su tutti il maestro<br />
<strong>di</strong> coro don Giovanni Battista Grosso e il<br />
noto Giuseppe Dogliani, il maestro <strong>di</strong> cappella<br />
dell’oratorio <strong>di</strong> Valdocco che nel 1879 si<br />
era reso promotore <strong>di</strong> un’imponente esecuzione<br />
della Missa Papae Marcelli <strong>di</strong> Gio-<br />
36 Cfr. O. MISCHIATI, Il Concilio <strong>di</strong> Trento e la polifonia<br />
– Una <strong>di</strong>versa proposta <strong>di</strong> lettura e prospettiva<br />
storiografica, in D. CURTI, M. GOZZI (a cura <strong>di</strong>), Musica<br />
e liturgia nella riforma tridentina, catalogo della<br />
mostra (Trento, 23 settembre – 26 novembre 1995),<br />
Trento 1995, pp. 19-29.<br />
37 Cfr. F. ROMITA, Jus musicae liturgicae, Torino<br />
1936, pp. 136-140; G. B. KATSCHTHALER, Storia della<br />
Musica Sacra, (trad. it. <strong>di</strong> P. Guerrini) Torino 1910²,<br />
pp.275-287.<br />
38 Cfr. N. GALLINO, Dal melodramma al cecilianesimo.<br />
Il ricambio della musica liturgica in Piemonte<br />
nella stampa militante fino al Motu Proprio <strong>di</strong> Pio X<br />
(1903), in Tra<strong>di</strong>zione popolare e linguaggio colto<br />
nell’Ottocento e Novecento musicale piemontese, Atti<br />
del convegno (Alessandria 15-16 aprile 1997), Torino<br />
1999 [Il Gridelino, 19], pp. 95-118.<br />
39 È educativo a proposito consultare l’opuscolo <strong>di</strong> G.<br />
TEBALDINI, La musica sacra in Italia, Milano 1893.
vanni Pierluigi da Palestrina. 40 Poiché a Penango<br />
aveva sede un istituto <strong>di</strong> quest’or<strong>di</strong>ne<br />
religioso 41 i cui seminaristi già da tempo curavano<br />
la parte musicale della liturgia parrocchiale,<br />
42 non sorprenderà che il parroco<br />
locale del periodo, don Giuseppe Garavelli,<br />
provocato dalle idee <strong>di</strong> rinnovamento dei seguaci<br />
<strong>di</strong> Don Bosco, avesse domandato il<br />
malleveria del Dogliani per entrare in contatto<br />
con un organaro <strong>di</strong> chiara fama. 43 E non è<br />
altresì motivo <strong>di</strong> stupore che il musicista salesiano<br />
passasse la pratica al torinese Carlo<br />
Vegezzi Bossi, il costruttore che in quel 1897<br />
stava terminando il colossale organo della<br />
chiesa del Sacro Cuore <strong>di</strong> Maria in Torino,<br />
opera simbolo del riformismo organario per i<br />
primigeni cultori <strong>di</strong> Santa Cecilia del capoluogo.<br />
44 Dimostratosi <strong>di</strong>sponibile al lavoro e<br />
pronto ad eventuali trasferte esplorative, fra<br />
Vegezzi Bossi ed il prevosto penanghese si<br />
inaugurò un intenso carteggio culminato nella<br />
redazione da parte del primo del piano fonico<br />
del nuovo strumento a canne. Nonostante<br />
le probabili pressioni dei viciniori salesiani<br />
perché il prospetto presentatogli si concretizzasse<br />
quanto prima, don Garavelli, più per<br />
ragioni pecuniarie che musicali, volle ancora<br />
rifarsi al lume critico <strong>di</strong> un esperto <strong>di</strong> fiducia,<br />
Diodato Tironi da Casorzo, organista delle<br />
chiese parrocchiale e confratriali della vicina<br />
Moncalvo sin dal 1862. 45<br />
Il suo parere, prossimo all’“empietà” reazionaria<br />
per il <strong>di</strong>sarmante realismo <strong>di</strong> cui era intriso,<br />
fu netto: se le <strong>di</strong>fficoltà finanziarie in<br />
40<br />
Cfr. G. BERUTTO, Il Piemonte e la musica 1800-<br />
1984, Torino 1984, pp. 80-81.<br />
41<br />
Sito nel cosiddetto “cascino”, la villa <strong>di</strong> campagna<br />
venduta alla Congregazione dal barone Leonino Sabino<br />
nel 1880: cfr. A. MERLETTO, La figura del Conte<br />
Magnocavalli cit., p. 133.<br />
42<br />
APP, Libro dell’Uscita Uscita della Chiesa Parrocchiale<br />
[1889] c. 145:<br />
“All’organista e Chi[erico] Agnoli per aver suonato<br />
l’organo nella festa <strong>di</strong> Pentecoste 2.00 ”;<br />
p. 146 “ Alli Rev.mi Salesiani per l’organista nella festa<br />
<strong>di</strong> S. Grato 3.00”.<br />
43<br />
Cfr. Appen<strong>di</strong>ce, Doc. 8/a.<br />
44<br />
Si veda l’entusiastico giu<strong>di</strong>zio a proposito <strong>di</strong><br />
quest’organo dato da G. FOSCHINI, La musica<br />
all’esposizione generale italiana <strong>di</strong> Torino 1898, in<br />
“Rivista Musicale Italiana”, V, 4 (1898), pp. 793-798.<br />
45<br />
Arch. Parr. Moncalvo, Compagnia del SS. Sacramento,<br />
Libro degli or<strong>di</strong>nati e delle entrate e delle uscite<br />
1719-1871, c. 270.<br />
24<br />
cui versava la parrocchia <strong>di</strong> Penango avessero<br />
spinto il Vegezzi Bossi a cassare dal progetto<br />
<strong>di</strong> base tre registri <strong>di</strong> concerto (cosa che<br />
egli era pronto a fare 46 ), la tavolozza timbrica<br />
dell’organo <strong>di</strong> Penango avrebbe perso ogni<br />
attrattiva fonica, risultando<br />
“regolare […] per comunità, non già per chiese Par-<br />
rocchiali <strong>di</strong> campagna nelle quali volsi nei suoni molta<br />
vivacità”. 47<br />
Per quanto il culto verso Santa Cecilia fosse<br />
da rinsaldare, tal finalità non era perseguibile<br />
cogli occhi chiusi: ed al clero <strong>di</strong> provincia <strong>di</strong><br />
fine Ottocento ciò era ben noto. Soprattutto<br />
se ad un ancor astratto concetto <strong>di</strong> liturgicità<br />
musicale si fosse dovuta immolare la collegiale<br />
partecipazione dei fedeli ai riti sacri.<br />
Adducendo a scusante il costo eccessivo degli<br />
oneri logistici sussi<strong>di</strong>ari (espe<strong>di</strong>ente retorico<br />
grazie al quale si mettevano al sicuro anche<br />
le abitu<strong>di</strong>ni canore e strumentali in<strong>di</strong>gene),<br />
don Garavelli interruppe le trattative con<br />
Vegezzi Bossi e si volse a sondare le ulteriori<br />
offerte del coevo mercato organario. 48 E il<br />
tentativo <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione fra le norme istituzionali,<br />
la voga secolare e la contingente <strong>di</strong>sponibilità<br />
monetaria gli riuscì. Fra gli artigiani<br />
assuefatti alla novella ortodossia musicale<br />
liturgica, l’attenzione del sacerdote si<br />
46 Cfr. Appen<strong>di</strong>ce, Documento 8/c.<br />
47 Ibi, Documento 8/d.<br />
48 Ricordo che Giuseppe Dogliani, dopo il fallito convegno<br />
con Carlo Vegezzi Bossi, invitò anche<br />
l’organaro lo<strong>di</strong>giano Gaetano Cavalli a formulare una<br />
propria soluzione erettiva per la chiesa parrocchiale <strong>di</strong><br />
San Grato. Tuttavia, il catalogo dei propri organi che<br />
questi fece pervenire a don Garavelli giunse a destinazione<br />
quando la convenzione con Giuseppe Gan<strong>di</strong>ni<br />
era già stata firmata (la lettera del Cavalli, datata 18<br />
<strong>di</strong>cembre 1897, si trova in APP, Carte riguardanti i<br />
Restauri e le decorazioni della Chiesa e relativo Organo<br />
1899).
fissò sul nome <strong>di</strong> Giuseppe Gan<strong>di</strong>ni, organaro<br />
che cominciava a muovere i primi passi<br />
nella <strong>di</strong>ocesi casalese. In capo a meno <strong>di</strong> un<br />
mese, il 6 <strong>di</strong>cembre 1897, le trattative intavolate<br />
furono favorevolmente finalizzate. Allo<br />
stesso prezzo praticato in seconda istanza da<br />
Vegezzi Bossi (£ 2500), il varesotto Gan<strong>di</strong>ni<br />
si impegnò a costruire un organo “liturgico”<br />
dotato <strong>di</strong> una tastiera <strong>di</strong> 58 tasti, <strong>di</strong> una pedaliera<br />
<strong>di</strong> 24 e <strong>di</strong> complessivi quin<strong>di</strong>ci registri,<br />
da cui risultavano però assenti alcuni <strong>di</strong> quelli<br />
che avrebbero tipicizzato la sua attività<br />
monferrina a venire: l’”Unda maris” al<br />
grand’organo, l’“Eufonio”, e il “Concerto<br />
violini” a quello espressivo. 49<br />
Ignoriamo chi fu il collaudatore dell’opera<br />
compiuta, nel 1898: ma ciò non è oltremodo<br />
significativo, visto che quel che più preme è<br />
la <strong>di</strong>namica intellettuale dell’avvenimento.<br />
Agendo d’anticipo sulle istanze che <strong>di</strong> lì a un<br />
lustro sarebbero <strong>di</strong>venute perentori dettami<br />
comportamentali, don Garavelli aderì, sacrificando<br />
il probabile strumento settecentesco<br />
<strong>di</strong> Liborio Grisanti, al movimento ceciliano.<br />
La sventurata per<strong>di</strong>ta con cui si pagò questo<br />
consenso permise tuttavia al nostro <strong>di</strong> preservare<br />
gran parte dell’originario patrimonio<br />
musicale in cui si rispecchiava la sua comunità:<br />
cioè la “molta vivacità” dei brani<br />
d’organo ascoltati in San Grato. In un periodo<br />
privo <strong>di</strong> gran<strong>di</strong> remore storicistiche e ricco<br />
<strong>di</strong> timori socialistici, la personalissima soluzione<br />
penanghese del problema musicale<br />
liturgico funse da stimolo per i credenti locali,<br />
nel sincretismo fra il gusto del passato e<br />
quello del futuro prossimo, 50 ad una sempre<br />
maggior coesione interclassista.<br />
A convincente <strong>di</strong>mostrazione che le epifanie<br />
decentrate del cecilianesimo piemontese degli<br />
albori furono sfruttate più in termini <strong>di</strong><br />
politica sociale che <strong>di</strong> stretta propaganda e-<br />
49 Vd. il progetto <strong>di</strong> riforma presentato per l’organo<br />
Silvera <strong>di</strong> Murisengo nel 1903 (Arch. Parr. Murisengo,<br />
Cart. “Organo”) e il piano fonico del’organo <strong>di</strong><br />
Calliano del 19<strong>12</strong>-3 (P. CAVALLO, Da Grisanti a<br />
Gan<strong>di</strong>ni cit., pp. 34-37).<br />
50 Come <strong>di</strong>mostra APP, Contabilità della Compagnia<br />
<strong>di</strong> S. Grato (s.i.c., ad annum), nel periodo 1893-1910<br />
il circolo della gioventù cattolica <strong>di</strong> Penango fu allietato<br />
annualmente da bande musicali provenienti da<br />
Calliano (nella grande maggioranza dei casi), da<br />
Grazzano, da Zanco e da Tonco.<br />
25<br />
stetica, nella ripulsa (così come ormai non<br />
stava più accadendo fra le penne dei pubblicisti<br />
settari 51 ) <strong>di</strong> ogni estremismo culturale.<br />
Legenda delle sigle utilizzate nel corso<br />
dell’articolo:<br />
Archivio Comunale <strong>di</strong> Penango (ACP)<br />
Archivio Parrocchiale <strong>di</strong> Penango (APP)<br />
51 Cfr., per tutti, TH. GIOVANNINI (pseudonimo <strong>di</strong> G.<br />
TEBALDINI), La riforma della musica sacra in Italia<br />
dopo il decreto ed il regolamento del luglio 1894, in<br />
“Rivista Musicale Italiana”, III, 2 (1896), pp. 329-349.
Appen<strong>di</strong>ce Documentaria<br />
1<br />
APP<br />
1856<br />
Libro Mastro della Reggenza della Chiesa Parrocchiale <strong>di</strong> Penango<br />
[1726 –1763 e 1856-1857, s.i.c.]<br />
[1856]<br />
Pagato per far tingere la cortina dell’organo compreso la fattura e l’occorrente 3,75<br />
2<br />
ACP<br />
1861, maggio 31<br />
Fald. 36 [provv.]<br />
Mandati<br />
[Foglio protocollo accluso<br />
recante data 1861, maggio 2, f. 1 r-v]<br />
Ill.mi Sig.ri<br />
Occhiale Giovanni fu Luigi <strong>di</strong> Penango avendo sino dal principio del mese <strong>di</strong> ottobre 1860 accettato<br />
l’incarico <strong>di</strong> organista della Chiesa Parrocchiale a cui le veniva affidato da questo Municipio<br />
per l’annua gratificazione <strong>di</strong> lire sessanta ricorre per avere il mandato <strong>di</strong> detta somma<br />
obbligandosi <strong>di</strong> continuare in detta qualità sino al compimento dell’annata<br />
E della grazia etc.<br />
L’anno mille ottocento sessantuno ed alli due <strong>di</strong> maggio in Penango<br />
Il consiglio comunale legalmente adunato in prosecuzione dell’or<strong>di</strong>naria sessione <strong>di</strong> primavera<br />
intervennero oltre al sig. Sindaco Cima Lodovico , li Sig.ri Consiglieri Biletta Stefano, Cavallero<br />
Giovanni, Nosenzo Tommaso, Firato Pietro Antonio, Oddone Giuseppe, e Firato Pietro<br />
fu Luigi,<br />
Vista ed esaminata [sic] l’avanti esteso ricorso del sig. Occhiale Giovanni quall’Organista <strong>di</strong><br />
questa Chiesa Parrocchiale<br />
Vista l’imposta fatta nel bilancio 1861 nel Tit. 1 Cat. 8 art. 32 per il detto oggetto in lire sessanta<br />
Il sullodato Consiglio manda rilasciare al detto Occhiale un mandato <strong>di</strong> lire sessanta somma<br />
eguale a quella bilanciata con che sia tenuto a proseguire in detta qualità sino al 1 ottobre p.v.<br />
epoca in cui finisce l’annata […]<br />
3<br />
ACP<br />
1864, novembre 20<br />
Affari <strong>di</strong> culto 1864-1870<br />
Fald. 541.<br />
[Foglio protocollo, 1 r-v]<br />
Verbale del Consiglio Comunale in or<strong>di</strong>ne all’imposta in bilancio 1865 per l’aggiustamento<br />
dell’organo della chiesa Parrocchiale <strong>di</strong> Penango.<br />
26
L’anno mille otto cento sessanta quattro il venti <strong>di</strong> novembre in Penango e nella Casa Comunale.<br />
Il Consiglio Comunale adunato in continuazione dell’or<strong>di</strong>naria sessione <strong>di</strong> autunno, intervennero<br />
oltre al Signor Sindaco Biletta Stefano, li Sig. Consiglieri Ferraris Pietro, Barberis Pietro,<br />
Oddone Giuseppe, Gagliardone Stefano, e Manacorda Maestro Vittorio componenti per tutti il<br />
numero legale siccome in prosecuzione <strong>di</strong> seduta.<br />
Il sindaco espone che ad istanza dei Sig. Consiglieri del Capo luogo venne imposto alla Categoria<br />
decima spese speciali del Titolo primo lire due cento cinquanta sugli intenti del Capo<br />
luogo, per aggiustamento dell’organo esistente in detta chiesa Parrocchiale, e e [sic] richiede<br />
dal presente Consiglio che sia autorizzata la Giunta municipale <strong>di</strong> far eseguire le necessarie<br />
operazioni da persona dell’arte, ben inteso che la spesa non abbia a rilevare oltre all’imposta<br />
per il che si eccita a deliberare.<br />
Il consiglio premessa lettura del sovra esposto e ritenuto che la relativa spesa <strong>di</strong> dette riparazioni<br />
sarebbe stata imposta a carico dei proprietarii del Capo [1v] luogo sull’istanza dei sig.<br />
Consiglieri locali, autorizza la Giunta Municipale a fare eseguire le riparazioni allo stesso organo<br />
da persona dell’arte; e rilasciare al medesimo quanto la Giunta riconoscerà essere dovuto<br />
per dette opere, ben inteso che la spesa non abbia ad eccedere quella stabilita in bilancio <strong>di</strong> lire<br />
due cento cinquanta.<br />
E messo il presente alla votazione per appello nominale venne approvato con tutti i voti favorevoli<br />
in numero <strong>di</strong> sei, e così nessun contrario.<br />
E precedente lettura e conferma si è sottoscritto il Sindaco, Assessore anziano e Segretaro.<br />
4<br />
APP<br />
1865, <strong>gennaio</strong> 13-15<br />
Libro dell’Uscita<br />
Uscita della Chiesa Parrocchiale<br />
[c. 33]<br />
id [<strong>gennaio</strong>] 13 Pagato a Giavarino <strong>di</strong> Calliano per la condotta delle canne dell’Organo da<br />
<strong>Asti</strong> 3.50<br />
id 15 Pagato al Giovanetto Pastore che servì per giorni <strong>12</strong> l’organaro 6.60<br />
5<br />
ACP<br />
1865, aprile 15<br />
Mandati<br />
Fald. 40 [provv.]<br />
[Verbale <strong>di</strong> adunanza della giunta municipale]<br />
L’anno mille ottocento sessanta cinque alli quindeci <strong>di</strong> Aprile in Penango e nella sala delle<br />
Congreghe Consolari.<br />
Si è adunata precedente avviso in iscritto la Giunta Municipale <strong>di</strong> Penango sotto la presidenza<br />
del Sig. Gagliardone Stefano Sindaco, e nelle persone delli signori Assessori Occhiale Giovanni<br />
con l’assistenza del Segretario<br />
Visto il verbale <strong>di</strong> questo Consiglio in data 20 novembre ultimo col quale sarebbe stato deliberato<br />
l’aggiustamento dell’organo <strong>di</strong> questa Chiesa Parrocchiale, come pure risulta autorizzata<br />
la presente Giunta <strong>di</strong> far eseguire le riparazioni da persona dell’arte, con che però la spesa non<br />
avesse a rilevare oltre a lire due cento cinquanta come da imposta fatta in bilancio 1865 categoria<br />
decima contabilità speciale;<br />
27
Visto che le riparazioni eseguite al detto organo dal Sig Vittino Giuseppe fabbricatore <strong>di</strong> organi<br />
della città <strong>di</strong> <strong>Asti</strong> avrebbe oltrepassato <strong>di</strong> lungo della somma imposta, e che l’eccedenza<br />
sarebbe stata pagata con red<strong>di</strong>ti proprii della fabbriceria <strong>di</strong> detta Chiesa<br />
Risultando che le riparazioni sarebbero state eseguite lodevolmente come risulta da visita fatta<br />
seguire dal Sig Organista Rolfo <strong>di</strong> Murisengo.<br />
La Giunta a mente del verbale avanti citato <strong>di</strong> questo Consiglio Comunale 20 9mbre manda<br />
rilasciarsi al predetto Sig Vittino fabbricatore un mandato <strong>di</strong> dette lire duecento cinquanta da<br />
prelevarsi al Tit.1 Cat. 10 art. 40.<br />
E precedente lettura si è sottoscritta […]<br />
6<br />
APP<br />
1865, giugno 7<br />
Libro dell’Uscita<br />
Uscita della Chiesa Parrocchiale<br />
[c. 33]<br />
Giugno 7 A Corrado Stifano Falegname per la pedalliera dell’organo 10<br />
7<br />
APP<br />
1873<br />
Risposte a quesiti proposti dall’Ill.mo e Rev.mo Vescovo <strong>di</strong> Casale in precedenza alla visita<br />
pastorale nella parrocchia <strong>di</strong> Penango Diocesi <strong>di</strong> Casale 1873<br />
[c. 5]<br />
26 Organo: se vi sia e in quale stato si trovi<br />
26 Vi è organo ristorato or son quattro anni [sic] a spese del Comune, a richiesta dei Fabbricieri<br />
della Chiesa che n’è la proprietaria: è l’antico organo della Chiesa <strong>di</strong> Calliano.<br />
8<br />
APP<br />
Carte riguardanti i Restauri e le decorazioni della Chiesa e relativo Organo 1899<br />
[Volume <strong>di</strong> carte rilegate]<br />
8a<br />
1897, ottobre 21<br />
Lettera <strong>di</strong> Carlo Vegezzi Bossi all’arciprete Giuseppe Garavelli <strong>di</strong> Penango<br />
[minuta, r-v]<br />
Rev.mo Signor Prevosto,<br />
Di questi giorni l’egregio maestro Dogliani venne da me per riferirmi che l’incarico <strong>di</strong> V. S.<br />
Rev.ma m’invita a presentare il progetto per il nuovo rogano da costruirsi nella nuova Chiesa<br />
<strong>di</strong> Penango.<br />
Siccome mi <strong>di</strong>sse che la Chiesa non può <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> Forte spesa così cercherò <strong>di</strong> fare quanto è<br />
più possibile artistico colla minor spesa.<br />
Sabbato [sic] 23 cor. verrò costì oppure manderò [1v] mio incaricato per la presentazione [del]<br />
progetto e, se del caso per la firma del contratto. Voglio sperare si potrà conchiudere poiché<br />
28
per parte mia nulla tralascerò per cooperare a fornir a V. S. Rev.ma un buon strumento col<br />
minor prezzo. Sarò ben lieto se mi sarà dato <strong>di</strong> collocare in Penango una mia opera fiducioso<br />
che che la buona riuscita attirerà altre or<strong>di</strong>nazioni e così aprirmi una nuova strada. In attesa,<br />
m’è caro sottoscrivermi della S. V. Rev.ma<br />
Devot.mo<br />
C. Vegezzi Bossi<br />
8b<br />
1897, ottobre 25<br />
Comunicazione <strong>di</strong> Carlo Vegezzi Bossi a don Giuseppe Garavelli<br />
[cartolina postale]<br />
Torino, 25 ottobre 97<br />
Rev.mo Signore,<br />
Contrariamente a quanto <strong>di</strong>ssi nella mia del 21- non mi sarà possibile venire costì che per la<br />
domenica 31 corr. Spero questo ritardo non <strong>di</strong>sturberà V.S. Rev.ma; in caso contrario mi favorisca<br />
un cenno <strong>di</strong> riscontro a questa mia, che vedrò <strong>di</strong> regolarmi secondo il suo desiderio. Colla<br />
massima stima, e ossequio, mi sottoscrivo della Sig.ria V. Rev.ma<br />
Obbligat.mo C. V. Bossi<br />
8c<br />
1897, novembre 5<br />
Lettera <strong>di</strong> Carlo Vegezzi Bossi a don Giuseppe Garavelli a corredo del piano fonico compilato<br />
dal primo.<br />
[Foglio]<br />
Torino 5 Novembre 1897<br />
Rev.mo Signore,<br />
Mi ricresce che la S. V. Rev.ma non possa <strong>di</strong>sporre per un organo <strong>di</strong> £ 3300. Pazienza, lo faremo<br />
ridotto a £ 2500 e ugualmente buono. Resta inteso che lo adatteremo alla cassa ora esistente.<br />
Benché V. S. Rev.ma abbia detto al mio Sig. Consoli che non vuol prendere la spesa <strong>di</strong><br />
trasporto a suo carico, la prego però <strong>di</strong> accettarla poiché su questo prezzo non posso proprio<br />
sobbarcarmi a questa spesa. In caso però non voglia proprio occuparsene allora lo prego <strong>di</strong><br />
aggiungere alla somma £ 100, ed in questo caso m’incarico <strong>di</strong> darlo alla stazione <strong>di</strong> Penango<br />
oppure alla più vicina in caso non vi siano trasporti alla piccola in quella <strong>di</strong> Penango. V. S.<br />
Rev.ma non avrà che a mandare due carri pel trasporto dalla stazione alla chiesa. Va bene ?<br />
Creda che per la S. V. Rev.ma faccio un vero prezzo <strong>di</strong> favore epperciò spero che mi farà poi<br />
il pagamento a saldo a termine non volendo <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> alcuna somma all’atto del contratto. In<br />
attesa d’un cenno <strong>di</strong> riscontro, tanto per mia norma ringrazio per il cortese invito fattomi e per<br />
le cortesie usate al mio sig. Consoli.<br />
Colla massima stima mi sottoscrivo della S. V. Rev.ma<br />
Devot.mo Carlo Vegezzi Bossi<br />
8d<br />
1897, novembre 11<br />
Brutta copia <strong>di</strong> una lettera <strong>di</strong> Don Giovanni Garavelli a Carlo Vegezzi Bossi<br />
[minuta, r-v]<br />
29
Penango 11 Novembre 97<br />
Stim.mo Signore,<br />
Come ricevetti la pregiatissima sua lettera del 5 corrente Novembre, coll’unito progetto per<br />
Organo a questa nostra Chiesa Parrocchiale, mi rivolsi al Signor Tirone valente organista della<br />
qui vicina Città <strong>di</strong> Moncalvo, il quale oggi ebbe la gentilezza <strong>di</strong> rispondermi che l’organo <strong>di</strong>minuito<br />
dei registri 8-9 e 11 riuscirebbe bensì regolare ed adatto per una comunità, non già per<br />
una chiesa Parrocchiale <strong>di</strong> campagna nelle quali volsi nei suoni molta vivacità. Ora non potendo<br />
io sobbarcarmi alla spesa, <strong>di</strong> cui nel progetto, senza la <strong>di</strong>minuzione dei tre predetti Registri,<br />
mi toccherà per ora rinunziare al piacere <strong>di</strong> affidare alla S. V. il proggetto lavoro [v] tanto<br />
più che ella vorrebbe a mio carico la condotta dei materiali e non concederebbe mora <strong>di</strong> sorta.<br />
Dolente <strong>di</strong> non potere conchiudere le trattative la riverisco e saluto <strong>di</strong> cuore e<br />
Mi proffesso<br />
Dev. Servo<br />
8e<br />
1897, <strong>di</strong>cembre 3<br />
Progetto <strong>di</strong> Giuseppe Gan<strong>di</strong>ni per il rinnovamento dell’organo<br />
[foglio]<br />
Progetto per la custruzione [sic] <strong>di</strong> un nuovo organo da 8° pie<strong>di</strong> Reali principiando dal Do<br />
grave cromaticamente al Fa [sic] sopraguto da tasti 58 per la chiesa parochiale <strong>di</strong> Penango<br />
Parte Meccanica<br />
1° Somiere costruito a nuovo sistema<br />
2° Vari Somieri per la basseria,<br />
3° Pedagliera da 24 pedali<br />
4° Elegante tastiera d’osso bianco coi <strong>di</strong>esis d’ebbano massiccio<br />
5° Registrazione a bottoni sopra la Tastiera<br />
6° Macchina pneomatica per alzare i mantici da gire a manubrio e suficienti<br />
7° Terzo piede <strong>di</strong>stacco del tasto<br />
8 pedale per il solo ripieno<br />
9 Pedale per il mezzo forte<br />
10 Pedaletti per introdurre vari registri <strong>di</strong> concerto senza staccare le mani dalla tastiera<br />
11 La meccanica e costruita tutto a nuovo sistema, pronta agile e silenziosa<br />
Parte Fonica Ripieno<br />
1° Principale da 8° Bassi e Soprani 58 stagno<br />
2° Principale da 8° 2° Bassi e Soprani 58 stagno misto<br />
3° Ottava Bassi e Soprani 58 “”<br />
4° Decima quinta 58 “”<br />
5° Quattro file <strong>di</strong> ripieno 252 “”<br />
Registri <strong>di</strong> Concerto<br />
1° Flauto da 8° pie<strong>di</strong> Soprani 34 “”<br />
2° Flauto da 4° pie<strong>di</strong> Bassi e Soprani 58 “”<br />
3° Viola da 8° pie<strong>di</strong> Bassi e Soprani principiando al 2° Do il rimanente servirsene del Principale<br />
da 8°, questo si fa per non avere suficiente [sic] posto 58 “”<br />
4 Violino da Concerto, Soprani da 8° pie<strong>di</strong> 34 “”<br />
5 Fagotto Bassi e Tromba soprani da 8° p. 58 “”<br />
Registi [sic] alla pedagliera<br />
1° Contrabassi da 16 pie<strong>di</strong> 24 legno<br />
30
2° Ottave <strong>di</strong> rinforso [sic] da 8° pie<strong>di</strong> 24 “”<br />
Da eseguire questo progetto godendo le Canne <strong>di</strong> faciata [sic] esistente, e retirando la materia<br />
dell’organo vecchio sarebbe la somma <strong>di</strong> £ire 2500, Duemila e cinque cento. A questo prezzo<br />
resta a carico dei signori comitenti il trasporto del materiale dalla stazione più vicina al paese,<br />
il tiramantice per tutto il tempo della cordatura, il mantenimento e la loggio [sic] per il fabbricatore;<br />
il rimanente le altre spese sono tutte a mio carico.<br />
Sto garante per <strong>di</strong>eci anni, salvo inconvenienti che non derivano dalla costruzione, mi sottopongo<br />
al colaudo <strong>di</strong> qualunque maestro <strong>di</strong> musica perito inteligente dell’arte, per il pagamento<br />
in due rate la prima a opera ultimata e colaudata la segonda entro l’anno successivo.<br />
Penango 3 Dicembre 1897<br />
Il Fabb.re Giuseppe Gan<strong>di</strong>ni<br />
Giuseppe Garavelli Prevosto<br />
8f<br />
1897, Dicembre 6<br />
Scrittura privata per il rinnovo dell’organo fra Giuseppe Gan<strong>di</strong>ni e Don Giuseppe Garavelli<br />
[Foglio protocollo, 1 r-v]<br />
Per la presente privata scrittura rimane inteso che il Sig. Gan<strong>di</strong>ni Giuseppe <strong>di</strong> Varese fabbricherà<br />
per la Chiesa Parrocchiale <strong>di</strong> Penango un organo secondo il progetto del prefato Gan<strong>di</strong>ni<br />
consegnato al parroco <strong>di</strong> Penango D. Giuseppe Garavelli, portante la data 3 Dicembre 1897.<br />
La fabbricazione dell’organo deve essere fatta secondo le regole dell’arte, adatta all’orchestra<br />
e alla cassa esistente nella detta Chiesa e colle mo<strong>di</strong>ficazioni suggerite dal Sig. Maestro Tironi.<br />
Per questa fabbricazione e per le griglie occorrenti per la Basseria e per tutti i lavori in legno,<br />
ferro ed altro, occorrenti all’impianto dell’organo, il Parroco corrisponde al prefato Sig.<br />
Gan<strong>di</strong>ni lire duemilacinquecento (2500) da pagarsi in due rate la prima appena ultimato e collaudato<br />
il lavoro, la seconda entro l’anno successivo. Il detto lavoro deve essere finito e collodato<br />
per il 31 Marzo p. venturo 1898. Il Gan<strong>di</strong>ni garantisce il suo lavoro cioè [v] l’organo per<br />
anni <strong>di</strong>eci, salvo gli inconvenienti che non derivano dalla costruzione.<br />
Il parroco d’altronde corrisponderà al solo fabbricatore Sig. Gan<strong>di</strong>ni l’alloggio e il vitto nel<br />
tempo dell’impianto, più procurerà al fabbricatore una persona a tirare i mantici. Il materiale è<br />
a carico del Sig. Gan<strong>di</strong>ni. La condotta dell’organo è a carico del Sig. Gan<strong>di</strong>ni da Varese a<br />
Moncalvo, e del parroco da Moncalvo a Penango.<br />
Penango 6 Dicembre 1897<br />
Giuseppe Garavelli Arciprete<br />
Gan<strong>di</strong>ni Giuseppe<br />
Sac. D. Giuseppe Milano parroco <strong>di</strong> Cioccaro – teste-<br />
Quirino Felice teste<br />
31
Corrado Camandone<br />
VITALISMO IMPLICITO: LINEAMENTI DI UNA FILOSOFIA DELLA VITA<br />
(terza parte)<br />
(Le precedenti puntate sono state pubblicate<br />
sui numeri 10 e 11)<br />
Capitolo settimo - Vita arte e lavoro<br />
L’arte, suono o segno, cioè musica, pittura,<br />
scultura, architettura, danza è una manifestazione<br />
della vita. L’artista è colui che<br />
ama e comunica agli altri il suo amore.<br />
La vita non nasce dalla musica, ma la musica<br />
dalla vita. Tutte le arti sono emanazioni,<br />
espansioni, rappresentazioni della vita.<br />
Possono descrivere, imitare, commentare,<br />
interpretare la natura e l’uomo stesso, nella<br />
sua realtà fisica, spirituale, sentimentale,<br />
subcosciente. Oggetto dell’arte è la vita;<br />
fine dell’arte è la vita stessa, mo<strong>di</strong>ficata,<br />
arricchita, nobilitata.<br />
Le prime opere d’arte figurativa della preistoria,<br />
nel paleolitico superiore, rappresentano<br />
uomini e animali. Per millenni, dai<br />
Sumeri, agli Egizi, ai Greci, l’arte ha rappresentato<br />
la vita. Tutte le correnti <strong>di</strong> arte<br />
non figurativa sono proiezioni della vita<br />
subcosciente.<br />
L’architettura domestica ha il fine <strong>di</strong> proteggere<br />
la vita nel modo migliore. A questo<br />
fine mirano le continue innovazioni tecniche,<br />
antisismiche, antimagnetiche, antiacustiche<br />
e i vari servizi interni. L’architettura<br />
pubblica, come arte e stile è proiezione<br />
dell’ideatore e come destinazione è opera a<br />
servizio della vita <strong>di</strong> aggregazione, necessaria<br />
per la formazione della società e lo<br />
sviluppo armonico della persona umana.<br />
Anche la musica è manifestazione vitale <strong>di</strong><br />
un particolare talento che descrive e commenta<br />
la natura o le passioni umane, a livello<br />
cosciente o inconscio.<br />
32<br />
Le arti minori e le arti applicate hanno lo<br />
stesso scopo: dare forma bella ad ambienti<br />
e oggetti utili alla vita umana, nelle sue esigenze<br />
fisiche, sentimentali, simboliche.<br />
Una vetrata, un quadro, una se<strong>di</strong>a, una<br />
ban<strong>di</strong>era, un anello rispondono ad esigenze<br />
vitali.<br />
Il lavoro, in quanto azione, è<br />
un’emanazione della vita <strong>di</strong> un soggetto<br />
autocosciente e libero che potenzia se stesso<br />
o altro da sé. I rapporti tra vita e lavoro<br />
sono strettissimi in quanto nessun lavoro è<br />
possibile senza la vita e tutti i lavori, a ben<br />
riflettere, hanno lo scopo più o meno imme<strong>di</strong>ato<br />
<strong>di</strong> conservare, proteggere, migliorare<br />
la vita. Al limite, questo scopo è perseguito<br />
anche quando il derubato uccide il<br />
ladro, o il ladro uccide il carabiniere per<br />
conservare la propria vita. La liceità o meno<br />
<strong>di</strong> queste azioni <strong>di</strong>pende dalle circostanze<br />
che devono essere valutate in sede morale<br />
e legale.<br />
Il caso in cui si toglie la vita a un altro,<br />
senza che la propria sia in pericolo, (es.<br />
l’infermiere che sopprime i malati gravi<br />
inguaribili) rientra certamente tra le azioni<br />
non autentiche, perché non hanno il fine <strong>di</strong><br />
conservare la vita. Ovviamente, per la stessa<br />
ragione, tali azioni non possono essere<br />
imposte per legge, in quanto ogni legge<br />
deve avere un minimo contenuto etico, nel<br />
quale è necessariamente incluso il rispetto<br />
della vita. Quin<strong>di</strong> sono illegittime tutte le<br />
leggi razziste, come quelle che hanno provocato<br />
l’olocausto.<br />
Anche nel mondo vegetale si può osservare<br />
un coor<strong>di</strong>namento delle leggi naturali al fine<br />
<strong>di</strong> conservare la vita. Le ra<strong>di</strong>ci assorbo-
no gli alimenti, i tronchi e i rami li portano<br />
alle foglie, ai fiori, ai frutti, destinati a uomini<br />
e animali; poi il seme prepara future<br />
piante. Pure nel regno animale si osserva il<br />
rispetto <strong>di</strong> questa legge: dalla caccia, agli<br />
amori, alla cura della prole, tutto è <strong>di</strong>retto<br />
alla conservazione della vita nella specie.<br />
Basta una breve riflessione per comprendere<br />
che quasi tutte le attività umane sono finalizzate<br />
alla conservazione della vita:<br />
l’agricoltura, l’e<strong>di</strong>lizia, il commercio,<br />
l’industria, la scuola, la me<strong>di</strong>cina, i mezzi<br />
<strong>di</strong> comunicazione, le leggi, i tribunali, le<br />
prigioni, la <strong>di</strong>fesa, l’arte, la religione hanno<br />
nella loro ideologia e in tutti i particolari<br />
delle loro strutture la concezione del vitalismo<br />
implicito: cioè riconoscono il valore<br />
fondamentale della vita, anche senza averlo<br />
<strong>di</strong>chiarato esplicitamente, perché norma<br />
fondamentale del senso comune. Questo<br />
vitalismo implicito, <strong>di</strong> fatto applicato in<br />
molti settori della vita sociale, è bene che<br />
<strong>di</strong>venti esplicito e sia esteso anche a quei<br />
settori che lo ignorano o lo <strong>di</strong>sattendono,<br />
con grave danno della società.<br />
Poiché il lavoro è emanazione della vita<br />
che perfeziona se stessa o altro da sé,<br />
l’assenza del lavoro priva la vita della sua<br />
espansione, riduce la sua funzionalità fino<br />
a portarla alla morte. Infatti chi in carcere è<br />
condannato all’inerzia, può subire<br />
un’involuzione della personalità fino<br />
all’abulia. Molti <strong>di</strong>soccupati o neopensionati<br />
cadono in depressione. La <strong>di</strong>soccupazione<br />
è un problema sociale e politico<br />
mon<strong>di</strong>ale, poiché il lavoro è effetto e causa<br />
della vita.<br />
Secondo il nostro punto <strong>di</strong> vista è erronea<br />
la concezione del lavoro per il lavoro, cioè<br />
che il lavoro è fine a se stesso. Quasi tutti i<br />
lavori richiedono fatica e sofferenza; anche<br />
il lavoro artistico sovente è associato alle<br />
sofferenze della ricerca e della <strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong><br />
raggiungere la perfezione voluta<br />
dall’artista. Ma ogni sofferenza esige una<br />
giustificazione che il lavoro per il lavoro<br />
non può dare.<br />
Anche la concezione del lavoro per il solo<br />
profitto è erronea, perché può portare alle<br />
conseguenze <strong>di</strong> un <strong>di</strong>sumano sfruttamento<br />
dei lavoratori e <strong>di</strong> tutti gli acquirenti dei<br />
33<br />
prodotti, venduti a prezzi superiori al loro<br />
valore reale.<br />
Per concludere: tutte le leggi riguardanti<br />
l’arte e il lavoro, per essere norme positive,<br />
legittime, devono rispettare il principio del<br />
vitalismo implicito o esplicito.<br />
Capitolo ottavo - Vita scienza e tecnica<br />
La scienza è conoscenza e come tale è inconcepibile<br />
senza la vita. Che la vita sia<br />
fonte e stimolo della speculazione è stato<br />
<strong>di</strong>mostrato nel capitolo secondo <strong>di</strong> questo<br />
saggio.<br />
Il termine “scienza”, il cui significato si è<br />
arricchito col passare del tempo, comprende<br />
tutti i rami dello scibile umano, che<br />
vanno dalla più semplice sensazione alla<br />
più astratta speculazione. La vita è il fondamento<br />
della scienza, intesa come attività<br />
del soggetto conoscente, ma lo è anche nel<br />
senso che, <strong>di</strong>rettamente o in<strong>di</strong>rettamente, la<br />
vita è oggetto unico della scienza. Anche la<br />
scienza per la scienza o la scienza per il<br />
profitto, in ultima analisi, si risolvono in<br />
scienza della vita e per la vita.<br />
Quella che in un certo momento storico<br />
può essere definita scienza per la scienza,<br />
in un periodo successivo può portare a scoperte<br />
con fini pratici a servizio della vita.<br />
La scienza astrofisica e astronautica potrebbe<br />
permettere in un futuro lontano il<br />
trasferimento del genere umano in altri<br />
corpi celesti, se le mutate con<strong>di</strong>zioni sulla<br />
terra fossero incompatibili con la vita umana.<br />
Nell’ipotesi che la scienza per la scienza<br />
non possa tradursi in scienza applicata, resta<br />
pur sempre un’attività che arricchisce la<br />
conoscenza, quin<strong>di</strong> la vita, <strong>di</strong> chi ad essa si<br />
de<strong>di</strong>ca.<br />
Il profitto non può essere l’ultimo effetto<br />
della scienza, perché esso è necessariamente<br />
una realtà nuova che sfocia nella società<br />
e produce effetti a catena. È vero che il<br />
profitto, come ogni altra attività umana,<br />
può essere destinato a <strong>di</strong>struggere la vita,<br />
ma tale comportamento è conseguenza <strong>di</strong><br />
una pazzia più o meno lucida, incompatibile<br />
col comune buon senso.<br />
Tutti i rami della scienza: dottrina della<br />
scienza, filosofia della scienza, scienza giu-
i<strong>di</strong>ca, scienza normativa, scienza sperimentale,<br />
scienza critica, scienza applicata,<br />
scienza morale, scienza positiva, scienza<br />
sociale, sono autentiche, positive e legittime<br />
se e in quanto riconoscono la posizione<br />
prioritaria del valore vita.<br />
Per quanto riguarda i rapporti tra vita e<br />
tecnica si può fare un <strong>di</strong>scorso analogo. La<br />
tecnica è l’impiego <strong>di</strong> strumenti e proce<strong>di</strong>menti<br />
specifici per la maggiore e più facile<br />
esecuzione <strong>di</strong> qualsiasi opera, sia nel campo<br />
materiale che in quello speculativo. La<br />
tecnica è autentica e legittima solo e in<br />
quanto è ispirata al più grande rispetto della<br />
vita. La concezione vitalistica esige che<br />
la tecnica, nei fini che si propone e nei<br />
mezzi che usa, rispetti il valore vita in tutte<br />
le sue forme. A questo principio devono<br />
ispirarsi tutte le leggi relative a sanità, alimentazione,<br />
urbanistica, e<strong>di</strong>lizia, comunicazioni,<br />
inquinamento, astronautica, biogenetica,<br />
informatica e tutti i settori in cui<br />
l’uomo produce dei beni o fruisce <strong>di</strong> essi.<br />
In molti settori continuamente emergenti<br />
dalle nuove tecniche, mancano leggi in <strong>di</strong>fesa<br />
della vita.<br />
Capitolo nono - Vita società e politica<br />
È evidente che la società è un insieme <strong>di</strong><br />
esseri viventi in relazione tra <strong>di</strong> loro. In un<br />
certo senso si può parlare <strong>di</strong> società anche<br />
riguardo al regno vegetale e ancor più riguardo<br />
al regno animale.<br />
Limitando la nostra considerazione alla società<br />
umana, notiamo che la società è fondata<br />
sulla vita, e a sua volta la vita sboccia<br />
in seno alla società. È autentica la società<br />
che protegge la sua sorgente.<br />
Non è nostro compito qui analizzare i<br />
complessi problemi circa la natura e le finalità<br />
della società. Basti ricordare che,<br />
34<br />
sulla scorta <strong>di</strong> Aristotele e <strong>di</strong> S. Tommaso,<br />
una legge naturale e un <strong>di</strong>ritto naturale rendono<br />
possibile la convivenza sociale.<br />
“L’uomo che si ritiene autosufficiente o è<br />
un animale bruto o un <strong>di</strong>o” (Aristotele).<br />
L’uomo è per natura un essere che ha bisogno<br />
degli altri: dalla famiglia riceve<br />
l’essere, dalla società ha <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> avere il<br />
benessere. Questo benessere è autentico se<br />
rispetta la vita e la natura dell’uomo, che<br />
ha l’esigenza fondamentale <strong>di</strong> godere della<br />
libertà. Ma poiché questa esigenza è <strong>di</strong> tanti<br />
in<strong>di</strong>vidui, ecco la necessità <strong>di</strong> una legge e<br />
<strong>di</strong> un’autorità. È civile una legge e<br />
un’autorità che non emanano leggi contro<br />
la vita, cioè leggi che autorizzano l’aborto,<br />
la <strong>di</strong>struzione <strong>di</strong> embrioni, l’eutanasia, la<br />
pena <strong>di</strong> morte e certe manipolazioni genetiche.<br />
Società e politica sono intimamente<br />
compenetrate poiché una società civile è<br />
tale se regolata da leggi come quelle descritte<br />
nel capitolo quarto, e retta da un legittimo<br />
governo. L’attività politica che crea<br />
i parlamenti e i governi, è autentica e positiva<br />
se è ispirata agli stessi valori riconosciuti<br />
e rispettati da una sana società, come<br />
è stata sopra delineata.<br />
Stretti e complessi i rapporti tra legge, politica<br />
e morale. Le posizioni dei politologi<br />
sono <strong>di</strong>verse: alcuni sostengono l’assoluta<br />
estraneità tra politica ed etica; altri ritengono<br />
che vi sia un legame inscin<strong>di</strong>bile tra politica<br />
ed etica. Il Croce, nella sua opera<br />
Storiografia e idealità morale, afferma: “E<br />
si vuole asserire l’assoluto <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> deroga<br />
alle leggi morali per la politica e la «ragion<br />
<strong>di</strong> Stato», perché mai e poi mai si dovrà<br />
consentire che la moralità conceda <strong>di</strong><br />
fare quel che la coscienza, cioè essa stessa,<br />
<strong>di</strong>chiara che non è da fare a nessun patto”.<br />
Ma una coscienza informata e ben formata<br />
non può non apprezzare la vita.
CURIOSITÀ<br />
TUNNEL SI, TUNNEL NO<br />
(Le proposte <strong>di</strong> don Bolla)<br />
Dalla metà degli anni ’40 e per un bel decennio<br />
la questione della costruzione <strong>di</strong> un<br />
tunnel sotto la collina <strong>di</strong> San Francesco per<br />
deviare dal centro abitato il traffico della<br />
statale <strong>Asti</strong> - Casale fu tema <strong>di</strong> <strong>di</strong>scussione<br />
e polemica ricorrente in Moncalvo.<br />
Anche il bollettino parrocchiale “La buona<br />
parola” entra nel <strong>di</strong>battito: dal numero 9-10<br />
del settembre - ottobre 1950 riportiamo -<br />
35<br />
mantenendone anche l’impostazione grafica<br />
- un intervento che riba<strong>di</strong>sce le posizioni<br />
del parroco <strong>di</strong> allora, mons. Giuseppe Bolla,<br />
sempre attento non solo ai problemi spirituali,<br />
ma anche alle istanze materiali dei<br />
suoi parrocchiani.<br />
Si ringrazia Rita Marzano, che ha cortesemente<br />
fornito alcuni numeri dell’ormai<br />
prezioso bollettino.<br />
“La spinosa questione è ritornata alla ribalta con probabilità più decisive dall’intervento che il<br />
governo ha impegnato.<br />
Sulle labbra della gente fioriscono con contrastante insistenza queste <strong>di</strong>verse aspirazioni:<br />
1) - Utilizzare lo stradale della Valle Scura per Grazzano, con sistemazione <strong>di</strong> due gran<strong>di</strong><br />
curve, una nell’incrocio con la salita per S. Maria, e l’altra nell’unione con la provinciale a fondo<br />
Corso Umberto.<br />
2) - La già progettata <strong>di</strong>rettissima <strong>Asti</strong> - Moncalvo -Stazione, che evita tutte le salite.<br />
3) - Unire la salita dal tirasegno alla cascina Madonnina con brevissimo tunnel, arrivando alla<br />
provinciale per <strong>Asti</strong> nell’incrocio, della strada <strong>di</strong> Grazzano con Corso Umberto.<br />
4) - Supposta la necessità o la decisione <strong>di</strong> attuare un tunnel:<br />
a) tenendo presente che non deve funzionare da stradale nazionale il Corso Umberto,<br />
perchè troppo pericolosamente contornato <strong>di</strong> abitazioni e frequentatissimo <strong>di</strong> bambini e <strong>di</strong><br />
pedoni per lo Stabilimento dell’AMSA.;<br />
b) che già per errore precedente e cioè nella costruzione del tronco ferroviario Ponzano - Castell’Alfero<br />
la nostra città ebbe il danno irreparabile <strong>di</strong> doversi estendere a Nord invece che<br />
nel magnifico versante Sud (valletta e filanda).<br />
c) che è doveroso far ogni sforzo per conciliare realisticamente in questa occasione e con<br />
sguardo all’avvenire i maggiori vantaggi citta<strong>di</strong>ni con la soluzione <strong>di</strong> questa correzione stradale.<br />
5) - Si propone a <strong>di</strong>scussione un nuovo stradale che <strong>di</strong>staccandosi dalla provinciale al principio<br />
della salita nei pressi della ex fornace, formi una nuova strada periferica che passando tra<br />
lo Stabilimento AMSA e la Distilleria, prosegua fino all’altezza da costruire una grande curva<br />
a 45 gra<strong>di</strong> ed entri nel tunnel che raggiungerà il tracciato precedentemente stabilito dal retro<br />
del garage Bianco fino al tirasegno.<br />
Così Moncalvo, che è sempre stata priva <strong>di</strong> un’area fabbricativa. potrebbe salutarmente ampliarsi<br />
nel versante Sud, la parte sua più salubre e meglio esposta al sole. In regime democratico<br />
non è spiegabile che la popolazione Moncalvese debba restare estranea nelle varie<br />
fasi <strong>di</strong> preparazione e <strong>di</strong> criteri <strong>di</strong> scelta della forma e della località <strong>di</strong> un’opera così importante<br />
e duratura, in relazione appunto agli interessi citta<strong>di</strong>ni presenti ma precipuamente futuri.<br />
Invochiamo dunque che, nel costume corrente in paesi veramente democratici, la rappresentanza<br />
più atta a riflessioni e ragionamenti, libera da interessi particolaristici e da partito preso,<br />
sia invitata con sollecitu<strong>di</strong>ne dal Comune a <strong>di</strong>scutere ed accordarsi sul progetto che sarà giu<strong>di</strong>cato<br />
più utile, onde presentarlo all’Autorità competente che certamente lo prenderà in considerazione<br />
per la decisione definitiva".
RILETTURE<br />
ARRIVA IL CINEMATOGRAFO<br />
(Cesare Vincobrio riletto da Corrado Camandone)<br />
LII.<br />
Iar seira, dop la solita baldoria Ieri sera, dopo la solita baldoria<br />
Ai Trei Re Vecc, m’han facc al sourtiment Ai Tre Re Vecchi, mi hanno fatto la proposta<br />
D’andà al cinematografo Vittoria Di andare al cinematografo Vittoria<br />
Tant csì par piasi ‘n po’ ‘d <strong>di</strong>vertiment. Così, tanto per prendersi un po’ <strong>di</strong> [<strong>di</strong>vertimento<br />
Ladarr, sasínn, scala<strong>di</strong>, apoustamentt Ladri, assassini, appostamenti<br />
Tuta seira l’è stacc la stesa storia: Tutta la sera è stata la stessa storia:<br />
Robi, robi da sorti ‘d sentiment, Cose, cose da far uscire <strong>di</strong> mente,<br />
Da per<strong>di</strong> l’intelet e la memoria! Da perdere l’intelletto e la memoria!<br />
Mi ‘ntant pensava: - Se ‘des par daboun Io intanto pensavo: Se adesso davvero,<br />
A quaicadun ‘d sa brusca coumpanía A qualcuno <strong>di</strong> questa losca compagnia<br />
Ai tacheis ‘d sbourà su d’ant is tendoun Saltasse in mente <strong>di</strong> venir giù da quel tendone<br />
E da vnì qui tra noui, coul l’è ‘n ambrœui! - E venire qui tra noi, sì che sarebbe un<br />
[problema!<br />
E ‘ntant mi tniva l’œucc a la sourtía E intanto io tenevo d’occhio l’uscita<br />
E la man ancioudà ‘ns al portafœui. E la mano inchiodata sul portafoglio.<br />
Nel 1925 il cinema era da poco arrivato a Moncalvo. Il nostro poeta, con poche parole e il solito<br />
tono sorridente, mette in risalto due fatti: la forza rappresentativa del cinema e il prevalente<br />
argomento messo in scena.<br />
Se il cinema non toccasse intimamente le persone, sarebbe già morto. Uno dei primi spettacoli<br />
cinematografici presentava l’arrivo del treno. L’impressione era così forte che le delicate signore<br />
ogni tanto svenivano per la sensazione <strong>di</strong> essere investite.<br />
Oggi, anche se siamo più abituati, senza svenire, siamo toccati nell’intimo da scene, problemi,<br />
<strong>di</strong>scorsi <strong>di</strong>ffusi dallo schermo. Il nostro simpatico poeta teneva d’occhio la porta per scappare<br />
e la mano sul portafoglio.<br />
Il cinema, oggi anche in casa, grazie alla televisione e il videoregistratore, ha preso il posto, in<br />
gran parte, dei libri. Non parliamo poi dei giovani, alcuni dei quali svengono per aver esaurito<br />
tutte le loro energie davanti allo schermo dei videogiochi, una specie <strong>di</strong> cinema fai da te. Come<br />
argomento dei film, oggi, a <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> un secolo dalla sua nascita, siamo ancora allo stesso<br />
punto: ladri, assassini, assalti, storie gialle o nere; in più abbiamo aggiunto fantascienza,<br />
sesso e horror.<br />
Il film è entrato nella cultura, ma la produzione positiva è ancora in minoranza. Le persone<br />
mature possono assaggiare tutti i film che vogliono, ma prima <strong>di</strong> <strong>di</strong>gerirli li giu<strong>di</strong>cano col loro<br />
buon senso.<br />
36
LIII.<br />
J era lì dnan da noui in fancioutin C’era lì davanti a noi un ragazzino<br />
Che tut la seira l’era restà ‘n pe, Che tutta la sera è rimasto in pie<strong>di</strong>,<br />
Rapi ‘n countemplasioun ‘d coui bei afè, Rapito in contemplazione <strong>di</strong> quelle belle<br />
cose,<br />
Coun al co teis par ved<strong>di</strong>j pu d’avsin. Col collo teso per vederle più da vicino.<br />
In bel moument però s’è voutà ‘ndrè Un bel momento però s’è voltato in<strong>di</strong>etro<br />
E mi ‘1 l’ho d’lounc bourdà: - Neh, bel bioun<strong>di</strong>n, E io l’ho subito bloccato: - Neh, bel bion<strong>di</strong>no,<br />
Cme ch’l’è ‘1 to nom? Mi soun al sour Coulin.. - Com’è il tuo nome? Io sono il signor Coulin.- <br />
E chil succ, succ: — Mi soun ‘n habitué. - E lui asciutto, asciutto: - Io sono un habitué<br />
-<br />
-Bo - j ho pensà - ‘1 sarà ‘l mestè ‘d so pari — - Bo - ho pensato - sarà il mestiere <strong>di</strong> suo<br />
[padre -<br />
- E ti, ch’a t’am <strong>di</strong>rai ch’a soun curious, - E tu, mi <strong>di</strong>rai che son curioso,<br />
Voeuti fa ‘1 paisan o l’ouperari ? - Vorresti fare il paesano o l’operaio ? -<br />
Chil l’è stacc pensierous in moumentin, Lui è stato pensieroso un momentino,<br />
Po’, coun j œucc al tendoun, am fa sout vous: Poi, con gli occhi allo schermo, mi fa [sottovoce:<br />
- Mi, quand ch’a sarò grand, fas al sasín. - - Io, quando sarò grande, faccio<br />
l’assassino. -<br />
Continua l’analisi del cinema e la sua influenza sui giovani.<br />
Il nostro poeta sta osservando un ragazzino che beve con gli occhi le figure che si muovono<br />
sullo schermo. Il poeta-spettatore si presenta al ragazzo <strong>di</strong>cendo il proprio nome e gentilmente<br />
gli chiede come si chiama. Il bel bion<strong>di</strong>no, senza staccare gli occhi dai suoi eroi, risponde con<br />
un aggettivo: habitué, cioè frequentatore assiduo dei cinespettacoli. Allora il poeta-psicologo<br />
pone una domanda intelligente per conoscere le idee che girano nella testa <strong>di</strong> un ragazzo che<br />
dà tanta importanza e tempo e cre<strong>di</strong>to ai messaggi del cinema: “Bel bion<strong>di</strong>no, che segui tanto<br />
il cinema, da grande, cosa vorresti fare? il conta<strong>di</strong>no o l’operaio?“. Il ragazzo spara una risposta<br />
congelante: “Quando sarò grande, farò l’assassino”.<br />
Una scelta <strong>di</strong> questo tipo si spiega solamente col fatto che lo schermo ha presentato l’assassino<br />
come un essere intelligente, coraggioso, che sfida le forze dell’or<strong>di</strong>ne, che fugge magari dalla<br />
prigione e coi sol<strong>di</strong> rubati si dà alla bella vita. Comunque, anche punito e giustiziato è <strong>di</strong>ventato<br />
una persona famosa.<br />
Oh, la fama, la grande droga anche dei nostri tempi, ritenuti furbi, evoluti, liberi da ogni tabù.<br />
Essere famoso, cioè conosciuto da tante persone, a qualunque costo: vestiti o nu<strong>di</strong>, con calendario<br />
personale o senza, con la testa rapata o chiuso nella gabbia del Grande Fratello, personaggio<br />
<strong>di</strong> quiz o <strong>di</strong> spot, protagonista <strong>di</strong> beghe pietose in pubblico o <strong>di</strong> scherzi fiacchi, tutto si<br />
fa pur <strong>di</strong> affacciarsi alla finestrina dello schermo televisivo, magari con la speranza, spesso delusa,<br />
<strong>di</strong> fare tanti sol<strong>di</strong>.<br />
Quando la cronaca ci parla <strong>di</strong> un delinquente minorenne, si riprende l’antica lagna: “Colpa<br />
della famiglia, della scuola, della televisione” . Di questi tre chi è più forte? La televisione.<br />
Ma nulla cambia. Cosa <strong>di</strong>re? povero popolo o povero governo?<br />
37
NOTIZIE<br />
MOSTRA DI EMMA FASSIO<br />
Dal 25 agosto al 9 settembre la Casa Montanari<br />
ha ospitato la mostra “Pulsioni, vita<br />
e fibra in movimento” <strong>di</strong> Emma Fassio.<br />
L’artista, <strong>di</strong> origini italo-svedesi ha iniziato<br />
la propria esperienza durante la permanenza<br />
negli Stati Uniti: a New York ha esposto<br />
lavori e vinto concorsi. Ultimamente, ha<br />
iniziato a sperimentare con tecniche che<br />
consistono nell’inserimento <strong>di</strong> fibre, filati e<br />
tessuti. Emma Fassio vuole trasmettere e<br />
comunicare nei suoi quadri le emozioni, le<br />
sensazioni e le pulsioni della vita, dove i<br />
colori e le loro sfumature sono elementi<br />
fondamentali.<br />
CONFERENZA DI LABAR E<br />
MOSTRA DI FLAVIO SACCO<br />
L’artista Labar ha tenuto l’8 settembre<br />
presso il salone della Biblioteca civica una<br />
interessante conferenza sul tema “Le tecniche<br />
<strong>di</strong> incisione originali”. Era presente<br />
l’incisore Flavio Sacco, che dal 15 al 30<br />
settembre ha poi tenuto in Casa Montanari<br />
la mostra dal titolo “Incisioni alla maniera<br />
nera”. Questa interessante tecnica, appresa<br />
da un giapponese consente <strong>di</strong> ottenere opere<br />
<strong>di</strong> straor<strong>di</strong>naria morbidezza, con forme<br />
bianche o colorate che emergono da una<br />
matrice nera.<br />
Al termine dell’esposizione, l’artista con<br />
gesto <strong>di</strong> grande gentilezza ha donato alla<br />
Biblioteca tre delle sue opere.<br />
MOSTRA DI MARIO PAVESE<br />
In occasione della Fiera del Tartufo, Casa<br />
Montanari ha ospitato dal 13 al 28 ottobre<br />
una bella mostra <strong>di</strong> tempere dell’artista<br />
moncalvese Mario Pavese dal titolo “Monfrà”.<br />
Come ha scritto Angela Strona, nelle<br />
opere <strong>di</strong> Pavese “c’è l’essenza più vera del<br />
Monferrato: i colori cal<strong>di</strong>, i sapori forti,<br />
38<br />
l’odore della campagna che nella notte è <strong>di</strong><br />
mosto e <strong>di</strong> tartufo”.<br />
L’esposizione ha attirato l’attenzione <strong>di</strong> un<br />
gran numero <strong>di</strong> visitatori, vecchi e nuovi<br />
estimatori del pittore che a Moncalvo ha<br />
de<strong>di</strong>cato la maggior parte delle sue opere.<br />
Nell’occasione, Mario Pavese, con gesto <strong>di</strong><br />
squisita amicizia, ha donato una sua opera,<br />
rappresentante il mercato del giovedì, al<br />
Comune <strong>di</strong> Moncalvo.<br />
CONFERENZA DEL RABBINO<br />
LUCIANO CARO<br />
Nell’ambito <strong>di</strong> un ciclo <strong>di</strong> iniziative volte a<br />
<strong>di</strong>vulgare la cultura ebraica, domenica 14<br />
ottobre la Biblioteca civica ha ospitato una<br />
conversazione dal titolo “Ebraismo a tavola”.<br />
Relatore è stato il dottor Luciano Caro,<br />
rabbino capo <strong>di</strong> Ferrara. Egli ha parlato<br />
al folto pubblico <strong>di</strong> cibi rituali e proibizioni<br />
alimentari, intese secondo i precetti biblici.<br />
Particolare interesse ha destato negli ascoltatori<br />
il concetto <strong>di</strong> cibo kasher, cioè ammesso<br />
e cucinato secondo millenarie regole<br />
ben precise.<br />
SCOLARESCHE IN VISITA<br />
Per il secondo anno consecutivo in occasione<br />
della Fiera del Bue grasso la Biblioteca<br />
civica ha ospitato una folta scolaresca<br />
della Scuola me<strong>di</strong>a “Dante Alighieri” <strong>di</strong><br />
Casale Monferrato, guidata dal professor<br />
Antonio Costanzo.<br />
In Biblioteca i giovani ospiti hanno incontrato<br />
l’artista Primo Favarin, che ha parlato<br />
<strong>di</strong> subiet <strong>di</strong> terracotta.<br />
Successivamente sono stati accompagnati<br />
nelle sale del Museo Civico, dove hanno<br />
ammirato le opere <strong>di</strong> arte contemporanea<br />
già esposte.<br />
La mattinata si è conclusa con la visita agli<br />
esemplari <strong>di</strong> bue grasso schierati sotto i<br />
portici <strong>di</strong> piazza Carlo Alberto.
ACQUISTO DI NUOVI LIBRI<br />
Proseguendo nella politica <strong>di</strong> costante rinnovamento<br />
del patrimonio bibliografico<br />
della Biblioteca civica, anche per il 2001<br />
sono stati acquistati molti nuovi volumi, <strong>di</strong><br />
svariati argomenti.<br />
Inoltre è stato acquistato l’ultimo aggiornamento<br />
della Enciclope<strong>di</strong>a Italiana (la<br />
LIBRI RICEVUTI<br />
Il presidente Alessandro Allemano ha donato<br />
una serie <strong>di</strong> 36 volumi <strong>di</strong> informatica.<br />
Il professor Corrado Camandone ha donato<br />
una copia del volume “La Vita” recentemente<br />
e<strong>di</strong>to dalle E<strong>di</strong>zioni Camilliane e<br />
contenente il saggio “Vitalismo implicito”<br />
pubblicato a puntate anche su “<strong>Pagine</strong><br />
<strong>Moncalvesi</strong>”.<br />
La Libreria Antiquaria Piemontese <strong>di</strong> Torino,<br />
tramite Angela Strona, ha donato alcuni<br />
volumi <strong>di</strong> vario genere, tra cui:<br />
“Timon Greco” <strong>di</strong> Galeotto Del Carretto,<br />
pubblicato da Giovanni Minoglio nel 1878<br />
in occasione della inaugurazione del Teatro<br />
Sociale <strong>di</strong> Moncalvo;<br />
“Mondo antico”, romanzo storico <strong>di</strong> Agostino<br />
Della Sala Spada (volume unico,<br />
1877);<br />
omaggio poetico e scritto storico pubblicati<br />
in occasione delle nozze <strong>di</strong> Emilio Della<br />
39<br />
Treccani, per intenderci), che riporta dati,<br />
fatti e personaggi aggiornati sino al 2000.<br />
Presso la libreria “Libro Idea” <strong>di</strong> Casale<br />
Monferrato sono poi stati acquistati 70 volumi,<br />
tra i quali opere <strong>di</strong>vulgative<br />
sull’Islam, volumi sulla civiltà ebraica in<br />
Italia, opere sulla storia coloniale italiana<br />
in Africa e altri sulla storia e il <strong>di</strong>aletto del<br />
Piemonte.<br />
Sala Spada con Caterina Biglione <strong>di</strong> Viarigi.<br />
Ha inoltre donato un’importante raccolta <strong>di</strong><br />
lettere del barone Fer<strong>di</strong>nando Dal Pozzo <strong>di</strong><br />
Castellino. La Biblioteca ringrazia la signora<br />
Angela Laurella Cicolini per la donazione<br />
molto gra<strong>di</strong>ta.<br />
L’Istituto per la Storia della Resistenza e<br />
della Società contemporanea in provincia<br />
<strong>di</strong> <strong>Asti</strong> ha inviato il volume in e<strong>di</strong>zione anastatica<br />
“Il vento cancella le orme” <strong>di</strong><br />
Amelio Novello.<br />
Sono inoltre giunte le seguenti riviste:<br />
“Monferrato Arte e Storia”, n. 13 (<strong>di</strong>cembre<br />
2001)<br />
“Il Platano”, anno XXVI- 2° semestre 2001
SUL PROSSIMO NUMERO<br />
In occasione delle celebrazioni per il cinquantesimo<br />
anniversario della morte <strong>di</strong> monsignor<br />
Giuseppe Bolla, parroco <strong>di</strong> Moncalvo dal<br />
1930 al 1952, il numero 13 <strong>di</strong> “<strong>Pagine</strong><br />
APPELLO AI LETTORI<br />
40<br />
<strong>Moncalvesi</strong>” uscirà in e<strong>di</strong>zione speciale con una<br />
serie <strong>di</strong> articoli che rievocheranno la figura <strong>di</strong><br />
questo illustre sacerdote.<br />
Per arricchire <strong>di</strong> documentazione la sezione <strong>di</strong> storia locale della Biblioteca civica rivolgiamo<br />
un appello a tutti i Lettori che posseggano annate o numeri sciolti dei seguenti perio<strong>di</strong>ci:<br />
La Buona Parola (dal 1936 in poi)<br />
L’Eco del Monferrato<br />
L’Eco moncalvese (dal 1975 in poi)<br />
a contattare la Direzione della Biblioteca.<br />
I giornali saranno trattati con ogni cura e precauzione, fotocopiati e riconsegnati<br />
ai proprietari in brevissimo tempo.<br />
Chi collaborerà riceverà in omaggio una pubblicazione. Si ringraziano quanti hanno già<br />
raccolto l’appello.<br />
Realizzato in proprio presso la Biblioteca civica “F. Montanari” piazza Buronzo 2 - 14036<br />
Moncalvo (AT) tel. e fax 0141. 917427<br />
In<strong>di</strong>rizzo Internet: http://provincia.asti.it/comuni/moncalvo/moncalvo.htm<br />
E–mail: moncalvo@provincia.asti.it<br />
Distribuzione gratuita. I numeri arretrati, se <strong>di</strong>sponibili, vengono ceduti previo rimborso delle<br />
spese <strong>di</strong> riproduzione.<br />
È vietata la riproduzione <strong>di</strong> testo e immagini contenuti in questo Bollettino –anche per<br />
quanto riguarda le “pagine Internet”– senza l’autorizzazione scritta della Redazione<br />
“Il Platano”, organo dell’Associazione Amici <strong>di</strong> <strong>Asti</strong>, rivista per lo stu<strong>di</strong>o della cultura<br />
e civiltà astigiana, pubblica saggi e stu<strong>di</strong>, ricerche e documenti ine<strong>di</strong>ti, notizie <strong>di</strong> manifestazioni<br />
culturali interessanti la nostra Regione. Redazione e amministrazione presso<br />
CEPROS, via D’Azeglio 42, tel. e fax 0141-593281.