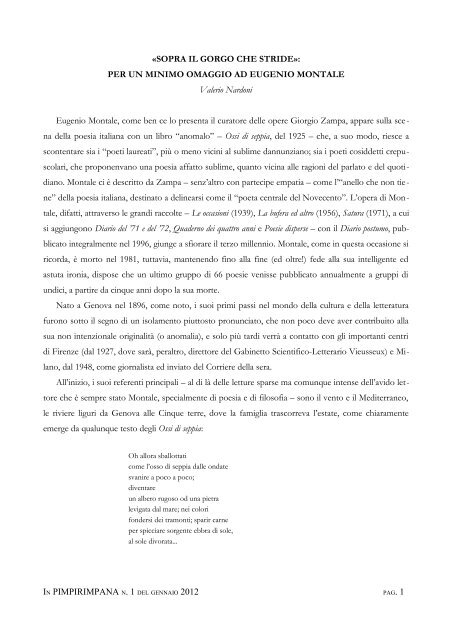Sopra il gorgo che stride - PIMPIRIMPANA
Sopra il gorgo che stride - PIMPIRIMPANA
Sopra il gorgo che stride - PIMPIRIMPANA
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
«SOPRA IL GORGO CHE STRIDE»:<br />
PER UN MINIMO OMAGGIO AD EUGENIO MONTALE<br />
Valerio Nardoni<br />
Eugenio Montale, come ben ce lo presenta <strong>il</strong> curatore delle opere Giorgio Zampa, appare sulla sce-<br />
na della poesia italiana con un libro “anomalo” – Ossi di seppia, del 1925 – <strong>che</strong>, a suo modo, riesce a<br />
scontentare sia i “poeti laureati”, più o meno vicini al sublime dannunziano; sia i poeti cosiddetti crepu-<br />
scolari, <strong>che</strong> proponenvano una poesia affatto sublime, quanto vicina alle ragioni del parlato e del quoti-<br />
diano. Montale ci è descritto da Zampa – senz’altro con partecipe empatia – come l’“anello <strong>che</strong> non tie-<br />
ne” della poesia italiana, destinato a delinearsi come <strong>il</strong> “poeta centrale del Novecento”. L’opera di Mon-<br />
tale, difatti, attraverso le grandi raccolte – Le occasioni (1939), La bufera ed altro (1956), Satura (1971), a cui<br />
si aggiungono Diario del ’71 e del ’72, Quaderno dei quattro anni e Poesie disperse – con <strong>il</strong> Diario postumo, pub-<br />
blicato integralmente nel 1996, giunge a sfiorare <strong>il</strong> terzo m<strong>il</strong>lennio. Montale, come in questa occasione si<br />
ricorda, è morto nel 1981, tuttavia, mantenendo fino alla fine (ed oltre!) fede alla sua intelligente ed<br />
astuta ironia, dispose <strong>che</strong> un ultimo gruppo di 66 poesie venisse pubblicato annualmente a gruppi di<br />
undici, a partire da cinque anni dopo la sua morte.<br />
Nato a Genova nel 1896, come noto, i suoi primi passi nel mondo della cultura e della letteratura<br />
furono sotto <strong>il</strong> segno di un isolamento piuttosto pronunciato, <strong>che</strong> non poco deve aver contribuito alla<br />
sua non intenzionale originalità (o anomalia), e solo più tardi verrà a contatto con gli importanti centri<br />
di Firenze (dal 1927, dove sarà, peraltro, direttore del Gabinetto Scientifico-Letterario Vieusseux) e Mi-<br />
lano, dal 1948, come giornalista ed inviato del Corriere della sera.<br />
All’inizio, i suoi referenti principali – al di là delle letture sparse ma comunque intense dell’avido let-<br />
tore <strong>che</strong> è sempre stato Montale, specialmente di poesia e di f<strong>il</strong>osofia – sono <strong>il</strong> vento e <strong>il</strong> Mediterraneo,<br />
le riviere liguri da Genova alle Cinque terre, dove la famiglia trascorreva l’estate, come chiaramente<br />
emerge da qualunque testo degli Ossi di seppia:<br />
Oh allora sballottati<br />
come l’osso di seppia dalle ondate<br />
svanire a poco a poco;<br />
diventare<br />
un albero rugoso od una pietra<br />
levigata dal mare; nei colori<br />
fondersi dei tramonti; sparir carne<br />
per spicciare sorgente ebbra di sole,<br />
al sole divorata...<br />
IN <strong>PIMPIRIMPANA</strong> N. 1 DEL GENNAIO 2012 PAG. 1
Famosissimi questi versi delle Riviere, <strong>che</strong> citiamo per la loro indubbia ut<strong>il</strong>ità quasi didascalica, ma<br />
non senza un poco di timore di essere sgridati da Montale, <strong>che</strong> in una lettera all’amico Sergio Solmi at -<br />
tribuisce a quel testo “<strong>il</strong> carattere di una trombonata giovan<strong>il</strong>e, con quelle camelie pallide, quelle voci<br />
d’oro, ecc. ecc”. D’altra parte, non c’è forse poesia di Montale più famosa di Meriggiare pallido e assorto<br />
(anch’essa fra le più anti<strong>che</strong> di Ossi di seppia, del 1916) e i non meno celebri Limoni, <strong>che</strong> sono definiti<br />
proprio “le trombe d’oro della solarità”.<br />
C’è dunque ironia ed autoironia nella poesia come nelle lettere di Montale, ma un’ironia inquieta e<br />
ansiosa, <strong>che</strong> fin dalle prime prove poeti<strong>che</strong> risulta “ebbra di sole”, ma dal “sole divorata”: <strong>il</strong> mondo<br />
poetico di Montale si crea e si distrugge sotto <strong>il</strong> suo stesso impeto vitale, si fonde in un tramonto co-<br />
stante <strong>che</strong> va dall’intuizione dei minimi vitali fino alla loro dissoluzione (“svanire a poco a poco”) e la<br />
loro assim<strong>il</strong>azione nei moti sconfinati dell’universo (“nei colori / fondersi dei tramonti”)... come si leg-<br />
ge ancora in una delle più potenti delle poesie postume, <strong>che</strong>, per brevità, vale la pena citare integralmen-<br />
te:<br />
Un giorno non lontano<br />
assisteremo alla collisione<br />
dei pianeti e <strong>il</strong> diamantato cielo<br />
finirà sommerso in avvalli.<br />
Allora coglieremo rut<strong>il</strong>anti fiori<br />
e stelle al neon.<br />
Guarda, ecco <strong>il</strong> segnale, un fuoco<br />
s’appicca in cielo, si scontrano<br />
Giove con Orione e nel terrib<strong>il</strong>e<br />
frastuono dov’è finito l’uomo?<br />
Certo basta un soffio al mondo<br />
in cui viviamo per scomparire.<br />
Rimarrà forse un grido, quello<br />
della terra <strong>che</strong> non vuole finire.<br />
Non c’è qui <strong>il</strong> “tramonto” ma “un fuoco / s’appicca in cielo”, non si parla di “svanire” e “fondersi”<br />
ma di un poco dissim<strong>il</strong>e “scomparire”; e al posto del pur tenace “osso di seppia” perduto fra le infinite<br />
ondate del mare, c’è qui un ugualmente orgoglioso e potente “grido”, la cui intensità, tuttavia, sembra<br />
avere po<strong>che</strong> possib<strong>il</strong>ità contro <strong>il</strong> “frastuono” di galassie <strong>che</strong> si scontrano.<br />
Accostando questi due testi, è certamente più fac<strong>il</strong>e percepire an<strong>che</strong> nel primissimo ed indimentica-<br />
b<strong>il</strong>e simbolo dell’“osso di seppia” non solo un frammento, un frantumo, o un truciolo, ma una particella di<br />
universo <strong>che</strong> vuole resistere alla sua totale dissoluzione. In corsivo, parole <strong>che</strong> rimandano ai titoli di im-<br />
portanti precedenti letterari di un Montale, quindi, forse isolato ma non distratto – i Frammenti lirici di<br />
Clemente Maria Rebora, del 1913; i Frantumi di Giovanni Boine, del 1915; i Trucioli di Cam<strong>il</strong>lo Sbarbaro,<br />
del 1920 – a cui si deve aggiungere an<strong>che</strong> la parola “rottame”, l’originario titolo della sezione centrale<br />
IN <strong>PIMPIRIMPANA</strong> N. 1 DEL GENNAIO 2012 PAG. 2
del libro <strong>che</strong>, forse proprio per eccessiva prossimità ai trucioli di Sbarbaro, cambiò nome in Ossi di sep-<br />
pia.<br />
L’osso di seppia, <strong>il</strong> grido del poeta naufrago nell’universo, giunge a riva scarnificato, non come vita,<br />
ma come testimonianza di una vita trascorsa chissà dove e chissà quando, dall’uomo, nell’infinito spazio<br />
e nell’infinito tempo della creazione.<br />
È fra questi due poli – oltre a tutto <strong>il</strong> possib<strong>il</strong>e e l’indicib<strong>il</strong>e della vita – <strong>che</strong> si attiva la lunga opera<br />
montaliana: fra spaesamento e resistenza, fra impulso e annich<strong>il</strong>imento, fra <strong>il</strong> “tremulo asse” di Esterina,<br />
da dove l’adolescente protagonista di Falsetto spicca <strong>il</strong> suo tuffo nella vita, e <strong>il</strong> “<strong>gorgo</strong>” pronto ad in-<br />
ghiottirla.<br />
In conclusione, premeva ricordare an<strong>che</strong> la velleità di Eugenio Montale per la musica – in gioventù<br />
ha studiato canto con <strong>il</strong> famoso baritono Ernesto Sivori – e <strong>il</strong> suo favoloso orecchio musicale, <strong>che</strong> è <strong>il</strong><br />
vero asso nella manica della sua opera sempre più trasgressiva delle regole dell’armonia metrica. In que-<br />
sta poesia, fra le sue più belle, Montale imposta un parallelo fra l’ingenua leggerezza della fanciulla e <strong>il</strong><br />
quel particolare tipo di canto, <strong>il</strong> falsetto appunto, <strong>che</strong>, eseguito con un minore sforzo muscolare rispetto<br />
alla voce piena, è capace di raggiungere note più acute. Questa assonanza imposta perfettamente non<br />
solo le linee di questo particolare testo, ma dell’atteggiamento dell’autore rispetto al suo fare poesia: un<br />
tuffo nel mare, un tuffo nel mistero del proprio avvenire, quando ancora l’esistenza non è percepita<br />
come piena e vive in una dimensione a suo modo più alta e delicata, come una voce in falsetto. Natural-<br />
mente, come la ragazza, an<strong>che</strong> la poesia vive nell’imminenza di una possib<strong>il</strong>e stonatura, dovuta al tempo<br />
<strong>che</strong> la toglierà alla grazia della sua primaria fres<strong>che</strong>zza.<br />
Si potrebbe a questo punto dire <strong>che</strong> tutto ciò è relativo soltanto ad Ossi di seppia e <strong>che</strong> <strong>il</strong> Montale<br />
adulto e poi vecchio – dopo la prima, sperimenterà ancora la Bufera della seconda guerra mondiale,<br />
come la morte della moglie, ecc. – lascerà perdere tali frivoli voli (mi permetto <strong>il</strong> vezzo di un involonta -<br />
rio falsetto, come <strong>il</strong> “sorridente presente” di Esterina), ma preferisco pensare <strong>che</strong> <strong>il</strong> Diario postumo sia un<br />
ancora un leggiadro tuffo “sopra <strong>il</strong> <strong>gorgo</strong> <strong>che</strong> <strong>stride</strong>”.<br />
IN <strong>PIMPIRIMPANA</strong> N. 1 DEL GENNAIO 2012 PAG. 3