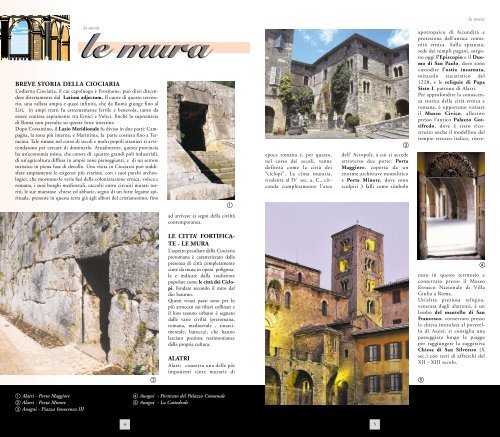Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
la storia<br />
<strong>le</strong> <strong>mura</strong><br />
BREVE STORIA DELLA CIOCIARIA<br />
L’odierna Ciociaria, il cui capoluogo è <strong>Frosinone</strong>, può dirsi discendere<br />
direttamente dal Latium adjectum. Il cuore di questo territorio,<br />
una vallata ampia e quasi infinita, che da Roma giunge fino al<br />
Liri, in ampi tratti fu estremamente ferti<strong>le</strong> e benevola, tanto da<br />
essere contesa aspramente tra Ernici e Volsci, finchè la supremazia<br />
di Roma non prevalse su queste lotte intestine.<br />
Dopo Costantino, il Lazio Meridiona<strong>le</strong> fu diviso in due parti: Campagna,<br />
la zona più interna, e Marittima, la parte costiera fino a Terracina.<br />
Ta<strong>le</strong> rimase nel corso di secoli e molti popoli stranieri si avvicendarono<br />
per cercare di dominarlo. Attualmente, questa provincia<br />
ha un’economia mista, che consta di quattro grandi poli industriali,<br />
di un’agricoltura diffusa in ampie zone pianeggianti, e di un settore<br />
turistico in piena fase di decollo. Una visita in Ciociaria può soddisfare<br />
ampiamente <strong>le</strong> esigenze più svariate, con i suoi parchi archeologici,<br />
che mostrano <strong>le</strong> varie fasi della colonizzazione ernica, volsca e<br />
romana, i suoi borghi medioevali, raccolti entro circuiti <strong>mura</strong>ri turriti,<br />
<strong>le</strong> sue maestose chiese ed abbazie, segno di un forte <strong>le</strong>game spiritua<strong>le</strong>,<br />
presente in questa terra già agli albori del cristianesimo, fino<br />
Alatri - Porta Maggiore<br />
Alatri - Porta Minore<br />
Anagni - Piazza Innocenzo III<br />
4<br />
<br />
ad arrivare ai segni della civiltà<br />
contemporanea.<br />
LE CITTA’ FORTIFICA-<br />
TE - LE MURA<br />
L’aspetto peculiare della Ciociaria<br />
preromana è caratterizzato dalla<br />
presenza di città comp<strong>le</strong>tamente<br />
cinte da <strong>mura</strong> in opera poligona<strong>le</strong><br />
e indicate dalla tradizione<br />
popolare come <strong>le</strong> città dei Ciclopi,<br />
fondate secondo il mito dal<br />
dio Saturno.<br />
Questi vivaci paesi sono per lo<br />
più arroccati sui rilievi collinari e<br />
il loro tessuto urbano è segnato<br />
dal<strong>le</strong> varie civiltà (preromana,<br />
romana, medioeva<strong>le</strong> , rinascimenta<strong>le</strong>,<br />
barocca), che hanno<br />
lasciato preziose testimonianze<br />
della propria cultura.<br />
ALATRI<br />
Alatri conserva una del<strong>le</strong> più<br />
imponenti cinte <strong>mura</strong>rie di<br />
Anagni - Porticato del Palazzo Comuna<strong>le</strong><br />
Anagni - La Cattedra<strong>le</strong><br />
<br />
epoca romana e, per questo,<br />
nel corso dei secoli, venne<br />
definita come la città dei<br />
“ciclopi”. La cinta <strong>mura</strong>ria,<br />
risa<strong>le</strong>nte al IV sec. a. C., circonda<br />
comp<strong>le</strong>tamente l’area<br />
<br />
dell’ Acropoli, a cui si accede<br />
attraverso due porte: Porta<br />
Maggiore, coperta da un<br />
enorme architrave monolitico<br />
e Porta Minore, dove sono<br />
scolpiti 3 falli come simbolo<br />
5<br />
apotropaico di fecondità e<br />
protezione dell’antica comunità<br />
ernica. Sulla spianata,<br />
sede dei templi pagani, sorgono<br />
oggi l’Episcopio e il Duomo<br />
di San Paolo, dove sono<br />
custodite l’ostia incarnata,<br />
miracolo eucaristico del<br />
1228, e <strong>le</strong> reliquie di Papa<br />
Sisto I, patrono di Alatri.<br />
Per approfondire la conoscenza<br />
storica della città ernica e<br />
romana, è opportuno visitare<br />
il Museo Civico, al<strong>le</strong>stito<br />
presso l’antico Palazzo Gottifredo,<br />
dove è stato ricostruito<br />
anche il modellino del<br />
tempio etrusco italico, rinve-<br />
<br />
la storia<br />
<br />
nuto in questo territorio e<br />
conservato presso il Museo<br />
Etrusco Naziona<strong>le</strong> di Villa<br />
Giulia a Roma.<br />
Un’altra preziosa reliquia,<br />
venerata dagli alatrensi, è un<br />
<strong>le</strong>mbo del mantello di San<br />
Francesco, conservato presso<br />
la chiesa intitolata al poverello<br />
di Assisi; si consiglia una<br />
passeggiata lungo <strong>le</strong> piagge<br />
per raggiungere la suggestiva<br />
Chiesa di San Silvestro (X<br />
sec.) con resti di affreschi del<br />
XII - XIII secolo.
ANAGNI<br />
Antica città sacra agli Ernici,<br />
Anagni rivestì sempre un<br />
importante ruolo religioso e<br />
politico.<br />
Durante il periodo ernico, la<br />
città era comp<strong>le</strong>tamente cinta<br />
dal<strong>le</strong> <strong>mura</strong> in opera poligona<strong>le</strong>,<br />
di cui oggi sono visibili poche<br />
tracce, lungo il versante settentriona<strong>le</strong><br />
dell’antica acropoli,<br />
databili tra il V e IV secolo. In<br />
età romana, questa cinta <strong>mura</strong>ria<br />
fu ampliata fino a comprendere<br />
l’emiciclo degli Arcazzi di<br />
Piscina, probabili terrazzamenti<br />
di una costruzione terma<strong>le</strong><br />
della fine del III / inizio II<br />
secolo a. C., e i resti del<strong>le</strong> Mura<br />
Serviane, dove sul pilastro centra<strong>le</strong><br />
è scolpito un simbolo fallico.<br />
Purtroppo, nel corso dei<br />
mil<strong>le</strong>nni la cinta <strong>mura</strong>ria ha<br />
subito numerosi rimaneggiamenti.<br />
Attualmente l’aspetto più peculiare<br />
dell’abitato di Anagni, città<br />
nata<strong>le</strong> di quattro pontefici,<br />
(Innocenzo III, Gregorio IX,<br />
A<strong>le</strong>ssandro IV, Bonifacio VIII),<br />
è il suo centro storico di aspetto<br />
medioeva<strong>le</strong>. Tra i monumenti,<br />
spicca per importanza artistica<br />
la superba Cattedra<strong>le</strong><br />
romanica di Santa Maria con<br />
la sua cripta affrescata, il duecentesco<br />
Palazzo Papa<strong>le</strong>, teatro<br />
del ce<strong>le</strong>bre “schiaffo di Anagni”,<br />
l’ardita architettura della<br />
Sala della Ragione nel Palazzo<br />
Comuna<strong>le</strong>, espressione massima<br />
del potere civi<strong>le</strong> della comunità<br />
anagnina, costruito tra il 1159 e<br />
il 1163 da Jacopo da Iseo, uno<br />
dei rappresentanti del<strong>le</strong> città<br />
lombarde, venuti a stipulare i<br />
“patti di Anagni” con Papa Adriano<br />
IV, contro l’Imperatore Federico<br />
Barbarossa.<br />
Da ammirare, nella Chiesa di<br />
S. Andrea, il Trittico del Salvatore,<br />
sp<strong>le</strong>ndida opera del XII<br />
secolo di scuola romana. Di<br />
fronte alla chiesa si trova la<br />
Arpino - Arco a sesto acuto<br />
Ferentino - Porta Sanguinaria<br />
famosa casa Barnekow, interessante esempio di casa medioeva<strong>le</strong>,<br />
decorata nell ‘800 con affreschi esoterici dal pittore svedese Barnekow.<br />
Molti sono i monumenti da scoprire in questa sp<strong>le</strong>ndida cittadina,<br />
che va visitata passeggiando nei vicoli, o lungo i viali alberati<br />
alla fine dei quali si aprono grandi piazze, dove si affacciano sp<strong>le</strong>ndidi<br />
edifici antichi, come la chiesa di San Pietro in Vineis, un<br />
monastero di cui si hanno <strong>le</strong> prime notizie già a partire dal XII secolo.<br />
La chiesa romanica conserva ancora il pavimento cosmatesco e<br />
interessanti affreschi del XII e XIV secolo.<br />
ARPINO<br />
Sulla sommità di Arpino, nel quartiere Civitavecchia, troviamo uno dei<br />
monumenti più stupefacenti del periodo pre-romano: l’arco a sesto<br />
acuto, antica porta scea aperta sul<strong>le</strong> <strong>mura</strong> in opera poligona<strong>le</strong>, costruite<br />
per difendere l’antica Arx. L’arco è costituito da una serie di grandi<br />
Atina - Bifora del Palazzo Duca<strong>le</strong><br />
Atina - Palazzo Duca<strong>le</strong><br />
<br />
massi, disposti ad incastro, senza Tulliano, sede del prestigioso<br />
l’ausilio di malte cementizie. Nel liceo ginnasio, che ogni anno<br />
Medioevo, lungo queste <strong>mura</strong>, ospita la manifestazione del Cer-<br />
vennero aggiunte numerose torri, tamen Ciceronianum Arpinas,<br />
che resero il borgo un importan- gara di traduzione e commento<br />
te punto strategico a difesa del di un brano di Marco Tullio<br />
sottostante nuc<strong>le</strong>o di Arpino. Cicerone, una manifestrazione<br />
Secondo un’antichissima <strong>le</strong>ggen- di risonanza europea, che regida,<br />
qui scelse di vivere Saturno stra la partecipazione di centi-<br />
divinità protettrice dell’agricoltunaia di liceali europei. Una visira.ta<br />
alla bella Chiesa parrocchia-<br />
Ancora resti di <strong>mura</strong> poligonali <strong>le</strong> di S. Miche<strong>le</strong> consente di<br />
s’incontrano sa<strong>le</strong>ndo verso il ammirare i dipinti del pittore<br />
quartiere di Civita Falconara, Giuseppe Cesari, noto come il<br />
sulla cui sommità sorge il castel- Cavalier d’ Arpino, e di imporlo<br />
di Ladislao Durazzo.<br />
tanti esponenti della cultura del<br />
Cuore del paese è l’e<strong>le</strong>gante piaz- barocco romano.<br />
za Municipio, delimitata su tre<br />
lati dal Palazzo Boncompagni, ATINA<br />
attualmente sede del Centro Nell’antichità, Atina venne consi-<br />
Internaziona<strong>le</strong> Umberto derata come l’ultimo centro<br />
Mastroianni, ce<strong>le</strong>bre scultore del difensivo contro il Sannio e, gra-<br />
‘900, dal Convitto Naziona<strong>le</strong> zie al<strong>le</strong> risorse del suo territorio,<br />
<br />
<br />
ricco di limonite, e al coraggio<br />
dei suoi uomini, venne definita<br />
“potens” da Virgilio.<br />
Nel<strong>le</strong> sa<strong>le</strong> del Museo comuna<strong>le</strong>,<br />
è possibi<strong>le</strong> avere una precisa idea<br />
dell’importanza strategica rivestita<br />
da questo paese, circondato da<br />
ruolo di importante centro<br />
amministrativo della Val<strong>le</strong> di<br />
Comino e qui fissarono la loro<br />
dimora i Signori Cantelmo, che<br />
provvidero alla ristrutturazione<br />
del Palazzo Duca<strong>le</strong>, dopo il vio-<br />
<strong>mura</strong> in opera poligona<strong>le</strong>, e col<strong>le</strong>nto terremoto del 1349. La poslocato<br />
su importanti vie di col<strong>le</strong>sente mo<strong>le</strong> del castello occupa<br />
gamento per il commercio, tra la gran parte di Piazza Saturno, la<br />
Campania e l’Etruria. Anche in cui sobria facciata è ingentilita da<br />
epoca medioeva<strong>le</strong>, Atina rivestì il bel<strong>le</strong> bifore e torri. Al secondo<br />
6 7
piano del Palazzo, si trova un grande mosaico romano a tessere bianche<br />
e nere (II sec. d. C.), raffigurante quattro eroi armati e proveniente<br />
dai resti di una antica domus.<br />
Al<strong>le</strong> spal<strong>le</strong> del castello, si trova la parrocchia<strong>le</strong> dell’Assunta decorata<br />
con te<strong>le</strong> di L. Velpi, che ricordano <strong>le</strong> storie di San Marco gali<strong>le</strong>o, patrono<br />
della città.<br />
FERENTINO<br />
Ferentino è tra <strong>le</strong> città ciociare ad avere il maggior numero di monumenti<br />
ed epigrafi romane. Il nuc<strong>le</strong>o urbano più antico è comp<strong>le</strong>tamente<br />
circondato dal<strong>le</strong> <strong>mura</strong> in opera poligona<strong>le</strong>, sul<strong>le</strong> quali si aprono<br />
numerose porte, di cui la più antica è Porta Sanguinaria, cosi detta perchè,<br />
probabilmente, era l’ultimo passaggio dei nemici di Ferentino, condannati<br />
a morte. Certamente è il terrazzamento dell’ Acropoli il<br />
monumento più imponente e suggestivo di Ferentino. Qui si apre anche<br />
un criptoportico romano, meglio conosciuto come il carcere di S.<br />
Ambrogio, patrono della città, vittima del<strong>le</strong> persecuzioni di Dioc<strong>le</strong>ziano.<br />
Particolarmente bel<strong>le</strong> sono <strong>le</strong> due chiese più grandi del paese, il Duomo<br />
romanico di San Giovanni e la Chiesa gotico cistercense di S. Maria<br />
Maggiore. Nel duomo sono da ammirare il pavimento a mosaico dei<br />
Veroli - Fasti Verulani<br />
Arpino - Statua di Marco Tullio Cicerone<br />
<br />
Cosma, il cero pasqua<strong>le</strong>, la<br />
sedia episcopa<strong>le</strong> del Vassal<strong>le</strong>tto<br />
e uno dei più bei cibori medioevali,<br />
opera di Drudus de Trivio.<br />
Spicca, per la sua e<strong>le</strong>gante linea<br />
architettonica, la Chiesa di Santa<br />
Maria Maggiore, costruita,<br />
all’inizio del XIII secolo, come<br />
grangia alimentare della vicina<br />
Abbazia di Casamari, di cui ne<br />
ripete la semplicità e la purezza<br />
dello sti<strong>le</strong> gotico cistercense.<br />
Poco distante dal centro abitato,<br />
su una collina, si trova il cenobio<br />
ce<strong>le</strong>stiniano, dedicato a S. Antonio,<br />
e per molto tempo, luogo di<br />
sepoltura di papa Ce<strong>le</strong>stino V.<br />
VEROLI<br />
Nella parte più alta della città<br />
di Veroli, a 700 metri di altezza,<br />
si trova la Rocca di S. Leucio,<br />
cinta dal<strong>le</strong> <strong>mura</strong> in opera<br />
poligona<strong>le</strong>, al<strong>le</strong> quali sono<br />
state appoggiate, nel Medioevo,<br />
<strong>mura</strong> e torri, per rafforzare<br />
questa antica fortezza ernica.<br />
Durante il periodo ernico,<br />
Veroli fu una del<strong>le</strong> città a capo<br />
della Lega Ernica, in lotta contro<br />
Roma. Divenuta più tardi<br />
fede<strong>le</strong> al<strong>le</strong>ata dell’Urbe, a<br />
Veroli fu concesso l’onore di<br />
festeggiare <strong>le</strong> stesse festività di<br />
Roma, come è testimoniato<br />
dai Fasti Verulani, frammento<br />
di ca<strong>le</strong>ndario marmoreo<br />
del I sec. d. C., posto nel corti<strong>le</strong><br />
di casa Reali; esso ricorda<br />
<strong>le</strong> festività dei primi tre mesi<br />
dell’anno, i giorni nefasti, i<br />
comiziali, gli intercisi.<br />
La sua ecceziona<strong>le</strong> posizione<br />
strategica la rese, per lungo<br />
tempo, inespugnabi<strong>le</strong> e qui<br />
trovarono prigionia o rifugio,<br />
re, imperatori e papi. E’ in<br />
questo borgo che si trova la<br />
chiesa più antica di<br />
Veroli,dedicata a San Leucio<br />
(XI sec.); <strong>le</strong> sue dimensioni<br />
ridotte e la semplicità dello sti<strong>le</strong><br />
ne fanno uno de tesori di<br />
questa cittadina, ricca di storia,<br />
arte e cultura.<br />
Anagni - Statua di Bonifacio VIII<br />
UOMINI ILLUSTRI<br />
La Ciociaria, come mil<strong>le</strong>nario<br />
ponte geografico tra Roma e<br />
Napoli, ha visto il passaggio e<br />
lo stanziamento di numerose<br />
popolazioni, che hanno segnato<br />
il territorio con opere civili<br />
e religiose, testimonianze<br />
tangibili della loro civiltà.<br />
La vicinanza con questi due<br />
grandi poli ha spesso favorito<br />
la presenza di rinomati artisti,<br />
che hanno lavorato nel<strong>le</strong><br />
numerose chiese, nei monasteri<br />
e presso <strong>le</strong> ricche famiglie di<br />
nobili, spesso imparentate con<br />
imperatori, pontefici e uomini<br />
di cultura.<br />
Certamente non è possibi<strong>le</strong>, in<br />
questa sede, menzionarli tutti<br />
ma è doveroso ricordare alcuni<br />
di questi personaggi ciociari,<br />
che, con la loro opera, hanno<br />
contribuito a scrivere un<br />
significativo capitolo della<br />
storia dell’ umanità.<br />
Dell’antichità ricordiamo<br />
Caio Mario, Marco Tullio<br />
Cicerone, Marco Vipsanio<br />
Agrippa, Pescennio Negro,<br />
Giovena<strong>le</strong>, Saturnino Lucio<br />
Apu<strong>le</strong>io, Marco Attilio<br />
Regolo; del medioevo i papi<br />
frusinati, Silverio ed Ormisda,<br />
i quattro pontefici di Anagni<br />
(Innocenzo III, Gregorio IX,<br />
A<strong>le</strong>ssandro IV, Bonifacio<br />
VIII), San Tommaso d’ Aquino,<br />
il pittore Antonio d’ Alatri<br />
seguace di Genti<strong>le</strong> da<br />
Fabriano; del rinascimento<br />
<strong>le</strong>tterati, poeti e pittori come<br />
Giovanni Sulpicio, il cardina<strong>le</strong><br />
Cesare Baronio, Giuseppe<br />
Cesari, meglio noto<br />
come il Cavalier d’ Arpino,<br />
fino ad arrivare all’età contemporanea<br />
con gli scultori<br />
Ernesto Biondi, Umberto<br />
Mastroianni, Tommaso<br />
Gismondi, il regista Anton<br />
Giulio Bracaglia, gli attori<br />
8 9<br />
<br />
<br />
Vittorio De Sica, Nino Manfredi,<br />
Marcello Mastroianni,<br />
i musicisti Severino Gazzelloni<br />
e Licinio Refice, lo scenografo<br />
Antonio Va<strong>le</strong>nte, il<br />
pittore Carlo Ludovico<br />
Bracaglia.<br />
Vanno, inoltre, ricordati i<br />
numerosi ciociari che, emigrati<br />
all’estero, con la loro tenacia<br />
hanno raggiunto ruoli e<br />
posizioni economiche di ecceziona<strong>le</strong><br />
importanza.<br />
Valga per tutti il nome di<br />
Char<strong>le</strong>s Forte, insignito del<br />
titolo di baronetto d’ Inghilterra<br />
dalla regina Elisabetta.
la storia<br />
<strong>le</strong> abbazie<br />
L’ABBAZIA DI MONTECASSINO<br />
A più di 500 metri di altezza, sovrastante l’antica Casinum, già i<br />
Volsci e, poi, i Romani avevano edificato maestosi templi da dedicare<br />
agli dèi. Sui resti di quegli edifici pagani, Benedetto da Norcia,<br />
nel 529, costruì un piccolo oratorio, destinato a divenire la casa<br />
madre dei benedettini e uno dei massimi centri d’irradiazione cultura<strong>le</strong><br />
d’occidente.<br />
I monaci cassinesi praticarono la medicina, la musica, l’astronomia,<br />
il diritto, <strong>le</strong> scienze filosofiche e tradussero dal latino e dal greco <strong>le</strong><br />
opere dell’antichità; nella biblioteca del monastero si conserva<br />
ancora il placito cassinese, primo documento giuridico scritto in<br />
lingua volgare.<br />
Nonostante <strong>le</strong> quattro rovinose distruzioni subite, Montecassino è<br />
ancora lì “dov’era com’era” come annunciato dall’Abate Ildefonso<br />
Rea. L’abbazia, come la vediamo oggi, è infatti, una perfetta ricostruzione<br />
di com’era, prima che i bombardamenti della seconda<br />
guerra mondia<strong>le</strong> la radessero comp<strong>le</strong>tamente al suolo.<br />
Si entra al monastero superando tre grandi chiostri rinascimentali,<br />
che consentono di raggiungere la Chiesa. Dei tre portali d’ingresso<br />
soltanto quello al centro è origina<strong>le</strong>. Esso è opera bizantina dell’ XI<br />
secolo e riporta incise in <strong>le</strong>ttere ageminate tutte <strong>le</strong> terre possedute<br />
dall’ Abbazia. I due portali laterali, opera del Canonica del 1952,<br />
ricordano alcuni episodi salienti della vita di San Benedetto a Montecassino,<br />
con in basso <strong>le</strong> quattro distruzioni subite dal Monastero<br />
(581-883-1349-1944).<br />
L’austera facciata non lascia presagire la sfarzosa policromia dei<br />
marmi pregiatissimi e degli stucchi dorati, che decorano la Chiesa;<br />
<strong>le</strong> volte un tempo dipinte da Luca Giordano sono state in parte<br />
Cassino - Abbazia di Montecassino<br />
Cassino - Montecassino: Chiostro<br />
10<br />
decorate dagli affreschi del pittore<br />
contemporaneo P. Annigoni,<br />
mentre sugli altari sono state<br />
collocate te<strong>le</strong> del XVII e XVIII<br />
secolo, di scuola napo<strong>le</strong>tana.<br />
Sotto l’altare, una suggestiva<br />
cripta accoglie <strong>le</strong> spoglie di San<br />
Benedetto e di sua sorella Scolastica.<br />
Per approfondire la conoscenza<br />
del ruolo rivestito da Montecassino<br />
nella storia della cultura,<br />
è necessario visitare il<br />
Museo, dove sono raccolti<br />
Veroli - Casamari: Interno dell’Abbazia<br />
Veroli - Casamari: Il Coro<br />
<br />
<br />
e <strong>le</strong> chiese<br />
<br />
codici miniati, pergamene e<br />
testi <strong>le</strong>tterari, che fecero di<br />
Montecassino il faro di civiltà<br />
per molti secoli.<br />
L’ABBAZIA<br />
DI CASAMARI<br />
L’abbazia di Casamari, nel<br />
comune di Veroli, si erge maestosa<br />
sui resti dell’ antico municipio<br />
romano di Cereatae<br />
Marianae dove nacque il ce<strong>le</strong>bre<br />
condottiero romano Caio<br />
Mario.<br />
Distrutto dal<strong>le</strong> invasioni barbariche,<br />
il luogo rimase abbandonato<br />
fino al 1096, quando<br />
quattro monaci benedettini vi<br />
costruirono un primo insediamento,<br />
più tardi ingrandito.<br />
Nel XIII secolo, venne affidato<br />
ai cistercensi, un nuovo ordine<br />
monastico tenuto in grande<br />
considerazione dai pontefici del<br />
tempo. I cistercensi, seguendo<br />
la regola di San Bernardo,<br />
edificarono nel 1203 una grande<br />
e semplice chiesa in sti<strong>le</strong><br />
gotico cistercense, rifiutando<br />
eccessi decorativi e mirando<br />
alla purezza della linea architettonica.<br />
La chiesa, dedicata alla Vergine<br />
Assunta e cointitolata ai Santi<br />
Giovanni e Paolo, fu iniziata<br />
con la benedizione di Innocenzo<br />
III, e consacrata, nel 1217,<br />
da Papa Onorio III. L’interno,<br />
di grande sobrietà, è a tre navate<br />
con abside rettangolare e<br />
transetto con sei cappel<strong>le</strong>; al<br />
centro si trova il grande ciborio<br />
barocco, donato da C<strong>le</strong>mente<br />
XI, nel 1711.<br />
Questo comp<strong>le</strong>sso abbazia<strong>le</strong><br />
rappresenta uno dei pochi<br />
modelli ancora integri dell’organizzazione<br />
spazia<strong>le</strong> prevista<br />
da Bernardo di Chiaraval<strong>le</strong>.<br />
La chiesa, infatti, come corpo<br />
di fabbrica più grande, è posta<br />
a nord per riparare il resto del<br />
11<br />
la storia<br />
convento dal vento di tramontana,<br />
il Chiostro luogo di preghiera,<br />
d’incontro e di passaggio<br />
dei monaci ha bel<strong>le</strong> bifore,<br />
finemente ornate, e consente di<br />
accedere all’Aula del Capitolo,<br />
al Refettorio, ai campi e al<strong>le</strong><br />
officine.<br />
Nel grande comp<strong>le</strong>sso abbazia<strong>le</strong>,<br />
si trovano anche una fornitissima<br />
Biblioteca, un Museo-<br />
Pinacoteca, dove sono custodite<br />
suppel<strong>le</strong>ttili romane, dipinti<br />
di Carassi, Guercino, Sassoferrato,<br />
Serodine, Balbi, Purificato<br />
e Fantuzzi.<br />
LA CERTOSA<br />
DI TRISULTI<br />
Immersa in uno dei paesaggi<br />
montani più belli della Ciociaria,<br />
a 800 metri di altezza, si<br />
trova la Certosa di Trisulti,<br />
sp<strong>le</strong>ndido comp<strong>le</strong>sso monastico<br />
divenuto monumento naziona<strong>le</strong>.<br />
Dopo un primo insediamento<br />
benedettino, durato circa due
secoli e sorto per iniziativa di<br />
San Domenico di Foligno, nel<br />
1204, per vo<strong>le</strong>re di Innocenzo<br />
III, il comp<strong>le</strong>sso monastico fu<br />
affidato ai monaci certosini,<br />
che lo mantennero fino alla<br />
fine della seconda guerra mondia<strong>le</strong>,<br />
quando fu affidato ai<br />
monaci cistercensi.<br />
Si accede al comp<strong>le</strong>sso attraversando<br />
un portone di ingresso,<br />
decorato con un bassorilievo<br />
raffigurante San Bartolomeo,<br />
protettore dei certosini, mentre<br />
nella seconda arcata il pittore<br />
Filippo Balbi dipinse la<br />
Madonna che porge del pane<br />
ad un monaco. Si raggiunge il<br />
piazza<strong>le</strong> principa<strong>le</strong> del monastero,<br />
dove si trovano la facciata<br />
medioeva<strong>le</strong> del Palazzo di<br />
Innocenzo III, che oggi ospita<br />
un’ importante Biblioteca e la<br />
facciata neoclassica della Chiesa<br />
intitolata alla Vergine Assunta,<br />
a San Bartolomeo e a San<br />
Bruno, fondatore dell’ordine certosino.<br />
La Chiesa ad aula è<br />
divisa in due settori da un tramezzo,<br />
sui cui lati si trovano<br />
Col<strong>le</strong>pardo - Trisulti: La Certosa<br />
Col<strong>le</strong>pardo - Trisulti: la Farmacia nella Certosa<br />
due altari che ospitano i corpi di due santi martiri: Bonifacio e<br />
Benedetto; a destra e a sinistra, in alto sul<strong>le</strong> pareti, si trovano bel<strong>le</strong><br />
te<strong>le</strong> di F. Balbi, mentre, in basso, è addossato il coro dei fratelli<br />
conversi, opera di intagliatori locali eseguito alla fine del XVII<br />
secolo.<br />
Superata la porta, che divide lo spazio riservato un tempo ai fratelli<br />
coristi, ammiriamo un coro finemente scolpito, ricco d’intagli<br />
e figure zoomorfe, eseguito dallo scultore Jacobò, alla fine<br />
del XVI secolo.<br />
Le pareti della chiesa sono rivestite da bel<strong>le</strong> te<strong>le</strong> del Balbi e del<br />
Battelli mentre al Caci spetta il grande affresco della volta, che raffigura<br />
la Gloria di Beati e Santi (1683). La fama di questo monastero<br />
è in parte <strong>le</strong>gata alla presenza di una bellissima farmacia<br />
Anagni - Interno della Cattedra<strong>le</strong><br />
Anagni - La Cripta della Cattedra<strong>le</strong><br />
<br />
<br />
<br />
affrescata dal pittore G.<br />
Manco con temi pompeiani e<br />
decorata con artistiche vetrine,<br />
entro <strong>le</strong> quali sono ancora conservati<br />
i recipienti in vetro che<br />
contenevano i medicamenti.<br />
Di fronte si trova un salottino,<br />
decorato da Filippo Balbi, un<br />
tempo adibito a foresteria.<br />
LE CATTEDRALI E<br />
LE CHIESE<br />
“Grande e so<strong>le</strong>nne paese pagano e<br />
cattolico...” così Carducci<br />
descrisse la Ciociaria, una terra,<br />
che, già durante il paganesimo,<br />
fu comp<strong>le</strong>tamente ricoperta di<br />
templi ed intrisa di sacralità.<br />
Sul<strong>le</strong> alture del<strong>le</strong> città più<br />
importanti furono erette <strong>le</strong><br />
Acropoli sacre a Saturno, sul<strong>le</strong><br />
porte del<strong>le</strong> <strong>mura</strong> poligonali, i<br />
simboli fallici furono scolpiti a<br />
protezione della popolazione,<br />
invocando la benevo<strong>le</strong>nza degli<br />
dei, ai quali si chiedeva la fertilità;<br />
nei boschi, presso <strong>le</strong> sorgenti<br />
sacre sul<strong>le</strong> are, si sacrificarono<br />
gli agnelli, in occasione<br />
del “Ver Sacrum”. Quando il<br />
paganesimo cessò di fare proseliti,<br />
la Ciociaria, raggiunta già<br />
da alcuni apostoli e pie donne,<br />
conobbe l’alba di un nuovo<br />
giorno, annunciato presso gli<br />
eremi di montagna e nei protocenobi,<br />
dai quali scaturì la regola<br />
del monachesimo benedettino.<br />
I rilievi del<strong>le</strong> colline “si<br />
vestirono” di nuovi edifici, e,<br />
sui resti dei templi, furono edi-<br />
12 13<br />
ficati <strong>le</strong> più bel<strong>le</strong> Chiese ed<br />
Abbazie di questa terra, che vive<br />
ancora oggi la propria fede con<br />
grande fervore spiritua<strong>le</strong>.<br />
LA CATTEDRALE<br />
DI ANAGNI<br />
Superbo capolavoro di architettura<br />
medioeva<strong>le</strong>, la Cattedra<strong>le</strong><br />
di Anagni è un insieme e<strong>le</strong>gante<br />
ed equilibrato della mescolanza<br />
dello sti<strong>le</strong> romanico campano<br />
con quello lombardo. Sulla<br />
severa facciata principa<strong>le</strong>, in<br />
sti<strong>le</strong> romanico campano, si<br />
aprono tre portali di cui il centra<strong>le</strong><br />
è sormontato da una decorazione<br />
derivata dall’arte classica<br />
con influenze bizantine.<br />
Molto più movimentata è la<br />
facciata posteriore, dove sono<br />
evidenti <strong>le</strong> influenze dello sti<strong>le</strong><br />
romanico lombardo, con <strong>le</strong> tre<br />
bel<strong>le</strong> absidi, sormontate da<br />
una serie di colonnine, che<br />
sostengono piccoli archi, dai<br />
fregi finemente decorati.<br />
Comp<strong>le</strong>tamente staccato dal<br />
corpo della chiesa, è il massiccio<br />
campani<strong>le</strong> con cinque ordini<br />
di aperture a monofore,
ifore e trifore.<br />
Di grande rilievo è l’interno<br />
della chiesa, abbellito, nel XIII<br />
secolo, con un pavimento a<br />
mosaico policromo, opera dei<br />
Cosma, e la zona del transetto,<br />
dove si trovano la bella iconostasi,<br />
la sedia episcopa<strong>le</strong> e il<br />
cero pasqua<strong>le</strong> realizzati dal<br />
<br />
Veroli - Basilica di S. M. Salome:<br />
La Scala Santa<br />
Veroli - Basilica di Santa Maria Salome<br />
Vassal<strong>le</strong>tto.<br />
Sulla navata latera<strong>le</strong> destra, in corrispondenza del transetto, si trova<br />
l’ingresso alla Cripta, vero tesoro di questa chiesa. Per la qualità pittorica<br />
e la comp<strong>le</strong>ssità dei temi affrescati su queste pareti, essa è<br />
considerata uno dei più importanti cicli pittorici d’arte medioeva<strong>le</strong>.<br />
Sempre lungo la navata destra, si trova anche l’ingresso al Lapidario<br />
e al Museo del Tesoro, che raccoglie paramenti sacri e oggetti<br />
d’uso liturgico, del XII-XV secolo.<br />
LA BASILICA DI SANTA MARIA SALOME<br />
DI VEROLI<br />
Questa Basilica, dedicata a Santa Salome, patrona e protettrice di<br />
Veroli, fu costruita nel 1209 quando, secondo <strong>le</strong> cronache medioevali,<br />
furono ritrovati i resti della pia donna, testimone del Calvario<br />
di Cristo.<br />
Sebbene vio<strong>le</strong>nti terremoti distrussero in parte il primo oratorio<br />
medioeva<strong>le</strong>, i verolani non cessarono di venerare la Santa e non<br />
rinunciarono mai a ricostruire il suo tempio.<br />
La Chiesa, come la vediamo oggi, è frutto dei lavori di ristrutturazione,<br />
compiuti nel 1700 su richiesta dei vescovi de’ Zaulis e Tartagni.<br />
L’interno, a tre navate, è ricco di bel<strong>le</strong> te<strong>le</strong> e affreschi attribuiti al<br />
Cavalier d’ Arpino, a F. Solimena, G. Passeri e G. Brandi, noti<br />
esponenti della pittura manierista e barocca. Poche ma interessanti<br />
sono <strong>le</strong> tracce della primitiva chiesa medioeva<strong>le</strong>: si notino gli affreschi<br />
del XIII- XV secolo, sulla parete del transetto a sinistra e<br />
nell’oratorio sottostante, con l’ingresso dalla navata di destra.<br />
Alatri - S. Maria Maggiore<br />
<br />
Particolarmente e<strong>le</strong>gante la<br />
Confessione, dove sono custoditi<br />
i resti di Santa Salome, che<br />
lasciò a Veroli un frammento<br />
della Croce di Cristo, <strong>mura</strong>to<br />
nel dodicesimo gradino della<br />
Scala Santa, situata nella<br />
seconda cappella a destra, dove<br />
si può lucrare l’indulgenza p<strong>le</strong>naria,<br />
seguendo <strong>le</strong> indicazioni<br />
dettate da Benedetto XIV, nel<br />
1751, e scritte sulla lapide a<br />
destra della scala.<br />
LA CHIESA DI SANTA<br />
MARIA MAGGIORE<br />
DI ALATRI<br />
Santa Maria Maggiore di Alatri,<br />
con la sua e<strong>le</strong>gante facciata, contribuisce<br />
ad abbellire l’omonima<br />
piazza cittadina, dove anticamente<br />
si trovavano edifici di culto<br />
pagano. Sulla facciata a capanna<br />
è inserito, come un prezioso<br />
mer<strong>le</strong>tto, un grande rosone trilobato<br />
che consente d’illuminare<br />
l’interno altrimenti troppo buio.<br />
Sulla sommità della navata<br />
destra, si appoggia il bel campani<strong>le</strong><br />
merlato. L’interno della<br />
chiesa presenta il duplice aspetto<br />
romanico e gotico, frutto della<br />
ricostruzione avvenuta dopo<br />
che, nel 1350, un vio<strong>le</strong>nto terremoto<br />
distrusse in parte la chiesa.<br />
Preziose opere d’epoca mediova<strong>le</strong><br />
sono custodite nella prima<br />
cappella di sinistra. Si tratta del<br />
gruppo ligneo della Madonna di<br />
Costantinopoli (XII sec.),<br />
capolavoro d’arte romanica,<br />
chiuso un tempo entro due pannelli<br />
laterali, dove sono scolpite<br />
<strong>le</strong> scene della vita di Maria e di<br />
Cristo, mentre il Trittico del<br />
Salvatore, sulla parete destra, è<br />
opera autografa del pittore Antonio<br />
d’ Alatri (XV sec), seguace<br />
di Genti<strong>le</strong> da Fabriano.<br />
Sull’altare, si trova il fonte battesima<strong>le</strong>,<br />
la cui vasca è sorretta<br />
da tre talamoni (XIII sec.), che<br />
esprimono gesti enigmatici; si fa<br />
notare, per la sua raffinata deco-<br />
razione e per l’ equilibrato senso<br />
architettonico, il piccolo tabernacolo<br />
rinascimenta<strong>le</strong> (parete<br />
latera<strong>le</strong> della navata destra), scolpito<br />
evidentemente da un artista<br />
dalla grande capacità tecnica.<br />
LA CATTEDRALE DI<br />
SAN DOMENICO<br />
DI SORA<br />
L’Abbazia di San Domenico è<br />
ubicata alla periferia di Sora,<br />
quasi sul<strong>le</strong> sponde del fiume<br />
Fibreno, affluente del Liri, e fu<br />
eretta, nel 1011, sui resti della<br />
villa agreste della famiglia di<br />
Cicerone.<br />
Il suo aspetto attua<strong>le</strong> lo si deve<br />
ai lavori di restauro, compiuti<br />
14 15<br />
<br />
dopo che un vio<strong>le</strong>nto terremoto,<br />
nel 1915, distrusse gran<br />
parte dell’edificio.<br />
L’interno della chiesa è a tre<br />
navate, con transetto rialzato,<br />
per lasciare spazio alla cripta<br />
sottostante, che rappresenta<br />
l’ambiente più suggestivo di<br />
questo edificio. Essa è del tipo<br />
“ad oratorio” ed è costituita da<br />
materia<strong>le</strong> di spoglio, coperta<br />
con volte a crociera.<br />
Lo spazio è ripartito in tre<br />
navate da 16 colonne, tutte<br />
disuguali e provenienti da edifici<br />
pagani. Nell’abside maggiore,<br />
è posto l’altare in marmo<br />
(dono di C<strong>le</strong>mente XI,<br />
1706), dove si trovano <strong>le</strong> spoglie<br />
di San Domenico di Foli-
gno, morto nel 1031, in età<br />
avanzata, dopo aver fondato<br />
importanti monasteri benedettini<br />
in Ciociaria. Sul lato sinistro<br />
della Chiesa, si nota il prospetto<br />
anteriore di un monumento<br />
funebre ad opera<br />
quadrata (I sec. a. C.) dove è<br />
posta una lapide, che ricorda la<br />
nascita in questo luogo del<br />
famoso oratore romano M. T.<br />
Cicerone.<br />
Anche sui fianchi esterni della<br />
chiesa, si trovano numerosi<br />
bassorilievi di monumenti<br />
funerari di condottieri romani,<br />
risa<strong>le</strong>nti al I sec. a. C.<br />
CHIESA SANTUARIO DI<br />
S. MARIA DEL PIANO<br />
DI AUSONIA<br />
Incerta è la data della prima<br />
costruzione di questa Chiesa, di<br />
cui <strong>le</strong> tracce più antiche sono rap-<br />
Sora - Cattedra<strong>le</strong> di San Domenico<br />
Ausonia - Santuario di S. Maria del Piano<br />
presentate dal ciclo di affreschi<br />
della cripta.<br />
La Chiesa, molto danneggiata dai<br />
bombardamenti della seconda<br />
guerra mondia<strong>le</strong>, è in sti<strong>le</strong> barocco<br />
nel primo tratto, fino al pre-<br />
<br />
<br />
sbiterio, e in sti<strong>le</strong> medioeva<strong>le</strong>.<br />
Di grande pregio, è il pavimento<br />
che un tempo decorava l’altare<br />
maggiore e oggi collocato in<br />
sacrestia: esso è uno sp<strong>le</strong>ndido<br />
esempio di maiolica napo<strong>le</strong>tana<br />
del 1700.<br />
Da una stretta scalinata, si accede<br />
alla cripta romanico bizantina<br />
del X secolo, divisa in un<br />
ambulacro comunicante con tre<br />
cappel<strong>le</strong>, dove si trova un suggestivo<br />
ciclo di affreschi, che narrano<br />
la vita e la storia di S.<br />
Remicarda.<br />
IL SANTUARIO DELLA<br />
MADONNA DI CAN-<br />
NETO DI SETTEFRATI<br />
Il Santuario della Madonna di<br />
Canneto rappresenta una del<strong>le</strong><br />
mète di pel<strong>le</strong>grinaggio più<br />
importanti per i fedeli che, dal<br />
Lazio, dall’Abruzzo e dal Molise,<br />
nei giorni compresi tra il 18<br />
e il 22 agosto, vengono numerosi<br />
a rendere omaggio alla<br />
Madonna Nera, custodita nella<br />
Chiesa. Il Santuario, di origine<br />
medieva<strong>le</strong> (sec. XII), sorge nel<br />
cuore dell’omonima val<strong>le</strong>, sui<br />
resti di un tempio pagano dedicato<br />
alla dea Mefiti, dove i<br />
pastori rinnovavano il loro patto<br />
di fratellanza. E’ situato nel<br />
territorio del comune di Sette-<br />
Aquino - Chiesa di Santa Maria della Libera<br />
frati, incastonato nel cuore del<br />
versante lazia<strong>le</strong> del Parco<br />
Naziona<strong>le</strong> d’Abruzzo e del<br />
Molise, da dove si gode un<br />
meraviglioso panorama su una<br />
del<strong>le</strong> più suggestive e caratteristiche<br />
zone della Ciociaria, la<br />
Val<strong>le</strong> di Comino.<br />
LA CHIESA DI SANTA<br />
MARIA DELLA LIBERA<br />
DI AQUINO<br />
La chiesa venne edificata nel<br />
1125, per vo<strong>le</strong>re di due nobildonne,<br />
Oddolina e Maria, raffigurate<br />
nel mosaico sul porta<strong>le</strong><br />
d’ingresso della chiesa. Il nome<br />
<strong>le</strong> deriva dall’aver preso il posto<br />
del tempio pagano, dedicato ad<br />
Erco<strong>le</strong> liberatore, di cui sono<br />
stati usati molti frammenti. La<br />
facciata, molto austera, è preceduta<br />
da un portico a tre arcate;<br />
da notare sull’ultimo gradino<br />
della ripida scalinata, <strong>le</strong> tabulae<br />
lusorie, una sorta di dama<br />
per il gioco del<strong>le</strong> pedine, molto<br />
in voga tra i romani. L’interno,<br />
di austera semplicità, è a tre<br />
navate ed è coperto da un grande<br />
soffitto a capriate.<br />
Sul lato sinistro della chiesa,<br />
si trova l’arco trionfa<strong>le</strong> di<br />
Marcantonio, con colonne<br />
binate e capitelli corinzi. Esso<br />
è una del<strong>le</strong> tante testimonianze<br />
d’epoca romana, rinvenute<br />
su questo territorio un tempo<br />
attraversato dall’antica Via Latina,<br />
di cui resta ancora visibi<strong>le</strong> un<br />
tratto di basolato strada<strong>le</strong>.<br />
LA CHIESA<br />
DI SAN NICOLA<br />
DI CASTRO DEI VOLSCI<br />
Al<strong>le</strong> porte del borgo medioeva<strong>le</strong><br />
di Castro dei Volsci, si trova<br />
questa Chiesa di grande semplicità<br />
architettonica, decorata<br />
da affreschi di scuola benedettina,<br />
raffiguranti scene<br />
dell’Antico e Nuovo Testamen-<br />
16 17<br />
<br />
to, disposte lungo <strong>le</strong> due pareti<br />
principali, e alcune figure<br />
isolate di Santi. Si consiglia<br />
una passeggiata nei vicoli del<br />
paese, nel cui Belvedere si erge<br />
il Monumento alla mamma<br />
Ciociara.<br />
LA CHIESA DI<br />
S. ANTONINO DI POFI<br />
La Chiesa è dedicata a S.<br />
Antonino martire che, in questo<br />
luogo, fece scaturire una<br />
sorgente d’acqua. La facciata,<br />
molto semplice, è affiancata da<br />
una torre campanaria.<br />
Le modeste dimensioni e la<br />
semplicità della linea architettonica<br />
non lasciano presagire la<br />
presenza dello sp<strong>le</strong>ndido<br />
affresco raffigurante il Giudizio<br />
Universa<strong>le</strong>, di scuola<br />
umbro lazia<strong>le</strong> (XV secolo), che<br />
orna la controfacciata della<br />
parete d’ingresso.
la storia<br />
i borghi<br />
Numerosi paesi, in Ciociaria, sono arroccati sui rilievi collinari, <strong>le</strong><br />
cui alture sono occupate da un castello, una rocca, o una torre.<br />
Questo fenomeno, si originò in seguito al<strong>le</strong> “lotte per <strong>le</strong> investiture<br />
papali”, quando <strong>le</strong> famiglie aristocratiche, direttamente impegnate<br />
nel<strong>le</strong> e<strong>le</strong>zioni del pontefice, predisposero la feudalizzazione del territorio,<br />
attraverso una capillare organizzazione militare, per la difesa<br />
o il contrattacco.<br />
I primi castelli, perciò, erano per lo più costruzioni fondate in posizioni<br />
scarsamente accessibili, realizzati con materia<strong>le</strong> rinvenuto sul<br />
posto, e, soprattutto, situati presso i tracciati di importanti vie consolari,<br />
per raggiungere rapidamente Roma o Napoli nei momenti di<br />
bisogno.<br />
Tra <strong>le</strong> <strong>mura</strong> di questi castelli di Ciociaria, spesso spartani, ma<br />
non privi di fascino, è possibi<strong>le</strong> rievocare i nomi e <strong>le</strong> storie di<br />
famosi personaggi come Federico II di Svevia, in lotta contro<br />
il potere papa<strong>le</strong>, Ce<strong>le</strong>stino V, morto prigioniero a Fumone, o<br />
l’affascinante poetessa Vittoria Colonna, amica epistolare di<br />
Michelangelo Buonarroti e sua musa ispiratrice. Intorno a<br />
queste fortezze militari, ben presto si raccolse la comunità, che<br />
chiedeva protezione al “signore”, costruendo così, degli sp<strong>le</strong>ndidi<br />
borghi medioevali, ancora oggi intatti e ricchi di storia,<br />
arte e cultura.<br />
Vico nel Lazio - Cinta Muraria<br />
Aquino - Torre del Castello<br />
18<br />
Bovil<strong>le</strong> Ernica - Le Mura<br />
<br />
In questa sede, vi proponiamo<br />
i più rappresentivi, nella speranza<br />
così di sol<strong>le</strong>ticare la<br />
curiosità del turista facendogli<br />
scoprire una terra tanto interessante,<br />
generosa ed ospita<strong>le</strong>.<br />
LA ROCCA MEDIOE-<br />
VALE E IL PALAZZO<br />
DUCALE DI ALVITO<br />
Sulla sommità di Monte Morrone,<br />
sorge la Rocca di Alvito<br />
e il suo borgo medioeva<strong>le</strong>, circondato<br />
da <strong>mura</strong> rinforzate da<br />
possenti torri cilindriche.<br />
Questa bella cittadina fu<br />
governata dai benedettini, nel<br />
X secolo, dai Conti d’ Aquino,<br />
nel Medioevo, e, successivamente,<br />
dai Gallio, ai quali si<br />
deve la trasformazione e l’ab-<br />
medioevali ed i castelli<br />
bellimento del Palazzo Duca<strong>le</strong>,<br />
attualmente adibito a sede<br />
municipa<strong>le</strong>.<br />
Si accede al piano nobi<strong>le</strong>,<br />
attraversando un atrio monumenta<strong>le</strong><br />
e sa<strong>le</strong>ndo un’imponente<br />
scalinata, per visitare: il<br />
ce<strong>le</strong>bre Teatrino di corte,<br />
decorato con affreschi e stucchi<br />
e recentemente restaurato,<br />
la Camera del Duca, la Sala<br />
del Consiglio, dove sono conservate<br />
bel<strong>le</strong> te<strong>le</strong> ed affreschi<br />
di scuola napo<strong>le</strong>tana del XVIII<br />
secolo.<br />
Tra <strong>le</strong> numerose testiomonianze<br />
artistiche, merita una visita la<br />
Chiesa di San Simeone Profeta,<br />
abbellita da te<strong>le</strong> ed affreschi<br />
barocchi, realizzati da allievi di<br />
Luca Giordano e M. Stanzione.<br />
IL CASTELLO<br />
DI AQUINO<br />
Dopo <strong>le</strong> distruzioni ad opera<br />
dei Barbari, la comunità di<br />
Aquino iniziò la costruzione<br />
di un Castello, affiancato da<br />
torri per la difesa della città.<br />
Il Castello, dedicato alla S.<br />
Croce, era detto Castello<br />
Pretorio perchè vi si amministrava<br />
la giustizia. Esso fu la<br />
residenza della famiglia d’ Aquino,<br />
alla qua<strong>le</strong> apparteneva San<br />
Tommaso. Grazie a recenti<br />
restauri, ciò che resta di esso<br />
è tornato a mostrare <strong>le</strong> sue<br />
bifore e l’imponente torre<br />
romboida<strong>le</strong>, che si affaccia sul<br />
“vallone d’ Aquino”, dove un<br />
tempo si trovava un lago prosciugato<br />
nel XVI secolo.<br />
19<br />
<br />
la storia<br />
<br />
BOVILLE ERNICA<br />
Bovil<strong>le</strong> Ernica è uno dei centri<br />
maggiormente fortificati della<br />
Ciociaria con <strong>le</strong> sue tre cinte<br />
di <strong>mura</strong> e <strong>le</strong> 18 torri, costruite<br />
per respingere <strong>le</strong> invasioni<br />
degli eserciti stranieri. Il borgo<br />
è caratterizzato da pregevoli<br />
chiese ed e<strong>le</strong>ganti palazzi rinascimentali<br />
e barocchi, che<br />
riecheggiano la fierezza di questa<br />
antica roccaforte. In particolare,<br />
la chiesa di San Pietro<br />
Ispano può essere considerata<br />
un vero e proprio scrigno, ricco<br />
di preziose opere d’arte<br />
come il Sarcofago pa<strong>le</strong>ocristiano<br />
del IV sec. d.C., raffigurante<br />
scene del Vecchio e<br />
Nuovo Testamento, la Croce<br />
in porfido un tempo esposta<br />
all’ingresso di San Pietro in<br />
Vaticano per essere baciata in
occasione dell’anno giubilare,<br />
la Madonna con il Bambino<br />
dello scultore rinascimenta<strong>le</strong><br />
Sansovino; meritevo<strong>le</strong> di particolare<br />
attenzione è l’angelo<br />
a mosaico, che ornava la<br />
Navicella in San Pietro, attribuito<br />
a Giotto e salvato da<br />
Monsignor Simoncelli dalla<br />
distruzione del<strong>le</strong> opere<br />
medioevali, operata durante i<br />
lavori di rinnovamento della<br />
basilica vaticana.<br />
Altrettanto interessante è la<br />
visita della parrocchia<strong>le</strong> di<br />
Sant’Angelo, con i suoi interni<br />
affrescati e la presenza di<br />
un dipinto attribuito al Cavalier<br />
d’Arpino.<br />
Passeggiando all’interno del<strong>le</strong><br />
strette viuzze, lungo i vicoli<br />
della cittadella, non può sfuggire<br />
l’imponenza del Palazzo<br />
Filonardi, la cui facciata è<br />
abbellita con un ampio porta<strong>le</strong><br />
del Vignola, di Palazzo Vizzardelli,<br />
Palazzo De Angelis<br />
e del Convento di San Francesco.<br />
IL CASTELLO<br />
DI FUMONE<br />
Entrando a Fumone e superata<br />
Fumone - Il Borgo<br />
Fumone - Interni del Castello<br />
<br />
la Porta, che dà accesso alla cittadina-castello,<br />
si ha la sensazione<br />
di aver lasciato al<strong>le</strong> spal<strong>le</strong><br />
il mondo e di essere improvvisamente<br />
tornati indietro nel<br />
tempo, fino al Medio Evo,<br />
quando questo borgo, dalla<br />
posizione inespugnabi<strong>le</strong>, venne<br />
usato come prigione di Stato.<br />
Proprio a causa della sua particolare<br />
posizione, Fumone ricoprì,<br />
nei secoli, il ruolo di<br />
“antenna d’avvistamento”, tanto<br />
che, con i suoi segnali di<br />
fumo, al<strong>le</strong>rtava Roma di possi-<br />
bili incursioni di nemici. Tutto<br />
l’abitato urbano del paese è,<br />
dunque, sorto, con funzione<br />
difensiva, e <strong>le</strong> case medioevali<br />
ruotano intorno al castellofortezza,<br />
trasformato nel 1500<br />
dal cardina<strong>le</strong> Longhi in residenza<br />
gentilizia. Attualmente il<br />
castello, ancora di proprietà<br />
della famiglia Longhi, è mèta di<br />
visitatori di tutto il mondo,<br />
affascinati dalla tragica storia di<br />
Papa Ce<strong>le</strong>stino V, morto qui<br />
prigioniero nel 1296, per vo<strong>le</strong>re<br />
del suo riva<strong>le</strong> Bonifacio VIII.<br />
All’interno, si trovano preziose<br />
opere d’arte, la cappella dedicata<br />
a Ce<strong>le</strong>stino V, dove sono<br />
custodite numerose reliquie di<br />
Santi, e un panoramico giardino<br />
pensi<strong>le</strong>, che, per la sua<br />
estensione (3500 mq), è il più<br />
grande d’ Europa, posto ad un<br />
altezza di 800 metri.<br />
IL CASTELLO<br />
DI ISOLA DEL LIRI<br />
La mo<strong>le</strong> di questo castello<br />
domina l’abitato di Isola del<br />
Liri, ed è inserito in una<br />
sp<strong>le</strong>ndida cornice paesaggistica,<br />
essendo circondato da<br />
un’ampio parco, dove scorre<br />
il Fiume Liri, che qui compie<br />
un salto di 29 metri,<br />
dando vita ad una suggesti-<br />
<br />
Isola del Liri - Il Castello Boncompagni Viscogliosi<br />
M. S. G. Campano -Veduta notturna del Castello<br />
<br />
va cascata nel centro del<br />
paese. Più volte rimaneggiato<br />
nel corso dei secoli, il<br />
castello oggi della famiglia<br />
Viscogliosi, ha bel<strong>le</strong> sa<strong>le</strong> di<br />
rappresentanza, affrescate nel<br />
XVII secolo, ma attualmente<br />
non è visitabi<strong>le</strong>.<br />
IL CASTELLO DUCALE<br />
DI MONTE SAN<br />
GIOVANNI CAMPANO<br />
Il centro storico di Monte San<br />
Giovanni Campano conserva<br />
angoli suggestivi, che riecheg-<br />
giano secoli di civiltà, di distruzioni<br />
e di ricostruzioni. Data l’area<br />
abbastanza circoscritta, si<br />
può godere della sua bel<strong>le</strong>zza<br />
con un solo colpo d’occhio. Il<br />
Palazzetto Rinascimenta<strong>le</strong>,<br />
con il suo porta<strong>le</strong> squadrato,<br />
rappresenta il cuore della cittadella,<br />
e<strong>le</strong>gantemente decorato in<br />
sti<strong>le</strong> cinquecentesco. A dominare<br />
il paese è il Castello duca<strong>le</strong>,<br />
originariamente costruito nel XI<br />
secolo e più volte distrutto e<br />
rimaneggiato. Esso possedeva<br />
ben 70 torri, due carceri, (uno<br />
maschi<strong>le</strong> e uno femmini<strong>le</strong>) e<br />
una serie di camminamenti<br />
interni per lo spostamento veloce<br />
del<strong>le</strong> truppe in caso di assedio.<br />
Purtroppo, a nulla valse<br />
questa imponente fortificazione<br />
quando il paese fu attaccato, nel<br />
1495, dall’esercito di Carlo V<br />
d’Angiò, che qui sperimentò gli<br />
effetti disatrosi della polvere da<br />
sparo, provocando uno spaventoso<br />
massacro.<br />
La fama di questo paese è <strong>le</strong>gata<br />
al nome di San Tommaso d’Aquino,<br />
che, nel Castello, venne<br />
tenuto prigioniero per due anni<br />
(1238-40), per vo<strong>le</strong>re dei suoi<br />
genitori, che non condividevano<br />
la sua scelta di farsi monaco<br />
domenicano. Il giovane, riuscito<br />
ad evadere con la complicità<br />
della sorella, si trasferì a Colonia<br />
20 21<br />
per studiare, sotto la guida di<br />
Alberto Magno. Oggi la piccola<br />
cappella a lui dedicata è mèta<br />
di numerosi visitatori, che<br />
vogliono approfondire la conoscenza<br />
della dottrina di una del<strong>le</strong><br />
menti più eccel<strong>le</strong>nti della<br />
Chiesa Cristiana.<br />
IL CASTELLO<br />
DI PIGLIO<br />
L’abitato di Piglio si sviluppa lungo<br />
la cresta di uno sperone roccioso,<br />
al<strong>le</strong> falde del monte Scalambra.<br />
La sua importante posizione<br />
strategica determinò la<br />
costruzione di un Castello- fortezza,<br />
assalito dal<strong>le</strong> truppe papaline<br />
di Pasqua<strong>le</strong> II, in lotta contro<br />
l’imperatore Enrico V.<br />
Dopo essere appartenuto a varie<br />
signorie, nel 1430, esso divenne<br />
possedimento dei Colonna .<br />
L’edificio, che ha subito parziali<br />
modifiche, conserva ancora l’aspetto<br />
originario con gli ambienti<br />
voltati a crociera. Purtroppo,<br />
nulla più rimane del<strong>le</strong> camere, un<br />
tempo decorate, di cui si fa menzione<br />
in un documento del 1340,<br />
dell’ archivio Colonna.<br />
IL CASTELLO<br />
DI TORRE CAIETANI<br />
Il Castello fu costruito tra il<br />
basso Impero e l’alto Medio<br />
Evo, come è attestato da alcuni
documenti, e, nel IX secolo, appartenne al senatore Teofilatto, che<br />
si garantì così un importante punto strategico difensivo per i suoi<br />
possedimenti in questa zona del Lazio.<br />
Il Castello rivestì questo ruolo anche quando fu acquistato, nel<br />
1296, da Roffredo Caetani, che lo considerò indispensabi<strong>le</strong> per<br />
contrastare i domini dei Colonna. Sebbene, inizialmente, il Castello<br />
sia stato un vero e proprio “castrum militare”, divenne, nel XII<br />
secolo, una residenza signori<strong>le</strong>, come testimoniano <strong>le</strong> sa<strong>le</strong> ornate da<br />
bifore, che incorniciano il bel paesaggio sottostante, dove si trova il<br />
lago di Canterno.<br />
IL CASTELLO DI TREVI NEL LAZIO<br />
Di Trevi nel Lazio si hanno notizie già da Plinio il Vecchio, che ne<br />
parla nel ”Naturalis Historia”. In età repubblicana, dopo la sconfitta<br />
degli Equi ,Treba Augusta (questo il suo antico nome), venne<br />
e<strong>le</strong>vata a “Municipio” e, in età imperia<strong>le</strong>, <strong>le</strong> vennnero accordati<br />
importanti privi<strong>le</strong>gi da Augusto, mantenuti in seguito anche da<br />
altri imperatori, come attesterebbe un’iscrizione del 193 d. C. Nel<br />
Medioevo, la sua particolare posizione geografica, a difesa dell’alta<br />
val<strong>le</strong> dell’Aniene, suggerì la costruzione di un Castello fortificato,<br />
posto su uno sperone di roccia calcarea, nella piazza principa<strong>le</strong> della<br />
Civita. Già Papa A<strong>le</strong>ssandro IV comprese la necessità di possedere<br />
questa postazione strategica e, nel XIV secolo, i Caietani, che<br />
occuparono stabilmente il castello per due secoli, ne curarono<br />
l’ampliamento, predisponendo ambienti adatti ad essere abitati.<br />
Oggi, grazie ad un lungo lavoro di restauro, questo castello, che un<br />
tempo rappresentava uno dei più importanti domìni dell’Abbazia di<br />
Subiaco, per popolazione e vastità di territori, è visitabi<strong>le</strong>.<br />
Torre Cajetani - Il Castello<br />
Veroli - Borgo Santa Croce<br />
<br />
VEROLI<br />
Veroli è un e<strong>le</strong>gante cittadina<br />
il cui duplice aspetto medioeva<strong>le</strong><br />
e settecentesco attesta i<br />
periodi economicamente più<br />
floridi della sua comunità.<br />
Nel quartiere medioeva<strong>le</strong> di<br />
Santa Croce, si trovano <strong>le</strong><br />
antiche case medioevali, che<br />
un tempo ospitavano fiorenti<br />
botteghe artigiane. E’ Piazza<br />
Mazzoli il cuore della cittadina<br />
e qui si trovano <strong>le</strong> massime<br />
espressioni del potere civi<strong>le</strong> e<br />
religioso. Il Palazzo Comuna<strong>le</strong>,<br />
la cui aula consiliare nel<br />
suo genere è tra <strong>le</strong> più bel<strong>le</strong><br />
d’Italia, essendo composta da<br />
scranni in noce di una antica<br />
sacrestia, e la Cattedra<strong>le</strong> di<br />
S. Andrea, al cui interno<br />
sono conservati un ricco<br />
Tesoro liturgico medioeva<strong>le</strong><br />
e preziose te<strong>le</strong> sei-settecentesche.<br />
Di notevo<strong>le</strong> interesse<br />
religioso è la Basilica di Santa<br />
Salome, patrona della città.<br />
Le cronache medioevali<br />
narrano che la pia donna<br />
Salome, madre degli apostoli<br />
Giacomo e Giovanni, portò a<br />
Veroli un frammento della<br />
croce di Cristo, riconosciuta<br />
come vera da papa Benedetto<br />
Veroli - Aula Consiliare<br />
Vico nel Lazio - Palazzo del Governatore<br />
<br />
XIV che, nel 1751, concesse<br />
di edificare una Scala Santa<br />
per l’ espiazione dei peccati.<br />
Da visitare la vicina Gal<strong>le</strong>ria<br />
la Catena, dove in<br />
mostra permanente si trovano<br />
<strong>le</strong> te<strong>le</strong> del pittore Francis<br />
Cox, esponente di spicco<br />
dell’arte contemporanea, e<br />
la Biblioteca Giovardiana,<br />
vero tesoro di cultura con i<br />
suoi codici miniati, <strong>le</strong> pergamene<br />
e <strong>le</strong> stampe cinquecentesche.<br />
Non si può lasciare Veroli<br />
senza aver passeggiato nei<br />
suggestivi vicoli di Borgo San<br />
Leucio, un tempo roccaforte<br />
ernica e poi prigione medioeva<strong>le</strong>,<br />
luogo di nascita dell’umanista<br />
Aonio Pa<strong>le</strong>ario.<br />
VICO NEL LAZIO<br />
Posto a difesa della Val<strong>le</strong> del<br />
Cosa e della Via Prenestina,<br />
Vico conserva ancora oggi<br />
intattta una poderosa cinta<br />
<strong>mura</strong>ria in calcarea intervallata<br />
da 24 torri e, per questo, viene<br />
paragonata alla città francese di<br />
22 23<br />
<br />
Carcassonne.<br />
Da una del<strong>le</strong> quattro porte d’accesso<br />
si entra in paese, dove si<br />
trova la Chiesa di san Miche<strong>le</strong><br />
Arcangelo, che conserva nel<br />
transetto sinistro un prezioso<br />
paliotto d’altare a mosaico in<br />
oro del XIII secolo, proveniente<br />
dalla basilica romana di San<br />
Giovanni in Laterano.<br />
La Chiesa di Santa Maria conserva,<br />
oltre ad una serie di affreschi<br />
e un prezioso crocifisso in<br />
madreperla inciso a mano di<br />
manifattura orienta<strong>le</strong>, una piccola<br />
cripta con tracce di antichissimi<br />
affreschi. Ancora una<br />
sorpresa Vico la riserva visitando<br />
la Chiesa di San Martino,<br />
dove è custodito un prezioso<br />
gruppo ligneo raffigurante la<br />
Madonna col Bambino, risa<strong>le</strong>nte<br />
al XII secolo: la statua possiede<br />
la so<strong>le</strong>nnità bizantina fusa<br />
alla plasticità poderosa del<strong>le</strong><br />
sculture romaniche.<br />
Esempio significativo dell’ edilizia<br />
civi<strong>le</strong> medioeva<strong>le</strong> è il bel<br />
palazzo del Governatore, un<br />
tempo residenza della famiglia<br />
Colonna. Sulla facciata, si aprono<br />
bifore e logge, che ne al<strong>le</strong>ggeriscono<br />
la massiccia struttura<br />
<strong>mura</strong>ria.
Numerose città della Ciociaria<br />
hanno origini molto antiche,<br />
essendosi sviluppate in epoca preromana,<br />
con la presenza del<strong>le</strong><br />
popolazioni volsche ed erniche.<br />
Dopo la loro sottomissione a<br />
Roma, esse ne diventarono fedeli<br />
al<strong>le</strong>ate e, in età imperia<strong>le</strong>, si<br />
ingrandirono con importanti edifici.<br />
La visita di questi centri<br />
archeologici, cinti da poderose<br />
<strong>mura</strong> poligonali, e fondate,<br />
secondo il mito, da Saturno,<br />
riserva grandi sorprese anche a<br />
chi ha visitato <strong>le</strong> grandiose rovine<br />
di centri più grandi.<br />
CASSINO<br />
Nonostante i feroci bombardamenti<br />
del 1944, che distrussero<br />
comp<strong>le</strong>tamente l’abitato di Cassino<br />
e la ce<strong>le</strong>bre Abbazia, ancora<br />
oggi è possibi<strong>le</strong> ammirare l’area<br />
archeologica dell’antica “Casinum”<br />
romana.<br />
In località Crocifisso, lungo la<br />
strada che sa<strong>le</strong> all’abbazia, troviamo<br />
l’ingresso al Museo Archeo-<br />
Cassino - Antica via Latina<br />
Cassino - Teatro Romano<br />
la storia<br />
l archeologia<br />
logico Naziona<strong>le</strong>, nel<strong>le</strong> cui sa<strong>le</strong><br />
sono conservati numerosi reperti,<br />
che testimoniano il passaggio dalla<br />
cultura volsca a quella romana.<br />
Fu in età imperia<strong>le</strong> che “Casinum”<br />
conobbe il periodo di massima<br />
floridezza economica con la<br />
presenza di numerose famiglie<br />
24<br />
Cassino - Resti dell’Anfiteatro<br />
Ferentino - Porta Maggiore<br />
<br />
patrizie, che trasformarono questo<br />
territorio da terra agreste a<br />
terra degli “otia”. E, in particolare,<br />
si ricorda la matrona romana<br />
Ummidia Quadratilla, che fece<br />
edificare, a proprie spese, il Teatro,<br />
l’Anfiteatro ed il Mauso<strong>le</strong>o,<br />
posti in prossimità della antica<br />
<br />
via Latina e ancora oggi visitabili<br />
attraversando l’antica Porta<br />
Campana.<br />
CASTRO DEI VOLSCI<br />
L’area archeologica e il Museo<br />
civico di Madonna del Piano,<br />
in località Casa<strong>le</strong>, riguardano un<br />
insediamento di notevo<strong>le</strong> interesse,<br />
databi<strong>le</strong> tra il IV secolo a.C.<br />
ed il IX secolo d.C.<br />
Gli scavi hanno riportato alla<br />
luce <strong>le</strong> strutture di una villa di<br />
età repubblicana, nuc<strong>le</strong>i di una<br />
villa imperia<strong>le</strong> e sovrapposizioni<br />
con edificio di culto e battistero,<br />
oltre ad una necropoli del<br />
VI-VII secolo d.C. Le fasi evolutive<br />
del grande comp<strong>le</strong>sso archeologico<br />
di Castro dei Volsci si possono<br />
ripercorrere nel loca<strong>le</strong><br />
Museo civico, che presenta uno<br />
spaccato di tutte <strong>le</strong> epoche storiche<br />
del territorio. Strumenti preistorici<br />
in pietra, materiali votivi<br />
provenienti dai santuari preromani,<br />
raffinati monili in bronzo,<br />
alcuni oggetti d’influenza<br />
etrusca, statue, vasi, rivestimenti<br />
in marmi policromi con motivi<br />
geometrici, oggetti in vetro di età<br />
romana sono sistemati nel<strong>le</strong> teche<br />
del Museo, dove è stata anche<br />
ricostruita una sepoltura alto<br />
medioeva<strong>le</strong> della necropoli datata<br />
tra il IV e il VII sec. d. C.<br />
<br />
FERENTINO<br />
Posto su un col<strong>le</strong>, a 393 metri di<br />
altezza sulla sottostante val<strong>le</strong> del<br />
Sacco, Ferentino è uno dei pochi<br />
paesi del frusinate che conserva,<br />
entro l’agglomerato urbano, una<br />
interessante area archeologica con<br />
monumenti ancora oggi ben conservati.<br />
Entro il tessuto urbano del<strong>le</strong><br />
imponenti <strong>mura</strong> poligonali, che<br />
cingono la città per più di due<br />
chilometri, troviamo inglobato<br />
nell’ imponente Acropoli il suggestivo<br />
“Mercato Romano”,<br />
databi<strong>le</strong> tra il II e I sec. a. C., in<br />
ottimo stato di conservazione. La<br />
città, durante la municipalità<br />
romana, conobbe pace e sp<strong>le</strong>ndore,<br />
tanto da divenire mèta privi<strong>le</strong>-<br />
25<br />
<br />
giata di vil<strong>le</strong>ggiatura per tutti<br />
coloro che, come il poeta Orazio,<br />
desideravano trascorrere un<br />
periodo di tranquillità lontano da<br />
Roma senza, però, dover rinunciare<br />
a una vita di società. A<br />
Ferentino, infatti, troviamo ancora<br />
i resti del Teatro romano (II<br />
sec.d. C), che poteva ospitare<br />
fino a 3500 persone, e i resti di<br />
grandiosi edifici termali in parte<br />
inclusi sotto la chiesa di S. Lucia.<br />
Le numerose epigrafi, rinvenute<br />
nel centro storico, rappresentano<br />
una tangibi<strong>le</strong> testimonianza della<br />
presenza a Ferentino di personaggi<br />
prestigiosi, come Flavia<br />
Domitilla, moglie di Vespasiano,<br />
Traiano Pompeo ed Aulo Quintilio<br />
Prisco per citarne solo alcuni.
Un importante documento storico è rappresentato dal monumento<br />
funerario del censore romano Aulo Quintilio Prisco. Si tratta di<br />
un’edicola, sulla qua<strong>le</strong> sono state incise <strong>le</strong> ultime volontà di questo<br />
personaggio generoso, che elargiva al popolo una somma in denaro<br />
e cibo nel giorno del suo comp<strong>le</strong>anno (nove maggio), mentre sessanta<br />
sesterzi erano riservati alla manutenzione del monumento<br />
erettogli dalla municipalità.<br />
<strong>Frosinone</strong> - Reperti nel Museo Archeologico<br />
Ferentino - Monumento ad Aulo Quintilio Prisco<br />
<br />
L’AREA ARCHEOLOGI-<br />
CA DI FREGELLAE E IL<br />
MUSEO DI CEPRANO<br />
Il pianoro, sul qua<strong>le</strong> sorgeva Fregellae,<br />
si estende per circa 90<br />
ettari tra i territori di Arce e<br />
Ceprano. Una serie di campagne<br />
di scavo, iniziate nel 1978, ha<br />
permesso di acquisire significative<br />
conoscenze sulla struttura<br />
urbanistica della antica città, di<br />
cui è stata scavata l’area pubblica,<br />
una zona residenzia<strong>le</strong> ed alcuni<br />
santuari. Il reticolo viario della<br />
zona centra<strong>le</strong> della città ha rivelato<br />
la presenza di un asse principa<strong>le</strong><br />
da identificarsi, presumibilmente,<br />
con un tratto urbano della<br />
Via Latina. Al di sotto<br />
dell’asse strada<strong>le</strong>, è stato rinvenuto<br />
un acquedotto, mentre nel<br />
comp<strong>le</strong>sso archeologico sono<br />
evidenti i resti di una vasta area<br />
del Foro, di un edificio terma<strong>le</strong><br />
e di santuari, in particolare<br />
quello dedicato al dio della<br />
Alatri - Ara Pulvinata di età augustea<br />
Pofi - Museo Preistorico di Pofi<br />
<br />
<br />
Medicina, Esculapio. Di particolare<br />
rilievo, inoltre, numerose<br />
domus, che hanno restituito<br />
interessanti testimonianze della<br />
partecipazione dei fregellani alla<br />
guerra combattuta da Roma in<br />
Oriente contro Antioco III di<br />
Siria, tra il 191 e 189 a.C. I materiali<br />
riportati alla luce sono esposti<br />
nel<strong>le</strong> sa<strong>le</strong> dell’Antiquarium di<br />
Ceprano (ospitato nel Palazzo<br />
Comuna<strong>le</strong>), dove si può rivivere<br />
la storia di questa antica città, e<br />
si possono ammirare talamoni,<br />
terrecotte ex voto, frammenti<br />
architettonici del santuario di<br />
Esculapio, pavimenti a mosaico,<br />
che costituiscono solo una<br />
parte dell’ecceziona<strong>le</strong> quantità di<br />
materia<strong>le</strong> rinvenuto e in corso di<br />
restauro.<br />
IL MUSEO<br />
ARCHEOLOGICO<br />
DI FROSINONE<br />
In seguito ad alcune campagne di<br />
scavo, condotte nel territorio del<br />
capoluogo, sono stati riportati<br />
alla luce una serie di suppel<strong>le</strong>ttili<br />
del periodo pre-romano e romano,<br />
esposte nel<strong>le</strong> sa<strong>le</strong> del Museo<br />
Comuna<strong>le</strong>, al<strong>le</strong>stito in un palazzo<br />
del centro storico. Le raccolte<br />
sono costituite da materia<strong>le</strong> in<br />
pietra e in terracotta, da vasellame<br />
ceramico, oggetti di ornamentazione<br />
persona<strong>le</strong>, sculture<br />
<br />
ed epigrafi. La visita al Museo è<br />
particolarmente interessante,<br />
anche grazie ai supporti didattici,<br />
che consentono il riconoscimento<br />
della funzione dei materiali e<br />
ne ricostruiscono il contesto in<br />
cui essi sono stati ritrovati.<br />
In questo modo, è possibi<strong>le</strong><br />
conoscere anche l’importanza<br />
dell’area in questione, un tempo<br />
attraversata dalla via Latina,<br />
importante via di comunicazione,<br />
che raggiungeva l’abitato dell’<br />
antica Frusino e l’anfiteatro<br />
romano, di cui oggi sono visibili<br />
pochi resti all’inizio dell’ attua<strong>le</strong><br />
via Roma.<br />
POFI<br />
Nel nuovo Museo Preistorico di<br />
Pofi, aperto al pubblico nel 2001,<br />
sono esposti importanti reperti<br />
che testimoniano la presenza dell’uomo<br />
tra i più antichi in Europa<br />
(Uomo di Ceprano, 800.000<br />
anni; Uomo di Anagni, 458.000<br />
anni; Uomo di Pofi, 350.000<br />
anni). Tra i reperti umani appare<br />
particolarmente importante il<br />
cranio dell’uomo di Ceprano, che<br />
per i tratti morfologici e la cronologia,<br />
oltre che rappresentare il<br />
più antico ominide rinvenuto in<br />
Europa, rappresenta una tappa<br />
importante dell’evoluzione umana.<br />
Nel percorso didattico sono messe<br />
in evidenza <strong>le</strong> fasi tecnologiche<br />
nella produzione di manufatti<br />
litici, con reperti del Pa<strong>le</strong>olitico<br />
inferiore, rinvenuti in numerose<br />
località della provincia di <strong>Frosinone</strong>.<br />
La tipologia e la cronologia<br />
di questi antichi insediamenti,<br />
26 27<br />
testimoniate da choppers, amigda<strong>le</strong>,<br />
raschiatoi, nuc<strong>le</strong>i, rappresentano<br />
l’evoluzione cultura<strong>le</strong> di<br />
un milione di anni. Gli antichi<br />
ambienti (laghi, fiumi, vulcani),<br />
scenario variabi<strong>le</strong> per clima ed<br />
evoluzione del territorio, sono<br />
rappresentati dal<strong>le</strong> flore e faune<br />
fossili tra cui spiccano notevoli<br />
resti di e<strong>le</strong>fanti. I crani, <strong>le</strong> mandibo<strong>le</strong>,<br />
<strong>le</strong> zanne, <strong>le</strong> ossa lunghe dei<br />
pachidermi esposti colpiscono<br />
per la qualità e lo stato di conservazione.<br />
La visita al Museo rappresenta<br />
la scoperta del più antico<br />
passato dell’uomo attraverso <strong>le</strong><br />
testimonianze di una regione, il<br />
Lazio meridiona<strong>le</strong> interno, tra i<br />
più interessanti in Europa.<br />
SUPINO<br />
In località “Cona del Popolo”, tra<br />
Supino e Morolo, si trovano i<br />
resti di una villa romana del I<br />
secolo d.C.<br />
Venuti alla luce nel corso di<br />
recenti scavi archeologici, presentano<br />
numerosi ambienti, con<br />
pavimenti in marmo a mosaico.<br />
Questi ultimi sono di una bel<strong>le</strong>zza<br />
e raffinatezza, tipiche dell’età<br />
imperia<strong>le</strong>. Alcuni rappresentano<br />
soggetti marini, con<br />
pesci, conchiglie, meduse, tritoni,<br />
mostri marini e figure<br />
femminili che nuotano. Ta<strong>le</strong><br />
comp<strong>le</strong>sso archeologico rappresenta<br />
la testimonianza evidente<br />
che la zona, immersa nel verde,<br />
al<strong>le</strong> falde dei monti Lepini, fin<br />
dall’epoca romana, veniva<br />
apprezzata e abitata dal<strong>le</strong> famiglie<br />
benestanti.