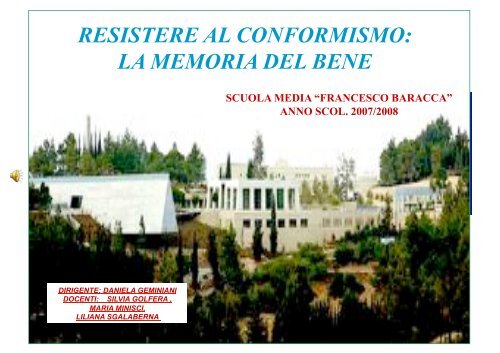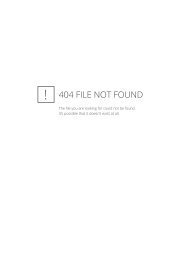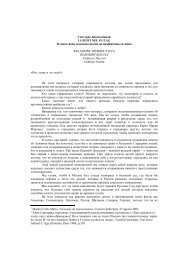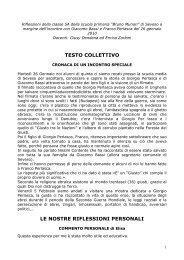RESISTERE AL CONFORMISMO: LA MEMORIA DEL BENE - Gariwo
RESISTERE AL CONFORMISMO: LA MEMORIA DEL BENE - Gariwo
RESISTERE AL CONFORMISMO: LA MEMORIA DEL BENE - Gariwo
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>RESISTERE</strong> <strong>AL</strong> <strong>CONFORMISMO</strong>:<br />
DIRIGENTE: DANIE<strong>LA</strong> GEMINIANI<br />
DOCENTI: SILVIA GOLFERA ,<br />
MARIA MINISCI,<br />
LILIANA SG<strong>AL</strong>ABERNA<br />
<strong>LA</strong> <strong>MEMORIA</strong> <strong>DEL</strong> <strong>BENE</strong><br />
SCUO<strong>LA</strong> MEDIA “FRANCESCO BARACCA”<br />
ANNO SCOL. 2007/2008
<strong>RESISTERE</strong> <strong>AL</strong> <strong>CONFORMISMO</strong>:<br />
“IL BUIO OLTRE <strong>LA</strong> SIEPE” DI<br />
HARPER LEE<br />
STORIA DEGLI EBREI DI LUGO<br />
DI ROMAGNA<br />
MOSHE BEJSKI: IL TRIBUN<strong>AL</strong>E<br />
<strong>DEL</strong> <strong>BENE</strong><br />
SFUGGIRE <strong>AL</strong> GENOCIDIO: GLI<br />
ARMENI<br />
I GIUSTI DI LUGO: L’ISTITUTO<br />
SAN GIUSEPPE<br />
VISITA <strong>AL</strong><strong>LA</strong> SCUO<strong>LA</strong> DI PACE INCONTRO CON RAV CARO E<br />
LEA OPPENHEIM
RIFLESSIONI DA “IL BUIO OLTRE <strong>LA</strong> SIEPE” DI HARPER LEE<br />
.<br />
<strong>LA</strong> PAURA <strong>DEL</strong> DIVERSO<br />
“Il buio oltre la siepe”. Queste parole riassumono<br />
tutto. Molti dei nostri problemi derivano proprio da<br />
questo. Il buio oltre la siepe è la paura del lontano e<br />
del diverso. Il voler attenersi ad un modello di<br />
società, spesso sbagliato. É l’essere conformi,<br />
uguali agli altri, sempre e comunque. Non saper<br />
riconoscere ciò che è giusto e ciò che è sbagliato<br />
DIVERSITÁ<br />
“Arrabbiarsi è umano, dopo aver letto questa storia.<br />
Ma è anche umano rendersi conto che la diversità è<br />
presente nel mondo e sempre lo sarà. Tutti siamo<br />
diversi e bisogna apprezzare ed essere apprezzati<br />
per questa diversità che caratterizza ognuno di noi.<br />
É fantastico!.”
PREGIUDIZI<br />
-Durante le vacanze io e i miei amici, andavamo a giocare a calcio. C’erano anche dei marocchini<br />
della nostra età. Poco a poco mi sono reso conto che non sono così male, né diversi da noi.<br />
-Si possono combattere i pregiudizi? Si, perché se prendi in giro una persona, poi magari la<br />
conosci meglio, ti diventa simpatica, e scopri che le cose che pensavi sono false.<br />
I GIUSTI<br />
-Penso che Atticus sia un uomo giusto, che non si fa influenzare dagli altri. Giusto significa<br />
credere nella cosa in cui si crede di più, e restargli fedele. Mi ha colpito molto una frase che dice<br />
alla figlia Scout: “Se non facessi la cosa giusta, non potrei più guardare in faccia nessuno”.<br />
-Significa che se non fai la cosa giusta saprai di avere sbagliato<br />
solo per paura di contraddire l’opinione della maggioranza.<br />
-Il giusto non è Superman o il cavaliere senza macchie e senza<br />
paura. Il giusto ha paura, e proprio per questo diventa coraggioso,<br />
colui che sa agire.<br />
Lee Harper, autrice de<br />
“Il buio oltre la siepe”
DONNE ARMENE<br />
GLI ARMENI<br />
Gli Armeni sono un gruppo etnico originario del<br />
Caucaso e dell'Anatolia orientale. Una larga<br />
concentrazione di armeni si trova in Armenia, dove<br />
rappresentano la maggioranza, mentre molte altre<br />
comunità sono sparse per il globo, per un totale di<br />
circa 8 milioni di individui. Gli Armeni hanno<br />
popolato l'Anatolia e il sud del Caucaso per oltre<br />
3.500 anni<br />
INTELLETTU<strong>AL</strong>I<br />
ARMENI
Il primo stato Armeno fu fondato agli inizi del VI secolo a.C. All'apice della sua potenza,<br />
dal 95 al 65 a.C., si estendeva dal Caucaso settentrionale a tutta la parte orientale<br />
dell'odierna Turchia, dal Libano all'Iran nord-occidentale. In seguito fu parte dell'Impero<br />
Romano (114 d.C. –118 d.C). Nel 301 d.C. l'Armenia fu la prima nazione ad adottare il<br />
Cristianesimo come religione di stato. Durante la sua successiva decandenza politica,<br />
l'Armenia si affidò alla chiesa per preservare e la propria identità.<br />
Paesaggi armeni
Genocidio armeno<br />
Primo massacro armeno<br />
Nel 1890 nell'Impero Ottomano si contavano circa 2,5 milioni di armeni, in maggioranza cristiani.<br />
Per reprimere il movimento autonomista armeno, il Governo ottomano incoraggiò fra i Curdi, che<br />
vivevano nello stesso territorio, sentimenti di odio anti-armeno.<br />
La violenza dei Curdi e l'aumento delle tasse spinsero gli Armeni alla rivolta. L'esercito ottomano<br />
rispose assassinando migliaia di armeni e bruciandone i villaggi. Due anni dopo alcuni rivoluzionari<br />
armeni occuparono la banca ottomana a Istanbul. Nella repressione persero la vita 50.000 armeni.
SECONDO MASSACRO ARMENO<br />
Durante la prima guerra mondiale, il governo della Turchia guidato dai Giovani Turchi temeva<br />
che gli armeni si alleassero coi russi. Allora eliminarono 300 nazionalisti armeni e ordinarono<br />
la deportazione dall'Anatolia verso i deserti della Siria e della Mesopotamia. Le marce della<br />
morte coinvolsero 1.800.000 persone. Moltissimi morirono di fame, malattia o sfinimento.<br />
Altri furono massacrati dalla milizia curda e dall'esercito turco.<br />
Il governo turco ancora oggi<br />
rifiuta di riconoscere il<br />
genocidio armeno, e questo è<br />
causa di tensione tra Unione<br />
Europea e Turchia. Una<br />
recente legge francese<br />
punisce con il carcere chi<br />
nega il genocidio armeno. In<br />
Turchia parlare del genocidio<br />
degli armeni è<br />
“antipatriottico”.<br />
Immagini del massacro
MAPPA <strong>DEL</strong> GENOCIDIO
<strong>LA</strong> <strong>MEMORIA</strong> ARMENA
<strong>LA</strong> DIASPORA ARMENA<br />
! Francia: 250,000<br />
! Georgia: 248,900<br />
! Turchia: 100,000<br />
! Giordania: 70,000<br />
! Canada: 40,505<br />
! Grecia: 35,000<br />
! Bulgaria: 10,832<br />
! Iraq: 10,000<br />
! Israele: 9,800<br />
! Egitto: 8,200<br />
! Russia: 1,131,000<br />
! Stati Uniti: 385,488<br />
! Iran: 400,000<br />
! Siria: 190,000<br />
! Armenia: 3.000.000<br />
! Libano: 140,000<br />
! Azerbaigian: 120,000<br />
! Sud America: 150,000<br />
! Ucraina: 100,000<br />
! Resto del mondo: 100,000
Fin dal medioevo a Lugo c’è stata una presenza<br />
ebraica.<br />
Girolamo Bonoli nella sua “Storia di Lugo ed<br />
annessi dall’origine fino al 1732” fissa una<br />
falsa origine in base alla supposta datazione di<br />
una lapide (1285), che invece risale al 1585. Si<br />
tratta della lapide di un certo Moshè mi-Pesahim.<br />
( da cui il cognome Pascali o Pasquali).<br />
Lugo attirava gli ebrei perché zona di mercato,<br />
e agricoltori e mercanti avevano bisogno di<br />
denaro liquido. Fra gli ebrei infatti c’erano<br />
prestatori di denaro, attività proibita ai cristiani.<br />
Gli ebrei lughesi vivevano mischiati ai<br />
concittadini, soprattutto in via Limite, oggi<br />
Corso Garibaldi, dove esisteva anche una<br />
prima Sinagoga.<br />
EBREI A LUGO<br />
Nel 1437 Lugo passa sotto gli Estensi, che proteggono gli ebrei, utili allo sviluppo<br />
dell’economia del Ducato. Ne giungono da Spagna e Portogallo, fra cui molti Marrani.
Portavano comunque un segno di riconoscimento: un disco giallo sul petto degli uomini,<br />
un velo giallo per le donne. Erano esentati banchieri, medici e studenti<br />
Fra il 1555 e il 1569 i Papi Paolo IV e Pio V pubblicano alcune Bolle (documenti che hanno<br />
valore di legge) contro gli ebrei. Ordinano di vivere in quartieri separati, i ghetti, di avere una sola<br />
sinagoga, di non possedere beni immobili, di non tenere domestici cristiani. Queste disposizioni<br />
toccarono gli ebrei lughesi dal 1597, quando il Ducato ferrarese passò allo Stato pontificio.<br />
Banco di<br />
prestito<br />
Il Ghetto venne istituito nell’ultimo tratto di via<br />
S. Agostino, oggi Corso Matteotti. Fissate due<br />
porte all’estremità della via, si poteva transitare<br />
solo di giorno. Le case vennero cedute egli ebrei<br />
in affitto perpetuo.<br />
Nel 1639 su circa 6000 abitanti, 606 sono ebrei.<br />
La comunità ha un Rabbino, enti<br />
assistenziali per i poveri, una scuola. La vita<br />
culturale è intensa: sulle lapidi del cimitero sono<br />
incisi composizioni poetiche, i pijutin.<br />
L’analfabetismo è quasi assente. Nel 1807 il<br />
rabbino di Lugo, Salomone David, partecipò al<br />
Sinedrio convocato a Parigi da Napoleone<br />
Bonaparte, che aveva fatto leggi a favore degli<br />
ebrei<br />
Ketubot, contratto<br />
matrimoniale
Il ghetto di Lugo, in<br />
una vecchia foto<br />
Con la conquista napoleonica<br />
gli ebrei diventano<br />
‘cittadini’.<br />
Col Congresso di Vienna,<br />
torna lo Stato Pontificio e gli<br />
ebrei persero i diritti<br />
conquistati. Solo nel 1860, col<br />
Regno d’Italia, gli ebrei<br />
ottennero pieni diritti.<br />
Verso il 1880 fu aperto il<br />
primo negozio fuori dal ghetto,<br />
della famiglia Del Vecchio. Un<br />
po’ alla volta ben sei negozi<br />
sotto al Pavaglione erano di<br />
ebrei. Ma alla fine dell’800<br />
molti preferirono spostarsi in<br />
città più grandi<br />
Nel 1938, quando furono emanate le leggi razziali, a Lugo risiedevano ancora alcuni ebrei. La<br />
sinagoga, in attività fino a quell’anno, fu distrutta durante la guerra da un bombardamento. Gli arredi<br />
salvati si trovano in parte a Ferrara. Alcuni documenti, come i Protocolli della comunità, sono<br />
conservati al British Museum di Londra, altri a New York.
Disegno del ghetto di Lugo<br />
Antico ghetto di Lugo
<strong>AL</strong>CUNE DISPOSIZIONI NEL<strong>LA</strong> SCUO<strong>LA</strong><br />
Art. 1. All'ufficio di insegnante nelle scuole statali … di<br />
qualsiasi ordine e grado … non potranno essere ammesse<br />
persone di razza ebraica.<br />
Art. 2. Alle scuole di qualsiasi ordine e grado… non potranno<br />
essere iscritti alunni di razza ebraica.<br />
LEGGI RAZZI<strong>AL</strong>I <strong>DEL</strong> 1938<br />
Agli ebrei fu vietato: fare il portiere in case di ariani, il<br />
fotografo, il mediatore, il tipografo. Esercitare il<br />
commercio ambulante. Vendere oggetti d'arte, libri,<br />
apparecchi radio, carte da gioco, strumenti ottici. Gestire<br />
scuole di ballo, di taglio, agenzie di viaggio e turismo.<br />
Pubblicare avvisi mortuari, inserire il proprio nome in<br />
elenchi telefonici, essere affittacamere, tenere apparecchi<br />
radio, accedere alle biblioteche pubbliche, far parte di<br />
associazioni culturali e sportive ….e molte altre cose<br />
ancora.<br />
Tutto questo viene<br />
raccontato nel film<br />
“Concorrenza sleale”<br />
di Ettore Scola.
Sinopsi. "Concorrenza sleale" : Roma 1938.<br />
In scena i proprietari rispettivamente d'una<br />
sartoria e d'una merceria. Dapprima divisi da<br />
rivalità professionale, che alimentano con<br />
furbizia, diventano amici quando uno dei due,<br />
di religione ebraica, è privato delle libertà<br />
fondamentali dalle leggi razziali.<br />
“Concorrenza sleale” di Ettore Scola<br />
Commenta l’autore:<br />
"Vivere nella stessa<br />
città, nella stessa<br />
strada.<br />
Fare lo stesso lavoro, appartenere alla stessa<br />
classe sociale, avere la stessa composizione<br />
familiare (una moglie, due figli, zii e nonni) eppure<br />
non essere uguali , non avere gli stessi diritti, non<br />
poter frequentare le stesse scuole, non poter esercitare il proprio lavoro né tenere<br />
aperto il proprio negozio, conoscere l'intolleranza e l'esclusione. Scoprire di essere<br />
considerati "diversi", per nascita e per razza.”
<strong>AL</strong>IMENTARE L’ODIO:<br />
VIGNETTE ANTISEMITE
Moshe Bejski col giornalista Gabriele Nissim<br />
“Il tribunale del bene” di Moshe Bejski<br />
Moshe Bejski, ebreo polacco, è uno dei 1200 salvati da<br />
Oskar Schindler. Creatore del Tribunale del bene è<br />
stato presidente della Commissione dei giusti presso il<br />
Memoriale di Yad Vashem a Gerusalemme. Come<br />
Simon Wiesenthal aveva sentito il dovere di dare la<br />
caccia agli ex-nazisti, Moshe voleva scovare tutti<br />
coloro che avevano aiutato ebrei in pericolo : “Non<br />
volevo che un solo giusto fosse dimenticato da noi<br />
ebrei” diceva.<br />
Chi sono i Giusti? Non superuomini ma persone che di fronte a un male estremo<br />
autorizzato dalla legge hanno cercato di salvare delle vite, semplicemente<br />
comportandosi da uomini.<br />
Secondo Moshe l’esperienza di un genocidio produce una doppia responsabilità: di<br />
ricordare le vittime e di non dimenticare coloro che vi si sono opposti, soccorrendo i<br />
perseguitati. Sognava in ogni scuola un’enciclopedia del bene, dove leggere storie di<br />
uomini buoni. Per non privare i giovani della fiducia nell’umanità e nel futuro. Di<br />
fronte al male, ciò che conta è il comportamento delle persone”.
Una lapide sulla Rocca e una al<br />
cimitero ebraico ricorda gli ebrei<br />
lughesi spariti nella Shoah.<br />
Ma alcuni cittadini hanno cercato<br />
di aiutarli: il rag. Poggiolini, il<br />
prof. Carlo Gambetti, Pino<br />
Baracca, la dott. Gallignani e il<br />
prof. Tommaselli, l’Istituto<br />
Salesiano, le suore di San<br />
Giuseppe, il sig. Galamini.<br />
-Il cav. Gambetti ricevette nel<br />
1965 una medaglia dalla Brigata<br />
ebraica.<br />
-I Salesiani ospitarono tre ragazzi:<br />
Eugenio Galandauer, Oskar<br />
Yacabovich e Carlo Bergher, di<br />
10, 13 e 12 anni.<br />
Lughesi in soccorso di ebrei<br />
Istituto<br />
S.Giuseppe<br />
Lugo<br />
-L’Istituto San Giuseppe ospita le sorelle Lidia ed Elena Forlì, Cecilia ed Antonia Galandauer, di 6 e 5 anni,<br />
Edda Yacabovich di 10 anni, le bambine Zuckermann, di Bologna.<br />
-Le suore del Sacro Cuore nascondono la coppia Randi, di cui si perdono le tracce.<br />
Molti altri lughesi offrono il proprio aiuto, nell’anonimato. Ci furono anche spie e approfittatori, ma di costoro non<br />
vale la pena ricordarsi.
Presso l’Istituto San Giuseppe frequenti erano le perquisizioni<br />
da parte dei tedeschi. Per questo le ospiti cambiano spesso<br />
collocazione, all’interno del convento: nel solaio, sotto mucchi<br />
di fascine, nella porcilaia, in gallerie sotterranee scavate<br />
nell’orto. Spesso per rendere difficili le ricerche, le suore<br />
fingevano di non capire le richieste dei tedeschi. Cercavano<br />
anche di mantenere con loro buoni rapporti, offrendo cibo e ciò<br />
che era possibile. Oggi le ragazze Zuckerman vivono una a<br />
Roma e l’altra in Israele. Tanti bambini persero la vita nella<br />
Shoah, e non divennero mai adulti. Nel 1955 la madre,<br />
Clara Zukerman, scrisse alle suore per ringraziarle di quanto<br />
avevano fatto.
Lettera di Clara Zuckerman<br />
a madre Vittoria Cozzani
La signora Lea Oppenheim, nata nel<br />
1936, trovò rifugio a Cotignola,<br />
nell’autunno del 1943, assieme ai<br />
genitori, protetti da Vittorio Zanzi. Il<br />
padre Marco, medico, assistette la<br />
popolazione di Budrio e Barbiano.<br />
Vittorio Zanzi otterrà il<br />
riconoscimento di “Giusto fra le<br />
nazioni”.<br />
Luciano Caro, rabbino capo della<br />
comunità ebraica di Ferrara, è<br />
nato a Torino. Aveva 6 anni<br />
quando nel 1938 fu espulso dalla<br />
scuola, in seguito alle leggi<br />
razziali. Suo padre è morto ad<br />
Awschwitz.<br />
Incontro con i testimoni:<br />
Rav Luciano Caro e Lea Oppenheim
Questo incontro mi ha fatto<br />
capire che non si deve odiare<br />
neppure chi ci fa del male.<br />
L’odio distrugge chi lo prova.<br />
La signora Lea è piena di energia,<br />
simpatica, ama gli animali. Incredibile,<br />
se si pensa a tutti i guai che ha passato.<br />
DOPO L’INCONTRO: RIFLESSIONI<br />
Ho pensato alle ultime parole del<br />
rabbino: “Ragazzi, vivete sempre la vita<br />
col sorriso sulla bocca”. Quella frase<br />
rappresenta lo stile di vita che vorrei<br />
adottare.
Alla Scuola di Pace di Marzabotto<br />
ore 10 Giochi di gruppo: disporsi in ordine per nome,<br />
nascita poi, “dal più sbagliato al più giusto” .<br />
Folla nel gruppo di “chi si sente sbagliato”.<br />
All’estremo opposto difficile motivare la scelta.<br />
ore 11: Discussione: dove siamo? Cosa è successo in<br />
questo luogo? Definire le parole: alleati, civili,<br />
rastrellamento, occupazione, partigiani, vittime,<br />
carnefici.<br />
“Come immagini i soldati che hanno<br />
compiuto la strage? Chi sono? Come sono le<br />
loro vite? Sono diversi da noi?”<br />
I ragazzi possono scegliere un’immagine che<br />
li aiuti a pensare.<br />
Emergono le parole: impotenza, robot,<br />
terminetor, scheletri, replicante, nulla,<br />
abbandono, solitudine, normalità.
ore 15. Si raccontata la vicenda di Khaled,<br />
un tunisino di Tselsa. Alcuni ebrei,<br />
inseguiti dalle truppe tedesche chiedono<br />
rifugio al villaggio. Tutti sono contrari.<br />
Solo Khaled si offre di aiutarli, contro la<br />
volontà della moglie Amina che teme<br />
rappresaglie. Khaled è fra i “Giusti” a<br />
Gerusalemme.<br />
I ragazzi, divisi in tre gruppi , devono sostenere le<br />
ragioni rispettivamente di Khaled, di Amina e del<br />
villaggio. Per loro è difficile calarsi nella vicenda.<br />
Faticano a trovare argomenti autentici, al di là degli<br />
stereotipi.
ore 15. Si raccontata la vicenda di Khaled,<br />
un tunisino di Tselsa. Alcuni ebrei,<br />
inseguiti dalle truppe tedesche chiedono<br />
rifugio al villaggio. Tutti sono contrari.<br />
Solo Khaled si offre di aiutarli, contro la<br />
volontà della moglie Amina che teme<br />
rappresaglie. Khaled è fra i “Giusti” a<br />
Gerusalemme.<br />
I ragazzi, divisi in tre gruppi , devono sostenere le<br />
ragioni rispettivamente di Khaled, di Amina e del<br />
villaggio. Per loro è difficile calarsi nella vicenda.<br />
Faticano a trovare argomenti autentici, al di là degli<br />
stereotipi.
I ragazzi vogliono parlare di sé e leggere i temi che hanno scritto, dal titolo :<br />
"Racconta un episodio della tua vita in cui hai trovato difficile scegliere, nel compiere un'azione,<br />
tra ciò che tu ritenevi "bene" e ciò che tu ritenevi "male". Quali difficoltà hai incontrato? Come<br />
hai agito? Se hai trovato soluzioni, quali?"<br />
Davide racconta il litigio con uno straniero: si riaccende la discussione. Riemerge forte il senso del<br />
gruppo, la difficoltà ad uscire da schemi riconosciuti come “normali”. L’altro da sé, quando viene da<br />
un mondo sconosciuto, evoca innanzi tutto paura e diffidenza. La differenza emerge più forte rispetto<br />
alle somiglianze.
IL RACCONTO DI DAVIDE<br />
“Un pomeriggio, io e Lollo, siamo andati a prendere una<br />
bella ciambella con la crema. Mentre attraversavamo il<br />
parco del Loto, il più bel parco di Lugo, incontrammo un<br />
ragazzo mai visto. Sembrava uno straniero. Capimmo che<br />
era romeno. Ci salutò, e noi niente. Allora si fermò di<br />
colpo , ci sgommò davanti con la bici e disse: “Vuoi<br />
picchiare??”. Io mi misi a ridere e stavo per fare a botte,<br />
per fargli capire che qui non comanda lui, ma ci pensai due<br />
secondi e mi trattenni. Era meglio di no, perché con le<br />
botte non si risolve niente, almeno così dicono i miei<br />
genitori. Allora gli risposi: “No! Non ne vale la pena”. Lui<br />
rimase zitto e mentre se ne andava, gridò: “Sono nuovo,<br />
state attenti!!” Io e Lollo ce ne andammo ridendo, perché<br />
tanto non poteva farci niente!! Io, come tutti sanno, sono<br />
razzista e mi sarebbe piaciuto dargli una bella lezioncina.<br />
Ma so che è male picchiare, e mi sono trattenuto. Ho fatto<br />
un grande sforzo per stare calmo. I miei genitori me lo<br />
dicono sempre, e io li ho ascoltati. “<br />
Davide
Parlare di sé e dell’umanità che ci<br />
circonda, riconoscere nella storia le tracce<br />
del nostro quotidiano, uscire dal<br />
conformismo e guardare la realtà con<br />
“occhi privi di pregiudizio” è un<br />
percorso lungo che non terminerà oggi.
Resistere al conformismo: la memoria del bene<br />
Lettura di “Il buio oltre la siepe” di Harper Lee<br />
Il ruolo dei Giusti nella Shoah: esempi nella realtà locale.<br />
Istituti religiosi lughesi in soccorso di ebrei perseguitati<br />
Materiali e bibliografia:<br />
“Ebrei a Lugo” ipertesto di Anna Sardelli e Liliana Sgalaberna<br />
Gemma Volli “Gli ebrei a Lugo” in Studi Romagnoli IV 1953<br />
Ines Marach “Il cimitero di Lugo e le sue antiche lapidi”<br />
Liliana Picciotto “I giusti d’Italia” Mondatori 2006“La persecuzione degli ebrei<br />
durante il fascismo” (Le leggi del 1938)” Camera dei deputati<br />
“I giusti e la memoria del bene” Antonia Grasselli e Sante Maletta CUSL<br />
“Il tribunale del bene” Gabriele Nissim<br />
“Aiutami a vivere” Liceo Linguistico S. Giuseppe 2000-2001<br />
“La masseria delle allodole” Atonia Arslan<br />
P. Sonnino, “Questo è stato. Una famiglia italiana nel lager” Il Saggiatore 2004<br />
Film: “Concorrenza sleale” di Scola