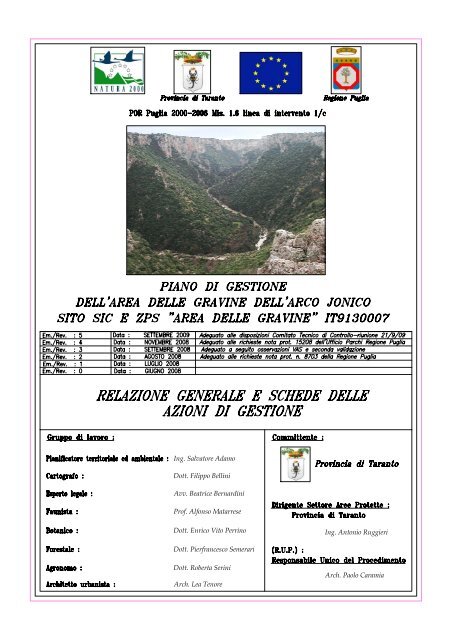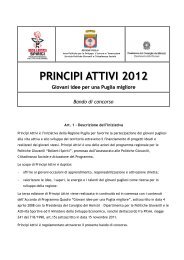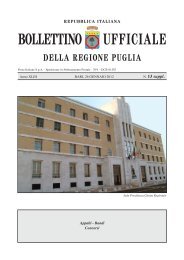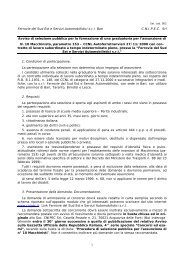Relazione generale - Provincia di Taranto
Relazione generale - Provincia di Taranto
Relazione generale - Provincia di Taranto
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Provincia</strong> <strong>di</strong> <strong>Taranto</strong><br />
POR PUGLIA 2000-2006 Mis. 1.6 linea <strong>di</strong> intervento 1/c<br />
Regione Puglia<br />
PIANO DI GESTIONE DELL’AREA DELLE GRAVINE DELL’ARCO<br />
JONICO SITO SIC E ZPS “AREA DELLE GRAVINE” IT9130007<br />
RELAZIONE GENERALE E SCHEDE DELLE AZIONI DI GESTIONE
INDICE<br />
INTRODUZIONE............................................................................................................................5<br />
PREMESSA...................................................................................................................................7<br />
1. COS’È IL PIANO DI GESTIONE : IL QUADRO NORMATIVO E METODOLOGICO DI RIFERIMENTO8<br />
1.1. Le Direttive Uccelli e Habitat.....................................................................................10<br />
1.2. Natura giuri<strong>di</strong>ca e finalità del PdG ...........................................................................11<br />
1.3. Rapporto tra PdG e altri strumenti <strong>di</strong> pianificazione. La valutazione <strong>di</strong> incidenza 12<br />
1.3.1. Il PdG e la pianificazione comunale ................................................................13<br />
1.3.2. Il PdG ed il PTCP ............................................................................................14<br />
1.3.3. Il PdG ed il PPTR ............................................................................................15<br />
1.3.4. Il PdG ed il Piano Strategico Territoriale <strong>di</strong> Area Vasta..................................15<br />
1.4. Struttura e contenuti del PdG ....................................................................................16<br />
2. QUADRO CONOSCITIVO ........................................................................................................18<br />
2.1. Ubicazione geografica e descrizione dei confini .......................................................18<br />
2.2. Clima regionale e locale.............................................................................................19<br />
2.3. Geologia e geomorfologia ..........................................................................................19<br />
2.4. Idrologia......................................................................................................................20<br />
2.5. Descrizione biologica .................................................................................................20<br />
2.5.1. Schede Natura 2000 : verifica e aggiornamento ..............................................20<br />
2.6. Atlante del territorio ...................................................................................................29<br />
2.6.1. Copertura del suolo, vegetazione e habitat ......................................................29<br />
2.6.2. Tipologie vegetazionali....................................................................................29<br />
2.6.2.1. Formazioni forestali ..........................................................................30<br />
2.6.2.2. Formazioni arbustive.........................................................................31<br />
2.6.2.3. Formazioni erbacee ...........................................................................32<br />
2.7. Stato <strong>di</strong> conservazione degli habitat e delle specie <strong>di</strong> interesse comunitario ...........34<br />
2.7.1. Habitat ...........................................................................................................34<br />
2.7.2. Flora ...........................................................................................................37<br />
2.7.3. Fauna ...........................................................................................................37<br />
2.8. Descrizione socio economica .....................................................................................38<br />
2.8.1. Popolazione ed occupazione ............................................................................38<br />
2.8.2. Uso del suolo ed agricoltura ............................................................................40<br />
2.9. Uso del suolo e proprietà comunali ...........................................................................48<br />
2.10. Tipologie <strong>di</strong> fon<strong>di</strong> utilizzabili per il sito..........................................................55
2.10.1. Piano <strong>di</strong> Sviluppo Rurale 2007-2013 – Puglia, finanziato dal Fondo Europeo<br />
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)......................................................55<br />
2.10.2. LEADER..........................................................................................................56<br />
2.10.3. Programma Operativo FESR 2007-2013 - Puglia, finanziato dal Fondo<br />
Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR)....................................................57<br />
2.10.4. Fondo Sociale Europeo (FSE) .........................................................................57<br />
2.10.5. LIFE + ...........................................................................................................58<br />
2.10.6. 7° Programma Quadro per la Ricerca (FP7)....................................................58<br />
2.11. La pianificazione urbanistica comunale........................................................59<br />
2.12. La normativa urbanistica nelle aree agricole – Zone omogenee “E” ..........60<br />
2.12.1. Comune <strong>di</strong> Castellaneta ...................................................................................60<br />
2.12.2. Comune <strong>di</strong> Crispiano .......................................................................................61<br />
2.12.3. Comune <strong>di</strong> Ginosa............................................................................................62<br />
2.12.4. Comune <strong>di</strong> Laterza...........................................................................................63<br />
2.12.5. Comune <strong>di</strong> Massafra ........................................................................................66<br />
2.12.6. Comune <strong>di</strong> Mottola ..........................................................................................67<br />
2.12.7. Comune <strong>di</strong> Palagianello ...................................................................................69<br />
2.12.8. Comune <strong>di</strong> Statte..............................................................................................72<br />
2.13. In<strong>di</strong>cazioni urbanistiche per il Piano <strong>di</strong> Gestione del Territorio del SIC/ZPS<br />
“Area delle Gravine”..................................................................................................74<br />
2.14. Descrizione dei valori archeologici, architettonici e culturali presenti nel sito<br />
..........................................................................................................................75<br />
2.14.1. Comune <strong>di</strong> Castellaneta ...................................................................................77<br />
2.14.2. Comune <strong>di</strong> Crispiano .......................................................................................78<br />
2.14.3. Comune <strong>di</strong> Ginosa............................................................................................79<br />
2.14.4. Comune <strong>di</strong> Laterza...........................................................................................80<br />
2.14.5. Comune <strong>di</strong> Massafra ........................................................................................81<br />
2.14.6. Comune <strong>di</strong> Mottola ..........................................................................................82<br />
2.14.7. Comune <strong>di</strong> Palagianello ...................................................................................83<br />
2.14.8. Comune <strong>di</strong> Statte..............................................................................................84<br />
2.14.9. Considerazioni .................................................................................................85<br />
2.15. Il paesaggio .....................................................................................................86<br />
2.15.1. I sistemi costitutivi fondamentali delle strutture paesistico-ambientali...........86<br />
3. VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE DI HABITAT E SPECIE ..................................89<br />
3.1. HABITAT .......................................................................................................................89<br />
3.2. FLORA 90<br />
3.3. FAUNA .........................................................................................................................90<br />
3
3.3.1. Specie elencate negli allegati della Direttiva Uccelli ......................................91<br />
3.3.2. Specie elencate negli allegati della Direttiva Habitat ......................................92<br />
3.4. Definizione degli in<strong>di</strong>catori per la valutazione dello stato <strong>di</strong> conservazione ed<br />
evoluzione delle specie animali <strong>di</strong> importanza comunitaria.....................................93<br />
3.5. Definizione degli in<strong>di</strong>catori per la valutazione dello stato <strong>di</strong> conservazione ed<br />
evoluzione degli Habitat forestali e degli Habitat inclusi nella Direttiva Habitat<br />
92/43CEE....................................................................................................................93<br />
3.6. Definizione degli in<strong>di</strong>catori per la valutazione dello stato <strong>di</strong> conservazione ed<br />
evoluzione delle specie vegetali <strong>di</strong> elevato valore biogeografico e conservazionistico<br />
..........................................................................................................................95<br />
3.7. Minacce e fattori limitanti..........................................................................................96<br />
3.7.1. Quadro riassuntivo <strong>di</strong> minacce e fattori limitanti, specie su cui agiscono e<br />
rilevanza.........................................................................................................101<br />
3.7.2. Quadro riassuntivo <strong>di</strong> minacce e fattori limitanti, Habitat su cui agiscono e<br />
rilevanza.........................................................................................................102<br />
4. OBIETTIVI DEL PIANO DI GESTIONE..................................................................................103<br />
5. STRATEGIE DI GESTIONE...................................................................................................108<br />
6. AZIONI DI GESTIONE – SCHEDE TECNICHE.......................................................................109<br />
6.1. Elenco schede delle azioni .......................................................................................109<br />
6.1.1. Tabella delle schede in funzione delle specie target......................................112<br />
6.1.2. Sud<strong>di</strong>visione delle schede per strategie, specie e habitat..............................115<br />
6.1.3. Schede delle Azioni <strong>di</strong> gestione.....................................................................121<br />
ALLEGATI ............................................................................................................................230<br />
Allegato A : Tabelle fitosociologiche ..............................................................................231<br />
Allegato B : Acronimi delle forme biologiche, delle forme <strong>di</strong> crescita e dei tipi corologici<br />
...................................................................................................................................239<br />
Allegato C : Elenco della cartografia del sito SIC/ZPS “Area delle Gravine” allegata al<br />
Piano <strong>di</strong> Gestione......................................................................................................240<br />
4
INTRODUZIONE<br />
Il Territorio Ionico ha la storia del suo paesaggio incisa in due fattori: la natura e<br />
l’antropologia. Chi scende dalla Murgia dei Trulli incontra imme<strong>di</strong>atamente la profon<strong>di</strong>tà del<br />
Golfo <strong>di</strong> <strong>Taranto</strong> <strong>di</strong>steso verso l’orizzonte me<strong>di</strong>terraneo. Chi risale verso l’interno vede<br />
l’anfiteatro calcareo innalzarsi repentino verso l’altopiano murgese, in solo pochi chilometri si<br />
osserva un salto altimetrico da zero a 500 metri. Dal tavolato della Murgia dei Trulli sono<br />
visibili i solchi profon<strong>di</strong> delle “Gravine” scavati nei fianchi dell’altipiano che degrada verso lo<br />
Ionio magno greco.<br />
All’interno <strong>di</strong> questi fenomeni geologici caratterizzanti ha agito nel corso dei millenni l’uomo<br />
con una sintesi complessa e molteplice <strong>di</strong> civiltà e <strong>di</strong> culture. Da qui il risultato o<strong>di</strong>erno del<br />
paesaggio tarantino: composto da esistenze e preesistenze. Confronto imprescin<strong>di</strong>bile fra<br />
interventi determinati dalle esigenze dell’uomo ed elementi della natura inelu<strong>di</strong>bili:<br />
conoscenza e incomprensioni; incontri e contrasti. Così sul piano antropologico occorre<br />
considerare gli apporti interni, frutto dell’elaborazione delle popolazioni autoctone, ed i flussi<br />
<strong>di</strong> saperi, tecnologie e civiltà giunti, nel corso del tempo e da provenienze <strong>di</strong>verse,<br />
dall’esterno, in particolare dalle sponde delle varie rive del Me<strong>di</strong>terraneo: Balcani, penisola<br />
Egea, Me<strong>di</strong>o Oriente, Africa settentrionale.<br />
Gli stessi geo-tipi vegetali e faunistici trovano il loro ancoraggio nell’aria vasta del<br />
Me<strong>di</strong>terraneo, teatro <strong>di</strong> migrazioni e spostamenti stagionali (uccelli e pollini), così come<br />
esistono da questa parte dell’Adriatico paleospecie che ritroviamo nella Penisola Balcanica e<br />
fra la Macedonia e il Mar Nero (quercus troiana, o tipi <strong>di</strong> salvia, orchidee).<br />
In questo quadro geo-naturale e geo-culturale occorre collocare ogni aspetto paesaggistico,<br />
se<strong>di</strong>mento archeologico e valore antropologico, capaci nella loro sintesi <strong>di</strong> modellare il<br />
territorio <strong>di</strong>chiarato dalla Regione Puglia, alla fine del <strong>di</strong>cembre 2005, Parco Regionale della<br />
Terra delle Gravine.<br />
Occorre poi ricordare che nel 1993 con il riconoscimento dei Sassi <strong>di</strong> Matera e nel 1996 con<br />
il riconoscimento dei Trulli <strong>di</strong> Alberobello, l’Unesco ha incluso i due manufatti litici <strong>di</strong> questa<br />
area nella lista mon<strong>di</strong>ale dei beni tutelati dal prestigioso organismo della conoscenza e della<br />
scienza. Tale inclusione ha comportato una doppia in<strong>di</strong>cazione: da una parte ha collocato i<br />
due patrimoni a Mezzogiorno, quali istanza della storia delle civiltà e delle relazioni fra i<br />
popoli me<strong>di</strong>terranei e pertanto meritevoli <strong>di</strong> essere protetti, e dall’altra ha incoraggiato la<br />
politica del territorio a puntare le sue carte sull’Amor Loci, ovvero: salvaguar<strong>di</strong>a dei beni preesistenti<br />
e valorizzazione degli stessi sotto il profilo della conoscenza e del turismo. Per<br />
estensione ha invitato le popolazioni della Terra delle Gravine e dei Trulli, a ricostruire a<br />
partire dalla risorsa dei beni culturali la propria identità presente e futura.<br />
La Regione Puglia, nel 2005, con l’istituzione del Parco Terra delle Gravine, ha ritagliato un<br />
territorio che non a caso abbraccia la Murgia delle Gravine: Ginosa, Laterza, Castellaneta,<br />
Palagianello, Statte, Cristiano, Mottola, Massafra, San Marzano, Grottaglie, e monte la<br />
Murgia dei Trulli con i comuni <strong>di</strong> Martina Franca e Villa Castelli. L’intento non <strong>di</strong>chiarato è<br />
quello <strong>di</strong> mettere insieme i territori della “pietra scavata” che hanno dato vita ai villaggi<br />
5
upestri e quelli della “pietra costruita” che hanno dato forma ai tholos: trulli della Murgia.<br />
L’Unesco <strong>di</strong> Parigi e il Governo Regionale si sono ritrovati d’accordo sul medesimo<br />
obiettivo: il territorio delle Gravine e della Murgia, della civiltà Rupestre e dei Trulli, sono<br />
parte <strong>di</strong> un’unica civiltà culturale e antropologica. A partire da questa consapevolezza la<br />
comunità abitante sul territorio deve ragionare per costruire, ricostruire la propria identità<br />
umana ed economica, e riconsiderare il proprio sviluppo, basato sulla valorizzazione del<br />
patrimonio ambientale e culturale. Mettersi in pie<strong>di</strong> a partire da sé: ovvero essere consapevole<br />
<strong>di</strong> quello che si ha e quello che si vuole fare.<br />
Va da sé che l’istituzione del Parco Regionale Terra delle Gravine fornendo garanzie locali <strong>di</strong><br />
salvaguar<strong>di</strong>a e conservazione, in qualche maniera favorisce l’eventuale estensione del<br />
riconoscimento Unesco <strong>di</strong> Matera e Alberobello, al patrimonio del Rupestre e dei Trulli della<br />
provincia ionica. Intento perseguito dall’Assessorato alle Aree Protette della <strong>Provincia</strong> <strong>di</strong><br />
<strong>Taranto</strong>, nei mesi in cui tale Ente ha la funzione <strong>di</strong> avviare la costituzione autonoma del<br />
Parco.<br />
6
PREMESSA<br />
Il Piano <strong>di</strong> Gestione del Sito <strong>di</strong> Importanza Comunitaria – Zona <strong>di</strong> Protezione Speciale (SIC-<br />
ZPS) “Area delle Gravine” è stato elaborato tenendo conto degli stu<strong>di</strong> svolti nell’ambito del<br />
Progetto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Direzione per la Protezione<br />
della Natura, LIFE NATURA IT/99/006279 “Verifica della Rete Natura 2000 in Italia:<br />
modelli <strong>di</strong> gestione” - Piano <strong>di</strong> Gestione Pilota relativo ai Siti d’Interesse Comunitario “Area<br />
delle Gravine” e “Gravine <strong>di</strong> Matera”.<br />
La <strong>Relazione</strong> Generale del Progetto aveva evidenziato la necessità <strong>di</strong> procedere alla redazione<br />
<strong>di</strong> uno specifico Piano <strong>di</strong> Gestione per l’area pugliese, data “la complessità delle<br />
problematiche <strong>di</strong> conservazione presenti nell’area delle gravine dell’arco ionico e<br />
l’inadeguatezza dei <strong>di</strong>versi strumenti <strong>di</strong> pianificazione territoriale esistenti” (cfr. p. 9 del<br />
documento richiamato).<br />
A tal fine, la Regione Puglia ha affidato alla <strong>Provincia</strong> <strong>di</strong> <strong>Taranto</strong> il compito <strong>di</strong> elaborare un<br />
Piano <strong>di</strong> Gestione per il SIC-ZPS “Area delle Gravine”, mettendo a <strong>di</strong>sposizione la<br />
documentazione richiamata.<br />
Le analisi svolte nell’ambito del Progetto LIFE sono state in questa sede opportunamente<br />
integrate, aggiornate e sviluppate con stu<strong>di</strong> specifici nei seguenti settori:<br />
• ambito legislativo: analisi e applicazione della normativa internazionale, comunitaria,<br />
nazionale e regionale;<br />
• ambito programmatico: status del sito, piani territoriali ed urbanistici presenti sul<br />
territorio, sistema infrastrutturale;<br />
• aspetti fisici: collocazione e confini del sito, clima, geologia e geomorfologia,<br />
idrologia;<br />
• aspetti biologici naturalistici;<br />
• aspetti socio-economici: attività antropiche interne ed esterne al sito, attività<br />
economiche della popolazione;<br />
• fonti <strong>di</strong> finanziamento: fon<strong>di</strong> comunitari, nazionali e locali finalizzati alla attuazione <strong>di</strong><br />
strategie <strong>di</strong> promozione e fruizione del territorio.<br />
• aspetti archeologici, architettonici, paesaggistici e culturali: caratteristiche e valori<br />
fisici, storici e culturali.<br />
7
1. COS’È IL PIANO DI GESTIONE : IL QUADRO NORMATIVO E METODOLOGICO DI<br />
RIFERIMENTO<br />
Il presente Piano <strong>di</strong> Gestione (in seguito PdG) relativo al SIC-ZPS “Area delle Gravine” è<br />
stato elaborato sulla base del quadro <strong>di</strong> riferimento normativo rilevante sul piano<br />
internazionale, comunitario, nazionale e regionale. Si è in particolare tenuto conto, tra gli altri,<br />
dei seguenti atti:<br />
Fonti internazionali<br />
• Convenzione <strong>di</strong> Parigi del 1950 per la tutela dell'avifauna.<br />
• Convenzione <strong>di</strong> Ramsar del 1971 sulla tutela delle zone umide <strong>di</strong> importanza<br />
internazionale.<br />
• Convenzione <strong>di</strong> Barcellona del 1976 per la protezione del mare Me<strong>di</strong>terraneo.<br />
• Convenzione <strong>di</strong> Berna del 1979 per la tutela della vita selvatica e dell'ambiente naturale<br />
d'Europa.<br />
• Convenzione <strong>di</strong> Bonn del 1979 per la tutela delle specie migratorie.<br />
• Convenzioni <strong>di</strong> Rio de Janeiro del 1992 sulla Bio<strong>di</strong>versità e sull'uso sostenibile delle<br />
risorse naturali e sul cambiamento climatico e sulla desertificazione.<br />
Fonti comunitarie<br />
• Regolamento 3226/82/CEE, mo<strong>di</strong>ficato dai Regolamenti 338/97/CE e 393/97/CE,<br />
relativo alla tutela delle specie in via <strong>di</strong> estinzione.<br />
• Direttiva 79/409/CEE, sulla conservazione degli uccelli selvatici (c.d. Direttiva Uccelli).<br />
• Direttiva 92/43/CEE, c.d. Direttiva “Habitat”.<br />
• Decisione del Consiglio 93/626/CEE del 25 ottobre 1993, relativa alla conclusione della<br />
Convenzione sulla <strong>di</strong>versità biologica.<br />
• Direttiva 97/49/CE, contenente mo<strong>di</strong>fiche all’Allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE.<br />
• Direttiva 97/62/CEE sull’adeguamento al progresso tecnico e scientifico della Direttiva<br />
92/43/CEE.<br />
Fonti statali<br />
• Legge 394/91 "Legge quadro sulle aree naturali protette" e s.m.i.<br />
• Legge 157/1992, atto nazionale <strong>di</strong> recepimento della Direttiva “Uccelli”.<br />
• Legge 124/1994 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla Bio<strong>di</strong>versità, con<br />
annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992”.<br />
• D.P.R. 357/1997, mo<strong>di</strong>ficato dal D.P.R. 120/2003, atto nazionale <strong>di</strong> recepimento della<br />
Direttiva 92/43/CEE.<br />
• D.M. 3 aprile 2000 del Ministero dell’Ambiente, contenente l'elenco dei siti <strong>di</strong><br />
importanza comunitaria (SIC) e delle zone <strong>di</strong> protezione speciale (ZPS), in<strong>di</strong>viduati ai<br />
sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE.<br />
• D.M. 3 settembre 2002 “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000”.<br />
• Decreto Legislativo 152/2006 “Testo Unico Ambientale” e s.m.i.<br />
8
• D.M. 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione <strong>di</strong> misure <strong>di</strong><br />
conservazione relative a Zone speciali <strong>di</strong> conservazione (ZSC) e a Zone <strong>di</strong> protezione<br />
speciale (ZSC)”.<br />
Fonti regionali<br />
• L.R. 19/1997 “Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella<br />
Regione Puglia”.<br />
• L.R. 116/2001 “Integrazione dell’art. 5 comma 1 della Legge Regionale 19/1997”.<br />
• L.R. 11/2001 “Norme sulla valutazione d'impatto ambientale in atti normativi, piani e<br />
programmi”.<br />
• L.R. 20/2001 “Norme generali <strong>di</strong> governo e uso del territorio”.<br />
• L.R. 25/2001 “Conferimento <strong>di</strong> funzioni e compiti amministrativi in materia <strong>di</strong><br />
urbanistica e pianificazione territoriale e <strong>di</strong> e<strong>di</strong>lizia residenziale pubblica”.<br />
• L.R. 24/2004 “Principi, in<strong>di</strong>rizzi e <strong>di</strong>sposizioni nella formazione del Documento<br />
regionale <strong>di</strong> assetto <strong>generale</strong> (DRAG)”.<br />
• L.R. 18/2005 “Istituzione del Parco naturale regionale “Terra delle gravine”.<br />
• R.R. 24/2005 “Misure <strong>di</strong> conservazione relative a specie prioritarie <strong>di</strong> importanza<br />
comunitaria <strong>di</strong> uccelli selvatici ni<strong>di</strong>ficanti nei centri e<strong>di</strong>ficati ricadenti in proposti Siti<br />
<strong>di</strong> importanza Comunitaria (pSIC) ed in Zone <strong>di</strong> Protezione Speciale (Z.P.S.)”.<br />
• L.R. 17/2007 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento<br />
delle funzioni amministrative in materia ambientale”.<br />
• R.R. 15/2008 “Regolamento recante misure <strong>di</strong> conservazione a sensi delle <strong>di</strong>rettive<br />
comunitarie 79/409 e 92/43 e del DPR 357/97 e successive mo<strong>di</strong>fiche e integrazioni”.<br />
Sul piano metodologico, la stesura del presente PdG si è basata sui seguenti documenti<br />
conoscitivi:<br />
• Schede Natura 2000 e stu<strong>di</strong> eseguiti dalla Regione Puglia e dalla <strong>Provincia</strong> <strong>di</strong> <strong>Taranto</strong> sul<br />
sito;<br />
• Manuale delle linee guida per la redazione dei piani <strong>di</strong> gestione dei siti Natura 2000 del<br />
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Direzione Protezione della Natura,<br />
nell’ambito del PROGETTO LIFE 99 NAT/IT/006279;<br />
• Manuel d’interprétation des habitats de l’Union Européenne, Commission Européenne,<br />
DG Environnement, Octobre 1999.<br />
• “La gestione dei siti della rete natura 2000 - Guida all’interpretazione dell’articolo 6<br />
della Direttiva Habitat 92/43/CEE, 2000”, documento preparato dalla Commissione<br />
Europea per sostenere gli Stati Membri nella propria politica <strong>di</strong> attuazione della Direttiva<br />
Habitat, 2000;<br />
• Sustainable Tourism And Natura 2000. Guidelines, Initiatives and Good Practices in<br />
Europe, DG Ambiente, Commissione Europea, 2000;<br />
• “Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta”, Comunicazione della Commissione al<br />
Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale e al Comitato delle<br />
Regioni sul VI Programma <strong>di</strong> Azione per l'ambiente della Comunità Europea ,<br />
Commissione delle Comunità Europee, 2001;<br />
9
• “Piano <strong>di</strong> Azione a favore della bio<strong>di</strong>versità: conservazione delle risorse naturali”,<br />
Commissione Europea, 2001;<br />
• “Piano <strong>di</strong> Azione a favore della bio<strong>di</strong>versità: agricoltura”, Commissione Europea, 2001;<br />
• Decisione del Consiglio 93/626/CEE del 25 ottobre 1993 relativa alla conclusione della<br />
Convenzione sulla <strong>di</strong>versità biologica.<br />
• Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato<br />
Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni sulla “Strategia tematica per la<br />
protezione del suolo”, Bruxelles, 22.9.2006 - COM(2006)231.<br />
• Proposta <strong>di</strong> Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per<br />
la protezione del suolo e mo<strong>di</strong>fica la Direttiva 2004/35/CE.<br />
Sono stati esaminati e presi in considerazione gli strumenti <strong>di</strong> pianificazione urbanistica e<br />
territoriale presenti sul territorio; le Linee Guida per la Pianificazione Strategica Territoriale<br />
<strong>di</strong> Area Vasta, approvate con D.G.R. 1072/2007; la <strong>Relazione</strong> <strong>di</strong> aggiornamento “L’avvio del<br />
percorso <strong>di</strong> pianificazione strategica”, Pianificazione Strategica territoriale dell’Area Vasta<br />
Tarantina, Ottobre 2007.<br />
Sono state infine esaminate le seguenti Delibere della Giunta Regionale pugliese: D.G.R.<br />
1440/2003 (aggiornata con D.G.R. 1963/2004 e D.G.R. 1087/2005), che approva il<br />
programma regionale per la tutela dell’ambiente denominato “Programma <strong>di</strong> azioni per<br />
l’ambiente” allegato al provve<strong>di</strong>mento ai sensi dell’art. 4 L.R. 17/2000; D.G.R. 1328/2007,<br />
“Principi, in<strong>di</strong>rizzi e <strong>di</strong>sposizioni nella formazione del Documento regionale <strong>di</strong> assetto<br />
<strong>generale</strong> (DRAG)”.<br />
Le fonti richiamate hanno contribuito alla in<strong>di</strong>viduazione delle finalità, della struttura e dei<br />
contenuti del PdG, alla definizione delle procedure connesse alla sua elaborazione e<br />
attuazione, alla qualificazione giuri<strong>di</strong>ca <strong>di</strong> questo strumento e alla chiarificazione dei rapporti<br />
tra esso e altri strumenti <strong>di</strong> pianificazione territoriale.<br />
1.1. Le Direttive Uccelli e Habitat<br />
Un ruolo essenziale ai fini della definizione del presente PdG va riconosciuto, a livello<br />
comunitario, alle citate Direttive Uccelli e Habitat e, a livello nazionale, agli atti normativi <strong>di</strong><br />
recepimento delle medesime.<br />
Si ricorda a riguardo che la Direttiva 79/409/CEE, sulla conservazione degli uccelli selvatici,<br />
ha ad oggetto la conservazione delle specie <strong>di</strong> uccelli viventi allo stato selvatico nel territorio<br />
dell’Unione Europea. Essa si applica agli “uccelli, alle uova, ai ni<strong>di</strong> e agli habitat” (art. 1.2) e<br />
suo obiettivo primario è la tutela <strong>di</strong> determinate specie ornitiche attraverso la protezione degli<br />
habitat in cui tali specie hanno il proprio ambiente vitale.<br />
La Direttiva in<strong>di</strong>vidua l’istituzione <strong>di</strong> “zone <strong>di</strong> protezione” o la creazione <strong>di</strong> “biotopi” quali<br />
misure per “ la preservazione, il mantenimento e il ripristino degli habitat” (art. 3.2) delle<br />
specie. Tali misure <strong>di</strong>sciplinano la cattura, l’uccisione, la <strong>di</strong>struzione dei ni<strong>di</strong> o delle uova, il<br />
<strong>di</strong>sturbo durante la ricerca del cibo nonché il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> commercializzazione <strong>di</strong> uccelli vivi o<br />
morti o parti <strong>di</strong> essi.<br />
10
La Direttiva 92/43/CEE si pone in continuità con il precedente intervento normativo<br />
comunitario e prevede la realizzazione della rete ecologica europea Natura 2000: questa è<br />
costituita dall'insieme dei siti denominati Zone <strong>di</strong> Protezione Speciale (ZPS) e Siti <strong>di</strong><br />
Importanza Comunitaria (SIC), attualmente proposti alla Commissione Europea e che al<br />
termine dell'iter istitutivo saranno designati come Zone Speciali <strong>di</strong> Conservazione (ZSC). I<br />
siti così in<strong>di</strong>viduati garantiranno la presenza, il mantenimento e/o il ripristino <strong>di</strong> habitat e <strong>di</strong><br />
specie peculiari del continente europeo, minacciati <strong>di</strong> frammentazione ed estinzione. La<br />
Direttiva prende in considerazione anche siti attualmente degradati, in cui tuttavia gli habitat<br />
abbiano conservato l'efficienza funzionale e che pertanto possano ritornare verso forme più<br />
evolute, eliminando le cause <strong>di</strong> degrado.<br />
Ogni sito Natura 2000 deve essere parte integrante del sistema <strong>di</strong> aree in<strong>di</strong>viduate per<br />
garantire a livello europeo la presenza e la <strong>di</strong>stribuzione degli habitat e delle specie<br />
considerate <strong>di</strong> particolare valore naturalistico.<br />
1.2. Natura giuri<strong>di</strong>ca e finalità del PdG<br />
Nel quadro sopra delineato, il PdG si pone come lo strumento attuativo delle misure <strong>di</strong><br />
conservazione degli habitat naturali e delle specie floro-faunistiche <strong>di</strong> interesse comunitario<br />
che, in base alla Direttiva Habitat, devono essere previste per le aree inserite nella Rete Natura<br />
2000.<br />
Il PdG è espressamente richiamato dall’art. 6 della Direttiva, secondo cui: “Per le zone<br />
speciali <strong>di</strong> conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure <strong>di</strong> conservazione necessarie<br />
che implicano all'occorrenza appropriati piani <strong>di</strong> gestione specifici o integrati ad altri piani <strong>di</strong><br />
sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali (…)”.<br />
In attesa della istituzione delle zone speciali <strong>di</strong> conservazione in Italia, il regime per esse<br />
previste si applica ai Siti <strong>di</strong> Importanza Comunitaria – Zone <strong>di</strong> Protezione Speciale (SIC-<br />
ZPS), come l’area delle gravine.<br />
Il PdG, come più in <strong>generale</strong> tutte le misure <strong>di</strong> conservazione, è strettamente funzionale alla<br />
realizzazione della finalità della Direttiva Habitat, che è quella <strong>di</strong> contribuire a salvaguardare<br />
la bio<strong>di</strong>versità me<strong>di</strong>ante la conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna<br />
selvatiche nel territorio europeo.<br />
Principale obiettivo del PdG, coerentemente con quanto previsto dall'art. 6 della Direttiva e<br />
dalle norme nazionali <strong>di</strong> recepimento - art. 4 D.P.R. 357/1997, mo<strong>di</strong>ficato e integrato dal<br />
D.P.R. 120/2003 - è dunque quella <strong>di</strong> garantire la presenza in con<strong>di</strong>zioni ottimali degli habitat<br />
e delle specie che hanno determinato l'in<strong>di</strong>viduazione del SIC-ZPS.<br />
In questo quadro, il PdG si pone come strumento operativo <strong>di</strong> regolamentazione degli usi del<br />
territorio finalizzato alla conservazione degli habitat e delle specie protette presenti nel sito.<br />
Esso opera come strumento <strong>di</strong> pianificazione settoriale, che richiede, quale con<strong>di</strong>cio sine qua<br />
non per la realizzazione degli obiettivi <strong>di</strong> tutela, il coinvolgimento e la con<strong>di</strong>visione dei<br />
soggetti pubblici e privati da esso a vario titolo coinvolti.<br />
11
Un punto irrinunciabile della filosofia dell’Unione Europea in tema <strong>di</strong> conservazione e<br />
sviluppo sostenibile locale è dato proprio dal coinvolgimento della popolazione: in questa<br />
prospettiva, il presente PdG è un documento aperto alla consultazione con i soggetti ad esso<br />
variamente interessati, in modo da assicurare eventuali integrazioni che potranno essere<br />
proposte dai singoli referenti e garantire quin<strong>di</strong> la piena operatività ed efficacia del PdG sul<br />
territorio.<br />
1.3. Rapporto tra PdG e altri strumenti <strong>di</strong> pianificazione. La valutazione <strong>di</strong><br />
incidenza<br />
Ai fini della realizzazione delle misure e azioni <strong>di</strong> conservazione da attuare e gestire<br />
attraverso il PdG, è in<strong>di</strong>spensabile una chiara definizione dei rapporti tra questo e altri<br />
strumenti pianificatori, previsti dalla normativa nazionale e/o regionale e variamente incidenti<br />
sul territorio del SIC-ZPS “Area delle Gravine”.<br />
A tale riguardo, si ricorda che parte del territorio interessato dal PdG coincide con l’area<br />
naturale protetta “Parco delle Gravine”, istituita con Legge Regionale 18/2005 “Istituzione del<br />
Parco naturale regionale “Terra delle gravine”.<br />
Gli strumenti <strong>di</strong> gestione del Parco previsti dalla Legge istitutiva, segnatamente il Piano<br />
Territoriale del Parco (art. 7), il Piano Pluriennale Economico-Sociale (art. 8) e il<br />
Regolamento (art. 9), non sono stati ad oggi adottati.<br />
Di questo dato si è tenuto conto in sede <strong>di</strong> elaborazione del PdG, che costituisce atto <strong>di</strong><br />
in<strong>di</strong>rizzo per il (futuro) Piano Territoriale del Parco, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n.<br />
144 del 26.02.2007. In particolare, il Regolamento del SIC-ZPS, annesso al presente PdG e<br />
contenente le misure <strong>di</strong> regolamentazione e <strong>di</strong> fruizione del sito, riba<strong>di</strong>sce tale principio,<br />
prevedendo l’applicazione, alle aree del SIC-ZPS coincidenti con il Parco, delle misure<br />
legislative o regolamentari <strong>di</strong> maggior tutela (cfr. art. 1 comma 3).<br />
Con riguardo invece alle aree del SIC-ZPS esterne al Parco, le misure <strong>di</strong> conservazione<br />
previste dal PdG <strong>di</strong>ventano elementi strutturanti della pianificazione provinciale e comunale<br />
<strong>di</strong> riferimento: rilevano a riguardo, da un lato, il Piano Territoriale <strong>di</strong> Coor<strong>di</strong>namento<br />
<strong>Provincia</strong>le – documento preliminare – elaborato dalla <strong>Provincia</strong> <strong>di</strong> <strong>Taranto</strong> e, dall’altro, i vari<br />
strumenti <strong>di</strong> pianificazione territoriale adottati o in via <strong>di</strong> adozione da parte dei Comuni<br />
coinvolti – Ginosa, Laterza, Castellaneta, Palagianello, Mottola, Massafra, Crispiano, Statte –<br />
e della Comunità Montana Murgia Tarantina.<br />
A riguardo, si sottolinea che la natura pianificatoria settoriale e specialistica del PdG impone<br />
che le prescrizioni in esso contenute siano tempestivamente recepite dagli strumenti <strong>di</strong> piano<br />
sopra richiamati, attraverso varianti ai piani già esistenti o adattamenti dei progetti o delle<br />
bozze in via <strong>di</strong> definizione.<br />
La necessaria armonizzazione tra i piani territoriali e urbanistici e il PdG, nel senso<br />
dell’adeguamento dei primi alle prescrizioni specialistiche e settoriali del secondo, evidenzia<br />
12
l’importanza della più ampia con<strong>di</strong>visione <strong>di</strong> obiettivi e strategie <strong>di</strong> conservazione: in questa<br />
prospettiva, viene dato particolare rilievo alla partecipazione dei vari attori istituzionali -<br />
Regione, <strong>Provincia</strong>, Comuni, Comunità Montana - e degli altri “stakeholders” interessati ai<br />
processi formativi e gestionali del PdG.<br />
Si ricorda inoltre che i piani, programmi e progetti che incidono sulla tutela degli habitat e<br />
specie del SIC-ZPS vanno sottoposti a valutazione <strong>di</strong> incidenza (art. 5 del DPR n. 395/97),<br />
procedura <strong>di</strong> carattere preventivo la cui <strong>di</strong>sciplina è contenuta nella L.R. 11/2001 “Norme<br />
sulla Valutazione <strong>di</strong> Impatto Ambientale”, nella D.G.R. n. 304 del 14 marzo 2006 “Atto <strong>di</strong><br />
in<strong>di</strong>rizzo e coor<strong>di</strong>namento per l’espletamento della procedura <strong>di</strong> valutazione <strong>di</strong> incidenza ai<br />
sensi dell’art. 6 della <strong>di</strong>rettiva 92/43/CEE e dell’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come<br />
mo<strong>di</strong>ficato ed integrato dall’art. 6 del D.P.R. n. 120/2003”, mo<strong>di</strong>ficata dalla D.G.R. n. 1366<br />
del 3 agosto 2007, “Atto <strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzo e coor<strong>di</strong>namento per l’attuazione in Puglia della Legge<br />
regionale n. 19/1997 e delle Leggi istitutive delle aree naturali protette regionali”. La<br />
valutazione <strong>di</strong> incidenza, se correttamente realizzata ed interpretata, costituisce lo strumento<br />
per garantire, dal punto <strong>di</strong> vista procedurale e sostanziale, il raggiungimento <strong>di</strong> un rapporto<br />
equilibrato tra la conservazione sod<strong>di</strong>sfacente degli habitat e delle specie e l'uso sostenibile<br />
del territorio. Alla procedura in oggetto sono de<strong>di</strong>cate specifiche norme del Regolamento<br />
annesso al presente PdG, a cui si rinvia (cfr. Parte VIII, artt. 25 e 26).<br />
1.3.1. Il PdG e la pianificazione comunale<br />
Il rapporto tra il PdG e la pianificazione <strong>di</strong> livello comunale è stabilito nella integrazione dei<br />
contenuti del primo nei secon<strong>di</strong>.<br />
Il contenuto del PdG infatti informa sia la parte strutturale dei piani (PUG/S) sia la parte<br />
programmatica (PUG/P).<br />
Il PdG si rivolge <strong>di</strong>rettamente “alle previsioni strutturali” del progetto dei PUG, contribuendo<br />
a favorire il “...perseguimento degli obiettivi <strong>di</strong> sostenibilità ambientale e territoriale, <strong>di</strong><br />
salvaguar<strong>di</strong>a e protezione dell’ambiente...e valorizzazione delle invarianti strutturali del<br />
territorio”. Esso offre una cospicua base informativa ai Comuni nei cui territori ricadono le<br />
aree SIC-ZPS, ai fini della pianificazione ed un supporto per la tutela e la valorizzazione del<br />
patrimonio ambientale e culturale (risorse territoriali locali, ambientali, paesaggistiche e<br />
culturali).<br />
Ciò avviene in coerenza con l’impostazione del DRAG, riguardo l’in<strong>di</strong>viduazione delle<br />
invarianti strutturali del territorio. Il PdG si presenta ai Comuni come momento <strong>di</strong> costruzione<br />
del consenso attorno al valore intrinseco del territorio dato dalla tutela dell’ambiente e del<br />
paesaggio. Ciò passa attraverso l’imprescin<strong>di</strong>bile ricorso ai criteri <strong>di</strong> co-pianificazione, <strong>di</strong><br />
collaborazione istituzionale, <strong>di</strong> partecipazione e quin<strong>di</strong> <strong>di</strong> creazione e conquista del consenso<br />
dei <strong>di</strong>versi portatori <strong>di</strong> interessi attorno ad una idea comune <strong>di</strong> costruzione della risorsa<br />
territoriale (cfr. DRAG).<br />
13
Per quanto riguarda il contenuto regolativo del PdG, esso deve trovare necessario recepimento<br />
all’interno delle cogenze in<strong>di</strong>cate dagli strumenti della pianificazione comunale, in particolare<br />
nella parte programmatica, nelle norme tecniche attuative (<strong>di</strong>sciplina urbanistica delle aree<br />
soggette a trasformazione in PUE e <strong>di</strong>sciplina urbanistica delle aree non incluse in PUE) e nel<br />
regolamento e<strong>di</strong>lizio.<br />
1.3.2. Il PdG ed il PTCP<br />
In base al D.Lgs. 112/98 e al T.U.E.L. 267/2000, la pianificazione territoriale provinciale si<br />
configura come strumento <strong>di</strong> governo del territorio su vasta scala, <strong>di</strong> esclusiva competenza<br />
dell’Ente <strong>Provincia</strong>. Il rapporto tra il PTCP e i piani settoriali <strong>di</strong> tutela è delineato dal D.Lgs.<br />
112/98 nei termini seguenti:<br />
Art. 57. (Pianificazione territoriale <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>namento e pianificazioni <strong>di</strong> settore)<br />
a. La Regione, con Legge regionale, prevede che il piano territoriale <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>namento<br />
provinciale <strong>di</strong> cui all'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, assuma il valore e<br />
gli effetti dei piani <strong>di</strong> tutela nei settori della protezione della natura, della tutela<br />
dell'ambiente, delle acque e della <strong>di</strong>fesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali<br />
sempre che la definizione delle relative <strong>di</strong>sposizioni avvenga nella forma <strong>di</strong> intese fra<br />
la provincia e le amministrazioni, anche statali, competenti.<br />
b. In mancanza dell'intesa <strong>di</strong> cui al comma 1, i piani <strong>di</strong> tutela <strong>di</strong> settore conservano il<br />
valore e gli effetti ad essi assegnati dalla rispettiva normativa nazionale e regionale.<br />
c. Resta comunque fermo quanto <strong>di</strong>sposto dall'articolo 149, comma 6, del presente<br />
decreto legislativo.<br />
Anche il TUEL definisce le funzioni della <strong>Provincia</strong> in materia <strong>di</strong> pianificazione territoriale.<br />
In particolare, in base all’art. 19, spettano alla <strong>Provincia</strong> i compiti <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa del suolo, <strong>di</strong> tutela<br />
e valorizzazione dell’ambiente, <strong>di</strong> valorizzazione dei beni culturali, <strong>di</strong> protezione della flora,<br />
della fauna, <strong>di</strong> parchi e riserve naturali.<br />
La L.R. 25/2000 conferma i compiti del PTCP in<strong>di</strong>cati nel T.U.E.L. (artt. 4 e 5), ribadendo<br />
che il PTCP, quale “atto <strong>di</strong> programmazione <strong>generale</strong> che definisce gli in<strong>di</strong>rizzi strategici <strong>di</strong><br />
assetto del territorio a livello sovra-comunale, con riferimento (...) agli aspetti <strong>di</strong> salvaguar<strong>di</strong>a<br />
paesistico ambientale” (art. 5 c. 3), ha “il valore e gli effetti dei piani <strong>di</strong> tutela nei settori della<br />
protezione della natura e della tutela dell’ambiente...” (art. 5 c. 2).<br />
E’ dunque confermato il principio, già contenuto nel DRAG, per cui il piano territoriale va<br />
inteso come un processo <strong>di</strong> costruzione <strong>di</strong> una idea con<strong>di</strong>visa <strong>di</strong> sviluppo sostenibile.<br />
Il PdG opererà quin<strong>di</strong> quale “piano attuativo” del costituendo PTCP.<br />
14
1.3.3. Il PdG ed il PPTR<br />
Il PdG partecipa al percorso pianificatorio delineato dal Documento Programmatico del Piano<br />
Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia. Il Piano Paesaggistico manifesta la volontà<br />
<strong>di</strong> sviluppare un percorso metodologico che consenta una valorizzazione attiva del patrimonio<br />
territoriale e paesistico. Al pari del piano paesaggistico, che si pone “come strumento in<br />
grado <strong>di</strong> produrre, oltre che vincoli, soprattutto regole <strong>di</strong> trasformazione, politiche, azioni,<br />
progetti che favoriscano l’elevamento della qualità dei paesaggi...comprendendovi le azioni<br />
<strong>di</strong> conservazione, quelle <strong>di</strong> valorizzazione, <strong>di</strong> riqualificazione, <strong>di</strong> ricostruzione” (cfr. pagg.<br />
10-11 DP PPTR), il PdG si pone l’obiettivo <strong>di</strong> raccontare e rappresentare le aree comprese al<br />
suo interno come aree <strong>di</strong> eccellenza per la cura e la valorizzazione delle risorse ambientali e<br />
culturali.<br />
L’area protetta si trasforma da area recintata e “vincolate(a) alla conservazione, a<br />
laboratori(o) sperimentali(e) <strong>di</strong> nuovi modelli <strong>di</strong> relazione fra inse<strong>di</strong>amenti antropici,<br />
ambiente e storia” (cfr. pag. 11 DP PPTR).<br />
Il PdG si pone quin<strong>di</strong> in una posizione <strong>di</strong>alogante con il Piano Paesaggistico, promuovendo<br />
una stretta collaborazione con la Segreteria tecnica <strong>di</strong> esso, fondata sulla comune idea del<br />
“passaggio da un sistema <strong>di</strong> pianificazione <strong>di</strong> tipo regolativo ad uno <strong>di</strong> tipo strategico”,<br />
nonché su un approccio co-pianificatorio, che stimoli “sinergie per la costruzione del quadro<br />
conoscitivo e degli atlanti patrimoniali” (cfr. pag. 42 DP PPTR).<br />
L’area compresa nel SIC-ZPS può quin<strong>di</strong> costituire territorio d’elezione per la<br />
sperimentazione <strong>di</strong> eventi compresi tra quelli proposti dal PPTR, come ad esempio quello<br />
in<strong>di</strong>cato alla lett. h) del Capitolo 4.3: “un progetto <strong>di</strong> parco agricolo multifunzionale<br />
(agricoltura <strong>di</strong> qualità, allevamento), funzioni ecologiche (territorio rurale come rete<br />
ecologica minore), paesistiche, energetiche (mix locale <strong>di</strong> fonti energetiche rinnovabili),<br />
fruitive (percorribilità), turistiche; realizzazione <strong>di</strong> reti corte fra produzione e consumo” (cfr.<br />
pag. 46 DP PPTR).<br />
1.3.4. Il PdG ed il Piano Strategico Territoriale <strong>di</strong> Area Vasta<br />
L’introduzione dell’Organismo Interme<strong>di</strong>o dell’Area Vasta ha creato dei livelli <strong>di</strong> interferenza<br />
con le competenze provinciali in materia <strong>di</strong> pianificazione territoriale e <strong>di</strong> programmazione,<br />
tanto più che la <strong>Provincia</strong> <strong>di</strong> <strong>Taranto</strong> non si è dotata <strong>di</strong> un Piano Territoriale <strong>di</strong><br />
Coor<strong>di</strong>namento.<br />
Il PdG e l’Ente territoriale competente, ossia la <strong>Provincia</strong>, terranno un rapporto<br />
istituzionalizzato con l’Ufficio Unico del Piano Strategico, seguendo anche in questo caso gli<br />
inviti alla co-pianificazione contenuti nel DRAG.<br />
Il Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013, come già accennato in precedenza,<br />
contiene, fra le Priorità <strong>di</strong> Intervento, due Assi (Asse 2 “Uso sostenibile ed efficiente delle<br />
risorse ambientali ed energetiche per lo sviluppo” e Asse 4 “Valorizzazione delle risorse<br />
naturali e culturali per l’attrattività e lo sviluppo”) che permettono <strong>di</strong> creare sinergie per<br />
l’attuazione delle “Strategie <strong>di</strong> Gestione” in<strong>di</strong>viduate dal PdG sud<strong>di</strong>vise, secondo le<br />
in<strong>di</strong>cazioni fornite dalle Linee Guida ministeriali, in azioni <strong>di</strong> <strong>di</strong>fferente natura:<br />
• interventi attivi (IA)<br />
• regolamentazioni (RE)<br />
• incentivazioni (IN)<br />
• programmi <strong>di</strong> monitoraggio (PM)<br />
• programmi <strong>di</strong>dattici (PD).<br />
15
1.4. Struttura e contenuti del PdG<br />
La struttura e i contenuti del PdG sono stati sviluppati in conformità del D.M. 3 settembre<br />
2002, contenente le Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000, che ha costituito un<br />
importante documento <strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzo in materia.<br />
Il presente PdG si articola in particolare nei seguenti Capitoli:<br />
• Quadro conoscitivo (Capitolo II): risponde alla necessità <strong>di</strong> conoscere gli elementi<br />
costitutivi caratterizzanti il sito, al fine <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare e calibrare la strategia gestionale<br />
più opportuna. Sono in questa parte raccolte e organizzate tutte le informazioni<br />
relative alle caratteristiche fisiche, biologiche, socio-economiche, archeologiche,<br />
architettoniche, culturali, paesaggistiche del sito. Le analisi svolte a riguardo<br />
nell’ambito del Progetto LIFE 99/IT/006279 sono state qui aggiornate con stu<strong>di</strong><br />
integrativi specifici.<br />
• Analisi e valutazione delle esigenze ecologiche <strong>di</strong> habitat e specie (Capitolo III): si<br />
articola - come da in<strong>di</strong>cazioni del Decreto - nei seguenti punti:<br />
− In<strong>di</strong>viduazione delle esigenze ecologiche. Per ogni habitat e specie <strong>di</strong> interesse<br />
comunitario sono state considerate come esigenze ecologiche “…tutte le<br />
esigenze dei fattori biotici e abiotici necessari per garantire lo stato <strong>di</strong><br />
conservazione sod<strong>di</strong>sfacente dei tipi <strong>di</strong> habitat e delle specie, comprese le loro<br />
relazioni con l’ambiente (aria, acqua, suolo, vegetazione, ecc.)”, secondo la<br />
definizione desunta dalla Guida all’interpretazione dell’art. 6 della Direttiva<br />
Habitat. l’in<strong>di</strong>viduazione delle esigenze ecologiche è stata possibile<br />
desumendo informazioni da varie fonti, quali: gli stu<strong>di</strong> conoscitivi <strong>di</strong> base, le<br />
descrizioni delle tipologie <strong>di</strong> sito presenti nel Manuale delle Linee Guida, le<br />
descrizioni degli habitat contenute nel Manuel d’interprétation des habitats de<br />
l’Union Européenne.<br />
− Definizione degli in<strong>di</strong>catori per la valutazione dello stato <strong>di</strong> conservazione ed<br />
evoluzione <strong>di</strong> specie ed habitat. Gli in<strong>di</strong>catori sono una parte imprescin<strong>di</strong>bile<br />
nel Piano: su <strong>di</strong> essi viene impostato il sistema <strong>di</strong> monitoraggio, “ misurazione”<br />
dello stato <strong>di</strong> conservazione del sito. Gli in<strong>di</strong>catori sono stati definiti<br />
desumendoli <strong>di</strong>rettamente o in<strong>di</strong>rettamente dagli stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> base delle società<br />
scientifiche, ovvero utilizzando gli in<strong>di</strong>catori proposti per tipologie <strong>di</strong> sito dal<br />
Manuale per la gestione dei siti Natura 2000. Essi sono stati poi aggiornati in<br />
relazione alle azioni definite nell’ambito della strategia <strong>di</strong> gestione.<br />
− In<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong> minacce e fattori <strong>di</strong> impatto. I dati necessari a questa<br />
valutazione sono stati desunti principalmente dagli stu<strong>di</strong> conoscitivi <strong>di</strong> base e<br />
del Manuale per la gestione dei siti Natura 2000.<br />
• Obiettivi (Capitolo IV): in<strong>di</strong>vidua gli obiettivi generali e specifici del PdG, in base al<br />
confronto tra minacce e fattori <strong>di</strong> impatto e valutazione delle esigenze ecologiche degli<br />
habitat e delle specie <strong>di</strong> interesse comunitario. Tali obiettivi derivano<br />
16
dall’in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong> fenomeni <strong>di</strong> criticità e degrado da eliminare o mitigare, ovvero<br />
<strong>di</strong> <strong>di</strong>namiche favorevoli alla conservazione del sito da salvaguardare.<br />
• Strategia <strong>di</strong> gestione (Capitolo V): gli obiettivi sono qui concretizzati attraverso la<br />
scelta <strong>di</strong> ambiti prioritari <strong>di</strong> intervento nei quali concentrare le previste azioni <strong>di</strong><br />
gestione.<br />
• Azioni <strong>di</strong> gestione (Capitolo VI): contiene le Schede tecniche e le Descrizioni<br />
sintetiche riferite alle azioni proposte dal PdG.<br />
• Appen<strong>di</strong>ce: Regolamento. Tale documento <strong>di</strong>sciplina le modalità <strong>di</strong> utilizzo e<br />
fruizione del SIC-ZPS, detta misure specifiche a tutela della flora, della fauna, degli<br />
habitat <strong>di</strong> interesse comunitario, delle risorse idriche, del suolo e del territorio;<br />
regolamenta le modalità <strong>di</strong> costruzione <strong>di</strong> opere e manufatti; <strong>di</strong>sciplina gli interventi<br />
ammessi sul paesaggio rurale; regolamenta e incentiva attività economiche ecosostenibili;<br />
regolamenta le procedure <strong>di</strong> valutazione <strong>di</strong> incidenza e <strong>di</strong> rilascio <strong>di</strong><br />
autorizzazioni; prevede un apparato sanzionatorio <strong>di</strong>retto a garantire il rispetto delle<br />
prescrizioni in esso contenute.<br />
17
2. QUADRO CONOSCITIVO<br />
Nel presente quadro conoscitivo sono stati riassunti e aggiornati, attraverso resoconti sintetici,<br />
i contenuti degli stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> base utilizzati per la redazione del Piano <strong>di</strong> Gestione ministeriale<br />
(progetto LIFE). A tali stu<strong>di</strong> si rimanda per una più completa e approfon<strong>di</strong>ta conoscenza del<br />
territorio delle gravine.<br />
In particolare si rimanda a:<br />
1. Progetto LIFE 99/NAT/IT/006279 “Verifica della rete Natura 2000 in Italia e<br />
modelli <strong>di</strong> Gestione”; gli stu<strong>di</strong> relativi a tale progetto sono stati redatti dalla<br />
Società Botanica Italiana per gli aspetti, forestali e botanico-vegetazionali,<br />
dall’Unione Zoologica Italiana per gli aspetti faunistici, dalla Società italiana <strong>di</strong><br />
Ecologia per gli aspetti idrogeologici.<br />
2. Stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> fattibilità per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale e<br />
della bio<strong>di</strong>versità del sistema delle gravine dell’arco jonico, redatto da (TEI –<br />
E.T.A.CONS srl –Ing. Farenga – Ing. Cotecchia.<br />
3. Progetto esecutivo - azione C2 LIFE 03 NAT/ IT/000134 ”Interventi <strong>di</strong><br />
salvaguar<strong>di</strong>a e <strong>di</strong> recupero della rete ecologica <strong>di</strong> connessione tra le gravine<br />
caratterizzata dall'habitat dei Thero-Brachypo<strong>di</strong>etea”.<br />
2.1. Ubicazione geografica e descrizione dei confini<br />
Il territorio cosiddetto delle “Gravine” si estende nel versante occidentale della <strong>Provincia</strong> <strong>di</strong><br />
<strong>Taranto</strong>. Il sito denominato “Area delle Gravine” è composto da due aree <strong>di</strong>stinte e separate<br />
interessando, in tutto o in parte, i territori dei comuni <strong>di</strong> Laterza, Ginosa, Castellaneta,<br />
Mottola, Palagiano, Palagianello, Massafra, Crispiano e Statte.<br />
Il territorio <strong>di</strong> tali Comuni si estende ad anfiteatro lungo l’arco costiero jonico che va dalla<br />
foce del fiume Bradano, ai confini con la Basilicata, ad Ovest; fino alla Gravina Gennarini, ai<br />
confini con il Comune <strong>di</strong> <strong>Taranto</strong>, ad Est.<br />
Dai dati <strong>di</strong>sponibili, nell’area interessata risultano circa 70 gravine <strong>di</strong> varia <strong>di</strong>mensione e<br />
<strong>di</strong>sposte lungo due archi, il primo sul terrazzamento che va da quota 100 m. s.l.m. fino a quota<br />
250 m. s.l.m. e l’altro sul tavolato che va dai 250 ai 400 m. s.l.m. <strong>di</strong> quota. L’intera superficie<br />
del SIC/ZPS (Fig. 2.1) ammonta a 26.740,235 ha.<br />
18
Fig. 1 - L’area del SIC/ZPS n. IT 9130007 “Area delle Gravine”.<br />
2.2. Clima regionale e locale<br />
Dal punto <strong>di</strong> vista bioclimatico la zona presenta un clima <strong>di</strong> tipo me<strong>di</strong>terraneo con estati<br />
secche e inverni miti con valori me<strong>di</strong> <strong>di</strong> temperatura raramente inferiori a 3 °C.<br />
2.3. Geologia e geomorfologia<br />
Le formazioni geologiche dominanti della regione Puglia sono: i calcari del Giurassico e<br />
soprattutto quelli del Cretaceo. Su tali rocce calcaree l’azione degli agenti atmosferici ha dato<br />
origine ai numerosi fenomeni carsici tipici della Puglia L'origine delle Murge si può far<br />
risalire proprio allo scontro avvenuto nel Cretaceo superiore, circa 100 milioni <strong>di</strong> anni fa, tra<br />
la zolla africana e quella europea. In seguito allo scontro si ebbe il sollevamento della<br />
"piattaforma appula": è in questo contesto tettonico che si modella l'attuale struttura a<br />
gra<strong>di</strong>nata delle Murge. La genesi delle gravine va ricercata, più che nei fenomeni<br />
geomorfologici propri dei climi umi<strong>di</strong>, in quelli tipici delle formazioni desertiche, dove il<br />
carattere torrentizio dei corsi d’acqua è in grado <strong>di</strong> scavare solchi profon<strong>di</strong>. L'azione erosiva<br />
19
della pioggia sul calcare, (<strong>di</strong> tipo meccanico), fu amplificata dalla <strong>di</strong>ssoluzione chimica del<br />
carbonato <strong>di</strong> calcio, che avveniva grazie all’azione solvente dell’anidride <strong>di</strong>sciolta nelle acque<br />
piovane, inquadrando il processo nel più vasto e complesso fenomeno del carsismo che<br />
riguarda l'intera Puglia. Le gravine, Infatti, contengono o sono contornate da grotte naturali,<br />
doline, inghiottitoi e altre formazioni carsiche (RUSSO e STASI, 2001).<br />
2.4. Idrologia<br />
Dal punto <strong>di</strong> vista idrografico tale area rientra, in gran parte, nel bacino idrografico del fiume<br />
Lato. In ere passate i fiumi che solcavano questo territorio si caratterizzavano per la presenza<br />
<strong>di</strong> un comportamento <strong>di</strong> tipo meandriforme e per una maggiore portata, come emerge dalla<br />
lettura dei paleoalvei. Attualmente invece questi fiumi si caratterizzano per il carattere<br />
spiccatamente torrentizio. La presenza <strong>di</strong> acqua corrente sul letto <strong>di</strong> queste forre, nel periodo<br />
estivo è in gran parte dovuto ai rilasci dei depuratori dei comuni presenti all’interno dei<br />
perimetri dei siti.<br />
2.5. Descrizione biologica<br />
2.5.1. Schede Natura 2000 : verifica e aggiornamento<br />
In questo paragrafo viene effettuato il confronto tra gli habitat e le specie attualmente presenti<br />
nelle schede Natura 2000 e quelli riportati negli stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> base. Nel documento <strong>di</strong><br />
aggiornamento che è in via <strong>di</strong> attuazione verranno forniti i dati <strong>di</strong> superficie degli habitat non<br />
ancora stimati, per quelle in cui il dato viene fornito si precisa che si tratta <strong>di</strong> “superfici<br />
stimate”. Nel paragrafo successivo (Atlante del territorio) vengono fornite ulteriori<br />
informazioni relative ad habitat e specie.<br />
Habitat<br />
Gli stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> base confermano la presenza dei sette habitat in<strong>di</strong>cati nella scheda Natura 2000<br />
del sito “Area delle Gravine”. Le superfici in<strong>di</strong>cate sono<br />
HABITAT<br />
92A0 Foreste a galleria <strong>di</strong> Salix alba e Populus<br />
alba<br />
Schede natura<br />
2000<br />
Stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> base e<br />
aggiornamento<br />
Superficie in<br />
ettari (stimata)<br />
Specie floristiche<br />
Gli stu<strong>di</strong> floristici <strong>di</strong> base hanno condotto all’in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong> numerose specie vegetali, <strong>di</strong><br />
cui 70 ritenute utili ai fini della conservazione e gestione del sito. Tra queste è da menzionare<br />
Campanula versicolor, specie minacciata a livello regionale e numerosi altri taxa,<br />
appartenenti a 25 famiglie botaniche, tra cui spiccano numerose specie appartenenti alla<br />
famiglia delle orchidaceae. Solo due specie pugliesi sono incluse nell’allegato II della<br />
<strong>di</strong>rettiva comunitaria 92/43 CEE, Stipa austroitalica e Marsilea strigosa.<br />
Gli stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> base per l’aggiornamento della scheda Natura 2000 hanno consentito<br />
l’inserimento ( N ) <strong>di</strong> 29 e l’esclusione ( E ) <strong>di</strong> 7 taxa. Il binomio <strong>di</strong> ciascuna specie segue la<br />
chek-list <strong>di</strong> Conti et al. 1 Specie Motivazione<br />
Acer monspessulanum ssp. monspessulanum N<br />
Aeonium undulatum E<br />
Anacamptis pyramidalis N<br />
Asyneuma limonifolium ssp. limonifolium N<br />
Athamanta sicula N<br />
Aurinia saxatilis ssp. megalocarpa N<br />
Centaurea apula E<br />
Cirsium tenoreanum N<br />
Coronilla valentina N<br />
Crocus thomasii N<br />
Cytisus spinescens N<br />
Eragrostis barrellieri E<br />
Euphorbia apios N<br />
Euphorbia dendroides N<br />
Euphorbia wulfenii E<br />
Fumana scoparia N<br />
Helianthemum jonium N<br />
Ionopsi<strong>di</strong>um albiflorum (= Jonopsi<strong>di</strong>um albiflorum) E<br />
Iris lorea N<br />
Linaria triphylla N<br />
Lomelosia argentea N<br />
Marsilea strigosa N<br />
Onosma echioides N<br />
Ophrys arachnitiformis E<br />
Orchis coriophora N<br />
Phlomis fruticosa N<br />
Quercus trojana N<br />
Rhamnus saxatilis ssp. infectoria N<br />
elevato valore biogeografico<br />
endemica delle Isole Canarie<br />
protetta da convenzione CITES<br />
elevato valore biogeografico<br />
elevato valore biogeografico<br />
elevato valore biogeografico<br />
non riportata per la penisola italiana nella<br />
check-list <strong>di</strong> Conti et al. 1<br />
endemica<br />
elevato valore biogeografico<br />
elevato valore biogeografico<br />
elevato valore biogeografico<br />
non riportata per la Puglia nella checklist<br />
<strong>di</strong> Conti et al. 1<br />
elevato valore biogeografico<br />
elevato valore biogeografico<br />
inclusa in Euphorbia characias che è<br />
specie ad ampia valenza ecologica<br />
elevato valore biogeografico<br />
elevato valore biogeografico<br />
mancano segnalazioni recenti per la<br />
Puglia<br />
elevato valore biogeografico<br />
rara nel territorio<br />
rara nel territorio<br />
Riportata nella lista rossa regionale con<br />
lo status <strong>di</strong> gravemente minacciata (CR)<br />
e per quella nazionale come vulnerabile<br />
(VU)<br />
endemica<br />
non riportata per la penisola italiana nella<br />
check-list <strong>di</strong> Conti et al. 1<br />
Protetta dalla convenzione CITES<br />
elevato valore biogeografico<br />
elevato valore biogeografico<br />
elevato valore biogeografico<br />
21
Satureja cuneifolia N<br />
Scabiosa pseu<strong>di</strong>setensis (= Lomelosia crenata ssp. pseu<strong>di</strong>setensis) E<br />
Scrophularia lucida N<br />
Sternbergia lutea N<br />
Thymus spinulosus N<br />
Trachelium caeruleum N<br />
Triticum biunciale N<br />
Tuberaria lignosa N<br />
elevato valore biogeografico<br />
non riportata per la Puglia nella checklist<br />
<strong>di</strong> Conti et al. 1<br />
elevato valore biogeografico<br />
protetta da convenzione CITES<br />
endemica dell’Italia centro-meridonale<br />
rara nel territorio<br />
riportata nella lista rossa regionale con lo<br />
status <strong>di</strong> gravemente minacciata (CR)<br />
rara nel territorio<br />
Di seguito si riportano i taxa riportati negli allegati II e IV della <strong>di</strong>rettiva comunitaria<br />
(92/43CEE), le entità endemiche, le specie presenti nelle liste rosse nazionali e regionali<br />
(Conti et al. 2 )con il relativo status <strong>di</strong> conservazione secondo l’I.U.C.N (International Union<br />
for Nature Conservation), quelle citate nelle convenzioni internazionali (Berna e CITES) e<br />
quelle rare o <strong>di</strong> elevato valore biogeografico, utili all’aggiornamento della scheda.<br />
Pteridopsida<br />
PTERIDOPHYTA<br />
Lista<br />
Dir.<br />
92/43 Endemica Rossa<br />
Naz.<br />
Lista<br />
Rossa<br />
Reg.<br />
Rara o <strong>di</strong> elevato<br />
Convenzioni <strong>di</strong><br />
Berna o CITES<br />
valore<br />
biogeografico<br />
<strong>Relazione</strong> tra<br />
habitat e specie 3<br />
Marsileaceae<br />
Trifoglio acquatico peloso<br />
Marsilea strigosa<br />
SPERMATOPHYTA<br />
II VU CR * ?<br />
Angiospermae<br />
Dicotyledoneae<br />
Aceraceae<br />
Acero minore<br />
Acer monspessulanum<br />
Asceple<strong>di</strong>aceae<br />
Vincetossico comune<br />
Vincetoxicum hirun<strong>di</strong>naria<br />
Borraginaceae<br />
Viperina comune<br />
Onosma echioides<br />
Campanulaceae<br />
Raponzolo meri<strong>di</strong>onale<br />
Asyneuma limonifolium ssp.<br />
limonifolium<br />
Campanula pugliese<br />
Campanula versicolor<br />
Trachelio coltivato<br />
Trachelium caeruleum<br />
Caryophyllaceae<br />
Garofano garganico<br />
Dianthus garganicus<br />
Cistaceae<br />
Fumana scoparia<br />
Fumana scoparia<br />
* ?<br />
* 9250, 9340<br />
* 6220<br />
* 8210, 9250, 9540<br />
LR EN 8210<br />
* 8210<br />
* 6220, 8210<br />
LR * -<br />
22
Eliantemo jonico<br />
Helianthemum jonium<br />
Fior gallinaccio maggiore<br />
Tuberaria lignosa<br />
Compositae<br />
Fiordaliso pugliese<br />
Centaurea brulla<br />
Fiordaliso garganico<br />
Centaurea subtilis<br />
Cardo <strong>di</strong> Tenore<br />
Cirsium tenoreanum<br />
Fiordaliso centauro<br />
Rhaponticoides centaurium<br />
Camomilla d’Otranto<br />
Anthemis hydruntina<br />
Cruciferae<br />
Alisso sassicolo<br />
Aurinia saxatilis ssp. megalocarpa<br />
Berteroa obliqua<br />
Berteroa obliqua ssp. obliqua<br />
Biscutella sbiancata<br />
Biscutella incana<br />
Euphorbiaceae<br />
Euforbia schiattarella<br />
Euphorbia apios<br />
Euforbia arborescente<br />
Euphorbia dendroides<br />
Fagaceae<br />
Quercia troiana<br />
Quercus trojana<br />
Labiatae<br />
Salvione giallo<br />
Phlomis fruticosa<br />
Salvia triloba<br />
Salvia fruticosa<br />
Santoreggia pugliese<br />
Satureja cuneifolia<br />
Timo spinosetto<br />
Thymus spinulosus<br />
Leguminosae<br />
Citiso spinoso<br />
Cytisus spinescens<br />
Cornetta <strong>di</strong> Valenza<br />
Coronilla valentina<br />
Liliaceae<br />
Aglio viola-scuro<br />
Allium atroviolaceum<br />
Aglio moscato<br />
Allium moschatum<br />
Linaceae<br />
* 5330<br />
VU * -<br />
* 6220, 8210<br />
* EN CR 8210<br />
* 6220<br />
* VU CR 9250, 9340<br />
* LR CR 6220<br />
* 8210<br />
VU * 6220<br />
* DD DD * 8210<br />
* * 6220, 9250, 9540<br />
* * 5330<br />
* 9250<br />
* -<br />
EN 8210, 6220<br />
* 6220<br />
* 6220<br />
* 6220<br />
* ?<br />
VU * -<br />
CR * ?<br />
Lino <strong>di</strong> Tommasini<br />
Linum austriacum ssp. tommasinii VU * 6220<br />
Paeoniaceae<br />
Peonia maschio<br />
Paeonia mascula<br />
Rhamnaceae<br />
VU 9250, 9340<br />
23
Ranno spinello<br />
Rhamnus saxatilis ssp. infectoria<br />
Rutaceae<br />
Dittamo<br />
Dictamnus albus<br />
Umbelliferae<br />
Atamanta siciliana<br />
Athamanta sicula<br />
Kummel <strong>di</strong> Grecia<br />
Carum multiflorum ssp.<br />
multifolrum<br />
Seseli abruzzese<br />
Seseli tommasinii<br />
Scrophulariaceae<br />
Linajola trifogliata<br />
Linaria triphylla<br />
Scrofularia pugliese<br />
Scrophularia lucida<br />
Monocotiledoni<br />
Amarillydaceae<br />
Zafferanastro giallo<br />
Sternbergia lutea<br />
Araceae<br />
Gigaro pugliese<br />
Arum apulum<br />
Graminaceae<br />
Cerere con una resta<br />
Triticum uniaristatum<br />
Cerere comune<br />
Triticum biunciale<br />
Lino delle fate piumoso<br />
Stipa austroitalica<br />
Iridaceae<br />
Zafferano <strong>di</strong> Thomas<br />
Crocus thomasii<br />
Giaggoilo meri<strong>di</strong>onale<br />
Iris lorea<br />
Giaggiolo siciliano<br />
Iris psudopumila<br />
Orchidaceae<br />
Orchide<br />
Anacamptis pyramidalis<br />
Barlia<br />
Barlia robertiana<br />
Ofride <strong>di</strong> Bertoloni<br />
Ophrys bertolonii<br />
Ofride fior <strong>di</strong> Bombo<br />
Ophrys bombyliflora<br />
Ofride dei Fuchi<br />
Ophrys fuciflora ssp. apulica<br />
Ofride dei Fuchi<br />
Ophrys fuciflora ssp.<br />
parvimaculata<br />
Ofride scura<br />
Ophrys fusca ssp. fusca<br />
Ofride gialla<br />
Ophrys lutea<br />
* -<br />
CR 6220, 8210<br />
* 8210<br />
LR EN 8210<br />
* ?<br />
* 6220<br />
* 8210<br />
* 6220<br />
* CR CR 9250, 9340<br />
EN EN 6220<br />
CR CR 6220<br />
II * * 6220<br />
* 6220<br />
* 6220, 9250<br />
* * 6220<br />
* 6220<br />
* 6220<br />
* 6220<br />
* 6220<br />
* * 6220<br />
* VU * 6220<br />
* 6220<br />
* 6220<br />
24
Ofride dei Fuchi<br />
Ophrys oxyrrhynchos<br />
Ofride verde-bruna<br />
Ophrys sphegodes<br />
Ofride tarantina<br />
Ophrys tarentina<br />
Ofride fior <strong>di</strong> vespa<br />
Ophrys tenthre<strong>di</strong>nifera<br />
Ballerina<br />
Orchis anthropophora<br />
Orchide a sacco<br />
Orchis collina<br />
Orchide cimicina<br />
Orchis coriophora<br />
Orchide italiana<br />
Orchis italica<br />
Orchide aguzza<br />
Orchis lactea<br />
Orchide minore<br />
Orchis morio<br />
Orchide a farfalla<br />
Orchis papilionacea<br />
Serapide lingua<br />
Serapias lingua<br />
Serapide minore<br />
Serapias parviflora<br />
Serapide maggiore<br />
Serapias vomeracea<br />
Viticcini autunnali<br />
Spiranthes spiralis<br />
* CR CR * 6220<br />
* 6220<br />
* CR CR * 6220<br />
* 6220<br />
* 6220<br />
* 6220<br />
* 6220, 9540<br />
* 6220<br />
* 6220<br />
* 6220<br />
* 6220<br />
* 6220<br />
* 6220<br />
* 6220<br />
* 6220<br />
Legenda: CR = Gravemente minacciata, EN = minacciata, LR = a basso rischio , VU = Vulnerabile, DD = Dati insufficienti<br />
(1): CONTI F., ABBATE G., ALESSANDRINI G. & BLASI C., 2005 – An Annotated Checklist of the Italian Vascular<br />
Flora. Palombi E<strong>di</strong>tori, Roma.<br />
(2) CONTI F., MANZI A. & PEDROTTI F., 1997 – Liste Rosse Regionali delle Piante d’Italia. World Wildlife Fund<br />
(WWF) Italia. Società Botanica Italiana (SBI). Centro Inter<strong>di</strong>partimentale Au<strong>di</strong>ovisivi e Stampa, Università <strong>di</strong> Camerino, 139<br />
pp..<br />
(3): HABITAT – 5330 Arbusteti termome<strong>di</strong>terranei e pre-steppici; 6220* Percorsi substeppici <strong>di</strong> graminacee e piante annue<br />
dei Thero-Brachypo<strong>di</strong>etea; 8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica; 8310 Grotte non ancora sfruttate a<br />
livello turistico; 9250 Querceti a Quercus trojana; 9340 Foreste <strong>di</strong> Quercus ilex e Quercus rotun<strong>di</strong>folia; 9540 Pinete<br />
me<strong>di</strong>terranee <strong>di</strong> pini mesogeni endemici; 92A0 Foreste a galleria <strong>di</strong> Salix alba e Populus alba.<br />
Specie faunistiche<br />
Gli stu<strong>di</strong> faunistici <strong>di</strong> base, oltre ad aumentare le conoscenze sulla <strong>di</strong>stribuzione e status delle<br />
specie <strong>di</strong> maggiore interesse comunitario, hanno portato all’aggiornamento delle schede <strong>di</strong><br />
Rete Natura.<br />
Di seguito si riportano sinteticamente i risultati conseguiti per i vari Taxa.<br />
Per la classe degli Insetti sono state classificate durante le indagini <strong>di</strong> campo 20 specie<br />
appartenenti a 16 <strong>di</strong>fferenti famiglie. Tutte le specie non erano riportate nelle schede <strong>di</strong> Rete<br />
Natura.<br />
Per gli Anfibi e Rettili sono state rilevate 14 specie, <strong>di</strong> cui 6 in allegato II e 8 in allegato IV<br />
della Direttiva Habitat (92/43/CEE).<br />
Per gli Uccelli sono state rilevate 19 specie listate in allegato I della <strong>di</strong>rettiva Uccelli<br />
(79/409/CEE). Di queste ben 18 sono ni<strong>di</strong>ficanti. Due specie, il Lanario e il Grillaio entrambe<br />
ni<strong>di</strong>ficanti, sono considerate prioritarie.<br />
25
Dal confronto tra i dati della scheda <strong>di</strong> Rete Natura e i dati raccolti durante la campagna <strong>di</strong><br />
ricerca risulta non confermata la presenza <strong>di</strong> 6 specie <strong>di</strong> Uccelli (Circus aeruginosus, Circus<br />
cyaneus, Circus pygargus, Falco eleonorae, Pluvialis apricaria, Ficedula albicollis) per il<br />
sito oggetto del piano.<br />
Per quanto riguarda i Mammiferi le specie rinvenute listate nella <strong>di</strong>rettiva Habitat sono 19, <strong>di</strong><br />
cui 8 elencate nell’allegato II e 11 nell’allegato IV. La maggior parte delle specie che<br />
rientrano nella <strong>di</strong>rettiva Habitat appartengono all’Or<strong>di</strong>ne dei Chirotteri e sono le uniche<br />
presenti nell’allegato II. Per il resto non sono presenti specie <strong>di</strong> particolare interesse conservazionistico<br />
fatta eccezione per l’Istrice e il Gatto selvatico, quest’ultimo da confermare.<br />
Facendo seguito alle ricerche finanziate dal progetto POR "Piano d’azione per la<br />
conservazione del Capovaccaio Neophron percnopterus e azioni <strong>di</strong> conservazione del Grillaio<br />
Falco naumanni Nibbio reale Milvus milvus e Nibbio bruno Milvus migrans nella ZPS-pSIC<br />
Area delle gravine” (Misura 1.6 Salvaguar<strong>di</strong>a della valorizzazione dei beni naturali e<br />
ambientali- Linea <strong>di</strong> intervento 2, Conservazione e recupero del patrimonio naturale regionale<br />
- BURP n 154 del 5.12.02) si riporta l’elenco aggiornato delle specie listate negli allegati II e<br />
IV della <strong>di</strong>rettiva 92/43 e nell’allegato I della <strong>di</strong>rettiva 79/409.<br />
MAMMIFERI Dir. 79/409<br />
Chiroptera<br />
Rinolofo maggiore<br />
Rhinolophus<br />
ferrumequinum<br />
Rinolofo minore<br />
Rhinolophus hipposideros<br />
Vespertilio minore<br />
Myotis blythii<br />
Vespertilio smarginato<br />
Myotis emarginatus<br />
Vespertilio <strong>di</strong> Capaccini<br />
Myotis capaccini<br />
Vespertilio maggiore<br />
Myotis myotis<br />
Pipistrello del Savi<br />
Hypsugo savii<br />
Pipistrello albolimbato<br />
Pipistrellus kuhlii<br />
Serotino comune<br />
Eptesicus serotinus<br />
Miniottero<br />
Miniopterus schreibersii<br />
Molosso <strong>di</strong> Cestoni<br />
Tadarida teniotis<br />
Dir.<br />
92/43<br />
Popolazione<br />
Stato <strong>di</strong><br />
conservazione<br />
<strong>Relazione</strong> tra habitat e<br />
specie 3<br />
II (1) Vulnerabile 8310, 6220<br />
II (1) Vulnerabile 8310, 5330, 9250, 9340<br />
II (1) Vulnerabile 8310, 6220, 5330<br />
II (1) Vulnerabile 8310, 6220, 5330<br />
II (1) In pericolo 8310, 9250<br />
II (1) Vulnerabile 8310, 5330, 9250, 9340<br />
IV (1) Sicuro 8310, 6220, 5330, 9540<br />
IV (1) Sicuro 8310, 6220, 5330, 9540<br />
IV (1) Sicuro 8310, 6220, 5330, 9540<br />
II (1) Vulnerabile 8310, 6220, 5330<br />
IV (1) Sicuro 8310, 6220, 5330, 8210<br />
26
UCCELLI Dir. 79/409<br />
Accipritiformes<br />
Falco pecchiaiolo<br />
Pernis apivorus<br />
Nibbio bruno<br />
Milvus migrans<br />
Nibbio reale<br />
Milvus milvus<br />
Capovaccaio<br />
Neophron percnopterus<br />
Biancone<br />
Circaetus gallicus<br />
Falconiformes<br />
Grillaio<br />
Falco naumanni<br />
Lanario<br />
Falco biarmicus<br />
Pellegrino<br />
Falco pellegrino<br />
Charadriiformes<br />
Occhione<br />
Burhinus oe<strong>di</strong>cnemus<br />
Strigiformes<br />
Gufo reale<br />
Bubo bubo<br />
Caprimulgiformes<br />
Succiacapre<br />
Caprimulgus europaeus<br />
Coraciiformes<br />
Martin pescatore<br />
Alcedo atthis<br />
Ghiandaia marina<br />
Coracias glandarius<br />
Passeriformes<br />
Calandra<br />
Melanochorypha calandra<br />
Calandrella<br />
Calandrella brachydactila<br />
Tottavilla<br />
Lullula arborea<br />
Calandro<br />
Anthus campestris<br />
Averla piccola<br />
Lanius collurio<br />
Averla cenerina<br />
Lanius minor<br />
Dir.<br />
92/43<br />
Popolazione<br />
Stato <strong>di</strong><br />
conservazione<br />
<strong>Relazione</strong> tra habitat e<br />
specie 3<br />
I Migratrice 9250, 9340<br />
I 3 cp Vulnerabile 6220, 8210<br />
I 2 cp In pericolo 6220, 9250, 9540<br />
I 1 cp In pericolo 6220, 8210<br />
I 2-3 cp Vulnerabile 6220, 9250, 9340, 9540<br />
I 286-340 cp 6220<br />
I 3 cp Vulnerabile 6220, 8210<br />
I Svernante Sicuro 6220, 8210<br />
I 10 cp In pericolo 6220<br />
I 1-2 cp Vulnerabile 6220, 8210<br />
I Nessun dato Vulnerabile 6220, 5330, 9540<br />
I Nessun dato Sicuro<br />
I 2-3 cp Vulnerabile 6220, 5330, 8210, 9250<br />
I<br />
I<br />
I<br />
7,6 cp/km 2<br />
pseudosteppa<br />
1,8 cp/km 2<br />
seminativo<br />
1,8 cp/km 2<br />
pseudosteppa<br />
1,6 cp/km 2<br />
seminativo<br />
0,5 cp/km 2<br />
pseudosteppa<br />
0,05 cp/km 2<br />
seminativo<br />
In <strong>di</strong>minuzione 6220<br />
In <strong>di</strong>minuzione 6220<br />
Vulnerabile 6220, 5330, 9250<br />
I Nessun dato Vulnerabile 6220<br />
I Nessun dato In <strong>di</strong>minuzione 5330<br />
I Nessun dato In <strong>di</strong>minuzione 6220, 5330<br />
27
RETTILI Dir. 79/409<br />
Dir.<br />
92/43<br />
Popolazione<br />
Stato <strong>di</strong><br />
conservazione<br />
<strong>Relazione</strong> tra habitat e<br />
specie 3<br />
Testu<strong>di</strong>nes<br />
Testuggine palustre<br />
Emys orbicularis<br />
II In pericolo 92A0<br />
Testuggine comune<br />
Testudo hermanni<br />
II In pericolo 6220, 5330, 9250, 9540<br />
Sauria<br />
Geco <strong>di</strong> Kotschi<br />
Cyrtodactylus kotschyi<br />
IV Sicuro 6220, 5330, 8210<br />
Ramarro occidentale<br />
Lacerta bilineata<br />
IV Sicuro 6220, 5330, 9250, 9540<br />
Lucertola campestre<br />
Podarcis sicula<br />
IV Sicuro 6220, 5330, 9540<br />
Serpentes<br />
Biacco<br />
Coluber viri<strong>di</strong>flavus<br />
IV Sicuro 6220, 5330, 9250, 9540<br />
Colubro liscio<br />
Coronella liscio<br />
IV Vulnerabile 5330, 9250<br />
Cervone<br />
6220, 5330, 9250, 9340,<br />
II<br />
Sicuro<br />
Elaphe quatuorlineata<br />
9540<br />
Colubro leopar<strong>di</strong>no<br />
Elaphe situla<br />
II Sicuro 6220, 5330, 8210, 9250<br />
la Natrice tassellata<br />
Natrix tessellata IV Sicuro 6220, 5330, 8210, 9250<br />
Caudata<br />
ANFIBI Dir. 79/409<br />
Tritone crestato<br />
Triturus carnifex<br />
Tritone italiano<br />
Triturus italicus<br />
Anura<br />
Ululone appenninico<br />
Bombina pachypus<br />
Rospo smeral<strong>di</strong>no<br />
Bufo viri<strong>di</strong>s<br />
Raganella italiana<br />
Hyla interme<strong>di</strong>a<br />
Dir.<br />
92/43<br />
II<br />
IV<br />
Popolazione<br />
Stato <strong>di</strong><br />
conservazione<br />
<strong>Relazione</strong> tra habitat e<br />
specie 3<br />
92A0<br />
92A0<br />
II Vulnerabile 92A0<br />
IV Sicuro 6220, 5330, 9250,3280<br />
IV Vulnerabile 9340, 92A0<br />
(3): HABITAT – 5330 Arbusteti termome<strong>di</strong>terranei e pre-steppici; 6220* Percorsi substeppici <strong>di</strong> graminacee e piante annue<br />
dei Thero-Brachypo<strong>di</strong>etea; 8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica; 8310 Grotte non ancora sfruttate a<br />
livello turistico; 9250 Querceti a Quercus trojana; 9340 Foreste <strong>di</strong> Quercus ilex e Quercus rotun<strong>di</strong>folia; 9540 Pinete<br />
me<strong>di</strong>terranee <strong>di</strong> pini mesogeni endemici; 92A0 Foreste a galleria <strong>di</strong> Salix alba e Populus alba.<br />
(4): Sui Chirotteri sono <strong>di</strong>sponibili solo dati relative alla presenza/assenza, per cui è impossibile definire lo stato delle<br />
popolazioni.<br />
28
2.6. Atlante del territorio<br />
2.6.1. Copertura del suolo, vegetazione e habitat<br />
L'area delle Gravine dell'arco ionico conserva ancora <strong>di</strong>screte estensioni boschive dominate<br />
dal fragno (Quercus trojana) e, nelle stazioni più calde e secche, dal leccio (Quercus ilex).<br />
Marginalmente sono presenti i querceti a roverella sensu lato (Quercus pubescens, Quercus<br />
virgiliana, Quercus dalechampii, Quercus amplifolia) e le pinete a pino d'Aleppo (Pinus<br />
halepensis).<br />
Le aree pseudosteppiche hanno una notevole estensione, anche se minore rispetto alla vicina<br />
Alta Murgia, e si rinvengono soprattutto nell’intervallo altitu<strong>di</strong>nale compreso tra 300 e 400 m<br />
s.l.m.<br />
Un aspetto particolarmente interessante, che determina la creazione <strong>di</strong> ambienti caratteristici,<br />
è rappresentato dalla presenza <strong>di</strong> uno spiccato gra<strong>di</strong>ente termico all’interno delle gravine.<br />
Questo fa sì che, procedendo dal margine superiore verso il fondo, si susseguano comunità<br />
vegetali che necessitano <strong>di</strong> un maggiore grado <strong>di</strong> umi<strong>di</strong>tà, il che da luogo alla base alla<br />
formazione <strong>di</strong> una vegetazione tipicamente mesofila.<br />
2.6.2. Tipologie vegetazionali<br />
Di seguito si riporta la descrizione delle tipologie vegetazionali naturali e semi-naturali<br />
presenti nel sito in esame e, laddove riscontrato, l’Habitat Natura 2000 <strong>di</strong> riferimento. In<br />
allegato alla presente sintesi si riportano:<br />
• Carta della copertura del suolo;<br />
• Carta della vegetazione (redatta sulla base <strong>di</strong> un quinto livello <strong>di</strong> classificazione del<br />
sistema europeo <strong>di</strong> mappatura dell’uso e copertura del suolo Corine Land Cover);<br />
• Carta degli habitat (redatta sulla base degli habitat riportati nell’allegato I della<br />
<strong>di</strong>rettiva Habitat 92/43 CEE).<br />
• Carta della <strong>di</strong>stribuzione reale della specie floristiche riportate nel § 2.5.1. La carta è<br />
redatta sulla base <strong>di</strong> un reticolo con maglia <strong>di</strong> 10 km<br />
• Carta fitosociologica <strong>di</strong> alcune tipologie vegetazionali rilevate in alcune aree<br />
campione.<br />
Nella cartografia, per ovvi motivi <strong>di</strong> scala, non figurano alcuni aspetti vegetazionali <strong>di</strong> pregio<br />
che meritano particolare attenzione sotto il profilo gestionale. Non è rilevabile, ad esempio, la<br />
vegetazione rupicola che include, tra l’altro, due habitat tutelati a livello comunitario, gli<br />
arbusteti termome<strong>di</strong>terranei e pre-steppici (5330) e le pareti rocciose calcaree con vegetazione<br />
casmofitica (8210), che sfuggono alla rappresentazione cartografica per via della forte<br />
inclinazione delle pareti rocciose. In questi casi limite è auspicabile, come previsto nella<br />
scheda d’azione IA19, uno stralcio in scala <strong>di</strong> maggiore dettaglio (fino a 1:2.000) della carta<br />
della vegetazione (scala 1:10.000) al fine <strong>di</strong> poter mappare in modo opportuno queste<br />
peculiari cenosi vegetali. Nel § 2.6.2.1. vengono comunque analizzate le tipologie <strong>di</strong><br />
vegetazione presenti, incluse quelle per cui non è stato possibile procedere alla loro<br />
29
appresentazione cartografica, e nel paragrafo § 2.7 vengono citati i luoghi dove esse sono<br />
state osservate.<br />
2.6.2.1. Formazioni forestali<br />
Boschi a dominanza <strong>di</strong> Quercus trojana<br />
Habitat Natura 2000: 9250 Querceti a Quercus trojana.<br />
Si tratta <strong>di</strong> formazioni generalmente governate a ceduo semplice o a ceduo matricinato e nelle<br />
quali sovente viene praticato il pascolo del bestiame, principalmente dei bovini. Quercus<br />
trojana Webb, nota comunemente col nome <strong>di</strong> “fragno”, è una specie appartenente<br />
all’elemento nord-est me<strong>di</strong>terraneo, che nell’ambito della penisola italiana risulta localizzata<br />
esclusivamente nelle Murge pugliesi. La presenza in Puglia <strong>di</strong> Quercus trojana riveste un<br />
notevole significato fitogeografico. Nei processi <strong>di</strong> degradazione legati soprattutto al taglio<br />
eccessivo, al pascolo e all’incen<strong>di</strong>o, il fragneto tende a essere sostituito, in seguito alla<br />
<strong>di</strong>struzione dello strato arboreo e arbustivo, da formazioni <strong>di</strong> macchia mesofila. I rilievi<br />
fitosociologici hanno consentito <strong>di</strong> inquadrare queste cenosi forestali nell’associazione<br />
Teucrio siculi-Quercetum trojanae (tabella fitosociologica allegata).<br />
Boschi <strong>di</strong> leccio<br />
Habitat Natura 2000: 9340 Foreste <strong>di</strong> Quercus ilex e Quercus rotun<strong>di</strong>folia.<br />
Formazioni forestali ed arbustive <strong>di</strong> tipo termofilo a prevalenza <strong>di</strong> Quercus ilex spesso<br />
ceduate e rinvenibili su substrati <strong>di</strong> tipo prevalentemente calcareo. La vegetazione si colloca<br />
all’interno delle fasce bioclimatiche termo e mesome<strong>di</strong>terranea, penetrando marginalmente in<br />
quella suprame<strong>di</strong>terranea. Nel territorio sono <strong>di</strong>ffuse prevalentemente lungo i pen<strong>di</strong> scoscesi<br />
esposti a nord e nord-ovest. In questa lecceta si osserva la presenza costante, nello strato<br />
arboreo, <strong>di</strong> Fraxinus ornus e numerose specie arbustive semprever<strong>di</strong>, come Tamus communis,<br />
Ruscus aculeatus, Rosa sempervirens etc. Lo strato erbaceo è caratterizzato da Asplenium<br />
onopteris, Viola alba ssp. dehnhardtii, Carex <strong>di</strong>stachya, Cyclamen hederifolium etc. Queste<br />
leccete riferibili fisionomicamente alle tipiche formazioni a Quercus ilex della fascia<br />
me<strong>di</strong>terranea, mostrano però una forte <strong>di</strong>versità floristica rispetto alle leccete del litorale<br />
ionico pugliese e una maggiore affinità con le vicine formazioni a Quercus trojana.<br />
Pinete e rimboschimenti<br />
Habitat Natura 2000: 9540 Pinete me<strong>di</strong>terranee <strong>di</strong> pini mesogeni endemici.<br />
In questo habitat rientrano le pinete termofile a Pinus halepensis, ricche in sclerofille<br />
dell’Oleo-Ceratonion siliquae, <strong>di</strong>ffuse prevalentemente lungo le aree costiere centromeri<strong>di</strong>onali<br />
e nelle gran<strong>di</strong> isole. Si tratta <strong>di</strong> formazioni autoctone che hanno <strong>di</strong>stribuzione<br />
frammentata, con nuclei spesso molto <strong>di</strong>sgiunti. Le pinete a pino d’Aleppo, si inse<strong>di</strong>ano su<br />
substrati <strong>di</strong> varia natura e risultano piuttosto rade, con un denso sottobosco arbustivo. I suoli<br />
sono, in genere, poco evoluti e talora rocciosi, per cui queste formazioni arboree assumono un<br />
ruolo marcatamente primario. Nell’area delle Gravine i dati <strong>di</strong> letteratura fanno riferimento a<br />
due <strong>di</strong>stinte associazioni fitosociologiche: Thymo capitati-Pinetum halepensis e Plantago<br />
30
albicantis-Pinetum halepensis (tabella fitosociologica allegata), che caratterizzano un tipo <strong>di</strong><br />
vegetazione che si sviluppa prevalentemente su substrato calcarenitico pliocenico con<br />
sottobosco a prevalenza <strong>di</strong> Pistacia lentiscus, specie guida dell’associazione, e numerose<br />
specie termofile dell’Oleo-Ceratonion siliquae. Nelle radure si annoverano alcune<br />
interessanti specie come Salvia triloba, Phlomis fruticosa e numerose orchidee. Si tratta <strong>di</strong> un<br />
habitat ad elevato rischio <strong>di</strong> alterazione poiché posto generalmente sui fianchi delle gravine,<br />
non <strong>di</strong> rado in aree panoramiche, dove è elevato il rischio <strong>di</strong> “valorizzazione impropria” del<br />
territorio e <strong>di</strong> conseguenza anche il rischio <strong>di</strong> incen<strong>di</strong> dolosi. A tal proposito occorre prevenire<br />
il rischio <strong>di</strong> rimboschimenti con pino d’Aleppo su aree incen<strong>di</strong>ate effettuati con ecotipi <strong>di</strong><br />
provenienza alloctona con rischio <strong>di</strong> “inquinamento genetico”. Analogo rischio, seppur in<br />
minor misura, è legato alla coltivazione in ville e giar<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> pini <strong>di</strong> incerta provenienza.<br />
Vegetazione ripariale<br />
Habitat Natura 2000: 92A0 Foreste a galleria <strong>di</strong> Salix alba e Populus alba.<br />
La vegetazione arborea ripariale è scarsamente presente nell’area, nel senso che solo<br />
raramente forma nuclei <strong>di</strong> consistenza significativa tali da poter essere rilevata<br />
cartograficamente, mentre risulta <strong>di</strong>ffusa lungo i torrenti all’interno delle gravine come nuclei<br />
spora<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> modesta entità.<br />
Tale vegetazione arborea è costituita prevalentemente da Populus alba, P. nigra, Salix alba,<br />
Ulmus minor. Nell’ambito della vegetazione ripariale sono presenti piccoli nuclei, non<br />
cartografabili, riferibili alle associazioni Phragmitetum australis, Thyphetum angustifoliae e<br />
Apietum no<strong>di</strong>flori.<br />
2.6.2.2. Formazioni arbustive<br />
Macchia termofila<br />
Habitat Natura 2000: 5330 Arbusteti termo-me<strong>di</strong>terranei e pre-steppici.<br />
È la vegetazione delle stazioni semirupestri e ben soleggiate, fisionomicamente dominata da<br />
Euphorbia dendroides, una delle poche caducifoglie estive della flora me<strong>di</strong>terranea. Essa<br />
caratterizza un tipo <strong>di</strong> macchia marcatamente termoxerofila, riferibile all’associazione Oleo-<br />
Euphorbietum-dendroi<strong>di</strong>s, ricca in specie dell’Oleo-Ceratonion siliquae. Queste comunità<br />
vegetazionali costituiscono un classico esempio <strong>di</strong> edafoclimax, in ambienti rocciosi o<br />
semirupestri molto acclivi spesso esposti a meri<strong>di</strong>one, dove a causa della forte pendenza, la<br />
continua erosione del substrato impe<strong>di</strong>sce la formazione <strong>di</strong> suolo maturo (e quin<strong>di</strong><br />
l’inse<strong>di</strong>amento della vegetazione forestale).<br />
Per macchia termofila si intende “tipicamente”, pur non costituendo habitat per la <strong>di</strong>rettiva<br />
habitat 92/43 CEE, la classica macchia a dominanza <strong>di</strong> sclerofille semprever<strong>di</strong>, in prevalenza<br />
Pistacia lentiscus e Phillyrea latifolia che è un tipo <strong>di</strong> vegetazione strettamente legata al<br />
bosco sotto il profilo <strong>di</strong>namico, nel senso che spesso essa è una derivazione del bosco a<br />
seguito <strong>di</strong> degradazione antropica. In particolare, la macchia alta termofila è il tipo <strong>di</strong><br />
vegetazione che più si avvicina alla lecceta dal punto <strong>di</strong> vista della composizione floristica<br />
annoverando specie <strong>di</strong> sottobosco come Asparagus acutifolius, Prasium majus, Smilax<br />
aspera, Rubia peregrina etc. Per macchia alta si considera un tipo <strong>di</strong> vegetazione arbustiva<br />
che supera 1,5-2 m <strong>di</strong> altezza. Si presenta generalmente fitta e intricata, talvolta con radure<br />
31
erbacee al suo interno. In genere è ubicata in aree non utilizzabili a scopi agricoli. È una<br />
tipologia vegetazionale ricorrente nell’ambito del territorio considerato, dove, a causa del<br />
variare dell’esposizione e delle caratteristiche microclimatiche si compenetra sovente con la<br />
macchia mesofila.<br />
Macchia mesofila<br />
È un tipo <strong>di</strong> vegetazione che, come già accennato, rappresenta uno sta<strong>di</strong>o <strong>di</strong>namico involutivo<br />
dei boschi semicaducifogli. Pertanto le specie riscontrate sono generalmente in comune con<br />
quelle dei boschi <strong>di</strong> fragno, con l’esclusione della componente arborea e con l’aggiunta <strong>di</strong><br />
specie estranee al bosco che si inse<strong>di</strong>ano grazie ai varchi presenti nella vegetazione e <strong>di</strong> specie<br />
tipiche della macchia termofila dato il carattere più termoxerofilo della macchia mesofila<br />
rispetto ai boschi <strong>di</strong> fragno.<br />
Questa tipologia <strong>di</strong> vegetazione, riferibile alla classe Rhamno-Prunetea, osservata lungo gli<br />
orli o nelle chiarie delle formazioni boschive principalmente a fragno, e caratterizzata dalla<br />
dominanza <strong>di</strong> arbusti caducifogli come Prunus spinosa, Rhamnus saxatilis ssp. infectorius,<br />
Crataegus monogyna, Juniperus oxycedrus ssp. oxycedrus, Rubus ulmifolius e Rosa canina.<br />
Questa macchia limita spesso la sua presenza lungo i muretti a secco o a piccoli impluvi. Le<br />
“siepi” che vanno interpretate come derivate dalla selezione antropica dei mantelli in<br />
connessione con l’uso agricolo del territorio, danno origine a delle formazioni <strong>di</strong> elevato<br />
valore storico-paesaggistico, come quelle osservate lungo i vecchi tratturi abbandonati.<br />
Garighe<br />
La gariga è un tipo <strong>di</strong> vegetazione caratterizzato da arbusti me<strong>di</strong>amente non più alti <strong>di</strong> 50 cm e<br />
con forte <strong>di</strong>scontinuità nella copertura vegetale per la presenza <strong>di</strong> ampie radure. I bassi arbusti<br />
che la costituiscono sono spesso <strong>di</strong> aspetto “microfillico”, cioè hanno foglie ridotte e<br />
squamiformi come conseguenza ad un adattamento a con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> più spiccata ari<strong>di</strong>tà del<br />
suolo. Tra le specie caratterizzanti fisionomicamente queste cenosi si annoverano <strong>di</strong>verse<br />
labiatae (Satureja montana, Thymus capitatus, Thymus spinulosus, Rosmarinus officinalis) e<br />
cistacee (Cistus creticus, Cistus monspeliensis, Fumana thymifolia, Fumana scoparia,<br />
Helianthemum jonium) che costituiscono aspetti vegetazionali <strong>di</strong>fferenti riferibili alla classe<br />
Cisto-Micromerietea e Rosmarinetea. È il tipo <strong>di</strong> vegetazione arbustiva che tende a prevalere<br />
sui suoli più degradati sotto il profilo pedologico e nelle aree con substrato roccioso<br />
affiorante.<br />
2.6.2.3. Formazioni erbacee<br />
Aree <strong>di</strong> pseudosteppa<br />
Habitat Natura 2000: 6220* Percorsi substeppici <strong>di</strong> graminacee e piante annue dei Thero-<br />
Brachypo<strong>di</strong>etea<br />
La pseudosteppa è un tipo <strong>di</strong> vegetazione semi-naturale presente nell’ambito del territorio in<br />
oggetto. Si origina per involuzione della gariga a seguito <strong>di</strong> pascolamento eccessivo, incen<strong>di</strong>o<br />
o decespugliamento; la qualcosa porta alla formazione <strong>di</strong> una vegetazione prevalentemente<br />
erbacea, su substrato roccioso affiorante, fisionomicamente caratterizzata dal prevalere <strong>di</strong><br />
graminacee come il barboncino meri<strong>di</strong>onale (Hyparrhenia hirta), specie a ciclo perenne a<br />
32
spiccato carattere <strong>di</strong> termo-xerofilia e nitrofilia e dal lino delle fate piumoso (Stipa<br />
austroitalica), specie endemica dell’Italia meri<strong>di</strong>onale. Questo tipo <strong>di</strong> vegetazione è arricchito<br />
dalla elevata presenza <strong>di</strong> specie vegetali effimere e da geofite. Laddove il <strong>di</strong>sturbo antropico<br />
tende a <strong>di</strong>minuire si riscontra una ricolonizzazione <strong>di</strong> specie arbustive che portano alla<br />
ricostituzione della gariga. Tale vegetazione risulta particolarmente localizzata nella porzione<br />
occidentale dell’“Area delle Gravine”, trovandosi nei <strong>di</strong>ntorni <strong>di</strong> Ginosa e lungo i margini<br />
della Gravina <strong>di</strong> Castellaneta. Nella porzione orientale dell’“Area delle Gravine” le<br />
pseudosteppe sono, invece, più frammentate e sparse sul territorio<br />
Da un punto <strong>di</strong> vista fitosociologico nei percorsi substeppici <strong>di</strong> graminacee e piante annue dei<br />
Thero-Brachypo<strong>di</strong>etea, rientrano <strong>di</strong>verse comunità vegetazionali, il cui inquadramento a<br />
livello <strong>di</strong> unità sintassonomiche <strong>di</strong> dettaglio è affidato all’espletamento dell’azione IA19. Le<br />
conoscenze <strong>di</strong> base unitamente alle esplorazioni <strong>di</strong> campo hanno evidenziato la prevalenza <strong>di</strong><br />
praterie perenni dominate fisionomicamente dal Barboncino meri<strong>di</strong>onale (Hyparrhenia hirta<br />
ssp. hirta) che pre<strong>di</strong>lige i versanti esposti a mezzogiorno e presente nell’area con formazioni<br />
riferibili all’Hyparrhenion hirtae. Di <strong>di</strong>versa natura e struttura sono i pratelli dominati da<br />
specie annuali riferibili al sottotipo Brachypo<strong>di</strong>etalia <strong>di</strong>stachyi (tabella fitosociologica<br />
allegata), con suolo spesso degradato e poco maturo. Queste ultime cenosi formano<br />
generalmente tessere <strong>di</strong> piccole <strong>di</strong>mensioni presenti nelle chiarie che si aprono nelle<br />
formazioni forestali a Fragno e Pino d’Aleppo o formando mosaico con tipologie <strong>di</strong><br />
vegetazione a gariga e/o macchia, con le praterie perenni dell’Hyparrhenion hirtae o anche<br />
con le formazioni ruderali riferibili alla classe Stellarietea me<strong>di</strong>ae.<br />
Vegetazione rupestre<br />
Habitat Natura 2000: 8210 Pareti rocciose con vegetazione casmofitica.<br />
Tale vegetazione rappresenta uno degli aspetti più pregevoli della vegetazione del territorio<br />
per la presenza <strong>di</strong> specie <strong>di</strong> notevole interesse conservazionistico come Campanula<br />
versicolor, Centaurea subtilis, Athamanta sicula, Carum multiflorum ssp. multifolrum<br />
Scrophularia lucida, Aurinia saxatilis ssp. megalocarpa e Dianthus garganicus.. I pen<strong>di</strong>i<br />
calcarei, più o meno ripi<strong>di</strong>, costituiscono un habitat idoneo all’affermarsi <strong>di</strong> una tipica flora e<br />
vegetazione rupestre. L’importanza <strong>di</strong> alcuni elementi floristici rinvenuti nell’area risiede<br />
nella loro rarità, in quanto rappresentano veri e propri relitti floristici che un tempo facevano<br />
parte della vegetazione costiera <strong>di</strong> quella che oggi si può considerare una paleocosta. L’azione<br />
erosiva dei venti dominanti, l’allungamento del periodo <strong>di</strong> siccità estivo, che determina<br />
un’ari<strong>di</strong>tà climatica, a cui si associa un’ari<strong>di</strong>tà pedologica legata alla presenza <strong>di</strong> un substrato<br />
calcareo particolarmente fratturato, che non trattiene le acque superficiali ha determinato<br />
peculiari adattamenti. Le strategie che utilizzano le piante erbacee in quest’ambiente sono<br />
<strong>di</strong>verse. Piante succulente come il Sedum sp. sopravvivono alla siccità grazie a foglie e fusti<br />
carnosi ricchi <strong>di</strong> tessuti parenchimatici all’interno dei quali viene immagazzinata l’acqua. La<br />
riduzione della traspirazione è legata alla presenza <strong>di</strong> una epidermide con membrane esterne<br />
fortemente ispessite provviste <strong>di</strong> grosse cuticole e protette da cospicui rivestimenti cerosi, da<br />
stomi in numero ridotto, affondati nell’epidermide e quasi sempre chiusi, ed alla capacità <strong>di</strong><br />
queste piante <strong>di</strong> propagarsi attraverso frammenti <strong>di</strong> fusto. Una particolarità <strong>di</strong> questa flora è<br />
quello <strong>di</strong> riuscire a vivere sulla nuda roccia e ad utilizzare l’acqua in essa circolante. Si tratta<br />
33
<strong>di</strong> un adattamento che consente alle piante <strong>di</strong> utilizzare l’acqua che le rocce immagazzinano<br />
durante i ben noti fenomeni <strong>di</strong> condensa. Questa <strong>di</strong>sponibilità idrica costante simula<br />
con<strong>di</strong>zioni microclimatiche particolari che consentono a queste specie <strong>di</strong> sopravvivere<br />
agevolmente durante il periodo <strong>di</strong> ari<strong>di</strong>tà estiva, grazie anche allo sviluppo in talune <strong>di</strong> esse,<br />
come già detto, <strong>di</strong> una modesta crassulenza. Da un punto <strong>di</strong> vista fitosociologico queste cenosi<br />
casmofitiche rientrano nell’associazione Campanulion versicoloris (tabella fitosociologica<br />
allegata).<br />
2.7. Stato <strong>di</strong> conservazione degli habitat e delle specie <strong>di</strong> interesse<br />
comunitario<br />
2.7.1. Habitat<br />
92A0 Foreste a galleria <strong>di</strong> Salix alba e Populus alba.<br />
La scarsa rappresentatività <strong>di</strong> questo habitat, che forma nuclei <strong>di</strong> esigua consistenza lungo i<br />
torrenti all’interno delle gravine, spiega la sua assenza nella scheda natura 2000 <strong>di</strong><br />
riferimento. Si rimanda ad una fase successiva (scheda d’azione n. carta della vegetazione) la<br />
loro puntuale localizzazione. Si rimanda ad una fase successiva, azione IA19, la loro<br />
localizzazione puntuale.<br />
5330 Arbusteti termo-me<strong>di</strong>terranei e pre-steppici<br />
Si tratta <strong>di</strong> una comunità arbustiva <strong>di</strong> tipo rupicolo ad Euforbia arborea che a causa<br />
dell’ubicazione stazionale non sembra avere problemi <strong>di</strong> tipo gestionale e conservazionistico.<br />
La sua presenza è certa nei seguenti siti:<br />
‣ Gravina <strong>di</strong> Laterza (comune <strong>di</strong> Laterza)<br />
‣ Gravina <strong>di</strong> Castellaneta (comune <strong>di</strong> Castellaneta)<br />
‣ Gravina <strong>di</strong> Palagianello (comune <strong>di</strong> Palagianello)<br />
ed è molto probabile anche in altre gravine dell’area, dove tuttavia mancano riferimenti<br />
atten<strong>di</strong>bili. Si rimanda alla realizzazione della carta della vegetazione (Scheda d’azione n.…)<br />
l’in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong> tutte le stazioni presenti. Si rimanda alla realizzazione della carta della<br />
vegetazione, azione IA19, la localizzazione <strong>di</strong> queste cenosi vegetali, tipiche <strong>di</strong> molte gravine.<br />
6220* Percorsi substeppici <strong>di</strong> graminacee e piante annue dei Thero-Brachypo<strong>di</strong>etea<br />
È l’habitat semi-naturale più <strong>di</strong>ffuso nell’ambito del territorio in oggetto. Nella porzione<br />
occidentale dell’ “Area delle Gravine” è uniformemente <strong>di</strong>stribuito su tutta la superficie. Al<br />
contrario, nella porzione orientale dell’”Area delle Gravine” risulta più localizzato. Le località<br />
in cui tale habitat è stato rilevato sono:<br />
‣ Gravina <strong>di</strong> S. Biagio, <strong>di</strong> Palagianello e <strong>di</strong> Forcella (comuni <strong>di</strong> Palagianello e Mottola)<br />
‣ Gravina <strong>di</strong> Castellaneta (comuni <strong>di</strong> Castellaneta, Palagianello e Mottola)<br />
‣ Gravina <strong>di</strong> Laterza (comune <strong>di</strong> Laterza)<br />
Le pseudosteppe mostrano attualmente uno stato <strong>di</strong> conservazione sod<strong>di</strong>sfacente, una<br />
<strong>di</strong>screta ricchezza floristica ed una notevole <strong>di</strong>versità cenologica. La vocazione del territorio è<br />
34
comunque forestale o al massimo arbustiva o (sulle rocce) camefitica, per cui è preve<strong>di</strong>bile<br />
che nel tempo le pseudosteppe vengano sostituite da consorzi strutturalmente più complessi,<br />
soprattutto in assenza <strong>di</strong> azioni <strong>di</strong> conservazione.<br />
8210 Pareti rocciose con vegetazione casmofitica<br />
I pen<strong>di</strong>i calcarei più o meno ripi<strong>di</strong> costituiscono un singolare habitat idoneo all’affermarsi <strong>di</strong><br />
una particolare flora e vegetazione rupestre. Senza dubbio è uno degli aspetti più pregevoli<br />
della vegetazione del territorio considerato.<br />
Le località in cui tale habitat è stato rilevato sono:<br />
‣ Gravina <strong>di</strong> Castellaneta (comuni <strong>di</strong> Castellaneta, Palagianello e Mottola);<br />
‣ Gravina <strong>di</strong> S. Stefano (comune <strong>di</strong> Castellaneta);<br />
‣ Complesso delle Gravine <strong>di</strong> Cocuglio, <strong>di</strong> Giacoia, della Vernata, <strong>di</strong> S. Nicola, <strong>di</strong><br />
Pentinelle e <strong>di</strong> Montecamplo (comuni <strong>di</strong> Laterza e Castellaneta);<br />
‣ Gravina del Varco (comune <strong>di</strong> Laterza);<br />
‣ Gravina <strong>di</strong> Laterza (comune <strong>di</strong> Laterza);<br />
‣ Gravina <strong>di</strong> Ginosa (comune <strong>di</strong> Ginosa);<br />
‣ Complesso delle Gravine <strong>di</strong> Gennarini, Leucaspide, Accettullo, Alezza, Mesola,<br />
Lamastuola, Triglio, Miola (Comuni <strong>di</strong> Crispiano e Statte);<br />
‣ Gravina del Vuolo e Gravina della Polvere (comune <strong>di</strong> Massafra);<br />
‣ Gravina della Madonna della Scala, Gravina <strong>di</strong> S. Marco, Gravina <strong>di</strong> S. Elia<br />
(Massafra);<br />
‣ Gravina <strong>di</strong> Colombato (Comune <strong>di</strong> Massafra);<br />
‣ Gravina <strong>di</strong> Petruscio (Comune <strong>di</strong> Mottola).<br />
La vegetazione casmofitica delle pareti rocciose presenta uno stato <strong>di</strong> conservazione sod<strong>di</strong>sfacente.<br />
Tuttavia essendo, le specie che compongono questa vegetazione, piuttosto rare e a<br />
scarsa copertura, il livello <strong>di</strong> attenzione sulla loro salvaguar<strong>di</strong>a dovrebbe risultare massimo.<br />
I versanti verticali su cui si localizza l’habitat in questione non ha consentito la sua<br />
in<strong>di</strong>viduazione su base cartografica, per cui la loro puntuale localizzazione sarà espletata con<br />
l’azione IA19.<br />
8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico<br />
Tale habitat è rilevante per motivi legati alla particolare tipologia <strong>di</strong> fauna collegata per cui si<br />
rimanda alle relazioni <strong>di</strong> carattere zoologico appositamente redatte per tali siti.<br />
9250 Querceti a Quercus trojana<br />
Quest’habitat include le formazioni generalmente governate a ceduo semplice o a ceduo<br />
matricinato, spesso pascolate, principalmente da bovini.<br />
La località in cui tale habitat è stato rilevato è:<br />
‣ Gravina <strong>di</strong> Laterza (comune <strong>di</strong> Laterza);<br />
‣ Bosco <strong>di</strong> Santantuono (comune <strong>di</strong> Mottola)<br />
‣ Bosco Selva San Vito (Laterza)<br />
L’attuale stato <strong>di</strong> conservazione dei boschi a Quercus trojana non è sod<strong>di</strong>sfacente. Essa è<br />
attualmente presente in forma <strong>di</strong> boscaglia invasa da specie della macchia e della gariga a<br />
causa dei tagli e del pascolo eccessivi e dei ripetuti incen<strong>di</strong>. Solo in pochi ambiti nel territorio<br />
35
<strong>di</strong> confine tra il comune <strong>di</strong> Laterza e quello <strong>di</strong> Matera è ancora possibile osservare lembi <strong>di</strong><br />
bosco in buono stato <strong>di</strong> conservazione.<br />
9340 Foreste <strong>di</strong> Quercus ilex e Quercus rotun<strong>di</strong>folia<br />
Include le formazioni <strong>di</strong> boscaglia termofila a prevalenza <strong>di</strong> Quercus ilex. Lo stato <strong>di</strong><br />
conservazione delle leccete può definirsi <strong>di</strong>screto in virtù del fatto che tali comunità trovano<br />
il loro optimum lungo i fianchi della gravina, quin<strong>di</strong> in ambiti <strong>di</strong> non facile utilizzo da parte<br />
dell’uomo.<br />
Nella porzione occidentale dell’“Area delle Gravine” l’habitat è <strong>di</strong>ffuso prevalentemente:<br />
‣ Lungo i pen<strong>di</strong> scoscesi della Gravina <strong>di</strong> Laterza<br />
‣ Fra Laterza e Ginosa.<br />
Nella porzione orientale è <strong>di</strong>ffuso principalmente:<br />
‣ nel territorio <strong>di</strong> Massafra.<br />
Altra località in cui tale habitat è stato rilevato è:<br />
‣ Gravina del Varco (comune <strong>di</strong> Laterza).<br />
9540 Pinete me<strong>di</strong>terranee <strong>di</strong> pini mesogeni endemici<br />
Le pinete a Pinus halepensis presenti nell’area delle Gravine costituiscono un tipo <strong>di</strong><br />
vegetazione che si sviluppa prevalentemente su substrato calcarenitico.<br />
Le località in cui tale habitat è stato rilevato sono:<br />
‣ Gravina <strong>di</strong> S. Biagio, <strong>di</strong> Palagianello e <strong>di</strong> Forcella (comuni <strong>di</strong> Palagianello e Mottola);<br />
‣ Gravina <strong>di</strong> Castellaneta (comuni <strong>di</strong> Castellaneta, Palagianello e Mottola);<br />
‣ Gravina <strong>di</strong> S. Stefano (comune <strong>di</strong> Castellaneta);<br />
‣ Complesso delle Gravine <strong>di</strong> Cocuglio, <strong>di</strong> Giacoia, della Vernata, <strong>di</strong> S. Nicola, <strong>di</strong><br />
Pentinelle e <strong>di</strong> Montecamplo (comuni <strong>di</strong> Laterza e Castellaneta);<br />
‣ Complesso delle Gravine <strong>di</strong> Gennarini, Leucaspide, Accettullo, Alezza, Mesola,<br />
Lamastuola, Triglio, Miola (Comuni <strong>di</strong> Crispiano e Statte);<br />
‣ Gravina della Madonna della Scala, Gravina <strong>di</strong> S. Marco, Gravina <strong>di</strong> S. Elia<br />
(Massafra);<br />
‣ Gravina <strong>di</strong> Colombato (Comune <strong>di</strong> Massafra);<br />
‣ Gravina <strong>di</strong> Petruscio (Comune <strong>di</strong> Mottola).<br />
Le pinete a Pinus halepensis rappresentano, comunque, un habitat poco presente nel territorio<br />
sebbene potenzialmente potrebbero colonizzare la maggior parte delle aree in cui affiorano le<br />
rocce calcarenitiche. Per tale motivo tali ambienti, il cui attuale stato <strong>di</strong> conservazione non<br />
sembra pienamente sod<strong>di</strong>sfacente anche a causa degli incen<strong>di</strong> boschivi nei confronti dei quali<br />
le pinete sono particolarmente vulnerabili pur avendo delle intrinseche strategie <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa,<br />
andrebbero salvaguardati in quanto tra i pochi esempi <strong>di</strong> formazioni forestali a pineta<br />
nell’ambito dell’Italia meri<strong>di</strong>onale. Inoltre, i popolamenti spontanei <strong>di</strong> pino d’Aleppo sono<br />
minacciati da fenomeni <strong>di</strong> “inquinamento genetico” in caso <strong>di</strong> rimboschimenti eseguiti con la<br />
piante della stessa specie ma con ecotipi <strong>di</strong> provenienza alloctona. Analogo rischio, seppur in<br />
minor misura, è legato all’impiego <strong>di</strong> pini <strong>di</strong> incerta provenienza in ville e giar<strong>di</strong>ni.<br />
36
2.7.2. Flora<br />
Gli stu<strong>di</strong> botanici fino ad oggi condotti sono generalmente datati e lacunosi. Solo <strong>di</strong> recente la<br />
comunità scientifica si è mossa allo scopo <strong>di</strong> approfon<strong>di</strong>re le conoscenze della flora e<br />
vegetazione dell’area. La maggiore bio<strong>di</strong>versità è localizzata principalmente nell’habitat dei<br />
Thero-Brachypo<strong>di</strong>etea, dove si annoverano specie <strong>di</strong> interesse comunitario come Stipa<br />
austroitalica, numorese orchidee, tra cui alcune endemiche, come Ophrys parvimaculata e<br />
Ophrys tarentina.<br />
Un aspetto particolarmente interessante è costituito da uno spiccato gra<strong>di</strong>ente termico presente<br />
all’interno delle gravine. Questo fa sì che, procedendo dal margine superiore verso il fondo, si<br />
susseguano comunità vegetali che necessitano <strong>di</strong> un maggiore grado <strong>di</strong> umi<strong>di</strong>tà. In particolare<br />
sono presenti alcune specie a <strong>di</strong>ffusione balcanica che raggiungono in Puglia l’estrema<br />
propaggine occidentale <strong>di</strong> un areale a prevalente <strong>di</strong>stribuzione orientale. Tali elementi sono:<br />
Campanula versicolor, Carum multiflorum, Asyneuma limonifolium, Aurinia saxatilis subsp.<br />
megalocarpa, Vincetoxicum hirun<strong>di</strong>naria subsp. adriaticum, Scrophularia lucida e Umbilicus<br />
cloranthus.<br />
Anche il “fragno”, è una specie che nell’ambito della penisola italiana risulta localizzata<br />
esclusivamente nelle Murge pugliesi. Ad esso sono associate <strong>di</strong>verse specie, che appartengono<br />
alle liste rosse nazionali e regionali, come Centaurea centaurium, Arum apulum e Paeonia<br />
mascula.<br />
Tra le specie endemiche spiccano: Centaurea subtilis, Anthemis hydruntina, Centaurea apula,<br />
quest’ultima specie <strong>di</strong> recente istituzione che appartiene al ciclo <strong>di</strong> Centaurea deusta.<br />
La particolarità <strong>di</strong> alcune entità floristiche rupestri rinvenute sui versanti delle gravine è<br />
dovuta al fatto <strong>di</strong> essere elementi <strong>di</strong> grande rarità che rappresentano veri e propri relitti<br />
floristici <strong>di</strong> una vegetazione tipicamente costiera.<br />
2.7.3. Fauna<br />
La valenza faunistica dell’area va ben oltre i confini regionali e nazionali. Il sito è, infatti,<br />
molto importante per la presenza <strong>di</strong> specie quali il Lanario (Falco biarmicus), il Grillaio<br />
(Falco naumanni), il Biancone (Circaetus gallicus), il Gufo reale (Bubo bubo) ed il<br />
Capovaccaio (Neophron percnopterus).<br />
In aggiunta, le gravine dell’arco ionico presentano un’elevata ricchezza <strong>di</strong> altre specie <strong>di</strong><br />
rapaci, sia <strong>di</strong>urni che notturni, quali: Gheppio (Falco tinnunculus), Barbagianni (Tyto alba),<br />
Civetta (Athena noctua), Gufo comune (Asio otus) e Assiolo (Otus scops).<br />
Gli ambienti rupicoli ospitano il Passero solitario (Monticola solitarius), la Ghiandaia marina<br />
(Coracias garrulus), il Corvo imperiale (Corvus corax), la Monachella (Oenanthe hispanica)<br />
e lo Zigolo capinero (Emberiza melanocephala); quest’ultimo <strong>di</strong> particolare valore<br />
biogeografico.<br />
Gli aspetti faunistici relativi alla classe dei Mammiferi sono meno evidenti, ma comunque<br />
sono rilevabili nell’area specie assenti o rare nelle altre zone della regione. Di particolare<br />
interesse è la presenza sia dell’Istrice (Hystrix cristata) che, al contrario <strong>di</strong> ciò che avviene nel<br />
resto del territorio italiano, in Puglia mostra una contrazione dell’areale <strong>di</strong>stributivo sia del<br />
Gatto selvatico (Felis silvestris), <strong>di</strong> cui comunque non sono note osservazioni recenti.<br />
37
Il contesto ambientale ancora in buono stato rende possibile la presenza <strong>di</strong> numerose altre<br />
specie <strong>di</strong> mammiferi come il Tasso (Meles meles), la Volpe (Vulpes vulpes), la Faina (Martes<br />
foina) e la Donnola (Mustela nivalis), che, anche se presenti in tutta la regione, trovano in<br />
quest’area popolazioni più ricche ed abbondanti<br />
Mancano totalmente specie <strong>di</strong> gran<strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni come i Cervi<strong>di</strong> (Cervo, Capriolo, Daino) e<br />
Carnivori più esigenti come il Lupo (Canis lupus). Unica eccezione è il Cinghiale (Sus scrofa)<br />
frutto comunque <strong>di</strong> ripopolamenti a scopo venatorio.<br />
Per quanto riguarda i Chirotteri le gravine ospitano importanti popolazioni <strong>di</strong> Rinolofo<br />
maggiore (Rhinolophus ferrumequinum), Rinolofo minore (Rhinolophus hypposideros),<br />
Rinolofo Euriale (Rhinolophus euryale), Vespertilio <strong>di</strong> Blyth (Myotis blythii), Vespertilio<br />
maggiore (Mhyotis myotis), Miniottero <strong>di</strong> Schreiber (Miniopterus schreibersii) e Vespertilio<br />
<strong>di</strong> Capaccini (Myotis capaccini), mentre il Rinolofo <strong>di</strong> Mèhely (Rhinolophus mèhely) è<br />
attualmente da considerarsi estinto.<br />
Le conoscenze <strong>di</strong>sponibili su questi mammiferi non sono esaustive, pertanto si ritiene<br />
necessario promuovere nuove iniziative <strong>di</strong> ricerca.<br />
Scarsi sono i dati relativi alla componente microteriologica. Tra i gliri<strong>di</strong> si segnala la presenza<br />
del Moscar<strong>di</strong>no (Muscar<strong>di</strong>nus avellanarius), che pur essendo ampiamente <strong>di</strong>ffuso su tutto il<br />
territorio italiano vede in Puglia una forte contrazione della <strong>di</strong>stribuzione a causa della<br />
frammentazione del proprio habitat. Stesso <strong>di</strong>scorso vale per altre specie <strong>di</strong> micromammiferi<br />
forestali come il Toporagno italico (Sorex samniticus) e l’Arvicola rossastra (Clethrionomys<br />
glareolus), non ancora segnalati nell’area delle gravine anche se potenzialmente presenti.<br />
Da quanto esposto si evidenzia una <strong>generale</strong> carenza <strong>di</strong> informazioni sulla ricchezza e<br />
composizione della mammalofauna dell’area, soprattutto per ciò che riguarda la componente<br />
microteriologica.<br />
Le conoscenze erpetologiche anche se in parte carenti, sono certamente le più complete ed<br />
evidenziano come l’area in questione sia, insieme al Gargano, una delle più ricche della<br />
regione. Particolarmente interessanti sono la presenza <strong>di</strong> specie <strong>di</strong> origine balcanica come il<br />
Geco <strong>di</strong> Kotschy (Cyrtodactylus kotschyi) ed il Colubro leopar<strong>di</strong>no (Elaphe situla).<br />
Gli habitat presenti sul fondo delle gravine, caratterizzati nei mesi più piovosi dalla presenza<br />
<strong>di</strong> raccolte <strong>di</strong> acqua temporanea, sono il rifugio ideale <strong>di</strong> numerose specie <strong>di</strong> anfibi altrove<br />
rari, come l’Ululone appenninico (Bombina pachypus), il Tritone italico (Triturus italicus), la<br />
Raganella italiana (Hyla interme<strong>di</strong>a) e alcuni rettili tra cui soprattutto la Natrice tassellata<br />
(Natrix tessellata).<br />
2.8. Descrizione socio economica<br />
2.8.1. Popolazione ed occupazione<br />
Per le indagini condotte a riguardo della <strong>di</strong>stribuzione della popolazione e delle attività si è<br />
fatto riferimento soprattutto ai dati ISTAT, integrati all’occorrenza da informazioni tratte<br />
dalla bozza preliminare del PTCP – Piano <strong>di</strong> Coor<strong>di</strong>namento Territoriale della <strong>Provincia</strong> <strong>di</strong><br />
<strong>Taranto</strong>.<br />
38
Nell’anno 2001, il censimento Istat registra per il territorio dei Comuni interessati in parte o<br />
del tutto dal SIC-ZPS Area delle Gravine una popolazione complessiva <strong>di</strong> 137.074 abitanti<br />
con una densità me<strong>di</strong>a <strong>di</strong> 117 abitanti per kmq, contro i 238 della <strong>Provincia</strong> <strong>di</strong> <strong>Taranto</strong> (Tab.<br />
2.8.1.a). Altro dato in controtendenza con la me<strong>di</strong>a provinciale è l’incremento demografico:<br />
nell’arco <strong>di</strong> <strong>di</strong>eci anni, infatti, la popolazione dell’area delle gravine è aumentata dell’1%<br />
circa (fatta eccezione per il solo Comune <strong>di</strong> Mottola) a fronte <strong>di</strong> una <strong>di</strong>minuzione complessiva<br />
provinciale pari al 10%.<br />
Tab. 2.8.1.a - Abitanti residenti, superficie territoriale e densità demografica – Anno 2001.<br />
COMUNE<br />
Popolazione residente<br />
al 21 ottobre<br />
2001<br />
al 20 ottobre<br />
1991<br />
Variazione <strong>di</strong> popolazione<br />
tra il 1991 ed il 2001<br />
valori assoluti %<br />
SUPERFICIE<br />
(kmq)<br />
DENSITA’<br />
(ab./kmq)<br />
Castellaneta 17.393 17.294 99 0,6 239,84 72,52<br />
Crispiano 12.973 12905 68 0,5 111,75 116,09<br />
Ginosa 22.146 21.907 239 1,1 187,06 118,39<br />
Laterza 14.996 14.505 491 3,4 159,63 93,94<br />
Massafra 30.923 30.623 300 1,0 125,52 246,36<br />
Mottola 16.575 16.795 -220 -1,3 212,33 78,06<br />
Palagianello 7.483 7.136 347 4,9 43,27 172,94<br />
Statte 14.585 14.477 108 0,7 92,72 157,30<br />
Area delle<br />
Gravine<br />
137.074 135.642 1.432 1,1 1.172 116,95<br />
Fonte: Istat, 14° censimento della popolazione<br />
Riguardo alla <strong>di</strong>stribuzione della popolazione, questa si concentra soprattutto nei centri urbani<br />
a fronte <strong>di</strong> una percentuale piuttosto bassa <strong>di</strong> residenti in case sparse e con un patrimonio<br />
abitativo <strong>di</strong> “seconde case” <strong>di</strong>ffuso soprattutto nei Comuni costieri <strong>di</strong> Castellaneta, Ginosa e<br />
Massafra.<br />
Anche se in controtendenza con quello provinciale, tuttavia il tasso <strong>di</strong> crescita demografico<br />
dell’area <strong>di</strong> interesse è tale da determinare comunque l’invecchiamento della popolazione: il<br />
numero delle persone adulte ed anziane è infatti nettamente superiore a quello dei giovani al<br />
<strong>di</strong> sotto dei quin<strong>di</strong>ci anni. Questo processo <strong>di</strong> progressiva senilizzazione si ripercuote<br />
inevitabilmente sui processi <strong>di</strong> urbanizzazione, poiché cresce la domanda <strong>di</strong> nuove abitazioni<br />
associata ad una riduzione degli in<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> affollamento me<strong>di</strong> per abitazione.<br />
Altra importante conseguenza è rappresentata dall’andamento dell’in<strong>di</strong>ce me<strong>di</strong>o <strong>di</strong> attività<br />
che, sebbene in lieve ripresa rispetto ai <strong>di</strong>eci anni precedenti, nel 2001 è pari al 42% circa, <strong>di</strong><br />
cinque punti inferiore al dato nazionale: nell’ambito dei Comuni dell’area, quello con l’in<strong>di</strong>ce<br />
<strong>di</strong> attività più elevato risulta essere Palagianello (48%), il Comune con l’in<strong>di</strong>ce più basso<br />
(39%) Statte.<br />
Un ulteriore 20,42% della popolazione attiva dell’area <strong>di</strong> interesse risulta essere <strong>di</strong>soccupata o<br />
comunque in cerca <strong>di</strong> prima occupazione, con punte <strong>di</strong> quasi il 63% se riferite alla<br />
<strong>di</strong>soccupazione giovanile e con un tasso <strong>di</strong> <strong>di</strong>soccupazione giovanile femminile in me<strong>di</strong>a<br />
superiore <strong>di</strong> venti punti rispetto a quello degli uomini.<br />
39
Per quanto riguarda i settori <strong>di</strong> occupazione, se fino al 1991 quello <strong>di</strong> riferimento era il<br />
comparto agricolo, nell’arco <strong>di</strong> <strong>di</strong>eci anni si è assistito al superamento della percentuale degli<br />
addetti impiegati in agricoltura, rimasta invariata al 30%, da parte <strong>di</strong> quello degli impiegati<br />
nell’industria, salita clamorosamente dal 16% al 41%: i due gran<strong>di</strong> comparti del settore<br />
“secondario” sono quello manifatturiero, legato soprattutto al comparto alimentare, e quello<br />
delle costruzioni.<br />
Il settore terziario, anch’esso in crescita, occupa invece il 16% <strong>di</strong> addetti nel commercio ed il<br />
13% <strong>di</strong> impiegati nelle pubbliche amministrazioni.<br />
Altro dato degno <strong>di</strong> nota tra i processi antropici che hanno influenza sul territorio e<br />
sull’ambiente, è il fenomeno del pendolarismo, ossia il numero <strong>di</strong> residenti che giornalmente<br />
si sposta per raggiungere la propria sede lavorativa al <strong>di</strong> fuori del Comune <strong>di</strong> <strong>di</strong>mora abituale:<br />
il numero <strong>di</strong> pendolari giornalieri nei Comuni dell’Area delle Gravine è pari a 19.078, con la<br />
percentuale più alta nel Comune <strong>di</strong> Massafra (20%) e quella più bassa nel Comune <strong>di</strong><br />
Palagianello (7%).<br />
2.8.2. Uso del suolo ed agricoltura<br />
Per procedere all’analisi dell’uso del suolo e dell’attività agricola nei Comuni compresi<br />
nell’Area delle Gravine si è consultato l’ultimo Censimento Istat dell’Agricoltura, ponendo a<br />
confronto, laddove possibile, i dati dell’anno 2000 con quelli del censimento precedente,<br />
relativo all’anno 1990.<br />
Il comparto produttivo che interagisce in misura maggiore e <strong>di</strong>retta con il SIC-ZPS è<br />
senz’altro quello agricolo, in quanto più della metà dell’area SIC-ZPS è occupata da superfici<br />
agricole aziendali e dalle relative colture agrarie: <strong>di</strong> conseguenza l’evoluzione del settore<br />
agricolo può con<strong>di</strong>zionare lo status del sito Natura 2000.<br />
In linea con quanto affermato in precedenza, rapportando complessivamente la superficie<br />
agraria aziendale (Tab. 2.8.2.a), comprensiva <strong>di</strong> SAU (superficie agricola utile), arboricoltura<br />
da legno e boschi, <strong>di</strong> tutti i Comuni dell’area, pari a 81.257 ha, con la superficie totale<br />
comunale, pari a 114.855 ha, risulta che la prima interessa ben il 71% della seconda e che i<br />
Comuni con la più alta incidenza <strong>di</strong> superfici agro-forestali relative, in proporzione cioè al<br />
proprio territorio comunale, sono Laterza, Mottola, Crispiano e Ginosa.<br />
Dalla successiva analisi (Tab. 2.8.2.b) delle destinazioni d’uso della superficie agro-forestale<br />
complessiva dei Comuni dell’Area delle Gravine, emerge che la destinazione d’uso prevalente<br />
è il seminativo (43%), seguito dalle coltivazioni legnose (32%), dai boschi (12%) e dai prati<br />
permanenti e pascoli (Fig. 2.8.2.A).<br />
In linea con quanto affermato in precedenza, rapportando complessivamente la superficie<br />
agraria aziendale (Tab. 2.8.2.a), comprensiva <strong>di</strong> SAU (superficie agricola utile), arboricoltura<br />
da legno e boschi, <strong>di</strong> tutti i Comuni dell’area, pari a 81.257 ha, con la superficie totale<br />
comunale, pari a 114.855 ha, risulta che la prima interessa ben il 71% della seconda e che i<br />
Comuni con la più alta incidenza <strong>di</strong> superfici agro-forestali relative, in proporzione cioè al<br />
proprio territorio comunale, sono Laterza, Mottola, Crispiano e Ginosa.<br />
Dalla successiva analisi (Tab. 2.8.2.b) delle destinazioni d’uso della superficie agro-forestale<br />
complessiva dei Comuni dell’Area delle Gravine, emerge che la destinazione d’uso prevalente<br />
40
è il seminativo (43%), seguito dalle coltivazioni legnose (32%), dai boschi (12%) e dai prati<br />
permanenti e pascoli (Fig. 2.8.2.A).<br />
Tab. 2.8.2.a - Numero aziende e relativa superficie agraria nell’Area delle Gravine.<br />
COMUNI<br />
Tab. 2.8.2.b - Uso del suolo dell’Area delle Gravine nel 2000 (ettari).<br />
TOT.<br />
SUP. AGRICOLA UTILIZZATA<br />
seminativi<br />
Numero<br />
aziende<br />
coltiv.<br />
legnose<br />
Superficie<br />
Agraria<br />
Aziendale<br />
(ettari)<br />
prati<br />
permanenti<br />
e pascoli<br />
Arbor.<br />
da<br />
legno<br />
Superficie<br />
comunale<br />
(ettari)<br />
boschi<br />
Sup. agr.<br />
su sup.<br />
comunale<br />
(%)<br />
Castellaneta 1451 13937 23984 58<br />
Crispiano 1227 8386 11175 75<br />
Ginosa 3603 14000 18706 75<br />
Laterza 1984 14509 15963 91<br />
Massafra 1059 6347 12552 51<br />
Mottola 2550 18341 21233 86<br />
Palagianello 719 2886 4327 67<br />
Statte 105 2851 6915 41<br />
Area Gravine 12698 81257 114855 71<br />
Fonte: elaborazione dati del V Censimento Istat Agricoltura 2000<br />
SUP. AGRARIA<br />
NON UTILIZZATA<br />
Tot.<br />
<strong>di</strong> cui<br />
destinata<br />
ad Attività<br />
Ricreative<br />
Castellaneta 13937 6605 4998 872 5 823 191 4 443<br />
Crispiano 8386 1677 3413 2342 550 316 89<br />
Ginosa 14000 6795 5560 417 18 592 299 8 318<br />
Laterza 14509 8855 1741 2193 1 1511 79 0 128<br />
Massafra 6347 1455 3442 519 631 176 0 124<br />
Mottola 18341 8415 3243 1122 3 4702 547 3 309<br />
Palagianello 2886 453 2135 50 24 71 1 155<br />
Statte 2851 585 1240 88 712 75 151<br />
Area Gravine 81257 34840 25771 7603 27 9546 1753 16 1717<br />
Fonte: elaborazione dati del V Censimento Istat Agricoltura 2000<br />
Altra<br />
sup.<br />
0%<br />
12%<br />
2%<br />
2%<br />
Uso suolo Area Gravine<br />
43%<br />
9%<br />
32%<br />
seminativi coltiv. legnose prati perm. e pascoli<br />
arboricoltura da legno boschi sup. agr. non utilizzata<br />
Altra sup.<br />
Fig. 2.8.2.A - Elaborazione Tab. 2.8.2.b.<br />
41
L’uso del suolo si <strong>di</strong>fferenzia in base alla quota ed alla fertilità dei terreni: mentre infatti nella<br />
pianura costiera, complice la possibilità <strong>di</strong> ricorrere all’apporto irriguo, si coltivano ortaggi,<br />
olivo, vite ed agrumi, nelle aree collinari, si riscontra la cerealicoltura <strong>di</strong> grano duro, orzo e<br />
graminacee ad uso zootecnico. Nelle aree meno fertili, dove i terreni sono caratterizzati da<br />
roccia affiorante e ridotto franco <strong>di</strong> coltivazione, ritornano le coperture boscate e sono<br />
presenti i pascoli.<br />
Per quanto riguarda l’estensione me<strong>di</strong>a delle aziende agricole, anche i Comuni dell’Area delle<br />
Gravine, come il resto della <strong>Provincia</strong> <strong>di</strong> <strong>Taranto</strong>, sono caratterizzati da una marcata<br />
frammentazione fon<strong>di</strong>aria dovuta alla predominanza <strong>di</strong> aziende con superfici <strong>di</strong> ridotte e<br />
ridottissime <strong>di</strong>mensioni (meno <strong>di</strong> 5 ha), gestite in conduzione <strong>di</strong>retta dal proprietario,<br />
coa<strong>di</strong>uvato, all’occorrenza, da manodopera familiare: su un totale <strong>di</strong> 12.698 aziende agrarie,<br />
solo 89 superano i 100 ha d’estensione.<br />
Questo dato spiega, anche se solo in parte, la principale caratteristica dell’Area delle Gravine<br />
dal punto <strong>di</strong> vista agronomico: ossia la gran varietà <strong>di</strong> paesaggi agrari, inframmezzati gli uni<br />
agli altri, ed il più delle volte corrispondenti a coltivazioni intensive, come vite (uva da tavola)<br />
e frutticoltura in genere.<br />
I dati dell’ultima indagine Istat, relativi all’anno 2000, confrontati con quelli della precedente<br />
e<strong>di</strong>zione del 1990, consentono <strong>di</strong> effettuare importanti riflessioni sull’andamento del settore<br />
primario nei Comuni dell’area delle gravine. Riguardo al numero delle aziende agricole<br />
presenti nell’area d’interesse, l’ultimo decennio si è chiuso complessivamente con un saldo<br />
positivo (+9%) (Tab. 2.8.2.c) a fronte però <strong>di</strong> una <strong>di</strong>minuzione della relativa SAU, che ha<br />
fatto registrare una flessione parimenti del 9% (Tab. 2.8.2.d). Dall’esame dell’andamento<br />
delle <strong>di</strong>verse destinazioni d’uso dei terreni agricoli negli ultimi <strong>di</strong>eci anni (ve<strong>di</strong> Tabb. 2.8.2.e<br />
e 2.8.2.f e relative Figg.), emerge una contrazione <strong>di</strong> tutte le <strong>di</strong>verse tipologie <strong>di</strong> colture, più<br />
marcata per i seminativi, ma estesa anche alle coltivazioni legnose, tra le quali l’unica<br />
eccezione è rappresentata dalla vite.<br />
Tab. 2.8.2.c - Andamento del numero delle aziende agricole nell’ultimo decennio.<br />
COMUNI<br />
n. aziende<br />
1990<br />
n. aziende<br />
2000<br />
variazione<br />
assoluta<br />
variazione<br />
%<br />
Castellaneta 1548 1415 - 133 - 9<br />
Crispiano 1548 1227 - 321 - 21<br />
Ginosa 3397 3603 206 6<br />
Laterza 1362 1984 622 46<br />
Massafra 1189 1179 - 10 - 1<br />
Mottola 1960 2550 590 30<br />
Palagianello 686 719 33 5<br />
Statte * 105<br />
Area Gravine 11690 12782 1092 9<br />
* Comune non ancora costituito<br />
Fonte: IV e V Censimento Istat dell’agricoltura<br />
42
Tab. 2.8.2.d - Andamento degli ettari <strong>di</strong> SAU nell’ultimo decennio.<br />
COMUNI<br />
HA HA variazione variazione<br />
1990 2000 assoluta %<br />
Castellaneta 17359 12475 - 4884 - 28<br />
Crispiano 8899 7431 - 1468 - 16<br />
Ginosa 14126 12773 - 1353 - 10<br />
Laterza 11809 12789 980 8<br />
Massafra 7331 5416 - 1915 - 26<br />
Mottola 12174 12779 605 5<br />
Palagianello 3181 2637 - 544 - 17<br />
Statte * 1914 1914<br />
Area Gravine 74879 68214 - 6665 - 9<br />
* Comune non ancora costituito<br />
Fonte: IV e V Censimento Istat dell’agricoltura<br />
7000<br />
6000<br />
evoluzione dei seminativi<br />
5000<br />
ettari<br />
4000<br />
3000<br />
2000<br />
1000<br />
0<br />
Cereali tot.<br />
Frumento<br />
Ortive<br />
1990 2000<br />
Foragg. Avv.<br />
colture<br />
Fig. 1.8.2.B - Evoluzione delle superfici a seminativo dal 1990 al 2000.<br />
14000<br />
evoluzione coltiv. legnose<br />
12000<br />
10000<br />
ettari<br />
8000<br />
6000<br />
4000<br />
2000<br />
0<br />
Vite Olivo Agrumi Fruttiferi colture<br />
1990 2000<br />
Fig. 2.8.2.C - Evoluzione delle superfici con coltivazioni legnose dal 1990 al 2000.<br />
43
Tab. 2.8.2.e - N. aziende e relative superfici con seminativi anno 1990 e 2000.<br />
Comune<br />
Castellaneta<br />
Anni<br />
Cereali totali Frumento Ortive<br />
aziende<br />
(n)<br />
Sup.<br />
(ettari)<br />
aziende<br />
(n)<br />
Sup.<br />
(ettari)<br />
aziende<br />
(n)<br />
Sup.<br />
(ettari)<br />
Foraggere<br />
avvicendate<br />
aziende<br />
(n)<br />
Sup.<br />
(ettari)<br />
1990 661 6238 550 3949 155 659 25 1962<br />
2000 464 7522 427 3605 216 587 179 1760<br />
Crispiano<br />
Ginosa<br />
Laterza<br />
Massafra<br />
Mottola<br />
Palagianello<br />
Statte<br />
1990 405 2419 351 1594 93 62 3 64<br />
2000 320 1243 258 803 35 66 22 289<br />
1990 1293 5090 1254 4755 297 1290 27 352<br />
2000 810 4548 786 4354 264 1067 28 227<br />
1990 851 5313 684 3634 56 25 336 2615<br />
2000 1112 6353 1063 5873 93 37 266 2387<br />
1990 125 677 102 329 87 108 46 775<br />
2000 73 633 49 428 35 36 31 476<br />
1990 656 3392 453 1659 202 111 454 5156<br />
2000 627 4261 311 1577 160 65 370 3859<br />
1990 38 132 27 114 67 365 30 152<br />
2000 19 113 11 68 42 214 19 68<br />
1990 - - - - - - - - - - - - - - - -<br />
2000 22 412 16 188 6 10 1 20<br />
Area delle<br />
Gravine<br />
1990 6505 46948 5752 35449 1553 3588 1004 11721<br />
2000 3447 21481 2921 16896 851 2081 916 9086<br />
Var. - 47 % - 54 % - 49 % -52 % -45 % -42 % -9 % - 22 %<br />
Fonte: IV e V Censimento Istat dell’agricoltura<br />
44
Tab. 2.8.2.f - Aziende e relative superfici con coltivazioni legnose anno 1990 e 2000<br />
Vite Olivo Agrumi Fruttiferi<br />
Comune<br />
Castellaneta<br />
Anni<br />
aziende sup. aziende sup. aziende sup. aziende sup.<br />
(n) (ettari) (n) (ettari) (n) (ettari) (n) (ettari)<br />
1990 777 2517 776 1639 241 796 164 263<br />
2000 647 2712 941 1372 250 691 140 198<br />
Crispiano<br />
Ginosa<br />
Laterza<br />
Massafra<br />
Mottola<br />
Palagianello<br />
Statte<br />
1990 369 376 811 2398 2 3 259 251<br />
2000 491 624 835 2616 6 8 159 163<br />
1990 770 1895 2456 2342 404 819 481 337<br />
2000 814 2435 2621 2208 365 670 209 126<br />
1990 381 451 717 714 3 6 110 149<br />
2000 403 692 1205 1000 7 7 106 41<br />
1990 525 954 775 1245 732 1957 141 125<br />
2000 144 429 711 1108 655 1770 73 92<br />
1990 632 836 1157 1009 17 43 557 433<br />
2000 507 953 1940 1823 21 49 788 408<br />
1990 485 1113 500 757 295 736 57 51<br />
2000 127 586 595 730 338 770 50 41<br />
1990 - - - - - - - - - - - - - - - -<br />
2000 17 134 85 1002 8 79 10 23<br />
Area delle<br />
Gravine<br />
1990 2146 6672 10216 12532 2887 6682 2177 1966<br />
2000 3150 8565 8933 11859 1650 4044 1535 1092<br />
Var. 47 % 28% -13% -5% -43% -39% -29% -44%<br />
Fonte: IV e V Censimento Istat dell’agricoltura<br />
Per quanto riguarda il settore zootecnico, in <strong>di</strong>eci anni, si è assistito ad un netto calo delle<br />
aziende (Tab. 2.8.2.g), che nell’intera Area delle Gravine <strong>di</strong>minuiscono <strong>di</strong> 437 unità, pari al<br />
34%, con un’incidenza maggiore nei Comuni <strong>di</strong> Ginosa (- 63%), Palagianello (- 48%) e<br />
Massafra (- 44%).<br />
Tab. 2.8.2.g - Andamento del n. delle aziende zootecniche nell’ultimo<br />
decennio.<br />
Comune<br />
Aziende<br />
1990<br />
Aziende<br />
2000<br />
variazione<br />
assoluta<br />
variazione<br />
%<br />
Castellaneta 177 138 - 39 - 22<br />
Crispiano 48 31 - 17 - 35<br />
Ginosa 104 38 - 66 - 63<br />
Laterza 217 177 - 40 - 18<br />
Massafra 55 31 - 24 - 44<br />
Mottola 430 399 - 31 - 7<br />
Palagianello 27 14 - 13 - 48<br />
Statte - - 4 - - - -<br />
Totale 1269 832 - 437 - 34<br />
Fonte: IV e V Censimento Istat dell’agricoltura<br />
45
Esaminando nel dettaglio l’andamento delle aziende zootecniche per tipologia <strong>di</strong> allevamento,<br />
risulta che la contrazione più evidente si è avuta a carico dell’allevamento suinicolo, avendo<br />
chiuso il 49% delle aziende, seguito da quello ovi-caprino, con la scomparsa del 40% delle<br />
aziende (Tab. 2.8.2.h).<br />
Tab. 2.8.2.h - Andamento del n. delle az. zootecniche per tipo <strong>di</strong> allevamento nell’ultimo decennio.<br />
N. AZIENDE ZOOTECNICHE<br />
Comune Anni Bovini Suini Ovini Caprini Equini Avicoli<br />
1990 142 18 37 23 36 81<br />
Castellaneta<br />
2000 106 9 32 20 17 20<br />
Crispiano<br />
Ginosa<br />
1990 34 13 19 15 15 15<br />
2000 19 10 9 11 12 9<br />
1990 41 3 29 12 14 50<br />
2000 18 1 14 8 9 6<br />
Laterza 1990 168 26 59 23 33 101<br />
2000 151 4 35 14 12 18<br />
Massafra<br />
Mottola<br />
Palagianello<br />
Statte<br />
1990 46 16 22 26 20 27<br />
2000 28 6 13 15 9 3<br />
1990 386 128 118 98 82 217<br />
2000 323 87 115 77 85 262<br />
1990 18 0 5 6 5 0<br />
2000 6 0 5 4 4 2<br />
1990 - - - - - - - - - - - -<br />
2000 2 0 1 1 3<br />
Area delle 1990 928 231 371 239 243 612<br />
Gravine 2000 653 117 224 149 149 323<br />
Var. - 30 % - 49% - 40% - 38% - 39% - 47%<br />
Fonte: IV e V Censimento Istat dell’agricoltura<br />
Attualmente, il patrimonio zootecnico complessivo dei Comuni dell’Area delle Gravine<br />
consiste in circa 32000 capi bovini, <strong>di</strong>ffusi soprattutto nei Comuni <strong>di</strong> Mottola (14420 capi), e<br />
<strong>di</strong> Laterza (9662 capi), ed in circa 20000 capi ovini e caprini predominanti nei medesimi<br />
Comuni (Tab. 2.8.2.i).<br />
46
Tab. 2.8.2.i<br />
N. DI CAPI PER TIPOLOGIA DI ALLEVAMENTO<br />
Comune Bovini <strong>di</strong> cui Vacche Suini Ovini Caprini Equini Avicoli<br />
Castellaneta 4551 2491 300 1980 673 159 1264<br />
Crispiano 828 359 213 750 404 77 80158<br />
Ginosa 1218 753 3 1861 403 27 128<br />
Laterza 9662 5720 44 4991 1393 48 56418<br />
Massafra 1239 584 198 729 569 62 123<br />
Mottola 14420 7723 828 3220 2226 586 4460<br />
Palagianello 161 76 0 387 80 18 242<br />
Statte 221 105 0 410 0 70 400<br />
Area delle Gravine 32300 17811 1586 14328 5748 1047 143193<br />
Fonte: V Censimento Istat dell’agricoltura<br />
La flessione subita dal settore zootecnico, quasi sicuramente dovuta alla scarsa red<strong>di</strong>tività ed<br />
agli elevati costi <strong>di</strong> adeguamento alle recenti normative comunitarie in materia <strong>di</strong> igiene e<br />
benessere degli animali, oltre a determinare <strong>di</strong>rettamente una per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> capitale agrario e<br />
manodopera specializzata, si riflette inevitabilmente sul paesaggio agrario. L’attività<br />
zootecnica, infatti, è quella che maggiormente assicura il presi<strong>di</strong>o rurale da parte delle<br />
famiglie che risiedono stabilmente in azienda: <strong>di</strong> conseguenza la chiusura delle aziende<br />
zootecniche favorisce non solo l’esodo dalle campagne, ma anche e soprattutto l’abbandono<br />
delle superfici a prato-pascolo e dei seminativi destinati alla produzione <strong>di</strong> foraggere.<br />
In conclusione, pur avendo l’Area delle Gravine una forte connotazione rurale, l’agricoltura<br />
appare ancora segnata da evidenti limiti strutturali. In primo luogo, l’eccessiva frammentazione<br />
fon<strong>di</strong>aria, con aziende il più delle volte estese meno <strong>di</strong> 2 ettari, con<strong>di</strong>zionata anche<br />
dalla progressiva <strong>di</strong>ffusione <strong>di</strong> forme <strong>di</strong> conduzione non più a titolo principale, non permette il<br />
ricorso ad una maggiore meccanizzazione che ridurrebbe, almeno in parte, i costi <strong>di</strong> gestione,<br />
sempre più elevati. Altro limite è rappresentato dalla atavica <strong>di</strong>ffidenza degli operatori locali a<br />
qualsiasi forma <strong>di</strong> associazionismo e cooperazione con cui affrontare in modo più competitivo<br />
il mercato.<br />
Inoltre, se negli anni passati, in virtù dell’aiuto compensativo per ettaro da parte della<br />
Comunità Europea, si è assistito alla progressiva, nonché in<strong>di</strong>scriminata, trasformazione delle<br />
superfici a pascolo in seminativi, me<strong>di</strong>ante la pratica dello “spietramento”, ora, a seguito della<br />
riforma della PAC, si assiste alla conversione dei seminativi in colture più specializzate quali<br />
vite e frutticoltura in genere. Infine, la scomparsa della pastorizia tra<strong>di</strong>zionale, specie <strong>di</strong> quella<br />
ovi-caprina, a favore <strong>di</strong> forme <strong>di</strong> allevamento <strong>di</strong> tipo stabulare fisso ed intensivo, rappresenta<br />
un serio rischio per la conservazione dei prati e dei pascoli.<br />
47
2.9. Uso del suolo e proprietà comunali<br />
Un importante contributo incluso tra gli stu<strong>di</strong> base del Progetto LIFE 99/NAT/IT/006279<br />
“Verifica della rete Natura 2000 in Italia e modelli <strong>di</strong> Gestione” - Piano <strong>di</strong> Gestione del SIC e<br />
ZPS "Area delle Gravine IT9130007 e Gravine <strong>di</strong> Matera IT9220135" - è rappresentato<br />
dall’allegato relativo alle proprietà comunali esistenti all’interno dell’area d’interesse. Infatti,<br />
il censimento <strong>di</strong> queste aree demaniali, estese complessivamente 1.791 ettari sui 26.740 ettari<br />
totali del SIC-ZPS, pari quin<strong>di</strong> al 7% circa dell’intera superficie dell’Area delle Gravine,<br />
rappresenta un in<strong>di</strong>spensabile, nonché prezioso strumento per poter programmare specifiche<br />
azioni <strong>di</strong> conservazione degli habitat ivi compresi. Questi ultimi, infatti, occupando una<br />
superficie <strong>di</strong> 1522 ettari, rappresentano l’85% circa delle proprietà comunali (Tab. 2.9.a),<br />
all’interno delle quali sono ricomprese anche superfici occupate da seminativi, uliveti, frutteti<br />
ed incolti produttivi.<br />
Tab. 2.9.a - Superfici in ettari degli habitat ricompresi nelle aree demaniali.<br />
bosco<br />
d'alto<br />
fusto<br />
bosco<br />
ceduo<br />
pascolo<br />
arborato<br />
pascolo<br />
pascolo<br />
cespugliato<br />
macchia<br />
me<strong>di</strong>terranea<br />
Totale<br />
habitat<br />
454 327 3 269 413 55 1.522<br />
Consistenza degli Habitat nelle aree demaniali<br />
27%<br />
4%<br />
30%<br />
18%<br />
0% 21%<br />
bosco d'alto fusto bosco ceduo pascolo arborato<br />
pascolo pascolo cespugliato macchia me<strong>di</strong>terranea<br />
Fig. 2.9.A - Elaborazione della Tab. 2.9.a.<br />
Si riportano <strong>di</strong> seguito gli elenchi delle proprietà demaniali <strong>di</strong> ciascun Comune, <strong>di</strong>stinte per<br />
Foglio <strong>di</strong> Mappa e particella:<br />
48
Elenco 2.9.a<br />
COMUNE DI CASTELLANETA<br />
Località F.M. P.lla Estensione mq. Uso del suolo<br />
… 61 19 183.522 bosco ceduo<br />
… 61 46 55.163 bosco ceduo<br />
… 61 20 59.616 pascolo cespugliato<br />
… 61 45 43.750 pascolo cespugliato<br />
… 61 48 351.744 pascolo cespugliato<br />
… 61 79 3.445 pascolo cespugliato<br />
… 61 80 2.760 pascolo cespugliato<br />
… 66 19 275.644 pascolo cespugliato<br />
… 66 20 425.462 pascolo cespugliato<br />
… 66 43 2.580 pascolo cespugliato<br />
Centro urbano 59 52 3.066 pascolo<br />
Centro urbano 59 86 1.915 pascolo<br />
Centro urbano 59 182 816 pascolo<br />
Centro urbano 59 197 466 pascolo<br />
Centro urbano 59 226 135 pascolo<br />
Centro urbano 128 1757 2.164 pascolo<br />
Centro urbano 50 72 4.165 seminativo<br />
Centro urbano 58 11 13.608 seminativo<br />
Centro urbano 58 21 2.691 seminativo<br />
Centro urbano 128 1664 5.121 seminativo<br />
Centro urbano 128 1742 2.800 seminativo<br />
Centro urbano 128 1810 1.559 seminativo<br />
Centro urbano 128 1927 6.400 seminativo<br />
Centro urbano 128 1930 216 seminativo<br />
Centro urbano 41 124 524 seminativo arborato<br />
Centro urbano 41 262 321 seminativo arborato<br />
Centro urbano 59 75 9.265 seminativo arborato<br />
Centro urbano 59 193 500 seminativo arborato<br />
Centro urbano 59 408 235 seminativo arborato<br />
Centro urbano 128 1833 552 seminativo arborato<br />
continua<br />
49
Località F.M. P.lla Estensione mq. Uso del suolo<br />
Centro urbano 41 163 24.900 incolto produttivo<br />
Centro urbano 41 173 780 incolto produttivo<br />
Centro urbano 128 1750 1.764 incolto produttivo<br />
Centro urbano 128 1828 45.327 incolto produttivo<br />
Centro urbano 41 263 125 incolto sterile<br />
Centro urbano 41 20 164 frutteto<br />
Centro urbano 128 1493 697 frutteto<br />
Centro urbano 58 26 2.420 mandorleto<br />
Centro urbano 58 52 7.492 mandorleto<br />
Centro urbano 58 69 330 mandorleto<br />
Centro urbano 58 161 1.129 mandorleto<br />
Centro urbano 58 172 255 mandorleto<br />
Centro urbano 58 190 221 mandorleto<br />
Centro urbano 58 202 3.496 mandorleto<br />
Centro urbano 58 204 3.705 mandorleto<br />
Centro urbano 58 205 45 mandorleto<br />
Centro urbano 58 207 317 mandorleto<br />
Centro urbano 59 123 163 mandorleto<br />
Centro urbano 59 125 168 mandorleto<br />
Centro urbano 59 199 2.500 mandorleto<br />
Centro urbano 59 220 1.465 mandorleto<br />
Centro urbano 128 1492 1.648 mandorleto<br />
Centro urbano 58 238 84 uliveto<br />
Centro urbano 59 218 8.472 uliveto<br />
Centro urbano 59 219 4.785 uliveto<br />
Centro urbano 59 409 475 uliveto<br />
Centro urbano 59 410 1.048 uliveto<br />
Centro urbano 59 411 258 uliveto<br />
… 60 260 2.476 uliveto<br />
… 60 263 3.408 uliveto<br />
… 60 264 3.104 uliveto<br />
… 66 45 4.300 uliveto<br />
… 73 460 17.349 uliveto<br />
… 73 462 148 uliveto<br />
… 73 463 1.084 uliveto<br />
… 73 465 11.412 uliveto<br />
… 73 467 3.944 uliveto<br />
Centro urbano 58 67 250 fabbricato rurale<br />
TOTALE IN ETTARI 162<br />
50
Elenco 2.9.b<br />
COMUNE DI GINOSA<br />
Località Foglio Particella Estensione mq. Uso del suolo<br />
Pascolato 34 410 6.727 Pascolo cespugliato<br />
Pascolato 34 429 18.480 Pascolo cespugliato<br />
Murge S. Pellegrino 44 70 22.340 Pascolo cespugliato<br />
Ganolella <strong>di</strong> Ginosa 63 145 27.790 Pascolo cespugliato<br />
Difesa 2 261 3.513 pascolo<br />
Difesa 2 262 22.696 pascolo<br />
Difesa 2 280 3..471 pascolo<br />
Piscarello 11 126 39.837 pascolo<br />
Vallone 11 197 74.713 pascolo<br />
Murge 11 200 74.003 pascolo<br />
Orti 19 172 368 pascolo<br />
Parchitello 26 155 1.551 pascolo<br />
Monaca d'oro 26 161 255 pascolo<br />
Murge 34 247 26.880 pascolo<br />
Murge S. Pellegrino 42 1 22.043 Pascolo<br />
Murge S. Pellegrino 42 2 59.871 Pascolo<br />
Murge S. Pellegrino 44 24 58.988 Pascolo<br />
Ganolella <strong>di</strong> Ginosa 63 63 5.126 Pascolo<br />
La Zaffatura 62 29 962 Seminativo<br />
Difesa 5 175 106.090 incolto produttivo<br />
Orti 18 29 39.425 incolto produttivo<br />
Orti 19 104 12.280 incolto produttivo<br />
Grotta del gufo 26 13 2.318 incolto produttivo<br />
Gravina 26 16 1.697 incolto produttivo<br />
Gravina 26 27 114 incolto produttivo<br />
Gravina 26 51 743 incolto produttivo<br />
Monaca d'oro 26 211 1.060 incolto produttivo<br />
Monaca d'oro 26 227 19.608 incolto produttivo<br />
Murge 27 99 6.363 incolto produttivo<br />
Vallone 33 22 18.720 incolto produttivo<br />
Murge 34 386 25.756 incolto produttivo<br />
Lama 33 72 1.450 mandorleto<br />
Lama 33 73 726 mandorleto<br />
Murge S. Pellegrino 43 32 104 Fabbricato rurale<br />
TOTALE IN ETTARI 70<br />
51
Elenco 2.9.c<br />
COMUNE DI LATERZA<br />
Località Foglio P.lla Estensione mq. Uso del suolo<br />
Bosco Selva S.Vito 98 5 268.995 bosco ceduo<br />
Grotta Giammarina 98 14 5.748 bosco ceduo<br />
Grotta Giammarina 98 18 7.706 bosco ceduo<br />
Bosco Selva S.Vito 98 21 2.378.681 bosco ceduo<br />
98 29 925 bosco ceduo<br />
Gravina <strong>di</strong> Laterza 111 10 307.666 bosco ceduo<br />
Gravina <strong>di</strong> Laterza 111 115 2.786 bosco ceduo<br />
Gravina <strong>di</strong> Laterza 111 116 2.172 bosco ceduo<br />
Bosco Sterpine 111 409 44.080 bosco ceduo<br />
111 410 1.766 bosco ceduo<br />
Bosco Sterpine 111 415 980 bosco ceduo<br />
Bosco Selva S.Vito 112 5 796 bosco ceduo<br />
Bosco Selva S.Vito 112 9 7.536 bosco ceduo<br />
Bosco Sterpine 142 3 597.924 pascolo cespugliato<br />
Bosco Sterpine 142 6 746.898 pascolo cespugliato<br />
Bosco Sterpine 142 19 11.420 pascolo cespugliato<br />
Bosco Sterpine 142 47 203.040 pascolo cespugliato<br />
Bosco Selva S.Vito 98 7 133.773 pascolo<br />
Bosco Selva S.Vito 98 16 12.295 pascolo<br />
Gravina <strong>di</strong> Laterza 110 2 2.655 pascolo<br />
111 13 1.892 pascolo<br />
Bosco Selva S.Vito 112 16 1.253 pascolo<br />
126 1 4.866 pascolo<br />
126 6 935 pascolo<br />
Bosco Radogna 126 23 47.674 pascolo<br />
138 75 7.183 pascolo<br />
Gravina <strong>di</strong> Laterza 138 97 9.599 pascolo<br />
Bosco Sterpine 142 7 671.986 pascolo<br />
Bosco Sterpine 142 16 16.212 pascolo<br />
Bosco Sterpine 142 46 11.680 pascolo<br />
Bosco Sterpine 142 57 1.046.256 pascolo<br />
Bosco Sterpine 142 59 109.076 pascolo<br />
Vicinale Ricciar<strong>di</strong> 137 44 29.393 seminativo<br />
Gravina <strong>di</strong> Laterza 85 6 90.589 incolto produttivo<br />
86 32 1.485 incolto produttivo<br />
Gravina <strong>di</strong> Laterza 97 26 23.060 incolto produttivo<br />
Gravina <strong>di</strong> Laterza 97 34 21.773 incolto produttivo<br />
Gravina <strong>di</strong> Laterza 97 121 1.170 incolto produttivo<br />
Gravina <strong>di</strong> Laterza 97 141 1.595 incolto produttivo<br />
Gravina <strong>di</strong> Laterza 97 142 570 incolto produttivo<br />
Gravina <strong>di</strong> Laterza 98 1 3.580 incolto produttivo<br />
Gravina <strong>di</strong> Laterza 98 2 4.440 incolto produttivo<br />
Gravina <strong>di</strong> Laterza 98 4 142.959 incolto produttivo<br />
Bosco Selva S.Vito 98 8 35.177 incolto produttivo<br />
Gravina <strong>di</strong> Laterza 110 6 254.586 incolto produttivo<br />
Gravina <strong>di</strong> Laterza 111 1 19.586 incolto produttivo<br />
Gravina <strong>di</strong> Laterza 111 9 418.873 incolto produttivo<br />
Gravina <strong>di</strong> Laterza 125 157 171.923 incolto produttivo<br />
continua<br />
52
Località Foglio P.lla Estensione mq. Uso del suolo<br />
… 126 4 682 incolto produttivo<br />
Bosco Radogna 126 14 1.098 incolto produttivo<br />
… 126 63 210 incolto produttivo<br />
Gravina <strong>di</strong> Laterza 132 14 69.838 incolto produttivo<br />
Gravina <strong>di</strong> Laterza 132 40 2.265 incolto produttivo<br />
Gravina <strong>di</strong> Laterza 132 52 142.383 incolto produttivo<br />
Gravina <strong>di</strong> Laterza 138 62 159.817 incolto produttivo<br />
… 138 78 7.050 incolto produttivo<br />
… 138 84 2.463 incolto produttivo<br />
Gravina <strong>di</strong> Laterza 141 36 34.947 incolto produttivo<br />
Canale Scarpone 142 8 106.982 incolto produttivo<br />
Gravina <strong>di</strong> Laterza 142 54 358.995 incolto produttivo<br />
Gravina <strong>di</strong> Laterza 142 56 19.580 incolto produttivo<br />
… 138 150 1.339 uliveto<br />
Gravina <strong>di</strong> Laterza 111 4 1.798 vigneto<br />
… 111 14 11.960 fabbricato rurale<br />
Bosco Sterpine 111 414 8.770 fabbricato rurale<br />
Bosco Sterpine 142 2 76 fabbricato rurale<br />
Lamia Fornetto 142 5 70 fabbricato rurale<br />
TOTALE IN ETTARI 882<br />
Elenco 2.9.d<br />
COMUNE DI MASSAFRA<br />
Località F.M. P.lla Estensione mq. Uso del suolo<br />
Mass. Casavola 7 6 11.240 pascolo<br />
….. 21 59 2.150 pascolo<br />
Piano Cernera 7 12 5.010 pascolo cespuglioso<br />
Monte S. Elia 13 16 964.131 pascolo cespuglioso<br />
Madonna della Scala 42 41 4.790 incolto produttivo<br />
Madonna della Scala 42 71 3.500 incolto produttivo<br />
Madonna della Scala 42 72 1.155 incolto produttivo<br />
Madonna della Scala 42 55 4.860 incolto produttivo<br />
Madonna della Scala 42 56 3.170 incolto produttivo<br />
Madonna della Scala 42 42 1.481 uliveto<br />
Madonna della Scala 42 43 1.881 uliveto<br />
Piano Cernera 7 11 241 fabbricato<br />
Mass. Bellavista 10 19 705 fabbricato<br />
TOTALE IN ETTARI 100<br />
53
Elenco 2.9.e<br />
COMUNE DI MOTTOLA<br />
Località F.M. P.lla Estensione mq. Uso del suolo<br />
Sant' Antuono 56 39 236.680 bosco d'alto fusto<br />
Sant' Antuono 56 40 84.112 bosco d'alto fusto<br />
Sant' Antuono 56 44 188.997 bosco d'alto fusto<br />
Parchitello 70 1 301.800 bosco d'alto fusto<br />
Parchitello 70 2 212.550 bosco d'alto fusto<br />
Parchitello 70 3 90.920 bosco d'alto fusto<br />
Sant' Antuono 73 1 381.800 bosco d'alto fusto<br />
Sant' Antuono 73 2 2.607.375 bosco d'alto fusto<br />
Sant' Antuono 73 3 447.900 macchia me<strong>di</strong>terranea<br />
Sterpina - Corneto 89 26 88.600 macchia me<strong>di</strong>terranea<br />
Sterpina - Corneto 89 27 16.698 macchia me<strong>di</strong>terranea<br />
Sant' Antuono 56 36 28.975 pascolo arborato<br />
Tamburello 103 15 1.040 pascolo arborato<br />
Petruscio 138 12 3.292 incolto produttivo<br />
Sant' Antuono 56 37 1.546 fabbricato rurale<br />
Sant' Antuono 56 38 4.257 fabbricato rurale<br />
Selvapiana 76 35 1.460 cisterna<br />
TOTALE IN ETTARI 470<br />
Elenco 2.9.f<br />
COMUNE DI PALAGIANELLO<br />
Località F.M. P.lla Estensione mq. Uso del suolo<br />
Serra Pizzuto 3 100 2.696 bosco d'alto fusto<br />
Serra Pizzuto 3 101 841 bosco d'alto fusto<br />
Serra Pizzuto 3 102 213.676 bosco d'alto fusto<br />
Serra Pizzuto 3 103 133.050 bosco d'alto fusto<br />
Serra Pizzuto 3 104 33.158 bosco d'alto fusto<br />
Serra Pizzuto 3 105 23.850 bosco d'alto fusto<br />
Serra Pizzuto 3 106 33.022 bosco d'alto fusto<br />
Serra Pizzuto 2 84 306.644 pascolo cespugliato<br />
Serra Pizzuto 2 98 16.908 pascolo cespugliato<br />
Serra Pizzuto 2 171 12.764 pascolo cespugliato<br />
Serra Pizzuto 3 89 27.213 pascolo cespugliato<br />
Serra Pizzuto 3 68 5.232 pascolo<br />
Serra Pizzuto 3 69 10.665 pascolo<br />
Serra Pizzuto 3 94 5.816 pascolo<br />
Serra Pizzuto 3 171 2.153 pascolo<br />
Parco del Casale 4 21 126.863 pascolo<br />
Parco del Casale 4 36 5.734 pascolo<br />
Parco del Casale 4 67 690 pascolo<br />
Parco del Casale 4 127 474 pascolo<br />
Parco del Casale 4 140 27.350 pascolo<br />
Parco del Casale 4 144 112 pascolo<br />
Parco del Casale 4 146 640 pascolo<br />
Parco del Casale 4 149 7.718 pascolo<br />
Parco del Casale 4 177 3.640 pascolo<br />
Parco del Casale 4 180 3.140 pascolo<br />
Parco del Casale 4 181 1.400 pascolo<br />
Parco del Casale 4 188 500 pascolo<br />
Parco del Casale 4 202 265 pascolo<br />
TOTALE IN ETTARI 101<br />
54
Elenco 2.9.g<br />
COMUNE DI STATTE<br />
Località F.M. P.lla Estensione mq. Uso del suolo<br />
La colombaia 94 173 2.307 parco archeologico<br />
La colombaia 94 175 26.628 parco archeologico<br />
La colombaia 114 126 32.255 parco archeologico<br />
La colombaia 114 128 51 parco archeologico<br />
TOTALE IN ETTARI 6<br />
2.10. Tipologie <strong>di</strong> fon<strong>di</strong> utilizzabili per il sito<br />
Il presente paragrafo è stato redatto consultando il PSR Puglia 2007-2013, il PO-FESR<br />
Puglia 2007-2013, la “Guida al finanziamento <strong>di</strong> natura 2000” (Ed. WWF), “I fon<strong>di</strong><br />
comunitari per Natura 2000 in Italia - Programmazione 2007-2013” (a cura <strong>di</strong> Comunità<br />
Ambiente SrL).<br />
Il sito “Area delle Gravine” è potenzialmente interessato dall’adozione delle seguenti misure<br />
economiche <strong>di</strong> cui si riportano, attraverso una descrizione sintetica, le caratteristiche salienti<br />
dei principali strumenti economico-finanziari <strong>di</strong>sponibili ossia:<br />
1. Fon<strong>di</strong> per l’Agricoltura:<br />
1.1. Piano <strong>di</strong> Sviluppo Rurale 2007-2013 - Puglia, finanziato dal fondo europeo<br />
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);<br />
1.2. Leader;<br />
2. Fon<strong>di</strong> Strutturali:<br />
2.1. Programma Operativo FESR 2007-2013 - Puglia, finanziato dal Fondo Europeo<br />
per lo Sviluppo Regionale (FESR);<br />
2.2. Fondo Sociale Europeo (FSE);<br />
3. Fon<strong>di</strong> per l’Ambiente:<br />
3.1. Life +;<br />
4. Fon<strong>di</strong> per la Ricerca:<br />
4.1. 7° Programma quadro per la ricerca (fp7).<br />
2.10.1. Piano <strong>di</strong> Sviluppo Rurale 2007-2013 – Puglia, finanziato dal Fondo<br />
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)<br />
Il FEASR nasce nel 2007 per sostituire il vecchio FEOGA (Fondo Europeo Agricolo <strong>di</strong><br />
Orientamento e <strong>di</strong> Garanzia) a cui subentra con lo scopo <strong>di</strong> finanziare i nuovi programmi <strong>di</strong><br />
sviluppo rurale tesi al miglioramento delle strutture agricole, alla <strong>di</strong>versificazione delle<br />
attività, allo sviluppo sostenibile delle foreste, allo sviluppo socio-economico delle aree rurali,<br />
alla protezione ambientale ed alla promozione delle pari-opportunità tra uomini e donne.<br />
Le autorità degli Stati Membri sono state dunque chiamate a sviluppare i Piani Strategici<br />
Nazionali (PSN) ed i Piani Strategici Regionali (PSR) per trasferire le priorità comunitarie,<br />
comprese nel Regolamento del Consiglio (CE) 1698/2005 e nelle Linee Guida Strategiche, nel<br />
contesto nazionale e regionale.<br />
La Regione Puglia ha quin<strong>di</strong> approvato con DGR n. 148 del 12 febbraio 2008 “il Programma<br />
<strong>di</strong> Sviluppo Rurale della Puglia 2007-2013”.<br />
55
In <strong>generale</strong>, quin<strong>di</strong>, la strategia del PSR della Puglia è basata sui tre gran<strong>di</strong> obiettivi, definiti<br />
ASSI, del sostegno comunitario allo sviluppo rurale:<br />
- Asse 1. Migliorare la competitività dei settori agricolo e forestale;<br />
- Asse 2. Valorizzare l’ambiente e lo spazio rurale attraverso la gestione del territorio;<br />
- Asse 3. Migliorare la qualità della vita nelle zone rurali e promuovere la <strong>di</strong>versificazione<br />
delle attività economiche.<br />
- Un quarto asse denominato “Leader” finanzierà progetti orizzontali riguardanti i tre settori<br />
<strong>di</strong> attività (ve<strong>di</strong> relativo paragrafo).<br />
Alcune azioni finanziabili relative a Natura 2000<br />
- Accrescimento del valore economico delle foreste;<br />
- accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali;<br />
- indennità a favore degli agricoltori delle zone svantaggiate <strong>di</strong>verse dalle zone montane;<br />
- pagamenti agro-ambientali;<br />
- sostegno agli investimenti non produttivi;<br />
- imboschimento <strong>di</strong> terreni agricoli;<br />
- imboschimento <strong>di</strong> terreni non agricoli;<br />
- incentivazione <strong>di</strong> attività turistiche;<br />
- tutela e riqualificazione del patrimonio rurale.<br />
Soggetti beneficiari<br />
Operatori agricoli, comunità rurali.<br />
2.10.2. LEADER<br />
Il Leader costituisce il quarto Asse del nuovo FEASR ed è stato ideato con l’obiettivo <strong>di</strong><br />
rafforzare le capacità professionali, progettuali e gestionali locali e <strong>di</strong> migliorare la<br />
partecipazione degli abitanti e/o delle amministrazioni alla definizione delle politiche <strong>di</strong><br />
sviluppo rurale.<br />
Per questa nuova fase, il metodo LEADER costituisce un’ulteriore possibilità per le aree<br />
rurali, in relazione all’ampliamento dei campi <strong>di</strong> investimento e alla revisione dei compiti e<br />
delle funzioni.<br />
Particolare attenzione sarà de<strong>di</strong>cata alla scelta dei piani <strong>di</strong> sviluppo locale, la cui strategia<br />
dovrà essere ben definita, scegliendo temi e obiettivi fortemente ancorati al territorio. I Piani<br />
<strong>di</strong> sviluppo locale potranno attingere alle sole misure dell’Asse III, previste nel PSR, purché<br />
venga assicurata una coerenza con gli obiettivi prioritari definiti dal PSR stesso.<br />
Alcune azioni finanziabili<br />
- Miglior utilizzo delle risorse naturali e culturali tese ad aumentare il valore dei siti;<br />
- supporto alla cooperazione tra territori rurali;<br />
- interscambio tra <strong>di</strong>fferenti aree rurali dell’Unione Europea.<br />
Soggetti beneficiari<br />
Gruppi <strong>di</strong> azione Locale (GAL), costituiti da partner pubblici e privati che elaborano una<br />
strategia <strong>di</strong> sviluppo pilota ed integrata (Piano <strong>di</strong> Sviluppo Locale) e procedono alla sua<br />
attuazione sul territorio.<br />
56
2.10.3. Programma Operativo FESR 2007-2013 - Puglia, finanziato dal Fondo<br />
Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR).<br />
Il FESR nasce con lo scopo <strong>di</strong> ri<strong>di</strong>stribuire alle regioni povere una parte dei contributi degli<br />
Stati membri, migliorandone le infrastrutture e favorendo nuove attività economiche.<br />
Obbiettivo del FESR è quello <strong>di</strong> promuovere una crescita compatibile con l’ambiente,<br />
rafforzando la competitività ed i sistemi innovativi.<br />
La Regione Puglia, rientrante nell’ambito dell’obbiettivo “Convergenza” ai sensi dell’art. 5,<br />
paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, ha approvato, con DGR n. 146 del 12<br />
febbraio 2008, a seguito della Decisione (CE) n. C/2007/5726 del 20 novembre 2007, il PO<br />
FESR 2007-2013 articolato nei seguenti Assi prioritari:<br />
− Asse I Promozione, valorizzazione e <strong>di</strong>ffusione della ricerca e dell’innovazione per la<br />
competitivitá;<br />
− Asse II Uso sostenibile e efficiente delle risorse ambientali ed energetiche per lo<br />
sviluppo;<br />
− Asse III Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l’attrattività territoriale;<br />
− Asse IV Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e lo sviluppo;<br />
− Asse V Reti e collegamenti per la mobilità;<br />
− Asse VI Competitività dei sistemi produttivi e occupazione;<br />
− Asse VII Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani;<br />
− Asse VIII Governance, capacità istituzionali e mercati concorrenziali ed efficaci.<br />
Alcune azioni finanziabili relative a Natura 2000<br />
− realizzazione <strong>di</strong> progetti a supporto della fruizione sostenibile a fini turistici del<br />
territorio naturale anche attraverso interventi per il recupero funzionale <strong>di</strong> siti <strong>di</strong><br />
interesse naturale compromessi e degradati;<br />
− promozione e valorizzazione del patrimonio naturale del sistema regionale per la<br />
Conservazione della Natura a fini turistici;<br />
− realizzazione <strong>di</strong> progetti per la valorizzazione finalizzata alla fruizione <strong>di</strong> aree<br />
ambientali omogenee in<strong>di</strong>viduate in piani <strong>di</strong> azione esistenti.<br />
E' escluso il sostegno al funzionamento delle strutture <strong>di</strong> gestione delle aree protette e gli<br />
interventi previsti possono essere attuati esclusivamente in aree in possesso <strong>di</strong> un Piano <strong>di</strong><br />
gestione approvato.<br />
Soggetti beneficiari<br />
Regione Puglia, Enti locali, Enti Ecclesiastici, Enti gestori delle aree protette, Fondazioni<br />
partecipate interamente da soggetti pubblici.<br />
2.10.4. Fondo Sociale Europeo (FSE)<br />
Previsto dal Regolamento (CE) n. 1081 del 5 luglio 2006, il Fondo Sociale Europeo agisce in<br />
conformità con il metodo <strong>di</strong> programmazione previsto per il periodo 2007-2013 e si pone<br />
come obbiettivo il miglioramento della quantità e della qualità e della produttività del lavoro,<br />
e la promozione della coesione sociale (nella strategia europea per l’occupazione).<br />
Alcune azioni finanziabili relative a Natura 2000<br />
Rafforzare la capacità istituzionale e l’efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi<br />
pubblici anche in relazione alla gestione <strong>di</strong> Natura 2000.<br />
57
Soggetti beneficiari<br />
Regione Puglia, Enti pubblici e privati, Enti gestori delle aree protette.<br />
2.10.5. LIFE +<br />
Il Life + nasce nel 2007 per sostituire i programmi LIFE (Natura, Ambiente e paesi terzi),<br />
Sviluppo urbano sostenibile, Promozione delle ONG che operano in campo ambientale e<br />
Forest Focus.<br />
La proposta Life + è ancora in <strong>di</strong>scussione all’interno delle Istituzioni europee ed il testo del<br />
Regolamento non è stato ancora terminato; sarà comunque formato da quattro componenti:<br />
“Natura e bio<strong>di</strong>versità”, “Attuazione e governance”, “Informazione e comunicazione”.<br />
La componente Natura e Bio<strong>di</strong>versità è finalizzata a:<br />
− contribuire all’implementazione delle politiche e <strong>di</strong>rettive comunitarie in materia, in<br />
particolare della Direttiva 79/409/CE e 92/43/CE e della Rete Natura 2000;<br />
− fornire un supporto per la messa a punto e l’implementazione degli strumenti utili al<br />
monitoraggio e alla valutazione dei vari impatti sulla natura, in particolare in relazione<br />
all’obiettivo <strong>di</strong> bloccare la per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> bio<strong>di</strong>versità entro il 2010;<br />
− fornire un supporto per una migliore gestione ambientale con il coinvolgimento dei<br />
gruppi <strong>di</strong> interesse.<br />
Alcune azioni finanziabili relative a Natura 2000<br />
- Stu<strong>di</strong>, indagini, elaborazione <strong>di</strong> modelli e <strong>di</strong> scenari;<br />
- Monitoraggio;<br />
- Formazione, workshop e riunioni;<br />
- Campagne <strong>di</strong> sensibilizzazione;<br />
- Azioni <strong>di</strong> informazione e comunicazione.<br />
Soggetti beneficiari<br />
Autorità nazionali, regionali e locali; Organismi specializzati previsti dalla legislazione<br />
comunitaria; Organizzazioni internazionali; Organizzazioni non governative.<br />
2.10.6. 7° Programma Quadro per la Ricerca (FP7)<br />
Il programma è il principale strumento per il finanziamento della ricerca e dello sviluppo<br />
tecnologico in Europa per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 ed il 31 <strong>di</strong>cembre 2013.<br />
Gli obiettivi del FP7 mirano a sostenere gli scopi dell’Agenda <strong>di</strong> Lisbona e quin<strong>di</strong> a:<br />
- supportare l’Area Europea della Ricerca;<br />
- promuovere le attività <strong>di</strong> ricerca in supporto delle altre politiche comunitarie.<br />
Si articola in quattro programmi principali: Cooperazione, Idee, Persone e Capacità.<br />
All’interno del programma Cooperazione si trova l’area tematica “Ambiente” che dovrebbe<br />
finanziare anche la ricerca nei siti Natura 2000.<br />
Alcune azioni finanziabili relative a Natura 2000<br />
- Nuove tecniche <strong>di</strong> monitoraggio;<br />
- Protezione degli ecosistemi;<br />
- Aumento della conoscenza su habitat e specie.<br />
Soggetti beneficiari<br />
Possono richiedere finanziamento consorzi formati da partner <strong>di</strong> <strong>di</strong>fferenti stati membri<br />
afferenti ad istituti <strong>di</strong> ricerca e imprese.<br />
58
2.11. La pianificazione urbanistica comunale<br />
L’attività legata all’analisi della normativa urbanistica all’interno del territorio dell’area ZPS<br />
“Area delle Gravine” ha comportato l’analisi degli strumenti urbanistici vigenti dei Comuni e<br />
i loro futuri sviluppi.<br />
La tabella che segue mostra la sintesi dei principali strumenti urbanistici redatti dai comuni<br />
ricadenti nell’area SIC/ZPS “Area delle Gravine”.<br />
Comune Strumento urbanistico Cronologia<br />
Castellaneta Programma <strong>di</strong><br />
Fabbricazione<br />
Variante al P.<strong>di</strong> F.<br />
Adottato il 22-6-1973 dal C.C<br />
Approvata con DGR 4659 del 30-5-1980<br />
Pre<strong>di</strong>sposto il D.P.P. (Documento Programmatico preliminare) per<br />
la redazione del PUG, adottato con Delibera del C.C. n. 58 del 1<br />
Crispiano<br />
Programma <strong>di</strong><br />
fabbricazione<br />
ottobre 2005.<br />
Adottato con delibera <strong>di</strong> C.C. nel 1977 e approvato dalla Regione<br />
con delibera nel 1978<br />
Pre<strong>di</strong>sposto il D.P.P. (Documento Programmatico Preliminare) per<br />
la redazione del PUG, adottato con Delibera del C.C. n. 41 del 5<br />
luglio 2006.<br />
Ginosa Piano Regolatore Generale Adottato con Delibera <strong>di</strong> C.C. n. 110 del 24/11/1994.<br />
Adeguato con Delibera <strong>di</strong> C.C. n. 113/2000 con l'introduzione delle<br />
prescrizioni e mo<strong>di</strong>fiche <strong>di</strong> cui alla delibera <strong>di</strong> GR. n. 1389 del<br />
30/10/2000.<br />
Approvato con Delibera GR del. 5/11/2001, n. 1606.<br />
Laterza Piano Regolatore Generale Adottato con Delibera <strong>di</strong> C. C. n. 48 del 19/12/1997 .<br />
Adeguato con Delibera <strong>di</strong> C.C. n. 48 del 28/10/2003 con<br />
l'introduzione delle prescrizioni e mo<strong>di</strong>fiche <strong>di</strong> cui a provve<strong>di</strong>mento<br />
della G.R. n.562 del 17/04/2003.<br />
Approvato con Delibera <strong>di</strong> G.R. del 20/04/2004, n.568<br />
Massafra Piano Regolatore Generale P.<strong>di</strong> F. approvato con DR n. 170/1973;<br />
Variante al P.<strong>di</strong> F. approvata con DR n. 1897/1977.<br />
Variante alla fascia costiera approvata con delibera <strong>di</strong> G.R. n. 3374<br />
/1980 e n. 7548/1981.<br />
Piano regolatore adottato con delibera <strong>di</strong> C.C. n.60 del 31.10.2000.<br />
Perimetrazione “Territori costruiti” PUTT/p approvata con delibera<br />
del Comm. Straor<strong>di</strong>nario n. 189/2001<br />
Con delibera <strong>di</strong> G.R. n. 2135 dell’11 <strong>di</strong>cembre 2007 non è stato<br />
approvato con rinvio per rielaborazione degli atti al Comune.<br />
Mottola Piano Regolatore Generale Adottato con delibera n. 51 <strong>di</strong> C.C. n. 51 del 14/7 /1993.<br />
Approvazione con prescrizioni con Delibera <strong>di</strong> G.R. n.2108 del<br />
09/12/2003.<br />
Adeguato con Delibera <strong>di</strong> C.C. n.05 del 17/03/2004<br />
Approvato in via definitiva con Delibera G.R. n.483 del 31/03/2005.<br />
Con delibera <strong>di</strong> Giunta Comunale n. 67 del 18/04/2008 è stata<br />
approvata la <strong>Relazione</strong> ed Atto <strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzo per la redazione del PUG<br />
Palagianello Piano Urbanistico<br />
Generale<br />
Statte<br />
Adottato il PRG <strong>di</strong> <strong>Taranto</strong><br />
(Comune <strong>di</strong> provenienza)<br />
riguardante il proprio<br />
territorio comunale.<br />
Approvato con Delibera <strong>di</strong> C.C. n. 23 del 7/5/2004<br />
Adeguamenti prescritti dalla Regione con Dlibera n. 1801 del<br />
6/12/2005.<br />
Approvazione delle risultanze della Conferenza <strong>di</strong> Servizi del<br />
11/01/2006 e 31/01/2006 per il controllo <strong>di</strong> compatibilità del PUG e<br />
Recepimento della determinazione <strong>di</strong> adeguamento del PUG con<br />
Deliberazione <strong>di</strong> G.R n. 235 del 7/3/2006.<br />
Approvazione PUG con D.C.C. n°38 del 13/07/2007<br />
Comune staccato dalla città <strong>Taranto</strong> nel 1993, con Legge regionale<br />
n. 6 e n. 22 del 1993, che ha definito il perimetro comunale.<br />
È stato pre<strong>di</strong>sposto il Documento Programmatico Preliminare per la<br />
redazione del PUG<br />
59
2.12. La normativa urbanistica nelle aree agricole – Zone omogenee “E”<br />
L’analisi urbanistica che segue ha preso in esame le aree agricole in<strong>di</strong>viduate come zona<br />
omogenea tipo “E” , secondo quanto previsto dal Decreto Interministeriale 2 aprile 1968 n.<br />
1444. – “Limiti inderogabili <strong>di</strong> densità e<strong>di</strong>lizia, <strong>di</strong> altezza, <strong>di</strong> <strong>di</strong>stanza tra i fabbricati e<br />
rapporti <strong>di</strong> massima tra gli spazi destinati agli inse<strong>di</strong>amenti residenziali e produttivi e spazi<br />
pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai<br />
fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione <strong>di</strong> quelli esistenti, ai<br />
sensi dell’art. 17 della Legge 6/8/1967, n. 765” e le restanti aree ricadenti in zona ZPS/SIC.<br />
L’analisi è stata svolta per ogni Comune compreso nel sito SIC/ZPS “Area delle Gravine”.<br />
2.12.1. Comune <strong>di</strong> Castellaneta<br />
Lo strumento urbanistico vigente –PDF- del Comune <strong>di</strong> Castellaneta in<strong>di</strong>vidua l’area agricola<br />
“E” come “Zona agricola per attività produttive” destinate ad attività primarie e prevalentemente<br />
all’esercizio delle attività agricole <strong>di</strong>rette o connesse all’agricoltura, con le foreste e<br />
con gli allevamenti <strong>di</strong> bestiame. Sono consentite nelle zone E:<br />
1. tipo A) costruzione a servizio <strong>di</strong>retto dell’agricoltura: abitazioni, fabbricati rurali come<br />
stalle, porcilaie, silos, serbatoi idrici ricoveri per macchine agricole. Valgono gli<br />
in<strong>di</strong>ci:<br />
• lotto minimo 10.000 m 2 ;<br />
• In<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> fabbricabilità fon<strong>di</strong>aria 0,05 m 3 /m 2 <strong>di</strong> cui al massimo 0,03 per la residenza;<br />
• In<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> copertura massimo 1,5% della superficie del lotto;<br />
• Altezza massima 8,00 m.<br />
2. tipo B) costruzioni a<strong>di</strong>bite alla conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli e<br />
per allevamenti industriali, costruzioni per industrie estrattive e cave o attività<br />
connesse allo sfruttamento in loco <strong>di</strong> risorse del sottosuolo e infine costruzione per<br />
industrie nocive. Valgono i seguenti in<strong>di</strong>ci:<br />
• lotto minimo 10.000 m 2<br />
• In<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> fabbricabilità fon<strong>di</strong>aria 0,05 m 3 /m 2 <strong>di</strong> cui al massimo 0,03 per la residenza.<br />
Attualmente, il Comune ha avviato l’iter <strong>di</strong> formazione del PUG, con l’adozione del D.P.P.<br />
(Documento Programmatico Preliminare) adottato con delibera <strong>di</strong> C.C. n. 58 del 01 ottobre<br />
2005. Tra gli obiettivi principali programmatici del documento per la formazione del PUG vi<br />
è quello <strong>di</strong> perseguire la tutela e la valorizzazione dei valori ambientali, storici e culturali<br />
finalizzati allo sviluppo sostenibile del territorio. In particolare, per il patrimonio ambientale<br />
del territorio costituito dalle aree boschive <strong>di</strong> MonteCamplo, dalle Gravine, dalle lame e dalle<br />
pinete costiere l’obiettivo è quello <strong>di</strong> attuare una politica <strong>di</strong> tutela dell’integrità fisica ed<br />
ambientale dei luoghi, accompagnata da una valorizzazione dei siti a valenza naturalistica,<br />
attraverso interventi sostenibili finalizzati ad un ecoturismo alternativo <strong>di</strong> qualità e a basso<br />
impatto ambientale.<br />
60
Estensione agro comune <strong>di</strong> Castellaneta<br />
Estensione area ricadente nel sito ZPS/SIC Area delle<br />
Gravine<br />
Estensione area in cui è presente l’habitat prioritario<br />
Estensione area ricadente nel Parco Terra<br />
delle Gravine<br />
ha circa<br />
23.974,56<br />
ha circa<br />
5.213<br />
ha circa<br />
687<br />
ha circa<br />
2.386,14.<br />
% estensione<br />
comunale<br />
ricadente nel sito<br />
ZPS/SIC<br />
% estensione<br />
comunale rispetto<br />
al totale del sito<br />
ZPS/SIC<br />
21,7 % 19,5 %<br />
3,0 %<br />
% estensione comunale<br />
ricadente nel Parco<br />
10 %<br />
2.12.2. Comune <strong>di</strong> Crispiano<br />
Lo strumento urbanistico vigente è il PDF (Piano <strong>di</strong> Fabbricazione). Per le aree agricole vale<br />
la seguente norma: “È consentita la costruzione della casa rurale e degli accessori per<br />
attrezzi, ricovero animali e deposito prodotti. Per le costruzioni <strong>di</strong> tipo industriale a servizio<br />
dell’agricoltura può esser richiesta la deroga alle norme ai sensi dell’art. 41 quater della<br />
legge 06.08.1967 n. 765, purché riconosciute <strong>di</strong> interesse pubblico. Il terreno inerente la<br />
costruzione deve essere gravato <strong>di</strong> vincolo <strong>di</strong> asservimento. È possibile accorpare le<br />
proprietà, purché ricadenti nel raggio <strong>di</strong> 500 metri nella misura massima <strong>di</strong> ha 2 e<strong>di</strong>ficando<br />
su uno dei lotti che abbia la superficie minima <strong>di</strong> m 2 5.000 e con rapporto volumetrico <strong>di</strong> 0,03<br />
mc/mq rispetto all’intera superficie <strong>di</strong> accorpamento e col rapporto <strong>di</strong> copertura <strong>di</strong> 1%. Le<br />
proprietà dell’accorpamento da non e<strong>di</strong>ficare devono essere asservite con trascrizione nel<br />
registro ipotecario”.<br />
• lotto minimo 5.000 m 2<br />
• rapporto <strong>di</strong> copertura 1%<br />
• In<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> fabbricabilità fon<strong>di</strong>aria: 0,03 m 3 /m 2 ;<br />
• Altezza massima:<br />
7,50 m<br />
Attualmente, il Comune ha avviato l’iter <strong>di</strong> formazione del PUG, con l’adozione del D.P.P.<br />
(Documento Programmatico Preliminare) adottato con delibera <strong>di</strong> C.C. n. 41 del 05 luglio<br />
2006.<br />
61
Estensione agro comune <strong>di</strong> Crispiano<br />
Estensione area ricadente nel sito ZPS/SIC Area delle<br />
Gravine<br />
Estensione area in cui è presente l’habitat prioritario<br />
ha circa<br />
11.092,80<br />
ha circa<br />
1.294,3<br />
ha circa<br />
146<br />
% estensione<br />
comunale<br />
ricadente nel sito<br />
ZPS/SIC<br />
% estensione<br />
comunale rispetto<br />
al totale del sito<br />
ZPS/SIC<br />
11,7 % 4,8 %<br />
1,3 %<br />
Estensione area ricadente nel Parco Terra<br />
delle Gravine<br />
ha circa<br />
3.698,25<br />
% estensione comunale<br />
ricadente nel Parco<br />
33,3 %<br />
2.12.3. Comune <strong>di</strong> Ginosa<br />
Lo strumento urbanistico vigente è il Piano Regolatore Generale. Le zone agricole riportate<br />
nell’art. 30 della NTA del Piano Regolatore Generale comprendono “tutto il territorio<br />
comunale ad esclusione delle aree destinate dal PRG ad altre attività e <strong>di</strong>versamente tipizzate<br />
dalle tavole <strong>di</strong> PRG. Le zone agricole sono destinate al mantenimento e allo sviluppo della<br />
produzione agricola o ad attività integrative ad esso connesse...”.<br />
Gli interventi si attuano per intervento <strong>di</strong>retto.<br />
Nelle zone agricole è consentita la costruzione <strong>di</strong> abitazioni rurali, annessi rustici, fabbricati<br />
destinati alle attività <strong>di</strong> trasformazione dei prodotti agricoli e dell’allevamento e dei loro<br />
annessi, <strong>di</strong> fabbricati a servizio delle attività agrituristiche e <strong>di</strong> fabbricati destinati alle attività<br />
assistenziali e sociali <strong>di</strong> servizio degli abitanti inse<strong>di</strong>ati. Inoltre, viene consentita la costruzione<br />
<strong>di</strong> impianti pubblici <strong>di</strong> telecomunicazioni, energia, acquedotti, fognature, <strong>di</strong>scariche <strong>di</strong><br />
rifiuti soli<strong>di</strong> urbani, purché regolarmente autorizzati dalle ASL competenti.<br />
Non vengono però consentiti interventi che risultino in contrasto con i caratteri ambientali e<br />
paesaggistici e danneggiano l’equilibrio ecologico esistente, e viene espressamente detto che è<br />
vietato l’abbattimento dei muri a secco esistenti e che tutti i muri a secco esistenti devono<br />
essere conservati e ripristinati<br />
Per gli in<strong>di</strong>ci valgono quelli imposti dalla legge urbanistica nazionale e regionale, vale a <strong>di</strong>re:<br />
• Superficie fon<strong>di</strong>aria minima 10.000 m 2<br />
• In<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> fabbricabilità fon<strong>di</strong>aria 0,03 m 3 /m 2<br />
• H max 7,50 ml.<br />
Per le attività <strong>di</strong> agriturismo le NTA, nell’adeguare il PRG alle prescrizioni del CUR,<br />
affermano che esse sono soggette alle vigenti <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> Legge Regionale e Statale.<br />
62
Estensione agro comune <strong>di</strong> Ginosa<br />
Estensione area ricadente nel sito ZPS/SIC<br />
Area delle Gravine<br />
Estensione area in cui è presente l’habitat<br />
prioritario<br />
ha circa<br />
18.627,54<br />
ha circa<br />
1.347<br />
ha circa<br />
118<br />
% estensione<br />
comunale<br />
ricadente nel sito<br />
ZPS/SIC<br />
% estensione<br />
comunale rispetto al<br />
totale del sito ZPS/SIC<br />
7,2 % 5,0 %<br />
1,0 %<br />
Estensione area ricadente nel Parco Terra delle<br />
Gravine<br />
ha circa<br />
511,74<br />
% estensione comunale<br />
ricadente nel Parco<br />
2,7 %<br />
2.12.4. Comune <strong>di</strong> Laterza<br />
Lo strumento urbanistico vigente è il Piano Regolatore Generale.<br />
L’art. 2.05 definisce le zone “E” come agricole, per attività prevalentemente primarie e <strong>di</strong><br />
tutela paesaggistico-ambientale.<br />
L’articolo 2.06 ha per titolo “Zone per attività primarie <strong>di</strong> tipo “E”, che sono zone destinate<br />
prevalentemente alla agricoltura e alla riforestazione.<br />
Le NTA prevedono che in tali zone possono essere ammesse attività industriali connesse con<br />
l’agricoltura, con l’allevamento del bestiame, con le industrie estrattive, con i depositi <strong>di</strong><br />
carburanti, con le reti <strong>di</strong> telecomunicazioni, <strong>di</strong> trasporto, <strong>di</strong> energia, <strong>di</strong> acquedotti e fognature,<br />
<strong>di</strong>scariche <strong>di</strong> rifiuti soli<strong>di</strong> e simili, compatibilmente con le rispettive leggi <strong>di</strong> settore.<br />
Per quanto riguarda i parametri e<strong>di</strong>lizi, l’e<strong>di</strong>ficazione viene subor<strong>di</strong>nata al rilascio della<br />
concessione e<strong>di</strong>lizia, rispettando le seguenti prescrizioni:<br />
• Superficie fon<strong>di</strong>aria minima: 5.000 m 2<br />
• In<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> fabbricabilità fon<strong>di</strong>aria massimo: 0,08 m 3 /m 2 , <strong>di</strong> cui 0,03 m 3 /m 2 destinabili<br />
alla residenza<br />
• Altezza massima: m 8,00 salvo costruzioni speciali<br />
• Rc secondo esigenze derivanti dal piano <strong>di</strong> sviluppo aziendale e comunque non<br />
superiore al 10% della Sf.<br />
In queste zone sono consentite le installazioni <strong>di</strong> serre con altezza fino a 3 m in gronda e a 6<br />
m al culmine se a falda, oppure a 4 m se a copertura piana. Le serre non vengono considerare<br />
delle “costruzioni” sia nel caso <strong>di</strong> serra <strong>di</strong> tipo stagionale che nel caso <strong>di</strong> tipo permanente. Per<br />
la prima vale un rapporto <strong>di</strong> copertura massimo consentito fino all’80% della superficie <strong>di</strong><br />
fondo, per la seconda vale il rapporto <strong>di</strong> copertura fino ad un massimo del 50% della<br />
superficie del fondo.<br />
Nella zona “E” è consentita la sistemazione del terreno per attività sportive che si svolgono in<br />
spazi naturali, quali il golf e la corsa <strong>di</strong> orientamento, il tiro con l’arco, gli sport equestri e<br />
simili che non mo<strong>di</strong>ficano l’assetto agricolo del terreno consentendo sia la continuazione <strong>di</strong><br />
attività <strong>di</strong> tipo agricolo sullo stesso sia la sua imme<strong>di</strong>ata rimessa a coltura.<br />
63
Per le recinzioni, oltre all’obbligo <strong>di</strong> mantenere i muretti a secco esistenti è prescritto, per<br />
quelli <strong>di</strong> nuova costruzione in connessione con recinzioni esistenti, il mantenimento delle<br />
stesse caratteristiche geometriche, materiali e tipologia costruttiva. Le recinzioni <strong>di</strong> nuovo<br />
impianto possono essere in muretti a secco o <strong>di</strong> muri <strong>di</strong> tufo scialbati o a “giorno” su cordolo<br />
<strong>di</strong> base e sovrastante grata, purché sia sempre garantito il normale ruscellamento delle acque<br />
superficiali.<br />
Al p.to 12 dell’art. 2.06 viene espressamente in<strong>di</strong>cata una misura <strong>di</strong> tutela ambientale<br />
attraverso “il rispetto e la conservazione della vegetazione esistente e la corretta<br />
regimentazione delle acque meteoriche e superficiali tramite apposite previsioni progettuali”.<br />
I progetti <strong>di</strong> interventi ricadenti in zone con Vincolo idrogeologico dovranno avere apposita e<br />
specifica relazione idrogeologica.<br />
Il p.to 13 dell’art.2.06 in<strong>di</strong>ca espressamente parametri inse<strong>di</strong>ativi maggiormente restrittivi con<br />
esplicito riferimento all’area comunale definita e perimetrata come “Zona a Protezione<br />
Speciale – Area delle Gravine”. In tale area è prescritto:<br />
• Superficie fon<strong>di</strong>aria minima: 20.000 m 2<br />
• In<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> fabbricabilità fon<strong>di</strong>aria massimo: 0,03 m 3 /m 2<br />
Nelle zone agricole sono anche previste possibilità e<strong>di</strong>ficatorie <strong>di</strong> tipo turistico-residenziale,<br />
<strong>di</strong> tipo turistico, <strong>di</strong> tipo sportivo/tempo libero (art. 2.07), finalizzate al mantenimento delle<br />
caratteristiche paesaggistiche e ambientali, alla integrazione delle attività agricole ed al<br />
mantenimento/recupero delle strutture esistenti. Tale possibilità e<strong>di</strong>ficatoria è subor<strong>di</strong>nata alla<br />
approvazione in Consiglio Comunale del relativo progetto, e vanno applicati gli in<strong>di</strong>ci<br />
destinati alla residenza in aree agricole (ossia pari a 0,03 m 3 /m 2 ).<br />
Con la stessa procedura sono previsti campi sportivi, piste ciclabili, motocross, gokart,<br />
percorsi pedonali attrezzati, spazi attrezzati per manifestazioni e attività vivaistiche nella<br />
misura del 20% della superficie fon<strong>di</strong>aria.<br />
Infine, sono previste attività <strong>di</strong> trasformazione dei prodotti agricoli (compresi caseifici,<br />
frantoi, cantine) ed attività zootecniche con relativi impianti <strong>di</strong> macellazione, conservazione e<br />
commercializzazione. L’e<strong>di</strong>ficazione è sempre connessa al rilascio della concessione e<strong>di</strong>lizia<br />
onerosa con approvazione da parte del Consiglio Comunale rispettando i seguenti parametri:<br />
• Superficie fon<strong>di</strong>aria minima 20.000 m 2<br />
• In<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> fabbricabilità fon<strong>di</strong>aria 0,10 m 3 /m 2 <strong>di</strong> cui 0,03 m 3 /m 2 destinabili alla<br />
residenza<br />
• Altezza massima: m 8,00, salvo costruzioni speciali.<br />
• Rc secondo esigenze derivanti dal piano <strong>di</strong> sviluppo aziendale e comunque non<br />
superiore al 10% della Sf<br />
Nella normativa tecnica viene poi inserita tutta la parte prescrittiva relativa al Piano<br />
Urbanistico Territoriale Tematico (PUTT) in<strong>di</strong>viduata nella cartografia <strong>di</strong> PRG riferita alle<br />
zone agricole E ricadenti sia negli ambiti territoriali estesi (ATE) sia negli ambiti territoriali<br />
<strong>di</strong>stinti (ATD), ossia a quelle che sono definite “Zone agricole per attività primarie sottoposte<br />
a tutela”.<br />
In coerenza con i loro livelli <strong>di</strong> tutela sono consentite solo nuove costruzioni connesse con<br />
l’agricoltura, la residenza e l’agriturismo e non sono ammesse attività industriali o estrattive.<br />
64
Tali interventi si realizzano tramite concessione e devono “salvaguardare gli aspetti peculiari<br />
dei siti e valorizzarli”. Fra l’altro, nelle zone agricole sottoposte a tutela vanno mantenuti,<br />
ricostruiti e costruiti i muretti <strong>di</strong> terrazzamento e le recinzioni con muretti <strong>di</strong> pietra a secco.<br />
Per ciascuno degli ambiti <strong>di</strong> tutela sono in<strong>di</strong>viduate le misure <strong>di</strong> salvaguar<strong>di</strong>a e i parametri<br />
inse<strong>di</strong>ativi.<br />
Per le zone E ricadenti in ATE “A” si applicano i seguenti parametri urbanistici :<br />
• Superficie fon<strong>di</strong>aria minima 5.000 m 2<br />
• In<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> fabbricabilità fon<strong>di</strong>aria 0,05 m 3 /m 2 <strong>di</strong> cui 0,03 m 3 /m 2 destinabili alla<br />
residenza<br />
• Altezza massima: m 4,00, salvo costruzioni speciali<br />
• Rc secondo esigenze derivanti dal piano <strong>di</strong> sviluppo aziendale e comunque non<br />
superiore al 10% della Sf<br />
Per le zone E ricadenti in ATE “B” si applicano i seguenti parametri urbanistici :<br />
• Superficie fon<strong>di</strong>aria minima: 5.000 m 2<br />
• In<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> fabbricabilità fon<strong>di</strong>aria 0,06 m 3 /m 2 <strong>di</strong> cui 0,03 m 3 /m 2 destinabili alla<br />
residenza<br />
• Altezza massima: m 6,00, salvo costruzioni speciali<br />
• Rc secondo esigenze derivanti dal piano <strong>di</strong> sviluppo aziendale e comunque non<br />
superiore al 10% della Sf<br />
Per le zone E ricadenti in ATE “C” e “D” si applicano i seguenti parametri urbanistici :<br />
• Superficie fon<strong>di</strong>aria minima 5.000 m 2<br />
• In<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> fabbricabilità fon<strong>di</strong>aria 0,08 m 3 /m 2 <strong>di</strong> cui 0,03 m 3 /m 2 destinabili alla<br />
residenza<br />
• Altezza massima: m 8,00, salvo costruzioni speciali<br />
• Rc secondo esigenze derivanti dal piano <strong>di</strong> sviluppo aziendale e comunque non<br />
superiore al 10% della Sf<br />
Regimi <strong>di</strong> tutela specifici sono previsti per le componenti ATD sia per la superficie del loro<br />
se<strong>di</strong>me “area <strong>di</strong> pertinenza” sia per la superficie in<strong>di</strong>viduata come necessaria per la loro<br />
salvaguar<strong>di</strong>a “area annessa”.<br />
Estensione agro comune <strong>di</strong> Laterza<br />
Estensione area ricadente nel sito ZPS/SIC<br />
Area delle Gravine<br />
Estensione area in cui è presente l’habitat<br />
prioritario<br />
ha circa<br />
15.960,85<br />
ha circa<br />
6.747,50<br />
ha circa<br />
2.057<br />
% estensione comunale<br />
ricadente nel sito<br />
ZPS/SIC<br />
% estensione comunale<br />
rispetto al totale del<br />
sito ZPS/SIC<br />
42,3 % 25,2 %<br />
13,0 %<br />
Estensione area ricadente nel Parco Terra<br />
delle Gravine<br />
ha circa<br />
4.895,80<br />
% estensione comunale<br />
ricadente nel Parco<br />
30,7 %<br />
65
2.12.5. Comune <strong>di</strong> Massafra<br />
Lo strumento urbanistico vigente è il PDF.<br />
Le NTA considerano le aree <strong>di</strong> tutto il territorio comunale non tipizzate <strong>di</strong>versamente come<br />
zone agricole con in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> fabbricabilità fon<strong>di</strong>aria pari a 0,03 m 3 /m 2 .<br />
Nelle zone destinate alle attività primarie tipo A) ossia costruzioni a servizio <strong>di</strong>retto<br />
dell’agricoltura (abitazioni, fabbricati rurali , ricoveri, ecc.) o per le attività primarie tipo B)<br />
ossia costruzioni a<strong>di</strong>bite alla conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli, annesse ad<br />
aziende agricole, allevamenti industriali gli in<strong>di</strong>ci previsti sono :<br />
• Superficie fon<strong>di</strong>aria minima 10.000 m 2<br />
• In<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> fabbricabilità fon<strong>di</strong>aria 0,05 m 3 /m 2 <strong>di</strong> cui max 0,03 m 3 /m 2 destinati alla<br />
residenza<br />
• Altezza massima: m 8,00, salvo costruzioni speciali<br />
• Rc non superiore al 10% della Sf<br />
• Superficie fon<strong>di</strong>aria minima 10.000 m 2<br />
• In<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> fabbricabilità fon<strong>di</strong>aria 0,05 m 3 /m 2 <strong>di</strong> cui max 0,03 m 3 /m 2 destinati alla<br />
residenza<br />
• Altezza massima: m 8,00, salvo costruzioni speciali<br />
• Rc non superiore al 10% della Sf<br />
Il Comune <strong>di</strong> Massafra ha adottato il Piano Regolatore con delibera <strong>di</strong> Consiglio Comunale n.<br />
60 del 31/10/2000. Gli atti del Piano sono stati sottoposti ai sensi della L.R. n. 24 del<br />
4/07/1994 e della L.R. n.8 del 21/08/1998 all’esame del CUR Ristretto. La Regione Puglia<br />
con delibera 2135/2007 ha ritenuto il Piano non meritevole <strong>di</strong> approvazione con rinvio del<br />
Piano all’Amm.ne Comunale affinché provveda alla sua rielaborazione tenendo in debito<br />
conto le peculiarità ambientali e paesaggistiche del territorio in questione e dei rilievi emersi<br />
nello stesso parere del CUR.<br />
Sebbene non approvato in via definitiva dalla Regione Puglia, si riportano gli in<strong>di</strong>ci previsti<br />
dalle NTA del Piano nelle zone E del P.R.G. strutturale territoriale - zone per attività primarie<br />
<strong>di</strong> tipo A :<br />
• Superficie fon<strong>di</strong>aria minima 5.000 m 2<br />
• In<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> fabbricabilità fon<strong>di</strong>aria 0,03 m 3 /m 2 per abitazioni rurali e civili<br />
0,02 m 3 /m 2 per fabbricati pertinenti alle attività<br />
produttive<br />
• Altezza massima:<br />
m 8,00, salvo costruzioni speciali<br />
Tali aree sono destinate in prevalenza all’agricoltura, alle foreste, alla caccia ed alla pesca; in<br />
esse sono ammesse attività industriali connesse con l’agricoltura, con l’allevamento del<br />
bestiame, con le industrie estrattive, coi depositi <strong>di</strong> carburanti e simili.<br />
66
Estensione agro comune <strong>di</strong> Massafra<br />
Estensione area ricadente nel sito ZPS/SIC<br />
Area delle Gravine<br />
Estensione area in cui è presente l’habitat<br />
prioritario<br />
ha circa<br />
12.680,97<br />
ha circa<br />
6.199,2<br />
ha circa<br />
1.148<br />
% estensione<br />
comunale ricadente<br />
nel sito ZPS/SIC<br />
% estensione<br />
comunale rispetto al<br />
totale del sito ZPS/SIC<br />
48,9 % 23,2 %<br />
9,0 %<br />
Estensione area ricadente nel Parco Terra<br />
delle Gravine<br />
ha circa<br />
3.516,24<br />
% estensione comunale<br />
ricadente nel Parco<br />
27,7 %<br />
2.12.6. Comune <strong>di</strong> Mottola<br />
Lo strumento urbanistico vigente è il Piano Regolatore Generale.<br />
Le NTA del Piano Regolatore <strong>di</strong> Mottola prevedono come zone agricole tutte quelle “parti del<br />
territorio destinate alle attività agricole e forestali, ovvero recuperabili per tali attività o<br />
comunque destinate ad attività connesse con le produzioni agricole e forestali, non soltanto<br />
con funzione produttiva ma anche con funzione <strong>di</strong> salvaguar<strong>di</strong>a del sistema idrogeologico,<br />
del paesaggio agrario e dell’equilibrio ecologico e naturale”.<br />
In tali zone oltre alla costruzione <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici o impianti funzionali alla produzione agricola e<br />
alle necessità degli operatori agricoli, sono altresì previsti: impianti pubblici a rete (telecomunicazioni,<br />
trasporto, energia, acquedotto, fognatura, e altro) e relativi manufatti, oltre ai<br />
seguenti interventi :<br />
a) nuove abitazioni necessarie all’operatore agricolo o agli addetti dell’azienda;<br />
b) fabbricati <strong>di</strong> servizio necessari per lo svolgimento delle attività produttive delle<br />
aziende singole o associate;<br />
c) fabbricati per l’allevamento zootecnico <strong>di</strong> tipo industriale con annessi fabbricati <strong>di</strong><br />
servizio;<br />
d) impianti tecnici e tecnologici al servizio del territorio agricolo,<br />
e) costruzioni relative agli usi agrituristici<br />
f) serre.<br />
Oltre a tali interventi, per gli e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> pregio storico o ambientale sono ammessi interventi <strong>di</strong><br />
manutenzione or<strong>di</strong>naria e straor<strong>di</strong>naria e <strong>di</strong> ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia su tutti gli e<strong>di</strong>fici esistenti.<br />
Le norme prevedono una <strong>di</strong>stinzione delle zone agricole in:<br />
• zona E 1, agricola normale;<br />
• zona E 2, agricola <strong>di</strong> interesse paesistico;<br />
• zona E 3, <strong>di</strong> salvaguar<strong>di</strong>a <strong>di</strong> elementi geomorfologici;<br />
• zona E 4, zone <strong>di</strong> bosco e <strong>di</strong> macchia me<strong>di</strong>terranea.<br />
Nelle zone agricole E 1 sono ammessi tutti gli interventi sopradetti. Esse sono utilizzate a<br />
scopi produttivi e gli in<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> fabbricabilità sono stati previsti in maniera modulata secondo il<br />
tipo <strong>di</strong> intervento.<br />
Interventi <strong>di</strong> tipo a) e b)<br />
67
• Unità minima colturale: 7,5 ha per aziende con allevamento e/o su terreni a bosco o<br />
foraggere; 3,5 ha per altre aziende<br />
• In<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> fabbricabilità fon<strong>di</strong>aria: 0,03 m 3 /m 2 per abitazioni<br />
0,05 m 3 /m 2 complessivi per abitazioni e fabbricati pertinenti alle attività<br />
• Altezza massima: m 7,5, salvo costruzioni speciali<br />
Interventi <strong>di</strong> tipo c) e d)<br />
• Unità minima colturale: 3,5 ha per interventi tipo c); 4,0 ha per interventi tipo d)<br />
• In<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> fabbricabilità fon<strong>di</strong>aria: una sola unità abitativa per impianto<br />
• Altezza massima: m 5 superiore possibile solo per impianti speciali<br />
Le zone agricole E 2 comprendono aree dove la tutela del paesaggio è preminente; in tale<br />
zone è fatto obbligo <strong>di</strong> mantenere le alberature esistenti, le recinzioni in muro a secco e tutti<br />
gli elementi colturali e paesaggistici presenti.<br />
Sono comunque consentiti alcune possibilità e<strong>di</strong>ficatorie e per gli interventi ammessi valgono<br />
le prescrizioni e gli in<strong>di</strong>ci previsti per la zona E1.<br />
Le zone agricole E 3 sono i territori coperti da tratti <strong>di</strong>scontinui <strong>di</strong> macchia o ad<strong>di</strong>rittura brulli<br />
e rocciosi, caratterizzati dalla presenza <strong>di</strong> elementi geomorfologici che si intendono tutelare,<br />
quali: pen<strong>di</strong>i, canali <strong>di</strong> deflusso delle acque meteoriche, aree <strong>di</strong> protezione dei boschi, piccole<br />
gravine o lame. In queste aree è ammesso il proseguimento dell’attività agricola nel rispetto <strong>di</strong><br />
tutti gli elementi naturali e il rimboschimento con essenze vegetali caratteristiche dell’area<br />
(bosco ceduo, macchia me<strong>di</strong>terranea o pini d’Aleppo). È ammessa la realizzazione <strong>di</strong> aree a<br />
verde per la ricreazione e <strong>di</strong> percorsi pedonali, sempreché tali interventi non alterino la<br />
morfologia dei luoghi.<br />
È assolutamente vietato ogni intervento <strong>di</strong> nuova costruzione. Tali zone possono far parte <strong>di</strong><br />
terreni agricoli ai soli fini del calcolo degli in<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> fabbricabilità.<br />
Le zone agricole E 4 sono le zone boscate o coperte da macchia me<strong>di</strong>terranea e sono<br />
automaticamente soggette a vincolo paesistico ai sensi della Legge 1497/39 e dalla Legge<br />
431/85 ancorché percorse o danneggiate dal fuoco. Tali zone possono far parte <strong>di</strong> terreni<br />
agricoli ai soli fini del calcolo degli in<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> fabbricabilità, ma devono essere mantenute a<br />
bosco o macchia e/o rimboschite nel caso <strong>di</strong> danneggiamento da incen<strong>di</strong> o altro. In caso <strong>di</strong><br />
rimboschimenti vanno utilizzate le essenze vegetali presenti nell’area. Sono escluse tutte le<br />
attività che comportano e<strong>di</strong>ficazione ad eccezione della realizzazione <strong>di</strong> strade sterrate tagliafuoco<br />
o necessarie per il passaggio <strong>di</strong> messi antincen<strong>di</strong>o e <strong>di</strong> soccorso.<br />
Con delibera <strong>di</strong> Giunta Comunale n. 67 del 18/04/2008 è stata approvata la <strong>Relazione</strong> ed Atto<br />
<strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzo per la redazione del PUG. Gli obiettivi in<strong>di</strong>viduati per la redazione del PUG sono<br />
sostanzialmente quelli <strong>di</strong> mantenere l’attuale zonizzazione delle aree residenziali <strong>di</strong><br />
espansione e per attività secondarie/servizi sulla base <strong>di</strong> <strong>di</strong>rettrici <strong>di</strong> azioni che permettano<br />
uno sviluppo sostenibile della citta<strong>di</strong>na, in considerazione della salvaguar<strong>di</strong>a del patrimonio<br />
ambientale e della valorizzazione delle risorse locali.<br />
Alcuni obiettivi sono : destinare la campagna principalmente all’agricoltura e al turismo come<br />
fonte <strong>di</strong> risorsa e <strong>di</strong> ricostruzione <strong>di</strong> risorse ambientali sottratte e/o danneggiate; limitare il<br />
68
consumo della “risorsa suolo”; perseguire obiettivi <strong>di</strong> qualità ambientale e rafforzare le<br />
identità storico culturale della città e del suo territorio.<br />
Estensione agro comune <strong>di</strong> Mottola<br />
Estensione area ricadente nel sito ZPS/SIC<br />
Area delle Gravine<br />
Estensione area in cui è presente l’habitat<br />
prioritario<br />
ha circa<br />
21.200,44<br />
ha circa<br />
3.711,7<br />
ha circa<br />
1.276<br />
% estensione<br />
comunale ricadente<br />
nel sito ZPS/SIC<br />
% estensione<br />
comunale rispetto al<br />
totale del sito ZPS/SIC<br />
17,5 % 13,9 %<br />
6,0 %<br />
Estensione area ricadente nel Parco Terra delle Gravine<br />
ha circa<br />
5.277,63<br />
% estensione comunale<br />
ricadente nel Parco<br />
24,9 %<br />
2.12.7. Comune <strong>di</strong> Palagianello<br />
Lo strumento urbanistico vigente è i Piano Urbanistico Generale (PUG).<br />
Il nuovo PUG <strong>di</strong> cui si è dotato il Comune prende esplicitamente in considerazione la<br />
pianificazione con i siti <strong>di</strong> interesse naturalistico <strong>di</strong> importanza comunitaria e le relative<br />
misure <strong>di</strong> conservazione e salvaguar<strong>di</strong>a degli habitat.<br />
Uno degli obiettivi del PUG (art 12 delle NTA) è quello della tutela e valorizzazione<br />
ambientale e paesaggistica attraverso il Recupero e salvaguar<strong>di</strong>a della bio<strong>di</strong>versità ecologica<br />
e della varietà estetica del territorio, effettuando azioni volte alla conservazione e al<br />
potenziamento dei corridoi paesaggistici (siepi, alberi, muretti a secco) e all'integrazione<br />
dello spazio antropizzato. Censimento <strong>di</strong> tutti gli e<strong>di</strong>fici, masserie, iazzi da sottoporre a<br />
tutela, oltre alla costituzione <strong>di</strong> una carta tematica che in<strong>di</strong>chi su tutto il territorio le aree <strong>di</strong><br />
interesse <strong>generale</strong> da salvaguardare e valorizzare. Il tutto in adeguamento alle previsioni e<br />
alle prescrizioni del P.U.T.T. e <strong>di</strong> tutti i piani e leggi <strong>di</strong> tutela.<br />
Per quanto riguarda il settore turistico, quello <strong>di</strong> incentivare uno sviluppo turistico riqualificando<br />
le aree a maggiore valenza paesaggistica, storica ed ambientale, con la possibilità <strong>di</strong><br />
poter sviluppare l’itinerario già presente dell'habitat rupestre nel comprensorio della “Terra<br />
delle Gravine”.<br />
A tal proposito il PUG ha in<strong>di</strong>viduato e perimetrato un’area definita zona A2 “Recupero degli<br />
inse<strong>di</strong>amenti rupestri” caratterizzata dalla presenza <strong>di</strong> numerosi “segni” della stratificazione<br />
storica dell’organizzazione inse<strong>di</strong>ativa e delle tecniche <strong>di</strong> conduzione agricola, per la quale è<br />
previsto un progetto unitario <strong>di</strong> restauro paesaggistico-ambientale che preveda una utilizzazione<br />
anche ai fini turistici dell’area (percorsi escursionistici lungo la gravina con luoghi <strong>di</strong><br />
sosta e si ristoro) oltre che il recupero paesistico-ambientale attraverso l’eliminazione dei<br />
“detrattori” (area <strong>di</strong> cava <strong>di</strong>smessa).<br />
Ha, inoltre, in<strong>di</strong>viduato e perimetrato alcune aree territoriali in cui è presente una <strong>di</strong>ffusa<br />
e<strong>di</strong>ficazione ricadente a ridosso <strong>di</strong> beni paesistico-ambientali <strong>di</strong>rettamente tutelati dalla L.R.<br />
69
n. 56/80, per le quali sarà pre<strong>di</strong>sposto un apposito piano <strong>di</strong> intervento P.I.R.T. (Piano <strong>di</strong><br />
Intervento <strong>di</strong> Recupero Territoriale) <strong>di</strong> cui all’art. 7.08 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.<br />
Il piano <strong>di</strong>stingue zona E1 agricola, ossia tutto il territorio comunale che non è tipizzato<br />
<strong>di</strong>fferentemente, zona agricola E2 “vincolata” e zona E3 “verde agricolo speciale”.<br />
Nelle zone agricole E1 sono consentiti interventi riservati all’esercizio <strong>di</strong> attività agricole o <strong>di</strong><br />
quelle strettamente connesse all’agricoltura. Pertanto, le opere e<strong>di</strong>ficatorie prevalentemente<br />
ammesse sono tutte quelle costruzioni <strong>di</strong> fabbricati a servizio dell’agricoltura, <strong>di</strong> fabbricati<br />
rurali come stalle, silos, ricorevi, ecc., <strong>di</strong> fabbricati a<strong>di</strong>biti alla conservazione e trasformazione<br />
dei prodotti agricoli (annessi ad aziende agricole che lavorino prevalentemente prodotti<br />
propri) e alle residenze dell’impren<strong>di</strong>tore agricolo e dei <strong>di</strong>pendenti dell’azienda.<br />
Si applicano i seguenti in<strong>di</strong>ci:<br />
• In<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> fabbricabilità fon<strong>di</strong>aria per le nuove costruzioni destinate esclusivamente ad<br />
abitazioni agricole: 0,03 m 3 /m 2<br />
• In<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> fabbricabilità fon<strong>di</strong>aria per le nuove costruzioni destinate ad aziende<br />
agricole: 0,06 m 3 /m 2 <strong>di</strong> cui 0,03 m 3 /m 2 per residenza e 0,03 m 3 /m 2 per gli annessi<br />
rustici<br />
• In<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> fabbricabilità fon<strong>di</strong>aria per interventi <strong>di</strong> valorizzazione e trasformazione dei<br />
prodotti agricoli e zootecnici: 0,15 m 3 /m 2 (in deroga)<br />
• Altezza massima :7,00 m<br />
Infine è prescritto che tutti gli inse<strong>di</strong>amenti esistenti e/o a farsi dovranno dotarsi <strong>di</strong> sistemi <strong>di</strong><br />
scarico adeguati alla normativa <strong>di</strong> tutela delle acque dall’inquinamento.<br />
La perimetrazione della zona E2 rinviene dalla presenza dei vincoli e dall’in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong><br />
tutte le emergenze del sistema botanico-vegetazionale e della potenzialità faunistica, del<br />
sistema della stratificazione storica dell’organizzazione inse<strong>di</strong>ativa, del sistema geo-morfoidrogeologico.<br />
Nell’area è compresa anche la perimetrazione del Parco delle Gravine<br />
dell’Arco Jonico. Pertanto, le NTA del PUG prevedono che, in attesa della costituzione del<br />
Parco, tali aree E2 ricadenti in area Parco siano tutelate attraverso le seguenti prescrizioni<br />
vincolanti:<br />
‣ non è consentita alcuna forma <strong>di</strong> nuova e<strong>di</strong>ficazione ad uso abitativo ma bensì la mera<br />
e<strong>di</strong>ficazione, ad uso esclusivamente produttivo, finalizzata alla conduzione del fondo<br />
per gli operatori agricoli qualificati (Coltivatori <strong>di</strong>retti, proprietari ed affittuari che<br />
de<strong>di</strong>cano all’attività agricola almeno la metà del tempo <strong>di</strong> lavoro complessivo e<br />
ricavano da tale attività almeno la metà del proprio red<strong>di</strong>to <strong>di</strong> lavoro, così come<br />
definiti dall’art 48 della L. n. 454/61 e succ. mo<strong>di</strong>f. ed int., Coltivatori aventi la<br />
qualifica <strong>di</strong> Impren<strong>di</strong>tori Agricoli a Titolo Principale ai sensi dell’art 12 della L.<br />
n.153/75, Cooperative agricole <strong>di</strong> conduzione bracciantile e forme associate<br />
assimibili).<br />
‣ Non è consentita l’apertura <strong>di</strong> nuove cave;<br />
‣ Non è consentito esercitare attività venatorie;<br />
‣ Non è consentito attuare opere <strong>di</strong> movimento terra tali da mo<strong>di</strong>ficare consistentemente<br />
la morfologia del terreno;<br />
70
‣ Non è consentito aprire nuove strade e/o ampliare le esistenti se non in funzione delle<br />
attività agricole forestali e pastorali;<br />
‣ Non è consentita l’allocazione <strong>di</strong> <strong>di</strong>scariche o depositi <strong>di</strong> rifiuti;<br />
‣ Non è consentita la realizzazione <strong>di</strong> serre ovvero <strong>di</strong> coperture anche stagionali non<br />
stabilmente infisse al suolo e destinate a proteggere colture;<br />
‣ È vietata l’installazione <strong>di</strong> impianti Stazioni Ra<strong>di</strong>o Base (S.R.B.) e Ra<strong>di</strong>otelevisivi<br />
(R.T.V.) produttori <strong>di</strong> campi elettromagnetici ad alta frequenza;<br />
‣ È inoltre vietata l’installazione <strong>di</strong> nuovi elettrodotti, sia aerei che interrati.<br />
‣ È inoltre vietata l’installazione <strong>di</strong> generatori eolici anche <strong>di</strong> potenza inferiore a 300<br />
Kw.<br />
Per quanto riguarda gli in<strong>di</strong>ci sono prescritti:<br />
• Superficie fon<strong>di</strong>aria minima: ettari 2.000;<br />
• In<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> fabbricabilità fon<strong>di</strong>aria: 0,01 m 3 /m 2 ;<br />
• Altezza massima dei fabbricati: m 4,00;<br />
Nella zona E2 agricola vincolata esterna alla perimetrazione del Parco è consentita,<br />
esclusivamente per gli operatori agricoli qualificati, la realizzazione <strong>di</strong> costruzioni connesse<br />
con l’agricoltura e l’attività zootecnica nel rispetto dei seguenti in<strong>di</strong>ci e parametri:<br />
• Superficie fon<strong>di</strong>aria minima: ettari 2.000;<br />
• In<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> fabbricabilità fon<strong>di</strong>aria: 0,01 m 3 /m 2 ;<br />
• Altezza massima dei fabbricati: m 4,00;<br />
Sono consentiti interventi <strong>di</strong> carattere agro-turistico e <strong>di</strong> turismo rurale.<br />
Gli interventi, tuttavia, devono essere sempre verificati rispetto all’eventuale interferenza con<br />
gli in<strong>di</strong>rizzi e le <strong>di</strong>rettive <strong>di</strong> tutela e con le prescrizioni <strong>di</strong> base degli ATE e ATD del PUTT/P.<br />
Infine, la zona E3 è costituita da quelle aree, anche ricadente all’interno del tessuto e<strong>di</strong>ficato<br />
esistente, che hanno subito profonde mo<strong>di</strong>ficazioni del loro originario assetto geomorfologico<br />
dovuto all’esercizio delle attività estrattive.<br />
Per tali aree sono previsti piani <strong>di</strong> recupero e progetti miranti a ripristino geomorfologicoe e<br />
l’utilizzo, a recupero ultimato, dovrà per il 60% conservare la destinazione agricola e/o a<br />
verde <strong>di</strong> interesse pubblico mentre il 40% potrà essere destinato a fini inse<strong>di</strong>ativi.<br />
Estensione agro comune <strong>di</strong> Palagianello<br />
Estensione area ricadente nel sito ZPS/SIC Area<br />
delle Gravine<br />
Estensione area in cui è presente l’habitat<br />
prioritario<br />
Estensione area ricadente nel Parco Terra<br />
delle Gravine<br />
ha circa<br />
4.340,08<br />
ha circa<br />
1.021,2<br />
ha circa<br />
130<br />
ha circa<br />
479,35<br />
% estensione<br />
comunale<br />
ricadente nel sito<br />
ZPS/SIC<br />
% estensione<br />
comunale rispetto<br />
al totale del sito<br />
ZPS/SIC<br />
23,5 % 3,8 %<br />
3,0 %<br />
% estensione comunale<br />
ricadente nel Parco<br />
11,0 %<br />
71
2.12.8. Comune <strong>di</strong> Statte<br />
Lo strumento urbanistico vigente è il Piano Regolatore Generale <strong>di</strong> <strong>Taranto</strong> riguardante il<br />
proprio territorio comunale.<br />
Il Comune <strong>di</strong> Statte ha autonomia propria dal 1993, essendosi staccato dal Comune <strong>di</strong><br />
<strong>Taranto</strong>. Il Comune <strong>di</strong> Statte ha assunto la parte relativa alle in<strong>di</strong>cazioni urbanistiche derivanti<br />
dal PRG <strong>di</strong> <strong>Taranto</strong>.<br />
Le aree agricole sono <strong>di</strong>vise in quattro articoli con vari livelli <strong>di</strong> tutela, che sono:<br />
a) zona <strong>di</strong> verde agricolo <strong>di</strong> tipo A);<br />
b) zona <strong>di</strong> verde agricolo <strong>di</strong> tipo B);<br />
c) zona <strong>di</strong> bosco attrezzato;<br />
d) zona speciale vincolata.<br />
Nelle zone agricole <strong>di</strong> tipo A) sono consentite le costruzioni al servizio dell’agricoltura con un<br />
in<strong>di</strong>ce fon<strong>di</strong>ario <strong>di</strong> fabbricabilità <strong>di</strong> 0,01 m 3 /m 2 . Le costruzioni ammesse sono: le stalle, i<br />
fienili, i granai, i solai, con esclusione delle residenze e delle destinazioni <strong>di</strong> tipo agricolo<br />
industriale.<br />
Nelle zone <strong>di</strong> verde agricolo <strong>di</strong> tipo B) sono consentite le costruzioni a servizio delle aziende<br />
agricole e in particolare le case coloniche, le stalle, i granai, le attrezzature rurali in genere, le<br />
residenze padronali, quelle del personale <strong>di</strong>rigente e degli addetti. Sono consentite cubature<br />
massime previste dal D.M. 2 aprile 1968.<br />
Nelle le zone <strong>di</strong> bosco attrezzato sono vietate le costruzioni e le trasformazioni in genere, in<br />
quanto istituite espressamente per tutelare e assicurare la conservazione e la valorizzazione e<br />
il go<strong>di</strong>mento delle aree boscate.<br />
La zona speciale vincolata è stata istituita per la realizzazione <strong>di</strong> un parco territoriale; è vietata<br />
qualsiasi altra destinazione, in caso <strong>di</strong> deca<strong>di</strong>mento dei vincoli, e qualsiasi trasformazione del<br />
suolo.<br />
Attualmente, il comune con Delibera <strong>di</strong> C.C. n. 66 del 22/12/2006 ha adottato il D.P.P.<br />
(Documento Programmatico Preliminare). Il D. P. P. costituisce l'avvio del proce<strong>di</strong>mento per<br />
la redazione del Piano Urbanistico Generale (PUG) e definisce gli obiettivi e i criteri <strong>di</strong><br />
impostazione del nuovo strumento urbanistico.<br />
Sulla base delle analisi preliminari sono stati in<strong>di</strong>viduati gli usi del suolo ed in particolare le<br />
aree che dovranno essere sottoposte a vincolo, tra le quali le aree ricadenti nel Parco Terra<br />
delle Gravine e delle aree ricadenti nel sito SIC/ZPS “Area delle Gravine”. Per tutti gli ambiti<br />
<strong>di</strong> rilievo naturalistico-ambientale, sono state in<strong>di</strong>viduate quali criticità a livello ambientale gli<br />
elementi che necessitano particolare attenzione per la loro caratteristiche <strong>di</strong> fragilità<br />
naturalistico-ambientale in rapporto alla presenza <strong>di</strong> elementi <strong>di</strong> peculiarità paesaggistica da<br />
tutelare e valorizzare (gravine, aree demaniali recentemente acquisite dall’Amministrazione<br />
per la valorizzazione <strong>di</strong> reperti archeologici e/o naturalistici, spazi liberi localizzati in zone<br />
intercluse, localizzate in prossimità <strong>di</strong> barriere infrastrutturali o in cunei degradati).<br />
Per quanto riguarda l’ambiente l’obiettivo del nuovo Piano già delineato nel documento è<br />
quello <strong>di</strong> promuovere interventi finalizzati alla salvaguar<strong>di</strong>a delle zone <strong>di</strong> valore ambientale e<br />
72
naturalistico presenti nel territorio, alla valorizzazione delle aree urbane con potenziali<br />
caratteristiche ambientali <strong>di</strong> pregio attraverso la costruzione <strong>di</strong> una “rete ecologica” che ne<br />
favorisca la connessione e la fruibilità.<br />
Dunque per il “sistema ambientale” la proposta è quella <strong>di</strong> realizzare una “rete ecologica” <strong>di</strong><br />
connessione tra le aree <strong>di</strong> maggior valore naturalistico presenti e previste nel territorio con<br />
quelle <strong>di</strong> maggior valore ecologico presenti e previste nei centri urbani. In particolare il<br />
progetto si dovrà sviluppare attraverso alcune <strong>di</strong>rettive principali quali:<br />
- Progetto <strong>di</strong> rete ecologica primaria (gravine e zone a bosco e macchia)<br />
- Progetto <strong>di</strong> rete ecologica secondaria (proposte <strong>di</strong> parco naturalistico), che<br />
comprenderà tre progetti <strong>di</strong> riqualificazione ambientale già realizzati “Recupero beni<br />
culturali”, proposta <strong>di</strong> acquisizione <strong>di</strong> aree boschive localizzate lungo la zona nord<br />
della Gravina Leucaspide e nei pressi della Masseria Grinesi, allo scopo <strong>di</strong> una<br />
futura destinazione a parco naturalistico e Parco periurbano "Leucaspide est"<br />
- Connettivo della rete ecologica costituito dal complesso delle aree agricole a uliveto<br />
con presenza <strong>di</strong> essenze secolari, dotate <strong>di</strong> caratteristiche <strong>di</strong> pregio naturalisticoambientale<br />
con funzione <strong>di</strong> connettivo della rete ecologica primaria prevista nel Dpp<br />
costituita dalla gravine e dalle aree a bosco e macchia.<br />
Estensione agro comune <strong>di</strong> Statte<br />
Estensione area ricadente nel sito ZPS/SIC<br />
Area delle Gravine<br />
Estensione area in cui è presente l’habitat<br />
prioritario<br />
ha circa<br />
6.702,72<br />
ha circa<br />
1.201,2<br />
ha circa<br />
327<br />
% estensione<br />
comunale ricadente<br />
nel sito ZPS/SIC<br />
% estensione<br />
comunale rispetto al<br />
totale del sito ZPS/SIC<br />
17,9 % 4,5 %<br />
5,0 %<br />
Estensione area ricadente nel Parco Terra<br />
delle Gravine<br />
ha circa<br />
2.718,92<br />
% estensione comunale<br />
ricadente nel Parco<br />
40,6 %<br />
73
2.13. In<strong>di</strong>cazioni urbanistiche per il Piano <strong>di</strong> Gestione del Territorio del<br />
SIC/ZPS “Area delle Gravine”<br />
La Regione Puglia con la Legge Regionale 27 luglio 2001, n. 20 “Norme generali <strong>di</strong> governo<br />
e uso del territorio”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 128 del 24 agosto 2001, si è dotata<br />
<strong>di</strong> una nuova legge in materia <strong>di</strong> urbanistica e <strong>di</strong> formazione degli strumenti <strong>di</strong> programmazione<br />
e <strong>di</strong> pianificazione a livello regionale, provinciale e comunale e con Legge Regionale<br />
Testo coor<strong>di</strong>nato della l.r. 12 aprile 2001, n. 11, così come mo<strong>di</strong>ficata dalla l.r. 14 giugno<br />
2007, n. 17; l.r. 3 agosto 2007, n. 25; l.r. 31 <strong>di</strong>cembre 2007, n. 40, in materia <strong>di</strong> procedura <strong>di</strong><br />
Valutazione <strong>di</strong> impatto ambientale, <strong>di</strong>sciplina le procedure <strong>di</strong> Valutazione <strong>di</strong> Impatto<br />
Ambientale (VIA). Disciplina inoltre le procedure <strong>di</strong> valutazione <strong>di</strong> incidenza ambientale <strong>di</strong><br />
cui al DPR del 8 settembre 1997, n. 357.<br />
Nel rispetto della nuove procedure introdotte dalla L.R. n. 11/2001, dalla L.R. 20/2001<br />
nonché dalle “Linee guida”del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del<br />
Territorio del 3 settembre 2002 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002)<br />
e dell’entrata in vigore del DRAG (D.G.R. n. 1328 del 03/08/2007) –Documento Regionale <strong>di</strong><br />
Assetto Generale quale strumento normativo contenente le linee guida e gli in<strong>di</strong>rizzi per la<br />
formazione degli strumenti urbanistici si <strong>di</strong>spone che:<br />
• tutti i comuni dovranno adeguare i propri strumenti urbanistici tenendo conto della<br />
presenza all’interno del loro territorio degli habitat prioritari dell’area SIC/ZPS e della<br />
perimetrazione del Parco “Terra delle Gravine”, adottando con una procedura<br />
d’urgenza per in<strong>di</strong>viduare misure <strong>di</strong> tutela e salvaguar<strong>di</strong>a degli habitat prioritari del<br />
sito SIC/ZPS, così come saranno definite dal presente Piano <strong>di</strong> Gestione dell’Area.<br />
Nelle zone comunali ricadenti in area SIC/ZPS per ogni intervento si dovrà procedere<br />
alla valutazione <strong>di</strong> incidenza ambientale ove previsto dalla normativa vigente e<br />
dovranno rimanere invariati gli in<strong>di</strong>ci urbanistici in<strong>di</strong>cati dagli attuali strumenti<br />
urbanistici<br />
• per il Comune <strong>di</strong> Palagianello il cui nuovo strumento urbanistico prevede<br />
espressamente la tutela delle aree ricadenti in area Parco delle Gravine, esso dovrà<br />
provvedere ad estendere le misure <strong>di</strong> salvaguar<strong>di</strong>a anche alle aree SIC/ZPS non<br />
ricadenti in area Parco;<br />
• tutti i comuni dovranno adottare politiche che incentivino tutte le tecnologie<br />
costruttive <strong>di</strong> bioarchitettura nelle aree ricadenti all’interno del sito SIC/ZPS e del<br />
Parco “Terra delle Gravine”;<br />
• gli strumenti urbanistici dovranno essere soggetti a VAS secondo quanto previsto dal<br />
D.Lgs. 152/2006 – Parte II<br />
• i comuni dovranno adottare politiche <strong>di</strong> pianificazione ecosostenibili adottando piani<br />
<strong>di</strong> settore ambientale (Piano <strong>di</strong> risanamento acustico, piani energetici comunali, piano<br />
<strong>di</strong> mobilità urbana ecc.).<br />
74
2.14. Descrizione dei valori archeologici, architettonici e culturali presenti<br />
nel sito<br />
Le caratteristiche morfologiche delle gravine con presenza <strong>di</strong> numerose grotte con<br />
caratteristiche <strong>di</strong> stabilità climatica hanno favorito l’inse<strong>di</strong>amento dell’uomo fin dal periodo<br />
Neolitico, il c.d. habitat rupestre. Ne sono testimonianza numerosissimi inse<strong>di</strong>amenti rupestri<br />
presenti nei vari comuni dell’area SIC.<br />
Tracce <strong>di</strong> inse<strong>di</strong>amenti paleolitici sono attestati in varie grotte nelle gravine <strong>di</strong> Ginosa,<br />
Masseria del Porto, Castellaneta, Masseria Minerva, Palagianello, Statte, Martina Franca,<br />
Grottaglie. Nella Grotta Sant’angelo <strong>di</strong> Statte sono stati scoperti segni <strong>di</strong> frequentazioni<br />
umane che vanno dal Paleolitico all’età bizantina. Senza contare il dolmen neolitico <strong>di</strong><br />
“Accettula”. Nelle gravine <strong>di</strong> Laterza si è attestata un’intera civiltà del periodo eneolitico che<br />
prende il suo nome. Scoglio del Tonno è stato uno dei primi porti <strong>di</strong> attracco per uomini<br />
provenienti dall’Egeo. Ginosa, Laterza e Massafra hanno costituito una dorsale <strong>di</strong><br />
attraversamento necessario <strong>di</strong> pastori, noma<strong>di</strong>, mercanti, agricoltori, fra l’Adriatico, lo Ionio<br />
ed il Tirreno. Certi ipogei <strong>di</strong> sepoltura sono presenti in Palestina in Siria come a Palagianello<br />
o nella masseria <strong>di</strong> Leucaspide. Simulacri, attrezzi, sepolture delle età del Bronzo sono state<br />
documentate a Masseria del Porto (Laterza), ma anche a Statte e Crispiano, o Lama del<br />
Penziero a Grottaglie. A Reinzano presso Martina Franca sono state trovate 12 scure <strong>di</strong> ferro<br />
sotto una grande quercia.<br />
Senza <strong>di</strong>menticare che i famosi “Ori <strong>di</strong> <strong>Taranto</strong>” sono stati confezionati da artigiani<br />
magnogreci <strong>di</strong> Crispiano e Ginosa. E nel territorio spesso l’abitare in grotte e in rifugi <strong>di</strong><br />
pietra a trullo, hanno segnato le stazioni <strong>di</strong> movimento <strong>di</strong> popolazioni italiche appenniniche e<br />
pre-appenniniche che poi si sono incontrati con gli inse<strong>di</strong>amenti della civiltà greche, o<br />
semitico-fenicie, e poi via via romane, bizantine, arabe, normanne… quasi tutte frutto <strong>di</strong> koiné<br />
e fusioni linguistico-religiose-antropologiche. In <strong>generale</strong>, occorre precisare, che tutto il<br />
Me<strong>di</strong>o Evo me<strong>di</strong>terraneo ed europeo è stato caratterizzato dall’abitare in grotta: prima per<br />
sfuggire all’invasione <strong>di</strong> nuovi popoli centro asiatici, e poi come siti <strong>di</strong> rinascita, sulla via dei<br />
gra<strong>di</strong> pellegrinaggi da Santjago de Compostela a Gerusalemme. La terra Ionica con le sue<br />
grotte e gravine era su questa traiettoria ed è stata recettrice dei movimenti <strong>di</strong> andata e ritorno,<br />
<strong>di</strong> cammino e <strong>di</strong> pellegrinaggi, <strong>di</strong> commerci e servitù <strong>di</strong> eserciti, fra Oriente e Occidente.<br />
Le cripte <strong>di</strong> San Nicola, Sant Angelo <strong>di</strong> Mottola, le grotte <strong>di</strong> San Marzano presentano segni,<br />
affreschi che si riferiscono a questi percorsi. Gli stessi trulli della Valle d’Itria (Valle<br />
dell’Odegitria, ovvero della Madonna nera <strong>di</strong> Costantinopoli protettrice dei pellegrini) sono<br />
sulla strada fra le civiltà dell’Asia Occidentale e quella più remota della Mesopotamia e della<br />
Persia. Il centro storico <strong>di</strong> Harran dove è approdato il patriarca Abramo, oggi in territorio<br />
curdo turco, è fatta a Trulli; nei <strong>di</strong>ntorni <strong>di</strong> Aleppo nella provincia dove è stata scoperta la<br />
grande città <strong>di</strong> Ebla, ci sono villaggi a trullo; nel Parco del Luberon nella Provence<br />
meri<strong>di</strong>onale ci sono villaggi a trullo e rifugi campestri a trullo sono in pie<strong>di</strong> in Istria.<br />
Così, in modo plastico, su un’ideale mappa delle migrazioni risalenti fra Oriente e Occidente,<br />
a passare dalla Murgia e dalla Terra delle Gravine, sono documentati villaggi rupestri, scavati<br />
o costruiti in superficie. Quasi per una indubitabile connessione fra tecnica e movimenti <strong>di</strong><br />
popolazioni nel Me<strong>di</strong>terraneo; sull’onda <strong>di</strong> una civiltà della pietra, <strong>di</strong> popoli della pietra, che<br />
sapevano dal neolitico in poi: utilizzare la pietra, architettare la pietra, abitare la pietra,<br />
costruire l’estetica del territorio con l’arte della pietra, affrescarla con le figure del proprio<br />
culto non solo in epoca cristiana ma anche con segni <strong>di</strong> arte e fe<strong>di</strong> primor<strong>di</strong>ali.<br />
75
L’ambiente rupestre costituisce la rappresentazione del rapporto fra uomo e pietra, fra Terra<br />
Madre e le sue Caverne. Così come il tholos-trullo, la proiezione verso l’alto, il cielo: il suo<br />
essere aria, vento, luce, espansione verso il cosmo, le stelle <strong>di</strong> cui le civiltà del Me<strong>di</strong>terraneo<br />
dai Sumeri, agli Egizi, ai Greci, agli Arabi sono stati stu<strong>di</strong>osi appassionati.<br />
Il patrimonio culturale è un elemento della storia materiale e immateriale che può restare<br />
muto, o ad<strong>di</strong>rittura restare vittima dell’incomprensione. Ciò che dà voce al paesaggio<br />
culturale delle Gravine e alla Murgia dei Trulli, è la consapevolezza ecologica ambientale e<br />
antropologica culturale della sua popolazione. La ricostruzione della storia ambientale, da una<br />
parte, e <strong>di</strong> quella agraria, architettonica, artistica, dall’altra, sono elementi essenziali, affinché<br />
all’interno <strong>di</strong> un territorio, <strong>di</strong> questo territorio, si possa instaurare una soggettività culturale<br />
nuova e pertanto <strong>di</strong> rapporto fra il proprio passato e il presente. Da qui la riconciliazione<br />
valoriale con la tra<strong>di</strong>zione e l’elaborazione <strong>di</strong> una propria idea <strong>di</strong> modernità. In questa<br />
<strong>di</strong>rezione uno dei fattori più importanti è dato dal rapporto <strong>di</strong> conoscenza, <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa e <strong>di</strong> cura<br />
delle caratteristiche e qualità del proprio territorio. Capire che il processo <strong>di</strong> se<strong>di</strong>mentazione<br />
del paesaggio e dei suoi elementi sensibili non sono un dato casuale ma parte <strong>di</strong> un processo<br />
<strong>di</strong> rapporti storici che nel tempo e nello spazio hanno determinato l’esistente, e costituiscono i<br />
se<strong>di</strong>menti sui cui riposano le “preesistenze” dell’affermazione identitaria locale.<br />
In questo processo non si mette in moto solo un meccanismo complesso complicato e<br />
molteplice del tutto simile a una reazione chimica <strong>di</strong> più elementi: fisici, tecnologici,<br />
economici, umani; ma la presenza stessa del paesaggio modellato dalla natura e<br />
dall’intervento dell’uomo <strong>di</strong>venta a sua volta l’effetto sensibile <strong>di</strong> un feed back, che determina<br />
il carattere e le scelte sotto ogni aspetto dei suoi abitanti. Seguendo queste in<strong>di</strong>cazioni degli<br />
stu<strong>di</strong> e delle acquisizione della nuova antropologia e scienza della natura, sia l’Unesco sia la<br />
Regione Puglia hanno fatto coincidere la propria volontà e decisione Politica. Il Parco della<br />
Terra delle Gravine deve costituire una volontà <strong>di</strong> consapevolezza e <strong>di</strong> risorsa per la sua<br />
gente. Per ciò: il fondamento <strong>di</strong> un nuovo futuro, che in particolare nella Terra ionica e nella<br />
<strong>Provincia</strong> <strong>di</strong> <strong>Taranto</strong> devono costituire qualcosa <strong>di</strong> più <strong>di</strong> una acquisizione culturale per<br />
<strong>di</strong>ventare un progetto pedagogico e sociale <strong>di</strong> cambiamento. In effetti in questo territorio il<br />
patrimonio ambientale, ecologico e artistico è entrato in forte contrasto con i fattori <strong>di</strong> degrado<br />
e <strong>di</strong> depressione. La presenza del IV Centro Siderurgico d’Europa, il suo carico <strong>di</strong><br />
inquinamento, l’occupazione <strong>di</strong> parte del territorio <strong>di</strong> servitù militari, fanno <strong>di</strong> <strong>Taranto</strong> un<br />
territorio a rischio non solo sul piano ambientale ma anche psicologico e sociale. Il Parco<br />
Terra delle Gravine costituisce per ciò un fondamento <strong>di</strong> politica territoriale, ambientale e<br />
culturale per ricostruisce un orizzonte <strong>di</strong> consapevolezza, <strong>di</strong> inversione <strong>di</strong> tendenza ecoambientale,<br />
ma anche culturale.<br />
Perché questo accada: occorrono stu<strong>di</strong>, reporter, come questo che vi sottoponiamo, - ma,<br />
anche - capacità <strong>di</strong> in<strong>di</strong>care, a tutto il territorio, ai loro amministratori, alla classe intellettuale,<br />
agli impren<strong>di</strong>tori, ai giovani, agli agricoltori, ai suoi uomini, uno per uno, la portata della<br />
partita in gioco. Non tentennare nel <strong>di</strong>re che il Parco Regionale delle Gravine, costituisce per<br />
la <strong>Provincia</strong> <strong>di</strong> <strong>Taranto</strong> una grande opportunità per Ricominciare il Futuro. La base <strong>di</strong> una<br />
ricchezza irripetibile là, sotto i nostri occhi, e che ancora, come la famosa lettera smarrita in<br />
molti dovranno finalmente vedere.<br />
Qualcuno con uno slogan <strong>di</strong>ce che il mondo sarà salvato dalla bellezza. Bene. Noi cre<strong>di</strong>amo<br />
che questo possa non essere solo uno slogan e che costituisca, invece, un ragionamento<br />
importante e un’opportunità concreta per il nostro territorio.<br />
Il patrimonio naturale e culturale delle Gravine è un bene irripetibile e <strong>di</strong> straor<strong>di</strong>naria portata<br />
per la popolazione della provincia <strong>di</strong> <strong>Taranto</strong>. La sua conservazione e la sua valorizzazione<br />
non è calcolabile in termini economici. Nei significati metafisici, invece, supera ogni capacità<br />
<strong>di</strong> immaginazione e coincide con la storia stessa della Terra Ionica.<br />
76
Di seguito vengono descritte le valenze archeologiche, architettoniche e culturali <strong>di</strong> ciascun<br />
comune.<br />
2.14.1. Comune <strong>di</strong> Castellaneta<br />
Nel territorio <strong>di</strong> Castellaneta sono presenti numerose gravine, , la più imponente delle quali è<br />
quella denominata Gravina <strong>di</strong> Castellaneta, che nasce dalla confluenza <strong>di</strong> due modesti solchi<br />
erosivi: il Canale Jummo e il Fosso Gravina <strong>di</strong> San Benedetto.<br />
Testimonianze del Paleolitico Me<strong>di</strong>o provengono da Cava Ciulli, nella Gravina <strong>di</strong> S. Stefano,<br />
da Contrada Le Grotte, da Canale Rochira, nei pressi della Gravina <strong>di</strong> S. Nicola <strong>di</strong> Lizzano;<br />
dalla zona <strong>di</strong> Masseria Greco o Tarallo.<br />
All'età eneolitica invece si possono attribuire le stazioni <strong>di</strong> Masseria Gigante, <strong>di</strong> Montecamplo<br />
e <strong>di</strong> Murgia S. Benedetto.<br />
La gravina del Porto, ai confini con l’agro <strong>di</strong> Gioia del Colle, è interessante dal punto <strong>di</strong> vista<br />
storico-archeologico come testimonianza <strong>di</strong> popoli che vi hanno abitato dal paleolitico sino ad<br />
età classica ed ellenistica.<br />
Le fonti documentarie rinvenute attestano che l’attuale centro <strong>di</strong> Castellaneta si sviluppa<br />
nell'alto Me<strong>di</strong>oevo lungo la singolare gravina <strong>di</strong> origine carsica. La città fu sotto la <strong>di</strong>nastia<br />
normanna fino al XIV secolo circa, quando poi fu donata da Enrico VI <strong>di</strong> Svevia<br />
all’arcivescovo <strong>di</strong> <strong>Taranto</strong>.<br />
Sono tre gli inse<strong>di</strong>amenti rupestri ben visibili: il primo nella Gravina Mater Christi; il secondo<br />
nella Gravina <strong>di</strong> S. Stefano; il terzo nella già citata ripida gravina che costeggia a oriente il<br />
centro abitato.<br />
Il primo inse<strong>di</strong>amento si può ipotizzare un inse<strong>di</strong>amento misto monastico-civile, vista la<br />
presenza <strong>di</strong> numerose grotte e <strong>di</strong> chiese rupestri, il secondo è stato considerato dagli stu<strong>di</strong>osi<br />
come un inse<strong>di</strong>amento eremitico-anacoretico e in seguito pastorale; il terzo infine è<br />
caratterizzato esclusivamente da santuari votivi e per l'asperità del territorio non appare adatto<br />
all'inse<strong>di</strong>amento umano.<br />
Delle chiese rupestri si ricordano: Chiesa rupestre del Padre Eterno, Chiesa rupestre <strong>di</strong> S.<br />
Maria <strong>di</strong> Costantinopoli, Chiesa rupestre <strong>di</strong> S. Maria Mater Christi, Chiesa rupestre <strong>di</strong> S.<br />
Stefano I, Chiesa rupestre <strong>di</strong> S. Maria del Pesco, Chiesa rupestre <strong>di</strong> S. Lucia, Chiesa rupestre<br />
<strong>di</strong> S. Stefano II o S. Michele Arcangelo, Chiesa rupestre <strong>di</strong> S. Stefano III.<br />
Nel territorio <strong>di</strong> Castellaneta sono più <strong>di</strong> cento le masserie storiche, costruite prima del 1930;<br />
<strong>di</strong> queste la metà erano già presenti, anche se non nelle forme attuali fin dal ‘700. Esse<br />
presentano tipologie e strutture architettoniche alquanto <strong>di</strong>versificate: dalle masseria<br />
fortificate a quelle a corte chiusa o compatte, ed ancora dalle masserie più semplici a quelle<br />
strutturate a villaggio.<br />
Di seguito si riportano alcune tra le Masserie più significati sotto il profilo architettonico e<br />
storico-culturale.<br />
Masseria Minerva<br />
Rappresenta un importante inse<strong>di</strong>amento, già frequentato in età neolitica e protostorica, ove è<br />
stato in<strong>di</strong>viduato un abitato <strong>di</strong> età ellenistico-romana, oltre alle strutture <strong>di</strong> un ponte romano.<br />
Masseria Del Vecchio Nuova<br />
77
Strutturata secondo la tipologia a corte chiusa, la casa padronale conserva quasi inalterato il<br />
suo aspetto originario.Sul prospetto esterno del muro <strong>di</strong> cinta è posto un portale alla cui<br />
sommità si erge una colombaia.<br />
Masseria Patarino<br />
Posta a 36 metri s.l.m. a sud <strong>di</strong> Castellaneta è ubicata nelle imme<strong>di</strong>ate vicinanze della Lama.<br />
La masseria risulta strutturata in un unico corpo a corte aperta che si sviluppa su due piani.<br />
Masseria S.Domenico alle Matine<br />
Posta in contrada Matine, la sua epoca <strong>di</strong> costruzione risale al ‘700. La struttura architettonica<br />
tipica delle masserie “fortificate” è caratterizzata dalla garitta posta sul prospetto del corpo<br />
centrale a due piani.<br />
Masseria del Porto<br />
La struttura si articola in un villaggio rurale <strong>di</strong> notevole interesse architettonico e<br />
paesaggistico che si caratterizza per la presenza della chiesetta.<br />
Masseria Giacoia<br />
La struttura si sviluppa secondo una tipologia a corte chiusa con casa padronale al primo<br />
piano. Il villaggio rurale si caratterizza per la presenza <strong>di</strong> una chiesetta posta a piano rialzato.<br />
Masseria Casone<br />
Posta ad est <strong>di</strong> Castellaneta a 300 m s.l.m. è interamente realizzata in carparo e si sviluppa su<br />
due piani realizzati in tempi <strong>di</strong>versi. Di particolare pregio dal punto <strong>di</strong> vista paesaggistico per<br />
la sua ubicazione, fu anticamente un casone <strong>di</strong> transumanza.<br />
2.14.2. Comune <strong>di</strong> Crispiano<br />
Il territorio <strong>di</strong> Crispiano è stato abitato fin dalla preistoria, come testimoniato dai ritrovamenti<br />
archeologici effettuati nelle località <strong>di</strong> Tumarola, Cigliano e Triglie, da cui si è stabilito che le<br />
origini <strong>di</strong> Crispiano sono da far risalire ad un periodo molto più antico <strong>di</strong> quello “romano”<br />
voluto dalla tra<strong>di</strong>zione locale.<br />
In epoca greca risulta intensamente abitato soprattutto nella contrada <strong>di</strong> Triglio e<br />
Cacciagualani, mentre in epoca romana rimane la memoria <strong>di</strong> due gran<strong>di</strong> aziende agricole in<br />
contrada Lupoli.<br />
Distrutta più volte dalle invasione dei barbari, la sua prima ricostruzione si deve alla presenza<br />
dei monaci brasiliani che impiantarono numerosi inse<strong>di</strong>amenti civili e monastici. La maggiore<br />
testimonianza <strong>di</strong> questi inse<strong>di</strong>amenti, è presso la gravina <strong>di</strong> Triglio, che fu sede per molto<br />
tempo <strong>di</strong> popolazioni messapiche. Si tratta <strong>di</strong> un inse<strong>di</strong>amento costituito da molte case grotte<br />
a due vani.<br />
Il centro <strong>di</strong> tale inse<strong>di</strong>amento è rappresentato dalla Chiesa <strong>di</strong> San Michele Arcangelo,<br />
e<strong>di</strong>ficata all’inizio del 1700 sopra l’antico tempio de<strong>di</strong>cato ad una dea greca.<br />
Posto a breve <strong>di</strong>stanza da tale inse<strong>di</strong>amento si trova Cubiculum Santi Juliani o <strong>di</strong> San<br />
Cipriano, chiesa cripta ricca un tempo <strong>di</strong> affreschi oggi purtroppo manomessi.<br />
Altri inse<strong>di</strong>amenti si rinvengono a nord, nella gravina <strong>di</strong> Alezza, un inse<strong>di</strong>amento composto<br />
da un gruppo <strong>di</strong> una ventina <strong>di</strong> grotte in parte scavate nella roccia tufacea, in parte <strong>di</strong> origine<br />
naturale, e nella parte terminale della stessa gravina, nella zona in cui essa viene a formare il<br />
Vallone, costituito da un numero elevato <strong>di</strong> grotte, in parte compromesso dallo sviluppo<br />
78
urbano del territorio <strong>di</strong> Crispiano, i cui reperti testimoniano che l’origine <strong>di</strong> tale inse<strong>di</strong>amento<br />
deve farsi risalire all’età me<strong>di</strong>oevale.<br />
Il territorio <strong>di</strong> Crispiano <strong>di</strong>venne posse<strong>di</strong>mento feudale dell’Abbazia <strong>di</strong> San Vito del Pizzo e<br />
poi delle Abbazie <strong>di</strong> Santa Maria del Galeso che possedeva i Casali <strong>di</strong> San Simone e Cigliano<br />
e <strong>di</strong> Santa Maria <strong>di</strong> Crispiano.<br />
L’Abbazia <strong>di</strong> Santa Maria <strong>di</strong> Crispiano sorgeva intorno al masso tufaceo fortificato<br />
denominato “Castello” e possedeva, oltre al Casale <strong>di</strong> Cristiano, un estesissimo territorio che<br />
giungeva fino al monte Sant’Elia ed abbracciava buona parte del territorio martinese.<br />
Nello stesso Casale, oltre alla presenza <strong>di</strong> un Castello risalente probabilmente all’età<br />
federiciana e <strong>di</strong> cui permangono solo poche tracce, è da rilevare la Chiesa <strong>di</strong> Sant’Angelo<br />
attualmente denominata “Chiesa Vecchia”. Nel corso del settecento fu trasformata nella<br />
cappella <strong>di</strong> Santa Maria <strong>di</strong> Crispiano.<br />
Ancora da ricordare è l’inse<strong>di</strong>amento posto nella gravina <strong>di</strong> Cigliano oggi denominato Porcile<br />
e comprendente anche un convento. Nelle imme<strong>di</strong>ate vicinanze è presente un pozzo scavato<br />
nella roccia all’interno del quale sfocia un tunnel sotterraneo che, costruito in epoca romana,<br />
serviva ad alimentare <strong>di</strong> acqua la città <strong>di</strong> <strong>Taranto</strong>.<br />
Numerose sono le Masserie presenti nel territorio <strong>di</strong> Crispiano. La tipologia della Masseria<br />
che si presenta isolata e fortificata da muri bianchi <strong>di</strong> cinta, è quella a corte chiusa<br />
autosufficiente e strutturata per poter accogliere le stalle, i magazzini per gli attrezzi e per le<br />
scorte alimentari necessarie per affrontare l’isolamento e la vita quoti<strong>di</strong>ana, ed infine la casa<br />
vera e propria.<br />
Di seguito si riportano alcune delle Masserie ritenute più significative sotto il profilo storico –<br />
architettonico: Vallenza Mongelli, Vallenza Martucci, Vallenza Ricci, Le Mesole, Pizzica,<br />
Calvello, Caccavella, Fanelli, Miola, Mesolicchie, Colucci, villino Pavone, Li Russoli,<br />
Cigliano, Me<strong>di</strong>nicchio, Lazzo <strong>di</strong> Orimini, Scorace, Lezza, Mortella, Casanuova, Comiteo,<br />
Casanuova, Mortello, Fogliano, La Scorcola. Lupoli, San Simone o Motulese.<br />
2.14.3. Comune <strong>di</strong> Ginosa<br />
Il territorio <strong>di</strong> Ginosa risulta popolato da epoca assai antica (centro in<strong>di</strong>geno peuceta e<br />
successivamente municipio romano) come testimoniato da numerosi ritrovamenti<br />
archeologici. Già noto nell’800 per rinvenimenti fortuiti <strong>di</strong> vasi e monete (CAPURSO 1985),<br />
dagli inizi del 1900 ai giorni nostri ha restituito una ricchissima documentazione archeologica,<br />
proveniente da <strong>di</strong>verse zone del centro abitato e da aree limitrofe ad esso, pertinenti l’abitato e<br />
in particolare la necropoli peuceta (Località Stornara Panatano, Località Chiaradonna-tenuta<br />
Girifalco, Via Salento-Contrada Cappuccino, Contrada Frisino presso km 34 S.S. <strong>Taranto</strong>-<br />
Metaponto, Palazzo Comunale, Area del Cimitero, Contrada Lama, Lama del Pozzo-Masseria<br />
Girifalco) (cfr. GIANNOTTA 1990; DELL’AGLIO-LIPPOLIS, s. d.).<br />
Fu poi interessato dalla civiltà rupestre che si <strong>di</strong>ffuse largamente. Gli inse<strong>di</strong>amenti rupestri <strong>di</strong><br />
Ginosa sono ubicati nelle Gravine <strong>di</strong> Rivolta e del Casale e fanno parte del profondo burrone<br />
che circonda a ferro <strong>di</strong> cavallo l'attuale abitato.<br />
79
Numerose sono le chiese rupestri presenti presso la gravina <strong>di</strong> Rivolta: la Cripta <strong>di</strong> Eliseo,<br />
resti <strong>di</strong> una chiesa rupestre; la chiesa <strong>di</strong> Santa Sofia I, scavata nel fianco orientale della<br />
gravina, si trova nelle vicinanze della più recente chiesa <strong>di</strong> Santa Sofia, inserita in un<br />
complesso <strong>di</strong> grotte ora <strong>di</strong>strutte; la chiesa <strong>di</strong> Santa Sofia II , descritta da VENDITTI 1968,<br />
riferibile probabilmente al tardo 1600 e occupò il posto della <strong>di</strong>strutta Santa Sofia I; anche gli<br />
affreschi presenti sono <strong>di</strong> epoca recente; la chiesa <strong>di</strong> Santa Barbara del XIII sec. d.C.; la<br />
chiesa <strong>di</strong> San Marco del XII sec. d.C.; la chiesa <strong>di</strong> Santa Caterina; la chiesa <strong>di</strong> San<br />
Bartolomeo decorata da numerosi affreschi; la chiesa rupestre “a capanna” definita così dal<br />
VENDITTI per la particolare foggia della copertura, costituita da soffitto profilato a due falde.<br />
Localizzate nella gravina <strong>di</strong> Casale si ricordano le chiese rupestri: chiesa <strong>di</strong> Santa Domenica,<br />
datata XII-XIII sec. d.C. e caratterizzata da numerosi affreschi; la chiesa rupestre dell’Ecce<br />
Homo del XIII sec. d.C.; la chiesa dell’Anonima; la chiesa <strong>di</strong> San Vito Vecchia; la chiesa dei<br />
Santi Me<strong>di</strong>ci da tempo <strong>di</strong>strutta, la chiesa <strong>di</strong> San Leonardo e la chiesa <strong>di</strong> San Pietro.<br />
Le masserie rappresentano un prezioso esempio dell’architettura del passato, testimonianza<br />
inse<strong>di</strong>ativa che iniziò a svilupparsi a partire dal 1500 e conobbe la sua massima espansione<br />
nel ‘700 e nel‘800. Le masserie del territorio <strong>di</strong> Ginosa rappresentano dei veri e propri<br />
“castrum“ fortificati dotati <strong>di</strong> torri interne, corti e muniti <strong>di</strong> sistemi <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa.<br />
Tra le Masserie <strong>di</strong> rilevanza storico architettonica sono da ricordare: Masseria Girifalco una<br />
delle più significative presenti nell’area delle gravine dell’arco jonico. La parte più antica<br />
(risalente al X-XI sec.) è costituita dall’alta torre, il complesso rurale fu ampliato nel ‘500 e<br />
nel ’700 e mo<strong>di</strong>ficato nell’‘800 e si configura come un palazzo-castello dotato <strong>di</strong> corte chiusa,<br />
abitazione padronale, cappella, locali, vaste cisterne per il recupero delle acque piovane e<br />
numerose feritoie <strong>di</strong>sseminate su quasi tutti gli e<strong>di</strong>fici; Masseria Peppariello e Masseria<br />
Follerato.<br />
2.14.4. Comune <strong>di</strong> Laterza<br />
Laterza ha origini antichissime come testimoniano in particolare i ritrovamenti emersi da una<br />
serie <strong>di</strong> scavi in località Can<strong>di</strong>le testimonianze relative alla facies <strong>di</strong> età eneolitica. La<br />
necropoli risale al 2000 a.C. Laterza ha subito l'influenza dei greci e dei romani: molti i<br />
reperti dell'epoca della Magna Grecia e dell'età romana.<br />
Resti <strong>di</strong> abitati databili al IV secolo a.C. sono stati in<strong>di</strong>viduati in Località Purgatorio e<br />
Panzanella; una necropoli <strong>di</strong> IV-III sec. a.C. è stata in<strong>di</strong>viduata in Località Facce Rossole;<br />
rinvenimenti vari si segnalano in Contrada Masseria Di Lena mentre un ricco corredo<br />
tombale fu rinvenuto in Contrada Masseria Panettiere.<br />
Gli inse<strong>di</strong>amenti rupestri sono in<strong>di</strong>viduabili in due zone: a sud del centro urbano attuale, tra<br />
via Aborigeni, contrada Verdazzi e la fontana vecchia e a nord nel tratto <strong>di</strong> gravina che si<br />
snoda lungo il corso principale, piazza Municipio e la chiesa <strong>di</strong> San Vito.<br />
La sovrapposizione in varie fasi <strong>di</strong> strutture urbanistiche successive, non consentono una<br />
lettura molto chiara del primitivo impianto urbanistico rupestre, notevolmente compromesso<br />
anche dalla natura friabile del tessuto caveoso e dalle infiltrazioni <strong>di</strong> acque naturali.<br />
Si segnalano le seguenti Chiese e cripte:<br />
‣ Chiesa rupestre San Vito del XVI secolo è sita in contrada Selva San Vito, sul ciglio della<br />
gravina, a poca <strong>di</strong>stanza dal centro abitato.<br />
80
‣ Chiesa della Mater Domini ha impianto basilicale comprendente due parti: un atrio con<br />
rientranze e nicchie alle pareti e un'aula a tre navate, delle quali quella centrale è absidata e<br />
<strong>di</strong>visa in tre campate da pilastri ed archi, decorata con affreschi.<br />
‣ Chiesa rupestre <strong>di</strong> San Giovanni Battista, inserita nel complesso caveoso che assume il<br />
nome <strong>di</strong> Laura <strong>di</strong> San Giovanni Battista, è ubicata alle spalle del Santuario Mater Domini.<br />
‣ Chiesa rupestre Cristo Giu<strong>di</strong>ce nel catino absidale è raffigurata un Desis con Cristo<br />
Pantocratore e San Giovanni Battista.<br />
‣ Chiesa rupestre San Giacomo costituita da due parti: la parte più antica, la chiesa ipogea <strong>di</strong><br />
San Giacomo I, nella quale sono stati rinvenuti "Il Giu<strong>di</strong>zio Universale" ed un affresco<br />
raffigurante il pellegrinaggio <strong>di</strong> tre pellegrini al santuario <strong>di</strong> Campostela; la chiesa<br />
semipogea <strong>di</strong> San Giacomo II, verso il gradone della gravina, nella quale è possibile<br />
ammirare l'affresco <strong>di</strong> Santo Bene<strong>di</strong>cente. Chiese rupestri in contrada Santa Caterina I e II<br />
‣ Chiesa rupestre <strong>di</strong> San Leucio costituita da due vani rettangolari. Al suo interno si trovano<br />
due affreschi, uno raffigurante Sant'Antonio Abate e l'altro San Leucio.<br />
‣ La cantina Spagnola o "grotta dei Mammoci", chiese rupestre del XVII secolo è' l'unica<br />
grotta in cui le raffigurazioni affrescate sono completate da sculture in altorilievo.<br />
Per quanto riguarda la presenza <strong>di</strong> masserie si ricordano: Masseria Cangiulli, ubicata a sud <strong>di</strong><br />
Laterza posta tra la Gravina del Varco e quella <strong>di</strong> Laterza, la struttura si caratterizza per<br />
l’ampia grotta interamente scavata nel tufo e per la torre colombaia; Masseria Scivolizzo, si<br />
apre sul bosco <strong>di</strong> Selva S.Vito e la struttura che si caratterizza per lo Jazzo recintato da<br />
muretti a secco; Masseria Can<strong>di</strong>le; Jazzo Di Cristo che si caratterizza per lo Jazzo i cui<br />
ricoveri, risultano interamente scavati nella roccia tufacea e Masseria Cicciogallo.<br />
2.14.5. Comune <strong>di</strong> Massafra<br />
Le testiminianze della Civiltà Rupestre sono presenti in quasi tutto il territorio <strong>di</strong> Massafra,<br />
sia nel centro abitato che in campagna.<br />
All’interno delle gravine sono spesso presenti grotte e cripte, per lo più riconducibili ad un<br />
periodo compreso tra il VII e il XIII sec. d.C.<br />
Qui le prime comunità cristiane e i primi luoghi <strong>di</strong> culto secondo la tra<strong>di</strong>zione sarebbero sorti<br />
a seguito del passaggio degli Apostoli Pietro, Paolo e Marco. Luoghi <strong>di</strong> culto ed eremitaggi,<br />
piccole laure o monasteri più organizzati sorsero nel tempo dentro e fuori i villaggi rupestri,<br />
ciascuno con propria autonomia religiosa, con una propria economia basata sul lavoro dei<br />
campi, sulla pastorizia e sullo scambio delle merci.<br />
Il centro urbano <strong>di</strong> Massafra è infatti sorto come evoluzione delle preesistenti grotte ipogee,<br />
pertanto per millenni sono convissuti modelli molto <strong>di</strong>fferenti fra loro, dai primi inse<strong>di</strong>amenti<br />
rupestri, a quelli del borgo antico sino ad arrivare al moderno centro abitato.<br />
Fra le testimonianze <strong>di</strong> questi inse<strong>di</strong>amenti rupestri vicinanziali, che fanno <strong>di</strong> Massafra una<br />
città assimilabile al Vicino Oriente, a province delle Cappadocia, si ricordano:<br />
‣ nella Gravina <strong>di</strong> San Marco, che limita ad oriente il borgo antico <strong>di</strong> Massafra si trovano<br />
due antichissime chiese rupestri: Chiesa de<strong>di</strong>cata ai SS. Pietro e Paolo, sita ai pie<strong>di</strong> del<br />
Castello, Chiesa de<strong>di</strong>cata a San Marco, posta nel tratto <strong>di</strong> gravina che da levante guarda il<br />
ponte nuovo. Altre chiese rupestri in località Gravina <strong>di</strong> San Marco sono Para<strong>di</strong>so <strong>di</strong><br />
Massafra, sagrato antistante la cripta <strong>di</strong> S. Marina, Chiesa della Candelora del XIII sec.<br />
81
d.C. con segni architettonici riferibili alle chiese a cupole multiple note a costantinopoli e<br />
che si ritrovano nella Cappadocia nelle chiese rupestri a colonna, ricca nell’apparato<br />
iconografico; Cripta <strong>di</strong> San Marco;<br />
‣ un complesso <strong>di</strong> grotte <strong>di</strong>sposte su sei piani, caratterizzato da una quinta triangolare,<br />
ubicato <strong>di</strong> fronte al Castello, denominate Casa dell’Igumeno. Le grotte sono in gran parte<br />
intercomunicanti, e recano giacitoi, sulle pareti nicchie per lucerne o ripostiglio, sulle volte<br />
lucernari, con carattere <strong>di</strong> laura-cenobio. La <strong>di</strong>mora principale, la Casa dell’Igumeno, ha<br />
perso la parte anteriore a causa <strong>di</strong> franamenti: l’ingresso principale è contrad<strong>di</strong>stinto da un<br />
timpano triangolare (come nei cenobi orientali), e da esso si accede ad altri ambienti tra cui<br />
una sala con cisterna. Al complesso si accede attraverso una Passeggiata Archeologica<br />
realizzata nel 1959;<br />
‣ grotte e caverne presso la gravina Madonna della Scala, anticamente denominata “Valle<br />
delle Rose”, che costituisce un articolato villaggio rupestre rimasto in uso almeno sino ai<br />
primi decenni del ‘300. Le grotte destinate ad abitazione sono per lo più ad uno o due vani,<br />
con un’altezza che non supera in me<strong>di</strong>a m 2,50, con focolari a lato dell’ingresso, con<br />
nicchie per l’alloggio <strong>di</strong> piccoli torchi familiari o <strong>di</strong> recipienti per la conservazione degli<br />
alimenti e dell’acqua, raramente presentano piccole finestre. Le cisterne sono sempre<br />
esterne, poste <strong>di</strong> fronte all’ingresso, ad uso verosimilmente collettivo, ed esterni, sotto<br />
roccia, sono anche i ricoveri per il bestiame. Il monumento più importante è il Santuario<br />
della Madonna della Scala;<br />
‣ la Gravina <strong>di</strong> Sant’Angelo è una <strong>di</strong>ramazione della Gravina della Madonna della Scala e<br />
contiene un piccolo complesso <strong>di</strong> abitazioni rupestri. Sulle pareti <strong>di</strong> alcune <strong>di</strong> queste grotte<br />
si conservano graffiti che rappresentano navi <strong>di</strong> tipo me<strong>di</strong>evale (in<strong>di</strong>viduate come agazie o<br />
taride, navi onerarie del primo periodo <strong>di</strong> Bisanzio), croci e tracce <strong>di</strong> iscrizioni greche. Qui<br />
è presente il complesso ipogeo <strong>di</strong> Sant’Angeo a Torrella dell’XI sec. d.C.<br />
‣ Sulle sponde della gravina Millarti sono riconoscibili un complesso <strong>di</strong> grotte e una chiesa<br />
rupestre. Nell’area è stata segnalata la presenza <strong>di</strong> un dolmen e <strong>di</strong> una specchia “con due<br />
tombe a cassone già violate” (segnalazione Archeogruppo <strong>di</strong> Massafra, 1972).<br />
Le Masserie sparse nel territorio <strong>di</strong> Massafra hanno per la maggior parte dei casi tipologia a<br />
corte chiusa o aperta, e presentano una struttura assai <strong>di</strong>versificata: alcune <strong>di</strong> esse sono infatti<br />
a “lamia”, altre a “trullo”.<br />
Tra le Masserie più importanti sono da rilevare la Masseria del Varcaturo per i ritrovamenti<br />
archeologici rinvenuti nel suo comprensorio e la Masseria del Monte S.Elia per l’importanza<br />
della sua ubicazione nell’area del monte omonimo.<br />
2.14.6. Comune <strong>di</strong> Mottola<br />
Sin dagli inizi del ‘700, numerose fonti storico-geografiche in<strong>di</strong>cano un’origine greca <strong>di</strong><br />
Mottola, ma tali ipotesi non sono avvalorate da dati archeologici, tuttavia l’abitato antico ha<br />
restituito materiali che hanno fatto presupporre l’esistenza <strong>di</strong> un abitato in<strong>di</strong>geno iapigio,<br />
ellenizzato forse nel corso del VI sec. a.C.<br />
82
La città <strong>di</strong> Mottola vanta un’eccezionale patrimonio storico, architettonico ed artistico<br />
rappresentato dagli inse<strong>di</strong>amenti rupestri d'età me<strong>di</strong>oevale che costellano il suo territorio<br />
rurale come il villaggio <strong>di</strong> Petruscio, presso la gravina omonima, e le numerose chiese.<br />
Lo straor<strong>di</strong>nario abitato <strong>di</strong> Petruscio non è stato mai cancellato da eventi antropici quali<br />
guerre, incursioni e devastazioni o da eventi naturali, terremoti, frane, alluvioni e le case, gli<br />
opifici, i luoghi sacri che per circa 2 km. si affacciano nella gravina, sono ancora visibili.<br />
La presenza della Torre <strong>di</strong> Petruscio è segnata dal Rizzi-Zanoni all’imboccatura della gravina<br />
e all’altezza della biforcazione verso la gravina (<strong>di</strong> Petruscio) e verso Mottola della strada<br />
proveniente da Massafra. Oggi il manufatto è ridotto ad un cumulo <strong>di</strong> macerie<br />
Il villaggio rupestre è forse riconducibile al IX sec. d.C e ne fanno parte: Chiesa rupestre<br />
detta "<strong>di</strong> Bufalo Petrusci”, Chiesa rupestre del greppo est, Chiesa rupestre detta la<br />
Cattedrale <strong>di</strong> Petruscio, Chiesa rupestre nei pressi <strong>di</strong> Masseria Scarano, Chiesa rupestre <strong>di</strong><br />
S. Marco, Chiesa rupestre in località Gravina <strong>di</strong> Forcella<br />
La presenza delle Masserie nel territorio <strong>di</strong> Mottola è sicuramente da ricollegare ad un<br />
periodo compreso nell’arco <strong>di</strong> circa duecento anni a cavallo tra la metà del XVII e la metà del<br />
XVIII secolo. In questo periodo i duchi realizzarono infatti nell’agro <strong>di</strong> Mottola almeno una<br />
trentina <strong>di</strong> inse<strong>di</strong>amenti agricoli tra i quali i più interessanti sono:<br />
Masseria Colombo: la struttura si caratterizza per la presenza dell’antico jazzo, dell’alto muro<br />
a secco a guardalupo e per una serie <strong>di</strong> vecchi trulli.<br />
Masseria Chiancarello, realizzata nella seconda metà del XVIII, presenta la struttura tipica del<br />
castello, con il terrazzo merlato e quattro torri <strong>di</strong>fensive.<br />
Masseria Casalrotto, e<strong>di</strong>ficata sulle grotte dell’antico casale e sui ruderi <strong>di</strong> un convento<br />
benedettino.<br />
Masseria il Tamburello fu e<strong>di</strong>ficata agli inizi del seicento, nel 1856 la vecchia costruzione<br />
ducale fu ampliata e rinforzata, all’interno dell’area è da rilevare il caratteristico villino<br />
Odaldo, posto a circa 500 metri dalla masseria e realizzato in stile liberty nel 1920.<br />
Tra le masserie non feudali le più significative sono Masseria de L’aglio con annessa cappella<br />
settecentesca <strong>di</strong> particolare pregio e campanile realizzato nel 1856 e Masseria San Francesco,<br />
con annessa cappella realizzata nella seconda metà dell’800 con copertura a botte.<br />
2.14.7. Comune <strong>di</strong> Palagianello<br />
Il territorio <strong>di</strong> Palagianello appare frequentato sin dal XII secolo, anche se la sua gravina ha<br />
restituito tracce <strong>di</strong> frequentazione molto antiche sin dal Paleolitico.<br />
La gravina ospita uno dei più suggestivi villaggi rupestri dell’arco jonico. L’inse<strong>di</strong>amento<br />
rupestre è localizzato a nord-ovest dell'attuale abitato e mostra tutte le caratteristiche <strong>di</strong> un<br />
inse<strong>di</strong>amento civile, nonostante il degrado e la <strong>di</strong>struzione <strong>di</strong> alcuni spalti della gravina, per lo<br />
sfruttamento del calcare come materiale da costruzione, ne abbiano in gran parte<br />
compromesso la visione <strong>di</strong> insieme. Il nucleo meglio conservato è situato alle pen<strong>di</strong>ci<br />
dell'attuale Santuario della Madonna delle Grazie, che probabilmente insiste su una<br />
precedente chiesa rupestre de<strong>di</strong>cata alla Vergine; nella stessa area si trovano anche le Chiese<br />
rupestri <strong>di</strong> San Gerolamo, Sant'Andrea e Santa Lucia.<br />
83
Nel tratto a sud-ovest dell'attuale abitato il paesaggio è più impervio, con il conseguente<br />
rarefarsi delle cavità e l'infittirsi della vegetazione, tuttavia in questa zona comunque si<br />
conservano le chiese rupestri <strong>di</strong> San Nicola e dei Santi Eremiti.<br />
L’abitato grottale <strong>di</strong> Palagianello, non ha subito il declino e l’abbandono degli inse<strong>di</strong>amenti<br />
rupestri rurali nel XIV secolo, ma è tra quei villaggi rupestri sui quali si sono inserite le<br />
strutture dell’architettura spontanea. Infatti, il vivere in domus – grupta è un modello <strong>di</strong> vita<br />
che continuerà anche in età post me<strong>di</strong>oevale, come si desume dalle fonti archivistiche per i<br />
secoli XV e XVI.<br />
Le testimonianze iconografiche rinvenute nelle chiese rupestri riportano ad una fase <strong>di</strong><br />
escavazione alto me<strong>di</strong>oevale.<br />
La chiesa ipogea <strong>di</strong> San Nicola è datata XIII-XIV sec. d.C. <strong>di</strong> pianta trapezoidale con tre<br />
nicchie ortogonali affrescate. L'invaso, strutturalmente databile ad età alto-me<strong>di</strong>oevale,<br />
presenta rimaneggiamenti e decorazioni successive, collocabili ad età basso-me<strong>di</strong>oevale.<br />
La chiesa dei Santi Eremiti ha un impianto architettonico risalente al X sec. d.C, mentre gli<br />
affreschi sono stati datati al XII sec. d.C.<br />
La chiesa <strong>di</strong> Sant’Andrea sorge attualmente isolata e avulsa dal contesto originario e<br />
inaccessibile dall'ingresso primitivo a causa dello sfruttamento e conseguente <strong>di</strong>struzione <strong>di</strong><br />
questo spalto della gravina come cava <strong>di</strong> materiale da costruzione. La chiesa è rimasta<br />
pertanto su vertiginose pareti a picco, a circa 10 metri <strong>di</strong> altezza rispetto al piano della cava<br />
stessa. L'accesso o<strong>di</strong>erno è stato ricavato me<strong>di</strong>ante un'apertura sul lato nord del bema,<br />
raggiungibile per mezzo <strong>di</strong> una lunga gra<strong>di</strong>nata dall'interno <strong>di</strong> un’azienda agricola. L’impianto<br />
architettonico risale al XII- XIII sec. d.C., mentre gli affreschi al XIII sec. d.C.<br />
Si ricordano inoltre: Chiesa rupestre <strong>di</strong> S. Gerolamo, Chiesa rupestre <strong>di</strong> S. Lucia, Chiesa<br />
rupestre "Jazzo Rivolta” e Cripta della Madonna delle Grazie o della Mater Domini.<br />
Sul territorio <strong>di</strong> Palagianello sono documentate <strong>di</strong>ciassette masserie storiche, già presenti<br />
prima del 1810, tra cui si ricordano:Torrata, masseria a corte con accorpamenti <strong>di</strong> volumi e<br />
chiesetta datata al 1762, Serrapizzuta, Parco <strong>di</strong> Stalla, masseria a corte con chiesetta accorpata<br />
a iazzi multipli, il nucleo della masseria era già esistente nella seconda metà del XVII secolo,<br />
Abissinia o Capo Varante, Visolo o Massella, Pozzo <strong>di</strong> Sarro.<br />
2.14.8. Comune <strong>di</strong> Statte<br />
La presenza <strong>di</strong> abitanti nella zona <strong>di</strong> Statte già nella prima metà del II millennio del Neolitico<br />
sembra confermata dalla presenza <strong>di</strong> grotte, dei dolmen <strong>di</strong> Accettulla e <strong>di</strong> Leucapisde e <strong>di</strong><br />
numerose tombe.<br />
I dolmen neolitici sono riconducibili alla me<strong>di</strong>a età del bronzo.Il secondo per importanza in<br />
Puglia, dopo quello <strong>di</strong> Bisceglie, è ubicato nei pressi della Masseria Leucaspide, a poca<br />
<strong>di</strong>stanza della stessa gravina.<br />
All’epoca romana, 123 a.C., risale la costruzione del primo tratto <strong>di</strong> acquedotto romano che si<br />
sviluppa dalla valle del Triglio fino a Statte.<br />
84
Anche se le prime notizie sicure del Casale <strong>di</strong> Statte risalgono al me<strong>di</strong>oevo, la sua nascita è<br />
sicuramente da ricollegare all’epoca della <strong>di</strong>struzione <strong>di</strong> <strong>Taranto</strong> avvenuta nel 927 ad opera<br />
dei Saraceni.<br />
Per quanto riguarda gli inse<strong>di</strong>amenti rupestri <strong>di</strong> Statte essi risultano ubicati nelle gravina posta<br />
ad ovest del centro abitato, che nasce dalla confluenza delle gravine minori <strong>di</strong> l’Amastuola e<br />
Triglie.<br />
Essa prende il nome <strong>di</strong> gravina d’Accetta nella parte superiore, gravina <strong>di</strong> Leucaspide nella<br />
parte interme<strong>di</strong>a e Gravina Gennarini nel tratto finale. Le cripte presenti S. Basilio, <strong>di</strong> S.<br />
Giuliano o S. Cipriano a Triglie e <strong>di</strong> S. Onofrio a To<strong>di</strong>sco sono databili intorno ai secoli XI –<br />
XII.<br />
Le Masserie del territorio <strong>di</strong> Statte sono tra le più belle <strong>di</strong> tutto il territorio dell’arco jonico. Di<br />
seguito si riportano quelle più significative sotto il profilo storico- architettonico: Masseria<br />
To<strong>di</strong>sco, fortificata del XVI –XVII secolo, Masseria Giranda, a corte, Masseria S. Teresa,<br />
Masseria Felicita e Masseria Accetta Grande del XV –XVII secolo, con frantoio del 1700.<br />
2.14.9. Considerazioni<br />
Il progetto deve risponde all’idea <strong>generale</strong> dell’unità <strong>di</strong> questo territorio nella <strong>di</strong>stinzione delle<br />
sue singole eccezionalità. Sicché l’unità non può essere confusa con una totalità generica ma<br />
deve rispettare un racconto d’insieme, dove alla parte corrisponde allo stesso tempo il tutto, e<br />
il tutto contiene le sue parti. In sostanza un territorio come La Terra delle Gravine non può<br />
essere confuso con la somma generica delle sue qualità, ma con il rispetto e l’esaltazione delle<br />
peculiarità. Sono tali valori che determinano nella loro connessione geologica, ambientale e<br />
antropologica l’identità <strong>di</strong> rappresentazione del territorio, all’interno e all’esterno. Nulla può<br />
essere escisso, <strong>di</strong>viso, nascosto, al tempo stesso occorre rintracciare un racconto globale,<br />
l’armonizzazione del tempo Grande e con il tempo Piccolo.<br />
Tutto deve ricercare una valorizzazione integrata fra le <strong>di</strong>verse parti e al tempo stesso far<br />
fluire il feed back della rete e la sua organizzazione. Il coor<strong>di</strong>namento territoriale permette<br />
proposte vantaggiose nella gestione finalizzata e concreta dell’area del Parco.<br />
Lo stu<strong>di</strong>o delle <strong>di</strong>verse località porta la conoscenza circostanziata <strong>di</strong> tutta l’area.<br />
Identificazione <strong>di</strong> habitat. Architetture. Carte dei valori. Analogie sul piano regionale,<br />
nazionale ed internazionale. Quadri interpretativi dei fenomeni in<strong>di</strong>viduati. Misure <strong>di</strong><br />
salvaguar<strong>di</strong>a e prescrizioni particolari. Recupero della tra<strong>di</strong>zione materiale e immateriale.<br />
Composizioni <strong>di</strong> archivi documentali e fotografici. Biblioteche e musei. Partecipazione a<br />
mostre, fiere, campagne <strong>di</strong> immagine, marchi <strong>di</strong> qualità per prodotti Doc e Dop agricoli e<br />
artigianali, itinerari stabiliti etc..<br />
<strong>Taranto</strong>, la sua terra, i suoi villaggi rupestri in gravine, i trulli della sua Murgia, nei millenni<br />
hanno intercettato e restituito, accolto ed elaborato: culture, nature, movimenti <strong>di</strong> popolazioni,<br />
saperi, conoscenze e civiltà da una riva all’altra del Me<strong>di</strong>terraneo Sicché il territorio delle<br />
Gravine e quello della Murgia dei Trulli sono stati da sempre territori in movimento: arrivi,<br />
partenze, ritorni. Ciò che in esso si è attestato ha perciò ra<strong>di</strong>ci aperte e molteplici ma anche<br />
capacità <strong>di</strong> ra<strong>di</strong>camento profondo. In questo gioco sì è prodotto il miracolo del Paesaggio, la<br />
sua rappresentazione <strong>di</strong> civiltà e storia, il mettersi in contatto con la natura del territorio, la<br />
sua geologia, le sue forme, la sua sensibilità.<br />
Miracolo irrepetibile che oggi ogni uomo del Rupestre e dei Trulli dovrebbe avere a cuore e in<br />
mente come segno del tutto: frutto del racconto d’insieme <strong>di</strong> questa Terra e al tempo stesso<br />
85
fondamento della Politica <strong>di</strong> salvaguar<strong>di</strong>a e <strong>di</strong> valorizzazione che la <strong>Provincia</strong> <strong>di</strong> <strong>Taranto</strong> e<br />
l’Assessorato alle aree protette vuole varare per questo Territorio.<br />
2.15. Il paesaggio<br />
Il paesaggio può essere inteso come luogo <strong>di</strong> aggregazione del mondo fisico, formato da un<br />
complesso <strong>di</strong> beni ambientali e antropico-culturali e dalle relazioni che li correlano.<br />
L’analisi del paesaggio, è legata al rapporto tra oggetto (il territorio) e soggetto (l’osservatore);<br />
da questo rapporto, nasce il legame percettivo <strong>di</strong> cui è sfondo il paesaggio.<br />
Definire il paesaggio le sue componenti, è operazione complessa.<br />
Oggetto <strong>di</strong> molteplici stu<strong>di</strong>, interpretazioni, <strong>di</strong>scussioni, tale definizione non può che essere<br />
"convenzionale”, correlata cioè al contesto "<strong>di</strong>sciplinare” (inteso come settore culturale e/o<br />
operativo) entro cui essa stessa si colloca.<br />
Nell’ambito <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o paesaggistico l’analisi del paesaggio, inteso come “un insieme integrale<br />
concreto” (“un concretum per eccellenza e per niente affatto un astratto”) non può essere<br />
elaborata in termini scientificamente corretti se non attraverso la in<strong>di</strong>viduazione prima ed<br />
analisi dopo, delle sue “componenti” (intese come elementi costitutivi) principali.<br />
La definizione data della componente “paesaggio” nell’ambito del Piano Urbanistico<br />
Territoriale Tematico/Paesaggio della Regione Puglia (Piano Paesistico ai sensi della 431/85),<br />
è quella <strong>di</strong> “un insieme integrale concreto, un insieme geografico in<strong>di</strong>ssociabile che evolve in<br />
blocco sia sotto l’effetto delle interazioni tra gli elementi che lo costituiscono, sia sotto quello<br />
della <strong>di</strong>namica propria <strong>di</strong> ognuno degli elementi considerati separatamente”.<br />
L’analisi del paesaggio e quin<strong>di</strong> la sua definizione, non può essere elaborata in termini<br />
scientificamente corretti se non attraverso l’in<strong>di</strong>viduazione ed il riconoscimento analitico<br />
delle sue componenti intese quali elementi costitutivi principali.<br />
Nel caso del PUTT/P della Regione Puglia, le componenti sono state in<strong>di</strong>viduate nei tre<br />
sistemi:<br />
• il sistema geologico-morfologico-idrogeologico<br />
• il sistema botanico-vegetazionale<br />
• il sistema della stratificazione storica dell’inse<strong>di</strong>amento umano.<br />
2.15.1. I sistemi costitutivi fondamentali delle strutture paesistico-ambientali<br />
L’analisi è stata effettuata me<strong>di</strong>ante una preliminare astratta in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong> “tipi <strong>di</strong><br />
paesaggio” per consentire la successive empirica determinazione (me<strong>di</strong>ante, appunto,<br />
osservazione e comparazione) dei “paesaggi tipici” della Regione.<br />
La <strong>di</strong>fferenziazione dei tipi <strong>di</strong> paesaggio in Puglia è essenzialmente dovuta all’assetto<br />
morfologico dei siti constatate sia la modesta <strong>di</strong>fferenziazione del clima, sia la <strong>di</strong>pendenza<br />
dell’idrografia e del manto vegetale proprio dalla morfologia.<br />
86
Il PUTT/P, reinterpretando le varie classificazioni dei “tipi <strong>di</strong> paesaggio” presenti in letteratura,<br />
in<strong>di</strong>vidua alcuni macrotipi e sottotipi <strong>di</strong> paesaggio pugliese.<br />
Il territorio oggetto <strong>di</strong> intervento (provincia <strong>di</strong> <strong>Taranto</strong>), secondo Pignatti, rientra nel Sistema<br />
Paesistico Murge-Salento mentre, secondo Ingegnoli, appartiene al Sistema Paesaggistico del<br />
Tavolato Apulo-Lucano.<br />
Paesaggio Murge-Salento<br />
La Puglia è formata in gran parte da un tavolato calcareo che nella parte più elevata, circa 400<br />
m s.l.m., costituisce le Murge mentre in quella più bassa, 100 m s.l.m. e quote inferiori,<br />
costituisce la penisola Salentina. In tutta l’area il clima è <strong>di</strong> tipo me<strong>di</strong>terraneo-arido, con<br />
piovosità generalmente inferiori ai 500 mm annui. Il calcare è il substrato prevalente nel<br />
paesaggio pugliese; dato che si rende evidente nei caratteristici muretti che orlano i campi<br />
coltivati. La vegetazione naturale climatogena è praticamente scomparsa e può essere<br />
ricostruita solo in via ipotetica. Di tipo sempre verde è rappresentata in particolare dalla<br />
lecceta termofila (Viburno querceto ilicis) che è stata sostituita lungo le coste e nelle stazioni<br />
più protette dalla macchia dell’Oleum lentischetum. Più all’interno si ha l’area del fragnio<br />
(Quercus troiana), una specie <strong>di</strong>ffusa in Grecia ed Anatolia, le cui popolazioni sono state<br />
talmente sottoposte all’impatto antropico che finora non è stato possibile identificarne<br />
l’appartenenza fitosociologica.<br />
La vegetazione sinantropica legata alle colture è ampiamente <strong>di</strong>ffusa. I lembi <strong>di</strong> vegetazione<br />
naturale possono venire incontrati soltanto nelle stazioni impervie che si localizzano<br />
soprattutto nelle gravine. È qui che si possono rinvenire popolamenti rupestri a Campanula<br />
versicolor, prati steppici, addensamenti <strong>di</strong> macchia e boschi <strong>di</strong> Pino d’Aleppo.<br />
Il paesaggio delle Murge-Salento è <strong>di</strong>ffuso su gran parte della Puglia. Al <strong>di</strong> fuori dei confini<br />
regionali è presente con poche variazioni nella parte orientale della Basilicata.<br />
Sistema paesaggistico del Tavolato Apulo-Lucano<br />
Questo sistema è uno dei più ari<strong>di</strong> d’Italia, con piovosità me<strong>di</strong>a annua inferiore ai 500 mm. La<br />
struttura geologica tipica del tavolato pugliese, mesozoica e terziaria, consiste in calcari a<br />
strati sottili con terre rosse carsiche e plaghe quaternarie alluvionali. I maggiori sottosistemi<br />
sono due:<br />
• tavolato basso e tavoliere;<br />
• tavolato alto e inciso.<br />
L’area <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o rientra nel sottosistema del “Tavolato alto e inciso”.<br />
Questo sottosistema si estende dalle Murge più alte alle colline plioceniche della Basilicata. È<br />
caratterizzato dal passaggio dagli altopiani carsici delle Murge ai terrazzamenti incisi che<br />
insistono sul Golfo <strong>di</strong> <strong>Taranto</strong>. Le Lame e le Gravine caratterizzano questo arido ambiente<br />
dove si notano spesso ecotessuti <strong>di</strong> tipo parallelo. La vegetazione arriva nella parte più alta<br />
delle Murge al climax della roverella, con presenza <strong>di</strong> Quercus ilex e Quercus troiana. L’oleolentischeto<br />
caratterizza l’orizzonte litoraneo mentre la lecceta termofila quello sub-litoraneo. I<br />
coltivi a cereali cedono il posto ad un’agricoltura molto <strong>di</strong>fferenziata tipica del giar<strong>di</strong>no<br />
me<strong>di</strong>terraneo ed inframmezzata da oliveti e vigneti. Lungo il litorale sono presenti tipiche<br />
pinete da rimboschimento.<br />
87
Il paesaggio del SIC “Area delle Gravine”<br />
Il paesaggio del SIC/ZPS “Area delle Gravine” secondo la classificazione gerarchica del<br />
territorio è interamente compreso nella Regione Me<strong>di</strong>terranea con bioclima <strong>di</strong> tipo oceanico.<br />
Il termotipo prevalente è mesome<strong>di</strong>terraneo con ombrotipo da secco a subumido-umido.<br />
I sistemi <strong>di</strong> paesaggio prevalenti sono: depositi carbonatici in facies <strong>di</strong> piattaforma e<br />
calcarenitici, depositi argillosi e alluvionali. Le morfologie sono costituite da rilievi a<br />
morfologia collinare, altopiani e fondovalle fluviali. Marginalmente il sito comprende depositi<br />
<strong>di</strong> terrazzo conglomeratico-sabbiosi. In sintesi il paesaggio dei SIC può essere inquadrato<br />
nelle seguenti unità ambientali:<br />
Regione Me<strong>di</strong>terranea<br />
• Unità ambientale degli altopiani calcarei del piano mesome<strong>di</strong>terraneo subumido-umido<br />
• Unità ambientale degli depositi alluvionali del piano termome<strong>di</strong>terraneo secco<br />
• Unità ambientale dei terrazzi conglomeratico-sabbiosi del piano termome<strong>di</strong>terrano secco<br />
• Unità ambientale dei rilievi collinari argillosi del piano mesome<strong>di</strong>terraneo subumidoumido<br />
• Unità ambientale dei rilievi calcarei del piano mesome<strong>di</strong>terraneo subumido-umido.<br />
88
3. VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE DI HABITAT E SPECIE<br />
3.1. HABITAT<br />
L'area delle Gravine dell'arco ionico annovera 8 habitat presenti in allegato I della <strong>di</strong>rettiva<br />
92/43 CEE, ognuna con peculiari esigenze ecologiche. È bene precisare che alcuni habitat<br />
presenti nella <strong>di</strong>rettiva comunitaria in realtà includono, talvolta, due o più tipologie<br />
vegetazionali <strong>di</strong>fferenti dal punto <strong>di</strong> vista ecologico e floristico. Ad esempio l’habitat “Thero-<br />
Brachypo<strong>di</strong>etea” fa riferimento a tre classi fitosociologiche <strong>di</strong>stinte: Lygeo-Stipetea, Poetea<br />
bulbosae e Tuberarietea guttatae. La prima classe fa riferimento a comunità <strong>di</strong> erbe perenni<br />
me<strong>di</strong>terranee, per lo più xeromorfe, organizzate in bassi tappeti erbosi, più o meno continui, o<br />
con gruppi caratteristici <strong>di</strong> graminacee <strong>di</strong> maggiore altezza, su suoli non salinizzati né<br />
idromorfici. Nella seconda classe sono compresi i prati semiari<strong>di</strong> o anche umi<strong>di</strong>, <strong>di</strong>ffusi<br />
soprattutto nella regione me<strong>di</strong>terranea occidentale (a carattere oceanico) della fascia climatica<br />
termome<strong>di</strong>terranea fino alla suprame<strong>di</strong>terranea, mantenuti ra<strong>di</strong> e fertilizzati dal pascolo ovino<br />
e dominati da basse piante perenni, camefite ed emicriptofite, mentre nella classe<br />
Tuberarietea guttatae sono inquadrate le comunità <strong>di</strong> piante pioniere ed effimere attive in<br />
primavera e nella prima estate, dominate da basse terofite non nitrofile, <strong>di</strong>stribuite nella<br />
regione Me<strong>di</strong>terranea con irra<strong>di</strong>azioni in quella Eurosiberiana, soltanto su suoli secchi e<br />
iniziali dei territori subme<strong>di</strong>terranei e steppici. Da questo breve ma esplicativo esempio è<br />
facile comprendere l’esigenza <strong>di</strong> realizzare la carta della vegetazione (scheda d’azione IA19),<br />
l’unica in grado <strong>di</strong> attribuire a ciascuna fisionomia un’associazione o almeno un alleanza<br />
fitosociologica, identificando in questo modo tutti i tipi <strong>di</strong> vegetazione realmente presenti e le<br />
relative esigenze ecologiche. Pertanto le esigenze ecologiche relative agli habitat della<br />
<strong>di</strong>rettiva Habitat 92/43 CEE, qui <strong>di</strong> seguito riportate, devono costituire un punto <strong>di</strong> partenza<br />
per analisi <strong>di</strong> maggior dettaglio che dovranno scaturire dalle azioni proposte.<br />
Habitat<br />
Esigenze ecologiche<br />
92A0 Foreste a galleria <strong>di</strong> Salix alba e Suoli alluvionali idromorfi, marcata umi<strong>di</strong>tà ambientale ed edafica.<br />
Populus alba.<br />
5330 - Arbusteti termome<strong>di</strong>terranei e Stazioni soleggiate, Pen<strong>di</strong>i scoscesi, substrato prevalentemente roccioso<br />
pre-steppici<br />
6220* Percorsi substeppici <strong>di</strong><br />
Tipo <strong>di</strong> suolo sottile, spesso calcareo con roccia affiorante,<br />
graminacee e piante annue dei Thero- pascolamento, decespugliamento, incen<strong>di</strong>o.<br />
Brachypo<strong>di</strong>etea<br />
9250 - Querceti a Quercus trojana Suoli calcarei e relativamente profon<strong>di</strong> con <strong>di</strong>screta <strong>di</strong>sponibilità<br />
d’acqua.<br />
9340 - Foreste <strong>di</strong> Quercus ilex Suoli <strong>di</strong> varia natura, relativamente profon<strong>di</strong>, versanti esposti<br />
generalmente a nord.<br />
9540 - Pinete me<strong>di</strong>terranee <strong>di</strong> pini Suolo prevalentemente calcareo, poco profondo.<br />
mesogeni endemici<br />
8210 - Pareti rocciose calcaree con<br />
vegetazione casmofitica<br />
8310 -Grotte non ancora sfruttate a<br />
livello turistico<br />
Pen<strong>di</strong>i calcarei più o meno ripi<strong>di</strong>, suolo esiguo, scarsa <strong>di</strong>sponibilità<br />
d’acqua (l’acqua <strong>di</strong>sponibile è quella circolante negli interstizi delle<br />
rocce).<br />
Suolo quasi inesistente, ombra, alta umidà relativa, bassa temperatura,<br />
bassissima <strong>di</strong>sponibilità d’acqua.<br />
89
3.2. FLORA<br />
La Direttiva 92/43/CEE non è stata molto attenta nel proporre specie vegetali ed habitat<br />
rappresentativi dell’intero territorio meri<strong>di</strong>onale. Solo una specie pugliese è inclusa<br />
nell’apposito allegato: Stipa austroitalica. Numerose altre specie pugliesi presenti nello<br />
specifico nell’area delle Gravine avrebbero meritato l’inclusione nella <strong>di</strong>rettiva, come ad<br />
esempio Arum apulum, Campanula versicolor, Anthemis hydruntina, Triticum biunciale,<br />
Biscutella incana, Marsilea strigosa ecc., in considerazione del loro carattere <strong>di</strong> relittualità e<br />
<strong>di</strong> assoluta necessità <strong>di</strong> tutela. Marsilea strigosa e Biscutella incana, allo stato attuale delle<br />
conoscenze, sembrano essere localmente estinte dalla Puglia. La scelta <strong>di</strong> Stipa austroitalica<br />
appare ingiustificata se si considera che è specie <strong>di</strong> pseudosteppa presente con popolamenti<br />
consistenti non solo in Puglia, dove è comunissima nell’area garganica, ma in altre regioni<br />
meri<strong>di</strong>onali come Basilicata e Calabria e pertanto non è certamente a rischio. In effetti, forma<br />
popolamenti estesi e abbastanza integri che non corrono nell’imme<strong>di</strong>ato rischi <strong>di</strong> <strong>di</strong>struzione<br />
generalizzata, specialmente in aree con substrato calcareo affiorante non adatte all’agricoltura.<br />
Gli stu<strong>di</strong> floristici <strong>di</strong> base hanno condotto all’in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong> un certo numero <strong>di</strong> specie<br />
vegetali per le quali, tuttavia, manca la redazione <strong>di</strong> un rapporto qualitativo e quantitativo. Si<br />
prevede, pertanto, con un apposito stu<strong>di</strong>o (azione IA18) la realizzazione della check-list <strong>di</strong><br />
tutte le specie botaniche presenti in quanto propedeutica all’attuazione <strong>di</strong> altre azioni del Pdg<br />
(check-list delle specie a rischio, conservazione ex situ e in situ). Gli stu<strong>di</strong> floristici <strong>di</strong> base<br />
hanno condotto all’in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong> un certo numero <strong>di</strong> specie vegetali per le quali, tuttavia,<br />
manca la redazione <strong>di</strong> un rapporto qualitativo e quantitativo. La carta della <strong>di</strong>stribuzione reale<br />
delle specie elencate nel § 2.5.1., infatti, costituisce solo il punto <strong>di</strong> partenza per la<br />
realizzazione <strong>di</strong> un apposito stu<strong>di</strong>o (azione IA18), che prevede la redazione della check-list <strong>di</strong><br />
tutte le specie botaniche presenti, ed è propedeutico all’attuazione <strong>di</strong> altre azioni del Pdg<br />
(conservazione ex situ e in situ, carta della vegetazione, ecc..).<br />
3.3. FAUNA<br />
L'area delle Gravine dell'arco ionico vede la presenza <strong>di</strong> ben 19 specie <strong>di</strong> Uccelli in allegato I<br />
della <strong>di</strong>rettiva "79/409". Tra queste, due specie, Lanario e Grillaio, sono considerate SPEC 1<br />
da BirdLife, cioè specie minacciate a livello globale.<br />
Le specie ni<strong>di</strong>ficanti sono 17: Nibbio bruno, Nibbio reale, Capovaccaio, Biancone, Grillaio,<br />
Lanario, Occhione, Gufo reale, Succiacapre, Martin pescatore, Ghiandaia marina, Calandra,<br />
Calandrella, Tottavilla, Calandro, Averla piccola e Averla cenerina; mentre due, Falco<br />
pecchiaiolo e Pellegrino, sono migratori e/o svernanti.<br />
In riferimento alla <strong>di</strong>rettiva Habitat 92/43 sono state riscontrate: 16 specie <strong>di</strong> chirotteri<br />
(Rinolofo eurìale, Rinolofo maggiore, Rinolofo minore, Rinolofo <strong>di</strong> Mèhely, Barbastello<br />
comune, Seròtino comune, Pipistrello <strong>di</strong> Savi, Vespertilio <strong>di</strong> Blyth, Vespertilio <strong>di</strong> Capaccini,<br />
Vespertilio maggiore, Pipistrello albolimbato, Pipistrello <strong>di</strong> Nathusius, Pipistrello nano,<br />
Orecchione grigio, Miniottero <strong>di</strong> Schreiber, Molosso <strong>di</strong> Cestoni) <strong>di</strong> cui 11 nuove specie<br />
rispetto a quelle in<strong>di</strong>cate nelle schede <strong>di</strong> Rete Natura; 2 specie <strong>di</strong> anfibi (Tritone crestato<br />
italiano, Ululone appenninico) e 4 specie <strong>di</strong> rettili (Testuggine palustre, Testuggine comune,<br />
Cervone, Colubro leopar<strong>di</strong>no).<br />
Nell'analisi delle esigenze ecologiche delle <strong>di</strong>verse specie sono state considerate solo quelle<br />
su cui si <strong>di</strong>sponevano dati sufficienti a livello locale. Per le altre specie sono state proposte<br />
azioni <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o e monitoraggio al fine <strong>di</strong> ampliare le conoscenze biologiche necessarie alla<br />
loro gestione.<br />
90
3.3.1. Specie elencate negli allegati della Direttiva Uccelli<br />
Specie verificate dagli stu<strong>di</strong><br />
<strong>di</strong> base (UZI e LIPU)<br />
Falco pecchiaiolo (Pernis<br />
apivorus)<br />
Capovaccaio (Neophron<br />
percnopterus)<br />
Esigenze ecologiche delle specie<br />
Ambienti boscati sia <strong>di</strong> latifoglie che conifere.<br />
In migrazione frequenta aree agricole alberate e zone suburbane.<br />
Buona <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> insetti, soprattutto api e vespe <strong>di</strong> cui preda anche i favi.<br />
Ambienti aperti, zone a steppa alternate a coltivazioni <strong>di</strong> cereali, ampie <strong>di</strong>stese a pascolo.<br />
Pascolo brado e buona <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> animali morti.<br />
Presenza <strong>di</strong> pareti rocciose tranquille e lontane da fonti <strong>di</strong> <strong>di</strong>sturbo.<br />
Nibbio reale (Milvus milvus) Ambienti eterogenei in cui si alternano zone aperte e boscate.<br />
Pascolo brado e buona <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> animali morti.<br />
Buona presenza <strong>di</strong> aree boschive in cui ni<strong>di</strong>ficare.<br />
Nibbio bruno (Milvus<br />
migrans)<br />
Biancone (Circaetus<br />
gallicus)<br />
Lanario (Falco biarmicus)<br />
Pellegrino (Falco<br />
peregrinus)<br />
Grillaio (Falco naumanni)<br />
Succiacapre<br />
(Caprimulgus europaeus)<br />
Occhione (Burhinus<br />
oe<strong>di</strong>cnemus)<br />
Gufo reale (Bubo bubo)<br />
Ghiandaia marina<br />
(Coracias garrulus)<br />
Martin pescatore (Alcedo<br />
atthis)<br />
Calandra (Melanocorypha<br />
calandra)<br />
Calandrella (Calandrella<br />
brachydactyla)<br />
Tottavilla (Lullula arborea)<br />
Calandro (Anthus<br />
campestris)<br />
Averla piccola (Lanius<br />
collurio)<br />
Averla cenerina (Lanius<br />
minor)<br />
Ambienti eterogenei in cui si alternano zone aperte e boscate.<br />
Pascolo brado e buona <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> animali morti.<br />
Buona presenza <strong>di</strong> aree boschive in cui ni<strong>di</strong>fcare.<br />
Ambienti a bassa densità umana e a limitata attività agricola.<br />
Aree boscose anche <strong>di</strong> modeste <strong>di</strong>mensioni, su ripi<strong>di</strong> pen<strong>di</strong>i, aventi composizione mista e<br />
con presenza <strong>di</strong> conifere.<br />
Ampia <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> colubri<strong>di</strong>.<br />
Ambienti aperti, zone stepposo-cerealicole, con ampie <strong>di</strong>stese <strong>di</strong> pascoli e praterie.<br />
Sistemi rupicoli prevalentemente calcarei.<br />
Ambienti eterogenei in cui si alternano zone aperte e boscate.<br />
Sistemi rupicoli prevalentemente calcarei.<br />
Ambienti aperti, zone a steppa alternate a coltivazioni <strong>di</strong> cereali, ampie <strong>di</strong>stese a pascolo,<br />
ambienti rocciosi con scarsa copertura arborea e arbustiva.<br />
Ampia <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> Ortotteri e Coleotteri.<br />
Disponibilità <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici storici nei centri urbani ricchi <strong>di</strong> cavità nei muri, sottotetti e<br />
anfratti.<br />
Boscaglie ricche <strong>di</strong> radure alternate a macchie più fitte e aree steppiche.<br />
Ampia <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> Ortotteri e Coleotteri.<br />
Ambienti ari<strong>di</strong> e steppici, con bassa e rada vegetazione. Evita ambienti con fitta copertura<br />
arborea.<br />
Buona <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> invertebrati e piccoli vertebrati.<br />
Ampia varietà <strong>di</strong> ambienti con presenza <strong>di</strong> aree aperte in prossimità <strong>di</strong> pareti rocciose.<br />
Disponibilità <strong>di</strong> mammiferi <strong>di</strong> taglia me<strong>di</strong>o-piccola (conigli, ratti, ricci, ecc.).<br />
Campagne alberate con residui <strong>di</strong> macchia me<strong>di</strong>terranea e piccoli boschi. Frequenta le<br />
aree agricole con coltivazioni tra<strong>di</strong>zionali ed estensive. Importante la presenza <strong>di</strong> vecchi<br />
alberi cavi e <strong>di</strong> rovine.<br />
Buona <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> invertebrati e piccoli vertebrati.<br />
Presenza <strong>di</strong> corsi d'acqua dolce, e stagni.<br />
Disponibilità <strong>di</strong> piccoli pesci e <strong>di</strong> granchi e insetti.<br />
Argini sabbiosi in cui costruire il nido.<br />
Ambienti aperti, zone a steppa alternate a coltivazioni <strong>di</strong> cereali, ampie <strong>di</strong>stese a pascolo.<br />
Ampia <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> semi <strong>di</strong> piante erbacee selvatiche e coltivate. Insetti e loro larve, in<br />
particolare ortotteri e coleotteri.<br />
Ambienti aperti, zone a steppa alternate a coltivazioni <strong>di</strong> cereali, ampie <strong>di</strong>stese a pascolo.<br />
Ampia <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> semi <strong>di</strong> piante erbacee selvatiche e coltivate. Insetti e loro larve, in<br />
particolare ortotteri e coleotteri.<br />
Ambienti aperti alternati a boschi e macchie.<br />
Ampia <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> semi <strong>di</strong> piante erbacee selvatiche e coltivate. Insetti e loro larve, in<br />
particolare ortotteri e coleotteri.<br />
Ambienti aperti, zone a steppa alternate a coltivazioni <strong>di</strong> cereali, ampie <strong>di</strong>stese a pascolo.<br />
Ampia <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> semi <strong>di</strong> piante erbacee selvatiche e coltivate. Insetti e loro larve, in<br />
particolare ortotteri e coleotteri.<br />
Ambienti ricchi <strong>di</strong> siepi e macchie boscose.<br />
Ampia <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> coleotteri, locuste, farfalle e bruchi, piccoli vertebrati.<br />
Ambienti aperti, zone a steppa alternate a coltivazioni <strong>di</strong> cereali, ampie <strong>di</strong>stese a pascolo.<br />
Ampia <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> coleotteri, locuste, farfalle e bruchi, piccoli vertebrati.<br />
91
3.3.2. Specie elencate negli allegati della Direttiva Habitat<br />
Specie verificate dagli<br />
stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> base (UZI e<br />
LIPU)<br />
Rinolofo maggiore<br />
(Rhinolophus<br />
ferrumequinum)<br />
Rinolofo minore<br />
(Rhinolophus<br />
hipposideros)<br />
Vespertilio minore<br />
(Myotis blythii)<br />
Vespertilio smarginato<br />
(Myotis emarginatus)<br />
Vespertilio <strong>di</strong> Capaccini<br />
(Myotis capaccini)<br />
Esigenze ecologiche delle specie<br />
Ambienti aperti, zone a steppa alternate a coltivazioni <strong>di</strong> cereali, ampie <strong>di</strong>stese a pascolo.<br />
Rifugio: e<strong>di</strong>fici o altre costruzioni all'aperto.<br />
Ibernazione: cavità sotterranee naturali o artificiali (grotte, gallerie, cave, ecc.) e<strong>di</strong>fici o<br />
altre costruzioni all'aperto.<br />
Ambienti eterogenei in cui si alternano zone aperte e boscate.<br />
Rifugio: e<strong>di</strong>fici o altre costruzioni all'aperto, grotte e cavo degli alberi.<br />
Ibernazione: cavità sotterranee naturali o artificiali (grotte, gallerie, cave, ecc.).<br />
Ambienti aperti, zone stepposo-cerealicole, con ampie <strong>di</strong>stese <strong>di</strong> pascoli, praterie,<br />
ambienti rocciosi con scarsa copertura arborea e arbustiva.<br />
Rifugio: cavità sotterranee naturali o artificiali (grotte, gallerie, cave, ecc.) e<strong>di</strong>fici o altre<br />
costruzioni all'aperto.<br />
Ibernazione: cavità sotterranee naturali o artificiali (grotte, gallerie, cave, ecc.).<br />
Ambienti aperti, zone stepposo-cerealicole, con ampie <strong>di</strong>stese <strong>di</strong> pascoli, praterie,<br />
ambienti rocciosi con scarsa copertura arborea e arbustiva.<br />
Rifugio: cavità sotterranee naturali o artificiali (grotte, gallerie, cave, ecc.) e<strong>di</strong>fici o altre<br />
costruzioni all'aperto.<br />
Ibernazione: cavità sotterranee naturali o artificiali (grotte, gallerie, cave, ecc.).<br />
Ambienti ricchi <strong>di</strong> vegetazione in presenza <strong>di</strong> acque superficiali.<br />
Rifugio: cavità sotterranee naturali o artificiali (grotte, gallerie, cave, ecc.)<br />
Ibernazione: cavità sotterranee naturali o artificiali (grotte, gallerie, cave, ecc.).<br />
Vespertilio maggiore<br />
(Myotis myotis)<br />
Miniottero<br />
(Miniopterus schreibersii)<br />
Testuggine palustre (Emys<br />
orbicularis)<br />
Testuggine comune<br />
(Testudo hermanni)<br />
Cervone (Elaphe<br />
quatuorlineata)<br />
Colubro leopar<strong>di</strong>no<br />
(Elaphe situla)<br />
Tritone crestato italiano<br />
(Triturus carnifex)<br />
Ululone appenninico<br />
(Bombina pachypus)<br />
Ambienti aperti, zone stepposo-cerealicole, con ampie <strong>di</strong>stese <strong>di</strong> pascoli, praterie,<br />
ambienti rocciosi con scarsa copertura arborea e arbustiva.<br />
Rifugio: cavità sotterranee naturali o artificiali (grotte, gallerie, cave, ecc.) e<strong>di</strong>fici o altre<br />
costruzioni all'aperto.<br />
Ibernazione: cavità sotterranee naturali o artificiali (grotte, gallerie, cave, ecc.).<br />
Ambienti aperti, zone stepposo-cerealicole, con ampie <strong>di</strong>stese <strong>di</strong> pascoli, praterie,<br />
ambienti rocciosi con scarsa copertura arborea e arbustiva.<br />
Rifugio: cavità sotterranee naturali o artificiali (grotte, gallerie, cave, ecc).<br />
Ibernazione: cavità sotterranee naturali o artificiali (grotte, gallerie, cave, ecc.); e<strong>di</strong>fici o<br />
altre costruzioni all'aperto.<br />
Raccolte d’acqua naturali e/o artificiali, canali <strong>di</strong> irrigazione e corsi d’acqua con ricca<br />
vegetazione igrofila.<br />
Ambienti aperti, zone a steppa alternate a coltivazioni <strong>di</strong> cereali, ampie <strong>di</strong>stese a pascolo.<br />
Ampia <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> semi <strong>di</strong> piante erbacee selvatiche e coltivate.<br />
Campagne alberate con residui <strong>di</strong> macchia me<strong>di</strong>terranea e piccoli boschi. Frequenta le<br />
aree agricole con coltivazioni tra<strong>di</strong>zionali ed estensive. Importante la presenza <strong>di</strong> vecchi<br />
alberi cavi e <strong>di</strong> rovine.<br />
Buona <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> invertebrati e piccoli vertebrati.<br />
Campagne alberate con residui <strong>di</strong> macchia me<strong>di</strong>terranea e piccoli boschi. Frequenta le<br />
aree agricole con coltivazioni tra<strong>di</strong>zionali ed estensive. Importante la presenza <strong>di</strong> vecchi<br />
alberi cavi e <strong>di</strong> rovine.<br />
Buona <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> invertebrati e piccoli vertebrati.<br />
Raccolte d’acqua naturali e/o artificiali con scarsa o nulla corrente e ricche <strong>di</strong> invertebrati.<br />
Stagni e raccolte d’acqua, anche temporanee con buona presenza <strong>di</strong> invertebrati.<br />
92
3.4. Definizione degli in<strong>di</strong>catori per la valutazione dello stato <strong>di</strong><br />
conservazione ed evoluzione delle specie animali <strong>di</strong> importanza<br />
comunitaria<br />
Gli in<strong>di</strong>catori sono stati definiti in riferimento ad un ipotetico e omnicomprensivo programma<br />
<strong>di</strong> monitoraggio del buono stato <strong>di</strong> conservazione delle specie, tenendo conto delle<br />
caratteristiche biologiche delle singole specie target considerate. Per le specie <strong>di</strong> cui si<br />
<strong>di</strong>spongono <strong>di</strong> buoni dati popolazionistici pregressi e <strong>di</strong> meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> censimento atten<strong>di</strong>bili e<br />
<strong>di</strong>retti (Grillaio, Capovaccaio, Lanario, Gufo reale, Biancone) sono stati proposti in<strong>di</strong>catori<br />
quali il n. <strong>di</strong> coppie ni<strong>di</strong>ficanti e/o i parametri <strong>di</strong> biologia riproduttiva ricavabili dal monito–<br />
raggio, mentre per altre specie a maggiore <strong>di</strong>ffusione territoriale o <strong>di</strong>fficilmente contattabili<br />
(Nibbio reale, Nibbio bruno, Occhione, Ghiandaia marina, Calandra e Alau<strong>di</strong><strong>di</strong> in <strong>generale</strong>,<br />
Lani<strong>di</strong>) sono stati proposti in<strong>di</strong>catori quali densità me<strong>di</strong>a in aree campione o su transetti e<br />
<strong>di</strong>ffusione nei <strong>di</strong>versi quadranti in cui è possibile sud<strong>di</strong>videre l'intera area delle gravine<br />
dell'arco ionico, sul modello degli attuali atlanti faunistici.<br />
Per la definizione delle metodologie <strong>di</strong> ricerca sul campo atte alla quantificazione degli<br />
in<strong>di</strong>catori vedasi l'allegato A: monitoraggio e stu<strong>di</strong>o delle specie animali <strong>di</strong> particolare<br />
interesse conservazionistico dell'area delle gravine dell'arco ionico.<br />
Tab. 3.4.a - Quadro riassuntivo degli in<strong>di</strong>catori utilizzati nel monitoraggio delle specie.<br />
In<strong>di</strong>catori<br />
specie<br />
I1 n. coppie ni<strong>di</strong>ficanti<br />
Grillaio, Capovaccaio, Biancone, Lanario, Nibbio reale, Nibbio bruno, Gufo<br />
reale, Ghiandaia marina<br />
I2 n. colonie <strong>di</strong> ni<strong>di</strong>ficazione<br />
Grillaio, Rinolofo maggiore, Rinolofo minore, Vespertilio minore,<br />
Vespertilio smarginato, Vespertilio <strong>di</strong> Capaccini, Vespertilio maggiore,<br />
Miniottero<br />
I3 n. colonie <strong>di</strong> svernamento<br />
Rinolofo maggiore, Rinolofo minore, Vespertilio minore, Vespertilio<br />
smarginato, Vespertilio <strong>di</strong> Capaccini, Vespertilio maggiore, Miniottero<br />
I4<br />
n. <strong>di</strong> siti occupati da almeno<br />
Capovaccaio, Lanario, Gufo reale<br />
1 ind.<br />
I5 n. giovani involati Capovaccaio, Lanario, Biancone<br />
I6<br />
n. <strong>di</strong> in<strong>di</strong>vidui in<br />
Capovaccaio, Nibbio reale, Nibbio bruno<br />
alimentazione al carnaio<br />
I7 n. me<strong>di</strong>o <strong>di</strong> ind./km lineare Nibbio reale, Nibbio bruno<br />
I8<br />
Occhione, Calandra, Calandrella, Tottavilla, Calandro, Averla piccola, Averla<br />
densità me<strong>di</strong>a per area<br />
cenerina, Tritone crestato italiano, Ululone appenninico, Testuggine palustre,<br />
campione<br />
Testuggine comune, Cervone, Colubro leopar<strong>di</strong>no<br />
3.5. Definizione degli in<strong>di</strong>catori per la valutazione dello stato <strong>di</strong><br />
conservazione ed evoluzione degli Habitat forestali e degli Habitat<br />
inclusi nella Direttiva Habitat 92/43CEE<br />
Per gli habitat riportati nell’allegato I della <strong>di</strong>rettiva Habitat 92/43 CEE verranno scelte<br />
opportune aree <strong>di</strong> saggio (azione PMR13) per monitorare la loro bio<strong>di</strong>versità ed il loro stato <strong>di</strong><br />
conservazione. Il campionamento delle variabili indagate dovrà essere <strong>di</strong> tipo probabilistico e<br />
secondo modalità casuali (o sistematico). Il <strong>di</strong>mensionamento del campione sarà stabilito in<br />
modo tale da avere dati statisticamente significativi. L’obiettivo principale è quello <strong>di</strong><br />
93
accogliere dati su base scientifica, per sostenere le politiche nazionali ed internazionali per la<br />
conservazione degli habitat e per la tutela della loro bio<strong>di</strong>versità, in particolare attraverso il<br />
monitoraggio <strong>di</strong> in<strong>di</strong>catori ecologici. In questo modo si potrà <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> una fotografia<br />
dettagliata e realistica dello stato della bio<strong>di</strong>versità degli habitat presenti, che potrà fornire una<br />
base solida per la costruzione della futura rete <strong>di</strong> monitoraggio della bio<strong>di</strong>versità su larga<br />
scala, come richiesto dalle decisioni del Consiglio dell’Unione Europea e dalle Conferenze<br />
attuative della Convenzione UN sulla Diversità Biologica. In relazione alla notevole<br />
estensione dell’area sono stati presi in considerazione alcuni in<strong>di</strong>catori per il monitoraggio su<br />
vasta scala dell’area in oggetto ed altri da applicare alle sole aree <strong>di</strong> saggio. Si rimanda alla<br />
scheda d’azione relativa n. IA 20 le modalità <strong>di</strong> rilevamento e monitoraggio: Gli in<strong>di</strong>catori<br />
selezionati sono i seguenti:<br />
Tab. 3.5.a - Quadro riassuntivo degli in<strong>di</strong>catori utilizzati nel monitoraggio degli Habitat.<br />
INDICATORI<br />
In<strong>di</strong>catore<br />
Habitat<br />
forestale<br />
Altri<br />
habitat<br />
N. Tipo<br />
I9 naturalità vegetazionale x x<br />
I10 estensione complessiva dell’habitat x x<br />
I11 <strong>di</strong>mensione della tessera più estesa dell’habitat x x<br />
I12 flora antropogena x x<br />
I13 ricchezza floristica x x<br />
I14 analisi fitosociologica dell’habitat x (*) x (*)<br />
I15 età del soprassuolo forestale x<br />
I16 <strong>di</strong>ametro me<strong>di</strong>o delle specie forestali x<br />
I17 altezza me<strong>di</strong>a delle specie forestali x<br />
I18 provvigione minimale x<br />
I19 tasso <strong>di</strong> rinnovazione x<br />
I20 segni <strong>di</strong> pascolamento x x<br />
I21 stato fitosanitario delle piante x<br />
I22 quantità <strong>di</strong> massa legnosa a terra x<br />
I23 spessore della lettiera e quantità <strong>di</strong> sostanza organica x<br />
I24 n° <strong>di</strong> specie arbustive per unità <strong>di</strong> superficie x x<br />
I25 n° <strong>di</strong> specie erbacee per unità <strong>di</strong> superficie x x<br />
I26 n° specie in<strong>di</strong>catrici <strong>di</strong> ari<strong>di</strong>tà x x<br />
I27 n° specie in<strong>di</strong>catrici <strong>di</strong> umi<strong>di</strong>tà x<br />
I28 n° specie in<strong>di</strong>catrici <strong>di</strong> luminosità x<br />
I29 in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> antropizzazione x x<br />
I30 coerenza corologica x x<br />
I31 in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> <strong>di</strong>versità <strong>di</strong> specie secondo Shannon x x<br />
I32 in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> dominanza (o <strong>di</strong> Simpson) x (*) x (*)<br />
I33 in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> equiripartizione o <strong>di</strong> Evenness x (*) x (*)<br />
I34 in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> equiripartizione secondo Peet-Pielou x x<br />
I35 in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> pascolamento x x<br />
(*) facoltativo.<br />
94
3.6. Definizione degli in<strong>di</strong>catori per la valutazione dello stato <strong>di</strong><br />
conservazione ed evoluzione delle specie vegetali <strong>di</strong> elevato valore<br />
biogeografico e conservazionistico<br />
Sono stati scelti in<strong>di</strong>catori applicabili su superfici ampie, in molti casi all’intera area SIC-ZPS<br />
e/o Area Parco, ed in<strong>di</strong>catori da utilizzare in un perio<strong>di</strong>co programma <strong>di</strong> monitoraggio,<br />
all’interno delle aree <strong>di</strong> saggio. Questi ultimi, che possono coincidere con quelle scelte per gli<br />
habitat, sono stati definiti in relazione allo stato <strong>di</strong> conservazione, delle caratteristiche<br />
biologiche ed ecologiche delle singole specie target considerate. Si precisa che mancano, allo<br />
stato attuale, dati relativi all’in<strong>di</strong>viduazione puntuale delle specie considerate, così come<br />
quella dei principali popolamenti in cui esse sono presenti. Pertanto questa azione deve essere<br />
preceduta da una redazione della check-list delle specie vegetali a rischio, per la quale si<br />
prevede uno stu<strong>di</strong>o ad hoc (Scheda d’azione n° IA18).<br />
Di seguito si riportano gli in<strong>di</strong>catori da applicarsi su vasta scala e quelli da utilizzare per le<br />
sole aree <strong>di</strong> saggio per la valutazione dello stato <strong>di</strong> conservazione delle specie riportate<br />
nell’allegato II della <strong>di</strong>rettiva Habitat 92/43 CEE, delle convenioni internazionali (Berna e<br />
CITES) e delle Liste Rosse Nazionali e Regionali o per quelle particolarmente importanti ai<br />
fini conservazionistici (es. endemiche etc.):<br />
INDICATORI<br />
N° Tipo Descrizione<br />
I36 Specie In<strong>di</strong>care se la specie è inclusa in<br />
un habitat della <strong>di</strong>rettiva habitat<br />
92/43 CEE<br />
A: si<br />
B: no<br />
I37 Popolazione Stima della popolazione in cui la<br />
specie è presente<br />
A: comune<br />
R: rara<br />
V: molto rara<br />
I38 Conservazione Numero <strong>di</strong> specie vegetali a<br />
rischio<br />
I39 Conservazione Percentuale <strong>di</strong> specie a rischio<br />
rispetto al numereo <strong>di</strong> specie<br />
vegetali presenti (%)<br />
I40 Isolamento Grado <strong>di</strong> isolamento della<br />
popolazione presente nel sito<br />
rispetto all’area <strong>di</strong> ripartizione<br />
naturale della specie<br />
I41 Motivazione Motivazione per cui la specie è<br />
presente nell’elenco<br />
A: popolazione isolata<br />
B: popolazione non isolata, ma ai margini<br />
dell’area <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione<br />
C: popolazione non isolata all’interno <strong>di</strong> una<br />
vasta fascia <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione<br />
A: elenco delle liste rosse regionali<br />
B: elenco delle liste rosse nazionali<br />
C: specie endemica<br />
D: convenzioni internazionali<br />
E: altri motivi<br />
(*) facoltativo.<br />
95
3.7. Minacce e fattori limitanti<br />
Vengono <strong>di</strong> seguito elencati i principali fattori <strong>di</strong> rischio che rappresentano oggettivi fattori <strong>di</strong><br />
limitazione per specie e habitat.<br />
Alcune <strong>di</strong> queste criticità sono state evidenziate nell’ambito del <strong>di</strong>battito con gli stakeholder<br />
locali. Una delle fasi del processo partecipativo ha riguardato, infatti, la raccolta e<br />
strutturazione della conoscenza locale in merito alle principali problematiche e criticità.<br />
Spietramento degli habitat steppici<br />
Il tra<strong>di</strong>zionale pascolo brado a bassa densità, che ha probabilmente creato e certamente<br />
mantenuto questo tipo <strong>di</strong> habitat (substeppico), è in corso <strong>di</strong> abbandono. Nelle aree più<br />
pianeggianti e con minor scheletro roccioso viene praticata la spietratura meccanica per<br />
pre<strong>di</strong>sporre il terreno alla coltivazione <strong>di</strong> cereali o all'impianto <strong>di</strong> colture arboree quali olivo e<br />
vite, portando quin<strong>di</strong> ad una profonda alterazione dell’ambiente originario.<br />
Lo spietramento determina mo<strong>di</strong>ficazioni delle caratteristiche <strong>di</strong> drenaggio del suolo, con<br />
conseguenze anche gravi relativamente all’innesco <strong>di</strong> fenomeni <strong>di</strong> degrado e <strong>di</strong>ssesto del<br />
territorio (erosione e allagamenti). I terreni spietrati infatti sono soggetti ad un veloce<br />
processo <strong>di</strong> degradazione a causa dell'azione erosiva dei venti e <strong>di</strong> <strong>di</strong>lavamento delle acque<br />
piovane, azioni non più contrastate dagli apparati ra<strong>di</strong>cali della preesistente vegetazione<br />
spontanea.<br />
Questa minaccia interviene all’interno delle aree trofiche <strong>di</strong> tutte le specie che caratterizzano<br />
il sito mo<strong>di</strong>ficando permanentemente, attraverso la macinazione della roccia calcarea<br />
superficiale, le caratteristiche pedologiche. Il tipo <strong>di</strong> intervento interessa principalmente le<br />
aree a pseudosteppa, che dalle ricerche condotte si in<strong>di</strong>vidua quale habitat trofico principale<br />
del Grillaio, Biancone e dell'Occhione, e quale habitat <strong>di</strong> ni<strong>di</strong>ficazione <strong>di</strong> alau<strong>di</strong><strong>di</strong> come la<br />
Calandra e la Calandrella, e lani<strong>di</strong> come l’Averla piccola e l’Averla cenerina.<br />
Le aree maggiormente colpite in passato sono state quelle ricadenti nei territori pugliesi <strong>di</strong><br />
Ginosa, Laterza, Castellaneta, Mottola, Massafra e Palagianello, determinando una forte<br />
riduzione e frammentazione delle aree <strong>di</strong> tipo steppico vegetanti su substrato calcareo.<br />
Rilevanza: alta.<br />
Carenza del contenuto <strong>di</strong> sostanza organica nei suoli: i risultati <strong>di</strong> recenti determinazioni<br />
analitiche condotte su campioni <strong>di</strong> suoli provenienti da aree agricole rappresentative<br />
dell’intero territorio regionale (Progetto <strong>di</strong> Ampliamento della Rete <strong>di</strong> Rilevazione<br />
Agrometeorologica Regionale; Misura 1.4 - Azione C - POR 2000-06) hanno messo in<br />
evidenza, per l’area interessato dal Piano <strong>di</strong> gestione, una <strong>di</strong>ffusa situazione <strong>di</strong> criticità<br />
correlata all’esiguità del contenuto <strong>di</strong> sostanza organica dei suoli. Oltre un terzo dei siti<br />
esaminati, infatti, risultano poveri (contenuto < 10 g/Kg) <strong>di</strong> sostanza organica, che esplica<br />
molteplici effetti benefici sulla struttura dei suoli, ivi compresi la tutela della bio<strong>di</strong>versità del<br />
suolo medesimo (richiamata anche dalla Convenzione sulla <strong>di</strong>versità biologica) e delle<br />
bio<strong>di</strong>versità <strong>di</strong> specie e geni vegetali ed animali, la tutela degli habitat, la produzione <strong>di</strong><br />
biomassa, in particolare nei settori dell’agricoltura e della silvicoltura, lo stoccaggio, la<br />
filtrazione e la trasformazione <strong>di</strong> nutrienti e <strong>di</strong> acqua, lo stoccaggio <strong>di</strong> carbonio, la<br />
degradazione <strong>di</strong> contaminanti e la tutela dell’ambiente fisico e della salute umana.<br />
Rilevanza: alta.<br />
96
Abbandono della pastorizia<br />
Le attuali politiche <strong>di</strong> sviluppo agricolo hanno determinato l'abbandono delle tra<strong>di</strong>zionali<br />
attività pastorali, basate sull'allevamento estensivo degli ovini, a favore <strong>di</strong> modelli <strong>di</strong><br />
allevamento più industriali e basati sui bovini, sia per la produzione <strong>di</strong> latte che <strong>di</strong> carne.<br />
Questo ha comportato l'abbandono <strong>di</strong> vaste estensioni <strong>di</strong> pascolo con la conseguente mo<strong>di</strong>fica<br />
degli stessi in gariga a lentisco, macchia a lentisco e macchia <strong>di</strong> leccio, e la scomparsa <strong>di</strong><br />
importanti risorse trofiche per specie come il Capovaccaio e il Nibbio reale che si nutrono <strong>di</strong><br />
animali morti. In <strong>generale</strong> l'abbandono della pastorizia tra<strong>di</strong>zionale rappresenta il volano che<br />
determina la trasformazione agricola del territorio.<br />
Rilevanza: alta.<br />
Impianto <strong>di</strong> vigneti<br />
Nelle aree a minor pendenza è stato praticato lo spietramento meccanico con macinazione del<br />
calcare e successivo impianto, per lo più, <strong>di</strong> vigneto a tendone per la produzione <strong>di</strong> uva da<br />
tavola. Tale coltivazione determina un notevole impatto sulla bio<strong>di</strong>versità locale e rappresenta<br />
una forte minaccia, in particolare, per specie quali il Grillaio e l'Occhione, e si esplica sia<br />
attraverso la completa preclusione dell'area, sia attraverso l'effetto dei bioci<strong>di</strong> che<br />
<strong>di</strong>ffondendosi nell'ambiente determinano un impoverimento della fauna invertebrata e il loro<br />
accumulo nei tessuti. Tale tipo <strong>di</strong> coltivazione è associata infatti un uso elevato <strong>di</strong> fitofarmaci.<br />
Rilevanza: me<strong>di</strong>a, localmente alta.<br />
Tagli boschivi irrazionali<br />
Le ripetute ceduazioni che si sono succedute nel corso dei secoli, spesso con turni molto<br />
ravvicinati e con prelievi legnosi eccedenti l’incremento, hanno determinato un <strong>generale</strong><br />
impoverimento dei boschi soprattutto <strong>di</strong> quelli a prevalenza <strong>di</strong> latifoglie eliofile (fragno) sia<br />
per quanto riguarda la provvigione, sia per quanto riguarda la struttura che risulta essere<br />
estremamente semplificata.<br />
Rilevanza: me<strong>di</strong>a<br />
Riforestazione naturale e artificiale<br />
Anche se in misura minore, si assiste anche alla riforestazione, naturale e più spesso<br />
artificiale, <strong>di</strong> molte aree in precedenza destinate al pascolo. Nel primo caso è la conseguenza<br />
dell’abbandono del pascolo che controllava l’estendersi dei boschi <strong>di</strong> querce me<strong>di</strong>terranee, nel<br />
secondo si tratta <strong>di</strong> interventi umani condotti principalmente durante gli anni '60 - '80 e<br />
secondariamente nella seconda metà degli anni ’90, anche con l’impianto <strong>di</strong> essenze<br />
alloctone. Le tecniche <strong>di</strong> riforestazione applicate nell’area delle Gravine prevedevano<br />
l’utilizzo <strong>di</strong> specie non autoctone e interessavano spesso aree ad alta valenza ecologica. Tale<br />
processo ha determinato la scomparsa <strong>di</strong> habitat prioritari e la banalizzazione delle comunità<br />
floro-faunistiche, introducendo un ulteriore fattore <strong>di</strong> pericolo rappresentato dall'elevato<br />
rischio <strong>di</strong> incen<strong>di</strong>o <strong>di</strong> tali formazioni boschive. I processi <strong>di</strong> riforestazione, naturale e<br />
artificiale, hanno determinato la scomparsa <strong>di</strong> habitat trofico per specie quali Grillaio,<br />
Lanario, Capovaccaio e Biancone e la riduzione <strong>di</strong> habitat <strong>di</strong> ni<strong>di</strong>ficazione e alimentazione per<br />
97
specie quali Calandra, Calandrella, Occhione, Averla cenerina e Averla piccola.<br />
Rilevanza: bassa, localmente me<strong>di</strong>a.<br />
Pascolo eccessivo<br />
L’esercizio del pascolo quando eccede l’in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> pascolamento sostenibile per i boschi,<br />
soprattutto nei popolamenti forestali situati nei pressi delle aziende agricole, tende a far<br />
degradare il bosco stesso in una sorta <strong>di</strong> pascolo arborato strettamente connesso alle esigenze<br />
dell’azienda. L’esercizio del pascolo (prevalentemente bovino), spinto oltre una soglia critica,<br />
determina <strong>di</strong>verse conseguenze negative tra le quali il compattamento del suolo, la riduzione<br />
dello stato erbaceo e arbustivo. Inoltre, l’eccessiva pressione del pascolo rende <strong>di</strong>fficile se non<br />
impossibile l’inse<strong>di</strong>amento della rinnovazione gamica. Ciò pregiu<strong>di</strong>ca l’esistenza a lungo<br />
termine dell’habitat forestale che degrada verso altre formazioni (macchia, gariga, infine<br />
steppa).<br />
Rilevanza: me<strong>di</strong>a, localmente alta<br />
Incen<strong>di</strong><br />
La pratica <strong>di</strong> incen<strong>di</strong>are le stoppie e gli incen<strong>di</strong> dolosi in <strong>generale</strong> rappresentano per l’area un<br />
oggettivo problema, in particolare per le specie animali a minore mobilità e per i ni<strong>di</strong>acei<br />
nonché per alcune tipologie <strong>di</strong> habitat:<br />
Querceti <strong>di</strong> Quercus troiana;<br />
Foreste <strong>di</strong> Quercus ilex;<br />
Pinete me<strong>di</strong>terranee <strong>di</strong> pini mesogeni endemici<br />
Rilevanza: me<strong>di</strong>a, localmente alta.<br />
Discariche abusive e contaminazioni<br />
La presenza <strong>di</strong>ffusa soprattutto nelle gravine prossime ai centri abitati e nelle aree meno<br />
presi<strong>di</strong>ate dall’agricoltura, <strong>di</strong> abbandoni, <strong>di</strong>scariche abusive e sversamenti <strong>di</strong> fanghi e sostanze<br />
tossiche, rappresenta un detrattore per l’ambiente.<br />
Rilevanza: bassa, localmente alta.<br />
Utilizzo <strong>di</strong> pestici<strong>di</strong> ed altri agenti inquinanti<br />
L’uso <strong>di</strong> insettici<strong>di</strong> determina una <strong>di</strong>minuzione delle potenzialità trofiche <strong>di</strong> vaste aree. Specie<br />
insettivore come il Grillaio o l'Occhione sono molto sensibili a qualsiasi intervento che<br />
preveda l’uso massiccio dei bioci<strong>di</strong>.<br />
Come ben noto, la maggior parte dei bioci<strong>di</strong> residuano nei tessuti e tendono ad avere un<br />
effetto negativo sul successo riproduttivo. L’espansione agricola, soprattutto delle pratiche<br />
intensive <strong>di</strong> coltivazione, determina un forte aumento dell’uso <strong>di</strong> insettici<strong>di</strong>, con effetti<br />
negativi sulle popolazioni <strong>di</strong> insettivori.<br />
Nell’area in oggetto la recente massiccia espansione agricola rende necessario stu<strong>di</strong> <strong>di</strong><br />
approfon<strong>di</strong>mento per la valutazione dell’influenza dei bioci<strong>di</strong> sulle popolazioni animali<br />
presenti all’interno del sito.<br />
Rilevanza: me<strong>di</strong>a, potenzialmente alta.<br />
98
Caccia e bracconaggio<br />
Per le specie migratrici, come il Grillaio e il Capovaccaio, che frequentano l'area delle gravine<br />
per ni<strong>di</strong>ficare da marzo a settembre, periodo in cui la caccia è chiusa, l'impatto <strong>di</strong> tale attività<br />
si può ritenere basso. Al contrario, la caccia <strong>di</strong> frodo e il bracconaggio, abbastanza <strong>di</strong>ffuso<br />
nell'area, è rivolto alla cattura delle Allodole. Tale "caccia" si attua attraverso l'utilizzo <strong>di</strong><br />
richiami registrati <strong>di</strong> tali uccelli e si effettua all'inizio della primavera e a fine estate-inizio<br />
autunno in aree aperte quali coltivazioni a cereali, pascoli e praterie ad Asfodeli, tutti ambienti<br />
frequentati da numerose specie rientranti negli allegati delle <strong>di</strong>rettive comunitarie, quali<br />
Calandra, Calandrella, Tottavilla e Calandro. L'impatto <strong>di</strong> tale attività illegale non è<br />
conosciuto ma si ritiene che molti esemplari possano, per ignoranza, essere abbattuti.<br />
Rilevanza: me<strong>di</strong>a<br />
Urbanizzazione e sviluppo industriale<br />
Il crescente sviluppo dei centri urbani determina la loro espansione a scapito della aree<br />
agricole e naturali presenti a ridosso delle periferie. Per una specie sinantropica quale il<br />
Grillaio, che ni<strong>di</strong>fica nelle vecchie costruzioni dei centri storici e si nutre nelle aree aperte<br />
circostanti, l'espansione delle periferie, con strutture non idonee alla riproduzione, può<br />
determinare un fenomeno <strong>di</strong> allontanamento dei siti <strong>di</strong> ni<strong>di</strong>ficazione da quelli <strong>di</strong> alimentazione<br />
producendo una maggiore richiesta energetica. Durante la delicata fase dell'allevamento della<br />
prole i genitori sono fortemente <strong>di</strong>pendenti dalle aree trofiche più prossime alla colonia e da<br />
stu<strong>di</strong> condotti in Spagna si è osservato come in tale periodo essi non si allontanino oltre i 10<br />
km dal centro della colonia.<br />
L’espansione delle periferie oltre a rendere la ricerca del cibo più <strong>di</strong>spen<strong>di</strong>osa causa la<br />
scomparsa <strong>di</strong>retta <strong>di</strong> aree utili all'alimentazione del Grillaio.<br />
La progressiva proliferazione <strong>di</strong> inse<strong>di</strong>amenti industriali, generalmente <strong>di</strong> piccole <strong>di</strong>mensioni,<br />
all'interno del paesaggio agricolo dell'area delle Gravine determina l'introduzione <strong>di</strong> ulteriori<br />
fattori <strong>di</strong> rischio sulla fauna, soprattutto quando i nuovi inse<strong>di</strong>amenti vengono realizzati su<br />
aree ad alto valore ambientale.<br />
Rilevanza: alta, localmente me<strong>di</strong>a.<br />
Ristrutturazione dei centri storici<br />
Il Grillaio è una specie sinantropica, ed in Puglia il 90% delle coppie ni<strong>di</strong>ficano nei centri<br />
storici dei comuni della Murgia <strong>di</strong> Bari e dell’area delle gravine dell’arco ionico. Attualmente<br />
sono in corso una serie <strong>di</strong> progetti <strong>di</strong> riqualificazione urbana in tutti i comuni interessati dalla<br />
presenza del Grillaio che non tengono conto delle esigenze vitali della specie. Ad esempio, le<br />
ristrutturazioni vengono spesso eseguite in piena stagione riproduttiva (marzo-luglio) con<br />
conseguente abbandono del sito <strong>di</strong> ni<strong>di</strong>ficazione e chiusura della maggior parte delle cavità<br />
utilizzate dal Grillaio per ni<strong>di</strong>ficare. In tali con<strong>di</strong>zioni le colonie riproduttive possono subire<br />
una pesante minaccia con per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> siti <strong>di</strong> ni<strong>di</strong>ficazione in quanto si impe<strong>di</strong>sce la<br />
riproduzione, riducendo la <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> siti idonei.<br />
Rilevanza: me<strong>di</strong>a, localmente alta.<br />
99
Elettrocuzione e collisione contro i cavi elettrici e gli impianti eolici<br />
Una delle maggiori cause <strong>di</strong> mortalità per <strong>di</strong>verse specie <strong>di</strong> rapaci <strong>di</strong> me<strong>di</strong>e e gran<strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>mensioni (Lanario, Capovaccaio, Gufo reale, Biancone e Nibbio reale) è legata<br />
all'elettrocuzione e all'impatto contro i cavi elettrici. Tralicci, linee elettriche e impianti eolici<br />
sono fattori <strong>di</strong> grande pericolo per gli avvoltoi, e in <strong>generale</strong> per i rapaci e le altre specie <strong>di</strong><br />
gran<strong>di</strong> veleggiatori rappresentando un grosso problema per la loro conservazione.<br />
A tale fine nelle aree <strong>di</strong> ni<strong>di</strong>ficazione, o comunque ritenute importanti per la conservazione<br />
dei rapaci, devono essere utilizzati degli accorgimenti tesi a minimizzare la probabilità <strong>di</strong> un<br />
impatto con tali strutture.<br />
Altro aspetto che nel prossimo futuro potrebbe rappresentare un potenziale problema è la<br />
realizzazione nell’area <strong>di</strong> impianti eolici, il cui impatto sulla fauna meriterebbe ulteriori<br />
approfon<strong>di</strong>menti.<br />
Rilevanza: alta.<br />
Sovrasfruttamento delle risorse idriche: la carenza della <strong>di</strong>sponibilità idrica per le specie<br />
naturali, costituisce un concreto fattore <strong>di</strong> rischio per il depauperamento degli habitat naturali<br />
e la per<strong>di</strong>ta delle bio<strong>di</strong>versità. In particolare, dall’analisi effettuata emergono comportamenti<br />
poco sostenibili per quanto concerne l’utilizzo <strong>di</strong> acque per l’irrigazione.<br />
Rilevanza: potenzialmente alta.<br />
Limitato controllo del territorio: tra le varie criticità emerse nell’ambito dell’analisi<br />
effettuata, vi è anche l’insufficienza <strong>di</strong> controllo del territorio. È, infatti, alquanto con<strong>di</strong>visa<br />
l’opinione secondo cui un incremento <strong>di</strong> tale controlli potrebbe esercitare un effetto deterrente<br />
ed ostacolare l’emergere <strong>di</strong> comportamenti in<strong>di</strong>viduali lesivi per gli habitat e le specie presenti<br />
nell’area <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o.<br />
Carenza <strong>di</strong> dati ambientali nelle aree protette e monitoraggio ambientale: la presenza,<br />
nelle imme<strong>di</strong>ate vicinanze delle zone in esame, <strong>di</strong> inse<strong>di</strong>amenti industriali <strong>di</strong> notevoli<br />
<strong>di</strong>mensioni, caratterizzati da rilasci in atmosfera <strong>di</strong> CO2 e <strong>di</strong> sostanze inquinanti, richiede<br />
l’installazione <strong>di</strong> sensori <strong>di</strong> tipo ambientale nelle stazioni <strong>di</strong> monitoraggio esistenti ed operanti<br />
in telemisura, allo scopo <strong>di</strong> poter più efficacemente valutare eventuali impatti sulla flora, sulla<br />
fauna e sulle matrici ambientali (aria, acqua e suolo).<br />
Rilevanza: me<strong>di</strong>a.<br />
Modesta percezione delle problematiche ambientali: l’analisi effettuata ha consentito,<br />
inoltre, <strong>di</strong> porre in evidenza la limitata comprensione delle problematiche ambientali che<br />
caratterizzano l’area in esame, con conseguente limitata partecipazione attiva delle comunità<br />
locali alla tutela delle aree naturali.<br />
Rilevanza: alta.<br />
100
3.7.1. Quadro riassuntivo <strong>di</strong> minacce e fattori limitanti, specie su cui agiscono e<br />
rilevanza<br />
Minacce e fattori limitanti attuali Specie su cui agiscono Rilevanza<br />
Spietramento degli habitat steppici Capovaccaio, Grillaio, Occhione, Ghiandaia Alta<br />
marina, Calandro, Calandra, Calandrella,<br />
Averla cenerina, Averla piccola Chirotteri,<br />
Rettili.<br />
Abbandono della pastorizia<br />
Capovaccaio, Nibbio reale, Grillaio, Alta<br />
Occhione, Ghiandaia marina, Calandra,<br />
Calandrella<br />
Tagli boschivi irrazionali Nibbio reale, Biancone Alta<br />
Impianto <strong>di</strong> vigneti<br />
Capovaccaio, Grillaio, Occhione, Calandro,<br />
Calandra, Calandrella, Averla cenerina,<br />
Averla piccola Chirotteri, Rettili.<br />
Riforestazione naturale e artificiale<br />
Pascolo eccessivo<br />
Capovaccaio, Grillaio, Occhione, Ghiandaia<br />
marina, Calandro, Calandra, Calandrella,<br />
Averla cenerina, Averla piccola Chirotteri,<br />
Rettili.<br />
Grillaio, Occhione, Ghiandaia marina,<br />
Calandro, Calandra, Calandrella, Tottavilla,<br />
Chirotteri, rettili.<br />
Me<strong>di</strong>a, localmente<br />
alta<br />
Me<strong>di</strong>a, localmente<br />
alta<br />
Incen<strong>di</strong> tutte Me<strong>di</strong>a, localmente<br />
alta<br />
Discariche abusive tutte Me<strong>di</strong>a, localmente<br />
alta<br />
Pestici<strong>di</strong> ed altri agenti inquinanti tutte Me<strong>di</strong>a,<br />
potenzialmente alta<br />
Urbanizzazione e sviluppo industriale<br />
(comprensivo della <strong>di</strong>struzione delle<br />
piccole raccolte d’acqua)<br />
Grillaio, Chirotteri.<br />
Alta<br />
Me<strong>di</strong>a, localmente<br />
alta<br />
Ristrutturazione dei centri storici Grillaio, Chirotteri. Me<strong>di</strong>a, localmente<br />
alta<br />
Caccia e bracconaggio<br />
Lanario, Falco pellegrino, Calandra, Me<strong>di</strong>a<br />
Calandrella, Tottavilla e Calandro<br />
Elettrocuzione, collisione contro i cavi Capovaccaio, Lanario, Biancone, Gufo reale, Alta<br />
elettrici e impianti eolici<br />
Nibbio reale,Nibbio bruno, Falco pellegrino,<br />
Occhione e Chirotteri<br />
Carenza <strong>di</strong> sostanza organica Tutte Alta<br />
Eccessivo utilizzo <strong>di</strong> acqua Tutte Potenzialmente alta<br />
Carenza <strong>di</strong> dati ambientali nelle aree Tutte<br />
Me<strong>di</strong>a<br />
protette e monitoraggio ambientale<br />
Modesta percezione delle Tutte<br />
Alta<br />
problematiche ambientali<br />
101
3.7.2. Quadro riassuntivo <strong>di</strong> minacce e fattori limitanti, Habitat su cui agiscono e<br />
rilevanza<br />
Minacce e fattori<br />
limitanti attuali<br />
Spietramento degli<br />
habitat steppici<br />
Abbandono della<br />
pastorizia<br />
Tagli boschivi<br />
irrazionali<br />
Impianto <strong>di</strong> vigneti<br />
Riforestazione<br />
naturale e artificiale<br />
Pascolo eccessivo<br />
Incen<strong>di</strong><br />
Discariche abusive<br />
Utilizzo <strong>di</strong> pestici<strong>di</strong> e<br />
altri agenti<br />
inquinanti<br />
Urbanizzazione e<br />
sviluppo industriale<br />
Habitat su cui agiscono<br />
Rilevanza<br />
Percorsi substeppici <strong>di</strong> graminacee e piante annue (Thero- Alta<br />
Brachypo<strong>di</strong>etea) (*)<br />
Percorsi substeppici <strong>di</strong> graminacee e piante annue (Thero- Alta<br />
Brachypo<strong>di</strong>etea) (*)<br />
Querceti <strong>di</strong> Quercus troiana<br />
Alta<br />
Foreste <strong>di</strong> Quercus ilex<br />
Pinete me<strong>di</strong>terranee <strong>di</strong> pini mesogeni endemici<br />
Percorsi substeppici <strong>di</strong> graminacee e piante annue (Thero- Me<strong>di</strong>a, localmente<br />
Brachypo<strong>di</strong>etea) (*)<br />
alta<br />
Percorsi substeppici <strong>di</strong> graminacee e piante annue (Thero- Alta<br />
Brachypo<strong>di</strong>etea) (*)<br />
Querceti <strong>di</strong> Quercus troiana<br />
Foreste <strong>di</strong> Quercus ilex<br />
Pinete me<strong>di</strong>terranee <strong>di</strong> pini mesogeni endemici<br />
Foreste a galleria <strong>di</strong> Salix alba e Populus alba.<br />
Percorsi substeppici <strong>di</strong> graminacee e piante annue (Thero- Me<strong>di</strong>a, localmente<br />
Brachypo<strong>di</strong>etea) (*)<br />
alta<br />
Querceti <strong>di</strong> Quercus troiana<br />
Foreste <strong>di</strong> Quercus ilex<br />
Querceti <strong>di</strong> Quercus troiana<br />
Me<strong>di</strong>a, localmente<br />
Foreste <strong>di</strong> Quercus ilex<br />
alta<br />
Pinete me<strong>di</strong>terranee <strong>di</strong> pini mesogeni endemici<br />
Formazioni <strong>di</strong> Euphorbia dendroides<br />
Percorsi substeppici <strong>di</strong> graminacee e piante annue (Thero- Localmente alta<br />
Brachypo<strong>di</strong>etea) (*)<br />
Querceti <strong>di</strong> Quercus troiana<br />
Foreste <strong>di</strong> Quercus ilex<br />
Pinete me<strong>di</strong>terranee <strong>di</strong> pini mesogeni endemici<br />
Formazioni <strong>di</strong> Euphorbia dendroides<br />
Foreste a galleria <strong>di</strong> Salix alba e Populus alba.<br />
Querceti <strong>di</strong> Quercus troiana<br />
sconosciuta,<br />
Foreste <strong>di</strong> Quercus ilex<br />
potenzialmente alta.<br />
Pinete me<strong>di</strong>terranee <strong>di</strong> pini mesogeni endemici<br />
Percorsi substeppici <strong>di</strong> graminacee e piante annue (Thero-<br />
Brachypo<strong>di</strong>etea) (*)<br />
Formazioni <strong>di</strong> Euphorbia dendroides<br />
Foreste a galleria <strong>di</strong> Salix alba e Populus alba<br />
Querceti <strong>di</strong> Quercus troiana<br />
alta, localmente<br />
Foreste <strong>di</strong> Quercus ilex<br />
me<strong>di</strong>a.<br />
Pinete me<strong>di</strong>terranee <strong>di</strong> pini mesogeni endemici<br />
Percorsi substeppici <strong>di</strong> graminacee e piante annue (Thero-<br />
Brachypo<strong>di</strong>etea) (*)<br />
Formazioni <strong>di</strong> Euphorbia dendroides<br />
Foreste a galleria <strong>di</strong> Salix alba e Populus alba<br />
102
4. OBIETTIVI DEL PIANO DI GESTIONE<br />
• Obiettivo <strong>generale</strong><br />
Definizione preliminare degli obiettivi<br />
Come definito dall’art. 6 della Direttiva “Habitat”, “ gli Stati membri stabiliscono le misure <strong>di</strong><br />
conservazione necessarie che implicano, all'occorrenza, appropriati piani <strong>di</strong> gestione<br />
specifici o integrati ad altri piani <strong>di</strong> sviluppo e le opportune misure regolamentari,<br />
amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi <strong>di</strong> habitat<br />
naturali <strong>di</strong> cui all’allegato I e delle specie <strong>di</strong> cui all’allegato II presenti nei siti”. Tali<br />
in<strong>di</strong>cazioni sono riportate anche dall’art. 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357 (regolamento<br />
attuativo della <strong>di</strong>rettiva Habitat).<br />
Inoltre, secondo quanto in<strong>di</strong>cato all’art. 4 della Direttiva “Uccelli” “Per le specie elencate<br />
nell’Allegato I sono previste misure speciali <strong>di</strong> conservazione per quanto riguarda l’habitat,<br />
per garantire la sopravvivenza e la riproduzione <strong>di</strong> dette specie nella loro area <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>stribuzione”.<br />
Sono quin<strong>di</strong> da prevedere misure esplicite finalizzate a raggiungere gli obiettivi generali della<br />
<strong>di</strong>rettiva, cioè “…il mantenimento o il ripristino, in uno stato <strong>di</strong> conservazione sod<strong>di</strong>sfacente,<br />
degli habitat naturali e delle specie <strong>di</strong> fauna e <strong>di</strong> flora <strong>di</strong> interesse comunitario”, tenendo<br />
conto “delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e<br />
locali”.<br />
Le misure da adottare devono ovviamente basarsi sulle esigenze ecologiche delle specie e<br />
degli habitat da tutelare.<br />
I piani <strong>di</strong> gestione devono quin<strong>di</strong> essere definiti in base alle specie e agli habitat <strong>di</strong> interesse<br />
comunitario effettivamente presenti nei siti (ad eccezione <strong>di</strong> quelli considerati come “non<br />
significativi” nel formulario standard <strong>di</strong> Natura 2000) e alle loro esigenze ecologiche.<br />
Occorre inoltre considerare gli altri piani <strong>di</strong> sviluppo esistenti, le esigenze generali <strong>di</strong> carattere<br />
socio-economico, oltre che la sostenibilità -anche economica- delle scelte fatte nel passato.<br />
Occorre in sostanza definire prima gli obiettivi <strong>di</strong> conservazione del sito e quin<strong>di</strong> le misure<br />
ritenute “opportune”, anche in base alle specifiche realtà locali.<br />
Gli obiettivi <strong>di</strong> conservazione del sito <strong>di</strong>pendono quin<strong>di</strong> da quali specie ed habitat <strong>di</strong> interesse<br />
comunitario sono presenti in modo ritenuto significativo.<br />
Poiché possono verificarsi casi <strong>di</strong> “concorrenza” fra <strong>di</strong>versi habitat e specie, cioè casi in cui le<br />
misure opportune per una o più specie o habitat risultano sfavorevoli per altre specie o habitat,<br />
appare utile stabilire degli elenchi <strong>di</strong> priorità <strong>di</strong> conservazione per sito o gruppo <strong>di</strong> siti<br />
(favorendo ad esempio le specie prioritarie oppure globalmente minacciate, oppure dando la<br />
precedenza alle specie per le quali il sito riveste maggiore importanza).<br />
• Obiettivi generali e specifici<br />
Obiettivo <strong>generale</strong> del Piano <strong>di</strong> gestione è la conservazione della bio<strong>di</strong>versità del sito, in<br />
termini <strong>di</strong> specie, comunità e paesaggio.<br />
Nell'area delle gravine dell'arco ionico è necessario mantenere, nel breve periodo, gli attuali<br />
livelli <strong>di</strong> popolazione delle specie <strong>di</strong> interesse comunitario, garantendo la tutela delle aree<br />
103
trofiche principali, rappresentate dagli habitat <strong>di</strong> tipo steppico (habitat prioritario per la<br />
Direttiva Habitat 92/43/CEE), e dei siti <strong>di</strong> ni<strong>di</strong>ficazione. A tale scopo risulta <strong>di</strong> fondamentale<br />
importanza vietare in modo assoluto lo spietramento.<br />
Sarà, altresì, necessario garantire un elevato grado <strong>di</strong> tutela ai siti <strong>di</strong> ni<strong>di</strong>ficazione <strong>di</strong> tutte le<br />
specie rupicole particolarmente sensibili al <strong>di</strong>sturbo antropico (Capovaccaio, Lanario e Gufo<br />
reale).<br />
Nel me<strong>di</strong>o-lungo periodo sarà necessario sviluppare meto<strong>di</strong>che <strong>di</strong> ripristino <strong>di</strong> aree <strong>di</strong> tipo<br />
steppico favorendo, anche attraverso l'adozione <strong>di</strong> politiche agricole specifiche, il recupero<br />
delle aree evolutesi verso formazioni vegetali a gariga o trasformate artificialmente in<br />
rimboschimenti <strong>di</strong> Pinacee.<br />
Tale obiettivo <strong>generale</strong> è sotto-articolabile nei seguenti obiettivi specifici:<br />
1. conservazione e ripristino degli habitat steppici<br />
Lo spietramento rappresenta la maggiore minaccia per la conservazione dell'habitat steppico<br />
per la Puglia. La pratica dello "spietramento", dopo aver impoverito la <strong>di</strong>versità genetica delle<br />
colture tra<strong>di</strong>zionali ha frammentato le vegetazioni spontanee e semplificato i mosaici<br />
ambientali con l'estensione delle monocolture intensive. Tale pratica, malgrado gli attuali<br />
<strong>di</strong>vieti, continua ad essere effettuata e determina la continua per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> aree trofiche per specie<br />
prioritarie come il Grillaio e aree <strong>di</strong> ni<strong>di</strong>ficazione e trofiche per specie come Occhione,<br />
Calandra, Calandrella, Calandro, Averla cenerina e Averla piccola, chirotteri, rettili e anfibi.<br />
L’insieme <strong>di</strong> queste azioni è finalizzata alla conservazione delle aree steppiche e al<br />
mantenimento dell'attuale integrità paesaggistica attraverso la pre<strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> una serie <strong>di</strong><br />
misure e <strong>di</strong> interventi che, oltre al <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> effettuare la pratica in aree ritenute “sensibili”,<br />
inducano forme “ragionevoli” <strong>di</strong> uso del territorio agrario, rendendo economicamente non<br />
conveniente il <strong>di</strong>ssodamento e la messa a coltura <strong>di</strong> aree marginali e promuovendo le buone<br />
pratiche che aiutino i proprietari a mantenere l’integrità dei luoghi o tramite la conversione<br />
dei terreni coltivati in aree a pascolo anche attraverso l’incentivazione all’allevamento <strong>di</strong><br />
razze domestiche autoctone.<br />
2. conservazione degli habitat forestali<br />
Nonostante la riduzione del prelievo legnoso, che in <strong>di</strong>versi casi sta determinando una<br />
conversione naturale dei cedui matricinati verso strutture <strong>di</strong> non facile definizione,<br />
assimilabili al ceduo composto o alla fustaia coetanea irregolare, sono ancora molto evidenti<br />
gli effetti delle ceduazioni compiute ripetutamente nel tempo, con turni ravvicinati e con<br />
riprese spesso eccedenti l’incremento me<strong>di</strong>o. Per consentire la conservazione <strong>di</strong> questi habitat<br />
è necessario avviare interventi selvicolturali che recepiscano le in<strong>di</strong>cazioni della Gestione<br />
Forestale Sostenibile con approcci che si devono, per quanto possibile, <strong>di</strong>fferenziare dalla<br />
selvicoltura fino ad ora praticata in questi boschi. A tal fine deve essere stabilita una rete<br />
permanente <strong>di</strong> punti <strong>di</strong> campionamento in cui perio<strong>di</strong>camente monitorare i principali<br />
in<strong>di</strong>catori che descrivono lo stato <strong>di</strong> conservazione degli habitat forestali. Per i cedui si ritiene<br />
opportuno verificare la possibilità <strong>di</strong> un ulteriore allungamento dei turni minimi e definire<br />
l’intensità minima <strong>di</strong> matricinatura. Inoltre, verificare dove sussistono le con<strong>di</strong>zioni<br />
ecologiche e sociali che consentano <strong>di</strong> avviare la conversione all’alto fusto. Gli eventuali<br />
interventi <strong>di</strong> rimboschimento e <strong>di</strong> rinfoltimento devono prevedere l’impiego esclusivo <strong>di</strong><br />
104
specie autoctone <strong>di</strong> ecotipi locali. Nelle zone boscate <strong>di</strong> proprietà pubblica, o dove misure <strong>di</strong><br />
conservazione più rigorose sono più facilmente adottabili, è da prevedere l’in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong><br />
piccole superfici soggette a tutela integrale in cui sia escluso qualsiasi tipo <strong>di</strong> intervento al <strong>di</strong><br />
fuori del monitoraggio. Infine appare necessario organizzare perio<strong>di</strong>che raccolte <strong>di</strong> materiale<br />
<strong>di</strong> propagazione ai sensi del D.lgs 386/2003.<br />
3. tutela e realizzazione dei corridoi ecologici<br />
Le attività antropiche hanno determinato non solo una riduzione delle superfici occupate da<br />
habitat o da altre fitocenosi non comprese negli allegati delle Direttive comunitarie ma anche<br />
la loro frammentazione. La riduzione delle superfici al <strong>di</strong> sotto <strong>di</strong> una soglia minima variabile<br />
per habitat e il loro isolamento costituisce una seria minaccia per la loro conservazione. È<br />
opportuno quin<strong>di</strong> la tutela e la realizazione <strong>di</strong> corridoi ecologici in grado <strong>di</strong> connettere le<br />
tessere dell’ecomosaico al fine <strong>di</strong> consentire gli scambi genici tra le popolazioni. Si ritiene<br />
opportuno anche la creazione <strong>di</strong> un corridoio ecologico in grado <strong>di</strong> assicurare la connessione<br />
tra le due parti separate che costituiscono il SIC – ZPS “Area delle gravine”<br />
4. protezione dei siti <strong>di</strong> ni<strong>di</strong>ficazione e incremento delle risorse trofiche delle specie<br />
d’interesse comunitario.<br />
Favorire le operazioni <strong>di</strong> restauro dei centri storici conciliandoli con le esigenze <strong>di</strong><br />
ni<strong>di</strong>ficazione del grillaio, attraverso una attenta campagna <strong>di</strong> sensibilizzazione degli addetti ai<br />
lavori e impedendo la <strong>di</strong>struzione dei siti <strong>di</strong> ni<strong>di</strong>ficazione esistenti.<br />
Favorire il mantenimento in buono stato <strong>di</strong> conservazione degli habitat steppici al fine <strong>di</strong><br />
incrementare le risorse trofiche per le specie riportate negli allegati delle <strong>di</strong>rettive.<br />
Favorire la protezione dei siti <strong>di</strong> ni<strong>di</strong>ficazione delle specie ad elevata sensibilità (Capovaccaio<br />
e Lanario), attraverso la regolamentazione <strong>di</strong> attività potenzialmente impattanti quali<br />
escursioni, lavori forestali e agricoli, arrampicata sportiva, caccia, ecc.<br />
Aumentare le risorse trofiche per le specie necrofaghe ed opportuniste attraverso la<br />
realizzazione <strong>di</strong> punti <strong>di</strong> alimentazione controllati.<br />
Verificare la presenza <strong>di</strong> situazioni <strong>di</strong> pericolo indotte dalla presenza <strong>di</strong> elettrodotti nei pressi<br />
dei siti <strong>di</strong> riproduzione e prevederne l’interramento.<br />
5. realizzazione <strong>di</strong> un uso sostenibile delle risorse naturali negli habitat <strong>di</strong> interesse<br />
comunitario e conservazione della <strong>di</strong>versità biologica.<br />
Il Piano definisce una politica <strong>di</strong> gestione ambientale rivolta non solo alla conservazione e<br />
tutela degli habitat ma propone un incentivo verso politiche <strong>di</strong> sviluppo ecosostenibili<br />
attraverso la pre<strong>di</strong>sposizione e l’adozione da parte dei comuni <strong>di</strong> specifici piani <strong>di</strong> settore tesi<br />
alla riduzione delle fonti <strong>di</strong> inquinamento atmosferico, idrico, acustico, elettromagnetico, ecc.<br />
In tal senso, appare particolarmente interessante l’adozione <strong>di</strong> strategie volte a ridurre i<br />
consumi idrici nelle nuove e<strong>di</strong>ficazioni ed a facilitare il recupero delle acque piovane.<br />
6. controllo dell’intero territorio del SIC-ZPS, ai fini della tutela della fauna e della<br />
flora, della prevenzione ambientale e della repressione <strong>di</strong> illeciti ambientali<br />
105
7. monitoraggio e ricerca<br />
Completamento delle conoscenze su specie/habitat nonché verifica delle azioni <strong>di</strong>rette <strong>di</strong><br />
conservazione. L’installazione <strong>di</strong> sensori ambientali presso le stazioni <strong>di</strong> monitoraggio<br />
attualmente presenti nelle aree protette considerate, consente <strong>di</strong> monitorare l’eventuale<br />
presenza <strong>di</strong> contaminanti eventualmente impattanti nei confronti degli habitat e delle specie in<br />
essi residenti.<br />
8. sensibilizzazione delle popolazioni verso le specie e gli habitat <strong>di</strong> interesse<br />
comunitario, anche per contribuire alla <strong>di</strong>ffusione del senso <strong>di</strong> appartenenza ai luoghi,<br />
favorendo la fruizione sostenibile delle aree protette.<br />
La mancanza <strong>di</strong> una <strong>di</strong>ffusa consapevolezza della fragilità del sistema ambientale, associata<br />
alla conoscenza <strong>di</strong> ipotesi <strong>di</strong> sviluppo e <strong>di</strong> forme integrative <strong>di</strong> red<strong>di</strong>to agrario, rappresentano<br />
fattori <strong>di</strong> criticità che possono essere superati attraverso azioni mirate <strong>di</strong> informazione e<br />
sensibilizzazione.<br />
Tali azioni, realizzate anche attraverso i no<strong>di</strong> del Sistema INFEA Puglia, presenti nell’area<br />
(Laboratorio <strong>di</strong> Educazione Ambientale dell’Area Jonica, e Centri <strong>di</strong> Educazione Ambientale<br />
<strong>di</strong> Manduria e <strong>di</strong> Statte) possono contribuire ad incrementare il senso <strong>di</strong> appartenenza ai<br />
luoghi e <strong>di</strong> affezione e tutela nei confronti delle aree protette, facilitando l’implementazione<br />
da parte dei citta<strong>di</strong>ni stessi <strong>di</strong> azioni per la protezione degli ecosistemi, quali, ad esempio,<br />
l’adozione <strong>di</strong> buone pratiche per la gestione del territorio.<br />
Informare le <strong>di</strong>verse categorie produttive interessate e la popolazione locale sull’importanza<br />
conservazionistica dell’area. Promuovere le attività svolte anche attraverso un adeguato<br />
coinvolgimento delle comunità locali con particolare riferimento ai giovani nella salvaguar<strong>di</strong>a<br />
degli habitat.<br />
Da punto <strong>di</strong> vista specifico le in<strong>di</strong>cazioni <strong>di</strong> carattere <strong>generale</strong> precedentemente descritte<br />
devono essere recepiti negli in<strong>di</strong>rizzi <strong>di</strong> carattere urbanistico.<br />
A tal fine per l’attuazione del piano <strong>di</strong> gestione della ZPS vanno presi in considerazione tre<br />
aspetti: l’aspetto procedurale, l’aspetto <strong>di</strong> equità, l’aspetto valutativo.<br />
Per l’aspetto procedurale si può ricorrere, una volta approvato piano <strong>di</strong> gestione, ad una<br />
“Variante Urbanistica <strong>di</strong> Salvaguar<strong>di</strong>a” con procedura <strong>di</strong> <strong>di</strong>chiarazione d’urgenza (da parte<br />
dell’organo competente regionale oppure da parte dell’organo competente provinciale e<br />
comunale) a stralcio delle in<strong>di</strong>cazioni sul perimetro definito degli habitat prioritari<br />
“riconosciuti” da parte dello strumento urbanistico vigente, in approvazione e/o in<br />
formazione. La variante <strong>di</strong> salvaguar<strong>di</strong>a segue le procedure definite dal punto c) dell’art 12<br />
(Variazioni al PUG) della Legge Regionale 20/2001. “Mo<strong>di</strong>fiche <strong>di</strong> perimetrazioni motivate<br />
da documentate e sopravvenute esigenze quali imposizioni <strong>di</strong> nuovi vincoli”.<br />
Per l’aspetto <strong>di</strong> equità si fa riferimento agli artt. 2 e 14 della L.R. 20/2001, che introducono il<br />
principio della “perequazione”. In questo caso il principio dovrebbe essere applicato alle aree<br />
in<strong>di</strong>viduate come “habitat” prioritario e riconosciute attraverso forme <strong>di</strong> compensazione al<br />
proprietario dell’area, in termini onerosi o <strong>di</strong> volumi e<strong>di</strong>ficabili (secondo gli in<strong>di</strong>ci esistenti<br />
sull’area e trasportato in altre zone, non necessariamente contigue).<br />
106
Per l’aspetto valutativo si dovranno costruire delle griglie <strong>di</strong> in<strong>di</strong>catori ambientali ed<br />
economici per la definizione e la valutazione degli interventi compresi all’interno <strong>di</strong><br />
programmi finanziati da fon<strong>di</strong> strutturali o fon<strong>di</strong> nazionali che vanno ad insistere nelle ZPS.<br />
Occorrerà effettuare una doppia valutazione: quella dell’intero programma con le procedure<br />
introdotte dalla <strong>di</strong>rettiva comunitaria in termini <strong>di</strong> Valutazione Ambientale Strategica come<br />
definite dagli articoli nn. 22, 23 e 24 della L.R. 11/2001 e quella singola attraverso la<br />
“Valutazione <strong>di</strong> Incidenza”.<br />
107
5. STRATEGIE DI GESTIONE<br />
La strategia del Piano <strong>di</strong> Gestione si realizza attraverso un set <strong>di</strong> “azioni” <strong>di</strong> <strong>di</strong>fferente natura:<br />
− interventi attivi (IA)<br />
− regolamentazioni (RE)<br />
− incentivazioni (IN)<br />
− programmi <strong>di</strong> monitoraggio (PM)<br />
− programmi <strong>di</strong>dattici (PD).<br />
Gli interventi attivi (IA) sono generalmente orientati a rimuovere/ridurre un fattore <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>sturbo ovvero a “orientare” una <strong>di</strong>namica naturale.<br />
Le regolamentazioni (RE) possono perseguire la tutela delle formazioni naturali e<br />
l’interruzione delle azioni <strong>di</strong> <strong>di</strong>sturbo sulle <strong>di</strong>verse componenti naturali (acqua, suolo,<br />
vegetazione, fauna).<br />
Le incentivazioni (IN) hanno la finalità <strong>di</strong> sollecitare l’introduzione presso le popolazioni<br />
locali <strong>di</strong> pratiche, procedure o metodologie gestionali <strong>di</strong> varia natura (agricole, forestali,<br />
produttive ecc.) che favoriscano il raggiungimento degli obiettivi del piano <strong>di</strong> gestione.<br />
I programmi <strong>di</strong> monitoraggio e/o ricerca (PMR) hanno anche la finalità <strong>di</strong> verificare il<br />
successo delle azioni proposte dal Piano <strong>di</strong> Gestione; tra tali programmi sono stati inseriti<br />
anche gli approfon<strong>di</strong>menti conoscitivi necessari a definire più precisamente le<br />
regolamentazioni.<br />
I programmi <strong>di</strong>dattici (PD) sono <strong>di</strong>rettamente orientati alla conoscenza e all’educazione<br />
ambientale, in<strong>di</strong>rettamente mirano al coinvolgimento delle popolazioni locali nella tutela del<br />
sito.<br />
108
6. AZIONI DI GESTIONE – SCHEDE TECNICHE<br />
Le azioni in<strong>di</strong>viduate per la gestione dell'area delle gravine dell'arco ionico sono state<br />
descritte in specifiche Schede, al fine <strong>di</strong> fornire all’Ente gestore utili strumenti operativi per<br />
attuare le in<strong>di</strong>cazioni gestionali.<br />
Tali schede descrivono per ogni azione aspetti e modalità tecnico-operative e in<strong>di</strong>viduano<br />
soggetti e risorse che dovrebbero essere coinvolte nella fase <strong>di</strong> attuazione. Alcune schede<br />
descrivono un solo tipo <strong>di</strong> azione, altre raccolgono contemporaneamente azioni <strong>di</strong> tipo <strong>di</strong>verso<br />
(interventi attivi, regolamentazioni e monitoraggi), nel caso in cui esse siano strettamente<br />
interconnesse.<br />
Le azioni sono state inoltre classificate rispetto a vari livelli <strong>di</strong> priorità basati sui seguenti<br />
criteri:<br />
• priorità ELEVATA - azioni finalizzate a eliminare o mitigare fenomeni o processi <strong>di</strong><br />
degrado e/o <strong>di</strong>sturbo in atto<br />
• priorità MEDIA - azioni finalizzate a monitorare lo stato <strong>di</strong> conservazione del sito<br />
• priorità BASSA - azioni finalizzate a valorizzare le risorse del sito e alla promozione<br />
/fruizione del sito.<br />
6.1. Elenco schede delle azioni<br />
Identificativo<br />
Priorità<br />
dell’azione<br />
Descrizione<br />
IA1 ELEVATA Pulizia dei dormitori pre e post riproduttivi del Grillaio al fine <strong>di</strong> limitare<br />
l’accumulo <strong>di</strong> guano prodotto.<br />
IA2 ELEVATA Realizzazione ed installazione <strong>di</strong> ni<strong>di</strong> artificiali per il Grillaio<br />
IA3 ELEVATA Attuazione <strong>di</strong> un programma <strong>di</strong> sorveglianza dei siti <strong>di</strong> ni<strong>di</strong>ficazione noti<br />
per le specie particolarmente sensibili al <strong>di</strong>sturbo<br />
IA4 ELEVATA In<strong>di</strong>viduazione e rimozione degli impatti negativi derivanti dalla presenza<br />
<strong>di</strong> linee elettriche in prossimità <strong>di</strong> siti <strong>di</strong> ni<strong>di</strong>ficazione <strong>di</strong> specie sensibili.<br />
IA5 ELEVATA Realizzazione e gestione <strong>di</strong> un sistema <strong>di</strong> carnai<br />
IA6 BASSA Conservazione e realizzazione dei corridoi ecologici<br />
IA7 ELEVATA Interventi <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa dagli incen<strong>di</strong> boschivi<br />
IA8 – PMR -<br />
IN<br />
ELEVATA<br />
Conservazione degli habitat forestali<br />
IA9 ELEVATA Interventi <strong>di</strong> pulizia delle gravine<br />
IA10 BASSA Realizzazione <strong>di</strong> percorsi naturalistici/escursionistici/culturali<br />
IA11 BASSA Sviluppo della mobilità lenta/piste ciclabili<br />
109
Identificativo<br />
IA12 – RE –<br />
PMR<br />
Priorità<br />
dell’azione<br />
ELEVATA<br />
Descrizione<br />
Conservazione ex situ del germoplasma autoctono<br />
IA13 BASSA Realizzazione <strong>di</strong> connessioni ecologiche nella viabilità esistente<br />
IA14 BASSA Emissioni zero – Città Virtuose<br />
IA15 – RE -<br />
PMR<br />
MEDIA<br />
Conservazione in situ (Riserve genetiche) degli habitat vegetazionali <strong>di</strong><br />
interesse comunitario<br />
IA16 - PMR BASSA Censimento degli alberi monumentali e loro valorizzazione anche a fini<br />
eco-turistici<br />
IA17 ELEVATA Contenimento della <strong>di</strong>ffusione <strong>di</strong> specie alloctone invadenti<br />
IA18 – PMR -<br />
PD<br />
MEDIA<br />
Check-list della flora ed in<strong>di</strong>viduazione delle specie vegetali ad elevato<br />
valore biogeografico e conservazionistico<br />
IA19 - PMR MEDIA Carta della vegetazione redatta con il metodo fitosociologico<br />
IA20 - PMR8 MEDIA Monitoraggio della bio<strong>di</strong>versità vegetale (Aree <strong>di</strong> saggio)<br />
IA21 - IN BASSA Attività <strong>di</strong> informazione e sensibilizzazione<br />
IA22 - IN ELEVATA Promozione e sostegno <strong>di</strong> pratiche agricole sostenibili per la conservative<br />
e l’aumento della sostanza organica nei suoli<br />
IA23 - PMR MEDIA Installazione <strong>di</strong> “sensori ambientali” su stazioni esistenti<br />
IA24 BASSA Sistema <strong>di</strong> gestione ambientale ISO14001 – EMAS<br />
IN1 BASSA Sostegno ed incentivazione dell’agricoltura biologica<br />
IN2 BASSA Tutela della bio<strong>di</strong>versità in agricoltura e creazione della figura del<br />
coltivatore custode<br />
IN3 ELEVATA Sostegno agli investimenti non produttivi: ripristino dei muretti a secco.<br />
IN4 BASSA Sostegno alla conservazione delle pratiche agricole estensive tra<strong>di</strong>zionali:<br />
prati-pascoli e foraggiere<br />
PMR1 MEDIA Mappaggio degli e<strong>di</strong>fici interessati dalla ni<strong>di</strong>ficazione del Grillaio in ogni<br />
colonia urbana<br />
PMR2 MEDIA Monitoraggio e stu<strong>di</strong>o delle popolazioni ni<strong>di</strong>ficanti <strong>di</strong> rapaci <strong>di</strong>urni e<br />
notturni<br />
PMR3 MEDIA Monitoraggio e stu<strong>di</strong>o delle specie <strong>di</strong> uccelli <strong>di</strong> interesse comunitario<br />
legate alle aree steppiche<br />
PMR 4 MEDIA Monitoraggio e stu<strong>di</strong>o delle popolazioni <strong>di</strong> Chirotteri, Anfibi e Rettili <strong>di</strong><br />
interesse comunitario (All. II e IV <strong>di</strong>r. Habitat)<br />
PMR5 ELEVATA Realizzazione <strong>di</strong> un catasto delle aree occupate da habitat steppico<br />
110
Identificativo Priorità<br />
Descrizione<br />
dell’azione<br />
PMR6 - RE MEDIA Stu<strong>di</strong> sul sistema delle praterie steppiche<br />
PMR7 MEDIA Stu<strong>di</strong> e monitoraggio delle comunità <strong>di</strong> vertebrati presenti nel sito<br />
PMR8 MEDIA Stu<strong>di</strong> e monitoraggio delle comunità <strong>di</strong> invertebrati presenti nel sito<br />
PMR9 MEDIA Monitoraggio e piano <strong>di</strong> gestione della popolazione <strong>di</strong> Cinghiale Sus<br />
scrofa presente nel sito<br />
PD1 BASSA Realizzazione <strong>di</strong> materiali informativi tecnici per gli or<strong>di</strong>ni degli<br />
Architetti, degli Ingegneri e per le varie associazioni <strong>di</strong> categoria<br />
coinvolte nei progetti <strong>di</strong> ristrutturazione degli e<strong>di</strong>fici storici<br />
PD2 BASSA Sviluppo e organizzazione <strong>di</strong> programmi <strong>di</strong> educazione e <strong>di</strong>vulgazione<br />
ambientale in grado <strong>di</strong> <strong>di</strong>ffondere tra le popolazioni locali la conoscenza<br />
delle specie e la necessità <strong>di</strong> proteggerne gli habitat<br />
PD3 BASSA Progettazione e realizzazione <strong>di</strong> interventi <strong>di</strong> formazione specialistica<br />
destinati al personale degli enti pubblici territoriali e associazioni<br />
ambientaliste interessate e aventi ad oggetto la normativa ambientale<br />
internazionale, comunitaria, nazionale e regionale, con particolare<br />
riferimento agli strumenti giuri<strong>di</strong>ci e istituzionali <strong>di</strong> conservazione e tutela<br />
dei siti Natura 2000<br />
111
6.1.1. Tabella delle schede in funzione delle specie target<br />
Identificativo Descrizione Specie target habitat target<br />
IA1 Pulizia dei dormitori pre e post riproduttivi del Grillaio al fine <strong>di</strong> Grillaio<br />
limitare l’accumulo <strong>di</strong> guano prodotto.<br />
IA2 Realizzazione ed installazione <strong>di</strong> ni<strong>di</strong> artificiali per il Falco naumanni Grillaio<br />
IA3 Attuazione <strong>di</strong> un programma <strong>di</strong> sorveglianza dei siti <strong>di</strong> ni<strong>di</strong>ficazione noti Lanario, Gufo reale,<br />
per le specie particolarmente sensibili al <strong>di</strong>sturbo<br />
Capovaccaio, Gheppio,<br />
Barbagianni , Civetta, Passero<br />
solitario, Ghiandaia marina,<br />
Corvo imperiale, Monachella<br />
IA4 In<strong>di</strong>viduazione e rimozione degli impatti negativi derivanti dalla Galliformi, Gruiformi,<br />
presenza <strong>di</strong> linee elettriche in prossimità <strong>di</strong> siti <strong>di</strong> ni<strong>di</strong>ficazione <strong>di</strong> specie Pellicaniformi e Ciconiformi,<br />
sensibili.<br />
mentre<br />
Falconiformi,<br />
Stringiformi, Passeriformi,<br />
Ciconiformi<br />
IA5 Realizzazione e gestione <strong>di</strong> un sistema <strong>di</strong> carnai Capovaccaio, Nibbio reale,<br />
Nibbio bruno, Corvo imperiale<br />
IA6 Conservazione e realizzazione dei corridoi ecologici Tutte 9250;9540, 6220<br />
IA7 Interventi <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa dagli incen<strong>di</strong> boschivi 9250;9540, 9340<br />
IA8 – PMR - Conservazione degli habitat forestali 9250;9540, 9340, 92A0<br />
IN<br />
IA9 Interventi <strong>di</strong> pulizia delle gravine 5330, 8210, 92A0, 8310<br />
IA10 Realizzazione <strong>di</strong> percorsi naturalistici/escursionistici/culturali 5330, 6220, 8210, 8310,<br />
92A0, 9540, 9340, 9250<br />
IA11 Sviluppo della mobilità lenta/piste ciclabili<br />
IA12 – RE –<br />
PMR<br />
Conservazione ex situ del germoplasma autoctono 5330, 6220, 8210, 8310,<br />
92A0, 9540, 9340, 9250<br />
IA13 Realizzazione <strong>di</strong> connessioni ecologiche nella viabilità esistente Anfibi, rettili e mammiferi<br />
IA14 Emissioni zero – Città Virtuose<br />
IA15 – RE -<br />
PMR<br />
Conservazione in situ (Riserve genetiche) degli habitat vegetazionali <strong>di</strong><br />
interesse comunitario<br />
5330, 6220, 8210, 8310,<br />
92A0, 9540, 9340, 9250
Identificativo Descrizione Specie target habitat target<br />
IA16 - PMR<br />
Censimento degli alberi monumentali e loro valorizzazione anche a fini<br />
eco-turistici<br />
9250;9540, 9340<br />
IA17 Contenimento della <strong>di</strong>ffusione <strong>di</strong> specie alloctone invadenti 5330, 6220, 8210, 8310,<br />
92A0, 9540, 9340, 9250<br />
IA18 – PMR<br />
- PD<br />
Check-list della flora ed in<strong>di</strong>viduazione delle specie vegetali ad elevato<br />
valore biogeografico e conservazionistico<br />
5330, 6220, 8210, 8310,<br />
92A0, 9540, 9340, 9250<br />
IA19 - PMR Carta della vegetazione redatta con il metodo fitosociologico 5330, 6220, 8210, 8310,<br />
92A0, 9540, 9340, 9250<br />
IA20 - PMR8 Monitoraggio della bio<strong>di</strong>versità vegetale (Aree <strong>di</strong> saggio) 5330, 6220, 8210, 8310,<br />
92A0, 9540, 9340, 9250<br />
IA21 - IN Attività <strong>di</strong> informazione e sensibilizzazione Tutti 5330, 6220, 8210, 8310,<br />
92A0, 9540, 9340, 9250<br />
IA22 - IN Promozione e sostegno <strong>di</strong> pratiche agricole sostenibili per la<br />
conservative e l’aumento della sostanza organica nei suoli<br />
IA23 - PMR Installazione <strong>di</strong> “sensori ambientali” su stazioni esistenti<br />
IA24 Sistema <strong>di</strong> gestione ambientale ISO14001 – EMAS<br />
IN1 Sostegno ed incentivazione dell’agricoltura biologica Lepidotteri, Coleotteri,<br />
Oligocheti, micromammiferi<br />
IN2 Tutela della bio<strong>di</strong>versità in agricoltura e creazione della figura del<br />
coltivatore custode<br />
IN3 Sostegno agli investimenti non produttivi: ripristino dei muretti a secco. Invertebrati, Rettili, Anfibi,<br />
IN4 Sostegno alla conservazione delle pratiche agricole estensive<br />
tra<strong>di</strong>zionali: prati-pascoli e foraggiere<br />
PMR1 Mappaggio degli e<strong>di</strong>fici interessati dalla ni<strong>di</strong>ficazione del Grillaio in<br />
ogni colonia urbana<br />
Micromammiferi.<br />
Specie Steppiche (Alau<strong>di</strong><strong>di</strong>,<br />
Occhione, ect..)<br />
Grillaio<br />
PMR2 Monitoraggio e stu<strong>di</strong>o delle popolazioni ni<strong>di</strong>ficanti <strong>di</strong> rapaci <strong>di</strong>urni Capovaccaio, Grillaio, Nibbio<br />
reale, Nibbio bruno, Lanario e<br />
Biancone, Gufo reale, Civetta,<br />
Barbagianni, Gufo comune,<br />
Assiolo<br />
6220<br />
113
Identificativo Descrizione Specie target habitat target<br />
PMR3<br />
PMR 4<br />
Monitoraggio e stu<strong>di</strong>o delle specie <strong>di</strong> uccelli <strong>di</strong> interesse comunitario<br />
legate alle aree steppiche<br />
Monitoraggio e stu<strong>di</strong>o delle popolazioni <strong>di</strong> Chirotteri, Anfibi e Rettili <strong>di</strong><br />
interesse comunitario (All. II e IV <strong>di</strong>r. Habitat)<br />
Specie Steppiche (Alau<strong>di</strong><strong>di</strong>,<br />
Occhione, ect..)<br />
Chirotteri, Anfibi e Rettili <strong>di</strong><br />
interesse comunitario (All. II e<br />
IV <strong>di</strong>r. Habitat)<br />
PMR5 Realizzazione <strong>di</strong> un catasto delle aree occupate da habitat steppico Grillaio, Specie Steppiche<br />
(Alau<strong>di</strong><strong>di</strong>, Occhione, ect..)<br />
PMR6 - RE Stu<strong>di</strong> sul sistema delle praterie steppiche Grillaio, Specie Steppiche<br />
(Alau<strong>di</strong><strong>di</strong>, Occhione, ect..)<br />
PMR7 Stu<strong>di</strong>o e monitoraggio delle comunità <strong>di</strong> vertebrati presenti nel sito Chirotteri, Pesci<br />
PMR8 Stu<strong>di</strong>o e monitoraggio delle comunità <strong>di</strong> invertebrati presenti nel sito Lepidotteri, Coleotteri e<br />
Crostacei<br />
PMR9 Monitoraggio e piano <strong>di</strong> gestione della popolazione <strong>di</strong> Cinghiale Cinghiale<br />
presente nel sito<br />
PD1 Realizzazione <strong>di</strong> materiali informativi tecnici per gli or<strong>di</strong>ni degli Grillaio<br />
Architetti, degli Ingegneri e per le varie associazioni <strong>di</strong> categoria<br />
coinvolte nei progetti <strong>di</strong> ristrutturazione degli e<strong>di</strong>fici storici<br />
PD2<br />
PD3<br />
Sviluppo e organizzazione <strong>di</strong> programmi <strong>di</strong> educazione e <strong>di</strong>vulgazione<br />
ambientale in grado <strong>di</strong> <strong>di</strong>ffondere tra le popolazioni locali la conoscenza<br />
delle specie e la necessità <strong>di</strong> proteggerne gli habitat<br />
Progettazione e realizzazione <strong>di</strong> interventi <strong>di</strong> formazione specialistica<br />
destinati al personale degli enti pubblici territoriali e associazioni<br />
ambientaliste interessate e aventi ad oggetto la normativa ambientale<br />
internazionale, comunitaria, nazionale e regionale, con particolare<br />
riferimento agli strumenti giuri<strong>di</strong>ci e istituzionali <strong>di</strong> conservazione e<br />
tutela dei siti Natura 2000<br />
6220<br />
6220<br />
Tutte 5330, 6220, 8210, 8310,<br />
92A0, 9540, 9340, 9250<br />
Tutte 5330, 6220, 8210, 8310,<br />
92A0, 9540, 9340, 9250<br />
114
6.1.2. Sud<strong>di</strong>visione delle schede per strategie, specie e habitat<br />
Azioni finalizzate alla salvaguar<strong>di</strong>a, tutela, ripristino efficienza e funzionalità ecologica degli<br />
habitat e specie.<br />
Identificativo<br />
Priorità<br />
dell’azione<br />
Descrizione<br />
IA1 ELEVATA Pulizia dei dormitori pre e post riproduttivi del Grillaio al fine <strong>di</strong> limitare<br />
l’accumulo <strong>di</strong> guano prodotto.<br />
IA2 ELEVATA Realizzazione ed installazione <strong>di</strong> ni<strong>di</strong> artificiali per il Grillaio<br />
IA4 ELEVATA In<strong>di</strong>viduazione e rimozione degli impatti negativi derivanti dalla presenza<br />
<strong>di</strong> linee elettriche in prossimità <strong>di</strong> siti <strong>di</strong> ni<strong>di</strong>ficazione <strong>di</strong> specie sensibili.<br />
IA5 ELEVATA Realizzazione e gestione <strong>di</strong> un sistema <strong>di</strong> carnai<br />
IA6 BASSA Conservazione e realizzazione dei corridoi ecologici<br />
IA7 ELEVATA Interventi <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa dagli incen<strong>di</strong> boschivi<br />
IA8 – PMR -<br />
IN<br />
ELEVATA<br />
Conservazione degli habitat forestali<br />
IA9 ELEVATA Interventi <strong>di</strong> pulizia delle gravine<br />
IA12 – RE –<br />
PMR<br />
ELEVATA<br />
Conservazione ex situ del germoplasma autoctono<br />
IA13 BASSA Realizzazione <strong>di</strong> connessioni ecologiche nella viabilità esistente<br />
IA15 – RE -<br />
PMR<br />
MEDIA<br />
Conservazione in situ (Riserve genetiche) degli habitat vegetazionali <strong>di</strong><br />
interesse comunitario<br />
IA17 ELEVATA Contenimento della <strong>di</strong>ffusione <strong>di</strong> specie alloctone invadenti<br />
IA22 - IN ELEVATA Promozione e sostegno <strong>di</strong> pratiche agricole sostenibili per la conservative<br />
e l’aumento della sostanza organica nei suoli<br />
IN1 BASSA Sostegno ed incentivazione dell’agricoltura biologica<br />
IN2 BASSA Tutela della bio<strong>di</strong>versità in agricoltura e creazione della figura del<br />
coltivatore custode<br />
IN3 ELEVATA Sostegno agli investimenti non produttivi: ripristino dei muretti a secco.<br />
IN4 BASSA Sostegno alla conservazione delle pratiche agricole estensive tra<strong>di</strong>zionali:<br />
prati-pascoli e foraggiere
Azioni finalizzate all’approfon<strong>di</strong>mento della conoscenza, allo stu<strong>di</strong>o e monitoraggio della<br />
Bio<strong>di</strong>versità del sito.<br />
Identificativo<br />
Priorità<br />
dell’azione<br />
Descrizione<br />
IA3 ELEVATA Attuazione <strong>di</strong> un programma <strong>di</strong> sorveglianza dei siti <strong>di</strong> ni<strong>di</strong>ficazione noti<br />
per le specie particolarmente sensibili al <strong>di</strong>sturbo<br />
IA16 - PMR BASSA Censimento degli alberi monumentali e loro valorizzazione anche a fini<br />
eco-turistici<br />
IA18 – PMR -<br />
PD<br />
MEDIA<br />
Check-list della flora ed in<strong>di</strong>viduazione delle specie vegetali ad elevato<br />
valore biogeografico e conservazionistico<br />
IA19 - PMR MEDIA Carta della vegetazione redatta con il metodo fitosociologico<br />
IA20 - PMR8 MEDIA Monitoraggio della bio<strong>di</strong>versità vegetale (Aree <strong>di</strong> saggio)<br />
IA23 - PMR MEDIA Installazione <strong>di</strong> “sensori ambientali” su stazioni esistenti<br />
PMR1 MEDIA Mappaggio degli e<strong>di</strong>fici interessati dalla ni<strong>di</strong>ficazione del Grillaio in ogni<br />
colonia urbana<br />
PMR2 MEDIA Monitoraggio e stu<strong>di</strong>o delle popolazioni ni<strong>di</strong>ficanti <strong>di</strong> rapaci <strong>di</strong>urni e<br />
notturni<br />
PMR3 MEDIA Monitoraggio e stu<strong>di</strong>o delle specie <strong>di</strong> uccelli <strong>di</strong> interesse comunitario<br />
legate alle aree steppiche<br />
PMR 4 MEDIA Monitoraggio e stu<strong>di</strong>o delle popolazioni <strong>di</strong> Chirotteri, Anfibi e Rettili <strong>di</strong><br />
interesse comunitario (All. II e IV <strong>di</strong>r. Habitat)<br />
PMR5 ELEVATA Realizzazione <strong>di</strong> un catasto delle aree occupate da habitat steppico<br />
PMR6 - RE MEDIA Stu<strong>di</strong> sul sistema delle praterie steppiche<br />
PMR7 MEDIA Stu<strong>di</strong> e monitoraggio delle comunità <strong>di</strong> vertebrati presenti nel sito<br />
PMR8 MEDIA Stu<strong>di</strong> e monitoraggio delle comunità <strong>di</strong> invertebrati presenti nel sito<br />
PMR9 MEDIA Monitoraggio e piano <strong>di</strong> gestione della popolazione <strong>di</strong> Cinghiale Sus<br />
scrofa presente nel sito<br />
116
Azioni finalizzate all’educazione e sensibilizzazione, alla valorizzazione e fruizione del sito.<br />
Identificativo Priorità<br />
dell’azione<br />
Descrizione<br />
IA10 BASSA Realizzazione <strong>di</strong> percorsi naturalistici/escursionistici/culturali<br />
IA11 BASSA Sviluppo della mobilità lenta/piste ciclabili<br />
IA14 BASSA Emissioni zero – Città Virtuose<br />
IA16 - PMR BASSA Censimento degli alberi monumentali e loro valorizzazione anche a fini<br />
eco-turistici<br />
IA21 - IN<br />
IA24<br />
PD1<br />
PD2<br />
PD3<br />
BASSA<br />
BASSA<br />
BASSA<br />
BASSA<br />
BASSA<br />
Azioni specifiche “Capovaccaio”<br />
Identificativo<br />
Priorità<br />
dell’azione<br />
Attività <strong>di</strong> informazione e sensibilizzazione<br />
Sistema <strong>di</strong> gestione ambientale ISO14001 – EMAS<br />
Realizzazione <strong>di</strong> materiali informativi tecnici per gli or<strong>di</strong>ni degli<br />
Architetti, degli Ingegneri e per le varie associazioni <strong>di</strong> categoria<br />
coinvolte nei progetti <strong>di</strong> ristrutturazione degli e<strong>di</strong>fici storici<br />
Sviluppo e organizzazione <strong>di</strong> programmi <strong>di</strong> educazione e <strong>di</strong>vulgazione<br />
ambientale in grado <strong>di</strong> <strong>di</strong>ffondere tra le popolazioni locali la conoscenza<br />
delle specie e la necessità <strong>di</strong> proteggerne gli habitat<br />
Progettazione e realizzazione <strong>di</strong> interventi <strong>di</strong> formazione specialistica<br />
destinati al personale degli enti pubblici territoriali e associazioni<br />
ambientaliste interessate e aventi ad oggetto la normativa ambientale<br />
internazionale, comunitaria, nazionale e regionale, con particolare<br />
riferimento agli strumenti giuri<strong>di</strong>ci e istituzionali <strong>di</strong> conservazione e tutela<br />
dei siti Natura 2000<br />
Descrizione<br />
IA3 ELEVATA Attuazione <strong>di</strong> un programma <strong>di</strong> sorveglianza dei siti <strong>di</strong> ni<strong>di</strong>ficazione noti<br />
per le specie particolarmente sensibili al <strong>di</strong>sturbo<br />
IA4 ELEVATA In<strong>di</strong>viduazione e rimozione degli impatti negativi derivanti dalla presenza<br />
<strong>di</strong> linee elettriche in prossimità <strong>di</strong> siti <strong>di</strong> ni<strong>di</strong>ficazione <strong>di</strong> specie sensibili.<br />
IA5 ELEVATA Realizzazione e gestione <strong>di</strong> un sistema <strong>di</strong> carnai<br />
IA6 BASSA Conservazione e realizzazione dei corridoi ecologici<br />
IA21 - IN<br />
PMR2<br />
PMR3<br />
PMR5<br />
BASSA<br />
MEDIA<br />
MEDIA<br />
ELEVATA<br />
Attività <strong>di</strong> informazione e sensibilizzazione<br />
Monitoraggio e stu<strong>di</strong>o delle popolazioni ni<strong>di</strong>ficanti <strong>di</strong> rapaci <strong>di</strong>urni e<br />
notturni<br />
Monitoraggio e stu<strong>di</strong>o delle specie <strong>di</strong> uccelli <strong>di</strong> interesse comunitario<br />
legate alle aree steppiche<br />
Realizzazione <strong>di</strong> un catasto delle aree occupate da habitat steppico<br />
PMR6 - RE MEDIA Stu<strong>di</strong> sul sistema delle praterie steppiche<br />
PD2 BASSA Sviluppo e organizzazione <strong>di</strong> programmi <strong>di</strong> educazione e <strong>di</strong>vulgazione<br />
ambientale in grado <strong>di</strong> <strong>di</strong>ffondere tra le popolazioni locali la conoscenza<br />
delle specie e la necessità <strong>di</strong> proteggerne gli habitat<br />
PD3 BASSA Progettazione e realizzazione <strong>di</strong> interventi <strong>di</strong> formazione specialistica<br />
destinati al personale degli enti pubblici territoriali e associazioni<br />
117
ambientaliste interessate e aventi ad oggetto la normativa ambientale<br />
internazionale, comunitaria, nazionale e regionale, con particolare<br />
riferimento agli strumenti giuri<strong>di</strong>ci e istituzionali <strong>di</strong> conservazione e tutela<br />
dei siti Natura 2000<br />
Azioni specifiche “Grillaio”<br />
Identificativo<br />
Priorità<br />
dell’azione<br />
Descrizione<br />
IA1 ELEVATA Pulizia dei dormitori pre e post riproduttivi del Grillaio al fine <strong>di</strong> limitare<br />
l’accumulo <strong>di</strong> guano prodotto.<br />
IA2 ELEVATA Realizzazione ed installazione <strong>di</strong> ni<strong>di</strong> artificiali per il Grillaio<br />
IA4 ELEVATA In<strong>di</strong>viduazione e rimozione degli impatti negativi derivanti dalla presenza<br />
<strong>di</strong> linee elettriche in prossimità <strong>di</strong> siti <strong>di</strong> ni<strong>di</strong>ficazione <strong>di</strong> specie sensibili.<br />
IA6 BASSA Conservazione e realizzazione dei corridoi ecologici<br />
IA21 - IN<br />
BASSA<br />
Attività <strong>di</strong> informazione e sensibilizzazione<br />
IA22 - IN ELEVATA Promozione e sostegno <strong>di</strong> pratiche agricole sostenibili per la conservative<br />
e l’aumento della sostanza organica nei suoli<br />
IN2 BASSA Tutela della bio<strong>di</strong>versità in agricoltura e creazione della figura del<br />
coltivatore custode<br />
IN3 ELEVATA Sostegno agli investimenti non produttivi: ripristino dei muretti a secco.<br />
IN4 BASSA Sostegno alla conservazione delle pratiche agricole estensive tra<strong>di</strong>zionali:<br />
prati-pascoli e foraggiere<br />
PMR1 MEDIA Mappaggio degli e<strong>di</strong>fici interessati dalla ni<strong>di</strong>ficazione del Grillaio in ogni<br />
colonia urbana<br />
PMR2<br />
MEDIA Monitoraggio e stu<strong>di</strong>o delle popolazioni ni<strong>di</strong>ficanti <strong>di</strong> rapaci <strong>di</strong>urni e<br />
notturni<br />
PMR6 - RE MEDIA Stu<strong>di</strong> sul sistema delle praterie steppiche<br />
PMR8 MEDIA Stu<strong>di</strong> e monitoraggio delle comunità <strong>di</strong> invertebrati presenti nel sito<br />
PMR9 MEDIA Monitoraggio e piano <strong>di</strong> gestione della popolazione <strong>di</strong> Cinghiale Sus<br />
scrofa presente nel sito<br />
PD1<br />
BASSA Realizzazione <strong>di</strong> materiali informativi tecnici per gli or<strong>di</strong>ni degli<br />
Architetti, degli Ingegneri e per le varie associazioni <strong>di</strong> categoria<br />
coinvolte nei progetti <strong>di</strong> ristrutturazione degli e<strong>di</strong>fici storici<br />
PD2 BASSA Sviluppo e organizzazione <strong>di</strong> programmi <strong>di</strong> educazione e <strong>di</strong>vulgazione<br />
ambientale in grado <strong>di</strong> <strong>di</strong>ffondere tra le popolazioni locali la conoscenza<br />
delle specie e la necessità <strong>di</strong> proteggerne gli habitat<br />
PD3 BASSA Progettazione e realizzazione <strong>di</strong> interventi <strong>di</strong> formazione specialistica<br />
destinati al personale degli enti pubblici territoriali e associazioni<br />
ambientaliste interessate e aventi ad oggetto la normativa ambientale<br />
internazionale, comunitaria, nazionale e regionale, con particolare<br />
riferimento agli strumenti giuri<strong>di</strong>ci e istituzionali <strong>di</strong> conservazione e tutela<br />
dei siti Natura 2000<br />
118
Azioni specifiche “habitat e specie steppiche”<br />
Identificativo<br />
Priorità<br />
dell’azione<br />
Descrizione<br />
IA4 ELEVATA In<strong>di</strong>viduazione e rimozione degli impatti negativi derivanti dalla presenza<br />
<strong>di</strong> linee elettriche in prossimità <strong>di</strong> siti <strong>di</strong> ni<strong>di</strong>ficazione <strong>di</strong> specie sensibili.<br />
IA6 BASSA Conservazione e realizzazione dei corridoi ecologici<br />
IA10 BASSA Realizzazione <strong>di</strong> percorsi naturalistici/escursionistici/culturali<br />
IA12 – RE –<br />
PMR<br />
ELEVATA<br />
Conservazione ex situ del germoplasma autoctono<br />
IA17 ELEVATA Contenimento della <strong>di</strong>ffusione <strong>di</strong> specie alloctone invadenti<br />
IA18 – PMR -<br />
PD<br />
MEDIA<br />
Check-list della flora ed in<strong>di</strong>viduazione delle specie vegetali ad elevato<br />
valore biogeografico e conservazionistico<br />
IA19 - PMR MEDIA Carta della vegetazione redatta con il metodo fitosociologico<br />
IA20 - PMR8 MEDIA Monitoraggio della bio<strong>di</strong>versità vegetale (Aree <strong>di</strong> saggio)<br />
IA21 - IN BASSA Attività <strong>di</strong> informazione e sensibilizzazione<br />
IN4 BASSA Sostegno alla conservazione delle pratiche agricole estensive tra<strong>di</strong>zionali:<br />
prati-pascoli e foraggiere<br />
PMR3 MEDIA Monitoraggio e stu<strong>di</strong>o delle specie <strong>di</strong> uccelli <strong>di</strong> interesse comunitario<br />
legate alle aree steppiche<br />
PMR5 ELEVATA Realizzazione <strong>di</strong> un catasto delle aree occupate da habitat steppico<br />
PMR6 - RE MEDIA Stu<strong>di</strong> sul sistema delle praterie steppiche<br />
PD2 BASSA Sviluppo e organizzazione <strong>di</strong> programmi <strong>di</strong> educazione e <strong>di</strong>vulgazione<br />
ambientale in grado <strong>di</strong> <strong>di</strong>ffondere tra le popolazioni locali la conoscenza<br />
delle specie e la necessità <strong>di</strong> proteggerne gli habitat<br />
PD3 BASSA Progettazione e realizzazione <strong>di</strong> interventi <strong>di</strong> formazione specialistica<br />
destinati al personale degli enti pubblici territoriali e associazioni<br />
ambientaliste interessate e aventi ad oggetto la normativa ambientale<br />
internazionale, comunitaria, nazionale e regionale, con particolare<br />
riferimento agli strumenti giuri<strong>di</strong>ci e istituzionali <strong>di</strong> conservazione e tutela<br />
dei siti Natura 2000<br />
119
Azioni specifiche “gestione forestale”<br />
Identificativo<br />
Priorità<br />
dell’azione<br />
Descrizione<br />
IA6 BASSA Conservazione e realizzazione dei corridoi ecologici<br />
IA7 ELEVATA Interventi <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa dagli incen<strong>di</strong> boschivi<br />
IA8 – PMR -<br />
IN<br />
ELEVATA<br />
Conservazione degli habitat forestali<br />
IA9 ELEVATA Interventi <strong>di</strong> pulizia delle gravine<br />
IA10 BASSA Realizzazione <strong>di</strong> percorsi naturalistici/escursionistici/culturali<br />
IA12 – RE –<br />
PMR<br />
IA15 – RE -<br />
PMR<br />
ELEVATA<br />
MEDIA<br />
Conservazione ex situ del germoplasma autoctono<br />
Conservazione in situ (Riserve genetiche) degli habitat vegetazionali <strong>di</strong><br />
interesse comunitario<br />
IA16 - PMR BASSA Censimento degli alberi monumentali e loro valorizzazione anche a fini<br />
eco-turistici<br />
IA17 ELEVATA Contenimento della <strong>di</strong>ffusione <strong>di</strong> specie alloctone invadenti<br />
IA18 – PMR -<br />
PD<br />
MEDIA<br />
Check-list della flora ed in<strong>di</strong>viduazione delle specie vegetali ad elevato<br />
valore biogeografico e conservazionistico<br />
IA19 - PMR MEDIA Carta della vegetazione redatta con il metodo fitosociologico<br />
IA20 - PMR8 MEDIA Monitoraggio della bio<strong>di</strong>versità vegetale (Aree <strong>di</strong> saggio)<br />
IA21 - IN BASSA Attività <strong>di</strong> informazione e sensibilizzazione<br />
PD2 BASSA Sviluppo e organizzazione <strong>di</strong> programmi <strong>di</strong> educazione e <strong>di</strong>vulgazione<br />
ambientale in grado <strong>di</strong> <strong>di</strong>ffondere tra le popolazioni locali la conoscenza<br />
delle specie e la necessità <strong>di</strong> proteggerne gli habitat<br />
PD3 BASSA Progettazione e realizzazione <strong>di</strong> interventi <strong>di</strong> formazione specialistica<br />
destinati al personale degli enti pubblici territoriali e associazioni<br />
ambientaliste interessate e aventi ad oggetto la normativa ambientale<br />
internazionale, comunitaria, nazionale e regionale, con particolare<br />
riferimento agli strumenti giuri<strong>di</strong>ci e istituzionali <strong>di</strong> conservazione e tutela<br />
dei siti Natura 2000<br />
120
6.1.3. Schede delle Azioni <strong>di</strong> gestione<br />
Scheda azione Tipologia sito (SIC/ZPS) CODICE E NOME SITO”<br />
sito SIC e ZPS "Area delle Gravine IT9130007”<br />
IA1 Titolo dell’azione Pulizia dei dormitori pre e post riproduttivi del<br />
Grillaio al fine <strong>di</strong> limitare l’accumulo <strong>di</strong> guano<br />
prodotto.<br />
Generale Localizzata <br />
Tipologia azione<br />
intervento attivo (IA)<br />
regolamentazione (RE)<br />
incentivazione (IN)<br />
programma <strong>di</strong> monitoraggio e/o ricerca (PMR)<br />
programma <strong>di</strong>dattico (PD)<br />
Eventuale stralcio<br />
cartografico (vale per<br />
le azioni localizzate)<br />
Descrizione dello stato<br />
attuale e<br />
contestualizzazione<br />
dell’azione nel PdG<br />
In<strong>di</strong>catori <strong>di</strong> stato<br />
Il Grillaio frequenta durante tutto il periodo <strong>di</strong> ni<strong>di</strong>ficazione dei dormitori notturni<br />
collettivi, all’interno <strong>di</strong> aree urbane, spesso in situazioni quali giar<strong>di</strong>ni pubblici o<br />
alberature stradali che possono determinare un <strong>di</strong>sturbo alla citta<strong>di</strong>nanza a causa<br />
dell’accumulo del guano alla base dei dormitori.<br />
Nel contesto dell’area delle gravine gli unici dormitori noti sono presenti nei<br />
centri urbani <strong>di</strong> Laterza e Ginosa (cerchiate in blu nello stralcio cartografico).<br />
N. coppie ni<strong>di</strong>ficanti (I1).<br />
121
Finalità dell’azione<br />
Descrizione dell’azione<br />
e programma<br />
operativo<br />
Verifica dello stato <strong>di</strong><br />
attuazione/avanzament<br />
o dell’azione<br />
Limitare i <strong>di</strong>sagi della popolazione residente dovuti all’accumulo <strong>di</strong> guano<br />
prodotto dai grillai, evitando il loro forzato allontanamento attraverso azioni<br />
cruente.<br />
Pulizia dei dormitori pre e post riproduttivi. Tale azione verrà effettuata da<br />
personale qualificato ed opportunamente formato, in modo da evitare che gli<br />
animali vengano <strong>di</strong>sturbati.<br />
Il Programma operativo prevede:<br />
a) in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong> <strong>di</strong>tte specializzate idonee al tipo <strong>di</strong> intervento;<br />
b) elaborazione <strong>di</strong> un programma <strong>di</strong> interventi <strong>di</strong> pulizia in modo da non<br />
determinare eccessivo <strong>di</strong>sturbo agli animali;<br />
c) verifica dei risultati.<br />
Pulizia dei siti.<br />
Descrizione<br />
risultati attesi<br />
dei<br />
Minore <strong>di</strong>sturbo alla citta<strong>di</strong>nanza attraverso la pulizia delle aree sottostanti<br />
ai dormitori.<br />
Interessi<br />
coinvolti<br />
economici<br />
Pubbliche amministrazioni.<br />
Soggetti competenti<br />
Priorità dell’azione<br />
Tempi<br />
e stima dei costi<br />
Amministrazioni comunali interessate dalla presenza <strong>di</strong> dormitori <strong>di</strong> Grillaio.<br />
ELEVATA<br />
Durata 5 anni, costo complessivo 10.000,00 €<br />
Totale complessivo 50.000,00. €<br />
Riferimenti<br />
programmatici e linee<br />
<strong>di</strong> finanziamento<br />
LIFE+ 2007-2013<br />
Programmazione POR 2007-2013<br />
Riferimenti tecnici e<br />
criteri progettuali<br />
122
Scheda azione Tipologia sito (SIC/ZPS) CODICE E NOME SITO”<br />
sito SIC e ZPS "Area delle Gravine IT9130007”<br />
IA2 Titolo dell’azione Realizzazione ed installazione <strong>di</strong> ni<strong>di</strong> artificiali<br />
per il Grillaio<br />
Generale Localizzata <br />
Tipologia azione<br />
intervento attivo (IA)<br />
regolamentazione (RE)<br />
incentivazione (IN)<br />
programma <strong>di</strong> monitoraggio e/o ricerca (PMR)<br />
programma <strong>di</strong>dattico (PD)<br />
Eventuale stralcio<br />
cartografico (vale per<br />
le azioni localizzate)<br />
Descrizione dello stato<br />
attuale e<br />
contestualizzazione<br />
dell’azione nel PdG<br />
In<strong>di</strong>catori <strong>di</strong> stato<br />
Finalità dell’azione<br />
Descrizione dell’azione<br />
e programma<br />
La specie Falco naumanni utilizza gli e<strong>di</strong>fici storici dei centri <strong>di</strong> Ginosa, Laterza,<br />
Castellaneta, Massafra, ecc. Ad eccezione delle prime due colonie le altre si<br />
presentano <strong>di</strong> recente formazione e spesso risentono della mancanza <strong>di</strong> siti idonei<br />
alla loro riproduzione. Inoltre, nelle colonie storiche la ristrutturazione dei tetti<br />
rende spesso impossibile la ricolonizzazione.<br />
È pertanto necessario fornire siti alternativi ed integrativi a quelli potenzialmente<br />
<strong>di</strong>sponibili.<br />
n. coppie ni<strong>di</strong>ficanti (I1); n. giovani involati (I3).<br />
Protezione dei siti <strong>di</strong> ni<strong>di</strong>ficazione della specie ad elevata sensibilità durante la<br />
fase riproduttiva.<br />
L’azione prevede la realizzazione e l’installazione <strong>di</strong> n. 200 ni<strong>di</strong> per il<br />
grillaio. I ni<strong>di</strong> saranno <strong>di</strong> varie tipologie (coppi-nido, ni<strong>di</strong> a muro, scatole<br />
123
operativo<br />
Verifica dello<br />
stato <strong>di</strong> attuazione/<br />
avanzamento<br />
dell’azione<br />
nido, ecc.) e saranno scelti tenendo conto delle proficue esperienze condotte<br />
in Spagna. I ni<strong>di</strong> verranno installati da una <strong>di</strong>tta specializzata sia su e<strong>di</strong>fici<br />
pubblici che privati, secondo uno schema definito dall’esecuzione dell’azione<br />
MR2.<br />
Descrizione dei<br />
risultati attesi<br />
Si prevede la colonizzazione <strong>di</strong> almeno n. 20 ni<strong>di</strong> all’anno per ciascun<br />
comune.<br />
Interessi economici<br />
coinvolti<br />
Soggetti competenti<br />
Priorità dell’azione<br />
Tempi<br />
e stima dei costi<br />
Riferimenti<br />
programmatici e linee<br />
<strong>di</strong> finanziamento<br />
Pubbliche amministrazioni.<br />
Regione Puglia, <strong>Provincia</strong> <strong>di</strong> <strong>Taranto</strong>, Università, Associazioni ambientaliste.<br />
ELEVATA<br />
Durata 5 anni. Costo complessivo 30.000,00 €.<br />
LIFE+ 2007-2013<br />
Programmazione POR 2007-2013<br />
Riferimenti tecnici e<br />
criteri progettuali<br />
124
125
Interessi<br />
coinvolti<br />
economici<br />
Pubbliche amministrazioni.<br />
Soggetti competenti<br />
Priorità dell’azione<br />
Tempi<br />
e stima dei costi<br />
Riferimenti<br />
programmatici e linee<br />
<strong>di</strong> finanziamento<br />
Regione Puglia, <strong>Provincia</strong> <strong>di</strong> <strong>Taranto</strong>, Comuni, Università, Associazioni<br />
ambientaliste.<br />
ELEVATA<br />
Durata 20 anni. Costo complessivo 500.000,00 €.<br />
LIFE+ 2007-2013<br />
Programmazione POR 2007-2013<br />
Riferimenti tecnici e<br />
criteri progettuali<br />
127
Scheda azione Tipologia sito (SIC/ZPS) CODICE E NOME SITO”<br />
sito SIC e ZPS "Area delle Gravine IT9130007”<br />
IA4 Titolo dell’azione In<strong>di</strong>viduazione e rimozione degli impatti<br />
negativi derivanti dalla presenza <strong>di</strong> linee<br />
elettriche in prossimità <strong>di</strong> siti <strong>di</strong> ni<strong>di</strong>ficazione <strong>di</strong><br />
specie sensibili.<br />
Generale Localizzata <br />
Tipologia azione<br />
intervento attivo (IA)<br />
regolamentazione (RE)<br />
incentivazione (IN)<br />
programma <strong>di</strong> monitoraggio e/o ricerca (PMR)<br />
programma <strong>di</strong>dattico (PD)<br />
Eventuale stralcio<br />
cartografico (vale per<br />
le azioni localizzate)<br />
Descrizione dello stato<br />
attuale e<br />
contestualizzazione<br />
dell’azione nel PdG<br />
In<strong>di</strong>catori <strong>di</strong> stato<br />
Finalità dell’azione<br />
Descrizione dell’azione<br />
e programma<br />
operativo<br />
La mortalità <strong>di</strong> uccelli a causa <strong>di</strong> elettrocuzione (folgorazione per contatto <strong>di</strong><br />
elementi conduttori) o collisione con linee elettriche e cavi in genere è stata<br />
documentata da più <strong>di</strong> un secolo (Bevanger, 1998), ed in Italia il problema viene<br />
riportato sin dall’inizio del 1900 (Vaccari, 1912 in Penteriani, 1998).<br />
I gruppi <strong>di</strong> uccelli maggiormente vulnerabili alle collisioni con cavi sono<br />
Galliformi, Gruiformi, Pellicaniformi e Ciconiformi, mentre Falconiformi,<br />
Stringiformi, Passeriformi, Ciconiformi sono maggiormente vittime<br />
dell’elettrocuzione.<br />
L’elettrocuzione si verifica soprattutto nelle linee elettriche a me<strong>di</strong>a tensione<br />
mentre quelle ad alta tensione sono pericolose in particolare per le collisioni (i<br />
conduttori sono troppo lontani per indurre la folgorazione). Nell'area delle<br />
gravine dell'arco ionico sono state riscontrate <strong>di</strong>verse situazioni a rischio, con<br />
numerose linee elettriche che attraversano i solchi delle gravine nei pressi delle<br />
pareti <strong>di</strong> ni<strong>di</strong>ficazione dei rapaci.<br />
N. coppie ni<strong>di</strong>ficanti (I1).<br />
Protezione dei siti <strong>di</strong> ni<strong>di</strong>ficazione dei rapaci attraverso la riduzione della<br />
mortalità da impatto e da elettrolocuzione.<br />
L'azione prevede un monitoraggio della rete a me<strong>di</strong>a ed alta tensione al fine<br />
<strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare eventuali situazioni <strong>di</strong> pericolo. I siti in<strong>di</strong>viduati verranno<br />
sottoposti a misure <strong>di</strong> mitigazione che possono prevedere l’interramento o<br />
l’isolamento dei cavi.<br />
Verifica dello<br />
stato <strong>di</strong> attuazione/<br />
Realizzazione del protocollo d’intesa con TERNA.<br />
128
avanzamento<br />
dell’azione<br />
Descrizione dei<br />
risultati attesi<br />
Eliminazione <strong>di</strong> un fattore <strong>di</strong> rischio per la fauna e conseguente aumento del<br />
successo riproduttivo.<br />
Interessi<br />
coinvolti<br />
economici<br />
ENEL e TERNA.<br />
Soggetti competenti<br />
Priorità dell’azione<br />
Tempi<br />
e stima dei costi<br />
Riferimenti<br />
programmatici e linee<br />
<strong>di</strong> finanziamento<br />
Regione Puglia, <strong>Provincia</strong> <strong>di</strong> <strong>Taranto</strong>.<br />
ELEVATA<br />
Durata 3 anni.<br />
In<strong>di</strong>viduazione dei tracciati da mo<strong>di</strong>ficare e/o da mettere in sicurezza:<br />
100.000,00 €<br />
LIFE+ 2007-2013<br />
Programmazione POR 2007-2013<br />
Riferimenti tecnici e<br />
criteri progettuali<br />
LINEE GUIDA PER LA MINIMIZZAZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO<br />
Il livello <strong>di</strong> pericolosità delle elettrificazioni presenti sul territorio italiano è<br />
estremamente elevato. A tale riguardo Penteriani (1998) ha proposto le seguenti<br />
linee guida per la minimizzazione e la mitigazione del rischio <strong>di</strong> elettrocuzione<br />
per l’avifauna.<br />
1. sottoporre le linee elettriche ad alta tensione esistenti ad una verifica del<br />
rischio <strong>di</strong> collisione, al fine <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare i tratti che, per le ragioni citate<br />
nei capitoli precedenti, risultino ad alto rischio e <strong>di</strong>sporvi adeguate<br />
misure <strong>di</strong> contenimento del rischio <strong>di</strong> collisione;<br />
2. pre<strong>di</strong>sporre sistemi che riducano il rischio <strong>di</strong> collisione in tutte le nuove<br />
linee elettriche ad alta tensione;<br />
3. sottoporre le linee elettriche a me<strong>di</strong>a tensione esistenti ad una verifica del<br />
rischio <strong>di</strong> elettrocuzione e secondariamente <strong>di</strong> collisione, al fine <strong>di</strong><br />
in<strong>di</strong>viduare i tratti ed i piloni che, per la presenza nelle vicinanze <strong>di</strong><br />
specie <strong>di</strong> particolare interesse conservazionistico e/o particolarmente<br />
esposte a questo tipo <strong>di</strong> pericolo, risultino ad alto rischio e <strong>di</strong>sporvi<br />
adeguate misure <strong>di</strong> contenimento del rischio <strong>di</strong> elettrocuzione e<br />
collisione;<br />
4. costruire tutte le nuove linee a me<strong>di</strong>a tensione in cavo isolato e, ove<br />
possibile, sotterrato;<br />
5. sostituire le vecchie linee a 220 e 380 volt a fili scoperti con cavi isolati;<br />
6. considerare sempre come aree a rischio tutte le aree protette e quelle zone<br />
ove siano previsti progetti <strong>di</strong> reintroduzione <strong>di</strong> specie <strong>di</strong> particolare<br />
interesse conservazionistico e/o particolarmente esposte a questo tipo <strong>di</strong><br />
pericolo;<br />
7. definire una lista <strong>di</strong> specie a priorità <strong>di</strong> conservazione, per le quali<br />
129
ichiedere necessariamente interventi <strong>di</strong> minimizzazione del rischio<br />
elettrico nelle aree dove esse siano <strong>di</strong>stribuite, anche al <strong>di</strong> fuori <strong>di</strong> aree<br />
protette;<br />
8. definire una metodologia standard <strong>di</strong> riferimento per la valutazione del<br />
grado <strong>di</strong> pericolosità <strong>di</strong> un tracciato elettrico;<br />
9. pre<strong>di</strong>sporre una unità operativa specializzata per la messa in opera delle<br />
minimizzazioni del rischio elettrico;<br />
10. <strong>di</strong>sporre un capitolato delle minimizzazioni effettuabili sulle<br />
elettrificazioni nazionali che prenda in considerazione i seguenti punti:<br />
a) tipi e posizione <strong>di</strong> posatoi su piloni della me<strong>di</strong>a tensione;<br />
b) tipi e posizione <strong>di</strong> sistemi <strong>di</strong> impe<strong>di</strong>mento alla posa;<br />
c) tipi e posizione <strong>di</strong> sistemi <strong>di</strong> avvertimento visivo;<br />
d) tipi <strong>di</strong> isolamento;<br />
e) tipi <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fiche da apportare alle strutture esistenti;<br />
f) progettazione <strong>di</strong> nuovi modelli <strong>di</strong> linea non più mortali;<br />
g) collocazione dei tracciati delle linee;<br />
h) stagioni ed orari della messa in opera delle nuove linee;<br />
i) stagioni ed orari della messa in opera delle minimizzazioni;<br />
j) stagioni ed orari della manutenzione or<strong>di</strong>naria;<br />
k) viabilità <strong>di</strong> accesso alla linea;<br />
l) situazioni climatiche e tipi <strong>di</strong> minimizzazioni;<br />
m)indagine per la messa in opera delle minimizzazioni daparte <strong>di</strong> personale<br />
qualificato.<br />
Tipologie <strong>di</strong> elettrificazione <strong>di</strong> interesse per l’avifauna<br />
Linee a Me<strong>di</strong>a Tensione (MT)<br />
Nel caso delle linee MT, in presenza <strong>di</strong> conduttori non ricoperti da guaina<br />
isolante, sono soprattutto la geometria dei pali, il materiale con cui essi sono<br />
costruiti e la <strong>di</strong>stanza fra i conduttori a rappresentare fattori <strong>di</strong> rischio per gli<br />
uccelli.<br />
Due ulteriori elementi <strong>di</strong> rischio, la cui pericolosità risulta elevatissima, sono<br />
rappresentati dai trasformatori (gruppi <strong>di</strong> conduttori riuniti in contenitori<br />
metallici, utilizzati per effettuare conversioni <strong>di</strong> voltaggio) e dagli interruttori<br />
aerei (interruttori posti su palo, la cui funzione è quella <strong>di</strong> interrompere il flusso<br />
<strong>di</strong> corrente nei cavi per isolare alcuni tratti della rete elettrica): la vicinanza tra fili<br />
elettrici determina il verificarsi dell’elettrocuzione.<br />
Le linee aeree MT si <strong>di</strong>vidono in due gruppi:<br />
• linee su isolatori rigi<strong>di</strong> (figg. 1, 2, 3, 4) con armamento semplice per amarro<br />
(tipo <strong>di</strong> <strong>di</strong>sposizione degli isolatori ben evidente in fig. 2, che costituiscono un<br />
elemento <strong>di</strong> <strong>di</strong>scontinuità del cavo aereo) od armamento doppio rigido;<br />
• linee su isolatori sospesi (figg. 5, 6, 7, 8) con armamento semplice per<br />
sospensione od armamento semplice per amarro.<br />
Gli armamenti possono essere su palo o su sostegno a traliccio.<br />
130
131
132
133
Collocazioni a rischio<br />
134
Le strutture <strong>di</strong> una linea MT sono particolarmente pericolose quando:<br />
1 - la <strong>di</strong>stanza fra i conduttori elettrici è inferiore all’apertura alare degli uccelli<br />
che potenzialmente possono posarvisi;<br />
2 - la geometria delle strutture <strong>di</strong> sostegno dei conduttori rende particolarmente<br />
accessibile il contatto con i cavi;<br />
3 - il materiale con cui sono costruiti le strutture <strong>di</strong> sostegno può fungere da<br />
conduttore <strong>di</strong> corrente elettrica.<br />
Per quanto riguarda la <strong>di</strong>stanza fra gli elementi strutturali <strong>di</strong> una linea MT va<br />
detto che, in <strong>generale</strong>, gli uccelli tendono ad evitare <strong>di</strong> posarsi laddove vi siano<br />
elementi che possano infasti<strong>di</strong>re l’animale: ben <strong>di</strong>fficilmente si vedrà un uccello<br />
posarsi dove gli sia impossibile <strong>di</strong> mantenere una postura corretta del corpo. E’<br />
stato osservato, infatti, che gli uccelli tendono ad evitare posatoi che presentino<br />
una limitazione <strong>di</strong> spazio libero in altezza pari ai 3/4 della loro lunghezza, mentre<br />
non risulta un fattore limitante il fatto che un uccello possa arrivare a toccare con<br />
le ali eventuali elementi circostanti. In questo senso risultano pericolose quelle<br />
strutture che presentano lo spazio libero necessario ad un uccello per posarvisi, in<br />
particolar modo nei confronti delle specie <strong>di</strong> gran<strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni.<br />
Le linee su pali <strong>di</strong> legno (non utilizzate in Italia) con elementi costruttivi non a<br />
terra non rappresentano, invece, secondo un rapporto del V.D.E.W. tedesco<br />
(1991), un pericolo per l’avifauna: essendo il legno isolante, non esiste pericolo<br />
<strong>di</strong> elettrocuzione per contatto fra conduttore e struttura <strong>di</strong> sostegno, anche se il<br />
rischio persiste per gli uccelli <strong>di</strong> maggiori <strong>di</strong>mensioni, che possono arrivare a<br />
toccare contemporaneamente i conduttori <strong>di</strong> due fasi. Come regola <strong>generale</strong>, non<br />
sono particolarmente pericolose quelle linee elettriche con isolatori sospesi<br />
(Waldschmidt, 1979). Pali <strong>di</strong> legno con elementi costruttivi a terra, pali <strong>di</strong><br />
cemento ed in materiale metallico e linee con isolatori rigi<strong>di</strong> rappresentano invece<br />
i tipi <strong>di</strong> strutture più pericolose e spesso mortali (V.D.E.W., 1991).<br />
Particolarmente pericolosi risultano i trasformatori, che per alcune specie <strong>di</strong><br />
uccelli rappresentano dei posatoi molto attraenti, talora anche degli elementi <strong>di</strong><br />
riparo e <strong>di</strong> sosta prolungata: la vicinanza dei fili verticali che partono dalla scatola<br />
del trasformatore verso la testa del palo è la causa delle folgorazioni. Le linee<br />
MT, sebbene assai <strong>di</strong> rado, possono anche intrappolare per le zampe un uccello<br />
nelle strutture <strong>di</strong> raccordo conduttore-isolatore e isolatore-testa del palo (Gretz,<br />
1981); l’animale, nel tentativo <strong>di</strong> liberarsi, può ferirsi gravemente o provocare il<br />
contatto mortale.<br />
Linee ad Alta Tensione (AT)<br />
Le geometrie dei sostegni AT presenti nel nostro Paese hanno <strong>di</strong>stanze, fra i cavi<br />
a <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> potenziale, tali da rendere poco probabile il rischio <strong>di</strong><br />
elettrocuzione. Bisogna, infatti, ricordare che le linee AT rappresentano un<br />
pericolo per l’avifauna soprattutto a causa delle morti per collisione che esse<br />
provocano quando i loro tracciati si trovano a coincidere con le rotte <strong>di</strong><br />
spostamento degli uccelli.<br />
Le linee AT hanno un voltaggio <strong>di</strong> 132-380 kV, una altezza dal suolo che può<br />
essere <strong>di</strong> 28, 42 e 60 metri ed uno spazio fra i conduttori <strong>di</strong> oltre 6 metri in<br />
larghezza e <strong>di</strong> minimo circa 4 metri in altezza.<br />
Collocazioni a rischio<br />
135
Esistono numerose collocazioni <strong>di</strong> una linea AT che possono essere considerate a<br />
forte rischio <strong>di</strong> collisione, anche se devono sempre essere prese in considerazione<br />
le con<strong>di</strong>zioni morfologiche e del paesaggio locale, nonché la composizione in<br />
specie dell’avifauna presente in prossimità del tracciato in questione. A questo<br />
proposito si può citare il caso dei fenicotteri, specie a grave rischio <strong>di</strong> collisione<br />
presenti nello Stagno <strong>di</strong> Molentargius (Cagliari), dove l’esistenza <strong>di</strong> una linea ad<br />
alta tensione è una costante minaccia per questa popolazione che subisce ogni<br />
anno per<strong>di</strong>te inaccettabili.<br />
I conduttori formati da fasci tripli sono relativamente ben in<strong>di</strong>viduabili durante il<br />
giorno ed in buone con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> visibilità, nonché relativamente rumorosi e<br />
quin<strong>di</strong> abbastanza percepibili anche dagli uccelli notturni. Se però risulta<br />
relativamente facile la percezione del fascio <strong>di</strong> cavi, è proprio questa che porta gli<br />
uccelli, che l’incontrano sulla loro traiettoria <strong>di</strong> volo, ad alzarsi leggermente in<br />
quota andando inevitabilmente ad urtare contro il conduttore neutro, molto più<br />
sottile degli altri e quin<strong>di</strong> meno visibile (A.M.B.E., 1993). Il conduttore neutro (o<br />
<strong>di</strong> guar<strong>di</strong>a) è infatti all’origine della maggior parte degli incidenti per collisione<br />
(A.M.B.E., 1993, Beaulaurier D.L., 1981). I tratti meno a rischio <strong>di</strong> collisione per<br />
una linea AT sono quelli posti nelle imme<strong>di</strong>ate vicinanze dei piloni, strutture ben<br />
visibili e, come tali, aggirate dagli uccelli che non sono però al sicuro da urti<br />
contro il tratto centrale <strong>di</strong> un conduttore. Una localizzazione dell’opera al limite<br />
superiore dei boschi e prossima a pareti rocciose rappresenta un elemento <strong>di</strong><br />
grave pericolo per specie ni<strong>di</strong>ficanti in ambienti rupestri (Grifone, Capovaccaio,<br />
Aquila reale, Aquila del Bonelli, Falco Pellegrino, Lanario, Gufo reale, Corvo<br />
imperiale e Picchio muraiolo).<br />
Una linea AT che attraversi, costeggi o passi in prossimità <strong>di</strong> zone umide risulterà<br />
molto pericolosa per tutti gli uccelli acquatici che qui sostano e ni<strong>di</strong>ficano, fra i<br />
quali figurano specie <strong>di</strong> particolare importanza a livello nazionale ed europeo. In<br />
queste zone, specialmente in inverno, si assiste alla concentrazione <strong>di</strong> centinaia o<br />
migliaia <strong>di</strong> in<strong>di</strong>vidui <strong>di</strong> specie <strong>di</strong>verse aumentando così il rischio <strong>di</strong> collisione<br />
mortale; l’alta frequenza <strong>di</strong> giornate <strong>di</strong> tempo perturbato, con vento e nebbia,<br />
unita alla presenza <strong>di</strong> uccelli <strong>di</strong> passo che non hanno familiarità con la morfologia<br />
locale, accresce il rischio <strong>di</strong> collisione.<br />
In linea <strong>generale</strong> sono particolarmente pericolosi i tracciati ad AT che si trovano<br />
nelle imme<strong>di</strong>ate vicinanze <strong>di</strong> siti <strong>di</strong> concentrazione <strong>di</strong> più in<strong>di</strong>vidui della stessa o<br />
<strong>di</strong> <strong>di</strong>verse specie (dormitori e luoghi <strong>di</strong> alimentazione comuni, siti <strong>di</strong><br />
ni<strong>di</strong>ficazione in colonie): l’elevato numero <strong>di</strong> uccelli presente aumenta la<br />
probabilità <strong>di</strong> collisioni. La mortalità degli uccelli aumenta se il tracciato della<br />
linea elettrica si trova in prossimità <strong>di</strong> una via <strong>di</strong> passaggio preferenziale (corso <strong>di</strong><br />
un fiume, bordo <strong>di</strong> un lago, tracciato <strong>di</strong> una gola) ed è ad un’altezza <strong>di</strong> poco<br />
superiore a quella delle chiome degli alberi: gli uccelli in volo radente le cime<br />
degli alberi hanno forti probabilità <strong>di</strong> urtare contro i conduttori (fig. 9A).<br />
Sebbene anche una altezza pari o <strong>di</strong> poco inferiore a quella delle chiome degli<br />
alberi renda estremamente pericolosa una linea elettrica (probabilmente il<br />
fogliame tende a mascherare e ad oscurare i conduttori: il suo effetto è comunque<br />
minore in quanto gli spostamenti all’interno del bosco avvengono in maniera<br />
meno veloce che al suo esterno (spesso si tratta <strong>di</strong> spostamenti <strong>di</strong> ramo in ramo),<br />
permettendo agli uccelli <strong>di</strong> avere, talora, il tempo <strong>di</strong> schivare l’ostacolo (fig. 9B).<br />
In ogni caso, una linea AT <strong>di</strong>viene particolarmente pericolosa quando viene<br />
136
mascherata da elementi naturali che ne riducano la già ridotta visibilità.<br />
La maggior parte delle collisioni avviene nei tratti degli elettrodotti AT dove si<br />
verificano i cosiddetti effetti trampolino, sbarramento, sommità e scivolo<br />
(A.M.B.E., 1991; Aménagement et Nature n. 79) così definiti:<br />
a) l’effetto trampolino, tra i più mortali, è determinato dalla<br />
presenza in prossimità <strong>di</strong> una linea elettrica <strong>di</strong> ostacoli <strong>di</strong> <strong>di</strong>versa natura (alberi,<br />
siepi, dossi, manufatti, ecc.) che obbligano gli uccelli in volo ad evitarli alzandosi<br />
in quota a livello dei conduttori, percepibili all’ultimo momento;<br />
b) l’effetto sbarramento si crea per la presenza <strong>di</strong> una linea elettrica lungo le vie<br />
<strong>di</strong> spostamento più tipiche per un uccello: è questo il caso <strong>di</strong> una linea elettrica<br />
perpen<strong>di</strong>colare all’asse <strong>di</strong> una valle seguito dagli uccelli durante i loro<br />
spostamenti;<br />
c) l’effetto scivolo è determinato dalla morfologia del paesaggio circostante una<br />
linea elettrica quando un elemento, come una collina o un versante, incanala il<br />
volo degli uccelli in <strong>di</strong>rezione <strong>di</strong> un elettrodotto perpen<strong>di</strong>colare al moto degli<br />
uccelli;<br />
d) l’effetto sommità è caratteristico soprattutto delle zone aperte, dove le sommità<br />
delle ondulazioni del terreno concentrano gli uccelli, particolarmente durante gli<br />
spostamenti <strong>di</strong> gruppo: i tratti <strong>di</strong> linea elettrica sommitali sono quelli che<br />
137
presentano la più elevata mortalità.<br />
Nel nostro Paese, tutte le linee AT che attraversano le aree dove sono ancora<br />
rinvenibili specie <strong>di</strong> uccelli <strong>di</strong> notevole interesse sia come ni<strong>di</strong>ficanti che come<br />
svernanti, molto sensibili al rischio elettrico, devono essere considerate a forte<br />
rischio <strong>di</strong> collisione. E’ questo il caso delle aree nelle quali troviamo la Cicogna<br />
bianca, il Fenicottero, la Gru e la Gallina prataiola, il Capovaccaio, il Grifone,<br />
l’Aquila reale, ecc.<br />
138
Scheda azione Tipologia sito (SIC/ZPS) CODICE E NOME SITO”<br />
sito SIC e ZPS "Area delle Gravine IT9130007”<br />
IA5 Titolo dell’azione Realizzazione e gestione <strong>di</strong> un sistema <strong>di</strong> carnai<br />
Generale Localizzata <br />
Tipologia azione<br />
intervento attivo (IA)<br />
regolamentazione (RE)<br />
incentivazione (IN)<br />
programma <strong>di</strong> monitoraggio e/o ricerca (PMR)<br />
programma <strong>di</strong>dattico (PD)<br />
Eventuale stralcio<br />
cartografico (vale per<br />
le azioni localizzate)<br />
Descrizione dello stato<br />
attuale e<br />
contestualizzazione<br />
dell’azione nel PdG<br />
In<strong>di</strong>catori <strong>di</strong> stato<br />
Finalità dell’azione<br />
Descrizione dell’azione<br />
e programma<br />
La continua riduzione del numero <strong>di</strong> ovini allo stato brado, nonché la conversione<br />
del pascolo in coltivazioni erbacee, ha sottratto notevoli risorse trofiche al<br />
Capovaccaio e al Nibbio reale, specie necrofaghe ed opportuniste.<br />
Tale riduzione appare come uno dei principali fattori che ha determinato la<br />
notevole contrazione <strong>di</strong> effettivi e <strong>di</strong> areali delle due specie.<br />
N. <strong>di</strong> in<strong>di</strong>vidui in alimentazione al carnaio (I5).<br />
L'incremento delle risorse trofiche per Capovaccaio e Nibbio reale, specie<br />
necrofaghe ed opportuniste, appare come uno dei principali fattori <strong>di</strong><br />
conservazione. La presenza del carnaio, come ampiamente <strong>di</strong>mostrato in progetti<br />
simili in Spagna e Francia, determina un incremento delle <strong>di</strong>sponibilità alimentari<br />
dell'area favorendo l'inse<strong>di</strong>amento <strong>di</strong> coppie e in<strong>di</strong>vidui territoriali.<br />
L'azione prevede la realizzazione <strong>di</strong> un carnaio attraverso:<br />
a) richiesta <strong>di</strong> autorizzazioni igenico-sanitarie;<br />
139
operativo<br />
Verifica dello stato<br />
<strong>di</strong> attuazione/<br />
avanzamento<br />
dell’azione<br />
Descrizione dei<br />
risultati attesi<br />
Interessi economici<br />
coinvolti<br />
Soggetti competenti<br />
Priorità dell’azione<br />
Tempi<br />
e stima dei costi<br />
Riferimenti<br />
programmatici e linee<br />
<strong>di</strong> finanziamento<br />
Riferimenti tecnici e<br />
criteri progettuali<br />
b) in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong> un'area idonea alla realizzazione; Ciascuna aree dovrà<br />
essere <strong>di</strong>stante dalle altre non meno <strong>di</strong> 5 km.<br />
c) realizzazione <strong>di</strong> opportune recinzioni al fine <strong>di</strong> impe<strong>di</strong>re l'ingresso <strong>di</strong><br />
specie indesiderate;<br />
d) adozione <strong>di</strong> un piano <strong>di</strong> rifornimento del carnaio attraverso accor<strong>di</strong> con<br />
macelli autorizzati utilizzando procedure igenico-sanitarie previste dalla<br />
legge. A regime, il carnaio dovrebbe funzionare come stazione <strong>di</strong><br />
smaltimento controllato <strong>di</strong> residui <strong>di</strong> macelleria. La quantità <strong>di</strong> materiale<br />
smaltita deve essere commisurata alle capacità <strong>di</strong> consumo dell’avifauna<br />
locale.<br />
Realizzazione del carnaio e sua gestione.<br />
La presenza <strong>di</strong> una fonte <strong>di</strong> cibo continua e costante dovrebbe determinare<br />
una maggiore frequentazione del sito da parte <strong>di</strong> Capovaccaio e Nibbio reale<br />
e una più sicura possibilità <strong>di</strong> ni<strong>di</strong>ficazione. Inoltre, la presenza del carnaio<br />
renderà più facile che eventuali animali in migrazione o in erratismo possano<br />
fermarsi nell'area.<br />
Nessuno.<br />
Regione Puglia, <strong>Provincia</strong> <strong>di</strong> <strong>Taranto</strong>, Comuni.<br />
ELEVATA<br />
Progettazione e realizzazione 20.000,00 €/cad. Gestione per 20 anni circa<br />
300.000,00 €.<br />
LIFE+ 2007-2013<br />
Programmazione POR 2007-2013<br />
Scheda tecnica carnai<br />
La necessità <strong>di</strong> realizzare dei carnai nasce dalle mutate con<strong>di</strong>zioni sociali legate<br />
alle nuove forme <strong>di</strong> allevamento e alla maggiore attenzione verso le norme<br />
igienico-sanitarie.<br />
Questo ha determinato la riduzione delle risorse trofiche per queste specie in<br />
particolare attraverso:<br />
• trasformazione dell’agricoltura locale da silvo-pastorale ad agricolo-intensiva;<br />
in molte aree, infatti, si sta inse<strong>di</strong>ando un’intensa monocoltura cerealicola, con<br />
messa a coltura <strong>di</strong> nuove aree e riduzione della pastorizia;<br />
• scomparsa del pascolo brado;<br />
• scomparsa delle <strong>di</strong>scariche per motivi igienico-sanitari.<br />
La realizzazione e gestione <strong>di</strong> carnai è già condotta con successo da molti anni in<br />
140
Spagna dove ad es. i carnai rappresentano un mezzo vali<strong>di</strong>ssimo per il sostegno<br />
delle popolazioni <strong>di</strong> uccelli necrofagi. Infatti il paese iberico ospita popolazioni<br />
ancora floride <strong>di</strong> Gipeto , Avvoltoio monaco, Grifone , Capovaccaio, Nibbio reale<br />
e Nibbio bruno grazie ad una rete <strong>di</strong> molte centinaia <strong>di</strong> carnai, gestiti in gran parte<br />
da pubbliche amministrazioni ma anche da associazioni naturalistiche. La<br />
presenza <strong>di</strong> questa rete <strong>di</strong> carnai attivi svolge molteplici funzioni perché consente<br />
anche:<br />
• <strong>di</strong> ridurre l’impatto dei bocconi avvelenati, usati contro i predatori;<br />
• <strong>di</strong> evitare la <strong>di</strong>spersione dei giovani uccelli nelle prime fasi <strong>di</strong> volo, con il<br />
rischio <strong>di</strong> rimanere vittime <strong>di</strong> linee elettriche e <strong>di</strong> bracconieri;<br />
• <strong>di</strong> garantire un’alimentazione costante dei ni<strong>di</strong>acei da parte dei genitori,<br />
aumentando il successo riproduttivo delle specie.<br />
• <strong>di</strong> garantire un punto <strong>di</strong> alimentazione fondamentale per giovani rapaci nati in<br />
cattività e liberati in natura nell’ambito <strong>di</strong> progetto <strong>di</strong> ripopolamento.<br />
Da stu<strong>di</strong> effettuati nel corso <strong>di</strong> decine <strong>di</strong> anni, in Andalusia si è scoperto che<br />
alcuni carnai rappresentano importanti punti <strong>di</strong> sosta per specie migratrici <strong>di</strong><br />
uccelli necrofagi, che trovano in queste aree cibo e tranquillità per poi proseguire<br />
con maggiore energia e sicurezza la loro rotta verso i quartieri invernali (per i<br />
capovaccai circa 3.500 Km <strong>di</strong> viaggio). La presenza <strong>di</strong> carnai attivi ha fatto<br />
sorgere in Spagna nuove attività ecoturistiche legate alla possibilità <strong>di</strong> osservare<br />
da vicino animali altrimenti molto schivi. Nei pressi dei carnai sono stati creati,<br />
ove le con<strong>di</strong>zioni ambientali lo consentivano, degli osservatori dai quali le<br />
persone possono vedere <strong>di</strong>rettamente gli uccelli mentre si alimentano. In altri casi<br />
i carnai sono stati dotati <strong>di</strong> impianti video per consentire la visione degli uccelli<br />
che utilizzano il punto <strong>di</strong> alimentazione da centri visite <strong>di</strong> parchi e riserve<br />
naturali.<br />
Anche in Italia ormai da molti anni vengono realizzati e gestiti <strong>di</strong>versi carnai,<br />
soprattutto all’interno <strong>di</strong> progetti <strong>di</strong> conservazione e reintroduzione <strong>di</strong> specie<br />
necrofaghe. Nella regione Puglia all’interno della Misura 1.6 linea 2 del P.O.R.<br />
2000-2006 sono stati finanziati due progetti che prevedevano la realizzazione e<br />
gestione <strong>di</strong> carnai, uno finanziato al comune <strong>di</strong> Gravina in Puglia riguarda “Piano<br />
<strong>di</strong> azione per la conservazione del Nibbio reale e del Nibbio bruno nel pSIC<br />
"Bosco Difesa Grande" l’altro finanziato al comune <strong>di</strong> Laterza riguarda “Piano<br />
d'azione per la conservazione del Capovaccaio e azioni <strong>di</strong> conservazione del<br />
Grillaio, Nibbio reale e Nibbio bruno nell'area delle Gravine”. In ambedue i<br />
progetti il carnaio sta cominciando ad avere successo e a svolgere la funzione per<br />
la quale è stato previsto.<br />
141
Modalità <strong>di</strong> realizzazione<br />
I carnai dovranno essere realizzati possibilmente in prossimità <strong>di</strong> solchi gravinali.<br />
Si in<strong>di</strong>viduano alcune aree utilizzabili a tale scopo nella documentazione grafica<br />
allegata.<br />
I sito <strong>di</strong> realizzazione sono previsti su substrato roccioso o su terreni agricoli<br />
abbonadonati. La zona dovrà essere aperta, possibilmente lontana da fonti <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>sturbo antropico (strade, e<strong>di</strong>fici, ect).<br />
Sulla base delle esperienze realizzate, le <strong>di</strong>mensioni me<strong>di</strong>e <strong>di</strong> un carnaio devono<br />
essere <strong>di</strong> almeno 0,5 HA.<br />
La recinzione sarà funzionale a tutela le specie che fruiranno del sito <strong>di</strong><br />
alimentazione da possibili predatori, in particolare cani vaganti. Inoltre la<br />
recinzione dovrà contenere l’ingresso rispetto a possibili specie che utilizzano la<br />
risorsa alimentare, quali cinghiale e volpi.<br />
Pertanto la recinzione sarà realizzata con rete a maglia sciolta con altezza dal<br />
suolo <strong>di</strong> cm. 180 e aggettante all’esterno, con angolo <strong>di</strong> circa 45° per cm 40.<br />
Inoltre sarà fissata al suolo, attraverso cordolo <strong>di</strong> cemento.<br />
I pali <strong>di</strong> sostegno sono <strong>di</strong> ferro a T, posizionati ogni m. 2 <strong>di</strong> interasse. E’ previsto<br />
un cancello <strong>di</strong> m. 3 <strong>di</strong> apertura per consentire l’accesso ai mezzi funzionali alla<br />
gestione del carnaio.<br />
Schemi <strong>di</strong> progetto<br />
60 – 80 m<br />
80 – 100 m<br />
142
1,8<br />
60 – 80 m<br />
Prospetto anteriore<br />
1,8<br />
80 – 100 m<br />
Prospetto laterale<br />
143
Scheda azione<br />
sito SIC e ZPS "Area delle Gravine IT9130007<br />
IA6<br />
Titolo dell’azione<br />
Conservazione e realizzazione dei corridoi<br />
ecologici<br />
Generale <br />
Localizzata <br />
Tipo azione<br />
intervento attivo (IA)<br />
regolamentazione (RE)<br />
incentivazione (IN)<br />
programma <strong>di</strong> monitoraggio e/o ricerca (PMR)<br />
programma <strong>di</strong>dattico (PD)<br />
Eventuale stralcio<br />
cartografico<br />
(vale per le azioni<br />
localizzate)<br />
Descrizione dello stato<br />
attuale e<br />
contestualizzazione<br />
dell’azione nel PdG<br />
(=relazione con<br />
l’obiettivo <strong>generale</strong> <strong>di</strong><br />
PdG)<br />
Finalità dell’azione<br />
(obiettivo specifico)<br />
L’elevata antropizzazione dell’area rischia <strong>di</strong> isolare le singole gravine,<br />
anche a causa della riduzione delle aree ecotonali <strong>di</strong> connessione tra le<br />
gravine e tra queste le altre aree naturali presenti sul territorio<br />
Favorire le connessioni ecologiche tra i vari habitat presenti nel sito<br />
Descrizione dell’azione<br />
(metodologia) e<br />
programma operativo<br />
Descrizione dei<br />
risultati attesi<br />
Interventi <strong>di</strong> salvaguar<strong>di</strong>a e miglioramento del paesaggio agrario e <strong>di</strong><br />
valorizzazione ambientale (fasce tampone, creazione <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zioni atte<br />
a favorire la <strong>di</strong>ffusione sul territorio degli habitat idonei allo sviluppo<br />
della flora e della fauna, mantenimento nel territorio <strong>di</strong> “infrastrutture<br />
ecologiche” quali siepi, filari erborati, ecc.).<br />
Mantenimento e incremento della rete ecologica.<br />
In<strong>di</strong>catori target<br />
Interessi economici<br />
coinvolti<br />
Proprietari pubblici e privati.<br />
144
Soggetti competenti<br />
e modalità attuative<br />
Priorità dell’azione<br />
Regione Puglia, <strong>Provincia</strong> <strong>di</strong> <strong>Taranto</strong>, Ente Parco.<br />
BASSA<br />
Tempi<br />
e stima dei costi<br />
Riferimenti<br />
programmatici e linee<br />
<strong>di</strong> finanziamento<br />
Riferimenti tecnici e<br />
criteri progettuali<br />
Tempi e costi generici, da valutarsi per singoli interventi.<br />
P.S.R. 2007 – 2013 Puglia<br />
Misura 216 – Sostegno agli investimenti non produttivi.<br />
Necessaria preventiva Valutazione <strong>di</strong> Incidenza.<br />
145
Scheda azione<br />
sito SIC e ZPS "Area delle Gravine IT9130007<br />
IA7<br />
Titolo dell’azione<br />
Interventi <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa dagli incen<strong>di</strong> boschivi<br />
Generale <br />
Localizzata <br />
Tipo azione<br />
intervento attivo (IA)<br />
regolamentazione (RE)<br />
incentivazione (IN)<br />
programma <strong>di</strong> monitoraggio e ricerca (PM)<br />
programma <strong>di</strong>dattico (PD)<br />
Eventuale stralcio<br />
cartografico<br />
(vale per le azioni<br />
localizzate)<br />
Descrizione dello stato<br />
attuale e<br />
contestualizzazione<br />
dell’azione nel PdG<br />
(=relazione con<br />
l’obiettivo <strong>generale</strong> <strong>di</strong><br />
PdG)<br />
Finalità dell’azione<br />
(obiettivo specifico)<br />
La pratica <strong>di</strong> incen<strong>di</strong>are le stoppie e gli incen<strong>di</strong> dolosi in <strong>generale</strong><br />
rappresentano per l’area un oggettivo problema, in particolare per le<br />
specie animali a minore mobilità e per i ni<strong>di</strong>acei nonché per alcune<br />
tipologie <strong>di</strong> habitat:<br />
• Querceti <strong>di</strong> Quercus trojana;<br />
• Foreste <strong>di</strong> Quercus ilex;<br />
• Pinete me<strong>di</strong>terranee <strong>di</strong> pini mesogeni endemici<br />
Prevenzione degli incen<strong>di</strong> boschivi finalizzata alla tutela degli habitat e<br />
delle specie.<br />
Descrizione dell’azione<br />
(metodologia) e<br />
programma operativo<br />
Realizzazione <strong>di</strong> fasce parafuoco <strong>di</strong> tipo attivo verde <strong>di</strong> ampiezza<br />
<strong>di</strong>mensionata in relazione alle caratteristiche degli eventuali fronti <strong>di</strong><br />
fiamma. Possono essere realizzate nelle seguenti zone, ove sia presente<br />
un elevato rischio <strong>di</strong> incen<strong>di</strong>o:<br />
• zone <strong>di</strong> transizione tra bosco e coltivi, quali seminativi, oliveti<br />
e vigneti.<br />
• zone <strong>di</strong> transizione tra bosco ed incolti.<br />
• zone <strong>di</strong> transizione tra bosco e pascoli.<br />
Altri interventi <strong>di</strong> prevenzione per una più efficace azione <strong>di</strong> contrasto<br />
degli incen<strong>di</strong> boschivi:<br />
• spalcature e/o asportazione <strong>di</strong> parti <strong>di</strong> piante secche o<br />
deperienti in particolare sulle piante <strong>di</strong> conifere <strong>di</strong> specie ad<br />
alta infiammabilità;<br />
• <strong>di</strong>radamento dal basso nei popolamenti <strong>di</strong> conifere;<br />
• <strong>di</strong>radamento e, ove possibile, conversione all’alto fusto dei<br />
146
cedui;<br />
• qualunque intervento volto a favorire l’affermazione delle<br />
latifoglie, nei boschi misti.<br />
• realizzazione <strong>di</strong> torrette d’avvistamento.<br />
Gli interventi dovranno essere realizzati al <strong>di</strong> fuori del periodo riproduttivo<br />
delle specie ornitiche.<br />
Descrizione dei<br />
risultati attesi<br />
In<strong>di</strong>catori target<br />
Diminuzione della superficie incen<strong>di</strong>ata.<br />
Lunghezza fasce parafuoco, superficie boscata interessata da interventi <strong>di</strong><br />
manutenzione finalizzati alla prevenzione antincen<strong>di</strong>o<br />
Interessi economici<br />
coinvolti<br />
Soggetti competenti<br />
e modalità attuative<br />
Priorità dell’azione<br />
Tempi<br />
e stima dei costi<br />
Riferimenti<br />
programmatici e linee<br />
<strong>di</strong> finanziamento<br />
Corpo Forestale dello Stato, Regione Puglia, Ente Parco, Comuni, <strong>Provincia</strong>.<br />
ELEVATA<br />
Per la realizzazione delle fasce parafuoco si stima un costo <strong>di</strong> circa 5.950,00<br />
€/ha<br />
Per la manutenzione or<strong>di</strong>naria delle fasce parafuoco si prevede un costo nel<br />
caso <strong>di</strong> ripulitura meccanica con allontanamento del materiale <strong>di</strong> risulta <strong>di</strong><br />
circa 585,00 €/ha e <strong>di</strong> 3.500,00 €/ha nel caso <strong>di</strong> ripulitura manuale;<br />
Per gli altri interventi selvicolturali, costi variabili in funzione del tipo <strong>di</strong><br />
intervento<br />
PSR 2007-2013 PUGLIA<br />
Misura 226 Azione 2 a) La creazione e manutenzione <strong>di</strong> infrastrutture <strong>di</strong><br />
protezione finalizzate all’antincen<strong>di</strong>o boschivo<br />
Riferimenti tecnici e<br />
criteri progettuali<br />
Necessaria preventiva Valutazione <strong>di</strong> Incidenza.<br />
147
Scheda azione<br />
Tipologia sito (SIC/ZPS)<br />
sito SIC e ZPS "Area delle Gravine<br />
IT9130007”<br />
IA8<br />
PMR<br />
IN<br />
Titolo dell’azione<br />
Conservazione degli habitat forestali<br />
Generale <br />
Localizzata <br />
Tipo azione<br />
intervento attivo (IA)<br />
regolamentazione (RE)<br />
incentivazione (IN)<br />
programma <strong>di</strong> monitoraggio e/o ricerca (PMR)<br />
programma <strong>di</strong>dattico (PD)<br />
Eventuale stralcio<br />
cartografico<br />
(vale per le azioni<br />
localizzate)<br />
Descrizione dello stato<br />
attuale e<br />
contestualizzazione<br />
dell’azione nel PdG<br />
(=relazione con<br />
l’obiettivo <strong>generale</strong> <strong>di</strong><br />
PdG)<br />
Gran parte delle fitocenosi forestali, soprattutto quelle situate sui pianori,<br />
sono soggette alle azione negative delle ripetute ceduazioni e del pascolo,<br />
oltre che degli effetti degli incen<strong>di</strong> ricorrenti. Questo ha determinato un<br />
progressivo degrado delle formazioni forestali che si manifesta con<br />
l’impoverimento floristico, la semplificazione della struttura e la maggiore<br />
vulnerabilità alle avversità biotiche e abiotiche che, in taluni casi, ne ha<br />
compromesso lo stato <strong>di</strong> conservazione soprattutto in conseguenza della<br />
<strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong> inse<strong>di</strong>amento e affermazione della rinnovazione naturale.<br />
Finalità dell’azione<br />
(obiettivo specifico)<br />
Descrizione dell’azione<br />
(metodologia) e<br />
programma operativo<br />
Descrizione dei<br />
risultati attesi<br />
Favorire i fenomeni <strong>di</strong> rinnovazione naturale, costituzione <strong>di</strong> boschi più<br />
complessi e capaci <strong>di</strong> essere maggiormente resistenti nei confronti delle<br />
avversità biotiche e abiotiche<br />
Interventi selvicolturali in linea con la Gestione Forestale Sostenibile.<br />
Progressivo avviamento dei cedui all’alto fusto dove è possibile per le<br />
con<strong>di</strong>zioni ecologiche e sociali. Tecniche <strong>di</strong> coltivazione dei boschi<br />
cedui meno impattanti (allungamento del turno minimo, matricinatura<br />
intensiva, ecc.). Gli eventuali interventi <strong>di</strong> rimboschimento e <strong>di</strong><br />
rinfoltimento devono prevedere l’impiego esclusivo <strong>di</strong> specie autoctone<br />
<strong>di</strong> ecotipi locali. È necessario organizzare perio<strong>di</strong>che raccolte <strong>di</strong><br />
materiale <strong>di</strong> propagazione ai sensi del D.lgs 386/2003<br />
Creazione <strong>di</strong> fitocenosi forestali meno semplificate<br />
148
In<strong>di</strong>catori target<br />
Interessi economici<br />
coinvolti<br />
Soggetti competenti<br />
e modalità attuative<br />
Priorità dell’azione<br />
Tempi<br />
e stima dei costi<br />
Riferimenti<br />
programmatici e linee<br />
<strong>di</strong> finanziamento<br />
Riferimenti tecnici e<br />
criteri progettuali<br />
In<strong>di</strong>catori da I9 a I34<br />
Proprietari pubblici e privati<br />
Regione Puglia, <strong>Provincia</strong> <strong>di</strong> <strong>Taranto</strong>, Ente Parco<br />
ELEVATA<br />
Azione costante nel tempo<br />
P.S.R. 2007 – 2013 Puglia<br />
Misura 122 Accrescimento del valore economico delle foreste<br />
Misura 227 - Investimenti non produttivi forestali<br />
Misura 226 - Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi<br />
Riferimenti:<br />
- Norme contenute nell’art. 23 “Gestione forestale” del Regolamento del SIC<br />
– ZPS;<br />
- L’Habitat 9250 “Boschi a Quercus trojana” in Italia, 2008. Autori: Misano<br />
G. & Di Pietro R.. Fitosociologia vol. 44 (2) suppl. 1: 235-238.<br />
- Bibliografia, <strong>di</strong> natura scientifica, recante dati sulla conservazione e<br />
gestione sostenibile degli habitat forestali.<br />
149
Scheda azione<br />
Sito SIC e ZPS "Area delle Gravine IT9130007<br />
IA9<br />
Titolo dell’azione<br />
Interventi <strong>di</strong> pulizia delle gravine<br />
Generale <br />
Localizzata <br />
Tipo azione<br />
intervento attivo (IA)<br />
regolamentazione (RE)<br />
incentivazione (IN)<br />
programma <strong>di</strong> monitoraggio e/o ricerca (PMR)<br />
programma <strong>di</strong>dattico (PD)<br />
Eventuale stralcio<br />
cartografico (vale per le<br />
azioni localizzate)<br />
Descrizione dello stato<br />
attuale e<br />
contestualizzazione<br />
dell’azione nel PdG<br />
(=relazione con<br />
l’obiettivo <strong>generale</strong> <strong>di</strong><br />
PdG)<br />
Finalità dell’azione<br />
(obiettivo specifico)<br />
Nelle aree delle gravine, soprattutto in quelle prossime ai centri urbani,<br />
spesso si riscontra la presenza <strong>di</strong> rifiuti <strong>di</strong> vario genere abbandonati<br />
in<strong>di</strong>scriminatamente (<strong>di</strong>scariche abusive). La presenza <strong>di</strong> rifiuti in tali aree<br />
può innescare fenomeni <strong>di</strong> degrado e/o inquinamento compromettendo la<br />
conservazione degli habitat, in particolare per formazioni rupicole, leccete,<br />
formazioni <strong>di</strong> Euphorbia dendroides.<br />
Risanamento dei solchi delle gravine e/o prossime ad esse inquinate e/o<br />
degradate ai fini della conservazione e tutela degli habitat.<br />
Descrizione dell’azione<br />
(metodologia) e<br />
programma operativo<br />
Dovranno essere pre<strong>di</strong>sposti singoli progetti <strong>di</strong> intervento finalizzati a<br />
realizzare un’accurata pulizia dell’area attraverso la totale rimozione dei<br />
rifiuti abbandonati.<br />
Nei casi in cui le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> sversamento e/o la tipologia dei rifiuti<br />
prelevati in situ (fusti, materiali contenenti amianto, elettrodomestici, ecc.)<br />
possono aver generato rilascio <strong>di</strong> inquinanti pericolosi, si dovrà procedere ad<br />
un piano <strong>di</strong> indagine preliminare (Piano <strong>di</strong> caratterizzazione) sull’eventuale<br />
stato <strong>di</strong> contaminazione del sito e successivamente alla pre<strong>di</strong>sposizione delle<br />
azioni previste dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i. (messa in sicurezza d’emergenza<br />
operativa, permanente, bonifica, ripristino ambientale).<br />
La raccolta dei rifiuti dovrà essere eseguita preferibilmente con mezzi<br />
manuali e adottando tutte le precauzioni e modalità <strong>di</strong> esecuzione per limitare<br />
l’impatto sugli habitat.<br />
Il progetto dovrà, inoltre, prevedere un piano <strong>di</strong> tutela, controllo e<br />
monitoraggio del sito attraverso interventi rivolti ad impe<strong>di</strong>re il libero<br />
accesso all’area, quali :<br />
• pre<strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> barriere in corrispondenza <strong>di</strong> ponti e/o<br />
attraversamenti per eliminare la possibilità fisica/operativa <strong>di</strong><br />
effettuare lo sversamento dei rifiuti nell’area delle gravine ;<br />
• protezione delle vie e dei passaggi che permettono un accesso alla<br />
gravina in modo incontrollato ;<br />
150
• sensibilizzazione della citta<strong>di</strong>nanza al problema dell’abbandono<br />
incontrollato dei rifiuti me<strong>di</strong>ante la pre<strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> cartelli<br />
informativi circa gli interventi effettuati sul sito e riguardo alle<br />
valenze paesaggistiche e naturali dell’area;<br />
• la posa in opera <strong>di</strong> idonea cartellonistica per il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> <strong>di</strong>scarica<br />
nelle zone perimetrali all’area della gravina;<br />
• realizzazione dove possibile <strong>di</strong> percorsi naturalistici (cfr scheda<br />
IA10) attraverso la posa in opera <strong>di</strong> segnaletica <strong>di</strong> informazione<br />
dell’area della gravina, sulle essenze presenti nell’habitat e la<br />
realizzazione <strong>di</strong> area sosta attrezzata.<br />
Gli interventi dovranno essere realizzati al <strong>di</strong> fuori del periodo riproduttivo<br />
delle specie ornitiche.<br />
Descrizione dei<br />
risultati attesi<br />
In<strong>di</strong>catori target<br />
Controllo e <strong>di</strong>minuzione del fenomeno <strong>di</strong> inquinamento delle aree ricadenti<br />
nel sito per abbandono <strong>di</strong> rifiuti. Sensibilizzazione delle comunità locali nei<br />
confronti della tutela dell’ambiente, aumento della vegetazione nelle aree<br />
bonificate.<br />
Superficie delle gravine risanate e aumento della vegetazione.<br />
Interessi<br />
coinvolti<br />
economici<br />
Soggetti competenti<br />
e modalità attuative<br />
Priorità dell’azione<br />
<strong>Provincia</strong> e Comuni.<br />
Gli interventi dovranno essere <strong>di</strong>sposti ed effettuati secondo le procedure e le<br />
norme in materia <strong>di</strong> gestione dei rifiuti e bonifica <strong>di</strong> siti inquinati, nel rispetto<br />
della salvaguar<strong>di</strong>a degli habitat.<br />
ELEVATA<br />
Tempi<br />
e stima dei costi<br />
Riferimenti<br />
programmatici e linee<br />
<strong>di</strong> finanziamento<br />
Riferimenti tecnici e<br />
criteri progettuali<br />
Tempi e costi generici, da valutarsi per singoli interventi.<br />
Fon<strong>di</strong> “Ecotassa” art.15. L.R. 5/1997<br />
Necessaria preventiva Valutazione <strong>di</strong> Incidenza.<br />
Riferimento normativo : d.lgs. 152/2006 e s.m.i.<br />
151
Scheda azione<br />
IA10<br />
sito SIC e ZPS "Area delle Gravine IT9130007<br />
Titolo dell’azione Realizzazione <strong>di</strong> percorsi<br />
naturalistici/escursionistici/culturali<br />
Generale <br />
Localizzata <br />
Tipo azione<br />
intervento attivo (IA)<br />
regolamentazione (RE)<br />
incentivazione (IN)<br />
programma <strong>di</strong> monitoraggio e/o ricerca (PMR)<br />
programma <strong>di</strong>dattico (PD)<br />
Eventuale stralcio<br />
cartografico<br />
(vale per le azioni<br />
localizzate)<br />
Descrizione dello stato<br />
attuale e<br />
contestualizzazione<br />
dell’azione nel PdG<br />
(=relazione con<br />
l’obiettivo <strong>generale</strong> <strong>di</strong><br />
PdG)<br />
Finalità dell’azione<br />
(obiettivo specifico)<br />
Descrizione dell’azione<br />
(metodologia) e<br />
programma operativo<br />
Non tutte le gravine presenti nel sito sono dotate <strong>di</strong> percorsi naturalistici ed<br />
infrastrutture per la fruizione e l’informazione ambientale. Le gravine<br />
costituiscono risorse naturali e culturali per la presenza <strong>di</strong>ffusa <strong>di</strong> resti della<br />
civiltà rupestre che non sempre sono valorizzate ai fini turistici. Inoltre, una<br />
non corretta fruizione delle aree può determinare comportamenti dannosi per<br />
gli habitat e le specie presenti.<br />
L’in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong> percorsi “guidati”, la sensibilizzazione e l’informazione<br />
attraverso idonei strumenti e cartellonistica contribuisce ad una gestione<br />
delle aree eco-compatibile con gli obiettivi <strong>di</strong> tutela del PdG.<br />
Favorire una fruizione antropica delle aree delle gravine compatibile con le<br />
esigenze <strong>di</strong> conservazione degli habitat in un’ottica <strong>di</strong> valorizzazione delle<br />
gravine e delle risorse del sito.<br />
Realizzazione <strong>di</strong> percorsi naturalistici/escursionistici già in<strong>di</strong>viduati dai<br />
Comuni o da altri strumenti <strong>di</strong> programmazione e/o stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> fattibilità o<br />
in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong> nuovi percorsi nelle aree delle gravine presenti nel sito.<br />
I percorsi dovranno essere in<strong>di</strong>viduati in modo da collegare i punti<br />
attrattori (beni naturalistici, paesaggistici, archeologici e architettonici)<br />
tenendo conto <strong>di</strong>:<br />
• presenza e status degli habitat e delle specie particolarmente<br />
vulnerabili;<br />
• recupero <strong>di</strong> sentieri già esistenti soprattutto dei vecchi tracciati<br />
storici;<br />
• in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong> aree sosta con attrezzature e servizi idonei alla<br />
fruizione;<br />
• connessione con la viabilità esistente attraverso aree <strong>di</strong> scambio<br />
viabilità/sentieri pedonali e/o ciclabili.<br />
I percorsi saranno dotati <strong>di</strong> idonea cartellonistica e pannelli informativi,<br />
152
<strong>di</strong> segnaletica orizzontale e verticale conforme a quanto previsto dalle<br />
normativa <strong>di</strong> riferimento.<br />
Dovrà essere privilegiato l’utilizzo <strong>di</strong> materiali naturali a basso impatto<br />
paesaggistico (recinzioni e arre<strong>di</strong> per le aree sosta in legno; sentieri<br />
realizzati con fondo naturale tipo brecciato, terra battuta; opere <strong>di</strong><br />
sostegno in pietra o materiale vegetale; sistemi <strong>di</strong> protezione con muretti<br />
a secco).<br />
Attività <strong>di</strong> promozione me<strong>di</strong>ante materiale <strong>di</strong>vulgativo, centri <strong>di</strong><br />
informazione e <strong>di</strong> formazione <strong>di</strong> guide turistiche.<br />
Descrizione dei<br />
risultati attesi<br />
In<strong>di</strong>catori target<br />
Interessi economici<br />
coinvolti<br />
Soggetti competenti<br />
e modalità attuative<br />
Priorità dell’azione<br />
Tempi<br />
e stima dei costi<br />
Promozione e fruizione del sito ai fini turistici - culturali<br />
Numero <strong>di</strong> visitatori/anno<br />
Operatori economici locali<br />
Ente Parco, Comuni, <strong>Provincia</strong> <strong>di</strong> <strong>Taranto</strong>.<br />
Nella redazione dei progetti si rende necessaria la collaborazione <strong>di</strong> un<br />
biologo o naturalista esperto in conservazione della fauna selvatica.<br />
BASSA<br />
Tempi ed importi generici da stimare per singoli interventi.<br />
Riferimenti<br />
programmatici e linee<br />
<strong>di</strong> finanziamento<br />
Programma LIFE+ (2007-2013)<br />
Programma Operativo FESR Puglia 2007-2013. ASSE IV Linea <strong>di</strong> intervento<br />
4.1 Infrastrutture, promozione e valorizzazione dell’economia turistica -<br />
Linea <strong>di</strong> intervento 4.2 Tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio<br />
culturale - 4.4 Interventi per la rete ecologica<br />
Riferimenti tecnici e<br />
criteri progettuali<br />
Necessaria preventiva Valutazione <strong>di</strong> Incidenza.<br />
Per la progettazione si dovrà fare riferimento ai contenuti tecnici presenti<br />
nella :<br />
- L.R. 25 agosto 2003, n. 21 Disciplina delle attività escursionistiche e reti<br />
escursionistiche della Puglia;<br />
- D.G.R. n. 316 del 20/03/2007 Regolamento per l’attuazione della Rete<br />
Escursionistica Pugliese (Linee guida per la realizzazione <strong>di</strong> sentieri della<br />
rete escursionistica Pugliese)<br />
153
Scheda azione<br />
sito SIC e ZPS "Area delle Gravine IT9130007<br />
IA11<br />
Titolo dell’azione<br />
Sviluppo della mobilità lenta/piste ciclabili<br />
Generale <br />
Localizzata <br />
Tipo azione<br />
intervento attivo (IA)<br />
regolamentazione (RE)<br />
incentivazione (IN)<br />
programma <strong>di</strong> monitoraggio e/o ricerca (PMR)<br />
programma <strong>di</strong>dattico (PD)<br />
Eventuale stralcio<br />
cartografico<br />
(vale per le azioni<br />
localizzate)<br />
Descrizione dello stato<br />
attuale<br />
e<br />
contestualizzazione<br />
dell’azione nel PdG<br />
(=relazione con<br />
l’obiettivo <strong>generale</strong> <strong>di</strong><br />
PdG)<br />
L’urbanizzazione e le attività umane occupano ed insi<strong>di</strong>ano l’ambiente<br />
naturale, <strong>di</strong>struggendolo o trasformandolo.<br />
Un’organizzazione del territorio, anche attraverso la mobilità che rispetti la<br />
natura è con<strong>di</strong>zione essenziale per la sopravvivenza delle numerose specie a<br />
rischio.<br />
Promuovere lo sviluppo della mobilità lenta all’interno delle aree incluse nel<br />
sito me<strong>di</strong>ante la realizzazione <strong>di</strong> una rete <strong>di</strong> piste ciclabili che colleghi le<br />
<strong>di</strong>verse valenze ambientali e architettoniche (masserie) del territorio<br />
compreso nel sito.<br />
Finalità dell’azione<br />
(obiettivo specifico)<br />
Descrizione dell’azione<br />
(metodologia) e<br />
programma operativo<br />
Valorizzazione e fruizione del patrimonio rurale attraverso la promozione <strong>di</strong><br />
“modalità” sostenibili per il territorio che portino a :<br />
• riduzione delle emissioni gassose inquinanti e del rumore nelle aree<br />
urbane e periurbane<br />
• promozione dell’utilizzo <strong>di</strong> veicoli ad emissione zero<br />
• <strong>di</strong>minuizione del traffico veicolare.<br />
Realizzazione <strong>di</strong> una rete ciclabile da sviluppare sia in ambito urbano<br />
che rurale attraverso :<br />
• realizzazione <strong>di</strong> piste ciclabile ricavate in ambito urbano ed<br />
extraurbano su strade esistenti<br />
• ripristino <strong>di</strong> sentieri e tratturi già esistenti, stra<strong>di</strong>ne interpoderali<br />
per la realizzazione <strong>di</strong> piste ciclabile in ambito rurale<br />
• in<strong>di</strong>viduazione in ambito urbano <strong>di</strong> punti <strong>di</strong> interscambio attrezzati<br />
(parcheggi <strong>di</strong> scambio - bike sharing)<br />
Gli itinerari saranno dotati <strong>di</strong> idonea segnaletica orizzontale e verticale<br />
conforme alla normativa vigente, attrezzati con cartelli e tabelle<br />
154
informativo – <strong>di</strong>dattiche.<br />
Lungo i percorsi dovranno essere in<strong>di</strong>viduate aree sosta con<br />
attrezzature e servizi idonei (stazioni <strong>di</strong> bike-sharing, rastrelliere,<br />
panchine, cestini portarifiuti, pensiline) anche in corrispondenza <strong>di</strong><br />
punti attrattori (masserie, architetture rurali).<br />
Dovranno essere preservati, in ogni caso, gli habitat <strong>di</strong> interesse<br />
prioritario e utilizzati esclusivamente materiali naturali ecocompatibili.<br />
Descrizione<br />
risultati attesi<br />
dei<br />
Sviluppo della mobilità lenta ai fini turistici e ricreativi. Riduzione<br />
dell’utilizzo dei mezzi a combustione<br />
In<strong>di</strong>catori target<br />
Km della rete ciclabile realizzati, n° <strong>di</strong> stazioni bike – sharing, n° utenti/anno<br />
Interessi<br />
coinvolti<br />
economici<br />
Operatori economici locali<br />
Soggetti competenti<br />
e modalità attuative<br />
Priorità dell’azione<br />
Comuni anche in consorzio.<br />
BASSA<br />
Tempi<br />
e stima dei costi<br />
Tempi e costi generici da stimare per singoli interventi.<br />
Riferimenti<br />
programmatici e linee<br />
<strong>di</strong> finanziamento<br />
Programma Operativo FESR Puglia 2007-2013. ASSE V - Linea <strong>di</strong><br />
intervento 5.3 Sviluppo <strong>di</strong> reti, infrastrutture e servizi <strong>di</strong> trasporto urbano ed<br />
extraurbano sostenibili ed accessibili<br />
ASSE IV – Linea <strong>di</strong> intervento 4.1 Infrastrutture, promozione e<br />
valorizzazione dell’economia turistica<br />
Programma LIFE+ (2007-2013)<br />
Riferimenti tecnici e<br />
criteri progettuali<br />
Necessaria preventiva Valutazione <strong>di</strong> Incidenza.<br />
Per quanto riguarda i criteri progettuali si fa riferimento al D.M n. 557/99<br />
Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche<br />
delle piste ciclabili<br />
155
Scheda azione<br />
sito SIC e ZPS "Area delle Gravine” IT9130007<br />
IA12<br />
RE<br />
PMR<br />
Titolo dell’azione<br />
Conservazione ex situ del germoplasma<br />
autoctono<br />
Generale <br />
Localizzata <br />
Tipo azione<br />
intervento attivo (IA)<br />
regolamentazione (RE)<br />
incentivazione (IN)<br />
programma <strong>di</strong> monitoraggio e ricerca (PMR)<br />
programma <strong>di</strong>dattico (PD)<br />
Eventuale stralcio<br />
cartografico<br />
(vale per le azioni<br />
localizzate)<br />
Descrizione dello stato<br />
attuale e<br />
contestualizzazione<br />
dell’azione nel PdG<br />
(=relazione con<br />
l’obiettivo <strong>generale</strong> <strong>di</strong><br />
PdG)<br />
Finalità dell’azione<br />
(obiettivo specifico)<br />
Tra i parametri <strong>di</strong> salvaguar<strong>di</strong>a dei popolamenti vegetali si annovera quello<br />
genetico, sia come <strong>di</strong>fesa dell’integrità genetica delle specie e delle<br />
popolazioni d’interesse, sia come controllo della <strong>di</strong>ffusione <strong>di</strong> specie estranee<br />
alla nostra flora. Pertanto il PdG deve prevedere la raccolta e la<br />
conservazione del patrimonio genetico vegetale autoctono incluse le<br />
conoscenze (etnobotaniche) che ne hanno accompagnato l’evoluzione.<br />
Preservare l’integrità genetica del patrimonio vegetale autoctono anche in<br />
funzione <strong>di</strong> interventi <strong>di</strong> ripristino e rinaturalizzazione.<br />
Descrizione dell’azione<br />
(metodologia) e<br />
programma operativo<br />
Descrizione dei<br />
risultati attesi<br />
Raccolta programmata e perio<strong>di</strong>ca nel tempo del germoplasma<br />
autoctono con relativa etichettatura a corredo per ciascun rilievo<br />
(toponimo, data, coor<strong>di</strong>nate GPS, specie vegetale <strong>di</strong> riferimento) e<br />
successivo trasferimento nelle strutture preposte alla conservazione e<br />
moltiplicazione. L’azione deve avvenire attraverso convenzione con<br />
banche genetiche, orti botanici e vivai specializzati. I dati <strong>di</strong> raccolta<br />
devono essere implementati su PC (banca dati) in modo da costituire<br />
un livello informativo utile per la programmazione delle successive<br />
raccolte <strong>di</strong> germoplasma. Le attività <strong>di</strong> moltiplicazione e<br />
reintroduzione devono essere svolte dai vivai in collaborazione con gli<br />
altri enti coinvolti.<br />
Realizzazione <strong>di</strong> collezioni <strong>di</strong> germoplasma autoctono reperito e<br />
consegnate ai centri specializzati.<br />
156
In<strong>di</strong>catori target<br />
Interessi economici<br />
coinvolti<br />
Soggetti competenti<br />
e modalità attuative<br />
Priorità dell’azione<br />
Tempi<br />
e stima dei costi<br />
Riferimenti<br />
programmatici e linee<br />
<strong>di</strong> finanziamento<br />
Riferimenti tecnici e<br />
criteri progettuali<br />
Programmi informativi realizzati, campioni <strong>di</strong> germoplasma raccolti,<br />
conservati e moltiplicati.<br />
Enti specializzati nella conservazione ex situ (Istituto <strong>di</strong> Genetica Vegetale<br />
del C.N.R. e Museo Orto Botanico dell’Università degli Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> Bari) e<br />
moltiplicazione (vivai presenti nel territorio).<br />
Enti <strong>di</strong> Ricerca, Regione Puglia, <strong>Provincia</strong> <strong>di</strong> <strong>Taranto</strong>, Ente Parco, Comuni,<br />
Comunità Montane, vivai, coltivatori custo<strong>di</strong>, impren<strong>di</strong>tori agricoli.<br />
ELEVATA<br />
L’azione è continuativa e permanente, costo complessivo su base triennale €<br />
80.000,00, esclusi i costi <strong>di</strong> moltiplicazione che verranno quantizzati in<br />
funzione dei materiali da allevare e propagare.<br />
LIFE+ 2007-2013<br />
P.S.R. 2007 – 2013 Puglia.<br />
Misura 214 azione 3 – 214/3 Tutela della bio<strong>di</strong>versità.<br />
Misura 214 azione 4 – 214/4 Progetti integrati e banche dati per la<br />
bio<strong>di</strong>versità.<br />
Misura 227 azione 2 – 227/2 Valorizzazione dei popolamenti da seme.<br />
Allegati:<br />
Scheda tecnica <strong>di</strong> rilevamento germoplasma<br />
CODICE RACCOLTA 00001<br />
DATA 25/06/08<br />
TOPONIMO SITO<br />
GRAVINA DI LAMASTUOLA<br />
RILEVATORE/I PERRINO E. & SEMERARI P.<br />
COORDINATE GEOGRAFICHE 40° 36’ 11’’ / 16°24’37’’<br />
CARATTERISTICHE AMBIENTE (TIPO DI VEGETAZIONE, SUOLO, ECC..)<br />
SPECIE<br />
VEGETAZIONE CASMOFITICA<br />
CAMPANULA VERSICOLOR<br />
NUMERO INDIVIDUI DA CUI PROVIENE IL GERMOPLASMA (PER CIASCUN SITO) 12<br />
raccolta <strong>di</strong> germoplasma<br />
Riferimenti:<br />
- Allegato 8 - Elenco delle specie vegetalia rischio. Programma <strong>di</strong> Sviluppo<br />
Rurale della Puglia 2007-2013.<br />
- Convenzione <strong>di</strong> Berna (1979).<br />
- Convenzione CITES (1975).<br />
- An Annotated Checklist of the Italian Vascular Flora, 2005. Autori: Conti<br />
157
F., Abbate G., Alessandrini G. & Blasi C.. Palombi E<strong>di</strong>tori, Roma.<br />
-Liste Rosse Regionali delle Piante d’Italia 1997. Autori: Conti F., Manzi A.<br />
& Pedrotti F., 1997 – World Wildlife Fund (WWF) Italia. Società Botanica<br />
Italiana (SBI). Centro Inter<strong>di</strong>partimentale Au<strong>di</strong>ovisivi e Stampa, Università<br />
<strong>di</strong> Camerino, 139 pp..<br />
- Bibliografia, <strong>di</strong> natura scientifica, recante dati sulla conservazione ex situ <strong>di</strong><br />
germoplasma autoctono presente nell’area in oggetto.<br />
158
Scheda azione<br />
sito SIC e ZPS "Area delle Gravine IT9130007<br />
IA13<br />
Titolo dell’azione<br />
Realizzazione <strong>di</strong> connessioni ecologiche nella<br />
viabilità esistente<br />
Generale <br />
Localizzata <br />
Tipo azione<br />
intervento attivo (IA)<br />
regolamentazione (RE)<br />
incentivazione (IN)<br />
programma <strong>di</strong> monitoraggio e/o ricerca (PMR)<br />
programma <strong>di</strong>dattico (PD)<br />
Eventuale stralcio<br />
cartografico<br />
(vale per le azioni<br />
localizzate)<br />
Descrizione dello stato<br />
attuale e<br />
contestualizzazione<br />
dell’azione nel PdG<br />
(=relazione con<br />
l’obiettivo <strong>generale</strong> <strong>di</strong><br />
PdG)<br />
Finalità dell’azione<br />
(obiettivo specifico)<br />
La causa primaria della per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> bio<strong>di</strong>versità è dovuta al processo <strong>di</strong><br />
frammentazione degli ambienti naturali per cause antropiche.<br />
La presenza <strong>di</strong> una strada in un determinato ambiente produce oltre che una<br />
per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong>retta <strong>di</strong> habitat anche una riduzione dell’omogeneità e della<br />
compattezza dell’ecosistema e un incremento dell’ “effetto margine” (serie <strong>di</strong><br />
effetti fisico–chimici e biologici che induce nei frammenti, una<br />
trasformazione della struttura vegetazionale, del microclima, della copertura<br />
del suolo che provoca effetti <strong>di</strong>retti e in<strong>di</strong>retti sulla <strong>di</strong>stribuzione e<br />
abbondanza delle specie animali e vegetali).<br />
La presenza fisica della strada, spesso dotata <strong>di</strong> barriere invalicabili quali<br />
new jersey, impe<strong>di</strong>sce il movimento <strong>di</strong> animali tra aree <strong>di</strong>verse e,<br />
in<strong>di</strong>rettamente, anche <strong>di</strong> piante (effetto barriera).<br />
Rendere “permeabile” un’infrastruttura (strada, ferrovia, autostrada) nei<br />
confronti della fauna selvatica. Tutela della fauna<br />
Descrizione dell’azione<br />
(metodologia) e<br />
programma operativo<br />
Realizzazione <strong>di</strong> corridoi faunistici per l’attraversamento della fauna<br />
lungo le infrastrutture lineari esistenti : strade, autostrade. Lungo le<br />
infrastrutture utilizzare condotti e/o canali già esistenti per realizzare<br />
“attraversamenti sicuri per la fauna” ossia : passerelle per il transito<br />
degli animali da inserire nei canali sotterranei, realizzazione <strong>di</strong> corsie<br />
faunistiche laterali al condotto e <strong>di</strong> collegamento tra l’attraversamento e<br />
gli ambienti naturali limitrofi. Tali corsie dovranno avere un suolo<br />
naturale (erba, terra, sabbia) e vegetazione <strong>di</strong> invito.<br />
159
Descrizione dei<br />
risultati attesi<br />
In<strong>di</strong>catori target<br />
Numero <strong>di</strong> sottopassi - strade e ferrovie adeguate<br />
Aumento della fauna locale<br />
Interessi economici<br />
coinvolti<br />
Soggetti competenti<br />
e modalità attuative<br />
Priorità dell’azione<br />
<strong>Provincia</strong>, ANAS, Comuni, ferrovie dello Stato, Ferrovie sud-est (zona<br />
buffer)<br />
BASSA<br />
Tempi<br />
e stima dei costi<br />
Riferimenti<br />
programmatici e linee<br />
<strong>di</strong> finanziamento<br />
Programma Operativo FESR Puglia 2007-2013. ASSE IV –Linea <strong>di</strong><br />
intervento 4.4 Interventi per la rete ecologica<br />
Riferimenti tecnici e<br />
criteri progettuali<br />
Esempio <strong>di</strong> un sottopasso per attraversamento fauna<br />
I sottopassaggi artificiali per attraversamento fauna locale potranno essere<br />
arricchiti con la presenza <strong>di</strong> corsi d’acqua, anche artificiali, collocati nelle<br />
vicinanze, allo scopo <strong>di</strong> richiamare maggiormente la presenza <strong>di</strong> animali nei<br />
punti predeterminati<br />
160
Scheda azione<br />
sito SIC e ZPS "Area delle Gravine IT9130007<br />
IA14<br />
Titolo dell’azione<br />
Emissioni zero – Città Virtuose<br />
Generale <br />
Localizzata <br />
Tipo azione<br />
intervento attivo (IA)<br />
regolamentazione (RE)<br />
incentivazione (IN)<br />
programma <strong>di</strong> monitoraggio e/o ricerca (PMR)<br />
programma <strong>di</strong>dattico (PD)<br />
Eventuale stralcio<br />
cartografico<br />
(vale per le azioni<br />
localizzate)<br />
Descrizione dello stato<br />
attuale e<br />
contestualizzazione<br />
dell’azione nel PdG<br />
(=relazione con<br />
l’obiettivo <strong>generale</strong> <strong>di</strong><br />
PdG)<br />
Salvaguardare l’efficienza e la funzionalità ecologica degli habitat e/o specie<br />
alle quali il sito è "de<strong>di</strong>cato" anche attraverso azioni indotte quali l’adozione<br />
<strong>di</strong> politiche che promuovano uno sviluppo ecocompatibile ed ecosostenibile<br />
del territorio, finalizzate al mantenimento ed alla conservazione dell’area e<br />
alla in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong> un equilibrio tra le attività antropiche e la tutela del<br />
sito. Elemento essenziale è la realizzazione <strong>di</strong> una rete <strong>di</strong> collaborazione a<br />
livello locale tra pubbliche amministrazione, enti <strong>di</strong> controllo ed imprese<br />
private, al fine <strong>di</strong> riconoscere un territorio come “virtuoso” che mira ad<br />
implementare politiche <strong>di</strong> sviluppo sostenibile.<br />
Questa azione ricade nell’obiettivo <strong>generale</strong> <strong>di</strong> miglioramento dello stato<br />
dell’ambiente attraverso la riduzione delle emissioni, riconducibili ai<br />
trasporti, agli inse<strong>di</strong>amenti civili, alle attività agricole, artigianali turistiche<br />
ed industriali.<br />
Finalità dell’azione<br />
(obiettivo specifico)<br />
Descrizione dell’azione<br />
(metodologia) e<br />
programma operativo<br />
Riduzione delle emissioni inquinanti e miglioramento dell’efficienza<br />
energetica, attraverso:<br />
• <strong>di</strong>ffusione <strong>di</strong> tecnologie innovative a basse emissioni e ad elevata<br />
efficienza energetica sia per quanto riguarda le nuove installazioni<br />
sia al momento del ricambio <strong>di</strong> impianti e macchinari;<br />
• maggiore utilizzo <strong>di</strong> combustibili a basso impatto ambientale e uso <strong>di</strong><br />
fonti energetiche rinnovabili;<br />
• adozione da parte del citta<strong>di</strong>no/consumatore <strong>di</strong> comportamenti atti a<br />
ridurre i consumi energetici e le emissioni derivanti dai sistemi <strong>di</strong><br />
riscaldamento e <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zionamento;<br />
• riduzione del traffico e sviluppo <strong>di</strong> una mobilità sostenibile;<br />
• riduzione delle emissioni <strong>di</strong> gas a effetto serra;<br />
• riduzione dell’inquinamento acustico;<br />
• riduzione dell’inquinamento luminoso ed elettromagnetico.<br />
Saranno intraprese azioni che mirano a favorire la riduzione<br />
dell’inquinamento connesso alle attività delle organizzazioni presenti sul<br />
161
territorio, in sinergia tra privati ed enti pubblici.<br />
In particolare, le PA potranno fare uso <strong>di</strong> strumenti gestionali ed<br />
organizzativi ed elaborare piani territoriali come, per esempio, piani<br />
urbani del traffico, piani energetici comunali, piani <strong>di</strong> risanamento<br />
acustico, piani <strong>di</strong> illuminazione, ecc. Qualora la pianificazione<br />
territoriale sia già esistente, gli interventi previsti dal Piano <strong>di</strong> Gestione<br />
dovranno integrarsi a quanto già regolamentato ed incideranno in modo<br />
principale su traffico, viabilità ed emissioni agricole ed industriali.<br />
Tenendo conto che le modalità <strong>di</strong> realizzazione degli interventi saranno<br />
definite nel dettaglio solo in fase <strong>di</strong> progettazione, allo scopo <strong>di</strong> valutare<br />
le peculiarità <strong>di</strong> ogni singolo sito, le azioni previste sono:<br />
• rafforzamento del trasporto pubblico e dell’intermodalità;<br />
• riduzione del traffico e sviluppo <strong>di</strong> una mobilità sostenibile<br />
(realizzazione <strong>di</strong> percorsi ciclabili, incentivazione utilizzo mezzi<br />
pubblici, car pulling, car sharing);<br />
• riduzione dell’impatto del trasporto pubblico sull’ambiente<br />
attraverso la promozione <strong>di</strong> mezzi a basse emissioni <strong>di</strong> scarico;<br />
• definizione dei criteri ed in<strong>di</strong>viduazione delle zone <strong>di</strong> limitazione<br />
totale o parziale del traffico;<br />
• certificazioni ambientale per gli enti pubblici;<br />
• sensibilizzazione degli attori locali all’uso <strong>di</strong> tecnologie<br />
innovative a basso impatto e definizione <strong>di</strong> incentivi per la<br />
certificazione ambientale delle imprese locali;<br />
• definizione <strong>di</strong> incentivi per il settore agricolo, zootecnico ed<br />
industriale per ridurre le emissioni in aria, in acqua e nel suolo.<br />
Descrizione dei<br />
risultati attesi<br />
• Adozione da parte delle comunità locali e delle organizzazione <strong>di</strong><br />
strumenti a supporto dello sviluppo eco-sostenibile;<br />
• Diminuzione e contenimento delle emissioni inquinanti;<br />
• Miglioramento della qualità <strong>di</strong> vita della comunità;<br />
• Valorizzazione del territorio e maggiore sviluppo delle attività<br />
turistiche.<br />
In<strong>di</strong>catori target • Numero <strong>di</strong> comuni che hanno attivato azioni per il contenimento<br />
delle emissioni;<br />
• Numero <strong>di</strong> iniziative intraprese per comune;<br />
• Numero <strong>di</strong> imprese o enti che hanno ottenuto la certificazione<br />
ambientale.<br />
Interessi economici<br />
coinvolti<br />
Soggetti competenti<br />
e modalità attuative<br />
Priorità dell’azione<br />
Operatori turistici; imprese artigiane ed agricole, PMI.<br />
Comuni, <strong>Provincia</strong>, Regione, ARPA, Imprese.<br />
BASSA<br />
162
Tempi<br />
e stima dei costi<br />
Riferimenti<br />
programmatici e linee<br />
<strong>di</strong> finanziamento<br />
Tempi e stima dei costi generici, da valutare per singoli piani e/o interventi.<br />
• Programma Operativo FESR Puglia 2007-2013. ASSE II Linea <strong>di</strong><br />
intervento 2.4 Interventi per l’utilizzo <strong>di</strong> fonti energetici rinnovabili e<br />
per l’adozione <strong>di</strong> tecniche per il risparmio energetico nei <strong>di</strong>versi<br />
settori <strong>di</strong> impiego - ASSE V Linea <strong>di</strong> intervento 5.3 Sviluppo <strong>di</strong> reti,<br />
infrastrutture e servizi <strong>di</strong> trasporto urbano ed extraurbano sostenibili<br />
ed accessibili ASSE VII Linea <strong>di</strong> intervento 7.2 Riqualificazione<br />
dell’ambiente nei centri urbani<br />
• PSR Regione Puglia 2007-2013 ASSE III Qualità della vita nelle<br />
zone rurali e <strong>di</strong>versificazione dell’economia rurale - ASSE IV<br />
“LEADER”<br />
Riferimenti tecnici e<br />
criteri progettuali<br />
163
Scheda azione<br />
sito SIC e ZPS "Area delle Gravine IT9130007<br />
IA15<br />
RE<br />
PMR<br />
Titolo dell’azione<br />
Conservazione in situ (Riserve genetiche)<br />
degli habitat vegetazionali <strong>di</strong> interesse<br />
comunitario<br />
Generale Localizzata <br />
Tipo azione<br />
intervento attivo (IA)<br />
regolamentazione (RE)<br />
incentivazione (IN)<br />
programma <strong>di</strong> monitoraggio e ricerca (PM)<br />
programma <strong>di</strong>dattico (PD)<br />
Eventuale stralcio<br />
cartografico<br />
(vale per le azioni<br />
localizzate)<br />
Descrizione dello stato<br />
attuale e<br />
contestualizzazione<br />
dell’azione nel PdG<br />
(=relazione con<br />
l’obiettivo <strong>generale</strong> <strong>di</strong><br />
PdG)<br />
Finalità dell’azione<br />
(obiettivo specifico)<br />
Descrizione dell’azione<br />
(metodologia) e<br />
programma operativo<br />
Descrizione dei<br />
risultati attesi<br />
L’area in oggetto presenta <strong>di</strong>versi habitat vegetazionali, alcuni dei quali<br />
prioritari, riportati nell’allegato I della <strong>di</strong>rettiva habitat 92/43/CEE che<br />
necessitano <strong>di</strong> opportuni misure <strong>di</strong> conservazione in situ. A tal fine devono<br />
essere in<strong>di</strong>viduate dei siti denominati “Riserve genetiche”.<br />
Preservare in modo integrale gli habitat identificati (riserve genetiche). Le<br />
riserve genetiche costituiranno i siti <strong>di</strong> elezione per la raccolta <strong>di</strong><br />
germoplasma autoctono spontaneo.<br />
Perimetrazione e monitoraggio delle riserve genetiche. L’estensione delle<br />
riserve genetiche varia in relazione al tipo/i <strong>di</strong> habitat presente/i nella<br />
riserva genetica. La riserva può variare da alcune decine <strong>di</strong> m 2 , come<br />
per la vegetazione casmofitica delle rupi calcaree (cod. 8210), ad alcuni<br />
ettari, come per la vegetazione steppica (cod. 6220). Pertanto la<br />
perimetrazione deve avvenire con modalità <strong>di</strong>verse in funzione del tipo<br />
ed estensione della riserva, mentre il monitoraggio sarà svolto me<strong>di</strong>ante<br />
l’utilizzo <strong>di</strong> appropriati in<strong>di</strong>catori (scheda <strong>di</strong> azione collegata). Le<br />
riserve genetiche, inoltre, costituiscono la fonte per la raccolta <strong>di</strong><br />
germoplasma autoctono spontaneo. All’interno <strong>di</strong> queste aree è ban<strong>di</strong>ta<br />
qualsiasi utilizzazione forestale anche quelli condotti me<strong>di</strong>ante tecniche<br />
<strong>di</strong> selvicoltura naturalistica.<br />
Perimetrazione delle riserve genetiche, conservazione delle risorse<br />
genetiche presenti e relative banche dati.<br />
164
In<strong>di</strong>catori target<br />
Interessi economici<br />
coinvolti<br />
Soggetti competenti<br />
e modalità attuative<br />
Priorità dell’azione<br />
Tempi<br />
e stima dei costi<br />
Riferimenti<br />
programmatici e linee<br />
<strong>di</strong> finanziamento<br />
Riferimenti tecnici e<br />
criteri progettuali<br />
Programmi informativi realizzati, numero <strong>di</strong> riserve genetiche identificate,<br />
elenco habitat, elenco specie.<br />
I portatori <strong>di</strong> interesse devono relazionasi ai <strong>di</strong>versi enti pubblici responsabili<br />
della conservazione delle riserve genetiche, come Regione Puglia, <strong>Provincia</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>Taranto</strong>, Ente Parco, Comuni, Comunità Montane.<br />
Enti <strong>di</strong> Ricerca regionali specializzati per il monitoraggio della<br />
conservazione in situ.<br />
MEDIA<br />
Per il monitoraggio <strong>di</strong> una riserva genetica i costi variano su base annuale da<br />
un minimo <strong>di</strong> circa € 1.000,00 ad un massimo <strong>di</strong> € 10.000,00 in <strong>di</strong>pendenza<br />
della sua ubicazione ed estensione. Per quanto attiene la sua conservazione i<br />
costi sono legati oltre ai parametri <strong>di</strong> cui si è detto precedentemente ad altri<br />
fattori, come l’incen<strong>di</strong>o, il <strong>di</strong>sturbo antropico, ed a lungo termine ai<br />
cambiamenti climatici. In questo caso la stima dei costi per il l’eventuale<br />
ripristino della riserva dovranno essere valutati caso per caso.<br />
LIFE+ 2007-2013<br />
P.S.R. 2007 – 2013 Puglia<br />
• Misura 216 azione 2 – 216/2 Fasce tampone e aree umide.<br />
• Misura 227 azione 1 – 227/2 Supporto alla rinaturalizzazione dei boschi<br />
per finalità non produttive.<br />
• Misura 227 azione 2 – 227/2 Valorizzazione dei popolamenti da seme.<br />
Allegati:<br />
- Scheda tecnica <strong>di</strong> rilevamento<br />
Riferimenti:<br />
- Allegato 1 & 2 della <strong>di</strong>rettiva Habitat 92/43 CEE.<br />
- Libro rosso degli habitat d’Italia. WWF<br />
- Conservazione in situ <strong>di</strong> Stipa austroitalica Martinovsky ssp. austroitalica,<br />
specie prioritaria dell’Allegato II della Direttiva “Habitat”, 2007. Autori:<br />
Forte L., Carruggio F., Curione F., Mantino F. & Macchia F.. Fitosociologia<br />
vol. 44 (2) suppl. 1: 225-230.<br />
165
Scheda azione<br />
sito SIC e ZPS "Area delle Gravine IT9130007<br />
IA16<br />
PMR<br />
Titolo dell’azione<br />
Censimento degli alberi monumentali e loro<br />
valorizzazione anche a fini ecoturistici<br />
Generale <br />
Localizzata <br />
Tipo azione<br />
intervento attivo (IA)<br />
regolamentazione (RE)<br />
incentivazione (IN)<br />
programma <strong>di</strong> monitoraggio e/o ricerca (PMR)<br />
programma <strong>di</strong>dattico (PD)<br />
Eventuale stralcio<br />
cartografico<br />
(vale per le azioni<br />
localizzate)<br />
Descrizione dello stato<br />
attuale e<br />
contestualizzazione<br />
dell’azione nel PdG<br />
(=relazione con<br />
l’obiettivo <strong>generale</strong> <strong>di</strong><br />
PdG)<br />
Finalità dell’azione<br />
(obiettivo specifico)<br />
La presenza <strong>di</strong> alberi secolari ha da sempre costituito un valore “storico”<br />
inestimabile per un territorio e pertanto si rende necessario censire in modo<br />
puntuale la loro localizzazione che risulterà utile a fini conservazionistici ed<br />
ecoturistici.<br />
Preservare gli esemplari arborei in<strong>di</strong>viduati.<br />
Descrizione dell’azione<br />
(metodologia) e<br />
programma operativo<br />
Descrizione dei<br />
risultati attesi<br />
In<strong>di</strong>catori target<br />
Censimento e raccolta <strong>di</strong> dati relativi a ciascun in<strong>di</strong>viduo (nome volgare,<br />
nome scientifico, circonferenza, altezza, età stimata, stato <strong>di</strong><br />
conservazione, localizzazione geografica riportante il comune <strong>di</strong><br />
appartenenza ed eventuale toponimo e le coor<strong>di</strong>nate G.P.S.). Proporre,<br />
successivamente, itinerari per la loro visita.<br />
Sensibilizzazione delle comunità locali per la valorizzazione. Censimento<br />
puntuale a fini conservazionistici ed ecoturistici. Realizzazione <strong>di</strong> una<br />
banca dati.<br />
Numero esemplari censiti<br />
Interessi economici<br />
coinvolti<br />
166
Soggetti competenti<br />
e modalità attuative<br />
Priorità dell’azione<br />
Corpo Forestale dello Stato, Ente Parco, Comuni, <strong>Provincia</strong> <strong>di</strong> Comunità<br />
Montane.<br />
BASSA<br />
Tempi<br />
e stima dei costi<br />
Riferimenti<br />
programmatici e linee<br />
<strong>di</strong> finanziamento<br />
Riferimenti tecnici e<br />
criteri progettuali<br />
Programma annuale. Costi € 40.000,00<br />
P.S.R. 2007 – 2013 Puglia<br />
Misura 313 azione 1 – 313/1 Creazione <strong>di</strong> itinerari naturalistici.<br />
P.O. FESR 2007-2013<br />
Asse IV “Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attravità e<br />
lo sviluppo” – Interventi per la rete ecologica (Cod. Reg. Att. 51, 55, 56)<br />
Allegati:<br />
- Scheda tecnica <strong>di</strong> rilevamento<br />
Riferimenti:<br />
- An Annotated Checklist of the Italian Vascular Flora, 2005. Autori: Conti<br />
F., Abbate G., Alessandrini G. & Blasi C.. Palombi E<strong>di</strong>tori, Roma.<br />
- Bibliografia, <strong>di</strong> natura <strong>di</strong>vulgativo-scientifica, riportante dati sulla presenza<br />
<strong>di</strong> alberi monumentali presenti nell’area in oggetto.<br />
167
Scheda azione<br />
sito SIC e ZPS "Area delle Gravine IT9130007<br />
IA17 Titolo dell’azione Contenimento della <strong>di</strong>ffusione <strong>di</strong> specie<br />
alloctone invadenti<br />
Generale <br />
Localizzata <br />
Tipo azione<br />
intervento attivo (IA)<br />
regolamentazione (RE)<br />
incentivazione (IN)<br />
programma <strong>di</strong> monitoraggio e/o ricerca (PMR)<br />
programma <strong>di</strong>dattico (PD)<br />
Eventuale stralcio<br />
cartografico<br />
(vale per le azioni<br />
localizzate)<br />
Descrizione dello stato<br />
attuale e<br />
contestualizzazione<br />
dell’azione nel PdG<br />
(=relazione con<br />
l’obiettivo <strong>generale</strong> <strong>di</strong><br />
PdG)<br />
Finalità dell’azione<br />
(obiettivo specifico)<br />
L’eccessiva <strong>di</strong>ffusione spontanea <strong>di</strong> specie vegetali alloctone è in contrasto<br />
con le esigenze <strong>di</strong> tutela degli habitat presenti.<br />
Tutela degli habitat<br />
Descrizione dell’azione<br />
(metodologia) e<br />
programma operativo<br />
Eliminazione degli esemplari arborei ed arbustivi appartenenti a specie<br />
alloctone da tempo naturalizzate.<br />
Descrizione dei<br />
risultati attesi<br />
In<strong>di</strong>catori target<br />
Interessi economici<br />
coinvolti<br />
Soggetti competenti<br />
Riduzione del numero degli in<strong>di</strong>vidui alloctoni<br />
In<strong>di</strong>catori ecologici riportati nel PdG.<br />
Regione Puglia, <strong>Provincia</strong> <strong>di</strong> <strong>Taranto</strong>, Ente Parco, Comunità Montane,<br />
Comuni.<br />
Enti pubblici e privati.<br />
168
e modalità attuative<br />
Priorità dell’azione<br />
Tempi<br />
e stima dei costi<br />
ELEVATA<br />
Tempi e costi generici, da valutarsi per singoli interventi.<br />
Riferimenti<br />
programmatici e linee<br />
<strong>di</strong> finanziamento<br />
Riferimenti tecnici e<br />
criteri progettuali<br />
169
Scheda azione<br />
sito SIC e ZPS "Area delle Gravine IT9130007<br />
IA18<br />
PMR<br />
PD<br />
Titolo dell’azione<br />
Check-list della flora ed in<strong>di</strong>viduazione delle<br />
specie vegetali ad elevato valore<br />
biogeografico e conservazionistico<br />
Generale <br />
Localizzata <br />
Tipo azione<br />
intervento attivo (IA)<br />
regolamentazione (RE)<br />
incentivazione (IN)<br />
programma <strong>di</strong> monitoraggio e/o ricerca (PMR)<br />
programma <strong>di</strong>dattico (PD)<br />
Eventuale stralcio<br />
cartografico<br />
(vale per le azioni<br />
localizzate)<br />
Descrizione dello stato<br />
attuale e<br />
contestualizzazione<br />
dell’azione nel PdG<br />
(=relazione con<br />
l’obiettivo <strong>generale</strong> <strong>di</strong><br />
PdG)<br />
Finalità dell’azione<br />
(obiettivo specifico)<br />
Descrizione dell’azione<br />
(metodologia) e<br />
programma operativo<br />
Gli stu<strong>di</strong> floristici <strong>di</strong> base hanno condotto all’in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong> numerose<br />
specie vegetali per le quali, tuttavia, manca la redazione <strong>di</strong> un rapporto<br />
qualitativo e quantitativo. La realizzazione della check-list delle specie<br />
botaniche presenti, incluse le briofite, costituisce l’informazione minima da<br />
acquisire, in quanto propedeutica all’attuazione <strong>di</strong> altre azioni del Pdg<br />
(check-list specie a rischio, conservazione ex situ e in situ). Di tutte le specie<br />
censite nell’area, 70 sono quelle riportate nelle schede rete Natura 2000<br />
aggiornata in quanto ritenute utili ai fini della conservazione e gestione del<br />
sito. Queste specie insieme, eventualmente, ad altre derivanti da successive<br />
ricerche devono essere adeguatamente preservate per tutelare la <strong>di</strong>versità<br />
biologica del territorio.<br />
Preservare le specie botaniche al fine <strong>di</strong> preservare la bio<strong>di</strong>versità dell’intero<br />
territorio, limitare la per<strong>di</strong>ta o la frammentazione degli habitat in cui esse<br />
sono presenti, <strong>di</strong>vulgare le conoscenze acquisite.<br />
Preservare le specie vegetali a rischio ed i loro siti.<br />
Il programma prevede:<br />
a) costituzione del gruppo <strong>di</strong> lavoro (cartografo esperto GIS e botanico/i<br />
esperti)<br />
b) Raccolta del materiale bibliografico esistente.<br />
c) Esplorazioni <strong>di</strong> campo per eventuali nuovi aggiornamenti. Le<br />
esplorazioni saranno concentrate prevalentemente nei perio<strong>di</strong> <strong>di</strong><br />
massima attività vegetativa delle piante.<br />
d) Realizzazione <strong>di</strong> un data-base aggiornabile; la nomenclatura dei<br />
170
inomi deve fare riferimento a Conti et al. (2005).<br />
e) Redazione <strong>di</strong> testi <strong>di</strong>vugativo-scientifici.<br />
f) In<strong>di</strong>viduazione puntuale delle specie a rischio attraverso mirate e<br />
puntuali esplorazioni <strong>di</strong> campo. Per ogni specie deve essere riportato<br />
nome scientifico, nome volgare, famiglia <strong>di</strong> appartenenza ed in aggiunta<br />
per gli esemplari arborei anche la circonferenza del tronco, altezza, età<br />
stimata e stato <strong>di</strong> conservazione. Ogni singola scheda deve riportare<br />
anche i dati stazionali (comune <strong>di</strong> appartenenza, eventuale toponimo,<br />
esposizione, quota, inclinazione, coor<strong>di</strong>nate G.P.S.). Si deve, inoltre,<br />
prevedere la realizzazione <strong>di</strong> immagini fotografiche georeferenziate del<br />
singolo in<strong>di</strong>viduo, dell’eventuale popolamento vegetale e dell’ambiente<br />
in cui è stato localizzato (nel caso <strong>di</strong> più popolamenti verrà considerato/i<br />
quello/i più rappresentativo/i).<br />
g) Realizzazione della carta della <strong>di</strong>stribuzione reale e potenziale delle<br />
specie floristiche ad elevato valore biogeografico e conservazionistico.<br />
Descrizione dei<br />
risultati attesi<br />
In<strong>di</strong>catori target<br />
Interessi economici<br />
coinvolti<br />
Soggetti competenti<br />
e modalità attuative<br />
Priorità dell’azione<br />
Tempi<br />
e stima dei costi<br />
Riferimenti<br />
programmatici e linee<br />
<strong>di</strong> finanziamento<br />
Redazione <strong>di</strong> una Check-list completa delle specie botaniche presenti.<br />
Divulgazione dei dati raccolti. Redazione <strong>di</strong> una banca dati aggiornabile.<br />
Redazione della carta della <strong>di</strong>stribuzione floristica delle specie ad elevato<br />
valore biogeografico e conservazionistico.<br />
Numero <strong>di</strong> specie e famiglie botaniche censite. Numero <strong>di</strong> specie vegetali a<br />
rischio e loro <strong>di</strong>stribuzione.<br />
Comuni, Ente Parco, Comunità Montane, <strong>Provincia</strong> <strong>di</strong> <strong>Taranto</strong>, Regione<br />
Puglia.<br />
Botanici esperti, Università ed Enti <strong>di</strong> Ricerca.<br />
MEDIA<br />
Un anno per la realizzazione della:<br />
a) Check-list;<br />
b) Carta della <strong>di</strong>stribuzione reale e potenziale delle specie a rischio;<br />
Costo stimato per i punti a e b è pari a € 15.000,00.<br />
c) Manuale <strong>di</strong>vulgativo-scientifico. Costo stimato, escluse le spese <strong>di</strong> stampa<br />
€ 10.000,00;<br />
d) I monitoraggi per i successivi aggiornamenti richiedono un costo stimato,<br />
su base triennale, pari a € 8.000,00.<br />
LIFE+ 2007-2013<br />
P.S.R. 2007 – 2013 Puglia<br />
Misura 216 azione 2 - 216/2 Fasce tampone e aree umide.<br />
Misura 227 azione 2 - 227/2 Supporto alla rinaturalizzazione <strong>di</strong> boschi per<br />
finalità non produttive.<br />
Misura 313 azione 4 - 313/4 Commercializzazione e promozione<br />
171
dell’offerta <strong>di</strong> turismo rurale.<br />
Misura 331 azione 2 - 331/2 Informazione.<br />
Riferimenti tecnici e<br />
criteri progettuali<br />
Allegati:<br />
- Scheda tecnica <strong>di</strong> rilevamento<br />
Riferimenti:<br />
- Allegato 8 - Elenco delle specie vegetalia rischio. Programma <strong>di</strong> Sviluppo<br />
Rurale della Puglia 2007-2013.<br />
- Convenzione <strong>di</strong> Berna (1979).<br />
- Convenzione CITES (1975).<br />
- An Annotated Checklist of the Italian Vascular Flora, 2005. Autori: Conti<br />
F., Abbate G., Alessandrini G. & Blasi C.. Palombi E<strong>di</strong>tori, Roma.<br />
-Liste Rosse Regionali delle Piante d’Italia 1997. Autori: Conti F., Manzi A.<br />
& Pedrotti F., 1997 – World Wildlife Fund (WWF) Italia. Società Botanica<br />
Italiana (SBI). Centro Inter<strong>di</strong>partimentale Au<strong>di</strong>ovisivi e Stampa, Università<br />
<strong>di</strong> Camerino, 139 pp..<br />
- Bibliografia, <strong>di</strong> natura scientifica, riportante dati sulle specie vegetali ad<br />
elevato valore biogeografico e conservazionistico presenti nell’area in<br />
oggetto.<br />
172
Scheda azione<br />
sito SIC e ZPS "Area delle Gravine IT9130007<br />
IA19<br />
PMR<br />
Titolo dell’azione<br />
Carta della vegetazione<br />
Generale <br />
Localizzata <br />
Tipo azione<br />
intervento attivo (IA)<br />
regolamentazione (RE)<br />
incentivazione (IN)<br />
programma <strong>di</strong> monitoraggio e/o ricerca (PMR)<br />
programma <strong>di</strong>dattico (PD)<br />
Eventuale stralcio<br />
cartografico<br />
(vale per le azioni<br />
localizzate)<br />
Descrizione dello stato<br />
attuale e<br />
contestualizzazione<br />
dell’azione nel PdG<br />
(=relazione con<br />
l’obiettivo <strong>generale</strong> <strong>di</strong><br />
PdG)<br />
Finalità dell’azione<br />
(obiettivo specifico)<br />
Descrizione dell’azione<br />
(metodologia) e<br />
programma operativo<br />
La realizzazione della carta della vegetazione, secondo il metodo<br />
fitosociologico, costituisce il principale mezzo informativo per la gestione<br />
dell’area, in quanto in essa confluiscono la carta degli habitat e <strong>di</strong> uso del<br />
suolo con l’aggiunta <strong>di</strong> informazioni legate ad altre tipologie vegetazionali,<br />
non contemplate nell’allegato I della <strong>di</strong>rettiva habitat 92/43 CEE e nel Corine<br />
Land Cover o includenti, con la stesso nome (es. Thero-Brachypo<strong>di</strong>etea) più<br />
cenosi vegetali. L’analisi della vegetazione secondo questo metodo, consente<br />
<strong>di</strong> attribuire le classi <strong>di</strong> uso o copertura del suolo a una o più unità<br />
fitosociologiche. Queste unità riassumono informazioni <strong>di</strong> carattere<br />
ecologico, <strong>di</strong>namico e successionale, che hanno un dettaglio gradatamente<br />
maggiore, andando da quelle più generiche (classi) a quelle più specifiche<br />
(associazioni). L’obiettivo <strong>di</strong> tale carta è quello <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare i tipi <strong>di</strong><br />
vegetazione che rappresentano sta<strong>di</strong> <strong>di</strong>namicamente collegati tra loro,<br />
costituendo le cosiddette “serie <strong>di</strong> vegetazione”. La mappatura delle serie<br />
delle vegetazione (cartografia <strong>di</strong>namica della vegetazione) consente <strong>di</strong><br />
valutare se le specie presenti in un territorio sono coerenti con la vegetazione<br />
potenziale.<br />
Conoscenza puntuale <strong>di</strong> tutte le tipologie <strong>di</strong> vegetazione presenti nel<br />
territorio e <strong>di</strong>namica della loro evoluzione al fine <strong>di</strong> programmare e<br />
pianificare i futuri interventi sul territorio.<br />
Esplorazioni e verifiche <strong>di</strong> campo con l’ausilio <strong>di</strong> ortofoto, carte<br />
topografiche, carta degli habitat e <strong>di</strong> uso del suolo. Le esplorazioni in<br />
campo devono esigere, in gran parte degli ambienti visitati, <strong>di</strong><br />
173
ilievamenti fitosociologici realizzati con il metodo sigmatista <strong>di</strong> Zurigo-<br />
Montpellier (Braun-Blanquet, 1932). La documentazione prodotta dai<br />
rilevamenti vegetazionali deve, naturalmente, portare ad attribuire le<br />
classi <strong>di</strong> uso e copertura del suolo a una o più unità fitosociologiche. In<br />
particolare rispetto alla problematica dei mosaici <strong>di</strong> vegetazione, degli<br />
habitat puntiformi, lineari etc. ci si baserà sull’utilizzo sinergico degli<br />
strumenti <strong>di</strong> classificazione del territorio largamente impiegati dalla<br />
comunità scientifica internazionale. Il programma prevede in or<strong>di</strong>ne<br />
temporale: a) costituzione del gruppo <strong>di</strong> lavoro (cartografo esperto GIS<br />
e botanico/i esperti in flora e vegetazione); b) programmazione del<br />
lavoro e delle uscite in campo; b) costruzione dello strato informativo in<br />
ambiente GIS; c) stampa dei materiali informativi già noti (ortofoto,<br />
carte tematiche, etc…); d) esplorazioni con realizzazione dei rilievi<br />
fitosociologici (prevedere per gran parte delle cenosi vegetali la<br />
realizzazione <strong>di</strong> foto georeferenziate utili sia come documento e sia per<br />
una più precisa <strong>di</strong>gitalizzazione dei poligoni in fase <strong>di</strong> implementazione<br />
GIS; e) creazione dei poligoni in ambiente GIS; f) relazione tecnica<br />
sintetica da allegare alla carta sinfitosociologica; g) Redazione della<br />
cartografia in scala 1:10.000, con tavole <strong>di</strong> maggiore dettaglio per<br />
rappresentare aree <strong>di</strong> particolare pregio naturalistico..<br />
Descrizione dei<br />
risultati attesi<br />
In<strong>di</strong>catori target<br />
Interessi economici<br />
coinvolti<br />
Soggetti competenti<br />
e modalità attuative<br />
Priorità dell’azione<br />
Carta della vegetazione in scala 1:10.000 e stralci in scala 1:5.000 o<br />
1:2.000 per alcune tipologie <strong>di</strong> vegetazione in cui è necessaria una scala <strong>di</strong><br />
maggior dettaglio corredata <strong>di</strong> relativa relazione tecnica.<br />
Distribuzione, numero, copertura e <strong>di</strong>namica delle tipologie <strong>di</strong> vegetazione<br />
presenti.<br />
Enti <strong>di</strong> ricerca, Ente Parco.<br />
Figure previste: a) Cartografo specializzato nell’operare in ambiente GIS; B)<br />
botanico/i <strong>di</strong> provata esperienza in stu<strong>di</strong> vegetazionali con approccio<br />
fitosociologico.<br />
MEDIA<br />
Tempi<br />
e stima dei costi<br />
Riferimenti<br />
programmatici e linee<br />
<strong>di</strong> finanziamento<br />
Tempo stimato: 2 anno Costo: € 80.000,00.<br />
LIFE+ 2007-2013<br />
POR Puglia 2007-2013<br />
174
Riferimenti tecnici e<br />
criteri progettuali<br />
Allegati:<br />
- Scheda tecnica <strong>di</strong> rilevamento fitosociologico<br />
- Carta uso del suolo<br />
- Carta degli habitat<br />
Riferimenti:<br />
- Libro Rosso degli Habitat d’Italia della Rete Natura, 2005. Ministero<br />
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. WWF Italia – onlus.<br />
- Contributi fitosociologici realizzati nell’area in esame.<br />
175
Scheda azione<br />
sito SIC e ZPS "Area delle Gravine IT9130007<br />
IA20<br />
PMR<br />
Titolo dell’azione<br />
Monitoraggio della bio<strong>di</strong>versità vegetale<br />
(Aree <strong>di</strong> saggio)<br />
Generale <br />
Localizzata <br />
Tipo azione<br />
intervento attivo (IA)<br />
regolamentazione (RE)<br />
incentivazione (IN)<br />
programma <strong>di</strong> monitoraggio e/o ricerca (PMR)<br />
programma <strong>di</strong>dattico (PD)<br />
Eventuale stralcio<br />
cartografico<br />
(vale per le azioni<br />
localizzate)<br />
Descrizione dello stato<br />
attuale e<br />
contestualizzazione<br />
dell’azione nel PdG<br />
(=relazione con<br />
l’obiettivo <strong>generale</strong> <strong>di</strong><br />
PdG)<br />
Finalità dell’azione<br />
(obiettivo specifico)<br />
Descrizione dell’azione<br />
(metodologia) e<br />
programma operativo<br />
Il monitoraggio delle con<strong>di</strong>zioni degli ecosistemi vegetali, ed in particolare<br />
quelli forestali, costituisce un impegno primario degli Stati membri<br />
dell’Unione Europea. In particolare con l’entrata in vigore del Regolamento<br />
(CE) n. 2152/2003 Forest Focus, il tema del monitoraggio del livello <strong>di</strong><br />
bio<strong>di</strong>versità degli ecosistemi forestali si è imposto tra quelli prioritari, al fine<br />
<strong>di</strong> favorire una migliore comprensione dell’interazione tra i fattori <strong>di</strong> impatto<br />
legati alle attività umane e lo stato <strong>di</strong> naturalità e funzionalità ecologica delle<br />
comunità forestali. Seguendo lo schema, opportunamente semplificato, del<br />
progetto pilota denominato BioSoil – bio<strong>di</strong>versity, che vede la partecipazione<br />
<strong>di</strong> 23 Stati membri dell’Unione Europea, è possibile monitorare la<br />
bio<strong>di</strong>versità degli habitat della <strong>di</strong>rettiva europea 92/43 CEE presenti nell’area<br />
SIC-ZPS in oggetto. In questo modo sarà possibile <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> una fotografia<br />
dettagliata e realistica dello stato della bio<strong>di</strong>versità.<br />
Preservare gli habitat e le specie botaniche a rischio per limitare la loro<br />
per<strong>di</strong>ta e/o frammentazione<br />
Fornire una base solida per la costruzione della futura rete <strong>di</strong> monitoraggio<br />
della bio<strong>di</strong>versità su larga scala, come richiesto dalle decisioni del Consiglio<br />
dell’Unione Europea e dalle Conferenze attuative della Convenzione UN<br />
sulla Diversità Biologica.<br />
Il programma prevede:<br />
a) costituzione del gruppo <strong>di</strong> lavoro (forestale e botanico)<br />
b) Scelta delle aree <strong>di</strong> saggio<br />
c) Esplorazioni <strong>di</strong> campo e compilazione della scheda tecnica (allegata<br />
alla presente), in cui si devono riportare i dati stazionali dell’area, gli<br />
176
in<strong>di</strong>catori generici e specifici (la scelta degli in<strong>di</strong>catori, riportati nel PdG,<br />
deve essere ponderata in relazione ad alcuni parametri, i più importanti<br />
dei quali sono l’estensione ed il tipo/i <strong>di</strong> habitat da monitorare).<br />
d) Realizzazione <strong>di</strong> un data-base aggiornabile.<br />
La seguente azione è propedeutica ad altre azioni.<br />
a) conservazione in situ degli habitat vegetazionali <strong>di</strong> interesse<br />
comunitario;<br />
b) conservazione in situ ed ex situ delle specie a rischio<br />
Descrizione dei<br />
risultati attesi<br />
In<strong>di</strong>catori target<br />
Interessi economici<br />
coinvolti<br />
Soggetti competenti<br />
e modalità attuative<br />
Priorità dell’azione<br />
Realizzazione <strong>di</strong> un data-base aggiornabile dello stato della bio<strong>di</strong>versità<br />
vegetale.<br />
In<strong>di</strong>catori ecologici riportati nel PdG.<br />
Enti <strong>di</strong> Ricerca, Comunità Europea, <strong>Provincia</strong> <strong>di</strong> <strong>Taranto</strong>, Ente Parco.<br />
Forestali e Botanici esperti, Università ed Enti <strong>di</strong> Ricerca.<br />
MEDIA<br />
Tempi<br />
e stima dei costi<br />
Riferimenti<br />
programmatici e linee<br />
<strong>di</strong> finanziamento<br />
- il monitoraggio deve essere effettuato con cadenza annuale per un costo<br />
stimato pari a circa € 30.000,00.<br />
LIFE+ 2007-2013<br />
POR Puglia 2007-2013<br />
177
Riferimenti tecnici e<br />
criteri progettuali<br />
Allegati:<br />
Schede tecnica <strong>di</strong> rilevamento (n°1)<br />
178
Schede tecnica <strong>di</strong> rilevamento n°2<br />
PDG – INDICATORI E ANALISI DELLA VEGETAZIONE<br />
AREA DI SAGGIO CODICE:_____________RILEVATORE/I:_______________________________<br />
1) intervallo <strong>di</strong> tempo del rilevamento:____________________________________________<br />
2) tipo <strong>di</strong> bosco e considerazioni generali sull’Area: _________________________________<br />
_____________________________________________________________________________<br />
3) tipo <strong>di</strong> attività interne all’area o nelle vicinanze specificare:_________________________<br />
_____________________________________________________________________________<br />
4) eventuali impatti visibili <strong>di</strong> tale attività:__________________________________________<br />
_____________________________________________________________________________<br />
5) eventuali problemi d’impatto del rilevatore:______________________________________<br />
_____________________________________________________________________________<br />
6) rapporti con i gestori dell’area (CFS o altro):_____________________________________<br />
_____________________________________________________________________________<br />
7) problemi <strong>di</strong> identificazione specie:______________________________________________<br />
_____________________________________________________________________________<br />
_____________________________________________________________________________<br />
_____________________________________________________________________________<br />
_____________________________________________________________________________<br />
8) specie con notazione provvisoria o insufficiente (specificare):_______________________<br />
_____________________________________________________________________________<br />
_____________________________________________________________________________<br />
_____________________________________________________________________________<br />
_____________________________________________________________________________<br />
_____________________________________________________________________________<br />
9) note utili alla corretta interpretazione dei dati e <strong>di</strong> casi particolari:_________________<br />
_____________________________________________________________________________<br />
_____________________________________________________________________________<br />
10) suggerimenti utili alla logistica:_______________________________________________<br />
_____________________________________________________________________________<br />
11) Note:_____________________________________________________________________<br />
_____________________________________________________________________________<br />
data:<br />
firme del/dei rilevatori<br />
Riferimenti:<br />
- An inventory of bio<strong>di</strong>versity in<strong>di</strong>cators in Europe, 2002. European<br />
Environment Agency.<br />
- Agricolture and environment in EU-15 IRENA – the in<strong>di</strong>cator report, 2005.<br />
European Environment Agency.<br />
- Progetto BioSoil – bio<strong>di</strong>versity, 2007. Manuale per le operazioni <strong>di</strong><br />
campionamento della vegetazione.<br />
- Bibliografia, <strong>di</strong> natura scientifica, riportante dati sull’uso <strong>di</strong> bioin<strong>di</strong>catori.<br />
179
Scheda azione<br />
sito SIC e ZPS “Area delle Gravine IT9130007”<br />
IA21<br />
IN<br />
Titolo dell’azione<br />
Attività <strong>di</strong> informazione e sensibilizzazione<br />
Generale <br />
Localizzata <br />
Tipo azione<br />
intervento attivo (IA)<br />
regolamentazione (RE)<br />
incentivazione (IN)<br />
programma <strong>di</strong> monitoraggio e/o ricerca (PMR)<br />
programma <strong>di</strong>dattico (PD)<br />
Eventuale stralcio<br />
cartografico<br />
(vale per le azioni<br />
localizzate)<br />
Descrizione dello stato<br />
attuale e<br />
contestualizzazione<br />
dell’azione nel PdG<br />
(=relazione con<br />
l’obiettivo <strong>generale</strong> <strong>di</strong><br />
PdG)<br />
Finalità dell’azione<br />
(obiettivo specifico)<br />
Attualmente, nel territorio in oggetto, operano efficacemente il Laboratorio<br />
dell’Area Jonica della <strong>Provincia</strong> <strong>di</strong> <strong>Taranto</strong>, co-gestito con il Comune <strong>di</strong><br />
Martina Franca ed il Centro <strong>di</strong> Educazione Ambientale <strong>di</strong> Statte. Nel<br />
territorio <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o è attiva, inoltre, a partire dal giugno del 1999 l'Oasi<br />
LIPU Gravina <strong>di</strong> Laterza, grazie alla comune volontà della <strong>Provincia</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>Taranto</strong>, del Comune <strong>di</strong> Laterza e della LIPU.<br />
L’Oasi estesa per circa 800 ettari è gestita coniugando protezione,<br />
conservazione e salvaguar<strong>di</strong>a del bene naturale con attività <strong>di</strong><br />
educazione ambientale, valorizzazione e promozione del territorio<br />
insieme ad una sua appropriata fruizione.<br />
Negli ultimi anni numerosi stu<strong>di</strong>, ricerche botaniche e faunistiche,<br />
condotte sia dal personale dell’Oasi che da zoologi, ornitologi e<br />
ricercatori e studenti <strong>di</strong> alcune Università italiane, hanno permesso <strong>di</strong><br />
approfon<strong>di</strong>re le conoscenze relative al patrimonio naturalistico<br />
presente e la loro <strong>di</strong>vulgazione Inoltre, l’attuazione <strong>di</strong> progetti <strong>di</strong><br />
conservazione, quali quelli de<strong>di</strong>cati al Capovaccaio e al Grillaio hanno<br />
permesso <strong>di</strong> ottenere importanti risultati <strong>di</strong> interesse scientifico e<br />
conservazionistico.<br />
In particolare la profonda riflessione, in atto nell’ambito del Sistema InFEA<br />
regionale e nei no<strong>di</strong> innanzi richiamati, sullo statuto epistemologico<br />
dell’educazione ambientale e sulle sue valenze formative, ha contribuito a<br />
mettere a fuoco ed a precisare alcuni aspetti essenziali della riflessione<br />
pedagogica in proposito, evidenziando quelle qualità <strong>di</strong>namiche e relazionali<br />
con il territorio, che motivano a proseguire con forza percorsi <strong>di</strong> fruizione<br />
sostenibile e valorizzazione delle aree naturali, in stretta connessione con<br />
percorsi pedagogici ed educativi.<br />
Le azioni educative realizzate dai no<strong>di</strong> del Sistema INFEA per la fruizione<br />
sostenibile nelle aree protette appare <strong>di</strong> estrema rilevanza, per il sito SIC e<br />
ZPS "Area delle Gravine IT9130007”, anche in relazione alle seguenti<br />
possibilità:<br />
- attingere elementi educativi <strong>di</strong>rettamente dalla natura e praticare percorsi<br />
180
formativi esperibili nella concretezza e nella rilevanza locale;<br />
- utilizzare metodologie educative empiriche, vissute all’interno <strong>di</strong> un’area<br />
naturale;<br />
- stabilire e/o rinsaldare il rapporto tra educazione ed ambiente naturale,<br />
evidenziando la circolarità delle relazioni ambientali;<br />
- insegnare, con modelli reali e tangibili, la complessità delle relazioni<br />
ambientali e gli approcci sistemici ed inter<strong>di</strong>sciplinari;<br />
- incentivare le attività sul campo, favorendo situazioni esplorative ed<br />
euristiche;<br />
- rafforzare il senso <strong>di</strong> appartenenza al territorio ed il grado <strong>di</strong> affezione<br />
alla natura;<br />
- concorrere alla rivitalizzazione ed alla gestione sostenibile dell’ Area<br />
delle Gravine;<br />
- attivare percorsi <strong>di</strong> partecipazione attiva e <strong>di</strong> coinvolgimento dei<br />
<strong>di</strong>fferenti portatori <strong>di</strong> interessi.<br />
Descrizione dell’azione<br />
(metodologia) e<br />
programma operativo<br />
Descrizione dei<br />
risultati attesi<br />
Le azioni realizzabili all’interno dell’area protetta fanno riferimento ad<br />
una variegata gamma <strong>di</strong> attività eco-compatibili, che possono essere<br />
gestite dai no<strong>di</strong> presenti sul territorio ed accre<strong>di</strong>tati al Sistema INFEA<br />
regionale:<br />
• educazione ambientale ed escursioni guidate, realizzate con le<br />
scuole, con le popolazioni locali e con gruppi <strong>di</strong> turisti;<br />
• gestione dell’accoglienza negli eco-musei, nei centri <strong>di</strong><br />
educazione ambientale;<br />
• attività <strong>di</strong> ricerca scientifica con l’utilizzo <strong>di</strong> specifiche risorse<br />
messe a <strong>di</strong>sposizione dalla Regione, dal MIUR e dall’Unione<br />
Europea, in collaborazione con Università e Centri <strong>di</strong> Ricerca;<br />
• realizzazione <strong>di</strong> materiali illustrativi e <strong>di</strong>dattici per favorire la<br />
conoscenza e la fruizione sostenibile delle aree protette;<br />
• contributo alla sorveglianza e gestione conservativa dell’area<br />
protetta, attraverso un’azione collaterale <strong>di</strong> presi<strong>di</strong>o del<br />
territorio.<br />
Riappropriazione dei territori da parte delle comunità locali e della<br />
popolazione studentesca con la riscoperta dei valori naturalistici<br />
dell’area.<br />
Valorizzazione turistica e fruizione sostenibile delle aree protette,<br />
realizzata attraverso azioni <strong>di</strong> informazione e <strong>di</strong> marketing territoriale.<br />
In<strong>di</strong>catori target<br />
Numero iniziative <strong>di</strong> informazione e sensibilizzazione finalizzate alla<br />
valorizzazione turistica dell’ “Area delle Gravine IT9130007”<br />
Interessi economici<br />
coinvolti<br />
Soggetti competenti<br />
e modalità attuative<br />
La valorizzazione turistica dell’area produce positivi impatti economici<br />
sull’intera filiera ad essa collegata: dal sistema turistico, all’artigianato, etc.<br />
Laboratorio <strong>di</strong> Educazione Ambientale dell’Area Jonica della <strong>Provincia</strong> <strong>di</strong><br />
<strong>Taranto</strong> e no<strong>di</strong> accre<strong>di</strong>tati al Sistema INFEA (Informazione, Formazione ed<br />
Educazione Ambientale).<br />
181
Priorità dell’azione<br />
Tempi<br />
e stima dei costi<br />
Riferimenti<br />
programmatici e linee<br />
<strong>di</strong> finanziamento<br />
BASSA<br />
Tempi e stima dei costi generici, da valutare per singoli programma <strong>di</strong><br />
comunicazione ed informazione.<br />
Programma Operativo FESR Puglia 2007-2013 - Asse II “Uso sostenibile e<br />
efficiente delle risorse ambientali ed energetiche per lo sviluppo” - Asse IV<br />
“Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e lo<br />
sviluppo”<br />
Programma Operativo FSE Puglia 2007-2013 – Asse IV Capitale Umano<br />
Riferimenti tecnici e<br />
criteri progettuali<br />
182
Scheda azione<br />
sito SIC e ZPS "Area delle Gravine IT9130007”<br />
IA22<br />
IN<br />
Titolo dell’azione<br />
Promozione e sostegno <strong>di</strong> pratiche agricole<br />
sostenibili per la conservazione e l’aumento<br />
della sostanza organica nei suoli<br />
Generale <br />
Localizzata <br />
Tipo azione<br />
intervento attivo (IA)<br />
regolamentazione (RE)<br />
incentivazione (IN)<br />
programma <strong>di</strong> monitoraggio e/o ricerca (PMR)<br />
programma <strong>di</strong>dattico (PD)<br />
Eventuale stralcio<br />
cartografico<br />
(vale per le azioni<br />
localizzate)<br />
Descrizione dello stato<br />
attuale e<br />
contestualizzazione<br />
dell’azione nel PdG<br />
(=relazione con<br />
l’obiettivo <strong>generale</strong> <strong>di</strong><br />
PdG)<br />
Finalità dell’azione<br />
(obiettivo specifico)<br />
Descrizione dell’azione<br />
(metodologia) e<br />
programma operativo<br />
L’area in oggetto è caratterizzata da una prevalente carenza <strong>di</strong> sostanza<br />
organica dei suoli a cui si associa un <strong>di</strong>ffuso deterioramento della qualità e<br />
della struttura del suolo per limitato apporto al terreno <strong>di</strong> sostanze organiche,<br />
con per<strong>di</strong>ta delle funzioni, della fertilità e della bio<strong>di</strong>versità del suolo. Ad<br />
aggravare tale scenario concorrono l’uso spesso irrazionale <strong>di</strong> <strong>di</strong>serbanti e<br />
prodotti fitosanitari, il sovrasfruttamento <strong>di</strong> acqua e suolo, la<br />
meccanizzazione spinta, la salinizzazione, etc.<br />
Tali criticità sono associate ad una scarsa presa <strong>di</strong> coscienza dell’importanza<br />
del problema, sia relativamente alla sua natura, che agli effetti che produce,<br />
richiedendo azioni specifiche <strong>di</strong> assistenza tecnica al mondo agricolo.<br />
Favorire e sostenere l’agricoltura sostenibile al fine <strong>di</strong>:<br />
• incrementare il contenuto <strong>di</strong> sostanza organica nei suoli;<br />
• razionalizzare l’impiego delle risorse naturali con particolare<br />
riferimento all’acqua ed al suolo;<br />
• ridurre gli input chimici ed energetici;<br />
• garantire l’equilibrio del suolo e le sue qualità biologiche,<br />
nutritive e funzionali;<br />
• salvaguardare la bio<strong>di</strong>versità attraverso la conservazione dei<br />
micro-ecosistemi e degli agrosistemi.<br />
Promozione e supporto delle BMP’s (Best Management Practices) in<br />
agricoltura attraverso:<br />
• la razionalizzazione dei piani <strong>di</strong> fertilizzazione, irrigazione e<br />
<strong>di</strong>fesa fitosanitaria;<br />
• il contenimento e l’ottimizzazione delle lavorazioni del terreno;<br />
• l’adozione ed il controllo delle norme <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zionalità<br />
ambientale, specie per quel che riguarda l’uso del compost <strong>di</strong><br />
qualità provenienti da residui vegetali (ammendanti “ver<strong>di</strong>”);<br />
• il sostegno <strong>di</strong> sistemi <strong>di</strong> informazione ed assistenza rivolti agli<br />
operatori agricoli, moderni ed efficienti;<br />
183
• l’incentivazione <strong>di</strong> produzioni guidate, integrate e biologiche.<br />
Descrizione dei<br />
risultati attesi<br />
Riduzione degli in<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> desertificazione e degradazione del suolo ed<br />
aumento della sostanza organica nei suoli.<br />
Innalzamento dell’in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> bio<strong>di</strong>versità del suolo, con particolare<br />
attenzione a micro-flora e micro-fauna terricole.<br />
Complessivo miglioramento della qualità del suolo e delle acque<br />
sotterrane e superficiali.<br />
In<strong>di</strong>catori target<br />
Interessi economici<br />
coinvolti<br />
Soggetti competenti<br />
e modalità attuative<br />
Priorità dell’azione<br />
Incremento del tenore della sostanza organica dei suoli.<br />
Riduzione degli input chimici (fertilizzanti, fitofarmaci, erbici<strong>di</strong>,<br />
fitoregolatori, ecc.) in agricoltura.<br />
Riduzione degli input energetici (carburanti per auto-trazione, lubrificanti,<br />
ecc.) in agricoltura.<br />
Aumento del consumo <strong>di</strong> compost <strong>di</strong> qualità provenienti da residui vegetali<br />
(ammendanti “ver<strong>di</strong>”).<br />
Operatori agricoli (produttori e tecnici) locali ed indotto della filiera<br />
agroalimentare.<br />
Privati. Associazioni <strong>di</strong> categoria. Consorzio provinciale <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa<br />
(CO.DI.TA.). ASSO.CO.DI.PU<br />
ELEVATA<br />
Tempi<br />
e stima dei costi<br />
Riferimenti<br />
programmatici e linee<br />
<strong>di</strong> finanziamento<br />
Riferimenti tecnici e<br />
criteri progettuali<br />
Tempi e costi generici da stimare per singoli interventi.<br />
Programma Operativo FESR Puglia 2007-2013.<br />
Programma <strong>di</strong> Sviluppo Rurale Puglia 2007-2013<br />
Necessaria preventiva Valutazione <strong>di</strong> Incidenza.<br />
184
Scheda azione<br />
sito SIC e ZPS "Area delle Gravine IT9130007”<br />
IA23<br />
PMR<br />
Titolo dell’azione<br />
Installazione <strong>di</strong> “sensori ambientali” su<br />
stazioni esistenti<br />
Generale <br />
Localizzata <br />
Tipo azione<br />
intervento attivo (IA)<br />
regolamentazione (RE)<br />
incentivazione (IN)<br />
programma <strong>di</strong> monitoraggio e/o ricerca (PMR)<br />
programma <strong>di</strong>dattico (PD)<br />
Eventuale stralcio<br />
cartografico<br />
(vale per le azioni<br />
localizzate)<br />
I simboli si riferiscono a <strong>di</strong>fferente dotazione sensoristica.<br />
Descrizione dello stato<br />
attuale e<br />
contestualizzazione<br />
dell’azione nel PdG<br />
(=relazione con<br />
l’obiettivo <strong>generale</strong> <strong>di</strong><br />
PdG)<br />
Finalità dell’azione<br />
(obiettivo specifico)<br />
Il monitoraggio della qualità dell’area all’interno dell’ “Area delle Gravine”<br />
assume particolare rilevanza a causa della presenza <strong>di</strong> inse<strong>di</strong>amenti<br />
industriali <strong>di</strong> notevoli <strong>di</strong>mensioni, che potrebbero eventualmente produrre<br />
effetti sugli habitat. In aggiunta la <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> n.8 stazioni già installate<br />
(Castellaneta, Mottola, Ginosa, Palagianello, Massafra, Martina Franca,<br />
<strong>Taranto</strong> e Grottaglie) gestite in telemisura dall’Associazione Regionale dei<br />
Consorzi <strong>di</strong> Difesa <strong>di</strong> proprietà della Regione Puglia, consente <strong>di</strong> poterle<br />
implementare con costi esigui ottenendo parametri utili (Anidride solforosa,<br />
Ossido <strong>di</strong> azoto, Biossido <strong>di</strong> azoto, Ozono, etc.) per la comprensione <strong>di</strong><br />
eventuali inquinamenti e dei conseguenti effetti ambientali sugli habitat e<br />
sulle specie.<br />
L’acquisizione in continuo dei dati ambientali e chimico-fisici risulta<br />
particolarmente utile per il perseguimento delle seguenti finalità:<br />
• conoscere, in tempo reale, evoluzioni e cambiamenti riguardanti gli<br />
elementi significativi del territorio, acquisiti dai sensori esistenti<br />
(temperatura aria, temperatura suolo, umi<strong>di</strong>tà relativa, ra<strong>di</strong>azione solare,<br />
precipitazione, pressione atmosferica, velocità vento, <strong>di</strong>rezione vento,<br />
eliofania, bagnatura fogliare, umi<strong>di</strong>tà del suolo) e da quelli da installare;<br />
• controllare in continuo il manifestarsi e l’evoluzione <strong>di</strong> eventi calamitosi<br />
(alluvioni, incen<strong>di</strong>, etc.) ed incidenti ambientali (smaltimenti, scarichi<br />
abusivi, etc.);<br />
• valutare e programmare in anticipo gli interventi per la protezione e<br />
salvaguar<strong>di</strong>a dell’ambiente (early warning);<br />
• conoscere il reale quadro <strong>di</strong> riferimento per la definizione degli interventi<br />
per la conservazione e la tutela delle aree protette;<br />
• verificare in continuo l’impatto delle attività produttive derivanti dalle<br />
aree a<strong>di</strong>acenti, al fine <strong>di</strong> tutelare e salvaguardare la bio<strong>di</strong>versità.<br />
185
Descrizione dell’azione<br />
(metodologia) e<br />
programma operativo<br />
L’azione si realizza attraverso l’installazione <strong>di</strong> sensori “ambientali” in<br />
stazioni <strong>di</strong> monitoraggio (agrometeorologico) in telemisura<br />
attualmente esistenti, per l’acquisizione <strong>di</strong> utilissime informazioni in<br />
grado <strong>di</strong> rappresentare lo stato <strong>di</strong> salute ambientale delle aree protette<br />
e <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare correttamente le modalità e le tipologie degli<br />
interventi. Occorre riba<strong>di</strong>re che la rete <strong>di</strong> monitoraggio<br />
agrometeorologico è particolarmente utile per la riduzione degli input<br />
chimici <strong>di</strong> origine agricola e per la razionalizzazione degli utilizzi<br />
irrigui.<br />
Descrizione dei<br />
risultati attesi<br />
Monitoraggio dello stato <strong>di</strong> salute delle aree protette e delle<br />
componenti ambientali.<br />
Prevenzione e rapido intervento in funzione dei rischi legati alle<br />
pressioni antropiche derivanti da attività agricole ed industriali delle<br />
aree circostanti.<br />
Riduzione degli input chimici (fertilizzanti, fitofarmaci, erbici<strong>di</strong>,<br />
fitoregolatori, ecc.) in agricoltura.<br />
In<strong>di</strong>catori target<br />
Sensori installati e relativi parametri monitorati.<br />
Interventi realizzati in funzione <strong>di</strong> alarm derivanti dall’azione <strong>di</strong><br />
monitoraggio.<br />
Interessi economici<br />
coinvolti<br />
Soggetti competenti<br />
e modalità attuative<br />
Priorità dell’azione<br />
Tutela delle produzioni locali e dei prodotti tipici.<br />
Associazione Regionale dei Consorzi <strong>di</strong> Difesa. Consorzio provinciale <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>fesa (CO.DI.TA.). ASSO.CO.DI.PU<br />
MEDIA<br />
Tempi<br />
e stima dei costi<br />
Riferimenti<br />
programmatici e linee<br />
<strong>di</strong> finanziamento<br />
Tempi e costi generici da stimare per singoli interventi.<br />
Programma Operativo FESR Puglia 2007-2013.<br />
Programma <strong>di</strong> Sviluppo Rurale Puglia 2007-2013<br />
Riferimenti tecnici e<br />
criteri progettuali<br />
186
Scheda azione<br />
sito SIC e ZPS "Area delle Gravine IT9130007<br />
IA24<br />
Titolo dell’azione Sistema <strong>di</strong> gestone ambientale ISO14001 –<br />
EMAS<br />
Generale <br />
Localizzata <br />
Tipo azione<br />
intervento attivo (IA)<br />
regolamentazione (RE)<br />
incentivazione (IN)<br />
programma <strong>di</strong> monitoraggio e/o ricerca (PMR)<br />
programma <strong>di</strong>dattico (PD)<br />
Eventuale stralcio<br />
cartografico<br />
(vale per le azioni<br />
localizzate)<br />
Descrizione dello stato<br />
attuale e<br />
contestualizzazione<br />
dell’azione nel PdG<br />
(=relazione con<br />
l’obiettivo <strong>generale</strong> <strong>di</strong><br />
PdG)<br />
L’analisi del territorio evidenzia una scarsa sensibilizzazione delle parti<br />
sociali, delle amministrazioni locali e degli operatori del mercato rispetto ai<br />
pericoli per l’ambiente ed alle necessità <strong>di</strong> tutela del patrimonio naturale; <strong>di</strong><br />
conseguenza, si riscontra – ad eccezione <strong>di</strong> singole realtà - una insufficiente<br />
capacità <strong>di</strong> utilizzo razionale delle risorse naturali e <strong>di</strong> gestione dei rischi<br />
ambientali finalizzata ad una riduzione degli impatti negativi sul territorio.<br />
L’implementazione <strong>di</strong> sistemi <strong>di</strong> gestione ambientale, la certificazione<br />
secondo la norma ISO 14001:04 e la registrazione EMAS si inseriscono<br />
nell’ambito <strong>di</strong> una pianificazione più <strong>generale</strong> che ha come obiettivo finale la<br />
tutela e la valorizzazione del territorio attraverso il miglioramento continuo<br />
delle prestazioni ambientali delle attività produttive, a beneficio dello<br />
sviluppo economico del territorio.<br />
Finalità dell’azione<br />
(obiettivo specifico)<br />
Ottenere la certificazione ISO 14001 e/o la registrazione EMAS <strong>di</strong><br />
imprese/enti coinvolti per:<br />
- ridurre i costi <strong>di</strong> gestione;<br />
- migliorare l’efficienza ambientale ed innalzare all’esterno la propria<br />
immagine;<br />
- raggiungere obiettivi ambientali e socio-economici definiti nel breve,<br />
me<strong>di</strong>o e lungo periodo;<br />
- comunicare e veicolare le politiche ambientali nell’ambito <strong>di</strong> imprese,<br />
organizzazioni, amministrazioni locali e <strong>di</strong> tutti gli stakeholders per<br />
salvaguardare e valorizzare il territorio.<br />
Descrizione dell’azione<br />
(metodologia) e<br />
programma operativo<br />
La pre<strong>di</strong>sposizione del Sistema <strong>di</strong> Gestione Ambientale e la successiva<br />
registrazione EMAS prevedono le seguenti fasi:<br />
- Analisi Ambientale Iniziale (AAI);<br />
187
- in<strong>di</strong>viduazione degli Aspetti Ambientali Significativi (AAS);<br />
- definizione della Politica Ambientale contenente i macro obiettivi relativi<br />
alle criticità ambientali ed alle problematiche esistenti;<br />
- in<strong>di</strong>viduazione degli obiettivi e dei programmi <strong>di</strong> miglioramento con<br />
riferimento agli aspetti ambientali ed alle prescrizioni normative;<br />
- implementazione del SGA e redazione del Manuale e delle procedure;<br />
- realizzazione <strong>di</strong> un au<strong>di</strong>t ambientale interno;<br />
- realizzazione <strong>di</strong> un au<strong>di</strong>t ambientale esterno;<br />
- elaborazione della Dichiarazione ambientale;<br />
- convalida della <strong>di</strong>chiarazione ambientale ed iscrizione nel registro<br />
EMAS.<br />
Descrizione dei<br />
risultati attesi<br />
Le azioni sopra descritte danno luogo ad effetti positivi non solo all’interno<br />
dell’area SIC ma anche all’esterno.<br />
I risultati interni (o <strong>di</strong>retti) possono riassumersi in:<br />
- conformità legislativa e conseguente riduzione dei rischi <strong>di</strong> sanzioni<br />
amministrative e penali;<br />
- riduzione dei costi gestionali (risparmio <strong>di</strong> materie prime, energia, ecc.);<br />
- maggiore efficienza organizzativa interna;<br />
- contenimento degli impatti ambientali negativi generati dalle attività<br />
all’interno del sito SIC.<br />
I risultati esterni (o in<strong>di</strong>retti) possono riassumersi in:<br />
- acquisizione <strong>di</strong> un’immagine accettata e riconosciuta a livello nazionale<br />
ed internazionale;<br />
- aumento della visibilità del sito SIC anche in termini <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>bilità e <strong>di</strong><br />
valorizzazione del territorio;<br />
- estensione della certificazione ambientale ad altre organizzazioni presenti<br />
sul territorio;<br />
- garanzia per gli stakeholders <strong>di</strong> una gestione del sito SIC in grado <strong>di</strong><br />
operare con procedure rispettose dell'ambiente e delle norme cogenti, con<br />
la finalità <strong>di</strong> perseguire un miglioramento continuo;<br />
- maggiore qualificazione dei prodotti e dei servizi dell’area SIC.<br />
In<strong>di</strong>catori target<br />
Interessi economici<br />
coinvolti<br />
- Numero comuni coinvolti;<br />
- Numero comuni certificati;<br />
- Numero imprese coinvolte;<br />
- Numero imprese certificate.<br />
L’azione mira alla qualificazione del contesto locale, ad uno sviluppo<br />
economico, sociale e culturale, ed ad un incremento del fattore competitivo a<br />
livello nazionale ed internazionale. Pertanto, sono interessati gli operatori<br />
economici locali (impren<strong>di</strong>tori turistici, artigiani, operatori del mondo rurale,<br />
ecc.), le PMI e le pubbliche amministrazioni.<br />
Soggetti competenti<br />
e modalità attuative<br />
Priorità dell’azione<br />
Imprese, Regione, Enti locali, ARPA, Aziende, Consorzi.<br />
BASSA<br />
188
Tempi<br />
e stima dei costi<br />
Riferimenti<br />
programmatici e linee<br />
<strong>di</strong> finanziamento<br />
I tempi previsti per la realizzazione del SGA e della certificazione EMAS<br />
sono 3 anni:<br />
- 1° anno: Analisi Ambientale Iniziale;<br />
- 2° anno: pianificazione ed implementazione del SGA;<br />
- 3° anno: au<strong>di</strong>t ambientale e iscrizione al registro EMAS.<br />
PSR Regione Puglia 2007-2013 Asse I - Consolidamento e sviluppo della<br />
qualità della produzione agricola e forestale - Asse 4 “LEADER”<br />
- Programma Operativo FESR Puglia 2007-2013 ASSE VII - Linea <strong>di</strong><br />
intervento 7.2 Riqualificazione dell’ambiente nei centri urbani<br />
Riferimenti e allegati<br />
tecnici<br />
189
Scheda azione Tipologia sito (SIC/ZPS) sito SIC e ZPS "Area delle Gravine IT9130007”<br />
IN1 Titolo dell’azione Sostegno ed incentivazione dell’agricoltura<br />
biologica<br />
Generale <br />
Localizzata <br />
Tipologia azione<br />
intervento attivo (IA)<br />
regolamentazione (RE)<br />
incentivazione (IN)<br />
programma <strong>di</strong> monitoraggio e/o ricerca (MR)<br />
programma <strong>di</strong>dattico (PD)<br />
Descrizione dello stato<br />
attuale e<br />
contestualizzazione<br />
dell’azione nel PdG<br />
In virtù della gran varietà <strong>di</strong> coltivazioni, spesso inframmezzate tra loro, presenti<br />
nell’area delle Gravine, dal punto <strong>di</strong> vista della conservazione degli habitat <strong>di</strong><br />
specie, anche l’uso massiccio dei pestici<strong>di</strong> (insettici<strong>di</strong> e <strong>di</strong>sserbanti chimici) su<br />
colture altamente specializzate, quali vigneti o frutteti, può rappresentare un<br />
fattore limitante.<br />
Finalità dell’azione<br />
(obbiettivo specifico)<br />
Incentivazione dell’agricoltura biologica in quanto modalità che considera<br />
l’intera azienda come fulcro dell’agroecosistema, soggetto riequilibratore degli<br />
elementi <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa e nutritivi attraverso un apporto limitato <strong>di</strong> fitofarmaci e<br />
fertilizzanti.<br />
Descrizione dell’azione<br />
e programma<br />
operativo<br />
Descrizione dei<br />
risultati attesi<br />
Interessi economici<br />
coinvolti<br />
Soggetti competenti<br />
Priorità dell’azione<br />
Il favorire lo sviluppo <strong>di</strong> pratiche agronomiche sostenibili può<br />
rappresentare un importante momento <strong>di</strong> riqualificazione della filiera,<br />
creando nuove ed interessanti possibilità <strong>di</strong> commercializzazione del<br />
prodotto attraverso:<br />
• Attività <strong>di</strong> informazione e <strong>di</strong> orientamento alle aziende agricole;<br />
• Sostegno alle aziende che intraprendono tale conversione.<br />
Aumento delle superfici coltivate in regime biologico<br />
Comparto agricolo<br />
Regione Puglia, <strong>Provincia</strong> <strong>di</strong> <strong>Taranto</strong>/Ente Parco; Associazioni <strong>di</strong> categoria;<br />
Agronomi ed Agrotecnici, Periti Agrari.<br />
BASSA<br />
190
Tempi<br />
e stima dei costi<br />
Riferimenti<br />
programmatici e linee<br />
<strong>di</strong> finanziamento<br />
Riferimenti tecnici e<br />
criteri progettuali<br />
L’azione sosterrà i soggetti che realizzano attività per un impegno quinquennale,<br />
che prevede il rispetto delle tecniche <strong>di</strong> produzione biologica definite dal<br />
regolamento CEE 2092/91 e s.m.i. Si riporta <strong>di</strong> seguito l’entità del premio per<br />
tipologia colturale:<br />
Coltura<br />
Premio<br />
(euro/ha)<br />
1. Cereali 96<br />
2. Pomodoro 357<br />
3. Patata 247<br />
4. Orticole ed altre erbacee 259<br />
5. Olivo 335<br />
6. Vite da tavola 770<br />
7. Vite da vino 506<br />
8. Agrumi 812<br />
9. Ciliegio 456<br />
10. Altre drupacee 738<br />
PSR Puglia 2007-2013<br />
Misura 214 - Pagamenti agroambientali - Azione 1: Agricoltura biologica.<br />
PSR Puglia 2007-2013 ed Allegato 6 dello stesso;<br />
Regolamento CEE 2092/91 e s.m.i.<br />
191
Scheda azione Tipologia sito (SIC/ZPS) sito SIC e ZPS “Area delle Gravine IT9130007”<br />
IN2 Titolo dell’azione Tutela della bio<strong>di</strong>versità in agricoltura e<br />
creazione della figura del coltivatore custode<br />
Generale <br />
Localizzata <br />
Tipologia azione<br />
intervento attivo (IA)<br />
regolamentazione (RE)<br />
incentivazione (IN)<br />
programma <strong>di</strong> monitoraggio e/o ricerca (MR)<br />
programma <strong>di</strong>dattico (PD)<br />
Descrizione dello stato<br />
attuale e<br />
contestualizzazione<br />
dell’azione nel PdG<br />
Il più delle volte la scelta dei prodotti da coltivare da parte degli operatori agricoli<br />
è dettata dai gusti dei consumatori e dalle esigenze del mercato che spingono<br />
verso specie e varietà più produttive, standar<strong>di</strong>zzate e omogenee e proprio per<br />
questo a stretta base genetica. Queste scelte, unite a meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> coltivazione<br />
intesivi, hanno contribuito a creare anche nell’area <strong>di</strong> interesse un’emergenza<br />
ambientale su questo tema.<br />
Finalità dell’azione<br />
(obbiettivo specifico)<br />
Descrizione dell’azione<br />
e programma<br />
operativo<br />
Descrizione dei<br />
risultati attesi<br />
Interessi economici<br />
coinvolti<br />
Soggetti competenti<br />
Priorità dell’azione<br />
Tempi<br />
L’azione è finalizzata ai seguenti obiettivi:<br />
a) conservazione della <strong>di</strong>versità genetica attraverso il mantenimento<br />
e/o recupero <strong>di</strong> specie/varietà a rischio <strong>di</strong> estinzione;<br />
b) tutela degli elementi caratteristici del paesaggio rurale.<br />
Il mantenimento e/o il recupero <strong>di</strong> specie/varietà a rischio <strong>di</strong> estinzione può<br />
creare nuovi ed interessanti sbocchi sul mercato <strong>di</strong> prodotti <strong>di</strong> nicchia con<br />
apposito marchio, attraverso:<br />
• Attività <strong>di</strong> informazione e <strong>di</strong> orientamento dei coltivatori custo<strong>di</strong>;<br />
• Sostegno alle aziende che intraprendono tale iniziativa.<br />
Aumento delle specie/varietà coltivate<br />
Comparto agricolo<br />
Regione Puglia, <strong>Provincia</strong> <strong>di</strong> <strong>Taranto</strong>/Ente Parco; Associazioni <strong>di</strong> categoria;<br />
Agronomi, Agrotecnici, Periti Agrari.<br />
BASSA<br />
L’azione sosterrà, con un aiuto quinquennale le aziende i cui conduttori si<br />
192
e stima dei costi<br />
Riferimenti<br />
programmatici e linee<br />
<strong>di</strong> finanziamento<br />
impegnano a conservare in situ, le risorse genetiche vegetali (colture) in<strong>di</strong>cate<br />
nella tabella in allegato alla presente scheda e che per questo sono qualificati<br />
come coltivatori custo<strong>di</strong>. Si riporta <strong>di</strong> seguito l’entità del premio per tipologia<br />
colturale.<br />
Coltura<br />
Premio<br />
(euro/ha)<br />
1. Colture da granella 86<br />
2. Orticole 186<br />
3. Olivo 175<br />
4. Vite 397<br />
5. Fruttiferi 417<br />
PSR Puglia 2007-2013<br />
Misura 214 - Pagamenti agroambientali - Azione 3: Tutela della bio<strong>di</strong>versità<br />
Riferimenti tecnici e<br />
criteri progettuali<br />
Elenco delle risorse genetiche autoctone provinciali:<br />
OLIVO<br />
(varietà da olio)<br />
1. Donna Francesca<br />
2. Oliva rossa<br />
3. Gniastra o inchiostra<br />
4. Leucocarpa<br />
5. Limona<br />
(varietà da mensa)<br />
1. San Benedetto<br />
2. Santa Caterina<br />
VITE<br />
(varietà da vino)<br />
1. Aleatico n.<br />
2. Fiano della Valle d’Itria o minatolo<br />
3. Marchione<br />
4. Mareggio<br />
5. Santa Teresa<br />
6. Uva attina<br />
7. Uva carrieri<br />
8. Uva della scala<br />
9. Cuccimaniello<br />
10. San Nicola<br />
FRUTTIFERI<br />
Albicocca Picocca<br />
Pero:<br />
1. A campanello<br />
2. Cilar<strong>di</strong><br />
3. Verde<br />
4. Rosso<br />
5. Tacca n’zuso<br />
Melo:<br />
193
Mela ghiacciata<br />
Susine:<br />
1. Passo <strong>di</strong> Spagna<br />
2. San Francesco<br />
Fico:<br />
1. Verdesca<br />
2. Ricotta<br />
3. Ritonna<br />
4. Mattepinto<br />
5. Folm<br />
6. Vito Carlo<br />
7. Natalegna<br />
8. Trimone<br />
9. Zingarello (nero, bianco)<br />
10. Verde <strong>di</strong> natale<br />
11. Fiorone nero <strong>di</strong> Sava<br />
Arancio:<br />
1. Portoghese<br />
2. Maltese<br />
3. Vaniglia<br />
Carciofo bianco<br />
Pomodoro Mandurese<br />
Cicerchia<br />
194
Scheda azione Tipologia sito (SIC/ZPS) sito SIC e ZPS "Area delle Gravine IT9130007”<br />
IN3 Titolo dell’azione Sostegno agli investimenti non produttivi:<br />
ripristino dei muretti a secco.<br />
Generale <br />
Localizzata <br />
Tipologia azione<br />
intervento attivo (IA)<br />
regolamentazione (RE)<br />
incentivazione (IN)<br />
programma <strong>di</strong> monitoraggio e/o ricerca (MR)<br />
programma <strong>di</strong>dattico (PD)<br />
Descrizione dello stato<br />
attuale e<br />
contestualizzazione<br />
dell’azione nel PdG<br />
L’importanza dei muretti a secco dal punto <strong>di</strong> vista della conservazione della<br />
natura è un dato ormai da tempo acquisito. Tralasciando il pur notevole aspetto<br />
paesaggistico <strong>di</strong> tali opere, è stata verificata la loro importanza sotto l’aspetto<br />
idrogeologico, nel mantenimento delle connessioni biotiche, nell’aumento della<br />
bio<strong>di</strong>versità.<br />
I muretti a secco, nel contesto del territorio pugliese, sono assimilabili a microhabitat<br />
con struttura a rete lineare estremamente funzionale alla conservazione sia<br />
delle cenosi faunistiche che <strong>di</strong> quelle floristiche, nel contesto degli ecosistemi<br />
agrari. In particolare, i muretti a secco e la vegetazione associata rappresentano<br />
aree <strong>di</strong> rifugio per Invertebrati, Rettili, Anfibi, Micromammiferi, anche<br />
d’interesse comunitario. Ovviamente i muretti più vecchi presentano una<br />
maggiore e consolidata colonizzazione da parte degli elementi naturali.<br />
Finalità dell’azione<br />
(obbiettivo specifico)<br />
Descrizione dell’azione<br />
e programma<br />
operativo<br />
Descrizione dei<br />
risultati attesi<br />
Interessi economici<br />
coinvolti<br />
L’obiettivo specifico dell’azione è quello <strong>di</strong> tutelare la bio<strong>di</strong>versità attraverso la<br />
conservazione e la <strong>di</strong>ffusione delle sistemazioni agro-forestali ad alto valore<br />
naturale, quali i muretti a secco.<br />
Da questo <strong>di</strong>scende il seguente obiettivo operativo: sostenere le spese legate ad<br />
investimenti <strong>di</strong> rifacimento dei muretti a secco che non portino ad alcun rilevante<br />
aumento nel valore o nella red<strong>di</strong>tività dell’azienda agricola o zootecnica<br />
Investimenti aziendali a beneficio delle aziende agricole che ripristinano muretti a<br />
secco con modalità <strong>di</strong> esecuzione e gestione conformi e coerenti con le relative<br />
<strong>di</strong>sposizioni contenute nel Regolamento del Piano <strong>di</strong> gestione del SIC-ZPS “Area<br />
delle gravine”.<br />
Aumento <strong>di</strong> superfici atte ad accogliere micro-habitat<br />
Impren<strong>di</strong>tori agricoli (singoli e associati) iscritti nel registro delle imprese<br />
agricole della CCIAA.<br />
195
Soggetti competenti<br />
Priorità dell’azione<br />
Tempi<br />
e stima dei costi<br />
Riferimenti<br />
programmatici e linee<br />
<strong>di</strong> finanziamento<br />
Regione Puglia, <strong>Provincia</strong> <strong>di</strong> <strong>Taranto</strong>/Ente Parco; Associazioni <strong>di</strong> categoria;<br />
Agronomi e Agrotecnici, Periti Agrari.<br />
ELEVATA<br />
Tempi e costi strettamente <strong>di</strong>pendenti dal numero <strong>di</strong> aziende che aderiranno alla<br />
presente misura.<br />
PSR Puglia 2007-2013<br />
Asse II, Misura 216 – Sostegno agli investimenti non produttivi - Azione 1:<br />
Ripristino muretti a secco<br />
Riferimenti tecnici e<br />
criteri progettuali<br />
PSR Puglia 2007-2013<br />
Art. 19 c. 2a del Regolamento del PdG: “i nuovi muretti a secco vanno costruiti<br />
nel rispetto della tipologia architettonica tra<strong>di</strong>zionale e del contesto<br />
paesaggistico, utilizzando pietre calcaree locali montate e incrociate a secco<br />
senza malta cementizia e/o altri leganti. Deve inoltre essere lasciata una fascia <strong>di</strong><br />
rispetto lungo il muretto pari a circa 50 centimetri per le colture erbacee e 2,5<br />
metri per le colture arboree. E’ consentito collocare sui muretti a secco reti<br />
zincate o plastificate solo per motivate esigenze <strong>di</strong> sicurezza. In tal caso la rete<br />
deve essere posta ad almeno 20 centimetri dalla sommità del muretto, per<br />
consentire il passaggio ai mammiferi selvatici. La manutenzione e/o il restauro<br />
dei muretti a secco esistenti deve avvenire secondo le tecniche costruttive sopra<br />
in<strong>di</strong>cate, senza smantellare totalmente il manufatto, ma soltanto attraverso il<br />
ripristino delle parti in cattivo stato <strong>di</strong> conservazione”<br />
196
Scheda azione Tipologia sito (SIC/ZPS) sito SIC e ZPS "Area delle Gravine IT9130007”<br />
IN4 Titolo dell’azione Sostegno alla conservazione delle pratiche<br />
agricole estensive tra<strong>di</strong>zionali: prati-pascoli e<br />
foraggiere<br />
Generale <br />
Localizzata <br />
Tipologia azione<br />
intervento attivo (IA)<br />
regolamentazione (RE)<br />
incentivazione (IN)<br />
programma <strong>di</strong> monitoraggio e/o ricerca (MR)<br />
programma <strong>di</strong>dattico (PD)<br />
Descrizione dello stato<br />
attuale e<br />
contestualizzazione<br />
dell’azione nel PdG<br />
L’attuale crisi attraversata dal settore zootecnico, unita alle svantaggiate<br />
con<strong>di</strong>zioni pedologiche <strong>di</strong> molte superfici occupate da pascoli e seminativi <strong>di</strong><br />
foraggiere, incidendo negativamente sulla produttività e sul red<strong>di</strong>to delle aziende<br />
agricole, fanno sì che nei Comuni del SIC-ZPS vi siano numerose zone<br />
minacciate <strong>di</strong> abbandono e marginalizzazione.<br />
Finalità dell’azione<br />
(obbiettivo specifico)<br />
Descrizione dell’azione<br />
e programma<br />
operativo<br />
Descrizione dei<br />
risultati attesi<br />
Interessi economici<br />
coinvolti<br />
Soggetti competenti<br />
Priorità dell’azione<br />
Per i motivi <strong>di</strong> cui sopra, la presente azione, correlata alle indennità compensative<br />
degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle aree svantaggiate, <strong>di</strong>verse<br />
da quelle montane, previste dalla Misura 212 del PSR 2007-2013, ha lo scopo <strong>di</strong><br />
promuovere la permanenza <strong>di</strong> attività agricole funzionali alla conservazione degli<br />
habitat e degli habitat <strong>di</strong> specie dell’Area, tutelando al contempo gli elementi<br />
caratteristici del paesaggio rurale.<br />
Sarà concessa un’indennità compensativa tesa a bilanciare i costi e le<br />
per<strong>di</strong>te <strong>di</strong> red<strong>di</strong>to dovute agli svantaggi naturali con<strong>di</strong>zionanti l’attività<br />
agricola per una superficie minima <strong>di</strong> 5 ha in aree classificate svantaggiate<br />
investite a prati e pascoli e a colture foraggiere, già in<strong>di</strong>viduate dalle Dirr.<br />
CEE 268/75, 273/75, 167/84 e coincidenti con le aree già finanziate con il<br />
Reg. CEE 1257/99.<br />
Mantenimento delle superfici occupate dai pascoli (habitat <strong>di</strong> pseudosteppa).<br />
Impren<strong>di</strong>tori agricoli (singoli e associati) iscritti nel registro delle imprese<br />
agricole della CCIAA.<br />
Regione Puglia, <strong>Provincia</strong> <strong>di</strong> <strong>Taranto</strong>/Ente Parco; Associazioni <strong>di</strong> categoria;<br />
Agronomi ed Agrotecnici, Periti Agrari.<br />
BASSA<br />
197
Tempi<br />
e stima dei costi<br />
Riferimenti<br />
programmatici e linee<br />
<strong>di</strong> finanziamento<br />
I beneficiari dovranno impegnarsi a proseguire l’attività agricola per almeno 5<br />
anni dal pagamento della prima indennità<br />
Si riporta <strong>di</strong> seguito l’entità dell’indennità per tipologia colturale.<br />
Superfici a prati e pascoli nelle aree svantaggiate:<br />
45 euro/ha<br />
- Superfici a foraggere: 100 euro/ha<br />
PSR Puglia 2007-2013<br />
Misura 212 – Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli<br />
agricoltori delle aree svantaggiate, <strong>di</strong>verse dalle zone montane.<br />
Riferimenti tecnici e<br />
criteri progettuali<br />
• Superficie minima: 5 ha in aree classificate svantaggiate investite a prati e<br />
pascoli e a colture foraggere;<br />
• Si escludono dal premio le superfici a “fida pascoli” in quanto terreni<br />
pubblici soggetti a specifiche autorizzazione della Regione Puglia - Settore<br />
Foreste - o <strong>di</strong> Amministrazioni comunali ai sensi delle prescrizioni <strong>di</strong><br />
massima e polizia forestale vigenti nei territori provinciali;<br />
• Carico <strong>di</strong> bestiame per unità <strong>di</strong> superficie condotta, compreso tra 0,2 e 1,4<br />
UBA/ha; nel calcolo del rispetto <strong>di</strong> tale rapporto potrà essere presa in<br />
considerazione per il solo calcolo degli UBA anche la superficie a “fida<br />
pascoli”;<br />
• Impegno a proseguire l’attività agricola per almeno i cinque anni successivi<br />
al pagamento della prima indennità;<br />
• I beneficiari della misura devono risultare adempienti alla normativa<br />
Comunitaria e nazionale obbligatoria vigente in materia <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zionalità, con<br />
particolare riferimento agli articoli 4 e 5 degli allegati III e IV del<br />
Regolamento CE 1782 e al Decreto Ministeriale del 18 ottobre 2007,<br />
pubblicato nella GU n. 253 del 30 ottobre 2007, per tutte le superfici oggetto<br />
<strong>di</strong> indennità.<br />
198
Scheda azione Tipologia sito (SIC/ZPS) CODICE E NOME SITO”<br />
sito SIC e ZPS "Area delle Gravine IT9130007”<br />
PMR1 Titolo dell’azione Mappaggio degli e<strong>di</strong>fici interessati dalla<br />
ni<strong>di</strong>ficazione del Grillaio in ogni colonia urbana<br />
Generale Localizzata <br />
Tipologia azione<br />
intervento attivo (IA)<br />
regolamentazione (RE)<br />
incentivazione (IN)<br />
programma <strong>di</strong> monitoraggio e/o ricerca (MR)<br />
programma <strong>di</strong>dattico (PD)<br />
Eventuale stralcio<br />
cartografico (vale per<br />
le azioni localizzate)<br />
Descrizione dello stato<br />
attuale e<br />
contestualizzazione<br />
dell’azione nel PdG<br />
In<strong>di</strong>catori <strong>di</strong> stato<br />
Finalità dell’azione<br />
Il Grillaio occupa l’intero comprensorio territoriale rappresentato dalle gravine<br />
dell’arco ionico, ni<strong>di</strong>ficando in quasi tutti i centri storici dei comuni presenti<br />
all’interno del perimetro della ZPS o nelle sue imme<strong>di</strong>ate vicinanze.<br />
La colonia <strong>di</strong> maggiori <strong>di</strong>mensioni è risultata quella <strong>di</strong> Ginosa con una stima nel<br />
2007 <strong>di</strong> 222 – 250 coppie ni<strong>di</strong>ficanti. Il centro storico <strong>di</strong> Laterza ospita la seconda<br />
colonia per <strong>di</strong>mensione con una popolazione nel 2007 <strong>di</strong> 38 – 56 coppie.<br />
Le indagini hanno rilevato la presenza <strong>di</strong> coppie ni<strong>di</strong>ficanti nel centro storico del<br />
Comune <strong>di</strong> Castellaneta, e la presenza <strong>di</strong> in<strong>di</strong>vidui nei comuni <strong>di</strong> Palagianello,<br />
Mottola e Massafra.<br />
Numero <strong>di</strong> coppie ni<strong>di</strong>ficanti (I1); Numero <strong>di</strong> colonie riproduttive (I2);<br />
Conciliare le operazioni <strong>di</strong> restauro dei centri storici con l’attività riproduttiva del<br />
Grillaio. L’azione produrrà elementi utili alla corretta applicazione del<br />
Regolamento Regionale n. 24/2005.<br />
199
Descrizione dell’azione<br />
e programma<br />
operativo<br />
Verifica dello<br />
stato <strong>di</strong> attuazione/<br />
avanzamento<br />
dell’azione<br />
Descrizione dei<br />
risultati attesi<br />
Interessi economici<br />
coinvolti<br />
Soggetti competenti<br />
Priorità dell’azione<br />
Tempi<br />
e stima dei costi<br />
Riferimenti<br />
programmatici e linee<br />
<strong>di</strong> finanziamento<br />
Il programma dell'azione prevede:<br />
a) Mappaggio dei fabbricati interessati dalla ni<strong>di</strong>ficazione del Grillaio;<br />
b) Realizzazione <strong>di</strong> un sistema informatizzato <strong>di</strong> consultazione a <strong>di</strong>sposizione<br />
delle amministrazioni comunali e della citta<strong>di</strong>nanza.<br />
Realizzazione della mappa delle colonie e dei fabbricati occupati da siti <strong>di</strong><br />
riproduzione.<br />
Produrre elaborati grafici, che aumentino le conoscenze sull'utilizzo delle<br />
aree urbane da parte della specie, identificando le zone a maggior<br />
frequentazione in modo da poter ridurre e/o eliminare l'impatto determinato<br />
da interventi <strong>di</strong> restauro non compatibili con la conservazione dei siti<br />
riproduttivi.<br />
Pubblica amministrazione e privati<br />
Regione Puglia, <strong>Provincia</strong> <strong>di</strong> <strong>Taranto</strong>, Comuni, Università, Associazioni<br />
ambientaliste.<br />
MEDIA<br />
Durata 2 anni. Costo complessivo 20.000,00 €.<br />
LIFE+ 2007-2013<br />
Programmazione POR 2007-2013<br />
Riferimenti tecnici e<br />
criteri progettuali<br />
200
Scheda azione Tipologia sito (SIC/ZPS) CODICE E NOME SITO”<br />
sito SIC e ZPS "Area delle Gravine IT9130007”<br />
PMR2 Titolo dell’azione Monitoraggio e stu<strong>di</strong>o delle popolazioni<br />
ni<strong>di</strong>ficanti <strong>di</strong> rapaci <strong>di</strong>urni e notturni<br />
Generale Localizzata <br />
Tipologia azione<br />
intervento attivo (IA)<br />
regolamentazione (RE)<br />
incentivazione (IN)<br />
programma <strong>di</strong> monitoraggio e/o ricerca (PMR)<br />
programma <strong>di</strong>dattico (PD)<br />
Eventuale stralcio<br />
cartografico (vale per<br />
le azioni localizzate)<br />
Descrizione dello stato<br />
attuale e<br />
contestualizzazione<br />
dell’azione nel PdG<br />
In<strong>di</strong>catori <strong>di</strong> stato<br />
Finalità dell’azione<br />
Descrizione dell’azione<br />
e programma<br />
operativo<br />
Verifica dello<br />
stato <strong>di</strong> attuazione/<br />
avanzamento<br />
dell’azione<br />
Descrizione dei<br />
risultati attesi<br />
La conoscenza delle <strong>di</strong>namiche <strong>di</strong> popolazione delle specie in questione risulta<br />
in<strong>di</strong>spensabile per una corretta gestione faunistica della ZPS. Inoltre, il<br />
monitoraggio perio<strong>di</strong>co delle popolazioni <strong>di</strong> rapaci consente <strong>di</strong> verificare gli<br />
effetti delle azioni <strong>di</strong> conservazione in<strong>di</strong>viduate nel Piano <strong>di</strong> Gestione.<br />
N. coppie ni<strong>di</strong>ficanti (I1), n. <strong>di</strong> siti occupati da almeno 1 ind. (I3), n. giovani<br />
involati (I4), n. me<strong>di</strong>o <strong>di</strong> ind./km (I6)<br />
Definizione della <strong>di</strong>stribuzione reale, della consistenza numerica e della <strong>di</strong>namica<br />
<strong>di</strong> popolazione.<br />
Si propongono i censimenti per le seguenti specie:<br />
Capovaccaio, Grillaio, Nibbio reale, Nibbio bruno, Lanario e Biancone.<br />
Sulla base dei dati raccolti verranno svolte indagini mirate alla verifica dei<br />
parametri <strong>di</strong> biologia riproduttiva. Da questa fase del monitoraggio si cercherà <strong>di</strong><br />
ricavare informazioni sull'inse<strong>di</strong>amento e formazione della coppia, sulla<br />
costruzione del nido, sulla deposizione, sull'allevamento e sull'esito della<br />
riproduzione (in termini sopratutto <strong>di</strong> giovani involati). I dati raccolti su apposite<br />
schede verranno successivamente archiviati e analizzati con il fine <strong>di</strong> ricavare<br />
informazioni utili alla conservazione.<br />
Produzione <strong>di</strong> report tecnici<br />
Conoscenza aggiornata dello stato <strong>di</strong> conservazione.<br />
201
Interessi economici<br />
coinvolti<br />
Soggetti competenti<br />
Priorità dell’azione<br />
Tempi<br />
e stima dei costi<br />
Enti territoriali, Università, Centri <strong>di</strong> Ricerca.<br />
Regione Puglia, <strong>Provincia</strong> <strong>di</strong> <strong>Taranto</strong>, Università, ONG ambientaliste.<br />
MEDIA<br />
Durata minima 20 anni. Costo complessivo per collaborazioni professionali <strong>di</strong><br />
400.000,00 €.<br />
Riferimenti<br />
programmatici e linee<br />
<strong>di</strong> finanziamento<br />
Riferimenti tecnici e<br />
criteri progettuali<br />
LIFE+ 2007-2013<br />
Programmazione POR 2007-2013<br />
Protocolli <strong>di</strong> monitoraggio<br />
Capovaccaio<br />
Protocollo <strong>di</strong> ricerca<br />
Censimento ni<strong>di</strong>ficanti<br />
Verifica <strong>di</strong> tutti i siti in cui la specie ha ni<strong>di</strong>ficato negli ultimi anni e nei siti<br />
potenziali o <strong>di</strong> presenza storica.<br />
La coppia, appena inse<strong>di</strong>ata, effettua delle spettacolari parate nuziali dalla<br />
seconda metà <strong>di</strong> marzo in poi. In tale periodo è possibile definire se le coppie<br />
note, per i siti storici, hanno rioccupato il sito e se si sono aggiunte nuove coppie<br />
e/o nuovi siti. Successivamente sarà necessario verificare l'avvenuta ni<strong>di</strong>ficazione<br />
attraverso l'osservazione del comportamento della coppia nei pressi del sito<br />
presunto (comportamento <strong>di</strong> cova, ecc.)<br />
Periodo: dai primi <strong>di</strong> marzo a fine aprile si deve concentrare l'attività <strong>di</strong> ricerca su<br />
tutta l'area indagata, in particolare per verificare la presenza <strong>di</strong> nuove coppie<br />
territoriali.<br />
Stu<strong>di</strong>o della biologia riproduttiva<br />
I dati dovranno essere raccolti in <strong>di</strong>verse ore della giornata coprendo in me<strong>di</strong>a<br />
l'intero arco delle ore <strong>di</strong>urne. I dati raccolti saranno inseriti in apposite schede in<br />
cui verranno registrati i dati relativi alle con<strong>di</strong>zioni atmosferiche, alla durata delle<br />
osservazioni, i comportamenti osservati, l'ora in cui sono stati osservati e la loro<br />
durata.<br />
I punti <strong>di</strong> osservazione saranno scelti in modo da evitare ogni <strong>di</strong>sturbo agli<br />
uccelli, e in ogni caso, nella prima parte del periodo riproduttivo il numero delle<br />
visite sarà ridotto al minimo necessario.<br />
Tutte le osservazioni saranno effettuate utilizzando binocoli e, sopratutto, un<br />
cannocchiale con 20-60 ingran<strong>di</strong>menti.<br />
Periodo: dalla fine <strong>di</strong> aprile a settembre.<br />
202
Definizione coppie<br />
territoriali<br />
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic<br />
Raccolta dati sulla<br />
biologia<br />
riproduttiva<br />
Grillaio<br />
Protocollo <strong>di</strong> ricerca<br />
Censimento ni<strong>di</strong>ficanti<br />
Conteggi ai dormitori notturni utilizzati dalla specie nei perio<strong>di</strong> pre- e postriprodutivi<br />
nelle due colonie note attualmente (Ginosa e Laterza). Verifica della<br />
presenza della specie in altri centri urbani al fine <strong>di</strong> accertare eventuali espansioni<br />
dell'areale locale <strong>di</strong> riproduzione.<br />
Periodo: conteggio pre-riproduttivo nei primi 15 gg <strong>di</strong> maggio; conteggio postriproduttivo<br />
tra l'ultima settimana <strong>di</strong> luglio e la prima d'agosto.<br />
Conteggio preriproduttivo<br />
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic<br />
Conteggio postriproduttivo<br />
Nibbio reale<br />
Protocollo <strong>di</strong> ricerca<br />
Censimento ni<strong>di</strong>ficanti<br />
Verifica della presenza e consistenza della specie all'interno della ZPS e pSIC<br />
delle Gravine pugliesi. Vista la mancanza <strong>di</strong> dati circa la consistenza e la<br />
ni<strong>di</strong>ficazione della specie nell'area si ritiene opportuno effettuare nel primo anno<br />
<strong>di</strong> indagine dei percorsi campione (transetti) mensili al fine <strong>di</strong> valutare la<br />
<strong>di</strong>stribuzione, i perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> presenza e la consistenza della specie. A tale scopo<br />
saranno valutati anche gli in<strong>di</strong>vidui che presumibilmente frequenteranno il<br />
carnaio e le <strong>di</strong>scariche dei rifiuti presenti in zona, in particolare durante la fase <strong>di</strong><br />
ni<strong>di</strong>ficazione, periodo in cui gli adulti riproduttori effettuano spostamenti in cerca<br />
<strong>di</strong> cibo più brevi e sono maggiormente legati al territorio più prossimo al nido.<br />
203
Negli anni successivi saranno effettuati censimenti ad hoc, attraverso<br />
l'osservazione standar<strong>di</strong>zzata <strong>di</strong> <strong>di</strong>splay territoriali, parate nuziali e trasporto <strong>di</strong><br />
materiale al nido.<br />
Nella definizione della <strong>di</strong>mensione della popolazione ni<strong>di</strong>ficante tutti i siti in cui<br />
sarà osservato il solo <strong>di</strong>splay territoriale, senza successiva presenza <strong>di</strong> in<strong>di</strong>zi certi<br />
<strong>di</strong> ni<strong>di</strong>ficazione avvenuta, saranno considerati coppie ni<strong>di</strong>ficanti probabili, mentre<br />
per i siti in cui si avranno in<strong>di</strong>zi certi <strong>di</strong> ni<strong>di</strong>ficazione saranno considerati coppie<br />
ni<strong>di</strong>ficanti certe.<br />
Periodo: dall'ultima settimana <strong>di</strong> gennaio alla seconda <strong>di</strong> aprile si deve<br />
concentrare il massimo dello sforzo nell'osservazione dei <strong>di</strong>spaly territoriali,<br />
parate nuziali e trasporto <strong>di</strong> materiali al nido. Secondo gli scarsi dati presenti in<br />
letteratura per l'Italia meri<strong>di</strong>onale, la specie presenta già a febbraio una spiccata<br />
attività riproduttiva, per cui si rende necessario verificare già dal mese <strong>di</strong> gennaio<br />
l'eventuale presenza <strong>di</strong> comportamenti riproduttivi.<br />
Stu<strong>di</strong>o della biologia riproduttiva<br />
I dati raccolti serviranno a definire l'esito della riproduzione. Una volta definite le<br />
aree in cui sono stati osservati <strong>di</strong>splay territoriali si dovranno effettuare delle<br />
osservazioni mirate alla verifica della avvenuta ni<strong>di</strong>ficazione, attraverso<br />
l'osservazione <strong>di</strong> comportamenti quali trasporto <strong>di</strong> materiale per il nido, in<strong>di</strong>vidui<br />
in cova, presenza e numero <strong>di</strong> uova e/o pulli, ascolto delle vocalizzazzioni dei<br />
giovani (begging calls).<br />
I punti <strong>di</strong> osservazione saranno scelti in modo da evitare ogni <strong>di</strong>sturbo agli<br />
uccelli, e in ogni caso, nella prima parte del periodo riproduttivo il numero delle<br />
visite sarà ridotto al minimo necessario.<br />
Tutte le osservazioni saranno effettuate utilizzando binocoli e, sopratutto, un<br />
cannocchiale con 20-60 ingran<strong>di</strong>menti.<br />
Periodo: Da febbraio a fine luglio.<br />
Nibbio bruno<br />
Protocollo <strong>di</strong> ricerca<br />
Censimento ni<strong>di</strong>ficanti<br />
Per il censimento delle coppie ni<strong>di</strong>ficanti vedasi quanto scritto per il Nibbio reale.<br />
Periodo: definizione dei siti occupati da metà marzo a fine aprile.<br />
Stu<strong>di</strong>o della biologia riproduttiva<br />
Vedere quanto scritto per il Nibbio reale.<br />
Periodo: Da aprile a fine luglio.<br />
204
Definizione coppie<br />
territoriali del<br />
Nibbio reale<br />
Definizione coppie<br />
territoriali del<br />
Nibbio bruno<br />
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic<br />
Raccolta dati sulla<br />
biologia riproduttiva <strong>di</strong><br />
Nibbio reale e bruno<br />
Lanario Falco biarmicus<br />
Protocollo <strong>di</strong> ricerca<br />
Censimento ni<strong>di</strong>ficanti<br />
Verifica <strong>di</strong> tutti i siti in cui la specie ha ni<strong>di</strong>ficato negli ultimi anni, <strong>di</strong> presenza<br />
storica e dei siti potenziali. Il censimento sarà effettuato attraverso l'osservazione<br />
standar<strong>di</strong>zzata <strong>di</strong> <strong>di</strong>splay territoriali, parate nuziali e trasporto <strong>di</strong> materiale al nido.<br />
Per il primo anno <strong>di</strong> indagine ci si dovrebbe limitare alla sola verifica dei siti<br />
idonei e noti per la specie, in quanto effettua i <strong>di</strong>splay territoriali già a partire da<br />
<strong>di</strong>cembre e può ni<strong>di</strong>ficare già a partire dagli inizi <strong>di</strong> febbraio.<br />
Per le stagioni successive sara necessario effettuare dei censimenti delle coppie<br />
territoriali attraverso l'ossservazioni dei <strong>di</strong>splay territoriali e soprattutto delle<br />
spettacolari parate nuziali, che normalmente la coppia effettua al <strong>di</strong>sopra della<br />
parete <strong>di</strong> ni<strong>di</strong>ficazione. La verifica dell'avvenuta ni<strong>di</strong>ficazione si avrà attraverso<br />
l'osservazione <strong>di</strong> in<strong>di</strong>vidui in cova, trasporto <strong>di</strong> prede, osservazioni <strong>di</strong> uova o<br />
ni<strong>di</strong>acei, ecc.<br />
Nella definizione della <strong>di</strong>mensione della popolazione ni<strong>di</strong>ficante tutti i siti in cui<br />
sarà osservato il solo <strong>di</strong>splay territoriale, senza successiva presenza <strong>di</strong> in<strong>di</strong>zi certi<br />
<strong>di</strong> ni<strong>di</strong>ficazione avvenuta, saranno considerati coppie ni<strong>di</strong>ficanti probabili, mentre<br />
per i siti in cui si avranno in<strong>di</strong>zi certi <strong>di</strong> ni<strong>di</strong>ficazione saranno considerati coppie<br />
ni<strong>di</strong>ficanti certe.<br />
Periodo: Da metà <strong>di</strong>cembre a metà marzo.<br />
Stu<strong>di</strong>o della biologia riproduttiva<br />
Sulla base dei dati ricavati nella fase <strong>di</strong> censimento delle coppie territoriali si<br />
dovrà verificare l'avvenuta ni<strong>di</strong>ficazione, attraverso l'osservazione <strong>di</strong> in<strong>di</strong>vidui in<br />
cova, trasporto <strong>di</strong> prede, osservazioni <strong>di</strong> uova o ni<strong>di</strong>acei, ecc., e procedere alla<br />
raccolta dei dai relativi alla fenologia della riproduzione.<br />
Periodo: da metà febbraio a fine luglio.<br />
205
Definizione coppie<br />
territoriali<br />
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic<br />
Raccolta dati sulla<br />
biologia<br />
riproduttiva<br />
Biancone Circaetus gallicus<br />
Protocollo <strong>di</strong> ricerca<br />
Censimento ni<strong>di</strong>ficanti<br />
Si effettueranno censimenti ad hoc, attraverso l'osservazione standar<strong>di</strong>zzata <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>splay territoriali, parate nuziali e trasporto <strong>di</strong> materiale al nido. Verranno<br />
indagati le aree storiche <strong>di</strong> presenza della specie e gli habitat ritenuti idonei.<br />
Periodo: dagli inizi <strong>di</strong> marzo a fine aprile.<br />
Stu<strong>di</strong>o della biologia riproduttiva<br />
I dati raccolti serviranno a definire l'esito della riproduzione. Una volta definite le<br />
aree in cui sono stati osservati <strong>di</strong>splay territoriali si dovranno effettuare delle<br />
osservazioni mirate alla verifica della avvenuta ni<strong>di</strong>ficazione, attraverso<br />
l'osservazione <strong>di</strong> comportamenti quali trasporto <strong>di</strong> materiale per il nido, in<strong>di</strong>vidui<br />
in cova, presenza e numero <strong>di</strong> uova e/o pulli, ascolto delle vocalizzazzioni dei<br />
giovani (begging calls).<br />
I punti <strong>di</strong> osservazione saranno scelti in modo da evitare ogni <strong>di</strong>sturbo agli<br />
uccelli, e in ogni caso, nella prima parte del periodo riproduttivo il numero delle<br />
visite sarà ridotto al minimo necessario.<br />
Tutte le osservazioni saranno effettuate utilizzando binocoli e, sopratutto, un<br />
cannocchiale con 20-60 ingran<strong>di</strong>menti.<br />
Periodo: da aprile a fine agosto.<br />
Definizione coppie<br />
territoriali<br />
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic<br />
Raccolta dati sulla<br />
biologia<br />
riproduttiva<br />
206
Scheda azione Tipologia sito (SIC/ZPS) CODICE E NOME SITO”<br />
sito SIC e ZPS "Area delle Gravine IT9130007”<br />
PMR3 Titolo dell’azione Monitoraggio e stu<strong>di</strong>o delle specie <strong>di</strong> uccelli <strong>di</strong><br />
interesse comunitario legate alle aree steppiche<br />
Generale Localizzata <br />
Tipologia azione<br />
intervento attivo (IA)<br />
regolamentazione (RE)<br />
incentivazione (IN)<br />
programma <strong>di</strong> monitoraggio e/o ricerca (PMR)<br />
programma <strong>di</strong>dattico (PD)<br />
Eventuale stralcio<br />
cartografico (vale per<br />
le azioni localizzate)<br />
Descrizione dello stato<br />
attuale e<br />
contestualizzazione<br />
dell’azione nel PdG<br />
In<strong>di</strong>catori <strong>di</strong> stato<br />
Finalità dell’azione<br />
Descrizione dell’azione<br />
e programma<br />
operativo<br />
Verifica dello<br />
stato <strong>di</strong> attuazione/<br />
avanzamento<br />
dell’azione<br />
Descrizione dei<br />
risultati attesi<br />
La conoscenza delle <strong>di</strong>namiche <strong>di</strong> popolazione delle specie in questione risulta<br />
in<strong>di</strong>spensabile per una coretta gestione faunistica della ZPS. Inoltre, il<br />
monitoraggio perio<strong>di</strong>co delle popolazioni <strong>di</strong> rapaci consente <strong>di</strong> verificare gli<br />
effetti delle azioni <strong>di</strong> conservazione in<strong>di</strong>viduate nel Piano <strong>di</strong> Gestione.<br />
N. coppie ni<strong>di</strong>ficanti (I1); densità me<strong>di</strong>a per area campione (I8).<br />
Le informazioni raccolte permetteranno <strong>di</strong> trarre in<strong>di</strong>cazioni sulle tendenze in atto<br />
nelle popolazioni delle specie <strong>di</strong> interesse e <strong>di</strong> conseguenza <strong>di</strong> poter attivare delle<br />
ulteriori azioni <strong>di</strong> conservazione specifiche. Inoltre, i risultati potranno essere<br />
utilizzati anche per effettuare dei confronti con le comunità ornitiche analoghe<br />
presenti in altre regioni italiane e in altri Stati del Me<strong>di</strong>terraneo.<br />
Me<strong>di</strong>ante l’utilizzo <strong>di</strong> meto<strong>di</strong>che standard <strong>di</strong> censimento si potrà svolgere a<br />
scadenza annuale il monitoraggio della comunità ornitica legata alle<br />
formazioni erbacee coltivate e pascolate del sito.<br />
La metodologia proposta verrà applicata nel corso dei mesi primaverili<br />
(marzo-maggio) alle popolazioni ornitiche ni<strong>di</strong>ficanti <strong>di</strong> Occhione, Calandra,<br />
Cappellaccia, Calandrella e Lani<strong>di</strong> (Averla capirossa e Averla cenerina).<br />
Produzione <strong>di</strong> report tecnici.<br />
Conoscenza aggiornata dello stato <strong>di</strong> conservazione.<br />
Interessi economici<br />
Enti territoriali, Università, Centri <strong>di</strong> Ricerca.<br />
207
coinvolti<br />
Soggetti competenti<br />
Priorità dell’azione<br />
Tempi<br />
e stima dei costi<br />
Riferimenti<br />
programmatici e linee<br />
<strong>di</strong> finanziamento<br />
Riferimenti tecnici e<br />
criteri progettuali<br />
Regione Puglia, <strong>Provincia</strong> <strong>di</strong> <strong>Taranto</strong>, Università, CNR, ONG ambientaliste.<br />
MEDIA<br />
Durata 20 anni.<br />
Costo complessivo per collaborazioni professionali <strong>di</strong> 200.000,00 €.<br />
LIFE+ 2007-2013<br />
Programmazione POR 2007-2013<br />
Occhione Bhurinus oe<strong>di</strong>cnemus<br />
Protocollo <strong>di</strong> ricerca<br />
Per il censimento dell'Occhione si utilizzerà la tecnica del playback. I rilevamenti<br />
verranno compiuti durante le ore <strong>di</strong>urne, dai primi <strong>di</strong> marzo alla fine <strong>di</strong> luglio, in<br />
due aree campione in cui si procederà alla in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong> stazioni <strong>di</strong><br />
emissione-ascolto <strong>di</strong>stanziate in maniera costante. Ogni transetto sara in<strong>di</strong>viduato<br />
all'interno <strong>di</strong> un'area campione omogenea o comprensiva <strong>di</strong> 3-4 <strong>di</strong>fferenti<br />
ambienti. La <strong>di</strong>mensione delle aree campione sarà compresa tra 2000 e 4000 ha e<br />
i transetti in essa in<strong>di</strong>viduati dovranno coprire l'intera area.<br />
Le <strong>di</strong>stanze tra i punti <strong>di</strong> emissione-ascolto varieranno da un minimo <strong>di</strong> 500 metri<br />
fino a 1000 metri.<br />
Per ogni transetto opereranno minimo due rilevatori e i dati verranno raccolti in<br />
apposite schede.<br />
La registrazione utilizzata sarà composta da <strong>di</strong>verse sequenze <strong>di</strong> "kourli" e "kluì"<br />
<strong>di</strong> intensità e velocità variabili, u<strong>di</strong>bili fino a 600 - 800 metri, e in<strong>di</strong>cati<br />
rispettivamente come versi aggressivi e <strong>di</strong> eccitazione da Cramp e Simmons<br />
(1983). Questi saranno derivati dalle registrazioni <strong>di</strong> Rochè (1983).<br />
In ogni punto <strong>di</strong> stimolazione l'emissione sarà effettuata in 3 fasi <strong>di</strong> 4' ciascuna (2'<br />
<strong>di</strong> richiamo e 2' <strong>di</strong> ascolto), per un totale <strong>di</strong> 12', utilizzando un riproduttore CD<br />
portatile e un altoparlante a larga banda.<br />
Censimento Alau<strong>di</strong><strong>di</strong><br />
Protocollo <strong>di</strong> ricerca<br />
Per il censimento delle <strong>di</strong>verse specie <strong>di</strong> Alau<strong>di</strong><strong>di</strong> ni<strong>di</strong>ficanti sarà utilizzata la<br />
tecnica dei Conteggi Puntiformi (Point Counts). I rilevamenti verranno compiuti<br />
dai primi <strong>di</strong> marzo alla fine <strong>di</strong> giugno, in due aree campione in cui si procederà<br />
alla in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong> un transetto su cui verranno effettuati dei punti <strong>di</strong><br />
rilevamento <strong>di</strong>stanziati <strong>di</strong> 300 metri. La <strong>di</strong>mensione delle aree campione sarà<br />
compresa tra 500 e 1500 ha.<br />
In ogni punto <strong>di</strong> osservazione e ascolto verranno segnate, su apposite schede,<br />
tutte le specie viste o sentite, il loro numero e il tipo <strong>di</strong> attività (canto territoriale,<br />
trasporto <strong>di</strong> imbeccate, volo, ecc.) per un periodo <strong>di</strong> tempo <strong>di</strong> 5'.<br />
Verranno effettuati due censimenti mensili nelle prime ore della giornata,<br />
percorrendo a pie<strong>di</strong> o in auto il transetto prestabilito.<br />
208
In ognuno dei punti <strong>di</strong> rilevamento, in giorni <strong>di</strong>versi da quelli del rilievo<br />
ornitologico, saranno effettuati dei rilievi sulla struttura vegetale al fine <strong>di</strong><br />
correlare le abbondanze specifiche con le <strong>di</strong>verse tipologie vegetali determinate.<br />
209
Scheda azione Tipologia sito (SIC/ZPS) CODICE E NOME SITO”<br />
sito SIC e ZPS "Area delle Gravine IT9130007”<br />
PMR 4 Titolo dell’azione Monitoraggio e stu<strong>di</strong>o delle popolazioni <strong>di</strong><br />
Chirotteri, Anfibi e Rettili <strong>di</strong> interesse<br />
comunitario (All. II e IV <strong>di</strong>r. Habitat)<br />
Generale Localizzata <br />
Tipologia azione<br />
intervento attivo (IA)<br />
regolamentazione (RE)<br />
incentivazione (IN)<br />
programma <strong>di</strong> monitoraggio e/o ricerca (PMR)<br />
programma <strong>di</strong>dattico (PD)<br />
Eventuale stralcio<br />
cartografico (vale per<br />
le azioni localizzate)<br />
Descrizione dello stato<br />
attuale e<br />
contestualizzazione<br />
dell’azione nel PdG<br />
In<strong>di</strong>catori <strong>di</strong> stato<br />
Finalità dell’azione<br />
Descrizione dell’azione<br />
e programma<br />
operativo<br />
Verifica dello<br />
stato <strong>di</strong> attuazione/<br />
avanzamento<br />
dell’azione<br />
Descrizione dei<br />
risultati attesi<br />
Interessi economici<br />
coinvolti<br />
Soggetti competenti<br />
La conoscenza delle <strong>di</strong>namiche <strong>di</strong> popolazione delle specie in questione risulta<br />
in<strong>di</strong>spensabile per una coretta gestione faunistica della ZPS. Inoltre, il<br />
monitoraggio perio<strong>di</strong>co delle popolazioni <strong>di</strong> rapaci consente <strong>di</strong> verificare gli<br />
effetti delle azioni <strong>di</strong> conservazione in<strong>di</strong>viduate nel Piano <strong>di</strong> Gestione.<br />
N. colonie <strong>di</strong> ni<strong>di</strong>ficazione (I2); n. colonie <strong>di</strong> svernamento (I3); densità me<strong>di</strong>a per<br />
area campione (I8).<br />
Definizione della <strong>di</strong>stribuzione reale, della consistenza numerica e ove possibile,<br />
del successo riproduttivo delle specie oggetto dell’azione.<br />
Verranno effettuati censimenti delle nursery e dei siti <strong>di</strong> ibernazione dei chirotteri<br />
e verrà analizzata la <strong>di</strong>stribuzione e la consistenza delle popolazioni <strong>di</strong> anfibi e<br />
rettili.<br />
Produzione <strong>di</strong> report tecnici.<br />
Completamento delle conoscenze sulle popolazioni <strong>di</strong> Chirotteri, Anfibi e<br />
Rettili presenti nell'area e verifica delle azioni <strong>di</strong>rette <strong>di</strong> conservazione sulla<br />
specie.<br />
Enti territoriali, Università, Centri <strong>di</strong> Ricerca.<br />
Regione Puglia, <strong>Provincia</strong> <strong>di</strong> <strong>Taranto</strong>, Università, ONG ambientaliste.<br />
210
Priorità dell’azione<br />
Tempi<br />
e stima dei costi<br />
Riferimenti<br />
programmatici e linee<br />
<strong>di</strong> finanziamento<br />
Riferimenti tecnici e<br />
criteri progettuali<br />
MEDIA<br />
Durata minima 20 anni. Costo complessivo per collaborazioni professionali <strong>di</strong><br />
200.000,00 €.<br />
LIFE+ 2007-2013<br />
Programmazione POR 2007-2013<br />
Anfibi e Rettili<br />
Censimenti completi <strong>di</strong> tipo qualitativo attraverso l’in<strong>di</strong>viduazione e l’analisi dei<br />
soli siti potenzialmente idonei alla presenza <strong>di</strong> Anfibi (stagni e raccolte d’acqua<br />
temporanee, fontanili e abbeveratoi, cisterne, ecc.). In<strong>di</strong>viduazione su carta, in<br />
scala adeguata, e su GPS delle singole stazioni e si censimento qualitativo delle<br />
specie presenti nei perio<strong>di</strong> idonei. In ogni sito in<strong>di</strong>viduato saranno effettuati<br />
almeno due campionamenti successivi; uno all’inizio della primavera (marzo –<br />
aprile) e l’altro in estate (agosto – settembre).<br />
Per i Rettili sono più idonei i censimenti completi in aree campione. Particolare<br />
attenzione sarà riservata alle specie <strong>di</strong> importanza comunitaria presenti nell’area:<br />
Testudo hermanni, Coluber quatuorlineata e Elaphe situla.<br />
Chirotteri<br />
L'attività <strong>di</strong> censimento dei Chirotteri dovrà essere svolta da uno specialista della<br />
materia con regolare autorizzazione del Ministero dell’Ambiente alla cattura e<br />
allo stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> questi mammiferi.<br />
L'attività <strong>di</strong> ricerca dovrà articolarsi secondo due approcci. Un primo approccio<br />
prevede la semplice verifica della presenza/assenza e della stima dei chirotteri,<br />
eventualmente, presenti in ogni cavità o sito idoneo visitato. Questo consentirà <strong>di</strong><br />
definire quali siti presentano un minimo grado <strong>di</strong> frequentazione da parte dei<br />
chirotteri e <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare nuovi siti che ospitano importanti popolazioni non<br />
conosciute in precedenza.<br />
Il secondo approccio all'indagine prevede il censimento delle specie presenti nelle<br />
nei siti che hanno evidenziato la presenza <strong>di</strong> gruppi <strong>di</strong> in<strong>di</strong>vidui.<br />
Durante le prospezioni, delle <strong>di</strong>verse cavità in<strong>di</strong>viduate, si dovrà determinare le<br />
specie presenti, la loro consistenza e la presenza <strong>di</strong> fattori <strong>di</strong> <strong>di</strong>sturbo e minaccia.<br />
L'identificazione delle specie presenti raramente potrà aversi tramite semplice<br />
osservazione (le specie troglofiche identificabili con relativa facilità sono solo<br />
Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros e Miniopterus<br />
schreibersi) per cui verranno effettuate delle catture temporanee attraverso<br />
l'utilizzo <strong>di</strong> retini telescopici e <strong>di</strong> mist-net posizionate all'ingresso delle cavità<br />
utilizzate come rifugio. Verranno, inoltre, raccolti tutti i resti e i crani <strong>di</strong> chirotteri<br />
presenti nei siti. Gli animali catturati verranno trattenuti per il solo periodo<br />
necessario all’identificazione, sessaggio e raccolta dei dati biometrici.<br />
Ogni in<strong>di</strong>viduo sarà classificato come juvenile, sub-adulto o adulto attraverso<br />
l'osservazione del grado <strong>di</strong> chiusura delle cartilagini epifisarie alla giuntura<br />
metacarpale-falange del IV <strong>di</strong>to (Stebbings, 1988; Kunz, 1988). Per<br />
l'identificazione delle specie verranno utilizzate le chiavi analitiche <strong>di</strong> Lanza<br />
211
(1959) e Schober & Grimmberger (1997). Per i materiali attribuibili alle specie<br />
criptiche Myotis myotis e M. blythii si fornirà una <strong>di</strong>agnosi specifica su base<br />
biometrica, secondo quanto in<strong>di</strong>cato da Arlettaz (1995) e Arlettaz et al. (1997).<br />
Alla luce della recente scoperta dell'esistenza <strong>di</strong> <strong>di</strong>verse specie criptiche<br />
apparteneti al gruppo Myotis mystacinus, con M. mystacinus, M. alcathoe, M.<br />
aurascens e M. brandtii (Benda & Tsytsulina, 2000; Helversen et al., 2001;<br />
Mayer & Helversen, 2001; Rue<strong>di</strong> et al., 2002; Rue<strong>di</strong> & Mayer, 2001) e al gruppo<br />
Pipistrellus pipistrellus, con P. pipistrellus e P. pygmaeus (Barratt et al., 1997), i<br />
dati relativi a questi due gruppi verranno analizzati sulla base delle moderne<br />
tecniche <strong>di</strong> indagine.<br />
Ove possibile, le osservazioni faunistiche saranno integrate con informazioni <strong>di</strong><br />
carattere ecologico relative all'ibernazione e alla riproduzione a seconda del<br />
periodo <strong>di</strong> indagine.<br />
La definizione della consistenza delle specie presenti pone <strong>di</strong>versi problemi<br />
metodologici a causa della <strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong> accesso ai siti <strong>di</strong> riposo/nursery, della<br />
<strong>di</strong>fficile separazione delle specie senza cattura dei singoli animali e del grado <strong>di</strong><br />
aggregazione mostrato dagli stessi. Nei siti <strong>di</strong> riposo <strong>di</strong> facile accesso e in<br />
presenza <strong>di</strong> colonie <strong>di</strong> modesta entità si opterà per il conteggio <strong>di</strong>retto, mentre nei<br />
siti <strong>di</strong> <strong>di</strong>fficile accesso e/o in presenza <strong>di</strong> colonie cospicue si stimerà il numero <strong>di</strong><br />
animali presenti utilizzando vari meto<strong>di</strong>.<br />
1. Raggruppamenti monospecifici: foto dei singoli cluster <strong>di</strong> in<strong>di</strong>vidui e<br />
successiva stima del numero <strong>di</strong> animali;<br />
2. Raggruppamenti plurispecifici: stima <strong>di</strong>retta del numero totale <strong>di</strong> animali<br />
presenti e successiva estrapolazione dell'abbondanza delle singole specie<br />
rilevate attraverso le frequenza <strong>di</strong> cattura.<br />
Lo stato <strong>di</strong> conservazione e la presenza <strong>di</strong> fattori <strong>di</strong> minaccia saranno valutati in<br />
base all'accessibilità del sito da parte dell'uomo e al rilevamento <strong>di</strong>retto <strong>di</strong> segni<br />
<strong>di</strong> presenza umana quali rifiuti, resti <strong>di</strong> falò, materiali depositati, ecc. I rilievi<br />
verranno effettuati durante tutto il periodo <strong>di</strong> indagine.<br />
212
Scheda azione<br />
sito SIC e ZPS “Area delle Gravine IT9130007”<br />
PMR5 Titolo dell’azione Realizzazione <strong>di</strong> un catasto delle aree<br />
occupate da habitat steppico<br />
Generale <br />
Localizzata <br />
Tipologia azione<br />
intervento attivo (IA)<br />
regolamentazione (RE)<br />
incentivazione (IN)<br />
programma <strong>di</strong> monitoraggio e/o ricerca (PMR)<br />
programma <strong>di</strong>dattico (PD)<br />
Descrizione dello<br />
stato attuale e<br />
contestualizzazione<br />
dell’azione nel PdG<br />
Lo spietramento rappresenta la maggiore minaccia per la conservazione<br />
dell’habitat steppico nell’area delle gravine dell’arco ionico e in <strong>generale</strong> in<br />
Puglia e in Basilicata. La pratica dello “spietramento”, dopo aver impoverito<br />
la <strong>di</strong>versità genetica delle colture tra<strong>di</strong>zionali, frammentato le vegetazioni<br />
spontanee e semplificato i mosaici ambientali con l’estensione delle<br />
monocolture intensive, in seguito ad una errata politica <strong>di</strong> sovvenzioni<br />
pubbliche, si è estesa ben oltre il limite del ragionevole. Il “recupero del<br />
franco <strong>di</strong> coltivazione”, ossia la trasformazione delle praterie e delle altre<br />
tipologie vegetazionali della gariga e della macchia in colture agrarie,<br />
attraverso la frantumazione delle pietre calcaree, produce terreni poveri ma<br />
idonei per impiantare vigneti, per innescare progetti <strong>di</strong> riforestazione o per<br />
l’espansione <strong>di</strong> zone urbanizzate, aumentando anche il rischio <strong>di</strong> incen<strong>di</strong>.<br />
Questi terreni una volta spietrati sono soggetti ad un veloce processo <strong>di</strong><br />
desertificazione, a causa dell’azione erosiva dei venti ed al <strong>di</strong>lavamento delle<br />
acque piovane, azioni non più contrastate dalla presenza degli apparati<br />
ra<strong>di</strong>cali della vegetazione spontanea. Tale devastante pratica <strong>di</strong> <strong>di</strong>ssodamento<br />
dei terreni rischia altresì <strong>di</strong> perturbare il delicato equilibrio idrogeologico<br />
sotterraneo, sottoposto a vincolo <strong>di</strong> “Riserva <strong>di</strong> acqua potabile”. Tale pratica,<br />
malgrado gli attuali <strong>di</strong>vieti, continua ad essere effettuata e determina la<br />
continua per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> aree trofiche per specie prioritarie come il Grillaio e aree<br />
<strong>di</strong> ni<strong>di</strong>ficazione e trofiche per specie come Occhione, Calandra, Calandrella,<br />
Calandro, Averla cenerina e Averla piccola, chirotteri, rettili e anfibi.<br />
In virtù <strong>di</strong> questo utilizzo <strong>di</strong>struttivo è necessario creare un catasto delle aree<br />
ancora integre dove concentrare gli sforzi <strong>di</strong> tutela.<br />
In<strong>di</strong>catori <strong>di</strong> stato<br />
Mantenimento delle attuali superfici <strong>di</strong> habitat steppico (I10)<br />
Finalità dell’azione<br />
Evitare ulteriori interventi <strong>di</strong> sbancamento e spietramento dei terreni<br />
attraverso l’utilizzo <strong>di</strong>storto dei fon<strong>di</strong> comunitari.<br />
213
Descrizione<br />
dell’azione e<br />
programma operativo<br />
Realizzazione <strong>di</strong> un catasto informatizzato delle aree a pascolo presenti nel<br />
Sic e nella ZPS.<br />
Verifica dello<br />
stato <strong>di</strong> attuazione/<br />
avanzamento<br />
dell’azione<br />
Mantenimento delle attuali superfici steppiche e perio<strong>di</strong>co confronto tra il<br />
numero <strong>di</strong> ettari occupati da pascolo prima dell’approvazione del Piano e<br />
dopo l’approvazione.<br />
Descrizione<br />
risultati attesi<br />
dei<br />
1. <strong>Relazione</strong> tecnica<br />
2. Banca dati delle aree a pascolo presenti nel SIC e nella ZPS<br />
Interessi<br />
coinvolti<br />
economici<br />
Proprietari privati e demanio per le proprietà pubbliche.<br />
Soggetti competenti<br />
Priorità dell’azione<br />
Tempi<br />
e stima dei costi<br />
Regione Puglia, <strong>Provincia</strong> <strong>di</strong> <strong>Taranto</strong>/Ente Parco.<br />
ELEVATA<br />
1 anno. Costo totale preventivato per consulenze 50.000 €.<br />
Riferimenti<br />
programmatici e linee<br />
<strong>di</strong> finanziamento<br />
Piano <strong>di</strong> Sviluppo Rurale della Puglia (2007-2013):<br />
Asse III, Misura 323: Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale.<br />
Riferimenti e allegati<br />
tecnici<br />
214
Scheda azione<br />
sito SIC e ZPS "Area delle Gravine IT9130007<br />
PMR6<br />
RE<br />
Titolo dell’azione<br />
Stu<strong>di</strong> sul sistema delle praterie steppiche<br />
Generale <br />
Localizzata <br />
Tipo azione<br />
intervento attivo (IA)<br />
regolamentazione (RE)<br />
incentivazione (IN)<br />
programma <strong>di</strong> monitoraggio e/o ricerca (PMR)<br />
programma <strong>di</strong>dattico (PD)<br />
Eventuale stralcio<br />
cartografico (vale per le<br />
azioni localizzate)<br />
Descrizione dello stato<br />
attuale e<br />
contestualizzazione<br />
dell’azione nel PdG<br />
(=relazione con<br />
l’obiettivo <strong>generale</strong> <strong>di</strong><br />
PdG)<br />
Finalità dell’azione<br />
(obiettivo specifico)<br />
Il paesaggio dei pianori dei siti è da millenni caratterizzato dalla presenza <strong>di</strong><br />
praterie “steppiche”. Il suo mantenimento è strettamente correlato al suo<br />
principale fattore modellante: la pastorizia brada. Sebbene l’attività<br />
zootecnica sia oramai organizzata verso modalità <strong>di</strong> allevamento<br />
prevalentemente a stabulazione fissa, l’allevamento brado, fondamentale per<br />
la conservazione dell’habitat steppico, se condotto in maniera irrazionale può<br />
costituire un fattore <strong>di</strong> minaccia per lo stesso habitat. Il sovrapascolamento<br />
costituisce uno dei principali problemi per le aree naturali dell’ambiente<br />
me<strong>di</strong>terraneo per le conseguenze che esso può avere non solo sulla<br />
degenerazione della vegetazione spontanea ma anche nei processi <strong>di</strong><br />
desertificazione. Un eccessivo carico <strong>di</strong> bestiame porta non solo ad una<br />
drastica riduzione della vegetazione naturale, con tutti gli effetti negativi che<br />
ne derivano, ma anche all’elevato costipamento da calpestio.<br />
Completamento dello stato <strong>di</strong> conoscenza circa l’impatto del pascolo (carico<br />
e modalità) sull’habitat steppico.<br />
Descrizione dell’azione<br />
(metodologia) e<br />
programma operativo<br />
Descrizione dei<br />
risultati attesi<br />
In<strong>di</strong>catori target<br />
Sviluppo <strong>di</strong> stu<strong>di</strong> specifici sulla <strong>di</strong>namica e sulla composizione floristica<br />
<strong>di</strong> steppe e cespuglieti e istituzione <strong>di</strong> un programma <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o sugli<br />
effetti <strong>di</strong> carichi <strong>di</strong>fferenziati <strong>di</strong> pascolanti, allo scopo <strong>di</strong> mantenere una<br />
cotica erbosa che consenta la conservazione della <strong>di</strong>versità floristica<br />
attuale. Determinazione dell’in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> pascolamento sostenibile<br />
Informazioni utili per la definizione del carico <strong>di</strong> pascolo in<br />
funzione dello stato <strong>di</strong> conservazione dell’habitat.<br />
Numero <strong>di</strong> capi <strong>di</strong> bestiame per unità <strong>di</strong> superficie (in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> pascolamento).<br />
215
I19 e I34<br />
Interessi economici<br />
coinvolti<br />
Soggetti competenti e<br />
modalità attuative<br />
Priorità dell’azione<br />
Allevatori<br />
Regione Puglia, <strong>Provincia</strong> <strong>di</strong> <strong>Taranto</strong>, Ente Parco<br />
MEDIA<br />
Tempi<br />
e stima dei costi<br />
Riferimenti<br />
programmatici e linee<br />
<strong>di</strong> finanziamento<br />
Riferimenti tecnici e<br />
criteri progettuali<br />
Durata 2 anni. Costo complessivo € 25.000,00.<br />
LIFE+ 2007-2013<br />
Programmazione POR 2007-2013<br />
AA. VV. Progetto esecutivo - azione C2 LIFE 03 NAT/ IT/000134<br />
”Interventi <strong>di</strong> salvaguar<strong>di</strong>a e <strong>di</strong> recupero della rete ecologica <strong>di</strong> connessione<br />
tra le gravine caratterizzata dall’habitat dei Thero-Brachypo<strong>di</strong>etea”<br />
216
Scheda azione<br />
sito SIC e ZPS "Area delle Gravine IT9130007”<br />
PMR 7 Titolo dell’azione Stu<strong>di</strong> e monitoraggio delle comunità <strong>di</strong><br />
vertebrati presenti nel sito<br />
Generale <br />
Localizzata <br />
Tipologia azione<br />
intervento attivo (IA)<br />
regolamentazione (RE)<br />
incentivazione (IN)<br />
programma <strong>di</strong> monitoraggio e/o ricerca (PMR)<br />
programma <strong>di</strong>dattico (PD)<br />
Eventuale stralcio<br />
cartografico<br />
(vale per le azioni<br />
localizzate)<br />
Descrizione dello stato<br />
attuale e<br />
contestualizzazione<br />
dell’azione nel PdG<br />
(=relazione con<br />
l’obiettivo <strong>generale</strong> <strong>di</strong><br />
PdG)<br />
Finalità dell’azione<br />
(obiettivo specifico)<br />
Descrizione dell’azione<br />
(metodologia) e<br />
programma operativo<br />
Descrizione dei<br />
risultati attesi<br />
Verifica dello stato <strong>di</strong><br />
Conoscenza delle comunità <strong>di</strong> vertebrati presenti nel sito e il loro<br />
monitoraggio perio<strong>di</strong>co.<br />
Tra i vertebrati i gruppi meno noti sono quelli dei Pesci e dei Mammiferi<br />
Chirotteri.<br />
Il completamento <strong>di</strong> conoscenze del gruppo dei vertebrati consentirà <strong>di</strong><br />
definire meglio i criteri gestionali in grado <strong>di</strong> favorire il mantenimento delle<br />
comunità e quin<strong>di</strong> la conservazione dell’ecosistema e della sua bio<strong>di</strong>versità.<br />
Me<strong>di</strong>ante l’utilizzo <strong>di</strong> meto<strong>di</strong>che standard <strong>di</strong> censimento ciascun gruppo sarà<br />
indagato al fine <strong>di</strong> determinare le specie presenti nel sito e possibilmente lo<br />
status e gli habitat selezionati.<br />
Per ciascun taxa si può prevedere <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare da 5 a 10 aree campione,<br />
selezionate in base alla loro rappresentatività ambientale e <strong>di</strong> svolgere in<br />
queste dei rilievi attraverso opportuni meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> campionamento definiti<br />
dagli specialisti del gruppo chiamati ad effettuare il censimento.<br />
1) Checklist delle specie <strong>di</strong> vertebrati presenti nel sito.<br />
2) Importanti dati riguardanti le corrette modalità <strong>di</strong> gestione degli habitat<br />
presenti nel sito.<br />
3) Aumento del numero <strong>di</strong> tesisti presenti nell’area attraverso accor<strong>di</strong> <strong>di</strong><br />
programma con le Università.<br />
4) Realizzazione <strong>di</strong> una collana e<strong>di</strong>toriale sulla fauna.<br />
Aumento bio<strong>di</strong>versità.<br />
217
attuazione/<br />
avanzamento<br />
dell’azione<br />
Interessi economici<br />
coinvolti<br />
Soggetti competenti<br />
e modalità attuative<br />
Priorità dell’azione<br />
Tempi<br />
e stima dei costi<br />
Riferimenti<br />
programmatici e linee<br />
<strong>di</strong> finanziamento<br />
Pubblica amministrazione.<br />
Regione Puglia/ <strong>Provincia</strong> <strong>di</strong> <strong>Taranto</strong>/Ente Parco/Associazioni<br />
ambientaliste/Università.<br />
MEDIA<br />
Cinque anni € 100.000,00<br />
Life + 2007-2013<br />
Riferimenti e allegati<br />
tecnici<br />
Scheda azione<br />
Sito SIC e ZPS "Area delle Gravine IT9130007”<br />
PMR8<br />
218
Titolo dell’azione<br />
Stu<strong>di</strong> e monitoraggio delle comunità <strong>di</strong><br />
invertebrati presenti nel sito<br />
Generale <br />
Localizzata <br />
Tipologia azione<br />
intervento attivo (IA)<br />
regolamentazione (RE)<br />
incentivazione (IN)<br />
programma <strong>di</strong> monitoraggio e/o ricerca (PMR)<br />
programma <strong>di</strong>dattico (PD)<br />
Eventuale stralcio<br />
cartografico (vale per<br />
le azioni localizzate)<br />
Descrizione dello<br />
stato attuale e<br />
contestualizzazione<br />
dell’azione nel PdG<br />
(=relazione con<br />
l’obiettivo <strong>generale</strong> <strong>di</strong><br />
PdG)<br />
Conoscenza delle comunità <strong>di</strong> invertebrati presenti nel sito e il loro<br />
monitoraggio perio<strong>di</strong>co.<br />
Particolare rilevanza assumono gli or<strong>di</strong>ni degli Insetti (Lepidotteri e<br />
Coleotteri) i quali comprendono numerose specie <strong>di</strong> interesse comunitario.<br />
Un’altra classe <strong>di</strong> particolare interesse è rappresentato dai Crostacei ed in<br />
particolare modo dei Crostacei d’acqua dolce, presenti con <strong>di</strong>verse specie nelle<br />
raccolte d’acqua effimere e lungo i solchi gravinali.<br />
Finalità dell’azione<br />
(obiettivo specifico)<br />
Descrizione<br />
dell’azione<br />
(metodologia) e<br />
programma<br />
operativo<br />
Descrizione dei<br />
risultati attesi<br />
Verifica dello stato <strong>di</strong><br />
attuazione/<br />
avanzamento<br />
La conoscenza della struttura delle comunità <strong>di</strong> Invertebrati permetterà <strong>di</strong><br />
meglio definire i criteri gestionali in grado <strong>di</strong> favorire il mantenimento delle<br />
comunità e quin<strong>di</strong> la conservazione dell’ecosistema e della sua bio<strong>di</strong>versità.<br />
Tale azione appare particolarmente importante in quanto questi taxa, spesso<br />
sottovalutati, rappresentano la base delle reti trofiche, per cui il loro status si<br />
riflette sull’intera comunità biotica del sito.<br />
Me<strong>di</strong>ante l’utilizzo <strong>di</strong> meto<strong>di</strong>che standard <strong>di</strong> censimento ciascun gruppo sarà<br />
indagato al fine <strong>di</strong> determinare le specie presenti nel sito e possibilmente lo<br />
status e gli habitat selezionati.<br />
Per ciascun taxa si può prevedere <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare da 5 a 10 aree campione,<br />
selezionate in base alla loro rappresentatività ambientale e <strong>di</strong> svolgere in<br />
queste dei rilievi attraverso opportuni meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> campionamento definiti dagli<br />
specialisti del gruppo chiamati ad effettuare il censimento.<br />
1) Checklist delle specie <strong>di</strong> invertebrati presenti nel sito.<br />
2) Importanti dati riguardanti le corrette modalità <strong>di</strong> gestione degli habitat<br />
presenti nel sito.<br />
3) Aumento del numero <strong>di</strong> tesisti presenti nell’area attraverso accor<strong>di</strong> <strong>di</strong><br />
programma con le Università.<br />
4) Realizzazione <strong>di</strong> una collana e<strong>di</strong>toriale sulla fauna minore.<br />
Aumento bio<strong>di</strong>versità.<br />
219
dell’azione<br />
Interessi economici<br />
coinvolti<br />
Soggetti competenti<br />
e modalità attuative<br />
Priorità dell’azione<br />
Tempi<br />
e stima dei costi<br />
Riferimenti<br />
programmatici e<br />
linee <strong>di</strong><br />
finanziamento<br />
Pubblica amministrazione.<br />
Regione Puglia/ <strong>Provincia</strong> <strong>di</strong> <strong>Taranto</strong>/Ente Parco/Associazioni<br />
ambientaliste/Università.<br />
MEDIA<br />
Cinque anni € 100.000,00<br />
Life + 2007-2013<br />
Riferimenti e allegati<br />
tecnici<br />
Scheda azione<br />
sito SIC e ZPS "Area delle Gravine IT9130007”<br />
PMR 9<br />
Titolo dell’azione<br />
Monitoraggio e piano <strong>di</strong> gestione della<br />
popolazione <strong>di</strong> Cinghiale Sus scrofa<br />
presente nel sito<br />
Generale Localizzata <br />
220
Tipologia azione<br />
intervento attivo (IA)<br />
regolamentazione (RE)<br />
incentivazione (IN)<br />
programma <strong>di</strong> monitoraggio e/o ricerca (PMR)<br />
programma <strong>di</strong>dattico (PD)<br />
Eventuale stralcio<br />
cartografico<br />
(vale per le azioni<br />
localizzate)<br />
Descrizione dello stato<br />
attuale e<br />
contestualizzazione<br />
dell’azione nel PdG<br />
(=relazione con<br />
l’obiettivo <strong>generale</strong> <strong>di</strong><br />
PdG)<br />
Il Cinghiale rappresenta l’unica specie <strong>di</strong> mammifero <strong>di</strong> gran<strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni<br />
presente nel sito. La sua origine non in<strong>di</strong>gena ma frutto <strong>di</strong> ripopolamenti a<br />
scopo venatorio ha determinato l’insorgere <strong>di</strong> uno squilibrio ecologico<br />
dovuto all’assenza <strong>di</strong> predatori naturali e alle particolari caratteristiche<br />
ecologiche della varietà ripopolata.<br />
L’impatto del cinghiale assume spesso valori preoccupanti sia rispetto alle<br />
produzioni agricole che all’ambiente naturale. Infatti, all’aumentare della<br />
densità della popolazione l’attività <strong>di</strong> scavo, tipica della specie, influisce<br />
negativamente sulla vegetazione e su numerose specie <strong>di</strong> fauna.<br />
Infine, la caccia al cinghiale praticate con cani e battute risulta spesso<br />
particolarmente impattante sull’ambiente.<br />
Finalità dell’azione<br />
(obiettivo specifico)<br />
Descrizione dell’azione<br />
(metodologia) e<br />
programma operativo<br />
Descrizione dei<br />
risultati attesi<br />
Verifica dello stato <strong>di</strong><br />
attuazione/<br />
avanzamento<br />
dell’azione<br />
Determinare l’attuale areale <strong>di</strong>stributivo della specie e la <strong>di</strong>mensione della<br />
popolazione.<br />
Determinare la capacità portante del territorio rispetto al cinghiale.<br />
Definire, se necessario, appositi programmi <strong>di</strong> gestione della specie.<br />
Per le specie si può prevedere <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare da 5 a 10 aree campione,<br />
selezionate in base alla loro rappresentatività ambientale e <strong>di</strong> svolgere in<br />
queste dei rilievi attraverso opportuni meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> campionamento definiti<br />
dagli specialisti del gruppo chiamati ad effettuare il censimento.<br />
Diminuire l’impatto del cinghiale sull’ambiente naturale e sulle attività<br />
agricole.<br />
Attenuare l’impatto dell’attività <strong>di</strong> caccia al cinghiale sulle altre specie <strong>di</strong><br />
fauna.<br />
Gestire correttamente la specie in termini <strong>di</strong> risorsa faunistica impedendo i<br />
ripopolamenti.<br />
Diminuzione dei danni da cinghiale.<br />
221
Interessi economici<br />
coinvolti<br />
Soggetti competenti<br />
e modalità attuative<br />
Priorità dell’azione<br />
Tempi<br />
e stima dei costi<br />
Riferimenti<br />
programmatici e linee<br />
<strong>di</strong> finanziamento<br />
Pubblica amministrazione.<br />
Regione Puglia/ <strong>Provincia</strong> <strong>di</strong> <strong>Taranto</strong>/Ente Parco/Associazioni<br />
ambientaliste/Università.<br />
MEDIA<br />
Tre anni € 75.000,00<br />
Life + 2007-2013<br />
Riferimenti e allegati<br />
tecnici<br />
222
Scheda azione Tipologia sito (SIC/ZPS) CODICE E NOME SITO”<br />
sito SIC e ZPS "Area delle Gravine IT9130007”<br />
PD1 Titolo dell’azione Realizzazione <strong>di</strong> materiali informativi tecnici<br />
per gli or<strong>di</strong>ni degli Architetti, degli Ingegneri e<br />
per le varie associazioni <strong>di</strong> categoria coinvolte<br />
nei progetti <strong>di</strong> ristrutturazione degli e<strong>di</strong>fici<br />
storici.<br />
Generale Localizzata <br />
Tipologia azione<br />
intervento attivo (IA)<br />
regolamentazione (RE)<br />
incentivazione (IN)<br />
programma <strong>di</strong> monitoraggio e/o ricerca (MR)<br />
programma <strong>di</strong>dattico (PD)<br />
Eventuale stralcio<br />
cartografico (vale per<br />
le azioni localizzate)<br />
Descrizione dello stato<br />
attuale e<br />
contestualizzazione<br />
dell’azione nel PdG<br />
In<strong>di</strong>catori <strong>di</strong> stato<br />
Finalità dell’azione<br />
Attualmente sono in corso una serie <strong>di</strong> progetti <strong>di</strong> riqualificazione urbana in tutti i<br />
comuni interessati dalla presenza del Grillaio che non tengono conto delle<br />
esigenze vitali della stessa.<br />
Gli interventi <strong>di</strong> ristrutturazione vengono spesso eseguiti in piena stagione<br />
riproduttiva (Marzo – Luglio) con conseguente abbandono del sito. Molto spesso<br />
viene chiusa la maggior parte delle cavità utilizzate dal Grillaio per ni<strong>di</strong>ficare. In<br />
tali con<strong>di</strong>zioni le colonie possono avere grosse <strong>di</strong>fficoltà nella fase riproduttiva<br />
con conseguente <strong>di</strong>minuzione della fitness.<br />
N. coppie ni<strong>di</strong>ficanti (I1); n. colonie <strong>di</strong> ni<strong>di</strong>ficazione (I2).<br />
Proteggere i siti <strong>di</strong> ni<strong>di</strong>ficazione del Grillaio attraverso il coinvolgimento delle<br />
<strong>di</strong>verse categorie produttive che più hanno influenza sulla conservazione della<br />
specie.<br />
Descrizione dell’azione<br />
e programma<br />
operativo<br />
Verifica dello<br />
stato <strong>di</strong> attuazione/<br />
avanzamento<br />
dell’azione<br />
Realizzazione <strong>di</strong> materiali informativi per gli amministratori, imprese e<strong>di</strong>li e<br />
progettisti (geometri, periti agrari, ingegneri e architetti) al fine <strong>di</strong><br />
regolamentare gli interventi <strong>di</strong> ristrutturazione dei vecchi e<strong>di</strong>fici e per<br />
conservare i siti <strong>di</strong> ni<strong>di</strong>ficazione.<br />
Produzione dei materiali tecnici a supporto delle categorie professionali<br />
(Architetti, Ingegneri, Geometri, Periti Agrari).<br />
Descrizione dei<br />
risultati attesi<br />
Contrastare la per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> siti <strong>di</strong> ni<strong>di</strong>ficazione e messa in atto <strong>di</strong> interventi <strong>di</strong><br />
restauro compatibili con la conservazione della specie.<br />
223
Interessi<br />
coinvolti<br />
economici<br />
Associazioni <strong>di</strong> categoria nel comparto e<strong>di</strong>le, pubbliche amministrazioni.<br />
Soggetti competenti<br />
Priorità dell’azione<br />
Tempi<br />
e stima dei costi<br />
Riferimenti<br />
programmatici e linee<br />
<strong>di</strong> finanziamento<br />
Regione Puglia, <strong>Provincia</strong> <strong>di</strong> <strong>Taranto</strong>, Università, Associazioni ambientaliste.<br />
BASSA<br />
Durata 1 anno. Costo complessivo per colonia 10.000,00 €.<br />
LIFE+ 2007-2013<br />
Programmazione Regionale 2007-2013<br />
Riferimenti tecnici e<br />
criteri progettuali<br />
224
Scheda azione Tipologia sito (SIC/ZPS) CODICE E NOME SITO”<br />
sito SIC e ZPS "Area delle Gravine IT9130007”<br />
PD2 Titolo dell’azione Sviluppo e organizzazione <strong>di</strong> programmi <strong>di</strong><br />
educazione e <strong>di</strong>vulgazione ambientale in grado<br />
<strong>di</strong> <strong>di</strong>ffondere tra le popolazioni locali la<br />
conoscenza delle specie e la necessità <strong>di</strong><br />
proteggerne gli habitat<br />
Generale Localizzata <br />
Tipologia azione<br />
intervento attivo (IA)<br />
regolamentazione (RE)<br />
incentivazione (IN)<br />
programma <strong>di</strong> monitoraggio e/o ricerca (PMR)<br />
programma <strong>di</strong>dattico (PD)<br />
Eventuale stralcio<br />
cartografico (vale per le<br />
azioni localizzate)<br />
Descrizione dello stato<br />
attuale<br />
e<br />
contestualizzazione<br />
dell’azione nel PdG<br />
In<strong>di</strong>catori <strong>di</strong> stato<br />
Finalità dell’azione<br />
Descrizione dell’azione e<br />
programma operativo<br />
Attualmente, tranne spora<strong>di</strong>che azioni <strong>di</strong> cooperative e associazioni ambientaliste,<br />
manca un serio programma teso a promuovere una maggiore consapevolezza<br />
dell’importanza <strong>di</strong> proteggere il patrimonio naturalistico del sito.<br />
Per questa ragione la realizzazione in maniera coor<strong>di</strong>nata e partecipata <strong>di</strong> eventi e<br />
materiali informativi per gli amministratori, la popolazione locale e per tutte le<br />
categorie produttive interessate (agricoltori, allevatori, operatori turistici), così<br />
come la produzione <strong>di</strong> materiale stampato per la sensibilizzazione degli alunni<br />
delle scuole e per il grande pubblico, avranno lo scopo <strong>di</strong> far comprendere<br />
l’importanza dell’area.<br />
Tutto questo dovrà essere coa<strong>di</strong>uvato da una intensa campagna<br />
nazionale/internazionale con presenza anche alle più importanti manifestazioni<br />
fieristiche europee e con l’obiettivo <strong>di</strong> far conoscere l’area anche a settori<br />
specializzati come i birdwatchers.<br />
Numero <strong>di</strong> programmi <strong>di</strong> educazione ambientale finanziati. N. <strong>di</strong> materiale<br />
informativo e <strong>di</strong>vulgativo prodotto. N. <strong>di</strong> eventi pubblici organizzati.<br />
Informare le <strong>di</strong>verse categorie produttive interessate e la popolazione locale<br />
sull’importanza dell’area, dare risalto alle attività svolte e promuovere un<br />
adeguato coinvolgimento per la salvaguar<strong>di</strong>a degli habitat e delle specie anche da<br />
parte dei più giovani.<br />
Progettazione e realizzazione <strong>di</strong> una campagna <strong>di</strong> informazione e<br />
sensibilizzazione dell'opinione pubblica;<br />
Produzione <strong>di</strong> materiale <strong>di</strong>vulgativo (brochure, adesivi, cartellonistica, Cd-rom)<br />
225
Verifica dello<br />
stato <strong>di</strong> attuazione/<br />
avanzamento dell’azione<br />
sull'ecologia delle specie tipiche dell'area delle gravine;<br />
Realizzazione <strong>di</strong> eventi pubblici sul tema della conservazione e delle minacce che<br />
gravano sull’area;<br />
Creazione <strong>di</strong> un centro <strong>di</strong> educazione ambientale.<br />
Produzione <strong>di</strong> materiali <strong>di</strong>dattici.<br />
Organizzazione <strong>di</strong> eventi.<br />
Progettazione <strong>di</strong> programmi <strong>di</strong> educazione ambientale<br />
Descrizione dei risultati<br />
attesi<br />
Sensibilizzazione dell’opinione pubblica rispetto alla necessita <strong>di</strong> salvaguar<strong>di</strong>a e<br />
tutela del sito.<br />
Interessi<br />
coinvolti<br />
economici<br />
Pubbliche amministrazioni.<br />
Soggetti competenti<br />
Priorità dell’azione<br />
Tempi<br />
e stima dei costi<br />
Riferimenti<br />
programmatici e linee <strong>di</strong><br />
finanziamento<br />
Regione Puglia, <strong>Provincia</strong> <strong>di</strong> <strong>Taranto</strong>, comunità Montane, Comuni, Enti Gestori,<br />
ONG ambientaliste.<br />
BASSA<br />
Durata 3 anni. Costo complessivo 300.000,00 €.<br />
Programmazione Regionale POR 2007-2013<br />
Riferimenti tecnici e<br />
criteri progettuali<br />
226
Scheda azione Tipologia sito (SIC/ZPS) CODICE E NOME SITO”<br />
sito SIC e ZPS "Area delle Gravine IT9130007”<br />
PD3 Titolo dell’azione Progettazione e realizzazione <strong>di</strong> interventi <strong>di</strong><br />
formazione specialistica destinati al personale<br />
degli enti pubblici territoriali e delle<br />
associazioni ambientaliste interessati e aventi<br />
ad oggetto la normativa ambientale<br />
internazionale, comunitaria, nazionale e<br />
regionale, con particolare riferimento agli<br />
strumenti giuri<strong>di</strong>ci e istituzionali <strong>di</strong><br />
conservazione e tutela dei siti Natura 2000<br />
Generale Localizzata <br />
Tipologia azione<br />
intervento attivo (IA)<br />
regolamentazione (RE)<br />
incentivazione (IN)<br />
programma <strong>di</strong> monitoraggio e/o ricerca (PMR)<br />
programma <strong>di</strong>dattico (PD)<br />
Eventuale stralcio<br />
cartografico (vale per le<br />
azioni localizzate)<br />
Descrizione dello stato<br />
attuale<br />
e<br />
contestualizzazione<br />
dell’azione nel PdG<br />
Il quadro normativo <strong>di</strong> riferimento in tema <strong>di</strong> tutela e gestione <strong>di</strong> siti <strong>di</strong> interesse<br />
comunitario e della bio<strong>di</strong>versità è in continua evoluzione: la stretta interazione tra<br />
strumenti <strong>di</strong> tutela normativa internazionale, comunitaria, nazionale e regionale,<br />
lo spiccato tecnicismo della materia, la necessaria integrazione tra conoscenze<br />
giuri<strong>di</strong>che, scientifiche e tecniche sono fattori che impongono agli enti pubblici a<br />
vario titolo coinvolti un continuo sforzo <strong>di</strong> adeguamento agli sviluppi della<br />
materia.<br />
La corretta formazione specialistica del personale delle PP.AA. operanti<br />
all’interno del SIC-ZPS “Area delle Gravine” rappresenta un passaggio essenziale<br />
ai fini <strong>di</strong> una corretta gestione, salvaguar<strong>di</strong>a e valorizzazione del patrimonio<br />
naturalistico che caratterizza l’area in oggetto.<br />
L’azione proposta ha ad oggetto lo sviluppo <strong>di</strong> moduli formativi lungo un<br />
percorso teorico-pratico che coinvolga i partecipanti: nell’ascolto, assimilazione e<br />
confronto sui contenuti sviluppati in aula; nella realizzazione <strong>di</strong> lavori <strong>di</strong> gruppo<br />
tematici nel corso <strong>di</strong> ogni modulo formativo; nella realizzazione <strong>di</strong> un proprio<br />
progetto sperimentale in cui applicare quanto appreso in fase teorica.<br />
Le giornate <strong>di</strong> formazione saranno articolate secondo un percorso <strong>di</strong>dattico che<br />
prevede formazione frontale; presentazione <strong>di</strong> case stu<strong>di</strong>es, desumibili<br />
dall’esperienza italiana e <strong>di</strong> altri Paesi europei ed extra-europei, da cui desumere<br />
buone prassi applicabili al SIC-ZPS area delle Gravine; esercitazioni;<br />
elaborazione <strong>di</strong> proposte progettuali <strong>di</strong>rette a inserire gli enti a vari titolo<br />
coinvolti nella gestione del SIS-ZPS in networks nazionali e internazionali <strong>di</strong>retti<br />
alla salvaguar<strong>di</strong>a e alla conservazione della bio<strong>di</strong>versità e degli habitat <strong>di</strong><br />
227
interesse naturalistico.<br />
In<strong>di</strong>catori <strong>di</strong> stato<br />
Finalità dell’azione<br />
Numero <strong>di</strong> programmi <strong>di</strong> educazione ambientale finanziati. N. <strong>di</strong> materiale<br />
informativo e <strong>di</strong>vulgativo prodotto. N. <strong>di</strong> eventi pubblici organizzati.<br />
Assicurare la formazione specialistica e l’aggiornamento in materia <strong>di</strong> tutela<br />
normativa ambientale del personale degli enti pubblici e delle associazioni<br />
ambientaliste interessate, agevolarne la adesione a networks nazionali e<br />
internazionali tra enti variamente coinvolti nella gestione e nella salvaguar<strong>di</strong>a<br />
della bio<strong>di</strong>versità, delle specie floro-faunistiche e degli habitat, contribuire ad una<br />
gestione ottimale del patrimonio naturalistico proprio del SIC-ZPS “Area delle<br />
Gravine” .<br />
Descrizione dell’azione e<br />
programma operativo<br />
Verifica dello<br />
stato <strong>di</strong> attuazione/<br />
avanzamento dell’azione<br />
Progettazione <strong>di</strong> percorsi formativi tematici<br />
Produzione <strong>di</strong> materiale <strong>di</strong>dattico sugli strumenti <strong>di</strong> tutela normativa ambientali<br />
applicabili al SIC-ZPS “Area delle Gravine”;<br />
Realizzazione <strong>di</strong> eventi pubblici sul tema della conservazione e delle minacce che<br />
gravano sull’area;<br />
Creazione <strong>di</strong> un centro specialistico <strong>di</strong> formazione in materia ambientale.<br />
Progettazione e elaborazione <strong>di</strong> materiali <strong>di</strong>dattici.<br />
Realizzazione <strong>di</strong> percorsi formativi e <strong>di</strong> specializzazione<br />
Organizzazione <strong>di</strong> seminari e convegni<br />
Descrizione dei risultati<br />
attesi<br />
Miglioramento delle conoscenze specialistiche del personale delle PP.AA.<br />
interessate in materia <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto ambientale, con particolare riferimento alla tutela<br />
normativa e alla gestione del SIC-ZPS Area delle Gravine.<br />
Interessi<br />
coinvolti<br />
economici<br />
Pubbliche Amministrazioni.<br />
Soggetti competenti<br />
Priorità dell’azione<br />
Tempi<br />
e stima dei costi<br />
Regione Puglia, <strong>Provincia</strong> <strong>di</strong> <strong>Taranto</strong>, comunità Montane, Comuni, Enti Gestori,<br />
ONG ambientaliste.<br />
BASSA<br />
Durata 3 anni. Costo complessivo 300.000,00 €.<br />
Riferimenti<br />
programmatici e linee <strong>di</strong><br />
finanziamento<br />
Nuova programmazione POR 2007-2013<br />
228
Riferimenti tecnici e<br />
criteri progettuali<br />
229
ALLEGATI<br />
Allegato A : Tabelle fitosociologiche<br />
Allegato B : Acronimi delle forme biologiche, delle forme <strong>di</strong> crescita e dei<br />
tipi corologici<br />
Allegato C : Elenco della cartografia del sito SIC/ZPS “Area delle Gravine”<br />
allegata al Piano <strong>di</strong> Gestione<br />
230
Allegato A : Tabelle fitosociologiche<br />
Brachypo<strong>di</strong>etalia <strong>di</strong>stachyi<br />
F<br />
O<br />
R<br />
M<br />
A<br />
B<br />
I<br />
O<br />
L<br />
O<br />
G<br />
I<br />
C<br />
A<br />
F<br />
O<br />
R<br />
M<br />
A<br />
T Numero rilievo 1 2<br />
I<br />
Altitu<strong>di</strong>ne (m s. l. m.) 340 335<br />
P<br />
O Esposizione (°) - -<br />
D C Inclinazione (°) 5 3<br />
I O<br />
Superficie (m 2 ) 20 20<br />
R<br />
C O Pietrosità (%) 15 15<br />
R L Rocciosità (%) 5 10<br />
E O<br />
Copertura totale (%) 100 95<br />
S G<br />
C I<br />
I C Altezza me<strong>di</strong>a strato erbaceo (cm) 35 30<br />
T O<br />
A<br />
Car. Ord. Brachypo<strong>di</strong>etalia <strong>di</strong>stachyi<br />
T Sc Mst Brachypo<strong>di</strong>um <strong>di</strong>stachyum (L.) Beauv. 4 3<br />
T Sc Me Coronilla scorpioides (L.) Koch 3 2<br />
T Sc Ms Crupina crupinastrum (Moris) Vis. 1 1<br />
T Sc Ms Polygala monspeliaca L. 1 1<br />
T Rp Me Trifolium scabrum L. 1 +<br />
T Sc Ms Ammoides pusilla (Brot.) Beistr. + +<br />
T Sc Ms Sideritis romana L. + +<br />
Ch Sf Ms Ajuga iva (L.) Schreber . +<br />
Car Cl. Tuberarietea guttatae<br />
T Sc Ms Linum strictum L. ssp. strictum 1 1<br />
T Sc Tmpw Trifolium campestre Schreber 1 1<br />
T Sc Me Bellar<strong>di</strong>a trixago (L.) All. 1 1<br />
T Sc Me Cynosurus echinatus L. + 1<br />
T Sc Me Helianthemum salicifolium (L.) Miller + +<br />
T Sc Me Scorpiurus muricatus L. + +<br />
T Sc Me Me<strong>di</strong>cago minima (L.) Bertol. + .<br />
Trasgr. Lygeo-Stipetea<br />
H Sc Me Eryngium campestre L. 1 +<br />
H Cs Ms Dactylis hispanica Roth + +<br />
Ch Sf Ms Teucrium capitatum (L.) Arcang. + +<br />
H Sc Me Convolvulus cantabrica L. + +<br />
G Rz Ms Asphodelus ramosus L. + +<br />
H Bn I Centaurea deusta Ten. + +<br />
231
Trasgr. Stellarietea me<strong>di</strong>ae<br />
T Sc Mst Aegilops geniculata Roth 1 1<br />
T Sc Met Dasypirum villosum (L.) Borbas 1 +<br />
T Sc Me Avena barbata Potter + +<br />
T Rp Me Anagallis arvensis L. + +<br />
T Sc Me Nigella arvensis L. + .<br />
Altre specie<br />
H Sc Ese Potentilla detommasii Ten. 1 +<br />
H Sc Ms Carlina corymbosa L. 1 +<br />
G Bl I Allium apulum Brullo, Guglielmo, Pavone & Salmeri + 1<br />
H Bn Me Pallenis spinosa (L.) Cass. + +<br />
H Sc Msne Stachys salviifolia Ten. + +<br />
G Rz Mne Asphodeline liburnica (Scop.) Rchb. + +<br />
H Sc Mne Cardopatum corymbosum (L.) Pers. + +<br />
- - - Scabiosa sp. + +<br />
H Rs Ec Carlina acaule L. + .<br />
Numero specie 36 34<br />
Località<br />
Gravina <strong>di</strong> Laterza<br />
Gli acronimi delle forme biologiche, delle forme <strong>di</strong> crescita e dei tipi corologici sono<br />
riportati in Allegato B<br />
232
Campanulion versicoloris<br />
F<br />
O<br />
R<br />
M<br />
A<br />
B<br />
I<br />
O<br />
L<br />
O<br />
G<br />
I<br />
C<br />
A<br />
F<br />
O<br />
R<br />
M<br />
A<br />
D<br />
T<br />
Numero rilievo 1 2 3 4<br />
I Altitu<strong>di</strong>ne (m s. l. m.) - - - -<br />
P<br />
O Esposizione (°) - - - -<br />
C Inclinazione (°) 80 90 80 70<br />
I O Superficie (m 2 ) 15 20 20 20<br />
Pietrosità (%) - - - -<br />
Rocciosità (%) 80 90 90 90<br />
Copertura totale (%) 15 15 20 15<br />
C<br />
R<br />
E<br />
S<br />
C<br />
I<br />
T<br />
A<br />
R<br />
O<br />
L<br />
O<br />
G<br />
I<br />
C<br />
O<br />
Altezza me<strong>di</strong>a strato erbaceo (cm) 30 25 25 20<br />
Ch Sf Mmne Aurinia saxatilis L. . . + .<br />
Car. All. Campanulion versicoloris & Ord. Onosmetalia frutescentis<br />
H Sc Omne Campanula versicolor Hawkins 1 2 1 +<br />
H Sc Mes Carum multiflorum (S. et S.) Boiss. + + + +<br />
H Bn Mm Scrophularia lucida . + + .<br />
Car Cl. Asplenietea trichomanis<br />
Ch Fr Ms Teucrium flavum L. + + + .<br />
G Bl Ms Umbilicus horizontalis (Guss.) DC + . . .<br />
H Sc Msdw Athamantha sicula L. . + . .<br />
H Rs Eat Ceterach officinarum DC. . + . .<br />
H Rs Ct Asplenium trichomanes (L.) . + . .<br />
Altre specie<br />
H Sc - Silene vulgaris (Moench) Garcke + + + .<br />
H Cs Met Melica ciliata L. + . + .<br />
Ch Sf Ms Micromeria graeca (L.) Bentham + . + .<br />
H Sc Mm Dianthus garganicus (Ten.) Brullo . + + .<br />
Ch Sf Msdw Phagnalon rupestre (L.) DC. . + + .<br />
Ch Fr Mn Satureja cuneifolia Ten. . + . +<br />
H Bn I Centaurea deusta Ten. + . . .<br />
T Sc Me Cynosurus echinatus L. + . . .<br />
H Bn Cs Daucus carota L. + . . .<br />
NP - Msm Euphorbia dendroides L. + . . .<br />
H Bn Me Pallenis spinosa (L.) Cass. + . . .<br />
Ch Fr I Fumana scoparia Pomel . + . .<br />
Ch Fr Mw Trachelium caeruleum L. . . + .<br />
233
Numero specie 12 12 11 3<br />
Gli acronimi delle forme biologiche, delle forme <strong>di</strong> crescita e dei tipi corologici sono<br />
riportati in Allegato B<br />
Località<br />
Ril. 1 Gravina <strong>di</strong> Castellaneta<br />
Ril 2 Gravina <strong>di</strong> Laterza<br />
Ril 3 Gravina Madonna della Scala (Massafra)<br />
Ril 3 Gravina del Colombato (Massafra)<br />
234
Thymo capitati-Pinetum halepensis<br />
F<br />
O<br />
R<br />
M<br />
A<br />
B<br />
I<br />
O<br />
L<br />
O<br />
G<br />
I<br />
C<br />
A<br />
F<br />
O<br />
R<br />
M<br />
A<br />
D<br />
T<br />
Numero rilievo 3 4<br />
I Altitu<strong>di</strong>ne (m s. l. m.) 348 352<br />
P<br />
O Esposizione - -<br />
C Inclinazione (°) - -<br />
I O Superficie (m 2 ) 60 70<br />
Pietrosità (%) 10 5<br />
Rocciosità (%) - -<br />
Copertura totale (%) 85 85<br />
C<br />
R<br />
E<br />
S<br />
C<br />
I<br />
T<br />
A<br />
R<br />
O<br />
L<br />
O<br />
G<br />
I<br />
C<br />
O<br />
Altezza me<strong>di</strong>a strato arbustivo (cm) 150 130<br />
Altezza me<strong>di</strong>a strato erbaceo (cm) 50 50<br />
Copertura strato arbustivo (%) 80 80<br />
Copertura strato erbaceo (%) 40 30<br />
Car. e Diff. Ass.<br />
Ch Fr Mse Thymus capitatus (L.) Hofmgg. et Lk. 1 +<br />
Car. All. (OLEO-CERATONION SILIQUAE)<br />
P Cs Mss Pistacia lentiscus L. 4 4<br />
Ch Fr Ms Prasium majus L. + 1<br />
P Cs Ms Olea europaea L. ssp. oleaster Hoffmgg et Link + +<br />
Car. Ord. (QUERCETALIA CALLIPRINI) e Cl. (QUERCETEA ILICIS)<br />
NP - Mpe Coronilla emerus L. ssp. emeroides (Boiss. et Spruner) Hayek 2 1<br />
P Ln Ms Rubia peregrina L. 2 1<br />
H Cs Ms Stipa bromoides (L.) Doerfl. 1 1<br />
P Cs Ms Phillyrea latifolia L. + 1<br />
NP _ Ms Asparagus acutifolius L. + +<br />
P Ln Ms Lonicera implexa Aiton + +<br />
Ch Fr Me Ruscus aculeatus L. + +<br />
H Sc Me Pulicaria odora (L.) Rchb. + +<br />
P Cs Msm Daphne gni<strong>di</strong>um + +<br />
P Sc Ess Fraxinus ornus L. + +<br />
P Cs P Quercus trojana Webb. + +<br />
P Cs Me Rhamnus alaternus L. + +<br />
P Sc Ms Quercus ilex L. + .<br />
Ch Fr Me Ruscus aculeatus L. + .<br />
P Cs Me Acer monspessulanum + .<br />
P Ln Me Clematis flammula L. . +<br />
235
Altre specie<br />
G Bl Ms Allium subhirsutum L. + 1<br />
H Sc P Buglossoides purpurocaerulea (L.) Johnston + 1<br />
NP - Msw Cistus creticus L. + +<br />
P Cs Tmp Crataegus monogyna Jacq. + +<br />
H Sc Me Convolvulus cantabrica L. + +<br />
H Bn Tmp Centaurium erythraea Rafn. + +<br />
H Sc Msdw Serratula chicoracea (L.) DC. + +<br />
Ch Sf Me Teucrium chamaedrys L. + .<br />
Numero specie 27 24<br />
Località<br />
Gravina <strong>di</strong> Laterza<br />
Gli acronimi delle forme biologiche, delle forme <strong>di</strong> crescita e dei tipi corologici sono<br />
riportati in Allegato B<br />
236
Teucrio siculi-Quercetum trojanae<br />
F<br />
O<br />
R<br />
M<br />
A<br />
B<br />
I<br />
O<br />
L<br />
O<br />
G<br />
I<br />
C<br />
A<br />
F<br />
O<br />
R<br />
M<br />
A<br />
D<br />
T<br />
Numero rilievo 1 2<br />
I Altitu<strong>di</strong>ne (m s. l. m.) 357 354<br />
P<br />
O Esposizione - -<br />
C Inclinazione (°) 30 5<br />
I O Superficie (m 2 ) 100 100<br />
Pietrosità (%) 5 10<br />
Rocciosità (%) 5 5<br />
Copertura totale (%) 80 90<br />
C<br />
R<br />
E<br />
S<br />
C<br />
I<br />
T<br />
A<br />
R<br />
O<br />
L<br />
O<br />
G<br />
I<br />
C<br />
O<br />
Altezza me<strong>di</strong>a strato arboreo (m) 4 5<br />
Altezza me<strong>di</strong>a strato arbustivo (cm) 110 100<br />
Altezza me<strong>di</strong>a strato erbaceo (cm) 50 50<br />
Copertura strato arboreo (%) 70 90<br />
Copertura strato arbustivo (%) 60 50<br />
Copertura strato erbaceo (%) 70 70<br />
Car. & <strong>di</strong>ff. <strong>di</strong> ass.<br />
P Cs P Quercus trojana Webb. 4 5<br />
G Rz Mm Festuca drymeia M. et K. 1 1<br />
H Sc I Teucrium siculum Rafin. + +<br />
Car. & <strong>di</strong>ff. Suball. Carpinion orientalis Horvat 1958 & All. Lauro-Quercenion pubescentis Ubal<strong>di</strong><br />
1995<br />
P Ln Me Clematis flammula L. 2 1<br />
P Cs Esep Quercus virgiliana (Ten.) Ten. 1 1<br />
P Ln Ms Rubia peregrina L. 1 +<br />
NP - Ms Asparagus acutifolius L. + +<br />
P Cs Me Pistacia terebinthus L. + +<br />
P Cs Ms Phillyrea latifolia L. + .<br />
Car. Ord. Quercetalia pubescenti petreae Klika 1933 corr.<br />
H Sc Cb Clinopo<strong>di</strong>um vulgare L. 1 +<br />
H Cs Ess Trifolium ochroleucum Hudson + 1<br />
H Sc P Buglossoides purpurocaerulea (L.) Johnston + +<br />
Car. Cl. Querco-fagetea Br.-Bl. & Vlieger in Viegler 1937<br />
H Cs Tmp Brachypo<strong>di</strong>um sylvaticum (Hudson) Beauv. 1 1<br />
H Sc Eca Calamintha sylvatica Bromf. + 1<br />
H Sc I Echinops ritro L. ssp. siculus (Strobl) Greuter + +<br />
P Cs Msw Cytisus villosus Pourret + .<br />
H Sc Ma Oenanthe pimpinelloides L. . +<br />
237
Trasgr. Cl. Querceta-ilicis<br />
P Cs Mss Pistacia lentiscus L. 1 +<br />
Ch Fr Me Ruscus aculeatus L. + 2<br />
H Cs Ms Stipa bromoides (L.) Doerfl. 2 1<br />
Trasgr. Cl. Rhamno-Prunetea<br />
P Cs Tmp Crataegus monogyna Jacq. 1 1<br />
NP - Ecp Rosa gallica L. + 1<br />
NP - Me Rubus ulmifolius Schott + .<br />
Altre specie<br />
G Bl Ms Allium subhirsutum L. 1 +<br />
G Rz Mne Asphodeline liburnica (Scop.) Rchb. + +<br />
NP - Ms Cistus creticus L. + +<br />
Ch Sf Me Dorycnium hirsutum (L.) Ser. + +<br />
- - - Lathyrus sp. + +<br />
H Bn Me Linum bienne Miller + +<br />
Ch Sf Me Teucrium chamaedrys L. + 1<br />
- - - Carex sp. + +<br />
- - - Euphorbia sp. + +<br />
- - - Geranium sp. + +<br />
H Sc Msdw Serratula chicoracea (L.) DC. + +<br />
- - - Silene sp. + +<br />
NP - Ms Cistus monspeliensis L. + .<br />
H Cs Met Melica ciliata L. + .<br />
H Cs Ea Anthoxanthum odoratum L. . 1<br />
G Bl I Allium apulum Brullo, Guglielmo, Pavone & Salmeri +<br />
G Bl Ms Allium sardoum Moris +<br />
T Sc Me Avena barbata Potter . +<br />
Numero specie 36 36<br />
Gli acronimi delle forme biologiche, delle forme <strong>di</strong> crescita e dei tipi corologici sono riportati in<br />
Appen<strong>di</strong>ce B<br />
238
Allegato B : Acronimi delle forme biologiche, delle forme <strong>di</strong> crescita e dei<br />
tipi corologici<br />
- FORMA COROLOGICA.<br />
Ch - camefita; P - fanerofita; G - geofita; H – emicriptofita; I - idrofita; NP - nanofanerofita; T - terofita.<br />
- FORMA DI CRESCITA.<br />
Bl - bulbosa; Bn – bienne; Cs – cespitosa; Ep – epifita; Fr - fruticosa; Ln - lianosa; Nt - natante; Pr - parassita; Pv<br />
- pulvinata; Rd - ra<strong>di</strong>cante; Rp - reptante; Rs - rosulata; Rz - rizomatosa; Sc - scaposa; Sd - scandente; Sf -<br />
suffruticosa; Su - Succulenta.<br />
- TIPO COROLOGICO.<br />
A - atlantico; Aa - anfi-atlantico; Ad - anfi-adriatico; Afs - sud-africano; As - sub-atlantico; Aus - australiano;<br />
Assw - asiatico sud-occidentale; Ast - asiatico-temperato; Avv - avventizio; C - cosmopolito; Cb -<br />
circumboreale; Cbt - circumboreale-temperato; Cs – sub-cosmopolito; Clt - coltivato; Ct - cosmopolitotemperato;<br />
E - europeo; Ea - euroasiatico; Eacw - euroasiatico centro-occidentale; Eat - euroasiatico-temperato;<br />
Eaw - euroasiatico-occidentale; Ec - centro-europeo, Eca - europeo-caucasico; Ecew - centroeuropeo orientaleoccidentale;<br />
Ecp - centro-europeo pontico; Ecse – centro-europeo sud-orientale; Ecw - centro-europeo<br />
occidentale; Eew - europeo orientale-occidentale; En - nord-europeo, Es - sud-europeo, Esb - eurosiberiano; Ese<br />
- europeo sud-orientale; Esp - sud-europeo pontico; Ess - sud-europeo - sud-siberiano; Esep - europeo-pontico<br />
sud-orientale; Ew - europeo occidentale; I - endemico; Is - subendemico; Nen – neotropicale naturalizzato; Ma -<br />
me<strong>di</strong>terraneo-atlantico; Masb – me<strong>di</strong>terraneo-subatlantico; Me - eurime<strong>di</strong>terraneo; Mea - eurime<strong>di</strong>terraneoatlantico;<br />
Meas - eurime<strong>di</strong>terraneo - sub-atlantico; Mee - eurime<strong>di</strong>terraneo orientale; Men - eurime<strong>di</strong>terraneo<br />
settentrionale, Mene - eurime<strong>di</strong>terraneo nord-orientale; Mem - eurime<strong>di</strong>terraneo macaronesiano; Mep -<br />
eurime<strong>di</strong>terraneo pontico; Mes - me<strong>di</strong>terrraneo orientale; Met - eurime<strong>di</strong>terraneo turaniano; Mew -<br />
eurime<strong>di</strong>terraneo occidentale; Mm - me<strong>di</strong>terraneo-montano; Mmc - me<strong>di</strong>terraneo-macaronesiano; Mme -<br />
me<strong>di</strong>terraneo-montano orientale; Mmm - me<strong>di</strong>terraneo-macaronesiano e messicano; Mmms - me<strong>di</strong>terraneomacaronesiano<br />
meri<strong>di</strong>onale; Mmn - me<strong>di</strong>terraneo-montano settentrionale; Mmne - me<strong>di</strong>terraneo-montano nordorientale;<br />
Mms - me<strong>di</strong>terraneo-montano meri<strong>di</strong>onale; Mmsw - me<strong>di</strong>terraneo-montano sud-occidentale; Mmw -<br />
me<strong>di</strong>terraneo-montano occidentale; Mn - me<strong>di</strong>terraneo settentrionale; Mne - me<strong>di</strong>terraneo nord-orientale; Mnw -<br />
me<strong>di</strong>terraneo nord-occidentale; Mne - me<strong>di</strong>terraneo nord-orientale; Mpe - me<strong>di</strong>terraneo-pontico orientale; Ms -<br />
stenome<strong>di</strong>terraneo; Msa - stenome<strong>di</strong>terraneo-atlantico; Msd - me<strong>di</strong>terraneo meri<strong>di</strong>onale; Msde - me<strong>di</strong>terraneo<br />
sud-orientale; Msdw - me<strong>di</strong>terraneo sud-occidentale; Mse - stenome<strong>di</strong>terraneo orientale; Msm -<br />
stenome<strong>di</strong>terraneo-macaronesiano; Msn - stenome<strong>di</strong>terraneo settentrionale; Msne - stenome<strong>di</strong>terraneo nordorientale;<br />
Msnw - stenome<strong>di</strong>terraneo nord-occidentale; Mss - stenome<strong>di</strong>terraneo meri<strong>di</strong>onale; Msse -<br />
stenome<strong>di</strong>terraneo sud-orientale; Mssw - stenome<strong>di</strong>terraneo sud-occidentale; Mst - stenome<strong>di</strong>terraneo-turaniano;<br />
Msw - stenome<strong>di</strong>terraneo occidentale; Mt - me<strong>di</strong>terraneo-turaniano; Mte - me<strong>di</strong>terraneo-turaniano orientale; Mts<br />
- me<strong>di</strong>terraneo-turaniano meri<strong>di</strong>onale; Mtm - me<strong>di</strong>terraneo-turaniano meri<strong>di</strong>onale; Mw - me<strong>di</strong>terraneo<br />
occidentale; O – orofilo; Oe - orofilo europeo; Oec - orofilo centro-europeo; Oes - orofilo sud-europeo; Oese -<br />
orofilo europeo sud-orientale; Oesw - orofilo europeo sud-occidentale; Omne - orofilo me<strong>di</strong>terraneo nordorientale;<br />
Omw - orofilo me<strong>di</strong>terraneo-occidentale; Otmp - orofilo paleotemperato; P - pontico; Pn -<br />
pantropicale, T - temperato; Tmp - paleotemperato; Tmpw - paleotemperato occidentale; Tp - tropicale; Tpts -<br />
paleotemperato-subtropicale; Tpp - paleotropicale; Tps - subtropicale; Tpsn - subtropicale - nesicolo; Tpsp -<br />
paleo-subtropicale.<br />
239
Allegato C : Elenco della cartografia del sito SIC/ZPS “Area delle Gravine”<br />
allegata al Piano <strong>di</strong> Gestione<br />
TAV. 1 Inquadramento territoriale (scala 1:100.000)<br />
TAV. 1.1 Inquadramento territoriale – Versante occidentale (scala 1:25.000)<br />
TAV. 1.2 Inquadramento territoriale – Versante orientale (scala 1:25.000)<br />
TAV. 2 Carta geologica (scala 1:50.000)<br />
TAV. 3 Carta geormorfologica e idrografica (scala 1:50.000)<br />
TAV. 4 Carta dell’Uso del Suolo (scala 1:50.000)<br />
TAV. 5 Carta degli Habitat (scala 1:50.000)<br />
TAV. 5.1 Carta degli Habitat - Versante occidentale (scala 1:25.000)<br />
TAV. 5.2 Carta degli Habitat - Versante orientale (scala 1:25.000)<br />
TAV. 5.3 Carta degli Habitat - Versante occidentale Settore n. 1 (scala 1:10.000)<br />
TAV. 5.4 Carta degli Habitat - Versante occidentale Settore n. 2 (scala 1:10.000)<br />
TAV. 5.5 Carta degli Habitat - Versante occidentale Settore n. 3 (scala 1:10.000)<br />
TAV. 5.6 Carta degli Habitat - Versante occidentale Settore n. 4 (scala 1:10.000)<br />
TAV. 5.7 Carta degli Habitat - Versante occidentale Settore n. 5 (scala 1:10.000)<br />
TAV. 5.8 Carta degli Habitat - Versante orientale Settore n. 6 (scala 1:10.000)<br />
TAV. 5.9 Carta degli Habitat - Versante orientale Settore n. 7 (scala 1:10.000)<br />
TAV. 5.10 Carta degli Habitat - Versante orientale Settore n. 8-9 (scala 1:10.000)<br />
TAV. 6 Carta fitosociologica (scala 1:50.000)<br />
TAV. 6.1 Carta fitosociologica - Versante occidentale (scala 1:25.000)<br />
TAV. 6.2 Carta fitosociologica - Versante orientale (scala 1:25.000)<br />
TAV. 7 Carta floristica - reticolo 10km (specie in: allegato II e IV della<br />
Dir. Habitat; Lista rossa Nazionale e Regionale; Conv.<br />
Internaz. <strong>di</strong> Berna e Cites; Specie rare, endemiche o <strong>di</strong><br />
elavato valore biogeografico)<br />
(scala 1:50.000)<br />
TAV. 8.1<br />
Carta della <strong>di</strong>stribuzione potenziale del NIBBIO BRUNO (scala 1:125.000)<br />
TAV. 8.2 Carta della <strong>di</strong>stribuzione potenziale del NIBBIO REALE (scala 1:125.000)<br />
TAV. 8.3 Carta della <strong>di</strong>stribuzione potenziale <strong>di</strong>: AVERLA CENERINA e<br />
(scala 1:125.000)<br />
AVERLA PICCOLA<br />
TAV. 8.4<br />
TAV. 8.5<br />
TAV. 8.6<br />
TAV. 8.7<br />
Carta della <strong>di</strong>stribuzione potenziale <strong>di</strong>: CALANDRO e<br />
CALANDRA<br />
Carta della <strong>di</strong>stribuzione potenziale <strong>di</strong>: CERVONE, COLUBRO<br />
LEOPARDINO e BIACCO<br />
Carta della <strong>di</strong>stribuzione potenziale <strong>di</strong>: CALANDRELLA e<br />
OCCHIONE<br />
Carta della <strong>di</strong>stribuzione potenziale <strong>di</strong>: GECO DI KOTSCHY,<br />
LUCERTOLA CAMPESTRE, RAMARRO OCCIDENTALE<br />
(scala 1:125.000)<br />
(scala 1:125.000)<br />
(scala 1:125.000)<br />
(scala 1:125.000)<br />
240
TAV. 8.8<br />
Carta della <strong>di</strong>stribuzione potenziale <strong>di</strong>: TESTUGGINE<br />
COMUNE e ROSPO SMERALDINO<br />
(scala 1:125.000)<br />
TAV. 8.9 Carta della <strong>di</strong>stribuzione potenziale del CAPOVACCAIO (scala 1:125.000)<br />
TAV. 8.10 Carta della <strong>di</strong>stribuzione potenziale del LANARIO (scala 1:125.000)<br />
TAV. 8.11 Carta della <strong>di</strong>stribuzione potenziale del GRILLAIO (scala 1:125.000)<br />
TAV. 8.1.1 Carta della <strong>di</strong>stribuzione potenziale del NIBBIO BRUNO,<br />
NIBBIO REALE, CAPOVACCAIO E LANARIO -<br />
Versante occidentale<br />
(scala 1:25.000)<br />
TAV. 8.1.2<br />
Carta della <strong>di</strong>stribuzione potenziale del NIBBIO BRUNO,<br />
NIBBIO REALE, CAPOVACCAIO E LANARIO - Versante<br />
orientale<br />
(scala 1:25.000)<br />
TAV. 8.1.3 Carta della <strong>di</strong>stribuzione potenziale <strong>di</strong> Grillaio e Occhione -<br />
Versante occidentale<br />
(scala 1:25.000)<br />
TAV. 8.1.4 Carta della <strong>di</strong>stribuzione potenziale <strong>di</strong> Grillaio e Occhione -<br />
Versante orientale<br />
TAV. 8.12.1 Carta del Valore Faunistico dei territori naturali ed agricoli -<br />
Versante occidentale<br />
TAV. 8.12.2 Carta del Valore Faunistico dei territori naturali ed agricoli -<br />
Versante orientale<br />
(scala 1:25.000)<br />
(scala 1:25.000)<br />
(scala 1:25.000)<br />
TAV. 9.1 Carta della sovrapposizione tra SIC ZPS " Area delle Gravine"<br />
e Parco Naturale Regionale “Terra delle Gravine”<br />
(scala 1:50.000)<br />
TAV. 9.2 Aree Naturali Protette (scala 1:100.000)<br />
TAV. 10 Pianificazione regionale (PRAE- PAI) (scala 1:50.000)<br />
TAV. 10.1 Vincoli ambientali e PUTT/PAESAGGIO (scala 1:50.000)<br />
TAV. 10.2 Carta dei beni archeologici e architettonici (scala 1:50.000)<br />
TAV. 11 Carta delle principali proprietà pubbliche (scala 1:50.000)<br />
TAV. 11.1 Carta delle principali proprietà pubbliche – Versante<br />
occidentale<br />
(scala 1:25.000)<br />
TAV. 11.2 Carta delle principali proprietà pubbliche – Versante orientale (scala 1:25.000)<br />
TAV. 12 Carta del corridoio ecologico tra le due aree del SIC ZPS (scala 1:50.000)<br />
TAV. 13.1 Mosaico strumenti urbanistici – versante occidentale (scala 1:25.000)<br />
TAV. 13 .2 Mosaico strumenti urbanistici – versante orientale (scala 1:25.000)<br />
241