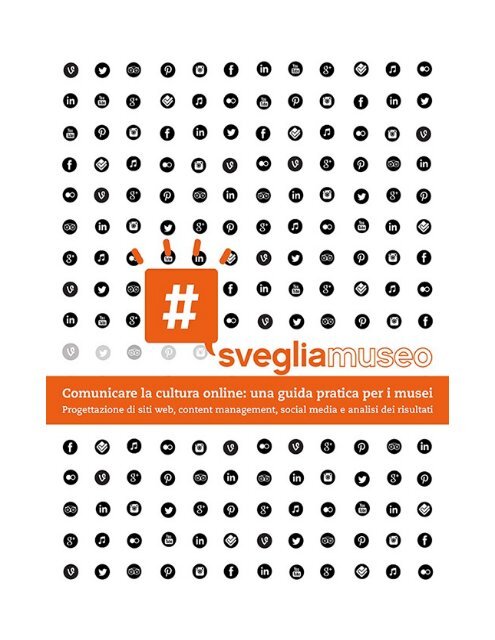Comunicare-la-cultura-online_Svegliamuseo
Comunicare-la-cultura-online_Svegliamuseo
Comunicare-la-cultura-online_Svegliamuseo
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Comunicare</strong> <strong>la</strong> <strong>cultura</strong> <strong>online</strong>: una guida pratica<br />
per i musei<br />
Progettazione di siti web, content management, social media e analisi<br />
dei risultati<br />
Francesca De Gottardo, Alessandro D’Amore, Valeria Gasparotti, Aurora Raimondi Cominesi<br />
con <strong>la</strong> col<strong>la</strong>borazione di Federico Giannini, Pietro Colel<strong>la</strong> e Astrid D’Eredità
<strong>Comunicare</strong> <strong>la</strong> <strong>cultura</strong> <strong>online</strong>: una guida pratica per i musei<br />
Progettazione di siti web, content management, social media e analisi dei risultati<br />
I edizione luglio 2014<br />
Copyleft licenza Creative Commons CC BY-NC 4.0 IT<br />
Realizzazione a cura di #svegliamuseo www.svegliamuseo.com<br />
Con <strong>la</strong> col<strong>la</strong>borazione di Tropico del Libro (editing) e Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo (comunicazione)<br />
Progetto grafico copertina di F<strong>la</strong>via Chiavaroli<br />
Sviluppo ebook di Veronica Giuffré
Indice<br />
Cover<br />
Frontespizio<br />
Copyright<br />
1. Perché questo ebook? (Francesca De Gottardo)<br />
2. La progettazione di siti web per i musei: aspetti fondamentali e proposta per uno<br />
strumento di analisi e valutazione (Federico Giannini)<br />
Introduzione<br />
Quali contenuti per un sito web museale?<br />
Progettare l’accessibilità di un sito web museale<br />
Cenni per una maggiore usabilità del sito web museale<br />
Rendere più veloci le pagine del sito attraverso accorgimenti tecnici<br />
Un sistema di valutazione per siti web museali<br />
Bibliografia<br />
3. Tecniche di comunicazione per <strong>la</strong> <strong>cultura</strong> <strong>online</strong>: storytelling e content mangement<br />
(Alessandro D’Amore)<br />
Che cos’è lo storytelling<br />
Perché lo storytelling<br />
Come si fa lo storytelling<br />
Best practices<br />
4. I social network per <strong>la</strong> <strong>cultura</strong>: quali sono, a cosa servono e come possono essere<br />
utilizzati dai musei (Francesca De Gottardo e Valeria Gasparotti, con il contributo di<br />
Astrid D’Eredità)<br />
Cosa sono i social network e perché sono importanti per i musei<br />
Bibliografia<br />
Facebook<br />
Twitter<br />
Pinterest<br />
Flickr<br />
Tumblr<br />
YouTube e video<br />
Google+<br />
Tripadvisor e Foursquare<br />
LinkedIn<br />
iTunesU<br />
5. Obiettivi e risultati: l’utilizzo degli analytics per misurare le performance <strong>online</strong><br />
(Pietro Colel<strong>la</strong>)<br />
Cos’è l’analisi dei dati<br />
Perché effettuare l’analisi dei dati <strong>online</strong><br />
Analisi qualitative e quantitative: un esempio pratico<br />
Come strutturare un processo di analisi<br />
La scelta degli strumenti<br />
Google Analytics<br />
Facebook Insights<br />
Twitter<br />
Instagram<br />
Iconsquare (in precedenza Statigr.am)<br />
API<br />
IFTTT<br />
6. <strong>Svegliamuseo</strong>: un progetto per “svegliare” i musei italiani <strong>online</strong> (Francesca De<br />
Gottardo)<br />
Antefatto<br />
Il progetto<br />
Sviluppi futuri<br />
7. Le interviste di #svegliamuseo (Alessandro D’Amore, Valeria Gasparotti, Francesca<br />
De Gottardo e Aurora Raimondi Cominesi)<br />
La community internazionale dei digital media manager museali<br />
Cosa abbiamo chiesto e perché<br />
I musei che si sono confrontati con noi fino ad ora<br />
8. Gli autori di questo ebook<br />
Note
1. Perché questo ebook?<br />
Francesca De Gottardo<br />
La storia di questo ebook è molto semplice e risale al mio primo incontro con<br />
Alessandro D’Amore, solo dopo pochi mesi dall’inizio del mio <strong>la</strong>voro per il progetto<br />
#svegliamuseo e subito prima che cominciasse a esservi coinvolto anche lui.<br />
La frase che ha dato il via al tutto è stata pronunciata da Alessandro e suonava<br />
pressappoco così: “guai a te se non pubblichi qualcosa sui risultati incredibili che state<br />
ottenendo”. Con una premessa del genere, come potevo tirarmi indietro?<br />
Il progetto #svegliamuseo è nato e cresciuto grazie al <strong>la</strong>voro di quattro persone – <strong>la</strong><br />
sottoscritta, Valeria Gasparotti, Alessandro e Aurora Raimondi Cominesi – che hanno<br />
affrontato lo spinoso argomento del<strong>la</strong> comunicazione digitale in ambito museale<br />
spinte da una grande passione e con un approccio che è maturato nel tempo, passando<br />
dal<strong>la</strong> provocazione al<strong>la</strong> riflessione, al dialogo e al<strong>la</strong> ricerca.<br />
Nel corso dei nove mesi che abbiamo dedicato all’esplorazione del mondo dei social<br />
network e del<strong>la</strong> <strong>cultura</strong> digitale in senso più ampio, abbiamo imparato molte cose e<br />
abbiamo avuto l’occasione di entrare in contatto con realtà molto diverse, dai grandi<br />
musei internazionali del calibro dello Smithsonian Institution, ai piccoli musei<br />
italiani che lottano ogni giorno con le difficoltà che tutti conosciamo, così tipiche –<br />
purtroppo – del settore <strong>cultura</strong>le, in Italia e non solo. L’esperienza che abbiamo<br />
vissuto e che stiamo ancora vivendo è sicuramente straordinaria, nel senso che esu<strong>la</strong><br />
dall’ordinario e per questo motivo crediamo valga <strong>la</strong> pena di condivider<strong>la</strong>.<br />
L’ebook che state per leggere è il risultato di una riflessione sui mondi del digitale e<br />
del<strong>la</strong> <strong>cultura</strong> che abbiamo fatto insieme ai musei, italiani e stranieri, e con alcune<br />
persone che abbiamo avuto <strong>la</strong> fortuna di incontrare nel nostro percorso: Federico<br />
Giannini, autore del blog e del<strong>la</strong> fortunata pagina Facebook “Finestre Sull’Arte”,<br />
Pietro Colel<strong>la</strong>, digital strategist duro e puro, esperto di analytics e di marketing per il<br />
settore profit, e Astrid D’Eredità, twittatrice incallita che gestisce, tra gli altri,<br />
l’account dell’Associazione Nazionale Archeologi.<br />
Un giorno è capitato che ci siamo seduti tutti intorno a un tavolo e abbiamo tirato<br />
fuori idee per scrivere qualcosa che facesse un po’ il punto del<strong>la</strong> situazione sugli<br />
argomenti ai quali ognuno di noi, a suo modo, era interessato. È così che abbiamo<br />
scelto di par<strong>la</strong>re di siti web, storytelling, social network e metodologie di analisi dei<br />
dati.
Questo ebook è il nostro contributo per approfondire <strong>la</strong> conoscenza di strumenti che<br />
sono spesso poco noti, sottovalutati, fraintesi o dati per scontati.<br />
Non pretende di essere <strong>la</strong> summa del sapere in materia, soprattutto perché siamo<br />
consapevoli che si tratta di una materia che si muove velocemente ed è, quindi,<br />
soggetta a cambiamenti repentini. Il nostro intento è contribuire a fare un po’ di<br />
chiarezza su alcuni argomenti e condividere le nostre esperienze di professionisti (e<br />
appassionati) di digitale museale.<br />
Speriamo che i musei italiani possano trovare qualche spunto interessante e che il<br />
dialogo intorno a questi temi non si esaurisca mai.
2. La progettazione di siti web per i musei: aspetti fondamentali e<br />
proposta per uno strumento di analisi e valutazione<br />
Federico Giannini<br />
Introduzione<br />
Negli ultimi anni, l’Italia, al contrario di ciò che si potrebbe pensare, ha avuto un<br />
ruolo di avanguardia nel campo del<strong>la</strong> progettazione dei siti web per i musei e, più<br />
in generale, del<strong>la</strong> definizione dei principi che determinano <strong>la</strong> qualità di un sito web<br />
<strong>cultura</strong>le.<br />
È in questo senso che operò il progetto MINERVA (Ministerial Network For<br />
Valorising Activities In Digitalisation), una rete di ministeri europei preposti al<strong>la</strong><br />
<strong>cultura</strong>, coordinati dal nostro Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che si<br />
poneva l’obiettivo “di facilitare <strong>la</strong> creazione di una visione comune nel<strong>la</strong> definizione<br />
delle azioni e dei programmi nel campo dell’accessibilità e fruibilità in rete dei beni<br />
<strong>cultura</strong>li”. Il progetto, che ha avuto il via nel 2002, ha ottenuto importanti risultati e<br />
vale <strong>la</strong> pena menzionare, tra gli altri, tre notevoli strumenti prodotti da MINERVA: il<br />
“Manuale per <strong>la</strong> qualità dei siti web pubblici <strong>cultura</strong>li”, il CMS “Museo & Web” e i<br />
“10 principi per <strong>la</strong> qualità di un sito web <strong>cultura</strong>le”.<br />
Il primo di questi strumenti è un elenco di regole che un sito web <strong>cultura</strong>le dovrebbe<br />
seguire per soddisfare al massimo grado criteri di usabilità e accessibilità. “Museo &<br />
Web” è invece un CMS (Content Management System) creato per dare ai musei,<br />
soprattutto quelli medio-piccoli, <strong>la</strong> possibilità di dotarsi di un sito web che possa<br />
soddisfare i principi di qualità che un sito web <strong>cultura</strong>le dovrebbe avere secondo le<br />
linee-guida del progetto. Infine, i 10 principi di qualità sono le dieci caratteristiche<br />
fondamentali che un sito web <strong>cultura</strong>le dovrebbe soddisfare per essere considerato un<br />
sito di qualità: il progetto ha fornito anche un sistema di valutazione che permette ai<br />
musei di verificare, attraverso schemi e domande, quanto il proprio sito web soddisfi<br />
i dieci principi.<br />
Sono trascorsi ormai diversi anni da quando questi strumenti hanno fatto <strong>la</strong> loro<br />
comparsa: il manuale per <strong>la</strong> qualità ha subito l’ultima revisione nel 2006, “Museo &<br />
Web” ha visto uscire <strong>la</strong> sua ultima versione nel 2011, mentre il sistema di verifica dei<br />
principi di qualità non viene più aggiornato dal 2006.<br />
Nel frattempo il web ha subito enormi cambiamenti: sono comparse – o si sono<br />
evolute – nuove forme di interazione tra pubblico e gestori di contenuti, abbiamo<br />
assistito all’ascesa dei social network e del loro impatto sulle modalità di<br />
comunicazione, e in un web dominato dai cosiddetti “user-generated content”, spesso
confusionari e scadenti, abbiamo visto crescere <strong>la</strong> richiesta di contenuti affidabili e di<br />
qualità, ma anche <strong>la</strong> richiesta di “contenitori” adatti a ospitare tali contenuti e a<br />
renderli il più possibile fruibili e leggibili.<br />
Scopo di questo capitolo è, quindi, quello di cercare di comprendere cosa dovrebbe<br />
contenere il sito web di un museo costruito secondo un canone di elevata qualità, e,<br />
soprattutto, come dovrebbe essere progettato il contenitore nell’ottica dei<br />
cambiamenti che il web ha subito negli ultimi tempi.<br />
Tuttavia, data <strong>la</strong> vastità dell’argomento – e pertanto senza alcuna pretesa di esaustività<br />
– ci si concentrerà in partico<strong>la</strong>re su quale dovrebbe essere <strong>la</strong> struttura di un sito web<br />
museale e sulle buone pratiche di usabilità e accessibilità, prendendo come base gli<br />
importanti risultati raggiunti dal progetto MINERVA.<br />
Si concluderà con una proposta per uno strumento di analisi e di valutazione per<br />
<strong>la</strong> qualità di un sito web <strong>cultura</strong>le, pensato e progettato secondo una visione di<br />
costante evoluzione e partecipazione, e tale da favorire l’autovalutazione da parte dei<br />
musei, così che potranno avere uno schema chiaro dei punti di forza e di debolezza<br />
dei propri siti web, in modo da intervenire con modifiche e aggiornamenti dove più<br />
opportuno.<br />
Cosa: quali contenuti per un sito web museale?<br />
Il CMS “Museo & Web”, nel<strong>la</strong> sua guida, individuava una struttura di base,<br />
consigliata per un sito web museale che intendesse essere il più completo possibile.<br />
Tale struttura, <strong>la</strong> cui ultima revisione risale al 2005, prevedeva sette aree principali:<br />
1. Il Museo: pagine dedicate all’istituzione museale (storia dell’edificio,<br />
storia del<strong>la</strong> collezione, mappa delle sale, i direttori, le ricerche,<br />
l’archivio, il museo nel territorio e nel<strong>la</strong> città) ma anche alle attività<br />
condotte dal museo (ricerca, acquisizioni, restauri, pubblicazioni,<br />
mostre ed esposizioni, didattica) e a informazioni di carattere pratico<br />
(orari di visita);<br />
2. Il Patrimonio: sezione dedicata al<strong>la</strong> collezione del museo con indici<br />
e cataloghi, model<strong>la</strong>zioni tridimensionali, database degli oggetti;<br />
3. I Percorsi: sezione in cui <strong>la</strong> collezione del museo viene presentata<br />
suddivisa per percorsi, che possono essere cronologici o tematici, ma<br />
anche pensati in re<strong>la</strong>zione al pubblico (per esempio, percorsi specifici
per i bambini);<br />
4. I Servizi: pagine dedicate ai servizi offerti dall’istituto museale<br />
(bookshop, caffetterie, archivi, sale attrezzate, informazioni per<br />
prenotazioni);<br />
5. Risorse in rete: una pagina con link utili;<br />
6. La comunità: uno spazio pensato per accogliere newsletter, forum di<br />
discussione, iniziative di associativismo legate al patrimonio del museo;<br />
7. Novità: una sezione con le ultime notizie.<br />
Oltre a queste macro-aree e al<strong>la</strong> home page, ovviamente, “Museo & Web”<br />
individuava un selettore per il multilinguismo, degli strumenti di metanavigazione<br />
(motore di ricerca interno, mappa del sito, guida, pagina dei contatti, moduli di<br />
feedback) e un piè di pagina (footer) contenente informazioni sui copyright,<br />
disc<strong>la</strong>imer, date di revisione e aggiornamento, url del<strong>la</strong> pagina.<br />
Sono passati nove anni dall’e<strong>la</strong>borazione di questo schema e molte delle informazioni<br />
in esso contenute sono tuttora valide; tuttavia, analizzando molti siti web museali e<br />
prendendo come punto di riferimento per questa analisi i siti web dei cinque musei<br />
più visitati del mondo secondo il rapporto 2012 di “Il Giornale dell’Arte” e “The Art<br />
Newspaper” (che sono Louvre, Metropolitan Museum of Art, British Museum, Tate<br />
Modern Gallery e National Gallery di Londra), notiamo che questo schema ha subito<br />
una forte evoluzione.<br />
Per comprendere i motivi che stanno al<strong>la</strong> base di tale evoluzione è necessario<br />
comprendere il comportamento degli utenti sui siti web dei musei: a tal proposito,<br />
giungono in aiuto i sondaggi condotti per valutare le azioni degli utenti e per capire le<br />
ragioni che li spingono a navigare sui siti web dei musei.<br />
Prendiamo, a titolo di esempio, tre sondaggi: uno condotto nel 2010, uno tra <strong>la</strong> fine<br />
del 2011 e gli inizi del 2012 e l’ultimo tra <strong>la</strong> fine del 2012 e gli inizi del 2013,<br />
rispettivamente dall’Agenzia Danese per il Patrimonio (un ente che dipende dal<br />
Ministero dei Beni Culturali del<strong>la</strong> Danimarca e che si occupa, tra le altre cose, dei<br />
musei statali danesi: ha condotto il sondaggio sul sito del Museo ARKEN di<br />
Copenaghen e sul sito dei musei del<strong>la</strong> città di Fredericia), dall’Indianapolis Museum<br />
of Art e dal British Museum di Londra. Una domanda che ha accomunato tutte le tre<br />
ricerche è stata: “per quale motivo navighi sul sito web del museo?” (e quindi: “quale<br />
tipo di informazioni cerchi principalmente sul sito di un museo?”). In tutti i casi, <strong>la</strong>
isposta preponderante (80% Agenzia Danese per il Patrimonio, 50% IMA, 39%<br />
British Museum: <strong>la</strong> percentuale così alta nel primo caso è dovuta al fatto che quello<br />
danese è, dei tre, l’unico sondaggio che prevedeva una risposta multip<strong>la</strong> al<strong>la</strong> domanda)<br />
è stata: “per preparare <strong>la</strong> visita”, ovvero “cerco informazioni pratiche che mi aiutino a<br />
preparare <strong>la</strong> mia visita”.<br />
Uno degli scopi principali degli utenti, nonché lo scopo principale per gli utenti dei<br />
siti web dei musei esaminati, è quindi quello di cercare informazioni per poi visitare<br />
di persona il museo.<br />
Si comprende quindi l’odierna scelta di moltissimi musei – compresi i cinque più<br />
visitati al mondo – di dedicare un’apposita sezione del sito al<strong>la</strong> visita, e in alcuni casi<br />
(Louvre, Metropolitan, British) si tratta anche del<strong>la</strong> prima voce del menù.<br />
Dunque, cosa dovrebbe includere una voce sul<strong>la</strong> visita (o sulle “Informazioni<br />
pratiche”, come viene chiamata dal Louvre) per essere il più esauriente possibile?<br />
Un’analisi dei principali siti web fa emergere alcune informazioni fondamentali:<br />
– Gli orari e i calendari di apertura;<br />
– Informazioni sui costi dei biglietti, nonché su eventuali riduzioni<br />
(gruppi, sco<strong>la</strong>resche, studenti) e convenzioni con enti, associazioni,<br />
ristoranti, attività commerciali e quant’altro;<br />
– Recapiti (numeri di telefono, email) per chiedere informazioni (o<br />
eventualmente form da compi<strong>la</strong>re);<br />
– Informazioni sul<strong>la</strong> raggiungibilità (mezzi di trasporto per recarsi al<br />
museo, sistemi di mappe che consentano agli utenti di calco<strong>la</strong>re il<br />
percorso da una determinata posizione.... );<br />
– Informazioni dedicate agli utenti diversamente abili (percorsi<br />
riservati, parcheggi riservati, modalità di visita);<br />
– Informazioni legate al<strong>la</strong> visita (presenza di audioguide a noleggio,<br />
informazioni sulle visite guidate);<br />
– Rego<strong>la</strong>mento del museo o elenco di divieti.<br />
A questo punto è possibile aggiungere <strong>la</strong> facoltà, data da molti musei, di acquistare i<br />
biglietti via web o prenotarli per telefono, nonché le FAQ che raccolgono le risposte
alle più frequenti domande rivolte dagli utenti allo staff del museo.<br />
La seconda tipologia di utenti è, invece, costituita da quelli che cercano<br />
informazioni, che, se sommati, diventano preponderanti nel caso del British Museum<br />
(62% Agenzia Danese, 16% per ragioni professionali + 21% per interesse personale<br />
IMA, 20% per interesse personale + 29% per ragioni professionali British Museum).<br />
Come suggerito anche da “Museo & Web”, <strong>la</strong> prassi è però quel<strong>la</strong> di dividere le<br />
informazioni che riguardano il museo in quanto istituto da quelle che riguardano il<br />
suo patrimonio (anche se, come si è già visto, rispetto a quanto suggerito da “Museo<br />
& Web” è meglio dedicare una parte a sé sia alle informazioni sul<strong>la</strong> visita sia, come si<br />
vedrà tra poco, ad alcune attività come le esposizioni e le attività educative).<br />
La sezione sul museo in quanto istituto andrà quindi a includere:<br />
– Notizie storiche sul museo, sia per ciò che riguarda <strong>la</strong> formazione<br />
del<strong>la</strong> sua collezione, sia sul<strong>la</strong> sede che <strong>la</strong> ospita (in questo caso, si<br />
potranno aggiungere anche notizie di carattere artistico e architettonico<br />
sul pa<strong>la</strong>zzo in cui ha sede il museo);<br />
– Descrizioni delle sale (ci sono musei che decidono di inserire solo le<br />
descrizioni delle sale principali, mentre musei come il British e il<br />
Metropolitan includono informazioni e descrizioni su ogni singo<strong>la</strong> sa<strong>la</strong><br />
del museo), con eventuale presenza di una p<strong>la</strong>nimetria navigabile che<br />
permetta agli utenti di raggiungere <strong>la</strong> sa<strong>la</strong> desiderata in modo facile e<br />
intuitivo, e con eventuali ricostruzioni a 360° di tutte le sale o di un<br />
numero significativo di esse (e magari anche dei principali oggetti che<br />
le sale ospitano);<br />
– Informazioni sulle attività di ricerca condotte dal museo, tenendo<br />
sempre presente il fatto che il museo non è solo luogo dove si fa<br />
formazione ed educazione, ma anche luogo dove si fa ricerca;<br />
– Informazioni sullo staff del museo (organigramma, direzione,<br />
ricercatori... );<br />
– Pagine dedicate ai mecenati del museo e alle attività di supporto;<br />
– Una sezione multimediale con gallerie fotografiche, video, audio<br />
podcast. Molti musei, tuttavia, decidono di creare una sezione a sé
stante: un esempio è il sito del<strong>la</strong> Reggia di Venaria Reale che ha una<br />
sezione multimediale che nel menù fa voce a sé, mentre il Louvre<br />
include <strong>la</strong> sua “mediateca” in una sezione dedicata in modo specifico<br />
al<strong>la</strong> visita, in quanto il museo francese ha deciso di condurre<br />
un’ulteriore separazione tra informazioni di carattere più spiccatamente<br />
“pragmatico”, come raggiungibilità e costi dei biglietti, e informazioni<br />
sul<strong>la</strong> visita, ovvero presenza di audioguide, percorsi, visite guidate;<br />
– Una sezione “<strong>la</strong>vora con noi” con tutte le posizioni aperte (meglio se<br />
con possibilità di candidatura diretta) ed eventuali form per<br />
autocandidatura.<br />
Riguardo, invece, <strong>la</strong> sezione sul patrimonio, potrà essere composta da:<br />
– Informazioni sui singoli oggetti, spesso presenti in un’apposita<br />
sezione di ricerca. Molti musei decidono di includerli anche nelle<br />
descrizioni delle sale: non di rado però alcuni musei, come Pa<strong>la</strong>zzo<br />
Ducale a Venezia, inseriscono gli oggetti del<strong>la</strong> collezione in database<br />
separati (benché sarebbe auspicabile che il database fosse integrato nel<br />
sito) o adottano approcci misti (come gli Uffizi che integrano nel sito<br />
descrizioni per un pubblico ampio e immagini, e inseriscono invece in<br />
un database separato le informazioni riservate agli specialisti come<br />
passaggi di proprietà, numeri di inventario e quant’altro);<br />
– Un motore di ricerca interno per opere e sale, meglio se con<br />
specifiche avanzate (ricerca per autore, per tipo di oggetto, per<br />
datazione... );<br />
– Percorsi di visita o di ricerca, che potranno essere cronologici,<br />
tematici su un argomento specifico, o rivolti a uno specifico pubblico<br />
(percorsi per i bambini) oppure ancora, tagliati su alcune precise<br />
esigenze del pubblico (il British, per esempio, propone percorsi per “chi<br />
ha poco tempo”);<br />
– Notizie biografiche sugli artisti o sui personaggi legati al museo;<br />
– Un glossario.
Un’ulteriore tendenza comune ai siti di tutti i principali musei mondiali – compresi i<br />
cinque più visitati – è quel<strong>la</strong> di dedicare un’apposita sezione agli eventi e alle<br />
mostre, che spesso sono dotate di propri mini-siti, e di inserire addirittura nel<strong>la</strong><br />
home page gli eventi o le mostre principali. Questa tendenza risponde a uno dei<br />
principali utilizzi del<strong>la</strong> rete da parte del pubblico, dei musei e non, ovvero quello di<br />
informarsi sulle ultime novità. Senza dimenticare poi che inserire le notizie sulle<br />
mostre in home page, magari con grandi fotografie, è una pratica che stimo<strong>la</strong> <strong>la</strong><br />
curiosità del pubblico che sarà più portato a cercare maggiori informazioni e a<br />
pianificare una visita. Vale <strong>la</strong> pena evidenziare che esiste una buona percentuale di<br />
utenti che capita sui siti web dei musei attraverso una navigazione casuale senza<br />
cercare alcunché di specifico: in riferimento ai sondaggi citati sopra, si tratta di un<br />
10% per l’IMA, e un 10% anche per il British.<br />
La pagina delle mostre e degli eventi potrà essere dotata di un calendario che<br />
permetterà agli utenti di cercare gli eventi specifici per un dato giorno dell’anno, e di<br />
una sezione dedicata alle mostre passate: evitare di cancel<strong>la</strong>re le informazioni sulle<br />
mostre passate è un modo di perseguire le finalità didattiche ed educative del<br />
museo, oltre che di prolungare <strong>la</strong> vita delle stesse esposizioni, facendo sì che gli<br />
utenti possano continuare a raccogliere informazioni su una mostra anche dopo che si<br />
è chiusa.<br />
Verrà inoltre data rilevanza al<strong>la</strong> sezione delle attività didattiche, che rappresentano<br />
un punto focale delle attività del museo, in quanto potremmo definirle, in termini<br />
molto semplici, come “tramite” tra le attività scientifiche del museo stesso e il<br />
pubblico: dato che spesso si pensa alle attività didattiche come a un qualcosa che si<br />
rivolge prettamente a un pubblico infantile, sarà cura del sito web distinguere tra le<br />
attività rivolte agli adulti e quelle invece rivolte ai bambini, che sul sito web del<br />
museo magari potranno anche beneficiare di applicazioni e giochi didattici (dei<br />
cinque musei più visitati del mondo, quelli che sul loro sito mettono a disposizione<br />
giochi e applicazioni sono il Metropolitan, il British e <strong>la</strong> Tate Modern). Un’ulteriore<br />
sezione potrà invece testimoniare, con resoconti e fotografie, le attività didattiche che<br />
sono state eseguite in passato: diversi musei scelgono di offrire questo tipo di<br />
testimonianza tramite i loro blog.<br />
Fondamentale sarà infatti anche l’interazione: diversi musei hanno realizzato sui loro<br />
siti dei blog, il più delle volte divulgativi, tramite i quali il pubblico viene informato<br />
su molti aspetti del<strong>la</strong> vita del museo, come per esempio:<br />
– Le attività scientifiche;<br />
– Gli oggetti delle collezioni;
– Le attività didattiche;<br />
– Gli eventi che si tengono presso il museo;<br />
– Approfondimenti sul territorio.<br />
Alcuni musei, come il British, hanno un unico blog per tutti gli aspetti del museo,<br />
mentre altri, come il Metropolitan, hanno scelto di aprire più blog, ognuno dedicato a<br />
un argomento o rivolto a un pubblico specifico (il Metropolitan ha, per esempio, un<br />
blog dedicato ai teenager).<br />
Il blog offrirà <strong>la</strong> possibilità di commentare gli articoli, permettendo quindi un<br />
dialogo con il pubblico, che potrà essere ulteriormente stimo<strong>la</strong>to dal<strong>la</strong> presenza di un<br />
forum di discussione.<br />
Quel<strong>la</strong> di offrire un forum è una pratica meno diffusa: l’unico museo, tra i primi dieci<br />
più visitati al mondo, a dare questa possibilità sul proprio sito è il Natural History<br />
Museum di Londra.<br />
Non bisognerà poi dimenticare di inserire negli articoli, nelle pagine istituzionali,<br />
nelle pagine del<strong>la</strong> collezione e un po’ in tutto il sito i tasti per condividere i<br />
contenuti sui social network, ormai sempre più indispensabili per <strong>la</strong><br />
comunicazione dei musei.<br />
L’interazione rappresenta il punto debole dei siti web dei musei italiani: dei dieci più<br />
visitati, solo il Museo Nazionale del Cinema di Torino ha un blog (peraltro non<br />
integrato nel sito web), e solo quattro – Pa<strong>la</strong>zzo Ducale di Venezia, Museo Nazionale<br />
di Castel Sant’Angelo, Reggia di Venaria Reale, Museo Nazionale del Cinema –<br />
offrono nel proprio sito web <strong>la</strong> possibilità di condividere i contenuti sui social<br />
network.<br />
Infine, come suggerito da “Museo & Web”, <strong>la</strong> sezione dei servizi conterrà<br />
informazioni sui principali servizi offerti dal museo: bookshop, archivi, caffetterie e<br />
ristoranti (magari con fotografie e menù), informazioni su possibilità di organizzare<br />
eventi nei musei.<br />
Molti musei, inoltre, hanno dotato il loro sito web di un portale e-commerce,<br />
integrato o parallelo, in cui mettono in vendita <strong>la</strong> merce acquistabile anche presso il<br />
museo stesso.<br />
Come: progettare l’accessibilità di un sito web museale<br />
Il W3C (World Wide Web Consortium), ovvero <strong>la</strong> ONG che si occupa di sviluppare gli
standard internazionali in fatto di web, definisce l’accessibilità come “<strong>la</strong> capacità<br />
di un sito web di essere acceduto efficacemente al<strong>la</strong> sua interfaccia e al suo contenuto<br />
da utenti diversi in differenti contesti”, e aggiunge che “rendere un sito web<br />
accessibile significa permettere l’accesso all’informazione contenuta nel sito anche a<br />
persone con disabilità fisiche di diverso tipo e a chi dispone di strumenti hardware e<br />
software limitati”.<br />
Si comprende quindi l’importanza dell’accessibilità: una pratica volta a consentire<br />
<strong>la</strong> consultazione completa di un sito web anche agli utenti diversamente abili come<br />
non vedenti, non udenti, ipovedenti, persone affette da disabilità che impediscono<br />
una piena possibilità di utilizzo di mouse e tastiera, persone affette da disabilità<br />
cognitive, ma<strong>la</strong>ti di epilessia fotosensibile. Queste persone potrebbero non avere<br />
pieno accesso alle risorse disponibili sul web e pertanto navigano in rete con<br />
strumenti diversi da quelli a cui noi siamo abituati.<br />
Ma l’accessibilità non riguarda solo i diversamente abili: può capitare che, per diversi<br />
motivi, una parte del<strong>la</strong> nostra utenza navighi sul nostro sito web con browser datati, o<br />
con funzionalità disabilitate. Una programmazione in chiave accessibile deve tener<br />
conto anche di queste variabili, anche se sarà opportuno, nel valutare le versioni<br />
accessibili rivolte a chi è dotato di “strumenti hardware e software limitati”,<br />
verificare le statistiche di accesso del sito web per organizzare degli interventi mirati.<br />
Lo stesso W3C, nel 1997, ha <strong>la</strong>nciato <strong>la</strong> WAI (Web Accessibility Initiative), un<br />
programma volto a definire le buone pratiche di accessibilità per i siti web, e in tal<br />
senso <strong>la</strong> WAI ha raggiunto, tra i vari risultati, l’e<strong>la</strong>borazione delle WCAG (Web<br />
Content Accessibility Guidelines), ovvero le linee-guida per l’accessibilità, ri<strong>la</strong>sciate in<br />
una prima versione 1.0 nel 1999 e nel<strong>la</strong> loro seconda versione 2.0, diventata una W3C<br />
Reccomendation, nel 2008.<br />
In Italia, l’accessibilità è stata oggetto del<strong>la</strong> cosiddetta “Legge Stanca” (Legge n. 4 del<br />
9 gennaio 2004), che ha introdotto l’obbligo, per i siti pubblici o di interesse pubblico,<br />
di rispettare i criteri e i principi per l’accessibilità previsti dal Decreto Ministeriale 8<br />
luglio 2005 (e successive modifiche), ovvero i cosiddetti “Requisiti tecnici e i diversi<br />
livelli per l’accessibilità agli strumenti informatici”. Il decreto, in partico<strong>la</strong>re, indica<br />
22 requisiti (aggiornati e ridotti a 12 con il D.M. del Ministero dell’Istruzione,<br />
dell’Università e del<strong>la</strong> Ricerca del 20 marzo 2013, ma di fatto estesi attraverso i<br />
cosiddetti “punti di controllo”) che devono essere soddisfatti onde poter garantire<br />
l’accessibilità del sito web. Oltre a ciò, compito delle pubbliche amministrazioni è<br />
anche quello di formare e aggiornare in modo costante il personale che si occupa<br />
del<strong>la</strong> manutenzione del sito, fare in modo che non sussistano forme di<br />
discriminazione tra dipendenti abili e dipendenti diversamente abili, coinvolgere un<br />
pubblico diversamente abile nelle operazioni di verifica di accessibilità dei siti web.<br />
Risulta, quindi, evidente che per i musei che dipendono da pubbliche amministrazioni
garantire piena accessibilità al proprio sito web non è solo una buona pratica, ma è<br />
anche un obbligo.<br />
Benché <strong>la</strong> presente analisi non abbia lo scopo di par<strong>la</strong>re in modo esauriente di tutti i<br />
temi legati all’accessibilità, si ritiene necessario fornire una serie di indicazioni<br />
fondamentali per far sì che un museo riesca a progettare un sito web in ottemperanza<br />
ai requisiti del D.M. 20 marzo 2013. Nell’elenco che segue, saranno indicati tra<br />
parentesi il numero del requisito che <strong>la</strong> pratica indicata contribuisce a soddisfare e il<br />
numero del criterio di successo WCAG 2.0 corrispondente:<br />
– Presenza dell’attributo “alt” delle immagini (soddisfa il requisito<br />
1.1 del D.M. 20 marzo 2013 e il criterio di successo WCAG 2.0 1.1.1).<br />
“alt” è l’abbreviazione di “alternative”, e indica l’alternativa testuale da<br />
utilizzare per descrivere le immagini per chi non le può vedere (utenti<br />
non vedenti, o utenti che utilizzano browser testuali). Bisogna cercare di<br />
essere piuttosto descrittivi, o comunque evitare di <strong>la</strong>sciare vuoto<br />
l’attributo (tale pratica è concessa esclusivamente per le immagini di<br />
decorazione, che devono essere ignorate dagli screen reader, ovvero i<br />
programmi che leggono una pagina web per un non vedente, e dai<br />
browser testuali). Non è inoltre consentito utilizzare simboli grafici<br />
privi di testo (o senza alternative testuali) per veico<strong>la</strong>re informazioni<br />
(3.3 D.M., WCAG 2.0 1.3.3).<br />
– Presenza di alternative testuali per elementi multimediali (1.1,<br />
2.1, 2.2, 2.3, 2.4 D.M., WCAG 2.0. 1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4,<br />
1.2.5). In caso di presenza di video o podcast audio, sarà bene fornire<br />
sempre dei sottotitoli e una descrizione esauriente, o un testo<br />
alternativo (alcuni musei presentano anche <strong>la</strong> trascrizione di molti video<br />
e podcast audio: è il caso, per esempio, del<strong>la</strong> National Gallery di<br />
Londra).<br />
– Separazione del<strong>la</strong> grafica dai contenuti (3.1 D.M., WCAG 2.0<br />
1.3.1). Un buon sito web deve utilizzare i fogli di stile (CSS, Cascading<br />
Style Sheets) per separare le informazioni sul<strong>la</strong> grafica del sito dai<br />
contenuti.<br />
– Informazioni, corre<strong>la</strong>zioni e struttura fruibili anche in mancanza<br />
di fogli di stile (3.1 D.M., WCAG 2.0 1.3.1). Diversi browser danno <strong>la</strong><br />
possibilità di disabilitare i fogli di stile: le corre<strong>la</strong>zioni tra i contenuti
devono rimanere fruibili anche quando i fogli di stile vengono<br />
disabilitati dagli utenti.<br />
– Presenza di un <strong>la</strong>yout tableless (3.1, 3.2 D.M., WCAG 2.0 1.3.1,<br />
1.3.2). È del tutto sconsigliata <strong>la</strong> pratica di utilizzare tabelle per<br />
impaginare il contenuto. Le tabelle devono contenere esclusivamente<br />
dati ed essere utilizzate per lo scopo per il quale sono state concepite.<br />
– Presenza di marcatori in caso di elenchi (3.1 D.M., WCAG 2.0<br />
1.3.1). Gli elenchi devono essere marcati con le apposite etichette<br />
HTML (, , ).<br />
– Definizione del<strong>la</strong> corretta sequenza di lettura (3.2 D.M., WCAG<br />
2.0 1.3.2). I contenuti testuali devono essere presentati in una forma<br />
coerente (per esempio, non si devono utilizzare tabelle o spazi bianchi<br />
per impaginare testi).<br />
– Evitare di basare le informazioni solo sul colore (4.1 D.M.,<br />
WCAG 2.0 1.4.1). Gli utenti daltonici potrebbero avere difficoltà a<br />
percepire informazioni basate solo sul colore (per esempio, link con<br />
poco contrasto rispetto al testo, oppure non sottolineati). È quindi bene<br />
fare in modo che il colore non sia l’unico metodo per distinguere<br />
informazioni (o quanto meno è bene usare contrasti decisi: si<br />
raccomanda un contrasto minimo di 3:1 tra il testo che veico<strong>la</strong><br />
informazioni e il testo circostante).<br />
– Suono e riproduzione control<strong>la</strong>bile in elementi multimediali (4.2<br />
D.M., WCAG 2.0 1.4.2). I p<strong>la</strong>yer di video e audio devono mettere<br />
l’utente in grado di poter fermare, mettere in pausa, mandare avanti e<br />
indietro <strong>la</strong> riproduzione e control<strong>la</strong>re il volume.<br />
– Utilizzare un adeguato contrasto cromatico tra testo e sfondo (4.3<br />
D.M., WCAG 2.0 1.4.3). Si raccomanda un contrasto minimo di 4,5:1<br />
tra lo sfondo e il testo (che può scendere a 3:1 in caso di font a 18 pixel<br />
– o 14 pixel e grassetto – e può essere trascurato nei testi di pura<br />
decorazione).<br />
– Testo ridimensionabile (4.4 D.M., WCAG 2.0 1.4.4). L’utente deve
essere in grado di ridimensionare il testo con il proprio mouse o<br />
attraverso i controlli del<strong>la</strong> tastiera, senza che ci sia perdita di contenuti<br />
o di funzionalità.<br />
– Assenza di testo sotto forma di immagine (4.5 D.M., WCAG 2.0<br />
1.4.5). Si deve evitare l’utilizzo di testi all’interno di immagini (fatta<br />
eccezione per i logotipi, ovvero i testi che fanno parte di loghi e<br />
marchi).<br />
– Evitare script che disabilitano gli strumenti di navigazione come<br />
tastiera, mouse, barre di navigazione (5.1, 5.2 D.M., WCAG 2.0<br />
2.1.1, 2.1.2). È sconsigliabile utilizzare script che disabilitano gli<br />
strumenti di navigazione, o ne limitano l’utilizzo (per esempio, script<br />
che disabilitano il focus di un’azione da tastiera come <strong>la</strong> selezione di un<br />
link). Si tratta inoltre di un’azione che va a vantaggio dell’usabilità del<br />
nostro sito web.<br />
– Evitare azioni con limiti di tempo o, se necessario, permettere<br />
all’utente di allungare il tempo limite (6.1 D.M., WCAG 2.0 2.2.1).<br />
Ogni utente ha bisogno di un certo tempo per portare a termine<br />
un’azione, e se è previsto un limite di tempo (per esempio, per<br />
permettere al<strong>la</strong> pagina di ricaricarsi), dobbiamo far sì che l’utente possa<br />
o sospendere il limite di tempo, o allungarlo.<br />
– Evitare scritte <strong>la</strong>mpeggianti o in movimento (6.2, 7.1 D.M.,<br />
WCAG 2.0 2.2.2, 2.3.1). Le scritte <strong>la</strong>mpeggianti potrebbero causare<br />
problemi agli utenti epilettici ed è bene evitarle completamente.<br />
– Salto di blocchi <strong>la</strong>ddove necessario (8.1 D.M., WCAG 2.0 2.4.1).<br />
Immaginiamo una pagina dove i contenuti informativi sono preceduti<br />
da una serie di pubblicità, banner o comunque informazioni che<br />
possono non interessare l’utente. Dobbiamo, in questi casi, metterlo<br />
nelle condizioni di poter saltare direttamente ai contenuti informativi<br />
attraverso un apposito link.<br />
– Utilizzare titoli descrittivi (8.2 D.M., WCAG 2.0 2.4.2). Per ogni<br />
pagina dobbiamo riempire il title tag con una descrizione breve ma<br />
esauriente e, soprattutto, dobbiamo evitare di inserire lo stesso title tag
su tutte le pagine del sito: è penalizzante anche in ottica di<br />
indicizzazione sui motori di ricerca). Questa pratica è importante anche<br />
in chiave di usabilità.<br />
– Preservare l’ordine del focus (8.3 D.M., WCAG 2.0 2.4.3). Un<br />
elemento in focus è l’elemento che in quel momento è attivo sul<strong>la</strong> nostra<br />
pagina: per esempio, in un form, è il campo che stiamo compi<strong>la</strong>ndo. Gli<br />
elementi che, nel<strong>la</strong> nostra pagina, ricevono il focus, devono riceverlo<br />
secondo un ordine logico (per esempio il focus non può saltare dal<br />
primo all’ultimo campo di un form, e poi tornare al terzo).<br />
– Rendere chiara <strong>la</strong> destinazione dei link (8.4 D.M., WCAG 2.0<br />
2.4.4). Dobbiamo far comprendere ai nostri utenti in modo chiaro e<br />
intuitivo <strong>la</strong> pagina verso cui sta puntando un link, magari avvalendoci<br />
anche dell’attributo “title” del tag “a”.<br />
– Proporre diversi modi per raggiungere un contenuto (8.5 D.M.,<br />
WCAG 2.0 2.4.5). Le pagine del nostro sito web devono essere<br />
raggiungibili da più di una fonte: per poter ottenere questo scopo è<br />
possibile inserire un motore di ricerca interno, una tavo<strong>la</strong> dei contenuti,<br />
una mappa del sito, o anche una sezione di pagine corre<strong>la</strong>te.<br />
– Utilizzare titoli descrittivi (8.6 D.M., WCAG 2.0 2.4.6). Le sezioni<br />
delle pagine web devono essere dotate di titoli descrittivi, e, allo stesso<br />
modo, i campi dei form devono avere etichette che li descrivano in<br />
modo semplice e intuitivo.<br />
– Evidenziare il focus (8.7 D.M., WCAG 2.0 2.4.7). Il focus di<br />
un’azione deve essere evidenziato in modo tale da renderlo visibile a chi<br />
sta navigando <strong>la</strong> pagina web. Il focus è evidenziato di default sulle<br />
pagine web, ma possiamo comunque cambiare lo stile del<strong>la</strong> messa in<br />
risalto del focus attraverso i fogli di stile.<br />
– Definire <strong>la</strong> lingua del<strong>la</strong> pagina (9.1 D.M., WCAG 2.0 3.1.1). Per<br />
ogni pagina web deve essere definita <strong>la</strong> lingua utilizzando l’apposito<br />
meta tag.<br />
– Evitare pagine bilingui (9.2 D.M., WCAG 2.0 3.1.2). È buona
norma evitare di inserire contenuti in due o più lingue diverse in una<br />
so<strong>la</strong> pagina web o, se proprio necessario, bisogna indicare quale è o<br />
quali sono le lingue diverse da quel<strong>la</strong> definita per <strong>la</strong> pagina dove<br />
iniziano le rispettive porzioni di testo. Si tratta di una pratica<br />
importantissima anche in chiave di usabilità.<br />
– Mantenere lo stesso contesto (10.1, 10.2, 10.3, 10.4 D.M., WCAG<br />
2.0 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4). Bisogna fare in modo che il temp<strong>la</strong>te<br />
grafico, i meccanismi di navigazione e gli elementi che abbiamo scelto<br />
(bottoni, colore dei link, formattazione dei titoli... ) si ripetano in tutto<br />
il sito web, in modo da non disorientare l’utente (e ciò va anche a tutto<br />
vantaggio dell’usabilità del sito). Se in una pagina il contesto cambia,<br />
dobbiamo avvisare l’utente.<br />
– Identificare gli errori e dare suggerimenti (11.1, 11.3 D.M.,<br />
WCAG 2.0 3.3.1, 3.3.3). Se ci sono delle azioni sul nostro sito web per<br />
le quali possono essere previsti errori (per esempio, compi<strong>la</strong>zione di<br />
form), nel caso in cui questi ultimi si presentino all’utente, dobbiamo<br />
evidenziarli in modo chiaro (con colori diversi o con box appositi), e<br />
dare all’utente suggerimenti per evitare che ripeta gli errori commessi.<br />
– Etichette per i campi dei form (11.2 D.M., WCAG 2.0 3.3.2). I<br />
campi dei form devono essere descritti in modo chiaro attraverso le<br />
apposite etichette.<br />
– Garantire <strong>la</strong> prevenzione degli errori (11.4 D.M., WCAG 2.0<br />
3.3.4). Per i form, soprattutto quelli che prevedono transazioni<br />
economiche o inserimenti di dati sensibili, dobbiamo garantire i<br />
principi del<strong>la</strong> reversibilità (ogni azione deve essere reversibile), del<br />
controllo (dobbiamo mettere l’utente in condizione di ricontrol<strong>la</strong>re i<br />
dati inseriti ed eventualmente di modificarli) e del<strong>la</strong> conferma (una<br />
volta terminato il processo di inserimento, dobbiamo presentare<br />
all’utente una pagina con il riepilogo dei dati onde permettergli di dare<br />
<strong>la</strong> conferma all’azione che sta eseguendo).<br />
– Presenza di una DTD, Document Type Definition (12.1 D.M.,<br />
WCAG 2.0 4.1.1). Per le nostre pagine web utilizzeremo una DTD<br />
conforme agli standard internazionali del W3C e ci assicureremo che le
pagine vengano redatte in modo corretto per quanto riguarda il<br />
linguaggio di markup.<br />
Oltre a queste indicazioni, si ritiene utile fornirne altre che, sebbene non legate<br />
direttamente ai punti indicati dal D.M., possono migliorare notevolmente<br />
l’accessibilità del nostro sito web e quindi fornire un’esperienza più soddisfacente agli<br />
utenti:<br />
– Rispetto degli standard W3C. Progettare un sito che sia conforme<br />
agli standard W3C è sinonimo di grande cura nel<strong>la</strong> progettazione e<br />
garantisce maggiori benefici per gli utenti (che si traducono in una<br />
maggiore accessibilità, in pagine più veloci, in assenza di spreco di<br />
codice superfluo che appesantisce inutilmente <strong>la</strong> pagina) e anche per i<br />
programmatori (le pagine conformi sono più facili da mantenere).<br />
Inoltre un sito web conforme è più pulito, a livello di codice, e quindi<br />
meglio navigabile non solo dagli utenti, ma anche dagli spider dei<br />
motori di ricerca.<br />
– Finestra del browser adattabile senza sovrapposizione di<br />
elementi. Quando l’utente riduce <strong>la</strong> dimensione del<strong>la</strong> finestra del<br />
browser, deve poter continuare a visualizzare gli elementi senza che si<br />
sovrappongano l’un l’altro, impedendogli una lettura corretta dei<br />
contenuti.<br />
– Utilizzo del sito anche con il codice JavaScript disabilitato.<br />
Diversi siti web affidano parte dei contenuti a script realizzati in codice<br />
JavaScript, che se disattivato mutilerà il sito di una sua parte. È<br />
doveroso fare in modo che, in caso di codice JavaScript disabilitato,<br />
non venga impedito all’utente di fruire dei contenuti messi a<br />
disposizione tramite script, magari con valide alternative o, quanto<br />
meno, facendo in modo che il codice disabilitato non rendainaccessibili<br />
certi contenuti.<br />
– Alternative per applet Java, oggetti F<strong>la</strong>sh e script vari. Vale lo<br />
stesso ragionamento fatto per gli script in JavaScript: se ci sono applet<br />
Java o oggetti F<strong>la</strong>sh che veico<strong>la</strong>no contenuti importanti, questi ultimi<br />
devono essere fruibili anche se l’utente non è dotato di dispositivi che<br />
permettano <strong>la</strong> visualizzazione di applet Java ed elementi F<strong>la</strong>sh (molti
telefoni cellu<strong>la</strong>ri e smartphone, per esempio, non supportano F<strong>la</strong>sh).<br />
– Presenza di accesskey per i link principali. Le accesskey sono<br />
combinazioni da tastiera che permettono di selezionare in modo veloce<br />
un link e sono utili per gli utenti che navigano sul web attraverso<br />
l’utilizzo del<strong>la</strong> tastiera. Implementare le accesskey nel proprio sito web<br />
significa avere cura di questo partico<strong>la</strong>re tipo di utenza ed è sempre<br />
un’ottima pratica.<br />
– Presenza di una dichiarazione di accessibilità. È sempre una buona<br />
pratica dotare il proprio sito web di una pagina in cui si informa<br />
l’utente su quali sono state le pratiche adottate in fase di<br />
programmazione per rendere il sito web accessibile.<br />
– Presenza di versioni accessibili in caso di sito non accessibile. Se<br />
non è possibile garantire l’accessibilità del sito web principale, sarà bene<br />
creare una versione del sito alternativa che sia pienamente accessibile.<br />
Come: cenni per una maggiore usabilità del sito web museale<br />
L’usabilità è definita dal<strong>la</strong> norma ISO 9241, emanata dall’International Organization<br />
for Standardization, come il “grado in cui un prodotto può essere usato da partico<strong>la</strong>ri<br />
utenti per raggiungere certi obiettivi con efficacia, efficienza e soddisfazione in uno<br />
specifico contesto d’uso”. È una norma del 1993, che si applica a tutti i prodotti<br />
informatici in generale, ma è calzante anche per i siti web.<br />
Possiamo quindi dire che l’usabilità riguarda il modo in cui i contenuti del nostro sito<br />
web sono più o meno navigabili con facilità. Pertanto l’usabilità investe <strong>la</strong> struttura<br />
del sito, il modo in cui è scritto il codice, <strong>la</strong> veste grafica, <strong>la</strong> scrittura dei<br />
contenuti. Semplificando: maggiore sarà l’usabilità del nostro sito web, più facile<br />
saranno <strong>la</strong> navigazione e l’utilizzo da parte degli utenti. Possiamo dunque pensare<br />
all’usabilità come al<strong>la</strong> facilità di navigazione e d’uso del sito web.<br />
Dal<strong>la</strong> norma ISO emergono tre parole-chiave fondamentali che rappresentano i tre<br />
principi-cardine dell’usabilità:<br />
– efficacia: uno degli approcci fondamentali dell’usabilità è quello<br />
secondo cui l’utente naviga su internet per cercare dei contenuti. Il sito<br />
web dovrà quindi essere strutturato in modo tale da permettere
all’utente di portare a termine questo compito senza difficoltà;<br />
– efficienza: gli utenti non solo utilizzano il web per ricercare<br />
informazioni, come si è detto sopra, ma desiderano anche che queste<br />
informazioni possano essere trovate nel minor tempo possibile. Il sito<br />
dovrà quindi essere strutturato in modo tale da far risaltare le<br />
informazioni più importanti (per esempio, i contenuti più importanti<br />
potranno essere inseriti nel menù principale, che non dovrà mai<br />
cambiare posizione all’interno del sito) e in modo che il caricamento<br />
delle pagine sia il più veloce possibile;<br />
– soddisfazione: gli utenti vogliono anche che <strong>la</strong> loro esperienza sul sito<br />
web sia gradevole. Bisogna pertanto progettare il sito in modo tale da<br />
restituire all’utente un’esperienza positiva: tempi di caricamento veloci,<br />
gradevolezza estetica, struttura facilmente comprensibile.<br />
Possiamo tuttavia essere più specifici ed enumerare altri principi fondamentali<br />
dell’usabilità per avere un panorama semplice, ma piuttosto completo, di quelli che<br />
dovrebbero essere i concetti da tenere a mente durante <strong>la</strong> progettazione di un sito<br />
web, per una maggiore comprensione dei tre principi-cardine dell’usabilità:<br />
– chiarezza: <strong>la</strong> struttura al<strong>la</strong> base di un sito web non deve dare adito a<br />
fraintendimenti e deve sempre essere coerente con se stessa. In altre<br />
parole, se si sceglie una linea grafica, andrà mantenuta per tutto il sito, e<br />
<strong>la</strong> stessa rego<strong>la</strong> vale per l’uso di colori o di elementi che corrispondono<br />
ad azioni, titoli, note e quant’altro, che non dovrebbe mai variare<br />
all’interno dello stesso sito web;<br />
– completezza: dobbiamo metterci nei panni dell’utente, comprendere<br />
quali sono le informazioni che il pubblico cerca sul nostro sito web, e<br />
fornirle nel modo più completo ed esauriente possibile;<br />
– comprensibilità: il pubblico del museo non è composto da soli<br />
specialisti, ma è un pubblico molto eterogeneo che può visitare il museo<br />
e il suo sito web per motivi e bisogni diversi, e sarà quindi necessario<br />
utilizzare un linguaggio chiaro e comprensibile nel<strong>la</strong> redazione dei testi.<br />
Se ci rivolgiamo a un pubblico vasto, è nettamente sconsigliato l’uso di<br />
termini specialistici, o di convenzioni – per esempio, sistemi di
notazione – che un pubblico di non addetti ai <strong>la</strong>vori non è tenuto a<br />
conoscere;<br />
– eleganza: il museo è un luogo dove viene custodito un sapere, dove si<br />
fa ricerca, dove si educa il pubblico non specialista, e dove possono<br />
essere svolte altre attività senza che però si perdano mai di vista gli<br />
obiettivi fondamentali per i quali un museo è nato. Di conseguenza, il<br />
museo sul web dovrà trasmettere un’immagine adeguata: una veste<br />
grafica elegante e curata può non solo far risaltare le informazioni che<br />
l’utente cerca, ma fargli vivere anche un’esperienza esteticamente<br />
piacevole.<br />
Per riuscire a soddisfare meglio questi concetti, il team di sviluppo del sito web<br />
museale potrebbe trovare utile, nelle fasi preliminari del progetto, farsi alcune<br />
domande:<br />
– A chi dovrebbe rivolgersi il nostro sito web?<br />
– Quali sono gli obiettivi che vogliamo raggiungere attraverso il nostro<br />
sito web?<br />
– Quali sono le informazioni principali che vogliamo far risaltare?<br />
– Che cosa un utente si aspetta, secondo noi, dal nostro sito web?<br />
– Quale immagine vogliamo trasmettere del nostro museo?<br />
Dobbiamo tener presente che, mentre progettiamo un sito, stiamo progettando un<br />
prodotto che presupporrà una interazione e, attraverso questa interazione, dovrà<br />
fornire delle risposte ai bisogni dell’utente. Come si è detto, il nostro approccio<br />
fondamentale deve essere quello secondo cui l’utente naviga sul web al<strong>la</strong> ricerca di<br />
informazioni, dunque per soddisfare un proprio bisogno.<br />
È quindi importante fare in modo che il prodotto finito tenga conto sia delle<br />
aspettative del museo (rapporto costi-benefici, immagine) sia di quelle dell’utente<br />
(facilità di navigazione, completezza delle informazioni).<br />
Anche <strong>la</strong> veste grafica dovrà risultare curata: uno dei dibattiti più interessanti, a<br />
proposito di usabilità, è quello sul rapporto tra usabilità ed estetica. Non sono pochi<br />
infatti coloro che ritengono che l’estetica debba essere subordinata all’usabilità, e
addirittura qualcuno ritiene che se il sito ha un buon grado di usabilità, l’estetica ha<br />
scarsa importanza. Tuttavia, diversi studi (tra cui il Web Credibility Project<br />
dell’Università di Stanford) hanno dimostrato che gran parte degli utenti che navigano<br />
in rete sono portati a fidarsi di più delle informazioni che compaiono in un sito dal<br />
design curato e professionale, piuttosto che dei contenuti reperiti in siti web dove <strong>la</strong><br />
grafica non è gradevole o non è funzionale allo scopo del sito web.<br />
Si è par<strong>la</strong>to in precedenza di accessibilità: qual è <strong>la</strong> differenza sostanziale tra usabilità<br />
e accessibilità? L’accessibilità riguarda soprattutto gli strumenti, mentre l’usabilità<br />
riguarda l’esperienza. Semplificando, scopo dell’accessibilità è quello di rimuovere<br />
le barriere che possono costituire un ostacolo al<strong>la</strong> fruizione del sito web da parte di<br />
utenti diversamente abili o che dispongono di sistemi di software limitati, mentre<br />
scopo dell’usabilità è quello di rendere un sito completo, chiaro, facile da<br />
navigare.<br />
Ne conseguono quindi alcune considerazioni:<br />
– Poiché l’accessibilità si concentra sugli strumenti, questa riguarda<br />
perlopiù <strong>la</strong> programmazione del sito web e non <strong>la</strong> grafica o <strong>la</strong><br />
completezza dei contenuti e delle informazioni, mentre l’usabilità<br />
investe il sito web nel<strong>la</strong> sua interezza.<br />
– Un sito web può essere usabile ma non accessibile, a causa, per<br />
esempio, del<strong>la</strong> presenza di codice JavaScript che veico<strong>la</strong> informazioni<br />
fondamentali e che un utente che abbia l’esecuzione del codice<br />
JavaScript disabilitata, non potrà mai ottenere. Allo stesso modo, può<br />
essere accessibile ma non usabile, per esempio quando tutte le<br />
barriere sono state rimosse, ma le informazioni possono essere difficili<br />
da trovare. È dunque infondato l’assunto secondo cui rendere un sito<br />
accessibile significa renderlo anche usabile.<br />
– È possibile valutare l’accessibilità con sistemi automatici, mentre<br />
invece l’analisi dell’usabilità è soprattutto euristica, anche se è possibile<br />
tracciare delle linee-guida (di cui si parlerà a breve). Questo perché le<br />
motivazioni al<strong>la</strong> base del<strong>la</strong> scelta di una struttura o di una veste grafica<br />
possono variare a seconda dei destinatari del sito web, mentre invece le<br />
misure per rendere un sito accessibile sono pensate per un target ben<br />
definito.<br />
Partendo da quest’ultimo punto, poiché l’analisi dell’usabilità si fonda su dati che è
difficile rendere oggettivi e matematicamente misurabili, non bisogna<br />
sottovalutare l’importanza delle indagini: sottoporre i potenziali utenti a un<br />
questionario prima che il sito web venga progettato sarà un notevole aiuto in fase di<br />
progettazione. Infatti, un questionario pensato per comprendere cosa i nostri utenti si<br />
aspettano dal nostro sito web ci consentirà di ricavare informazioni utili sul nostro<br />
pubblico, che potranno fornire suggestioni decisive al team di sviluppo.<br />
Le indagini si riveleranno inoltre fondamentali anche quando il sito web sarà <strong>online</strong>,<br />
perché potranno evidenziare eventuali aree critiche su cui intervenire per apportare<br />
miglioramenti al sito. Questo perché il modo migliore per valutare quanto il nostro<br />
sito soddisfa i principi-cardine dell’usabilità consiste proprio nel condurre dei test con<br />
utenti che realmente utilizzano il nostro sito web.<br />
Tuttavia l’usabilità è un argomento molto vasto, a cui sono stati dedicati interi libri e<br />
su cui esiste una specifica bibliografia di settore. Intento di questa trattazione non è<br />
quello di discutere l’argomento in maniera esaustiva (si rimanda quindi al<strong>la</strong><br />
bibliografia a completamento del capitolo): si ritiene comunque utile indicare alcune<br />
linee-guida fondamentali che si possono applicare con successo al<strong>la</strong> maggior parte dei<br />
siti web e, nello specifico, a quelli dei musei.<br />
– Dominio dedicato. Diversi siti web museali sono ospitati sul sito<br />
dell’ente o dell’istituzione a cui fanno riferimento (Comune, Provincia,<br />
Accademia). Tuttavia sarebbe meglio che un museo avesse un dominio<br />
dedicato onde permettere ai visitatori di riconoscere il sito web in<br />
modo più facile, di raggiungerlo in modo più efficace, e di trovarlo con<br />
maggior successo sui motori di ricerca.<br />
– Assenza di sp<strong>la</strong>sh page. Per “sp<strong>la</strong>sh page” si intende una pagina<br />
introduttiva, spesso fine a se stessa, il più delle volte costituita da una<br />
immagine inserita con lo scopo di attirare l’utente, e da un link che lo<br />
introduce nel sito “vero”, oppure viene presentata all’utente <strong>la</strong><br />
possibilità di scegliere <strong>la</strong> lingua di cui intende avvalersi durante <strong>la</strong><br />
navigazione. La pratica del<strong>la</strong> sp<strong>la</strong>sh page, partico<strong>la</strong>rmente in voga ai<br />
primordi del web e oggi caduta in disuso sui siti più moderni, è da<br />
evitare in quanto pone un ostacolo spesso inutile tra l’utente e il suo<br />
obiettivo: perché costringere l’utente a fare un passo più del necessario<br />
per raggiungere le informazioni che cerca?<br />
– URL SEO-friendly. Per URL SEO-friendly si intende l’indirizzo di<br />
una pagina web strutturato in modo tale da renderlo utile e
comprensibile sia da parte dei motori di ricerca, sia da parte degli<br />
utenti. Un URL SEO-friendly può essere, per esempio, questo:<br />
www.sitodelmuseo.com/informazioni/orari.html . Non è invece SEOfriendly<br />
un indirizzo come questo: www.sitodelmuseo.com/page.php?<br />
ID=57. Fin dall’indirizzo del<strong>la</strong> pagina web si intuisce pertanto che in<br />
quel<strong>la</strong> pagina si troveranno informazioni sugli orari del museo, cosa<br />
invece affatto intuibile dal secondo indirizzo. Il team di sviluppo farà<br />
pertanto sì che gli indirizzi delle pagine siano strutturati in modo SEOfriendly.<br />
– Presenza di title tag e meta description descrittivi. La title tag e <strong>la</strong><br />
meta description sono due parametri molto importanti, sia per i motori<br />
di ricerca, perché meglio sono redatte queste informazioni, maggiori<br />
saranno le possibilità di sca<strong>la</strong>re i risultati dei motori di ricerca, sia per<br />
gli utenti, perché cercando una pagina sul motore potranno vedere in<br />
anteprima di che cosa par<strong>la</strong>. Inoltre questi campi sono utili anche per<br />
eventuali feed RSS, che potranno veico<strong>la</strong>re informazioni utili per gli<br />
utenti attraverso questi due parametri, ma anche per i social (che<br />
utilizzeranno i dati di title tag e meta description per costruire<br />
l’anteprima del link).<br />
– Presenza di un motore di ricerca interno. Per facilitare <strong>la</strong> ricerca<br />
di informazioni da parte dell’utente, potrà rive<strong>la</strong>rsi utile inserire un<br />
motore di ricerca che possa “setacciare” le pagine del nostro sito per<br />
trovare le informazioni che interessano all’utente.<br />
– Presenza di breadcrumb. Per “breadcrumb”, ovvero “briciole di<br />
pane”, si intende uno strumento di navigazione che permette all’utente<br />
di individuare <strong>la</strong> pagina in cui si trova e di vedere anche il percorso che<br />
porta a quel<strong>la</strong> pagina (per esempio: “Home – Informazioni – Orari”).<br />
Nell’esempio, le voci che costituiscono i livelli superiori del<strong>la</strong> pagina in<br />
cui l’utente si trova saranno linkate per permettere all’utente di poterci<br />
tornare in qualsiasi momento, mentre non sarà linkata l’ultima delle<br />
“briciole”, ovvero <strong>la</strong> pagina in cui l’utente si trova. Le breadcrumb<br />
forniscono un importante aiuto al<strong>la</strong> navigazione in quanto consentono<br />
all’utente di sapere sempre in quale punto del sito si trova. Sarà<br />
opportuno piazzarne nel<strong>la</strong> parte superiore del<strong>la</strong> pagina, in prossimità dei<br />
titoli.
– Evitare di disabilitare gli strumenti di navigazione. Non è raro<br />
imbattersi in siti che disabilitano certe funzionalità utili per <strong>la</strong><br />
navigazione (barre degli strumenti, barre di scorrimento, addirittura<br />
utilizzo del mouse o del<strong>la</strong> tastiera), o cambiano l’aspetto del browser<br />
(per esempio, abilitano in automatico <strong>la</strong> funzionalità “full screen”). Per<br />
garantire un buon livello di usabilità, è necessario evitare queste<br />
pratiche che hanno il solo risultato di disorientare l’utenza e di rendere<br />
difficoltosa <strong>la</strong> navigazione.<br />
– Evitare l’uso di popup per l’apertura di link. L’uso di popup o<br />
“finestre modali” è sconsigliabile in quanto disturba l’utente, è associata<br />
a pratiche poco simpatiche come l’apertura di pubblicità ingannevoli e<br />
distoglie l’attenzione dell’utente dal sito web . Inoltre i popup vengono<br />
aperti il più delle volte tramite codice JavaScript, e si è visto che tale<br />
pratica non garantisce piena accessibilità al sito se l’utilizzo di codice<br />
JavaScript è l’unico mezzo per veico<strong>la</strong>re informazioni importanti.<br />
– Gli elementi devono essere ricorrenti. Se abbiamo scelto un colore<br />
per un link, una forma per i bottoni, un font per una intestazione e via<br />
dicendo, dobbiamo fare in modo che tali elementi non cambino mai<br />
all’interno delle pagine. Viceversa, l’utente sarà disorientato e <strong>la</strong> sua<br />
esperienza non sarà gradevole e lo spingerà ad abbandonare il sito.<br />
– Far sì che i menù di navigazione siano individuabili con facilità.<br />
La maggior parte degli utenti si aspetta di trovare il menù nel<strong>la</strong> parte<br />
alta del<strong>la</strong> pagina, o sul<strong>la</strong> sinistra dello schermo. Sarà quindi opportuno<br />
inserire almeno il menù principale in una di queste due posizioni.<br />
– Fare in modo che i menù non cambino posizione. Lo schema di<br />
base definito per il sito deve rimanere tale in tutte le pagine, pertanto i<br />
menù non dovranno cambiare posizione. Il rischio è ancora quello di<br />
disorientare l’utente.<br />
– Rendere i link ben distinguibili. La natura ipertestuale del web<br />
dovrebbe far sì che i link presenti nelle pagine siano ben evidenti: sarà<br />
quindi opportuno scegliere un colore diverso e che possibilmente cambi<br />
al passaggio del mouse, e magari utilizzare una sottolineatura. Sarà<br />
possibile inoltre scegliere un colore differente per i link che l’utente ha
già visitato.<br />
– Fare in modo che i marcatori di lista siano puntati o numerati.<br />
Gli elenchi dovranno essere puntati o numerati per fare in modo che<br />
l’utente riesca a distinguerli velocemente e agevolmente.<br />
– Evitare l’uso di una terminologia specialistica. A meno che il<br />
nostro sito web non sia rivolto agli “addetti ai <strong>la</strong>vori” (ma, trattandosi di<br />
un sito web museale, il nostro pubblico sarà molto eterogeneo),<br />
dovremo evitare di utilizzare un linguaggio con termini che un pubblico<br />
non specialista non potrebbe comprendere. Tuttalpiù, doteremo il sito<br />
di un glossario. Ovviamente ciò non toglie che possano essere presenti<br />
sezioni del sito web dedicate agli specialisti del settore. Alcuni siti web<br />
inoltre propongono diversi itinerari di lettura a seconda del tipo di<br />
utenza.<br />
– Utilizzare citazioni bibliografiche. Per dare modo all’utente di<br />
approfondire certi contenuti del nostro sito web (un’opera, un reperto,<br />
un artista, un personaggio) può essere una buona idea inserire<br />
riferimenti bibliografici, però con notazioni che siano facilmente<br />
comprensibili da parte di un pubblico vasto. È bene evitare, quindi,<br />
sistemi come APA, MLA o Chicago, che vanno bene per articoli<br />
scientifici ma che sono poco indicati per pubblicazioni destinate a un<br />
pubblico ampio, come appunto un sito web. Molto meglio prediligere<br />
un sistema tradizionale autore-titolo, inserendo per intero nome<br />
dell’autore o degli autori, titolo del libro, città di pubblicazione, casa<br />
editrice, anno di pubblicazione. Utile anche evitare il ricorso a formule<br />
come ibidem o op.cit..<br />
– Utilizzare una mappa del sito. L’utilizzo di una mappa del sito può<br />
fornire un aiuto all’utente che potrà così avere un quadro completo del<br />
sito.<br />
– Utilizzare pagine di aiuto. Se si pensa che certe azioni possono<br />
recare difficoltà all’utente (per esempio, <strong>la</strong> compi<strong>la</strong>zione di un form per<br />
<strong>la</strong> richiesta di informazioni), sarà opportuno inserire delle pagine o<br />
delle note attraverso le quali aiutare e guidare l’utente.
– Assenza di pagine bilingui, trilingui, eccetera. Molti siti web hanno<br />
<strong>la</strong> pessima abitudine di non creare diverse versioni per ognuna delle<br />
lingue nelle quali intendono sviluppare il sito, ma creano un’unica<br />
versione con pagine che hanno al loro interno le traduzioni. Questa<br />
pratica è però totalmente sbagliata per diversi motivi. Intanto, non<br />
permette di individuare con chiarezza <strong>la</strong> lingua del<strong>la</strong> pagina (una pagina<br />
bilingue italiano/inglese è da considerare italiana o inglese?). In<br />
secondo luogo, si pone il problema delle traduzioni delle voci del menù:<br />
perché il pubblico non italofono dovrebbe navigare nel sito con le voci<br />
del menù in italiano per trovare le traduzioni in inglese all’interno del<strong>la</strong><br />
versione italiana? In terzo luogo, l’utenza è abituata a scegliere <strong>la</strong> lingua<br />
e a trovarsi quindi in versioni del sito web completamente tradotte, e<br />
senza informazioni in lingue diverse (a meno che non si tratti di<br />
citazioni, ma sarà quindi il caso di indicare <strong>la</strong> lingua diversa e offrire<br />
una traduzione). Risulta quindi chiaro che inserire pagine con i<br />
contenuti tradotti all’interno delle pagine stesse è quanto di più sbagliato<br />
si possa fare.<br />
– Nel caso in cui il sito abbia uno shop <strong>online</strong>, inserire informazioni<br />
su privacy e sicurezza. Se abbiamo deciso di dotare il nostro sito web<br />
di uno shop <strong>online</strong> in cui si effettuano transazioni economiche, è<br />
importante, anche per una questione di trasparenza, indicare condizioni<br />
di vendita, modalità del trattamento dei dati (l’indicazione di queste<br />
ultime è obbligatoria per legge in Italia), informazioni sul soggetto<br />
responsabile del<strong>la</strong> vendita (indirizzi, iscrizioni al registro delle imprese,<br />
sede legale, partita IVA: tutti dati obbligatori per legge in Italia). I<br />
prezzi dovranno essere inoltre indicati in modo chiaro, specificando se<br />
comprendono imposte, costi di spedizione ed eventuali altri costi<br />
aggiuntivi.<br />
Come: rendere più veloci le pagine del sito attraverso accorgimenti tecnici<br />
Uno degli obiettivi principali di uno sviluppatore web è quello di creare pagine che<br />
abbiano tempi di caricamento che siano i più bassi possibile. La velocità di<br />
caricamento è importante sia per gli utenti, che con pagine veloci otterranno le<br />
informazioni che cercano in tempi più rapidi, sia per i motori di ricerca, in quanto<br />
Google ha recentemente fatto sapere che <strong>la</strong> velocità di caricamento delle pagine ha un
notevole impatto sui risultati del<strong>la</strong> ricerca sul motore.<br />
Si elencano quindi di seguito alcuni accorgimenti tecnici che contribuiscono ad<br />
abbattere i tempi di caricamento delle pagine.<br />
– Mantenere basso il peso del<strong>la</strong> pagina. Più è basso il peso del<strong>la</strong><br />
pagina (che non corrisponde so<strong>la</strong>mente al peso del file HTML:<br />
quest’ultimo infatti va sommato a tutti gli elementi presenti nel<strong>la</strong><br />
pagina, come immagini, codici JavaScript, file CSS e quant’altro),<br />
maggiore sarà <strong>la</strong> velocità di caricamento.<br />
– Abbassare il numero di richieste HTTP. Le richieste HTTP sono le<br />
richieste di informazioni che partono dal browser con cui navighiamo e<br />
arrivano al server che ospita <strong>la</strong> pagina. Il browser invia una richiesta per<br />
ogni elemento del<strong>la</strong> pagina, e il server risponderà con uno status e<br />
alcune informazioni sull’elemento. Se, per esempio, <strong>la</strong> pagina che<br />
navighiamo è costituita dal file HTML, e dentro ci sono solo cinque<br />
immagini, il browser invierà sei richieste al server. Più sono le richieste<br />
inviate al server e, quindi, maggiore è il numero di elementi in una<br />
pagina, più lento sarà il tempo di caricamento. È possibile abbassare il<br />
numero di richieste con alcuni accorgimenti: per esempio, usare lo<br />
sprite per le immagini, riunire i diversi CSS in un unico file, così come i<br />
codici JavaScript.<br />
– Eliminare i link che rimandano a pagine non esistenti. I “broken<br />
link”, ovvero link che rimandano a risorse non esistenti (immagini non<br />
più presenti sul sito, file CSS rimossi e quant’altro) hanno il solo effetto<br />
di inviare al server richieste inutili che causano rallentamento nel<br />
caricamento del<strong>la</strong> pagina.<br />
– Fare in modo che le immagini siano sca<strong>la</strong>te. Per “immagine<br />
sca<strong>la</strong>ta” intendiamo un’immagine che abbia le dimensioni con le quali<br />
effettivamente si presenterà all’utente sul browser. Non ha senso<br />
caricare sul server un’immagine di 1200 x 1000 pixel, se poi <strong>la</strong><br />
ridimensioneremo a 120 x 100 pixel nel<strong>la</strong> nostra pagina: si tratta di un<br />
inutile spreco di peso che influisce negativamente sui tempi di<br />
caricamento del<strong>la</strong> pagina.<br />
– Specificare le dimensioni delle immagini con gli attributi
“height” e “width”. Specificare le dimensioni delle immagini aiuta il<br />
browser a scaricarle più velocemente.<br />
– Ottimizzare le immagini. Le immagini per il web dovranno essere<br />
compresse in modo “lossy”, ovvero “con perdita” di informazioni<br />
originali. Questo tipo di compressione è adeguato per il web in quanto<br />
consente di preservare una buona qualità delle immagini per il web (<strong>la</strong><br />
compressione “lossy” non è invece indicata per <strong>la</strong> stampa, in quanto <strong>la</strong><br />
perdita di qualità sarebbe nettamente percepibile, cosa che non avviene<br />
sullo schermo, a meno di fortissime compressioni). Questa operazione<br />
consente di risparmiare moltissima memoria e di conseguenza consente<br />
di abbattere notevolmente i tempi di caricamento delle pagine.<br />
Ottimizzare le immagini significa anche scegliere il formato<br />
appropriato: elementi grafici che non hanno molti colori dovrebbero<br />
essere salvati in GIF, mentre grafiche più dettagliate saranno rese con il<br />
formato JPG.<br />
– Fare il minifying di CSS, JavaScript e HTML. Per “Minifying” si<br />
intende <strong>la</strong> compressione dei file CSS, JS e HTML. Esistono degli<br />
appositi strumenti in rete che comprimono questi file e consentono di<br />
renderli più leggeri.<br />
– Fare il deferring del codice JavaScript. Finché il codice JavaScript<br />
non viene processato, il browser non invia richieste, e questo causa un<br />
rallentamento dei tempi di caricamento del<strong>la</strong> pagina: tuttavia, a volte il<br />
codice è inutile finché non viene attivata una certa funzionalità del<br />
nostro sito. Esistono tecniche che possono però fare in modo che il<br />
codice JavaScript venga processato solo quando necessario e non vada<br />
quindi a “intralciare” il <strong>la</strong>voro del browser.<br />
– Inserire i riferimenti al codice CSS nel<strong>la</strong> head del<strong>la</strong> pagina. Per<br />
ottenere migliori performance, le informazioni re<strong>la</strong>tive ai file CSS (che<br />
rego<strong>la</strong>no <strong>la</strong> grafica del sito) devono essere inserite nel<strong>la</strong> head del<strong>la</strong><br />
nostra pagina HTML: il rendering del<strong>la</strong> pagina infatti non sarà completo<br />
finché non verranno scaricate tutte le informazioni sullo stile, e fornire<br />
subito queste informazioni al browser accelera i tempi di caricamento.<br />
– Evitare l’import CSS. L’import CSS consente a un file CSS di
includere un ulteriore file CSS. Questa pratica però rallenta il<br />
caricamento del<strong>la</strong> pagina ed è meglio evitar<strong>la</strong>.<br />
– Ottimizzare l’ordine di caricamento degli script. Se <strong>la</strong> corretta<br />
esecuzione di codice JavaScript dipende dai file CSS, sarà opportuno<br />
caricare i file JS dopo i file CSS.<br />
– Fare in modo che le risorse siano uniche. Se in dieci pagine diverse<br />
dobbiamo mostrare dieci immagini identiche, dovremo fare in modo<br />
che tutte puntino al<strong>la</strong> stessa risorsa (è inutile quindi caricare sul server<br />
dieci file diversi per un’unica immagine: si tratta solo di uno spreco di<br />
risorse e crea inutili rallentamenti).<br />
– Abilitare <strong>la</strong> connessione keep-alive. Abilitare <strong>la</strong> connessione keepalive<br />
significa fare in modo che <strong>la</strong> connessione tra browser e server<br />
rimanga aperta anche dopo che il browser ha scaricato una risorsa<br />
(l’opzione contraria è “close”, connessione che si chiude dopo che <strong>la</strong><br />
richiesta viene eseguita). Tenere <strong>la</strong> connessione aperta significa<br />
risparmiare notevoli risorse in fase di caricamento del<strong>la</strong> pagina. Onde<br />
evitare rischi dovuti al fatto che <strong>la</strong> connessione rimanga sempre aperta<br />
(per esempio, le connessioni keep-alive causano un aumento di <strong>la</strong>voro<br />
del server), sul server sarà possibile impostare dei tempi di timeout.<br />
– Utilizzare <strong>la</strong> cache del browser in modo efficace. La cache del<br />
browser memorizza sul computer dell’utente gli elementi di una pagina<br />
web, in modo che quando l’utente <strong>la</strong> visita una seconda volta, il<br />
caricamento sia più veloce in quanto le risorse sono già nel<strong>la</strong> memoria<br />
del<strong>la</strong> cache. Attraverso il file .htaccess del proprio sito web, è possibile<br />
dire al browser quali tipi di file memorizzare nel<strong>la</strong> cache e per quanto<br />
tempo.<br />
Un sistema di valutazione per siti web museali<br />
A conclusione dell’analisi, si presenta un sistema di valutazione per i siti web<br />
museali. È stato pensato in modo tale da renderlo il più oggettivo possibile e<br />
applicabile anche attraverso auto-valutazione.<br />
È suddiviso in undici sezioni (Lingue, Informazioni, Museo, Patrimonio, Eventi,
Interazione, Educazione, Servizi, Accessibilità, Usabilità, Valutazione tecnica) che<br />
cercano di analizzare tutti gli aspetti fondamentali del sito web di un museo.<br />
A loro volta, le undici sezioni sono costituite da diversi parametri (111 in totale) a cui<br />
è stato attribuito un diverso punteggio, a seconda dell’importanza che il parametro<br />
riveste per il sito web.<br />
Esistono anche parametri che hanno come punteggio massimo 0, ma che possono<br />
avere anche punteggi negativi: questa scelta è stata operata soprattutto per quelle che<br />
vengono considerate pratiche fondamentali, senza seguire le quali il sito web si ritiene<br />
molto penalizzato.<br />
I punteggi massimi di tutti i parametri, sommati, conferiscono al museo un punteggio<br />
totale massimo di 200 punti.<br />
Il sistema è stato utilizzato per <strong>la</strong> prima volta sui siti web dei 10 musei più visitati del<br />
mondo e sui siti dei 10 musei più visitati d’Italia nel 2012 (secondo il rapporto di “Il<br />
Giornale dell’Arte” e “The Art Newspaper”). I risultati sono presentati in questa<br />
tabel<strong>la</strong>. Dal<strong>la</strong> c<strong>la</strong>ssifica dei musei italiani più visitati sono stati esclusi <strong>la</strong> Galleria<br />
dell’Accademia di Firenze e il Museo degli Argenti-Giardini di Boboli in quanto i<br />
musei del Polo Museale Fiorentino condividono tutti lo stesso sito web, con leggere<br />
differenze a seconda del museo. Per quanto riguarda <strong>la</strong> valutazione tecnica, i test sono<br />
stati condotti sulle home page dei siti e su alcune delle pagine più significative (storia<br />
del museo, collezioni, informazioni, ecc.).<br />
Museo Città Data analisi Punti<br />
Musée du Louvre Parigi 02/01/14 121<br />
Metropolitan Museum of Art New York 02/01/14 143<br />
British Museum Londra 03/01/14 152<br />
Tate Modern Londra 03/01/14 143<br />
National Gallery of Art Londra 05/01/14 144<br />
Natural History Museum Londra 13/01/14 145<br />
Musei Vaticani Città del Vaticano 13/01/14 86<br />
National Pa<strong>la</strong>ce Museum Taipei 18/01/14 99<br />
National Gallery of Art Washington 13/01/14 109<br />
Centre Pompidou Parigi 19/01/14 77<br />
Galleria degli Uffizi Firenze 02/01/14 81<br />
Pa<strong>la</strong>zzo Ducale Venezia 03/01/14 104<br />
Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo Roma 04/01/14 65
Museo Reggia Centrale di Venaria del Reale Risorgimento Roma Torino 05/01/14 04/01/14 35 111<br />
Museo Nazionale del Cinema Torino 18/01/14 103<br />
Museo di Pa<strong>la</strong>zzo Vecchio Firenze 13/01/14 54<br />
Reggia di Caserta Caserta 19/01/14 62<br />
Musei del Castello Sforzesco Mi<strong>la</strong>no 20/01/14 73<br />
Museo delle Antichità Egizie Torino 29/01/14 84<br />
Si presentano di seguito i singoli parametri del sistema di valutazione. In caso di<br />
tempi di caricamento eccessivi di una pagina o di una funzione, si è riprovato per i 2<br />
giorni successivi. In caso di persistenza dei problemi (e nel caso in cui manchino<br />
avvisi di malfunzionamento), si assegna punteggio -3. Si assegna punteggio -3 anche<br />
qualora una funzione del sito rimandi a errori 404 o malware (esempio: il link per gli<br />
orari di apertura rimanda a una pagina non esistente o su cui sono presenti virus).<br />
La valutazione tecnica va condotta sul<strong>la</strong> home page (o su una pagina interna se è<br />
presente una sp<strong>la</strong>sh page).<br />
La valutazione di accessibilità e usabilità è da effettuare almeno su una pagina per<br />
tutte le sezioni principali, se presenti (storia del museo, descrizione di una sa<strong>la</strong>,<br />
descrizione di un oggetto, form di ricerca o di contatto).<br />
1. Lingue (punteggio massimo: 10 punti)<br />
N Criterio<br />
Punteggi<br />
1 lingua: 1 punto<br />
2-3 lingue: 3 punti<br />
1 Numero di lingue presenti sul sito<br />
4-5 lingue: 5 punti<br />
Più di 5 lingue: 6 punti<br />
Informazioni complete in una so<strong>la</strong> lingua: 1<br />
2 Completezza lingue<br />
Informazioni complete in tutte le lingue: 4<br />
2. Informazioni (punteggio massimo: 21 punti)<br />
N. Criterio Punteggi
1 Orari di apertura Non presenti: 0; Presenti: 1.<br />
Informazioni su costi dei<br />
2<br />
biglietti<br />
Non presenti: 0; Presenti: 1.<br />
Informazioni sulle riduzioni<br />
3<br />
delle tariffe<br />
Non presenti: 0; Presenti: 1.<br />
Informazioni su convenzioni<br />
4 con enti/associazioni/ristoranti Non presenti: 0; Presenti: 1.<br />
ecc.<br />
5<br />
Possibilità di<br />
acquistare/prenotare biglietti Non presenti: 0; Presenti: 2.<br />
on line o per telefono<br />
Recapiti telefonici per<br />
6<br />
informazioni<br />
Non presenti: 0; Presenti: 1.<br />
Non possibile: 0;<br />
7 Possibilità di contatto via web Via mail: 1;<br />
Con form dedicato: 2.<br />
8<br />
9<br />
Informazioni su come<br />
raggiungere il museo<br />
Presenza Google Maps o<br />
sistema di mappe con<br />
posizione museo<br />
Non presenti: 0;<br />
Indicazioni generiche sul<strong>la</strong> posizione: 1;<br />
Informazioni sul<strong>la</strong> raggiungibilità con vari mezzi<br />
di trasporto: 2.<br />
Non presente: 0;<br />
Presente: 1;<br />
Presente + calcolo percorso: 2.<br />
10 Presenza di FAQ Non presenti: 0; Presenti: 2.<br />
11<br />
Informazioni dedicate ai<br />
diversamente abili<br />
Non presenti: 0;<br />
Solo segna<strong>la</strong>zione facilitazioni: 1;<br />
Informazioni dettagliate (modalità di visita,<br />
servizi appositi, parcheggi riservati ecc.): 2.<br />
12 Informazioni su audioguide Non presenti: 0; Presenti: 1.<br />
13 Informazioni su visite guidate Non presenti: 0; Presenti: 2.<br />
Informazioni su<br />
14 divieti/rego<strong>la</strong>menti Non presenti: 0; Presenti: 1.<br />
3. Museo (punteggio massimo: 38 punti)
N. Criterio Punteggi<br />
Non presente: 0;<br />
Una pagina informativa: 2;<br />
1 Storia del museo<br />
Storia ricca con sottosezioni: 4. +1 pt. se con<br />
immagini.<br />
2<br />
Informazioni sul<strong>la</strong> sede del<br />
museo<br />
3 Descrizione delle sale<br />
4<br />
5<br />
Informazioni su attività<br />
scientifiche e ricerca<br />
Informazioni sullo staff del<br />
museo<br />
6 P<strong>la</strong>nimetria<br />
7<br />
Pagine dedicate ai mecenati e<br />
alle iniziative di supporto<br />
8 Sezione multimedia<br />
9 Visita virtuale a 360°<br />
10 Sezione “Lavora con noi”<br />
Non presenti: 0;<br />
Presenti assieme a info storiche: 1;<br />
Una pagina informativa: 2;<br />
Informazioni ricche con storia del pa<strong>la</strong>zzo e<br />
sottosezioni: 4. +1 pt. se con immagini.<br />
Non presenti: 0;<br />
Una pagina informativa o highlight o descrizioni<br />
di un numero parziale di sale: 2;<br />
Ricche descrizioni delle singole sale: 5. +1 pt. se<br />
con immagini.<br />
Non presenti: 0; Presenti: 3.<br />
Non presenti: 0; Presenti: 2.<br />
Non presente: 0;<br />
Presente immagine: 1;<br />
P<strong>la</strong>nimetria navigabile (senza link alle pagine<br />
delle sale): 2;<br />
P<strong>la</strong>nimetria navigabile (con link alle sale): 3.<br />
Non presenti: 0; Presenti: 2.<br />
Non presente: 0.<br />
+2 punti per video; +2 punti per audio podcast.<br />
Non presente: 0;<br />
Selezione limitata di sale: 2;<br />
Visita virtuale a tutto il museo o al<strong>la</strong> maggior<br />
parte delle sale: 4.<br />
Non presente: 0;<br />
Presente: 3. +1 punto se con possibilità di<br />
candidatura diretta.
4. Patrimonio (punteggio massimo: 22 punti)<br />
N. Criterio Punteggi<br />
Non presenti: 0;<br />
Una pagina informativa o highlight: 2;<br />
1 Descrizioni Database distaccato: 5;<br />
opere/reperti/oggetti Descrizioni del<strong>la</strong> maggior parte di oggetti : 7. +1 se con<br />
immagini; +1 se con informazioni per specialisti (passaggi,<br />
bibliografie, presenza in archivi ecc.).<br />
2<br />
Motore di ricerca<br />
interno sale e<br />
Non presente: 0;<br />
Risultati nel motore di ricerca generico: 1; Motore dedicato:<br />
opere/oggetti/reperti 2. +1 se con specifiche avanzate.<br />
3 Percorsi tematici Non presenti: 0; Presenti: 4.<br />
4<br />
Notizie biografiche<br />
su artisti/personaggi Non presenti: 0; Presenti: 3.<br />
del museo<br />
Glossario dei<br />
5<br />
termini tecnici<br />
Non presente: 0; Presente: 3.<br />
5. Eventi (punteggio massimo: 17 punti)<br />
N. Criterio Punteggio<br />
Non presenti: 0;<br />
Una pagina con singole news:<br />
1 Informazioni su mostre in corso<br />
2;<br />
Sottosezioni dedicate alle<br />
mostre: 5.<br />
Non presenti: 0;<br />
Una pagina con singole news:<br />
2 Informazioni su mostre passate<br />
2;<br />
Sottosezioni dedicate alle<br />
mostre: 5.<br />
Non presenti: 0;<br />
Una pagina con singole news:<br />
Informazioni su conferenze, convegni, concerti, 1;<br />
3<br />
proiezioni ecc.
Sottosezione dedicata agli<br />
eventi: 3.<br />
Non presente: 0;<br />
4 Magazine dedicato agli eventi<br />
Presente e acquistabile: 1;<br />
Consultabile <strong>online</strong>: 2.<br />
5 Calendario dedicato agli eventi Non presente: 0; Presente: 2.<br />
6. Interazione (punteggio massimo: 20 punti)<br />
N. Criterio Punteggio<br />
Blog dedicato alle<br />
1 Non presente: 0; Presente: 3.<br />
iniziative del museo<br />
Non presente: 0;<br />
Meno di una volta al mese: 1;<br />
2 Aggiornamento del blog Mensile: 2;<br />
Settimanale: 3;<br />
Quotidiano: 4.<br />
3<br />
Possibilità di<br />
commentare<br />
4 Blog integrato nel sito<br />
Non presente: 0;<br />
Solo il blog o solo sottosezioni: 1;<br />
Blog e sottosezioni: 2. +1 se possibile commentare anche<br />
le opere. +1 se possibile commentare anche con il<br />
proprio profilo social.<br />
Non presente: 0;<br />
Non integrato (sottodominio o grafica differente): 1;<br />
Integrato: 2.<br />
5 Forum di discussione Non presente: 0; Presente: 1.<br />
6<br />
Possibilità di<br />
condividere i contenuti<br />
sui social network<br />
Non presente: 0;<br />
Solo i contenuti del blog: 1;<br />
La maggior parte delle pagine del sito: 1.<br />
7 Area personale Non presente: 0; Presente: 1.<br />
8<br />
Link ai profili social del<br />
museo<br />
Non presenti: 0;<br />
Presenti in una so<strong>la</strong> pagina del sito: 1;<br />
Presenti in tutte le pagine (header, footer... ): 2.
7. Educazione (punteggio massimo: 12 punti)<br />
N. Criterio Punteggio<br />
Informazioni su attività<br />
1<br />
educative<br />
Non presenti: 0; Presenti: 3.<br />
Informazioni su attività per<br />
2<br />
bambini<br />
Non presenti: 0; Presenti: 2.<br />
Articoli su attività svolte Non presenti: 0; Presenti: 3. +1 se con immagini.<br />
3<br />
(anche nel blog)<br />
+1 se con video.<br />
Giochi o applicazioni<br />
4<br />
educative<br />
Non presenti: 0; Presenti: 2.<br />
8. Servizi (punteggio massimo: 10 punti)<br />
N. Criterio Punteggio<br />
1<br />
Informazioni su bar e<br />
ristoranti<br />
2 Shop <strong>online</strong><br />
Non presenti: 0;<br />
Informazioni generiche: 1;<br />
Informazioni con fotografie e menù: 2.<br />
Non presenti: 0; Presenti: 1. +1 se con vendita di<br />
gadget del museo.<br />
Informazioni su<br />
3<br />
organizzazione eventi<br />
Non presenti: 0; Presenti: 1.<br />
4 Informazioni sul bookshop Non presenti: 0; Presenti: 1.<br />
Informazioni su archivi e<br />
5<br />
biblioteche<br />
Non presenti: 0; Presenti: 3.<br />
Informazioni sull’ufficio<br />
6<br />
stampa<br />
Non presenti: 0; Presenti: 1.<br />
9. Realizzazione tecnica: valutazione accessibilità (punteggio massimo: 14<br />
punti)<br />
N. Criterio Punteggio<br />
1 Rispetto standard W3C Sito non conforme: 0; Sito conforme: 2.
Sito senza <strong>la</strong>yout tableless o con struttura<br />
2 Layout tableless o basato su frame<br />
basata su frame: -2; Approccio misto: -1;<br />
Layout tableless: 0.<br />
3 Presenza di una DTD Non presente: -2; Presente: 0.<br />
4<br />
Separazione grafica/contenuti con<br />
fogli di stile CSS<br />
5 Alternative testuali per immagini<br />
Assenza di CSS esterni: -1; Presenza di CSS<br />
esterni: 0.<br />
Non presenti o vuote o non significative: 0;<br />
Presenti: 1.<br />
Non presenti o vuote o non significative: 0;<br />
Presenti: 1.<br />
Alternative testuali per elementi<br />
6<br />
multimediali (anche sottotitoli)<br />
Elementi <strong>la</strong>mpeggianti o in<br />
7<br />
movimento<br />
Non presenti: 0; Presenti: -2.<br />
Adeguato contrasto cromatico tra<br />
8<br />
sfondo e contenuti<br />
Non adeguato: -2; Adeguato: 0.<br />
Finestra del browser adattabile Con sovrapposizione: -2; Senza<br />
9<br />
senza sovrapposizione di elementi sovrapposizione: 0.<br />
Garanzia di utilizzo dei contenuti<br />
10 principali anche con Javascript Non garantito: -3; Garantito: 0.<br />
disabilitato<br />
Alternative per applet Java, script<br />
11<br />
JavaScript, elementi F<strong>la</strong>sh o altro<br />
Non presenti: 0; Presenti o non necessario: 1.<br />
12 Destinazione dei link chiara Non presente: 0; Presente: 1.<br />
13 Accesskey per i link principali Non presenti: 0; Presenti: 1.<br />
14 Dichiarazione di accessibilità Non presente: 0; Presente: 1.<br />
Funzionalità disponibili anche in<br />
15<br />
mancanza di fogli di stile<br />
Non presenti: -2; Presenti: 0.<br />
16 Form con etichette Non presenti: 0; Presenti o non necessarie: 1.<br />
Presenza di versioni accessibili in<br />
Non presenti: -2; Presenti o non necessarie o<br />
17 caso di mancanza requisiti di<br />
sito già accessibile: 0.<br />
accessibilità<br />
Identificazione del<strong>la</strong> lingua delle<br />
18<br />
pagine<br />
Non presente: 0; Presente: 1.<br />
19 Marcatori di lista per elenchi Non presenti: 0; Presenti: 2.<br />
Definizione del<strong>la</strong> corretta<br />
20<br />
sequenza di lettura<br />
Non presente: -2; Presente o non necessaria: 0.<br />
21 Testo ridimensionabile Non presente: -1; Presente: 0.
22 Suono e riproduzione control<strong>la</strong>bili Non presenti: -2; Presenti o non necessari: 0.<br />
in elementi multimediali<br />
Informazioni non basate solo sul<br />
23<br />
colore<br />
Non presenti: -1; Presenti: 0.<br />
24 Testo sotto forma di immagine Presente: 0; Non presente: 1.<br />
Estensioni in caso di azioni con<br />
25<br />
limiti di tempo<br />
Non presenti: -2; Presenti o non necessari: 0.<br />
26 Salto di blocchi <strong>la</strong>ddove necessario Non presenti: -1; Presenti o non necessari: 0.<br />
27 Ordine del focus preservato Non preservato: -1; Preservato: 0.<br />
28 Focus di un’azione evidenziato Non evidenziato: -1; Evidenziato: 0.<br />
29 Errori evidenziati e suggerimenti Non presenti: -3; Presenti o non necessari: 0.<br />
Pagine di conferma e controllo in<br />
30<br />
caso di inserimento dati<br />
Non presenti: -1; Presenti o non necessari: 0.<br />
9. Realizzazione tecnica: valutazione usabilità (punteggio massimo: 16 punti)<br />
N. Criterio Punteggio<br />
1 Dominio dedicato No: 0; Sì: 1.<br />
2 Motore di ricerca interno Non presente: 0; Presente: 2.<br />
3 Sp<strong>la</strong>sh page Non presente: 0; Presente: -1.<br />
4<br />
Title tag e meta description<br />
significativi<br />
Non presenti: 0;<br />
Solo title tag o solo meta description: 1;<br />
Presenti: 2.<br />
5 URL SEO Friendly Non presenti: 0; Presenti: 1.<br />
Popup o form JavaScript per Non presenti (o presenti, ma con adeguate<br />
6<br />
apertura contenuti<br />
alternative): 0; Presenti: -2.<br />
7 Uso di terminologia specialistica<br />
Non presente (o diversi percorsi in base ai<br />
tipi di pubblico): 1; Presente: 0.<br />
Citazioni bibliografiche o letture<br />
8<br />
consigliate<br />
Non presenti: 0; Presenti: 2.<br />
Menù di navigazione che non Cambio posizione: -2; Stessa posizione in<br />
9<br />
cambiano posizione<br />
tutto il sito: 0.<br />
Menù individuabile con chiarezza e<br />
10<br />
facilità<br />
Non intuitivo: -2; Intuitivo: 0.
11 Link ben evidenziati Non presenti: 0; Presenti: 1.<br />
12 Marcatori di lista puntati o numerati Non presenti: 0; Presenti: 1.<br />
Disabilitazione strumenti<br />
13<br />
navigazione<br />
Non presente: 0; Presente: -2.<br />
Se presente shop <strong>online</strong>, sicurezza Non presente: -3; Presente o non necessario:<br />
14<br />
transazioni e rispetto privacy 0.<br />
15 Mappa del sito Non presente: 0; Presente: 2.<br />
16 Pagine di aiuto per <strong>la</strong> navigazione Non presenti: 0; Presenti: 1.<br />
17 Elementi grafici ricorrenti Non presenti: 0; Presenti: 1.<br />
18 Breadcrumb Non presenti: 0; Presenti: 1.<br />
19 Pagine bilingui Non presenti: 0; Presenti: -2.<br />
9. Valutazione tecnica (punteggio massimo: 20 punti)<br />
N. Criterio Punteggio<br />
Meno di 300 kb: 5<br />
Tra 301 e 500 kb: 4<br />
1 Peso del<strong>la</strong> pagina<br />
Tra 501 kb e 1,00 Mb: 3<br />
Tra 1,01 Mb e 1,50 Mb: 1<br />
Oltre 1,50 Mb: 0<br />
Sotto 1 secondo: 5<br />
Tra 1,01 e 1,5 sec: 4<br />
2 Tempi di caricamento<br />
Tra 1,51 e 2,5 sec: 3<br />
Tra 2,51 e 3,5 sec: 1<br />
Oltre 3,51 sec: 0<br />
Meno di 70: 3<br />
Tra 70 e 110: 2<br />
3 Richieste HTTP<br />
Tra 111 e 150: 1<br />
Oltre 150: 0<br />
4 Presenza di immagini sca<strong>la</strong>te No: 0; In parte: 1; Tutte: 2.<br />
5 Immagini con dimensioni specificate No: 0; In parte: 1; Tutte: 2.<br />
6 Keep-Alive abilitato No: 0; Sì: 1<br />
7 CSS nel<strong>la</strong> head del documento No: -1: Sì: 0<br />
Da 0 a 100 kb: 2<br />
8 JavaScript deferring<br />
Da 101 a 200 kb: 1
Oltre 200 kb: 0.<br />
Bibliografia<br />
Thyge Moos e Ida Braendholdt Lundgaard (a cura di), The Museum’s web Users,<br />
Heritage Agency of Denmark, Copenaghen, 2010.<br />
Gray Browman, Silvia Filippini Fantoni e Robert Stein, Exploring the Re<strong>la</strong>tionship<br />
between visitor motivation and engagement in <strong>online</strong> museum audiences in Nancy<br />
Proctor e Rich Cherry (a cura di), Museums and the Web 2012: Proceedings, Museums<br />
and the Web, San Diego, 2012.<br />
Darren Peacock e Jonny Brownbill, Audiences, visitors, users: reconceptualising users of<br />
museum on-line content and services, Museums and the Web, San Francisco, 2007.<br />
Alessandro Andreini (a cura di), Il sito web del museo, Regione Toscana, Firenze,<br />
2008.<br />
Ruth Rentschler, Anne-Marie Hede, Museum Marketing: competing in the global<br />
marketp<strong>la</strong>ce, Butterworth-Heinemann, Oxford, 2008.<br />
Neil G. Kotler, Philip Kotler, Wendy I. Kotler, Museum Marketing and Strategy:<br />
designing missions building audiences generating revenues and resources, Jossey-Bass,<br />
San Francisco, 2008.<br />
Max Arends, Doron Goldfarb, Dieter Merkl e Martin Weingartner, Interaction with art<br />
museums on the web in Proceedings of the IADIS Int’l Conference WWW/Internet,<br />
Roma, 2009.<br />
Maria Teresa Balboni Brizza, Immaginare il museo: riflessioni sul<strong>la</strong> didattica e il<br />
pubblico, Jaca Book, Mi<strong>la</strong>no, 2006.<br />
Maria Teresa Natale e Rubino Saccoccio, Museo&Web: un kit pratico per le istituzioni<br />
<strong>cultura</strong>li che vogliono realizzare un sito web di qualità in Archeologia e calco<strong>la</strong>tori, ISSN<br />
1120-6861, N. 21, 2010 , pag. 27-47
Franco Cambi, Franca Gattini (a cura di), La scienza nel<strong>la</strong> scuo<strong>la</strong> e nel museo: percorsi<br />
di sperimentazione in c<strong>la</strong>sse e al museo, Armando, Roma, 2008.<br />
Michele Diodati, Accessibilità. Guida completa, Apogeo, Mi<strong>la</strong>no, 2007.<br />
Jeffrey Zeldman, Progettare siti web standard (traduzione di Livio Mondini), Paravia,<br />
Mi<strong>la</strong>no, 2007.<br />
Sofia Postai, Siti che funzionano 2.0, Hops, Mi<strong>la</strong>no, 2004.<br />
Riccardo Polesel, Promuoversi mediante internet, Franco Angeli, Mi<strong>la</strong>no, 2012.<br />
Jakob Nielsen, Designin web usability, Macmil<strong>la</strong>n, New York, 2000.<br />
Jakob Nielsen e Hoa Loranger, Prioritizing web usability, New Riders, Berkeley, 2006.<br />
Maurizio Boscarol, Ecologia dei siti web, Tecniche Nuove, Mi<strong>la</strong>no, 2003.<br />
Jakob Nielsen, Kara Pernice, Eyetracking web usability, New Riders, Berkeley, 2010.<br />
Giorgio Brajnik, Elio Toppano, Creare siti web multimediali, Paravia, Mi<strong>la</strong>no, 2007.
3. Tecniche di comunicazione per <strong>la</strong> <strong>cultura</strong> <strong>online</strong>: storytelling e<br />
content management<br />
Alessandro D’Amore<br />
Che cos’è lo storytelling<br />
Il termine storytelling è composto dalle parole story (storia) e telling (raccontare),<br />
indicando una tendenza che ultimamente va molto di moda in tantissimi ambiti<br />
professionali: “raccontare storie”.<br />
Colui che racconta una storia – potremmo dire in maniera professionale – seguendo i<br />
dettami dello storytelling è chiamato storyteller.<br />
Nel<strong>la</strong> lingua italiana abbiamo un altro nome, che ci portiamo dietro dal passato, meno<br />
professionale ma decisamente più evocativo: cantastorie. Con le dovute differenze e<br />
distinzioni, non c’è niente di più simile ad uno storyteller moderno: deve sviluppare<br />
delle capacità personali, seguire uno schema narrativo, utilizzare degli strumenti<br />
narrativi, catturare l’attenzione del pubblico e veico<strong>la</strong>re un messaggio che – spesso – è<br />
conoscenza.<br />
È una bellissima operazione di ritorno al passato, di riappropriazione di competenze<br />
che avevamo e che abbiamo sempre avuto, che non abbiamo mai perso e che<br />
dobbiamo solo consapevolmente recuperare. Un ritorno ai poemi omerici in cui <strong>la</strong><br />
notizia di una guerra, lunghissima e atroce, è arrivata fino a noi attraverso il racconto<br />
e l’incrocio di tante storie. L’Iliade, infatti, non è <strong>la</strong> cronaca di una guerra, ma il<br />
racconto di tante storie.<br />
Tutti noi abbiamo già sperimentato lo storytelling e gli effetti di questo processo su<br />
noi stessi fin dai nostri primi anni di vita. L’inizio di una fiaba, di un racconto<br />
fantastico, di una storia – appunto – raccontataci durante l’infanzia era una magica<br />
azione di storytelling.<br />
Lo storytelling è stato portato sotto i riflettori dal mondo del marketing, del<strong>la</strong><br />
comunicazione aziendale e del<strong>la</strong> pubblicità. Le grandi aziende si sono rese conto che<br />
il brand, il marchio, il “nome” non bastavano più. Le persone – e non più i<br />
consumatori – volevano delle storie. Esempi, in questo senso, sono lo spot natalizio di<br />
Apple e le due campagne pubblicitarie di P&G per Londra 2012 e Sochi 2014.<br />
In Italia ci siamo addirittura inventati un format televisivo per mettere in evidenza <strong>la</strong><br />
nostra bravura nello scrivere e nel raccontare. Tuttavia, chi da tempo ha fatto dello<br />
storytelling il suo punto di forza sono senza dubbio i documentari del National<br />
Geographic. Per par<strong>la</strong>rci di una specie, di una razza o di un ecosistema si sceglie un<br />
esemp<strong>la</strong>re (o una coppia), lo si “umanizza” e si racconta <strong>la</strong> sua vita dall’inizio al<strong>la</strong>
fine, prendendo spunto per raccontarci l’alimentazione, i rapporti sociali oppure come<br />
questi animali affrontano <strong>la</strong> morte. Non si tratta di storytelling? Certo che sì e anche<br />
del<strong>la</strong> miglior specie.<br />
La definizione più completa ed esaustiva per racchiudere in ultima analisi lo<br />
storytelling, è quel<strong>la</strong> di Gianluca Fiscato: raccontare «una storia capace di suscitare<br />
emozioni, spiegare i perché, illustrare i come e invogliare l’ascoltatore a cercare<br />
il cosa» 1 .<br />
Nei Paesi anglosassoni e oltreoceano – non solo perché <strong>la</strong> pratica dello storytelling e le<br />
riflessioni su questa specializzazione, anche in ambito <strong>cultura</strong>le, sono cominciate<br />
molto tempo fa – si preferisce fare un’ulteriore specifica e non par<strong>la</strong>re solo di<br />
storytelling bensì di digital storytelling, cioè raccontare una storia con tutte le<br />
caratteristiche di cui abbiamo detto ma su un medium digitale.<br />
A questo proposito, riportiamo <strong>la</strong> versione del<strong>la</strong> American Digital Storytelling<br />
Association che definisce il digital storytelling come «the modern expression of the<br />
ancient art of storytelling (in which) stories derive their power by weaving images, music,<br />
narrative, and voice together, giving deep dimension and vivid colour to characters,<br />
situations, experiences and insights» 2 .<br />
Bastano queste poche riflessioni per capire quanto uno strumento come il digital<br />
storytelling possa essere potente e utile nel settore <strong>cultura</strong>le italiano, inteso nel senso<br />
più ampio possibile.<br />
Ma perché mai un museo o un’istituzione <strong>cultura</strong>le dovrebbe darsi allo storytelling?<br />
Perché lo storytelling<br />
In un articolo del 2008, lo studioso americano Gary Carson ricorda come lo<br />
storytelling sia <strong>la</strong> condizione principale e fondamentale per rendere un museo<br />
rilevante per le persone, come lo storytelling sia <strong>la</strong> condicio sine qua non del<strong>la</strong><br />
sopravvivenza stessa di un museo e – non da ultimo – come lo storytelling sia «il<br />
potente mezzo attraverso il quale passa il moderno apprendimento» 3 .<br />
Questo meccanismo, dunque, si configura come lo strumento migliore per diffondere<br />
e agevo<strong>la</strong>re un nuovo modo di apprendere e di creare coinvolgimento a lungo termine<br />
nel pubblico.<br />
Nell’ultimo decennio si è ulteriormente sviluppato un filone di studi piuttosto<br />
interessante che analizza e approfondisce lo storytelling come strumento di<br />
apprendimento dal punto di vista pedagogico e socio-pedagogico. Come afferma<br />
Weick, «le storie sono una parte fondamentale del<strong>la</strong> nostra vita, sono utilizzate tutti i
giorni come significato nell’espressione di noi stessi e per trovare un modo per dare<br />
senso al<strong>la</strong> vita» 4 .<br />
È proprio a questo che si riferisce Carson nel suo articolo precedentemente citato: se<br />
un museo vuole significare qualcosa per le persone, se vuole essere rilevante per il suo<br />
pubblico, deve raccontare storie. Storie che non siano avulse dal<strong>la</strong> realtà circostante o<br />
dall’epoca presente, storie che parlino di persone comuni, storie attraverso cui gli<br />
ascoltatori possano identificarsi e partecipare al<strong>la</strong> creazione di significato, per se<br />
stessi e per <strong>la</strong> comunità.<br />
I collegamenti tra l’apprendimento e lo storytelling sono evidenziati in un articolo di<br />
Josephs 5 in cui argomenta chiaramente come il raccontare storie crei molteplici<br />
significati e sia il modo migliore per collegare le esperienze personali le une alle<br />
altre attraverso il “baratro dell’ignoto”. In partico<strong>la</strong>re, lo storytelling ci permette di<br />
andare oltre <strong>la</strong> semplice esperienza e di fare un salto di significato, che ci fa vedere<br />
oltre, ci fa capire e apprendere. In definitiva, per Josephs, lo storytelling è un processo<br />
attivo che collega le singole esperienze attraverso <strong>la</strong> riflessione per farci giungere ad<br />
un significato non evidente che chiamiamo conoscenza.<br />
Il potere e le potenzialità che vivono nello storytelling sono state bril<strong>la</strong>ntemente<br />
fermate in una frase di altri due studiosi americani, McDrury e Alterio: «quando<br />
raccontiamo delle storie e le analizziamo, utilizzando dialoghi riflessivi, creiamo <strong>la</strong><br />
condizione e <strong>la</strong> possibilità di generare dei cambiamenti, in noi stessi e negli<br />
altri» 6 .<br />
Una possibilità da poter sfruttare non di poco conto per un museo.<br />
Inoltre gli studiosi propongono anche un modello di apprendimento basato sullo<br />
storytelling e sulle tecniche di costruzione e decostruzione delle storie al<strong>la</strong> ricerca di<br />
significato delle esperienze che vi invito a consultare.<br />
Come abbiamo visto brevemente, lo storytelling è uno strumento potentissimo che<br />
attende solo di essere esplorato, studiato e sperimentato con cognizione di causa dai<br />
musei e dalle istituzioni <strong>cultura</strong>li del nostro Paese.<br />
Ad un’attenta analisi, non manca nul<strong>la</strong> alle nostre istituzioni: hanno le storie (le<br />
collezioni di ogni singolo museo), hanno il microfono (tutti gli strumenti web, dai<br />
social media ai blog), hanno un pubblico al<strong>la</strong> ricerca di storie (i milioni di utilizzatori<br />
del<strong>la</strong> rete).<br />
Quindi, se non manca nul<strong>la</strong>, perché finora non ci siamo alzati dalle nostre sedie e<br />
abbiamo cominciato a raccontare storie? Forse perché finora nessuno ci aveva detto<br />
che potevamo farlo, o come potevamo farlo, o perché farlo.<br />
I nuovi strumenti che <strong>la</strong> modernità mette a disposizione ci forniscono un ulteriore<br />
incentivo per intraprendere questa strada e per al<strong>la</strong>rgare i nostri orizzonti e i nostri
obiettivi.<br />
Se un museo vuole ripensare il suo ruolo all’interno del territorio e delle comunità in<br />
cui agisce, deve necessariamente ripensare se stesso ed essere pronto a far crol<strong>la</strong>re<br />
virtualmente i propri muri e le proprie teche per far “par<strong>la</strong>re” le proprie collezioni<br />
attraverso i racconti dei dipendenti e dei visitatori.<br />
Come si fa lo storytelling<br />
Sembrerà banale ribadirlo, ma ovviamente non c’è un solo modo di fare storytelling; se<br />
ne potrebbero individuare molteplici varianti.<br />
Per fortuna, lo storytelling è uno strumento malleabile e – se conosciuto<br />
opportunamente – può essere adattato, modificato, riprodotto ed esportato in<br />
qualsiasi contesto. In sostanza, esistono infiniti modi di raccontare storie tanti quanti<br />
sono gli infiniti contesti che si possono raccontare.<br />
Quando mi riferisco agli infiniti contesti, non sto esagerando ma sto facendo<br />
semplicemente riferimento al<strong>la</strong> realtà: tutto può essere raccontato utilizzando gli<br />
strumenti dello storytelling.<br />
Un caso di studio (esemp<strong>la</strong>re ed estremo allo stesso tempo) del 2008 lo dimostra: si<br />
può raccontare anche il nul<strong>la</strong>. L’agenzia spagno<strong>la</strong> Shackleton Group ha deciso di<br />
organizzare un esperimento per testare l’efficacia di una campagna pubblicitaria<br />
altamente targettizzata di un prodotto mai promosso prima da <strong>la</strong>nciare solo sui canali<br />
satellitari tematici specifici. È stata scelta <strong>la</strong> promozione turistica di un paesino<br />
dell’Aragona, Miravete de <strong>la</strong> Sierra, con 12 abitanti tutti ultra settantenni, girando uno<br />
spot televisivo, creando un sito web ad hoc, una ricostruzione virtuale del paese e del<br />
merchandising. Il punto focale del<strong>la</strong> campagna era rivolto al fatto che in quel paese<br />
non succedesse nul<strong>la</strong>, infatti <strong>la</strong> frase finale dello spot era: “qui non succede mai nul<strong>la</strong>.<br />
E a te, da quanto tempo è che non ti succede nul<strong>la</strong>? Visita Miravete de <strong>la</strong> Sierra”. Al<strong>la</strong><br />
fine dell’esperimento, il sito aveva ricevuto 517 mi<strong>la</strong> visite, l’awareness del paesino<br />
era cresciuta del 489% e – cosa non trascurabile – i due bed & breakfast del paese<br />
hanno registrato il tutto esaurito per 4 mesi di fi<strong>la</strong> 7 .<br />
Siccome non vogliamo riferirci allo storytelling tout court, ma solo fare un riferimento<br />
specifico al panorama museale, possiamo individuare tre principali modalità di<br />
racconto:<br />
– lo storytelling diretto, in cui il museo si racconta in prima persona, è<br />
<strong>la</strong> voce narrante del<strong>la</strong> storia;
– lo storytelling indiretto, in cui il museo si fa raccontare dai suoi<br />
visitatori, ci sono quindi tante voci narranti;<br />
– lo storytelling partecipativo, in cui il museo svolge <strong>la</strong> funzione di<br />
primus inter pares, è solo una delle tante voci narranti.<br />
Si può essere tentati di pensare che, nel<strong>la</strong> maggior parte dei casi, sarebbe preferibile<br />
lo storytelling partecipativo, soprattutto continuando a leggere l’articolo di Carson: «le<br />
persone sono stanche di ascoltare i monologhi dei cosiddetti esperti, vogliono entrare<br />
a far parte di una comunità ed entrare in contatto con i loro pari per condividere<br />
esperienze, conoscenze e capacità» 8 .<br />
In realtà, non è esattamente così: non c’è una modalità che funziona e una che non<br />
funziona, una giusta e una sbagliata. Esistono casi di successo per ognuna di queste<br />
categorie.<br />
Il discrimine sta sempre nel modo in cui si racconta e nel<strong>la</strong> metodologia che si<br />
utilizza.<br />
Follow the leaders, loro ti diranno come fare<br />
Fortunatamente, molte altre persone prima di noi hanno studiato, sperimentato,<br />
praticato e par<strong>la</strong>to di storytelling. Quindi non dobbiamo far altro che studiare:<br />
cercare sempre nuovo materiale, nuovi casi di studi, inserire su Google le parole<br />
chiave che ci interessano: tutto è lecito. L’importante è non smettere mai di avere<br />
fame di conoscenza.<br />
E non si fa riferimento solo alle pubblicazioni scientifiche, agli articoli oppure agli
atti dei convegni sparsi per il territorio nazionale e mondiale, ma ci si rivolge anche ai<br />
blog, ai forum, alle pagine Facebook, a qualsiasi cosa. Perché di solito gli storyteller –<br />
quelli bravi e con idee geniali – adorano avere un blog da curare, in cui scrivere le<br />
loro riflessioni, i loro pensieri o semplicemente avere un posto dove par<strong>la</strong>re dei propri<br />
progetti. Quei blog vanno considerati come vere e proprie oasi nel deserto.<br />
È buona norma iscriversi a tutti i blog che sembrano meritevoli di attenzione, seguire<br />
le pagine Facebook interessanti, richiedere l’iscrizione a dei gruppi che sembrano<br />
trattare argomenti che rientrano nei vostri interessi, ricercare almeno una volta a<br />
settimana l’hashtag #storytelling su Twitter, dedicare almeno un’ora al giorno nel<strong>la</strong><br />
ricerca di nuovo materiale.<br />
È così che sono riuscito a redigere una lista delle caratteristiche principali e<br />
fondamentali che una storia deve avere per essere rilevante per i nostri pubblici. Una<br />
grande mano me l’ha data anche Emma Coats, probabilmente pochi di voi <strong>la</strong><br />
conosceranno perché è una regista free<strong>la</strong>nce. Perché un/a professionista museale<br />
dovrebbe interessarsi ad una regista free<strong>la</strong>nce? Perché ha <strong>la</strong>vorato con <strong>la</strong> Pixar, e chi<br />
meglio delle persone che <strong>la</strong>vorano lì sanno come si racconta una storia?<br />
Così <strong>la</strong> regista ha twittato, tempo fa, i suoi personali 22 suggerimenti per raccontare<br />
una storia. Ne citerò solo i più significativi e quelli che più si adattano al nostro<br />
contesto:<br />
«#1: You admire a character for trying more than for their successes;<br />
#4: Once upon a time there was ___. Every day, ___. One day ___.<br />
Because of that, ___. Because of that, ___. Until finally ___<br />
#8: Finish your story, let go even if it’s not perfect. In an ideal world<br />
you have both, but move on. Do better next time;<br />
#13: Give your characters opinions. Passive/malleable might seem<br />
likable to you as you write, but it’s poison to the audience;<br />
#17: No work is ever wasted. If it’s not working, let go and move on –<br />
it’ll come back around to be useful <strong>la</strong>ter».<br />
Altre fonti nel<strong>la</strong> mia esperienza sono stati Ed Rodley, Associate Director of<br />
Integrated Media al Peabody Essex Museum in Salem, e un sito internet americano<br />
“The Moth, True Stories Told Alive”.<br />
Il professor Rodley ha partecipato all’American Alliance Museums di quest’anno che<br />
si è tenuto a Seattle e – insieme ad altre eminenti personalità, tra le quali Nina Simon<br />
del Santa Cruz Museum of Arts & History – ha organizzato un panel dedicato allo<br />
storytelling: “Telling stories about storytelling”. Siccome lo spirito di condivisione di<br />
idee, pratiche e informazioni contraddistingue gli storytellers, Rodley ci rega<strong>la</strong> questo
Story Tip Sheet. È preziosissimo e ci ricorda che fortunatamente «there’s an<br />
underlying structure that propels a story and holds people’s attention. Something big<br />
is at stake; you’ve set out on a quest. There’s a conflict: you face trials, torments, a test.<br />
There’s a twist, a surprising turn of events. The story builds up to a climax: the “moment<br />
of change”. Then, resolution».<br />
Ma il professionista che ha reso <strong>la</strong> vita di ogni storyteller decisamente più facile è stato<br />
Jasper Visser.<br />
Nel suo blog “The Museum of the Future”, ha provato a delineare le caratteristiche che<br />
deve avere una storia per attirare l’attenzione del pubblico e soprattutto per far sì che<br />
il pubblico interagisca con <strong>la</strong> voce narrante, ovvero l’istituzione stessa.<br />
Innanzitutto <strong>la</strong> fiducia e <strong>la</strong> coerenza. Gli ascoltatori hanno fiducia nel narratore?<br />
Esiste coerenza tra ciò che sei e ciò che racconti? Sembra un dettaglio, ma in realtà è<br />
<strong>la</strong> solida base di partenza per qualsiasi operazione di storytelling.<br />
La storia deve:<br />
– essere unica e deve avere dei contenuti inaspettati. Pensate a<br />
quanti miti o luoghi comuni si potrebbero sfatare se i musei<br />
cominciassero a raccontare tutte le storie “inaspettate” che ci sono al<br />
loro interno;<br />
– svilupparsi cercando di muovere emozioni. Le più grandi<br />
narrazioni – pensate, per esempio, ai gialli di Conan Doyle – si basano<br />
sulle emozioni: fondamentale utilizzare nel<strong>la</strong> narrazione conflitti,<br />
soluzioni, tensioni, misteri e rive<strong>la</strong>zioni;<br />
– par<strong>la</strong>re del pubblico, deve generare re<strong>la</strong>zione, in modo che gli<br />
ascoltatori possano identificarsi con i nostri personaggi. Per usare le<br />
parole di Visser, «bisogna trattare i propri ascoltatori come degli eroi,<br />
ogni volta che dici loro qualcosa»;<br />
– creare connessioni fisiche nel<strong>la</strong> vita reale, non deve essere fine a se<br />
stessa, deve essere capace di trasformare un lettore interessato in un<br />
partecipante entusiasta.<br />
Esserci non vuol dire raccontarsi: i tempi e i modi<br />
Prima di andare avanti, facciamo un brevissimo riassunto schematico delle
caratteristiche irrinunciabili che – secondo guru e studiosi – una storia deve avere<br />
(liberamente ispirato dall’infografica di ABC Copywriting e da Riccardo Esposito):<br />
– fiducia. Le persone che ascoltano <strong>la</strong> storia hanno fiducia nel<br />
narratore? Hanno fiducia in te? Questo aspetto è fondamentale per<br />
garantire <strong>la</strong> buona riuscita del<strong>la</strong> tua azione di storytelling;<br />
– emozioni. Le storie hanno bisogno di uno sviluppo che tocchi le<br />
emozioni. Grandi narrazioni si basano su grandi emozioni: conflitti,<br />
soluzioni, tensioni, misteri e rive<strong>la</strong>zioni;<br />
– re<strong>la</strong>zione. Il pubblico deve identificarsi nel racconto. Questo<br />
passaggio ci permetterà di creare un rapporto speciale: identificarsi con<br />
il personaggio di una storia vuol dire <strong>la</strong>sciarsi trasportare nel<strong>la</strong><br />
narrazione;<br />
– semplicità. Una storia semplice è una storia forte. Togliamo tutto ciò<br />
che non serve al<strong>la</strong> narrazione: tagliamo eventi meno importanti, uniamo<br />
due personaggi minori in uno, riduciamo al minimo menzioni ad altri<br />
luoghi;<br />
– personale. Il destinatario vuole dare un significato personale al<strong>la</strong><br />
storia. Noi possiamo indicare <strong>la</strong> struttura, possiamo suggerire dei<br />
riferimenti, ma dobbiamo <strong>la</strong>sciare spazio alle persone di applicare una<br />
propria morale del<strong>la</strong> favo<strong>la</strong>;<br />
– immersione. A volte il pubblico si immerge completamente in una<br />
storia, vive le esperienze raccontate in prima persona e diventa il<br />
personaggio principale. Ecco, questo è l’obiettivo di ogni storyteller;<br />
– familiare. L’audience valuta nuove storie confrontandole con quelle<br />
che già conosce. Storie diverse possono condividere una struttura<br />
col<strong>la</strong>udata, uno sviluppo riconoscibile e facile da inquadrare.<br />
È utile ribadire questi punti non solo perché sono molto importanti nel<strong>la</strong> costruzione<br />
di una storia – cioè del<strong>la</strong> nostra comunicazione <strong>online</strong> – e perché le liste aiutano a<br />
memorizzare ed esemplificare i concetti, ma anche perché dobbiamo sempre tenerli<br />
presente in qualsiasi manifestazione testuale o visuale realizziamo per il web.
Passiamo alle note negative.<br />
Il peggior nemico dello storyteller / comunicatore è l’autoreferenzialità. Scrivere<br />
storie che riguardano poche persone, affrontare argomenti e tematiche che<br />
interessano noi e non il nostro pubblico, scrivere pensando a noi e non ai nostri<br />
lettori.<br />
Il secondo peggior nemico dello storyteller / comunicatore è pensare di aver fatto<br />
abbastanza.<br />
Aprire un blog e scrivere solo un post di benvenuto, iscriversi ad un social network e<br />
postare ogni mattina <strong>la</strong> scritta “buongiorno” – magari accompagnata da un’immagine<br />
a caso –, fare il live-tweeting di un evento ben riuscito e poi dimenticarsi dei follower<br />
oppure caricare un video su YouTube e poi trascurare il canale. Tutte queste cose non<br />
sono storytelling, non sono raccontarsi. Il racconto e <strong>la</strong> comunicazione non sono<br />
implicite nel<strong>la</strong> presenza <strong>online</strong>, devono essere programmate, progettate ed e<strong>la</strong>borate.<br />
Il terzo peggior nemico dello storyteller / comunicatore è <strong>la</strong> costanza. Se il museo o<br />
l’istituzione <strong>cultura</strong>le vuole intraprendere un’azione di storytelling e di comunicazione<br />
<strong>online</strong> deve pianificare l’organizzazione e l’e<strong>la</strong>borazione dei contenuti giornalmente o<br />
– quantomeno – settimanalmente. La scrittura e il racconto devono rientrare tra le<br />
attività quotidiane: sia che si tratti di post sul blog, di foto nel<strong>la</strong> bacheca di Pinterest o<br />
di mini-video montati con l’applicazione Vine.<br />
Ovviamente si tenderà a pensare che tutto questo vada a scontrarsi inesorabilmente<br />
con l’organizzazione interna di un museo. Invece – per esperienza diretta e indiretta –<br />
vi assicuro che potreste rimanere molto sorpresi di quanti vantaggi e soluzioni possa<br />
portare il content p<strong>la</strong>nning, o meglio, <strong>la</strong> pianificazione dei contenuti.<br />
Non esagero in difetto se dico che 5 ore a settimana siano sufficienti per produrre un<br />
post di 250 parole, programmare tweet per 7 giorni e schedu<strong>la</strong>re condivisioni su<br />
Facebook. Come si diceva, l’attività non deve essere casuale ma programmata<br />
preventivamente. Solo se si ha ben chiaro dove si vuole arrivare e come arrivarci, si<br />
può scegliere <strong>la</strong> strada più comoda da percorrere.<br />
Dopo aver detto cos’è lo storytelling, perché utilizzarlo nel<strong>la</strong> nostra strategia<br />
comunicativa, quali sono le caratteristiche che trasformano <strong>la</strong> nostra storia in una<br />
buona storia, ripassiamo i tre mantra del<strong>la</strong> comunicazione <strong>online</strong>:<br />
– rimaniamo concentrati sul pubblico, dobbiamo scrivere cosa<br />
interessa loro, non quello che ci piace;<br />
– l’improvvisazione è abolita, tutto deve essere progettato e<br />
pianificato;
– <strong>la</strong> costanza è tutto, renderete i vostri lettori fedeli e desiderosi dei<br />
vostri contenuti.<br />
Il tempio tetrastilo è morto: le scelte linguistiche<br />
Il punto nevralgico è questo: se vogliamo usare strumenti nuovi, dobbiamo<br />
utilizzare un linguaggio nuovo.<br />
Non possiamo scrivere un post per il blog del nostro museo con lo stesso stile e lo<br />
stesso vocabo<strong>la</strong>rio con cui Giuseppe Fiorelli teneva il suo diario dei <strong>la</strong>vori durante le<br />
escavazioni di Pompei nell’800. È assolutamente necessaria una diversificazione dei<br />
registri.<br />
I professionisti del settore museale non devono smettere di utilizzare termini<br />
specialistici né devono limitarsi ad un lessico di 100 parole, ma devono esercitarsi a<br />
trovare il giusto registro per il re<strong>la</strong>tivo strumento. Quindi l’inevitabile<br />
accorgimento necessario è sempre lo stesso: ricordarsi a chi stiamo scrivendo, chi<br />
leggerà questo nostro scritto.<br />
Se ci rivolgiamo a dei professionisti, possiamo fare sfoggio del nostro miglior<br />
compendio specialistico. Ma, se non sappiamo precisamente chi potrebbe leggere il<br />
nostro scritto, dobbiamo dare a tutti – indipendentemente dal grado di istruzione – <strong>la</strong><br />
possibilità e gli strumenti per capire ciò che scriviamo. Non è dietro ai tecnicismi che<br />
si sviluppa <strong>la</strong> mission di un museo.<br />
La riflessione può essere ampliata ulteriormente e non limitar<strong>la</strong> al<strong>la</strong> so<strong>la</strong><br />
comunicazione <strong>online</strong>, perché anche nel<strong>la</strong> comunicazione offline (pannellistica,<br />
brochure, flyer, didascalie che accompagnano le vetrine) dovrebbe vigere <strong>la</strong> stessa<br />
rego<strong>la</strong>. Per esempio, cosa impedisce in un museo di sostituire un cartellino con <strong>la</strong><br />
didascalia “frammento policromo di fregio del tempio tetrastilo A – fase II” con un<br />
più semplice “frammento decorativo colorato del tempio del 250 a.C.”?<br />
Questo caso – assolutamente vero – evidenzia, in tutta <strong>la</strong> sua drammaticità, il pericolo<br />
dell’autoreferenzialità.<br />
Quando scriviamo qualcosa da pubblicare <strong>online</strong> o da esporre in pubblico, non<br />
scriviamo mai per noi o per i nostri colleghi. Questo è un punto fermo dal quale non<br />
discostarsi mai.<br />
Per scrivere belle storie bisogna utilizzare le parole giuste. Spesso queste parole non<br />
sono roboanti o altisonanti, ma sono semplici e d’uso comune.<br />
Spiegare fenomeni complessi con parole quotidiane, che possono capire tutti, che<br />
rendono <strong>la</strong> complessità del mondo e degli eventi semplice, è il vero segreto dei<br />
grandi divulgatori.
Se i musei vogliono continuare a tenere fede al<strong>la</strong> definizione ufficiale del 2001<br />
dell’International Council of Museums 9 (“Museum is a non-profit making, [...] which<br />
acquires, conserves, researches, communicates and exhibits for purpose of study”), per<br />
comunicare efficacemente con i propri pubblici devono adeguarsi agli strumenti<br />
comunicativi del tempo presente e utilizzare un vocabo<strong>la</strong>rio vicino alle persone.<br />
Dopo queste riflessioni metodologiche irrinunciabili, passiamo in rassegna dei<br />
semplici accorgimenti che possono aiutare nel<strong>la</strong> scrittura:<br />
– utilizzare <strong>la</strong> forma attiva;<br />
– evitare parole complesse o tecnicismi, meglio un vocabo<strong>la</strong>rio di uso<br />
comune;<br />
– se esiste una paro<strong>la</strong> per spiegare un concetto, è consigliato utilizzar<strong>la</strong>;<br />
– sempre meglio <strong>la</strong> forma affermativa, evitando in partico<strong>la</strong>r modo <strong>la</strong><br />
doppia negazione per affermare;<br />
– preferire i verbi ai sostantivi, appesantiscono il testo e lo rendono<br />
meno dinamico;<br />
– arrivare al punto, non perdiamo tempo con introduzioni infinite e<br />
riduciamo le parole “inutili” (cioè quelle <strong>la</strong> cui presenza o assenza non<br />
modifica il significato del testo);<br />
– utilizzare <strong>la</strong> piramide rovesciata, seguendo lo schema: informazione<br />
importante, dettagli di supporto, informazioni re<strong>la</strong>tive (qui potete<br />
approfondire;<br />
– scrivere, rileggere e (eventualmente) riscrivere;<br />
– leggere i commenti ma non prenderli tutti in considerazione, le<br />
critiche possono aiutarci a migliorare, ma non dobbiamo dipendere dal<br />
giudizio altrui;<br />
– leggere molto;
– scrivere moltissimo, l’ispirazione non viene a comando e ridurre il<br />
vizio del<strong>la</strong> procrastinazione è una buona norma.<br />
A questo punto, chiudiamo questo paragrafo con <strong>la</strong> parziale riproposizione di una<br />
famosa “bustina di Minerva” di Umberto Eco 10 da “Il mestiere di scrivere”. Un modo<br />
tutto partico<strong>la</strong>re, spettaco<strong>la</strong>re e geniale di fornire 40 suggerimenti utili secondo il<br />
prof. Eco per scrivere bene. Ecco i più bril<strong>la</strong>nti:<br />
«2. Non è che il congiuntivo va evitato, anzi, che lo si usa quando<br />
necessario.<br />
6. Ricorda (sempre) che <strong>la</strong> parentesi (anche quando pare<br />
indispensabile) interrompe il filo del discorso.<br />
11. Sii avaro di citazioni. Diceva giustamente Emerson: “Odio le<br />
citazioni. Dimmi solo quello che sai tu.”<br />
19. Metti, le virgole, al posto giusto.<br />
27. Non essere enfatico! Sii parco con gli esc<strong>la</strong>mativi!<br />
32. Cura puntiliosamente l’ortograffia.<br />
40. Una frase compiuta deve avere.»<br />
Anche l’occhio vuole <strong>la</strong> sua parte: l’organizzazione del testo scritto<br />
Dopo aver analizzato le parole da utilizzare e quelle da evitare, le forme migliori e<br />
quelle peggiori, pensiamo al<strong>la</strong> forma che dovremmo dare alle parole, a come<br />
strutturare un testo in maniera che sia facilmente leggibile.<br />
Di seguito si citerà abbondantemente un bellissimo e fondamentale post dal blog di<br />
Luisa Carrada, dal titolo “Sul web così si legge, così si scrive (dati al<strong>la</strong> mano)” 11 .<br />
Alcuni passi saranno riportati pari pari – e contrassegnati da virgolette per<br />
evidenziarne <strong>la</strong> maternità – perché sono troppo importanti (e ben scritti) per essere<br />
smembrati o modificati e soprattutto perché mai nessuno li aveva inseriti in una<br />
trattazione specificamente destinata ai professionisti museali.<br />
Per capire come organizzare un testo scritto, sembra lecito chiedersi in realtà in che<br />
modo si legge. Questa domanda se l’è posta Jakob Nielsen nel 2007 e si è dato anche<br />
una risposta: “Come si legge sul web? Non si legge”.<br />
Infatti «<strong>la</strong> lettura che si fa sugli schermi è profondamente diversa da quel<strong>la</strong> che<br />
abbiamo sempre fatto sui libri e sui giornali di carta (molto più diversa del<strong>la</strong><br />
scrittura!). Nielsen continua a studiar<strong>la</strong> e oggi ha compendiato i risultati delle sue<br />
ricerche in un pdf di 355 pagine: “How people read on the web”, che dà moltissime
indicazioni su come scrivere testi efficaci, sintetizzate in 83 linee-guida.<br />
La lettura è prima di tutto un’azione visiva: prima si guarda, poi si decodifica.<br />
Sul web questo è ancora più vero: il testo vive insieme alle immagini, diventa esso<br />
stesso immagine, come nei titoli e nelle infografiche. La lettura è <strong>la</strong> più importante<br />
attività che si fa in rete. Il testo è il filo che connette tutto.<br />
Eppure c’è una sorta di paradosso in questo, che rende le nostre navigazioni convulse e<br />
non sempre appaganti: si legge tanto, ma si cerca di leggere il meno possibile. La<br />
lettura in rete è soprattutto esplorazione: si cerca di capire al volo quali parti del<strong>la</strong><br />
pagina leggeremo, quali salteremo, quali guarderemo velocemente, quali ignoreremo<br />
totalmente. Il tutto in pochissimi secondi. Se il testo passa questo primo esame, è più<br />
probabile che leggeremo almeno alcune parti in maniera più tranquil<strong>la</strong> e profonda,<br />
che stamperemo <strong>la</strong> pagina per appuntar<strong>la</strong> e sottolinear<strong>la</strong>.<br />
Raramente il nostro testo sarà letto per intero. Esplorare più che leggere è una<br />
strategia di sopravvivenza, efficace in una rete fin troppo affol<strong>la</strong>ta.<br />
Ma non si esplora a caso, anzi esploriamo seguendo strategie ben precise. Ed è<br />
interessante sapere che queste strategie non cambiano se siamo nativi digitali,<br />
smanettoni smaliziati o neofiti del web. Tutti guardiamo più o meno le stesse cose.<br />
Può anche capitare di leggere tutto, ma è l’eccezione, non <strong>la</strong> rego<strong>la</strong>, e questo avviene<br />
quando <strong>la</strong> motivazione è partico<strong>la</strong>rmente forte.<br />
Nielsen individua quattro strategie di lettura sul web, ma c’è un caso in cui<br />
possiamo essere assolutamente certi che il nostro testo non incontrerà i suoi lettori:<br />
quando è un muro di parole, fitto, con le righe troppo lunghe, l’interlinea<br />
insufficiente, nessuna andata a capo, senza stili del carattere variati.<br />
La modalità con cui abbordiamo questo tipo di testi è nota: <strong>la</strong> forma a F.<br />
Nota perché Nielsen ne ha par<strong>la</strong>to moltissimo e perché è stata confermata da altri
studi autorevoli come quelli del Poynter Institute. Si legge per intero l’incipit, il primo<br />
capoverso, per capire di cosa si par<strong>la</strong>. Man mano che si procede, si tende a leggere<br />
solo l’inizio dei capoversi e in misura sempre minore, fino ad abbandonare <strong>la</strong> lettura.<br />
In questo modo, molte informazioni rischiano di venire del tutto escluse<br />
dall’attenzione del lettore. Se poi si comincia, come spesso si fa, con ritualità<br />
introduttive e non con l’informazione più importante, il rischio diventa certezza.<br />
Se da lettori cerchiamo di leggere il meno possibile e puntare alle parti del testo più<br />
interessanti, da autori dobbiamo strutturare il testo in maniera da far emergere i<br />
motivi di interesse a colpo d’occhio e far fermare il lettore in quel<strong>la</strong> manciata di<br />
secondi in cui ci giochiamo tutto.<br />
Per questo Nielsen raccomanda <strong>la</strong> struttura millefoglie: capoversi brevi, staccati e<br />
tito<strong>la</strong>ti con chiarezza, da scorrere subito e velocemente uno dopo l’altro come si<br />
affonda <strong>la</strong> forchetta nel famoso dolce.<br />
Non si leggerà comunque tutto, ma almeno si troverà ciò che interessa. Se ben<br />
applicato, il millefoglie convince a leggere anche pagine piuttosto lunghe.<br />
Spesso gli utenti si fanno un’idea di una pagina anche in meno di un secondo. In<br />
questa prima valutazione l’elemento più importante è il titolo. Quando c’è, oltre <strong>la</strong><br />
metà degli utenti lo legge.<br />
I titoli si devono assolutamente vedere e percepire come tali e per questo si può usare<br />
ogni tipo di accorgimento: colore, dimensioni, spazi, font. I titoli sono una sorta di<br />
faro, ma non esageriamo con l’evidenziazione visiva, altrimenti il disorientamento è<br />
assicurato.<br />
All’inizio l’attenzione è sempre al massimo, anche sul<strong>la</strong> carta. Non sappiamo ancora<br />
nul<strong>la</strong>, non abbiamo niente da supporre, da indovinare, nessun luogo dove <strong>la</strong> mente può<br />
correre in avanti. Man mano che accumuliamo informazioni, invece, <strong>la</strong> mente si<br />
mette a fare quel che le piace di più: anticipare. Per questo l’incipit è, insieme al<br />
titolo, il testo più importante. Non solo l’incipit di tutto il testo, ma anche del singolo<br />
capoverso, del<strong>la</strong> singo<strong>la</strong> frase. Le persone leggono le prime poche parole di una riga<br />
molto più di tutto il resto e spessissimo <strong>la</strong>sciano <strong>la</strong> riga a metà. Per questo le parole<br />
più importanti devono stare all’inizio:<br />
– Nel titolo, perché aiuta l’occhio, <strong>la</strong> mente e anche il motore di<br />
ricerca;<br />
– Nel primo capoverso, spesso l’unico che si legge per intero. Perché<br />
dà l’idea del tutto, come una cornice, e permette di capire che cosa<br />
viene dopo. Una volta capito, l’occhio continua <strong>la</strong> sua esplorazione con<br />
una “lettura spot”, oppure si concentra in quel<strong>la</strong> impegnata. Il primo<br />
capoverso è quindi decisivo. Il crollo del<strong>la</strong> lettura avviene tra il terzo e
quarto: l’81% degli utenti legge il primo capoverso, il 71% il secondo, il<br />
63% il terzo, solo il 32% il quarto;<br />
– Nel<strong>la</strong> frase, perché le prime parole sono quelle a più alta probabilità<br />
di lettura. Se sono vuote, piatte, se non contengono indicazioni o<br />
informazioni, sarà l’intera frase a essere abbandonata;<br />
– Nelle voci di una lista: se <strong>la</strong> prima paro<strong>la</strong> è sempre <strong>la</strong> stessa, l’utente<br />
<strong>la</strong> salta per andarsi a cercare da solo quel<strong>la</strong> diversa. A proposito di liste,<br />
i bullet sono importanti: il 70% guarda <strong>la</strong> lista con i bullet, soltanto il<br />
55% quel<strong>la</strong> senza bullet».<br />
Quindi, se non vogliamo vanificare i precedenti tre passi all’interno del<strong>la</strong> nostra<br />
strategia comunicativa che hanno riguardato l’organizzazione del<strong>la</strong> storia, <strong>la</strong> scelta<br />
dell’argomento e <strong>la</strong> selezione delle parole, dovremo imparare a rispettare anche i<br />
principi basi<strong>la</strong>ri del<strong>la</strong> disposizione del testo in una pagina web.<br />
Best practices<br />
Per esigenze di spazio, sono stati scelti solo cinque casi in cui l’istituzione museale ha<br />
programmato e messo in pratica un’eccellente azione di storytelling. Va da sé che<br />
abbiamo dovuto tra<strong>la</strong>sciare molti altri contesti italiani ed europei, ma questo non vuol<br />
dire che non siano meritevoli di nota. Anche in questo caso è valido l’invito a non<br />
smettere mai di cercare.<br />
Storytelling indiretto – De<strong>la</strong>ware Art Museum, Wilmington<br />
Nel 2007 il museo d’arte del De<strong>la</strong>ware <strong>la</strong>ncia un progetto che già dal nome non <strong>la</strong>scia<br />
nul<strong>la</strong> al caso: “The Art of Storytelling”. L’idea è quel<strong>la</strong> di integrare le visite guidate<br />
delle sco<strong>la</strong>resche al museo e i programmi formativi sco<strong>la</strong>stici con un momento di<br />
coinvolgimento diretto dei partecipanti. Poi però il progetto si amplia, è stato<br />
al<strong>la</strong>rgato il target a cui si rivolge e gli è stato dedicato un apposito sito (collegato ma<br />
autonomo rispetto al sito web del museo). L’idea è semplice: raccontateci <strong>la</strong> storia<br />
che vi ha ispirato questo o quel quadro che avete potuto ammirare durante <strong>la</strong> vostra
visita al museo.<br />
Nel<strong>la</strong> sua semplicità, l’idea funziona e ben presto diventa un punto di riferimento per<br />
<strong>la</strong> comunità e attira le attenzioni degli specialisti. Dopo le prime 6 settimane sono<br />
arrivate al museo 350 storie. Allora il museo decide di al<strong>la</strong>rgare il suo bacino di<br />
potenziali partecipanti al progetto e decide di caricare <strong>online</strong> una galleria di immagini<br />
dei suoi dipinti più famosi per permettere anche alle persone che non hanno mai<br />
visitato il museo di poter raccontare <strong>la</strong> propria storia. In realtà il museo fa molto di<br />
più: aggiunge un’ulteriore sezione al sito dedicato (“Picture a story”) in cui è<br />
addirittura possibile creare <strong>la</strong> propria “storia per immagini” prendendo elementi,<br />
paesaggi e personaggi dai dipinti caricati <strong>online</strong> dal museo.<br />
A distanza di diversi anni, il sito contiene migliaia di storie (raccontate attraverso<br />
parole ed immagini) categorizzate per soggetto o tema, valorizzate, votate e<br />
incentivate (infatti le migliori vengono registrate dagli utenti stessi e inserite nelle<br />
audio-guide ufficiali).<br />
Riprendendo le parole dei curatori, «abbiamo scoperto che stimo<strong>la</strong>re <strong>la</strong> capacità di<br />
raccontare dei visitatori è un modo efficace per coinvolgerli e per indurli a pensare e<br />
a guardare l’arte in maniera critica e creativa allo stesso tempo. Inoltre queste<br />
iniziative hanno un riscontro positivo anche per le istituzioni museali sia perché si<br />
raggiungono e si coinvolgono nuovi pubblici sia perché permettono di ricevere un<br />
valido feedback dell’azione svolta del museo nel<strong>la</strong> comunità» 12 .<br />
Storytelling diretto – Statens Museum for Kunst, Copenaghen<br />
La Galleria d’Arte Nazionale del<strong>la</strong> Danimarca dal 1998 (anno in cui è stata inaugurata<br />
<strong>la</strong> nuova a<strong>la</strong> del museo) fino ad oggi, ha sempre inseguito rinnovamento e<br />
innovazione.<br />
Oltre ad un’eccellente opera di digitalizzazione e condivisione delle sue maggiori<br />
opere <strong>online</strong> e a diversi programmi di coinvolgimento da parte di target giovani o<br />
molto giovani, <strong>la</strong> Galleria ha intrapreso un’interessante e mirata azione di racconto del<br />
museo portata avanti dai restauratori e dai curatori in un’apposita sezione del sito.<br />
Come si usa dire, il nome è tutto un programma, ma è semplice ed efficace: “Stories<br />
from the Conservator”. Non lezioni o articoli specialistici: storie.<br />
I post sono brevi, ricchi di immagini e redatti utilizzando un vocabo<strong>la</strong>rio<br />
semplice e termini di uso comune (ovviamente tutti i post – ma possiamo anche dire<br />
tutto il sito – sono scritti in doppia lingua: danese e inglese). Non sono previsti<br />
commenti ai post, ma <strong>la</strong> discussione, le domande e le curiosità si spostano facilmente<br />
sul<strong>la</strong> pagina Facebook o sul profilo Twitter del museo.
Nello stesso spazio dedicato al <strong>la</strong>voro e al racconto dei restauratori attraverso <strong>la</strong><br />
scrittura, c’è anche un altro pezzo di una grande azione di storytelling: <strong>la</strong> sezione video.<br />
I restauratori in tre minuti par<strong>la</strong>no del <strong>la</strong>voro che stanno svolgendo, di come lo stanno<br />
svolgendo e del perché. Nessun “parolone” o tecnicismo, si spiega il proprio <strong>la</strong>voro<br />
come lo si farebbe a degli amici al tavolo di un bar, senza mai essere banali.<br />
Ovviamente i video hanno tutti i sottotitoli in inglese.<br />
Il museo ha anche un blog in cui vengono trattati temi maggiormente specialistici e<br />
metodologici (ad esempio, “Possono degli adulti essere tentati di fermarsi a disegnare<br />
nel bel mezzo di una mostra d’arte?”) ma in maniera meno assidua.<br />
Storytelling partecipativo – MoMA New York<br />
La scelta strategica del colosso museale di New York è stata di farsi raccontare e di<br />
raccontarsi, in un mix virtuoso, accattivante e stimo<strong>la</strong>nte. Nel suo blog (anche in<br />
questo caso il titolo è un piccolo capo<strong>la</strong>voro) – “Inside/Out” – il museo si propone di<br />
portare “quello che c’è dentro” al museo, fuori, verso i visitatori, e far “entrare nel<br />
museo” ciò che viene da fuori, dai visitatori. Un colpo di genio semantico. Ma non<br />
solo, perché <strong>la</strong> trovata non si ferma al<strong>la</strong> scelta del nome o all’opportunità di mettere<br />
interno ed esterno del museo sullo stesso livello di importanza e di collegarli sul<strong>la</strong><br />
stessa piattaforma, ma fa un ulteriore passo in avanti quando si arriva al<strong>la</strong> categoria<br />
“Viewpoints”, punti di vista. La prima sottosezione è “I went to MoMA and” e <strong>la</strong><br />
seconda “Intern Chronicles” (senza trascurare un altro bello spazio per tutti coloro che<br />
volessero scrivere del<strong>la</strong> loro esperienza al MoMA – “Visitor viewpoint”).<br />
Non c’era un modo migliore per dare <strong>la</strong> stessa importanza e lo stesso spazio sia al<br />
parere, al giudizio e al punto di vista dei visitatori che a quello degli operatori<br />
museali. I visitatori possono dare un riscontro immediato del<strong>la</strong> loro visita con gli<br />
ormai famosi cartoncini che il museo fornisce all’ingresso e sui quali si possono<br />
scrivere, disegnare le proprie impressioni.<br />
Insomma, <strong>online</strong> e offline, operatori e visitatori, tutto nell’attività di storytelling del<br />
MoMA è perfettamente integrato per esistere e co-esistere in armonia e coerenza.<br />
Storytelling sui social network: Facebook – Musee de <strong>la</strong> Grande Guerre di Pays de<br />
Meaux<br />
In occasione del centenario dell’entrata in guerra del<strong>la</strong> Francia durante <strong>la</strong> Prima<br />
Guerra Mondiale, il museo ha organizzato questa bellissima iniziativa per far rivivere
l’orrore e sensibilizzare, in definitiva per comunicare.<br />
Ipotizzando che Facebook esistesse sin dagli inizi del Novecento, è stata raccontata <strong>la</strong><br />
storia di Léon Vivien, un insegnante di 29 anni, realmente esistito, che ha vissuto in<br />
prima persona l’orrore del conflitto: ha <strong>la</strong>sciato il suo paese, gli amici, <strong>la</strong> famiglia e<br />
una moglie incinta per entrare nell’esercito dopo <strong>la</strong> morte del migliore amico.<br />
Il profilo dell’insegnante è stato aggiornato per ben dieci mesi, durante i quali Léon ha<br />
raccontato cosa stesse succedendo, le sue emozioni, l’angoscia, l’ansia di dover vivere<br />
ogni giorno a contatto con il pericolo: si può dire, insomma, che il macrocosmo del<br />
Primo Conflitto Mondiale è stato riprodotto nel microcosmo del<strong>la</strong> sua anima e<br />
proiettato sul social network di Zuckerberg.<br />
Immagini originali, dialoghi diretti e scambi di battute con altri 9 personaggi, fino al<br />
tragico finale del 22 maggio 1915, riassunto in una straziante frase al<strong>la</strong> moglie: “Ho<br />
paura, Made<strong>la</strong>ine. Ti amo. Sono arrivati”.<br />
L’iniziativa ha avuto talmente tanto successo che il museo ha aumentato del 45% il<br />
flusso dei visitatori in meno di un anno.<br />
Storytelling sui social network: Twitter – Historic Royal Pa<strong>la</strong>ces, Londra<br />
Il dipartimento dei servizi educativi del<strong>la</strong> Torre di Londra ha coinvolto – nell’ambito<br />
di alcune attività sco<strong>la</strong>stiche – un gruppo di studenti delle scuole londinesi in un<br />
progetto che facesse rivivere le storie, le disavventure e a volte le ingiustizie subite<br />
dai reclusi e condannati a morte che sono passati dal<strong>la</strong> prigione inglese nei secoli.<br />
Attraverso una ri-scrittura del<strong>la</strong> loro vita, basata sui documenti ufficiali, e in<br />
partico<strong>la</strong>re delle ultime 24 ore che trascorsero nel<strong>la</strong> Torre, gli studenti hanno dato<br />
voce a questi personaggi attraverso una serie di tweet che seguivano – appunto – le<br />
loro ultime ore di vita prima dell’esecuzione, potremmo quasi dire in diretta con il<br />
passato.<br />
L’esperimento non si è fermato all’aspetto social ma è proseguito: infatti i ragazzi<br />
hanno curato una sezione ufficiale del sito e hanno registrato in alcuni file audio le<br />
storie migliori e più affascinanti che l’istituzione ha reso disponibili su iTunes.
4. I social network per <strong>la</strong> <strong>cultura</strong>: quali sono, a cosa servono e come<br />
possono essere utilizzati dai musei<br />
Francesca De Gottardo e Valeria Gasparotti, con <strong>la</strong> col<strong>la</strong>borazione di Astrid D’Eredità<br />
Cosa sono i social network e perché sono importanti per i musei<br />
Da quando esiste, il web è sempre stato percepito come uno strumento che mette in<br />
collegamento le persone. Il concetto si è ampliato esponenzialmente dopo <strong>la</strong> nascita<br />
del Web 2.0, un nuovo modo di concepire Internet che ruota intorno al<strong>la</strong> capacità di<br />
permettere l’interazione tra l’utente e <strong>la</strong> rete.<br />
La conseguenza diretta di questa evoluzione è stata <strong>la</strong> comparsa dei social media,<br />
ovvero di tutte quelle applicazioni che si basano sui presupposti ideologici del Web<br />
2.0 e che consentono <strong>la</strong> creazione e lo scambio di contenuti generati dagli utenti, gli<br />
User Generated Content (UGC). In altre parole, i social media sono un servizio <strong>online</strong><br />
per <strong>la</strong> costruzione di comunità virtuali di persone che condividono gli stessi interessi.<br />
Grazie a questa caratteristica, i social media hanno rivoluzionato il modo di fare<br />
informazione, trasformando le persone da fruitori di contenuti in produttori e<br />
curatori. Inoltre, quello che era un monologo “uno a molti” nel Web 1.0 si è<br />
trasformato in un dialogo “molti a molti”, caratteristico del Web 2.0.<br />
In realtà, i social network sono sempre esistiti e Facebook e Twitter non sono altro<br />
che l’evoluzione <strong>online</strong> del<strong>la</strong> teoria delle reti sociali, studiata fin dal diciannovesimo<br />
secolo dagli esperti di antropologia e sociologia e riferita alle complesse dinamiche<br />
re<strong>la</strong>zionali che esistono tra i membri di tutti i sistemi sociali, a qualsiasi livello.<br />
Secondo <strong>la</strong> teoria delle reti sociali, un “social network” è una struttura sociale<br />
composta da nodi – ovvero individui o organizzazioni – che sono legati tra loro da una<br />
o più tipologie di rapporto di interdipendenza, come i valori, le aspirazioni, lo<br />
scambio economico, l’amicizia, l’odio e così via. Tutte le re<strong>la</strong>zioni sociali si possono<br />
riassumere in termini di nodi e legami: i nodi sono gli attori individuali del network, i<br />
legami sono le re<strong>la</strong>zioni che essi riescono a stabilire tra loro.<br />
Di conseguenza, un “web social network”, come può essere Facebook, non fa altro che<br />
ricreare in un mondo virtuale le infinite strutture sociali composte da individui e<br />
re<strong>la</strong>zioni.<br />
Martin Stiksel, fondatore del social network musicale Last.fm, riassume in una frase<br />
tutte le implicazioni di quanto appena esposto “I think the future of social networks still<br />
lies in the connections between people and the potential that lies in these connections. If<br />
there is a possibility to pool all of this knowledge, like there is in a social network, to the
enefit of everybody, that’s a really, really powerful thing.” (Fonte Co-bw.com)<br />
Perché i musei dovrebbero sapere cosa sono i social network e, soprattutto, perché<br />
dovrebbero utilizzarli?<br />
È una domanda che è più che lecito porsi e <strong>la</strong> prima risposta che si è tentati di dare è<br />
quel<strong>la</strong> sbagliata, almeno parzialmente: “perché lo fanno tutti”. È vero, oggi una<br />
considerevole percentuale del<strong>la</strong> popo<strong>la</strong>zione mondiale utilizza questi strumenti. Basti<br />
pensare che i dati di inizio 2014 per l’Italia testimoniano <strong>la</strong> penetrazione dei social<br />
media presso il 52% del<strong>la</strong> popo<strong>la</strong>zione totale, mentre il 92% degli utenti che<br />
accedono a internet possiede almeno un account social (dati We Are Social).
Sono numeri impressionanti, ma dovrebbero indurci ad ampliare il ragionamento<br />
rispetto al semplice “voler esserci”. Se così tante persone utilizzano i social network e<br />
se lo scopo principale di questi media è <strong>la</strong> costruzione di comunità sul<strong>la</strong> base del<br />
principio che “l’amico del mio amico è mio amico”, il potenziale per i musei è<br />
enorme, soprattutto in termini di engagement e di quelle che nel marketing chiamano<br />
brand awareness e brand image, ovvero <strong>la</strong> riconoscibilità di un museo e il tipo di<br />
percezione che è in grado di generare presso il pubblico.<br />
I social network sono lo strumento ideale per le organizzazioni <strong>cultura</strong>li che vogliano<br />
costruire una forte comunità intorno ai propri valori e alle proprie collezioni, poiché<br />
si tratta di strumenti che consentono, allo stesso tempo, sia di condividere<br />
informazioni di qualsiasi tipo in tempo reale, sia di sfruttare rapidamente ed<br />
esponenzialmente le re<strong>la</strong>zioni tra i nodi del<strong>la</strong> rete sociale.<br />
Inoltre, queste piattaforme consentono di superare il tradizionale approccio “top<br />
down”, tipico delle istituzioni che <strong>la</strong>vorano nell’ambito del<strong>la</strong> conoscenza (Università,<br />
media, musei, biblioteche etc.).<br />
In altre parole, grazie ai social network, un museo ha <strong>la</strong> possibilità di condividere in<br />
rete i propri contenuti più interessanti, creativi e aggiornati – come video, fotografie,<br />
eventi e iniziative <strong>online</strong> di qualunque tipo (contest, meeting, live-chat, quiz). Allo<br />
stesso tempo però, gli utenti possono partecipare, commentare e perfino creare<br />
contenuti a loro volta.
Questo approccio si discosta dall’immagine tradizionalmente associata a un museo,<br />
percepito come autoritario, inaccessibile e complesso. Nello stesso tempo,<br />
quest’immagine è in grado di raggiungere un numero esponenziale di persone,<br />
ovunque esse si trovino nel mondo e senza che ci sia un diretto collegamento con <strong>la</strong><br />
struttura, perché può sfruttare i collegamenti che esistono tra gli utenti, legati da<br />
interessi e amicizie in comune, ma anche dall’appartenenza alle stesse community o a<br />
community collegate.<br />
Quindi, i social network sono oggi il modo più semplice e rapido per i musei per<br />
raggiungere nuovi utenti e creare nuove comunità di pubblico, grazie al fatto che il<br />
Web 2.0 ha cambiato i meccanismi al<strong>la</strong> base dei comportamenti d’acquisto e i<br />
consumatori di oggi si fidano molto di più del cosiddetto word of mouth orizzontale<br />
– o più c<strong>la</strong>ssico “passaparo<strong>la</strong>” – rispetto al<strong>la</strong> tradizionale comunicazione verticale di<br />
tipo pubblicitario.<br />
In aggiunta a questa considerazione su brand awareness e brand image, e forse ancora<br />
importante, è <strong>la</strong> possibilità offerta dai social network di creare un dialogo del tipo<br />
“molti a molti” con gli utenti che fanno parte di una determinata comunità.<br />
I musei che vogliono costruire una re<strong>la</strong>zione a doppio senso con il loro pubblico,<br />
sostituendo<strong>la</strong> a quel<strong>la</strong> c<strong>la</strong>ssica “dall’alto verso il basso”, trovano in questi strumenti un<br />
utile supporto strategico. Grazie al<strong>la</strong> co-creazione dei contenuti, <strong>la</strong> comunità degli<br />
appassionati può diventare parte attiva nel<strong>la</strong> vita delle istituzioni e interagire in prima<br />
persona con il museo di cui è sostenitrice.<br />
Tramite questa forma preziosissima di engagement, il museo ha un ulteriore canale di<br />
dialogo con il proprio pubblico, ne riceve i feedback immediati sulle proprie attività,<br />
lo coinvolge in alcune decisioni e lo rende partecipe di quello che succede dietro le<br />
quinte.<br />
Tuttavia, è importante precisare che, senza un’adeguata strategia di trasformazione<br />
radicale dell’istituzione, i social media rischiano di rappresentare uno dei tanti trend<br />
tecnologici che si esauriscono con il tempo. Par<strong>la</strong>re di trasformazione digitale<br />
significa investire tempo e risorse nel<strong>la</strong> riflessione sui valori e sul<strong>la</strong> mission<br />
dell’istituzione. Sono questi stessi valori, infatti, che possono essere aperti al pubblico<br />
grazie ai social media, in un rapporto di co-creazione di significato, invece che di<br />
semplice trasmissione a senso unico dei contenuti.<br />
Nei paragrafi che seguono, descriveremo le caratteristiche e le possibilità di utilizzo<br />
per le principali piattaforme social. Tuttavia, questo testo non vuole essere esaustivo:<br />
esistono, infatti, numerose altre modalità di creazione e divulgazione di contenuti per<br />
i musei che non sono affrontate in questo ebook. Blog, mobile media (mobile app,
audio guide) e chioschi interattivi sono altri esempi di piattaforme che i musei<br />
possono adottare per generare significato intorno alle loro collezioni. “Condividere” e<br />
“connettersi” sono ormai diventate le parole chiave che influenzano il nostro modo di<br />
vivere, pensare e <strong>la</strong>vorare. Di conseguenza, non possiamo pensare che il pubblico di<br />
un museo si aspetti di sospendere questi comportamenti quando visita o si interfaccia<br />
con un’istituzione <strong>cultura</strong>le.<br />
Una nota<br />
Gli esempi riportati all’interno di questo capitolo sono frutto di una ricerca iniziata<br />
nel<strong>la</strong> primavera 2014 e terminata mentre scriviamo. Il settore di cui ci stiamo<br />
occupando – social network in ambito museale – è in continua evoluzione e gli<br />
esempi riportati servono a fornire un’ispirazione, ma non escludiamo che, a breve<br />
tempo dall’uscita di questo ebook, possano risultare già “#old” se comparati a progetti<br />
più recenti.<br />
Bibliografia<br />
G. Mannucci, “Art institutions and web social networks: Facebook’s innovation in<br />
reaching new markets”, 2008<br />
D.J. Watts, S.H. Strogatz, “Collective Dynamics of ‘Small World’ Network”, Nature<br />
1998<br />
M.E.J. Newman, A.L. Barabasi, D.J. Watts, “The Structure and Dynamic of Complex<br />
Networks”, Princeton University Press, 2003<br />
Il Sole 24 ore, “Il fenomeno Facebook”, Nòva, 2008
Facebook<br />
Cos’è<br />
Spiegare cosa sia Facebook sembra oggi del tutto superfluo, considerando quanto<br />
questo social network è entrato a far parte delle vite di tutti noi. È indicativo il fatto<br />
che in Italia ci siano più di 26 milioni di account Facebook su 35 milioni di utenti<br />
connessi a Internet e su 61 milioni di popo<strong>la</strong>zione totale: più di un terzo del Paese<br />
utilizza questa piattaforma e vi trascorre una media di due ore e mezza al giorno (Dati<br />
We Are Social).<br />
Com’è nato il “re” dei social network? Facebook ha fatto <strong>la</strong> sua comparsa in stato<br />
embrionale nel febbraio del 2004, grazie all’idea di uno studente di Harvard che oggi<br />
è una super star del digitale e conta un patrimonio personale che supera i 25 miliardi<br />
di dol<strong>la</strong>ri. L’idea originale di Mark Zuckerberg si chiamava Facemash ed era poco<br />
più di un sito web goliardico interno al campus che permetteva di votare gli studenti<br />
in base all’aspetto fisico, utilizzando le immagini prese dagli album sco<strong>la</strong>stici (i<br />
facebook, per l’appunto). L’evoluzione del programma, The Facebook.com, era<br />
originariamente progettata per i soli studenti di Harvard, ma fu presto aperta anche<br />
agli studenti di altre università del<strong>la</strong> zona di Boston, del<strong>la</strong> Ivy League e del<strong>la</strong> Stanford<br />
University. Nel 2006, Facebook ha aperto le sue porte anche a chi non possedeva un
indirizzo email “.edu”, con <strong>la</strong> so<strong>la</strong> condizione che avesse più di 13 anni di età.<br />
Nel tempo di un anno dal<strong>la</strong> sua apertura al pubblico, Facebook ha sca<strong>la</strong>to <strong>la</strong><br />
graduatoria dei siti più visitati, passando dal<strong>la</strong> sessantesima al<strong>la</strong> settima posizione,<br />
secondo il sito americano Alexa che si occupa di statistiche sul traffico di Internet.<br />
Dal luglio 2007, il social network di Zuckerberg è stabilmente nel<strong>la</strong> c<strong>la</strong>ssifica dei 10<br />
siti più visitati al mondo ed è il primo sito negli Stati Uniti per foto visualizzabili.<br />
L’Italia ha iniziato a scoprire Facebook nel 2008, quando si è registrato un boom di<br />
presenze che è andato aumentando fino a raggiungere le impressionanti cifre attuali.<br />
In totale, oggi Facebook è disponibile in oltre 70 lingue e conta 1,310 miliardi di<br />
utenti attivi, aggiundicandosi il titolo di più grande social network del mondo (fonte<br />
Mashable).<br />
Come funziona<br />
Dal momento che, secondo le statistiche, una persona su tre ha già un suo profilo<br />
Facebook attivo, il rischio di essere banali nello spiegare come funziona questo social<br />
media è veramente alto, per cui ci limiteremo ad alcune indicazioni di massima,<br />
rimandando a Facebook.com/help e a Mashable.com/Facebook-for-beginners per<br />
eventuali approfondimenti.<br />
Iniziare ad utilizzare Facebook è estremamente facile: basta fornire un indirizzo<br />
email valido e alcuni dati personali come nome, cognome e data di nascita. La<br />
registrazione è gratuita, così come tutte le funzionalità del<strong>la</strong> piattaforma, dal<br />
momento che Facebook ricava i suoi profitti dalle pubblicità (banner, advertising e<br />
post sponsorizzati).<br />
Una volta completata <strong>la</strong> registrazione, gli utenti possono creare il loro profilo<br />
personale, scegliendo <strong>la</strong> propria profile picture (160x160 pixel) e <strong>la</strong> cover image<br />
(851x315 pixel), inviando richieste di amicizia ai propri contatti email e cercando<br />
altri utenti tramite lo strumento di ricerca messo a disposizione dal<strong>la</strong> piattaforma.<br />
Tramite <strong>la</strong> funzione “Settings”, è possibile impostare i livelli di privacy del proprio<br />
profilo e le notifiche che si desidera ricevere in re<strong>la</strong>zione ai diversi tipi di attività<br />
degli amici nei nostri confronti (tag, menzioni, like, condivisioni, messaggi diretti).<br />
La sezione “Activity log”, invece, consente di tenere sotto controllo <strong>la</strong> nostra attività<br />
e <strong>la</strong> timeline del nostro profilo.<br />
La home di un profilo Facebook raccoglie i news feed sulle attività degli amici e delle<br />
pagine di cui siamo fan. Quando <strong>la</strong> si consulta da desktop, <strong>la</strong> piattaforma consente<br />
ancora di impostare <strong>la</strong> modalità con cui si desidera visualizzare il feed di notizie,
offrendo <strong>la</strong> scelta tra “Top stories” e “Most recent”, mentre da mobile non è più<br />
possibile decidere e il flusso di notizie segue l’algoritmo di Facebook.<br />
Ma che cos’è l’algoritmo di Facebook? Si chiama Edge Rank ed è <strong>la</strong> formu<strong>la</strong> che<br />
determina <strong>la</strong> visibilità di un post, creato da un utente o da una pagina, all’interno dei<br />
news feed degli amici o dei fan. Ovvero, se “edge” è qualunque tipo di notizia – un<br />
post, un link, una foto, un video, un “mi piace”, un commento, un cambio di status, e<br />
così via –, l’edge rank è l’ordine in cui ci vengono presentate le attività del<strong>la</strong> nostra<br />
rete. Quando apriamo Facebook, infatti, non vediamo ogni azione che hanno fatto i<br />
nostri amici, le persone che seguiamo o le pagine su cui abbiamo messo “mi piace” e<br />
questo succede perché Facebook fa una selezione dei contenuti e ci presenta quelli<br />
che, in base alle sue valutazioni delle nostre attività, dovrebbero essere più rilevanti<br />
per noi.<br />
Di conseguenza, capire il funzionamento dell’edge rank è fondamentale per chi<br />
gestisce una pagina Facebook e vuole che più persone possibile ne vedano gli update.<br />
L’algoritmo che rego<strong>la</strong> il meccanismo di ranking è stato reso pubblico per <strong>la</strong> prima<br />
volta nel 2010 e da allora ha subito più modifiche. Quando scriviamo, l’edge rank di<br />
Facebook risponde a questo principio: ∑ = fe ue we nfe.<br />
Dove fe è <strong>la</strong> frequenza di pubblicazione, che entra in re<strong>la</strong>zione con ue, ovvero<br />
l’Affinity score tra l’autore del post e l’utente che lo visualizza, we, che è il “peso” del<br />
post, e nfe, il negative feedback.<br />
In altre parole, <strong>la</strong> visibilità di un post su Facebook è condizionata, in primo luogo,<br />
dal<strong>la</strong> re<strong>la</strong>zione che c’è tra chi scrive e chi legge (affinity score): se visitiamo spesso il<br />
profilo di un amico o <strong>la</strong> pagina di un’azienda, se facciamo like ai contenuti di<br />
quell’utente, se commentiamo, se abbiamo molti amici in comune, Facebook deduce<br />
che c’è un alto livello di affinità tra di noi e che, di conseguenza, i contenuti di<br />
quell’amico o di quell’azienda sono interessanti per noi.<br />
Un altro fattore molto importante da considerare è il “peso” del post, ovvero il<br />
numero di like, condivisioni e commenti che quel post ha ricevuto da parte di tutti gli<br />
altri utenti, in partico<strong>la</strong>re dai nostri amici. È da tenere presente che, per Facebook,<br />
post che contengono fotografie e video sono più interessanti rispetto a post<br />
puramente testuali e avranno più possibilità di essere visti, mentre quelli contenenti<br />
link che rimandino l’utente al di fuori del<strong>la</strong> piattaforma abbassano decisamente il<br />
“peso”, e quindi <strong>la</strong> visibilità, del post.<br />
Infine, rientrano nel calcolo del rank anche quanto spesso abbiamo interagito in<br />
passato con un certo tipo di post e se noi o altre persone abbiamo nascosto o bloccato<br />
quel post (fonti utili per capire l’edge rank sono Whatisedgerank.com,<br />
Socialbakers.com e Alessandrafarabegoli.it).
Il totale degli utenti che vede un post su Facebook è definito “Reach” ed è influenzato<br />
da tutti i fattori appena esposti. In media, circa il 6% degli utenti – nostri amici o<br />
fan di una pagina – riesce a visualizzare un post senza investimenti in Facebook<br />
advertising.<br />
Profili, fan page e gruppi<br />
Facebook è una piattaforma dall’architettura complessa e l’utente può scegliere se<br />
gestire, oltre al proprio profilo personale, anche fan page e gruppi, che possono a loro<br />
volta essere aperti, chiusi o segreti.<br />
Profilo personale. È composto da due sezioni principali, selezionabili grazie ai<br />
pulsanti in alto a destra nel<strong>la</strong> barra di Facebook: <strong>la</strong> “Home”, che raccoglie le attività<br />
dei propri amici e delle pagine di cui si è fan (il news feed del profilo risponde ai<br />
principi dell’edge rank che abbiamo appena esaminato), e il profilo vero e proprio, o<br />
diario, nel quale gli amici possono <strong>la</strong>sciarci messaggi, postare foto e commentare foto<br />
e messaggi che abbiamo postato a nostra volta. Facebook permette di impostare i<br />
livelli di privacy che vogliamo applicare ai contenuti presenti nel nostro profilo e di<br />
decidere quali informazioni personali vengano visualizzate da chi lo visita. È possibile<br />
gestire direttamente <strong>la</strong> sezione “About” e modificare le voci che ci interessano.<br />
Chi può aprire un profilo su Facebook? Chiunque abbia più di 13 anni e dimostri di<br />
essere una persona fisica, con un nome e cognome e una data di nascita. Account<br />
multipli, furto d’identità e utilizzo del profilo da parte di aziende e organizzazioni<br />
rappresentano vio<strong>la</strong>zioni dei termini di utilizzo del<strong>la</strong> piattaforma.<br />
Fan page. Nate nel 2007, le pagine Facebook sono rivolte a tutte le entità che non<br />
sono persone fisiche e che vogliono essere rappresentate su questo social network. In<br />
sostanza, <strong>la</strong> fan page è <strong>la</strong> soluzione perfetta per istituzioni pubbliche, organizzazioni,<br />
associazioni e aziende private che vogliano utilizzare Facebook per costruire un<br />
dialogo con il proprio pubblico. Quando visualizziamo una pagina, troviamo tutte le<br />
informazioni sull’ente o sull’azienda nel<strong>la</strong> tab al di sotto del<strong>la</strong> cover image e possiamo<br />
decidere di diventarne fan schiacciando il tasto “like”. In questo modo, Facebook ci<br />
terrà aggiornati sulle attività di quell’ente o azienda. Se scorriamo verso il basso gli<br />
aggiornamenti del<strong>la</strong> pagina, possiamo commentarli, fare like e condividere nel nostro<br />
profilo quelli che ci piacciono partico<strong>la</strong>rmente.<br />
Chiunque può aprire una fan page, anche se solo i rappresentanti ufficiali possono<br />
agire per conto di un’azienda o di un ente o personaggio pubblico. Per creare una
pagina, è sufficiente selezionare l’apposita voce nel menu in alto a destra nel<strong>la</strong> barra<br />
di Facebook e seguire le istruzioni del<strong>la</strong> piattaforma per scegliere il tipo di ente che si<br />
rappresenta e il settore di appartenenza, inserire <strong>la</strong> propria descrizione, il sito internet<br />
di riferimento e l’immagine di profilo. Una volta che si sono impostate queste<br />
caratteristiche di base, <strong>la</strong> pagina è attiva ed è personalizzabile con numerose opzioni,<br />
sia di gestione, sia di visualizzazione. Il creatore di una pagina può autorizzare altri<br />
utenti a gestir<strong>la</strong>, scegliendo di assegnare diversi livelli di responsabilità. Chi ha gli<br />
accessi admin del<strong>la</strong> pagina, può visualizzare gli Insights e può decidere se attivare<br />
eventuali campagne di advertising per aumentare <strong>la</strong> visibilità dei post (per questi<br />
argomenti, rimandiamo al capitolo 5 di questo ebook).<br />
Gruppi. La caratteristica principale dei gruppi è il potenziamento delle connessioni<br />
tra gli utenti, sfruttando <strong>la</strong> condivisione di un interesse comune. Esistono gruppi<br />
segreti, chiusi o aperti. I primi sono visualizzabili solo dai membri del gruppo e ci si<br />
può accedere esclusivamente attraverso invito, mentre i secondi sono visualizzabili da<br />
tutti gli utenti di Facebook (solo nome, descrizione e chi ne fa parte, non i post), ma<br />
vi si può accedere solo previa approvazione del<strong>la</strong> propria richiesta di ammissione. I<br />
gruppi aperti, invece, sono visualizzabili in tutti i loro elementi da qualunque utente<br />
di Facebook, post del gruppo compresi, e chiunque può commentare e condividere<br />
contenuti con il gruppo. In questo caso, l’iscrizione è legata al<strong>la</strong> volontà di rimanere<br />
aggiornati sulle attività del gruppo.<br />
Chiunque può creare un gruppo Facebook, basta selezionare <strong>la</strong> voce “crea gruppo”<br />
nel<strong>la</strong> colonna dedicata ai gruppi, sul<strong>la</strong> sinistra del<strong>la</strong> schermata home di Facebook,<br />
scegliere un nome e un’icona e invitare nuovi utenti a farne parte.<br />
Il formato di un gruppo è molto simile a quello del profilo personale: si impostano<br />
profile e cover image, si possono condividere foto, messaggi e commenti, e si può fare<br />
like o condividere i contenuti pubblicati dagli altri membri.<br />
Meglio profilo, pagina o gruppo?<br />
Soprattutto agli inizi, molti enti <strong>cultura</strong>li si sono trovati nell’indecisione di non sapere<br />
quale formato scegliere e, ancora oggi, troviamo musei che gestiscono <strong>la</strong> loro presenza<br />
su Facebook tramite profili personali. In realtà, questa scelta è sbagliata: vediamo in<br />
alcuni punti perché (fonti Idearia, Girl Geek Life e<br />
facebook.com/notes/tresette/facebook-web-marketing-pagina-o-gruppo).<br />
1. Secondo <strong>la</strong> definizione che Facebook stesso ne dà, il profilo
personale dovrebbe rappresentare una persona, non aziende,<br />
associazioni, cooperative, festival e qualunque entità non sia una<br />
persona fisica. Potenzialmente, Facebook è autorizzato a chiudere i<br />
profili che ritiene non rispondano a questo principio. Di conseguenza,<br />
continuare a gestire un profilo con <strong>la</strong> possibilità di perdere contenuti e<br />
“amici” da un giorno all’altro è un’operazione rischiosa e altamente<br />
sconsigliata.<br />
2. Il profilo può essere gestito da un’unica persona e Facebook impone<br />
il limite massimo di 5000 amici. La fan page, invece, è gestibile da più<br />
persone con diversi ruoli (admin, editor, moderatore, analista, etc) e può<br />
essere seguita da infiniti fan.<br />
3. La fan page risponde meglio ai criteri del SEO (Searching Engine<br />
Optimization) ed è indicizzata da Google, Yahoo, Bing e da tutti i motori<br />
di ricerca. Il che significa che i contenuti pubblicati nel<strong>la</strong> nostra pagina<br />
saranno visibili anche fuori da Facebook e potrebbero apparire nel<strong>la</strong><br />
ricerca dell’utente che digita le parole chiave connesse con gli<br />
argomenti dei nostri post, aumentando notevolmente <strong>la</strong> visibilità del<br />
museo <strong>online</strong>.<br />
Inoltre, <strong>la</strong> fan page permette di utilizzare l’advertising per aumentare <strong>la</strong><br />
visibilità dei post su Facebook e fornisce utili statistiche sull’andamento<br />
del<strong>la</strong> propria attività e sul<strong>la</strong> demografia del pubblico, grazie al<strong>la</strong> sezione<br />
“Insights”.<br />
Infine, <strong>la</strong> fan page consente di programmare <strong>la</strong> pubblicazione dei<br />
post in orari e giorni successivi. Nessuna di queste funzioni è inclusa<br />
nel profilo personale, né nei gruppi.<br />
4. Il profilo espande i propri contatti sul principio del<strong>la</strong> richiesta di<br />
amicizia e, su Facebook, il rapporto di amicizia lega gli utenti in<br />
modo bidirezionale: se Lorenzo e Andrea diventano amici,<br />
acconsentono reciprocamente a rendere visibili i loro contenuti all’altro<br />
e, ogni volta che uno dei due pubblicherà qualcosa sul proprio diario,<br />
l’altro vedrà l’aggiornamento nel<strong>la</strong> propria home page. Immaginiamo<br />
ora un ipotetico museo che apre un profilo su Facebook: come farà a<br />
iniziare <strong>la</strong> propria attività su questo social network? Deve chiedere<br />
l’amicizia agli utenti. Sicuramente non si tratta di un buon biglietto da<br />
visita per un ente <strong>cultura</strong>le, fa un po’ “venditore porta a porta” ed è un
gesto che può facilmente essere percepito come invadente, dal<br />
momento che l’utente medio utilizza Facebook a scopo totalmente<br />
personale e non ha nessun interesse a far vedere le proprie foto delle<br />
vacanze a un perfetto sconosciuto.<br />
Non è migliore lo scenario a parti invertite: se l’utente visita il sito web<br />
del museo e sceglie di voler essere aggiornato sulle sue attività, clicca il<br />
tasto “Facebook” e si ritrova a dover aspettare e sperare che il museo<br />
confermi l’amicizia.<br />
Al contrario, <strong>la</strong> fan page si basa su un rapporto unidirezionale, nel quale<br />
il fan clicca “mi piace” e riceve gli aggiornamenti del museo nel<strong>la</strong><br />
propria home, senza dover condividere nessuna informazione personale.<br />
Le obiezioni che spesso vengono sollevate da chi ha scelto il profilo personale invece<br />
del<strong>la</strong> pagina riguardano il livello – appunto – personale del rapporto che si crea con il<br />
pubblico. È vero: da un profilo possiamo inviare messaggi privati agli amici e<br />
possiamo taggarli nei nostri post e nelle nostre foto, ma siamo sicuri che agli amici –<br />
che poi sono fan, quindi persone che a ma<strong>la</strong> pena conoscono il museo, nel<strong>la</strong> maggior<br />
parte dei casi – questo livello di invasività faccia piacere?<br />
Per quanto riguarda <strong>la</strong> scelta tra pagina e gruppo, invece, dipende da quali sono gli<br />
obiettivi che un museo cerca di perseguire su Facebook. La fan page è un perfetto<br />
strumento di marketing e comunicazione, mentre il gruppo consiste in una<br />
community di persone che condividono un’idea, un progetto o un interesse.<br />
Rispetto ad una pagina, il gruppo è più informale e riduce le distanze, dal momento<br />
che si crea un rapporto di conoscenza e di scambio al<strong>la</strong> pari tra chi ne fa parte.<br />
Spesso, i membri più affiatati del gruppo stringono amicizia tramite i profili<br />
personali e, in genere, il gruppo consente un livello di interazione e di dialogo più alto<br />
rispetto al<strong>la</strong> pagina.<br />
Per contro, non fornisce dati demografici sui membri né analytics sulle attività, è<br />
possibile che gli utenti disattivino le notifiche per <strong>la</strong> pubblicazione di nuovi contenuti<br />
e, di conseguenza, i post in un gruppo hanno un reach molto più basso rispetto al<strong>la</strong> fan<br />
page.<br />
Facebook per i musei<br />
Gli utilizzi di Facebook da parte di un museo sono pressoché infiniti. Questa<br />
piattaforma incoraggia <strong>la</strong> creatività, il dialogo, <strong>la</strong> voglia di stupire e di coinvolgere il
pubblico e si presta, quindi, molto bene al<strong>la</strong> comunicazione di un museo che voglia<br />
mettersi in gioco con mente aperta e intraprendenza.<br />
Non ci sono regole partico<strong>la</strong>ri da seguire per l’utilizzo di questo social network, anche<br />
se quelle che è bene tenere presenti sono sottintese dall’algoritmo dell’edge rank:<br />
meglio contenuti visivi – fotografie e video –, meglio integrare i post che contengono<br />
un link esterno con una foto o un video che l’utente visualizza all’interno di Facebook.<br />
In genere, per aumentare l’interazione si consiglia di:<br />
– scegliere un tono di voce adatto al canale, ovvero diretto, informale e<br />
– perché no? – anche giocoso, compatibilmente con le scelte di<br />
comunicazione del museo;<br />
– rispondere sempre ai fan nei commenti, ringraziando per i<br />
complimenti, soddisfacendo le curiosità e cercando di non farsi<br />
trascinare in discussioni pubbliche o in inutili polemiche (se proprio<br />
non si riesce a evitare <strong>la</strong> discussione, è preferibile chiedere all’utente di<br />
spostare il dialogo su messaggio privato 13 );<br />
– terminare i post con domande o con inviti diretti al pubblico a<br />
compiere una determinata azione (“scoprite”, “leggete”, “sapevate<br />
che?”);<br />
– scegliere fotografie e immagini che possano colpire l’attenzione del<br />
pubblico, per avere più probabilità che gli utenti si soffermino anche<br />
sul<strong>la</strong> componente testuale;<br />
– scrivere testi brevi, che concentrino il messaggio più importante nelle<br />
prime tre righe e che non superino, se possibile, le cinque righe (dopo<br />
questo limite, infatti, Facebook nasconde il contenuto e gli utenti sono<br />
invitati a cliccare il link “Read more” per terminare <strong>la</strong> frase);<br />
– limitarsi nel<strong>la</strong> quantità di informazioni di tipo educativo che si cerca<br />
di dare in un Facebook update: ricordiamoci che gli utenti sono su<br />
questo social network per divertirsi, possiamo condividere un concetto<br />
principale e più accattivante e invitarli ad approfondire l’argomento<br />
cliccando sul link;<br />
– pubblicare almeno un contenuto al giorno, senza però correre il
ischio di pubblicarne troppi e di risultare invadenti;<br />
– scegliere gli orari di pubblicazione più indicati sul<strong>la</strong> base del<strong>la</strong><br />
presenza <strong>online</strong> dei nostri fan: i Facebook Insights e <strong>la</strong> funzione<br />
“Schedule” ci aiutano a programmare i post quando hanno più<br />
possibilità di essere visti da chi ci segue;<br />
– mostrare il più possibile gli aspetti del museo che normalmente non<br />
sono visibili, come dietro le quinte, <strong>la</strong>voro dei curatori, allestimento<br />
delle mostre e così via;<br />
– sforzarsi di essere creativi nel<strong>la</strong> scelta delle fotografie da pubblicare e<br />
nell’organizzazione degli album fotografici, prendendo spunto dalle<br />
board su Pinterest (non solo “Mostra su Pinturicchio”, ma anche “Opere<br />
del 1945”, “La primavera al museo”, “Rosso”, etc.)<br />
– coinvolgere il pubblico con quiz, hashtag tematici, indovinelli sugli<br />
oggetti delle collezioni, richiami al partico<strong>la</strong>re giorno dell’anno in cui ci<br />
si trova, collegamenti con gli eventi contemporanei e con i trending<br />
topic;<br />
– tenere sempre presente il pubblico e farsi guidare da questo genere di<br />
domande: “questo contenuto è interessante? La gente lo vorrebbe vedere<br />
nel<strong>la</strong> propria home? È un contenuto che porta a commentare? È una<br />
foto che i fan potrebbero voler condividere?”<br />
– non avere mai paura di sperimentare: Facebook è un social network e<br />
niente rimane scolpito nel<strong>la</strong> pietra, l’esperimento più assurdo può<br />
trasformarsi in un inaspettato successo di pubblico e il post che fallisce<br />
miseramente si può sempre cancel<strong>la</strong>re.<br />
Twitter<br />
Cos’è<br />
Twitter è un servizio gratuito di social networking e micro-blogging che si basa sul<strong>la</strong>
condivisione di messaggi di testo del<strong>la</strong> lunghezza massima di 140 caratteri.<br />
Il nome “Twitter” deriva dal verbo inglese to tweet che significa “cinguettare” e si<br />
riferisce, appunto, al<strong>la</strong> brevità dei messaggi e al<strong>la</strong> capacità di questa piattaforma di<br />
consentire lo sviluppo di infinite conversazioni tra illimitati utenti, in un “cinguettio”<br />
continuo di opinioni, punti di vista, pensieri, notizie e informazioni.<br />
Twitter è stato creato nel 2006 da Odeo, una società californiana al<strong>la</strong> ricerca di<br />
un’idea originale per salvarsi dal<strong>la</strong> bancarotta. Allo stadio embrionale, il progetto si<br />
chiamava Twttr – ispirato da Flickr – e si trattava di un servizio per comunicare con<br />
un ristretto numero di persone attraverso SMS.<br />
Già nel 2007, <strong>la</strong> piattaforma iniziava a diffondersi rapidamente e a guadagnare<br />
migliaia di utenti, grazie al<strong>la</strong> semplicità di utilizzo e al<strong>la</strong> diretta connessione con<br />
l’ambito giornalistico e con l’aggiornamento in tempo reale delle notizie.<br />
Oggi, ci sono nel mondo più di 900 milioni di account Twitter registrati, dei quali<br />
solo 255 milioni attivi. I dati riportano una media di 500 milioni di Tweet inviati<br />
ogni giorno, nell’80% dei casi da un dispositivo mobile. Una curiosità: il paese che<br />
twitta di più è l’Arabia Saudita, con un utente attivo su tre. In Cina <strong>la</strong> piattaforma è<br />
bloccata a causa delle disposizioni governative, mentre l’Italia è al sedicesimo posto<br />
nel<strong>la</strong> c<strong>la</strong>ssifica mondiale per tasso di penetrazione.<br />
Nel nostro Paese, il numero degli utenti di Twitter si avvicina ai 10 milioni, dei quali<br />
solo il 35% (3.4 milioni) sono utenti attivi. Anche in Italia, più del<strong>la</strong> metà delle<br />
persone che si connette a Twitter lo fa da smartphone o da tablet, confermando che<br />
questo social network è soprattutto una piattaforma mobile (fonti About.twitter.com<br />
e Myweb20.it).<br />
Quanto all’età, <strong>la</strong> media degli utilizzatori di Twitter si aggira intorno ai 24 anni a<br />
livello globale e ai 32 anni a livello italiano (siamo in assoluto <strong>la</strong> nazione con l’età<br />
media più alta e con <strong>la</strong> percentuale di utilizzo tra i teenager più bassa).<br />
Come funziona<br />
Cos’è un tweet? È un messaggio di 140 caratteri, che diventano 120 nei casi in cui<br />
vogliamo inserire un link o un’immagine.<br />
In quei 140 caratteri, spesso si inseriscono simboli strani e diciture difficili da<br />
comprendere per chi è alle prime armi con questo social network, tra #, @, ow.ly,<br />
bit.ly e così via. Esaminiamo un esempio di tweet e elenchiamo di quali parti si<br />
compone.
Hashtag [#].<br />
Il simbolo del cancelletto serve a contrassegnare le parole chiave di un tweet. Twitter<br />
ha trasformato questo carattere in un sistema di indicizzazione dei contenuti. In<br />
altre parole, gli hashtag sono le etichette che rendono ricercabili e visibili i nostri<br />
tweet anche da utenti che non ci seguono e non vedono i nostri aggiornamenti in news<br />
feed.<br />
Di conseguenza, sono sia un utile strumento per cercare nuovi account da seguire e<br />
conversazioni in cui partecipare (es. digitiamo #musei e scopriamo chi ne sta<br />
par<strong>la</strong>ndo), sia l’unico metodo possibile per effettuare delle ricerche su specifici temi<br />
in questa piattaforma (es. #medioevo, #Tintoretto, #contemporaryart).<br />
Alcuni hashtag sono partico<strong>la</strong>rmente importanti perché raggruppano professionisti e<br />
notizie intorno a uno specifico tema. Nel caso del<strong>la</strong> comunicazione digitale per i<br />
musei, gli hashtag “must read” sono (fonte Danamus.es): #museweb (musei e progetti<br />
web), #musesocial (musei e social media), #musetech (musei e tecnologie, definite in<br />
maniera molto vasta), #mtogo (musei e tecnologie mobili), #openg<strong>la</strong>m (opendata nel<br />
settore <strong>cultura</strong>le), #musegames (musei e gamification) e #museumed (musei e settore<br />
educativo).<br />
È importante utilizzare gli hashtag anche nei nostri tweet, in modo da renderli<br />
ricercabili dagli altri utenti e da aumentarne sensibilimente <strong>la</strong> visibilità.<br />
Basta scegliere una paro<strong>la</strong> chiave tra quelle che abbiamo scritto nel tweet – quel<strong>la</strong><br />
grazie al<strong>la</strong> quale vorremmo che gli utenti ci trovassero – e digitare un # davanti,<br />
facendo attenzione a non usare spazi tra due parole se vogliamo indicizzarle insieme<br />
(es. #artecontemporanea) e a non inserire altri segni di punteggiatura o caratteri<br />
partico<strong>la</strong>ri (#questoèunhashtag, #questo,invece,nonloè e #neanche&questo).
Siccome un tweet è comunque un messaggio che deve veico<strong>la</strong>re un testo di senso<br />
compiuto, è bene sforzarsi di utilizzare un numero ridotto di hashtag, fino a un<br />
massimo di 3. Nei casi di hashtag numerosi, <strong>la</strong> prassi consiglia di utilizzarli tutti al<strong>la</strong><br />
fine del testo, per non ostaco<strong>la</strong>re <strong>la</strong> lettura del tweet (fonti Girlgeeklife.com e<br />
Mashable.com).<br />
Mention [@].<br />
Il simbolo del<strong>la</strong> chioccio<strong>la</strong> serve per citare altri profili, indipendentemente dal fatto<br />
che siano nostri follower, musei, personaggi famosi etc. Grazie al<strong>la</strong> mention,<br />
possiamo attirare l’attenzione degli altri utenti di Twitter sui nostri contenuti, dal<br />
momento che questa funzione genera una notifica automatica nel profilo di chi<br />
abbiamo menzionato.<br />
La mention crea un collegamento tra due account ed è il metodo fondamentale per<br />
iniziare nuove conversazioni e per rispondere a un utente che ci ha menzionati a sua<br />
volta.<br />
È utilizzata anche nei casi in cui stiamo condividendo un articolo, un sito o un’idea e<br />
vogliamo dare credito all’autore, citandolo all’interno del nostro tweet: in questi<br />
casi, si utilizza comunemente <strong>la</strong> dicitura “via @nome”.<br />
Url abbreviate.<br />
Il motivo per cui spesso gli indirizzi di siti internet su Twitter sono accorciati risale<br />
al<strong>la</strong> necessità di risparmiare caratteri nei 140 totali a disposizione. Siti come Bit.ly,<br />
Hootsuite e Wordpress accorciano automaticamente qualsiasi url, mentre se si<br />
<strong>la</strong>scia il link lungo, Twitter si limita a tagliare <strong>la</strong> url con tre puntini di sospensione.<br />
Funzioni.<br />
Per ogni tweet inviato, è possibile rispondere all’autore, cliccando sull’apposito<br />
comando: in questo modo, Twitter automaticamente metterà all’inizio del tweet che<br />
stiamo scrivendo i nomi del<strong>la</strong> o delle persone a cui rispondiamo, gli autori del tweet<br />
originale, e tutte le persone eventualmente citate nello scambio di tweet.<br />
Inoltre, cliccando <strong>la</strong> funzione “Retweet”, è possibile scegliere di retwittare un<br />
contenuto che ci ha colpito, in modo da farlo comparire nel nostro profilo e da<br />
condividerlo con tutti i nostri follower. Solo nel caso in cui stiamo utilizzando Twitter<br />
da smartphone, avremo <strong>la</strong> possibilità di scegliere se retwittare il tweet così com’è, con<br />
il nome dell’autore come account principale, o se citarlo come “quote tweet”,<br />
riportando il tweet come nostro e mantenendo <strong>la</strong> mention dell’autore nel corpo del<br />
tweet. In questo secondo caso, è importante sottolineare come il limite dei 140<br />
caratteri possa impedire <strong>la</strong> funzione di citazione, nel caso in cui l’aggiunta del<strong>la</strong>
mention al corpo del tweet dovesse superare <strong>la</strong> soglia di testo consentita.<br />
L’ultima funzione di interazione messa a disposizione da Twitter è <strong>la</strong> preferenza,<br />
ovvero <strong>la</strong> stellina che funziona da bookmark, consentendoci di salvare un tweet che<br />
riteniamo interessante in una specifica sezione del nostro profilo (<strong>la</strong> pagina<br />
“Preferiti” del nostro menu). Anche se <strong>la</strong> funzione primaria dei preferiti è <strong>la</strong><br />
possibilità di salvare contenuti per successivo approfondimento, nel tempo si è<br />
evoluta e ha finito per assumere un altro valore, più simile al “mi piace” di Facebook.<br />
Usiamo i preferiti per esprimere il nostro accordo su un’opinione o per ringraziare chi<br />
ci ha menzionato, facendo sapere che abbiamo visto il tweet in cui par<strong>la</strong> di noi (fonti<br />
Hi-tech.leonardo.it e 4marketing.biz).<br />
Il profilo<br />
Nel momento in cui ci si iscrive a Twitter, <strong>la</strong> prima scelta importante da compiere<br />
riguarda il Twitter handle, ovvero il nome che ci rappresenta sul<strong>la</strong> piattaforma e non<br />
solo. Infatti, questo elemento viene indicizzato da Google ed è tra le prime notizie a<br />
comparire quando qualcuno ci cerca <strong>online</strong>. Per questo motivo, è importante<br />
scegliere un nome che sia il più possibile chiaro, riconoscibile e autoesplicativo,<br />
evitando sigle difficilmente riconducibili al museo.<br />
Nel caso del singolo professionista museale, inoltre, è consigliabile utilizzare un<br />
nickname che sia direttamente collegabile al proprio nome e cognome.<br />
La seconda scelta importante riguarda <strong>la</strong> bio, ovvero il profilo in 160 caratteri che ci<br />
definisce su questo social network. Prima di decidere se seguire o meno un utente su<br />
Twitter, se ne control<strong>la</strong> <strong>la</strong> bio, che svolge il ruolo di un vero e proprio biglietto da<br />
visita e che, di conseguenza, va curata con estrema attenzione. Spesso una bio<br />
incompleta o non chiara può dissuadere un potenziale follower che viene spinto a<br />
domandarsi se seguire un determinato utente possa o meno garantirgli di leggere<br />
contenuti rilevanti nel suo news feed.<br />
La bio deve par<strong>la</strong>re di chi siamo. Per un museo, questo significa identificarne <strong>la</strong><br />
tipologia e il luogo, cercando di comunicare in poche parole e con originalità perché<br />
vale <strong>la</strong> pena seguirlo. È sconsigliabile sprecare caratteri per segna<strong>la</strong>re <strong>la</strong> propria<br />
presenza social su altri canali, mentre è utile sfruttare l’apposita voce per indicare il<br />
sito dell’istituzione: in questo modo, stiamo dando un’informazione utile e<br />
garantendo traffico sul<strong>la</strong> nostra piattaforma principale.<br />
Nel caso di account Twitter individuali, <strong>la</strong> bio dovrebbe specificare brevemente di<br />
cosa ci occupiamo e quali sono le nostre passioni, gli argomenti di cui twittiamo
maggiormente, così che coloro che decidono di seguirci capiscano che cosa aspettarsi<br />
da noi.<br />
Inoltre, se vogliamo identificarci come “professionisti di un determinato museo”, è<br />
importante inserire il disc<strong>la</strong>imer in cui si specifica che ciò che diciamo non è il<br />
riflesso dell’istituzione per cui <strong>la</strong>voriamo. In questo modo, salvaguardiamo<br />
associazioni che possono creare spiacevoli disguidi o influenzare <strong>la</strong> percezione del<br />
museo.<br />
Infine, su Twitter <strong>la</strong> foto del profilo è partico<strong>la</strong>rmente importante perché ci<br />
identifica e ci distingue nel flusso costante e fittissimo di tweet che affol<strong>la</strong> <strong>la</strong> home di<br />
ogni utente.<br />
Un museo dovrebbe scegliere un’immagine che sia immediatamente riconducibile<br />
all’istituzione e che sia distinguibile nonostante le piccole dimensioni. Nel<strong>la</strong> maggior<br />
parte dei casi, l’immagine ideale è il logo del museo, soprattutto quando è il risultato<br />
di una attività di branding mirata.<br />
Considerando che Twitter è <strong>la</strong> piattaforma perfetta per <strong>la</strong> costruzione di un network<br />
virtuale tra professionisti, è fondamentale che le singole persone scelgano fotografie<br />
in cui sono riconoscibili. Immaginiamo, infatti, di partecipare a una conferenza in cui<br />
sono presenti i nostri contatti di Twitter: avere <strong>la</strong> foto del nostro cane come immagine<br />
del profilo non favorisce certo <strong>la</strong> socializzazione.<br />
Inoltre, per aiutare gli utenti a riconoscerci e a seguirci, è utile avere un’immagine il<br />
più possibile coordinata nei diversi canali, dai social media al sito internet.<br />
Follower e following<br />
La dinamica al<strong>la</strong> base dell’interazione su Twitter è il follow, ovvero l’azione di<br />
“seguire” altri utenti su questo social network, leggendone il flusso di tweet nel<strong>la</strong><br />
nostra home.<br />
Quando scegliamo di seguire qualcuno, lo facciamo sul<strong>la</strong> base del<strong>la</strong> bio che ne<br />
descrive gli interessi o per ricambiare il fatto che ha iniziato a seguirci.<br />
L’elenco dei following che mano a mano ci costruiamo è una risorsa importantissima<br />
per tenerci aggiornati sui temi che ci interessano più da vicino.<br />
Twitter stesso si definisce come “the fastest way to get real time information from<br />
around the world” (fonte Youtube.com), il che significa che uno dei motivi principali<br />
per cui possiamo usare questo social network è tenerci aggiornati su quello che<br />
accade nel mondo, con <strong>la</strong> possibilità di scegliere alcuni settori in partico<strong>la</strong>re. Nel caso<br />
dei musei, è possibile partecipare a intere conversazioni che riguardano ambiti anche
molto specifici di questo campo, basta sapere quali hashtag cercare (v. sopra) e quali<br />
account seguire per tenersi informati su determinati argomenti.<br />
Chi seguire, quindi? Ovviamente gli account di altri musei, a cominciare da quelli<br />
che operano nel nostro stesso campo, continuando con quelli che sono più virtuosi e<br />
possono rappresentare una best practice su Twitter da cui prendere ispirazione. Ma<br />
perché limitarsi? Le fonti di informazione possono essere le più disparate, dai<br />
magazine <strong>online</strong> che par<strong>la</strong>no di arte / scienza / storia etc., agli influencer dei diversi<br />
settori e ai singoli professionisti che esprimono nel<strong>la</strong> loro bio e nei loro tweet<br />
opinioni interessanti su un determinato tema.<br />
Un trucco per scoprire account interessanti, soprattutto quando stiamo muovendo i<br />
primi passi su Twitter, è il pulsante “Following” che troviamo nel profilo di chi<br />
seguiamo: prendere spunto dalle scelte di chi è attivo su questo social network da più<br />
tempo di noi è un ottimo inizio per cominciare a capire quali sono i nomi ricorrenti,<br />
gli influencer e gli account di riferimento per certi argomenti.<br />
Inoltre, per facilitare <strong>la</strong> scoperta e l’aggiornamento sui trend in corso, Twitter mette a<br />
disposizione <strong>la</strong> tab “Scopri”, nel<strong>la</strong> quale si trovano i tweet e gli account di tendenza,<br />
insieme ai suggerimenti utili su chi seguire basati su chi stiamo già seguendo.<br />
Quando si ha un elenco di following un po’ consistente, <strong>la</strong> home di Twitter inizia a<br />
sovraffol<strong>la</strong>rsi e diventa difficile riuscire a seguire quello che è un vero e proprio<br />
fiume in piena di tweet. Uno strumento davvero molto utile per organizzare i<br />
following sono le liste, che consentono di “iso<strong>la</strong>re dal<strong>la</strong> massa” gli account che<br />
riteniamo più significativi e di cui non vogliamo perderci neanche un aggiornamento.<br />
Twitter consente di creare infinite liste, che possono essere pubbliche o private. Nel<br />
caso delle prime, tutti gli utenti possono vederle e decidere di seguirle, qualora il tipo<br />
di argomento e <strong>la</strong> qualità del<strong>la</strong> selezione di account siano interessanti. In questo senso,<br />
dare un’occhiata alle liste di chi seguiamo può essere sempre utile per scoprire nuovi<br />
account e per decidere di tenerci aggiornati – con un solo click – su un intero gruppo<br />
di persone che ci sembrano rilevanti.<br />
Quando, cosa e come twittare<br />
I contenuti che raggiungono le persone su Facebook e su Twitter seguono logiche<br />
fondamentalmente diverse ed è molto importante conoscerle per definire una<br />
strategia di contenuti che sia in linea con <strong>la</strong> community che segue il nostro museo<br />
<strong>online</strong>.<br />
Mentre Facebook si basa su un algoritmo che tiene conto del<strong>la</strong> rilevanza dei contenuti
e del rapporto tra chi scrive e chi legge, Twitter funziona in modo puramente<br />
cronologico, mostrando tutti i contenuti agli utenti in ordine di pubblicazione, senza<br />
applicare alcun filtro (fonte Wearesocial.it).<br />
Di conseguenza, siamo sicuri che vediamo nel<strong>la</strong> nostra home tutti i tweet degli utenti<br />
che stiamo seguendo: l’unico limite è il tempo. In altre parole, se un utente non si<br />
connette a Twitter per un’ora e segue 500 persone, è molto probabile che non vedrà<br />
mai quello che il nostro museo ha pubblicato 50 minuti prima, dal momento che il<br />
tweet sarà notevolmente sceso nell’ordine cronologico del<strong>la</strong> sua home, al punto da non<br />
essere più neanche visibile.<br />
Va da sé che su Twitter indovinare <strong>la</strong> giusta frequenza di pubblicazione dei<br />
contenuti è vitale. Anche se gli studi di settore dimostrano che non esiste il momento<br />
perfetto in assoluto per twittare e ottenere l’engagement dei nostri sogni, ci sono<br />
comunque alcune indicazioni di massima che può essere utile tenere presenti (fonti<br />
Blog.bufferapp.com e Wearesocial.it). Ad esempio, considerando che <strong>la</strong> maggioranza<br />
degli utenti di Twitter utilizza <strong>la</strong> app da smartphone, i picchi più rilevanti di<br />
engagement si misurano durante gli spostamenti dei pendo<strong>la</strong>ri per raggiungere<br />
l’ufficio (8-9 di mattina, 5-6 di sera) e in pausa pranzo. Inoltre, sembra che gli<br />
account che si rivolgono a un pubblico consumer abbiano percentuali maggiori di<br />
visibilità durante i weekend (17%).<br />
Indipendentemente da quello che dicono le statistiche, il ruolo più importante nel<strong>la</strong><br />
programmazione dei tweet è giocato dal<strong>la</strong> conoscenza del<strong>la</strong> propria community.<br />
Esistono diversi tool <strong>online</strong> gratuiti che consentono di studiare <strong>la</strong> composizione del<br />
nostro target e di scoprirne demografia, preferenze e orari di connessione al<strong>la</strong><br />
piattaforma. I più utilizzati sono Followerwonk, Twitonomy e Twter<strong>la</strong>nd, che<br />
consentono di esportare i dati in grafiche molto utili semplici da interpretare (fonte<br />
Bee-social.it).<br />
Una volta compresi gli orari migliori per condividere i nostri contenuti, possiamo fare<br />
ricorso ad altri strumenti <strong>online</strong> che ci consentono di programmarne <strong>la</strong> pubblicazione.<br />
Grazie a tool come Tweetdeck, Hootsuite e Buffer – per citare i più famosi –<br />
possiamo evitare di doverci ricordare di pubblicare un tweet <strong>la</strong> domenica dopo<br />
pranzo. Inoltre, tutti gli strumenti di gestione di Twitter consentono di effettuare<br />
analisi del<strong>la</strong> propria performance, decisamente utili in fase di evaluation (v. capitolo<br />
5).<br />
Qual è il numero ideale di tweet al giorno? Anche in questo caso, non esiste una<br />
risposta assoluta. In media, le ricerche dimostrano che l’average engagement rate<br />
diminuisce dopo il terzo tweet giornaliero e che, quindi, il numero “giusto” di tweet al<br />
giorno si aggira tra i 3 e i 5, quando parliamo di aziende e istituzioni medio-piccole,
tra i 5 e 10 per quelle più consistenti, tra i 20 e i 50 per le aziende del calibro di Coca<br />
Co<strong>la</strong>.<br />
Quanto ai contenuti da twittare, è innegabile che Twitter sia un ottimo canale per<br />
condividere le attività del museo con un ampio numero di utenti. Dalle collezioni<br />
alle mostre, dai singoli partico<strong>la</strong>re di un’opera al collegamento con un trending topic,<br />
dagli eventi speciali agli hashtag creati ad hoc per determinati contest, quiz e<br />
iniziative <strong>online</strong>: i musei hanno infinite riserve di materiali che possono usare per<br />
rendere il loro account Twitter interessante, vitale e mai noioso.<br />
Detto questo, sarebbe consigliabile cercare di variare i propri contenuti e di<br />
interval<strong>la</strong>re quelli strettamente legati al<strong>la</strong> vita del museo con altre notizie del settore<br />
che possono interessare i nostri follower.<br />
Ad esempio, un museo del<strong>la</strong> scienza può condividere articoli che riguardino scoperte,<br />
ricerche e iniziative in corso, mentre un museo archeologico può raccontare<br />
brevemente le gesta di un personaggio del passato, includendo link che rimandino ad<br />
un approfondimento del contesto storico.<br />
L’importante è cercare sempre di mettersi nei panni di chi ci segue e legge i nostri<br />
aggiornamenti, per fare in modo di condividere spunti che siano sempre il più<br />
possibile variegati, interessanti e ad alto tasso di engagement.<br />
Su Twitter, è incoraggiata <strong>la</strong> ri-condivisione dei contenuti altrui: <strong>la</strong> dinamica del<br />
retweet serve a interval<strong>la</strong>re un profilo altrimenti intasato di propri contenuti e a<br />
dimostrare l’apertura di un account museale verso questo mondo altamente<br />
partecipativo. Una nota da ricordare: è importante control<strong>la</strong>re sempre le fonti e le<br />
notizie, qualora si retwittino contenuti altrui. Inoltre, possiamo alternare “retweet” e<br />
“quote tweet”, curandoci di aggiungere un commento o una nota per personalizzare <strong>la</strong><br />
condivisione, quando lo spazio lo consente.<br />
Come si compone il “tweet perfetto”?<br />
Secondo gli studi di settore, il tweet perfetto è lungo tra i 70 e 100<br />
caratteri.<br />
In questo modo, i follower che giudicano interessante un nostro<br />
contenuto possono retwittarlo aggiungendo un commento personale<br />
(“quote tweet”) e saranno più incentivati al<strong>la</strong> condivisione. Non si tratta<br />
di una rego<strong>la</strong> d’oro, ma è sicuramente un’accortezza che può essere utile<br />
tenere presente, qualora ci trovassimo nel<strong>la</strong> situazione di avere ancora<br />
50 caratteri a disposizione e di pensare “e ora cosa scrivo?”.
I tweet che contengono immagini registrano un tasso di engagement<br />
due volte superiore rispetto a quelli che non ne hanno.<br />
I tweet che contengono hashtag ricevono un tasso di risposta maggiore,<br />
ma attenzione: quelli che hanno solo 1 o 2 hashtag ottengono il 21% di<br />
engagement in più rispetto a quelli che ne hanno 3 o più.<br />
I tweet che contengono link hanno l’86% di probabilità in più di essere<br />
retwittati rispetto a quelli che non ne hanno.<br />
(Fonti Blog.bufferapp.com, Tracksocial.com, Twittercounter.com/10-ways-to-keepyour-twitter-follower-engaged<br />
e Twittercounter.com/making-5-twitter-mistakes)<br />
Live Tweeting<br />
Il live tweeting è l’attività di diffondere in tempo reale via Twitter osservazioni,<br />
citazioni e concetti chiave di un evento cui si sta assistendo “in presenza”. È una<br />
funzione che è tipicamente collegata a conferenze e convegni, ma non è detto che<br />
debba limitarsi a questi: si può twittare in diretta un workshop, un evento con il<br />
pubblico, un programma televisivo che riguarda temi connessi all’attività del museo, e<br />
così via.<br />
Perché farlo? Perché un resoconto accurato di un evento a cui poche altre persone<br />
stanno partecipando ci permetterà di aumentare il numero di follower e di<br />
acquisire credito e visibilità nel settore in cui operiamo, sia presso gli utenti che<br />
leggono i nostri tweet “da casa”, sia presso quelli che partecipano all’evento e al live<br />
tweeting (fonte Techrepublic.com).<br />
Le regole da tenere presenti per un buon live tweeting sono poche e semplici: diamo<br />
valore ai nostri tweet, riportando concetti che riteniamo interessanti per chi ci segue;<br />
ricordiamoci di utilizzare sempre l’hashtag dell’evento cui stiamo partecipando e di<br />
menzionare l’account dello speaker che stiamo citando; cerchiamo di essere efficaci<br />
nei tweet e di non over twittare (il rischio di essere percepiti come spam da parte dei<br />
nostri follower è sempre dietro l’angolo).<br />
Twitter netiquette e altri consigli utili
A differenza di Facebook, Twitter è una piattaforma più complessa, seguita da utenti<br />
esigenti e attenti al rispetto del<strong>la</strong> cosiddetta “netiquette” e di alcune regole non scritte<br />
di base (fonti Mashable.com, Autori.fanpage.it, Wired.it e <strong>Svegliamuseo</strong>.com).<br />
Su Twitter sarebbe meglio:<br />
– ringraziare quando si viene citati, o, per lo meno, dare un segnale che<br />
si è letto il tweet, aggiungendolo ai preferiti;<br />
– rispondere alle domande, dirette e indirette, che ci vengono rivolte;<br />
– retwittare i contenuti che ci riguardano che riteniamo interessanti;<br />
– non re-postare in automatico da altri social, dal momento che, spesso,<br />
quest’azione si traduce in tweet incompleti che terminano con i tre<br />
puntini di sospensione per ragioni di spazio;<br />
– calibrare bene <strong>la</strong> frequenza dei tweet in base alle risposte dei propri<br />
follower, cercando di non intasarne il news feed e nello stesso tempo di<br />
non rimanere assenti dal<strong>la</strong> piattaforma troppo a lungo;<br />
– prestare attenzione al<strong>la</strong> qualità dei propri contenuti ed evitare<br />
contenuti irrilevanti, incomprensibili o fuori contesto: conta quello che<br />
si twitta, piuttosto che quanto si twitta;<br />
– evitare lo spam e l’autopromozione aggressiva: è un’ottima cosa<br />
par<strong>la</strong>re del<strong>la</strong> propria attività, ma è bene anche diversificare i contenuti<br />
che condividiamo con i nostri follower;<br />
– non chiedere il retweet, dal momento che, se quello che scrivi è ricco<br />
di spunti e meritevole di essere diffuso, il retweet verrà spontaneamente<br />
dai tuoi follower;<br />
– utilizzare <strong>la</strong> funzione retweet / quote tweet per condividere contenuti<br />
interessanti che riguardano il campo in cui opera il museo, ricordandoci<br />
di <strong>la</strong>sciarne menzionato l’autore: i “furti” di tweet sono davvero mal<br />
visti su questa piattaforma;
– non esagerare con gli hashtag: si tratta di parole chiave che servono a<br />
indicizzare i contenuti, per cui #non #ha #molto #senso #utilizzarli #per<br />
#ogni #paro<strong>la</strong>, anche perché rendono complicata <strong>la</strong> lettura;<br />
– tenere presenti i parametri di lunghezza e comprensibilità quando<br />
creiamo hashtag ad hoc per determinati eventi: più breve è l’hashtag,<br />
più caratteri saranno a disposizione degli utenti per i contenuti dei<br />
tweet;<br />
– non usare l’account istituzionale come se fosse il nostro megafono<br />
personale ed evitare di <strong>la</strong>sciarci trascinare in discussioni che nul<strong>la</strong><br />
hanno a che vedere con <strong>la</strong> mission del museo e il suo tone of voice;<br />
– fare attenzione al<strong>la</strong> grammatica e a eventuali correzioni automatiche<br />
dello smartphone o del tablet: potremmo aver scritto il tweet più<br />
interessante del<strong>la</strong> storia, ma l’errore grammaticale o sintattico non<br />
spingerà i follower al retweet.<br />
Pinterest<br />
Cos’è<br />
Pinterest è un social network basato sul<strong>la</strong> condivisione di immagini che consente agli<br />
utenti di catalogare passioni e interessi.<br />
Il termine “Pinterest” deriva dal verbo inglese “to pin” che significa letteralmente<br />
“appuntare, fissare con una puntina”. Di conseguenza, Pinterest è assimi<strong>la</strong>bile a una<br />
bacheca virtuale che permette di condividere le cose che troviamo in rete e che ci<br />
piacciono, ovvero i nostri “interest”.<br />
Entrare in Pinterest equivale a intraprendere un viaggio in un mondo ispirazionale,<br />
dove le persone si raccontano attraverso le immagini, <strong>la</strong>sciando poco spazio alle<br />
parole.<br />
Questo social network esiste dal 2010 e da allora ha conosciuto una crescita<br />
inarrestabile, con 1,2 milioni di utenti registrati ad agosto 2011, 11 milioni a gennaio<br />
2012 e ben 70 milioni a ottobre del 2013.<br />
I dati ufficiali non sono pubblicati, ma tutte le ricerche condotte da terze parti<br />
confermano che Pinterest è oggi uno dei social network più interessanti, al punto che<br />
si trova al ventisettesimo posto nell’elenco dei siti più visitati a livello globale sti<strong>la</strong>to
da Alexa (fonti<br />
Nymag.com, Alexa.com, Searchenginewatch.com).<br />
A livello mondiale, <strong>la</strong> maggior parte degli utenti di Pinterest sono donne. Questo dato<br />
è facilmente collegabile con il fatto che si tratta di un social network basato<br />
soprattutto sul processo di scoperta di “cose belle”. Il principio al<strong>la</strong> base di Pinterest è,<br />
infatti, <strong>la</strong> differenza tra search e discovery. Quando cerchiamo qualcosa <strong>online</strong>,<br />
abbiamo più o meno già in mente che cosa vogliamo e ci limitiamo a utilizzare il web<br />
per trovare quell’oggetto al miglior prezzo o nel<strong>la</strong> variabile che più ci piace. Quando<br />
invece stiamo scoprendo qualcosa, non si tratta quasi mai di un oggetto di cui<br />
eravamo al<strong>la</strong> ricerca in maniera specifica, ma piuttosto di un’immagine che ci<br />
colpisce per <strong>la</strong> sua bellezza e unicità in mezzo ad altre cose interessanti. Ecco,<br />
Pinterest ha categorizzato questo processo di scoperta degli oggetti, soprattutto di<br />
quelli “belli”, in grado di colpire visivamente l’osservatore.<br />
Come funziona<br />
Le caratteristiche principali di Pinterest sono l’immediatezza, <strong>la</strong> semplicità e <strong>la</strong><br />
velocità d’uso.<br />
La prima cosa da fare è scaricare il “pin it button” dal sito di Pinterest e instal<strong>la</strong>rlo<br />
sul<strong>la</strong> barra degli strumenti del browser che utilizziamo di solito<br />
(Mashable.com/pinterest-beginners-guide). In questo modo, quando navighiamo in<br />
internet e vediamo immagini o altri contenuti multimediali che ci colpiscono, basta<br />
selezionarle con il mouse e cliccare il “pin it button” per sceglierle e “pinnarle”<br />
direttamente nel nostro profilo.<br />
Il passo successivo sarà organizzare i nostri pin secondo tematiche trasversali. Lo<br />
strumento per farlo sono le bacheche o board, che fungono da contenitori e che<br />
possono essere create senza limiti e organizzate sul<strong>la</strong> base dei temi più svariati. Ad<br />
ogni nuovo pin, infatti, Pinterest richiede in automatico l’inserimento di una<br />
descrizione – anche sommaria – e l’assegnazione dell’immagine pinnata a una board,<br />
che può essere già esistente o da creare per l’occasione.<br />
Le board sono pubbliche e permettono <strong>la</strong> connessione tra persone aventi gli stessi<br />
gusti e interessi; proprio per sottolineare questa potenzialità di connessione tra gli<br />
utenti, Pinterest consente anche <strong>la</strong> gestione condivisa delle board.<br />
In sostanza, quindi, se mentre navigo <strong>online</strong> vedo un’immagine che mi piace, ad<br />
esempio una riproduzione del Viandante sul mare di nebbia di Caspar David Friedrich,<br />
posso cliccare il pin it button direttamente dal<strong>la</strong> barra di navigazione. Da qui, <strong>la</strong> posso<br />
pinnare nel<strong>la</strong> mia board a tema “Arte” o posso creare una nuova board ad hoc e
chiamar<strong>la</strong> “Giornata malinconica”. Posso anche scegliere se condividere questo mio<br />
nuovo pin sui miei profili Facebook e Twitter. I collegamenti tra Pinterest e altri<br />
social network, infatti, consentono di amplificare <strong>la</strong> visibilità di ogni azione che<br />
compiamo e di aumentare a dismisura <strong>la</strong> rete delle connessioni tra pinners, board e<br />
possibili ispirazioni, creando un “effetto social” a cascata.<br />
Inoltre, Pinterest consente anche il repin di immagini condivise da altri utenti. Nel<strong>la</strong><br />
nostra home troviamo le attività degli account che abbiamo deciso di seguire e a volte<br />
è sufficiente scorrere questo feed per farsi prendere da infinite nuove ispirazioni. È<br />
possibile seguire un utente, in modo da essere aggiornati su ogni suo nuovo pin, o<br />
anche solo le singole board.<br />
In generale, grazie al<strong>la</strong> sua natura altamente visiva, utilizzare Pinterest è molto più<br />
difficile a dirsi che a farsi.<br />
Pinterest per i musei<br />
Pinterest si inserisce molto bene nel<strong>la</strong> strategia web di quei musei che hanno già<br />
implementato un sistema integrato di comunicazione <strong>online</strong> tramite sito e social<br />
network orizzontali, come Facebook e Twitter. In questi casi, Pinterest può<br />
funzionare da efficiente cassa di risonanza e può contribuire a far conoscere le<br />
attività del museo anche molto al di fuori dei confini geografici in cui opera, dal<br />
momento che l’engagment in questa piattaforma è molto più vinco<strong>la</strong>to all’aspetto<br />
visivo rispetto a quello testuale.<br />
Inoltre, grazie al fatto che alle immagini si può aggiungere una descrizione, Pinterest<br />
si configura come un potente strumento di content curation: il focus è sul<strong>la</strong><br />
selezione, è <strong>la</strong> “visione” del curatore che dà coerenza al<strong>la</strong> board (fonti<br />
Oscilloscopioazzurro.blogspot.it e Pa<strong>la</strong>zzomadamatorino.it). E se questo principio è<br />
valido per un normale utente che organizza i contenuti che trova nel web,<br />
immaginiamo quali possono essere le potenzialità per un museo e per le collezioni che<br />
sono in esso contenute!<br />
Quali sono, quindi, i principali motivi per cui un museo dovrebbe utilizzare questo<br />
social network?<br />
1. Perché Pinterest consente di mettere in mostra una selezione delle<br />
proprie collezioni, ma anche di pubblicizzare le proprie attività, il<br />
bookshop o le stesse altre iniziative <strong>online</strong> del museo.<br />
Permette quindi di avere visibilità presso un pubblico diverso e
decisamente più ampio (non dimentichiamoci che si tratta di una<br />
piattaforma con più di 70 milioni di utenti da tutto il mondo). Inoltre,<br />
questo strumento consente di amplificare <strong>online</strong> le competenze di<br />
curate<strong>la</strong> che già normalmente caratterizzano un museo: grazie a<br />
Pinterest, è possibile organizzare in board le mostre più impossibili, gli<br />
accostamenti più creativi, le opere più disparate da diverse parti del<br />
museo o da diversi musei nel mondo.<br />
2. Perché, grazie al<strong>la</strong> possibilità di ricevere i commenti e i like degli<br />
utenti, il museo riesce a misurare quasi istantaneamente il livello di<br />
gradimento di un’opera, di un pezzo di una collezione o di una mostra.<br />
3. Perché chiunque può commentare i pin e le board di un utente e i<br />
musei possono alimentare il confronto e favorire <strong>la</strong> col<strong>la</strong>borazione,<br />
invitando i propri follower all’interazione. Inoltre, <strong>la</strong> possibilità di<br />
creare board condivise rappresenta un’occasione unica di co-creazione<br />
dei contenuti insieme al proprio pubblico.<br />
4. Perché l’uso creativo di Pinterest è un’ottima dimostrazione di<br />
amore per l’arte e di fedeltà al<strong>la</strong> propria mission. Che cos’è infatti un<br />
museo se non un’istituzione al servizio del<strong>la</strong> società, aperta al pubblico e<br />
dedita a comunicare ed esporre le proprie opere “a fini di studio,<br />
educazione e diletto”? E quale strumento migliore di Pinterest per farlo<br />
in maniera interessante, coinvolgente e alternativa?<br />
(Fonti <strong>Svegliamuseo</strong>.com, Themuseumofthefuture.com,<br />
Jennifuchs.tumblr.com, Theguardian.com).
Inspirational<br />
J. Paul Getty Museum – Paro<strong>la</strong> d’ordine: creatività<br />
Pinterest è lo strumento perfetto per dare visibilità alle collezioni, ma occorre evitare<br />
il più possibile gli elenchi ripetitivi e noiosi. Il cuore delle attività su questo social<br />
network è l’engagement e un museo dovrebbe sfruttare o inventare temi trasversali che<br />
riescano a colpire chi lo segue e che potranno guadagnargli <strong>la</strong> simpatia del pubblico<br />
<strong>online</strong>: basta usare un po’ di fantasia.<br />
Il J. Paul Getty Museum deve essere un riferimento per tutti i musei in questo senso e<br />
basta guardare i titoli delle loro board per capire come un approccio non<br />
convenzionale sia <strong>la</strong> chiave del successo su Pinterest. Monkeys in the Margins, sulle<br />
miniature medievali, Separated at Birth?, sulle somiglianze tra le opere d’arte, Macho<br />
Mustached Men, sul<strong>la</strong> imperversante moda dell’uomo con i baffi, e così via: non<br />
stupisce che questo museo superi il milione di follower!<br />
LACMA – Focus sul museo<br />
Il Los Angeles County Museum of Art può essere un buon riferimento per quei musei<br />
che desiderano utilizzare Pinterest per presentarsi in maniera insolita e ad un<br />
pubblico più vasto di quello che frequenta il loro sito internet.<br />
Il LACMA ha creato board tematiche che accompagnano il visitatore attraverso le<br />
sale del museo, consentendogli di esplorarne le diverse attività, le evoluzioni nel<strong>la</strong><br />
storia e gli angoli più remoti. Meritano LACMA Through the Years, P<strong>la</strong>ces & Spaces e<br />
Conservation at LACMA.<br />
Diefenbunker Museum – We love our community!<br />
Lo dice il titolo stesso del<strong>la</strong> board: il Diefenbunker Museum, in Canada, usa Pinterest<br />
soprattutto per costruire e premiare <strong>la</strong> community degli appassionati del museo.<br />
Grazie all’uso delle board condivise e al<strong>la</strong> scelta di temi come Education and<br />
Programming, con idee fai-da-te da realizzare dentro e fuori il museo, e Love Under<br />
Cover, con spunti per <strong>la</strong> festa di San Valentino al museo, sembra proprio che il<br />
Diefenbunker stia riuscendo nell’impresa di far sentire il pubblico al centro delle<br />
proprie attività, anche <strong>online</strong>.
Smithsonian – Occhio al calendario<br />
Sarà complice il fatto che lo Smithsonian comprende 19 musei, ma il loro profilo di<br />
Pinterest è davvero bello da guardare. In partico<strong>la</strong>re, lo segnalerei per <strong>la</strong> bravura con<br />
cui riescono a collegare le board al calendario, ovvero alle festività e agli eventi –<br />
sportivi e non – che nel frattempo succedono nel mondo. Qualche esempio creativo?<br />
Smiths-Ho-Ho-Ho-nian, Superb Owls, Happy Haunting Halloween e Take me out to the<br />
ball game.<br />
Chicago History Museum – Un punto di riferimento per <strong>la</strong> città (e per lo shopping)<br />
Il Chicago History Museum è l’esempio perfetto di museo che punta a essere un<br />
riferimento per il proprio territorio su Pinterest. In sostanza, chi cerca immagini di<br />
Chicago finisce prima o poi sul loro profilo: hanno board per tutti i gusti, da Biking in<br />
Chicago a Chicago Families, da Chicago Flora & Fauna a Chinese Chicago e così via.<br />
È anche interessante far notare <strong>la</strong> board a tema Museum Store, che raccoglie tutti gli<br />
oggetti presenti nel bookshop e che è collegata all’e-commerce del museo, dove<br />
l’utente può direttamente acquistare quello che lo colpisce partico<strong>la</strong>rmente.<br />
Instagram<br />
Cos’è<br />
Instagram è una piattaforma <strong>online</strong> e mobile per <strong>la</strong> condivisione di foto e video. Il<br />
programma permette l’applicazione di filtri che creano un effetto “vintage” sugli<br />
scatti, nonché una manipo<strong>la</strong>zione di base delle immagini (dimensione, rotazione,<br />
illuminazione).<br />
Instagram consente, inoltre, di condividere le foto opportunamente modificate e<br />
filtrate direttamente su Facebook, Twitter, Tumblr e Flickr.<br />
Fondato da Kevin Systrom e Mike Krieger nell’ottobre 2010, questo social network è<br />
stato poi comprato da Facebook nell’aprile 2012. Nei due mesi successivi al suo<br />
<strong>la</strong>ncio, Instagram ha raggiunto un milione di utenti registrati. Nel 2013, infine, <strong>la</strong><br />
piattaforma è stata implementata grazie all’aggiunta di una funzione video e,<br />
successivamente, di Instagram Direct, il servizio di messaggistica che consente di<br />
inviare foto privatamente a un gruppo di massimo quindici destinatari.
Oggi su Instagram ci sono circa 200 milioni di utenti attivi al mese, una popo<strong>la</strong>zione<br />
peraltro molto giovane, se consideriamo che il 37% dei ragazzi tra i 18 e i 29 anni lo<br />
utilizza. Il 68% dell’utenza di Instagram è composta da donne, e, più in generale, il<br />
17% degli utenti di internet passa il suo tempo su questo social network (fonti<br />
Jennstrends.com/instagram-statistics-for-2014/, Blog.instagram.com e<br />
Jennstrends.com/limits-on-instagram/). Quest’ultimo, in partico<strong>la</strong>re, è un dato su cui<br />
riflettere quando pensiamo alle “piattaforme social su cui è necessario avere una<br />
presenza istituzionale” 14 .<br />
Tra le tipologie di contenuti che si possono trovare su Instagram, troviamo soprattutto<br />
foto artistiche e dettagli e scorci “hip”. In questo senso, il c<strong>la</strong>im di Instagram è<br />
“Capture and Share the World’s Moments”. Vale a dire che questo social network<br />
incoraggia <strong>la</strong> condivisione di frammenti del<strong>la</strong> vita, dei viaggi e degli interessi dei suoi<br />
utenti, configurandosi come un diario visivo molto potente ed esteticamente<br />
attraente. Lo stesso principio si applica agli Instagram Video.<br />
In un blog post sull’assenza di mobile app memorabili create da musei, Koven Smith<br />
cita Instagram come app “eccezionale” 15 . Il motivo è che Instagram fa leva su un<br />
comportamento che <strong>la</strong> gente aveva già prima che facessero <strong>la</strong> loro comparsa<br />
smartphone e tablet – fare foto e condividerle – e lo rende molto più semplice. In<br />
altre parole, Instagram fornisce gli strumenti per democratizzare una tendenza e<br />
render<strong>la</strong> norma.<br />
Come funziona<br />
Nonostante esista una versione desktop, Instagram è una piattaforma prettamente<br />
mobile: l’atto stesso di scattare una foto e condivider<strong>la</strong> è ormai profondamente<br />
integrato tra i comportamenti che abbiamo quando siamo in giro con il nostro<br />
smartphone. Inoltre, <strong>la</strong> versione desktop non consente di caricare foto e Instagram<br />
non offre <strong>la</strong> possibilità di programmare i post in anticipo, sia in-app, sia con altre<br />
piattaforme come Hootsuite.<br />
È possibile scattare una foto e modificar<strong>la</strong> direttamente dal<strong>la</strong> app, oppure si può<br />
caricarne una già scattata in precedenza.<br />
Una volta caricata <strong>la</strong> foto, ci troviamo davanti a una schermata con gli editing tool.<br />
Questi consentono di zoomare e raddrizzare uno scatto, di cambiare variabili come<br />
luminosità, contrasto ed esposizione, e di aggiungere una cornice.<br />
La parte veramente divertente è legata all’applicazione dei filtri: differenti “stili” che<br />
agiscono su colori e luminosità, creando una patina vintage veramente unica e<br />
ricordando gli effetti del<strong>la</strong> fotografia analogica delle toy camera. Il fattore che esalta
ulteriormente questa componente estetica ed è anche <strong>la</strong> “firma” di Instagram è il<br />
formato sempre quadrato delle immagini.<br />
Dopo aver modificato <strong>la</strong> foto, è possibile inserire una didascalia, con un limite di<br />
2200 caratteri. Questo spazio è dedicato al<strong>la</strong> descrizione del<strong>la</strong> foto e all’inserimento<br />
degli hashtag principali.<br />
Gli hashtag sono una componente fondamentale di Instagram, dal momento che<br />
costituiscono il modo fondamentale per <strong>la</strong> ricerca dei contenuti da parte degli utenti.<br />
Di conseguenza, a meno che qualcuno non vi segua già, l’hashtag è l’unico modo<br />
attraverso cui un determinato utente può scoprirvi su Instagram. Facciamo un<br />
esempio: se un utente, in qualunque parte del mondo si trovi, è interessato alle opere
dei Preraffaelliti, cercherà sicuramente il re<strong>la</strong>tivo hashtag e potrebbe così scoprire<br />
l’account Instagram di 24 Ore Cultura, che attualmente gestisce <strong>la</strong> mostra su questo<br />
movimento artistico a Pa<strong>la</strong>zzo Chiablese a Torino.<br />
Le regole di “bon ton” re<strong>la</strong>tive agli hashtag e alle mention sono le stesse che si possono<br />
applicare a qualsiasi altro social media: evitare gli hashtag troppo lunghi o <strong>la</strong> divisione<br />
di una frase in tanti hashtag; evitare parole o mention irrilevanti solo per raggiungere<br />
un bacino più ampio e sperare di raccogliere più like (il più delle volte verrete<br />
percepiti come spam e perderete credibilità).<br />
Ricordiamo inoltre che nel<strong>la</strong> didascalia del<strong>la</strong> foto non possono essere inseriti link, è<br />
quindi necessario sfruttare lo spazio disponibile per <strong>la</strong> creazione di un messaggio<br />
chiaro ed esplicativo.<br />
Una volta che <strong>la</strong> foto è pronta, può essere applicata anche una location page, per<br />
identificare il luogo in cui è stata scattata. Questo aspetto diventa cruciale per i<br />
musei, in quanto i contenuti di Instagram possono essere filtrati anche attraverso<br />
queste pagine. Fate in modo di averne una permette di recuperare tutte le foto che<br />
riguardano un’istituzione e di massimizzare <strong>la</strong> ricerca. Inoltre, si può scegliere di<br />
geolocalizzare un’immagine: accedendo a quest’opzione, sarà possibile raccogliere su<br />
una mappa, accessibile in home page, tutte le foto scattate.<br />
È inoltre possibile essere taggati e taggare altri utenti: le foto in cui siete taggati<br />
appariranno in una specifica sezione, accessibile dal<strong>la</strong> vostra home page. (Fonti<br />
Slideshare.net e Youtube.com).<br />
La funzione video consente <strong>la</strong> creazione e il caricamento di filmati di massimo 15<br />
secondi. Non ci sono strumenti di back end che permettono di editare e montare il<br />
video, ma è tuttavia possibile caricare video girati ed editati precedentemente, sia da<br />
computer sia da cellu<strong>la</strong>re.<br />
La funzione video consente l’applicazione di filtri che sono completamente differenti<br />
da quelli delle foto.<br />
Il video, una volta finito, non consente <strong>la</strong> funzione loop: in questo senso, una volta che<br />
l’utente l’ha visto, dovrà cliccare nuovamente su p<strong>la</strong>y per rivederlo, contrariamente a<br />
quanto succede su Vine in cui il video riparte automaticamente.<br />
Su Instagram gli utenti possono interagire tramite commenti o likes. È possibile<br />
visualizzare le foto su cui gli utenti che seguiamo hanno fatto like. Questa funzione<br />
non è da sottovalutare se si pensa a come raggiungere “gli amici degli amici” che sono<br />
nelle stesse communities dei nostri followers e, potenzialmente, possono essere<br />
interessati ai nostri contenuti.
Instagram per i musei<br />
Quali sono i motivi principali per cui un museo dovrebbe usare questo social<br />
network?<br />
1. La quantità di utenti attivi su Instagram lo c<strong>la</strong>ssifica come uno dei<br />
“must to be on” social network. Inoltre, l’età media del<strong>la</strong> maggior parte<br />
degli utenti lo rende partico<strong>la</strong>rmente interessante: i giovani, infatti,<br />
sono spesso una delle categorie di visitatori che i musei fanno più fatica<br />
a coinvolgere.<br />
2. La componente estetica che caratterizza Instagram si presta molto<br />
bene ai tipi di contenuti che i musei possono condividere. Non solo arte<br />
e oggetti partico<strong>la</strong>rmente affascinanti, ma anche scorci degli edifici e<br />
scatti da eventi o programmi. Inoltre, con Instagram si possono<br />
evidenziare dettagli affascinanti dal<strong>la</strong> collezione che normalmente non<br />
verrebbero notati, attirando così potenzialmente l’attenzione su oggetti<br />
meno popo<strong>la</strong>ri o conosciuti.<br />
3. Instagram si presta moltissimo al<strong>la</strong> condivisione di momenti da<br />
“dietro le quinte”. Dai depositi alle movimentazioni di oggetti, dagli<br />
eventi all’attività di ufficio: basta un po’ di fantasia e l’universo museo<br />
può entrare e spopo<strong>la</strong>re nel<strong>la</strong> cornice quadrata di questo social network.<br />
4. L’immediatezza di un social visivo, abbinata alle potenzialità di una<br />
piattaforma mobile. A differenza di Pinterest, Instagram vive<br />
prettamente su uno smartphone. È lì che si trovano tutte le foto e video<br />
e da lì le posso condividere con estrema facilità. Questa componente<br />
favorisce <strong>la</strong> condivisione di immagini da parte del pubblico, anche<br />
durante <strong>la</strong> visita al museo, e <strong>la</strong> creazione di iniziative da parte del<br />
museo, come photo contest e instawalk<br />
(Instagramers.com/destacados/how-to-organize-an-instameet/), per<br />
aumentare l’engagement. La possibilità di scrivere brevi didascalie,<br />
inoltre, consente di aggiungere domande, quiz o concorsi e di<br />
strutturare <strong>la</strong> componente descrittiva del<strong>la</strong> storia che viene raccontata<br />
per immagini.
Inspirational<br />
Il Metropolitan Museum of Art vince un Webby Award<br />
Sarà per gli scatti da Met Ga<strong>la</strong>, o per le impressioni del Tempio di Dendur nel<strong>la</strong><br />
Sackler Wing, ma è veramente difficile non trovare “momenti instagrammabili” in un<br />
museo come il Met. Il suo profilo Instagram ha da poco vinto un Webby Award 16<br />
nel<strong>la</strong> sezione Social: Art and Culture.<br />
Sebbene il museo rimanga “gelidamente” poco interattivo in termini di commenti e<br />
incoraggiamenti, le foto dimostrano come un’istituzione possa far leva sul<strong>la</strong> bellezza<br />
degli spazi e degli eventi e celebrar<strong>la</strong> attraverso un social network.<br />
SF MoMA con #P<strong>la</strong>yartfully<br />
Il San Francisco MoMA invita gli utenti a scoprire l’arte nel mondo intorno a loro<br />
attraverso un piccolo gioco. Il museo, al momento chiuso per <strong>la</strong>vori di rinnovo, usa <strong>la</strong><br />
città come un p<strong>la</strong>yground, chiedendo agli utenti di cercare l’arte nei posti più<br />
sorprendenti e di postar<strong>la</strong> con l’hashtag #P<strong>la</strong>yArtfully. Il gioco prende piede su diversi<br />
social network, ma <strong>la</strong> versione di Instagram è decisamente <strong>la</strong> più strutturata. Ogni<br />
giorno il museo posta un “prompt” con una grafica apposita per <strong>la</strong> piattaforma.<br />
#CupForFund Pa<strong>la</strong>zzo Madama<br />
Nel 2013, Pa<strong>la</strong>zzo Madama ha organizzato <strong>la</strong> prima campagna di crowdfunding<br />
italiana per l’acquisto di un servizio di porcel<strong>la</strong>na del 1730, un tempo appartenuto al<strong>la</strong><br />
famiglia Taparelli D’Azeglio, famiglia di Torino. La campagna social per l’iniziativa<br />
ha incluso l’hashtag #cupforfund e <strong>la</strong> call to action che invitava pubblico a scattare<br />
foto delle tazze preferite postandole su Instagram.<br />
Nell’ambito di quest’iniziativa, Pa<strong>la</strong>zzo Madama e Instagrammers hanno <strong>la</strong>vorato<br />
insieme per l’organizzazione di una Instawalk in cui i visitatori erano invitati a<br />
visitare il museo e a condividere foto del<strong>la</strong> propria tazza, generando occasioni per <strong>la</strong><br />
donazione.<br />
MoMA affida a curatrice in trasferta l’Instagram account del museo<br />
Curatori, ricercatori e conservatori dei musei viaggiano continuamente per seguire<br />
prestiti o fare ricerca sul campo. Durante questi viaggi, visitano città, musei ed eventi,<br />
entrano in contatto con opportunità di arricchimento professionale e personale che si<br />
estendono a tutta l’istituzione. Perché non capitalizzare in termini social? Il MoMA<br />
affida per alcuni giorni l’account Instagram ai suoi curatori in viaggio. Un esempio?<br />
<strong>la</strong> curatrice Roxana Marcoci, in visita a Berlino.
Nga organizza un Instameet<br />
La National Gallery of Art ha da poco aperto il suo canale Instagram. Come<br />
guadagnare follower e contenuti per il canale in una volta so<strong>la</strong>, promuovendo nel<br />
contempo anche le attività del Museo? Organizzando un Instameet naturalmente!<br />
Amsterdam Tattoo Museum mette in vetrina le proprie attività<br />
L’Amsterdam Tattoo Museum conserva <strong>la</strong> collezione del famoso tattoo artist Henk<br />
‘Hanky Panky’ Schiffmacher. Il museo ha attraversato diversi problemi economici che<br />
lo hanno costretto a cambiare sede, tuttavia <strong>la</strong> community di tatuatori e artisti<br />
internazionali che ruota intorno a quest’istituzione è sempre rimasta molto unita. Il<br />
museo ospita anche uno studio in cui tatuatori offrono i loro servizi. Il canale<br />
Instagram è una vetrina di tutte le attività che il museo porta avanti: dalle fiere agli<br />
eventi, dalle serate folli a work in progress sul<strong>la</strong> pelle dei clienti, <strong>la</strong> voce di questo<br />
canale è tutt’altro che seria e istituzionale. Il museo utilizza questo social network con<br />
lo stesso spirito irriverente e amichevole che lo caratterizza.<br />
Flickr<br />
Cos’è<br />
Flickr è una piattaforma di photo e video sharing nata nel 2004 e acquisita da Yahoo<br />
nel 2005.<br />
La community di questo social network è in costante crescita: a marzo 2013, infatti,<br />
<strong>la</strong> piattaforma contava 87 milioni di utenti.<br />
Flickr stabilisce due principali obiettivi: aiutare gli utenti a mettere le foto a<br />
disposizione delle persone interessate e abilitare nuovi metodi per l’organizzazione<br />
delle foto e dei video. Si tratta di due semplici punti, tuttavia è interessante notare<br />
come questi soddisfino esigenze nate con il digitale. Un tempo sviluppavamo i rullini<br />
e organizzavamo foto in album cartacei, che accatastavamo su mensole polverose,<br />
pronti per essere consultati in occasioni partico<strong>la</strong>ri insieme al<strong>la</strong> famiglia. Se<br />
dovessimo compiere oggi quell’operazione verremmo sommersi da materiale, basti<br />
considerare <strong>la</strong> quantità di foto che archiviamo digitalmente – su computer o<br />
smartphone/tablet – anche senza essere fotografi professionisti.<br />
La community di Flickr è molto variegata. Oltre a utenti che impiegano questa<br />
piattaforma per l’organizzazione dei loro contenuti video e foto, questa raccoglie<br />
anche fotografi professionisti o amatoriali che <strong>la</strong> utilizzano come vetrina per i propri<br />
<strong>la</strong>vori.
Come funziona<br />
Foto e video possono essere consultati e scaricati senza dover creare un account,<br />
tuttavia, per caricare contenuti è necessario registrarsi.<br />
Le foto e i video possono essere tito<strong>la</strong>ti e taggati, e quest’ultima azione può essere<br />
compiuta anche dagli utenti non autori, qualora il proprietario lo consenta.<br />
Flickr è stato riconosciuto come il primo esempio di uso effettivo del<strong>la</strong> “folcsonomia”<br />
o folksonomy, ovvero <strong>la</strong> pratica di assegnare tag a un contenuto al fine di<br />
indicizzarlo. Tale pratica può essere “broad”, quando è col<strong>la</strong>borativa e compiuta da<br />
più utenti, o “narrow” quando è soltanto colui che pubblica il contenuto a taggarlo.<br />
(Fonti: Wikipedia.org; Flickr.com/about/; Stephanspencer.com)<br />
Gli utenti possono anche commentare i contenuti, quando aperti. Infatti, Flickr<br />
consente <strong>la</strong> gestione di profili privati e pubblici. Altra interessante funzione è<br />
costituita dalle note che gli utenti possono postare direttamente sul<strong>la</strong> foto per<br />
segna<strong>la</strong>rne o commentarne i partico<strong>la</strong>ri. Ecco un (esempio).<br />
Gli utenti di Flickr possono organizzare le foto in album e una stessa foto può entrare<br />
a far parte di più album. Gli stessi album possono inoltre rientrare in collezioni,<br />
organizzate, a loro volta, in collezioni di categoria più alta. È inoltre possibile<br />
geolocalizzare le immagini, che finiranno su una mappa. La mappa, così come ogni<br />
contenuto caricato su Flickr, può essere incorporata in blog e siti terzi.<br />
Una delle funzioni più interessanti di questa piattaforma è quel<strong>la</strong> che consente di<br />
ri<strong>la</strong>sciare immagini sotto licenze, prevalentemente Creative Commons, o avere<br />
“Tutti i diritti riservati” di quello che si carica. Le licenze Commons consentono di<br />
scaricare e riutilizzare le immagini a determinate condizioni. È possibile, attraverso<br />
ricerche avanzate, selezionare le immagini con licenze CC per una data paro<strong>la</strong> chiave.<br />
(Fonti: Flickr.com/creativecommons/; Creativecommons.org/licenses)<br />
Tra le licenze Commons che Flickr utilizza segnaliamo le principali:<br />
Attribuzione CC BY: raccomandata per l’uso massimo dei materiali, consente a terzi<br />
di distribuire, modificare e utilizzare, anche commercialmente, un’opera affinchè sia<br />
dato credito all’autore.<br />
Attribuzione CC BY-NC: consente ad altri di copiare, distribuire, visualizzare ed<br />
e<strong>la</strong>borare un’opera (e opere derivanti) a fini esclusivamente non commerciali. Le<br />
opere derivate dovranno accreditare l’autore ed essere non commerciali. Tuttavia,
queste non devono a loro volta licenziare le opere derivate nello stesso modo.<br />
Attribuzione CC BY-ND: questa licenza permette <strong>la</strong> ridistribuzione, commerciale e<br />
non, segna<strong>la</strong>ndo il credito e non modificando l’opera.<br />
Attribuzione CC BY-SA: questa licenza permette a terzi di modificare, ottimizzare<br />
ed utilizzare l’opera come base, creditando l’autore. L’uso commerciale è consentito a<br />
meno che non sia specificato diversamente. Le nuove creazioni dovranno sottostare ai<br />
medesimi termini. Wikipedia, così come alcuni software open source, utilizzano<br />
questa licenza che è consigliata per materiali che potrebbero beneficiare<br />
dell’incorporazione di contenuti da progetti come Wikipedia o simili.<br />
Flickr per i musei<br />
Come accennato, Flickr è, prima di tutto, un potente strumento per l’organizzazione<br />
di contenuti video e fotografici.<br />
Al di là del<strong>la</strong> conservazione di immagini del<strong>la</strong> collezione e delle foto storiche, i musei<br />
producono una quantità importante di fotografie durante eventi, inaugurazioni o<br />
operazioni “behind the scenes” – come conservazione e movimentazioni. Flickr può<br />
rappresentare un ottimo strumento per garantire <strong>la</strong> loro organizzazione, anche se non<br />
finalizzata al<strong>la</strong> diffusione al pubblico, ma solo internamente o tra i principali<br />
stakeholder.<br />
Inoltre, caricare contenuti su Flickr permette di avere una base “linkabile” per altri<br />
contenuti, come blog post, altre piattaforme social o perfino apps e chioschi<br />
interattivi.<br />
Le istituzioni <strong>cultura</strong>li possono utilizzare questo strumento in modi creativi e radicali.<br />
Ad esempio, l’uso di Flickr per i musei può ispirare <strong>la</strong> realizzazione di mostre cocurate<br />
con il pubblico e altre iniziative a partire dalle immagini.<br />
Diversamente, <strong>la</strong> piattaforma offre degli strumenti utili anche a soddisfare semplici<br />
esigenze organizzative, come il supporto al<strong>la</strong> gestione dell’archivio fotografico.<br />
Quest’ultima opzione, tuttavia, fa sorgere domande sulle possibilità tecniche e<br />
museologiche, per <strong>la</strong> conservazione di quello che diventerebbe, a tutti gli effetti, un<br />
archivio digitale. (vedi Museumsandtheweb.com)<br />
Diversi musei postano ormai foto su Flickr ri<strong>la</strong>sciate senza partico<strong>la</strong>ri restrizioni,<br />
come parte del progetto The Commons on Flickr. La piattaforma definisce questo<br />
sviluppo come un modo per condividere i tesori nascosti negli archivi fotografici del
mondo e, successivamente, mostrare come l’input delle istituzioni che le ri<strong>la</strong>sciano<br />
possa renderle ancora più ricche.<br />
Le licenze Creative Commons offrono un’alternativa al copyright totale e sollevano<br />
riflessioni – anche controverse – su come i musei possano garantire o limitare<br />
l’accesso alle loro collezioni. Sebbene il dibattito non possa soltanto limitarsi a Flickr<br />
e ai materiali fotografici, ma includa opere, manoscritti, documenti d’archivio e altro<br />
ancora, i musei non possono ignorare questa importantissima tendenza. Grandi<br />
istituzioni hanno già messo a disposizione alcuni archivi fotografici attraverso<br />
questa piattaforma che può rappresentare un punto di partenza, un piccolo passo, su<br />
una strada verso una maggiore apertura. (vedi Museumsandtheweb.com)<br />
In conclusione, aggiungiamo che, rispetto alle altre piattaforme di photo sharing,<br />
Flickr fornisce un supporto più “istituzionale” e permette l’aggregazione di contenuti<br />
di vario genere. È comunque presente un aspetto “curatoriale”, come in Pinterest,<br />
nel<strong>la</strong> creazione di albums e collezioni. Tuttavia, Flickr rappresenta <strong>la</strong> base del<strong>la</strong><br />
“piramide social” considerando <strong>la</strong> flessibilità con cui i contenuti pubblicati possono<br />
essere riutilizzati e linkati anche dal<strong>la</strong> stessa istituzione su una molteplicità di altre<br />
piattaforme.<br />
Inspirational<br />
Common Ground: a community-curated meetup<br />
Nel 2009 le istituzioni aderenti al The Commons on Flickr hanno organizzato una<br />
meet up in differenti luoghi intorno al mondo. Questo tipo di evento, oggi sempre più<br />
comune e conosciuto come tweetup o instawalk, ha rappresentato una delle prime<br />
occasioni di riflessione sulle comunità <strong>online</strong> nonchè sul<strong>la</strong> sovrapposizione tra Web e<br />
esperienza fisica nel museo.<br />
The Powerhouse Museum<br />
Una delle istituzioni che fanno parte di The Commons condivide su Flickr immagini<br />
provenienti dalle tre maggiori collezioni storiche. Queste possono essere condivise<br />
liberamente in quanto i diritti su queste immagini sono decaduti. Tra gli utilizzi più<br />
interessanti, abbiamo <strong>la</strong> serie Then & Now di Paul Wagon, un programmatore<br />
australiano che, attraverso le API di Flickr, ha combinato le immagini storiche dei<br />
luoghi del museo con le immagini dei luoghi attuali, assemb<strong>la</strong>ndole su Google Maps<br />
Street View.
A titolo informativo, segnaliamo un’altra piattaforma che consente di mappare siti<br />
<strong>cultura</strong>li e di aggiungervi “uno strato” con foto storiche e di archivio, nonché<br />
contenuti inaspettati: HistoryPin.<br />
Tumblr<br />
Cos’è<br />
Tumblr è una piattaforma di micro-blogging fondata da David Karp nel 2007 e<br />
acquistata da Yahoo!Inc. nel 2013.<br />
È un social network che consente agli utenti di postare multimedia e contenuti<br />
testuali in piattaforme simili a blog, tuttavia più brevi e, soprattutto, più dinamiche.<br />
Le tipologie di blog sono diversissime, ma sempre caratterizzate da una partico<strong>la</strong>re<br />
cura dei dettagli: da collezioni di illustrazioni a blog tematici su cinema, cucina,<br />
fumetti etc., a veri e propri diari personali, fino al<strong>la</strong> proposta di matrimonio del 2009<br />
(fonte Techcrunch.com).<br />
Ad oggi sono presenti 188.7 milioni di blog su Tumblr per un totale di 88,297,300<br />
post. La piattaforma supporta 13 lingue, ma il focus principale degli utenti non<br />
sembra essere il testo scritto: secondo un articolo di Mashable, già nel 2011 quasi <strong>la</strong><br />
metà dei post su questo social era costituito da immagini (fonte Mashable.com).<br />
La maggioranza degli utenti ha un’età compresa tra i 18 e i 34 anni, seguita dal<strong>la</strong><br />
fascia tra i 35 e i 49 anni. I tempi di permanenza degli utenti sul<strong>la</strong> piattaforma sono<br />
elevati, con un’ora e mezza di media al mese per persona, un record che è superato<br />
solo da Facebook (vedi Comeusare.tumblr.com).<br />
Come funziona?<br />
Postare su Tumblr è molto semplice: gli utenti possono accedere al<strong>la</strong> propria home<br />
page o dashboard, che contiene gli aggiornamenti di tutti i blog che hanno deciso di<br />
seguire. Dal<strong>la</strong> dashboard è possibile commentare, ri-bloggare (retumblr) e fare like ai<br />
post.<br />
La dashboard permette anche di caricare post di testo, immagini, video, citazioni e<br />
link, ed è possibile programmare <strong>la</strong> pubblicazione dei post. Inoltre, l’utente può<br />
scegliere di connettere il proprio blog su Tumblr a Twitter e Facebook.<br />
Sul<strong>la</strong> dashboard è inoltre presente il Tumblr Radar, uno spazio in cui compaiono
contenuti partico<strong>la</strong>rmente interessanti curati dallo staff del social network.<br />
Tumblr utilizza le tag: si tratta di parole chiave che ogni utente può inserire all’interno<br />
del post che sta pubblicando, per permettere agli altri utenti di cercare e filtrare i<br />
contenuti per tema.<br />
Questa piattaforma consente anche di editare lo stile e l’aspetto del proprio blog e<br />
fornisce una buona scelta di temi predefiniti e modificabili in HTML. Infine, è<br />
anche possibile personalizzare l’URL del proprio blog.<br />
Un aspetto molto positivo di Tumblr è che, essendo sostenuto da finanziatori privati, è<br />
uno dei pochi social network che non contengono pubblicità. Tuttavia, il sistema<br />
permette di evidenziare i propri contenuti rispetto ad altri, pagando una cifra<br />
abbastanza bassa.<br />
Tumblr per i musei<br />
Tumblr consente <strong>la</strong> creazione di contenuti molto partico<strong>la</strong>ri. Pur avendo dinamiche<br />
simili a Twitter e l’immediatezza visiva di Instagram, consente di postare diverse<br />
tipologie di media senza partico<strong>la</strong>ri limiti di spazio.<br />
Le GIF (Graphics Interchange Format) sono una componente molto popo<strong>la</strong>re su<br />
Tumblr: si tratta infatti di immagini dal tono partico<strong>la</strong>rmente ironico e leggero che<br />
vengono animate per singoli frame, senza audio, spesso dotate di sottotitoli.<br />
In questo senso, Tumblr è <strong>la</strong> piattaforma ideale per contenuti semi-dinamici. Oggetti<br />
e opere museali, tipicamente “immobili” e spesso non manipo<strong>la</strong>bili, possono quindi<br />
prendere vita grazie alle GIF e, ad esempio, è possibile mostrare il funzionamento di<br />
una macchina di Leonardo o far sì che <strong>la</strong> famosa Dama accarezzi l’ermellino.<br />
L’elemento di “serendipity” sembra <strong>la</strong> firma di questo social network: è un canale in<br />
cui un dettaglio nascosto o un oggetto poco conosciuto possono funzionare da<br />
elemento di attrazione per raccontare una storia, con una componente di sorpresa che<br />
ricorda quel<strong>la</strong> che ci assale quando troviamo qualcosa di inaspettato in soffitta.<br />
Tumblr costituisce una piattaforma re<strong>la</strong>tivamente impegnativa in termini di creazione<br />
di contenuti “tagliati” su di essa, non ricic<strong>la</strong>ti da altri social. Tuttavia, <strong>la</strong> quantità di<br />
utenti che lo usano e il suo spirito giovane e a tratti ironico lo rendono un canale<br />
veramente partico<strong>la</strong>re, che, se usato con <strong>la</strong> giusta strategia, può fornire tantissimi<br />
spunti a un museo. (Fonti Theguardian.com e Museumnerd.tumblr.com).<br />
Inspirational
Horniman Museum & Gardens<br />
Vincitore del Best of the Web 2014 per <strong>la</strong> categoria social, il Tumblr dell’Horniman<br />
Museum & Gardens sembra una scato<strong>la</strong> magica piena di oggetti bizzarri, creature<br />
misteriose e decorazioni di altri tempi.<br />
Il team del museo ha trasformato un’operazione completamente interna – <strong>la</strong> revisione<br />
dell’archivio del<strong>la</strong> collezione – in un evento social. Il Tumblr raccoglie infatti tutti gli<br />
oggetti curiosi e inaspettati che il team trova nei depositi, aprendo al pubblico le porte<br />
su questa componente “dietro le quinte”.<br />
Smithsonian Libraries<br />
Il team “diffuso” delle Smithsonian Libraries fa un uso totalmente nuovo di Tumblr,<br />
creando GIF animate dai libri nel<strong>la</strong> collezione. Il risultato è un mix divertentissimo<br />
che racconta e anima storie altrimenti immobili sul<strong>la</strong> pagina. Scelte per il Tumblr<br />
Radar per ben otto volte, queste GIF sono frutto del <strong>la</strong>voro di un vero e proprio<br />
artista.<br />
Brooklyn Museum – Keith Haring’s Journal<br />
Il Brooklyn Museum, nell’ambito del<strong>la</strong> mostra su Keith Haring, ha postato ogni giorno<br />
una pagina del diario dell’artista su un account Tumblr appositamente aperto.<br />
All’interno del<strong>la</strong> mostra, una postazione iPad permetteva di accedere al Tumblr e<br />
consultarne i contenuti.<br />
Exploratorium – Explodingtorium<br />
Il famosissimo Science Center di San Francisco ha un account Tumblr, associato a<br />
quello più “istituzionale”, che utilizza per postare foto storiche. Queste raccontano <strong>la</strong><br />
storia dell’istituzione e danno <strong>la</strong> possibilità di esplorare gli archivi, altrimenti<br />
inaccessibili al pubblico.
YouTube e video<br />
Cosa sono<br />
YouTube è una piattaforma web gratuita per <strong>la</strong> condivisione e visualizzazione in rete<br />
di video (video sharing). Il nome deriva dal termine “tube”, che in s<strong>la</strong>ng inglese indica<br />
<strong>la</strong> televisione e si riferisce ai primi modelli dotati di tubo catodico, affiancato al<br />
pronome “you”: dunque “you tube” significa “tu fai <strong>la</strong> televisione”, proprio in<br />
re<strong>la</strong>zione al<strong>la</strong> capacità fornita dal servizio di organizzare propri canali e raccolte di<br />
video, autoprodotti o recuperati in rete.<br />
Fondato nel 2005 da Chad Hurley, Steve Chen e Jawed Karim e divenuto proprietà di<br />
Google Inc. già dal 2006, è il terzo sito web più visitato al mondo dopo Google e
Facebook, nonché il secondo motore di ricerca dopo il colosso di Mountain View. I<br />
dati ufficiali rive<strong>la</strong>no che ogni mese più di un miliardo di utenti unici visita<br />
YouTube, vengono guardati oltre 6 miliardi di ore di video (pari a quasi un’ora per<br />
ogni persona sul<strong>la</strong> Terra) e ogni minuto viene effettuato l’upload di 100 ore di filmati<br />
(fonti Statista.com e Youtube.com). Secondo Nielsen, YouTube raggiunge più<br />
americani adulti nel<strong>la</strong> fascia di età 18-34 anni rispetto a qualsiasi rete via cavo.<br />
YouTube ha una vera audience internazionale molto diversificata, non c’è da<br />
sorprendersi considerando <strong>la</strong> varietà di contenuti che vi si possono trovare. Tra i video<br />
che possiamo ritenere più popo<strong>la</strong>ri abbiamo Vlog (video blog personali su diversi<br />
argomenti, Comedy skits, Gaming (un’interessante sub-<strong>cultura</strong> di YouTube include<br />
utenti che registrano e trasmettono partite con videogiochi), Educational, Musica,<br />
Artisti e perfino video che includono effetti speciali.<br />
Vine è un’applicazione gratuita che permette agli utenti di creare direttamente dal<br />
proprio telefono video in loop del<strong>la</strong> durata massima di 6,5 secondi, chiamati appunto<br />
vines, e di condividerli su diversi servizi di social networking, come Facebook o<br />
Twitter.<br />
Secondo i dati diffusi da Twitter, che ha rilevato <strong>la</strong> start up nel 2012, pochi mesi<br />
dopo il <strong>la</strong>ncio ad opera degli ideatori Dom Hofmann, Rus Yusupov e Colin Kroll,<br />
nell’agosto 2013 Vine segnava quota 40 milioni di utenti registrati (vedi<br />
Twitter.com/vineapp e Mashable.com); non esistono però cifre ufficiali circa il reale<br />
numero dei profili attivi o ulteriori aggiornamenti a riguardo (fonte Theverge.com).<br />
La community di Vine include giovani utenti nonché artisti e creativi. Si tratta di una<br />
community re<strong>la</strong>tivamente picco<strong>la</strong> e in Italia <strong>la</strong> app non ha ancora preso<br />
partico<strong>la</strong>rmente piede. Gli utenti di Vine e YouTube sono simili in termini di<br />
demografica: giovani tra i 18 e i 29 anni. Capita spesso, inoltre, che le community dei<br />
due canali col<strong>la</strong>borino: Youtubers molto popo<strong>la</strong>ri, specie quelli che creano comedy<br />
skits e video virali, sono solitamente attivi anche su Vine.<br />
La possibilità di realizzare brevi filmati è simile al<strong>la</strong> funzione video di Instagram –<br />
discussa nel capitolo dedicato a questa piattaforma – , se si eccettua <strong>la</strong> differente<br />
durata dei filmati, che per l’applicazione ora di proprietà di Facebook è compresa tra<br />
i 3 e i 15 secondi. Inoltre, mentre per Vine il loop del video è automatico, Instagram<br />
richiede il tap dell’utente per farlo ripartire ogni volta.<br />
Un’ultima piattaforma che permette <strong>la</strong> condivisione video è Vimeo, fondata nel 2004.<br />
Vimeo raccoglie unisce soprattutto un pubblico di appassionati e professionisti di<br />
cinema e animazione. I maggiori contenuti che vi si trovano, infatti, sono corti,
cartoni e film indipendenti nonché documentari con una vena partico<strong>la</strong>rmente<br />
“artistica”.<br />
Come funzionano<br />
YouTube presenta diverse possibilità di utenza, in forma passiva ed attiva.<br />
La prima consiste nell’utilizzo del<strong>la</strong> piattaforma come fosse praticamente un motore<br />
di ricerca da interrogare per ottenere video su un dato argomento o prodotto da uno<br />
specifico autore. Come accennato, <strong>la</strong> piattaforma è il secondo motore di ricerca dopo<br />
Google. Questo significa che chi usa questa piattaforma per caricare contenuti deve<br />
prestare attenzione al<strong>la</strong> tito<strong>la</strong>zione, scegliendo parole efficaci ma semplici, così da<br />
agevo<strong>la</strong>rne <strong>la</strong> ricerca da parte degli utenti.<br />
Il livello successivo si traduce nel<strong>la</strong> sottoscrizione di un account personale (più<br />
propriamente detto “canale”, collegato ad un indirizzo Gmail) che consente di<br />
commentare, raccogliere ed organizzare i filmati preferiti in archivi (“p<strong>la</strong>ylist”) in<br />
base al soggetto o ai gusti personali.<br />
Questa seconda modalità prevede non solo <strong>la</strong> visualizzazione ma anche <strong>la</strong> produzione<br />
e l’immissione in rete di contenuti propri, a loro volta sistemati entro p<strong>la</strong>ylist.<br />
Pubblicare un video su YouTube è molto semplice: una volta <strong>la</strong>nciate le procedure<br />
di caricamento del file dal proprio pc (è anche possibile registrare direttamente dal<strong>la</strong><br />
webcam o creare una slideshow) si aprirà una finestra che consentirà di inserire le<br />
informazioni di base re<strong>la</strong>tive al contenuto del filmato, come il titolo, <strong>la</strong> descrizione, i<br />
tag e le impostazioni circa <strong>la</strong> privacy, tutti dati utili per <strong>la</strong> rintracciabilità in rete<br />
dell’opera pubblicata. Una seconda schermata permetterà di definire in dettaglio<br />
ulteriori preferenze circa, ad esempio, i commenti di terzi, <strong>la</strong> localizzazione, le<br />
licenze di riproduzione e distribuzione (ovvero <strong>la</strong> possibilità di incorporare il video in<br />
siti esterni), <strong>la</strong> categoria di appartenenza e le statistiche.<br />
Recenti innovazioni del servizio consentono ora di personalizzare un canale YouTube<br />
con elementi grafici selezionati tra i propri scatti oppure tra quelli messi a<br />
disposizione sul<strong>la</strong> piattaforma stessa (Channel Art). Si tratta di una caratteristica<br />
utile a chi intenda rafforzare il proprio brand o coordinare l’immagine, ad esempio, su<br />
tutte le piattaforme social in cui è presente. Esistono inoltre un music store, per<br />
aggiungere musica ai video che l’utente crea o carica, e un servizio di sottotito<strong>la</strong>zione<br />
dei contenuti. I sottotitoli, partico<strong>la</strong>rmente importanti quando si pensa<br />
all’accessibilità di filmati, possono essere caricati individualmente, creati attraverso<br />
voice recognition – in questo caso è consigliata <strong>la</strong> revisione – o generati mediante una
ichiesta agli utenti del canale.<br />
YouTube fornisce diversi strumenti di back-end per osservare gli analytics del<br />
canale, molto utili per tenere sotto controllo andamenti, utenza e durata del<strong>la</strong><br />
visualizzazione.<br />
Ricordiamo inoltre che, attraverso Google Hangout, è possibile impostare uno<br />
streaming live sul proprio canale YouTube.<br />
È possibile anche incorporare pubblicità all’interno di un canale, così come esistono<br />
canali a pagamento. È prevista, inoltre, <strong>la</strong> possibilità di impostare <strong>la</strong> ricezione di<br />
donazioni sul proprio canale. Il merchandising è infine parte del<strong>la</strong> YouTube Culture:<br />
se un canale ha partico<strong>la</strong>re successo, contiene slogan e personaggi che diventano<br />
popo<strong>la</strong>ri tra gli utenti, è pratica comune creare t-shirts e gadgets dedicati. (Fonti<br />
Support.google.com, Chefuturo.it, Dixieleigh.com, Support.google.com/youtube,<br />
Youtube.com, Tuttosuyoutube.it, Support.google.com/youtube/answer)<br />
È possibile caricare un video su Vine solo attraverso <strong>la</strong> app, filmando direttamente<br />
con il proprio dispositivo mobile. Non è possibile importare video da altre<br />
piattaforme, cosa invece realizzabile con Instagram, YouTube e Vimeo. La app offre<br />
strumenti di video editing piuttosto e<strong>la</strong>borati che permettono <strong>la</strong> gestione di effetti e<br />
montaggio anche complessi. La versione desktop, uscita recentemente, permette solo<br />
di ripostare i video di altri utenti (revine).<br />
Come dicevamo, a differenza dei video di Instagram, i micro filmati ottenuti<br />
utilizzando Vine sono riprodotti in loop, ovvero ininterrottamente. Possono essere<br />
registrati direttamente da smartphone senza soluzione di continuità oppure come<br />
insieme di più sequenze giustapposte e successivamente condivisi con gli altri<br />
utenti, per poi essere ri<strong>la</strong>nciati su Facebook e Twitter o inseriti in embed in siti terzi.<br />
In entrambi gli ambienti, invece, il contenuto può essere geolocalizzato ed<br />
accompagnato da hashtag e descrizioni che lo completino.<br />
(Fonti Techcrunch.com, Blog.twitter.com, Blog.instagram.com, Help.instagram.com,<br />
Vinevsinstagram.com, Mashable.com, Blog.kissmetrics.com).<br />
Per quanto riguarda Vimeo, <strong>la</strong> piattaforma offre un account gratuito basico e uno Pro<br />
a pagamento, che fornisce caratteristiche avanzate.<br />
La funzione “Tip Jar”, fornisce agli user <strong>la</strong> possibilità di fare donazioni. Nel<strong>la</strong><br />
versione Pro User, si possono anche guardare video “on demand”, tuttavia,<br />
nell’immaginare possibili utilizzi da parte dei musei, garantire accesso libero e<br />
illimitato dovrebbe essere un principio dominante. Vimeo offre inoltre <strong>la</strong> possibilità<br />
di sottotito<strong>la</strong>re i contenuti. Il formato, soprattutto con l’opzione Pro, è molto più
grande e “pulito” di YouTube, dove invece regnano una quantità di link, altri video e<br />
pubblicità.<br />
YouTube per i musei<br />
Quali sono i motivi principali per cui un museo dovrebbe usare YouTube?<br />
Forse, in questo caso, <strong>la</strong> domanda dovrebbe essere: quali sono i motivi per cui un<br />
museo non dovrebbe usare YouTube? Il canale, infatti, dovrebbe rientrare in una più<br />
ampia strategia video di cui <strong>la</strong> creazione di contenuti ad hoc è parte integrante.<br />
Sono pochi i musei, italiani ed esteri, che hanno deciso di sperimentare seriamente<br />
sulle possibilità offerte dai canali video.<br />
Comunemente, YouTube viene utilizzato come archivio di raccolta dei contenuti<br />
che un museo già possiede, caratterizzati da un formato statico – come conferenze e<br />
talk – e spesso creati da video maker professionisti. È infatti pratica comune per i<br />
musei riversare su questa piattaforma i contenuti creati per chioschi interattivi in<br />
galleria, o altri supporti multimediali per cui i video erano stati originariamente<br />
prodotti.<br />
Se è vero che ogni social ha <strong>la</strong> sua <strong>cultura</strong>, i suoi rituali, le sue community e i suoi<br />
linguaggi, ciò è ancora più vero per YouTube. Le istituzioni <strong>cultura</strong>li non possono<br />
quindi approcciare questo canale come un archivio e aspettarsi di costruire una<br />
community intorno a esso. I contenuti devono essere “tagliati” per <strong>la</strong> piattaforma e<br />
partire da una profonda conoscenza del<strong>la</strong> “YouTube culture”. Spesso, questo significa<br />
optare per un tono informale e libero.<br />
Se quello che un museo desidera costruire è <strong>la</strong> popo<strong>la</strong>rità, questo canale impone <strong>la</strong><br />
definizione di un tono personalizzato e interattivo. Esistono infatti serie, come<br />
NerdFighters e Minutephysics, che offrono contenuti educativi, apparentemente<br />
inadatti per <strong>la</strong> piattaforma. Grazie al tono divertente, goliardico e informale,<br />
raggiungono picchi di utenza incredibili.<br />
Sebbene questo ragionamento possa essere fatto per qualunque piattaforma social, è<br />
partico<strong>la</strong>rmente applicabile all’uso di Vine, in quanto vi è connessa una community<br />
re<strong>la</strong>tivamente ristretta e “specifica”. La app ha una <strong>cultura</strong> totalmente differente dagli<br />
altri canali video che abbiamo analizzato. Ciò significa che ri-postare contenuti creati<br />
per altre piattaforme non porterebbe al<strong>la</strong> costruzione di audience solide e<br />
appassionate, ma piuttosto determinerebbe uno spreco di tempo e risorse per <strong>la</strong><br />
gestione di un ulteriore canale social.<br />
Quando si par<strong>la</strong> di strategia video – o di strategia social in generale – è importante
esplorare e conoscere il “taglio” che <strong>la</strong> molteplicità di canali offrono. Talvolta, le<br />
logiche che applichiamo nel<strong>la</strong> creazione di contenuti per un determinato media – in<br />
questo caso il video – non valgono per queste piattaforme sociali, soggette a logiche<br />
completamente differenti.<br />
Alcuni riferimenti per l’utilizzo di YouTube in ambito <strong>cultura</strong>le possono essere:<br />
– Dixieleigh.com<br />
– Museumsandtheweb.com<br />
– Archeovideo.wordpress.com<br />
– Childrensmuseum.org<br />
– Pencils.com<br />
– Blogs.houstonpress.com<br />
– Socialbrite.org<br />
Inspirational<br />
The Brain Scoop – The Field Museum, Chicago<br />
Emily Graslie presenta il canale The Brain Scoop nel ruolo di Chief Curiosity<br />
Correspondent del Field Museum di Chicago. The Brain Scoop mostra un possibile<br />
esempio di come un museo possa investire per <strong>la</strong> creazione di video adatti a<br />
YouTube.<br />
Il principale obiettivo è quello di mostrare il “behind the scenes” del museo,<br />
illustrando gli oggetti e le attività più strane, curiose e interessanti. Il tutto a cadenza<br />
rego<strong>la</strong>re – ogni due settimane un nuovo episodio – e con uno stile estremamente<br />
spiritoso. Emily è sicuramente il personaggio “di punta” in questo senso e con il suo<br />
ruolo si propone di ispirare le giovani donne a intraprendere carriere nell’ambito<br />
scientifico.<br />
MOCATV<br />
MOCATV è un canale YouTube dedicato all’arte contemporanea e sviluppato come<br />
estensione digitale del Department of Education & Exhibition Programming del<br />
Museum of Contemporary Art di Los Angeles. Il canale contiene video originali e<br />
curati volti a educare e coinvolgere un’audience globale. Sebbene il <strong>la</strong>voro del MOCA<br />
sia prettamente <strong>la</strong>voro di studio, cosa che <strong>la</strong> maggior parte dei musei non possono<br />
permettersi, il risultato è partico<strong>la</strong>rmente interessante. L’istituzione, infatti, utilizza il<br />
canale per esporre contenuti all’intersezione tra film film, video, musica,
performance, danza e altro ancora.<br />
Metropolitan Museum of Art<br />
I video sono divisi in p<strong>la</strong>ylist e coprono una gamma di temi vastissima: concerti,<br />
interviste con artisti, dietro le quinte con i restauratori, ma soprattutto vere e proprie<br />
lectures sulle opere, gli oggetti, gli strumenti musicali e gli elementi architettonici<br />
del<strong>la</strong> collezione permanente. Sembrano essere partico<strong>la</strong>rmente apprezzati i video del<strong>la</strong><br />
sezione “82nd and Fifth”, una webserie con clip da due minuti che esplorano 100<br />
opere del Met con l’intervento di 100 curatori. Tutti i video presentano nelle poche<br />
righe di accompagnamento il link al sito del progetto attraverso il quale è possibile<br />
ammirare l’opera con close-up in altissima definizione.<br />
Google+<br />
Cos’è<br />
Gestito dal colosso di Mountain view, Google+ è <strong>la</strong> componente social dei molti<br />
servizi offerti da Google. Ci sono 540 milioni di utenti attivi che usano ogni giorno<br />
almeno una delle componenti dell’universo Google, mentre <strong>la</strong> versione “Plus” ne conta<br />
300 milioni ed è un social network in costante crescita.<br />
Google+ è stato <strong>la</strong>nciato nel 2011 con una prima fase di test solo su invito. Oggi è<br />
usato in maggioranza da utenti maschi (65%) e <strong>la</strong> fascia d’età più popo<strong>la</strong>re è quel<strong>la</strong><br />
tra i 25 e i 34 anni (31%). Le restrizioni per gli utenti minorenni hanno influenzato<br />
<strong>la</strong> presenza di teenager fino a quando, nel 2012, Google+ ha consentito l’iscrizione<br />
agli utenti con almeno 13 anni d’età (fonte Wearesocial.it).<br />
Cosa rende partico<strong>la</strong>rmente interessante Google+? Il fatto che i contenuti pubblici<br />
condivisi su questa piattaforma vengono indicizzati e posizionati da Google, a<br />
differenza di quanto accade con i tweet o i post di Facebook. In altre parole, se<br />
vogliamo che un nostro contenuto appaia tra i primi risultati di ricerca su Google, il<br />
modo migliore è condividerlo nel suo Social Engine (fonte Karibusana.org).<br />
Come funziona<br />
Tutte le applicazioni Google sono tra loro connesse: per questo motivo, l’account G+ è<br />
creato nel momento stesso in cui si sottoscrive un account Gmail ed è collegato
all’utilizzo di Google Maps, YouTube, Google P<strong>la</strong>y e altri servizi dell’universo Google.<br />
Sebbene questa integrazione non sia sempre fluida e intuitiva, <strong>la</strong> piattaforma contiene<br />
strumenti diversificati e interessanti.<br />
Un profilo Google+ include elementi base di social networking, come una foto, <strong>la</strong><br />
possibilità di inserire una bio, una cover image, esperienze, luoghi visitati e interessi.<br />
È presente un’area per <strong>la</strong> pubblicazione di update e <strong>la</strong> condivisione di contenuti.<br />
Gli “amici” possono essere c<strong>la</strong>ssificati in “cerchie”. Queste non sono altro che liste<br />
che a cui si può negare o garantire l’accesso al<strong>la</strong> visualizzazione di determinati post.<br />
Allo stesso modo, gli utenti possono determinare cosa visualizzare nel proprio news<br />
feed selezionando una o più specifiche cerchie.<br />
Lo stream di notizie del<strong>la</strong> home è visualizzato su colonne e consente interazioni e<br />
commenti.<br />
Google+ utilizza <strong>la</strong> funzione “+1” per permettere alle persone di raccomandare i<br />
contenuti, simile al “mi piace” di Facebook. Il numero di +1 ottenuto da un<br />
determinato post con link a un sito è corre<strong>la</strong>to a come Google c<strong>la</strong>ssifica i risultati<br />
nelle ricerche su browser: un dettaglio decisamente da non sottovalutare.<br />
A partire dal proprio profilo Google+, sia in versione desktop sia da dispositivo<br />
mobile, è possibile utilizzare Google Hangout, uno strumento gratuito di video<br />
conferenza che consente <strong>la</strong> partecipazione attiva di gruppi fino a 10 persone.<br />
Tra le molte funzioni, Hangogut consente di scambiare documenti, prendere appunti e<br />
condividere gli schermi con altri utenti. Ma non è finita qui: con Hangout è possibile<br />
creare dei “webcasts” delle video conferenze, Google Hangout on Air, che possono<br />
inoltre essere registrate su YouTube per future visualizzazioni. È possibile creare <strong>la</strong><br />
video conferenza dal proprio profilo Google+, ma anche dal proprio account<br />
YouTube. In questo caso, <strong>la</strong> registrazione sarà visualizzata direttamente su questo<br />
canale.<br />
Google+ per i musei<br />
Nonostante Google+ sia sempre più utilizzato come alternativa a Facebook, si tratta<br />
di un social network ancora difficile da comprendere per molte istituzioni.<br />
Tuttavia, ad uno sguardo più approfondito, Google+ offre servizi che possono<br />
costituire delle ottime opportunità per i musei. Invece che tentare di replicare qui<br />
l’esperienza di altre piattaforme, questo canale ha tutto il potenziale per essere<br />
approcciato in modo creativo.
Google Cultural Institute è <strong>la</strong> piattaforma che offre a musei e istituzioni <strong>la</strong><br />
possibilità di rendere accessibili le collezioni. Google Art Project include immagini<br />
ad alta risoluzione di opere e oggetti provenienti dai musei partner dell’iniziativa, che<br />
possono essere consultate come delle vere e proprie “mostre virtuali”. Inoltre, Google<br />
ha attivato un programma per rendere l’interno dei musei accessibile tramite Street<br />
View.<br />
A questo si aggiunge Art Talks, una serie di Google Hangout On Air accessibili dal<strong>la</strong><br />
pagina Google+ di Google Art Project, in cui curatori, educatori e professionisti<br />
museali discutono un partico<strong>la</strong>re movimento artistico, il <strong>la</strong>voro di un artista o altro.<br />
Ma Google Hangout può costituire uno strumento potentissimo anche al di là di questi<br />
“eventi”. Un museo può infatti letteralmente mettersi in contatto con il proprio<br />
pubblico, con altri musei o con esperti in qualsiasi parte del mondo, per generare in<br />
maniera semplice e immediata contenuti e risorse.<br />
Sebbene non specificamente rivolti agli utilizzatori finali, Google Drive e Google<br />
Docs sono una componente molto utile per l’organizzazione e il <strong>la</strong>voro di<br />
comunicazione e produzione di contenuti all’interno di un museo.<br />
Specie quando <strong>la</strong> produzione di contenuti per i social e non solo è affidata a più<br />
persone, Google Drive permette di organizzare documenti e informazioni,<br />
consentendo l’editing e <strong>la</strong> consultazione di documenti da parte di molteplici utenti, <strong>la</strong><br />
creazione di semplici questionari e altri tipi di fogli di <strong>la</strong>voro. Nonostante si tratti di<br />
strumenti che si allontanano dall’aspetto “social”, li inseriamo in questo report in<br />
quanto rappresentano mezzi gratuiti per l’organizzazione del <strong>la</strong>voro connesso ai social<br />
e non solo.<br />
Inspirational<br />
Beyond Bollywood – una mostra digitale a supporto di una mostra fisica<br />
La mostra “Beyond Bollywood”, esposta al National Museum of Natural History fino<br />
ad Aprile 2015, esplora come l’immigrazione indiana abbia influenzato <strong>la</strong> <strong>cultura</strong><br />
americana. Lo Smithsonian Asian Pacific American Center completa l’esposizione<br />
con una mostra digitale che include alcuni dei contenuti presenti in quel<strong>la</strong> fisica,<br />
rendendoli accessibili, insieme ad alcuni pezzi “esclusivi” per <strong>la</strong> versione digitale.<br />
Royal Ontario Museum – Missione ricercatore/professione reporter!<br />
Il museo canadese utilizza Google+ per pubblicizzare eventi e iniziative. Inoltre,<br />
Google Hangout on Air viene usato per creare incontri e appuntamenti digitali, con il
pubblico locale e non. Un esempio? ROM ha messo letteralmente in connessione i<br />
ricercatori “sul campo” con i pubblici in visita. Nel maggio 2014, alcuni ricercatori<br />
sono partiti al<strong>la</strong> volta di Trout River e Woody Point nel<strong>la</strong> regione di Newfound<strong>la</strong>nd<br />
(Canada), per recuperare lo scheletro di una balena lunga circa 23 metri. L’animale,<br />
parte di una specie a rischio di estinzione, è morto insieme ad altri otto e i campioni<br />
recuperati da questa spedizione serviranno al museo per approfondirne e diffonderne<br />
<strong>la</strong> conoscenza, anche in termini di salvaguardia. Il ROM ha potuto informare i<br />
visitatori sui dettagli di questa spedizione proprio grazie a un Google Hangout On Air<br />
con i ricercatori inviati sul posto.<br />
#Drinkingaboutmuseums – Google+ e <strong>la</strong> community museale<br />
Drinking about museums è una serie di incontri informali tra professionisti del<br />
mondo dei musei che, trovandosi nel<strong>la</strong> stessa città per conferenze o per <strong>la</strong>voro,<br />
decidono di incontrarsi per socializzare, fare networking e discutere progetti di<br />
interesse comune. Iniziata qualche anno fa da un gruppo di professionisti a seguito<br />
del<strong>la</strong> conferenza Museums and the Web, #drinkingaboutmuseums ha luogo ormai in<br />
tutto il mondo. Grazie a un hashtag che i partecipanti usano per informarsi sulle<br />
location, professionisti da tutto il mondo si incontrano per bere qualcosa insieme e<br />
fare community. Sebbene l’iniziativa si al<strong>la</strong>rghi nel mondo digitale su molti altri<br />
canali, Google+ è diventato <strong>la</strong> “board” ufficiale per informare in quali città hanno<br />
luogo gli appuntamenti.<br />
Art talks per l’educazione: una conversazione tra musei<br />
Quando si par<strong>la</strong> di pubblico si pensa sempre solo ai visitatori che varcano le soglie dei<br />
musei. Ma i pubblici, in realtà, possono anche essere gli stakeholder: in questo caso,<br />
gli insegnanti. Come trovare le giuste risorse – immagini ad alta risoluzione, testi,<br />
consigli – per incorporare l’arte nell’insegnamento in c<strong>la</strong>sse? Una task force di grandi<br />
musei, come Art Institute of Chicago, Metropolitan Museum of Art, Museum of<br />
Modern Art e National Gallery of Art, si incontrano tramite Google Art Talk per<br />
fornire agli insegnanti consigli su risorse gratuite per educatori del<strong>la</strong> fascia K-12<br />
(educazione primaria e secondaria nel sistema americano). Questo Talk è un esempio<br />
niente male di quello che lo strumento può fare e aiuta a pensare a questo social<br />
network come strumento di comunicazione per far arrivare i messaggi a una<br />
specifiche categoria.<br />
Tripadvisor e Foursquare
Cosa sono<br />
Nel<strong>la</strong> pagina dedicata alle informazioni sul portale stesso, fondato nel 2000 ed ora<br />
facente parte del gruppo Expedia Inc. Family Travel Company, Tripadvisor è<br />
definito “il sito di viaggi più grande del mondo, nato per aiutare i viaggiatori a<br />
pianificare <strong>la</strong> vacanza perfetta”.<br />
Nonostante siano state frequentemente sollevati dubbi e polemiche sul<strong>la</strong> veridicità<br />
delle informazioni in essa contenute 17 , <strong>la</strong> piattaforma è stata raggiunta da oltre 260<br />
milioni di visitatori unici ogni mese nel 2013 (Google Analytics, dati mondiali,<br />
luglio 2013) e contiene oltre 150 milioni di recensioni e opinioni re<strong>la</strong>tive a più di 3.7<br />
milioni di strutture, ristoranti e attrazioni (fonte Statista.com).<br />
Creato a partire dal 2008 da Dennis Crowley e Naveen Selvadurai, Foursquare è<br />
invece un servizio basato sul<strong>la</strong> geolocalizzazione dedicato a dispositivi mobili o dotati<br />
di GPS che permette agli utenti registrati di condividere <strong>la</strong> propria posizione con i<br />
propri contatti. L’applicazione è, infatti, per definizione, dedicata a “esploratori che<br />
vogliono conoscere i luoghi migliori e condividere ciò che hanno scoperto con gli<br />
altri”.<br />
I dati ufficiali tracciano il profilo di una community costituita da oltre 50 milioni di<br />
persone in tutto il mondo che hanno eseguito oltre 6 miliardi di check-in; il numero<br />
dei check-in vede un aumento quotidiano quantificabile addirittura in milioni (fonte<br />
Wired.com).<br />
Come funziona Foursquare<br />
Foursquare funziona come un vero e proprio motore di ricerca geolocalizzato e<br />
offre <strong>la</strong> possibilità di individuare specifiche tipologie di edifici o luoghi di<br />
intrattenimento situati nelle circostanze (vedi Aboutfoursquare.com).<br />
L’attività principale è quel<strong>la</strong> di effettuare i check-in, cioè segna<strong>la</strong>re <strong>la</strong> propria<br />
presenza in un dato luogo, con diverse finalità:<br />
- comunicare il luogo in cui ci si trova, per attività di self branding o<br />
più semplicemente per scoprire in tempo reale chi sia nelle vicinanze<br />
(dato visualizzabile nel<strong>la</strong> sezione “Nei dintorni”) o cosa stiano facendo i<br />
propri contatti in altre città (sezione “In tutto il mondo”);
- <strong>la</strong>sciare commenti e giudizi sugli esercizi e i luoghi conosciuti,<br />
consigliandone o meno <strong>la</strong> visita;<br />
- consultare i commenti di altri utenti per farsi un’idea sui luoghi<br />
interessanti nei quali recarsi;<br />
- accedere agli special, cioè a partico<strong>la</strong>ri sconti, promozioni o premi<br />
che le aziende dedicano agli utenti per incentivare le visite (<strong>la</strong> funzione<br />
non è ancora molto diffusa in Italia);<br />
- sbloccare i badge, ovvero piccoli riconoscimenti che si ottengono in<br />
base alle proprie abitudini nel fare i check-in, ad esempio frequentare le<br />
sale da cinema, i ristoranti, i locali per karaoke (vedi<br />
Foursquarebadges.it). Alcuni badges sono sviluppati in col<strong>la</strong>borazione<br />
con partner commerciali, altri si riferiscono ad eventi importanti come<br />
le elezioni americane o il Tour de France, altri ancora sono stati<br />
realizzati in col<strong>la</strong>borazione con amministrazioni locali hanno scelto di<br />
dedicarne alle proprie città come Mi<strong>la</strong>no, Bologna, Parigi, Istanbul,<br />
Boston solo per citarne alcune (vedi It.foursquare.com/4sqcities);<br />
- diventare mayor, ovvero aggiudicarsi il titolo di maggior<br />
frequentatore di una località;<br />
- organizzare i propri desiderata nel<strong>la</strong> sezione “Cose da fare” e<br />
compi<strong>la</strong>re liste di luoghi: per esempio si può redigere l’elenco di punti<br />
di interesse che si desidera visitare nel corso di un viaggio o quello di<br />
località già note; le liste possono essere visualizzate e salvate anche da<br />
terzi che intendano utilizzarle.<br />
Come si effettua il check-in<br />
Per effettuare il check-in è necessario accedere al<strong>la</strong> applicazione, disponibile su<br />
smartphone e tablet, e cliccare sul pulsante azzurro che indica il segnaposto sul<strong>la</strong><br />
mappa: immediatamente il sistema fornirà <strong>la</strong> lista dei luoghi nelle vicinanze<br />
specificandone <strong>la</strong> tipologia, l’indirizzo, <strong>la</strong> distanza e se eventualmente in quel dato<br />
momento uno dei contatti si trovi nello stesso posto. Basterà poi selezionare il luogo
prescelto ed eseguire il check-in, che può essere accompagnato anche da uno status,<br />
una foto o il tag di amici presenti e condiviso su Facebook e Twitter. Chi intenda,<br />
invece, tenere per sé <strong>la</strong> propria presenza ed archiviar<strong>la</strong> unicamente nel<strong>la</strong> cronologia<br />
dei luoghi visitati può selezionare l’opzione ‘privato’.<br />
Come si organizzano le liste<br />
Le liste di interesse possono essere organizzate direttamente dal pannello di controllo<br />
di Foursquare su smartphone cliccando sul pulsante “Tutte le liste” e selezionando in<br />
successione il tasto +. Così facendo sarà possibile indicare il nome prescelto per <strong>la</strong><br />
nuova lista e da quel momento aggiungere i luoghi preferiti, accedendo al<strong>la</strong> scheda<br />
informativa di ciascuno di essi e cliccando sul pulsante “Salva questo posto su una<br />
lista”.<br />
L’elenco può essere ricondiviso su Facebook e Twitter e aperto agli aggiornamenti dei<br />
propri contatti. La piattaforma offre inoltre, come detto, l’occasione di seguire liste<br />
tematiche prodotte da amici o brand (fonte Foursquareitalia.org).<br />
I social di geolocalizzazione per i musei<br />
Quali sono i principali motivi per cui un museo dovrebbe utilizzare Foursquare?<br />
1. Per attirare nuovi visitatori.<br />
Per utilizzare al massimo Foursquare è anzitutto necessario diventare<br />
amministratore per conto del museo, in modo da poter gestire<br />
direttamente le operazioni dal pannello di controllo (vedi<br />
Support.foursquare.com).<br />
In seguito sarà possibile organizzare più attività dedicate agli utenti:<br />
- fornire offerte ai visitatori che effettuano il check-in;<br />
- aggiungere informazioni interessanti e suggerimenti sulle<br />
attività del museo, sul<strong>la</strong> presenza di bookshop e caffetteria e<br />
indicazioni su orari di apertura e mostre in corso;<br />
- monitorare i commenti delle persone che compiono il check-in<br />
e inserirli tra i propri contatti;<br />
- individuare altri luoghi di interesse nelle immediate vicinanze
del museo e aggiungere consigli e suggerimenti su di essi. Si<br />
possono, ad esempio, fornire indicazioni su edifici storici del<br />
circondario oppure su esercizi commerciali con i quali si è<br />
sig<strong>la</strong>ta una partnership (“Prima di visitare il museo fate<br />
co<strong>la</strong>zione in questo bar: il cappuccino è ottimo!”).<br />
2. Per fidelizzare i visitatori e premiare i più assidui tra essi.<br />
Un museo o una galleria possono sfruttare Foursquare per coinvolgere i<br />
visitatori attraverso gli “specials”, sconti e premi da offrire agli utenti<br />
più fedeli che ripetono più volte il check-in.<br />
Alcune idee:<br />
- Mayor: premio dedicato al visitatore più fedele, sbloccato<br />
automaticamente da Foursquare che calco<strong>la</strong> per ciascun utente il<br />
numero di presenze in un dato luogo;<br />
- Numero totale dei check-in: omaggio per il visitatore che<br />
esegue il check-in in museo per un certo numero di volte<br />
(“Foursquare dice che sei stato qui 10 volte? Ecco un biglietto<br />
d’ingresso gratuito per te!”);<br />
- Basato sul<strong>la</strong> frequenza delle visite: lo special viene sbloccato,<br />
ad esempio, ogni 5 check-in.<br />
(“Agli utenti di Foursquare è riservato il 20% di sconto sugli<br />
acquisti al bookshop ogni 5 check-in!”)<br />
- Wildcard special: sempre valido, ma il personale verificherà le<br />
condizioni previste direttamente sullo smartphone prima di<br />
attivare <strong>la</strong> promozione (“Mostraci il tuo Swarm badge e potrai<br />
ottenere un drink presso <strong>la</strong> caffetteria del museo o un catalogo<br />
gratuito”).<br />
3. Per aumentare <strong>la</strong> propria presenza nel<strong>la</strong> comunità <strong>online</strong>.<br />
Al di là dell’utilizzo in senso stretto nel<strong>la</strong> sede museale, Foursquare offre<br />
ulteriori opportunità di coinvolgere gli utenti, ad esempio<br />
concentrandosi sul<strong>la</strong> storia del quartiere in cui il museo si trova.<br />
Accanto ai tips sul<strong>la</strong> qualità del servizio degli esercizi commerciali, è<br />
infatti possibile pianificare una serie di commenti che aiutino ad<br />
approfondire e meglio comprendere il significato storico di un luogo e
che, col tempo, si accumuleranno in diversi strati.<br />
Per un visitatore può essere interessante recuperare informazioni che<br />
riguardino un pa<strong>la</strong>zzo sede del<strong>la</strong> Camera di Commercio che, ad<br />
esempio, potrebbe essere stato nel secolo precedente sede del<strong>la</strong> Borsa<br />
del<strong>la</strong> città e prima ancora, in età romana, un tempio dedicato ad un<br />
imperatore romano: queste indicazioni sono utili non solo per<br />
contestualizzare le fasi di vita di un luogo ma anche per evidenziare <strong>la</strong><br />
natura mutevole delle comunità in cui viviamo.<br />
Inspirational<br />
National Museum of Women in the Arts<br />
Sebbene questo museo incorpori valori e ideali universali, che gli permettono di<br />
raggiungere una audience globale attraverso i social, Foursquare è molto utile per<br />
creare engagement con il pubblico locale che visita il museo. L’istituzione, infatti,<br />
rega<strong>la</strong> sconti esclusivi a tutti coloro che fanno Check-in.<br />
LinkedIn<br />
Cos’è<br />
LinkedIn è una piattaforma social con focus sulle re<strong>la</strong>zioni professionali,<br />
l’esperienza <strong>la</strong>vorativa e il networking.<br />
Fondato nel 2002 e <strong>la</strong>nciato nel dicembre 2003, è oggi disponibile in 20 lingue. Nel<br />
2013, LinkedIn riportava <strong>la</strong> presenza di circa 259 milioni di membri in oltre 200<br />
paesi. Tra i maggiori utilizzatori, ci sono gli Stati Uniti e l’India, mentre l’Italia è<br />
all’ottavo posto con 6 milioni di utenti (Fonti: En.wikipedia.org e Mashable.com).<br />
Come funziona<br />
LinkedIn consente <strong>la</strong> creazione di profili personali, gruppi e profili aziendali.<br />
Diverse tipologie di azioni sono possibili sul<strong>la</strong> piattaforma: <strong>la</strong> più interessante è<br />
certamente <strong>la</strong> possibilità di postare offerte di <strong>la</strong>voro e comunicarle attraverso <strong>la</strong> rete.<br />
Tutte le funzioni base di LinkedIn sono gratuite, tuttavia esiste anche una versione a
pagamento che permette di sbloccarne alcune: ad esempio, è possibile sapere chi ha<br />
visitato il nostro profilo.<br />
È interessante come LinkedIn riporti che il 60% degli iscritti dichiari non essere<br />
attivamente in cerca di una nuova posizione <strong>la</strong>vorativa, ma che potrebbero essere<br />
interessati se un’opportunità si verificasse.<br />
LinkedIn consente inoltre di inviare e ricevere messaggi privati, tuttavia, non è<br />
possibile farlo se l’utente che volete contattare non è nel<strong>la</strong> vostra rete (a meno che non<br />
abbiate un account Pro).<br />
È importante ricordare che LinkedIn è una piattaforma professionale, non si tratta<br />
di una semplice “versione seria” di Facebook. Post, profile picture e tono non<br />
dovrebbero essere frivoli o destinati a un’utenza più “light” che su questo canale non<br />
troverebbe spazio.<br />
Aziende e recruiter navigano su questo social al<strong>la</strong> ricerca di profili professionali<br />
interessanti. Aprire un account personale su LinkedIn ha quindi senso se si vuole<br />
essere riconosciuti come professionisti in un determinato settore. Le regole di buon<br />
senso si applicano quindi di conseguenza.<br />
È importante darsi un profilo riconoscibile ed evitare <strong>la</strong> dispersione dei concetti che<br />
rendono <strong>la</strong> nostra esperienza <strong>la</strong>vorativa e accademica specifica. Il live feed di<br />
LinkedIn sarà quindi utilizzabile per condividere notizie o commenti in re<strong>la</strong>zione al<br />
proprio campo professionale.<br />
Infine, i gruppi consentono agli utenti di postare notizie o articoli, mentre i profili<br />
aziendali sono in genere chiusi, consentendo agli utenti di interagire solo nei<br />
commenti a un post.<br />
LinkedIn per i musei<br />
I musei su LinkedIn vengono categorizzati come aziende. Tuttavia, anche se un<br />
museo non dovesse avere posizioni aperte in maniera frequente, decidere di aprire un<br />
account su LinkedIn può essere funzionale a creare re<strong>la</strong>zioni di networking con<br />
altri professionisti del settore.<br />
L’uso prettamente professionale di questo canale lo rende però poco appetibile per<br />
coloro che vogliono postare contenuti re<strong>la</strong>tivi al<strong>la</strong> collezione o agli eventi del museo.<br />
Tuttavia, utilizzi interessanti e “creativi” sono possibili: si pensi per esempio a un<br />
museo di arte contemporanea che voglia reclutare artisti o a un museo scientifico<br />
che voglia contattare insegnanti potenzialmente interessati ad alcune attività.<br />
Il margine di LinkedIn è molto più specifico, ma questo non toglie che un museo<br />
possa utilizzare alcune funzioni – i gruppi in partico<strong>la</strong>re – per prendere contatti con i
suoi stakeholder.<br />
Inspirational<br />
Hack your Hello at AAM<br />
Nina Simon ha aperto un gruppo su LinkedIn così che i partecipanti al<strong>la</strong> conferenza<br />
nazionale dell’American Alliance of Museums potessero incontrarsi a partire da<br />
interessi comuni o domande. Sono tantissimi i professionisti che partecipano<br />
all’evento ogni anno e <strong>la</strong> conferenza non ha un focus unico. Dall’archivio al<strong>la</strong><br />
conservazione, dal digitale al<strong>la</strong> curate<strong>la</strong>, tutto il mondo museale – prevalentemente<br />
americano – si ritrova in questo evento. In questo senso, <strong>la</strong> mediazione che lo<br />
strumento digitale pone permette di “sciogliere il gelo” del networking in persona e<br />
garantisce agli utenti di individuare professionisti con cui condividono maggiormente<br />
gli interessi.<br />
Museums and the Web<br />
Museum Computer Network<br />
Sono diverse le associazioni che utilizzano i gruppi di LinkedIn come piattaforma per<br />
scambiare idee, commenti e notizie. Partico<strong>la</strong>rmente interessanti quelle di Museums<br />
and the Web e Museum Computer Network. Oltre che fonte di notizie, i gruppi<br />
permettono di individuare i professionisti museali nel settore del digitale.<br />
iTunesU<br />
Cos’è<br />
iTunesU è una piattaforma Apple gratuita che permette a differenti tipologie di<br />
istituzioni educative di diffondere i loro contenuti in diversi formati e di creare veri e<br />
propri corsi.<br />
Università, musei, biblioteche, stazioni radio e televisive possono rendere accessibili<br />
risorse che non trovano altri canali adatti per essere rese pubbliche.<br />
La piattaforma funziona esattamente come iTunes, il sistema di distribuzione<br />
musicale di Apple. Invece di fornire album e canzoni, tuttavia, iTunesU raduna corsi,<br />
video lectures, talk e documenti in un unico spazio.
L’applicazione può essere scaricata gratuitamente per tablet o smartphone, ma<br />
funziona anche in versione desktop, essendo parte integrante del programma iTunes.<br />
Ciononostante, si tratta di una piattaforma prettamente mobile, in quanto <strong>la</strong><br />
maggioranza degli user tende ad accedere ai contenuti da tablet.<br />
Lanciata nel 2007, nel 2013 ha raggiunto un bilione di download (fonte Apple.com).<br />
Il “pezzo forte” di iTunesU è costituito dalle università e scuole che lo utilizzano<br />
principalmente per <strong>la</strong> pubblicazione di corsi – veri e propri ebook interattivi che<br />
permettono di creare lezioni suddivise in sezioni. Tuttavia, il canale ha anche uno<br />
spazio dedicato agli enti no-profit. Per consultare <strong>la</strong> lista, basta aprire iTunes, entrare<br />
nello Store, selezionare iTunesU e accedere al<strong>la</strong> sezione “Oltre il campus” (vedi<br />
Macworld.com).<br />
Come funziona<br />
Come dicevamo, iTunesU è integrato nell’iTunes Store e ne replica alcune<br />
dinamiche (vedi Apple.com/itunes e Apple.com/itunes/podcasts). Infatti, nel<strong>la</strong><br />
piattaforma educational i singoli contenuti (items) sono organizzati in collezioni, così<br />
come in quel<strong>la</strong> musicale le canzoni sono organizzate in album. In questo senso, l’ente<br />
che crea e diffonde le collezioni – come un’Università – può essere paragonata al<strong>la</strong><br />
casa discografica.<br />
La home page di un canale mostra le collezioni disponibili per lo specifico ente<br />
educativo, permettendo di filtrarle per argomento, tema o usando le tag che<br />
l’istituzione ha riportato nel caricare le risorse sul canale. Sul<strong>la</strong> home page è possibile<br />
inoltre vedere quali sono le collezioni o gli items più popo<strong>la</strong>ri e selezionare soltanto i<br />
corsi, qualora l’utente fosse al<strong>la</strong> ricerca di questo specifico tipo di contenuto.
L’istituzione può organizzare le varie collezioni sotto ulteriori ombrelli tematici. Gli<br />
items presenti nelle collezioni possono essere video, audio o contenuti testuali, come<br />
i pdf. I corsi, invece, hanno una struttura a sé stante che integra audio, video e testi in<br />
un unico supporto.<br />
L’utente può scegliere se visualizzare un item in streaming (direttamente dal canale),<br />
scaricarlo individualmente, o iscriversi al<strong>la</strong> collezione. In questo modo, ogni volta che<br />
nuovi items vengono aggiunti, l’utente li troverà automaticamente scaricabili nel<strong>la</strong> sua<br />
libreria.<br />
Il partico<strong>la</strong>re tipo di organizzazione che il canale impone, non privo di limitazioni<br />
considerando che impiega gli stessi criteri del corrispettivo musicale, richiede<br />
all’istituzione di avere una forte unità visiva in termini di brand così che i contenuti<br />
appartenenti a un determinato ente siano immediatamente riconoscibili quando<br />
l’utente li cerca.<br />
Per quanto riguarda l’amministrazione dei contenuti, iTunesU fornisce un’interessante<br />
dashboard che consente di osservare quali sono le collezioni e i corsi maggiormente<br />
scaricati, nonché dati demografici degli user e indicazione degli strumenti da cui<br />
accedono (tablet, smartphone, desktop). In questo senso, è possibile tenere sotto<br />
controllo tutta una serie di criteri che informino <strong>la</strong> strategia di utilizzo di<br />
quest’interessante piattaforma.<br />
iTunesU per i musei<br />
“Oltre il campus” fornisce uno spazio specifico perché le no-profit possano diffondere<br />
i propri contenuti educativi. La definizione che si può applicare a “materiali<br />
educativi” è molto ampia e sotto questo ombrello cadono gran parte delle risorse che<br />
un museo crea e conserva. Da registrazioni di talk durante conferenze a video con<br />
curatori ed esperti riversati da altre piattaforme – per esempio chioschi interattivi<br />
presenti in mostra –, a corsi e lezioni frontali creati ad hoc.<br />
Molti musei e istituzioni <strong>cultura</strong>li utilizzano YouTube riversando sul<strong>la</strong> piattaforma i<br />
loro contenuti video. Tuttavia, iTunesU offre un canale molto più mirato per quei<br />
contenuti che sono prettamente “educational” e il cui formato o stile non si adatta al<strong>la</strong><br />
voce, più dinamica e flessibile, richiesta agli utenti YouTube.<br />
A questa funzione iTunesU aggiunge <strong>la</strong> possibilità di diffusione di testi e contenuti<br />
audio che possono anche essere “specialistici”. In questo senso, il canale viene<br />
utilizzato per <strong>la</strong> ricerca di risorse con motivazioni differenti da quelle che<br />
determinano <strong>la</strong> ricerca su YouTube o altre piattaforme. iTunesU offre quindi alle
istituzioni uno spazio adeguato per rendere disponibili contenuti anche più difficili<br />
e accademici.<br />
In ogni caso, un museo dovrebbe affrontare <strong>la</strong> scelta dei contenuti sul<strong>la</strong> base delle<br />
preferenze dei propri utenti e procedendo per esperimenti insieme a loro.<br />
Sebbene in questo report abbiamo deciso di analizzare solo questa piattaforma,<br />
ricordiamo che sono tantissimi i musei che utilizzano iTunes e SoundCloud per<br />
diffondere i loro contenuti audio – spesso riversando contenuti creati per le più<br />
“tradizionali” audio guide. Tra questi, troviamo ad esempio il MoMA, che offre una<br />
serie di podcast includendo descrizioni audio delle opere presenti all’interno delle<br />
mostre, descrizioni verbali per non vedenti e “MoMA Audio: Kids”, che contiene<br />
descrizioni in un formato più accessibile per i più piccoli. Un esperimento<br />
partico<strong>la</strong>rmente interessante, in questo senso, è costituito da MoMA “Unadultered”,<br />
una serie di podcasts non ufficiali creati da bambini tra i 3 e i 10 anni.<br />
Inspirational<br />
Smithsonian Hirshorn Museum and Sculpture Garden<br />
Lo Smithsonian Hishhorn divide i propri contenuti sul canale iTunesU per tipologia<br />
(Talks, Magazines, Exhibits, Brochures, ArtLab+, Themes). Grazie al<strong>la</strong> forte<br />
riconoscibilità e al<strong>la</strong> semplicità del design applicato al canale, le collezioni sono<br />
visivamente coinvolgenti e agevo<strong>la</strong>no <strong>la</strong> ricerca da parte degli utenti. La home del<br />
canale include inoltre singoli items e sceglie di farli comparire sotto ombrelli tematici<br />
chiari.<br />
Brooklyn Museum sceglie di chiudere il proprio account iTunesU<br />
Inseriamo questo caso perché fa riflettere su come un canale come iTunesU possa non<br />
essere adatto a una determinata istituzione. I motivi sono spesso legati al<strong>la</strong> necessità<br />
di bi<strong>la</strong>nciare i costi e i benefici di una piattaforma. Nel caso del Brooklyn Museum, il<br />
canale rappresentava uno strumento macchinoso e, nonostante gli sforzi, l’istituzione<br />
non è mai riuscita a ottenere risultati significativi. iTunesU non è uno strumento<br />
semplice e vale <strong>la</strong> pena investigare il suo potenziale solo se pensiamo che possa<br />
veramente esserci utile a raggiungere determinate fasce di pubblico.<br />
Smithsonian Libraries<br />
Le Smithsonian Libraries creano appositamente corsi per questa piattaforma. Questa<br />
scelta è molto interessante in quanto il target principale di quest’organizzazione
“behind the scenes”, che non ha una collezione esposta al pubblico, è composto da<br />
ricercatori e studiosi. In questo senso, lo strumento “Corsi” offerto da iTunesU<br />
permette all’istituzione di riflettere sui propri contenuti e presentarli in un formato<br />
accessibile, aprendoli così a nuove e non tradizionali audience.<br />
Hardvard Thinks Big<br />
La rinomata istituzione mette insieme una serie di episodi volti a presentare le<br />
“grandi idee” esposte da alcuni membri del<strong>la</strong> facoltà. Quest’iniziativa è di interesse in<br />
quanto mostra come anche un museo possa fare leva sui suoi esperti per<br />
“impacchettare” contenuti appositamente creati per questa piattaforma. In questo<br />
caso, non solo il titolo e il format rendono chiare le intenzioni dell’Università, ma il<br />
successo del<strong>la</strong> collezione dimostra come il popolo digitale – e non solo gli studenti<br />
del<strong>la</strong> facoltà – abbia sete di conoscenza e significati.
5. Obiettivi e risultati: l’utilizzo degli analytics per misurare le<br />
performance <strong>online</strong><br />
Pietro Colel<strong>la</strong><br />
Cos’è l’analisi dei dati<br />
L’analisi dei dati è un processo che consiste nel<strong>la</strong> racconta, e<strong>la</strong>borazione e<br />
rappresentazione dei dati al fine di supportare una serie di decisioni strategiche. Tale<br />
definizione, seppure semplicistica, comprende un vasto mondo composto di processi<br />
e persone.<br />
Per processi si intendono tutte le routine e le operazioni che devono essere svolte per<br />
raccogliere i dati, e<strong>la</strong>borarli in maniera più o meno stutturata e rappresentarli. Le<br />
persone, invece, sono tutti i soggetti che prendono parte ai processi appena descritti,<br />
nonché altri individui indirettamente coinvolti: spesso chi fa l’analisi dei dati non è<br />
chi realmente prende le decisioni.<br />
L’analisi dei dati si compone di diverse fasi, anche se non è possibile individuare una<br />
sca<strong>la</strong> gerarchica di importanza: tutte hanno lo stesso peso e seguono una precisa<br />
sequenza. Ovvero, se <strong>la</strong> raccolta dei dati viene fatta in maniera superficiale ne<br />
risentiranno l’e<strong>la</strong>borazione e soprattutto <strong>la</strong> rappresentazione finale, che risulterà<br />
inconsistente e priva di spunti pratici. Al contrario, se a fronte di una raccolta di un<br />
elevato numero di dati seguono una scarsa e<strong>la</strong>borazione e una pessima<br />
rappresentazione, verranno vanificati gli sforzi del<strong>la</strong> fase iniziale facendo risultare il<br />
<strong>la</strong>voro poco rappresentativo del<strong>la</strong> realtà.<br />
Esiste però una fase che, nel parere di chi scrive, è sicuramente <strong>la</strong> più importante di<br />
tutte: <strong>la</strong> definizione degli obiettivi.<br />
Spesso, questa viene trattata in maniera superficiale, con <strong>la</strong> conseguente nascita di<br />
problemi nel corso dell’analisi. Per il momento, è sufficiente precisare che gli<br />
obiettivi dell’analisi devono essere reali e raggiungibili, chiari e comprensibili a chi<br />
esegue l’intero processo.
1. La raccolta<br />
La prima parte del processo di analisi dei dati è <strong>la</strong> raccolta. Nello specifico, questa<br />
fase comprende tutte quelle operazioni che hanno lo scopo di ottenere il maggior<br />
numero possibile di informazioni.<br />
In rete, non è sempre semplice avere a disposizione tutti i dati dei quali si ha<br />
necessità. Ad esempio, è sicuramente possibile ricavare molti dati sui visitatori del<br />
proprio sito web, mentre, al contrario, è molto più faticoso ottenere informazioni<br />
dalle piattaforme che non sono di proprietà, come i social network. O ancora, a volte<br />
è impossibile raccogliere informazioni da media non di proprietà e non gestiti<br />
dall’utente, come i siti web di terzi.<br />
Esistono però due strade che si possono seguire: <strong>la</strong> prima sono le API, acronimo di<br />
Application Programming Interface, che si possono utilizzare per potersi interfacciare<br />
con i social network e ottenere delle informazioni destrutturate, ovvero tanti dati da<br />
aggregare ed e<strong>la</strong>borare successivamente. La seconda strada sono le piattaforme,<br />
gratuite o a pagamento, che integrano diversi servizi di analisi dei dati e che<br />
restituiscono valori di sintesi aggregati. Rispetto all’utilizzo delle API, i portali appena<br />
descritti riescono a fornire dati difficilmente individuabili sul<strong>la</strong> rete che vengono<br />
rappresentati a livello aggregato, quindi già e<strong>la</strong>borati.<br />
In pratica, sul<strong>la</strong> rete si possono trovare tre grandi gruppi di dati disponibili; in estrema<br />
sintesi, possiamo ottenere:<br />
– dati grazzi, e<strong>la</strong>borabili e interpretabili;<br />
– dati e<strong>la</strong>borati, che in alcuni casi sono ri-e<strong>la</strong>borabili e sicuramente<br />
interpretabili;<br />
– informazioni interpretate, che sono già presentabili e sul<strong>la</strong> base delle<br />
quali è possibile prendere direttamente delle decisioni.<br />
2. L’e<strong>la</strong>borazione<br />
La seconda fase del processo di analisi dei dati è l’e<strong>la</strong>borazione, cioè tutte quelle<br />
operazioni attraverso le quali i dati vengono aggregati e analizzati per poter dare<br />
una risposta precisa agli obiettivi del<strong>la</strong> ricerca.<br />
Grazie al<strong>la</strong> rete, sono sempre meno le energie che si utilizzano in questa fase. Gli<br />
addetti ai <strong>la</strong>vori stanno lentamente riducendo l’utilizzo di Excel o altri software di<br />
calcolo, come SPSS, per potere <strong>la</strong>vorare sui dati.<br />
Da un <strong>la</strong>to, si tratta di una situazione positiva perché <strong>la</strong>scia <strong>la</strong> possibilità di
concentrare maggiori energie nelle operazioni precedenti o successive, dall’altro, però,<br />
il minore tempo necessario per l’e<strong>la</strong>borazione è dovuto al fatto che i dati si trovano<br />
sempre più in forma aggregata, quindi non grezzi, e hanno già subito una certa<br />
e<strong>la</strong>borazione che può influenzare <strong>la</strong> decisione finale. Per spiegare meglio questa<br />
affermazione, pensiamo al<strong>la</strong> dashboard di Google Analytics che mostra il grafico delle<br />
visite giornaliere di un sito web. Per ottenere questa visuale è stato già realizzato, da<br />
Google, un processo di raccolta dei dati, di aggregazione e successivamente di<br />
presentazione in un grafico a linee per una più immediata interpretazione da parte<br />
dell’utente finale. Niente però vieta di e<strong>la</strong>borare nuovamente quel dato per ottenere<br />
altre informazioni.<br />
Spesso, quando si <strong>la</strong>vora <strong>online</strong>, <strong>la</strong> fase di e<strong>la</strong>borazione è molto ridotta: difficilmente<br />
l’utente si trova a <strong>la</strong>vorare con i dati grezzi (i report in CSV di Facebook ne sono un<br />
esempio) e sempre più ha a disposizione un’informazione già presentata<br />
graficamente (ad esempio, gli Insights di Facebook).<br />
3. La presentazione<br />
Il punto di arrivo del processo di analisi è <strong>la</strong> presentazione dei dati. In questa fase si<br />
includono tutte quelle operazioni che hanno l’obiettivo di presentare graficamente i<br />
risultati dell’analisi e di fornire una serie di spunti qualitativi per poter dare il via ad<br />
un momento di riflessione e di discussione sulle possibili cause e conseguenze di un<br />
certo valore di una certa variabile, o insieme di variabili, e al<strong>la</strong> definizione di una<br />
linea strategica e di azione.<br />
Se gli obiettivi sono stati specificati in maniera corretta, spesso <strong>la</strong> presentazione<br />
contiene già le principali informazioni sulle cause e sulle conseguenze di un certo<br />
aspetto.<br />
Rappresentare i dati può sembrare semplice, ma bisogna sempre tener presente chi è<br />
il destinatario finale del <strong>la</strong>voro. La mancata comprensione di un grafico nasce dal<br />
fatto che chi lo sta leggendo non ha le necessarie competenze, conoscenze e capacità<br />
per farlo. Chi <strong>la</strong>vora sui dati ormai è assuefatto alle informazioni e dà per scontato<br />
molti fatti e concetti che il pubblico dell’analisi non conosce o non riesce a capire<br />
perché non ha una visione su tutti i dati analizzati.<br />
È compito del presentatore studiare e realizzare un percorso di visualizzazione dei<br />
dati che sia chiaro ed esplicativo del <strong>la</strong>voro, che segua un percorso simile al seguente:<br />
– Processo di raccolta, e<strong>la</strong>borazione e presentazione<br />
– Principali dati utilizzati
– Livello di raggiungimento degli obiettivi di ricerca<br />
– Analisi delle cause<br />
– Analisi delle conseguenze<br />
Le persone<br />
Le persone coinvolte nel processo di analisi sono sostanzialmente di due tipi:<br />
– Chi commissiona l’analisi<br />
– Chi esegue e presenta l’analisi<br />
A volte questi soggetti coincidono, ma possono anche essere differenti. Nel caso in<br />
cui non si tratti del<strong>la</strong> stessa persona, si devono ben tenere in considerazione le diverse<br />
competenze, conoscenze e capacità che questi soggetti hanno.<br />
Chi formu<strong>la</strong> gli obiettivi non conosce il percorso che l’analista deve seguire, quindi<br />
deve non solo essere ben attento a spiegare in maniera corretta e comprensibile quello<br />
che vuole ottenere, ma deve anche assicurarsi che gli obiettivi siano stati ben recepiti.<br />
Dall’altra parte, chi svolge l’analisi deve fare attenzione ad interpretare<br />
correttamente i goal di ricerca senza concentrarsi, prima del previsto, sulle operazioni<br />
da svolgere.<br />
Entrambi gli interlocutori devono cercare di comprendere i differenti codici di<br />
comunicazione utilizzati e valorizzare le proprie capacità di ascolto e interpretazione<br />
delle necessità altrui. In questa fase, assume molta importanza <strong>la</strong> componente umana<br />
del<strong>la</strong> persona, rispetto a quel<strong>la</strong> meramente tecnica.<br />
Perché effettuare l’analisi dei dati <strong>online</strong><br />
La risposta più semplice è immediata è: per gestire al meglio <strong>la</strong> re<strong>la</strong>zione con il<br />
cliente.<br />
La rete mette a disposizione dei musei molti strumenti con i quali comunicare al<br />
proprio target e questo comporta <strong>la</strong> necessità di gestire, in maniera integrata, tanti<br />
touchpoint, o punti di contatto.<br />
La gestione integrata dei canali web ha inizio con una parte analitica, ovvero l’analisi<br />
dei dati, una parte strategica, con <strong>la</strong> definizione delle strategie di alto livello, una<br />
parte operativa che consiste nel<strong>la</strong> realizzazione pratica delle strategie.
La fase analitica è <strong>la</strong> prima e ha come output una serie di dati e informazioni che<br />
definiscono, più o meno approfonditamente, lo scenario nel quale si opera.<br />
Solitamente, si riesce a capire se qualcuno par<strong>la</strong> in rete di un museo se ci sono altri<br />
canali aperti da fan e appassionati oltre quelli già attivati. Spesso si può individuare<br />
uno specifico target che par<strong>la</strong> di un museo e dedurre quali sono le caratteristiche<br />
demografiche, sociali e comportamentali <strong>online</strong> e offline. Si può infine stimare il<br />
reach, cioè il numero totale di utenti raggiunti, e calco<strong>la</strong>re il livello di interazione tra<br />
i fan e il museo e tra i visitatori stessi.<br />
Ad un livello più profondo, è possibile condurre un’analisi qualitativa, valutando, ad<br />
esempio, il contenuto delle discussioni e i significati sviluppati. Questa fase<br />
presuppone un certo livello di conoscenza del proprio target e delle caratteristiche del<br />
museo in questione.<br />
A questo punto si avranno sicuramente chiari lo scenario nel quale opera il museo,<br />
caratterizzato da opportunità da cogliere e minacce da affrontare, e <strong>la</strong> valutazione del<br />
posizionamento web del museo, caratterizzato da punti di forza e di debolezza. Per<br />
maggiori approfondimenti si può fare riferimento all’Analisi S.W.O.T..<br />
Nel<strong>la</strong> fase strategica, si utilizzano le informazioni e i dati ottenuti per sviluppare<br />
linee strategiche di alto livello.<br />
In questo caso, non esiste un’unica ricetta corretta e precisa, ma si deve tenere conto<br />
di una serie di vincoli (economici, gestionali, strutturali, umani e di tempo) entro i<br />
quali il management ha <strong>la</strong> possibilità di operare. Ai fini di questa trattazione, è<br />
sufficiente precisare che è molto importante che <strong>la</strong> strategia sia coerente con le<br />
caratteristiche del target.<br />
Scopo del<strong>la</strong> fase strategica è anche l’individuazione di obiettivi di breve e<br />
medio/lungo periodo e di KPI (Key Performance Indicators) qualitativi e quantitativi.<br />
La terza fase, quel<strong>la</strong> operativa, identifica tutte operazioni con le quali si realizza <strong>la</strong><br />
strategia in maniera efficace ed efficente. Questa fase è ampiamente trattata<br />
all’interno dell’ebook, che racconta case study e strategie digitali cui i musei che<br />
leggono possono ispirarsi.<br />
Il percorso non è però terminato, in quanto è necessario sviluppare un momento di<br />
verifica sul raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitavi che ci si era<br />
prefissati. In quest’ultima fase, nuovamente analitica, ha senso analizzare ancora i dati<br />
per poter fare tutte le valutazioni del caso.
È ora chiaro a cosa realmente serve l’analisi dei dati. Nel<strong>la</strong> fase iniziale di un<br />
processo strategico è necessario fornire informazioni sullo scenario nel quale si opera<br />
e sui punti di debolezza di un museo. Nel<strong>la</strong> fase finale, l’analisi dei dati permette di<br />
valutare qualitativamente a quantitativamente il raggiungimento degli obiettivi.<br />
Seguirà una fase di analisi dei gap – o punti critici – per ottenere informazioni e<br />
spunti sulle azioni correttive da mettere in atto.<br />
Analisi qualitative e quantitative: un esempio pratico<br />
Fondamentalmente, l’analisi dei dati è caratterizzata da due approcci: uno di tipo<br />
qualitativo e uno quantitativo, dove<br />
Per analisi di tipo qualitativo si intende un processo destrutturato guidato dal<strong>la</strong> libera<br />
intuizione di una persona. L’obiettivo di questo tipo di approccio è realizzare una<br />
macro analisi dei dati a disposizione e, basandosi sull’esperienza e sulle competenze<br />
possedute, sviluppare una serie di ipotesi e di congetture. A queste sarà data conferma
o smentita dalle analisi quantitative, che sono eseguite proprio per poter rappresentare<br />
con numeri e dati un preciso aspetto di uno scenario o di un’ipotesi sviluppata in<br />
precedenza.<br />
Sul<strong>la</strong> rete, questi due approcci si realizzano in parallelo e, a volte, si intrecciano.<br />
Ad esempio, nel momento in cui si vogliono analizzare le performance di una<br />
pagina Facebook, solitamente si procede per prima cosa ad un’analisi macroscopica<br />
per control<strong>la</strong>re il livello di interazione degli utenti sui contenuti pubblicati.<br />
Potrebbe verificarsi che vi sia un calo dell’engagement (con tale termine si intende il<br />
numero di azioni che gli utenti hanno realizzato, come per esempio mettere like,<br />
commentare o condividere) e, in questo caso, il primo passo da seguire è verificare<br />
qualitativamente se vi sono delle possibili cause che si possono approfondire, come<br />
ad esempio l’orario di pubblicazione, <strong>la</strong> tipologia di contenuto, e così via.<br />
Il secondo passaggio è basato sull’esperienza e competenza di chi svolge l’analisi,<br />
nonché sui dati storici che aiutano a formu<strong>la</strong>re delle ipotesi, come “i contenuti di un<br />
certo tipo attirano meno i fan”.<br />
A questo punto, il terzo step è l’analisi nel dettaglio dei singoli post, tramite i<br />
Facebook Insights oppure utilizzando direttamente i dati grezzi che Facebook offre,<br />
per verificare se l’ipotesi formu<strong>la</strong>ta trova fondamento nei dati a disposizione. In caso<br />
di risposta affermativa, il problema è già risolto e si può passare ad una nuova fase<br />
strategica per modificare le proprie azioni e correggere eventuali errori.<br />
È doveroso precisare che per sviluppare un nuovo piano sarà necessario dotarsi di dati<br />
e informazioni che possano fornire una base sul<strong>la</strong> quale prendere le decisioni. Dunque<br />
il processo di analisi dei dati non può considerarsi completo se non si forniscono<br />
informazioni che abbiano un valore strategico, sulle quali basare le decisioni<br />
future.<br />
Seppure in maniera molto sintetica e superficiale, è stata data una panoramica di<br />
come analisi qualitative e quantitative si intreccino tra di loro e siano il col<strong>la</strong>nte del<br />
processo di gestione integrata del<strong>la</strong> re<strong>la</strong>zione con il cliente.<br />
Nel<strong>la</strong> pratica, l’analisi di un singolo social network (come il caso citato in precedenza)<br />
viene spesso accompagnata da un studio più al<strong>la</strong>rgato, che tocca altre piattaforme e<br />
media utilizzati dai musei. Ad esempio, le performance del<strong>la</strong> pagina Facebook hanno<br />
delle conseguenze che si riflettono sul sito web, che di riflesso crea meno traffico<br />
verso l’ecommerce o altri social netowork.<br />
Un buon analista web deve essere in grado di avere una visione a 360° dei mezzi<br />
utilizzati, per riuscire a comprendere appieno in che modo si modifichino i flussi e il<br />
comportamento del proprio target, quando si agisce sulle diverse leve di intervento.<br />
Queste abilità si acquisiscono sia con <strong>la</strong> pratica, sia con un attento studio delle
variazioni dei dati, sia impostando un perfetto sistema di misurazione dei canali.<br />
Come strutturare un processo di analisi<br />
In questa sezione si esamineranno quali sono gli strumenti che <strong>la</strong> rete mette a<br />
disposizione per poter raccogliere e analizzare i dati. Nel<strong>la</strong> prima parte verrà dato<br />
risalto al<strong>la</strong> definizione degli obiettivi di ricerca, per poi approfondire, anche se in<br />
maniera non esaustiva, i mezzi da utilizzare per svolgere il processo di analisi dei dati<br />
sui canali del museo.<br />
La definizione degli obiettivi<br />
Più volte si è ripetuto che <strong>la</strong> fase di definizione degli obiettivi è caratterizzata da una<br />
componente che richiede un alto livello professionale per specificare nel dettaglio gli<br />
indicatori che si vogliono ottenere e quali aspetti è necessario approfondire.<br />
A questa si affianca, però, una componente umana e re<strong>la</strong>zionale che porta i soggetti<br />
coinvolti a cercare di capire più approfonditamente se in realtà gli obiettivi debbano<br />
essere meglio specificati o solo analizzati più a fondo, a causa di un diverso codice di<br />
comunicazione e di background tra le persone coinvolte. Generalmente, questa è una<br />
del<strong>la</strong> fasi più sottovalutate e che crea i maggiori rallentamenti durante l’analisi.<br />
Ad esempio, può avere senso <strong>la</strong> richiesta di stimare il tasso di utenti che interagiscono<br />
con un contenuto, ma ciò non rappresenta una base di partenza per poter studiare<br />
delle nuove strategie, per il semplice fatto che ci sono tanti modi che gli utenti hanno<br />
per interagire.<br />
A volte può avere senso approfondire una certa prospettiva, ma tale richiesta deve<br />
essere esplicitata da chi decide gli obiettivi, altrimenti si rischia di realizzare un<br />
report incompleto e con poco significato.<br />
Per tale motivo si discuteranno, senza nessuna pretesa di esaustività, quali sono le<br />
caratteristiche principali che gli obiettivi devono avere per ottenere un’analisi di<br />
valore.<br />
Raggiungibilità. Spesso ci si trova di fronte a richieste che non possono essere<br />
soddisfatte perché non esistono strumenti che possano fornire i dati. Ad esempio, non<br />
è possibile conoscere le caratteristiche demografiche del target di una pagina<br />
Facebook non proprietaria.<br />
Gli obiettivi devono sempre essere raggiungibili perché l’analisi possa essere realizzata<br />
in modo corretto. La principale causa dell’irraggiungibilità degli obiettivi nasce dal<strong>la</strong>
mancanza di competenze da parte di chi richiede l’analisi.<br />
Chiarezza e precisione. Gli obiettivi devono sottendere al<strong>la</strong> creazione di indicatori<br />
numerici, ad esempio il numero delle visite di un sito e <strong>la</strong> variazione percentuale sul<br />
periodo precedente.<br />
Se l’obiettivo è troppo vago si corre il rischio di non ottenere i risultati attesi. Si crea<br />
un gap tra obiettivi richiesti e output realizzato che può diventare anche molto<br />
grande, al punto da non fornire una base di informazioni sul<strong>la</strong> quale creare delle<br />
strategie. Per tale motivo si tende a strutturare l’achitettura degli obiettivi in 3 livelli:<br />
– Obiettivo generale: formu<strong>la</strong>to in modo ampio, serve per indicare <strong>la</strong><br />
direzione del<strong>la</strong> ricerca;<br />
– Sotto-obiettivi: delimitano l’obiettivo generale e permettono di<br />
definire le linee di ricerca da adottare;<br />
– Obiettivi specifici: indicano il vero punto di arrivo del<strong>la</strong> ricerca,<br />
nonché i risultati e gli indicatori attesi.<br />
Periodo di riferimento. È altresì importante stabilire i tempi del<strong>la</strong> ricerca, cioè gli<br />
intervalli temporali da prendere in considerazione per l’analisi. In questo caso, non<br />
esiste un approccio preciso e definitivo, anche se è bene tenere a mente che intervalli<br />
troppo lunghi generano tante informazioni che devono essere accuratemente<br />
interpretate per individuare un trend.<br />
Ad esempio, se si nota un amento del 300% delle visite ad un sito nell’arco di un anno<br />
è faticoso risalire ad ogni singolo elemento che potrebbe aver influito sul<strong>la</strong> variazione:<br />
una nuova versione del portale, le attività promozionali, le azioni di comunicazione<br />
offline.<br />
Di contro, se il periodo di tempo è troppo breve si rischia di etichettare come trend<br />
delle variazioni dovute a specifici eventi che difficilmente possono ripetersi.<br />
Mutuando dall’esempio precedente, se si realizzano delle attività promozionali, è<br />
normale e fisiologico un aumento delle visite al sito del museo, ciò non può essere<br />
considerato un trend perché, al termine delle campagna, quasi sicuramente le visite<br />
caleranno e si assesteranno su un punto più basso.<br />
Per questi motivi, <strong>la</strong> decisione dell’intervallo temporale da analizzare è scelta in<br />
funzione degli obiettivi. Se si vorrà stimare <strong>la</strong> risposta nel breve periodo degli utenti<br />
alle campagne di comunicazione, l’intervallo sarà breve. Se si vorrà analizzare come il<br />
nuovo <strong>la</strong>yout del sito ha impattato sul<strong>la</strong> navigazione degli utenti, l’intervallo sarà più<br />
lungo.
Rilevanza. Gli obiettivi richiesti devono essere rilevanti, cioè devono realmente<br />
creare una base di informazioni utile per prendere decisioni.<br />
Se, al<strong>la</strong> fine del processo di analisi, non si ottengono dati necessari per <strong>la</strong> decisione,<br />
significa che gli obiettivi richiesti non avevano <strong>la</strong> giusta rilevanza. Se le richieste sono<br />
poco consistenti, anche l’intera analisi risulterà di poco valore, con conseguente<br />
spreco di risorse e tempo.<br />
Se un museo vuole cercare di aumentare le visite al proprio sito e poi portare gli<br />
utenti su Facebook dove può dialogare con loro, ha poco senso scegliere come<br />
indicatore di ricerca il dispositivo utilizzato per navigare o <strong>la</strong> provenienza<br />
demografica. Piuttosto, sarebbe rilevante studiare il comportamento del consumatore<br />
e i flussi di visita, nonché il tempo di permanenza sul sito e il numero di pagine<br />
visitate. Ciò potrebbe fornire spunti per valutare come l’utente naviga il sito e quanti<br />
arrivano sul<strong>la</strong> pagina di Facebook per leggere nuovi aggiornamenti.<br />
Questo vuole essere solo un esempio, che ha lo scopo di mostrare come specificare<br />
degli obiettivi inconsistenti possa portare a non avere dati sui quali prendere delle<br />
decisioni.<br />
La scelta degli strumenti<br />
La scelta degli strumenti da utilizzare nell’analisi è il passo finale prima del<strong>la</strong> fase di<br />
raccolta vera e propria.<br />
La selezione deve essere fatta in funzione degli obiettivi da raggiungere e in base alle<br />
re<strong>la</strong>zioni di causa ed effetto che esistono tra i diversi canali.<br />
In rete si possono trovare strumenti gratuiti o a pagamento. Nel<strong>la</strong> prima categoria<br />
rientrano, ad esempio, Google Analytics, Facebook Insights e Twitter Analytics: tutti<br />
strumenti creati dalle rispettive aziende di produzione del<strong>la</strong> piattaforme da esaminare.<br />
A questi si aggiungono altri tool che hanno funzioni simili o supplementari e che sono<br />
disponibili sia gratuitamente, sia a pagamento.<br />
I social network che al momento non forniscono alcun tipo di informazioni per<br />
l’analisi sono Instagram e Whatsapp, tenendo ben presente che quest’ultimo non è
considerato un social network in stile c<strong>la</strong>ssico ma è più un’app di messaging.<br />
Una soluzione molto efficace per le aziende è <strong>la</strong> scelta di utilizzare strumenti<br />
strutturati per integrare in un’unica piattaforma tutti i canali utilizzati e avere una<br />
visione d’insieme dell’andamento. Nello specifico, si par<strong>la</strong> di “software di<br />
monitoring” che forniscono anche altri servizi molto potenti, come il listening su<br />
alcune parole chiave in tutta <strong>la</strong> rete e le analisi semantiche delle conversazioni e<br />
demografiche sul target. I costi di questi strumenti, in media, si aggirano su alcune<br />
centinaia di euro mensili, cifra che, purtroppo, li pone al fuori dal<strong>la</strong> portata di molti<br />
musei.<br />
Si passerà ora ad analizzare le caratteristiche dei principali strumenti a disposizione e<br />
a valutare le loro potenzialità in un’ottica di business.<br />
Google Analytics<br />
Google Analytics è un servizio fornito gratuitamente da Google che consente di<br />
analizzare le statistiche sui visitatori di un sito web. Attualmente è in uso presso circa<br />
il 50% dei siti web (fonte W3techs.com)<br />
Consente di ottenere molte informazioni sulle caratteristiche demografiche del<br />
proprio target, sul<strong>la</strong> provenienza e sul comportamento di visita del sito. Google<br />
Analytics si può integrare con altri servizi come Adwords, <strong>la</strong> rete Disp<strong>la</strong>y e il<br />
Remarketing.<br />
Dal punto di vista dell’analisi dei dati, Analytics non permette all’utente di vedere i<br />
dati grezzi, ma mostra le informazioni a livello aggregato, che possono essere<br />
successivamente e<strong>la</strong>borate oppure direttamente presentate, riducendo i tempi.<br />
Gli Obiettivi<br />
Un aspetto molto importante di Analytics sono gli Obiettivi, cioè <strong>la</strong> capacità del sito di<br />
far realizzare una determinata azione ad un utente. Nel<strong>la</strong> pratica, un obiettivo può<br />
essere <strong>la</strong> conclusione di una transazione, oppure il raggiungimento di un certo numero<br />
di pagine visitate per visita, o ancora il download di una brochure informativa.<br />
Ogni volta che l’utente tiene il comportamento che si vuole tracciare, si genera una<br />
conversione che viene segnata nell’apposita sezione.<br />
Si possono impostare quattro tipi di obiettivo:
– Destinazione: si indica una pagina specifica che l’utente deve<br />
raggiungere. Un esempio c<strong>la</strong>ssico è <strong>la</strong> pagina di ringraziamento per<br />
l’acquisto effettuato, oppure <strong>la</strong> pagina per il completamento del<strong>la</strong><br />
registrazione. Ai fini del<strong>la</strong> trattazione, è opportuno precisare che questo<br />
tipo di obiettivo si integra con l’analisi del flusso di navigazione, allo<br />
scopo di comprendere il tunnel di conversione.<br />
– Evento: viene specificata una certa azione che l’utente deve compiere<br />
per poter segnare una conversione, ad esempio il click su un bottone o<br />
su un’immagine, <strong>la</strong> riproduzione di un video, <strong>la</strong> raccomandazione<br />
sociale. Al<strong>la</strong> stregua del precedente obiettivo, seguendo i flussi di<br />
navigazione si può stimare il tunnel di conversione. A differenza di tutti<br />
gli altri obiettivi, impostare un evento comporta l’inserimento di uno<br />
snippet (frammento, poche righe) di codice all’interno del<strong>la</strong> pagina,<br />
quindi è necessario avere accesso ai sorgenti o contattare lo sviluppatore<br />
del sito.<br />
– Durata: segna<strong>la</strong> le visite che durano per un determinato periodo di<br />
tempo o più a lungo. Questo indicatore può essere utilizzato per valutare<br />
<strong>la</strong> capacità che ha un portale di fornire informazioni utili, quindi<br />
minore è <strong>la</strong> durata del<strong>la</strong> visita, maggiore è <strong>la</strong> facilità di ricercare i<br />
contenuti desiderati. Al contrario, può essere utilizzato per capire se i<br />
navigatori continuano a visitare le sezioni del sito per ottenere ulteriori<br />
approfondimenti e se il materiale presente è utile e interessante.<br />
Ovviamente, il concetto di “contenuto utile e interessante” va<br />
approfondito mediante altri indicatori.<br />
– Pagine/schermate per visita: segna una conversione quando il<br />
visitatore visualizza uno specifico numero di pagine o schermate.<br />
Questo indicatore può essere integrato con il secondo sopra citato.<br />
Le Dashboard<br />
Con il termine Dashboard si fa riferimento ad una schermata che permette all’utente<br />
di avere una visuale d’insieme su uno specifico aspetto, grazie all’utilizzo dei<br />
widget. Questi sono dei componenti grafici che hanno lo scopo di facilitare all’utente<br />
l’interazione e <strong>la</strong> comprensione dei dati.
Con Google Analytics si possono creare dashboard di ampio raggio per avere una<br />
visione generale circa le visite al sito e <strong>la</strong> capacità di conversione del portale, come<br />
l’esempio in figura. Oppure si possono creare delle dashboard che analizzino uno<br />
specifico aspetto, come, ad esempio, le caratteristiche demografiche di tutti i<br />
visitatori nuovi e di ritorno del sito.<br />
Le dashboard possono essere create dall’apposito menu, oppure importate dal<strong>la</strong><br />
sezione “Galleria”, dove sono presenti quelle che <strong>la</strong> community di Analytics ha già<br />
creato e condiviso. Questa seconda opzione facilita notevolmente il museo che ha<br />
poca praticità con il sistema.<br />
Le Sezioni<br />
Google Analytics è strutturato in 5 sezioni, che verranno ora analizzate nelle loro<br />
caratteristiche principali.<br />
1. Realtime<br />
Questa sezione è strutturata per fornire informazioni in tempo reale sul<strong>la</strong> località di<br />
provenienza degli utenti, le sorgenti di traffico (diretto, referral, social), i contenuti<br />
visualizzati, gli eventi che si sono verificati e le conversioni ottenute.<br />
Questa parte di Analytics è molto utile nel caso vi siano partico<strong>la</strong>ri situazioni che<br />
generano picchi di traffico in un arco di tempo molto ristretto, in genere si par<strong>la</strong> di
poche ore. Alcuni esempi c<strong>la</strong>ssici di utilizzo possono essere inaugurazioni di mostre<br />
esclusive, aperture speciali, eventi in diretta. Diventa utile, in tali casi, capire le<br />
caratteristiche principali del target che sta visualizzando il sito e il comportamento di<br />
navigazione.<br />
2. Pubblico<br />
La sezione Pubblico contiene le informazioni sugli utenti che visitano il sito e, nello<br />
specifico, le caratteristiche demografiche: <strong>la</strong> località di provenienza del<strong>la</strong><br />
connessione, <strong>la</strong> lingua utilizzata e gli interessi. Inoltre, si può valutare <strong>la</strong> fedeltà dei<br />
navigatori, se si tratta di nuovi utenti o di visite reiterate. Infine, è possibile sapere<br />
con quale device l’utente si collega, da mobile o fisso, quale browser e quale provider<br />
utilizza per <strong>la</strong> connessione.<br />
La schermata principale del<strong>la</strong> sezione “Pubblico” è una panoramica di tutte le sottosezioni.<br />
Come si evince dal<strong>la</strong> figura, Google Analytics mostra alcuni widget che<br />
permettono di avere una visione d’insieme sul target.<br />
Nel<strong>la</strong> parte superiore del<strong>la</strong> pagina viene mostrato un grafico che evidenzia<br />
l’andamento delle visite, solitamente, nell’ultimo mese; subito sono vi sono alcuni<br />
indicatori di performance:<br />
– Sessione: numero totale di visite;<br />
– Utenti: numero di utenti unici che hanno visitato il sito (se tale valore<br />
supera quello precedente significa che ci sono visitatori che ritornano);<br />
– Visualizzazioni di pagina: indicatore generico del numero totale di<br />
pagine visualizzate, da confrontare con altri valori più specifici, come<br />
ad esempio <strong>la</strong> durata delle visita;
– Pagine/visita: indica il numero delle pagine visualizzate in ogni<br />
visita. Questo dato va rapportato al numero delle pagine totali del sito e<br />
ai flussi dei visitatori. Si prenda per esempio <strong>la</strong> situazione in cui i<br />
navigatori sono al<strong>la</strong> ricerca del programma degli eventi dell’estate: se il<br />
numero delle pagine/visita è elevato significa che le informazioni sul<br />
sito non sono facilmente ricercabili e che l’utente deve visitare molte<br />
pagine per poter trovare l’informazione che cerca;<br />
– Durata sessione media: indica il tempo medio del<strong>la</strong> durata del<strong>la</strong><br />
visita e, come già discusso, va analizzato insieme ad altri indicatori,<br />
come il numero delle pagine/visita;<br />
– Frequenza di rimbalzo: rappresenta il numero dei visitatori che<br />
abbandonano il sito dal<strong>la</strong> stessa pagina dal<strong>la</strong> quale sono entrati. Se, per<br />
esempio, <strong>la</strong> maggior parte degli utenti arriva sul<strong>la</strong> home page e <strong>la</strong><br />
abbandona, ciò può significare che il sito non fornisce un valore<br />
aggiunto al<strong>la</strong> navigazione e i visitatori non riescono a trovare quello che<br />
cercano;<br />
– Percentuale di nuove sessioni: indica il rapporto tra i nuovi utenti e<br />
i visitatori complessivi del sito. Minore è tale rapporto, maggiore è il<br />
tasso di fedeltà al portale.<br />
Nel<strong>la</strong> parte inferiore del<strong>la</strong> pagina vengono fornite informazioni che possono essere<br />
definite “di contorno”, perché danno dati aggiuntivi e integrativi di quelli appena<br />
esaminati: i dati demografici, il sistema, <strong>la</strong> tecnologia utilizzata e <strong>la</strong> lingua.<br />
Dati demografici e Interessi. Tali informazioni vengono ricavate da cookie di terze<br />
parti DoubleClick. Nel<strong>la</strong> pratica, non tutti i siti possono ottenere questi dati, ma<br />
so<strong>la</strong>mente quelli che raggiungono un massa critica di visite tale che, anche mediante<br />
analisi di scomposizione dei dati, non è possibile ricavare l’identità di un singolo<br />
utente.<br />
Dati geografici. Indicano qual è <strong>la</strong> lingua utilizzata dai visitatori e <strong>la</strong> provenienza<br />
geografica. Un’analisi approfondita di questa sezione potrebbe aiutare a comprendere<br />
se è necessario utilizzare un sito multi-lingua e quale linguaggio implementare.<br />
Comportamento. In questa sezione si possono valutare gli indicatori che aiutano a<br />
comprendere l’affezione di un navigatore al sito web. È possibile sapere quanti sono i<br />
nuovi visitatori e quanti sono quelli che ritornano e, di questi, quante volte il singolo<br />
utente ritorna sul sito. Vengono, infine, forniti i dati sul<strong>la</strong> durata delle visite.
Tecnologia e Mobile. In queste due sezioni è possibile comprendere quali browser e<br />
provider di connettività utilizzano i navigatori, nonché <strong>la</strong> percentuale di visite da<br />
mobile. Solitamente questi dati hanno molto valore per gli sviluppatori, piuttosto che<br />
per l’area marketing.<br />
Flusso di utenti. Questa sezione permette di valutare i modelli di traffico al sito web in<br />
re<strong>la</strong>zione alle sorgenti di provenienza. La schermata è composta dai nodi, che sono i<br />
punti di passaggio del traffico; dalle connessioni, che indicano il percorso dell’utente;<br />
dalle uscite (<strong>la</strong> parte in rosso), che rappresentano in quale nodo i visitatori hanno<br />
abbandonato il sito.<br />
Si possono selezionare diverse sorgenti di traffico per effettuare analisi che hanno un<br />
valore più qualitativo che quantitativo. Il flusso di navigazione va successivamente<br />
approfondito con altri indicatori numerici in re<strong>la</strong>zione all’obiettivo di ricerca.<br />
3. Acquisizione<br />
La parte di “Acquisizione” restituisce le informazioni circa <strong>la</strong> provenienza dei<br />
navigatori, quindi permette di comprendere quali sono i canali che generano traffico<br />
sul sito. Google Analytics, a priori, identifica 5 sorgenti di traffico:<br />
– Organico: tutti gli utenti che sono atterrati sul sito perché erano al<strong>la</strong><br />
ricerca di una precisa keyword su un motore di ricerca. Analytics non<br />
fornisce, però, <strong>la</strong> lista delle parole chiave che generano traffico al sito, a<br />
meno che non sia in atto una campagna pubblicitaria su Adwords e<br />
l’utente abbia cliccato sull’annuncio;<br />
– Diretto: i navigatori che arrivano sul sito digitando direttamente<br />
l’indirizzo nel<strong>la</strong> barra del browser. Si tratta quindi di persone che già<br />
conoscono il portale e lo visitano solitamente per uno specifico motivo;<br />
– Referral: indica i siti e le re<strong>la</strong>tive pagine che portano traffico sul sito.<br />
È fondamentale capire quali siti stanno generando valore per il portale,<br />
il livello di coinvolgimento degli utenti e <strong>la</strong> loro capacità di realizzare<br />
gli obiettivi;<br />
– Email: tutti gli utenti che arrivano sul sito dopo aver cliccato su<br />
un’email. Solitamente si tratta di campagne di mailinglist;<br />
– Social: i navigatori che arrivano dai social network. In questo caso è<br />
stato condiviso su un social un link al sito che è stato successivamente<br />
cliccato. Anche in questo caso, diventa fondamentale comprendere il<br />
comportamento dei visitatori e <strong>la</strong> capacità di raggiungere gli obiettivi<br />
per poter valutare quale social network genera più valore.
I dati che si ottengono da questa sezione, generalmente, vengono incrociati con quelli<br />
del comportamento sul sito e delle conversioni ottenute. Nel<strong>la</strong> schermata iniziale,<br />
quel<strong>la</strong> panoramica, si ottiene una visione di insieme sulle sorgenti, il comportamento<br />
e le conversioni.<br />
Per ognuna delle sorgenti vi è una sotto-sezione dedicata.<br />
Tutto il traffico. Vengono visualizzati tutte le sorgenti e i mezzi di provenienza degli<br />
utenti, senza alcuna c<strong>la</strong>ssificazione tra diretto, organico e via dicendo. Questo<br />
permette di avere una visione precisa di quali sono i siti o le campagne che generano<br />
più traffico e quali obiettivi vengono raggiunti.<br />
Referral. Sono indicati tutti i domini e le singole pagine che generano traffico sul sito.<br />
Campagne. È una lista di tutte le campagne che hanno generato traffico sul portale. In<br />
questa sezione, per esempio, compaiono le campagne pubblicitarie realizzate con <strong>la</strong><br />
mailinglist, con i banner, oppure sui social network o su Adwords. I risultati presenti<br />
sono influenzati dall’utente stesso che può decidere o meno di tracciare una<br />
campagna.<br />
Sociale. Vengono mostrati quali social network generano traffico al sito. Si può<br />
approfondire quali sono le pagine di atterraggio, quindi quale contenuto è stato<br />
condiviso e ha attirato l’attenzione dell’utente. Nel<strong>la</strong> sezione Trackback è possibile<br />
visualizzare quali sono le pagine condivise sui social che hanno portato traffico al sito.<br />
Questa sezione è molto importante se si vuole capire quali sono i contesti e gli<br />
argomenti nei quali il museo viene citato e che generano interesse nei visitatori.
Adwords e Ottimizzazione per i motori di ricerca. Sono due sezioni che si attivano<br />
quando si collega l’account Adwords a quello di Analytics e si realizzano delle<br />
campagne a pagamento. Ai fini di questa trattazione, non verrà dato approfondimento<br />
di queste sezioni.<br />
4. Comportamento<br />
La sezione sul comportamento restituisce degli indicatori che permettono di valutare<br />
quantitativamente e qualitativamente i contenuti presenti nel sito.<br />
Oggi, chi gestisce un sito deve creare, con una certe frequenza, dei contenuti che<br />
siano realmente utili ai visitatori. Da un <strong>la</strong>to aumenta <strong>la</strong> soddisfazione dei navigatori<br />
che trovano un plusvalore nel sito, dall’altro Google valuta positivamente questa<br />
situazione e incrementa il ranking, migliorando il posizionamento sul motore di<br />
ricerca.<br />
In questa sezione, dunque, si possono ottenere informazioni sul<strong>la</strong> durata del<strong>la</strong> visita e<br />
<strong>la</strong> profondità, sui contenuti del sito, e sugli eventi realizzati dai navigatori.<br />
Come tutte le altre sezioni già viste, anche quel<strong>la</strong> “Comportamento” ha una visuale<br />
panoramica, (in figura sono stati censurati alcuni dati sensibili).<br />
Nel<strong>la</strong> parte superiore è rappresentanto l’andamento mensile del numero complessivo<br />
di pagine visitate.<br />
Più in basso, vi sono degli indicatori numerici sul numero complessivo delle pagine,<br />
il tempo medio di durata di una visita e <strong>la</strong> frequenza di rimbalzo. Nel<strong>la</strong> parte<br />
inferiore, nello specifico quel<strong>la</strong> che è stata offuscata, vi è <strong>la</strong> lista di tutte le pagine che<br />
vengono più visitate. Grazie a questa c<strong>la</strong>ssifica, si possono fare una serie di<br />
considerazioni circa i migliori e peggiori contenuti del sito.
Contenuti del sito. In questa sotto-sezione si possono realmente c<strong>la</strong>ssificare i<br />
contenuti. In primo luogo è necessario comprendere su quali pagine gli utenti<br />
atterrano, quindi quali sono gli argomenti che portano i visitatori sul sito o quali sono<br />
le pagine che si diffondono più facilmente in rete. Poi si valutano i dettagli, cioè le<br />
macro aree logiche nelle quali sono stati suddivisi i contenuti.<br />
Per un museo, questa fase comporta una serie di difficoltà nel<strong>la</strong> concettualizzazione<br />
del<strong>la</strong> suddivisione, però, per meglio rendere l’idea, basta pensare ad un e-commerce di<br />
moda che divide <strong>la</strong> sua collezione in scarpe, maglie, pantaloni, accessori. Grazie ad<br />
una visione di dettaglio, può studiare quali sono le aree che più attirano l’utente.<br />
Come ultimo passaggio, si valuta da quali pagine il visitatore abbandona il sito.<br />
Solitamente l’uscita si verifica se l’informazione ricercata è stata individuata oppure<br />
quando si arriva ad un punto morto del<strong>la</strong> navigazione.<br />
Per ottimizzare i contenuti è necessario seguire il processo di analisi appena descritto,<br />
che deve essere integrato con altri elementi, come le caratteristiche del target o gli<br />
obiettivi di conversione.<br />
Ricerca del sito. In questa sotto-sezione sono raccolte tutte le keyword che l’utente<br />
ricerca nell’apposito modulo all’interno del sito. Questa lista aiuta a comprendere<br />
quali sono gli argomenti e le informazioni di cui il navigatore ha bisogno e che non<br />
riesce ad individuare facilmente.<br />
Eventi. La parte degli eventi si collega agli Obiettivi che sono stati trattati in<br />
precedenza. In questa schermata sono raccolti tutti gli eventi tracciati e vengono<br />
fornite informazioni di approfondimento, come <strong>la</strong> pagina nel<strong>la</strong> quale l’evento si è<br />
verificato e il flusso di navigazione che ha portato una certa sorgente a generare<br />
l’evento.<br />
Analisi dati In-Page. Si tratta di una schermata dinamica che aiuta a capire come gli<br />
utenti utilizzino realmente il sito web, quali siano le aree del<strong>la</strong> pagina più cliccate e<br />
come avvenga l’interazione con i contenuti. Spesso, da questa sotto-sezione nascono<br />
delle considerazioni di tipo qualitativo per poter ottimizzare le singole pagine e i<br />
contenuti.<br />
5. Conversioni<br />
Questa è <strong>la</strong> sezione di maggiore sostanza di tutto l’applicativo perché permette di<br />
capire se il sito raggiunge lo scopo per il quale è stato creato e se gli utenti tengono i<br />
comportamenti previsti e raggiungono gli obiettivi prefissati nel<strong>la</strong> strategia.
Affinché questa sezione sia funzionante, è opportuno impostare degli obiettivi<br />
dall’apposito pannello di controllo “Obiettivi”, che si trova in Amministrazione, sotto<br />
<strong>la</strong> Vista del sito di riferimento.<br />
Google Analytics prevede già una casistica di goal da attivare, oppure si può<br />
procedere manualmente all’inserimento.<br />
La sezione “Conversioni” a differenza di tutte quelle precedenti, non ha una<br />
panoramica complessiva, ma è necessario approfondire le singole sezioni. In questa<br />
sede, ai fini del<strong>la</strong> trattazione, verrà esaminata so<strong>la</strong>mente <strong>la</strong> sotto-sezione degli<br />
“Obiettivi”.<br />
Obiettivi. Da questa schermata è possibile valutare e studiare il tasso di<br />
raggiungimento del singolo obiettivo e rapportarlo ad altri indicatori, come il numero<br />
di utenti unici o il numero delle visite.<br />
È importante approfondire anche l’URL nel<strong>la</strong> quale il goal è stato segnato e,<br />
soprattutto, il percorso inverso, che mostra quali sono le pagine a ritroso che l’utente<br />
ha seguito.<br />
Un altro strumento è <strong>la</strong> canalizzazione dell’obiettivo, <strong>la</strong> quale restituisce una<br />
rappresentazione grafica del tunnel di conversione e che aiuta a studiare i passaggi<br />
che l’utente compie. In pratica, partendo da un certo numero di utenti che arriva al<br />
sito, il tunnel si stringe progressivamente ad imbuto durante <strong>la</strong> navigazione, poiché<br />
diminuisce fisiologicamente durate <strong>la</strong> visita il numero degli utenti che sottendono ad<br />
un preciso obiettivo.
Facebook Insights<br />
Facebook mette a disposizione di chi gestisce le fan page uno strumento di analisi,<br />
chiamato “Insights”, che permette di ottenere informazioni sul<strong>la</strong> composizione del<br />
target, aiuta a valutare chi interagisce con <strong>la</strong> pagina e quali contenuti ottengono più<br />
interazione.<br />
Gli Insights si attivano automaticamente quando si superano i 30 like e, solitamente,<br />
i dati non si aggiornano in real time, quindi bisogna sempre considerare una certa<br />
varianza per i dati di brevissimo periodo.<br />
Le performance dei gruppi<br />
Prima di analizzare Insights, si vuole ricordare che anche per i gruppi al di sotto dei<br />
250 membri esiste un piccolo sistema per valutare le performance.<br />
Ad oggi, questo metodo, seppur macchinoso e rudimentale, è realmente funzionante,<br />
ma non è da escludere che futuri aggiornamenti di Facebook possano rendere<br />
inutilizzabile e inefficace il procedimento.<br />
Il punto di partenza dell’analisi sono gli utenti che hanno visualizzato il contenuto<br />
condiviso, che vengono mostrati da Facebook nel<strong>la</strong> parte inferiore del post, al<strong>la</strong> voce<br />
“Visualizzato da”. Questo dato rappresenta <strong>la</strong> portata effettiva del post, che spesso è<br />
superiore a quel<strong>la</strong> che hanno le singole pagine. Se poi si rapporta il numero delle<br />
interazioni ottenute dal post (like, commenti e condivisioni) al<strong>la</strong> portata, si ottiene il<br />
tasso degli utenti che, dopo aver visto il post, hanno interagito con esso.<br />
Questo piccolo stratagemma fornisce due informazioni: in primo luogo il numero di<br />
utenti che realmente legge i post, solitamente con rispettivi nomi e cognomi; in<br />
secondo luogo, si può studiare quali sono gli iscritti al gruppo che più interagiscono<br />
attivamente.<br />
Come funziona Insights<br />
L’accesso agli Insights avviene cliccando l’ononimo pulsante nel menu superiore che<br />
appare sul<strong>la</strong> pagina del<strong>la</strong> quale si è amministratori.<br />
A tal proposito, si ricorda che le fan page hanno diversi livelli di accesso e ad<br />
ognuno di essi sono associate schermate differenti: all’aumentare del<strong>la</strong> posizione<br />
gerarchica, aumenta <strong>la</strong> quantità delle informazioni visualizzate.
Facebook permette anche l’esportazione in forma tabel<strong>la</strong>re di tutti i dati<br />
rappresentati graficamente, insieme ad altre tipologie di approfondimento: è<br />
sufficiente accedere al<strong>la</strong> sezione “Esporta” in alto a destra nel menu.<br />
Come Google Analytics, anche Facebook ha una schermata iniziale che mostra una<br />
panoramica generale del<strong>la</strong> pagina su un arco di tempo settimanale.<br />
La pagina è divisa in tre parti.<br />
La parte superiore contiene il menu dal quale si può accedere alle sezioni di<br />
approfondimento per valutare <strong>la</strong> composizione del target, <strong>la</strong> portata del<strong>la</strong> pagina e<br />
l’andamento dei post.<br />
Poco sotto vi sono tre riquadri che includono alcuni indicatori di sintesi.<br />
Il primo a sinistra mostra il numero dei like complessivi del<strong>la</strong> pagina e l’andamento<br />
settimanale confrontato con quello del<strong>la</strong> settimana precedente (in realtà questo<br />
indicatore ha una scarsa valenza perché il periodo di riferimento settimanale è scelto<br />
arbitrariamente da Facebook e potrebbe non coincidere i tempi delle strategie in<br />
atto).<br />
Il riquadro centrale mostra <strong>la</strong> portata dei post, cioè quanta gente visualizza le<br />
condivisioni, e, anche in questo caso, vi è il confronto tra <strong>la</strong> settimana attuale e quel<strong>la</strong><br />
precedente.
Infine, nel<strong>la</strong> sezione a destra viene mostrato il coinvolgimento settimanale, cioè<br />
quanti utenti hanno cliccato sul post e interagito con un’azione (like, commento,<br />
condivisione).<br />
In pratica, analizzando l’immagine, si può affermare che questa settimana <strong>la</strong> pagina<br />
ha ottenuto 9 nuovi like e i post (non viene mostrato il numero delle condivisioni)<br />
sono stati visti da 927 utenti, 436 dei quali hanno cliccato sui post, mentre solo alcuni<br />
hanno interagito: 33 hanno cliccato like, 4 hanno commentato e altri 4 hanno<br />
condiviso il contenuto.<br />
La parte inferiore di questa schermata mostra le performance degli ultimi post e<br />
verrà approfondida successivamente.<br />
Una terza parte è attiva solo se viene monitorato l’andamento dei “mi piace” di altre<br />
pagine.<br />
Mi Piace<br />
In questa sezione si possono approfondire alcuni aspetti d’insieme sul<strong>la</strong> crescita del<strong>la</strong><br />
pagina, nonché sul<strong>la</strong> provenienza dei like. È divisa in 4 parti:<br />
(elenco numerato)<br />
La prima sotto-sezione mostra quanti like si ottengono giornalmente. Si tratta di un<br />
indicatore che non ha un valore assoluto, ma va rapportato con altri dati che saranno<br />
approfonditi successivamente. In questa sotto-sezione si può selezionare anche l’arco<br />
temporale dell’analisi, che influenzerà tutti i grafici che si trovano al di sotto.<br />
La seconda sotto-sezione mostra i like giornalieri in maniera aggregata, quindi di<br />
primo acchito si può notare con quale velocità <strong>la</strong> pagina cresce. L’arco temporale di<br />
riferimento è quello che si è impostato nel<strong>la</strong> sezione precedente.<br />
La terza sotto-sezione è un grafico a linee che permette di approfondire quanti like<br />
provengono da azioni spontanee degli utenti, quanti sono quelli che provengono da<br />
campagne pubblicitarie e quanti utenti hanno tolto il “Mi Piace” al<strong>la</strong> pagina.<br />
L’ultima sezione è forse <strong>la</strong> più importante, perché mostra <strong>la</strong> provenienza dei like.<br />
Facebook individua 4 tipologie di provenienza dei fan:<br />
– Sul<strong>la</strong> tua Pagina: utenti che arrivano sul<strong>la</strong> pagina e mettono like,<br />
solitamente perché <strong>la</strong> ricercano o vi arrivano direttamente;<br />
– Suggerimenti di Pagine: ad un utente che ha appena messo “Mi
Piace” a una pagina o a un post, vengono mostrati suggerimenti di<br />
pagine simili. Solitamente si tratta di fan che sono abbastanza in linea<br />
con i contenuti del<strong>la</strong> fan page di riferimento;<br />
– Navigazione su dispositivo mobile: like effettuati da dispositivi<br />
mobile;<br />
– I tuoi post: utenti che hanno messo like direttamente dal post, senza<br />
atterrare prima sul<strong>la</strong> pagina;<br />
– Altri.<br />
Persone<br />
Dopo aver analizzato i “Mi Piace”, sembra logico comprendere le caratteristiche<br />
demografiche del target del<strong>la</strong> pagina.<br />
I grafici presenti in questa sezione sono facilmente interpretabili e mostrano le<br />
percentuali di uomini e donne, nonché le fasce di età alle quali appartengono.<br />
Le barre in blu si riferiscono al<strong>la</strong> pagina analizzata, quelle in grigio indicano <strong>la</strong> media<br />
di Facebook. Non sempre questo dato può essere utile all’analisi perché un dato<br />
medio non è sempre confrontabile con un prodotto di nicchia o un servizio non di<br />
massa.<br />
Nel<strong>la</strong> parte inferiore del<strong>la</strong> sezione è riportata <strong>la</strong> provenienza dei fan che permette di<br />
valutare l’eventualità di scrivere post in più lingue o di realizzare campagne di<br />
comunicazione per ogni singo<strong>la</strong> zona di provenienza dei visitatori, stimo<strong>la</strong>ndo, ad<br />
esempio, i fan che si trovano più vicini al museo.<br />
Vi sono, inoltre, altre 2 sotto-sezioni che danno informazioni demografiche sulle<br />
persone raggiunte, cioè quelle che hanno visto i contenuti del<strong>la</strong> pagina senza esserne<br />
fan, e su quelle coinvolte, cioè quelle che hanno interagito in maniera diretta con i<br />
post.<br />
Solitamente non ci sono grandi differenze tra questi gruppi di target e piccole<br />
variazioni percentuali sono poco significative, anche in considerazione del fatto che<br />
possono essere causate da arrotondamenti. Se però si notano dei gap, significa che vi<br />
sono delle azioni correttive da mettere in atto.<br />
L’ultima sotto-sezione assume notevole importanza nel caso dei musei perché mostra<br />
le caratteristiche demografiche degli utenti che hanno fatto check-in e <strong>la</strong> loro<br />
provenienza geografica. Queste sono le persone che veramente hanno visitato il<br />
museo: a loro bisogna comunicare e indirizzare le nostre campagne di fidelizzazione.
Portata<br />
La portata, altresì detta Reach, indica il numero delle persone che hanno<br />
visualizzato il post.<br />
Nello specifico, Facebook fa riferimento al numero di utenti che hanno visto<br />
comparire nel<strong>la</strong> propria timeline il post e non vi è alcuna sicurezza che il post sia stato<br />
realmente letto o compreso. Questa sezione è suddivisa in 4 parti.<br />
– La prima sotto-sezione indica esclusivamente <strong>la</strong> portata di ogni<br />
singolo post, limitandosi a indicare il numero delle impression generate.<br />
– La seconda mostra il numero delle interazioni giornaliere degli<br />
utenti, quindi non in funzione del singolo post. I dati del<strong>la</strong> prima e<br />
seconda sezione possono essere rapportati tra di loro, per valutare<br />
approfonditamente l’andamento dell’engagement nel tempo e sul singolo<br />
post. Purtroppo, <strong>la</strong> modalità di rappresentazione dei dati (diagramma ad<br />
area) non permette di ottenere i dati grezzi, che invece si possono<br />
visualizzare mediante <strong>la</strong> funzione di esportazione dei dati.<br />
– La terza sotto-sezione mostra i feedback negativi ottenuti, come<br />
utenti che nascondono il post o lo segna<strong>la</strong>no come spam.<br />
– Per ultimo, viene mostrata <strong>la</strong> portata complessiva di tutta <strong>la</strong><br />
pagina, cioè tutte le notizie, comparse sul<strong>la</strong> timeline degli utenti, che<br />
sono generate dai post pubblicati, dai post scritti da altre persone, dal<br />
ricorso a Facebook Advertising, dai tag e dalle registrazioni.<br />
Generalmente, all’analisi del reach segue l’analisi dei contenuti e delle interazioni, allo<br />
scopo di individuare l’imbuto del comportamento degli utenti sul<strong>la</strong> nostra pagina di<br />
Facebook.<br />
Post<br />
Questa sezione aiuta a valutare quali sono i post che hanno avuto le migliori<br />
performance ed è suddivisa in due parti.
La sotto-sezione superiore contiene tre schermate.<br />
1. Nel<strong>la</strong> prima viene mostrato quando i fan del<strong>la</strong> pagina sono <strong>online</strong> e<br />
quanti sono. Questo dato può essere utile per individuare gli orari<br />
migliori in cui condividere. Si può anche analizzare il singolo dato<br />
giornaliero e sviluppare il perfetto timing del piano di condivisione.<br />
2. La seconda schermata è utile per fare un’analisi macroscopica del<br />
piano editoriale in quanto vengono mostrati quali sono i contenuti che<br />
ottengono maggiore engagement.<br />
Facebook individua tre tipi di contenuto: video, link e foto. L’esempio<br />
riportato in figura evidenzia che i link hanno meno successo delle foto e<br />
anche dei video, è dunque facile affermare che i video sono il contenuto<br />
migliore e che sarebbe meglio condividerne di più.<br />
Se si approfondisce l’analisi sul dato scomposto, si nota che i video<br />
hanno una portata doppia rispetto ai link e trip<strong>la</strong> rispetto alle foto,<br />
nonostante il numero di “Mi Piace, commenti e condivisioni” sia<br />
sostanzialmente uguale.<br />
A quanto pare, gli utenti mediamente interagiscono in maniera identica<br />
su tutti i contenuti, ma sono maggiormente attratti da video e foto, in<br />
funzione ai “Click su post”. Ad esempio, se rapportiamo i click sul post<br />
al<strong>la</strong> portata media, si nota che in media il 27% degli utenti che ha visto<br />
il video ha cliccato sul post, mentre per le foto si tratta del 24%. I dati<br />
sono sostanzialmente molto vicini, quindi non c’è una tipologia di<br />
contenuti che realmente prevale sulle altre.
3. La terza parte di questa sotto-sezione mostra i post principali delle<br />
pagine sotto controllo e mostra qual è il singolo post che durante <strong>la</strong><br />
settimana ha ottenuto maggior engagement.<br />
La seconda sotto-sezione è, forse, quel<strong>la</strong> più importante per valutare i contenuti,<br />
poiché essi sono mostrati singo<strong>la</strong>rmente con tutti i dati di approfondimento.<br />
Per ogni condivisione si può valutare <strong>la</strong> tipologia di contenuto (link, foto, video), il<br />
destinatario (se tutti o uno specifico target geografico), <strong>la</strong> portata (quante persone<br />
hanno visto il post) e il coinvolgimento (le modalità di interazione).<br />
La portata può essere a sua volta divisa in organica o a pagamento, se si utilizza<br />
Facebook advertising, e in fan/non fan. Il coinvolgimento mostra il numero di click<br />
per post e il numero di interazioni.<br />
Per comprendere le performance del<strong>la</strong> pagina si valuta prima <strong>la</strong> portata, poi<br />
l’attrattività del post in base ai click e infine l’engagement rate.<br />
Un secondo livello di approfondimento può essere affrontato cliccando sul pulsante<br />
con <strong>la</strong> freccia verso il basso che è posizionato a fianco del<strong>la</strong> voce “Mi piace,<br />
Commenti e Condivisioni”, che restituisce altri indicatori.<br />
Il primo mostra le attività degli utenti, dividendo i “mi piace” da commenti e<br />
condivisioni: in questa schermata è realmente possibile comprendere e valutare le<br />
performance del singolo post.<br />
La seconda sezione prende il nome di “Post nascosti, Tutti i post nascosti,<br />
Segna<strong>la</strong>zioni di spam, “Non mi piace più” sul<strong>la</strong> tua Pagina” e mostra tutti i feedback<br />
negativi per ogni singolo contenuto condiviso.<br />
Infine, è possibile visualizzare il tasso di coinvolgimento che si ottiene suddividendo
<strong>la</strong> somma delle interazioni degli utenti (non necessariamente fan) sul post e di click<br />
sul contento per <strong>la</strong> portata.<br />
Se, nel<strong>la</strong> sotto-sezione che mostra <strong>la</strong> lista tabel<strong>la</strong>re dei contenuti, si clicca sul singolo<br />
post , si accede ad una visuale di approfondimento per valutare i “mi piace”, i<br />
commenti e le condivisioni ottenuti sul post pubblicato e sulle condivisioni pubbliche<br />
da altri utenti (quelle senza filtri di privacy, generalmente altre pagine).<br />
Inoltre, in funzione del contenuto, è possibile ottenere informazioni sui click sul link,<br />
se si tratta di un indirizzo web, sulle visualizzazioni di foto se si tratta di un’immagine,<br />
sui click per riprodurre il video e il tempo di visualizzazione se si tratta di un filmato.<br />
È necessario precisare che questa sezione degli Insights di Facebook contiene molte<br />
informazioni che sono state trattate ricorrendo al<strong>la</strong> sintesi e agli esempi pratici,<br />
piuttosto che all’approfondimento numerico del dato. Di primo acchito potrebbe<br />
apparire molto complesso analizzare le performance dei post, ma <strong>la</strong> pratica costante<br />
e l’esperienza rendono queste operazioni molto semplici, divertenti e stimo<strong>la</strong>nti e<br />
possono realmente fornire una base di dati per <strong>la</strong> realizzazione di nuove strategie.<br />
Visite<br />
L’ultima sezione che si analizzerà riguarda <strong>la</strong> provenienza delle visite sul<strong>la</strong> pagina,<br />
similmente a quanto detto per Google Analytics.<br />
Questa sezione è suddivisa in 3 parti.<br />
La prima mostra quali sezioni del<strong>la</strong> fan page l’utente visita:<br />
– il diario, cioè <strong>la</strong> schermata principale;<br />
– le informazioni, che sono una parte di approfondimento del<strong>la</strong> pagina<br />
che può essere visitata, ad esempio, per capire quali sono gli orari di<br />
apertura di un museo o per avere notizie più dettagliate rispetto a quelle<br />
sintetiche che si trovano nel<strong>la</strong> pagina principale;<br />
– le foto, accedendo dall’apposita tab;<br />
– le schede di amministrazione (non sono importanti ai fini dello studio<br />
sull’utente finale);<br />
– altre schede, se sono state create.<br />
La seconda sezione mostra il numero delle azioni che gli utenti hanno realizzato sul<strong>la</strong><br />
pagina: si tratta di check-in, menzioni o pubblicazione di post. Questi dati sono utili
per individuare i fan più affezionati e fedeli del museo.<br />
L’ultimo grafico riporta i domini esterni a Facebook dai quali provengono le visite, e<br />
aiuta a capire se gli utenti ricercano <strong>la</strong> pagina dall’esterno, se ci sono referral<br />
importanti che puntano al<strong>la</strong> fan page e se il sito web è in grado di portare traffico.<br />
Twitter<br />
Twitter fornisce un sistema di analisi delle performance del profilo.<br />
Nel momento in cui si scrive questo e-book, l’accesso ad Analytics è disponibile solo a<br />
chi ha implementato le Twitter Cards. Probabilmente questo servizio, in futuro, sarà<br />
attivato per tutti gli utenti.<br />
Per molto tempo, gli utenti di Twitter – soprattutto le aziende – hanno avuto <strong>la</strong><br />
necessità di valutare le performance del proprio profilo, ovvero il suo tasso di crescita,<br />
<strong>la</strong> composizione del<strong>la</strong> base di utenti, il livello di interazione sui contenuti, <strong>la</strong> capacità<br />
di sviluppare discussioni su precisi argomenti e l’utilizzo degli hahstag.<br />
Negli ultimi anni, grazie alle API messe a disposizione da Twitter (si può control<strong>la</strong>re<br />
<strong>la</strong> documentazione su Dev.twitter.com/docs), sono nati molti strumenti, sia gratuiti<br />
sia a pagamento, che aiutano gli utenti nell’analisi delle proprie performance. Alcuni<br />
di essi si possono ancora utilizzare e integrare con gli Analytics di Twitter:<br />
– www.twitonomy.com<br />
– www.tweetlevel.edelman.com<br />
– www.simplymeasured.com<br />
– www.foller.me<br />
– www.tweetstats.com<br />
– www.twtr<strong>la</strong>nd.com<br />
– www.twittercounter.com<br />
– www.twitaholic.com
– www.tweetreach.com<br />
– www.topsy.com<br />
– www.followerwonk.com<br />
– www.mentionmap.com<br />
Twitter Analytics si compone di 3 macro aree che approfondiscono i Tweet, i<br />
Follower e le Twitter Cards.<br />
Tweet<br />
La sezione Tweet permette di valutare le performance dei contenuti condivisi e<br />
dunque di comprendere quali sono i contenuti migliori e quali hanno bisogno di<br />
essere rivisti.<br />
La prima schermata al<strong>la</strong> quale ci si trova di fronte è un grafico riassuntivo del<strong>la</strong><br />
portata, ovvero il numero delle persone che hanno visualizzato i tweet.<br />
Nel<strong>la</strong> parte sottostante, sono elencati tutti i tweet e per ognuno di essi viene<br />
dettagliata <strong>la</strong> portata, il numero di interazioni e l’engagement rate espresso in<br />
percentuale. Cliccando sul tweet, si possono approfondire le tipologie di interazioni<br />
degli utenti: numero di risposte, numero di retweet e numero di preferiti.<br />
Si può anche valutare l’andamento orario del reach, solo per le prime 30 ore di ogni<br />
singolo tweet.<br />
La sezione a destra contiene degli indicatori giornalieri sull’andamento dei tweet. Ai
più attenti non sarà sfuggito che gli Analytics offrono due tipologie di informazioni:<br />
una filtrata per contenuto (nel<strong>la</strong> parte centrale) e una filtrata per giorno (nel<strong>la</strong> colonna<br />
di destra). Questo tipo di posizionamento aiuta ad avere una visione panoramica e di<br />
dettaglio in un’unica pagina, <strong>la</strong>sciando poi <strong>la</strong> possibilità di approfondire ogni singolo<br />
tweet.<br />
(Fonte: Vincos.it)<br />
Follower<br />
La sezione dei follower, al<strong>la</strong> stregua degli Insights di Facebok, aiuta a valutare <strong>la</strong><br />
crescita dell’account e <strong>la</strong> composizione qualitativa e quantitativa dei follower.<br />
La parte superiore contiene un grafico a linee che mostra <strong>la</strong> crescita del numero dei<br />
fan. Subito sotto, si può studiare <strong>la</strong> composizione del<strong>la</strong> base di utenti iniziando dagli<br />
interessi, per poi sapere quali sono gli argomenti che maggiormente vengono trattati.<br />
Twitter li suddivide in “partico<strong>la</strong>ri” e “principali”.<br />
Inoltre, è possibile valutare <strong>la</strong> provenienza geografica a livello di nazione e di città<br />
di provenienza.<br />
Infine, vi sono informazioni sul genere sessuale e su quali sono gli altri account che i
follower seguono maggiormente.<br />
Valutando gli interessi principali e secondari, insieme agli account seguiti dai<br />
follower, si può capire quali sono i temi che possono ottenere un maggior feedback e<br />
su quali puntare a discapito di argomenti che non interessano al target.<br />
Twitter Cards<br />
Le Twitter Cards permettono <strong>la</strong> creazione di un tweet arricchito, ad esempio, da<br />
un’anteprima del post o da una breve descrizione del<strong>la</strong> pagina, e si utilizzano per<br />
misurare l’impatto virale di un account e dei suoi follower.<br />
È necessario inserire uno snippet di codice nel sito manualmente oppure tramite un<br />
plugin se si utilizza Wordpress (si veda Dev.twitter.com).<br />
Il primo elemento visibile è una panoramica (Istantanea) delle performance<br />
numeriche ottenute: nel<strong>la</strong> circonferenza più grande sono indicati i valori totali, in<br />
quel<strong>la</strong> più picco<strong>la</strong> le azioni e i goal realizzati dall’account in esame.
Come si nota nell’immagine, iniziando ad analizzare dal<strong>la</strong> circonferenza a sinistra, <strong>la</strong><br />
Card è stata twittata una volta dall’account e due volte da altri utenti: spostandosi<br />
verso il centro, si possono visualizzare le impression (il reach) e infine quanti sono i<br />
click e i retweet ottenuti.<br />
Nel<strong>la</strong> sezione più in basso, si può notare un grafico a linee che mostra l’andamento<br />
giornaliero aggregato dei tweet, del reach e dei click. Tale grafico è utile per avere<br />
sempre una visuale d’insieme e individuare eventuali picchi in attivo o in negativo.<br />
Più in basso ancora vi è una panoramica di tutte le Twitter Cards utilizzate e il loro<br />
tasso di conversione, che può essere confrontato con il tasso medio di tutte le Cards<br />
attive sul social network.<br />
Infine, nell’ultima sezione in basso si notano i link, cioè le pagine, che hanno ottenuto<br />
più interazioni da parte del pubblico.<br />
Nel<strong>la</strong> macro area del<strong>la</strong> Twitter Cards, ai fini dello scopo di questo e-book, verranno<br />
analizzate solo le sezioni re<strong>la</strong>tive alle Fonti e agli Influencer. In quest’ultima sezione,<br />
nello specifico, vengono analizzati quegli account che Twitter c<strong>la</strong>ssifica come<br />
influencer e che hanno condiviso le nostre Cards. Dal<strong>la</strong> schermata si deduce anche<br />
qual è stato il reach generato da ogni influencer e i click che ha portato: questi dati<br />
permettono di sapere quali sono gli utenti che generano maggior valore per il nostro<br />
account.<br />
Nel<strong>la</strong> sezione re<strong>la</strong>tiva alle Fonti, si può sapere quali app, widget e siti web hanno<br />
generato il maggior numero di interazioni in termini di portata e click.
(fonte: http://www.skande.com/)<br />
Instagram<br />
Instagram non ha un sistema pubblico di Analytics. Per fortuna, però, questo social<br />
network mette a disposizione alcune API, meno potenti di quelle di Facebook e di<br />
Twitter, che comunque permettono di valutare le performance di un account.<br />
Nel tempo, sono nate molte app, alcune gratis, altre a pagamento, che sfruttano le API<br />
per strutturare dei sistemi di Analytics soddisfacenti, grazie ai quali è possibile<br />
analizzare i follower e i following, nonché le performance delle fotografie.<br />
Verrà analizzato un solo strumento che, a esclusivo parere di chi scrive, è il giusto<br />
compromesso per i costi (nulli, in quanto è uno strumento gratuito) e le informazioni<br />
che permette di ottenere. È opportuno precisare che i dati che utilizzano applicativi di<br />
questo tipo sono pubblici, per cui l’analisi può essere realizzata sia sul nostro account,<br />
sia su quello di altri musei.<br />
Iconosquare (in precedenza Statigr.am)<br />
È un applicativo gratuito, raggiungibile su Iconosquare.com, composto da sei<br />
schermate.<br />
Nel<strong>la</strong> prima – panoramica – si possono visualizzare i dati generali, come i media
caricati, l’andamento dei follower negli ultimi 7 giorni e i tassi di interazione degli<br />
utenti:<br />
– love rate, quanti like in media per ogni foto;<br />
– talk rate, quanti commenti in media per ogni foto;<br />
– spread rate, quanti like per ogni foto provenienti dai non follower.<br />
La seconda sezione è una panoramica mensile sull’andamento dell’account, con un<br />
focus sui contenuti e sui follower.<br />
La terza parte approfondisce i media e mostra le informazioni su quanti sono quelli<br />
condivisi, quando vengono postati, quali i filtri e quali hashtag sono maggiormente<br />
utilizzati dall’account.<br />
La quarta sezione analizza l’engagement e individua quali foto hanno conseguito <strong>la</strong><br />
migliore risposta dai fan e quanti commenti e like sono stati ottenuti giornalmente.<br />
La quinta sezione, mostra in sintesi in quale giorno e in quale orario i post ottengono<br />
il maggiore engagement, dando dunque <strong>la</strong> possibilità di decidere di condividere le<br />
foto negli orari migliori.<br />
Nell’esempio in figura: da un’analisi generale si nota che il sabato e <strong>la</strong> domenica sono<br />
i giorni in cui si hanno maggiori interazioni e nell’orario pomeridiano e serale si<br />
concentra maggiormente l’engagement. In realtà, se si guarda più attentamente, il<br />
sabato mattina è il momento in cui si ottengono le migliori performance.
Proseguendo l’analisi del<strong>la</strong> sezione, si può valutare per quanto tempo un contenuto<br />
genera interazioni, quindi se i fan sono molto attivi o meno. Infine si possono avere<br />
informazioni riguardanti l’utilizzo degli hashtag, se quelli che utilizza l’account sono<br />
tra quelli più in voga su Instagram e <strong>la</strong> frequenza di utilizzo degli stessi.<br />
L’ultima sezione permette di valutare <strong>la</strong> crescita nel tempo di follower e i<br />
following, di ricevere suggerimenti sui nuovi utenti che hanno interagito con<br />
l’account e che potrebbero essere seguiti, infine mostra quali sono i profili ai quali<br />
l’account ha dato più like.<br />
API<br />
Le A.P.I., acronimo di Application Programming Interface (in italiano Interfaccia di<br />
Programmazione di un’Applicazione), sono un’insieme di procedure definite dallo<br />
sviluppatore che permettono l’espletamento di specifiche funzioni di un certo<br />
programma. Ad esempio Facebook, grazie alle sue API, ci permette di avere <strong>la</strong> lista di<br />
tutte le persone che hanno messo like ad uno specifico post di una certa pagina.<br />
L’argomento delle API è di tipo avanzato e presuppone <strong>la</strong> capacità di programmare e<br />
<strong>la</strong> conoscenza dei linguaggi necessari per potersi interfacciare con le varie<br />
piattaforme.<br />
Ai fini del<strong>la</strong> trattazione, è sufficiente evidenziare che le API rappresentano un livello<br />
di astrazione più elevato del codice puro, semplificando il <strong>la</strong>voro del programmatore<br />
che non deve riscrivere sempre le medesime funzioni.<br />
Facebook, Twitter e Instagram mettono a disposizione del<strong>la</strong> API che si possono<br />
utilizzare anche direttamente da browser:<br />
– Facebook: https://developers.facebook.com/tools/explorer<br />
– Twitter: https://dev.twitter.com/console<br />
– Instagram: http://instagram.com/developer/api-console/<br />
Facebook dispone di un set di API molto potente e molte informazioni sono già rese<br />
disponibili negli Insights (tuttavia <strong>la</strong> ricerca di “quali sono gli utenti che hanno messo<br />
like ad uno specifico post” si può realizzare so<strong>la</strong>mente tramite API).
Anche Twitter fornisce delle API potenti, delle quali, però, molte non sono integrate<br />
negli Analytics forniti dal<strong>la</strong> piattaforma, come tutte quelle che riguardano gli hashtag.<br />
Scrivendo il codice corretto, si possono ottenere molte informazioni: a titolo di<br />
esempio, si può scoprire se vi sono degli influencer che utilizzano un determinato<br />
hashtag.<br />
Instagram, invece, ha un set limitato di API che vengono utilizzate da tutti gli<br />
applicativi che analizzano le performance di un account. Tuttavia, si tratta di<br />
informazioni superficiali e non approfondite.<br />
Le API, attualmente, vengono utilizzate dagli sviluppatori di tutti i software di<br />
listening e da tutti gli applicativi gratuiti o a pagamento precedentemente menzionati.<br />
Con l’obiettivo del<strong>la</strong> sintesi e ai fini dello scopo dell’e-book, si analizzerà ora uno<br />
strumento che permette di integrare le API di tanti social network.<br />
IFTTT<br />
È un applicativo, acronimo di If This Then That, raggiungibile su Ifttt.com, che<br />
integra diversi web services.<br />
Come si intuisce dal nome, l’applicazione si struttura in 2 parti, una “this” e una<br />
“that”.<br />
La prima ha l’obiettivo di creare un evento, al verificarsi del quale si attiva una<br />
procedura automatica, che è specificata nel<strong>la</strong> seconda parte. Ad esempio, può<br />
rappresentare un evento “Il checkin su Foursquare” o “una foto su Facebook nel<strong>la</strong><br />
quale io sono taggato”.<br />
La parte di “that” indica l’azione che verrà effettuata, come ad esempio “Condividi il<br />
mio check-in su Facebook” oppure “condividi <strong>la</strong> foto su Twitter”.<br />
La combinazione di This (Trigger) e That (Action) prende il nome di Recipe, le quali<br />
vengono costantemente aggiunte e aggiornate dal<strong>la</strong> community di IFTTT.<br />
Alcuni recipes che possono essere utili ad un museo:
– Quando cambia l’immagine del profilo di Facebook, allora cambia<br />
anche quel<strong>la</strong> di Twitter;<br />
– Quando su Instagram viene pubblicata una foto con un certo hashtag<br />
(ad esempio quello del museo), allora twitta<strong>la</strong> ringraziando i fan;<br />
– Quando pubblico su Instagram una foto, allora carica<strong>la</strong> in un album su<br />
Facebook.<br />
Le applicazioni di IFTTT sono realmente molto ampie e i casi sopra citati sono un<br />
estratto esemplificativo. Le potenzialità di questo strumento aiutano i Community<br />
Manager a gestire e integrare velocemente tutti i canali di comunicazione di un<br />
museo o di un’azienda.
6. <strong>Svegliamuseo</strong>: un progetto per “svegliare” i musei italiani <strong>online</strong><br />
Francesca De Gottardo<br />
Antefatto<br />
L’avventura di #svegliamuseo è iniziata nell’estate del 2013, quando sono stata<br />
incaricata di svolgere alcune ricerche sui musei italiani <strong>online</strong> per conto dell’agenzia<br />
per cui <strong>la</strong>voravo.<br />
Nello specifico, si trattava di mappare il posizionamento <strong>online</strong> e sui social network<br />
degli enti <strong>cultura</strong>li di Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, per una<br />
ricerca finalizzata a supportare <strong>la</strong> candidatura di Venezia come Capitale Europea<br />
del<strong>la</strong> Cultura nel 2019.<br />
Malgrado l’esito del processo di selezione non sia andato a buon fine per Venezia,<br />
l’indagine che ho svolto si è rive<strong>la</strong>ta molto utile ed è stata a tutti gli effetti <strong>la</strong> base da<br />
cui si è sviluppata successivamente l’idea di #svegliamuseo.<br />
Nel corso delle mie ricerche, infatti, ho scoperto come molte delle istituzioni <strong>cultura</strong>li<br />
più rappresentative del territorio esaminato fossero scarsamente comunicate <strong>online</strong>.<br />
Fatta eccezione per alcune realtà del Trentino Alto Adige e per gli enti supportati da<br />
fondazioni private nelle altre regioni, quasi tutti i siti internet presi in esame si sono<br />
rive<strong>la</strong>ti antiquati, statici e molto limitati nel fornire informazioni all’utente. Nel<strong>la</strong><br />
grande maggioranza dei casi, inoltre, i musei di piccole dimensioni non erano presenti<br />
<strong>online</strong> con siti propri, ma solo attraverso siti comunali o reti provinciali che<br />
raggruppavano le realtà del territorio in portali forniti di schede.<br />
Spostando l’analisi sui social network, <strong>la</strong> situazione continuava a dimostrarsi più che<br />
<strong>la</strong>cunosa. Erano pochissimi i musei di piccole e medie dimensioni presenti su<br />
Facebook e quasi nessuno di essi si trovava su Twitter. Tutte le altre piattaforme di<br />
social networking o blogging erano completamente trascurate da quasi tutte le<br />
strutture prese in esame. Persino alcune tra le realtà <strong>cultura</strong>li più note non erano<br />
rintracciabili sui social network di maggiore utilizzo, mentre, in alcuni casi, i<br />
profili erano presenti, ma gestiti da visitatori e appassionati, invece che dalle<br />
istituzioni stesse.<br />
Anche gli enti <strong>cultura</strong>li che curavano <strong>la</strong> propria presenza social dimostravano, nel<strong>la</strong><br />
maggior parte, uno scarso spirito d’iniziativa verso un utilizzo più completo e creativo<br />
di questi strumenti, limitandosi ad annunciare gli eventi in corso di svolgimento, gli<br />
orari di apertura e i futuri appuntamenti.<br />
Ovviamente, già all’epoca del<strong>la</strong> mia ricerca, esistevano alcune eccezioni notevoli,<br />
come il Mart di Rovereto, il MUSE di Trento – ai tempi ancora in pre–apertura – e <strong>la</strong>
Peggy Guggenheim Collection di Venezia. Tolti questi e pochi altri esempi iso<strong>la</strong>ti di<br />
utilizzo efficace del web, l’indagine si chiudeva prendendo atto di una situazione<br />
generalizzata di arretratezza e di mancata comprensione delle potenzialità offerte<br />
dagli strumenti digitali.<br />
Concludevo <strong>la</strong> mappatura sostenendo che “<strong>la</strong> comunicazione <strong>online</strong> dei musei e delle<br />
istituzioni <strong>cultura</strong>li nel Nordest si trova in questo momento in una fase di transizione,<br />
con alcuni esempi iso<strong>la</strong>ti di eccellenza, una buona parte di strutture che si stanno<br />
adeguando al cambiamento e una restante parte, ancora numerosa, di musei che non<br />
si comunicano <strong>online</strong> o lo fanno con metodi antiquati. Alcune realtà si differenziano<br />
nettamente dal<strong>la</strong> media e dimostrano di aver bene appreso <strong>la</strong> lezione dei musei<br />
stranieri, scegliendo di intraprendere <strong>la</strong> strada del<strong>la</strong> comunicazione bidirezionale che<br />
lega il museo all’utente, coinvolto in prima persona e chiamato a diventare egli stesso<br />
produttore di contenuti.”<br />
Una volta terminata <strong>la</strong> ricerca per Venezia Capitale Europea del<strong>la</strong> Cultura, mi è<br />
rimasta <strong>la</strong> curiosità di approfondire <strong>la</strong> situazione dei musei <strong>online</strong> nel resto d’Italia e<br />
di metter<strong>la</strong> a confronto con le pratiche di gestione degli strumenti digitali da parte dei<br />
musei stranieri. Ero curiosa di capire quali fossero le reali potenzialità offerte dai<br />
social network in ambito museale e quali potessero essere i trend di sviluppo del<br />
digitale nel settore <strong>cultura</strong>le.<br />
Grazie a questa seconda fase di ricerca di best practices e di benchmark, ho iniziato<br />
a raccogliere una buona quantità di materiale sull’argomento “musei e mondo<br />
digitale” e a riflettere sull’idea di utilizzar<strong>la</strong> in un progetto strutturato.<br />
L’analisi svolta, infatti, confermava <strong>la</strong> necessità di iniziare una discussione con i<br />
musei italiani su queste tematiche, in modo da sottolineare l’importanza di un uso<br />
strategico degli strumenti digitali e di rendere accessibili le informazioni, gli esempi<br />
positivi e i possibili spunti di utilizzo.<br />
Il progetto<br />
Lo scopo iniziale di #svegliamuseo, quindi, è stato principalmente quello di accendere<br />
i riflettori sui temi legati al digitale in ambito museale.<br />
Abbiamo volutamente scelto un nome provocatorio, che fosse allo stesso tempo di<br />
richiamo e auto–esplicativo, nel tentativo di attirare l’attenzione del<strong>la</strong> comunità degli<br />
addetti ai <strong>la</strong>vori e di tutti gli appassionati che volessero partecipare al dialogo che<br />
stavamo cercando di impostare.<br />
Lo stesso tono di voce del progetto voleva essere in linea con gli obiettivi che ci<br />
eravamo posti e con gli argomenti di cui stavamo trattando: professionale, sì, ma
distaccato dai dogmi del<strong>la</strong> comunicazione tradizionalmente elevata del<strong>la</strong> <strong>cultura</strong> e più<br />
vicino allo stile diretto e chiaro del<strong>la</strong> comunicazione <strong>online</strong>.<br />
Per perseguire il duplice obiettivo di evidenziare le carenze del settore <strong>cultura</strong>le<br />
<strong>online</strong>, ma soprattutto di fornire esempi, risorse e spunti che potessero incoraggiare<br />
il cambiamento, abbiamo progettato di agire su due fronti principali.<br />
Da una parte, mettiamo in connessione i musei internazionali che utilizzano gli<br />
strumenti digitali in maniera efficace, strutturata e creativa, con i musei italiani che<br />
si offrono volontari per essere consigliati sulle strategie web e social da adottare.<br />
Dall’altra, ci proponiamo di dare voce ai musei italiani che sono già presenti <strong>online</strong><br />
in maniera proattiva, chiedendo loro di condividere esperienze, problematiche<br />
affrontate e sviluppi futuri, in modo che possano svolgere una funzione di traino e di<br />
esempio per i colleghi meno “avanzati” digitalmente.<br />
Inoltre, attraverso un blog, un gruppo su Facebook, un hashtag e un account su<br />
Twitter, abbiamo iniziato a condividere <strong>online</strong> articoli di nostra produzione e<br />
notizie provenienti dal web sugli argomenti intorno ai quali ruota #svegliamuseo,<br />
cercando di mettere in circolo <strong>la</strong> conoscenza: dai social media alle strategie di<br />
comunicazione e ai metodi di analisi, dai blog museali agli esempi più all’avanguardia<br />
di utilizzo dello storytelling, dal mobile ai media interattivi all’uso delle wearable<br />
technologies, dagli opendata all’internet of things e altro ancora.<br />
Con il passare dei mesi e grazie al contatto costante con i musei – italiani e stranieri –<br />
che si è venuto a creare nel gruppo Facebook, su Twitter e tramite scambi di email<br />
con i singoli professionisti, abbiamo potuto arricchire <strong>la</strong> nostra comprensione di<br />
queste tematiche e delle problematiche connesse, e abbiamo iniziato a <strong>la</strong>vorare ad un<br />
approfondimento del<strong>la</strong> mission di #svegliamuseo.<br />
L’obiettivo che ci poniamo oggi è di svolgere un ruolo di aggregatore di risorse e di<br />
contenitore di idee sui temi connessi al digitale in ambito museale, incoraggiando un<br />
maggiore dialogo tra le comunità di professionisti nel settore <strong>cultura</strong>le e<br />
chiamando a raccolta esperti dal contesto nazionale e internazionale.<br />
Vorremmo, quindi, che il nostro progetto diventasse un punto di incontro, di<br />
conversazione e di scambio su tecnologie, media e comunicazione <strong>online</strong> nel settore<br />
<strong>cultura</strong>le. Un’idea che è ben riassunta da quanto si legge nel<strong>la</strong> home del sito:<br />
“#svegliamuseo è un progetto sperimentale nato per ‘svegliare’ i musei italiani <strong>online</strong><br />
sfruttando il potere del Web per creare un effetto rete.”<br />
In questo senso, il fatto che non siamo un museo e che possiamo sfruttare una ben<br />
maggiore libertà di movimento e una visione d’insieme ci aiuta a <strong>la</strong>vorare dall’esterno<br />
per creare – appunto – una rete trasversale che coinvolga i musei in Italia e nel mondo<br />
per lo sviluppo di best practices e di miglioramento reciproco.
Sviluppi futuri<br />
In meno di un anno dal suo inizio, #svegliamuseo ha assistito – e in parte ha<br />
partecipato – a un sensibile processo di trasformazione nel settore del<strong>la</strong><br />
comunicazione <strong>online</strong> del<strong>la</strong> <strong>cultura</strong> italiana che si proponeva di mettere in moto.<br />
È innegabile che, rispetto a un anno fa, siano molti di più i musei italiani presenti sui<br />
social network, soprattutto su Twitter e Facebook, con alcune eccezioni su Pinterest,<br />
Instagram e YouTube.<br />
Si tratta di un fenomeno che ha riguardato soprattutto i musei di piccole e medie<br />
dimensioni, dimostrando che esiste <strong>la</strong> volontà di aprirsi all’utilizzo di questi strumenti<br />
e che hanno gioco più facile le strutture che sono meno penalizzate dalle gerarchie<br />
interne.<br />
Per fare un esempio numerico: i musei italiani che hanno partecipato all’iniziativa<br />
“Ask a Curator Day” su Twitter a settembre 2013 erano solo 15; a febbraio 2014<br />
erano in 34 i nostri musei per “Follow a Museum Day”, mentre a fine marzo 2014<br />
erano più di 110 per <strong>la</strong> “Museum Week”.<br />
Questo significa non solo che si è diffusa una più forte consapevolezza delle<br />
potenzialità offerte dai mezzi di comunicazione <strong>online</strong>, ma anche che gli enti<br />
<strong>cultura</strong>li italiani iniziano ad apprezzare i vantaggi che derivano dal<strong>la</strong> partecipazione a<br />
iniziative condivise e dal<strong>la</strong> costruzione di una rete su sca<strong>la</strong> internazionale.<br />
Ci rendiamo conto di come non basti aprire un account su Twitter per considerare di<br />
aver fatto il proprio dovere nel<strong>la</strong> costruzione di una strategia di comunicazione<br />
<strong>online</strong>. Senza una corretta fase di pianificazione di target e obiettivi a priori e di<br />
evaluation e analisi dei dati a posteriori, i social network rischiano di essere<br />
utilizzati fine a se stessi e di non apportare nessun contributo al<strong>la</strong> gestione di una<br />
struttura museale.<br />
È necessario, inoltre, che <strong>la</strong> strategia <strong>online</strong> di un museo sia studiata in riferimento<br />
alle necessità specifiche dell’istituzione e al suo target, così come al<strong>la</strong> situazione<br />
<strong>cultura</strong>le, politica ed economica in cui essa opera.<br />
#svegliamuseo vorrebbe muoversi in questa direzione, proponendosi come una<br />
piattaforma di ascolto e riflessione su strategie, forme e dimensioni possibili che i<br />
media digitali possono assumere. In un settore in continua evoluzione, non vogliamo<br />
dettare regole ma <strong>la</strong>voriamo per creare opportunità di apprendimento e di scambio,<br />
cercando costantemente un confronto con i professionisti che si rapportano con questi<br />
argomenti nel<strong>la</strong> loro pratica <strong>la</strong>vorativa quotidiana.<br />
Per rendere più immediato e più facilmente fruibile questo dialogo tra figure<br />
professionali in tutto il mondo, abbiamo inaugurato una nuova fase del progetto,
chiamata <strong>Svegliamuseo</strong> On Air, che consiste in una serie di incontri virtuali<br />
tramite Google Hangout, trasmessi in diretta e registrati su YouTube. Si tratta di<br />
una serie di video-interviste di un’ora in cui incoraggiamo lo scambio di metodologie,<br />
esempi e consigli tra un professionista di un museo straniero e un collega di un museo<br />
italiano intorno a specifici temi nell’ambito del digitale museale, dal<strong>la</strong> pianificazione<br />
strategica sui social network all’uso degli analytics, dalle metodologie di blogging agli<br />
strumenti di gestione dei post, dal<strong>la</strong> formazione digitale dello staff alle tecniche di<br />
gamification. Stanno aderendo al progetto gli esponenti di alcuni tra i musei più<br />
all’avanguardia nell’utilizzo di questi strumenti e ci auguriamo che le interviste<br />
possano essere un’utile occasione di apprendimento reciproco.<br />
Iniziative di questo tipo vogliono contribuire ad alimentare <strong>la</strong> curiosità e lo spirito<br />
d’intraprendenza dei musei italiani. In questo senso, #svegliamuseo continuerà<br />
sempre a <strong>la</strong>vorare e a ricercare per creare iniziative che portino allo sviluppo<br />
professionale del personale museale, per ottenere una digital awareness diffusa e<br />
trasversale anche in ambito <strong>cultura</strong>le.<br />
In meno di un anno, quindi, #svegliamuseo ha vissuto una significativa<br />
trasformazione: da “movimento” connotato da elementi di attivismo e provocazione,<br />
si è evoluto in un vero e proprio progetto strutturato. La risposta positiva da parte<br />
delle community che ci seguono ha alimentato il nostro entusiasmo e <strong>la</strong> voglia di<br />
impegnarci per fornire nuovi contenuti e continuare il dialogo su questi temi.<br />
Forti dell’esperienza che stiamo accumu<strong>la</strong>ndo e spinti dal<strong>la</strong> profonda passione per <strong>la</strong><br />
<strong>cultura</strong> che ci contraddistingue, ci muoviamo verso un ruolo strutturato e ci sforziamo<br />
di far sì che #svegliamuseo possa diventare un riferimento nel settore del<strong>la</strong><br />
comunicazione <strong>cultura</strong>le digitale, sia a livello di aggregazione dei contenuti, sia per<br />
quanto riguarda <strong>la</strong> possibilità di creare attività di formazione professionale e<br />
consulenza.
6. Le interviste di #svegliamuseo<br />
Alessandro D’Amore, Aurora Raimondi Cominesi, Francesca De Gottardo, Valeria<br />
Gasparotti<br />
La community internazionale dei digital media manager museali<br />
Se c’è una cosa che abbiamo imparato dalle varie esperienze <strong>la</strong>vorative nel settore del<br />
digitale museale è che le persone che ci <strong>la</strong>vorano, a qualsiasi livello, formano una<br />
community estremamente ricettiva.<br />
Infatti, il ruolo del digital media manager, o delle sue declinazioni, è re<strong>la</strong>tivamente<br />
nuovo all’interno del<strong>la</strong> maggior parte delle istituzioni. Spesso le persone arrivano a<br />
svolgere questo <strong>la</strong>voro partendo da posizioni differenti, come Comunicazione e<br />
Pubbliche Re<strong>la</strong>zioni o Educazione, e talvolta l’inquadramento stesso di questa<br />
posizione non è chiaramente definito.<br />
La capacità di reinventarsi e <strong>la</strong> profonda curiosità costituiscono, quindi, una sorta<br />
di prerequisito per i professionisti di questo settore.<br />
A questo proposito, abbiamo avuto <strong>la</strong> fortuna di interfacciarci con persone “social”<br />
nel vero senso del<strong>la</strong> paro<strong>la</strong>, sempre disponibili ad aiutare e a dare sostegno al progetto,<br />
a prescindere da livello, quantità di esperienza o ruolo.<br />
Fin dall’inizio, #svegliamuseo ha sfruttato le potenzialità racchiuse in questo<br />
ricchissimo gruppo di professionisti entusiasti. Invece di compi<strong>la</strong>re liste di Do’s &<br />
Don’ts sull’uso degli strumenti digitali basandoci solo sulle nostre competenze e<br />
professionalità, abbiamo preferito fare un passo indietro e giocare il ruolo di<br />
arbitri, favorendo connessioni e mediando <strong>la</strong> trasmissione di informazioni tra i<br />
professionisti museali italiani e quelli esteri.<br />
Nonostante venga dato ampio spazio alle best practices provenienti da altri paesi,<br />
l’obiettivo delle interviste di #svegliamuseo non è quello di fare paragoni apportando<br />
un punto di vista esterofilo. Al contrario, vorremmo infondere un atteggiamento<br />
propositivo, favorendo <strong>la</strong> costruzione di una community italiana che possa<br />
interfacciarsi al<strong>la</strong> pari con quel<strong>la</strong> estera.<br />
Inoltre, <strong>la</strong> scelta di illuminare i “retroscena” dei digital media department esteri è<br />
motivata dal<strong>la</strong> nostra volontà di far comprendere come, spesso, i problemi e le<br />
difficoltà che si affrontano in musei anche molto avanzati digitalmente – come <strong>la</strong><br />
Tate, ad esempio – siano estremamente simili a quelli con cui si confrontano i musei<br />
italiani, indipendentemente dal<strong>la</strong> loro importanza o grandezza.
È anche interessante notare come questa community non si limiti a riflettere su come<br />
sfruttare i social network e i digital media per superare il modello di trasmissione “top<br />
down” del museo tradizionale, ma utilizzi questi strumenti come canale primario<br />
per lo scambio tra professionisti.<br />
Twitter è l’esempio principale in questo senso: intorno agli hashatg #museweb,<br />
#musetech, #mtogo e #musesocial, ha luogo ogni giorno un ricco scambio di risorse e<br />
iniziative per lo sviluppo professionale nel settore. Le conferenze internazionali come<br />
Museums and the Web o Museumnext costituiscono utili momenti di incontro<br />
effettivo che consolidano maggiormente col<strong>la</strong>borazioni e scambi.<br />
Il nostro obiettivo con le interviste di #svegliamuseo ai professionisti stranieri, quindi,<br />
è quello di generare uno scambio e di favorire <strong>la</strong> discussione sul piano internazionale<br />
in modo che si creino quante più possibili occasioni di confronto e di crescita.<br />
Cosa abbiamo chiesto e perché<br />
1. Team, formazione e processi interni<br />
Le domande che abbiamo rivolto ai professionisti delle comunicazione museale, in<br />
Italia e all’estero, sono volte soprattutto a sve<strong>la</strong>re gli aspetti di “dietro le quinte” del<br />
<strong>la</strong>voro dei digital department o delle persone che rivestono il ruolo di digital media<br />
manager.<br />
Come prima cosa, abbiamo ritenuto interessante comprendere come i team di <strong>la</strong>voro<br />
siano strutturati e come si interfaccino con i dipartimenti più tradizionali.<br />
Musei più grandi e complessi, come <strong>la</strong> Tate o il Prado, possiedono un digital team<br />
interno nel quale <strong>la</strong>vorano diverse figure (generalmente da due a quattro persone) che<br />
gestiscono il sito e gli strumenti multimediali nelle gallerie, insieme ai social media e<br />
ai progetti digitali.<br />
Rispetto all’organigramma generale delle istituzioni, il digital team risiede spesso nel<br />
dipartimento dedicato al<strong>la</strong> comunicazione o all’educazione, mentre talvolta è un<br />
settore a sé stante.<br />
In alcuni casi, invece, i social media sono visti come uno strumento di trasmissione<br />
a più voci, nel quale il digital team svolge un ruolo di coordinamento, mentre<br />
dipartimenti come educazione o curate<strong>la</strong> vengono incentivati a col<strong>la</strong>borare al<strong>la</strong><br />
creazione di contenuti per gli specifici canali. Un esempio in questo senso è il Mart di<br />
Rovereto, che assegna <strong>la</strong> gestione di Pinterest al settore educazione per affinità e<br />
compatibilità del<strong>la</strong> piattaforma rispetto alle attività svolte dal dipartimento.<br />
Nei musei più piccoli, invece, i social media sono gestiti da un’unica persona, <strong>la</strong> quale<br />
spesso non è nemmeno parte del dipartimento comunicazione, né ha una formazione
specifica in questo senso. Esempi come il James A. Michener Art Museum, però, ci<br />
dimostrano come siano <strong>la</strong> buona volontà, <strong>la</strong> curiosità e l’entusiasmo a muovere anche<br />
le professionalità lontane dall’universo social verso <strong>la</strong> comprensione e il<br />
padroneggiamento di questi strumenti.<br />
Ulteriori aspetti su cui abbiamo cercato di concentrarci sono <strong>la</strong> formazione e il<br />
background dei professionisti digitali nei musei.<br />
Spesso, infatti, se si pensa al<strong>la</strong> possibile job description di un digital media curator, ci si<br />
immagina che questa figura non debba possedere solo competenze di tipo strategico e<br />
capacità di scrittura su varie piattaforme, ma anche che padroneggi <strong>la</strong> capacità di<br />
gestire i canali da un punto di vista tecnico.<br />
Sebbene molti tra gli intervistati abbiano riferito di avere competenze di base nel<br />
settore IT, spesso ereditate da precedenti <strong>la</strong>vori, queste non sembrano essere un prerequisito<br />
fondamentale per <strong>la</strong>vorare con gli strumenti digitali. Molto più importanti<br />
sono <strong>la</strong> curiosità, <strong>la</strong> flessibilità e <strong>la</strong> capacità di re-inventarsi. È bene sottolineare<br />
come <strong>la</strong> maggior parte degli intervistati abbia una formazione di tipo umanistico e<br />
come <strong>la</strong> passione per l’arte, <strong>la</strong> <strong>cultura</strong> e <strong>la</strong> mission del museo sia un elemento<br />
fondamentale in tutti i contesti che abbiamo esplorato.<br />
In tutti i casi, i professionisti intervistati si pongono il problema del<strong>la</strong> “digital<br />
awareness” e di come questa si sviluppi in maniera trasversale all’istituzione. Alcuni<br />
musei hanno evidenziato le difficoltà che possono sorgere quando una strategia<br />
digitale non è completamente compresa, condivisa o supportata a tutti i livelli<br />
dell’organizzazione.<br />
In questo senso, le opportunità di sviluppo professionale per lo staff dovrebbero<br />
essere incoraggiate. Queste possono prendere <strong>la</strong> forma di attività di formazione, con<br />
modelli e approcci più o meno informali, nonché momenti per <strong>la</strong> condivisione e <strong>la</strong><br />
spiegazione delle modalità di <strong>la</strong>voro che coinvolgono il digitale applicate ai progetti.<br />
Il digital team dovrebbe essere il principale sostenitore dell’introduzione del digitale<br />
nel mondo del museo, non solo rivolto agli utenti finali, ma anche e soprattutto per<br />
l’avvio di un cambiamento interno. La Tate è l’esempio emblematico in questo senso,<br />
dal momento che ha messo in atto una strategia per diffondere competenze e mind set<br />
a tutti i livelli interni al museo, in uno scenario in cui il digital team agisce quasi come<br />
un consulente per il personale degli altri dipartimenti.<br />
In generale, questo primo nucleo di domande ci è sembrato molto interessante, in<br />
quanto ci costringe a riflettere su come il cambiamento e <strong>la</strong> consapevolezza interni a<br />
un’istituzione siano determinanti nel generare il processo di cambiamento verso<br />
l’esterno, visibile e tangibile agli utenti finali.
2. Iniziare una strategia di comunicazione <strong>online</strong>: difficoltà<br />
e motivazioni<br />
Per <strong>la</strong> maggior parte delle istituzioni museali intervistate, <strong>la</strong> decisione di cominciare a<br />
utilizzare le piattaforme di social networking è stata <strong>la</strong>nciata da un direttore<br />
partico<strong>la</strong>rmente sensibile ai nuovi strumenti di comunicazione o da un direttivo<br />
attento agli sviluppi del<strong>la</strong> tecnologia.<br />
È stato così – per esempio – per lo Statens Museum for Kunst di Copenaghen, il<br />
Museum of Arts and History di Santa Cruz, il DDR Museum di Berlino, il<br />
Rijksmuseum di Amsterdam, il Prado di Madrid, il National Museum of Women in<br />
the Arts e l’Horiniman Museum & Gardens.<br />
Ma questo non vuol dire che <strong>la</strong> spinta all’utilizzo di questi strumenti possa derivare<br />
solo dalle “alte sfere” dell’organigramma museale.<br />
Infatti, sia Mar Dixon sia Àlex Hinojo ci hanno confermato come l’impulso possa<br />
provenire da un singolo dipendente, da un dipartimento o da un professionista che,<br />
senza scopo di lucro, si metta a disposizione di una serie di musei del territorio per<br />
creare una comunità virtuale. Questo, in partico<strong>la</strong>re, è il caso di Hinojo, che ha creato<br />
un progetto ad hoc per riunire i musei cata<strong>la</strong>ni in una rete virtuosa e consentire di<br />
espandere le proprie possibilità di visibilità e di raggiungimento di nuovi pubblici.<br />
D’altronde, anche le interviste ai musei italiani hanno confermato come sia spesso lo<br />
spirito d’iniziativa del singolo a dare l’avvio all’apertura di questi canali.<br />
Tutti i musei intervistati hanno ritenuto opportuno pianificare, organizzare e<br />
progettare una social media strategy per i motivi sopra citati: ampliamento dei propri<br />
pubblici, raggiungimento di un buon posizionamento <strong>online</strong>, aumento di quel<strong>la</strong> che<br />
potremmo chiamare brand awareness e nuove possibilità di engagement del pubblico.<br />
La difficoltà comune incontrata dal<strong>la</strong> maggior parte delle istituzioni alle quali<br />
abbiamo rivolto le nostre domande è quel<strong>la</strong> del coordinamento <strong>la</strong>vorativo.<br />
L’inserimento di nuove mansioni all’interno dell’organico ha inevitabilmente portato i<br />
musei a ripensare <strong>la</strong> distribuzione del <strong>la</strong>voro, delle ore e degli orari. A parte i pochi<br />
casi in cui è stata prevista l’assunzione di nuove figure professionali (v. Statens<br />
Museum e Horniman Museum), per gli altri si è resa necessaria l’attività di<br />
formazione del personale interno già presente.<br />
Sono state messe in funzione turnazioni durante i weekend e le festività, così come<br />
riunioni o meeting interdipartimentali per <strong>la</strong> programmazione e l’e<strong>la</strong>borazione dei<br />
contenuti. Infatti, per alcuni intervistati (v. Rijksmuseum e National Museum of<br />
Women in the Arts), anche <strong>la</strong> necessità di interfacciarsi con tanti dipartimenti,<br />
personalità e interessi è stata rilevata come una criticità iniziale.<br />
Un’altra grande difficoltà incontrata dai musei che cominciavano ad utilizzare i social<br />
media è stata <strong>la</strong> poca fiducia del pubblico – e a volte anche dei professionisti stessi –
verso questi strumenti e le loro potenzialità. Oggi <strong>la</strong> situazione è chiaramente molto<br />
cambiata, considerando che queste piattaforme fanno ormai parte del<strong>la</strong> nostra vita<br />
quotidiana.<br />
In ultimo, riteniamo rilevante l’osservazione puntualizzata da Merete Sanderhoff,<br />
responsabile e curatrice del reparto digital dello Statens Museum: <strong>la</strong> difficoltà di<br />
trovare il coraggio per essere un museo open, che significa essere pronti stare sotto<br />
<strong>la</strong> lente d’ingrandimento di milioni di persone e avere <strong>la</strong> forza di ammettere gli<br />
eventuali errori che si commettono.<br />
3. Diversi canali: quali priorità, quali obiettivi<br />
Una volta presa <strong>la</strong> decisione di investire sul<strong>la</strong> comunicazione <strong>online</strong>, e creato un team<br />
digital, o, perlomeno, designata <strong>la</strong> persona che se ne occuperà, il passo successivo è<br />
quello di sviluppare una strategia social, selezionando i canali su cui si vuole essere<br />
presenti e decidendo in che modo si intende sfruttarli.<br />
Ogni piattaforma social e digitale ha finalità proprie e si adatta a veico<strong>la</strong>re<br />
informazioni differenti: per questo motivo, abbiamo chiesto come si approcciano i<br />
musei italiani e stranieri a questa differenziazione, e come <strong>la</strong> sfruttano.<br />
Anzitutto, va detto che i social network sono da considerare un’emanazione del<br />
centro operativo <strong>online</strong> del museo: il sito web ufficiale. È qui che si concentrano<br />
tutte le informazioni, a partire dal database dettagliato del<strong>la</strong> collezione, e tutti i target,<br />
cosa che lo rende anche il canale più difficile da gestire. È dal sito web che lo staff<br />
digitale può attingere per promuovere <strong>la</strong> collezione e invitare l’audience del museo a<br />
fare altrettanto: il progetto “Rijksstudio” non esisterebbe se il museo non avesse reso<br />
disponibili 150.000 opere sul suo sito.<br />
Ma <strong>la</strong>ddove <strong>la</strong> comunicazione sul sito è resa difficoltosa dal<strong>la</strong> compresenza di diversi<br />
tipi di audience, e da una conseguente necessità di e<strong>la</strong>borare contenuti funzionali,<br />
entrano in gioco i social network a semplificare il <strong>la</strong>voro del reparto comunicazione.<br />
I social media permettono, infatti, di selezionare un target di riferimento (priorità<br />
numero uno) e di differenziarlo per ogni canale, tenendo però sempre presente, come<br />
ci hanno ricordato il Prado e il National Museum of the Women in the Arts, che <strong>la</strong><br />
strategia migliore è quel<strong>la</strong> di associare tra loro le diverse piattaforme per<br />
massimizzare il loro impatto. L’esempio migliore? L’iniziativa “Dinosauri in carne e<br />
ossa” del Museo di Storia Naturale di Firenze: multicanale, interattiva e coinvolgente.<br />
Da quale social network iniziare? I musei con cui abbiamo par<strong>la</strong>to confermano che<br />
si debba farlo da Facebook, ad oggi <strong>la</strong> piattaforma più popo<strong>la</strong>re, anche tra i membri<br />
dello staff museale.
Il potenziale di Facebook viene individuato nel<strong>la</strong> capacità di sviluppare un dialogo<br />
quotidiano con il pubblico, e il suo impiego si focalizza generalmente sul<strong>la</strong><br />
divulgazione di eventi e attività legate al museo. Attenzione, però: non sempre questa<br />
si rive<strong>la</strong> una strategia vincente. Allo Statens Museum for Kunst, ad esempio, hanno<br />
constatato che <strong>la</strong> promozione degli eventi non funzionava bene e che il pubblico si<br />
approcciava al museo per scoprire cose nuove, divertenti e significative sull’arte,<br />
vedendo nell’istituzione una risorsa credibile al riguardo. Così al Prado: i post di<br />
maggior successo sono quelli legati alle opere d’arte del<strong>la</strong> ricca collezione spagno<strong>la</strong>.<br />
Un altro campanello di al<strong>la</strong>rme viene dal Museo del<strong>la</strong> Scienza e del<strong>la</strong> Tecnologia<br />
Leonardo da Vinci di Mi<strong>la</strong>no: attenzione a non usare Facebook come un’estensione<br />
del<strong>la</strong> newsletter, il pubblico si aspetta contenuti unici.<br />
Ad ogni modo, scegliere di concentrarsi sul<strong>la</strong> promozione di eventi corrisponde anche<br />
a localizzare geograficamente il proprio pubblico, limitandolo a quello locale.<br />
Perché il pubblico si al<strong>la</strong>rghi su sca<strong>la</strong> globale, il social network più utilizzato è invece<br />
Twitter, il cui target è molto ben preciso: quello dei colleghi e dei professionisti<br />
museali, nonché dei “fanatici” dell’arte, dell’archeologia e del<strong>la</strong> scienza.<br />
L’utilizzo di hashtag dedicati e ricorrenti e lo scambio di cinguettii con istituzioni<br />
simili al<strong>la</strong> propria permettono di diffondere <strong>la</strong> mission e i contenuti del museo in un<br />
contesto atto a recepirli e potenziarli. Come confermatoci da Álex Hinojo dei Musei<br />
Cata<strong>la</strong>ni, Twitter è il canale più influente tra le piattaforme social. E <strong>la</strong><br />
#museumweek l’ha dimostrato anche in Italia, dove Twitter sta prendendo sempre più<br />
piede, anche tra un pubblico meno elitario (e dove Pa<strong>la</strong>zzo Madama costituisce<br />
l’esempio più illuminato di utilizzo creativo, trascinante e comunitario di questa<br />
piattaforma).<br />
Il problema del<strong>la</strong> diffusione di una determinata piattaforma nel paese in cui si opera è<br />
un punto altrettanto importante da prendere in considerazione. Prendiamo, ad<br />
esempio, Pinterest: ancora quasi sconosciuto in Spagna, poco utilizzato in Italia.<br />
Eppure Pinterest ha un potenziale enorme: quello di <strong>la</strong>sciare che sia il pubblico a fare<br />
il “<strong>la</strong>voro sporco”, interagendo, senza mediazione, con le opere, mentre è il museo a<br />
<strong>la</strong>sciarsi ispirare. Vedere per credere: le board del Museum of Art & History di Santa<br />
Cruz.<br />
Se Facebook e Twitter permettono un dialogo costante con il proprio pubblico; se<br />
Pinterest aiuta a diffondere i contenuti del<strong>la</strong> collezione e YouTube funge da archivio<br />
di notizie su eventi, mostre e contenuti più “ufficiali”, dov’è che il museo si mette<br />
veramente “a nudo” e si presenta libero da ogni patina istituzionale? La risposta è:
Instagram. È qui che, non importa in quale paese vi troviate, potrete apprezzare i<br />
dietro le quinte, le foto di una nevicata vista dagli uffici, un cartellone pubblicitario<br />
che stona con <strong>la</strong> facciata più “c<strong>la</strong>ssica” del museo, il primo piano di un qualche strano<br />
oggetto (v. Horniman Museum), e così via.<br />
Altri canali meno diffusi, come Google+ o Foursquare, servono da “supporter” alle<br />
altre piattaforme: Google+ per ottimizzare il posizionamento del museo nei motori di<br />
ricerca; Foursquare per monitorare i check-in via Twitter o proporre premi e sconti a<br />
chi si geo-localizza al museo (v. NMWA).<br />
Dalle conversazioni che abbiamo portato avanti, è emersa anche l’enorme potenzialità<br />
offerta dai social network di comunicare con un tono diverso da quello del puro<br />
marketing. Al centro dell’universo social c’è il visitatore, non il museo: è bandito il<br />
tono “pubblicitario” e si crea massima apertura a conversazioni amichevoli,<br />
incoraggianti, inclusive. Ed è importante che si tratti di conversazioni, non di<br />
monologhi del museo né di dialoghi uni<strong>la</strong>terali del pubblico: come hanno saggiamente<br />
sottolineato dallo Statens Museum di Copenhagen, nessuno continua a chiamare chi<br />
non risponde mai.<br />
E se si volessero avere queste conversazioni in altre lingue? La scelta del<br />
multilinguismo è molto soggettiva, non codificata, sicuramente problematica, e<br />
<strong>la</strong>ddove il problema per i musei anglosassoni non si pone, può diventarlo per paesi<br />
come l’Italia che vogliano aprirsi ad un pubblico più globale. Fate del vostro meglio e<br />
quello che potete, direbbe Luca Melchionna del Mart – però, ecco, almeno provateci.<br />
Ad ogni modo, qualunque lingua si utilizzi, bisogna tenere a mente che gli obiettivi<br />
non cambiano, e sono gli stessi per tutti: <strong>la</strong> finalità dei social network è anche quel<strong>la</strong><br />
di stimo<strong>la</strong>re le persone a visitare il museo e fidelizzarle oltre <strong>la</strong> visita, nonché istruirle<br />
sui contenuti che sono il cuore pulsante di ciascun museo. Nel<strong>la</strong> definizione ICOM, il<br />
Museo “espone a fini di studio, educazione e diletto”: i social media rappresentano<br />
un’ulteriore opportunità in questo senso.<br />
4. Interazione <strong>online</strong> – offline<br />
La domanda è stata posta per investigare come i social media siano integrati nelle<br />
gallerie, sia in termini di marketing e promozione dei canali in cui il museo è<br />
presente, al fine di ottenere fan e follower, sia in termini di creazione di<br />
opportunità di interazione con i visitatori, sempre connessi al<strong>la</strong> rete, anche durante<br />
una visita al museo.<br />
Fino a tempi recenti, <strong>la</strong> dimensione digitale e quel<strong>la</strong> fisica del museo sono state
considerate come separate e indipendenti. Oggi, sempre più persone accedono a<br />
internet, compiono transazioni, <strong>la</strong>vorano e si connettono con amici, familiari e<br />
comunità attraverso i loro strumenti mobile. Un articolo di Mashable conferma che<br />
internet da mobile supererà internet da desktop nel 2015 18 . Un’altra ricerca compiuta<br />
da Cisco stima che, per <strong>la</strong> fine del 2014, il numero di cellu<strong>la</strong>ri connessi al<strong>la</strong> rete sarà<br />
maggiore di quello delle persone presenti sul<strong>la</strong> Terra, mentre, nel 2018, ci saranno<br />
quasi 1.4 mobile devices per capita 19 . Tutto questo significa che sempre più visitatori<br />
varcheranno <strong>la</strong> soglie del museo con i loro smartphone e/o tablet in mano,<br />
utilizzandoli per accedere alle informazioni e scattare foto, ma, sopra ogni cosa, per<br />
condividere <strong>la</strong> loro esperienza con altri.<br />
Di conseguenza, i musei devono pensare a come integrare i social media all’interno<br />
dei loro spazi, a sostegno di questo addizionale livello di engagement. Non è più<br />
possibile par<strong>la</strong>re solo dell’interazione “statica” e accademica generata dalle didascalie<br />
o dagli altri strumenti di interpretazione, ma è necessario comprendere come<br />
l’engagement sia ormai “a doppio senso” e guardi ai social media come a un<br />
importante strumento per il coinvolgimento attivo del visitatore.<br />
L’integrazione più comune dei social media all’interno degli spazi museali è<br />
rappresentata dall’inserimento delle icone nei supporti istituzionali, quali<br />
brochures e pannelli, presenti all’ingresso.
Ma questo tipo di visibilità è sufficiente a generare engagement?<br />
Esistono molte altre pratiche che sfruttano meglio le opportunità rappresentate dai
social media nelle gallerie. Quel<strong>la</strong> più comune riguarda <strong>la</strong> creazione e diffusione di<br />
un hashtag specifico per <strong>la</strong> condivisione delle foto scattate durante l’esperienza al<br />
museo o ad una mostra. In alcuni casi, il museo condivide le foto pubblicate dagli<br />
utenti, talvolta anche on-site, come succede al<strong>la</strong> Tate Britain.
I photo contest sono un’ulteriore pratica sempre più consolidata.<br />
Il National Museum of Women in the Arts ne organizza durante gli eventi serali<br />
indirizzati a un pubblico giovane. In queste occasioni, il museo chiede ai visitatori di<br />
scattare istantanee del<strong>la</strong> serata e di condividerle con un hashtag predefinito.<br />
Più in generale, i musei si stanno indirizzando verso <strong>la</strong> creazione di “momenti<br />
instagrammabili”. Un esempio in questo senso è <strong>la</strong> pratica del “museum selfie”,<br />
vale a dire gli autoscatti in contesti museali. Sempre di più, infatti, i musei mettono a<br />
disposizione “selfie station” in cui i visitatori possono farsi autoscatti, spesso ironici e<br />
giocosi, nel contesto di una partico<strong>la</strong>re opera o ambiente.<br />
Nonostante siano meno comuni, sono utilizzate anche altre tecniche e spunti per far<br />
partire conversazioni.<br />
Il Royal Ontario Museum, per esempio, incoraggia i visitatori a twittare domande e<br />
riflessioni in re<strong>la</strong>zione ai diversi settori del museo, indicando sul<strong>la</strong> mappa gli account
Twitter dei curatori di riferimento per ogni area, oltre a quello ufficiale<br />
dell’istituzione. Questo esempio è di partico<strong>la</strong>re interesse perché si tratta di una<br />
sovrapposizione tra <strong>la</strong> comunicazione istituzionale, rappresentata dal<strong>la</strong> mappa, e<br />
quel<strong>la</strong> più amichevole e tipica del<strong>la</strong> comunicazione <strong>online</strong>, rappresentata dagli<br />
account Twitter.<br />
Un altro esempio interessante di interazione tra <strong>online</strong> e offline viene dall’Italia. Il<br />
MUSE di Trento, infatti, poco prima dell’inaugurazione ufficiale ha posizionato un<br />
container nel<strong>la</strong> piazza principale del<strong>la</strong> città e l’ha utilizzato come un “calendario<br />
dell’avvento del MUSE”, un vero e proprio tabellone per il conto al<strong>la</strong> rovescia, che è<br />
stato rive<strong>la</strong>to, giorno dopo giorno, con l’aiuto dei passanti. Alle sei di sera di ogni<br />
giorno un suono – di animali, natura o strumenti tecnologici – annunciava lo<br />
sve<strong>la</strong>mento di una tessera del calendario e chi riusciva ad indovinarne l’origine poteva<br />
girare <strong>la</strong> casel<strong>la</strong> e partecipare ad un momento di condivisione collettiva, amplificato<br />
anche sui social media del museo. Infatti, tutti i partecipanti al gioco offline sono<br />
stati fotografati e sono entrati a far parte di una gallery su Facebook e sul profilo<br />
Pinterest del museo, creando un interessante fenomeno virale di condivisione delle<br />
immagini e di attenzione costante, proiettata sul conto al<strong>la</strong> rovescia per l’apertura<br />
del<strong>la</strong> nuova sede del MUSE.
Nel complesso, tutti i musei intervistati dichiarano di “non fare abbastanza” per<br />
l’integrazione dei social media nelle gallerie, dimostrando quanto questi strumenti<br />
fatichino ancora a trovare il loro posto all’interno dell’istituzionalità del museo.<br />
<strong>Comunicare</strong> <strong>la</strong> presenza social è importante, tuttavia, e mostre e collezioni offrono<br />
opportunità enormi per andare oltre al<strong>la</strong> semplice promozione di queste piattaforme e<br />
per coinvolgere i visitatori negli spazi, incoraggiandoli a guardare più da vicino<br />
l’ambiente e gli oggetti che li circondano.<br />
5. Evaluation dei dati<br />
Come si fa a capire se i social network “funzionano”? Da cosa dipende il successo<br />
sui canali <strong>online</strong> e come andare incontro alle aspettative e alle richieste del<strong>la</strong><br />
direzione del museo?<br />
L’evaluation dovrebbe qualificarsi come uno step fondamentale di qualsiasi progetto,<br />
digitale e non. In un contesto in cui le istituzioni <strong>la</strong>vorano sempre di più “a progetto”<br />
e sono vinco<strong>la</strong>te da finanziamenti a singhiozzo e contratti a tempo determinato,<br />
l’approccio standard vuole che, una volta terminato un progetto, si passi<br />
immediatamente a quello successivo. A conclusione di una mostra, un evento o una<br />
campagna <strong>online</strong>, l’attività di evaluation, ossia <strong>la</strong> valutazione dei dati, dovrebbe essere<br />
parte fondante dell’iter da percorrere, soprattutto considerando che i dati raccolti<br />
possono servire come base di partenza per il progetto successivo.<br />
L’evaluation nei confronti dell’attività sui social media non ha ancora un ruolo solido<br />
e definito tra i musei che abbiamo intervistato.<br />
Spesso, <strong>la</strong> natura “sperimentale” di molti progetti social non <strong>la</strong>scia il tempo o non<br />
genera <strong>la</strong> consapevolezza necessaria per una riflessione in questo senso.<br />
L’attività di valutazione dei dati, infatti, necessita di un pensiero più strutturato, in<br />
quanto operazione “invisibile”, percepita come meno importante, soprattutto in<br />
contesti in cui le risorse in termini di denaro e tempo sono scarse.<br />
Le cause possono essere diverse. La prima è, spesso, <strong>la</strong> mancanza di consapevolezza<br />
rispetto a cosa misurare per valutare il successo (numero di like? numero di<br />
amici? qualità dei commenti e delle interazioni?). Inoltre, <strong>la</strong> mancanza di<br />
orientamento rispetto al<strong>la</strong> miriade di strumenti a basso costo che permettono di<br />
gestire e valutare <strong>la</strong> presenza <strong>online</strong> costituisce un ulteriore deterrente. Nonostante <strong>la</strong><br />
maggior parte di queste piattaforme offra alcuni servizi gratuiti che consentono di<br />
gestire le metriche base, accedere a quelli che consentono un’analisi approfondita può<br />
comportare una spesa onerosa.<br />
Mentre nel settore profit questo tipo di reportistica è un pre-requisito fondamentale
per tenere sotto controllo andamenti, trend e soprattutto ritorno economico, il settore<br />
no-profit è ancora titubante.<br />
La maggior parte dei musei intervistati produce, in un modo o nell’altro, report<br />
contenenti i risultati dell’attività social sui vari canali. Gli strumenti utilizzati sono<br />
spesso HootSuite e Tweet Deck, tuttavia si nota come l’uso di questi strumenti sia<br />
limitato e sia ancora impossibile tenere traccia dei dati qualitativi (il tono positivo di<br />
un commento, per esempio) se non attraverso <strong>la</strong> registrazione manuale di determinate<br />
risposte ai post su spreadsheet in Excel o tramite <strong>la</strong> creazione di Storify.<br />
Quasi tutti i musei intervistati, tuttavia, comprendono l’importanza dell’evaluation,<br />
soprattutto per generare consapevolezza del valore dell’attività social all’interno<br />
del museo .<br />
Tra i musei italiani, un caso di eccellenza in questo campo è Pa<strong>la</strong>zzo Madama, che<br />
integra<br />
l’evaluation all’interno dei propri progetti come momento fondamentale, svolgendo<br />
analisi su metriche definite per il prima, il durante e il dopo. In questo modo, <strong>la</strong><br />
valutazione dell’attività social “par<strong>la</strong>” con le altre fasi del progetto, elevando l’attività<br />
<strong>online</strong> a parte integrante dell’attività del museo.<br />
Carlotta Margarone – Digital Media Curator a Pa<strong>la</strong>zzo Madama – inoltre, condivide i<br />
risultati del <strong>la</strong>voro sui social media a diversi livelli: crea report mensili e semestrali<br />
sull’attività <strong>online</strong> per <strong>la</strong> direzione del museo e per gli altri dipartimenti interni, ma<br />
anche per l’esterno, riportando in conferenze sul tema del digitale gli obiettivi, i<br />
risultati e i dati re<strong>la</strong>tivi alle singole iniziative (un caso su tutti è quello del<strong>la</strong> campagna<br />
#CupForFunds).<br />
È da notare come, nello strutturare report che raccontino e traccino l’attività <strong>online</strong><br />
del museo, sia spesso necessario usare un linguaggio che sia comprensibile dal<strong>la</strong><br />
direzione dell’istituzione. Non tutto lo staff del museo, infatti, utilizza Twitter o sa<br />
cosa sia Instagram, quindi includere screenshot e “tradurre” i termini in modo che<br />
siano accessibili a tutti fa parte del processo di sensibilizzazione e legittimazione di<br />
questi strumenti.<br />
Al National Museum of Women in the Arts, <strong>la</strong> valutazione del <strong>la</strong>voro sui social media<br />
è inserita all’interno delle attività di evaluation su mostre e programmi.<br />
Partico<strong>la</strong>rmente interessante è il caso delle Smithsonian Libraries, le quali hanno<br />
acquistato un servizio specifico – Union Metrics – per <strong>la</strong> valutazione dell’account<br />
Tumblr che consente di tracciare non solo il numero di utenti, ma anche come questi<br />
siano collegati tra loro. In questo senso, l’istituzione analizza <strong>la</strong> propria audience<br />
potenziale, oltre a quel<strong>la</strong> reale, andando a comprendere in quali community i propri<br />
follower sono inseriti.
6. Consigli per un museo alle prime armi<br />
I suggerimenti che siamo riusciti a raccogliere durante le interviste sono stati<br />
piuttosto diversificati e comprendono un ampio raggio di azioni possibili e<br />
consigliate.<br />
I consigli ricorrenti possono essere riassunti in questa lista:<br />
– Conoscere da chi è composto il proprio pubblico e sapere su quali<br />
piattaforme si trova;<br />
– E<strong>la</strong>borare una strategia ponendosi le giuste domande;<br />
– Non avere paura di sperimentare: ci sono molti strumenti per<br />
valutare cosa è andato bene e cosa invece male per ogni progetto;<br />
– Scegliere accuratamente le piattaforme su cui essere presenti, meglio<br />
poche ma utili per il raggiungimento del target ricercato;<br />
– Trovare il tono di voce più adatto all’istituzione.<br />
Tutte le maggiori istituzioni contattate colgono l’occasione per focalizzare buona<br />
parte dei loro suggerimenti sull’importanza del<strong>la</strong> pianificazione, del<strong>la</strong> conoscenza dei<br />
propri pubblici e di quali piattaforme o social network essi preferiscano. È<br />
un’operazione preliminare considerata fondamentale da tutti i musei intervistati.<br />
Alcune istituzioni – come lo Statens Museum, National Museum of Women in the<br />
Arts e le Smithsonian Libraries – hanno posto l’accento anche sul<strong>la</strong> necessità di<br />
intraprendere una social media strategy solo in presenza di personale altamente<br />
motivato e disponibile (soprattutto al<strong>la</strong> flessibilità oraria e al<strong>la</strong> ridefinizione dei<br />
propri incarichi e mansioni) e di spiegare gli obiettivi e le modalità di raggiungimento<br />
di questi obiettivi al<strong>la</strong> maggior parte delle persone possibile all’interno del museo, in<br />
maniera che tutti possano comprenderne i vantaggi e le opportunità (soprattutto<br />
coloro i quali hanno poteri decisionali e amministrativi).<br />
Un interessante focus del Rijksmuseum, invece, accende i riflettori sulle collezioni: il<br />
pubblico si aspetta dal museo storie uniche e interessanti. È questa una chiave di volta<br />
importantissima per creare engagement e fidelizzazione nel pubblico.
Anche per quanto riguarda i contenuti condivisi dall’istituzione sui social media, un<br />
consiglio ricorrente (v. Rijksmuseum e Horniman Museum) è di evitare post<br />
promozionali o commerciali: gli utenti sono bombardati da contenuti e informazioni<br />
e non si aspettano da un museo condivisioni marketing oriented.<br />
Certamente un altro suggerimento rilevante è contenuto nel<strong>la</strong> famosa frase: “Think<br />
big, start small, move fast”. Sono di questo avviso, ad esempio, Mar Dixon e Àlex<br />
Hinojo: <strong>la</strong> strategia digitale viene considerata da questi due professionisti come un<br />
elemento vivo e in continuo mutamento, perennemente al<strong>la</strong> ricerca dell’equilibrio<br />
perfetto e soggetto al<strong>la</strong> ridefinizione costante degli obiettivi e delle metodologie.<br />
Senza dubbio, un suggerimento interessante riguarda l’allineamento ai trend<br />
nazionali e internazionali: ad esempio, il DDR Museum consiglia di unirsi ad<br />
iniziative <strong>online</strong> internazionali e di ampio respiro; il National Museum of Women in<br />
the Arts si focalizza sul<strong>la</strong> ricerca e sullo studio delle strategie messe in pratica da<br />
istituzioni museali maggiormente attive sui social o che hanno attivato una digital<br />
strategy prima di noi; Smithsonian Libraries raccomanda di tenersi sempre informati<br />
sui trend <strong>online</strong> e offline del settore.<br />
L’ultimo punto che ci sembra meritevole di essere preso in considerazione sono le<br />
domande che un’istituzione <strong>cultura</strong>le deve porsi prima di pianificare, redigere e<br />
mettere in pratica una social media strategy.<br />
Tutti i musei intervistati concordano su quanto questo passaggio sia cruciale: se non ci<br />
si pone le domande giuste, si rischia di non ottenere i risultati che si desiderano.<br />
Inoltre, se si parte con una strategia digitale senza sapere dove voler arrivare,<br />
sicuramente si arriverà ad un risultato sbagliato o comunque diverso dalle nostre<br />
aspettative.<br />
Rientra tutto nel<strong>la</strong> grande e impegnativa attività del<strong>la</strong> programmazione preliminare di<br />
una digital strategy, ma domande quali “dov’è il mio pubblico?”, “chi è il mio<br />
pubblico?”, “quali risultati voglio ottenere?” e “attraverso quali strumenti<br />
raggiungo i miei obiettivi?” devono essere i primi quesiti che vengono in mente<br />
durante <strong>la</strong> progettazione di una strategia.<br />
In effetti – come ha affermato Adrian Murphy del Horniman Museum & Gardens – :<br />
“La tecnologia può fare tutto ciò che tu le dici di fare. Per questo motivo, bisogna<br />
essere sicuri che tu le stia dicendo di fare le cose giuste”.<br />
I musei che si sono confrontati con noi fino ad ora<br />
1.Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto – Mart
Abbiamo avuto il piacere di par<strong>la</strong>re con Luca Melchionna, Coordinatore del<strong>la</strong><br />
Comunicazione Digitale del Mart.<br />
L’istituzione è nata in due tempi, prima nel 1987 e poi nel 2002, nel<strong>la</strong> nuova sede di<br />
Rovereto disegnata da Mario Botta, e oggi si configura come uno dei musei di arte<br />
contemporanea più conosciuti in Italia.<br />
Il Mart detiene, inoltre, il primato di museo all’avanguardia per quanto riguarda <strong>la</strong><br />
comunicazione <strong>online</strong> e l’apertura al mondo digitale, posizionandosi ai primi posti per<br />
numero di follower sui principali social media e curando professionalmente le proprie<br />
attività di engagement.<br />
Il Mart è presente <strong>online</strong> sui seguenti canali:<br />
– sito web: http://www.mart.trento.it/<br />
– Facebook: https://www.facebook.com/martrovereto<br />
– Twitter: https://twitter.com/mart_museum<br />
– Google+: https://plus.google.com/u/0/+martrovereto/posts<br />
– LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/2235669<br />
– Pinterest: http://www.pinterest.com/martmuseum/<br />
– Flickr: https://www.flickr.com/photos/mart_museum/<br />
– YouTube: https://www.youtube.com/user/MartRovereto<br />
2. Museo delle Scienze di Trento – MUSE<br />
Abbiamo intervistato Elisa Tessaro, Referente web e social media, Sezione<br />
Comunicazione e Promozione del MUSE.<br />
Il Museo delle Scienze di Trento ha inaugurato <strong>la</strong> nuova sede, disegnata da Renzo<br />
Piano, a luglio del 2013 e in meno di un anno ha raggiunto cifre ragguardevoli, sia in<br />
termini di pubblico, sia in riferimento all’engagement digitale.<br />
Seguita da uno staff giovane e aperto al<strong>la</strong> sperimentazione, <strong>la</strong> comunicazione del<br />
museo sul web è stata improntata fin da subito al coinvolgimento del<strong>la</strong> community<br />
degli appassionati, al punto che <strong>la</strong> voce “Social Media” è presente nel menu in home<br />
page del sito, accompagnata dall’invito a partecipare al<strong>la</strong> vita del MUSE tramite i<br />
profili social.<br />
Il MUSE è presente <strong>online</strong> sui seguenti canali:<br />
– sito web: http://www.muse.it/<br />
– Facebook: https://www.facebook.com/musetrento<br />
– Twitter: https://twitter.com/MUSE_Trento
– Pinterest: http://www.pinterest.com/musemuseum/<br />
– YouTube: https://www.youtube.com/user/MUSETrento<br />
3. Museo Nazionale del<strong>la</strong> Scienza e del<strong>la</strong> Tecnologia “Leonardo da Vinci” di Mi<strong>la</strong>no –<br />
MUST<br />
Ha risposto alle nostre domande Paolo Cavallotti, Responsabile Internet e Media<br />
Interattivi del MUST.<br />
Quello di Mi<strong>la</strong>no è il più grande museo del<strong>la</strong> scienza e del<strong>la</strong> tecnologia in Italia ed è<br />
una struttura all’avanguardia per molti aspetti, a cominciare dal<strong>la</strong> mission, basata<br />
sull’apertura dell’istituzione al<strong>la</strong> discussione di temi scientifici, al<strong>la</strong> ricerca e<br />
all’impatto sul<strong>la</strong> società.<br />
Il MUST è stato uno dei primi musei nostrani a investire nel<strong>la</strong> ricerca interna per<br />
quanto riguarda lo sviluppo web e media e oggi tutte le sue attività si estendono sui<br />
canali digitali, in un processo di integrazione costante tra <strong>online</strong> e offline.<br />
Il MUST è presente <strong>online</strong> sui seguenti canali:<br />
– sito web: http://www.museoscienza.org/<br />
– Facebook: https://www.facebook.com/museoscienza<br />
– Twitter: https://twitter.com/Museoscienza/<br />
– YouTube: https://www.youtube.com/user/museoscienza<br />
4. Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze – MSN<br />
Ci ha raccontato <strong>la</strong> sua esperienza Alba Scarpellini, Responsabile Ufficio<br />
Comunicazione, Sviluppo e Organizzazione eventi al MSN.<br />
Fondato nel 1775 da Pietro Leopoldo di Lorena, il MSN è il più importante museo<br />
naturalistico italiano e uno tra i maggiori in Europa.<br />
Aperto a tutti fin dalle origini, il museo oggi ha fatto dell’apertura – al pubblico, alle<br />
novità, alle iniziative digitali – una propria caratteristica fondante. Molto attivo<br />
<strong>online</strong>, il MUST cura quotidianamente il rapporto di engagement con <strong>la</strong> propria<br />
community e non smette di sperimentare nuove piattaforme, da Second Life a<br />
Tumblr.<br />
Il MSN è presente <strong>online</strong> sui seguenti canali:
– sito web: http://www.msn.unifi.it/mdswitch.html<br />
– Facebook: https://www.facebook.com/museostorianaturalefirenze<br />
– Twitter: https://twitter.com/StoriaNaturale<br />
– YouTube: https://www.youtube.com/user/museostorianaturale1<br />
– Flickr: https://www.flickr.com/photos/museostorianaturalefirenze/<br />
– Foursquare: https://it.foursquare.com/storianaturale<br />
– Tumblr: http://dinosauricarneossafirenze.tumblr.com/,<br />
http://passaggioinindia.tumblr.com/<br />
– Yelp: http://www.yelp.com/biz/museo-di-geologia-e-paleontologiafirenze<br />
5. Pa<strong>la</strong>zzo Madama di Torino<br />
In re<strong>la</strong>zione con #svegliamuseo fin dagli inizi del progetto, ha par<strong>la</strong>to più volte con<br />
noi di digitale e musei Carlotta Margarone, Digital Media Curator di Pa<strong>la</strong>zzo Madama<br />
e Communication Manager presso Fondazione Torino Musei.<br />
Pa<strong>la</strong>zzo Madama appartiene sicuramente a quelle poche realtà museali italiane che si<br />
distinguono in quanto a creatività del<strong>la</strong> comunicazione <strong>online</strong>, abilità strategica<br />
nell’uso degli strumenti e capacità di essere presenti in maniera efficace su diverse<br />
piattaforme.<br />
Tra i protagonisti del<strong>la</strong> Museum Week a livello europeo e spesso presente a<br />
conferenze internazionali sui temi che riguardano il digitale in ambito <strong>cultura</strong>le,<br />
questo museo rappresenta un fiore all’occhiello per il nostro patrimonio <strong>cultura</strong>le<br />
<strong>online</strong> e segue al<strong>la</strong> lettera <strong>la</strong> propria mission – “farsi attraversare dai desideri del<br />
pubblico” – qualificandosi sempre di più come “museo aperto” da prendere a<br />
modello.<br />
Pa<strong>la</strong>zzo Madama è presente <strong>online</strong> sui seguenti canali:<br />
– sito web: http://www.pa<strong>la</strong>zzomadamatorino.it/index.php<br />
– Facebook: https://www.facebook.com/pa<strong>la</strong>zzomadamatorino<br />
– Twitter: https://twitter.com/pa<strong>la</strong>zzomadamato<br />
– Pinterest: http://www.pinterest.com/pa<strong>la</strong>zzomadama/<br />
– Instagram: http://instagram.com/pa<strong>la</strong>zzomadama<br />
– YouTube: https://www.youtube.com/user/pa<strong>la</strong>zzomadamatorino<br />
– Flickr: https://www.flickr.com/groups/pa<strong>la</strong>zzomadamatorino/<br />
– Foursquare: https://it.foursquare.com/v/pa<strong>la</strong>zzo-madama--museocivico-darte-antica/
– Spotify: http://open.spotify.com/user/pa<strong>la</strong>zzomadamato<br />
6. Museo Nazionale del Prado, Madrid<br />
Per il nostro primo sconfinamento oltralpe abbiamo avuto modo di intervistare Javier<br />
Pantoja Ferrari, Direttore del Dipartimento per i Servizi Web e <strong>la</strong> Comunicazione <strong>online</strong>.<br />
Nato come Gabinetto di Storia Naturale nel 1785 per impulso di Carlo III, il Prado è<br />
diventato, nel corso di due secoli, il museo per eccellenza per conoscere <strong>la</strong> storia del<strong>la</strong><br />
pittura spagno<strong>la</strong>.<br />
Oggi è primo in Spagna per numero di utenti sui maggiori social network, risultato di<br />
una illuminata apertura verso i maggiori trend internazionali nel campo del<strong>la</strong><br />
tecnologia e del<strong>la</strong> comunicazione museale, e un’attenzione verso l’integrazione dei<br />
percorsi museali e digitali.<br />
Il Prado è presente <strong>online</strong> sui seguenti canali:<br />
– sito web: http://www.museodelprado.es/<br />
– Facebook: https://www.facebook.com/museonacionaldelprado<br />
– Twitter: https://twitter.com/museodelprado<br />
– Pinterest: http://www.pinterest.com/museodelprado/<br />
– YouTube: http://www.youtube.com/museodelprado<br />
– Google+: https://plus.google.com/+MuseoNacionaldelPrado/about<br />
– Foursquare: https://es.foursquare.com/museodelprado<br />
7. Musei Cata<strong>la</strong>ni<br />
Da un interessante scambio di tweet è nata <strong>la</strong> nostra intervista a Àlex Hinojo, Cultural<br />
Sector Engager e promotore del progetto @Cata<strong>la</strong>nMuseums.<br />
Quel<strong>la</strong> dei musei del<strong>la</strong> Catalogna è una realtà frastagliata, divisa tra grandi musei,<br />
come il Museo Picasso di Barcellona, e piccole realtà, come <strong>la</strong> biblioteca locale di<br />
Roquetes, ma con un denominatore comune: il legame con il territorio e <strong>la</strong> storia del<strong>la</strong><br />
Catalogna.<br />
Per far fronte a questa disparità e moltitudine di voci, il progetto si proponeva di<br />
riunire gli sforzi di ognuno sotto un’egida “digitale” comune. Ad oggi, l’account<br />
Twitter del progetto ha cessato di essere attivo, essendo <strong>la</strong> sfida stata raccolta dai<br />
musei e portata avanti da loro.
Il progetto @Cata<strong>la</strong>nMuseums era presente <strong>online</strong> sui seguenti canali:<br />
– Twitter: https://twitter.com/Cata<strong>la</strong>nMuseums<br />
8. Statens Museum for Kunst, Copenhagen<br />
Una doppia intervista, questa, che ha visto <strong>la</strong> partecipazione di Merete Sanderhoff,<br />
Curatrice del Dipartimento Digital e Ricercatrice, e Sarah Grøn, Digital Editor.<br />
La Galleria Nazionale ospita <strong>la</strong> maggior collezione d’arte in Danimarca, nata nel 1521<br />
quando il re Christian II ricevette in dono da Albrecht Dürer “le più belle copie dei<br />
miei disegni”.<br />
Oggi quegli stessi disegni sono promossi sul web da un team giovane e ricco di ottime<br />
idee. E per quanto i canali social del SMK non abbiano ancora raggiunto grandi<br />
numeri, sono loro <strong>la</strong> forza trainante del<strong>la</strong> (neo-nata) rivoluzione digitale in<br />
Danimarca.<br />
Il SMK è presente <strong>online</strong> sui seguenti canali:<br />
– sito web: http://www.smk.dk/en/<br />
– Facebook: https://www.facebook.com/smk<br />
– Twitter: https://twitter.com/statensmuseum/<br />
– Instagram: http://instagram.com/statensmuseumforkunst<br />
– Pinterest: http://www.pinterest.com/statensmuseum/<br />
– YouTube: http://www.youtube.com/user/StatensMuseumfKunst<br />
– Google+: https://plus.google.com/+StatensMuseumforKunst/<br />
9. Museum of Art and History, Santa Cruz (CA)<br />
Abbiamo avuto il piacere di intervistare Elise Granata, Community Engagement &<br />
Marketing Associate.<br />
L’MAH nasce come museo di arte contemporanea ma con una mission ben precisa:<br />
quel<strong>la</strong> di essere un museo per il territorio e <strong>la</strong> comunità che lo popo<strong>la</strong>, con cui il<br />
museo interagisce costantemente e per il quale ha sviluppato mirati programmi<br />
didattici.<br />
Diretto da un nome come Nina Simon, autrice del volume “The Participatory<br />
Museum” e del popo<strong>la</strong>re blog “Museum 2.0”, l’MAH non può che essere un museo<br />
partico<strong>la</strong>rmente attento alle tematiche social e del<strong>la</strong> comunicazione <strong>online</strong>, figurando
tra i migliori esempi al mondo.<br />
L’MAH è presente <strong>online</strong> sui seguenti canali social:<br />
– sito web: http://www.santacruzmah.org/<br />
– Facebook: https://www.facebook.com/santacruzmah<br />
– Twitter: https://twitter.com/santacruzmah<br />
– Instagram: http://instagram.com/santacruzmah<br />
– Pinterest: http://www.pinterest.com/santacruzmah/<br />
– Vimeo: http://vimeo.com/santacruzmah<br />
– Flickr: https://www.flickr.com/photos/santacruzmah/<br />
10. Rijksmuseum, Amsterdam<br />
L’esperienza social del Rijksmuseum ci è stata presentata da Linda Volkers, Marketing<br />
Manager.<br />
Il museo o<strong>la</strong>ndese ha spesso cambiato sede e volto (architettonico), ma mai il cuore<br />
pulsante delle sue collezioni: l’arte e <strong>la</strong> storia del paese che lo ospita.<br />
Quello che ha fatto, però, è stato renderle accessibili ad un pubblico più vasto, il<br />
primo tra i musei del mondo ad aver digitalizzato oltre 150.000 opere e ad averle rese<br />
disponibili a tutti, senza vincoli, e modificabili. Non c’è bisogno di aggiungere che<br />
l’attenzione ai social e al<strong>la</strong> comunicazione va di pari passo.<br />
Il Rijksmuseum è presente <strong>online</strong> sui seguenti canali social:<br />
– sito web: https://www.rijksmuseum.nl/en<br />
– Facebook: https://www.facebook.com/rijksmuseum?fref=ts<br />
– Twitter: https://twitter.com/rijksmuseum<br />
– Instagram: http://instagram.com/rijksmuseum<br />
– Pinterest: http://www.pinterest.com/rijksmuseum/<br />
– YouTube: http://www.youtube.com/user/RijksmuseumAmsterdam<br />
11. DDR Museum, Berlino<br />
Intervista a Federica Felicetti, Social Media Manager italiana “adottata” dal museo<br />
tedesco.<br />
Un museo, questo, dal<strong>la</strong> mission ben precisa: quel<strong>la</strong> di raccontare Berlino all’epoca
del<strong>la</strong> Repubblica Democratica Tedesca (DDR – Deutsche Demokratische Republik).<br />
Oggi è uno dei musei più visitati del<strong>la</strong> città, in cui il visitatore è invitato a entrare in<br />
contatto diretto e fisico con le opere. Una difficoltà che <strong>online</strong> è stata superata<br />
tramite <strong>la</strong> partecipazione a mostre virtuali, per esempio, e un’attenta cura dei social,<br />
con risposte… in tempo reale!<br />
Il DDR Museum è presente <strong>online</strong> sui seguenti canali social:<br />
– sito web: http://www.ddr-museum.de/<br />
– Facebook: http://facebook.com/ddrmuseum<br />
– Twitter: https://twitter.com/ddrmuseum<br />
– Pinterest: http://www.pinterest.com/ddrmuseum/<br />
– YouTube: http://www.youtube.com/ddrmuseum<br />
– Google+: https://plus.google.com/+DDRMuseumBerlin<br />
12. Museo Nazionale delle Donne nell’Arte, Washington D.C.<br />
Nel<strong>la</strong> capitale americana abbiamo par<strong>la</strong>to con Laura Hoffmann, Digital Media<br />
Specialist.<br />
Grazie a lei abbiamo scoperto un museo forse “di nicchia” ma ricco di tematiche,<br />
artistiche e sociali, importanti per capire il ruolo delle donne nell’arte. Fondato nel<br />
1987, è l’unico grande museo nel mondo dedicato a questo tema e agli ideali ad esso<br />
connessi.<br />
La loro strategia social primaria? Agire trasversalmente sui vari dipartimenti del<br />
museo, coinvolgendo l’intero staff e riuscendo così a proporre contenuti sempre di<br />
qualità per il pubblico e sempre in linea con lo scopo dell’istituzione.<br />
Lo NMWA è presente <strong>online</strong> sui seguenti canali social:<br />
– sito web: http://www.nmwa.org/<br />
– Facebook: https://www.facebook.com/womeninthearts<br />
– Twitter: https://twitter.com/womeninthearts<br />
– Flickr: https://www.flickr.com/photos/womeninthearts/<br />
13. Mar Dixon – Culture Themes, UK<br />
Non un’istituzione museale vera e propria, ma un progetto dedicato al<strong>la</strong>
comunicazione <strong>cultura</strong>le e una mente dinamica dietro le sue molteplici diramazioni<br />
social: quel<strong>la</strong> di Mar Dixon, Audience Developer e Social Media Specialist.<br />
L’abbiamo intervistata e cercato di capire da dove nascono, a cosa servono, quale<br />
successo abbiano i numerosissimi hashtag a tema <strong>cultura</strong> che Mar promuove su<br />
Twitter (in partico<strong>la</strong>re). Uno fra tutti? #Museumweek.<br />
Mar è presente <strong>online</strong> sui seguenti canali social:<br />
– sito web: http://culturethemes.blogspot.it/<br />
– Twitter: https://twitter.com/CultureThemes<br />
14. Horniman Museum & Gardens, Londra<br />
Abbiamo avuto il piacere di chiacchierare con Adrian Murphy, Responsabile Digital e<br />
Marketing.<br />
Fondato nel 1860, il museo illustra, tramite gli oggetti, i manufatti e i campioni<br />
collezionati da Frederick John Horniman nel corso dei suoi numerosi viaggi, <strong>la</strong> storia<br />
naturale, sociale e artistica dei popoli del mondo.<br />
L’Horniman è una picco<strong>la</strong> star nel firmamento digitale grazie all’idea di raccontarsi<br />
sui social attraverso le immagini. La cifra stilistica del suo storytelling virtuale? Il<br />
bizzarro, l’inusuale, l’inaspettato, a volte persino l’estremo, basti pensare all’iniziativa<br />
di successo “Extreme Curator” con hashtag dedicato su Twitter. Apertosi<br />
precocemente al<strong>la</strong> comunicazione digitale e ai social media, l’Horniman è da sempre<br />
una fucina di idee e un punto di riferimento per molti.<br />
L’Horniman è presente <strong>online</strong> nei seguenti canali social:<br />
– sito web: http://www.horniman.ac.uk/<br />
– Facebook: https://www.facebook.com/hornimanmuseumandgardens<br />
– Twitter: https://twitter.com/HornimanMuseum<br />
– Instagram: http://instagram.com/hornimanmuseumgardens<br />
– Pinterest: http://www.pinterest.com/hornimanmuseum/<br />
– YouTube: http://www.youtube.com/user/horniman<br />
– Flickr: https://www.flickr.com/groups/horniman_museum/pool/<br />
– Tumblr: http://in-the-horniman.tumblr.com/<br />
15. Tate, Londra
Intervista corale a John Stack, Head of Digital; Rosie Cardiff, Senior Digital Producer;<br />
Elena Vil<strong>la</strong>espesa, Digital Analyst; Tijana Tasich, Web Producer.<br />
La Tate ospita <strong>la</strong> collezione nazionale di arte britannica dal 1500 ai giorni nostri,<br />
arricchita da opere internazionali sia moderne che contemporanee, spaziando da un<br />
quadro di Turner ad una fotografia di Henry Wessel, passando per <strong>la</strong> famosa<br />
“fontana” di Duchamp.<br />
Per capire quanto sia contemporaneo e digitale questo museo vi basti sapere che sul<strong>la</strong><br />
facciata del museo campeggia l’indirizzo web del sito ufficiale. E del digitale, al<strong>la</strong><br />
Tate, si vuole fare il connettore invisibile di ogni altra attività del museo – per ora, ci<br />
stanno riuscendo benissimo..<br />
La Tate è presente <strong>online</strong> sui seguenti canali social:<br />
– sito web: http://www.tate.org.uk/<br />
– Facebook: https://www.facebook.com/tategallery<br />
– Twitter: https://twitter.com/tate<br />
– YouTube: http://www.youtube.com/user/tate<br />
16. Smithsonian Libraries, Washington D.C.<br />
Le voci di Richard Naples, Scho<strong>la</strong>rly Communication & IT Support, e Keri Thompson,<br />
Web Services & Digital Library Digital Projects Librarian, ci hanno raccontato le<br />
Smithsonian Libraries dal<strong>la</strong> prospettiva digital.<br />
Qualche numero per imparare a conoscerle meglio: 20 biblioteche; 4.000 istituzioni<br />
servite in tutto il mondo; 2 milioni tra libri a stampa e manoscritti conservati.<br />
Ed un team associato ad ogni piattaforma social, attraverso cui le biblioteche si<br />
raccontano. Non avendo una collezione visitabile, libri e documenti si animano per il<br />
pubblico solo su Tumblr – nel senso che prendono davvero “vita” sul<strong>la</strong> piattaforma<br />
digitale (vedere per credere, per esempio, il faro che dice “I love you”).<br />
Le Smithsonian Libraries sono presenti <strong>online</strong> sui seguenti canali social:<br />
– sito web: http://library.si.edu/<br />
– Facebook: https://www.facebook.com/SmithsonianLibraries?ref=s<br />
– Twitter: https://twitter.com/SILibraries<br />
– Instagram: http://instagram.com/SILibraries<br />
– YouTube: http://www.youtube.com/user/SmithsonianLibraries<br />
– Tumblr: http://blog.library.si.edu/
17. Royal Ontario Museum, Toronto<br />
Abbiamo chiacchierato con Ryan Dodge, Social Media Coordinator del ROM di<br />
Toronto.<br />
Il ROM è uno dei maggiori musei al mondo di storia naturale: vi potete trovare<br />
dinosauri e samurai, ma anche <strong>la</strong> storia dettagliata del<strong>la</strong> colonizzazione del Canada.<br />
Da un punto di vista digital, l’era dei dinosauri è ormai un ricordo e il museo è<br />
<strong>la</strong>nciato verso nuove sperimentazioni, specialmente con canali meno usati dalle altre<br />
istituzioni e una maggiore integrazione tra <strong>online</strong> e onsite. Solo qui potete trovare gli<br />
account Twitter dei curatori stampati sul<strong>la</strong> mappa (cartacea) del museo.<br />
Il ROM è presente <strong>online</strong> sui seguenti canali social:<br />
– sito web: http://www.rom.on.ca/en<br />
– Facebook: https://www.facebook.com/royalontariomuseum<br />
– Twitter: https://twitter.com/ROMtoronto<br />
– Google+: https://plus.google.com/+royalontariomuseum
Gli autori di questo ebook<br />
#svegliamuseo team<br />
Francesca secondo Aurora<br />
Francesca De Gottardo è <strong>la</strong> fondatrice di #svegliamuseo, nonché sua assidua e<br />
infaticabile project manager.<br />
Laureata con successo in Egittologia prima e in Archeologia Funeraria poi, dopo <strong>la</strong><br />
<strong>la</strong>urea ha <strong>la</strong>vorato nell’editoria e delle fondazioni <strong>cultura</strong>li, per poi seguire un Master<br />
in Marketing e Comunicazione al<strong>la</strong> Bocconi. Da lì a social media manager per<br />
un’agenzia di comunicazione il passo è stato breve, come decidere di ripartire di<br />
nuovo da zero e vo<strong>la</strong>re a Washington, dove attualmente è visiting social media<br />
professional per lo Smithsonian Institution.<br />
La sua città natale, Pordenone, le è rimasta incol<strong>la</strong>ta addosso come un nome di<br />
battaglia, ma le sue battaglie ormai le combatte in tutto il mondo.<br />
http://bit.ly/LinkedIn-Francesca-De-Gottardo<br />
francescadegottardo@gmail.com<br />
Francesca ha co-ideato questo ebook e ne è stata <strong>la</strong> project manager. Ha curato in<br />
partico<strong>la</strong>re il capitolo sui social network (introduzione ai social media, Facebook, Twitter<br />
e Pinterest) e il capitolo su #svegliamuseo, co-editando il capitolo sulle interviste di<br />
#svegliamuseo.<br />
Alessandro secondo Valeria<br />
Alessandro D’Amore è membro del team di #svegliamuseo, in cui riveste il ruolo di<br />
storytelling expert. Da bravo archeologo, scava sotto le parole, gli oggetti e i luoghi –<br />
digitali e reali – e scova <strong>la</strong> poesia che si nasconde in ogni cosa.<br />
Laureato con lode in Archeologia, sta finendo un Master in Comunicazione e Nuovi<br />
Media e il suo percorso accademico è completato da un’esperienza solida e variegata<br />
in musei e istituzioni, tra cui il Museo di Stato del<strong>la</strong> Repubblica di San Marino.<br />
Dal Molise con furore, vive a Forlì ma sogna spesso di fuggire altrove.<br />
it.linkedin.com/pub/alessandro-d-amore/67/962/3b5
damore.ale@gmail.com<br />
Alessandro ha co-ideato questo ebook, ha curato il capitolo sullo storytelling e alcune<br />
parti del capitolo sulle interviste di #svegliamuseo.<br />
Valeria secondo Francesca<br />
Valeria Gasparotti è co-founder del canale <strong>Svegliamuseo</strong> On Air e project manager di<br />
#svegliamuseo, contribuendo al<strong>la</strong> sua definizione strategica e ai suoi sviluppi.<br />
È <strong>la</strong>ureata in Comunicazione e Gestione nei Mercati dell’Arte e del<strong>la</strong> Cultura e ha<br />
<strong>la</strong>vorato come addetta stampa per il Museo Nazionale del<strong>la</strong> Scienza e del<strong>la</strong><br />
Tecnologia “Leonardo da Vinci”. L’esperienza di un anno nel Dipartimento Strategie<br />
Mobili dello Smithsonian Institution ha ispirato e supportato <strong>la</strong> sua tesi di Master<br />
sull’interpretazione mobile nei musei. È attualmente project coordinator presso il<br />
National Museum of Natural History di Washington DC.<br />
Carrarina DOC, per quanto lo rinneghi, unisce un carattere di marmo a tutto il pepe<br />
di una rossa naturale.<br />
www.linkedin.com/in/valeriagasparotti<br />
valeria.gasparotti@gmail.com<br />
Per questo ebook, Valeria ha curato alcuni contenuti del capitolo sui social network<br />
(Instagram, Tumblr, Google+, iTunes U, Linkedin, Flickr e YouTube). Ha inoltre coeditato<br />
il capitolo sulle interviste di #svegliamuseo.<br />
Aurora secondo Alessandro<br />
Aurora Raimondi Cominesi è stata il primo membro di #svegliamuseo, braccio destro<br />
del capitano per i primi mesi e traduttrice compulsiva.<br />
Subito dopo <strong>la</strong> <strong>la</strong>urea in Archeologia e un tirocinio presso il Museo Archeologico di<br />
Cremona, è vo<strong>la</strong>ta a Los Angeles per <strong>la</strong>vorare al J. Paul Getty Museum come<br />
Curatorial Intern. Dalle riproduzioni è però voluta tornare alle ville pompeiane e ai<br />
loro affreschi: oggi <strong>la</strong>vora per <strong>la</strong> Fondazione Restoring Ancient Stabiae e vede il<br />
Vesuvio tutti i giorni.<br />
Se <strong>la</strong> volete conquistare (<strong>cultura</strong>lmente, s’intende), rega<strong>la</strong>tele una grammatica di una
lingua straniera che non conosce. Tipo lo swahili.<br />
it.linkedin.com/pub/aurora-raimondi-cominesi/22/985/957<br />
aurora_raimondi@hotmail.com<br />
Per questo ebook, Aurora ha curato le schede dei musei stranieri e ha co-editato il<br />
capitolo sulle interviste di #svegliamuseo.<br />
Con <strong>la</strong> preziosa col<strong>la</strong>borazione di<br />
Federico Giannini<br />
Federico Giannini è un web designer e web developer professionista, con una<br />
specifica formazione nell’ambito delle tecnologie web per i beni <strong>cultura</strong>li. In qualità<br />
di professionista del web, col<strong>la</strong>bora anche con alcuni musei nell’ambito dello sviluppo<br />
di tecnologie web.<br />
È <strong>la</strong>ureato con il massimo dei voti in Informatica Umanistica all’Università di Pisa, è<br />
tito<strong>la</strong>re di un’attività che si occupa di realizzazioni per il web e ha scritto alcuni saggi<br />
divulgativi di storia dell’arte.<br />
Svolge infatti anche l’attività di divulgatore: è l’ideatore e l’autore di “Finestre<br />
sull’Arte” (www.finestresul<strong>la</strong>rte.info), il più importante progetto italiano di<br />
divulgazione storico-artistica sul web.<br />
Abita a Carrara.<br />
https://www.linkedin.com/pub/federico-giannini/41/118/580<br />
posta@federicogiannini.com<br />
Per questo ebook, Federico ha curato il capitolo sul<strong>la</strong> progettazione di siti web per i musei.<br />
Pietro Colel<strong>la</strong><br />
Pietro Colel<strong>la</strong> è Digital Strategist & Analyst in Gummy Industries. Ha studiato<br />
Marketing Management da Bari a Brescia ed è appassionato di social media<br />
marketing, branding <strong>online</strong> e data analysis.<br />
In ufficio lo si vede spesso alle prese con grafici e fogli Excel ed è anche il
esponsabile ufficiale del<strong>la</strong> macchina del caffè e dell’advertising <strong>online</strong>.<br />
Iphone dipendente, trascorre il suo tempo libero ascoltando tanta musica elettronica e<br />
adora dilettarsi in cucina… rigorosamente pugliese!<br />
https://www.linkedin.com/in/pietrocolel<strong>la</strong><br />
pietro.colel<strong>la</strong>@gmail.com<br />
Per questo ebook, Pietro ha curato il capitolo sull’utilizzo degli analytics per misurare le<br />
performance dei musei <strong>online</strong>.<br />
Astrid D’Eredità<br />
Astrid D’Eredità è un’archeologa passata dalle trincee di scavo al<strong>la</strong> rete per occuparsi<br />
di social media e web content management. È consulente di diverse agenzie, tra cui<br />
Brand Portal e Manafactory, nel<strong>la</strong> cui crew ha raccontato l’edizione 2013 del Festival<br />
“Hai Paura del Buio?” degli Afterhours.<br />
Ha conseguito un PhD in Archeologia e una specializzazione in Museologia e<br />
Museografia ed è stata borsista del Centro Studi “Gianfranco Imperatori” di Civita.<br />
Nel tempo libero dal <strong>la</strong>vora come responsabile del<strong>la</strong> comunicazione dell’Associazione<br />
Nazionale Archeologi e dell’Orchestra di Piazza Vittorio, e instagramma con passione<br />
i Patulìdi, i suoi due incolpevoli gatti rossi.<br />
http://www.linkedin.com/in/astridderedita<br />
astrid.deredita@gmail.com<br />
Per questo ebook, Astrid ha curato alcuni contenuti del capitolo sui social network<br />
(YouTube, Foursquare e Tripadvisor).
Note<br />
1. http://www.4marketing.biz/2012/05/cose-lo-storytelling-sette-punti-percomprenderlo/#.U6VeU7F41q0<br />
2. http://electronicportfolios.com/digistory/<br />
3. Carson G., «The End of History Museums: What’s p<strong>la</strong>n B?», in The Public<br />
Historian, 30 (4), 2008, pp. 9 – 27.<br />
4. Weick, K.E., Sensemaking in Organizations, Sage, 1995.<br />
5. Josephs, C., «The Way of the S/Word: Storytelling as Emerging Liminal»,<br />
International Journal of Qualitative Studies in Education, 21(3), 2008, pp. 251-267.<br />
6. Mc Drury, J. and Alterio, M., Learning Through Storytelling in Higher Education,<br />
2003, London, Kogan Page.<br />
7. http://www.shackletongroup.com/en/portfolio?page=2<br />
8. Carson G., 2008.<br />
9. “Museum is a non-profit making, permanent institution in the service of society<br />
and of its development, and open to the public, which acquires, conserves, researches,<br />
communicates and exhibits, for purpose of study, education and enjoyment, material<br />
evidence of people and their environment.”<br />
10. Eco U., La Bustina di Minerva, Bompiani 2000.<br />
11. http://www.mestierediscrivere.com/articolo/letturaweb_nielsen<br />
12. Fisher M. et alii, The Art of Storytelling: Enriching Art Museum Exhibits and<br />
Education through Visitors Narratives, 2008.<br />
13. Il gestore di una fan page non può inviare un messaggio privato a un utente, ma
può rispondere a quelli che gli utenti inviano al<strong>la</strong> pagina.<br />
14. Clough, Dixie. You Tube and Video Strategy for museums – appuntamento<br />
<strong>Svegliamuseo</strong> on Air, 16 Giugno 2014 https://www.youtube.com/watch?<br />
v=8BZSUI2g2xg<br />
15. Smith, Koven. How can museums make memorable apps? Koven J. Smith Dot<br />
Com. 13 Luglio 2013 http://kovenjsmith.com/archives/1194<br />
16. Il prestigioso premio riconosce casi di eccellenza nell’ambito internet in diverse<br />
categorie: http://www.webbyawards.com/<br />
17. Ayeh J. H., Ahu N., Law R. (2013) “Do We Believe in TripAdvisor?” Examining<br />
Credibility Perceptions and Online Travelers’ Attitude toward Using User-Generated<br />
Content, Journal of Travel Research, <strong>online</strong> article, pp. 1-16<br />
18. O’Dell, Jolie. New Study Shows the Mobile Web Will Rule by 2015. 13 April<br />
2010. http://mashable.com/2010/04/13/mobile-web-stats/<br />
19. Cisco. Visual Networking Index. 5 February 2014.<br />
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/col<strong>la</strong>teral/service-provider/visual-networkingindex-vni/white_paper_c11-520862.html.