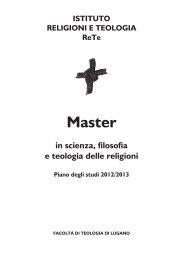Piano degli studi 2013/2014 - Facoltà di Teologia di Lugano
Piano degli studi 2013/2014 - Facoltà di Teologia di Lugano
Piano degli studi 2013/2014 - Facoltà di Teologia di Lugano
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
FACOLTÀ DI<br />
TEOLOGIA DI LUGANO<br />
<strong>Piano</strong> <strong>degli</strong> <strong>stu<strong>di</strong></strong><br />
<strong>2013</strong>/<strong>2014</strong><br />
www.teologialugano.ch
via Giuseppe Buffi 13 – Casella Postale 4663 – CH-6904 <strong>Lugano</strong><br />
Tel: +41-(0)58/6664555 – Fax: +41-(0)58/6664556<br />
info@teologialugano.ch<br />
www.teologialugano.ch
In<strong>di</strong>ce<br />
1. Presentazione della Facoltà <strong>di</strong> <strong>Teologia</strong> <strong>di</strong> <strong>Lugano</strong> ...............p. 6<br />
1.1. Attività d’insegnamento e <strong>di</strong> ricerca ..................................6<br />
1.2. Titoli rilasciati ...................................................7<br />
1.3. Convenzioni e collaborazioni .......................................8<br />
2. Autorità - Docenti - Amministrazione ............................9<br />
2.1. Gran Cancelliere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9<br />
2.2. Rettore, docenti, ricercatori e assistenti ...............................9<br />
2.3. Amministrazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11<br />
2.4. Il Servizio Qualità. ...............................................12<br />
2.5. Il Servizio Pari Opportunità. .......................................13<br />
3. Ricerca ....................................................14<br />
3.1. Introduzione ...................................................14<br />
3.2. Dipartimenti, istituti, cattedre e centri ...............................15<br />
3.2.1. Dipartimento <strong>di</strong> <strong>Teologia</strong> ......................................15<br />
3.2.1.1. Istituto <strong>di</strong> Storia della <strong>Teologia</strong> ...........................15<br />
3.2.1.2. Istituto <strong>di</strong> Cultura e Archeologia delle terre Bibliche (ISCAB). ...15<br />
3.2.1.3. Istituto Internazionale <strong>di</strong> Diritto Canonico<br />
e Diritto comparato delle Religioni (DiReCom) ..............16<br />
3.2.1.4. Istituto Religioni e <strong>Teologia</strong> (ReTe) ........................17<br />
3.2.1.5. Centro <strong>di</strong> <strong>stu<strong>di</strong></strong> Hans Urs von Balthasar ....................17<br />
3.2.2. Dipartimento <strong>di</strong> Filosofia. ......................................18<br />
3.2.2.1. Istituto <strong>di</strong> Stu<strong>di</strong> Filosofici (ISFI). ...........................18<br />
3.2.2.2. Cattedra Antonio Rosmini ...............................19<br />
3.3. Progetti .......................................................19<br />
3.3.1. Ricerche scientifiche in corso ...................................19<br />
3.3.2. Dottorati alla FTL ............................................19<br />
3.4. Commissione Ricerca ............................................20<br />
3.5. Strumenti. .....................................................20<br />
3.5.1. Biblioteca FTL ...............................................20<br />
3.5.2. Rivista Teologica <strong>di</strong> <strong>Lugano</strong> (RTLu). ..............................20<br />
3.5.3. Veritas et Jus. Semestrale inter<strong>di</strong>sciplinare <strong>di</strong> <strong>Lugano</strong>. ................21<br />
3.5.4. Eupress FTL ................................................22<br />
3.5.5. Altre collaborazioni e<strong>di</strong>toriali ...................................22<br />
3.5.6. Alcuni link utili alla ricerca. .....................................23<br />
Calendario accademico <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong><br />
Semestre autunnale <strong>2013</strong> .............................................24<br />
Semestre primaverile <strong>2014</strong> ...........................................26<br />
4. Ammissione, esami e tasse accademiche .........................28
4.1. Criteri <strong>di</strong> ammissione ............................................28<br />
4.2. Modalità d’iscrizione .............................................30<br />
4.3. Esami .........................................................31<br />
4.4. Tasse accademiche ..............................................33<br />
4.4.1. Studenti or<strong>di</strong>nari e straor<strong>di</strong>nari. .................................33<br />
4.4.2. Studenti u<strong>di</strong>tori .............................................33<br />
4.4.3. Tasse d’esami ...............................................33<br />
4.4.4. Rilascio documenti ...........................................34<br />
4.4.5. Sussi<strong>di</strong> e borse <strong>di</strong> <strong>stu<strong>di</strong></strong>o .......................................34<br />
5. Programma complessivo <strong>degli</strong> <strong>stu<strong>di</strong></strong> .............................35<br />
5.1. Presentazione <strong>degli</strong> <strong>stu<strong>di</strong></strong> teologici ..................................35<br />
5.1.1. Bachelor of Theology .........................................35<br />
5.1.2. Master of Theology/Baccellierato in <strong>Teologia</strong>. ......................35<br />
5.1.3. Licenza canonica in <strong>Teologia</strong>. ...................................36<br />
5.1.4. Dottorato in <strong>Teologia</strong> .........................................37<br />
5.2. Altri percorsi ...................................................37<br />
5.3. Presentazione dettagliata. .........................................38<br />
5.3.1. Vecchio or<strong>di</strong>namento (studenti immatricolati entro l’a.a. 2011/12) ......39<br />
5.3.1.1. Bachelor of Theology ....................................39<br />
5.3.1.2. Master of Theology/Baccellierato in <strong>Teologia</strong> ..................41<br />
5.3.2. Nuovo or<strong>di</strong>namento (studenti immatricolati a partire dall’a.a. 2012/13) ..44<br />
5.3.2.1. Bachelor of Theology in<strong>di</strong>rizzo teologico-filosofico ...............44<br />
5.3.2.2. Bachelor of Theology in<strong>di</strong>rizzo teologico ......................47<br />
5.3.2.3. Master of Theology .....................................49<br />
5.3.3. Corsi opzionali ..............................................51<br />
5.3.4. Seminari ...................................................54<br />
5.4. Ulteriore offerta formativa ........................................55<br />
5.4.1. Settimane inter<strong>di</strong>sciplinari <strong>di</strong> corsi intensivi ........................55<br />
5.4.2. Corsi serali .................................................55<br />
5.4.3. Summer School – Gerusalemme. ................................55<br />
5.5. Descrizione dei singoli corsi e seminari. ..............................57<br />
6. Informazioni varie ..........................................131<br />
6.1. Recapiti dei docenti, dei ricercatori e <strong>degli</strong> assistenti ...................131<br />
6.2. Associazione Alumni FTL ....................................... 133<br />
6.3. Associazione sostenitori .........................................134<br />
6.4. Offerte alla FTL ................................................134<br />
6.5. Seminari, Comunità, Convitti e altri alloggi per studenti della FTL. ........134<br />
6.6. Pastorale universitaria ...........................................136<br />
Orario semestre autunnale <strong>2013</strong> ......................................138<br />
Orario semestre primaverile <strong>2014</strong>. ....................................140<br />
In<strong>di</strong>ce dei nomi dei docenti, dei ricercatori e <strong>degli</strong> assistenti ..........142<br />
In<strong>di</strong>ce delle descrizioni dei corsi .................................144<br />
4
1. Presentazione della Facoltà <strong>di</strong> <strong>Teologia</strong> <strong>di</strong> <strong>Lugano</strong><br />
La Facoltà <strong>di</strong> <strong>Teologia</strong> <strong>di</strong> <strong>Lugano</strong> 1 è stata istituita il 20 novembre 1993 2 ed è la prima<br />
istituzione universitaria eretta in Ticino. Tra le ragioni della sua fondazione vi sono:<br />
«l’incremento della ricerca e l’insegnamento della filosofia e della teologia» e l’esigenza<br />
<strong>di</strong> dare risposta alle «istanze presenti nella società ticinese perché la Svizzera italiana<br />
sia dotata <strong>di</strong> istituzioni <strong>di</strong> livello universitario» 3 . Svolge sia insegnamento sia ricerca,<br />
inserendosi nell’offerta formativa superiore <strong>di</strong> tipo umanistico, in particolare in filosofia,<br />
teologia e scienze delle religioni. Le linee guida della FTL, che concretizzano obiettivi,<br />
collocamento accademico e sociale, punti fondamentali del proprio sviluppo e dell’offerta<br />
<strong>di</strong> <strong>stu<strong>di</strong></strong>o sono consultabili per esteso negli Statuti della FTL 4 e in versione parziale<br />
anche sul sito della Facoltà: www.teologialugano.ch.<br />
La FTL è persona giuri<strong>di</strong>ca a norma del Co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> Diritto Canonico (CJC, can. 113) 5 e<br />
svolge la sua attività in Svizzera.<br />
Nella legge sulla Chiesa cattolica il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino ha<br />
decretato tra l’altro che: «La Chiesa cattolica apostolica romana nel Cantone Ticino è<br />
una corporazione <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto pubblico nei limiti stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi» 6 e,<br />
inoltre, che «è riconosciuta la personalità giuri<strong>di</strong>ca <strong>degli</strong> Enti ecclesiastici eretti dall’Or<strong>di</strong>nario<br />
con statuti e regolamenti propri» 7 , come è il caso della FTL.<br />
La Fondazione “Vincenzo Molo”, costituita il 26 febbraio 1991 per curare il finanziamento<br />
della FTL 8 , è oggi una fondazione civile secondo il Co<strong>di</strong>ce Civile Svizzero e quin<strong>di</strong><br />
soggetta alla vigilanza dello Stato.<br />
Il 27 giugno <strong>2013</strong> la Conferenza Universitaria Svizzera (CUS) ha rinnovato l’accre<strong>di</strong>tamento<br />
alla FTL (già concesso una prima volta nel 2005), con vali<strong>di</strong>tà fino al 2020.<br />
1.1. Attività d’insegnamento e <strong>di</strong> ricerca<br />
L’offerta <strong>di</strong> insegnamento è regolata da norme precise, pubblicate nello Statuto della FTL<br />
(al titolo VI: Or<strong>di</strong>namento <strong>degli</strong> Stu<strong>di</strong> e nell’Ordo Stu<strong>di</strong>orum, al cap. 2 e nel Nuovo Statuto<br />
titolo IV soprattutto art. 35). Vi si stabiliscono, tra l’altro, la durata dei cicli <strong>di</strong> <strong>stu<strong>di</strong></strong>o, gli<br />
insegnamenti principali, il numero dei corsi a scelta e dei seminari richiesti. L’offerta <strong>di</strong><br />
tutti gli insegnamenti è pubblicata ogni anno nel <strong>Piano</strong> <strong>degli</strong> Stu<strong>di</strong>.<br />
La ricerca è promossa dalle seguenti istituzioni accademiche: Istituto <strong>di</strong> Stu<strong>di</strong> Filosofici<br />
1<br />
Di seguito FTL.<br />
2<br />
FTL, Statuti, Statuto, Introduzione, 1. Il Consiglio <strong>di</strong> Facoltà della FTL ha approvato in data 21.12.2011 un<br />
nuovo Statuto (d’ora in poi in<strong>di</strong>cato con Nuovo Statuto). Attualmente si è in attesa dell’approvazione <strong>di</strong> tale<br />
nuovo Statuto da parte dell’Autorità competente.<br />
3<br />
Ibidem.<br />
4<br />
In particolare nello Statuto, Introduzione e Titolo 1: Fine e costituzione della Facoltà.<br />
5<br />
FTL, Statuti, Statuto, art. 4.<br />
6<br />
Legge sulla Chiesa cattolica, art. 1.<br />
7<br />
Ivi, art. 21.<br />
8<br />
FTL, Statuti, Statuto, Introduzione.<br />
6
(ISFI); Istituto <strong>di</strong> Storia della <strong>Teologia</strong>; Istituto <strong>di</strong> Diritto canonico e <strong>di</strong>ritto comparato delle<br />
religioni (DiReCom); Istituto <strong>di</strong> Cultura e Archeologia delle terre Bibliche (ISCAB); Istituto Religioni<br />
e <strong>Teologia</strong> (ReTe); Centro <strong>di</strong> Stu<strong>di</strong> Hans Urs von Balthasar; Cattedra Antonio Rosmini.<br />
La FTL <strong>di</strong>spone della più ampia autonomia decisionale per quanto concerne insegnamento<br />
e ricerca. Ogni decisione in merito è infatti affidata al Consiglio <strong>di</strong> Facoltà, organo<br />
<strong>di</strong> <strong>di</strong>rezione della FTL, che si riunisce almeno due volte al semestre 9 .<br />
1.2. Titoli rilasciati<br />
L’offerta comprende 7 cicli <strong>di</strong> <strong>stu<strong>di</strong></strong>o:<br />
• Bachelor of Theology (B Th) della durata <strong>di</strong> 6 semestri per un totale <strong>di</strong> 180 ects;<br />
• Master of Theology (M Th) della durata <strong>di</strong> 4 semestri per un totale <strong>di</strong> 120 ects (Baccellierato<br />
in <strong>Teologia</strong>, grado accademico ecclesiastico, se preceduto dal Bachelor of<br />
Theology per un totale <strong>di</strong> 300 ects);<br />
• Licenza canonica in <strong>Teologia</strong> della durata <strong>di</strong> 4 semestri per un totale <strong>di</strong> 120 ects<br />
con le seguenti specializzazioni: <strong>Teologia</strong> Biblica, <strong>Teologia</strong> Dogmatica, <strong>Teologia</strong><br />
Morale e Storia della <strong>Teologia</strong> 10 ;<br />
• Dottorato in <strong>Teologia</strong> della durata <strong>di</strong> 4/6 semestri <strong>di</strong> ricerca scientifica, culminante<br />
nella elaborazione <strong>di</strong> una tesi scritta e la sua <strong>di</strong>fesa pubblica, nonché la sua pubblicazione<br />
11 ;<br />
• Master of Arts in Diritto canonico ed ecclesiastico comparato (Istituto Internazionale<br />
<strong>di</strong> Diritto canonico e Diritto comparato delle Religioni) della durata <strong>di</strong> 4 semestri<br />
per un totale <strong>di</strong> 120 ects con due <strong>di</strong>fferenti specializzazioni in Diritto comparato<br />
delle religioni e in Diritto canonico comparato;<br />
• Master of Arts in Scienza, filosofia e teologia delle religioni (Istituto Religioni e <strong>Teologia</strong>)<br />
della durata <strong>di</strong> 4 semestri per un totale <strong>di</strong> 120 ects;<br />
• Bachelor of Arts in Filosofia (Istituto <strong>di</strong> Stu<strong>di</strong> Filosofici) della durata <strong>di</strong> 6 semestri per<br />
un totale <strong>di</strong> 180 ects, con 6 <strong>di</strong>fferenti percorsi, 3 dei quali in collaborazione con<br />
la Facoltà <strong>di</strong> scienze della comunicazione della Università della Svizzera Italiana e<br />
1 percorso personalizzato me<strong>di</strong>ato con la Facoltà <strong>di</strong> scienze economiche sempre<br />
della USI. Dopo tale triennio è possibile accedere a master e lauree specialistiche<br />
sia alla FTL sia in altre Università (a seconda dell’in<strong>di</strong>rizzo scelto).<br />
Ad ognuno dei titoli sopradescritti, la FTL allega un Diploma supplement, secondo le modalità<br />
della Convenzione <strong>di</strong> Bologna, in italiano e in inglese. Si tratta <strong>di</strong> un modello europeo<br />
che presenta l’intero percorso seguito dallo studente, specificando durata e cre<strong>di</strong>ti<br />
del ciclo <strong>di</strong> <strong>stu<strong>di</strong></strong> concluso, nonché le competenza acquisite, in modo da permetterne la<br />
mobilità e facilitarne il riconoscimento interuniversitario.<br />
9<br />
FTL, Statuti, Statuto, Capitolo 4 art. 14 – Nuovo Statuto, titolo II cap. 1 pag. 3.<br />
10<br />
“La Licenza è il grado accademico che abilita all’insegnamento in un Seminario maggiore o in una scuola<br />
equivalente ed è perciò richiesto a tale fine” (Sapientia Christiana, art. 50, par. 1).<br />
11<br />
“Il Dottorato è il grado accademico, che abilita all’insegnamento in una Facoltà, ed è perciò richiesto a tale<br />
fine” (Sapientia Christiana, art. 50, par. 1). Sono ammessi al Dottorato in <strong>Teologia</strong> gli studenti che hanno<br />
conseguito la Licenza canonica in <strong>Teologia</strong> (Sapientia Christiana, art. 49, par. 2).<br />
7
1.3. Convenzioni e collaborazioni<br />
La FTL ha stipulato convenzioni con le seguenti istituzioni accademiche: Facoltà <strong>di</strong><br />
scienze della comunicazione dell’Università della Svizzera Italiana, Facoltà <strong>di</strong> <strong>Teologia</strong><br />
dell’Università <strong>di</strong> Friborgo (CH), Istituto <strong>di</strong> Diritto canonico della Facoltà <strong>di</strong> <strong>Teologia</strong><br />
dell’Università Cattolica <strong>di</strong> Vienna, Università Cattolica del Sacro Cuore <strong>di</strong> Milano, Facoltà<br />
Teologica <strong>di</strong> Sicilia San Giovanni Evangelista <strong>di</strong> Palermo, Facoltà <strong>di</strong> Diritto canonico<br />
della Pontificia Università Lateranense <strong>di</strong> Roma, Dipartimento <strong>di</strong> Filosofia della Facoltà<br />
<strong>di</strong> Lettere dell’Università <strong>di</strong> Ginevra, Stu<strong>di</strong>um Biblicum Franciscanum <strong>di</strong> Gerusalemme,<br />
Università <strong>di</strong> Silesia in Katowice (Polonia), Università <strong>di</strong> Bialystok (Polonia), Almo Collegio<br />
Borromeo (Pavia), Facoltà <strong>di</strong> <strong>Teologia</strong> Greco-Cattolica <strong>di</strong> Blaj-Alba (Romania),<br />
Scuola Universitaria <strong>di</strong> Musica del Conservatorio della Svizzera Italiana (CSI).<br />
A livello locale collabora con: il Museo delle Culture <strong>di</strong> <strong>Lugano</strong>, il Franklin College, la<br />
Fondazione per le Culture della Pace, SOS Ticino, il Dicastero Informazione e Integrazione<br />
Sociale della Città <strong>di</strong> <strong>Lugano</strong>, l’Associazione Biblioteca Salita dei Frati, il Centro<br />
<strong>stu<strong>di</strong></strong> Orizzonti filosofici <strong>di</strong> Locarno (ORFIL), la Società Teleserma srl. La6 TV <strong>di</strong> Varese.<br />
8
2. Autorità - Docenti - Amministrazione<br />
2.1. Gran Cancelliere<br />
S.E. Mons. Pier Giacomo Grampa, Vescovo <strong>di</strong> <strong>Lugano</strong><br />
Nello svolgere la sua funzione, il Gran Cancelliere è assistito dal Consiglio Superiore,<br />
che ha solo voce consultiva.<br />
Membri<br />
S. Em. Card. Gilberto Agustoni, Roma<br />
Mons. Oliviero Bernasconi, Delegato vescovile, Genestriero<br />
Prof. Dr. Azzolino Chiappini, <strong>Lugano</strong><br />
Prof. Dr. Libero Gerosa, <strong>Lugano</strong><br />
S. Em. Card. Franciszeck Macharski, Arcivescovo <strong>di</strong> Cracovia<br />
Can. Mons. Luigi Mazzetti, Rappresentante Capitolo Cattedrale <strong>di</strong> <strong>Lugano</strong><br />
Prof. Dr. Remigio Ratti, <strong>Lugano</strong><br />
S. Em. Card. Christoph Schönborn, Arcivescovo <strong>di</strong> Vienna<br />
S. Em. Card. Angelo Scola, Arcivescovo <strong>di</strong> Milano<br />
2.2. Rettore, docenti, ricercatori e assistenti 1<br />
Chiappini Azzolino, Rettore<br />
Professori or<strong>di</strong>nari:<br />
Chiappini Azzolino<br />
Gerosa Libero<br />
Hauke Manfred<br />
Jerumanis André-Marie<br />
Marabelli Costante<br />
Professori straor<strong>di</strong>nari:<br />
Krienke Markus<br />
Orsatti Mauro<br />
Paxima<strong>di</strong> Giorgio<br />
Sgubbi Giorgio<br />
Ventimiglia Giovanni<br />
Schmidbaur Hans Christian<br />
Professori associati:<br />
Lazzeri Valerio<br />
Professori emeriti:<br />
Biffi Inos<br />
Ciccone Lino<br />
1<br />
Le biografie complete dei docenti, dei ricercatori e <strong>degli</strong> assistenti si possono trovare all’in<strong>di</strong>rizzo:<br />
www.teologialugano.ch/docenti.php.<br />
9
Professori invitati:<br />
Arroba Conde Manuel Jesús<br />
Bassani Luigi Marco<br />
Corvi Roberta<br />
Diodato Roberto<br />
Ejeh Bene<strong>di</strong>ct<br />
Fabris Adriano<br />
Ferrari Silvio<br />
Francavilla Domenico<br />
Giordani Alessandro<br />
Gomarasca Paolo<br />
Imbach Rue<strong>di</strong><br />
Kenny Anthony<br />
Kukla Andrzej<br />
Docenti incaricati:<br />
Alborghetti Patrizio<br />
Battaglia Gino<br />
Bernasconi Rocco<br />
Calanchini Carlo<br />
Cattaneo Arturo<br />
Cattaneo Carlo<br />
de Petris Paolo<br />
Eisenring Gabriela<br />
Fidanzio Marcello<br />
Foglia<strong>di</strong>ni Emanuela<br />
Kiroulos Hani Bakhoum<br />
Laim Clau<strong>di</strong>o<br />
Corpo docenti interme<strong>di</strong>o:<br />
Bianchi Meda Letizia<br />
Di Marco Myriam Lucia<br />
Gagliano Gabriella<br />
Guerzoni Gianluca<br />
Ortelli Matasci Stefania<br />
Pacella Rosa Rita<br />
Laras Giuseppe<br />
Lenoci Michele<br />
Lottieri Carlo<br />
Mastromatteo Giuseppe<br />
Monceri Flavia<br />
Mulligan Kevin<br />
Musselli Luciano<br />
Negruzzo Simona<br />
Pacillo Vincenzo<br />
Perfetti Stefano<br />
Pighin Bruno Fabio<br />
Soldati Gianfranco<br />
Urbani Ulivi Lucia<br />
Lechner Jean-Claude<br />
Magarotto Varini Marina<br />
Manzi Franco<br />
Milani Clau<strong>di</strong>a<br />
Orelli Luisa<br />
Sala Maura<br />
Solo Darius Bamuene<br />
Tombolini Antonio<br />
Varsalona Agnese<br />
Violi Stefano<br />
Volonté Ernesto William<br />
Zanini Nicola<br />
Palese Alberto<br />
Pellicioli Linda<br />
Stabellini Andrea<br />
Ta<strong>di</strong>ni Samuele Francesco<br />
Zanar<strong>di</strong> Lan<strong>di</strong> Paola<br />
10
2.3. Amministrazione<br />
Segretario generale ed economo<br />
Riceve solo su appuntamento:<br />
Cristiano Robbiani Ufficio: 3.7 Tel.: 058 – 6664560<br />
E-mail: cristiano.robbiani@teologialugano.ch<br />
Segreteria del Rettore Ufficio: 3.4 Tel.: 058 – 6664551<br />
Per appuntamenti con il Rettore<br />
scrivere a: segreteria@teologialugano.ch<br />
Segreteria <strong>di</strong>dattica Ufficio: 3.4 Tel.: 058 – 6664555<br />
Lisa Costa Fazzi<br />
Orari <strong>di</strong> ricevimento:<br />
Da lunedì a venerdì: 09.15-10.30 / pomeriggio chiuso<br />
Immatricolazioni e situazione <strong>stu<strong>di</strong></strong>: su appuntamento<br />
E-mail: lisa.costa@teologialugano.ch<br />
Ricezione<br />
Sara Cascio Ufficio: 0.4.1 Tel.: 058 – 6664555<br />
Orari <strong>di</strong> sportello:<br />
Lunedì-Venerdì: 09.15-12.15/14.15-15.15 / mercoledì pomeriggio chiuso<br />
E-mail: sara.cascio@teologialugano.ch<br />
Segretaria istituto DiReCom<br />
Carla Fraioli Ufficio: 2.6.2 Tel.: 058 – 6664572<br />
E-mail: <strong>di</strong>recom@teologialugano.ch<br />
Orari <strong>di</strong> ricevimento:<br />
Martedì: 09.00-11.30/14.30-17.30<br />
Giovedì-Venerdì: 14.30-17.30<br />
Segretaria Istituto ISFI - Istituto <strong>di</strong> Stu<strong>di</strong> Filosofici<br />
Elena Vonzun Ufficio: 0.4.2 Tel.: 058 – 6664577<br />
E-mail: info@isfi.ch<br />
Orari <strong>di</strong> ricevimento:<br />
Lunedì e Martedì: 11.30-12.30<br />
Mercoledì, Giovedì e Venerdì: 09.00-10.00<br />
Segreteria Istituto ReTe<br />
E-mail: rete@teologialugano.ch Ufficio: 3.4 Tel.: 058 – 6664555<br />
Orari <strong>di</strong> ricevimento:<br />
Da Lunedì a venerdì: 09.15-10.30 / pomeriggio chiuso<br />
Immatricolazioni e situazione <strong>stu<strong>di</strong></strong>: su appuntamento<br />
E<strong>di</strong>toria<br />
Antonio Tombolini, <strong>di</strong>rettore e<strong>di</strong>toriale Ufficio: 2.3 Tel.: 058 – 6664559<br />
11
Salvatore Bellopede, redattore Ufficio: 3.8 Tel.: 058 – 6664553<br />
E-mail: eupress@teologialugano<br />
Collaboratori<br />
Gerardo ed Ester Mastropietro, custo<strong>di</strong> Tel.: 058 – 6664575<br />
2.4. Il Servizio Qualità<br />
Dall’a.a. 2001/2002, e specialmente in seguito all’Accre<strong>di</strong>tamento ricevuto dalla Conferenza<br />
Universitaria Svizzera il 24/2/2005, la FTL ha sviluppato in modo sempre più<br />
organico ed efficace un Sistema <strong>di</strong> Garanzia della Qualità (SGQ).<br />
Con SGQ si intende una strategia il cui scopo è la garanzia e il miglioramento continuo<br />
della qualità delle attività della FTL e, insieme, lo sviluppo <strong>di</strong> una cultura della qualità.<br />
Il SGQ riguarda anzitutto la <strong>di</strong>dattica e la ricerca e, inoltre, i servizi agli studenti, la comunicazione<br />
interna, le pari opportunità.<br />
Il SGQ è regolamentato, per ognuno dei settori in<strong>di</strong>cati, secondo processi definiti, approvati<br />
dalle autorità competenti della FTL, e pubblicati nelle Direttive interne d’accertamento<br />
della qualità della FTL, consultabili sul sito della FTL.<br />
La responsabilità del SGQ è <strong>di</strong> tutti i componenti della Facoltà. In particolare gli attori<br />
principali sono: il team del Servizio Qualità per la raccolta <strong>di</strong> dati e il supporto operativo;<br />
il Rettore e i Direttori dei Dipartimenti per l’interpretazione dei dati raccolti e<br />
le decisioni or<strong>di</strong>narie; il Consiglio <strong>di</strong> Facoltà e il Consiglio <strong>degli</strong> Stabili per le questioni<br />
decisionali rilevanti e straor<strong>di</strong>narie. Ciò significa, in altre parole, che le informazioni<br />
raccolte nei processi <strong>di</strong> valutazione da parte del Servizio Qualità sono interpretate e<br />
utilizzate sistematicamente a livello <strong>di</strong> decisioni strategiche da parte dei summenzionati<br />
organi <strong>di</strong>rettivi della FTL.<br />
Resoconti trasparenti sulle procedure e sui risultati delle valutazioni – nel rispetto dei dati<br />
personali e della reputazione delle persone – sono pubblicati ogni anno sul sito della FTL.<br />
Il SGQ è una strategia <strong>di</strong>namica in continuo miglioramento.<br />
Il Servizio Qualità della FTL si occupa principalmente della raccolta <strong>di</strong> dati e della documentazione<br />
dei processi, cercando <strong>di</strong> offrire alle autorità accademiche competenti un<br />
quadro coerente dell’istituzione nel suo insieme.<br />
Il Servizio Qualità della FTL è stato istituito con decisione del Consiglio <strong>di</strong> Facoltà (CdF)<br />
del 17/11/2004. Nel CdF del 18/04/2007 è stato costituito il team.<br />
Il Servizio Qualità collabora con l’analogo servizio dell’USI.<br />
E-mail: qualita@teologialugano.ch<br />
12
2.5. Il Servizio Pari Opportunità<br />
Tra gli in<strong>di</strong>ci della qualità <strong>di</strong> un’istituzione universitaria vi è la garanzia delle pari opportunità.<br />
Per questo motivo la FTL, con decisione del Consiglio <strong>di</strong> Facoltà del 12/3/2008,<br />
ha istituito il Servizio Pari Opportunità della FTL (SePO-FTL). Ne è responsabile Myriam<br />
Lucia Di Marco. Il SePO-FTL effettua perio<strong>di</strong>camente ricerche statistiche e/o sondaggi<br />
presso studenti, corpo docente e personale amministrativo, analizzando i risultati<br />
in particolare dal punto <strong>di</strong> vista del genere. Attraverso il SePO la FTL si propone <strong>di</strong><br />
monitorare dati sensibili come la rappresentanza femminile e maschile nei vari ambiti,<br />
la sod<strong>di</strong>sfazione relativamente ai servizi offerti, la qualità delle relazioni interpersonali<br />
e fra i generi, al fine <strong>di</strong> garantire un ambiente <strong>di</strong> <strong>stu<strong>di</strong></strong>o e <strong>di</strong> ricerca ottimale anche dal<br />
punto <strong>di</strong> vista delle pari opportunità.<br />
E-mail: qualita@teologialugano.ch<br />
13
3. Ricerca<br />
3.1. Introduzione<br />
La FTL svolge attività <strong>di</strong> ricerca e presta particolare attenzione a questo aspetto. Il<br />
tempo de<strong>di</strong>cato alla ricerca da parte <strong>di</strong> tutti i professori impiegati alla FTL è pari almeno<br />
al 30% del tempo complessivo <strong>di</strong> lavoro. Ogni professore stabile, infatti, non può insegnare<br />
per più <strong>di</strong> otto ore settimanali (sei se ricopre funzioni <strong>di</strong>rettive o amministrative):<br />
il motivo <strong>di</strong> tali restrizioni del carico della <strong>di</strong>dattica risiede precisamente nel dovere/<br />
<strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> ogni professore universitario <strong>di</strong> de<strong>di</strong>carsi alla ricerca.<br />
Alla FTL la ricerca viene promossa soprattutto, sebbene non esclusivamente, dagli istituti,<br />
dai centri e dalle cattedre, afferenti a loro volta al Dipartimento <strong>di</strong> <strong>Teologia</strong> e a<br />
quello <strong>di</strong> Filosofia. Tutti gli istituti della FTL svolgono attività <strong>di</strong> ricerca ed alcuni svolgono<br />
anche attività <strong>di</strong>dattica. Per tale motivo, in questo capitolo, vengono presentati gli<br />
istituti, i centri e le cattedre, con particolare riferimento alle loro attività <strong>di</strong> ricerca. Per<br />
quanto riguarda, invece, i bachelor e i master proposti da alcuni <strong>di</strong> essi, si rimanda ai<br />
rispettivi piani <strong>degli</strong> <strong>stu<strong>di</strong></strong>.<br />
Nella sezione «Progetti» vengono presentati più in dettaglio alcuni significativi progetti<br />
<strong>di</strong> ricerca in corso alla FTL e alcuni progetti conclusi, insieme al numero delle tesi<br />
<strong>di</strong> Dottorato rilasciate e in corso. La ricerca che si svolge in FTL è finanziata sia dalla<br />
stessa Facoltà che da istituzioni esterne. La FTL utilizza il budget destinato alla ricerca<br />
soprattutto per la pubblicazione dei saggi dei docenti, risultato delle loro ricerche, per i<br />
workshops <strong>di</strong> ricerca e per il sostegno finanziario <strong>di</strong> giovani assistenti e ricercatori.<br />
Per quanto riguarda le istituzioni esterne si segnala il finanziamento da parte della Unione<br />
Europea <strong>di</strong> «Ethicbots», programma <strong>di</strong> ricerca internazionale e inter<strong>di</strong>sciplinare che<br />
ha coinvolto l’Istituto <strong>di</strong> Filosofia Applicata (ora Istituto <strong>di</strong> Stu<strong>di</strong> Filosofici) della FTL, insieme<br />
ad altre prestigiose Università europee 1 . Inoltre, il Fondo Nazionale Svizzero per la<br />
ricerca (SNF) ha finanziato il Convegno Internazionale «Giovanni Paolo II. Legislatore<br />
della Chiesa. Fondamenti, innovazioni e aperture», organizzato dall’Istituto DiReCom<br />
della FTL. È in valutazione un progetto per una “ricerca in<strong>di</strong>pendente” presso l’SNF.<br />
La ricerca della FTL viene finanziata anche da Fondazioni private, come per esempio<br />
la Fondazione Pica-Alfieri, la Fondazione Reginaldus, la Fondazione Maderni-Alberga e<br />
altre.<br />
1<br />
Ethicbots, acronimo del progetto <strong>di</strong> ricerca Emerging Technoethics of Human Interaction with Communication,<br />
Bionic, and robOTic systems ha visto coinvolte, insieme all’Istituto <strong>di</strong> Filosofia applicata della FTL (ora<br />
Istituto <strong>di</strong> Stu<strong>di</strong> filosofici), le seguenti istituzioni: Università “Federico II” <strong>di</strong> Napoli, Dipartimento <strong>di</strong> Scienze<br />
fisiche e Dipartimento <strong>di</strong> Informatica e Sistemistica, Italia; Fraunhofer Institute for Autonomous intelligent<br />
Systems, Sankt Augustin, Germania; Scuola <strong>di</strong> Robotica, Genova, Italia; University of Rea<strong>di</strong>ng, Department<br />
of Cybernetics, Inghilterra; Hochschule der Me<strong>di</strong>en University of Applied Sciences, Stuttgart, Germania;<br />
LAAS-CNRS, Toulouse, Francia; Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa, Italia; Università <strong>di</strong> Pisa, Dipartimento <strong>di</strong><br />
Filosofia, Italia; Middlesex University, Interaction Design Centre, School of Computing, London, Inghilterra.<br />
14
3.2. Dipartimenti, istituti, cattedre e centri<br />
3.2.1. Dipartimento <strong>di</strong> <strong>Teologia</strong><br />
Diretto dal Rettore della FTL, il Dipartimento <strong>di</strong> <strong>Teologia</strong> comprende quattro Istituti:<br />
l’Istituto <strong>di</strong> Storia della <strong>Teologia</strong>; l’Istituto <strong>di</strong> Cultura e Archeologia delle terre Bibliche;<br />
l’Istituto Internazionale <strong>di</strong> Diritto Canonico e Diritto Comparato delle Religioni; l’Istituto<br />
Religioni e <strong>Teologia</strong>; il Centro <strong>di</strong> Stu<strong>di</strong> Hans Urs von Balthasar.<br />
3.2.1.1. Istituto <strong>di</strong> Storia della <strong>Teologia</strong><br />
Identità e finalità – Il presente Istituto, creato nella Facoltà <strong>di</strong> <strong>Teologia</strong> <strong>di</strong> <strong>Lugano</strong>, ha<br />
come proprio fine la promozione dello <strong>stu<strong>di</strong></strong>o della teologia e contribuisce, in questo<br />
specifico ambito del sapere teologico, a qualificare l’insegnamento e la ricerca scientifica<br />
della stessa Facoltà. Esso fa oggetto particolare del proprio interesse la figura, il<br />
metodo, il linguaggio, la sistemazione del sapere teologico in relazione alle varie epoche<br />
della storia. Con ciò intende mettere in luce il carattere storico della teologia e insieme<br />
rispondere alle <strong>di</strong>rettive conciliari e postconciliari circa un insegnamento delle <strong>di</strong>scipline<br />
teologiche attento alla <strong>di</strong>mensione della storicità.<br />
Servizio <strong>di</strong>dattico-formativo – Il contributo dell’Istituto alla <strong>di</strong>dattica della Facoltà in or<strong>di</strong>ne<br />
alla storia della teologia consiste:<br />
1. nell’assicurare l’insegnamento istituzionale nel primo ciclo<br />
2. nell’organizzare corsi e seminari <strong>di</strong> specializzazione nel ciclo <strong>di</strong> Licenza<br />
3. nell’assistere la ricerca dei dottoran<strong>di</strong>.<br />
Servizio scientifico – Oltre l’aspetto <strong>di</strong>dattico, l’Istituto concepisce il proprio servizio alla<br />
Facoltà soprattutto come impegno nella promozione della ricerca specializzata e nella<br />
<strong>di</strong>vulgazione dei suoi risultati. Questo servizio comporta:<br />
1. l’attivazione <strong>di</strong> una propria produzione scientifica;<br />
2. la promozione e l’organizzazione, con una certa perio<strong>di</strong>cità, <strong>di</strong> incontri e/o colloqui<br />
tra specialisti;<br />
3. il sostegno alla cooperazione scientifica stabile con altre facoltà, università, istituti o<br />
centri <strong>di</strong> ricerca de<strong>di</strong>ti allo <strong>stu<strong>di</strong></strong>o della storia della teologia.<br />
Sotto questo ultimo profilo, l’Istituto può già contare, all’atto della sua fondazione, su <strong>di</strong><br />
un rapporto privilegiato con l’Istituto per la Storia della <strong>Teologia</strong> Me<strong>di</strong>evale <strong>di</strong> Milano.<br />
Organizzazione – L’Istituto <strong>di</strong> Storia della <strong>Teologia</strong> ha un suo statuto ed è finanziato<br />
autonomamente e <strong>di</strong>retto dal Prof. Dr. Inos Biffi.<br />
3.2.1.2. Istituto <strong>di</strong> Cultura e Archeologia delle terre Bibliche (ISCAB)<br />
L’Istituto <strong>di</strong> Cultura e Archeologia delle terre Bibliche (ISCAB) nasce dall’esperienza<br />
dei «Convegni Terra Sancta» che, a partire dal 2008 hanno riunito presso la FTL numerosi<br />
<strong>stu<strong>di</strong></strong>osi <strong>di</strong> fama internazionale attorno a soggetti riguardanti il mondo biblico<br />
particolarmente dal punto <strong>di</strong> vista archeologico. L’Istituto si propone <strong>di</strong> organizzare<br />
attività <strong>di</strong>dattiche e <strong>di</strong> ricerca centrate sull’interesse per il testo biblico visto nel suo<br />
contesto archeologico e più generalmente culturale. Una particolare attenzione viene<br />
posta alla <strong>di</strong>mensione ermeneutica dell’archeologia, aperta alla <strong>di</strong>mensione sopran-<br />
15
naturale ed alla particolare natura dell’evento religioso biblico come avvenimento<br />
storico. Nell’Anno Accademico <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong> l’Istituto è impegnato nella preparazione e<br />
nella realizzazione del IV «Convegno Terra Sancta» e nella precisazione delle proprie<br />
iniziative e<strong>di</strong>toriali e <strong>di</strong> ricerca. Nel semestre invernale verrà offerto un corso intensivo<br />
in blocco <strong>di</strong> critica testuale, aperto anche a studenti <strong>di</strong> altre Facoltà. Attività precipua<br />
dell’Istituto è inoltre l’organizzazione dei corsi estivi <strong>di</strong> archeologia e <strong>di</strong> ebraico<br />
biblico, che si svolgono ogni anno durante il mese <strong>di</strong> luglio (per ulteriori informazioni:<br />
www.corsiagerusalemme.org). Nell’attesa <strong>di</strong> una più precisa definizione <strong>degli</strong> statuti<br />
e dell’organigramma, l’Istituto è <strong>di</strong>retto ad interim dal Prof. Dr. Giorgio Paxima<strong>di</strong>,<br />
docente or<strong>di</strong>nario <strong>di</strong> Esegesi dell’Antico Testamento.<br />
3.2.1.3. Istituto Internazionale <strong>di</strong> Diritto Canonico e Diritto comparato delle Religioni<br />
(DiReCom)<br />
Identità e finalità – All’inizio dell’anno accademico 2001-2002, anno del trasferimento<br />
della FTL nel Campus dell’USI, viene eretto presso la FTL l’Istituto Internazionale <strong>di</strong><br />
Diritto Canonico e Diritto Comparato delle Religioni. Esso intende offrire a tutti i suoi<br />
studenti ed in particolare a quelli delle Chiese in Svizzera e nell’Insubria, la possibilità <strong>di</strong><br />
una formazione scientifica in Diritto canonico comparato, Diritto ecclesiastico e Diritto<br />
comparato delle religioni. Didattica e ricerca scientifica si ispirano sia all’insegnamento<br />
del Concilio Vaticano II, secondo cui «nell’esposizione del Diritto Canonico» si deve<br />
tener «presente il mistero della Chiesa, secondo la costituzione dogmatica De Ecclesia»<br />
(OT 16.4); sia a quello del Magistero Pontificio più recente, in particolare <strong>di</strong> Papa Benedetto<br />
XVI circa la necessità <strong>di</strong> riscoprire il ruolo del <strong>di</strong>ritto naturale nell’analisi giuri<strong>di</strong>ca<br />
comparata dei <strong>di</strong>versi sistemi giuri<strong>di</strong>ci religiosi.<br />
Servizio <strong>di</strong>dattico-scientifico – Il contributo dell’Istituto DiReCom all’attività <strong>di</strong>dattica e<br />
scientifica della FTL in or<strong>di</strong>ne allo <strong>stu<strong>di</strong></strong>o del Diritto canonico e Diritto ecclesiastico<br />
consiste:<br />
1. Nell’assicurare l’insegnamento istituzionale nei <strong>di</strong>versi cicli <strong>di</strong> <strong>stu<strong>di</strong></strong>o della FTL;<br />
2. Nel promuovere lo <strong>stu<strong>di</strong></strong>o del Diritto canonico (sia latino che orientale), del Diritto<br />
ecclesiastico e del Diritto comparato delle religioni con Master specifico;<br />
3. Nel promuovere la ricerca scientifica nelle <strong>di</strong>scipline elencate.<br />
Collaborazioni accademiche – Per raggiungere i suoi scopi l’Istituto DiReCom favorisce<br />
la cooperazione stabile con altre facoltà e università, in particolare con istituti <strong>di</strong> ricerca<br />
nel campo del Diritto Canonico della Facoltà <strong>di</strong> <strong>Teologia</strong> dell’Università Statale <strong>di</strong> Vienna.<br />
Il 17 maggio 2002 è stata firmata a Vienna una convenzione <strong>di</strong> collaborazione nel<br />
campo della ricerca scientifica fra DiReCom e l’Istituto <strong>di</strong> Diritto Canonico della Facoltà<br />
<strong>di</strong> <strong>Teologia</strong> dell’Università Statale <strong>di</strong> Vienna. In data 8 aprile 2011 l’Istituto DiReCom<br />
della FTL ha stipulato una convenzione con l’Almo Collegio Borromeo <strong>di</strong> Pavia ai fini<br />
<strong>di</strong> organizzare una stabile collaborazione accademica nella ricerca e nella formazione<br />
post-laurea relative all’attualità dell’umanesimo cristiano per un corretto approccio delle<br />
questioni etiche e giuri<strong>di</strong>che poste dalla società contemporanea. Inoltre, nel campo<br />
della <strong>di</strong>dattica, dal 2007 in poi grazie ad accor<strong>di</strong> raggiunti con alcune Facoltà <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto<br />
canonico, gli studenti che hanno conseguito presso l’Istituto DiReCom il Master in Diritto<br />
16
canonico ed ecclesiastico comparato, in<strong>di</strong>rizzo: Diritto canonico comparato, possono –<br />
dai rispettivi decani – essere iscritti al terzo anno <strong>di</strong> Licenza in <strong>di</strong>ritto canonico.<br />
Organizzazione – L’Istituto DiReCom della FTL ha un suo statuto ed è finanziato autonomamente.<br />
Fondatore e Direttore dell’Istituto: Prof. Dr. Libero Gerosa.<br />
Per richiedere il <strong>Piano</strong> <strong>degli</strong> <strong>stu<strong>di</strong></strong> del Master e per qualsiasi altra informazione rivolgersi a:<br />
Segreteria dell’Istituto DiReCom<br />
Tel.: +41-(0)58/6664572; Fax: +41-(0)58/6664556<br />
E-mail: <strong>di</strong>recom@teologialugano.ch<br />
Internet: www.teologialugano.ch/<strong>di</strong>recom.php<br />
3.2.1.4. Istituto Religioni e <strong>Teologia</strong> (ReTe)<br />
Identità e finalità – L’Istituto Religioni e <strong>Teologia</strong> (ReTe) è stato eretto nel 2007 sulle<br />
basi del precedente Centro <strong>di</strong> <strong>Teologia</strong> ecumenica. Esso è nato allo scopo <strong>di</strong> promuovere<br />
ricerche e <strong>stu<strong>di</strong></strong> qualificati sui <strong>di</strong>versi mon<strong>di</strong> religiosi in rapporto con la riflessione<br />
teologica cattolica.<br />
Servizio <strong>di</strong>dattico-scientifico – Il Master si articola in quattro semestri, per complessivi<br />
120 ects. In ogni semestre vi sono alcuni insegnamenti fondamentali e alcuni corsi e<br />
seminari a scelta dello studente. Sono previsti tre curricula: Scienze delle religioni, Filosofia<br />
delle religioni e <strong>Teologia</strong> delle religioni. Complessivamente bisogna conseguire: 85<br />
ects <strong>di</strong> insegnamenti fondamentali e caratterizzanti obbligatori, 15 ects <strong>di</strong> insegnamenti<br />
complementari e 20 ects per l’elaborazione della tesi finale.<br />
Collaborazioni accademiche – Per raggiungere il suo scopo, l’Istituto è impegnato nella<br />
cooperazione accademica e organizzativa con altri Istituti <strong>di</strong> formazione e <strong>di</strong> ricerca<br />
nella Svizzera e all’estero. In particolare dall’a.a. 2008/2009 è attiva una convenzione<br />
con il Dipartimento Formazione e Appren<strong>di</strong>mento della SUPSI ai fini della qualificazione<br />
all’insegnamento della religione.<br />
Collaborazioni non accademiche e sbocchi professionali – Dal 2009/2010 sono attive forme<br />
<strong>di</strong> collaborazione con il Dicastero Informazione e Integrazione Sociale del comune<br />
<strong>di</strong> <strong>Lugano</strong> per l’effettuazione <strong>di</strong> stages professionali presso detto <strong>di</strong>castero. Inoltre, è<br />
stata siglata una convenzione con SOS Ticino che permette l’accesso alla formazione<br />
DERMAN per interpreti e me<strong>di</strong>atori interculturali.<br />
Organizzazione – L’Istituto ReTe della FTL ha un suo statuto ed è finanziato autonomamente.<br />
Direttore dell’Istituto e del Master: Prof. Dr. Adriano Fabris.<br />
Per richiedere il <strong>Piano</strong> <strong>degli</strong> <strong>stu<strong>di</strong></strong> del Master:<br />
Segreteria dell’Istituto ReTe<br />
Tel.: +41-(0)58/6664555; Fax: +41-(0)58/6664556<br />
E-mail: rete@teologialugano.ch<br />
Internet: www.teologialugano.ch/rete.php<br />
3.2.1.5. Centro <strong>di</strong> <strong>stu<strong>di</strong></strong> Hans Urs von Balthasar<br />
Il Centro <strong>di</strong> <strong>stu<strong>di</strong></strong> Hans Urs von Balthasar è stato creato dal fondatore della FTL, Mons.<br />
Eugenio Corecco, nel febbraio 1993 con lo scopo <strong>di</strong> promuovere la conoscenza del<br />
17
pensiero <strong>di</strong> von Balthasar, una figura ispiratrice della teologia insegnata alla Facoltà. Il<br />
Centro si propone <strong>di</strong> favorire la “ricerca balthasariana” me<strong>di</strong>ante un approccio descrittivo<br />
e d’approfon<strong>di</strong>mento, includendo un <strong>di</strong>scernimento critico, in vista <strong>di</strong> mostrare la<br />
sua attualità e fecon<strong>di</strong>tà nel pensiero filosofico e teologico contemporaneo. Il Centro è<br />
<strong>di</strong>retto dal Prof. Dr. André-Marie Jerumanis e conta sulla collaborazione del Prof. Dr.<br />
Jacques Servais (Università Gregoriana; Associazione Lubac-Balthasar-Speyr).<br />
Internet: www.balthasar.teologialugano.ch<br />
3.2.2. Dipartimento <strong>di</strong> Filosofia<br />
Il Dipartimento <strong>di</strong> Filosofia (istituito in seno alla FTL durante il Consiglio <strong>di</strong> Facoltà del<br />
12/5/2004) si occupa <strong>di</strong> tutte le questioni che attengono alle attività scientifiche e <strong>di</strong>dattiche<br />
<strong>di</strong> filosofia alla FTL. Fanno parte <strong>di</strong> questo Dipartimento l’Istituto <strong>di</strong> Stu<strong>di</strong> Filosofici<br />
(ISFI) e la Cattedra Antonio Rosmini.<br />
Il Direttore del Dipartimento <strong>di</strong> Filosofia è il Prof. Dr. Giovanni Ventimiglia e la segretaria<br />
Elena Vonzun (B. phil).<br />
3.2.2.1. Istituto <strong>di</strong> Stu<strong>di</strong> Filosofici (ISFI)<br />
L’ISFI, Istituto <strong>di</strong> Stu<strong>di</strong> Filosofici, è un Istituto della FTL che svolge attività <strong>di</strong> ricerca e<br />
<strong>di</strong>dattica.<br />
Identità e finalità – Lo scopo principale dell’Istituto è anzitutto quello <strong>di</strong> promuovere<br />
l’incontro filosofico della tra<strong>di</strong>zione classica della metafisica e dell’ontologia con la<br />
metafisica e l’ontologia analitica contemporanee. L’ISFI, inoltre, si prefigge <strong>di</strong> applicare<br />
i risultati della indagine metafisica all’analisi e alla soluzione <strong>di</strong> problemi concreti e circoscritti<br />
della contemporaneità. Per questi motivi, pur non tralasciando gli altri ambiti<br />
della filosofia, l’ISFI si concentra in particolare nei campi della metafisica e dell’ontologia<br />
e, inoltre, nei campi dell’ontologia applicata e, in generale, della filosofia applicata.<br />
All’ISFI insegnano e svolgono attività <strong>di</strong> ricerca, oltre ai professori stabili, professori <strong>di</strong><br />
riconosciuta competenza, come ad esempio A. Bottani, Paolo Di Lucia, R. Diodato, A.<br />
Fabris, M. Lenoci, A. de Libera, K. Mulligan. Nell’a.a. in corso si sono aggiunti anche R.<br />
Imbach e G. Soldati.<br />
La ricerca – L’ISFI riserva un’attenzione particolare alla ricerca. Gli ambiti <strong>di</strong> indagine<br />
privilegiati sono soprattutto due: la metafisica (intesa sia come ontologia che come<br />
teologia naturale) e la filosofia applicata. Attualmente sono in corso quattro ricerche<br />
nell’ambito della metafisica: «Two-sense theory of existence» (Ventimiglia); «La ricezione<br />
delle cosiddette “dottrine non scritte” <strong>di</strong> Platone nel XIII secolo» (Ventimiglia);<br />
«Ontologia delle proprietà» (Giordani e Costa); «Ontologia dell’essenza» (Giordani).<br />
Inoltre, sono in corso due ricerche nell’ambito della filosofia applicata: «Filosofia del<br />
virtuale» (Diodato, Fabris, Ventimiglia) e «Un’idea svizzera <strong>di</strong> libertà: Guglielmo Ferrero,<br />
Wilhelm Röpke, Denis de Rougemont» (Lottieri). Le ricerche in corso, ed alcune<br />
ricerche già concluse, sono descritte più in dettaglio al paragrafo «Progetti» (ve<strong>di</strong> sotto)<br />
e, inoltre, nel link «ricerca» del sito: www.isfi.ch.<br />
Le pubblicazioni – La maggior parte delle ricerche promosse dall’ISFI è pubblicata nella<br />
serie <strong>di</strong> <strong>stu<strong>di</strong></strong> dell’Istituto, presso l’E<strong>di</strong>tore Carocci <strong>di</strong> Roma, che ha per titolo: «Metafi-<br />
18
sica tomistica e metafisica analitica». Per il progetto completo della serie si rimanda al<br />
sito: www.isfi.ch.<br />
La <strong>di</strong>dattica – A livello <strong>di</strong>dattico l’ISFI gestisce il Bachelor in Filosofia, corso <strong>di</strong> <strong>stu<strong>di</strong></strong> triennale<br />
attivato alla FTL, che prevede la continuazione <strong>degli</strong> <strong>stu<strong>di</strong></strong> presso master o lauree<br />
specialistiche in altre università. Per maggiori informazioni si rimanda al sito www.isfi.ch<br />
e al <strong>Piano</strong> <strong>degli</strong> Stu<strong>di</strong> in versione cartacea, da richiedere in segreteria.<br />
Il servizio sociale – L’ISFI intrattiene rapporti <strong>di</strong> collaborazione con l’Associazione non<br />
profit «Pro-filo-umano» (http://homepage.bluewin.ch/profiloumano), che promuove la<br />
filosofia come forma <strong>di</strong> servizio sociale (nelle carceri, nelle comunità <strong>di</strong> recupero per<br />
ex-tossico<strong>di</strong>pendenti etc.).<br />
Direzione, segreteria, informazioni -Direttore: Prof. Dr. Giovanni Ventimiglia; segretaria:<br />
B.phil. Elena Vonzun.<br />
Tel.: +41 –(0)58/6664555/577; Fax: +41-(0)58/6664556<br />
E-mail: info@isfi.ch<br />
Internet: www.isfi.ch<br />
3.2.2.2. Cattedra Antonio Rosmini<br />
La Cattedra Antonio Rosmini della Facoltà <strong>di</strong> <strong>Teologia</strong> <strong>di</strong> <strong>Lugano</strong> si impegna nella<br />
ricerca della filosofia teoretica (metafisica) e dell’etica sociale. Sotto la <strong>di</strong>rezione <strong>di</strong><br />
Markus Krienke si delinea un autentico “think <strong>di</strong>fferent” rosminiano. Questo si articola,<br />
nel campo teoretico, come “ontologia trinitaria” che <strong>di</strong>venta fruibile nei termini <strong>di</strong><br />
un personalismo cristiano, e nel campo pratico come “cattolicesimo liberale” che<br />
promuove un autentico liberalismo sulla base valoriale dell’immagine cristiana della<br />
persona.<br />
Oltre progetti <strong>di</strong> ricerca e lezioni presso la Facoltà <strong>di</strong> <strong>Teologia</strong> <strong>di</strong> <strong>Lugano</strong>, la Cattedra<br />
organizza convegni e <strong>di</strong>battiti pubblici, contribuisce al <strong>di</strong>battito pubblico ticinese e<br />
italiano, e costituisce un punto <strong>di</strong> riferimento per <strong>stu<strong>di</strong></strong>osi su Rosmini, su temi <strong>di</strong> filosofia<br />
moderna ed etica sociale <strong>di</strong> tutto il mondo.<br />
Innanzitutto, la Cattedra Antonio Rosmini gestisce la “VideoCattedra Rosmini”<br />
sostenuta da “La 6 Tv” con video lezioni gratuitamente scaricabili da internet<br />
(www.cattedrarosmini.org) e la “Rosmini TV”, accessibile via streaming (www.rosmini.tv).<br />
Per ulteriori informazioni: www.rosmini.ch.<br />
Twitter: @CattedraRosmini<br />
3.3. Progetti<br />
3.3.1. Ricerche scientifiche in corso<br />
Un elenco delle ricerche in corso alla FTL e <strong>di</strong> alcune già concluse è consultabile in rete<br />
al link: “Attività <strong>di</strong> ricerca” (www.teologialugano.ch/ricerca.php).<br />
3.3.2. Dottorati alla FTL<br />
I Dottorati sono una parte fondamentale dello svolgimento della ricerca alla Facoltà <strong>di</strong><br />
19
<strong>Teologia</strong>. La FTL infatti, ha rilasciato ben 70 Dottorati (che per gli studenti della FTL<br />
corrisponde all’ottenimento della Libera Docenza), e due Dottorati honoris causa consegnati<br />
il 29 ottobre 2011 al metropolita <strong>di</strong> Volokolamsk Hilarion Alfeev, Presidente del<br />
Dipartimento delle relazioni esterne del Patriarcato <strong>di</strong> Mosca e il 1° <strong>di</strong>cembre 2012 al<br />
compositore estone Arvo Pärt.<br />
3.4. Commissione Ricerca<br />
La Commissione Ricerca ha il fine <strong>di</strong> valutare la vali<strong>di</strong>tà dei progetti <strong>di</strong> ricerca presentate<br />
dalla Facoltà, dai suoi Istituti o da singoli professori della FTL, a Istituzioni <strong>di</strong> ricerca<br />
terze che finanziano “ricerche competitive” (come SNF o Unione Europea). È composta<br />
dai proff. Libero Gerosa, Giorgio Paxima<strong>di</strong>, Manfred Hauke, Giovanni Ventimiglia,<br />
Costante Marabelli.<br />
3.5. Strumenti<br />
3.5.1. Biblioteca FTL<br />
È il principale strumento <strong>di</strong> ricerca e <strong>di</strong> <strong>stu<strong>di</strong></strong>o della FTL. Dall’anno accademico 2001-<br />
2002 è incorporata nella Biblioteca dell’USI.<br />
La Biblioteca universitaria <strong>di</strong> <strong>Lugano</strong> (BUL) offre un adeguato ventaglio <strong>di</strong> servizi, tra<br />
i quali in particolare si segnala la realizzazione <strong>di</strong> un’interfaccia web che presenta l’elenco<br />
dei corsi universitari e propone per ognuno una scheda bibliografica. L’accesso<br />
alle risorse, alle informazioni e alla documentazione indotto dalla struttura dei corsi<br />
vuole essere il naturale approccio per gli studenti che affrontano i temi dei corsi:<br />
www.library.lu.usi.ch/core/index.asp.<br />
Quale membro attivo della rete delle biblioteche svizzere, la Biblioteca universitaria <strong>di</strong><br />
<strong>Lugano</strong> offre la possibilità <strong>di</strong> accedere ai cataloghi delle biblioteche e centri <strong>di</strong> documentazione<br />
membri della cooperazione, virtualmente estendendo il proprio patrimonio documentario<br />
ed assicurandone il reale utilizzo attraverso il prestito interbibliotecario.<br />
In<strong>di</strong>rizzo: via Giuseppe Buffi 13, 6904 <strong>Lugano</strong> (CH)<br />
Tel. +41 -(0)58/6664500<br />
Internet: www.library.lu.usi.ch<br />
Orari <strong>di</strong> apertura: Lunedì-Venerdì 9:00-22:00; Sabato 9:00-12.15<br />
Orario prestito interbibliotecario: Lunedì- Venerdì 9:00-18:00<br />
3.5.2. Rivista Teologica <strong>di</strong> <strong>Lugano</strong> (RTLu)<br />
La Rivista Teologica della FTL è un quadrimestrale (Statuti Art. 65) pubblicato dal 1996.<br />
Il perio<strong>di</strong>co ospita quattro sezioni: Articoli, Contributi, Miscellanea e Recensioni. Oltre<br />
a presentare il lavoro scientifico dei docenti della Facoltà, la RTLu si apre a contributi<br />
<strong>di</strong> qualificati esperti internazionali; in più, nella sezione «Miscellanea», viene dato spazio<br />
a una serie <strong>di</strong> interventi <strong>di</strong> alto profilo scientifico, redatti però in forma <strong>di</strong>vulgativa per<br />
favorire la comunicazione tra mondo universitario e opinione pubblica.<br />
20
Direttore: Prof. Dr. Giorgio Paxima<strong>di</strong><br />
Vice <strong>di</strong>rettore: Prof. Dr. Manfred Hauke<br />
Caporedattore: Prof. Dr. Antonio Tombolini.<br />
Internet: www.teologialugano.ch/rivistateologica.php<br />
3.5.3. Veritas et Jus. Semestrale inter<strong>di</strong>sciplinare <strong>di</strong> <strong>Lugano</strong><br />
Dal 2001 è stato costituito presso la Facoltà <strong>di</strong> <strong>Teologia</strong> <strong>di</strong> <strong>Lugano</strong> l’Istituto<br />
Internazionale <strong>di</strong> Diritto canonico e <strong>di</strong> ritto comparato delle religioni (DiReCom), con<br />
l’inten to <strong>di</strong> favorire lo <strong>stu<strong>di</strong></strong>o <strong>di</strong> queste <strong>di</strong>scipline con un metodo scientifico rinnovato,<br />
ossia capace <strong>di</strong> coniugare il momento fondativo con quello comparativo. Dal 2002 lo stesso<br />
Istituto ha iniziato a pubblicare l’Annuario DiReCom.<br />
Dal 2002 al 2009 sono stati pubblicati ben nove nume ri dell’Annuario su temi <strong>di</strong><br />
grande attualità, come laicità dello stato e libertà religiosa, tolleranza e simboli religiosi,<br />
universalità dei <strong>di</strong>ritti umani ed altri ancora. Fin dal primo quaderno, de<strong>di</strong>cato<br />
all’interpretazione delle leggi, gli autori si sono lasciati guidare dalla convinzione che<br />
la corretta interpretazione delle norme esige sempre non solo <strong>di</strong> ricercare la verità<br />
o valore ultimo su cui si fonda no, ma anche che tale ricerca va compiuta tenendo<br />
pre sente che il cammino ermeneutico o processo interpretativo non è mai “una strada a<br />
senso unico”. Esso presuppone uno sfor zo comparativo ed inter<strong>di</strong>sciplinare, capace <strong>di</strong><br />
rinnovare gli strumenti concettuali e metodologici delle <strong>di</strong>scipline scientifiche coinvolte<br />
in questo lavoro.<br />
Con il 2010 si è voluto rafforzare sia il carattere inter<strong>di</strong>sciplinare <strong>di</strong> questo lavoro<br />
scientifico, sia la sua accessibilità da parte del grande pubblico, con l’intento <strong>di</strong> attirare<br />
l’attenzione su quel can tiere <strong>di</strong> lavori in corso che è <strong>di</strong>ventato il <strong>di</strong>ritto ecclesiasti co<br />
svizzero, in piena evoluzione verso un <strong>di</strong>ritto pubblico su Chiese e Comunità religiose<br />
molto <strong>di</strong>versificate fra <strong>di</strong> loro. E ciò nella lucida consapevolezza che – come ha<br />
affermato Papa Benedetto XVI davanti all’Assemblea Generale dell’Organizzazione<br />
delle Nazioni Unite a New York il 18 aprile 2008 – “il bene comune che i <strong>di</strong>ritti umani<br />
aiutano a raggiungere non si può realizzare semplice mente con l’applicazione <strong>di</strong><br />
procedure corrette e neppure me<strong>di</strong>ante un semplice equilibrio fra <strong>di</strong>ritti contrastanti…<br />
(bensì) rafforzando gli sforzi <strong>di</strong> fronte alle pressioni per reinterpretare i fondamenti<br />
della Dichiarazione Univer sale dei Diritti dell’Uomo”. Questo sforzo sarà tanto più<br />
efficace, quanto maggiore e rigoroso il confronto fra le <strong>di</strong>verse <strong>di</strong>scipline scientifiche<br />
interpellate (dalla filoso fia alla teologia, dal <strong>di</strong>ritto canonico al <strong>di</strong>ritto ecclesia stico, dal<br />
<strong>di</strong>ritto comparato delle religioni alle scienze della comunicazione religiosa). Anzi è<br />
necessario che in tale sforzo <strong>di</strong> inter<strong>di</strong>sciplinarietà tutte queste <strong>di</strong>sci pline scientifiche<br />
sappiano mostrare la loro capacità <strong>di</strong> rispondere ai problemi concreti posti dalla società<br />
civi le europea sempre più multiculturale e multietnica. La trasformazione dell’Annuario<br />
DiReCom in un Semestrale inter<strong>di</strong>sciplinare è dettata proprio dal desiderio <strong>di</strong> dare<br />
un contributo qualificato a questo duplice sforzo <strong>di</strong> grande importanza scientifica<br />
e <strong>di</strong> bruciante attualità. Questa nuova pubblicazione, curata da docenti, ricercatori<br />
ed esperti vicini all’Istituto DiReCom porta il titolo “Veritas et Jus - Semestrale<br />
inter<strong>di</strong>sciplinare <strong>di</strong> <strong>Lugano</strong>” ed è e<strong>di</strong>ta dall’omonima Associazione, istituita a questo<br />
scopo il 21 gennaio 2010.<br />
21
Curatori: Prof. Dr. Libero Gerosa (<strong>di</strong>rettore), Prof. Dr. Gabriela Eisenring e Prof. Dr.<br />
Vincenzo Pacillo.<br />
Comitato scientifico: Arturo Cattaneo, Paolo Di Lucia, Mostafa El Ayoubi, Adriano<br />
Fabris, Silvio Ferrari, Philippe Gardaz, Clau<strong>di</strong>us Luterbacher, Ludger Müller, René<br />
Pahud de Mortanges, Peter Schulz, Vittorio Dan Segre, Arnd Uhle, Giovanni Ventimiglia.<br />
Caporedattore: Antonio Tombolini<br />
Per attivare l’abbonamento rivolgersi a: abbonamenti@veritasetjus.ch.<br />
Responsabile: Avv. Letizia Bianchi Meda, lic.iur.can.<br />
3.5.4. Eupress FTL<br />
Eupress FTL è la sigla dell’attività e<strong>di</strong>toriale della Facoltà <strong>di</strong> <strong>Teologia</strong> <strong>di</strong> <strong>Lugano</strong>.<br />
Con la partnership dell’e<strong>di</strong>tore italiano Reggiani e in continuità con i volumi e le collane<br />
già inaugurate, mira a conferire ulteriore visibilità e prestigio a <strong>stu<strong>di</strong></strong> compiuti nella o in<br />
collaborazione con la FTL. In particolare con la collana <strong>di</strong> testi universitari “Pro manuscripto”<br />
si realizza l’intento <strong>di</strong> aprirsi al contributo <strong>di</strong> altre Facoltà o Università, assumendo<br />
così un profilo sempre più inter<strong>di</strong>sciplinare e internazionale. Tale produzione<br />
e<strong>di</strong>toriale, che conta ormai più <strong>di</strong> un’ottantina <strong>di</strong> opere pubblicate a partire dal 2002, si<br />
affianca alla Rivista Teologica <strong>di</strong> <strong>Lugano</strong>.<br />
Il catalogo delle pubblicazioni è consultabile al link www.teologialugano.ch/eupressftl.php.<br />
Ultima pubblicazione: Libero Gerosa, Diritti e popoli in Giovanni Paolo II. Principi<br />
fondamentali e prospettive future, <strong>Lugano</strong> <strong>2013</strong>.<br />
Direttore e<strong>di</strong>toriale: Prof. Dr. Antonio Tombolini<br />
3.5.5. Altre collaborazioni e<strong>di</strong>toriali<br />
L’Istituto <strong>di</strong> Storia della <strong>Teologia</strong> e l'Istituto <strong>di</strong> Stu<strong>di</strong> Filosofici collaborano con le case<br />
e<strong>di</strong>trici: Jaca Book e Carocci.<br />
Dalla collaborazione con Jaca Book nascono due collane che trattano temi inerenti alla<br />
teologia: una è <strong>di</strong>retta dai Proff. Inos Biffi e Costante Marabelli intitolata Biblioteca <strong>di</strong><br />
Cultura Me<strong>di</strong>evale; l’altra <strong>di</strong>retta dal Prof. Libero Gerosa e prende il nome <strong>di</strong> Amateca.<br />
La Biblioteca <strong>di</strong> Cultura Me<strong>di</strong>evale ha pubblicato finora cinque importanti volumi per<br />
la ricerca nel campo della storia della teologia, l’ultimo dei quali uscirà nel mese <strong>di</strong> settembre<br />
del presente anno: Walter Daniel, Vita <strong>di</strong> Aelredo <strong>di</strong> Rievaulx, a cura <strong>di</strong> Antonio<br />
Tombolini, presentazione <strong>di</strong> Azzolino Chiappini, introduzione <strong>di</strong> Inos Biffi, IST FTL/Jaca<br />
Book, Milano 2012. Per quanto concerne invece la seconda collana, vengono ripresi<br />
temi fondamentali per l’educazione e la formazione <strong>degli</strong> studenti nelle facoltà teologiche.<br />
Gli autori hanno come comune riferimento le opere <strong>di</strong> Henri de Lubac e Hans Urs<br />
von Balthasar, secondo un principio sistematico che guida tutta la ripartizione della materia<br />
e che può essere formulato nel modo seguente: Gesù il Cristo, “la chiave, il centro<br />
e il fine <strong>di</strong> tutta la storia umana” (GS 10,2), non è solamente l’autore della redenzione,<br />
ma è anche il capo della creazione. Egli è “l’Alfa e l’Omega” (Ap 21,6) dell’uomo, del<br />
cosmo e della loro storia. Tale visione cristocentrica ha permesso <strong>di</strong> <strong>di</strong>videre la materia<br />
22
tra<strong>di</strong>zionale in sette sezioni, per un totale <strong>di</strong> ventidue volumi, pubblicati in un<strong>di</strong>ci lingue<br />
<strong>di</strong>verse. L’Associazione internazionale amateca, che ha sede giuri<strong>di</strong>ca a <strong>Lugano</strong>, è stata<br />
fondata da Mons. Dr. Eugenio Corecco, già Vescovo <strong>di</strong> <strong>Lugano</strong> e fondatore della FTL,<br />
ed è ora presieduta da S.Em. Card. Dr. Christoph Schönborn e coor<strong>di</strong>nata dal Prof.<br />
Dr. Libero Gerosa. Il Consiglio <strong>di</strong> Facoltà del 12 marzo 2008 ha deciso <strong>di</strong> cooptare nel<br />
Consiglio Direttivo <strong>di</strong> Eupress FTL un rappresentante <strong>di</strong> amateca fra i <strong>di</strong>versi docenti<br />
della FTL che collaborano alla collana.<br />
All’interno dell’attività e<strong>di</strong>toriale Carocci invece, vi è una specifica serie <strong>di</strong> <strong>stu<strong>di</strong></strong> che si<br />
occupa <strong>di</strong> temi filosofici: Metafisica tomistica e metafisica analitica, nella quale viene<br />
pubblicato materiale scientifico specifico dell’ISFI della FTL. Direttore della serie: Prof.<br />
Dr. Giovanni Ventimiglia.<br />
Breve descrizione della Collana: «Pur occupandosi <strong>di</strong> temi molto simili, quando non<br />
identici – le prove dell’esistenza <strong>di</strong> Dio, gli attributi <strong>di</strong> Dio, l’essere, l’essenza, la verità,<br />
gli universali, la libertà, la persona umana, la conoscenza etc. – la metafisica analitica e<br />
quella aristotelico-tomistica somigliano, oggi, a due rette parallele che non si incontrano<br />
mai. La serie <strong>di</strong> <strong>stu<strong>di</strong></strong> intende ovviare a tale inconveniente. Lo fa anzitutto facendo conoscere<br />
al pubblico italiano una serie <strong>di</strong> autori non molto noti, proveniente soprattutto<br />
dall’area del cosiddetto “tomismo analitico”, che hanno già realizzato ponti interessanti<br />
sul mare che <strong>di</strong>vide i due continenti filosofici. Lo fa, poi, anche con <strong>stu<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> carattere<br />
teoretico volti a costruire ponti nuovi. Lo spirito che anima l’impresa, tuttavia, non è<br />
tanto il <strong>di</strong>alogo per il <strong>di</strong>alogo, ma il <strong>di</strong>alogo per la verità, cioè la convinzione che una<br />
maggiore collaborazione fra le due metafisiche possa giovare al progresso della filosofia<br />
e alla conoscenza della verità.» La serie ha pubblicato tre volumi, l’ultimo dei quali è<br />
G. Ventimiglia, «To be» o «esse»? La questione dell’essere nel tomismo analitico, Carocci,<br />
Milano 2012, e vi sono in corso <strong>di</strong> pubblicazione altri cinque volumi sempre <strong>di</strong> temi<br />
riguardanti l’esistenza <strong>di</strong> Dio e l’essere nel tomismo.<br />
3.5.6. Alcuni link utili alla ricerca<br />
--<br />
www.mirabileweb.it (archivio per la documentazione me<strong>di</strong>evale)<br />
--<br />
http://philindex.org/ (ricerche per bibliografie in campo filosofico)<br />
--<br />
www.rep.routledge.com (enciclope<strong>di</strong>a filosofica)<br />
--<br />
www.bns.it/opac (catalogo del servizio bibliotecario nazionale italiano)<br />
--<br />
http://plato.stanford.edu/ (enciclope<strong>di</strong>a filosofica dell’università <strong>di</strong> Stanford)<br />
--<br />
www.vatican.va (sito ufficiale del Vaticano in cui si trovano tutti i documenti ed<br />
encicliche pubblicati della Chiesa)<br />
--<br />
http://www.teologialugano.ch/links.php (per informazioni varie)<br />
--<br />
http://www3.chiesacattolica.it/teologiassisi/meto_link.htm (elenco per strumenti<br />
<strong>di</strong>sponibili)<br />
23
Calendario accademico <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong><br />
Semestre autunnale <strong>2013</strong><br />
Giugno <strong>2013</strong><br />
28 Termine per le pre-iscrizioni alla FTL per l’anno accademico <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong><br />
Termine per la pre-iscrizione obbligatoria agli esami <strong>di</strong> grado (sessione <strong>di</strong> ottobre <strong>2013</strong>)<br />
Termine per l’iscrizione agli esami particolari della sessione <strong>di</strong> settembre<br />
dell’a.a. <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong><br />
Luglio <strong>2013</strong><br />
1 Inizio vacanze estive<br />
Agosto <strong>2013</strong><br />
1 Festa nazionale svizzera<br />
15 Festa - Assunzione<br />
26 Termine ultimo per l’iscrizione agli esami <strong>di</strong> grado e per la consegna delle tesi (sessione<br />
<strong>di</strong> ottobre <strong>2013</strong>)<br />
30 Fine dell’anno accademico 2012/<strong>2013</strong><br />
Settembre <strong>2013</strong><br />
2 Inizio dell’anno accademico <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong><br />
Inizio del corso intensivo <strong>di</strong> lingua italiana per i nuovi studenti non italofoni<br />
Termine ultimo delle iscrizioni alla FTL e ai corsi del semestre autunnale<br />
Scadenza per l’inoltro della domanda <strong>di</strong> richiesta del riconoscimento corsi per il semestre<br />
autunnale <strong>2013</strong><br />
Settimana 2-6 settembre <strong>2013</strong> - esami<br />
2-13 Sessione <strong>di</strong> settembre <strong>degli</strong> esami particolari dell’a.a. 2012/<strong>2013</strong><br />
Settimana 9-13 settembre <strong>2013</strong> - esami<br />
13 Termine per la consegna dei libretti accademici<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
Settimana 16-20 settembre <strong>2013</strong> - settimana intensiva<br />
16 Inizio dei corsi della prima settimana intensiva<br />
Settimana 23-27 settembre <strong>2013</strong> - corsi<br />
23 Inizio dei corsi istituzionali del semestre autunnale <strong>2013</strong><br />
Settimana 30 settembre - 4 ottobre <strong>2013</strong> - corsi ed esami <strong>di</strong> grado<br />
30-4 Sessione <strong>di</strong> ottobre <strong>degli</strong> esami <strong>di</strong> grado dell’a.a. 2012/<strong>2013</strong><br />
Settimana 7-11 ottobre <strong>2013</strong> - corsi<br />
Settimana 14-18 ottobre <strong>2013</strong> - corsi<br />
Settimana 21-25 ottobre <strong>2013</strong> - corsi<br />
Settimana 28 ottobre - 1 novembre <strong>2013</strong> - corsi<br />
1 Festa - Tutti i Santi<br />
Settimana 4-8 novembre <strong>2013</strong> - corsi<br />
24
8<br />
9<br />
10<br />
11<br />
12<br />
13<br />
Settimana 11-15 novembre <strong>2013</strong> - corsi<br />
Settimana 18-22 novembre <strong>2013</strong> - corsi<br />
18 Termine pre-iscrizione obbligatoria agli esami <strong>di</strong> grado (sessione <strong>di</strong> gennaio <strong>2014</strong>)<br />
Settimana 25-30 novembre <strong>2013</strong> - corsi ed eventi<br />
30 Dies academicus<br />
Settimana 2-6 <strong>di</strong>cembre <strong>2013</strong> - corsi<br />
Settimana 9-13 <strong>di</strong>cembre <strong>2013</strong> - corsi<br />
9 Termine ultimo per l’iscrizione agli esami <strong>di</strong> grado e per la consegna delle tesi<br />
(sessione <strong>di</strong> gennaio <strong>2014</strong>)<br />
Settimana 16-20 <strong>di</strong>cembre <strong>2013</strong> - corsi<br />
20 Ultimo giorno dei corsi del semestre autunnale<br />
Termine per l’iscrizione agli esami particolari (sessione autunnale<br />
7-24 gennaio <strong>2014</strong>)<br />
Scadenza per l’inoltro della domanda <strong>di</strong> richiesta riconoscimento corsi<br />
per il semestre primaverile <strong>2014</strong><br />
23 <strong>di</strong>cembre <strong>2013</strong> - 6 gennaio <strong>2014</strong> - vacanze natalizie<br />
25 Festa - Natale<br />
26 Festa - Santo Stefano<br />
1 Festa - Capodanno<br />
6 Festa - Epifania<br />
Gennaio <strong>2014</strong><br />
7-24 Sessione autunnale <strong>degli</strong> esami particolari e <strong>di</strong> grado<br />
24 Termine ultimo delle iscrizioni ai corsi del semestre primaverile<br />
27 Inizio delle vacanze intersemestrali<br />
Calendario accademico <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong><br />
25
Semestre primaverile <strong>2014</strong><br />
Calendario accademico <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong><br />
1<br />
Settimana 17-21 febbraio <strong>2014</strong> - settimana intensiva<br />
17 Inizio dei corsi della seconda settimana intensiva<br />
Settimana 24-28 febbraio <strong>2014</strong> - corsi<br />
24 Inizio dei corsi istituzionali del semestre primaverile <strong>2014</strong><br />
2 Settimana 3-7 marzo <strong>2014</strong> - corsi<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9<br />
10<br />
11<br />
12<br />
13<br />
Settimana 10-14 marzo <strong>2014</strong> - corsi<br />
14 Scadenza per l’inoltro della domanda <strong>di</strong> Borsa <strong>di</strong> Stu<strong>di</strong>o per l’a.a. <strong>2014</strong>/2015<br />
(bds@teologialugano.ch)<br />
Settimana 17-21 marzo <strong>2014</strong> - corsi<br />
19 Festa - San Giuseppe<br />
Settimana 24-28 marzo <strong>2014</strong> - corsi<br />
Settimana 31 marzo - 4 aprile <strong>2014</strong> - corsi<br />
Settimana 7-11 aprile <strong>2014</strong> - corsi<br />
Settimana 14-18 aprile <strong>2014</strong> - corsi<br />
14 Termine pre-iscrizione obbligatoria agli esami <strong>di</strong> grado (sessione <strong>di</strong> giugno <strong>2014</strong>)<br />
16 (ore 12.15) Inizio delle vacanze <strong>di</strong> Pasqua<br />
20 Festa - Pasqua <strong>di</strong> Resurrezione<br />
Settimana 21-25 aprile <strong>2014</strong> - vacanze pasquali<br />
21 Festa - Lunedì dell’Angelo<br />
Settimana 28 aprile - 2 maggio <strong>2014</strong> - corsi<br />
28 Ripresa dei corsi<br />
1 Festa - San Giuseppe artigiano<br />
Settimana 5-9 maggio <strong>2014</strong> - corsi<br />
5 Termine ultimo per l’iscrizione agli esami <strong>di</strong> grado e per la consegna delle tesi<br />
(sessione <strong>di</strong> giugno <strong>2014</strong>)<br />
Settimana 12-16 maggio <strong>2014</strong> - corsi<br />
Settimana 19-23 maggio <strong>2014</strong> - corsi<br />
Settimana 26-30 maggio <strong>2014</strong> - corsi<br />
29 Festa - Ascensione<br />
30 Ultimo giorno dei corsi del semestre primaverile<br />
Termine ultimo per l’iscrizione agli esami particolari (sessione <strong>di</strong> giugno <strong>2014</strong>)<br />
26
Settimana 2-6 giugno <strong>2014</strong> - preparazione agli esami<br />
Settimana 9-13 giugno <strong>2014</strong> - esami<br />
9 Festa - Pentecoste<br />
10-27 Sessione primaverile <strong>degli</strong> esami particolari e <strong>di</strong> grado<br />
Settimana 16-20 giugno <strong>2014</strong> - esami<br />
19 Festa - Corpus Domini<br />
Settimana 23-27 giugno <strong>2014</strong> - esami<br />
27 Termine per le pre-iscrizioni alla FTL per l’anno accademico <strong>2014</strong>/2015<br />
Termine pre-iscrizione obbligatoria agli esami <strong>di</strong> grado (sessione <strong>di</strong> ottobre <strong>2014</strong>)<br />
Giugno <strong>2014</strong><br />
29 Festa - Santi Pietro e Paolo<br />
30 Inizio vacanze estive<br />
Agosto <strong>2014</strong><br />
1 Festa nazionale svizzera<br />
15 Festa - Assunzione<br />
25 Termine ultimo per l’iscrizione agli esami <strong>di</strong> grado e per la consegna delle tesi<br />
(sessione <strong>di</strong> ottobre <strong>2014</strong>)<br />
Termine per l’iscrizione agli esami particolari della sessione <strong>di</strong> settembre<br />
dell’a.a. <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong><br />
29 Fine dell’anno accademico <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong><br />
Settembre <strong>2014</strong><br />
1 Inizio dell’anno accademico <strong>2014</strong>/2015<br />
Inizio del corso intensivo <strong>di</strong> lingua italiana per i nuovi studenti non italofoni<br />
Termine ultimo delle iscrizioni alla FTL e ai corsi del semestre autunnale<br />
Scadenza per l’inoltro della domanda <strong>di</strong> richiesta del riconoscimento corsi per<br />
il semestre autunnale <strong>2014</strong><br />
1-12 Sessione autunnale <strong>degli</strong> esami particolari dell’a.a. <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong><br />
15-19 Inizio dei corsi della prima settimana intensiva<br />
22 Inizio dei corsi istituzionali del semestre autunnale <strong>2014</strong><br />
Calendario accademico <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong><br />
Settembre-Ottobre <strong>2014</strong><br />
29-3 Sessione <strong>di</strong> ottobre <strong>degli</strong> esami <strong>di</strong> grado dell’a.a. <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong><br />
27
4. Ammissione, esami e tasse accademiche<br />
4.1. Criteri <strong>di</strong> ammissione<br />
La FTL può essere frequentata da studenti or<strong>di</strong>nari, straor<strong>di</strong>nari e u<strong>di</strong>tori.<br />
Ammissione e tasse accademiche<br />
a) Per l’ammissione ai Bachelor of Theology e Bachelor of Arts in Filosofia in qualità <strong>di</strong> studente<br />
or<strong>di</strong>nario si richiedono i seguenti titoli:<br />
• per gli svizzeri: maturità federale, maturità cantonale; attestato <strong>degli</strong> esami complementari<br />
(esami passerella) accompagnato da un attestato federale <strong>di</strong> maturità<br />
professionale;<br />
• per gli stranieri: un titolo che consenta l’iscrizione all’Università nei rispettivi Paesi<br />
<strong>di</strong> origine. In genere sono ammessi i titolari <strong>di</strong> una maturità estera secondo le<br />
<strong>di</strong>rettive della Commissione dei Rettori Universitari Svizzeri (CRUS). Per dettagli:<br />
www.crus.ch/information-programmes/reconnaissance-swiss-enic/admission/<br />
admission-en-suisse/certificats-etrangers.html?L=1.<br />
--<br />
Le iscrizioni <strong>degli</strong> studenti or<strong>di</strong>nari avvengono dopo l’esame della documentazione<br />
e un colloquio con il Rettore, previo appuntamento da concordare presso la<br />
segreteria.<br />
--<br />
È necessario consegnare l’originale della maturità in segreteria. Esso verrà restituito<br />
al termine <strong>degli</strong> <strong>stu<strong>di</strong></strong>.<br />
--<br />
La FTL non accoglie la richiesta <strong>di</strong> iscrizione con la qualifica <strong>di</strong> studente or<strong>di</strong>nario<br />
presentata da coloro che sono contemporaneamente iscritti ad altre Università<br />
o Atenei.<br />
b) Per l’ammissione in qualità <strong>di</strong> studente straor<strong>di</strong>nario si richiede: curriculum vitae e<br />
curriculum <strong>stu<strong>di</strong></strong>orum. Gli studenti straor<strong>di</strong>nari non possono aspirare ai gra<strong>di</strong> accademici,<br />
ma possono conseguire il Certificato <strong>di</strong> <strong>stu<strong>di</strong></strong> teologici se hanno adempiuto a tutte le<br />
<strong>di</strong>sposizioni a esso relative.<br />
c) Per l’ammissione come studente u<strong>di</strong>tore non si richiede alcun titolo. La partecipazione<br />
alle lezioni della Facoltà è possibile dopo una regolare iscrizione, <strong>di</strong> norma senza<br />
la facoltà <strong>di</strong> sostenere gli esami.<br />
d) I chierici, sia <strong>di</strong>ocesani sia religiosi, e le religiose sono ammessi alla FTL con l’autorizzazione<br />
preliminare del loro Or<strong>di</strong>nario o Superiore competente.<br />
Bachelor of Arts in Filosofia ISFI<br />
L’ammissione è subor<strong>di</strong>nata al superamento <strong>di</strong> un colloquio <strong>di</strong> ammissione, volto ad<br />
accertare una conoscenza minima della materia e l’attitu<strong>di</strong>ne a <strong>stu<strong>di</strong></strong>arla ad un livello<br />
universitario.<br />
Ammissione su “dossier”: possono essere ammessi i can<strong>di</strong>dati <strong>di</strong> età superiore a 25 anni<br />
28
sprovvisti dei titoli sopra citati, se ritenuti in possesso <strong>di</strong> una formazione ed esperienze<br />
significative, attestate con la domanda d’iscrizione e solo dopo aver superato un esame<br />
<strong>di</strong> ammissione.<br />
Master of Theology<br />
Si richiede il <strong>di</strong>ploma <strong>di</strong> Bachelor of Theology (o titolo equipollente).<br />
Master of Arts in Scienza, filosofia e teologia delle religioni<br />
Titolo <strong>di</strong> <strong>stu<strong>di</strong></strong>o ritenuto valido per l’ammissione (Bachelor o Master in Filosofia o <strong>Teologia</strong>,<br />
Bachelor o Master in <strong>di</strong>scipline umanistiche, laurea <strong>di</strong> I livello conseguita in una<br />
Università italiana) con il dettaglio <strong>di</strong> tutte le materie seguite e <strong>degli</strong> esami sostenuti (è<br />
necessario consegnare l’originale che verrà restituito al termine <strong>degli</strong> <strong>stu<strong>di</strong></strong>).<br />
Master of Arts in Diritto canonico ed ecclesiastico comparato (in<strong>di</strong>rizzo in Diritto canonico<br />
comparato e in<strong>di</strong>rizzo in Diritto Comparato delle religioni)<br />
Il primo in<strong>di</strong>rizzo (Diritto canonico comparato) del Master si <strong>di</strong>fferenzia in due percorsi,<br />
uno per giuristi ed uno per teologi.<br />
Per i primi, ossia per coloro che hanno già acquisito una formazione accademica in <strong>di</strong>scipline<br />
giuri<strong>di</strong>che e non posseggono un titolo canonico in teologia, è obbligatorio seguire<br />
un biennio introduttivo <strong>di</strong> corsi teologico-filosofici comprendente quattro semestri.<br />
Per i secon<strong>di</strong>, ossia per coloro che sono in possesso <strong>di</strong> un titolo accademico in <strong>Teologia</strong>,<br />
non è necessario il biennio introduttivo, anche se possono essere obbligati dal Consiglio<br />
Direttivo dell’Istituto a scegliere qualche corso o seminario tra quelli offerti dalla FTL<br />
(in particolare <strong>Teologia</strong> del Diritto canonico, Ecclesiologia e <strong>Teologia</strong> fondamentale).<br />
Per l’ammissione al secondo in<strong>di</strong>rizzo (Diritto comparato delle religioni) è necessario<br />
essere in possesso <strong>di</strong> un Bachelor in Filosofia, in <strong>di</strong>ritto o in un’altra <strong>di</strong>sciplina umanistica.<br />
Ammissione e tasse accademiche<br />
Licenza canonica in <strong>Teologia</strong><br />
È aperto agli studenti che hanno conseguito il Master of Theology/Baccellierato in <strong>Teologia</strong><br />
con una valutazione pari almeno a 8/10. La Commissione “Ammissione ed esami” può<br />
richiedere un esame <strong>di</strong> ammissione a coloro che non ottemperano a tutte le con<strong>di</strong>zioni<br />
richieste dalla FTL. Inoltre può esigere corsi <strong>di</strong> perfezionamento nelle lingue antiche a<br />
seconda della specializzazione scelta.<br />
Dottorato in <strong>Teologia</strong><br />
Il Dottorato in <strong>Teologia</strong> è aperto solo agli studenti che hanno conseguito il titolo <strong>di</strong> Licenza<br />
canonica in <strong>Teologia</strong> con una valutazione pari o superiore a 8/10.<br />
Il lavoro dello studente è incentrato sulla redazione della tesi <strong>di</strong> Dottorato, che dovrà<br />
offrire un contributo scientifico originale e che verrà pubblicata dopo la <strong>di</strong>fesa della<br />
medesima davanti alla Commissione d’Esame preposta.<br />
29
4.2. Modalità d’iscrizione<br />
Ammissione e tasse accademiche<br />
L’iscrizione ha luogo consegnando l’apposito formulario debitamente compilato, corredato<br />
dai seguenti documenti:<br />
• Curriculum vitae dettagliato;<br />
• Una <strong>di</strong>chiarazione nella quale si attesta <strong>di</strong> non essere più iscritti in un’altra Università<br />
(è vietata l’iscrizione contemporanea a <strong>di</strong>verse università italiane o estere, o istituti<br />
universitari ed equiparati, a <strong>di</strong>verse Facoltà e a corsi <strong>di</strong> <strong>stu<strong>di</strong></strong>o della stessa Università);<br />
• Originale del titolo <strong>di</strong> maturità o titolo equivalente (un titolo che dà la possibilità allo<br />
studente <strong>di</strong> iscriversi alle università del proprio paese <strong>di</strong> provenienza);<br />
• Titolo <strong>di</strong> <strong>stu<strong>di</strong></strong>o ritenuto valido per l’ammissione con il dettaglio <strong>di</strong> tutte le materie<br />
seguite e <strong>degli</strong> eventuali esami sostenuti;<br />
• Fotocopia <strong>di</strong> un documento valido (passaporto o carta d’identità);<br />
• 3 fotografie formato tessera;<br />
• 1 fotografia formato elettronico da inviare a segreteria@teologialugano.ch;<br />
• Lettera <strong>di</strong> autorizzazione da parte dell’Or<strong>di</strong>nario o del Superiore competente (se<br />
studenti ecclesiastici);<br />
• Documento che certifichi l’idoneità morale emesso da un’autorità ecclesiastica (se<br />
trattasi <strong>di</strong> laici);<br />
• Eventualmente formulario domanda <strong>di</strong> richiesta riconoscimento corsi (termine<br />
ultimo 2 settembre – per il semestre autunnale / 20 <strong>di</strong>cembre <strong>2013</strong> – per il semestre<br />
primaverile).<br />
L’elenco della documentazione richiesta può anche essere scaricato dal sito della FTL<br />
alla pagina: www.teologialugano.ch/pdf/ammissione.pdf.<br />
Per tutti i titoli e documenti, che non siano redatti in latino o nelle lingue nazionali svizzere<br />
è richiesta, oltre all’originale, la traduzione autenticata in italiano.<br />
Agli studenti non italofoni è richiesto anche un attestato che certifichi la conoscenza<br />
della lingua italiana.<br />
Agli studenti stranieri è richiesto una copia del permesso <strong>di</strong> <strong>di</strong>mora valido e il<br />
certificato <strong>di</strong> iscrizione ad una Cassa malati svizzera.<br />
Non sono ammesse iscrizioni oltre i termini stabiliti dal calendario accademico.<br />
L’iscrizione accademica è valida solo se accompagnata da un documento che attesti l’avvenuto<br />
pagamento della quota d’iscrizione. In mancanza <strong>di</strong> tale giustificativo, lo studente<br />
non può essere ammesso alla frequenza delle lezioni o agli esami. L’immatricolazione<br />
avviene al termine dell’iter d’iscrizione.<br />
30
4.3. Esami<br />
Esami particolari<br />
• L’assenza a 1/3 delle lezioni <strong>di</strong> un corso priva lo studente del <strong>di</strong>ritto all’esame del<br />
corso.<br />
• Il ritiro dell’iscrizione all’esame deve essere fatto entro 3 giorni dalla data fissata;<br />
dopo questa scadenza il ritiro è possibile solo inoltrando un certificato me<strong>di</strong>co (in<br />
questo caso il termine <strong>di</strong> consegna è <strong>di</strong> 3 giorni dopo la data dell’esame). In caso<br />
<strong>di</strong> assenza del can<strong>di</strong>dato l’esame viene considerato come non superato.<br />
• Gli esami sono pubblici.<br />
• Superato positivamente l’esame, lo studente non sod<strong>di</strong>sfatto del voto può chiedere<br />
<strong>di</strong> ripetere l’esame nella sessione successiva. In questo caso l’esame sarà<br />
comunque registrato sul verbale come nullo.<br />
• Un esame può essere annullato una sola volta, dopo vale come non superato.<br />
• Un esame non superato può essere ripetuto due volte.<br />
• Se alla terza volta lo studente non avrà superato l’esame, sarà tenuto a frequentare<br />
<strong>di</strong> nuovo il corso relativo.<br />
• Deroghe possono essere concesse dal Rettore solo su preavviso favorevole della<br />
Commissione Ammissione ed esami e per motivi molto gravi.<br />
Esami <strong>di</strong> grado<br />
• Bachelor of Theology:<br />
--<br />
1 copia della tesi va consegnata in segreteria allegando il formulario “Voto<br />
tesi” compilato dal Relatore e la lista <strong>degli</strong> esami sostenuti;<br />
--<br />
la stesura del lavoro scritto deve seguire le “Norme redazionali per i lavori<br />
scritti presentati presso la FTL”; scaricabili dal sito internet della FTL alla pagina<br />
www.teologialugano.ch/pdf/Normeredazionali.pdf.<br />
• Master of Theology/Baccellierato in <strong>Teologia</strong>:<br />
--<br />
il programma dell’esame finale orale, che tende alla verifica dell’assimilazione<br />
esatta, solida e personale dell’insieme delle <strong>di</strong>verse <strong>di</strong>scipline teologiche <strong>di</strong><br />
ciascuno studente, abbraccia 12 tesi principali (le domande delle 12 tesi sono<br />
<strong>di</strong>sponibili in segreteria);<br />
--<br />
la stesura del lavoro scritto deve seguire le “Norme redazionali per i lavori<br />
scritti presentati presso la FTL”; scaricabili dal sito internet della FTL alla pagina<br />
www.teologialugano.ch/pdf/Normeredazionali.pdf;<br />
--<br />
1 copia della tesi va consegnata in segreteria allegando il formulario “Voto<br />
tesi” compilato dal Relatore e la lista <strong>degli</strong> esami sostenuti.<br />
• Licenza canonica in <strong>Teologia</strong>:<br />
--<br />
il formulario <strong>di</strong> approvazione del titolo definitivo della tesi va consegnato in<br />
segreteria entro l’inizio del II anno;<br />
--<br />
4 copie rilegate della tesi devono essere consegnate in segreteria nei termini<br />
stabiliti dal calendario accademico, allegando la lista <strong>degli</strong> esami sostenuti;<br />
--<br />
il programma dell’esame finale comprende sia l’esposizione della tesi <strong>di</strong> Li-<br />
Ammissione e tasse accademiche<br />
31
Ammissione e tasse accademiche<br />
cenza canonica in <strong>Teologia</strong> sia la <strong>di</strong>scussione <strong>di</strong> 10 tesi (6 della specializzazione<br />
scelta e 4 riferite alle altre <strong>di</strong>scipline <strong>di</strong> specializzazione). L’elenco delle tesi<br />
per il corrente anno accademico sono <strong>di</strong>sponibili in segreteria.<br />
• Dottorato in <strong>Teologia</strong>:<br />
--<br />
si tenga presente che la <strong>di</strong>fesa della tesi <strong>di</strong> Dottorato è un atto accademico<br />
pubblico;<br />
--<br />
il formulario <strong>di</strong> approvazione del titolo definitivo della tesi va consegnato in<br />
segreteria entro l’inizio del II anno;<br />
--<br />
6 copie rilegate della tesi devono essere consegnate in segreteria almeno due<br />
mesi prima della <strong>di</strong>scussione;<br />
--<br />
alla fine della <strong>di</strong>fesa pubblica il Rettore o il suo rappresentante si limita a proclamare<br />
il can<strong>di</strong>dato Dottore, mentre la nota finale e la corrispondente menzione,<br />
nonché le con<strong>di</strong>zioni poste dalla giuria per la pubblicazione della <strong>di</strong>ssertazione,<br />
saranno comunicate dalla segreteria <strong>di</strong>rettamente all’interessato.<br />
32
4.4. Tasse accademiche<br />
4.4.1. Studenti or<strong>di</strong>nari e straor<strong>di</strong>nari<br />
Cicli <strong>di</strong> <strong>stu<strong>di</strong></strong>o<br />
Tasse in CHF (al semestre)<br />
Bachelor of Theology 900.--<br />
Master of Theology/Baccellierato in <strong>Teologia</strong> 900.--<br />
Licenza canonica in <strong>Teologia</strong> 900.--<br />
Dottorato in <strong>Teologia</strong> 1.000.--<br />
Master of Arts in Diritto canonico ed ecclesiastico<br />
1.100.--<br />
comparato<br />
Master of Arts in Scienza, filosofia e teologia<br />
1.100.--<br />
delle religioni<br />
Bachelor of Arts in Filosofia<br />
- Residenti in Svizzera:<br />
- Non residenti in Svizzera:<br />
2.000.--<br />
4.000.--<br />
Gli studenti “fuori corso” sono comunque tenuti al pagamento delle tasse intere, fino al<br />
conseguimento del titolo <strong>di</strong> <strong>stu<strong>di</strong></strong>o.<br />
Le iscrizioni al semestre accademico e ai relativi esami particolari e <strong>di</strong> grado sono valide<br />
unicamente previo pagamento della relativa tassa accademica semestrale 1 .<br />
4.4.2. Studenti u<strong>di</strong>tori 21<br />
Corsi frequentati fino a 12 ore fino a 26 ore fino a 39 ore fino a 52 ore<br />
1° corso semestrale CHF 100.-- CHF 200.-- CHF 250.-- CHF 300.--<br />
Ogni corso aggiunto CHF 50.-- CHF 100.-- CHF 125.-- CHF 150.--<br />
Ammissione e tasse accademiche<br />
4.4.3. Tasse d’esami<br />
a) Per gli esami particolari <strong>di</strong> materia non è prevista alcuna tassa;<br />
b) Tasse per gli esami <strong>di</strong> grado:<br />
--<br />
Master of Theology/Baccellierato in <strong>Teologia</strong> 300.--<br />
--<br />
Licenza canonica in <strong>Teologia</strong> 450.--<br />
--<br />
Dottorato in <strong>Teologia</strong> 800.--<br />
--<br />
Master of Arts in Scienza, filosofia e teologia delle religioni 100.--<br />
--<br />
Master of Arts in Diritto canonico ed ecclesiastico comparato 100.--<br />
1<br />
Per gravi e comprovati motivi, lo studente può sottoporre al Rettore della FTL una richiesta <strong>di</strong> congedo.<br />
Nel caso venga accettata, lo studente mantiene l’immatricolazione pagando una tassa ridotta e beneficiando<br />
della qualifica <strong>di</strong> studente senza frequentare attività <strong>di</strong>dattiche.<br />
2<br />
Per beneficiari AVS e AI la tassa è ridotta del 50% (è necessario allegare i giustificativi al formulario d’iscrizione).<br />
Sono esonerati dalla tassa gli studenti regolarmente immatricolati all’USI. Eventuali eccezioni (per<br />
esempio le Settimane <strong>di</strong> corsi e seminari intensivi), verranno segnalate a parte.<br />
33
Ammissione e tasse accademiche<br />
4.4.4. Rilascio documenti<br />
a) Attestato <strong>di</strong> frequenza (solo per u<strong>di</strong>tori) 20.--<br />
b) Bachelor of Theology 50.--<br />
c) Master of Theology/Baccellierato in <strong>Teologia</strong> 100.--<br />
d) Licenza canonica in <strong>Teologia</strong> 200.--<br />
e) Dottorato in <strong>Teologia</strong> 250.--<br />
f) Master of Arts in Scienza, filosofia e teologia delle religioni 50.--<br />
g) Master of Arts in Diritto canonico ed ecclesiastico comparato 50.--<br />
La Segreteria della FTL rilascia documenti solo su presentazione della ricevuta <strong>di</strong> avvenuto<br />
pagamento della tassa d’iscrizione<br />
4.4.5. Sussi<strong>di</strong> e borse <strong>di</strong> <strong>stu<strong>di</strong></strong>o<br />
Fin dai suoi inizi, e per volontà del fondatore S.E. Mons. Eugenio Corecco, Vescovo <strong>di</strong><br />
<strong>Lugano</strong>, la FTL fu orientata a sostenere studenti meritevoli, provenienti da ogni parte<br />
del mondo, e in particolare dall’Europa dell’Est.<br />
In più <strong>di</strong> un’occasione i suoi successori, S.E. Mons. Giuseppe Torti e S.E. Mons. Pier<br />
Giacomo Grampa, hanno riba<strong>di</strong>to che sostenere il fondo borse <strong>di</strong> <strong>stu<strong>di</strong></strong>o della FTL, per<br />
la Diocesi e per tutti i fedeli, è uno dei mo<strong>di</strong> più importanti <strong>di</strong> partecipare alla missione<br />
universale della Chiesa nel mondo.<br />
Per inoltrare le domande o chiedere informazioni più dettagliate rivolgersi a<br />
bds@teologialugano.ch e consultare il sito www.teologialugano.ch/borse<strong>stu<strong>di</strong></strong>o.php.<br />
Dove in<strong>di</strong>rizzare le richieste? Vengono considerate solo le e-mail<br />
inviate ai seguenti in<strong>di</strong>rizzi. Attenzione a usare l’in<strong>di</strong>rizzo apposito:<br />
• Domande per le borse <strong>di</strong> <strong>stu<strong>di</strong></strong>o (per l’anno <strong>2014</strong>/2015 scadenza:<br />
14.03.<strong>2014</strong>): bds@teologialugano.ch<br />
• Richiesta <strong>di</strong> attestati d’iscrizione, tabelle scholarum, richiesta <strong>di</strong> visto<br />
(con almeno 5 giorni <strong>di</strong> preavviso): attestati@teologialugano.ch<br />
• Richiesta <strong>di</strong> informazioni: info@teologialugano.ch<br />
34
5. Programma complessivo <strong>degli</strong> <strong>stu<strong>di</strong></strong><br />
5.1. Presentazione <strong>degli</strong> <strong>stu<strong>di</strong></strong> teologici<br />
Dall’anno accademico 2012/13 è stato introdotto un nuovo <strong>Piano</strong> <strong>degli</strong> <strong>stu<strong>di</strong></strong> per gli studenti<br />
in teologia. Il vecchio <strong>Piano</strong> <strong>degli</strong> <strong>stu<strong>di</strong></strong> rimane in vigore per tutti gli immatricolati<br />
entro l’anno accademico 2011/12 (5.3.1.), mentre per gli studenti immatricolati a partire<br />
dall’anno accademico 2012/13 si applica il nuovo <strong>Piano</strong> <strong>degli</strong> <strong>stu<strong>di</strong></strong> (5.3.2.).<br />
5.1.1. Bachelor of Theology<br />
Vecchio or<strong>di</strong>namento: Gli studenti devono ottenere in 6 semestri 180 ects che si<br />
sud<strong>di</strong>vidono in 163,5 ects <strong>di</strong> corsi prescritti e 16,5 ects <strong>di</strong> corsi a scelta incluso un seminario<br />
obbligatorio per ogni anno accademico. Inoltre, lo studente è tenuto a re<strong>di</strong>gere<br />
un elaborato finale <strong>di</strong> almeno 30 pagine 1 .<br />
Nuovo or<strong>di</strong>namento: Il Bachelor of Theology prevede due in<strong>di</strong>rizzi: teologico e teologico-filosofico.<br />
• L’in<strong>di</strong>rizzo teologico propone le materie teologiche fondamentali e permette <strong>di</strong><br />
proseguire gli <strong>stu<strong>di</strong></strong> in altre università. Gli studenti devono ottenere in 6 semestri<br />
181.5 ects, <strong>di</strong> cui 169.5 ects <strong>di</strong> corsi prescritti a cui vanno aggiunti 2 seminari obbligatori<br />
e la redazione <strong>di</strong> un elaborato finale <strong>di</strong> almeno 30 pagine.<br />
• L’in<strong>di</strong>rizzo teologico-filosofico è in<strong>di</strong>cato per coloro che intendono continuare con<br />
il Master of Theology/Baccellierato in <strong>Teologia</strong> 2 . Gli studenti devono ottenere in<br />
6 semestri 180 ects, <strong>di</strong> cui 164 ects <strong>di</strong> corsi prescritti e 16 ects <strong>di</strong> corsi a scelta<br />
inclusi 3 seminari obbligatori (1 <strong>di</strong> filosofia, 1 <strong>di</strong> sacra scrittura e 1 <strong>di</strong> teologia fondamentale)<br />
e un elaborato finale <strong>di</strong> almeno 30 pagine.<br />
Il triennio <strong>di</strong> Bachelor of Theology deve terminare entro 6 anni dalla data <strong>di</strong> iscrizione<br />
(termine massimo). Potranno essere concesse delle eccezioni solo dal Rettore della FTL.<br />
Per ottenere ciò lo studente dovrà presentare richiesta scritta quanto prima in Segreteria.<br />
Programma <strong>degli</strong> <strong>stu<strong>di</strong></strong><br />
5.1.2. Master of Theology/Baccellierato in <strong>Teologia</strong><br />
Vecchio or<strong>di</strong>namento: Il percorso canonico completo <strong>di</strong> teologia (che termina con il<br />
grado accademico <strong>di</strong> Master of Theology/Baccellierato in <strong>Teologia</strong>) implica l’acquisizione<br />
<strong>di</strong> un totale <strong>di</strong> 301,5 ects, <strong>di</strong> cui 241,5 <strong>di</strong> corsi prescritti, 40 <strong>di</strong> seminari obbligatori (2 <strong>di</strong><br />
Sacra Scrittura; 2 <strong>di</strong> teologia fondamentale; 2 <strong>di</strong> teologia dogmatica; 2 <strong>di</strong> teologia morale;<br />
2 <strong>di</strong> filosofia) e la redazione <strong>di</strong> un elaborato finale <strong>di</strong> almeno 50 pagine.<br />
1<br />
Per ottenere il Master of Theology/Baccellierato in <strong>Teologia</strong> dopo aver conseguito il Bachelor of Theology (vecchio<br />
or<strong>di</strong>namento), lo studente dovrà integrare il proprio piano <strong>degli</strong> <strong>stu<strong>di</strong></strong> secondo il percorso in<strong>di</strong>cato al<br />
punto 5.3.1.2.<br />
2<br />
Nel caso vi sia uno studente che volesse proseguire per l’ottenimento del Master of Theology/Baccellierato in<br />
<strong>Teologia</strong>, ma ha conseguito il Bachelor con l’in<strong>di</strong>rizzo teologico, sarà tenuto a recuperare gli esami mancanti<br />
necessari per l’iscrizione al Master of Theology/Baccellierato in <strong>Teologia</strong>, convalidando quelli già sostenuti nel<br />
triennio e prescritti nel biennio <strong>di</strong> specializzazione.<br />
35
Programma <strong>degli</strong> <strong>stu<strong>di</strong></strong><br />
Nuovo or<strong>di</strong>namento: Gli studenti devono ottenere in 4 semestri 120 ects che si sud<strong>di</strong>vidono<br />
in 94,5 ects <strong>di</strong> corsi prescritti e 25,5 ects <strong>di</strong> corsi a scelta, incluso un seminario<br />
obbligatorio per anno accademico (1 <strong>di</strong> teologia dogmatica e 1 <strong>di</strong> teologia morale) e la<br />
redazione <strong>di</strong> un elaborato finale <strong>di</strong> almeno 50 pagine.<br />
Il biennio <strong>di</strong> Master of Theology deve terminare entro 5 anni dalla data <strong>di</strong> iscrizione<br />
(termine massimo). Potranno essere concesse delle eccezioni solo dal Rettore della<br />
FTL. Per ottenere ciò lo studente dovrà presentare richiesta scritta quanto prima in<br />
Segreteria.<br />
5.1.3. Licenza canonica in <strong>Teologia</strong><br />
Lo studente può scegliere per la Licenza canonica in <strong>Teologia</strong> una delle seguenti specializzazioni:<br />
teologia biblica, teologia dogmatica, teologia morale e storia della teologia.<br />
Vecchio or<strong>di</strong>namento: Il titolo richiede la frequenza <strong>di</strong> 4 semestri per un totale <strong>di</strong><br />
72 ects: 52 ects <strong>di</strong> corsi <strong>di</strong> cui almeno 23/24 ects nell’area <strong>di</strong>sciplinare scelta e 20 ects<br />
<strong>di</strong> tesi scritta. Agli studenti che hanno conseguito il Master of Theology/Baccellierato in<br />
<strong>Teologia</strong> presso la FTL è richiesta la frequenza <strong>di</strong> 2 semestri per un totale <strong>di</strong> 60 ects: 40<br />
ects <strong>di</strong> corsi <strong>di</strong> cui almeno 23/24 ects nell’area <strong>di</strong>sciplinare scelta e 20 ects <strong>di</strong> tesi scritta.<br />
Nuovo or<strong>di</strong>namento: Per tutti i nuovi studenti immatricolati (anche per coloro che<br />
hanno conseguito il Master of Theology/Baccellierato in <strong>Teologia</strong> presso la FTL) il titolo<br />
prevede la frequenza <strong>di</strong> 4 semestri per un totale <strong>di</strong> 120 ects <strong>di</strong> cui almeno 23/24 ects<br />
nell’area <strong>di</strong>sciplinare scelta e 30 ects <strong>di</strong> tesi scritta.<br />
Per entrambi gli or<strong>di</strong>namenti valgono le seguenti in<strong>di</strong>cazioni:<br />
• Specializzazione in teologia biblica: è obbligatoria la frequenza <strong>di</strong> 4 corsi da 3 ects e<br />
2 seminari <strong>di</strong> teologia biblica, nonché 1 corso <strong>di</strong> 3 ects o 1 seminario <strong>di</strong> dogmatica.<br />
È richiesta anche una valutazione d’esame <strong>di</strong> lingua ebraica e <strong>di</strong> greco <strong>di</strong> secondo<br />
livello.<br />
• Specializzazione in teologia dogmatica: è obbligatoria la frequenza <strong>di</strong> 4 corsi da 3<br />
ects e 2 seminari <strong>di</strong> teologia dogmatica, nonché 1 corso <strong>di</strong> 3 ects o 1 seminario <strong>di</strong><br />
Sacra Scrittura.<br />
• Specializzazione in teologia morale: è obbligatoria la frequenza <strong>di</strong> 4 corsi da 3 ects<br />
e 2 seminari <strong>di</strong> teologia morale, nonché 1 corso <strong>di</strong> 3 ects o 1 seminario <strong>di</strong> Sacra<br />
Scrittura.<br />
• Specializzazione in storia della teologia: è obbligatoria la frequenza <strong>di</strong> 4 corsi da 3<br />
ects e 2 seminari <strong>di</strong> storia della teologia, nonché 1 corso <strong>di</strong> 3 ects o 1 seminario<br />
<strong>di</strong> teologia dogmatica.<br />
La tesi <strong>di</strong> Licenza canonica in <strong>Teologia</strong> deve comprovare l’attitu<strong>di</strong>ne dello studente alla<br />
ricerca scientifica. Il lavoro scritto deve seguire le “Norme redazionali per i lavori scritti<br />
presentati presso la FTL”, scaricabili dal sito internet della Facoltà alla pagina www.<br />
teologialugano.ch/pdf/Normeredazionali.pdf.<br />
All’inizio del ciclo lo studente sceglie una specializzazione e non può iscriversi contemporaneamente<br />
a due o più specializzazioni.<br />
36
Il biennio <strong>di</strong> Licenza canonica in <strong>Teologia</strong> deve terminare entro 5 anni dalla data <strong>di</strong> iscrizione<br />
(termine massimo). Potranno essere concesse delle eccezioni solo dal Rettore<br />
della FTL. Per ottenere ciò lo studente dovrà presentare richiesta scritta quanto prima<br />
in Segreteria.<br />
5.1.4. Dottorato in <strong>Teologia</strong><br />
Il ciclo <strong>di</strong> Dottorato richiede la frequenza <strong>di</strong> un minimo <strong>di</strong> 4 semestri ad un massimo <strong>di</strong><br />
6 semestri. La durata può essere prorogata <strong>di</strong> altri 6 semestri solo in casi eccezionali e<br />
previa autorizzazione scritta del Rettore e del Direttore della tesi.<br />
È aperto solo agli studenti che hanno conseguito il titolo <strong>di</strong> Licenza canonica in <strong>Teologia</strong><br />
con una valutazione pari almeno a 8 punti su 10.<br />
Agli studenti che hanno conseguito la Licenza canonica in <strong>Teologia</strong> presso la FTL, è richiesta<br />
nel primo anno la frequenza <strong>di</strong> 2 corsi ed 1 seminario, con obbligo d’esame,<br />
scelti <strong>di</strong> comune accordo con il <strong>di</strong>rettore della tesi.<br />
Gli studenti che invece hanno conseguito la Licenza canonica in <strong>Teologia</strong> in un’altra Facoltà<br />
devono seguire, nel primo anno, 2 corsi e 1 seminario per semestre, con obbligo<br />
d’esame, scelti <strong>di</strong> comune accordo con il <strong>di</strong>rettore della tesi.<br />
La stesura della <strong>di</strong>ssertazione <strong>di</strong> Dottorato deve seguire i criteri esposti nel documento<br />
“Norme redazionali per i lavori scritti presentati presso la FTL”, scaricabili dal sito internet<br />
della FTL alla pagina www.teologialugano.ch/pdf/Normeredazionali.pdf.<br />
Il conferimento del titolo è subor<strong>di</strong>nato alla pubblicazione della tesi o almeno della sua<br />
parte principale, consegnando in segreteria 10 volumi della stessa.<br />
Programma <strong>degli</strong> <strong>stu<strong>di</strong></strong><br />
5.2. Altri percorsi<br />
- Bachelor of Arts in Filosofia<br />
Il <strong>Piano</strong> <strong>degli</strong> <strong>stu<strong>di</strong></strong> del Bachelor of Arts in Filosofia può essere richiesto alla segreteria<br />
dell’ISFI oppure scaricato dal sito internet: www.isfi.ch.<br />
- Master of Arts in Diritto canonico ed ecclesiastico comparato<br />
Due specializzazioni: Diritto canonico comparato e Diritto comparato delle religioni.<br />
Il <strong>Piano</strong> <strong>degli</strong> <strong>stu<strong>di</strong></strong> del Master of Arts in Diritto canonico ed ecclesiastico comparato può<br />
essere richiesto alla segreteria dell’Istituto DiReCom oppure scaricato dal sito internet:<br />
www.teologialugano.ch/<strong>di</strong>recom.php.<br />
- Master of Arts in Scienza, filosofia e teologia delle religioni<br />
Il <strong>Piano</strong> <strong>degli</strong> <strong>stu<strong>di</strong></strong> del Master of Arts in Scienza, filosofia e teologia delle religioni può<br />
essere richiesto alla segreteria dell’Istituto Rete oppure scaricato dal sito internet:<br />
www.teologialugano.ch/rete.php.<br />
37
5.3. Presentazione dettagliata<br />
• I co<strong>di</strong>ci dei corsi sono composti da quattro caratteri e sono da interpretare come<br />
segue: i due caratteri iniziali in<strong>di</strong>cano la <strong>di</strong>sciplina e le ultime due lettere in<strong>di</strong>cano<br />
il carattere del corso (CP: corso prescritto; CO: corso opzionale; SO: seminario<br />
opzionale).<br />
Programma <strong>degli</strong> <strong>stu<strong>di</strong></strong><br />
Legenda:<br />
L’orario dei corsi è consultabile in bacheca o nel sito web della FTL:<br />
www.teologialugano.ch/corsi.php<br />
Per eventuali cambiamenti d’orario e altre precisazioni:<br />
www.teologialugano.ch/avvisi.php<br />
AT: Antico Testamento<br />
DC: Diritto canonico<br />
DI: Diversi<br />
FF: Filosofia<br />
IT: Introduzione alla <strong>Teologia</strong><br />
LT: Liturgia<br />
NT: Nuovo Testamento<br />
PA: Patristica<br />
SC: Storia della Chiesa<br />
SI: Settimana intensiva<br />
TD: <strong>Teologia</strong> dogmatica<br />
TF: <strong>Teologia</strong> fondamentale<br />
TM: <strong>Teologia</strong> morale<br />
TP: <strong>Teologia</strong> pastorale<br />
38
5.3.1. Vecchio or<strong>di</strong>namento (studenti immatricolati entro l’a.a. 2011/12)<br />
L’orario dei corsi è consultabile in bacheca o nel sito web della FTL: www.teologialugano.ch/corsi.php<br />
Per eventuali cambiamenti d’orario e altre precisazioni: www.teologialugano.ch/avvisi.php<br />
5.3.1.1. Bachelor of Theology<br />
In seguito all’entrata in vigore del nuovo or<strong>di</strong>namento, nel corrente anno accademico<br />
sarà attivato unicamente il terzo anno (cf. 5.1.).<br />
III anno – Semestre autunnale<br />
Sigla Corso Professore Ects<br />
TDCP <strong>Teologia</strong> sacramentaria: Eucaristia H.C. Schmidbaur 3<br />
ATCP Sapienza d’Israele G. Paxima<strong>di</strong> 4.5<br />
DCCP <strong>Teologia</strong> del <strong>di</strong>ritto canonico e norme generali I L. Gerosa 3<br />
DICP Lingua ebraica A* M. Fidanzio –<br />
FFCP <strong>Teologia</strong> naturale G. Sgubbi 3<br />
TMCP <strong>Teologia</strong> morale fondamentale III: “la <strong>di</strong>mensione A.-M. Jerumanis / L. Pellicioli 3<br />
drammatica dell’agire morale”<br />
TFCP Fede e ragione G. Sgubbi 3<br />
TMCP <strong>Teologia</strong> morale speciale I: Una morale del cuore A.-M. Jerumanis / L. Pellicioli 3<br />
filiale<br />
SCCP Storia della Chiesa III: riforma protestante e cattolica<br />
S. Negruzzo 3<br />
DICP <strong>Teologia</strong> e spiritualità dell’Oriente cristiano A. Chiappini 3<br />
TDCP Cristologia: parte biblico-storica M. Hauke 3<br />
Totale ects 31.5<br />
Programma <strong>degli</strong> <strong>stu<strong>di</strong></strong><br />
III anno – Semestre primaverile<br />
Sigla Corso Professore Ects<br />
DCCP Diritto costituzionale canonico I L. Gerosa 3<br />
DICP Lingua ebraica A* M. Fidanzio –<br />
TDCP Ecclesiologia H.C. Schmidbaur 6<br />
NTCP Letteratura giovannea M. Orsatti 6<br />
TDCP <strong>Teologia</strong> sacramentaria: Or<strong>di</strong>ne, Penitenza, Unzione<br />
H.C. Schmidbaur 3<br />
<strong>degli</strong> infermi<br />
TDCP Il mistero del Dio rivelato G. Sgubbi 6<br />
TPCP <strong>Teologia</strong> pastorale: scopo e mezzi C. Laim 3<br />
Totale ects 27<br />
* Questo corso dura 2 semestri.<br />
39
Seminari (SO) / Corsi (CO) a scelta nell’arco dei tre anni<br />
Programma <strong>degli</strong> <strong>stu<strong>di</strong></strong><br />
Ve<strong>di</strong> lista infra 5.3.3. e 5.3.4.<br />
Sigla Corso Ects<br />
SO Seminario a scelta Durante il I anno 4<br />
SO Seminario a scelta Durante il II anno 4<br />
SO Seminario a scelta Durante il III anno 4<br />
CO Corso a scelta 3<br />
CO Corso a scelta 1.5<br />
LS<br />
Lavoro scritto (30 pagine)<br />
Totale ects 16.5<br />
40
5.3.1.2. Master of Theology/Baccellierato in <strong>Teologia</strong><br />
In seguito all’entrata in vigore del nuovo or<strong>di</strong>namento, nel corrente anno accademico<br />
saranno attivati il terzo, quarto e quinto anno (cf. 5.1.).<br />
III anno – Semestre autunnale<br />
Sigla Corso Professore Ects<br />
TDCP <strong>Teologia</strong> sacramentaria: Eucaristia H.C. Schmidbaur 3<br />
ATCP Sapienza d’Israele G. Paxima<strong>di</strong> 4.5<br />
DCCP <strong>Teologia</strong> del <strong>di</strong>ritto canonico e norme generali I L. Gerosa 3<br />
DICP Lingua ebraica A* M. Fidanzio –<br />
FFCP <strong>Teologia</strong> naturale G. Sgubbi 3<br />
TMCP <strong>Teologia</strong> morale fondamentale III: “la <strong>di</strong>mensione A.-M. Jerumanis / L. Pellicioli 3<br />
drammatica dell’agire morale”<br />
TFCP Fede e ragione G. Sgubbi 3<br />
TMCP <strong>Teologia</strong> morale speciale I: Una morale del cuore A.-M. Jerumanis / L. Pellicioli 3<br />
filiale<br />
SCCP Storia della Chiesa III: riforma protestante e cattolica<br />
S. Negruzzo 3<br />
DICP <strong>Teologia</strong> e spiritualità dell’Oriente cristiano A. Chiappini 3<br />
Totale ects 28.5<br />
Programma <strong>degli</strong> <strong>stu<strong>di</strong></strong><br />
III anno – Semestre primaverile<br />
Sigla Corso Professore Ects<br />
DCCP Diritto costituzionale canonico I L. Gerosa 3<br />
DICP Lingua ebraica A* M. Fidanzio –<br />
TDCP Ecclesiologia H.C. Schmidbaur 6<br />
NTCP Letteratura giovannea M. Orsatti 6<br />
TDCP <strong>Teologia</strong> sacramentaria: Or<strong>di</strong>ne, Penitenza, Unzione<br />
H.C. Schmidbaur 3<br />
<strong>degli</strong> infermi<br />
TDCP Il mistero del Dio rivelato G. Sgubbi 6<br />
TPCP <strong>Teologia</strong> pastorale: scopo e mezzi C. Laim 3<br />
Totale ects 27<br />
* Questo corso dura 2 semestri.<br />
41
Programma <strong>degli</strong> <strong>stu<strong>di</strong></strong><br />
IV anno – Semestre autunnale<br />
Sigla Corso Professore Ects<br />
TMCP <strong>Teologia</strong> morale speciale II: eros e agape A.-M. Jerumanis / L. Pellicioli 3<br />
ATCP Salmi M. Fidanzio 1.5<br />
TDCP Cristologia: parte biblico-storica M. Hauke 3<br />
TDCP Escatologia H.C. Schmidbaur 3<br />
TDCP Mariologia M. Hauke 3<br />
DCCP Istituzioni generali <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto canonico L. Gerosa / A. Stabellini 3<br />
TMCP <strong>Teologia</strong> del matrimonio E.W. Volonté 3<br />
TMCP Introduzione alla Dottrina sociale della Chiesa: la M. Krienke 3<br />
Chiesa e la sfida del post-umanesimo<br />
SCCP Storia della Chiesa IV: gli ultimi 3 secoli C. Cattaneo 3<br />
LTCP Liturgia pastorale e pratica N. Zanini 3<br />
Totale ects 28.5<br />
IV anno – Semestre primaverile<br />
Sigla Corso Professore Ects<br />
TPCP Didattica dell’istruzione religiosa C. Laim 3<br />
DICP Introduzione alla teologia spirituale V. Lazzeri 3<br />
LTCP Anno liturgico N. Zanini 3<br />
FFCP Filosofia della natura e della scienza A. Giordani 4.5<br />
TDCP Cristologia: parte sistematica M. Hauke 4.5<br />
TDCP La creazione e il peccato originale M. Hauke 3<br />
FFCP Filosofia cristiana: Fides quaerens intellectum: L’impegno<br />
C. Marabelli 6<br />
razionale della ricerca teologica <strong>di</strong> Anselmo<br />
d’Aosta<br />
Totale ects 27<br />
42
V anno – Semestre autunnale<br />
Sigla Corso Professore Ects<br />
DCCP Diritto matrimoniale canonico G. Eisenring / M. Magarotto 3<br />
Varini<br />
TDCP Storia dei dogmi M. Hauke 3<br />
DICP L’uomo alla luce del mistero del Dio unitrino A. Varsalona 3<br />
FFCP Corso monografico in filosofia moderna: La critica M. Krienke 3<br />
della ragion pura<br />
Non si attiva nell’a.a. <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong><br />
DCCP Diritto costituzionale canonico II (I parte) A. Cattaneo 1.5<br />
Totale ects 13.5<br />
V anno – Semestre primaverile<br />
Sigla Corso Professore Ects<br />
TDCP <strong>Teologia</strong> della Grazia H.C. Schmidbaur 3<br />
PACP <strong>Teologia</strong> dei Padri V. Lazzeri 3<br />
TMCP <strong>Teologia</strong> morale speciale III: introduzione alla Bioetica<br />
A.-M. Jerumanis / L. Pellicioli 3<br />
DCCP Diritto canonico e pastorale L. Gerosa 3<br />
LS Lavoro scritto 20<br />
Totale ects 32<br />
Programma <strong>degli</strong> <strong>stu<strong>di</strong></strong><br />
Corsi obbligatori per i seminaristi della Diocesi <strong>di</strong> <strong>Lugano</strong><br />
Sigla Corso Professore Ects<br />
DCCO La funzione <strong>di</strong> insegnare della Chiesa 1<br />
A. Stabellini 1.5<br />
Semestre primaverile<br />
DCSO Diritto ecclesiastico svizzero: parte generale V. Pacillo 4<br />
Semestre autunnale<br />
DCCO La funzione <strong>di</strong> santificare della Chiesa 1<br />
Semestre autunnale<br />
Si attiva nell’a.a. <strong>2014</strong>/2015<br />
A. Cattaneo 1.5<br />
• Nota: Il CdF decide che gli studenti seminaristi destinati alla Diocesi <strong>di</strong> <strong>Lugano</strong>, svolgeranno, oltre a<br />
tutti i corsi previsti dal <strong>Piano</strong> <strong>degli</strong> <strong>stu<strong>di</strong></strong>, anche i corsi <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto canonico obbligatori solo per loro. Essi<br />
quin<strong>di</strong> supereranno i 301.5 ECTS.<br />
43
5.3.2. Nuovo or<strong>di</strong>namento (studenti immatricolati a partire dall’a.a. 2012/13)<br />
L’orario dei corsi è consultabile in bacheca o nel sito web della FTL: www.teologialugano.ch/corsi.php<br />
Per eventuali cambiamenti d’orario e altre precisazioni: www.teologialugano.ch/avvisi.php<br />
5.3.2.1. Bachelor of Theology in<strong>di</strong>rizzo teologico-filosofico<br />
Programma <strong>degli</strong> <strong>stu<strong>di</strong></strong><br />
Nel corrente anno accademico saranno attivati il primo e il secondo anno (cf. 5.1.).<br />
I anno – Semestre autunnale<br />
Sigla Corso Professore Ects<br />
ATCP Introduzione all’AT M. Fidanzio / M. Sala 4.5<br />
DICP Psicologia generale C. Calanchini 3<br />
FFCP Storia della filosofica antica C. Marabelli 4.5<br />
FFCP Storia della filosofia antica - corso monografico* C. Marabelli 1.5<br />
FFCP Introduzione alla filosofia G. Ventimiglia / L. Urbani 3<br />
Ulivi<br />
DICP Lingua latina*** A. Tombolini -<br />
FFCP Logica classica A. Giordani 4<br />
FFCP Antropologia filosofica G. Ventimiglia / N.N. 4.5<br />
FFCP Antropologia filosofica - corso monografico* G. Ventimiglia / N.N. 1.5<br />
DICP Metodologia del lavoro scientifico A. Palese -<br />
DICP Lingua italiana** A. Tombolini -<br />
Totale ects 26.5<br />
I anno – Semestre primaverile<br />
Sigla Corso Professore Ects<br />
NTCP Introduzione al NT M. Fidanzio 3<br />
FFCP Storia della filosofia me<strong>di</strong>evale C. Marabelli 4.5<br />
FFCP Storia della filosofia me<strong>di</strong>evale - corso monografico* C. Marabelli 1.5<br />
ITCP Iniziazione allo <strong>stu<strong>di</strong></strong>o della teologia V. Lazzeri 3<br />
LTCP Introduzione alla liturgia N. Zanini 3<br />
DICP Lingua latina*** A. Tombolini –<br />
FFCP Filosofia politica M. Krienke 3<br />
DICP Lingua italiana** A. Tombolini<br />
FFCP Logica contemporanea A. Giordani 4<br />
SCCP Storia della Chiesa I: antica M. Hauke 3<br />
Totale ects 25<br />
44
II anno – Semestre autunnale<br />
Sigla Corso Professore Ects<br />
ATCP Introduzione ai libri storici A. Paxima<strong>di</strong> 6<br />
FFCP <strong>Teologia</strong> naturale G. Sgubbi 3<br />
FFCP Teoria della conoscenza M. Lenoci 4.5<br />
FFCP Teoria della conoscenza - corso monografico* M. Lenoci 1.5<br />
PACP Introduzione alla patrologia V. Lazzeri 4.5<br />
FFCP Storia della filosofia moderna M. Krienke 4.5<br />
FFCP Storia della filosofia moderna - corso monografico* S. Ta<strong>di</strong>ni 1.5<br />
SCCP Storia della Chiesa II: me<strong>di</strong>evale C. Cattaneo 3<br />
DICP Lingua latina*** A. Tombolini -<br />
DICP Lingua greca A** J.-C. Lechner -<br />
II anno – Semestre primaverile<br />
Totale ects 28.5<br />
Sigla Corso Professore Ects<br />
TFCP <strong>Teologia</strong> fondamentale – la Rivelazione G. Sgubbi 6<br />
FFCP Filosofia della natura della scienza e della tecnica A. Giordani 3<br />
FFCP Storia della filosofia contemporanea R. Corvi 4.5<br />
FFCP Storia della filosofia contemporanea - corso monografico*<br />
A. Fabris 1.5<br />
FFCP Ontologia G. Ventimiglia / N.N. 4.5<br />
FFCP Ontologia - corso monografico* G. Ventimiglia / N.N. 1.5<br />
FFCP Etica generale M. Krienke 4.5<br />
FFCP Etica generale - corso monografico* M. Krienke 1.5<br />
DICP Lingua greca A** J.-C. Lechner -<br />
Totale ects 27<br />
Programma <strong>degli</strong> <strong>stu<strong>di</strong></strong><br />
* Corso monografico e/o lettura testi.<br />
** Questo corso dura 2 semestri.<br />
*** Questo corso dura 3 semestri.<br />
45
Programma <strong>degli</strong> <strong>stu<strong>di</strong></strong><br />
III anno – Semestre autunnale – non attivato nell’a.a. <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong><br />
Sigla Corso Professore Ects<br />
NTCP I Vangeli sinottici M. Orsatti 6<br />
SCCP Storia della Chiesa III: riforma protestante e cattolica<br />
S. Negruzzo 3<br />
DCCP <strong>Teologia</strong> del <strong>di</strong>ritto canonico e norme generali I L. Gerosa 3<br />
DICP Lingua ebraica A** M. Fidanzio –<br />
TDCP <strong>Teologia</strong> sacramentaria: Introduzione generale, H.C. Schmidbaur 4.5<br />
Battesimo, Confermazione<br />
TDCP Cristologia M. Hauke 6<br />
TMCP <strong>Teologia</strong> morale fondamentale I A.-M. Jerumanis / L. Pellicioli 6<br />
Totale ects 28.5<br />
III anno – Semestre primaverile – non attivato nell’a.a. <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong><br />
Sigla Corso Professore Ects<br />
SCCP Storia della Chiesa IV: gli ultimi 3 secoli C. Cattaneo 3<br />
NTCP Letteratura paolina M. Orsatti 6<br />
ATCP Profeti G. Paxima<strong>di</strong> 4.5<br />
TDCP <strong>Teologia</strong> sacramentaria: Eucaristia H.C. Schmidbaur 3<br />
DCCP Diritto costituzionale canonico I L. Gerosa 3<br />
TMCP <strong>Teologia</strong> morale fondamentale II A.-M. Jerumanis / L. Pellicioli 3<br />
DICP Lingua ebraica A** M. Fidanzio -<br />
TDCP Il mistero del Dio rivelato G. Sgubbi 6<br />
Totale ects 28.5<br />
* Corso monografico e/o lettura testi.<br />
** Questo corso dura 2 semestri.<br />
Totale corsi prescritti 164<br />
3 seminari obbligatori 12<br />
Lavoro scritto 4<br />
Totale 180<br />
46
5.3.2.2. Bachelor of Theology in<strong>di</strong>rizzo teologico<br />
Per sapere quali corsi si attivano, consultare gli orari sul sito della Facoltà.<br />
Lingue e corsi propedeutici<br />
Sigla Corso Professore Ects<br />
DICP Lingua italiana (2 semestri) A. Tombolini -<br />
DICP Lingua latina (3 semestri) A. Tombolini -<br />
DICP Lingua greca (2 semestri) J.-C. Lechner -<br />
DICP Metodologia del lavoro scientifico A. Palese -<br />
Totale ects -<br />
Filosofia<br />
Sigla Corso Professore Ects<br />
FFCP Introduzione alla filosofia G. Ventimiglia / L. Urbani 3<br />
Ulivi<br />
FFCP Storia della filosofia antica C. Marabelli 4.5<br />
FFCP Storia della filosofia antica - corso monografico* C. Marabelli 1.5<br />
FFCP Storia della filosofia me<strong>di</strong>evale C. Marabelli 4.5<br />
FFCP Storia della filosofia me<strong>di</strong>evale - corso monografico* C. Marabelli 1.5<br />
FFCP Storia della filosofia moderna M. Krienke 4.5<br />
FFCP Storia della filosofia moderna - corso monografico* S. Ta<strong>di</strong>ni 1.5<br />
FFCP Storia della filosofia contemporanea R. Corvi 4.5<br />
FFCP Storia della filosofia contemporanea - corso monografico*<br />
A. Fabris 1.5<br />
FFCP Ontologia G. Ventimiglia / N.N. 4.5<br />
FFCP Ontologia - corso monografico* G. Ventimiglia / N.N. 1.5<br />
FFCP Etica generale M. Krienke 4.5<br />
FFCP Etica generale - corso monografico* M. Krienke 1.5<br />
FFCP Teoria della conoscenza M. Lenoci 4.5<br />
FFCP Teoria della conoscenza - corso monografico* M. Lenoci 1.5<br />
FFCP Antropologia filosofica G. Ventimiglia / N.N. 4.5<br />
FFCP Antropologia filosofica - corso monografico* G. Ventimiglia / N.N. 1.5<br />
FFCP <strong>Teologia</strong> naturale G. Sgubbi 3<br />
Totale ects 54<br />
Programma <strong>degli</strong> <strong>stu<strong>di</strong></strong><br />
47
Programma <strong>degli</strong> <strong>stu<strong>di</strong></strong><br />
<strong>Teologia</strong><br />
Sigla Corso Professore Ects<br />
ATCP Introduzione all’AT M. Fidanzio / M. Sala 4.5<br />
NTCP Introduzione al NT M. Fidanzio 3<br />
ATCP Introduzione ai libri storici G. Paxima<strong>di</strong> 6<br />
ATCP Profeti G. Paxima<strong>di</strong> 4.5<br />
ATCP Sapienza d’Israele G. Paxima<strong>di</strong> 4.5<br />
NTCP I Vangeli sinottici M. Orsatti 6<br />
NTCP Letteratura paolina M. Orsatti 6<br />
NTCP Letteratura giovannea M. Orsatti 6<br />
SCCP Storia della Chiesa I: antica M. Hauke 3<br />
SCCP Storia della Chiesa II: me<strong>di</strong>evale C. Cattaneo 3<br />
SCCP Storia della Chiesa III: riforma protestante e cattolica S. Negruzzo 3<br />
SCCP Storia della Chiesa IV: gli ultimi 3 secoli C. Cattaneo 3<br />
ITCP Iniziazione allo <strong>stu<strong>di</strong></strong>o della teologia V. Lazzeri 3<br />
PACP Introduzione alla patrologia V. Lazzeri 4.5<br />
LTCP Introduzione alla liturgia N. Zanini 3<br />
TFCP <strong>Teologia</strong> fondamentale – la Rivelazione G. Sgubbi 6<br />
TDCP <strong>Teologia</strong> sacramentaria: Introduzione generale, H.C. Schmidbaur 4.5<br />
Battesimo, Confermazione<br />
TDCP <strong>Teologia</strong> sacramentaria: Eucaristia H.C. Schmidbaur 3<br />
TDCP <strong>Teologia</strong> sacramentaria: Or<strong>di</strong>ne, Penitenza, Unzione<br />
H.C. Schmidbaur 3<br />
<strong>degli</strong> infermi<br />
TDCP Cristologia M. Hauke 6<br />
TDCP Il mistero del Dio rivelato G. Sgubbi 6<br />
TDCP Ecclesiologia H.C. Schmidbaur 6<br />
TDCP Escatologia H.C. Schmidbaur 3<br />
DICP <strong>Teologia</strong> e spiritualità dell’Oriente cristiano A. Chiappini 3<br />
TMCP <strong>Teologia</strong> morale fondamentale I A.-M. Jerumanis / L. Pellicioli 6<br />
TMCP <strong>Teologia</strong> morale fondamentale II A.-M. Jerumanis / L. Pellicioli 3<br />
DCCP <strong>Teologia</strong> del <strong>di</strong>ritto canonico e norme generali I L. Gerosa 3<br />
Totale ects 115.5<br />
* Corso monografico e/o lettura testi.<br />
Totale corsi prescritti 169.5<br />
2 seminari obbligatori 8<br />
Lavoro scritto 4<br />
Totale 181.5<br />
48
5.3.2.3. Master of Theology<br />
Master I anno – Semestre autunnale<br />
Sigla Corso Professore Ects<br />
ATCP Sapienza d’Israele G. Paxima<strong>di</strong> 4.5<br />
TMCP <strong>Teologia</strong> del matrimonio E.W. Volonté 3<br />
TMCP <strong>Teologia</strong> morale speciale I A.-M. Jerumanis 3<br />
ATCP Salmi M. Fidanzio 1.5<br />
TFCP Fede e Ragione G. Sgubbi 3<br />
TDCP Escatologia H.C. Schmidbaur 3<br />
TMCP <strong>Teologia</strong> morale fondamentale III: la <strong>di</strong>mensione A.-M. Jerumanis / L. Pellicioli 3<br />
drammatica dell’agire morale<br />
DCCP Istituzioni generali <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto canonico L. Gerosa / A. Stabellini 3<br />
TMCP Introduzione alla Dottrina sociale della Chiesa: la M. Krienke 3<br />
Chiesa e la sfida del post-umanesimo<br />
Totale ects 27<br />
Master I anno – Semestre primaverile<br />
Sigla Corso Professore Ects<br />
FFCP Corso <strong>di</strong> filosofia cristiana C. Marabelli 6<br />
TDCP Ecclesiologia H.C. Schmidbaur 6<br />
NTCP Letteratura giovannea M. Orsatti 6<br />
TDCP <strong>Teologia</strong> sacramentaria: Or<strong>di</strong>ne, Penitenza, Unzione<br />
H.C. Schmidbaur 3<br />
<strong>degli</strong> infermi<br />
TPCP <strong>Teologia</strong> pastorale: scopo e mezzi C. Laim 3<br />
DICP Introduzione alla teologia spirituale V. Lazzeri 3<br />
DICP <strong>Teologia</strong> e spiritualità dell’Oriente cristiano A. Chiappini 3<br />
Totale ects 30<br />
Programma <strong>degli</strong> <strong>stu<strong>di</strong></strong><br />
Master II anno – Semestre autunnale<br />
Sigla Corso Professore Ects<br />
LTCP Liturgia pastorale e pratica N. Zanini 3<br />
TDCP La creazione e il peccato originale M. Hauke 3<br />
PACP <strong>Teologia</strong> dei Padri V. Lazzeri 3<br />
TFCP L’uomo alla luce del mistero del Dio Unitrino A. Varsalona 3<br />
DCCP Diritto matrimoniale canonico G. Eisenring / M. Magarotto 3<br />
Varini<br />
TDCP Storia dei dogmi M. Hauke 3<br />
DCCP Diritto costituzionale canonico II (I parte) A. Cattaneo 1.5<br />
Totale ects 19.5<br />
49
Programma <strong>degli</strong> <strong>stu<strong>di</strong></strong><br />
Master II anno – Semestre primaverile<br />
Sigla Corso Professore Ects<br />
TPCP Didattica dell’istruzione religiosa C. Laim 3<br />
TDCP Mariologia M. Hauke 3<br />
LTCP Anno liturgico N. Zanini 3<br />
TDCP <strong>Teologia</strong> della Grazia H.C. Schmidbaur 3<br />
TMCP <strong>Teologia</strong> morale speciale II A.-M. Jerumanis / L. Pellicioli 3<br />
TPCP Diritto canonico e pastorale L. Gerosa 3<br />
Totale ects 18<br />
Totale corsi prescritti 94.5<br />
2 seminari obbligatori + corsi a scelta 13.5<br />
Lavoro scritto 12<br />
Totale 120<br />
Totale complessivo Bachelor + Master 300<br />
50
5.3.3. Corsi opzionali<br />
L’orario dei corsi è consultabile in bacheca o nel sito web della FTL: www.teologialugano.ch/corsi.php<br />
Per eventuali cambiamenti d’orario e altre precisazioni: www.teologialugano.ch/avvisi.php<br />
Per gli studenti del ciclo <strong>di</strong> Licenza canonica in <strong>Teologia</strong> è possibile, concordando con il<br />
<strong>di</strong>rettore della tesi, scegliere i corsi prescritti per il quinquennio <strong>di</strong> <strong>Teologia</strong> a con<strong>di</strong>zione<br />
che non siano già stati frequentati in precedenza.<br />
Semestre autunnale<br />
Sigla Corso Professore Ects<br />
DCCO Diritto costituzionale canonico II A. Cattaneo 3<br />
DCCO Le sanzioni nella Chiesa A. Cattaneo 3<br />
DCCO Istituzioni <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto romano G. Eisenring 3<br />
DCCO Musulmani in Europa: sfida ed opportunità per la S. Ferrari 1.5<br />
libertà religiosa<br />
DCCO Diritto bud<strong>di</strong>sta D. Francavilla 1.5<br />
DCCO Diritti e popoli nel Magistero <strong>di</strong> Giovanni Paolo II L. Gerosa 1.5<br />
DCCO Diritto delle Società <strong>di</strong> Vita Apostolica e Prelature A. Kukla 1.5<br />
personali: <strong>di</strong>fferenze e analogie<br />
DCCO Introduzione alle fonti del <strong>di</strong>ritto ebraico e temi G. Laras 3<br />
scelti <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto matrimoniale ebraico<br />
DCCO Funzione <strong>di</strong> insegnare e santificare: CIC e CCEO A. Stabellini 3<br />
comparati<br />
DICO Introduzione all’ebraismo P. Alborghetti 3<br />
DICO <strong>Teologia</strong> dell’Olocausto R. Bernasconi 3<br />
DICO Il Cristo glorioso e la storia universale in lui predestinata<br />
I. Biffi -<br />
Prosegue nel semestre primaverile<br />
DICO L’identità teologica del protestantesimo P. de Petris 3<br />
DICO Introduzione alla teologia bizantino-ortodossa E. Foglia<strong>di</strong>ni 3<br />
DICO Lingua ebraica B<br />
G. Paxima<strong>di</strong> -<br />
Prosegue nel semestre primaverile<br />
DICO Lingua greca B<br />
J.-C. Lechner -<br />
Prosegue nel semestre primaverile<br />
DICO Introduzione alla critica testuale N.N. 1.5<br />
DICO Latinità I e II<br />
A. Tombolini -<br />
Prosegue nel semestre primaverile<br />
FFCO Filosofia ebraica. Antica e me<strong>di</strong>evale P. Alborghetti 3<br />
FFCO Estetica generale R. Diodato 3<br />
FFCO Filosofia e religione A. Fabris 3<br />
Programma <strong>degli</strong> <strong>stu<strong>di</strong></strong><br />
51
Programma <strong>degli</strong> <strong>stu<strong>di</strong></strong><br />
FFCO Pluralismo culturale e modelli <strong>di</strong> giustizia (Filosofia P. Gomarasca 3<br />
del <strong>di</strong>alogo interculturale)<br />
FFCO Morale, democrazie e conformismo in Kenneth C. Lottieri 3<br />
Minogue (Filosofia delle scienze sociali 3)<br />
FFCO Tesi e controversie sull’universo normativo (filosofia<br />
C. Lottieri 3<br />
del <strong>di</strong>ritto 3)<br />
FFCO La <strong>di</strong>alettica d’amore tra Eloisa e Abelardo, premessa<br />
C. Marabelli 3<br />
a un progetto <strong>di</strong> vita religiosa<br />
LTCO Liturgia delle Ore romana N. Zanini 3<br />
NTCO Dalla profezia all’apocalittica nell’uno e nell’altro F. Manzi 3<br />
Testamento<br />
NTCO Armonia e tensioni nella comunità <strong>di</strong> Corinto. La M. Orsatti 3<br />
Seconda Lettera <strong>di</strong> Paolo ai Corinti<br />
NTCO Il Vangelo della domenica M. Orsatti 3<br />
PACO La questione “mistica” e l’università V. Lazzeri 3<br />
SICO Dialogo interreligioso oggi: <strong>di</strong>fficoltà e prospettive G. Battaglia 1.5<br />
SICO La filosofia dell’amore nel Me<strong>di</strong>oevo (da Bernardo R. Imbach 2<br />
Di Chiaravalle a Marsilio Ficino)<br />
SICO Amore ed emozioni nella filosofia moderna e contemporanea<br />
G. Soldati 2<br />
SICO Pluralità, <strong>di</strong>ssidenza, confronto nel <strong>di</strong>alogo religioso S. Violi 1.5<br />
tra XI e XII<br />
TDCO Il ministero petrino M. Hauke 3<br />
TDCO Il “Signore dell’armonia” - Uno sguardo asiatico su H.C. Schmidbaur 3<br />
Cristo – Parte V<br />
TMCO <strong>Teologia</strong> della misericor<strong>di</strong>a A.-M. Jerumanis / L. Pellicioli 3<br />
TMCO Il lavoro come questione antropologica M. Krienke 1.5<br />
TMCO Dottrina Sociale della Chiesa e mercato G. Mastromatteo 3<br />
Semestre primaverile<br />
Sigla Corso Professore Ects<br />
DCCO Diritto e proce<strong>di</strong>mento amministrativo canonico L. Bianchi Meda 1.5<br />
DCCO Diritto <strong>degli</strong> Istituti <strong>di</strong> Vita Consacrata A. Cattaneo 2<br />
DCCO Introduzione al <strong>di</strong>ritto costituzionale canonico: A. Cattaneo 1.5<br />
CCEO e CIC a confronto<br />
DCCO Temi scelti <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto processuale II G. Eisenring 1.5<br />
DCCO Prassi giu<strong>di</strong>ziale canonica B. Ejeh 3<br />
DCCO Modelli <strong>di</strong> rapporto tra Stato e Chiesa in Europa S. Ferrari 1.5<br />
DCCO Diritto indù D. Francavilla 1.5<br />
DCCO Diritto canonico ortodosso H.B. Kiroulos 1.5<br />
DCCO Storia delle istituzioni canoniche L. Musselli 3<br />
52
DCCO Diritto patrimoniale canonico V. Pacillo 3<br />
DCCO Prassi amministrativa canonica B.F. Pighin 3<br />
DCCO Matrimoni misti con cristiani <strong>di</strong> altre confessioni D. Solo 1.5<br />
DCCO La funzione <strong>di</strong> insegnare della Chiesa I A. Stabellini 1.5<br />
DCCO La funzione <strong>di</strong> insegnare della Chiesa II A. Stabellini 1.5<br />
DICO La mistica ebraica P. Alborghetti 3<br />
DICO Il Talmud P. Alborghetti 3<br />
DICO Letteratura ebraica R. Bernasconi 3<br />
DICO Il Cristo glorioso e la storia universale in lui predestinata<br />
I. Biffi 6<br />
Prosegue dal semestre autunnale<br />
DICO Il cristianesimo del <strong>di</strong>ssenso P. de Petris 3<br />
DICO Lo Shabbat: norme, significato e liturgia C. Milani 3<br />
DICO Introduzione alle religioni orientali F. Monceri 3<br />
DICO Introduzione all’Islam L. Orelli 1.5<br />
DICO Scienze naturali e teologia A. Palese 3<br />
DICO Lingua ebraica B<br />
G. Paxima<strong>di</strong> 3<br />
Prosegue dal semestre autunnale<br />
DICO Storia delle religioni S. Perfetti 3<br />
DICO Le e<strong>di</strong>zioni patristiche da Erasmo ai Maurini (1516- J.-C. Lechner 3<br />
1690)<br />
DICO Lingua greca B<br />
J.-C. Lechner 3<br />
Prosegue dal semestre autunnale<br />
DICO Latinità I e II<br />
A. Tombolini 3<br />
Prosegue dal semestre autunnale<br />
FFCO Economia e religione L.M. Bassani 3<br />
FFCO Storia del pensiero politico contemporaneo L.M. Bassani 3<br />
FFCO Estetica applicata: l’“esperienza estetica” R. Diodato 3<br />
FFCO Globalizzazione ed etica cristiana: una globalizzazione<br />
G. Mastromatteo 3<br />
al servizio dell’uomo<br />
FFCO Metodologia della ricerca in filosofia G. Ventimiglia / N.N. 1.5<br />
NTCO La ricerca <strong>di</strong> Gesù, Figlio <strong>di</strong> Dio, nel Vangelo secondo<br />
F. Manzi 3<br />
Luca<br />
NTCO Il Signore dell’universo (Lettera <strong>di</strong> san Paolo ai Colossesi)<br />
M. Orsatti 3<br />
SICO Aquinas on being A. Kenny 2<br />
SICO La questione della felicità nella filosofia contemporanea<br />
K. Mulligan 2<br />
TDCO Le apparizioni mariane nella vita della Chiesa M. Hauke 3<br />
TDCO/SO Morte e immortalità come temi chiave dell’escatologia<br />
cristiana<br />
M. Hauke 3/4<br />
Programma <strong>degli</strong> <strong>stu<strong>di</strong></strong><br />
53
TDCO L’Uomo U<strong>di</strong>tore della Parola. Storia e sviluppo della<br />
H.C. Schmidbaur 3<br />
<strong>Teologia</strong> della Parola come fondo e base dei do-<br />
cumenti magisteriali Dei Verbum e Verbum Domini<br />
TMCO La teologia morale orientale A.-M. Jerumanis / L. Pellicioli 3<br />
Programma <strong>degli</strong> <strong>stu<strong>di</strong></strong><br />
* Latinità dura tre semestri (inizia nel semestre primaverile <strong>2013</strong> e termina nel semestre<br />
primaverile <strong>2014</strong>) e vale 3 ects.<br />
** Corso <strong>di</strong> blocco prima dell’inizio delle lezioni del semestre primaverile <strong>2014</strong>.<br />
5.3.4. Seminari<br />
L’orario dei corsi è consultabile in bacheca o nel sito web della FTL: www.teologialugano.ch/corsi.php<br />
Per eventuali cambiamenti d’orario e altre precisazioni: www.teologialugano.ch/avvisi.php<br />
Semestre autunnale<br />
Sigla Corso Professore Ects<br />
DCSO Pro-seminario <strong>di</strong> terminologia giuri<strong>di</strong>ca e canonistica<br />
L. Bianchi Meda 2.5<br />
DCSO Diritto ecclesiastico svizzero: parte generale V. Pacillo 4<br />
FFSO Seminario <strong>di</strong> filosofia: morte e immortalità nel pensiero<br />
M. Krienke 4<br />
moderno<br />
FFSO Seminario: Haec sublimis veritas: Dio come Essere C. Marabelli 4<br />
verità imprescin<strong>di</strong>bile della filosofia cristiana<br />
NTSO Il racconto della Passione in Matteo M. Orsatti 4<br />
NTSO I Vangeli dell’Infanzia M. Orsatti 4<br />
PASO Lettura <strong>di</strong> alcuni testi classici della tra<strong>di</strong>zione carmelitana<br />
V. Lazzeri 4<br />
TDSO Il sacramento dell’Eucaristia nel <strong>di</strong>battito contemporaneo<br />
M. Hauke 4<br />
TDSO “Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del H.C. Schmidbaur 4<br />
mondo che verrà!” – Come saremo e come vivremo<br />
nell’al-<strong>di</strong>-là? – Un incontro con le varie teorie<br />
storiche sulla “risurrezione della carne” e sulla<br />
nuova vita con un corpo trasformato e glorificato<br />
in un “mondo nuovo”<br />
TDSO “Letture balthasariane”. Pagine scelte dalla “Theodramatik”<br />
G. Sgubbi 4<br />
TMSO La famiglia e le nuove forme famigliari del XXI secolo<br />
A.-M. Jerumanis / L. Pellicioli 4<br />
Semestre primaverile<br />
Sigla Corso Professore Ects<br />
DCSO Temi scelti <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto sostantivo e processuale matrimoniale<br />
G. Eisenring 4<br />
DISO “Quale Islām?” La religione islamica a confronto A. Chiappini / M.L. Di Marco 4<br />
54
FFSO I sensi dell’essere. Seminario progre<strong>di</strong>to G. Ventimiglia / A. Giordani 4<br />
NTSO Le comunità cristiane negli Atti <strong>degli</strong> Apostoli M. Orsatti 4<br />
TDCO/SO Morte e immortalità come temi chiave dell’escatologia<br />
M. Hauke 3/4<br />
cristiana<br />
TDSO I nuovi modelli <strong>di</strong> <strong>Teologia</strong> trinitaria del XX secolo H.C. Schmidbaur 4<br />
come riscoperta della rilevanza antropologica, soteriologia<br />
ed ecclesiologica d’un modello comunitario<br />
e relazionale <strong>di</strong> Dio<br />
TMSO Bioetica e religioni A.-M. Jerumanis / L. Pellicioli 4<br />
TMSO Seminario <strong>di</strong> Dottrina sociale. I partiti e i sindacati<br />
cristiani in Europa: le basi culturali, la loro storia, le<br />
sfide del futuro<br />
M. Krienke 4<br />
Attenzione: Poiché un seminario non può avere più <strong>di</strong> 12-15 persone, lo studente<br />
deve in<strong>di</strong>care, al momento della iscrizione, due seminari (1 a scelta e 2 a scelta). Nel caso<br />
in cui il primo in<strong>di</strong>cato è già completo, lo studente verrà inscritto seguendo la seconda<br />
proposta (il criterio per la Segreteria è quello della priorità <strong>di</strong> tempo nella iscrizione).<br />
5.4. Ulteriore offerta formativa<br />
Programma <strong>degli</strong> <strong>stu<strong>di</strong></strong><br />
5.4.1. Settimane inter<strong>di</strong>sciplinari <strong>di</strong> corsi intensivi<br />
Le settimane inter<strong>di</strong>sciplinari <strong>di</strong> corsi intensivi sono offerte dai professori della FTL in<br />
collaborazione con professori provenienti da altre università.<br />
La frequenza è obbligatoria per gli studenti della FTL e nel contempo aperta al grande<br />
pubblico. La locan<strong>di</strong>na <strong>di</strong> presentazione dei singoli corsi è <strong>di</strong>sponibile in ricezione o<br />
segreteria all’inizio dei rispettivi semestri oppure consultabile nel sito web della FTL<br />
(www.teologialugano.ch/corsi.php).<br />
Settimana intensiva - semestre autunnale<br />
Periodo: 16-20 settembre <strong>2013</strong><br />
Settimana intensiva - semestre primaverile<br />
Periodo: 17-21 febbraio <strong>2014</strong><br />
5.4.2. Corsi serali<br />
Il programma <strong>di</strong> eventuali corsi serali e preserali sarà pubblicato separatamente e consultabile<br />
sul sito internet della FTL.<br />
5.4.3. Summer School – Gerusalemme<br />
Archeologia e Geografia Biblica<br />
Docenti: Eugenio Alliata, Frédéric Manns (Stu<strong>di</strong>um Biblicum Franciscanum, Gerusalemme)<br />
Dan Bahat, (University St. Michael’s of Toronto - Formerly District Archaeologist<br />
of Jerusalem), Leah Di Segni (Hebrew University of Jerusalem), Michael<br />
55
Programma <strong>degli</strong> <strong>stu<strong>di</strong></strong><br />
Cohen (Israeli Antiquities Authority), Yusuf Natsheh (Al-Quds University), Marcello<br />
Fidanzio (Istituto <strong>di</strong> Cultura e Archeologia delle terre Bibliche- FTL).<br />
Presentazione:<br />
Il corso prevede lezioni in aula (totale <strong>di</strong> 24 ore accademiche) <strong>di</strong> Geografia, Archeologia,<br />
Topografia; lezioni all’interno <strong>degli</strong> scavi archeologici; escursioni ai principali<br />
siti archeologici e ai più importanti musei del Paese. Il programma <strong>di</strong> massima delle<br />
escursioni prevede: visite a Gerusalemme (Ophel, area del Tempio, quartiere<br />
giu<strong>di</strong>aico, monte Sion, via Dolorosa e santo Sepolcro, monte <strong>degli</strong> Ulivi e valle del<br />
Cedron); escursioni giornaliere (Betlemme ed Ero<strong>di</strong>on; Bet Guvrin e Maresha; Bersabea;<br />
Qumran e Gerico; Cesarea Marittima); escursione in Galilea (Meghiddo,<br />
Sefforis, Nazaret, Tabor, Tiberiade, Cafarnao, Tabgha, Dan, Banias, Bet Shean).<br />
Durante la permanenza verranno presentati agli studenti i principali centri <strong>di</strong> ricerca<br />
operanti a Gerusalemme.<br />
Bibliografia:<br />
• J. Murphy-O’Connor, La Terra Santa. Guida storico-archeologica, Bologna 1996 (o<br />
similare);<br />
• D. Bahat, Atlante <strong>di</strong> Gerusalemme, Padova 2011;<br />
• Terra Sancta. Archeologia ed esegesi, a cura <strong>di</strong> G. Paxima<strong>di</strong> - M. Fidanzio, <strong>Lugano</strong><br />
<strong>2013</strong>;<br />
• E. Netzer, L’architettura <strong>di</strong> Erode. Il grande costruttore, Padova 2012;<br />
• P. Kaswalder, Onomastica biblica. Fonti scritte e ricerca archeologica, (SBF Collectio<br />
Minor 40), Jerusalem 2002<br />
• Egeria, Diario <strong>di</strong> viaggio, Milano 2006 (o altra e<strong>di</strong>zione);<br />
Altre in<strong>di</strong>cazioni bibliografiche saranno fornite durante il corso.<br />
Lettorato <strong>di</strong> Ebraico biblico<br />
Docenti: Gregor Geiger (Stu<strong>di</strong>um Biblicum Franciscanum), Clau<strong>di</strong>a Rosenzweig<br />
(Università Bar Ilan - Hebrew University of Jerusalem) Giorgio Paxima<strong>di</strong> (Facoltà <strong>di</strong><br />
<strong>Teologia</strong> <strong>di</strong> <strong>Lugano</strong>).<br />
Programma:<br />
Lettorato <strong>di</strong> ebraico biblico, introduzione alla critica testuale, storia della lingua ebraica.<br />
Dal lunedì al venerdì lezioni ogni mattina (totale 36 ore accademiche); il pomeriggio<br />
preparazione in<strong>di</strong>viduale della traduzione e del commento grammaticale dei testi oggetto<br />
delle lezioni. Esame alla fine <strong>di</strong> ogni settimana. Testi: Gen 39ss; Lev 19; 1 Sam 1-4; Est<br />
Bibliografia da procurarsi prima della partenza: Biblia Hebraica Stuttgartensia, una<br />
grammatica <strong>di</strong> ebraico biblico, un vocabolario <strong>di</strong> ebraico biblico.<br />
Ulteriore bibliografia verrà in<strong>di</strong>cata nel corso delle lezioni.<br />
56
5.5. Descrizione dei singoli corsi e seminari<br />
• I corsi vengono presentati in questo or<strong>di</strong>ne: alfabetico per professore, semestre<br />
e titolo.<br />
• Le descrizioni mancanti dei corsi attivati dalla FTL verranno fornite all’inizio del<br />
rispettivo semestre.<br />
• In ogni caso vincolante è quanto esposto all’albo della Facoltà.<br />
L’orario dei corsi è consultabile in bacheca o nel sito web della FTL: www.teologialugano.ch/corsi.php<br />
Per eventuali cambiamenti d’orario e altre precisazioni: www.teologialugano.ch/avvisi.php<br />
Filosofia ebraica. Antica e me<strong>di</strong>evale<br />
Prof. Dr. Patrizio Alborghetti<br />
Sigla: FFCO Semestre autunnale Ects: 3<br />
Obiettivo corso: Presentazione del pensiero filosofico ebraico antico e me<strong>di</strong>evale attraverso<br />
i principali filosofi.<br />
Modalità <strong>di</strong> valutazione: Esame orale.<br />
Contenuto del corso: A partire da Filone fino agli ultimi filosofi del me<strong>di</strong>oevo, la riflessione<br />
ebraica ha offerto una prima rielaborazione dei contenuti della tra<strong>di</strong>zione biblica.<br />
Soprattutto nel me<strong>di</strong>oevo, <strong>di</strong> fronte alla necessità <strong>di</strong> confrontarsi con la cultura araba e<br />
cristiana circostanti, i sapienti ebrei sviluppano una nuova forma <strong>di</strong> pensiero per esporre<br />
la propria fede. Questa riflessione eserciterà un forte influsso sui pensatori cristiani e<br />
contribuirà alla grande rinascita <strong>degli</strong> <strong>stu<strong>di</strong></strong> del periodo.<br />
Bibliografia essenziale<br />
• Maurice-Ruben Hayoun, I filosofi ebrei nel me<strong>di</strong>oevo, Milano 1994.<br />
• Maurice-Ruben Hayoun, La filosofia ebraica, Milano 2009.<br />
• André Chouraqui, Il pensiero ebraico, Brescia 1989.<br />
Corsi <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong><br />
Introduzione all’ebraismo<br />
Prof. Dr. Patrizio Alborghetti<br />
Sigla: DICO Semestre autunnale Ects: 3<br />
Obiettivo corso: Introduzione ai <strong>di</strong>versi aspetti della tra<strong>di</strong>zione ebraica.<br />
Modalità <strong>di</strong> valutazione: Esame orale.<br />
Contenuto del corso: Il termine ebraismo rimanda a quella realtà che ha inizio con la<br />
comparsa dei Patriarchi. Tuttavia, dal momento fondante, la fede d’Israele ha assunto,<br />
nel corso della sua storia, pur nella fedeltà all’origine, molteplici e <strong>di</strong>fferenti aspetti.<br />
Dopo aver presentato gli eventi fondamentali che aprono la storia <strong>di</strong> Israele, il corso<br />
si vuole soffermare, soprattutto, sul momento specifico che, più <strong>degli</strong> altri, ha caratterizzato<br />
l’identità ebraica, ossia il periodo rabbinico, con la formazione della tra<strong>di</strong>zione<br />
orale: la Mishnah e il Talmud.<br />
Bibliografia essenziale<br />
• Philippe Haddad, L’ebraismo spiegato ai miei amici, Firenze 2003.<br />
• Maurice-Ruben Hayoun, L’ebraismo. Storia e identità, Milano 2010.<br />
57
• Deborah Cohenca, Rav Ariel Di Porto, Giordana Limentani, Gaia Piperno, Tiziana<br />
Sonnino, Le basi dell’ebraismo, Milano 2011.<br />
Corsi <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong><br />
Il Talmud<br />
Prof. Dr. Patrizio Alborghetti<br />
Sigla: DICO Semestre primaverile Ects: 3<br />
Obiettivo corso: Introdurre alla lettura <strong>di</strong> uno dei testi fondamentali della tra<strong>di</strong>zione<br />
ebraica.<br />
Modalità <strong>di</strong> valutazione: Esame orale.<br />
Contenuto del corso: Il Talmud è la messa per iscritto della tra<strong>di</strong>zione orale. Unione<br />
della Mishnah – la raccolta delle norme che regolamentano la vita ebraica – e della<br />
ghemarah – il commento alla Mishnah –, contiene tutta la sapienza ebraica. Attraverso<br />
l’analisi dei brani principali, si vuole iniziare alla conoscenza <strong>di</strong> questo monumento della<br />
storia occidentale.<br />
Bibliografia essenziale<br />
• Abraham Cohen, Il Talmud, 1999.<br />
• Gunter Stemberger, Il Talmud. Introduzione, Testi, commenti, 1989.<br />
• I racconti del Talmud. La fiamma dei Maestri, a cura <strong>di</strong> Giuseppe Laras, 2000.<br />
La mistica ebraica<br />
Prof. Dr. Patrizio Alborghetti<br />
Sigla: DICO Semestre primaverile Ects: 3<br />
Obiettivo corso: Introdurre al pensiero mistico esperienziale ebraico.<br />
Modalità <strong>di</strong> valutazione: Esame orale.<br />
Contenuto del corso: Il pensiero mistico è l’aspetto sperimentale della fede ebraica. Il<br />
fedele, dopo aver accostato il mistero attraverso le vie dello <strong>stu<strong>di</strong></strong>o, giunge ad assaporare<br />
l’oggetto della sua ricerca.<br />
La mistica ebraica verrà presentata attraverso l’analisi delle varie correnti che nella storia<br />
si sono susseguite. Si de<strong>di</strong>cherà particolare attenzione alla Qabbalah e al suo testo<br />
fondamentale, ossia al libro dello splendore (Sefer hazohar).<br />
Bibliografia essenziale<br />
• Giuseppe Laras, La mistica ebraica, 2012.<br />
• Maurice-Ruben Hayoun, Lo Zohar. Alle origini della mistica ebraica, 2011.<br />
• Zohar. La luce della Kabbalah, traduzione e commento <strong>di</strong> Michael Laitman, 2011.<br />
Economia e religione<br />
Prof. Dr. Luigi Marco Bassani<br />
Sigla: FFCO Semestre primaverile Ects: 3<br />
Modalità <strong>di</strong> valutazione: Esame orale.<br />
Contenuto del corso: Il corso si propone <strong>di</strong> fornire un’interpretazione innovativa e stimolante<br />
a proposito delle relazioni tra sensibilità religiosa e filosofia economica. Si prenderanno<br />
le mosse dalla prima grande analisi tentata da Max Weber nella sua Sociologia<br />
58
delle religioni per poi giungere alle principali sintesi contemporanee, concentrandosi<br />
specificamente sul nesso cristianesimo-economia <strong>di</strong> mercato ma fornendo pure cenni<br />
sulle esperienze economiche contemplate nelle culture islamiche ed ebraiche.<br />
Bibliografia essenziale<br />
• D. Antiseri, Cattolici a <strong>di</strong>fesa del mercato, Soveria Mannelli, 2005;<br />
• A. Chafuen, Cristiani per la libertà. Ra<strong>di</strong>ci cattoliche dell’economia <strong>di</strong> mercato, Macerata,<br />
2008;<br />
• I cattolici, l’economia, il mercato, a cura <strong>di</strong> P. Barucci, Soveria Mannelli, 2009;<br />
• M. Weber, Sociologia delle religioni, Torino, 2008.<br />
Storia del pensiero politico contemporaneo<br />
Prof. Dr. Luigi Marco Bassani<br />
Sigla: FFCO Semestre primaverile Ects: 3<br />
Modalità <strong>di</strong> valutazione: Esame orale.<br />
Contenuto del corso: A partire dal panorama concettuale successivo alla rivoluzione<br />
francese, il corso ambisce a presentare agli studenti la nascita delle ideologie politiche<br />
contemporanee, con particolare attenzione agli sviluppi ottocenteschi del liberalismo e<br />
del marxismo.<br />
Si procederà quin<strong>di</strong> ad illustrare l’evoluzione delle principali correnti del pensiero politico<br />
novecentesco, sino a giungere al recente <strong>di</strong>battito sull’idea <strong>di</strong> giustizia suscitato dalla<br />
proposta teorica <strong>di</strong> Rawls.<br />
Bibliografia essenziale<br />
Dispense tratte da:<br />
• Luigi M. Bassani, Stefano B. Galli, Franco Livorsi, Da Platone a Rawls. Lineamenti <strong>di</strong><br />
storia del pensiero politico, Torino, 2012.<br />
Letture tratte da:<br />
• B. Leoni, Il pensiero politico moderno e contemporaneo, Macerata, 2009.<br />
Corsi <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong><br />
Dialogo interreligioso oggi: <strong>di</strong>fficoltà e prospettive<br />
Prof. Dr. Gino Battaglia<br />
Sigla: SICO Semestre autunnale Ects: 1.5<br />
Presentazione: La descrizione sarà fornita all’inizio dell’anno accademico.<br />
<strong>Teologia</strong> dell’Olocausto<br />
Prof. Dr. Rocco Bernasconi<br />
Sigla: DICO Semestre autunnale Ects: 3<br />
Obiettivo corso: Fornire le conoscenze per poter analizzare criticamente i <strong>di</strong>versi tentativi<br />
<strong>di</strong> reinterpretare il mondo, Dio, la fede e la natura del male, alla luce <strong>di</strong> Auschwitz.<br />
Modalità <strong>di</strong> valutazione: Esame orale.<br />
Contenuto del corso: Il corso offre una panoramica delle principali interpretazioni<br />
ebraiche e cristiane dell’Olocausto, mettendo in luce gli elementi <strong>di</strong> continuità e <strong>di</strong>scontinuità<br />
con le tra<strong>di</strong>zionali risposte che le due religioni hanno dato al problema del male<br />
59
Corsi <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong><br />
e della teo<strong>di</strong>cea. Inoltre, l’Olocausto sarà messo in relazione con la modernità europea<br />
e con l’anti-giudaismo cristiano.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
Gli studenti dovranno scegliere due testi <strong>di</strong> cui almeno uno <strong>di</strong> Massimo Giuliani.<br />
• Fackenheim, Emil. Olocausto. Brescia, 2011.<br />
• Giuliani, Massimo. Auschwitz Nel Pensiero Ebraico. Frammenti Delle “Teologie<br />
Dell’olocausto”. Brescia, 1998.<br />
• Jonas, Hans. Il Concetto Di Dio Dopo Auschwitz. Genova, 1993.<br />
Altri materiali saranno <strong>di</strong>stribuiti durante il corso.<br />
Letteratura ebraica<br />
Prof. Dr. Rocco Bernasconi<br />
Sigla: DICO Semestre primaverile Ects: 3<br />
Obiettivo corso: Fornire una panoramica sulle forme e i temi della tra<strong>di</strong>zione letteraria<br />
ebraica dalla Bibbia all’età contemporanea.<br />
Modalità <strong>di</strong> valutazione: Esame orale.<br />
Contenuto del corso: Dalla Bibbia alla Shoah la storia del popolo ebraico si esprime in<br />
una ricca e variegata produzione letteraria che presenta una pluralità <strong>di</strong> temi e forme:<br />
dai Rotoli del Mar Morto, al Talmud, dai Midrashim ai Co<strong>di</strong>ci me<strong>di</strong>evali, dai testi chassi<strong>di</strong>ci<br />
alle interpretazioni teologiche dell’11 Settembre.<br />
Il corso, si rivolge alle persone interessate all’ebraismo, ma anche all’esegesi cattolica<br />
e al <strong>di</strong>alogo ebraico-cristiano. Le lezioni si svolgeranno in forma seminariale sulla base<br />
della lettura <strong>di</strong> testi in traduzione, che saranno forniti dal docente all’inizio delle lezioni.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
Fonti e letteratura secondaria saranno <strong>di</strong>stribuiti dal docente durante il corso.<br />
Pro-seminario <strong>di</strong> terminologia giuri<strong>di</strong>ca e canonistica<br />
Lic.iur.can. Letizia Bianchi Meda<br />
Sigla: DCSO Semestre autunnale Ects: 2.5<br />
Presentazione: Il pro-seminario introduce alle questioni metodologiche e agli strumenti<br />
per il lavoro scientifico nell’ambito del <strong>di</strong>ritto canonico. Le tre domande principali alle<br />
quali si vuole rispondere sono: Che cos’è il <strong>di</strong>ritto canonico? Perché <strong>stu<strong>di</strong></strong>arlo? Come<br />
<strong>stu<strong>di</strong></strong>arlo? È previsto anche qualche esercizio pratico che lo studente svolge autonomamente<br />
o in gruppo e a cui viene applicato il metodo appreso nel corso.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• E. Sastre Santos, Metodologia giuri<strong>di</strong>ca. La tesi e lo <strong>stu<strong>di</strong></strong>o del Diritto canonico, Roma<br />
2002 2 ;<br />
• L. Gerosa, Diritto canonico. Fonti e metodo, Milano 1996.<br />
60
Diritto e proce<strong>di</strong>mento amministrativo canonico<br />
Lic.iur.can. Letizia Bianchi Meda<br />
Responsabile scientifico: Prof. Dr. Libero Gerosa<br />
Sigla: DCCO Semestre primaverile Ects: 1.5<br />
Presentazione: Questo corso vorrebbe essere una prima e generale introduzione allo<br />
<strong>stu<strong>di</strong></strong>o dei lineamenti portanti del sistema amministrativo canonico ed è propedeutico<br />
allo <strong>stu<strong>di</strong></strong>o concreto e <strong>di</strong>namico della giurisprudenza e della prassi amministrativa. Il<br />
corso si articolerà in due parti.<br />
Parte I: Il <strong>di</strong>ritto amministrativo canonico: 1. Potestà <strong>di</strong> governo e potestà esecutiva.<br />
Funzione e finalità del <strong>di</strong>ritto amministrativo della Chiesa. Tutela del bene pubblico e<br />
della salus animarum. 2. L’atto amministrativo: a) definizione; b) natura; c) tipologia; d)<br />
tipicità e atipicità dell’atto amministrativo. 3. Vali<strong>di</strong>tà dell’atto amministrativo. 4. Patologia<br />
dell’atto amministrativo: a) nullità e annullabilità; b) inefficacia e inesistenza; c)<br />
legittimità e illegittimità; d) rescin<strong>di</strong>bilità. 5. Il silenzio amministrativo.<br />
Parte II: Il proce<strong>di</strong>mento amministrativo canonico: 1. Attività amministrativa e attività<br />
giu<strong>di</strong>ziaria nella Chiesa. 2. Rapporti <strong>di</strong>namici e <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> competenze tra il Tribunale<br />
Apostolico della Rota Romana, il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e<br />
le Congregazioni Romane. 3. I ricorsi amministrativi nel CIC 1983. Natura e tipologie:<br />
a) il tentativo <strong>di</strong> conciliazione; b) il ricorso gerarchico. 4. La giustizia amministrativa nella<br />
prassi del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica: a) inquadramento generale<br />
della STSA nella Curia Romana: la <strong>di</strong>aconia funzionale con gli altri organismi della Curia<br />
Romana (con riferimenti alla Cost. Ap. Pastor Bonus e al Regolamento Generare della<br />
Curia Romana); b) la Sectio Altera della STSA; c) evoluzione della prassi amministrativa<br />
della STSA prima e dopo il CIC 1983; d) le Normae Speciales della STSA; e) <strong>di</strong>samina<br />
del processo contenzioso amministrativo presso la Sectio Altera; f) responsabilità<br />
dell’autorità ecclesiastica e risarcimento dei danni (morali) causati dall’atto amministrativo<br />
riconosciuto illegittimo.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• F. D’Ostilio, Il <strong>di</strong>ritto amministrativo della Chiesa, Città del Vaticano 1996 (Parte<br />
II e Parte III);<br />
• E. La Bandeira, Trattato <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto amministrativo canonico, Milano 1994.<br />
Corsi <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong><br />
Il Cristo glorioso e la storia universale in lui predestinata<br />
Prof. Dr. Inos Biffi<br />
Sigla: DICO Semestri autunnale e primaverile Ects: 6<br />
La descrizione sarà fornita all’inizio dell’anno accademico.<br />
Psicologia generale<br />
Prof. Dr. Carlo Calanchini<br />
Sigla: DICP Semestre autunnale Ects: 3<br />
Obiettivo corso: Presentare basi neurofisiologiche e funzioni/<strong>di</strong>namiche psicologiche<br />
essenziali. Discussione <strong>di</strong> casi.<br />
Modalità <strong>di</strong> valutazione: Esame orale.<br />
61
Corsi <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong><br />
Contenuto del corso: Basi neuro anatomiche e –fisiologiche delle funzioni psichiche.<br />
La psiche: storia del concetto. Filosofia e psicologia. Funzioni cognitive ed emozioni.<br />
La memoria. L’intelligenza. Il contesto relazionale e sociale. L’evoluzione psicologica<br />
dell’in<strong>di</strong>viduo. Pensiero primario/pensiero secondario. Il sogno, il simbolo, la creazione<br />
artistica. La religione. Bene e Male da un punto <strong>di</strong> vista psicologico.<br />
Bibliografia essenziale<br />
• Ansermet F., Magistretti P., A ciascuno il suo cervello – Plasticità neuronale e inconscio.<br />
Torino 2008,<br />
• Mundo, E., Neuroscienze per la psicologia clinica – Le basi del <strong>di</strong>alogo mente-cervello.<br />
Milano 2009,<br />
• Calanchini, C. L, “Ueber Gemütsregungen – Emotionen zwischen philosophischer<br />
Theorie und psychotherapeutischer Praxis”. Bern, 2012.<br />
Diritto costituzionale canonico II (I e II parte)<br />
Prof. Dr. Arturo Cattaneo<br />
Sigla: DCCP/CO Semestre autunnale Ects: 1.5+1.5<br />
Presentazione: La duplice <strong>di</strong>mensione della Chiesa: universale-particolare e il loro mutuo<br />
rapporto. La <strong>di</strong>mensione universale della Chiesa: il primato del Papa e gli organi <strong>di</strong><br />
collaborazione con il ministero petrino; il Collegio episcopale e le <strong>di</strong>verse manifestazioni<br />
dello spirito collegiale. La <strong>di</strong>mensione particolare della Chiesa: la riscoperta della Chiesa<br />
particolare ad opera del Vaticano II; gli elementi costitutivi della Chiesa particolare. I<br />
raggruppamenti <strong>di</strong> Chiese particolari: province ecclesiastiche e regioni ecclesiastiche; i<br />
Metropoliti; i concili particolari; le Conferenze episcopali. Le strutture complementari<br />
alle Chiese particolari: prelature e or<strong>di</strong>nariati personali. Struttura interna delle Chiese<br />
particolari: il sinodo <strong>di</strong>ocesano; la curia <strong>di</strong>ocesana; il consiglio presbiterale e il collegio<br />
dei consultori; i capitoli dei canonici; il consiglio pastorale; le parrocchie, i parroci e i<br />
vicari parrocchiali; i vicari foranei; i rettori delle chiese e i cappellani.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• J.I. Arrieta, Diritto dell’organizzazione ecclesiastica, Milano 1997;<br />
• A. Cattaneo, Fondamenti ecclesiologici del <strong>di</strong>ritto canonico, Venezia 2011;<br />
• L. Sabbarese, La costituzione gerarchica della Chiesa universale e particolare, Città<br />
del Vaticano 1999.<br />
Le sanzioni nella Chiesa<br />
Prof. Dr. Arturo Cattaneo<br />
Sigla: DCCO Semestre autunnale Ects: 3<br />
Presentazione: I. Il fondamento della potestas punien<strong>di</strong> in Ecclesia. II. La nozione canonica<br />
<strong>di</strong> delitto. L’imputabilità. L’incapacità <strong>di</strong> imputazione. Le circostanze influenti<br />
sulla imputabilità. III. La pena canonica: finalità e tipologie. L’applicazione delle pene.<br />
La sospensione della pena. La cessazione o la remissione della pena. I sostitutivi della<br />
pena. IV. Le pene previste per i singoli delitti: <strong>di</strong>samina dei cann. 1364-1398 CIC. I delicta<br />
graviora riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede. V. Profili <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto<br />
62
penale comparato: i titoli XXVII e XXVIII del CCEO 1990. VI. Cenni al processo penale<br />
giu<strong>di</strong>ziario.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• B. Pighin, Diritto penale canonico, Venezia 2008;<br />
• A. Calabrese, Diritto penale canonico, Roma 1996;<br />
• V. De Paolis - D. Cito, Le sanzioni nella Chiesa. Commento al Co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> Diritto Canonico.<br />
Libro VI, Roma 2003.<br />
Diritto <strong>degli</strong> Istituti <strong>di</strong> Vita Consacrata<br />
Prof. Dr. Arturo Cattaneo<br />
Sigla: DCCO Semestre primaverile Ects: 2<br />
Presentazione: Virtualità e limiti dell’espressione <strong>di</strong> vita «consacrata». Norme comuni<br />
a tutti gli istituti <strong>di</strong> vita consacrata. Gli istituti religiosi: case religiose; il governo <strong>degli</strong><br />
istituti; ammissione dei can<strong>di</strong>dati e formazione dei membri; obblighi e <strong>di</strong>ritti <strong>degli</strong> istituti<br />
e dei loro membri; l’apostolato <strong>degli</strong> istituti; separazione dei membri dall’istituto; i<br />
religiosi elevati all’episcopato; le conferenze dei Superiori maggiori. Gli istituti secolari.<br />
Le società <strong>di</strong> vita apostolica.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• V. De Paolis, La vita consacrata nella Chiesa, Bologna 1992. Commentario teologico<br />
– giuri<strong>di</strong>co al Co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto canonico, Roma 2007;<br />
• Aa.Vv., Il <strong>di</strong>ritto nel mistero della Chiesa, vol. II, Roma 2001 3 ;<br />
• A. Neri, Sapere giuri<strong>di</strong>co ed esperienza <strong>di</strong> fede. Lezioni introduttive al <strong>di</strong>ritto canonico,<br />
<strong>Lugano</strong> 2007;<br />
• Aa.Vv., Co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto canonico e leggi complementari commentato, a cura <strong>di</strong><br />
J.I. Arrieta, Roma 2004<br />
Corsi <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong><br />
Introduzione al <strong>di</strong>ritto costituzionale canonico: CCEO e CIC a confronto<br />
Prof. Dr. Arturo Cattaneo<br />
Sigla: DCCO Semestre primaverile Ects: 1.5<br />
Presentazione: I «due polmoni» della Chiesa <strong>di</strong> Cristo: la Chiesa latina e le Chiese<br />
orientali. La co<strong>di</strong>ficazione orientale. Perché <strong>stu<strong>di</strong></strong>are anche il CCEO? La sistematica del<br />
CCEO. Le sue principali caratteristiche. I rapporti fra i due Co<strong>di</strong>ci. Le Chiese «sui iuris»,<br />
i riti e, in modo particolare, l’istituzione patriarcale e sinodale nelle Chiese orientali<br />
cattoliche. L’eparchia e gli esarcati. Gli statuti personali orientali: chierici, laici e religiosi.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• E. Corecco, Sinodalità, in Ius et communio, Vol II, a cura <strong>di</strong> G. Borgonovo e A.<br />
Cattaneo, Casale Monferrato 1997, pp. 39-81;<br />
• Giovanni Paolo II, Lettera Orientale lumen (2.V.1995);<br />
• D. Salachas, Istituzioni <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto canonico delle Chiese cattoliche orientali, Bologna<br />
1993 (rist. 2008).<br />
63
Corsi <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong><br />
Storia della Chiesa II: me<strong>di</strong>evale<br />
Prof. Dr. Carlo Cattaneo<br />
Sigla: SCCP Semestre autunnale Ects: 3<br />
Presentazione: 1. Concetto <strong>di</strong> me<strong>di</strong>oevo; 2. Il cristianesimo <strong>di</strong> massa. Le missioni ai<br />
popoli nord europei; 3. La coscienza religiosa <strong>di</strong> fronte ai barbari; 4. L’età carolingia; 5.<br />
Decadenza e riforma della Chiesa dalla fine dell’età carolingia all’età gregoriana; 6. L’evoluzione<br />
dei rapporti fra Oriente e Occidente nel me<strong>di</strong>o evo. Presupposti alla scissione<br />
del 1054; 7. La vita monastica me<strong>di</strong>oevale; 8. Genesi e sviluppo dell’idea <strong>di</strong> Crociata; 9.<br />
Il papato me<strong>di</strong>oevale e le potenze secolari; 10. Papato e Impero nei sec. XII-XIII; 11. Gli<br />
or<strong>di</strong>ni men<strong>di</strong>canti. Vita religiosa dei laici nel me<strong>di</strong>oevo.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• A.M. Erba-P.L. Guiducci, La Chiesa nella Storia. Duemila anni <strong>di</strong> cristianesimo, 2003;<br />
• L R. Pernoud, Me<strong>di</strong>oevo. Un secolare pregiu<strong>di</strong>zio, Milano 1996;<br />
• C.H. Lawrence, Il monachesimo me<strong>di</strong>evale. Forme <strong>di</strong> vita religiosa in Occidente, Cinisello<br />
Balsamo 1993.<br />
• Gabriella Piccinni, Il Me<strong>di</strong>oevo, Milano 2004.<br />
Storia della Chiesa IV: gli ultimi tre secoli<br />
Prof. Dr. Carlo Cattaneo<br />
Sigla: SCCP Semestre autunnale Ects: 3<br />
Presentazione: 1. Chiesa e Rivoluzione francese; 2. La Chiesa italiana e il Risorgimento<br />
- Il Sillabo e il Concilio Vaticano I; 3. Leone XIII e la questione sociale; 4. La svolta<br />
pastorale e riformatrice <strong>di</strong> Pio X - Il “modernismo”; 5. La Chiesa e i totalitarismi: Pio XI<br />
e Pio XII; 6. Il Concilio Vaticano Il.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• G. Martina, Storia della Chiesa da Lutero ai nostri giorni. L’età del liberalismo, vol. 3,<br />
L’età contemporanea, vol. 4, Brescia 1998.<br />
<strong>Teologia</strong> e spiritualità dell’Oriente cristiano<br />
Prof. Dr. Azzolino Chiappini<br />
Sigla: DICP Semestre autunnale Ects: 3<br />
Il corso sostituisce quello prescritto <strong>di</strong> Introduzione all’ecumenismo.<br />
Presentazione: Il Concilio Vaticano II, nel decreto Unitatis Re<strong>di</strong>ntegratio (9) invita la<br />
Chiesa cattolica a conoscere le altre tra<strong>di</strong>zioni cristiane. Nella storia del cristianesimo,<br />
oltre alla tra<strong>di</strong>zione latina, una grande importanza hanno quelle delle Chiese dell’Oriente,<br />
nate nei primi secoli e tutte esistenti dal primo millennio.<br />
Il corso intende presentare i temi fondamentali <strong>di</strong> queste tra<strong>di</strong>zioni, considerando le<br />
Chiese che sono rimaste fuori delle decisioni del Concilio <strong>di</strong> Calcedonia, e poi de<strong>di</strong>cando<br />
un’attenzione particolare a quelle denominate ortodosse (da Costantinopoli, all’esperienza<br />
slava, senza tralasciare altre esperienze, come quella rumena).<br />
Verranno presentati i gran<strong>di</strong> temi della teologia, della spiritualità (monachesimo, esicasmo,<br />
preghiera del cuore), della liturgia (le icone).<br />
64
Bibliografia essenziale:<br />
• Giovanni Paolo II, Lettera Apostolica, Orientale Lumen (2 maggio 1995)<br />
• Christos Yannaras, La fede dell’esperienza ecclesiale. Introduzione alla teologia ortodossa,<br />
Brescia, 1993<br />
• Bartholomeos I, Incontro al mistero, Magnano (BI), <strong>2013</strong><br />
• Ilarion Alfeev, La Chiesa Ortodossa Russa. 1. Profilo storico, Bologna <strong>2013</strong>.<br />
“Quale Islām?” La religione islamica a confronto<br />
Prof. Dr. Azzolino Chiappini e M. phil. Myriam Lucia Di Marco<br />
Sigla: DISO Semestre primaverile Ects: 4<br />
Presentazione: In occasione dell’incontro con gli ambasciatori della Santa Sede, il 22<br />
marzo <strong>2013</strong>, Papa Francesco ha ricordato l’importanza del <strong>di</strong>alogo con le altre religioni,<br />
soprattutto con l’Islām, apprezzando la presenza <strong>di</strong> tante Autorità civili e religiose del<br />
mondo islamico durante la Messa d’inizio del suo ministero petrino. Per un autentico<br />
<strong>di</strong>alogo però, la conoscenza <strong>di</strong> tale religione sempre più presente sul nostro territorio<br />
è fondamentale.<br />
Dopo un’introduzione generale al tema, il seminario si propone <strong>di</strong> <strong>stu<strong>di</strong></strong>are i <strong>di</strong>versi<br />
ambiti dell’Islām, dalla filosofia politica (e presunta sua incongruenza con la democrazia)<br />
alla bioetica, dalle interpretazioni del Corano (includendo il sufismo) alla concezione<br />
della donna (e la con<strong>di</strong>zione del velo), non sottovalutando il suo legame con il cristianesimo<br />
e l’ebraismo.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• B. Naaman – E. Scognamiglio, Islâm Îmâm. Verso una comprensione, Padova 2009<br />
• M. Campanini, Il pensiero islamico contemporaneo, Bologna 2005<br />
• S. Allievi, La guerra delle moschee. L’Europa e la sfida del pluralismo religioso, Vicenza<br />
2010<br />
Propedeuticità: Aver frequentato il corso <strong>di</strong> introduzione all’Islam della Prof. Orelli.<br />
Corsi <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong><br />
Storia della filosofia contemporanea<br />
Prof.ssa Dr.ssa Roberta Corvi<br />
Sigla: FFCP Semestre primaverile Ects: 4.5<br />
Obiettivo corso: Il corso intende fornire gli strumenti per orientarsi nelle principali<br />
tematiche del pensiero contemporaneo.<br />
Modalità <strong>di</strong> valutazione: Esame orale.<br />
Contenuto del corso: Correnti fondamentali della filosofia ottocentesca: idealismo,<br />
marxismo, positivismo; Kierkegaard e Schopenhauer. Tra Ottocento e Novecento:<br />
il pragmatismo, Bergson, Cassirer. Linee fondamentali del pensiero contemporaneo:<br />
Nietzsche, Freud, la crisi dei fondamenti; fenomenologia, esistenzialismo ed ermeneutica.<br />
Neopositivismo e filosofia analitica.<br />
Bibliografia essenziale<br />
• S. Vanni Rovighi, Storia della filosofia moderna. Dalla rivoluzione scientifica a Hegel,<br />
Brescia 1976, capp. 21-24.<br />
• S. Vanni Rovighi, Storia della filosofia contemporanea. Dall’Ottocento ai giorni nostri,<br />
65
Brescia 1980, capp. 2, 3, 5, 6, 11.<br />
• R. Corvi, Temi filosofici del Novecento, Milano 2010.<br />
Ulteriore bibliografia sarà in<strong>di</strong>cata durante il corso.<br />
Propedeuticità: Consigliati Corsi <strong>di</strong> storia della filosofia antica, me<strong>di</strong>evale e moderna.<br />
Corsi <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong><br />
L’identità teologica del protestantesimo<br />
Rev. Dr. Paolo de Petris<br />
Sigla: DICO Semestre autunnale Ects: 3<br />
Obiettivo corso: Introdurre gli studenti all’approfon<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> un pensiero teologico<br />
che presenta un largo denominatore comune sugli elementi costitutivi della fede cristiana.<br />
Per favorire la comprensione verrà fatto uso <strong>di</strong> presentazioni in Powerpoint.<br />
Modalità <strong>di</strong> valutazione: Esame orale.<br />
Contenuto del corso: Oltre tre secoli fa Jacques Bénigne Bousset nel suo trattato Histoire<br />
des variations des Églises protestantes aveva pesantemente criticato il Protestantesimo<br />
lamentandone la mancanza <strong>di</strong> unità dottrinale e ancora oggi per un cattolico<br />
che si avvicina alla <strong>Teologia</strong> della Riforma del XVI secolo risulta talvolta problematico<br />
in<strong>di</strong>viduarne e comprenderne i fondamenti e la Raison d’être.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• V. Subilia, Solus Christus, 1980;<br />
• V. Vinay, La Riforma Protestante, 1979;<br />
• J. Leith, Basic Christian Doctrine, 1992.<br />
Il cristianesimo del <strong>di</strong>ssenso<br />
Rev. Dr. Paolo de Petris<br />
Sigla: DICO Semestre primaverile Ects: 3<br />
Obiettivo corso: Rileggere criticamente la teologia <strong>di</strong> alcuni dei più significativi movimenti<br />
del <strong>di</strong>ssenso, a partire dall’Arianesimo sino ai giorni nostri.<br />
Per favorire la comprensione verrà fatto uso <strong>di</strong> presentazioni in Powerpoint.<br />
Modalità <strong>di</strong> valutazione: Esame orale.<br />
Contenuto del corso: Nella storia del Cristianesimo si sono sviluppate forme <strong>di</strong> fede e<br />
<strong>di</strong> spiritualità in contrasto con l’orientamento delle chiese ufficiali. Alcuni <strong>di</strong> questi movimenti<br />
sono scomparsi mentre altri, usciti dalla fase della clandestinità e del settarismo,<br />
sono <strong>di</strong>ventati veri e propri movimenti <strong>di</strong> massa.<br />
La storia, spesso e volentieri scritta dai vincitori, non è stata sempre equanime nei confronti<br />
della “<strong>di</strong>ssidenza”.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• Michel Teron, Piccola Enciclope<strong>di</strong>a delle Eresie Cristiane, 2008<br />
• Paul Tillich, Storia del Pensiero Cristiano, 1969.<br />
66
Estetica generale<br />
Prof. Dr. Roberto Diodato<br />
Sigla: FFCO Semestre autunnale Ects: 3<br />
Obiettivo corso: Il corso mostrerà lo sviluppo delle principali “categorie” estetiche<br />
(arte, bellezza, immaginazione, forma, gusto) nella storia del pensiero filosofico, concentrando<br />
l’attenzione soprattutto sull’estetica contemporanea.<br />
Modalità <strong>di</strong> valutazione: Esame orale.<br />
Contenuto del corso: Verranno in particolare esaminati i seguenti concetti: i significati<br />
dell’estetica, il rapporto arte-bellezza, il rapporto arte-verità.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• R. Diodato, E. De Caro, G. Boffi, Percorsi <strong>di</strong> estetica, Brescia 2009,<br />
• S. Vizzardelli, Verso una nuova estetica, Milano 2010,<br />
• J.P. Cometti, J. Morizot, R. Pouivet, Le sfide dell’estetica, Torino 2002.<br />
Propedeuticità: Nessuna. Corso consigliato a partire dal secondo anno.<br />
Estetica applicata: l’“esperienza estetica”<br />
Prof. Dr. Roberto Diodato<br />
Sigla: FFCO Semestre primaverile Ects: 3<br />
Presentazione: Cosa vuol <strong>di</strong>re fare “esperienza estetica”? L’argomento può essere declinato<br />
in molti mo<strong>di</strong>, ma il suo approfon<strong>di</strong>mento dal punto <strong>di</strong> vista filosofico è essenziale<br />
per comprendere alcune rilevanti <strong>di</strong>namiche della vita contemporanea, nella<br />
quale sovente la nostra esperienza estetica del mondo finisce per essere anestetizzata e<br />
proporsi soltanto nella forma della ripetizione <strong>di</strong> modelli già precostituiti. Il corso esaminerà<br />
in particolare i concetti <strong>di</strong> “intuizione creativa” e <strong>di</strong> “esperienza estetica dell’ente”<br />
mostrando il nesso fondamentale tra estetica e ontologia.<br />
Modalità <strong>di</strong> valutazione: Esame orale.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• J. Maritain, L’intuizione creativa nell’arte e nella poesia, Brescia 1983,<br />
• M. Merleau-Ponty, L’occhio e lo spirito, Milano 1989,<br />
• Roberto Diodato, L’invisibile sensibile, Milano 2012.<br />
Propedeuticità: Estetica generale.<br />
Corsi <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong><br />
Diritto matrimoniale canonico<br />
Esercizi <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto matrimoniale canonico<br />
Prof.ssa Dr.ssa Gabriela Eisenring e Prof.ssa Dr.ssa Marina Magarotto Varini<br />
Sigla: DCCP Semestre autunnale Ects: 3<br />
Presentazione: Il corso <strong>stu<strong>di</strong></strong>a nella prima parte le nozioni fondamentali: quella <strong>di</strong> famiglia<br />
e <strong>di</strong> matrimonio, la genesi del patto coniugale, la struttura del vincolo coniugale, la<br />
sacramentalità <strong>di</strong> questa istituzione, il favor matrimonii, lo ius connubii, la preparazione<br />
al matrimonio, la giuris<strong>di</strong>zione della Chiesa sulla famiglia e, in fine, la <strong>di</strong>mensione formale<br />
della celebrazione delle nozze canoniche. Nella seconda parte si <strong>stu<strong>di</strong></strong>a le <strong>di</strong>verse<br />
cause <strong>di</strong> nullità del matrimonio, sulla base della regolamentazione fornita dal Co<strong>di</strong>ce,<br />
dell’esame della giurisprudenza e della dottrina canonica. Vengono trattati qui gli impe-<br />
67
Corsi <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong><br />
<strong>di</strong>menti matrimoniali, anomalie del consenso quale causa efficiente del matrimonio, che<br />
nessuna autorità umana può supplire e la convalida e sanazione del matrimonio invalido.<br />
L’insegnamento teorico verrà completato con sessioni in cui sono risolti i casi pratici.<br />
Infine, il programma contempla anche casi eccezionali <strong>di</strong> scioglimento del matrimonio,<br />
la separazione coniugale con permanenza del vincolo e alcuni aspetti particolari della<br />
relazione matrimoniale e gli aspetti giuri<strong>di</strong>ci della pastorale familiare.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• P. Barbero, Diritto matrimoniale canonico, <strong>Lugano</strong> 2009;<br />
• P.J. Viladrich, Il consenso matrimoniale. Tecniche <strong>di</strong> qualificazione e <strong>di</strong> esegesi delle<br />
cause canoniche <strong>di</strong> nullità (cc. 1095-1107 CIC), Milano 2001.<br />
Istituzioni <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto romano<br />
Prof.ssa Dr.ssa Gabriela Eisenring<br />
Sigla: DCCO Semestre autunnale Ects: 3<br />
Presentazione: Lo <strong>stu<strong>di</strong></strong>o del sistema giuri<strong>di</strong>co del periodo classico romano, ricostruito<br />
partendo dalle fonti, fornisce le basi per comprendere le istituzioni giuri<strong>di</strong>che recepite<br />
dall’or<strong>di</strong>namento canonico. Il corso <strong>stu<strong>di</strong></strong>a il <strong>di</strong>ritto romano come fenomeno storico e<br />
come componente fondamentale della cultura giuri<strong>di</strong>ca me<strong>di</strong>evale e moderna in Occidente.<br />
Verrà posta in luce, attraverso l’analisi <strong>di</strong> alcuni principi ed istituzioni giuri<strong>di</strong>ci<br />
particolarmente significativi, l’importanza che assume il <strong>di</strong>ritto romano con le sue concezioni<br />
e dello sviluppo del <strong>di</strong>ritto canonico.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
All’inizio delle lezioni saranno in<strong>di</strong>cate la bibliografia <strong>di</strong> base e le fonti che verranno<br />
utilizzate nell’ambito del corso.<br />
Temi scelti <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto processuale II<br />
Prof.ssa Dr.ssa Gabriela Eisenring<br />
Sigla: DCCO Semestre primaverile Ects: 1.5<br />
La descrizione sarà fornita all’inizio dell’anno accademico.<br />
Temi scelti <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto sostantivo e processuale matrimoniale<br />
Prof.ssa Dr.ssa Gabriela Eisenring<br />
Sigla: DCSO Semestre primaverile Ects: 4<br />
Presentazione: Il seminario ha per oggetto lo <strong>stu<strong>di</strong></strong>o e l’analisi della prassi processuale<br />
canonica nelle cause <strong>di</strong> nullità del matrimonio relativamente al can. 1095, nn. 2-3 ed<br />
al can. 1101. La prima parte del seminario è de<strong>di</strong>cata all’approfon<strong>di</strong>mento critico dello<br />
<strong>stu<strong>di</strong></strong>o della normativa contenuta nel can. 1095, nn. 2-3 e nel can. 1101. La seconda<br />
parte del seminario prevede l’esposizione e la <strong>di</strong>scussione <strong>di</strong> alcune fattispecie concrete<br />
<strong>di</strong> nullità matrimoniale.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• C. Gullo - A. Gullo, Prassi processuale nelle cause canoniche <strong>di</strong> nullità del matrimonio,<br />
Città del Vaticano 2005.<br />
68
I riferimenti giurisprudenziali saranno in<strong>di</strong>cati durante lo svolgimento delle lezioni.<br />
Prassi giu<strong>di</strong>ziale canonica<br />
Prof. Dr. Bene<strong>di</strong>ct Ejeh<br />
Sigla: DCCO Semestre primaverile Ects: 3<br />
Presentazione: Il corso intende riprendere le conoscenze già apprese <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto processuale<br />
allargandole, in chiave pratica, al processo <strong>di</strong> nullità matrimoniale, con particolare<br />
attenzione a quanto in<strong>di</strong>cato dall’Istruzione “Dignitas connubii”, del 25 gennaio 2005.<br />
Durante il corso verranno assegnate anche esercitazioni pratiche per familiarizzare con<br />
la prassi giu<strong>di</strong>ziale canonica, nonché verranno offerti specimen <strong>di</strong> atti giu<strong>di</strong>ziari.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• C. Gullo, Prassi processuale nelle cause canoniche <strong>di</strong> nullità del matrimonio. Terza<br />
e<strong>di</strong>zione aggiornata con l’Istr. “Dignitas Connubii” del 25 gennaio 2005, Città del<br />
Vaticano 2009 3 ;<br />
• D. Salvatori, Principi fondamentali <strong>di</strong> prassi giu<strong>di</strong>ziaria, ad usum au<strong>di</strong>torum Venezia<br />
2011;<br />
• J.I. Arrieta (ed.), L’Istruzione Dignitas Connubii nella <strong>di</strong>namica delle cause matrimoniali,<br />
Venezia 2006;<br />
• P.A. Bonnet - C. Gullo (ed.), Il giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> nullità matrimoniale dopo l’Istruzione Dignitas<br />
Connubii. Parte prima: i principi, Stu<strong>di</strong> giuri<strong>di</strong>ci 75, Città del Vaticano 2007;<br />
• P.A. Bonnet - C. Gullo (ed.), Il giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> nullità matrimoniale dopo l’Istruzione<br />
Dignitas Connubii. Parte seconda: la parte statica del processo, Stu<strong>di</strong> giuri<strong>di</strong>ci 76,<br />
Città del Vaticano 2007;<br />
• P.A. Bonnet - C. Gullo (ed.), Il giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> nullità matrimoniale dopo l’Istruzione<br />
Dignitas Connubii. Parte terza: la parte <strong>di</strong>namica del processo, Stu<strong>di</strong> giuri<strong>di</strong>ci 77,<br />
Città del Vaticano 2008.<br />
Corsi <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong><br />
Filosofia e religione<br />
Prof. Dr. Adriano Fabris<br />
Sigla: FFCO Semestre autunnale Ects: 3<br />
Obiettivo corso: Il corso si propone <strong>di</strong> analizzare i mo<strong>di</strong> in cui è possibile, da un punto<br />
<strong>di</strong> vista filosofico, approfon<strong>di</strong>re la <strong>di</strong>mensione dell’esperienza religiosa.<br />
Modalità <strong>di</strong> valutazione: Esame orale.<br />
Contenuto del corso: Nel corso saranno approfon<strong>di</strong>te, da un punto <strong>di</strong> vista fenomenologico<br />
e antropologico, la <strong>di</strong>fferenza e la relazione che sussistono tra l’approccio filosofico<br />
e l’atteggiamento religioso e sarà in<strong>di</strong>viduata nel problema del senso la questione che<br />
anima la ricerca filosofica e che trova nel coinvolgimento della fede una sua adeguata<br />
elaborazione. Come testo <strong>di</strong> riferimento in proposito sarà analizzato il Proslogion <strong>di</strong> S.<br />
Anselmo.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• S. Anselmo, Proslogion, Milano oppure Roma;<br />
• A. Fabris, Filosofia della religione, Roma 2012.<br />
69
Corsi <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong><br />
Corso monografico <strong>di</strong> Storia della filosofia contemporanea:<br />
Fenomenologia e filosofia dell’esistenza<br />
Prof. Dr. Adriano Fabris<br />
Sigla: FFCP Semestre primaverile Ects: 1.5<br />
Obiettivo corso: Il corso intende approfon<strong>di</strong>re alcuni aspetti della riflessione fenomenologica,<br />
in particolare <strong>di</strong> area cattolica, e della filosofia dell’esistenza.<br />
Modalità <strong>di</strong> valutazione: Esame orale.<br />
Contenuto del corso: Il corso intende offrire una specifica ricostruzione, soprattutto,<br />
del pensiero <strong>di</strong> Edmund Husserl, <strong>di</strong> E<strong>di</strong>th Stein, <strong>di</strong> Max Scheler, <strong>di</strong> Martin Heidegger, <strong>di</strong><br />
Gabriel Marcel, attraverso un puntuale riferimento alle principali opere <strong>di</strong> questi autori.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
È obbligatoria e utile la lettura del manuale <strong>di</strong> storia della filosofia <strong>di</strong> G. Reale e D. Antiseri,<br />
pubblicato da La Scuola <strong>di</strong> Brescia. È richiesta in particolare la lettura dei capitoli<br />
riguardanti gli autori citati<br />
Propedeuticità: Conoscenze <strong>di</strong> storia della filosofia.<br />
Musulmani in Europa: sfida ed opportunità per la libertà religiosa<br />
Prof. Dr. Silvio Ferrari<br />
Sigla: DCCO Semestre autunnale Ects: 1.5<br />
La descrizione sarà fornita all’inizio dell’anno accademico.<br />
Modelli <strong>di</strong> rapporto tra Stato e Chiesa in Europa<br />
Prof. Dr. Silvio Ferrari<br />
Sigla: DCCO Semestre primaverile Ects: 1.5<br />
La descrizione sarà fornita all’inizio dell’anno accademico.<br />
Introduzione all’Antico Testamento<br />
Prof. Dr. Marcello Fidanzio e Dott.ssa Maura Sala<br />
Sigla: ATCP Semestre autunnale Ects: 4.5<br />
Obiettivo corso: Introdurre allo <strong>stu<strong>di</strong></strong>o dell’Antico Testamento valendosi delle scienze<br />
dell’antichità e della tra<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> lettura della Scrittura all’interno della Chiesa.<br />
Modalità <strong>di</strong> valutazione: Esame orale.<br />
Contenuto del corso: Ambiente biblico (geografia e introduzione alla storia d’Israele),<br />
formazione e caratteristiche del testo biblico (rapporto oralità e scrittura, generi letterari,<br />
antiche versioni e introduzione alla critica testuale). Canone, l’ispirazione, ermeneutica<br />
della Scrittura.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• L. Mazzinghi, Storia <strong>di</strong> Israele. Dalle origini al periodo romano, Bologna 2007;<br />
• Introduzione all’Antico Testamento, a cura <strong>di</strong> E. Zenger, Brescia 2005;<br />
• Pontificia Commissione Biblica, L’interpretazione della Bibbia nella Chiesa. Commento<br />
a cura <strong>di</strong> G. Giberti – F. Mosetto, Torino 1997.<br />
70
Salmi<br />
Prof. Dr. Marcello Fidanzio<br />
Sigla: ATCP Semestre autunnale Ects: 1.5<br />
Obiettivo corso: Introdurre allo <strong>stu<strong>di</strong></strong>o e alla preghiera dei Salmi e del salterio come<br />
libro.<br />
Modalità <strong>di</strong> valutazione: Esame orale.<br />
Contenuto del corso: Saranno presentate le tre gran<strong>di</strong> correnti della moderna ricerca<br />
sui Salmi (storia delle forme, analisi poetica, lettura canonica) sia sotto il profilo teorico,<br />
sia con lo <strong>stu<strong>di</strong></strong>o esemplare <strong>di</strong> alcuni salmi. Infine s’introdurrà l’interpretazione cristiana<br />
e il metodo prosopologico.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• L. Alonso Schökel, I Salmi, Roma, 1992-1993.<br />
• G. Barbiero, Il regno <strong>di</strong> Jhwh e del suo Messia. Salmi scelti dal primo libro del Salterio,<br />
Roma 2008.<br />
• M.-J. Rondeau, Les commentaires patristiques du Psautier, Roma 1982-1985.<br />
Corsi <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong><br />
Lingua ebraica A<br />
Prof. Dr. Marcello Fidanzio<br />
Sigla: DICP Semestri autunnale/primaverile Ects: -<br />
Obiettivo corso: Introdurre alla lettura della lingua ebraica biblica e alla conoscenza<br />
delle sue strutture fondamentali.<br />
Modalità <strong>di</strong> valutazione: Esame orale.<br />
Contenuto del corso: A) Ortografia e Fonologia: consonanti, vocali, sillabe, accenti; B)<br />
Morfologia: articolo, preposizioni e particelle, pronomi, sostantivi, aggettivi, introduzione<br />
al sistema verbale; C) Elementi <strong>di</strong> sintassi; D) Lessico ebraico.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• J. Weingreen, Grammatica <strong>di</strong> Ebraico Biblico, trad. <strong>di</strong> M. Fidanzio, <strong>Lugano</strong>-Milano<br />
2011 (inglese: A practical Grammar for Biblical Hebrew, Oxford 1959; francese:<br />
Hébreu Biblique. Méthode élémentaire, Paris 2004).<br />
Introduzione al Nuovo Testamento<br />
Prof. Dr. Marcello Fidanzio<br />
Sigla: NTCP Semestre primaverile Ects: 3<br />
Obiettivo corso: Introdurre allo <strong>stu<strong>di</strong></strong>o del Nuovo Testamento valendosi delle scienze<br />
dell’antichità e della tra<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> lettura della Scrittura all’interno della Chiesa.<br />
Modalità <strong>di</strong> valutazione: Esame orale.<br />
Contenuto del corso: Prima parte: ambiente del NT (quadro geografico, situazione<br />
storica, istituzioni sociali e politiche, correnti e gruppi religiosi, testimonianze archeologiche),<br />
testo del NT (formazione, storia del testo, critica testuale), interpretazione.<br />
Seconda parte presentazione cursiva dei libri del NT.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• M. Orsatti, Introduzione al Nuovo Testamento, <strong>Lugano</strong> 2005;<br />
71
• R. Penna, La Formazione del Nuovo Testamento nelle sue tre <strong>di</strong>mensioni, Cinisello<br />
Balsamo 2011;<br />
• R.E. Brown, Introduzione al Nuovo Testamento, Brescia 2001.<br />
Corsi <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong><br />
Introduzione alla teologia bizantino-ortodossa<br />
Prof.ssa Emanuela Foglia<strong>di</strong>ni<br />
Responsabile scientifico: Prof. Dr. Azzolino Chiappini<br />
Sigla: DICO Semestre autunnale Ects: 3<br />
Obiettivo corso: Fornire una panoramica sulla specificità della riflessione teologica bizantino-ortodossa.<br />
Modalità <strong>di</strong> valutazione: Esame orale.<br />
Contenuto del corso: Il corso prenderà in esame i <strong>di</strong>versi capitoli della teologia bizantino-ortodossa<br />
sul piano teologico e estetico: ciascuno <strong>di</strong> essi verrà illustrato a partire<br />
dalle icone che “rappresentano” lo specifico tema trattato e dalla riflessione teologica<br />
che ne esprime il contenuto. Lo specifico approccio ortodosso a queste tematiche sarà<br />
perseguito attraverso un confronto con la prospettiva occidentale.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• E. Foglia<strong>di</strong>ni, L’immagine negata. Il concilio <strong>di</strong> Hieria e la formalizzazione ecclesiale<br />
dell’iconoclasmo, Milano <strong>2013</strong>;<br />
• J. Meyendorff, La teologia bizantina. Sviluppi storici e temi dottrinali, Marietti/Lampi<br />
<strong>di</strong> Stampa, 1999;<br />
• Leonid Uspenskij, La teologia dell’icona. Iconografia e storia, Milano 2009.<br />
Diritto bud<strong>di</strong>sta<br />
Prof. Dr. Domenico Francavilla<br />
Sigla: DCCO Semestre autunnale Ects: 1.5<br />
La descrizione sarà fornita all’inizio dell’anno accademico.<br />
Diritto indù<br />
Prof. Dr. Domenico Francavilla<br />
Sigla: DCCO Semestre primaverile Ects: 1.5<br />
Presentazione: Nella prima parte del corso verranno esaminati i concetti fondamentali<br />
del <strong>di</strong>ritto indù e la sua evoluzione storica. In particolare verranno analizzati: il concetto<br />
<strong>di</strong> dharma, le fonti del <strong>di</strong>ritto indù, la soluzione delle controversie. Nella seconda parte<br />
verranno <strong>stu<strong>di</strong></strong>ati alcuni aspetti del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> famiglia indù nell’In<strong>di</strong>a contemporanea e<br />
nelle comunità della <strong>di</strong>aspora in Europa.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• D. Francavilla, “Diritto indù”, in S. Ferrari-A. Neri (a cura <strong>di</strong>), Introduzione al<br />
<strong>di</strong>ritto comparato delle religioni, <strong>Lugano</strong>, 2007, pp. 219-238;<br />
• W. Menski, Hindu Law: Beyond Tra<strong>di</strong>tion and Modernity, Delhi, 2003, pp. 71-130<br />
e pp. 273-321; in alternativa: R. Lingat, La tra<strong>di</strong>zione giuri<strong>di</strong>ca dell’In<strong>di</strong>a, Milano,<br />
2003, pp. 13-32 e pp. 203-359.<br />
72
Nel corso delle lezioni verrà inoltre <strong>di</strong>stribuito altro materiale.<br />
Diritti e popoli nel Magistero <strong>di</strong> Giovanni Paolo II<br />
Prof. Dr. Libero Gerosa<br />
Sigla: DCCO Semestre autunnale Ects: 1.5<br />
Presentazione: Tanto a livello del necessario rinnovamento <strong>di</strong>sciplinare e canonico,<br />
quanto a quello dell’altrettanto necessario rilancio dell’azione missionaria della Chiesa.<br />
Giovanni Paolo II è stato ante litteram un campione dell’ermeneutica del rinnovamento<br />
nella continuità proposta da Papa Benedetto XVI come chiave <strong>di</strong> lettura e <strong>di</strong> attuazione<br />
del Concilio Vaticano II. Non solo la <strong>di</strong>mostrazione della verità <strong>di</strong> questa osservazione,<br />
ma soprattutto l’in<strong>di</strong>viduazione dei suoi principi fondamentali e delle sue possibili<br />
prospettive <strong>di</strong> sviluppo sia a livello del <strong>di</strong>ritto della Chiesa, sia a quello più generale dei<br />
<strong>di</strong>ritti umani e dei <strong>di</strong>ritti dei popoli, costituiscono gli obiettivi principali <strong>di</strong> questo corso.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
Le in<strong>di</strong>cazioni bibliografiche si trovano nell’apparato critico dei libri <strong>di</strong>:<br />
• L. Gerosa, L’identità laica dei citta<strong>di</strong>ni europei: inconciliabile con il monismo islamico?<br />
Implicazioni giuri<strong>di</strong>co-istituzionali del <strong>di</strong>alogo interreligioso, 2009;<br />
• Id., Diritti e popoli in Giovanni Paolo II, <strong>Lugano</strong>-Venezia <strong>2013</strong>.<br />
Corsi <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong><br />
Istituzioni generali <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto canonico<br />
Prof. Dr. Libero Gerosa e Lic. theol.; Lic. iur. can. Andrea Stabellini<br />
Sigla: DCCP Semestre autunnale Ects: 3<br />
Presentazione: Tutto il <strong>di</strong>ritto canonico, ossia il <strong>di</strong>ritto della Chiesa, sia come realtà<br />
strutturale intrinseca della comunione ecclesiale sia come scienza, è ultimamente informato<br />
e perciò spiegabile a partire dai tre elementi primor<strong>di</strong>ali della costituzione<br />
della Chiesa: Parola, Sacramento e Carisma. Ciò vale anche per sistematica e contenuti<br />
normativi principali del nuovo Co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto canonico per la Chiesa Cattolica Latina.<br />
Quali sono gli istituti canonici principali del CIC ed i principi ecclesiologici ad essi<br />
soggiacenti? Il confronto con il Co<strong>di</strong>ce per le Chiese Cattoliche Orientali può aiutare a<br />
comprenderli meglio? A queste ed altre domande risponde il corso presentando tutti i<br />
principali istituti giuri<strong>di</strong>ci del <strong>di</strong>ritto canonico.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• L. Gerosa, Introduzione al <strong>di</strong>ritto canonico, Città del Vaticano 2012, Vol. II.<br />
La bibliografia <strong>di</strong> approfon<strong>di</strong>mento sarà fornita all’inizio del corso.<br />
<strong>Teologia</strong> del <strong>di</strong>ritto canonico e norme generali I<br />
Prof. Dr. Libero Gerosa<br />
Sigla: DCCP Semestre autunnale Ects: 3<br />
Presentazione: La Chiesa, comunità <strong>di</strong> fede e amore nata dall’ascolto del Vangelo e dalla<br />
celebrazione dei Sacramenti, ha bisogno <strong>di</strong> una struttura giuri<strong>di</strong>ca per essere se stessa e<br />
svolgere la sua missione nel mondo? In campo cattolico finora la risposta più compiuta<br />
l’ha data il canonista tedesco Klaus Mörsdorf: Parola e Sacramento non solo sono le due<br />
73
Corsi <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong><br />
colonne principali della Costituzione della Chiesa, ma in quanto “parola” e “simbolo”<br />
sono anche le forme primarie della comunicazione umana, con una struttura ontologica<br />
capace <strong>di</strong> produrre relazioni giuri<strong>di</strong>che in ogni cultura. Quali sono i fondamenti storici<br />
e gli sviluppi sistematici post-conciliari <strong>di</strong> questa geniale intuizione? Il corso <strong>di</strong> <strong>Teologia</strong><br />
del <strong>di</strong>ritto canonico (= I parte) risponde a questi interrogativi; la chiave ermeneutica per<br />
comprendere le Norme generali del CIC (= II parte), ed in particolare quelle riguardanti<br />
la legge, la consuetu<strong>di</strong>ne e l’atto amministrativo nella Chiesa è invece quella suggerita<br />
da Papa Benedetto XVI alla Rota Romana (21.01.2012): il trascen<strong>di</strong>mento della lettera<br />
rende cre<strong>di</strong>bile la lettera stessa.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• L. Gerosa, Introduzione al <strong>di</strong>ritto canonico, Citta del Vaticano 2012, Vol. I.<br />
La bibliografia <strong>di</strong> approfon<strong>di</strong>mento sarà fornita all’inizio del corso.<br />
Diritto canonico e pastorale<br />
Prof. Dr. Libero Gerosa<br />
Sigla: DCCP Semestre primaverile Ects: 3<br />
Presentazione: La “pastoralità” è il leimotiv <strong>di</strong> tutta la co<strong>di</strong>ficazione canonica. Vale davvero<br />
questo principio in tutti i canoni del <strong>di</strong>ritto della Chiesa? Anche per i Movimenti e<br />
le Nuove Comunità? Anche per l’amministrazione? Il corso/seminario vuole rispondere<br />
a queste domande attraverso 2 serie <strong>di</strong> esercitazioni pratiche: la prima sui problemi incontrati<br />
dalle nuove forme aggregative nella loro integrazione con la pastorale <strong>di</strong>ocesana;<br />
la seconda con l’analisi <strong>di</strong> <strong>di</strong>versi atti amministrativi. Entrambe si concluderanno con<br />
un esame scritto.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
La bibliografia sarà fornita all’inizio del corso.<br />
Diritto costituzionale canonico I<br />
Prof. Dr. Libero Gerosa<br />
Sigla: DCCP Semestre primaverile Ects: 3<br />
Presentazione: Il programma del corso comprende lo <strong>stu<strong>di</strong></strong>o dei fondamenti ecclesiologici<br />
del <strong>di</strong>ritto costituzionale canonico e quello delle nozioni, spesso travisate nell’opinione<br />
pubblica, <strong>di</strong> collegialità, partecipazione, sinodalità, corresponsabilità e cooperazione.<br />
Accanto alla descrizione <strong>di</strong> natura e scopo <strong>degli</strong> organi <strong>di</strong> governo nel corso ci si<br />
pone domande circa la possibilità <strong>di</strong> una Costituzione formale della Chiesa Universale,<br />
la necessità <strong>di</strong> superare pericolose riduzioni nazionalistiche delle Chiese particolari, le<br />
<strong>di</strong>verse modalità <strong>di</strong> esercizio del potere al servizio della comunione e della missione<br />
ecclesiale.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• L. Gerosa, Introduzione al <strong>di</strong>ritto canonico, Citta del Vaticano 2012, Vol. II;<br />
• G. Incitti, Il Popolo <strong>di</strong> Dio. La struttura giuri<strong>di</strong>ca fondamentale tra uguaglianza e<br />
<strong>di</strong>versità, Roma 2007.<br />
74
Logica classica<br />
Prof. Dr. Alessandro Giordani<br />
Sigla: FFCP Semestre autunnale Ects: 4<br />
Obiettivo corso: Il corso offre un’introduzione alla logica classica.<br />
Modalità <strong>di</strong> valutazione: Esame orale.<br />
Contenuto del corso: Il corso <strong>di</strong> logica classica costituisce un’introduzione alla logica sviluppata<br />
secondo lo schema scolastico. Il corso è quin<strong>di</strong> sud<strong>di</strong>viso in due parti. La prima,<br />
corrispondente alla logica minor tra<strong>di</strong>zionale, presenterà una teoria essenziale dei concetti,<br />
delle proposizioni e delle inferenze. La seconda, corrispondente alla logica maior<br />
tra<strong>di</strong>zionale, presenterà le basi della prima dal punto <strong>di</strong> vista ontologico, affrontando i<br />
problemi classici relativi agli universali, in riferimento ai concetti, alla verità, in riferimento<br />
alle proposizioni, e alla connessione <strong>di</strong> conseguenza, in riferimento alle inferenze.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• Dispensa del corso,<br />
• S. Vanni Rovighi, Elementi <strong>di</strong> filosofia, vol I, Brescia 1999,<br />
• C. Boyer, Cursus Philosophiae, vol I, Bruge 1962.<br />
Corsi <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong><br />
Filosofia della natura, della scienza e della tecnica<br />
Prof. Dr. Alessandro Giordani<br />
Sigla: FFCP Semestre primaverile Ects: 3/4.5<br />
Obiettivo corso: Il corso <strong>di</strong> filosofia della natura e della scienza si propone <strong>di</strong> introdurre<br />
gli studenti ai problemi fondamentali della <strong>di</strong>sciplina e alle teorie attualmente <strong>di</strong>battute<br />
in questo ambito.<br />
Modalità <strong>di</strong> valutazione: Esame orale.<br />
Contenuto del corso: Il corso si sviluppa in tre parti. Nella prima parte si intende chiarire<br />
il concetto <strong>di</strong> conoscenza scientifica, come forma specifica <strong>di</strong> conoscenza determinata<br />
dai caratteri dell’oggettività e della capacità esplicativa. Nella seconda si considera<br />
il problema delle procedure <strong>di</strong> fondazione scientifica. Nella terza si intende infine introdurre<br />
il <strong>di</strong>battito relativo alla verità scientifica, <strong>di</strong>scutendo le posizioni del realismo e<br />
dell’antirealismo.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• A. Giordani, Lezioni <strong>di</strong> filosofia della scienza, Milano 2010,<br />
• J. Ladyman, Filosofia della scienza, Roma 2007,<br />
• P. Kosso, Leggere il libro della natura, Bologna 1997.<br />
La lettura del libro <strong>di</strong> P. Kosso è obbligatoria per gli studenti che seguono il vecchio<br />
or<strong>di</strong>namento.<br />
Logica contemporanea<br />
Prof. Dr. Alessandro Giordani<br />
Sigla: FFCP Semestre primaverile Ects: 4<br />
Obiettivo corso: Il corso offre un’introduzione alla logica contemporanea.<br />
Modalità <strong>di</strong> valutazione: Esame orale e/o scritto.<br />
Contenuto del corso: IIl corso <strong>di</strong> logica contemporanea presenta un’introduzione alla<br />
75
Corsi <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong><br />
logica, con particolare riferimento ai principali problemi <strong>di</strong> filosofia della logica. Il corso<br />
prevede la trattazione sintattica e semantica della logica classica, proposizionale e<br />
pre<strong>di</strong>cativa, con alcuni sviluppi in relazione alla logica modale. Si prevede inoltre l’applicazione<br />
<strong>degli</strong> strumenti logici introdotti nella trattazione <strong>di</strong> problemi filosofici classici.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• Dispensa del corso,<br />
• S. Galvan, Logica dei pre<strong>di</strong>cati, Milano 1999,<br />
• D. van Dalen, Logic and Structure, Berlin 2004.<br />
Propedeuticità: Nessuna, ma è consigliato il corso <strong>di</strong> Logica classica.<br />
Pluralismo culturale e modelli <strong>di</strong> giustizia<br />
(Filosofia del <strong>di</strong>alogo interculturale)<br />
Prof. Dr. Paolo Gomarasca<br />
Sigla: FFCO Semestre autunnale Ects: 3<br />
Obiettivo corso: Analisi e <strong>di</strong>scussione del problema etico-politico della convivenza tra<br />
culture nelle società complesse.<br />
Modalità <strong>di</strong> valutazione: Esame orale.<br />
Contenuto del corso: Ricostruzione del modello <strong>di</strong> “società bene or<strong>di</strong>nata” presentato<br />
da Rawls in A Theory of Justice (1971) e successivamente riformulato in Political<br />
Liberalism (1993). Focus sulla questione del rapporto tra in<strong>di</strong>viduo e comunità e sulla<br />
questione della compossibilità <strong>di</strong> prospettive culturali alternative entro il framework<br />
democratico. Proposta <strong>di</strong> modelli <strong>di</strong> giustizia concorrenti (A. MacIntyre, C. Taylor).<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• Rawls, John. 2008. Una teoria della giustizia (Milano)<br />
• Rawls, John. 2012. Liberalismo politico (Torino)<br />
• MacIntyre, Alasdair. 2011. “How Aristotelianism can become revolutionary:<br />
ethics, resistance, and utopia”. In Paul Blackledge & Kelvin Knight (eds.), Virtue<br />
and Politics: Alasdair Macintyre’s Revolutionary Aristotelianism (Notre Dame, IN).<br />
Cristologia: parte biblico-storica<br />
Prof. Dr. Manfred Hauke<br />
Sigla: TDCP Semestre autunnale Ects: 3<br />
Presentazione: Il mistero <strong>di</strong> Cristo si trova nel centro <strong>degli</strong> <strong>stu<strong>di</strong></strong> teologici. Il corso <strong>di</strong><br />
cristologia mostra dapprima il fondamento biblico della fede in Gesù Cristo. Seguono la<br />
formazione del dogma cristologico nella Chiesa antica oltre che le linee portanti dell’ulteriore<br />
sviluppo. Un approfon<strong>di</strong>mento sistematico avverrà nell’anno IV (Master).<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• J. Auer, Gesù il Salvatore, 2 vol., Assisi 1993;<br />
• A. Amato, Gesù il Signore, Bologna 1999 5 ;<br />
• C. Schönborn, Dio inviò suo Figlio, Milano 2002.<br />
• A. Ziegenaus, Gesù Cristo. La pienezza della salvezza. Cristologia e soteriologia (Dogmatica<br />
cattolica IV), Città del Vaticano 2012<br />
76
Il ministero petrino<br />
Prof. Dr. Manfred Hauke<br />
Sigla: TDCO Semestre autunnale Ects: 3<br />
Obiettivo corso: Il corso approfon<strong>di</strong>sce la comprensione del ministero petrino nella<br />
Chiesa.<br />
Modalità <strong>di</strong> valutazione: Esame orale (<strong>di</strong>spensa).<br />
Contenuto del corso: Il legame con il successore <strong>di</strong> Pietro è essenziale per la fede cattolica.<br />
Il corso presenta i fondamenti biblici e lo sviluppo storico del primato pontificio<br />
per dare poi uno sguardo alla <strong>di</strong>scussione sistematica. Vi entra anche la <strong>di</strong>mensione<br />
ecumenica e l’accoglienza del ministero petrino nella vita dei santi.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• Aa. Vv., Il primato del successore <strong>di</strong> Pietro, Città del Vaticano 1998;<br />
• W. Kasper (ed.), Il ministero petrino. Cattolici e ortodossi in <strong>di</strong>alogo, Roma 2004;<br />
• K. Schatz, Il primato del Papa. La sua storia dalle origini ai nostri giorni, Brescia 1996.<br />
Mariologia<br />
Prof. Dr. Manfred Hauke<br />
Sigla: TDCP Semestre autunnale Ects: 3<br />
Presentazione: Il corso descrive l‘importanza <strong>di</strong> Maria “nel mistero <strong>di</strong> Cristo e della<br />
Chiesa” (Lumen gentium, cap. VIII). Dopo una presentazione dei dati biblici ed un breve<br />
sguardo generale sulla storia della mariologia, verranno trattati i contenuti sistematici<br />
(fra cui i quattro dogmi mariani: Maria Vergine e Madre <strong>di</strong> Dio, Immacolata Concezione,<br />
Assunzione).<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• J. Galot, Maria. La donna nell’opera della salvezza, Roma 2005 3 ;<br />
• M. Ponce Cuéllar, María. Madre del Redentor y Madre de la Iglesia, Barcelona<br />
2001 2 ;<br />
• M. Hauke, Introduzione alla Mariologia (Collana <strong>di</strong> Mariologia, 2), <strong>Lugano</strong> 2008.<br />
Corsi <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong><br />
Il sacramento dell’Eucaristia nel <strong>di</strong>battito contemporaneo<br />
Prof. Dr. Manfred Hauke<br />
Sigla: TDSO Semestre autunnale Ects: 4<br />
Obiettivo corso: Il seminario si focalizza su alcune tematiche specialmente <strong>di</strong>scusse<br />
della teologia moderna.<br />
Modalità <strong>di</strong> valutazione: Lavoro scritto (e partecipazione orale).<br />
Contenuto del corso: L’Eucaristia è “fonte e culmine <strong>di</strong> tutta la vita cristiana”. Facendo<br />
tesoro della <strong>di</strong>scussione teologica contemporanea, verranno <strong>stu<strong>di</strong></strong>ate tra l’altro la questione<br />
della “forma” essenziale della Santa Messa, la transustanziazione, il rapporto tra<br />
sacrificio e banchetto, l’interpretazione del pro multis e l’approccio teologico <strong>di</strong> papa<br />
Benedetto XVI per la “riforma della riforma” liturgica.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• A. García Ibáñez, L’Eucaristia, dono e mistero. Trattato storico-dogmatico sul mistero<br />
eucaristico, Roma 2006;<br />
77
• V. Raffa, Liturgia eucaristica, Roma 2003 2 (ristampa 2011);<br />
• J. Ratzinger, <strong>Teologia</strong> della liturgia (Opera omnia 11), Città del Vaticano 2010.<br />
Corsi <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong><br />
Storia dei dogmi<br />
Prof. Dr. Manfred Hauke<br />
Sigla: TDCP Semestre autunnale Ects: 3<br />
Presentazione: La dogmatica integra in sé una lunga storia delle risposte della Chiesa nel<br />
proporre la <strong>di</strong>vina Rivelazione. Perciò ci vuole una conoscenza <strong>di</strong> base delle principali<br />
tappe <strong>di</strong> questa storia la quale comincia già nelle praesymbola del Nuovo Testamento,<br />
si articola con vigore nei Concili ecumenici e si manifesta anche in vari documenti pontifici.<br />
Il corso seguirà essenzialmente una traccia cronologica in cui saranno integrati i<br />
vari aspetti sistematici. Per partecipare alla presentazione è in<strong>di</strong>spensabile l’utilizzo del<br />
“Denzinger”. Infine verranno sviluppati sistematicamente i principi ermeneutici inerenti<br />
allo sviluppo del dogma.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• H. Denzinger, Enchiri<strong>di</strong>on symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei<br />
et morum. E<strong>di</strong>zione bilingue, a cura <strong>di</strong> P. Hünermann, Bologna 2004 5 ;<br />
• J. Collantes, La fede della Chiesa cattolica. Le idee e gli uomini nei documenti dottrinali<br />
del Magistero, Città del Vaticano 1993;<br />
• B. Sesboüé – J. Wolinski (edd.), Storia dei dogmi, 4 voll., Casale Monferrato 1996-98.<br />
Le apparizioni mariane nella vita della Chiesa<br />
Prof. Dr. Manfred Hauke<br />
Sigla: TDCO Semestre primaverile Ects: 3<br />
Obiettivo corso: Il corso vuol contribuire al <strong>di</strong>scernimento tra mariofanie autentiche e<br />
pseudo-manifestazioni.<br />
Modalità <strong>di</strong> valutazione: Esame orale (<strong>di</strong>spensa).<br />
Contenuto del corso: Le apparizioni mariane fanno parte del carisma profetico e hanno<br />
bisogno d’essere <strong>di</strong>stinte da fenomeni pseudo-mistiche. Il corso offre una panoramica<br />
storica sulle mariofanie con l’accento sugli eventi accolti come cre<strong>di</strong>bili dall’autorità ecclesiastica.<br />
Dalla presentazione emergono l’interpretazione teologica e una criteriologia<br />
per il sano <strong>di</strong>scernimento.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• D.A. Foley, Il libro delle apparizioni mariane. Influenza e significato nella storia<br />
dell’uomo e della Chiesa, Milano 2004;<br />
• Pontificia Academia Mariana Internationalis (ed.), Apparitiones Beatae Mariae Virginis<br />
in historia, fide, theologia. Acta congressus mariologici-mariani internationalis in<br />
civitate Lourdes anno 2008 celebrati, a cura <strong>di</strong> S.M. Cecchin e A. Ligotti, vol. I, Città<br />
del Vaticano 2010;<br />
• R. Laurentin – P. Sbalchiero (edd.), Dizionario delle apparizioni della Vergine Maria,<br />
Roma 2010.<br />
78
Cristologia: parte sistematica<br />
Prof. Dr. Manfred Hauke<br />
Sigla: TDCP Semestre primaverile Ects: 4.5<br />
Presentazione: Il corso è la continuazione della prima parte (biblico-storica) collocata<br />
nel primo anno <strong>degli</strong> <strong>stu<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> baccellierato. Ci sarà un approfon<strong>di</strong>mento dei gran<strong>di</strong> temi<br />
sistematici attorno alla persona e all’opera salvifica <strong>di</strong> Gesù Cristo. Si <strong>stu<strong>di</strong></strong>ano i vari<br />
aspetti della natura <strong>di</strong>vina e <strong>di</strong> quella umana del Salvatore uniti nell’unica persona del<br />
Verbo eterno (p.es. l’unione ipostatica e l’autocoscienza <strong>di</strong> Gesù). La soteriologia verrà<br />
particolarmente sviluppata e comprende vari aspetti: l’aspetto “narrativo” dei “Misteri<br />
della vita <strong>di</strong> Gesù” (come la “vita nascosta”, il battesimo al Giordano, la Trasfigurazione,<br />
la Passione, la Risurrezione); l’esplorazione dei concetti chiave (come me<strong>di</strong>azione,<br />
redenzione, solidarietà salvifica, sostituzione vicaria, espiazione, riconciliazione). In fine,<br />
ci si accosta al rapporto tra l’unicità della me<strong>di</strong>azione <strong>di</strong> Cristo e l’universalità della sua<br />
offerta salvifica.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• G. Cavalcoli, Il mistero della Redenzione, Bologna 2004;<br />
• M. Gronchi, Trattato su Gesù Cristo Figlio <strong>di</strong> Dio Salvatore, Brescia 2008;<br />
• J. Ratzinger – Benedetto XVI, Gesù <strong>di</strong> Nazaret, 2 voll., Città del Vaticano 2007 e<br />
2010. (ve<strong>di</strong> anche la bibliografia della parte biblico-storica).<br />
Corsi <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong><br />
La Creazione e il peccato originale<br />
Prof. Dr. Manfred Hauke<br />
Sigla: TDCP Semestre primaverile Ects: 3<br />
Presentazione: Il corso dogmatico sulla creazione mostra l’importanza e la concretezza<br />
della fede in Dio Creatore. Dopo un’introduzione biblica e storica del tema, il percorso<br />
tratta la relazione generale del creato in Dio, tra cui la creazione dal nulla, la bontà del<br />
mondo e la <strong>di</strong>vina provvidenza. Si <strong>stu<strong>di</strong></strong>ano poi le singole opere del creato: l’uomo, il<br />
cosmo visibile nel suo rapporto con l’umanità e gli angeli. Infine viene presentata la<br />
dottrina del peccato originale.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• G. Gozzelino, Il mistero dell’uomo in Cristo. Saggio <strong>di</strong> protologia, Leumann (Torino)<br />
1992;<br />
• J. Morales, El Misterio de la Creación, Pamplona 1994;<br />
• L. Scheffczyk, La creazione come apertura alla salvezza. Dottrina della creazione<br />
(Dogmatica cattolica III), Città del Vaticano 2012.<br />
Morte e immortalità come temi chiave dell’escatologia cristiana<br />
Prof. Dr. Manfred Hauke<br />
Sigla: TDCO/SO Semestre primaverile Ects: 3/4<br />
Seminario e corso opzionale in blocco, 10-13 febbraio <strong>2014</strong>.<br />
Il seminario può essere anche seguito come corso opzionale.<br />
Obiettivo corso: Vengono <strong>stu<strong>di</strong></strong>ati dei temi <strong>di</strong> confine tra la cultura contemporanea e la<br />
fede cristiana.<br />
79
Corsi <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong><br />
Modalità <strong>di</strong> valutazione: Lavoro scritto (e partecipazione orale) (per il seminario) – esame<br />
orale (per chi segue il seminario come corso).<br />
Contenuto del corso: La morte è uno dei problemi più rilevanti dell’esistenza umana. Il<br />
messaggio cristiano offre la risposta decisiva, capace d’integrare la conoscenza umana e<br />
<strong>di</strong> illuminarla con la <strong>di</strong>vina rivelazione. Il seminario approfon<strong>di</strong>rà alcuni aspetti speciali,<br />
tra l’altro la valutazione delle “esperienze pre-morte” e il rapporto tra l’immortalità<br />
dell’anima e la risurrezione della carne.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• G. Ancona, Escatologia cristiana (Nuovo corso <strong>di</strong> teologia sistematica, XIII), Brescia<br />
2007 2 ;<br />
• P.C. Düren, Der Tod als Ende des ir<strong>di</strong>schen Pilgerstandes, Augsburg 2001 4 ;<br />
• A. Ziegenaus, Il futuro della creazione in Dio. Escatologia (Dogmatica cattolica, VIII),<br />
Città del Vaticano 2012 (in preparazione).<br />
Storia della Chiesa I: antica<br />
Prof. Dr. Manfred Hauke<br />
Sigla: SCCP Semestre primaverile Ects: 3<br />
Presentazione: Per comprendere la vita della Chiesa è in<strong>di</strong>spensabile una conoscenza <strong>di</strong><br />
base del suo percorso storico. Nella Chiesa antica si manifestano i fondamenti della fede<br />
nelle loro origini, per esempio il canone delle Sacre Scritture, la vita liturgica e la struttura<br />
gerarchica. Il superamento <strong>di</strong> varie eresie permette un chiarimento della dottrina<br />
ecclesiale, professata nel Credo. Si svolgono un confronto, un <strong>di</strong>alogo e una ricezione<br />
critica con le culture non cristiane dell’epoca.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• K.S. Frank, Manuale <strong>di</strong> Storia della Chiesa antica, Città del Vaticano 2000;<br />
• A. Franzen, Piccola storia della Chiesa, Brescia 2004 10 ;<br />
• L. Pietri - E. Prinzivalli (a cura <strong>di</strong>), Storia del cristianesimo, voll. I-III, Roma 2000-2003).<br />
La filosofia dell’amore nel Me<strong>di</strong>oevo (da Bernardo Di Chiaravalle<br />
a Marsilio Ficino)<br />
Prof. Dr. Rue<strong>di</strong> Imbach<br />
Sigla: SICO Semestre autunnale Ects: 2<br />
La descrizione sarà fornita all’inizio dell’anno accademico.<br />
<strong>Teologia</strong> morale fondamentale III. La <strong>di</strong>mensione drammatica<br />
dell’agire morale<br />
Prof. Dr. André-Marie Jerumanis<br />
Dr. phil.; Lic. theol. Linda Pellicioli<br />
Sigla: TMCP Semestre autunnale Ects: 3<br />
Presentazione: Esiste una tensione drammatica tra la libertà finita dell’uomo e quella<br />
infinita <strong>di</strong> Dio ra<strong>di</strong>cata nella finitezza dell’uomo e nel rifiuto originario del legame con<br />
Dio. Il peccato appare come una contrad<strong>di</strong>zione della libertà filiale e della sua verità; è<br />
80
ifiuto dell’amicizia filiale. Il corso propone una rilettura del trattato del peccato a partire<br />
dall’Evento cristologico, che offra la possibilità <strong>di</strong> fondare la gratuità del perdono,<br />
e <strong>di</strong> integrare la conversione e la riconciliazione della libertà colpevole nella <strong>di</strong>namica<br />
liberante dell’amore misericor<strong>di</strong>oso manifestato sulla Croce.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• A.M. Jerumanis, In Cristo, con Cristo, per Cristo. Manuale <strong>di</strong> teologia morale fondamentale.<br />
Approccio storico-sistematico, Torino <strong>2013</strong>;<br />
• R. Tremblay, S. Zamboni (eds.), Figli nel Figlio. Una teologia morale fondamentale<br />
(Presentazione <strong>di</strong> Luigi Lorenzetti), Bologna 2008;<br />
• G. Ravasi, Le porte del Peccato. I sette vizi capitali, Milano 2007.<br />
<strong>Teologia</strong> morale speciale I. Una morale del cuore filiale<br />
Prof. Dr. André-Marie Jerumanis<br />
Dr. phil.; Lic. theol. Linda Pellicioli<br />
Sigla: TMCP Semestre autunnale Ects: 3<br />
Presentazione: Nella teoria della virtù, la morale prende come punto <strong>di</strong> partenza l’atto<br />
interiore,da cui deriva l’atto esteriore. La prospettiva filiale dell’antropologia permette<br />
<strong>di</strong> determinare“filialmente” la morale dell’interiorità. Lo Spirito filiale attira a sé l’interiorità<br />
della persona filiale,rendendo possibile la trasformazione dell’uomo “carnale” in<br />
uomo “spirituale” (Gal 5). L’antropologia filiale determina la comprensione delle virtù<br />
teologali e delle virtù car<strong>di</strong>nali, inrelazione con la sequela Christi configurando filialmente<br />
l’organismo delle virtù secondo i tratti filiali <strong>di</strong> Cristo stesso.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• A.M. Jerumanis, In Cristo, con Cristo, per Cristo. Manuale <strong>di</strong> teologia morale fondamentale.<br />
Approccio storico-sistematico, Torino <strong>2013</strong>;<br />
• R. Tremblay, S. Zamboni (eds.), Figli nel Figlio. Una teologia morale fondamentale,<br />
Bologna 2008;<br />
• R. Frattalone, Religione, Fede, Speranza e Carità. Virtù del cristiano, Roma 2003.<br />
Corsi <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong><br />
<strong>Teologia</strong> della misericor<strong>di</strong>a<br />
Prof. Dr. André-Marie Jerumanis<br />
Dr. phil.; Lic. theol. Linda Pellicioli<br />
Sigla: TMCO Semestre autunnale Ects: 3<br />
Presentazione: Presentazione del corso. Il cristianesimo senza la misericor<strong>di</strong>a non è<br />
vero cristianesimo (Papa Francesco). La misericor<strong>di</strong>a è una parola fondamentale della<br />
Scrittura che in realtà esprime “il cuore immenso <strong>di</strong> Dio. E la miseria dell’uomo. Dio<br />
che dal profondo del suo cuore si prende cura delle nostre miserie è il Buon Samaritano<br />
della parabola che <strong>di</strong>ce all’albergatore, pren<strong>di</strong>ti cura e al mio ritorno ti rimborserò.<br />
(Car<strong>di</strong>nal Barbarin). Il corso presenterà i fondamenti <strong>di</strong> la teologia cristiana della misericor<strong>di</strong>a<br />
per mostrane le conseguenze per la teologia morale e il <strong>di</strong>alogo interreligioso.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• W. Kasper, Misericor<strong>di</strong>a.Concetto fondamentale del vangelo - Chiave della vita cristiana,<br />
Brescia <strong>2013</strong>;<br />
81
• C. Rocchetta, <strong>Teologia</strong> della tenerezza: un “vangelo” da riscoprire, Bologna 2000;<br />
• Giovanni Paolo II, Dives in misericor<strong>di</strong>a (1980).<br />
Corsi <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong><br />
<strong>Teologia</strong> morale speciale II: Eros e agape<br />
Prof. Dr. André-Marie Jerumanis<br />
Dr. phil.; Lic. theol. Linda Pellicioli<br />
Sigla: TMCP Semestre autunnale Ects: 3<br />
Presentazione: Il corso affronterà la questione della responsabilità umana nel campo<br />
del matrimonio e della sessualità alla luce del binomio eros-agapè. “…tra l’amore e il<br />
Divino esiste una qualche relazione: l’amore promette infinità, eternità — una realtà più<br />
grande e totalmente altra rispetto alla quoti<strong>di</strong>anità del nostro esistere. Ma al contempo<br />
è apparso che la via per tale traguardo non sta semplicemente nel lasciarsi sopraffare<br />
dall’istinto. Sono necessarie purificazioni e maturazioni, che passano anche attraverso la<br />
strada della rinuncia. Questo non è rifiuto dell’eros, non è il suo «avvelenamento», ma<br />
la sua guarigione in vista della sua vera grandezza” (Benedetto XVI, Deus caritas est, 5).<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• L. Ciccone, Etica sessuale. Persona, matrimonio, vita verginale, Milano 2004;<br />
• G. Dianin, Matrimonio, sessualità, fecon<strong>di</strong>tà. Corso <strong>di</strong> morale familiare, Padova 2006;<br />
• Y. Semen, La sessualità secondo Giovanni Paolo II, Roma 2011 4 .<br />
La famiglia e le nuove forme famigliari del XXI secolo<br />
Prof. Dr. André-Marie Jerumanis<br />
Dr. phil.; Lic. theol. Linda Pellicioli<br />
Sigla: TMSO Semestre autunnale Ects: 4<br />
Obiettivo corso: Esaminare lo sviluppo storico, la sittuazione attuale e le prospettive<br />
future della più antica l’istituzione umana – la famiglia.<br />
Modalità <strong>di</strong> valutazione: Presentazione orale e lavoro scritto.<br />
Contenuto del corso: «La famiglia nei tempi o<strong>di</strong>erni è stata, come e forse più <strong>di</strong> altre<br />
istituzioni, investita dalle ampie, profonde e rapide trasformazioni della società e della<br />
cultura» (Giovanni Paolo II). Spesso sentiamo parlare della «crisi della familia» testimoniata<br />
dall’aumento dei <strong>di</strong>vorzi, dal calo delle nacite, dall’istitualizzazione delle nuove<br />
forme famigliari: le famiglie ricomposte, le madri single, l’adozione dei figli dalle copie<br />
omosessuali, le madri ‘surogate’ ecc. Nel seminario esamineremo le cause filosofiche,<br />
ideologiche e sociologiche della nuova situazione, aprofon<strong>di</strong>remo <strong>di</strong>versi aspetti delle<br />
nuove forme famigliari e della filiazione e, infine, cercheremo proposte per la nuova<br />
evangelizazione dell’ambito famigliare.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• Z. Bauman, La solitu<strong>di</strong>ne del citta<strong>di</strong>no globale, Milano 2000 6 ;<br />
• A.L. Zanatta, Le nuove famiglie, Bologna 2003;<br />
• P. Donati, La famiglia nella società relazionale, Milano 1986.<br />
82
Bioetica e religioni<br />
Prof. Dr. André-Marie Jerumanis<br />
Dr. phil.; Lic. theol. Linda Pellicioli<br />
Sigla: TMSO Semestre primaverile Ects: 4<br />
Obiettivo corso: Se vogliono «contrastare lo scontro <strong>di</strong> civiltà» i cristiani devono <strong>stu<strong>di</strong></strong>are<br />
le gran<strong>di</strong> religioni «a cominciare dall’Islam, dal Bud<strong>di</strong>smo e dall’Induismo», come lo<br />
ha detto Giovanni Paolo II nel 2002. Nel lavoro del seminario vorremo esaminare quali<br />
sono le posizioni delle gran<strong>di</strong> religioni, come Cattolicesimo, Protestantesimo, Ebraismo,<br />
Islamismo, Bud<strong>di</strong>smo ed Induismo, sui <strong>di</strong>versi temi <strong>di</strong> bioetica: la sperimentazione<br />
sugli embrioni umani, l’aborto selettivo, la fecondazione artificiale, l’ingegneria genetica,<br />
l’eutanasia, i xenotrapianti ecc.<br />
Modalità <strong>di</strong> valutazione: Presentazione orale e lavoro scritto.<br />
Contenuto del corso: La bioetica è una scienza inter<strong>di</strong>sciplinare che <strong>stu<strong>di</strong></strong>a in modo sistematico<br />
la condotta umana e la esamina alla luce dei valori e dei principi morali nell’area<br />
delle scienze della vita e della cura della salute – l’ambito biome<strong>di</strong>co. La <strong>di</strong>mensione<br />
religiosa è in se totalizzante abbracciando tutta la vita dell’uomo – dal concepimento ad<br />
oltre la morte, e da sempre ha cercato <strong>di</strong> dare in<strong>di</strong>cazioni per l’agire umano. La ricerca<br />
del seminario avrà come lo scopo <strong>di</strong> esaminare e confrontare le risposte date dalle<br />
gran<strong>di</strong> religioni del mondo agli urgenti problemi <strong>di</strong> bioetica.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• M. Aramini, Bioetica e religioni, Milano 2007;<br />
• S. Moran<strong>di</strong>ni, R. Pegoraro, Alla fine della vita: Religioni e Bioetica, Roma 2003;<br />
• G. Buono, P. Pelosi, Bioetica religioni missioni, Bologna 2007.<br />
Corsi <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong><br />
La teologia morale orientale<br />
Prof. Dr. André-Marie Jerumanis<br />
Dr. phil.; Lic. theol. Linda Pellicioli<br />
Sigla: TMCO Semestre primaverile Ects: 3<br />
Presentazione: Il teologo ortodosso S. Ševčuk ha evidenziato l’apporto orientale alla<br />
ricerca teologica morale contemporanea, rilevando che la “via dei figli <strong>di</strong> Dio” della<br />
morale ortodossa <strong>di</strong> fronte alla spersonalizzazione e all’in<strong>di</strong>vidualismo esasperato contemporaneo<br />
e chiamata a rimanere fedele alla propria concezione <strong>di</strong> morale quale agire<br />
cristico. Solo cosi puo essere una risposta alla necessita vitale del popolo <strong>di</strong> Dio <strong>di</strong> riscoprire<br />
e presentare al mondo moderno la verita della figliolanza <strong>di</strong>vina della persona<br />
umana per evitare l’auto<strong>di</strong>struzione che minaccia l’uomo spersonalizzato.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• B. Petra, Tra cielo e terra. Introduzione alla teologia morale ortodossa contemporanea,<br />
Bologna 1992;<br />
• B. Petra, L’etica ortodossa. Storia, fonti, identità, Assisi 2010;<br />
• P. Evdokimov, La vita trasfigurata in Cristo. Prospettive <strong>di</strong> morale ortodossa, Introduzione<br />
<strong>di</strong> Ševčuk, Roma 2001.<br />
83
Corsi <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong><br />
<strong>Teologia</strong> morale speciale III: introduzione alla bioetica<br />
Prof. Dr. André-Marie Jerumanis<br />
Dr. phil.; Lic. theol. Linda Pellicioli<br />
Sigla: TMCP Semestre primaverile Ects: 3<br />
Presentazione: La bioetica è una <strong>di</strong>sciplina ‘recente’ che si occupa delle questioni etiche<br />
che sorgono parallelamente al progre<strong>di</strong>re della ricerca biologica e me<strong>di</strong>ca. Il corso d’introduzione<br />
intende trattare la questione della fondazione epistemologica della bioetica,<br />
la storia della bioetica, i para<strong>di</strong>gmi interpretativi, la <strong>di</strong>mensione giuri<strong>di</strong>ca della bioetica,<br />
la questione bioetica nella prospettiva della <strong>di</strong>gnità umana.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• E. Sgreccia, Manuale <strong>di</strong> bioetica, Milano 1996-1998, 2 voll.;<br />
• G. Russo, Bioetica. Manuale per teologi, Roma 2005;<br />
• M. Aramini, Introduzione alla bioetica, Milano 2010 3 .<br />
Aquinas on being<br />
Prof. Dr. Anthony Kenny<br />
Sigla: SICO Semestre primaverile Ects: 2<br />
La descrizione sarà fornita all’inizio dell’anno accademico.<br />
Diritto canonico ortodosso<br />
Prof. Dr. Hani Bakhoum Kiroulos<br />
Sigla: DCCO Semestre primaverile Ects: 1.5<br />
Presentazione: 1. Introduzione. 2. La struttura canonica della Chiesa Ortodossa: I. Battezzati<br />
attorno al Vescovo; II. La Parrocchia; III. Il vescovo in mezzo ai Vescovi; IV. La<br />
questione del Vescovo Ausiliare; V. L’“auto-cefalia”; VI. La Diaspora. 3. Le fonti antiche<br />
comuni <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto canonico: I. I primi Docu-menti <strong>di</strong> Contenuto Canonico Liturgico;<br />
II. I canoni dei Concili Ecumenici; III. Sino<strong>di</strong> locali; IV. Canoni dei Santi Padri; V. La<br />
legislazione imperiale. 4. La co<strong>di</strong>ficazione delle leggi canoniche ed ecclesiastiche. 5. Alcuni<br />
Principi per il Diritto Ortodosso: I. Applicabilità <strong>di</strong> Diritto Canonico; II. Significato<br />
pastorale <strong>di</strong> Diritto Canonico; III. Il concetto <strong>di</strong> “economia”. 6. Il <strong>di</strong>ritto canonico della<br />
chiesa Copta Ortodossa (esempio <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto Canonico Ortodosso) a) La norma ecclesiastica;<br />
b) Il Credo.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
La bibliografia sarà fornita all’inizio del corso.<br />
Introduzione alla Dottrina sociale della Chiesa: la Chiesa<br />
e la sfida del post-umanesimo<br />
Prof. Dr. Markus Krienke<br />
Sigla: TMCP Semestre autunnale Ects: 3<br />
Obiettivo corso: Questa e<strong>di</strong>zione dell’Introduzione si focalizza in maniera particolare<br />
sulla sfida del post-umanesimo, che si articola a vari livelli della cultura, delle scienze e<br />
del life style.<br />
84
Modalità <strong>di</strong> valutazione: Esame orale <strong>di</strong> 20 minuti; le modalità dettagliate dell’esame<br />
saranno comunicate nella prima lezione.<br />
Contenuto del corso: Il corso introduce ai principi fondamentali della Dottrina sociale<br />
della Chiesa (persona, solidarietà, sussi<strong>di</strong>arietà) e ai concetti regolativi della giustizia<br />
sociale e del bene comune. Senz’altro, questi sono messi ra<strong>di</strong>calmente in crisi da un<br />
post-umanesimo fortemente presente nella cultura europea tardo-moderna che attacca<br />
fortemente le basi personalistiche <strong>degli</strong> or<strong>di</strong>namenti liberal-democratici. In questa<br />
situazione, la Dottrina sociale della Chiesa rimane la voce autorevole in <strong>di</strong>fesa del personalismo,<br />
che è il fondamento della cultura occidentale. Su questa base si delineano<br />
nuove prospettive <strong>di</strong> collaborazione tra cristiani e laici e le possibilità <strong>di</strong> una nuova<br />
sintesi culturale.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• Luca Grion (ed.), La sfida postumanista. Colloqui sul significato della tecnica, Bologna<br />
2012.<br />
• Joseph Höffner, La dottrina sociale cristiana, Cinisello Balsamo 1995 6 .<br />
• Renato Oniga, Contro la post-religione. Per un nuovo umanesimo cristiano, Verona<br />
2009.<br />
• Joseph Ratzinger / Jürgen Habermas, Etica, religione e Stato liberale, a c. <strong>di</strong> M. Nicoletti,<br />
Brescia 2008 2 .<br />
Corsi <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong><br />
Il lavoro come questione antropologica<br />
Prof. Dr. Markus Krienke<br />
Sigla: TMCO Semestre autunnale Ects: 1.5<br />
Obiettivo corso: Il corso introduce, in maniera molto fondamentale e basilare, ai principi<br />
dell’antropologia cristiana e a come essi si traducono nell’etica del lavoro.<br />
Modalità <strong>di</strong> valutazione: Breve elaborato scritto <strong>di</strong> 5-8 pagine; le regole dettagliate riguardo<br />
alle modalità <strong>di</strong> stesura e <strong>di</strong> consegna dello stesso saranno comunicate nella<br />
prima lezione.<br />
Contenuto del corso: Giovanni Paolo II, nell’enciclica Laborem exercens, definisce che<br />
il «problema del lavoro» è da considerarsi «la chiave della questione sociale». In altre<br />
parole, non si tratta <strong>di</strong> un’etica applicata come tante altre, ma della <strong>di</strong>mensione in cui<br />
l’essere umano si concretizza. Infatti, come fa notare la stessa enciclica, «me<strong>di</strong>ante il lavoro<br />
l’uomo […] realizza se stesso come uomo ed anzi, in un certo senso, “<strong>di</strong>venta più<br />
uomo”». Questo corso presenta, in modo concreto, il significato <strong>di</strong> questa frase e come<br />
sono da valutare le sfide attuali delle “trasformazioni” nel mondo del lavoro. Il corso è<br />
de<strong>di</strong>cato in modo particolare ai collaboratori dell’OCST.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• Ulrich Beck, Il lavoro nell’epoca della fine del lavoro. Tramonto delle sicurezze e nuovo<br />
impegno civile, tr. it. H. Rie<strong>di</strong>nger, Torino 2000.<br />
• Pierpaolo Donati, Il lavoro che emerge. Prospettive del lavoro come relazione sociale<br />
in una economia dopo-moderna, Torino 2001.<br />
• Simone Moran<strong>di</strong>ni, Il lavoro che cambia. Un’esplorazione etico-teologica, Bologna<br />
2000.<br />
85
Corsi <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong><br />
Seminario <strong>di</strong> filosofia: morte e immortalità nel pensiero moderno<br />
Prof. Dr. Markus Krienke<br />
Sigla: FFSO Semestre autunnale Ects: 4<br />
Obiettivo corso: Il tema del corso è tema pressoché scomparso dai sillabi accademici:<br />
sintomo del post-moderno che ricade nell’arcaico? Per la riflessione me<strong>di</strong>evale e moderna<br />
questo tema assume una <strong>di</strong>mensione metafisica importante.<br />
Modalità <strong>di</strong> valutazione: (1) presentazione orale <strong>di</strong> 20 minuti su un tema scelto; (2)<br />
partecipazione alle <strong>di</strong>scussioni durante il seminario; (3) elaborato scritto <strong>di</strong> 12-15 pagine.<br />
Le regole dettagliate riguardo alle modalità <strong>di</strong> stesura e <strong>di</strong> consegna dell’elaborato<br />
saranno comunicate nella prima lezione.<br />
Contenuto del corso: Soprattutto il mondo del cyberspazio si lega a un desiderio<br />
espresso dalle mitologie attraverso le gnosi fino a forme <strong>di</strong> life style post-moderno.<br />
Questo desiderio è l’immortalità. Contemporaneamente, la morte non viene più tematizzata,<br />
e si tende a rimuoverla dalla quoti<strong>di</strong>anità. Quella <strong>di</strong> riflettere su “morte e<br />
immortalità” nella loro connessione metafisica sembra una caratteristica del pensiero<br />
me<strong>di</strong>evale e moderno. Dopo un’introduzione generale che riassume i testi classici, nelle<br />
relazioni e <strong>di</strong>scussioni del seminario si affronteranno specialmente gli autori moderni. In<br />
un secondo momento saranno invitati esperti esterni <strong>di</strong> università svizzere ed italiane<br />
per affrontare alcuni temi sistematici, che ricollegano il tema del corso alla teologia<br />
dogmatica, alla sociologia, alla psicologia, alla me<strong>di</strong>cina e alla prospettiva interreligiosa.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• Zygmunt Bauman, Mortalità, immortalità e altre strategie <strong>di</strong> vita, Bologna 2012 2 .<br />
• Max Scheler, Morte e sopravvivenza, a c. <strong>di</strong> E. Simonotti, Brescia 2012.<br />
• Michele Federico Sciacca, Morte e immortalità, Milano 1968 3 .<br />
• Xavier Tilliette, Morte e immortalità, a c. <strong>di</strong> G. Sansonetti, Brescia 2011.<br />
Propedeuticità: Per studenti a partire dal secondo anno.<br />
Storia della filosofia moderna. Da Cartesio a Hegel<br />
Prof. Dr. Markus Krienke<br />
Sigla: FFCP Semestre autunnale Ects: 4.5<br />
Obiettivo corso: Introduzione al para<strong>di</strong>gma del pensiero moderno del soggetto attraverso<br />
le <strong>di</strong>namiche da Cartesio a Hegel, con particolare attenzione all’alternativa <strong>di</strong><br />
Rosmini.<br />
Modalità <strong>di</strong> valutazione: Esame orale <strong>di</strong> 20 minuti; le modalità dettagliate dell’esame<br />
saranno comunicate nella prima lezione.<br />
Contenuto del corso: Il problema <strong>di</strong> una teoresi adeguata dell’assoluto costituisce<br />
senz’altro il tema principale della modernità e per questo la <strong>di</strong>mensione del soggetto<br />
si evidenzia come in<strong>di</strong>spensabile. Proprio in Rosmini, alla fine della modernità, si avvera<br />
l’assioma <strong>di</strong> Bacone, espresso all’inizio della stessa era: «un po’ <strong>di</strong> filosofia porta la<br />
mente <strong>degli</strong> uomini all’ateismo, ma molta filosofia riporta le menti <strong>degli</strong> uomini verso<br />
la religione». In questa <strong>di</strong>namica saranno considerate le principali opere del pensiero<br />
moderno.<br />
86
Bibliografia essenziale:<br />
• Massimo Mori, Storia della filosofia moderna, Roma-Bari 2009 3 .<br />
• Georg Sans, Al crocevia della filosofia contemporanea, Roma 2010.<br />
• Sofia Vanni Rovighi, Storia della filosofia moderna, con la collaborazione <strong>di</strong> A. Bausola,<br />
2 voll., Brescia 1976-1980.<br />
• Wilhelm Weischedel, Il <strong>di</strong>o dei filosofi, vol. 1. Dai presocratici a Kant, Genova 2005 3 ;<br />
vol. 2. Dall’idealismo tedesco a Heidegger, Genova 1996 2 .<br />
Propedeuticità: Aver seguito i corsi <strong>di</strong> storia della filosofia antica e me<strong>di</strong>evale.<br />
Etica generale. Il bene e il giusto<br />
Prof. Dr. Markus Krienke<br />
Sigla: FFCP Semestre primaverile Ects: 4.5<br />
Obiettivo corso: Introdurre ai gran<strong>di</strong> para<strong>di</strong>gmi classici della riflessione normativa<br />
nell’etica e riflettere criticamente sul ritorno dell’etica delle virtù nelle correnti attuali<br />
della filosofia analitica e della filosofia dell’arte della vita.<br />
Modalità <strong>di</strong> valutazione: Esame orale <strong>di</strong> 20 minuti; le modalità dettagliate dell’esame<br />
saranno comunicate nella prima lezione.<br />
Contenuto del corso: Escludendo un noncognitivismo <strong>di</strong> fondo, si presentano i quattro<br />
gran<strong>di</strong> modelli <strong>di</strong> etica normativa: etica della virtù, etica deontologica, etica consequenzialista,<br />
metaetica. L’introduzione a questi modelli si svolge attraverso la lettura <strong>di</strong> alcune<br />
opere fondamentali: Aristotele e Tommaso d’Aquino per il primo para<strong>di</strong>gma, Kant<br />
e Habermas per il secondo, Bentham e Mill per il terzo, e infine Moore e Putnam per il<br />
quarto. La riflessione attuale si incentra su MacIntyre, Foot e Nussbaum, da un lato, e<br />
sull’approccio <strong>di</strong> Wilhelm Schmid, dall’altro.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• Luigi Alici, Filosofia morale, Brescia 2011.<br />
• Antonio Da Re, Filosofia morale. Storia, teorie, argomenti, Milano 2008 2 .<br />
• Antonio Poppi, Per una fondazione razionale dell’etica. Introduzione al corso <strong>di</strong> filosofia<br />
morale, Milano 1998.<br />
• John Rawls, Lezioni <strong>di</strong> storia della filosofia morale, a c. <strong>di</strong> B. Herman, Milano 2004.<br />
Propedeuticità: Aver seguito i corsi <strong>di</strong> storia della filosofia.<br />
Corsi <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong><br />
Corso monografico <strong>di</strong> Etica generale: Etica come conciliazione.<br />
I «Lineamenti» <strong>di</strong> Hegel<br />
Prof. Dr. Markus Krienke<br />
Sigla: FFCP Semestre primaverile Ects: 1.5<br />
Obiettivo corso: Presentazione e comprensione <strong>di</strong> uno dei capisal<strong>di</strong> della riflessione<br />
etica moderna che critica l’etica kantiana proprio a partire dal concetto <strong>di</strong> libertà, che in<br />
questo modo guadagna le due importanti <strong>di</strong>mensioni dell’alterità e dell’eticità.<br />
Modalità <strong>di</strong> valutazione: Esame orale <strong>di</strong> 10 minuti; le modalità dettagliate dell’esame<br />
saranno comunicate nella prima lezione.<br />
Contenuto del corso: Partendo da un breve riassunto dei principi della filosofia prati-<br />
87
Corsi <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong><br />
ca <strong>di</strong> Kant, si analizzano i Lineamenti <strong>di</strong> filosofia del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> Hegel non come ra<strong>di</strong>cale<br />
contrapposizione, bensì in funzione dell’intenzione <strong>di</strong> trovare un nuovo para<strong>di</strong>gma per<br />
il liberalismo moderno. In questo modo, il principio soggettivo <strong>di</strong> libertà consegue l’alterità<br />
e anche la categoria del <strong>di</strong>ritto, che si esplicita nelle varie <strong>di</strong>mensioni dell’eticità,<br />
ma solo dopo che tale principio è stato me<strong>di</strong>ato da un approfon<strong>di</strong>mento della riflessione<br />
morale. Infine, questo sviluppo della libertà moderna viene brevemente paragonato alla<br />
“risposta” rosminiana a Kant.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• Vittorio Hösle, Il sistema <strong>di</strong> Hegel, a c. <strong>di</strong> G. Stelli, Napoli 2012.<br />
• Marco Ivaldo, Storia della filosofia morale, Roma 2009.<br />
• Leonardo Messinese, Libertà e Stato. L’eticità nei Lineamenti <strong>di</strong> filosofia del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong><br />
Hegel, Roma 1994.<br />
• Adriaan Peperzak, Filosofia e politica. Commentario della Prefazione alla Filosofia del<br />
<strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> Hegel, Milano 1991.<br />
Propedeuticità: Aver seguito i corsi <strong>di</strong> storia della filosofia.<br />
Filosofia politica<br />
Prof. Dr. Markus Krienke<br />
Sigla: FFCP Semestre primaverile Ects: 3<br />
Obiettivo corso: Le lezioni introducono ai problemi fondamentali <strong>di</strong> filosofia politica<br />
attraverso la lettura dei testi principali classici, moderni e contemporanei.<br />
Modalità <strong>di</strong> valutazione: Esame orale <strong>di</strong> 20 minuti; le modalità dettagliate dell’esame<br />
saranno comunicate nella prima lezione.<br />
Contenuto del corso: Partendo dalla problematica del “potere” (Foucault, Schmitt), si<br />
indaga sul concetto <strong>di</strong> giustizia come termine principale <strong>di</strong> legittimazione politica nel<br />
pensiero classico e in Rawls. Attraverso la tematizzazione dei tre concetti principali <strong>di</strong><br />
or<strong>di</strong>namento politico moderno (Stato sovrano, democrazia identitaria, Stato costituzionale),<br />
ci si confronta criticamente con la teoria critica <strong>di</strong> Habermas e si introduce ai no<strong>di</strong><br />
sistematici <strong>di</strong> “politica e <strong>di</strong>ritti” e “politica e religione” nel contesto “post-nazionale”.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• Sergio Cotta, Diritto e politica, Milano 1974.<br />
• Virginio Marzocchi, Filosofia politica. Storia, concetti, contesti, Roma-Bari 2011.<br />
• Stefano Petrucciani, Modelli <strong>di</strong> filosofia politica, Torino 2003.<br />
• John Rawls, Lezioni <strong>di</strong> storia della filosofia politica, tr. it. V. Ottonelli, a c. <strong>di</strong> S. Veca,<br />
Milano 2009.<br />
Seminario <strong>di</strong> Dottrina sociale. I partiti e i sindacati cristiani in Europa:<br />
le basi culturali, la loro storia, le sfide del futuro<br />
Prof. Dr. Markus Krienke<br />
Sigla: TMSO Semestre primaverile Ects: 4<br />
Obiettivo corso: Introduzione <strong>di</strong> alcuni episo<strong>di</strong> storici <strong>di</strong> esperienze cattoliche in politica<br />
(partiti, sindacati), per analizzare la situazione o<strong>di</strong>erna, porre domande critiche e tentare<br />
<strong>di</strong> affrontare le sfide del futuro.<br />
88
Modalità <strong>di</strong> valutazione: (1) presentazione orale <strong>di</strong> 20 minuti su un tema scelto; (2)<br />
partecipazione alle <strong>di</strong>scussioni durante il seminario; (3) elaborato scritto <strong>di</strong> 12-15 pagine.<br />
Le regole dettagliate riguardo alle modalità <strong>di</strong> stesura e <strong>di</strong> consegna dell’elaborato<br />
saranno comunicate nella prima lezione.<br />
Contenuto del corso: Il seminario procederà attraverso l’analisi storica e sistematica<br />
dell’esperienza dei cristiani nei partiti e nei sindacati, nella tensione specifica che questa<br />
situazione tra Magistero e realtà concreta comportava. Nelle relazioni e <strong>di</strong>scussioni del<br />
corso si presenteranno i profili <strong>di</strong> alcuni partiti e sindacati, e anche dei personaggi <strong>di</strong><br />
spicco dei medesimi, e ci si interrogherà sui problemi teoretici e pratici che dovevano<br />
affrontare. In un secondo momento saranno invitati esperti dal Ticino e dall’Italia che<br />
tratteranno alcune questioni specifiche ed integreranno in questo modo le prospettive<br />
delineate durante il seminario.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• Niels Arbol, I democristiani nel mondo, tr. it. S. Trevisan, Cinisello Balsamo 1990.<br />
• Franco Biffi (ed.), Una vita per la giustizia. Monsignor Luigi Del-Pietro prete per il<br />
mondo del lavoro, Locarno 1984.<br />
• Jean-Dominique Durand, Storia della Democrazia cristiana in Europa. Dalla rivoluzione<br />
francese al postcomunismo, Milano 2002.<br />
• Sergio Zaninelli, Il sindacato bianco tra guerra, dopoguerra e fascismo. 1914–1926,<br />
Milano 1982.<br />
Corsi <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong><br />
Diritto delle Società <strong>di</strong> Vita Apostolica e Prelature personali: <strong>di</strong>fferenze<br />
e analogie<br />
Prof. Dr. Andrzej Kukla<br />
Sigla: DCCO Semestre autunnale Ects: 1.5<br />
Presentazione: Norme comuni a tutte le società <strong>di</strong> vita apostolica e agli istituti <strong>di</strong> vita<br />
consacrata; Nozione ecclesiologica <strong>di</strong> vita consacrata; Nozione teologico-canonica <strong>di</strong><br />
vita consacrata e apostolica (<strong>di</strong>fferenze); Concetto ed elementi caratteristici delle società<br />
<strong>di</strong> vita apostolica; Ecclesialità della vita consacrata e delle società <strong>di</strong> vita apostolica;<br />
Funzioni della Gerarchia rispetto ai consigli; Tipologia <strong>degli</strong> Istituti; Il patrimonio <strong>degli</strong><br />
Istituti e sua conservazione; Erezione, aggregazione, <strong>di</strong>visione e soppressione <strong>degli</strong> Istituti<br />
e delle loro parti (<strong>di</strong>visione dell’Istituto in parti, fusione <strong>di</strong> parti esistenti, mo<strong>di</strong>fica<br />
<strong>di</strong> circoscrizioni); Divisione interna dell’Istituto; Istituti <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto pontificio e <strong>di</strong>ocesano;<br />
Funzioni del Vescovo <strong>di</strong>ocesano riguardo agli Istituti <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong>ocesano; La <strong>di</strong>pendenza<br />
<strong>di</strong>retta ed esclusiva dalla Santa Sede degl’Istituti <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto pontificio; Soppressione <strong>degli</strong><br />
Istituti riservata alla Santa Sede e soppressione delle parti <strong>degli</strong> Istituti riservata all’autorità<br />
interna competente; L’autonomia <strong>di</strong> tutti gli Istituti - <strong>di</strong>ritto proprio; Istituti clericali<br />
e laicali; La potestà dei Superiori e dei Capitoli; L’ammissione del fedele all’Istituto; Abito<br />
religioso; Osservanza e contenuto evangelico-canonico dei consigli evangelici; Osservanza<br />
dei consigli e del <strong>di</strong>ritto proprio dell’Istituto; Il consiglio evangelico <strong>di</strong> castità;<br />
Il consiglio evangelico <strong>di</strong> povertà; Il consiglio evangelico <strong>di</strong> obbe<strong>di</strong>enza; Esortazione alla<br />
comunione fraterna, fondata sulla carità; Le nuove forme <strong>di</strong> vita consacrata; L’or<strong>di</strong>ne<br />
delle Vergini; I fedeli consacrati per la professione dei consigli evangelici; Altre possibili<br />
89
Corsi <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong><br />
e future forme <strong>di</strong> vita consacrata; La communita e la casa religiosa; Erezione e soppressione<br />
delle case religiose; La soppressione dell’unica casa; Il governo <strong>degli</strong> Istituti;<br />
Esercizio della funzione e della potestà, I superiori; La funzione e la potestà; Servizio e<br />
<strong>di</strong>alogo nell’esercizio della potestà; Ammissione e formazione; Noviziato e formazione<br />
dei novizi; Formazione permanente; La professione religiosa in genere; La professione<br />
perpetua o definitive; Nomina o elezione valide; Obblighi e <strong>di</strong>ritti <strong>degli</strong> Istituti e dei loro<br />
membri, Apostolato <strong>degli</strong> Istituti e fedeltà alla missione e alle opera proprie; I beni temporali<br />
e la loro amministrazione; Separazione dall’Istituto; Uscita; Dimissione.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
La bibliografia sarà fornita all’inizio del corso.<br />
Didattica dell’istruzione religiosa<br />
Prof. Dr. Clau<strong>di</strong>o Laim<br />
Sigla: TPCP Semestre primaverile Ects: 3<br />
Obiettivo del corso: Dare allo studente solide conoscenze storiche sullo sviluppo<br />
dell’impegno catechistico della Chiesa lungo i secoli. Scoprire e capire come si pone<br />
oggi il problema centrale della Catechesi e del suo rinnovamento, nella strategia globale<br />
della così detta “nuova evangelizzazione”.<br />
Contenuto del corso: Dopo la prima parte storica lo studente sarà introdotto, attraverso<br />
esercitazioni pratiche, nei <strong>di</strong>scorsi sui contenuti da trasmettere, sui vari meto<strong>di</strong> e<br />
linguaggi a <strong>di</strong>sposizione e sui <strong>di</strong>fferenti destinatari dell’annuncio ecclesiale.<br />
Modalità <strong>di</strong> valutazione: esame orale finale <strong>di</strong> 15 minuti.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• Cei, Il rinnovamento della Catechesi, documento-base, Roma, 1970<br />
• F. Payer, Nuova metodologia catechistica, Roma, 1975<br />
• Bollin-Gasparini, La Catechesi nella vita della Chiesa, Roma, 1990<br />
<strong>Teologia</strong> pastorale: scopo e mezzi<br />
Prof. Dr. Clau<strong>di</strong>o Laim<br />
Sigla: TPCP Semestre primaverile Ects: 3<br />
Obiettivo del corso: Introdurre lo studente nella conoscenza storica delle gran<strong>di</strong> sfide<br />
pastorali affrontate dalla Chiesa nel suo cammino ed attrezzarlo, alla luce dei testi del<br />
Concilio Vaticano II per <strong>di</strong>ventare un operatore pastorale efficace nel contesto <strong>di</strong> una<br />
Comunità cristiana viva, profetica e de<strong>di</strong>ta al servizio <strong>degli</strong> uomini del nostro tempo.<br />
Contenuto del corso: La prima parte ripercorre storicamente l’esercizio del servizio<br />
pastorale in <strong>di</strong>fferenti epoche, caratterizzate da luci ed ombre, Nella seconda parte ci<br />
si sofferma sul tema specifico della pastorale della Comunità cristiana ai nostri giorni, in<br />
riferimento ai bisogni evolutivi <strong>di</strong> ogni persona, nella linea <strong>di</strong> un servizio <strong>di</strong> vero accompagnamento<br />
esistenziale.<br />
Modalità <strong>di</strong> valutazione: esame orale finale <strong>di</strong> 15 minuti.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• P. Zulehner, <strong>Teologia</strong> pastorale, voll. 1-2-3-4, Brescia, 1992<br />
90
• S. Pintor, L’uomo via della Chiesa, Bologna, 1992<br />
• L. Soravito-L. Bressan, Il rinnovamento della parrocchia, Padova, 2007<br />
Introduzione alle fonti del <strong>di</strong>ritto ebraico e temi scelti<br />
<strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto matrimoniale ebraico<br />
Prof. Dr. Rav. Giuseppe Laras<br />
Sigla: DCCO Semestre autunnale Ects: 3<br />
Presentazione: Il corso si propone <strong>di</strong> <strong>stu<strong>di</strong></strong>are i principi fondamentali del Diritto ebraico<br />
ed in particolare le fonti, nella loro evoluzione storica, con la <strong>di</strong>scussione sulla co<strong>di</strong>ficazione<br />
e l’esame <strong>di</strong> qualche testo giuri<strong>di</strong>co tradotto in italiano. La seconda parte sarà<br />
de<strong>di</strong>cata al matrimonio, la sua formazione, gli impe<strong>di</strong>menti, il problema dei matrimoni<br />
misti, la nullità del matrimonio e il suo scioglimento (<strong>di</strong>vorzio). Verranno de<strong>di</strong>cate alcune<br />
lezioni a problemi <strong>di</strong> bioetica, concernenti in particolare la fine della vita.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
La bibliografia sarà fornita all’inizio del corso.<br />
Corsi <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong><br />
Introduzione alla patrologia<br />
Prof. Dr. Valerio Lazzeri<br />
Sigla: PACP Semestre autunnale Ects: 4.5<br />
Obiettivo corso: Mettere in contatto vivo con momenti e figure della letteratura patristica.<br />
Modalità <strong>di</strong> valutazione: Esame orale.<br />
Contenuto del corso: I Padri sono quegli autori cristiani le cui opere costituiscono un<br />
riferimento inelu<strong>di</strong>bile della tra<strong>di</strong>zione vivente della fede. Si cercherà <strong>di</strong> <strong>di</strong>segnare la<br />
linea <strong>di</strong> sviluppo della loro testimonianza letteraria nel contesto della Chiesa antica,<br />
proponendo la lettura <strong>di</strong> alcuni testi significativi e in<strong>di</strong>cando gli strumenti e le vie per<br />
coglierne l’importanza per la teologia e per la vita cristiana.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• E. Cattaneo; G. De Simone; C. Dell’Osso; L. Longobardo, “Patres Ecclesiae”. Una<br />
introduzione alla teologia dei padri della Chiesa, Trapani, 2008;<br />
• A. Di Berar<strong>di</strong>no (ed.), Nuovo <strong>di</strong>zionario patristico e <strong>di</strong> antichità cristiane, voll. I-III,<br />
Genova-Milano 2006-2008;<br />
• H.R. Drobner, Patrologia, Casale Monferrato, 2002 2 .<br />
Lettura <strong>di</strong> alcuni testi classici della tra<strong>di</strong>zione carmelitana<br />
Prof. Dr. Valerio Lazzeri<br />
Sigla: PASO Semestre autunnale Ects: 4<br />
Obiettivo corso: Mettere a contatto <strong>di</strong>retto con i testi principali della letteratura spirituale<br />
carmelitana.<br />
Modalità <strong>di</strong> valutazione: Partecipazione attiva, lavoro scritto e presentazione orale.<br />
Contenuto del corso: Le opere <strong>di</strong> S. Teresa d’Avila e <strong>di</strong> S. Giovanni della Croce, classici<br />
della letteratura cristiana, sono <strong>di</strong>ventati punti <strong>di</strong> riferimento <strong>di</strong> <strong>di</strong>verse nuove forme<br />
91
<strong>di</strong> vita comune cristiana e <strong>di</strong> molti uomini e donne alla ricerca <strong>di</strong> una guida per il loro<br />
cammino spirituale. Si cercherà <strong>di</strong> riflettere su alcuni criteri <strong>di</strong> lettura e <strong>di</strong> esercitarsi ad<br />
applicarli ai testi stessi.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• Opere <strong>di</strong> Teresa d’Avila e <strong>di</strong> Giovanni della Croce.<br />
Corsi <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong><br />
La questione “mistica” e l’università<br />
Prof. Dr. Valerio Lazzeri<br />
Sigla: PACO Semestre autunnale Ects: 3<br />
Obiettivo corso: Disegnare il contesto culturale, filosofico e teologico <strong>di</strong> un momento<br />
<strong>di</strong> rinascita <strong>di</strong> interesse accademico per la “mistica”.<br />
Modalità <strong>di</strong> valutazione: Esame orale.<br />
Contenuto del corso: L’interesse per la letteratura “mistica” è oggi particolarmente<br />
vivo. Basterebbe a testimoniarlo il numero crescente <strong>di</strong> e<strong>di</strong>zioni e <strong>di</strong> pubblicazioni al<br />
riguardo. Da qui l’importanza <strong>di</strong> <strong>stu<strong>di</strong></strong>are il particolare momento storico che ha portato<br />
filosofi, storici, me<strong>di</strong>ci, psicologi e antropologi della laicissima Università francese dei<br />
primi del ‘900 – molto prima dei teologi! – ad affrontare con meto<strong>di</strong> scientifici l’esperienza<br />
spirituale cristiana e a porre le basi <strong>di</strong> una vera e propria questione “mistica”<br />
tuttora lungi dal creare consensi tra gli <strong>stu<strong>di</strong></strong>osi.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• E. Poulat, L’Université devant la Mystique. Expérience de Dieu sans mode ou Transcendance<br />
du Dieu d’Amour, Paris, 1999.<br />
Iniziazione allo <strong>stu<strong>di</strong></strong>o della <strong>Teologia</strong><br />
Prof. Dr. Valerio Lazzeri<br />
Sigla: ITCP Semestre primaverile Ects: 3<br />
Obiettivo corso: Mostrare la connessione tra teologia e impegno esistenziale nella fede.<br />
Modalità <strong>di</strong> valutazione: Esame orale.<br />
Contenuto del corso: Dopo una prima parte de<strong>di</strong>cata alla natura, all’oggetto, al metodo<br />
e alla configurazione della teologia a partire dal suo rapporto con la rivelazione <strong>di</strong> Dio in<br />
Gesù Cristo, si darà un rapido sguardo alle varie forme assunte dalla riflessione teologica<br />
nella storia per giungere a meglio situarne l’importanza nel contesto attuale della vita<br />
cristiana, della Chiesa e della cultura.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• R. Latourelle, <strong>Teologia</strong> scienza della salvezza, Assisi, 2005 8 ;<br />
• G. Ruggieri, Prima lezione <strong>di</strong> teologia, Roma-Bari, 2011.<br />
Introduzione alla teologia spirituale<br />
Prof. Dr. Valerio Lazzeri<br />
Sigla: DICP Semestre primaverile Ects: 3<br />
Obiettivo corso: Introdurre alla problematica generale <strong>di</strong> una riflessione teologica sul<br />
vissuto spirituale cristiano.<br />
92
Modalità <strong>di</strong> valutazione: Esame orale.<br />
Contenuto del corso: Riflettere sul vissuto spirituale è un’esigenza intrinseca sia della<br />
teologia che del <strong>di</strong>namismo inaugurato con il battesimo. Adottando un approccio prevalentemente<br />
storico, si cercherà <strong>di</strong> descrivere le principali tappe dell’itinerario attraverso<br />
cui la necessità <strong>di</strong> un’intelligenza dell’esperienza spirituale porta a identificare, nel corso<br />
del ’900, una <strong>di</strong>sciplina denominata “teologia spirituale”.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• G. Moioli, <strong>Teologia</strong> spirituale, in Dizionario Teologico Inter<strong>di</strong>sciplinare, I, Torino<br />
1977, pp. 36-66;<br />
• J.M. García (a cura <strong>di</strong>), <strong>Teologia</strong> e spiritualità oggi. Un approccio intra<strong>di</strong>sciplinare,<br />
Roma, 2012.<br />
<strong>Teologia</strong> dei Padri<br />
Prof. Dr. Valerio Lazzeri<br />
Sigla: PACP Semestre primaverile Ects: 3<br />
Obiettivo corso: Illustrare i fondamenti della teologia a partire dalla consapevolezza che<br />
i Padri della Chiesa ne hanno avuto.<br />
Modalità <strong>di</strong> valutazione: Esame orale.<br />
Contenuto del corso: Dopo aver mostrato come i Padri giungono a legittimare una riflessione<br />
teologica a partire dall’esigenza intrinseca dell’esperienza della fede, si cercherà<br />
<strong>di</strong> seguire l’itinerario attraverso cui si arriva a elaborare il riferimento alla tra<strong>di</strong>zione<br />
apostolica come principio fondamentale e il rapporto con la Scrittura come criterio<br />
essenziale <strong>di</strong> un approfon<strong>di</strong>mento non solo ma anche intellettuale della Rivelazione.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• M. Fiedrowicz, <strong>Teologia</strong> dei Padri della Chiesa. Fondamenti dell’antica riflessione cristiana<br />
sulla fede, Brescia, 2010;<br />
• M. Fiedrowicz, Handbuch der Patristik. Quellentexte zur Theologie der Kirchenväter,<br />
Freiburg i.B., 2010.<br />
Corsi <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong><br />
Lingua greca A<br />
Prof. Dr. Jean-Claude Lechner<br />
Sigla: DICP Semestri autunnale/primaverile Ects: -<br />
Presentazione: Il corso intende dare le conoscenza basilari della grammatica greca<br />
(morfologia, sintassi, vocabolario) insistendo sulle particolarità della lingua greca del<br />
Nuovo Testamento. Alla fine del corso si leggeranno brani semplici tratti dai vangeli<br />
canonici.<br />
Modalità <strong>di</strong> valutazione: Esame orale.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• Novum Testamentum grasce et latine<br />
• Joseph Dey, Schola Verbi, Münster 1953 (Quest’opera è stata adattata per il corso).<br />
• Friedrich Blass, Albert Debrunner, Grammatica greca del Nuovo Testamento (ed.<br />
it.), Brescia 1997.<br />
93
Corsi <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong><br />
Lingua greca B<br />
Prof. Dr. Jean-Claude Lechner<br />
Sigla: DICO Semestri autunnale/primaverile Ects: 3<br />
Presentazione: Il corso intende approfon<strong>di</strong>re le conoscenze acquistate durante il corso<br />
<strong>di</strong> base. Alla fine del corso si procederà alla lettura <strong>di</strong> testi neotestamentari e patristici.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• Novum Testamentum grasce et latine<br />
• Marguerite Harl, La langue de Japhet, Paris 1992<br />
• Friedrich Blass, Albert Debrunner, Grammatica greca del Nuovo Testamento (ed.<br />
it.), Brescia 1997.<br />
Le e<strong>di</strong>zioni patristiche da Erasmo ai Maurini (1516-1690)<br />
Prof. Dr. Jean-Claude Lechner<br />
Sigla: DICO Semestre primaverile Ects: 3<br />
Presentazione: Il corso intende presentare quasi due secoli <strong>di</strong> e<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> testi dei Padri<br />
della Chiesa limitandosi all’ambito cattolico. Con la lettura <strong>di</strong> testi spesso ine<strong>di</strong>ti (de<strong>di</strong>che,<br />
prefazioni) si tenta <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare le ragioni <strong>di</strong> tali e<strong>di</strong>zioni (testi per alimentare la<br />
devozione, testi pubblicati a scopo apologetico, per confutare la parte eretica ecc.) e <strong>di</strong><br />
presentarne le problematiche teologiche. Il corso non trascura l’aspetto materiale delle<br />
e<strong>di</strong>zioni: perciò una parte del corso si svolgerà alla Biblioteca Salita dei Frati dove gli<br />
studenti potranno vedere e<strong>di</strong>zioni del XVI e del XVIII secolo.<br />
Modalità <strong>di</strong> valutazione: Lavoro scritto.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
La bibliografia viene presentata durante le lezioni.<br />
Teoria della conoscenza<br />
Prof. Dr. Michele Lenoci<br />
Sigla: FFCP Semestre autunnale Ects: 4.5<br />
Contenuto del corso: Prima parte: 1) natura della conoscenza; 2) il problema critico e lo<br />
scetticismo; 3) l’evidenza, i suoi livelli e le sue <strong>di</strong>fficoltà; 4) l’intenzionalità; 5) l’astrazione<br />
e le sue con<strong>di</strong>zioni.<br />
Seconda parte: 1) certezza, verità e giustificazione; 2) natura e forme della verità; 3)<br />
l’apriori e l’esperienza; 4) conoscenza e azione; 5) mente e corpo.<br />
Modalità <strong>di</strong> valutazione: Esame orale.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• S. Vanni Rovighi, Elementi <strong>di</strong> filosofia, vol. I, Brescia <strong>2013</strong>.<br />
• M. Lenoci, Appunti <strong>di</strong> teoria della conoscenza, (pro manuscripto).<br />
Propedeuticità: Per poter partecipare al corso occorre aver sostenuto gli esami <strong>di</strong> Storia<br />
della filosofia antica e me<strong>di</strong>evale e Storia della filosofia moderna e contemporanea.<br />
94
Corso monografico <strong>di</strong> teoria della conoscenza: Il problema della verità<br />
nel <strong>di</strong>battito contemporaneo<br />
Prof. Dr. Michele Lenoci<br />
Sigla: FFCP Semestre autunnale Ects: 1.5<br />
Contenuto del corso: La concezione della verità nella prospettiva ermeneutica, analitica<br />
e post-moderna.<br />
Modalità <strong>di</strong> valutazione: Esame orale.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• P. Engel – R. Rorty, A cosa serve la verità?, Bologna 2007.<br />
Propedeuticità: Per poter partecipare al corso occorre aver sostenuto gli esami <strong>di</strong> Storia<br />
della filosofia antica e me<strong>di</strong>evale e Storia della filosofia moderna e contemporanea.<br />
Morale, democrazie e conformismo in Kenneth Minogue<br />
(Filosofia delle scienze sociali 3)<br />
Prof. Dr. Carlo Lottieri<br />
Sigla: FFCO Semestre autunnale Ects: 3<br />
Obiettivo corso: Il corso si propone <strong>di</strong> esaminare le tesi elaborate dal filosofo britannico<br />
Kenneth Minogue ne La mente servile.<br />
Modalità <strong>di</strong> valutazione: Esame orale.<br />
Contenuto del corso: Nel suo <strong>stu<strong>di</strong></strong>o, Minogue esamina taluni tratti del degrado morale<br />
delle società occidentali e punta il <strong>di</strong>to contro l’imporsi <strong>di</strong> un nuovo dogmatismo, tanto<br />
più oppressivo quanto più si presenta come liberante. Il corso cercherà <strong>di</strong> approfon<strong>di</strong>re<br />
la nozione <strong>di</strong> “politico-morale”, che può offrire una chiave <strong>di</strong> notevole interesse per la<br />
comprensione <strong>di</strong> taluni tratti della cultura contemporanea.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• Kenneth Minogue, La mente servile. La vita morale nell’era della democrazia, Torino,<br />
2012;<br />
• Kenneth Minogue, La mente liberal, Macerata, 2011;<br />
• Kenneth Minogue, Conservatism Realism, London, 1996.<br />
Corsi <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong><br />
Tesi e controversie sull’universo normativo (filosofia del <strong>di</strong>ritto 3)<br />
Prof. Dr. Carlo Lottieri<br />
Sigla: FFCO Semestre autunnale Ects: 3<br />
Obiettivo corso: Il corso tematizza le implicazioni ontologiche, linguistiche sociali e <strong>di</strong><br />
altro tipo dei sistemi normativi.<br />
Modalità <strong>di</strong> valutazione: Esame orale.<br />
Contenuto del corso: L’universo normativo è frutto <strong>di</strong> una nostra costante partecipazione<br />
ai processi che elaborano regole e inducono a rispettarle. Il corso si propone<br />
<strong>di</strong> mostrare la pluralità dei para<strong>di</strong>gmi concettuali che sono adottati per accostarsi alla<br />
“norma” e, al tempo stesso, le forti interconnessioni tra le <strong>di</strong>verse scuole <strong>di</strong> pensiero<br />
che <strong>stu<strong>di</strong></strong>ano la <strong>di</strong>mensione normativa.<br />
95
Bibliografia essenziale:<br />
• Giuseppe Lorini e Lorenzo Passerini Glazel, a cura <strong>di</strong>, Filosofie della norma, Torino,<br />
2012.<br />
• Amedeo G. Conte, Paolo Di Lucia, Luigi Ferrajoli, Mario Iori, a cura <strong>di</strong>, Filosofia<br />
del <strong>di</strong>ritto, Milano, 2002.<br />
Corsi <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong><br />
Dalla profezia all’apocalittica nell’uno e nell’altro Testamento<br />
Prof. Dr. Franco Manzi<br />
Sigla: NTCO Semestre autunnale Ects: 3<br />
Obiettivo corso: Il corso <strong>di</strong> taglio teologico-biblico dà una chiave interpretativa della<br />
profezia e dell’apocalittica.<br />
Modalità <strong>di</strong> valutazione: Per favorire l’appren<strong>di</strong>mento e la preparazione dell’esame orale,<br />
il docente mette a <strong>di</strong>sposizione una <strong>di</strong>spensa.<br />
Contenuto del corso: Il Dio dell’alleanza si è rivelato sia nell’AT che nel NT «con parole<br />
e azioni» (cf DV 14). Analizzando vari brani della profezia e dell’apocalittica dell’AT e<br />
dell’Apocalisse <strong>di</strong> Giovanni, il corso mostra come il Signore si sia manifestato me<strong>di</strong>ante<br />
«segni». Ha rispettato così la libertà delle persone, che, per comprendere il senso salvifico<br />
dei segni <strong>di</strong> Dio, sono chiamate ad aprirsi a lui con fede.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• F. Manzi, Le orme <strong>di</strong> Cristo. Discernimento e profezia, Milano, 2005.<br />
• F. Manzi (ed.), AsSaggi biblici. Introduzione alla Bibbia anima della teologia, Milano,<br />
2006, pp. 266-281.<br />
• P. Caspani (ed.), Liberaci dal Maligno. L’esperienza del demoniaco e la riflessione<br />
teologica, Milano, 2008, pp. 11-38.<br />
La ricerca <strong>di</strong> Gesù, Figlio <strong>di</strong> Dio, nel Vangelo secondo Luca<br />
Prof. Dr. Franco Manzi<br />
Sigla: NTCO Semestre primaverile Ects: 3<br />
Obiettivo corso: Il corso <strong>di</strong> taglio teogico-biblico dà una chiave interpretativa della cristologia<br />
<strong>di</strong> Luca.<br />
Modalità <strong>di</strong> valutazione: Per favorire l’appren<strong>di</strong>mento e la preparazione dell’esame orale,<br />
il docente mette a <strong>di</strong>sposizione una <strong>di</strong>spensa.<br />
Contenuto del corso: Il corso presenta le tappe storiche della formazione dei vangeli,<br />
intesi come «attestazioni» credenti («testimonianze» <strong>di</strong> fede cristallizzate in «testi»<br />
narrativi) dei ricor<strong>di</strong> sulla vita <strong>di</strong> Gesù. Si sofferma poi a spiegare brani del Vangelo <strong>di</strong><br />
Luca da cui traspare come Gesù sia cresciuto «drammaticamente», passando attraverso<br />
l’appren<strong>di</strong>mento dell’obbe<strong>di</strong>enza al Padre soprattutto durante la passione.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• F. Manzi, La bellezza <strong>di</strong> Maria. Riflessioni bibliche, Milano, 2005.<br />
• F. Manzi, Le orme <strong>di</strong> Cristo. Discernimento e profezia, Milano, 2005.<br />
• F. Manzi, Gesù do<strong>di</strong>cenne. Spunti biblici e riflessioni teologiche, Milano, 2007.<br />
96
Storia della filosofia antica<br />
Prof. Dr. Costante Marabelli<br />
Sigla: FFCP Semestre autunnale Ects: 4.5<br />
Obiettivo corso: Comprendere come si costituisce e si definisce, nelle sue principali<br />
articolazioni e figure speculative, il lascito dell’«invenzione» filosofica dei Greci.<br />
Modalità <strong>di</strong> valutazione: Tests scritti (durante il corso e finale). Possibilità <strong>di</strong> esame orale<br />
supplementare solo per chi supera complessivamente i tests scritti.<br />
Contenuto del corso: Iniziazione, nel rispetto <strong>di</strong> un’attenta ermeneutica storica, ai principali<br />
concetti della «filosofia» classica, dagli albori pre-platonici a Plotino. I fuochi si<br />
appunteranno sui momenti forti, qualificanti: 1) la teoresi, con la costruzione <strong>di</strong> una<br />
«scienza» dell’intero (Platone, Aristotele, Plotino) e 2) la moralità, con la valorizzazione<br />
della ragione nella ricerca del perfezionamento della vita umana (Socrate, Aristotele,<br />
scuole ellenistiche).<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• G. Reale, Il pensiero antico, Milano 2001.<br />
• E. Berti, In principio era la meraviglia. Le gran<strong>di</strong> questioni della filosofia antica, Roma-<br />
Bari 2008.<br />
Altri strumenti utili saranno in<strong>di</strong>cati a inizio corso e nel sito della FTL.<br />
Corsi <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong><br />
Corso monografico <strong>di</strong> Storia della filosofia antica: Il Timeo,<br />
«mito scientifico» <strong>di</strong> Platone<br />
Prof. Dr. Costante Marabelli<br />
Sigla: FFCP Semestre autunnale Ects: 1.5<br />
Presentazione: Questo <strong>di</strong>alogo è stata l’opera più influente <strong>di</strong> Platone fino al Rinascimento.<br />
Raffaello <strong>di</strong>pinge Platone con in mano il Timeo. Esso descrive il passaggio (creazione)<br />
dal mondo intelligibile al mondo fisico, mettendo al centro l’azione del <strong>di</strong>o Demiurgo,<br />
«che sempre geometrizza» (Plutarco). Il corso intende esserne un’introduzione<br />
alla lettura, fornendo gli elementi per la sua comprensione.<br />
Questo corso, oltre che costituire una parte integrante (e quin<strong>di</strong> obbligatoria) del corso<br />
<strong>di</strong> storia della filosofia antica, che si svolgerà in coda (ultimo segmento del semestre)<br />
della sua parte generale (da Talete a Plotino), può costituire un corso opzionale, quin<strong>di</strong><br />
frequentabile in<strong>di</strong>pendentemente, previa iscrizione.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
Una traduzione italiana del Timeo.<br />
Altri strumenti saranno in<strong>di</strong>cati a inizio corso.<br />
La <strong>di</strong>alettica d’amore tra Eloisa e Abelardo, premessa a un progetto<br />
<strong>di</strong> vita religiosa<br />
Prof. Dr. Costante Marabelli<br />
Sigla: FFCO Semestre autunnale Ects: 3<br />
Obiettivo corso: Verificare l’ipotesi interpretativa della prima parte dell’epistolario (lettere<br />
I-V, VI) come prologo <strong>di</strong> natura letterario-retorica a un progetto che potremmo<br />
definire <strong>di</strong> teologia “pratica”.<br />
97
Corsi <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong><br />
Modalità <strong>di</strong> valutazione: Esame orale.<br />
Contenuto del corso: Pietro Abelardo è stato senza dubbio un grande protagonista<br />
della cultura del secolo XII, filosofo, teologo, letterato, riformatore religioso, amato e<br />
avversato. Eloisa, celebrata come una delle donne più intelligenti e colte dei suoi tempi<br />
ne fu <strong>di</strong>scepola, amante, sposa segreta, e poi separata, per poi ri<strong>di</strong>ventare <strong>di</strong>scepola<br />
spirituale. Il corso cerca <strong>di</strong> cogliere il senso della rievocazione della loro storia (e delle<br />
tensioni che in essa si produssero) nel famoso e <strong>di</strong>scusso epistolario che li concerne alla<br />
luce del <strong>di</strong>segno <strong>di</strong> vita religiosa per Eloisa e le sue monache che le due ultime lettere <strong>di</strong><br />
Abelardo (VII e VIII) illustrano, a cui la <strong>di</strong>alettica del loro amore e delle loro idee filosofiche<br />
sull’amore fa da curiosa introduzione.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• Abelardo ed Eloisa, Epistolario, a cura <strong>di</strong> I. Pagani, Torino 2008.<br />
• E. Gilson, Héloïse et Abélard, Paris 1997 3 .<br />
• G. Lobrichon, Eloisa. Abelardo, l’amore, il sapere, Roma 2005.<br />
Propedeuticità: Corsi <strong>di</strong> storia della filosofia antica e me<strong>di</strong>evale.<br />
Seminario: Haec sublimis veritas: Dio come Essere<br />
verità imprescin<strong>di</strong>bile della filosofia cristiana<br />
Prof. Dr. Costante Marabelli<br />
Sigla: FFSO Semestre autunnale Ects: 4<br />
Obiettivo corso: Ritrovare il senso <strong>di</strong> una coincidenza tra «filosofia cristiana» e filosofia<br />
dell’essere.<br />
Modalità <strong>di</strong> valutazione: Esame scritto.<br />
Contenuto del corso: Lettura de L’Être et l’Essence, <strong>di</strong> Étienne Gilson, testo fondamentale<br />
del Novecento che riscopre, nella filosofia dell’essere <strong>di</strong> san Tommaso, un<br />
equilibrio necessario e possibile tra senso del mistero e razionalità. Sarà analizzato il<br />
significato del cosiddetto tomismo esistenziale sostenuto e <strong>di</strong>feso da Gilson nelle sue<br />
premesse (storiche e teoretiche) e nelle sue articolazioni, esaminando e <strong>di</strong>scutendo<br />
anche alcune critiche ad esso rivolte.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• É. Gilson, L’Être et l’Essence, Paris 1987 2 ; tr. it. Massimo, Milano 2007 2 .<br />
• A. Del Noce, La riscoperta del tomismo in Étienne Gilson..., in Stu<strong>di</strong> in onore <strong>di</strong> G.<br />
Bonta<strong>di</strong>ni, Milano 1979.<br />
Sarà in<strong>di</strong>cata a inizio corso la bibliografia critica.<br />
Propedeuticità: Corsi <strong>di</strong> storia della filosofia antica, me<strong>di</strong>evale, moderna e contemporanea.<br />
Storia della filosofia me<strong>di</strong>evale<br />
Prof. Dr. Costante Marabelli<br />
Sigla: FFCP Semestre primaverile Ects: 4.5<br />
Obiettivo corso: Cogliere le originalità e i valori autenticamente filosofici prodotti da<br />
una fides quaerens intellectum.<br />
98
Modalità <strong>di</strong> valutazione: Tests scritti (durante il corso e finale). Possibilità <strong>di</strong> esame orale<br />
supplementare solo per chi supera complessivamente i tests scritti.<br />
Contenuto del corso: Nel ripercorrere, dalla Tarda antichità (Agostino) all’Umanesimo<br />
(Cusano), l’impegno intellettuale dei credenti (cristiani, ebrei, musulmani) in cerca<br />
dell’intelligibilità dell’oggetto del loro credo, saranno contestualizzati ed evidenziati i<br />
momenti in cui l’ere<strong>di</strong>tà della «filosofia» antica suscita <strong>di</strong>scussioni e produce originalità<br />
<strong>di</strong> pensiero.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• E. Gilson, La filosofia nel Me<strong>di</strong>oevo, Milano 2011.<br />
• A. de Libera, Storia della filosofia me<strong>di</strong>evale, Milano 1997.<br />
• A. Kenny, Filosofia me<strong>di</strong>evale, Torino 2012.<br />
Propedeuticità: Corso <strong>di</strong> storia della filosofia antica.<br />
Corso monografico <strong>di</strong> Storia della filosofia me<strong>di</strong>evale:<br />
L’opuscolo <strong>di</strong> S. Tommaso Sull’eternità del mondo: la posizione filosofica<br />
<strong>di</strong> un teologo su un tema <strong>di</strong> grande <strong>di</strong>scussione e scontro<br />
Prof. Dr. Costante Marabelli<br />
Sigla: FFCP Semestre primaverile Ects: 1.5<br />
Presentazione: Quest’opuscolo <strong>di</strong> San Tommaso affronta un tema scottante: la compatibilità<br />
della dottrina aristotelica dell’eternità del mondo e la dottrina della rivelazione<br />
biblico-cristiana. Il corso intende esserne un’introduzione alla lettura, fornendo gli elementi<br />
per la sua comprensione storico-contestuale. Il modo <strong>di</strong> confrontarsi con la dottrina<br />
aristotelica e le soluzioni <strong>di</strong> Tommaso saranno confrontati con quelli così <strong>di</strong>versi<br />
del contemporaneo san Bonaventura.<br />
Questo corso, oltre a costituire una parte integrante (e quin<strong>di</strong> obbligatoria) del corso<br />
<strong>di</strong> storia della filosofia me<strong>di</strong>evale, che si svolgerà in coda (ultimo segmento del semestre)<br />
della sua parte generale (da Agostino a Cusano), può costituire un corso opzionale,<br />
quin<strong>di</strong> frequentabile in<strong>di</strong>pendentemente, previa iscrizione.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• Tommaso d’Aquino, L’ unità dell’intelletto. L’eternità del mondo, Bologna 2012.<br />
• Sigieri <strong>di</strong> Brabante, L’ eternità del mondo-De aeternitate mun<strong>di</strong>, Palermo 2009.<br />
• Boezio <strong>di</strong> Dacia, Sull’eternità del mondo, Milano 2003.<br />
Per Bonaventura saranno in<strong>di</strong>cati i testi opportuni a inizio corso.<br />
Propedeuticità: Corsi <strong>di</strong> storia della filosofia antica.<br />
Corsi <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong><br />
Filosofia cristiana: Fides quaerens intellectum:<br />
L’impegno razionale della ricerca teologica <strong>di</strong> Anselmo d’Aosta<br />
Prof. Dr. Costante Marabelli<br />
Sigla: FFCP Semestre primaverile Ects: 6<br />
Obiettivo corso: indagare sul significato per chi crede <strong>di</strong> me<strong>di</strong>tare sul valore razionale<br />
del proprio credere.<br />
Modalità <strong>di</strong> valutazione: Esame orale.<br />
99
Corsi <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong><br />
Contenuto del corso: Saranno prese in considerazione, introdotte e analizzate con puntuale<br />
commento, singolarmente, le opere <strong>di</strong> Anselmo che <strong>di</strong> solito si in<strong>di</strong>cano come filosofiche<br />
(Monologion, Proslogion con il Pro insipiente <strong>di</strong> Gaunilone e la Risposta <strong>di</strong> Anselmo,<br />
De grammatico, De veritate, De libertate arbitrii, De casu <strong>di</strong>aboli), al fine <strong>di</strong> determinare<br />
il percorso che conduce alla certezza razionale circa l’Assoluto e circa il modo con cui<br />
l’uomo vi si deve rapportare, dalla quale prende consistenza nel credente quella che<br />
Anselmo chiama me<strong>di</strong>tazione (ossia, se <strong>di</strong>rebbe, pensiero confidente e ritornante) sulle<br />
ragioni della fede.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• Anselmo d’Aosta, Opere filosofiche, a cura <strong>di</strong> S. Vanni Rovighi, Roma-Bari 2008.<br />
• K. Bart, Anselmo d’Aosta. Fides quaerens intellectum, Brescia 2001.<br />
• É. C. Viola, Anselmo d’Aosta. Fede e ricerca dell’intelligenza, Milano 2000.<br />
Propedeuticità: Corsi <strong>di</strong> storia della filosofia antica e me<strong>di</strong>evale.<br />
Dottrina Sociale della Chiesa e mercato<br />
Prof. Dr. Giuseppe Mastromatteo<br />
Sigla: TMCO Semestre autunnale Ects: 3<br />
Obiettivo corso: È una riflessione sulle istanze morali ed etiche espresse dalla Dottrina<br />
Sociale della Chiesa alla luce dell’evoluzione dell’economia contemporanea. L’obiettivo<br />
è rivolto a cogliere significato e valore, ma anche limiti e contrad<strong>di</strong>zioni, dei sistemi economici<br />
o<strong>di</strong>erni, negli aspetti che <strong>di</strong>sciplinano la vita e l’integrità della persona, ovvero nel<br />
rapporto che si instaura tra gli in<strong>di</strong>vidui e il sistema <strong>di</strong> produzione economica nel corso<br />
del suo sviluppo. Tale approccio porta a ripensare i presupposti, i postulati, i para<strong>di</strong>gmi<br />
e le finalità delle <strong>di</strong>scipline economiche e sociali per cogliere il nesso fondamentale tra<br />
economia e umanità.<br />
Modalità <strong>di</strong> valutazione: Esame orale.<br />
Contenuto del corso: Il nesso tra Chiesa e mercato appare riconducibile al nesso stesso<br />
tra umanità ed economia, dove si condensa l’esperienza dell’uomo nel suo rapporto<br />
con gli altri uomini e con le cose.<br />
Le regole della realtà economica nuova e senza precedenti dell’era industriale e tecnologica<br />
ha portato a una crescente <strong>di</strong>varicazione tra il comportamento sociale nella storia<br />
e la visione concreta <strong>di</strong> ciò che rappresenta l’impegno cristiano nel mondo, imperniato<br />
sulla povertà e sulla testimonianza <strong>di</strong> Cristo Salvatore.<br />
La Dottrina Sociale della Chiesa, nello specifico e particolare riferimento delle encicliche<br />
Rerum novarum, Centesimus annus, Caritas in Veritate, ha definito i principi<br />
fondamentali <strong>di</strong> valutazione etica <strong>di</strong> qualsiasi sistema ed istituzione sociale nei valori<br />
della persona, della solidarietà e della sussi<strong>di</strong>arietà. Ha delineato in proposito il bilanciamento<br />
possibile tra le lo-giche <strong>di</strong> funzionamento dei sistemi economici contemporanei<br />
e lo sviluppo dei presupposti etici e spirituali dell’umanità, solo attraverso<br />
l’affermazione <strong>di</strong> un’idea guida sostanzialmente <strong>di</strong>versa rispetto ai comportamenti<br />
prevalenti. Tale idea guida ha punti <strong>di</strong> riferimento essenziali nella responsabilità in<strong>di</strong>viduale,<br />
nella solidarietà e nella carità.<br />
Nell’ambito della trattazione del rapporto tra Parola <strong>di</strong> Dio e impegno nel mondo, il<br />
100
Magistero della Chiesa richiama l’attenzione sulla povertà intesa come centro focale<br />
dell’antropologia cristiana. La povertà, intesa come con<strong>di</strong>zione spirituale generata dalla<br />
relazione del credente con Dio, è lo strumento che funge da propellente <strong>di</strong> un impegno<br />
nel mondo guidato da principi <strong>di</strong> giustizia e <strong>di</strong> solidarietà.<br />
Il <strong>di</strong>scorso teologico e filosofico concernente l’impegno del cristiano nel mondo si deve<br />
con-frontare sistematicamente non solo con il modo <strong>di</strong> produrre e <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuire, ma<br />
anche con le stesse forme delle obbligazioni reciproche tra gli esseri umani e le stesse<br />
forme <strong>di</strong> <strong>di</strong>sporre delle cose.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• E.-W. Bockenforde - G. Bazoli , Chiesa e Capitalismo, Brescia, 2010.<br />
• L. Pasinetti, Dottrina sociale della Chiesa e teoria economica, Milano, 2012.<br />
• A. Scola, La Dottrina sociale della Chiesa: risorsa per una società plurale, Milano, 2007.<br />
Globalizzazione ed etica cristiana: una globalizzazione<br />
al servizio dell’uomo<br />
Prof. Dr. Giuseppe Mastromatteo<br />
Sigla: FFCO Semestre primaverile Ects: 3<br />
Obiettivo corso: Partendo dall’esame <strong>degli</strong> effetti della globalizzazione, si verifica in particolare<br />
la concreta capacità <strong>di</strong> questo processo <strong>di</strong> coinvolgere i paesi più poveri del mondo.<br />
A fronte dell’insufficienza della sola razionalità economica a offrire risposte efficaci per<br />
risolvere i problemi <strong>di</strong> marginalizzazione delle realtà più povere, si prospetta un <strong>di</strong>verso<br />
approccio basato sulla razionalità etica, così come espressa dall’etica cristiana.<br />
L’etica cristiana, basandosi sul presupposto della giustizia e carità, apre alla cultura del<br />
dono, quale chiave interpretativa <strong>di</strong> un nuovo rapporto tra le persone.<br />
Modalità <strong>di</strong> valutazione: Esame orale.<br />
Contenuto del corso: Il processo <strong>di</strong> globalizzazione in atto, con la crescente integrazione<br />
tra le varie economie in termini <strong>di</strong> commercio internazionale, flussi finanziari e<br />
informazioni, solleva <strong>di</strong>verse questioni. Una delle più delicate riguarda la capacità o<br />
meno della globalizzazione <strong>di</strong> coinvolgere e <strong>di</strong> offrire opportunità <strong>di</strong> sviluppo e crescita<br />
al maggior numero possibile <strong>di</strong> paesi, anche ai più poveri ed isolati.<br />
La globalizzazione ha favorito la riduzione della povertà in un largo numero <strong>di</strong> paesi in<br />
via <strong>di</strong> sviluppo ma non sembra in grado <strong>di</strong> aiutare i paesi più poveri e marginali ad uscire<br />
dai loro problemi. Il rischio <strong>di</strong> emarginazione e miseria in questi paesi, dove vivono circa<br />
due miliar<strong>di</strong> <strong>di</strong> persone, è particolarmente preoccupante.<br />
Il corso analizza se e quale relazione esiste tra globalizzazione ed istanze etiche. Inizialmente<br />
si descrivono i fatti economici e sociali che caratterizzano l’economia globalizzata;<br />
successivamente si riflette sul rapporto tra razionalità economica e razionalità etica,<br />
con riferimento specifico all’etica cristiana, in cui assumono particolare rilievo i concetti<br />
<strong>di</strong> giustizia e carità.<br />
La cultura del dono, applicata nella piena libertà, è lo specchio dell’amore ricevuto da<br />
Dio e <strong>di</strong>venta pertanto un riferimento importante nel <strong>di</strong>scorso teologico e filosofico<br />
concernente l’impegno del cristiano nel mondo.<br />
Corsi <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong><br />
101
Corsi <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong><br />
Bibliografia essenziale:<br />
• P. Collier e D.R. Dollar, Globalization, Growth and Poverty: Buil<strong>di</strong>ng and Inclusive<br />
World Economy, World Bank Pubblitcations, 2002.<br />
• G. Mastromatteo, Globalizzazone e sviluppo dei paesi poveri, Istituto <strong>di</strong> Economia e<br />
Finanza, Università Cattolica del Sacro Cuore <strong>di</strong> Milano, <strong>2013</strong>.<br />
• Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, Compen<strong>di</strong>o della Dottrina Sociale<br />
della Chiesa, Libreria E<strong>di</strong>trice Vaticana, Città del Vaticano, 2005.<br />
Lo Shabbat: norme, significato e liturgia<br />
Prof.ssa Dr.ssa Clau<strong>di</strong>a Milani<br />
Sigla: DICO Semestre primaverile Ects: 3<br />
Obiettivo corso: Fornire una presentazione della principale festività ebraica, dall’epoca<br />
biblica all’ebraismo contemporaneo.<br />
Modalità <strong>di</strong> valutazione: Esame orale.<br />
Contenuto del corso: Sarà presentato lo Shabbat, la principale festività ebraica, attraverso<br />
i passi biblici che ne fondano l’osservanza; si analizzeranno gli obblighi e i <strong>di</strong>vieti,<br />
la liturgia festiva, gli usi e costumi delle comunità ebraiche. Verrà inoltre preso in esame<br />
il significato che lo Shabbat riveste per l’ebraismo contemporaneo, attraverso la lettura<br />
<strong>di</strong> alcuni passi <strong>di</strong> autori significativi.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• Isidor Grunfeld, Lo Shabbàth. Guida alla comprensione e all’osservanza del Sabato,<br />
Firenze 2004 2 .<br />
• Abraham Joshua Heschel, Il Sabato, Milano 2001.<br />
Dispensa a cura della docente.<br />
Introduzione alle religioni orientali<br />
Prof.ssa Dr.ssa Flavia Monceri<br />
Sigla: DICO Semestre primaverile Ects: 3<br />
Presentazione: 1) Le ‘religioni’ in prospettiva comparata: problemi e prospettive (6<br />
ore); 2) Introduzione al buddhismo (6 ore); 3) Introduzione al confucianesimo (6 ore);<br />
4) Taoismo e Zen (8 ore).<br />
Modalità <strong>di</strong> valutazione: Esame orale.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• Dispensa a carattere storico-introduttivo (da leggere prima <strong>degli</strong> incontri);<br />
• M.D. Eckel, Capire il buddhismo, Milano 2007;<br />
• J. Oldstone-Moore, Capire il confucianesimo, Milano 2007;<br />
• J. Oldstone-Moore, Capire il taoismo, Milano 2007.<br />
La questione della felicità nella filosofia contemporanea<br />
Prof. Dr. Kevin Mulligan<br />
Sigla: SICO Semestre primaverile Ects: 2<br />
La descrizione sarà fornita all’inizio dell’anno accademico.<br />
102
Storia delle istituzioni canoniche<br />
Prof. Dr. Luciano Musselli<br />
Sigla: DCCO Semestre primaverile Ects: 3<br />
Presentazione: Il corso si propone <strong>di</strong> analizzare, in luce storica, il profilo canonistico<br />
delle principali istituzioni ecclesiali (con particolare riguardo agli organi <strong>di</strong> Governo della<br />
Chiesa universale e locale ed allo sviluppo della giuris<strong>di</strong>zione ecclesiastica) e <strong>degli</strong> istituti<br />
tipici dello “ius canonicum” (ed esempio il matrimonio). Tale analisi sarà effettuata in<strong>di</strong>viduando<br />
i momenti nodali della trasformazione della <strong>di</strong>sciplina che concerne i settori<br />
oggetto <strong>di</strong> <strong>stu<strong>di</strong></strong>o, in stretto collegamento con lo sviluppo delle fonti e della dottrina del<br />
<strong>di</strong>ritto canonico dalle origini ad oggi.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• L. Musselli, Storia del <strong>di</strong>ritto canonico. Introduzione alla storia del <strong>di</strong>ritto e delle istituzioni<br />
ecclesiali, Torino 2007;<br />
• J. Orlan<strong>di</strong>s, Le istituzioni della Chiesa Cattolica, Cinisello Balsamo 2005;<br />
• C. Fantappié, Introduzione storica al <strong>di</strong>ritto canonico, Bologna 2003;<br />
• J. Gaudemet, Eglise et cité, histoire du droit canonique, Paris 1994 (trad. ital.: Storia<br />
del <strong>di</strong>ritto canonico, Cinisello Balsamo 1998).<br />
Corsi <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong><br />
Storia della Chiesa III: riforma protestante e cattolica<br />
Prof.ssa Dr.ssa Simona Negruzzo<br />
Sigla: SCCP Semestre autunnale Ects: 3<br />
Obiettivo corso: Formare la capacità <strong>di</strong> analizzare criticamente i fatti storici <strong>di</strong> lunga e<br />
breve durata, per comprendere i movimenti e le <strong>di</strong>namiche sociali, culturali e religiose<br />
del nostro tempo.<br />
Modalità <strong>di</strong> valutazione: Esame orale.<br />
Contenuto del corso: La storia della Chiesa dal XV al XVII secolo Dopo aver illustrato<br />
l’origine e lo sviluppo della riforma protestante attraverso le biografie dei principali<br />
esponenti e le vicende delle Chiese da loro fondate, verranno tracciate le linee principali<br />
della riforma cattolica, le tappe del concilio <strong>di</strong> Trento, le iniziative e gli strumenti messi<br />
in atto della controriforma tra Cinque e Seicento.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• Robert Bireley, Ripensare il cattolicesimo 1450-1700, Genova-Milano, 2010;<br />
• Giacomo Martina, Storia della Chiesa. I: L’età della Riforma, Brescia, 2008 5 ;<br />
• Peter George Wallace, La lunga età della riforma, Bologna, 2006.<br />
Introduzione all’Islam<br />
Prof.ssa Dr.ssa Luisa Orelli<br />
Sigla: DICO Semestre primaverile Ects: 1.5<br />
Presentazione: Cenni storici: dalla jâhilîya all’islam. Cronologia della rivelazione coranica.<br />
I cinque pilastri del culto. Sunnismo e sciismo. Prime correnti teologiche e esperienze<br />
mistiche.<br />
103
Bibliografia essenziale:<br />
• Paolo Branca, Introduzione all’Islam, Torino, 1995<br />
• Il Corano, a cura <strong>di</strong> Alessandro Bausani, Milano, 2006<br />
Corsi <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong><br />
Armonia e tensioni nella comunità <strong>di</strong> Corinto.<br />
La Seconda Lettera <strong>di</strong> Paolo ai Corinti<br />
Prof. Dr. Mauro Orsatti<br />
Sigla: NTCO Semestre autunnale Ects: 3<br />
Presentazione: Vivace e intrigante, i cristiani <strong>di</strong> Corinto hanno goduto una lunga permanenza<br />
<strong>di</strong> Paolo, creando rapporti costruttivi, ma non privi <strong>di</strong> forti tensioni. Nell’ardore<br />
<strong>di</strong> un amore spesso carico <strong>di</strong> polemica, l’Apostolo apre le segrete del suo cuore per<br />
documentare l’autenticità della sua missione. Da tale amore, esaltante e <strong>di</strong>fficile, è nato<br />
lo scritto più autobiografico <strong>di</strong> tutto l’epistolario paolino: la Seconda Lettera ai Corinti.<br />
Il corso propone una lettura approfon<strong>di</strong>ta del testo al fine <strong>di</strong> comprendere quella comunità,<br />
per molti aspetti specchio delle nostre.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• J. Lambrecht, Second Corinthians, Collegeville 1998.<br />
• M. Orsatti, Armonia e tensioni nella comunità. La Seconda Lettera <strong>di</strong> Paolo ai Corinti,<br />
Bologna 1998.<br />
• J. Murphy O’Connor, The Theology of the Second Letter to the Corinthians, Cambridge<br />
1991.<br />
I Vangeli dell’Infanzia<br />
Prof. Dr. Mauro Orsatti<br />
Sigla: NTSO Semestre autunnale Ects: 4<br />
Seminario riservato agli studenti (non u<strong>di</strong>tori).<br />
Presentazione: Spesso negletti perché considerati <strong>di</strong> poca importanza e più spesso ancora<br />
trattati come colorati ed ingenui racconti e<strong>di</strong>ficanti, i Vangeli dell’infanzia sprigionano<br />
storia e spiritualità, quando sono sottoposti ad uno <strong>stu<strong>di</strong></strong>o scrupoloso, sapientemente<br />
guidato dalla teologia.<br />
Il seminario intende aiutare gli studenti a riscoprire in modo nuovo ed esaltante testi<br />
molto conosciuti, perché proposti ogni anno in occasione del Natale, ma non sempre<br />
trattati con il dovuto rispetto e con la sapiente competenza.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• R.E. Brown, La nascita del Messia secondo Matteo e Luca, Assisi 1981.<br />
• R. Laurentin, I Vangeli dell’infanzia <strong>di</strong> Cristo. La verità del Natale al <strong>di</strong> là dei miti,<br />
Cinisello Balsamo 1985.<br />
• S. Munoz Iglesias, Los Evangelios de la Infancia. Los anuncios angélicos previos en el<br />
Evangelio de la Infancia, II, Madrid 1986.<br />
• M. Orsatti, I vangeli dell’infanzia, in: M. Laconi (ed.), Logos. Corso <strong>di</strong> <strong>stu<strong>di</strong></strong> Biblici, vol<br />
V: Vangeli sinottici e Atti <strong>degli</strong> Apostoli, Leumann (TO) 1994, 443-457.<br />
• M. Orsatti, Natale, la bella notizia, Milano 2009 2 .<br />
104
Il racconto della Passione in Matteo<br />
Prof. Dr. Mauro Orsatti<br />
Sigla: NTSO Semestre autunnale Ects: 4<br />
Seminario riservato agli studenti (non u<strong>di</strong>tori).<br />
Presentazione: Il nucleo della Passione occupa nella trama evangelica un posto <strong>di</strong> rilievo<br />
per estensione e per intensità. A <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> altre parti, qui il racconto <strong>di</strong>venta molto<br />
dettagliato per la ricca cronologia, per le abbondanti citazioni veterotestamentarie, per<br />
la dovizia <strong>di</strong> personaggi. Domina soprattutto il valore teologico che permette al lettore<br />
<strong>di</strong> entrare un poco nel mistero della sofferenza e della morte. Dalle tenebre del male<br />
spunta una luce che <strong>di</strong>venterà ra<strong>di</strong>osa nel giorno della Risurrezione.<br />
Il seminario intende aiutare gli studenti ad approfon<strong>di</strong>re il racconto della Passione in<br />
Matteo, favorendo la comprensione intellettuale e stimolando l’accoglienza spirituale<br />
del messaggio.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• R.E. Brown, La morte del Messia. Un commentario ai racconti della passione nei<br />
quattro vangeli, Brescia 1999.<br />
• V. Messori, Patì sotto Ponzio Pilato? Un’indagine sulla passione e morte <strong>di</strong> Gesù, Torino<br />
1992.<br />
• R. Meynet, Testamento, processo, esecuzione e risurrezione <strong>di</strong> Gesù nei vangeli sinottici,<br />
Bologna 2002.<br />
• D. Senior, La passione <strong>di</strong> Gesù nel vangelo <strong>di</strong> Matteo, Milano 1990.<br />
Corsi <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong><br />
Il Vangelo della domenica<br />
Prof. Dr. Mauro Orsatti<br />
Sigla: NTCO Semestre autunnale Ects: 3<br />
Presentazione: La conoscenza dei testi liturgici proposti ogni domenica, soprattutto del<br />
Vangelo, permette una partecipazione più viva, coinvolgendo il cristiano in un’azione<br />
che gli appartiene <strong>di</strong>rettamente. Mentre il sacerdote ha il dovere <strong>di</strong> presiedere l’eucaristia,<br />
il fedele vi partecipa in modo corresponsabile e attivo, non come semplice spettatore.<br />
Anche per l’omelia o pre<strong>di</strong>ca il fedele può giocare un ruolo che non sia quello <strong>di</strong><br />
semplice ascoltatore.<br />
Il corso si propone <strong>di</strong> aiutare i partecipanti nella comprensione dei testi liturgici, per<br />
coinvolgerli in una partecipazione più ecclesiale della celebrazione liturgica.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• M. Orsatti, In cammino con la Parola. Commento alle letture festive: Anno C, Brescia<br />
2003.<br />
• M. Orsatti, Obbe<strong>di</strong>enti alla Parola. Commento alle letture festive: Anno A, Brescia<br />
2007.<br />
105
Corsi <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong><br />
Il Signore dell’universo (Lettera <strong>di</strong> san Paolo ai Colossesi)<br />
Prof. Dr. Mauro Orsatti<br />
Sigla: NTCO Semestre primaverile Ects: 3<br />
Presentazione: Lettera breve, <strong>di</strong> solo quattro capitoli, meno famosa <strong>di</strong> altre, lo scritto<br />
<strong>di</strong> Paolo alla comunità <strong>di</strong> Colossi, località dell’attuale Turchia, ha il grande merito <strong>di</strong><br />
presentare Cristo come Signore dell’universo. Alcune frasi, ad esempio “cercate le cose<br />
<strong>di</strong> lassù”, sono famose e familiari, perché adottate dalla liturgia nel periodo pasquale. La<br />
gran<strong>di</strong>osità <strong>di</strong> Cristo è con<strong>di</strong>zione per esaltare il valore dell’uomo, chiamato a costruire<br />
una società con nuovi rapporti ed altresì con<strong>di</strong>zione per costruire la Chiesa, corpo mistico<br />
dove ognuno trova il suo posto e la sua valorizzazione.<br />
Il corso propone la lettura integrale della lettera e il suo commento. Sarà una piacevole<br />
sorpresa e un go<strong>di</strong>mento per l’intelligenza e per la vita spirituale.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• J.N. Aletti, Lettera ai Colossesi, Bologna 1994.<br />
• M. Orsatti, Cristo, Signore dell’uomo e del cosmo, <strong>Lugano</strong> <strong>2014</strong>.<br />
• G. Rossé, Lettera ai Colossesi. Lettera agli Efesini, Roma 2001.<br />
Le comunità cristiane negli Atti <strong>degli</strong> Apostoli<br />
Prof. Dr. Mauro Orsatti<br />
Sigla: NTSO Semestre primaverile Ects: 4<br />
Seminario riservato agli studenti (non u<strong>di</strong>tori).<br />
Presentazione: Con l’anno della fede da poco concluso, tutte le comunità cristiane si<br />
sono impegnate per rinnovare la loro adesione a Cristo, per scoprire una nuova linfa<br />
missionaria, per essere più autentiche e incisive in un mondo ormai secolarizzato. Il<br />
richiamo agli Atti <strong>degli</strong> Apostoli per conoscere le primitive comunità cristiane <strong>di</strong>venta<br />
un sapiente punto <strong>di</strong> riferimento e altresì la scoperta <strong>di</strong> metodologie antiche, eppure<br />
sempre nuove, capaci <strong>di</strong> affrontare le sempre crescenti sfide. Con l’esempio <strong>di</strong> Gesù<br />
sotto gli occhi, con il <strong>di</strong>namismo dello Spirito e con lo sforzo <strong>di</strong> ricerca della verità,<br />
quelle comunità insegnano ancora oggi alle nostre le vie sicure per annunciare con gioia<br />
Cristo al mondo.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• D. Attinger, Atti <strong>degli</strong> Apostoli, Magnano (VC) 2010.<br />
• J. Fitzmyer, Gli Atti <strong>degli</strong> Apostoli, Brescia 2003.<br />
• M. Orsatti, Le strade dello Spirito. Me<strong>di</strong>tazioni sugli Atti <strong>degli</strong> Apostoli, Milano 2005.<br />
Letteratura giovannea<br />
Prof. Dr. Mauro Orsatti<br />
Sigla: NTCP Semestre primaverile Ects: 6<br />
Presentazione: Definito “Vangelo spirituale” per la sua raffinata teologia, il IV Vangelo<br />
segue un tracciato proprio che lo <strong>di</strong>stingue nettamente da Matteo, Marco e Luca. Ricco<br />
<strong>di</strong> ampi <strong>di</strong>scorsi, limitato nei miracoli (solo sette, chiamati “segni”), ha una visione<br />
propria <strong>di</strong> Gesù, presentato fin dall’inizio nel suo mistero <strong>di</strong> Parola fatta carne. Cam-<br />
106
minando in mezzo agli uomini e rivelando loro il Padre, li porta progressivamente alla<br />
scoperta della luce <strong>di</strong> cui è portatore. Saranno proposti alcuni brani, scelti per offrire<br />
squarci su tutto il Vangelo.<br />
Il corso riguarderà anche altri due scritti attribuiti a Giovanni, la Prima Lettera, un autentico<br />
trattato <strong>di</strong> spiritualità fondato sull’amore, e l’Apocalisse, purtroppo conosciuta<br />
più per la sua <strong>di</strong>fficoltà che per la ricchezza del suo messaggio.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• R. Fabris, Giovanni, Roma 1992<br />
• X. Léon Dufour, Lettura dell’Evangelo secondo Giovanni, Cinisello Balsamo (MI)<br />
2007 2<br />
• F.J. Moloney, Il Vangelo <strong>di</strong> Giovanni, Leumann (TO) 2007.<br />
Diritto ecclesiastico svizzero: parte generale<br />
Prof. Dr. Vincenzo Pacillo<br />
Sigla: DCSO Semestre autunnale Ects: 4<br />
Presentazione: Il corso vuole proporre una <strong>di</strong>samina critica delle norme <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto federale<br />
<strong>di</strong>rette a regolamentare la libera estrinsecazione del sentimento religioso nell’or<strong>di</strong>namento<br />
svizzero. Dopo una premessa storica, ci si soffermerà in particolare: a) sulle<br />
norme costituzionali: il preambolo, l’art. 15, l’art. 72; b) sulla legislazione or<strong>di</strong>naria (<strong>di</strong>ritto<br />
civile e penale); c) Sulla giurisprudenza del Tribunale Federale.<br />
Le ultime 6 lezioni saranno de<strong>di</strong>cate all’analisi del Diritto ecclesiastico ticinese.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• L.Gerosa (Hg.), Chiesa cattolica e Stato in Svizzera. Atti del Convegno della Conferenza<br />
dei vescovi svizzeri (<strong>Lugano</strong>, 3–4 novembre 2008), Locarno 2009;<br />
• V. Pacillo, Stato e Chiesa cattolica nella Repubblica e Cantone Ticino. Profili giuri<strong>di</strong>ci<br />
comparati, Bellinzona 2009.<br />
Corsi <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong><br />
Diritto patrimoniale canonico<br />
Prof. Dr. Vincenzo Pacillo<br />
Sigla: DCCO Semestre primaverile Ects: 3<br />
Presentazione: La Chiesa, per lo svolgimento della sua missione ha bisogno <strong>di</strong> beni materiali:<br />
infatti “le realtà terrene e quelle che, nella con<strong>di</strong>zione umana, superano questo<br />
mondo, sono strettamente unite tra loro, e la Chiesa stessa si serve delle cose temporali<br />
nella misura che la propria missione richiede” (GS, 76). Il Co<strong>di</strong>ce regola le modalità<br />
con le quali la Chiesa può acquistare, possedere, amministrare, ed alienare i beni temporali.<br />
Il corso approfon<strong>di</strong>rà le seguenti tematiche: a) i beni temporali e la loro funzione<br />
e destinazione nella missione della Chiesa; b) l’acquisto dei beni temporali (cann. 1259<br />
– 1272); c) l’amministrazione dei beni temporali (cann. 1273 – 1289); d) i contratti e<br />
specialmente l’alienazione (cann. 1290 – 1298); e) i beni temporali <strong>degli</strong> Istituti <strong>di</strong> vita<br />
consacrata e la loro amministrazione; f) pie volontà in genere e pie fondazioni (cann.<br />
1299 – 1310); g) i beni culturali della Chiesa e la legislazione canonica.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• Aa.Vv., I beni temporali della Chiesa (Stu<strong>di</strong> giuri<strong>di</strong>ci L), Città del Vaticano 1999;<br />
107
• V. De Paolis, I beni temporali della Chiesa, Bologna 1995;<br />
• J.P. Schouppe, Elementi <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto patrimoniale canonico, Milano 1997.<br />
Corsi <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong><br />
Metodologia del lavoro scientifico<br />
Dott. sc. biol., Lic. theol. Alberto Palese<br />
Sigla: DICP Semestre autunnale Ects: -<br />
Presentazione: Il corso si propone <strong>di</strong> offrire allo studente criteri, meto<strong>di</strong> e strumenti<br />
per lo <strong>stu<strong>di</strong></strong>o universitario e una introduzione al metodo della ricerca scientifica, con<br />
particolare riferimento allo <strong>stu<strong>di</strong></strong>o della filosofia e della teologia. Gli studenti dovranno<br />
re<strong>di</strong>gere un testo <strong>di</strong> carattere scientifico sotto la supervisione del docente.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• Eco, U., Come si fa una tesi <strong>di</strong> laurea, 2001 (1985)<br />
• Lorizio, G., Galantino, N., Metodologia teologica. Avviamento allo <strong>stu<strong>di</strong></strong>o e alla ricerca<br />
pluri<strong>di</strong>sciplinare, 2004<br />
• Wicks, J., Introduzione al metodo teologico, 1994<br />
Scienze naturali e teologia<br />
Dott. sc. biol., Lic. theol. Alberto Palese<br />
Sigla: DICO Semestre primaverile Ects: 3<br />
Presentazione: Le scienze naturali e la teologia, sembrano guardare al mondo da punti<br />
<strong>di</strong> vista e con modalità <strong>di</strong>fferenti, eppure il confronto e la polemica non cessano <strong>di</strong> alimentarsi,<br />
rendendo evidente la necessità <strong>di</strong> un approccio informato e criticamente valido.<br />
Nella prima parte del corso saranno analizzati i presupposti per una corretta articolazione<br />
tra il sapere delle due <strong>di</strong>scipline. Nella seconda parte verranno analizzati alcuni<br />
esempi maggiori <strong>di</strong> articolazione tra <strong>di</strong>scorso scientifico e teologico, come ad esempio<br />
la teoria dell’evoluzione, la cosmologia e “l’ipotesi Gaia”, ripercorrendone il cammino<br />
storico ed applicando i criteri analitici ed ermeneutici introdotti nella prima parte.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• Dominique Lambert, Scienza e teologia, figure <strong>di</strong> un <strong>di</strong>alogo, 2006<br />
• Lodovico Galleni, Scienza e teologia, proposte per una sintesi feconda, 1992<br />
• Una antologia <strong>di</strong> testi essenziali sarà <strong>di</strong>stribuita durante il corso.<br />
Introduzione ai libri storici<br />
Prof. Dr. Giorgio Paxima<strong>di</strong><br />
Sigla: ATCP Semestre autunnale Ects: 6<br />
Presentazione: Durante il corso verrà presentata quella sezione della Bibbia conosciuta<br />
con il nome <strong>di</strong> “Libri storici”. In questa classificazione tra<strong>di</strong>zionale trovano posto una<br />
serie <strong>di</strong> opere <strong>di</strong>fferenti. In primo luogo incontreremo il Pentateuco, con i suoi problemi<br />
redazionali e la sua enorme importanza teologica, affronteremo poi il ciclo della storia<br />
deuteronomistica e le opere del cronista. Appartengono inoltre a questa sezione della<br />
Bibbia i libri dei Maccabei, che ci trasportano in un mondo ancora <strong>di</strong>verso. Contenuto<br />
del corso sarà una presentazione organica dei varî gruppi <strong>di</strong> testi e delle singole opere<br />
108
che permetta agli studenti <strong>di</strong> orientarsi in questa letteratura. Alla presentazione dei singoli<br />
libri farà seguito la lettura <strong>di</strong> alcuni testi più significativi, intesa soprattutto a fornire<br />
un minimo <strong>di</strong> basi metodologiche ed una spinta che invogli alla lettura personale.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• J. Blenkinsopp, Il Pentateuco. Introduzione ai primi cinque libri della Bibbia, Brescia<br />
1996.<br />
• G. Von Rad, <strong>Teologia</strong> dell’Antico Testamento, vol. 1: <strong>Teologia</strong> delle tra<strong>di</strong>zioni storiche<br />
<strong>di</strong> Israele, Brescia 1972.<br />
• J. L. Ska, Introduzione alla lettura del Pentateuco, Roma 1998<br />
Lingua ebraica B<br />
Prof. Dr. Giorgio Paxima<strong>di</strong><br />
Sigla: DICO Semestri autunnale/primaverile Ects: 3<br />
Presentazione: Il corso si articola su due semestri: il primo semestre sarà de<strong>di</strong>cato<br />
all’approfon<strong>di</strong>mento del sistema verbale, della sintassi e del lessico della lingua ebraica,<br />
anche attraverso la lettura <strong>di</strong> semplici brani in prosa; nel secondo semestre saranno<br />
proposti testi <strong>di</strong> <strong>di</strong>fficoltà crescente dapprima in prosa ed in seguito anche poetici. Gli<br />
studenti saranno invitati a preparare personalmente la traduzione dei testi ed il commento<br />
grammaticale, cosicché il lavoro <strong>di</strong> lettura e <strong>di</strong> traduzione in classe sia svolto<br />
attivamente da essi sotto la guida del professore. Commenti <strong>di</strong> tipo letterario e teologico<br />
saranno svolti dal professore, senza però perdere <strong>di</strong> vista l’indole essenzialmente<br />
linguistica del corso. Requisito necessario per la frequenza è l’aver già seguito il corso <strong>di</strong><br />
Lingua ebraica A (primo livello) ed aver sostenuto il relativo esame, oppure avere una<br />
sufficiente conoscenza <strong>di</strong> base dell’ebraico biblico.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• Biblia Hebraica Stuttgartensia, Stuttgart 1987 (o posteriori).<br />
• J. Weingreen, A Practical Grammar for Classical Hebrew, Oxford 1959 2 (ed. francese<br />
Hébreu Biblique. Méthode élémentaire, Paris 1984).<br />
• P. Joüon, Grammaire de l’hébreu biblique, Rome 1923 (e ristampe posteriori).<br />
Corsi <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong><br />
Sapienza d’Israele<br />
Prof. Dr. Giorgio Paxima<strong>di</strong><br />
Sigla: ATCP Semestre autunnale Ects: 4.5<br />
Presentazione: Il corso si propone <strong>di</strong> offrire una panoramica della letteratura sapienziale<br />
seguendone lo sviluppo storico e teologico ed evidenziandone l’importanza nel cammino<br />
dell’autocoscienza <strong>di</strong> Israele. In maniera particolare si coglieranno le occasioni per<br />
evidenziare il ruolo <strong>di</strong> “<strong>di</strong>alogo” che tale letteratura ha svolto, permettendo ad Israele la<br />
riflessione sulla propria specificità in rapporto ad altre culture: dal vicino oriente antico<br />
e dalla Mesopotamia, all’Egitto ed alla sfida dell’ellenismo. Sarà anche sottolineata la<br />
funzione che questa letteratura svolge nelle relazioni tra i due Testamenti. Durante il<br />
corso saranno presentate le singole opere in modo generale e <strong>di</strong> ciascuna <strong>di</strong> esse saranno<br />
analizzati alcuni brani più rappresentativi.<br />
109
Bibliografia essenziale:<br />
• Aa. Vv., L’Antico Testamento e le culture del tempo, Roma 1990.<br />
• A. Niccacci, La casa della sapienza, Cinisello Balsamo 1994.<br />
• G. Von Rad, La sapienza in Israele, Genova 1982.<br />
Corsi <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong><br />
Storia delle religioni<br />
Prof. Dr. Stefano Perfetti<br />
Sigla: DICO Semestre primaverile Ects: 3<br />
Presentazione: Introduzione alla storia delle religioni e ai suoi meto<strong>di</strong>. Le nozioni <strong>di</strong><br />
‘religione’, <strong>di</strong> ‘sacro’ e la formazione del concetto <strong>di</strong> ‘Dio’: politeismi, enoteismi e monoteismi.<br />
Teorie sull’origine e le funzioni delle religioni. Le religioni del mondo antico:<br />
analisi <strong>di</strong> testi cosmogonici egiziani, mesopotamici, ebraici. Modelli <strong>di</strong> rapporti tra religioni:<br />
dalla religione etnica alla religione universale; universalismo religioso e <strong>di</strong>alogo religioso.<br />
Pluralità delle religioni, fondamentalismi religiosi, in<strong>di</strong>fferenza religiosa. Il futuro<br />
delle religioni in un mondo interculturale: il <strong>di</strong>alogo come problema e come metodo.<br />
Le <strong>di</strong>namiche dell’ecumenismo. Rapporti tra la storia delle religioni e teologia, filosofia,<br />
linguistica, psicologia e sociologia.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
1. obbligatori:<br />
• G. Filoramo, M. Massenzio, M. Raveri, P. Scarpi, Manuale <strong>di</strong> storia delle religioni,<br />
Roma-Bari 1998 (X ristampa 2004).<br />
• P. Scarpi, Si fa presto a <strong>di</strong>re Dio. Riflessioni per un multiculturalismo religioso, Milano,<br />
2010.<br />
• G. Filoramo, Che cos’è la religione. Temi, meto<strong>di</strong>, problemi, Torino 2004 (cap. V<br />
‘Tipi <strong>di</strong> religioni’; cap. VI ‘Funzioni della religione’; cap. VII La violenza della religione:<br />
pp. 173-319).<br />
2. facoltativi (sulla base <strong>degli</strong> interessi personali):<br />
• A. Fabris, Filosofia e <strong>Teologia</strong>, Brescia 2004, pp. 11-103.<br />
• R. Gibellini, Passione per il Regno. Percorsi del Novecento teologico, in R. Gibellini<br />
(ed.), Prospettive teologiche per il XXI secolo, Brescia 2003, pp. 5-26.<br />
• J. Ratzinger, Fede, verità, tolleranza. Il cristianesimo e le religioni del mondo, Siena<br />
2010 (parte I, cap. 2, pp. 57-114; parte II, cap. 1, pp. 117-143).<br />
Prassi amministrativa canonica<br />
Prof. Dr. Bruno Fabio Pighin<br />
Sigla: DCCO Semestre primaverile Ects: 3<br />
Presentazione: Il corso intende mettere a fuoco le conoscenze sistematiche con l’aiuto<br />
dell’esperienza giuri<strong>di</strong>ca concreta della vita <strong>di</strong> cancelleria delle curie e delle problematiche<br />
legate alla presa <strong>di</strong> decisioni pastorali in materia giuri<strong>di</strong>ca. Tra gli argomenti<br />
da trattare si in<strong>di</strong>cano: il protocollo, la redazione <strong>di</strong> decreti – statuti – regolamenti,<br />
la compilazione <strong>degli</strong> atti giuri<strong>di</strong>ci inerenti la vita consacrata e le associazioni <strong>di</strong> fedeli<br />
presenti nella <strong>di</strong>ocesi, le questioni relative agli enti ecclesiastici, le fondazioni, gli archivi<br />
<strong>di</strong>ocesano e parrocchiale; i decreti relativi all’amministrazione dei beni temporali.<br />
110
Bibliografia essenziale:<br />
• M. Mosconi, Gli atti <strong>di</strong> curia: dall’istanza alla notifica; protocollo e archiviazione,<br />
QDE 23 (2010) pp. 101-125;<br />
• G. Brugnotto, L’ufficio ecclesiastico. Nozione, costituzione, ambiti <strong>di</strong> competenza,<br />
soppressione, QDE 24 (2011) pp. 51-71;<br />
• T. Vanzetto, Provvisione e soppressione dell’ufficio ecclesiastico, QDE 24 (2011)<br />
pp. 72-95;<br />
• G. Trevisan, Gli uffici <strong>di</strong> parroco, amministratore parrocchiale, vicario parrocchiale.<br />
Alcune in<strong>di</strong>cazioni concrete, QDE 24 (2011) pp. 96-108;<br />
• C.M. Redaelli, Figure giuri<strong>di</strong>che per l’attribuzione della cura pastorale in più parrocchie,<br />
QDE 23 (2010) pp. 223-253;<br />
• G.P. Montini, La rimozione del parroco tra legislazione, prassi e giurisprudenza, QDE<br />
24 (2011) pp. 109-125.<br />
• Utilizzazione dei formulari in linea sul sito www.quaderni<strong>di</strong><strong>di</strong>rittoecclesiale.org.<br />
“Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà!” –<br />
Come saremo e come vivremo nell’al-<strong>di</strong>-là? – Un incontro<br />
con le varie teorie storiche sulla “risurrezione della carne”<br />
e sulla nuova vita con un corpo trasformato e glorificato<br />
in un “mondo nuovo”<br />
Prof. Dr. Hans Christian Schmidbaur<br />
Sigla: TDSO Semestre autunnale Ects: 4<br />
Obiettivo corso: Un incontro più profondo con, e una <strong>di</strong>scussione critica dei vari modelli<br />
teologici, filosofici e cosmologici sul compimento finale dell’uomo e del mondo<br />
intero nell’al-<strong>di</strong>-là.<br />
Modalità <strong>di</strong> valutazione: Saranno valutati i lavori (scritti e/o orali) presentati dagli studenti<br />
e la partecipazione attiva alle <strong>di</strong>scussioni sui lavori altrui.<br />
Contenuto del corso: Il cristianesimo promette non solo una vita eterna per l’uomo<br />
nell’al-<strong>di</strong>-là, ma anche un compimento finale universale che trasforma sia l’uomo intero,<br />
sia anche la creazione intera in un “uomo nuovo” ed un “mondo nuovo” che partecipano<br />
<strong>di</strong>rettamente alla vita <strong>di</strong>vina come l’essere assoluto ed incon<strong>di</strong>zionato: “Atten<strong>di</strong>amo<br />
come salvatore il Signore Gesù Cristo che trasformerà il nostro misero corpo per uniformarlo<br />
al suo corpo glorioso, in virtù del potere che ha <strong>di</strong> sottomettere a sé tutto l’universo” (Fil<br />
3,20s) – “Si semina un corpo naturale, ma risorge un corpo spirituale” (1Cor 15,44). – “Poi<br />
vi<strong>di</strong> un cielo nuovo e una terra nuova. Infatti, il cielo e la terra <strong>di</strong> prima erano scomparsi.<br />
… E vi<strong>di</strong> la Città santa, la nuova Gerusalemme, <strong>di</strong>scesa dal cielo da presso Dio. … Ecco la<br />
<strong>di</strong>mora <strong>di</strong> Dio con gli uomini. … Non vi sarà più morte né lutto e grida e dolore. Sì, le cose <strong>di</strong><br />
prima sono passate” (Ap 21). Questi versetti figurati non sollevano solo molte questioni<br />
aperte, ma contengono anche una concezione più ampia <strong>di</strong> Dio, del mondo e dell’uomo<br />
con nuovi potenziali trasformativi che sono sempre stati una sfida affascinante per l’intelletto<br />
umano tra l’antichità fino alle cosmologie moderni.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• J. Ratzinger, Escatologia. Morte e vita eterna, Assisi 2005;<br />
Corsi <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong><br />
111
• J. Moltmann, <strong>Teologia</strong> della Speranza, Brescia 1970;<br />
• I. Sanna, Fede, scienza e fine del mondo. Come sperare oggi, Brescia 2002.<br />
Corsi <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong><br />
Escatologia<br />
Prof. Dr. Hans Christian Schmidbaur<br />
Sigla: TDCP Semestre autunnale Ects: 3<br />
Presentazione: Il para<strong>di</strong>so? L’inferno? Il purgatorio? – Che cosa viene dopo la morte? –<br />
“Dio che ha risuscitato il Signore, risusciterà anche noi con la sua potenza!” (1Cor 6,14).<br />
La promessa <strong>di</strong> una nuova vita eterna è certamente il messaggio più lieto del cristianesimo:<br />
Siamo chiamati a “vedere Dio faccia a faccia!” (1Cor 13,12). Ma la gioia nel cielo<br />
non è il solo fine possibile per tutti. Nell’interpretazione della rivelazione il cristianesimo<br />
ha sviluppato successivamente una “topologia <strong>di</strong>fferenziata” del mondo eterno. Non<br />
esiste solamente un para<strong>di</strong>so per i fedeli e un inferno per infedeli e peccatori, ma anche<br />
un purgatorio per i quasi-fedeli, un “limbo” per i bambini non-battezzati, un primo e un<br />
secondo giu<strong>di</strong>zio, un para<strong>di</strong>so per le anime separate e alla fine del tempo la risurrezione<br />
dei corpi nel regno <strong>di</strong> Dio, la “nuova Gerusalemme”? Nella storia della fede e della<br />
spiritualità questa “topologia” dottrinale ha provocato paura, duri complessi <strong>di</strong> colpa e<br />
sfiducia. Molti teologi liberali hanno negato in conseguenza l’esistenza del <strong>di</strong>avolo e del<br />
giu<strong>di</strong>zio finale proclamando – come Origene – una apocatastasis panthon. In ogni caso<br />
l’escatologia è un elemento integrale della fede cristiana. Visto dalla prospettiva del<br />
Vangelo con la sua promessa <strong>di</strong> una “salvezza anche per i peccatori” il vero contenuto<br />
dell’escatologia cristiana può essere interpretato senza necessità <strong>di</strong> eliminare elementi<br />
integrali della rivelazione.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• Th. Schneider, Nuovo Corso <strong>di</strong> Dogmatica 2, Brescia 1995<br />
• J. Ratzinger, Escatologia. Morte e vita eterna (Piccola dogmatica cattolica n. 9), ed.<br />
Cittadella Assisi 4/2005.<br />
• K. Rahner, Sulla teologia della morte (1966); Geist in Welt (1964), Schriften (1954).<br />
Il “Signore dell’armonia” – Uno sguardo asiatico su Cristo – Parte V<br />
Prof. Dr. Hans Christian Schmidbaur<br />
Sigla: TDCO Semestre autunnale Ects: 3<br />
Obiettivo corso: Non solamente già per lungo tempo il cristianesimo e la Chiesa, ma<br />
oggi anche la teologia cristiana si hanno già trasformati in “fenomeni mon<strong>di</strong>ali”: negli altri<br />
continenti non si ricetta più solamente la nostra “teologia occidentale” e tra<strong>di</strong>zionale!<br />
– Molti teologi cristiani d’In<strong>di</strong>a, della Cina, <strong>di</strong> Giappone, della Corea, delle Filippine o <strong>di</strong><br />
altri paesi d’Asia ci confrontano oggi invece già con i suoi propri modelli genuinamente<br />
asiatici e ciononostante veramente cristiani <strong>di</strong> teologia e cristologia che formano insieme<br />
un arricchimento affascinante ed prezioso sì dell’autocomprensione della nostra<br />
religione, sì anche <strong>di</strong> vari aspetti etici, antropologici e spirituali fino ad oggi inosservati<br />
della persona <strong>di</strong> Gesù Cristo stesso! – Il corso opzionale invita ad un primo incontro con<br />
i vari autori recenti del “cristianesimo asiatico” che mette anche il nostro Signore in una<br />
nuova luce sorprendente!<br />
112
Modalità <strong>di</strong> valutazione: Saranno valutati esami orali o lavori scritti presentati dagli studenti.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• M. Fédou, Regards asiatiques sur le Christ, ed. Desclée, Paris 1998 [Bibl. Univ. <strong>di</strong><br />
<strong>Lugano</strong>]; Concilium. Rivista internazionale <strong>di</strong> teologia 2/2008; Queriniana/Brescia<br />
2008 [Bibl. Univ. <strong>Lugano</strong>];<br />
• H.B. Maitre / P. Humbertclaude / M. Prunier, Présences occidentales au Japon. Du<br />
siècle chrétien à la récouverture du XIX siècle, ed. Cerf Paris 2011;<br />
• R. Gombrich, Il Pensiero del Buddha, Adelphi E<strong>di</strong>zioni 2012.<br />
<strong>Teologia</strong> sacramentaria: Eucaristia<br />
Prof. Dr. Hans Christian Schmidbaur<br />
Sigla: TDCP Semestre autunnale Ects: 3<br />
Presentazione: Nessun sacramento plasma più la Chiesa cattolica, le sue Chiese, la sua<br />
vita liturgica quoti<strong>di</strong>ana, il suo anno liturgico con le sue grande feste, e la sua spiritualità<br />
comune e privata come il sacramento dell’eucaristia: Il “Santissimo Sacramento” sta<br />
sempre al centro della vita della Chiesa! L’eucaristia come “simbolo e segno della convivenza<br />
<strong>di</strong>vino-umana” non è solamente un “cibo” o “nutrimento” quoti<strong>di</strong>ano ed esistenziale,<br />
ma anche l’oggetto principale dell’adorazione e <strong>di</strong> una comunione spirituale<br />
dei nostri fedeli. Questa teologia e spiritualità dell’eucaristia che si formò a partire dai<br />
primi secoli fino ad oggi, ha formato tutta la nostra cultura ecclesiale e la nostra ecclesiologia<br />
cattolica che è fino in fondo una “ecclesiologia sacramentale”, come <strong>di</strong>mostrano<br />
anche tutte le Encicliche tra Mystici Corporis <strong>di</strong> Pio XII (1943) ed Ecclesia de Eucharistia<br />
<strong>di</strong> Giovanni Paolo II. Malgrado il fatto che nel <strong>di</strong>alogo scientifico-teologico <strong>di</strong> oggi non<br />
si fissa più ai vecchi temi della transustanziazione o della presenza reale e continua del<br />
Signore nel Santissimo Sacramento, siamo oggi confrontati con nuovi problemi nella vita<br />
pastorale e spirituale: Con una evaporazione latente della spiritualità eucaristica e con<br />
un nuovo lassismo nei nostri rapporti con l’eucaristia e con gli altri sacramenti nelle nostre<br />
parrocchie, dove si “svende” il sacramento dell’eucaristia, della prima comunione<br />
e della cresima in modo sconsiderato, anche ai non praticanti, come un commerciante<br />
serve la sua “clientela <strong>di</strong> passaggio”! Altri problemi s’incontrano con la domanda della<br />
cosiddetta “intercomunione” nel <strong>di</strong>alogo e nelle prassi dell’ecumenismo!<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• G.L. Müller, Dogmatica cattolica, Milano 1999<br />
• Th. Schneider, Nuovo Corso <strong>di</strong> Dogmatica 2, Brescia 1995<br />
• G. Padoin, “Molti altri segni fece Gesù” (Gv 20,30). Sintesi <strong>di</strong> teologia dei sacramenti,<br />
Bologna 2006<br />
Corsi <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong><br />
Ecclesiologia<br />
Prof. Dr. Hans Christian Schmidbaur<br />
Sigla: TDCP Semestre primaverile Ects: 6<br />
Presentazione: L’ecclesiologia è una <strong>di</strong>sciplina relativamente giovane in confronto alla<br />
tra<strong>di</strong>zione della teologia tramandata da 2000 anni, ma assume oggi una sempre maggio-<br />
113
Corsi <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong><br />
re importanza: Il corso offre un’introduzione nei vari aspetti biblici, storici, sistematici,<br />
carismatici ed ecumenici dell’ecclesiologia che formano la base dell’ecclesiologia del<br />
Concilio Vaticano II e ci aprono anche le porte ad una <strong>di</strong>scussione con i vari modelli<br />
dell’ecclesiologia battesimale e dell’ecumenismo spirituale che plasmano il <strong>di</strong>battito teologico<br />
ed interreligioso d’oggi.<br />
La riflessione crescente durante i 150 anni passati – incominciando con il Concilio Vaticano<br />
I, attraverso i vari movimenti liturgici, l’enciclica Mystici Corporis <strong>di</strong> Pio XII, il<br />
Concilio Vaticano II con la sua nuova Ecclesiologia Comune del decreto Lumen Gentium<br />
e dell’ecumenismo in Unitatis Re<strong>di</strong>ntegratio, e l’enciclica Ecclesia de Eucharistia <strong>di</strong> Giovanni<br />
Paolo II hanno prodotto un grande arricchimento ecclesiologico con molte nuove<br />
prospettive e domande aperte. Con il pontificato <strong>di</strong> Benedetto XVI una nuova epoca <strong>di</strong><br />
un “ecumenismo spirituale” è iniziata e apre nuove prospettive!<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• G.L. Müller, Dogmatica cattolica, Milano 1999, pp. 693-764<br />
• S. Wiedenhofer, La Chiesa. Lineamenti fondamentali <strong>di</strong> ecclesiologia, Milano 1994<br />
• G. Philips, La Chiesa e il suo mistero. Storia, testo e commendo della Lumen Gentium,<br />
Milano 1986<br />
I nuovi modelli <strong>di</strong> <strong>Teologia</strong> trinitaria del XX secolo come riscoperta<br />
della rilevanza antropologica, soteriologia ed ecclesiologica<br />
d’un modello comunitario e relazionale <strong>di</strong> Dio<br />
Prof. Dr. Hans Christian Schmidbaur<br />
Sigla: TDSO Semestre primaverile Ects: 4<br />
Obiettivo corso: Stu<strong>di</strong> profon<strong>di</strong> e critici dei modelli avanguar<strong>di</strong>stici <strong>di</strong> Rahner, Ratzinger,<br />
Courth, Jüngel, Moltmann, Pannenberg, Balthasar, Greshake, Forte e Hilberath con<br />
un’analisi delle loro conseguenze antropologiche, soteriologiche ed ecclesiologiche.<br />
Modalità <strong>di</strong> valutazione: Saranno valutati i lavori (scritti e/o orali) presentati dagli studenti<br />
e la partecipazione attiva alle <strong>di</strong>scussioni sui lavori altrui.<br />
Contenuto del corso: Dopo secoli <strong>di</strong> isolamento in un trattato speciale con un contenuto<br />
solamente speculativo che aveva perso ogni contatto ispirativi con il resto della<br />
teologia, la teologia trinitaria ha visto una grande rinascita nel XX secolo: Molti autori<br />
presentavano nuovi abbozzi con presupposti, punti <strong>di</strong> partenza, meto<strong>di</strong> e scopi <strong>di</strong>versi<br />
che volevano tutti raggiungere una riscoperta della rilevanza straor<strong>di</strong>naria del mistero<br />
della S. Trinità per un’antropologia, soteriologia ed ecclesiologia più viva e adatta alla<br />
natura comunitaria dell’uomo. Partendo dagli autori detti sopra, il seminario non vuole<br />
solamente ricavare le varie opzioni filosofiche e premesse eteronomi <strong>degli</strong> autori detti,<br />
ma anche <strong>di</strong>mostrare la ragionevolezza continua e i valori antropologici ed ecclesiologici<br />
preziosissimi d’una teologia trinitaria <strong>di</strong> nuovo storico-salvifica.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• K. Rahner, Il Dio trino come fondamento originario e trascendente della storia della<br />
salvezza, in: MySal 3, Brescia pp. 401-507;<br />
• E. Jüngel, Dio, mistero del mondo, Brescia 1985;<br />
• B. Forte, Trinità come storia, Cinisello B. 1985.<br />
114
L’Uomo U<strong>di</strong>tore della Parola. Storia e sviluppo della <strong>Teologia</strong><br />
della Parola come fondo e base dei documenti magisteriali<br />
Dei Verbum e Verbum Domini<br />
Prof. Dr. Hans Christian Schmidbaur<br />
Sigla: TDCO Semestre primaverile Ects: 3<br />
Obiettivo corso: La giusta interpretazione della Sacra Scrittura che sec. 1Tess 2,13 è da<br />
accettare come un “Verbo <strong>di</strong> Dio” è oggi confrontata con vari tipi <strong>di</strong> esegesi con metodologie<br />
e premesse <strong>di</strong>versi, ma anche con una <strong>di</strong>screpanza più e più significante tra il<br />
rapporto scientifico con la Bibbia ed il suo ruolo e rango come Sacra Scrittura in fede,<br />
liturgia e spiritualità. Prima del decreto conciliare Dei Verbum che hanno fortemente<br />
ispirati, molti teologi si avevano già messi in cammino per lo sviluppo d’una nuova<br />
<strong>Teologia</strong> della Parola più <strong>di</strong>fferenziata che permetteva non solo un <strong>di</strong>alogo costruttivo<br />
con il pensiero moderno, ma anche con l’ecumenismo e le altre religioni. Il corso non<br />
intende solo un’analisi delle teorie <strong>di</strong> H. Schlier, O. Semmelroth, K. Rahner, J. Ratzinger,<br />
O. Cullmann e D. Concolino, ma una riscoperta della <strong>Teologia</strong> della Parola tra<strong>di</strong>zionale<br />
nell’antichità e nel me<strong>di</strong>oevo.<br />
Modalità <strong>di</strong> valutazione: Saranno valutati esami orali o lavori scritti presentati dagli studenti.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• D. Concolino, <strong>Teologia</strong> della Parola. Per una comprensione sinfonica della Parola <strong>di</strong><br />
Dio alla luce della Costituzione Dogmatica “Dei Verbum”, Soneria Mannelli 2006;<br />
• F. Refoulé/F. Dreyfus, Quale esegesi oggi nella Chiesa? II, Reggio Emilia 1993;<br />
• G. Alberigo, Storia del Concilio Vaticano I-IV, Bologna 1995-2001, qui II,221-230;<br />
IV,473-77.<br />
Corsi <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong><br />
<strong>Teologia</strong> sacramentaria: Or<strong>di</strong>ne, penitenza, unzione <strong>degli</strong> infermi<br />
Prof. Dr. Hans Christian Schmidbaur<br />
Sigla: TDCP Semestre primaverile Ects: 3<br />
Presentazione: I sacramenti non solo esprimono, ma continuano anche in modo efficace<br />
la donazione salvifica e misericor<strong>di</strong>osa del Signore agli uomini bisognosi d’una guarigione<br />
dell’anima e del corpo. Inoltre <strong>di</strong>mostrano anche la sacramentalità della Chiesa stessa<br />
che è – come luogo continuo della sua <strong>di</strong>mora attiva nel mondo – autorizzata ad agire<br />
nel Suo nome. Questo s’esprime specialmente nell’or<strong>di</strong>nazione sacerdotale come autorizzazione<br />
e missione ad un agere in persona Jesu Christi capitis nella Chiesa: come un<br />
or<strong>di</strong>ne sacro <strong>di</strong>mostra una duplice valenza cristologica ed ecclesiologica che ricostruisce<br />
l’uomo nuovo in Cristo (penitenza) e vuole consolare e re-innalzare i malati (unzione<br />
<strong>degli</strong> infermi).<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• G.L. Müller, Dogmatica cattolica, Milano 1999<br />
• G. Padoin, “Molti altri segni fece Gesù” (Gv 20,30). Sintesi <strong>di</strong> teologia dei sacramenti,<br />
Bologna 2006<br />
• E. Castellucci, Il mistero or<strong>di</strong>nato, Brescia 2006<br />
115
Corsi <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong><br />
<strong>Teologia</strong> della Grazia<br />
Prof. Dr. Hans Christian Schmidbaur<br />
Sigla: TDCP Semestre primaverile Ects: 3<br />
Presentazione: “Gratia supponit naturam et perficit eam”: Con questo concetto la teologia<br />
tra<strong>di</strong>zionale descrive il rapporto tra natura e grazia nella storia della salvezza:<br />
L’uomo come persona ed immagine <strong>di</strong> Dio ha un “desiderio naturale ad videndum<br />
Dei” ed è destinato ad unificarsi nella comunità d’amore con il suo creatore, anche se<br />
dopo il peccato originale la natura umana è una natura parzialmente danneggiata. Per<br />
raggiungere la sua destinazione naturale l’uomo ha bisogno <strong>di</strong> una grazia guarente e<br />
santificante. La natura umana come ragione ed amore è destinata alla grazia <strong>di</strong> Dio che<br />
offra una relazione interpersonale. Nella storia del cristianesimo la dottrina della grazia<br />
ha sviluppato molte teorie <strong>di</strong>fferenti: Il conflitto tra Agostino e Pelagio, tra la “via antica”<br />
scolastica e la “via nuova”, tra i riformatori ed il concilio <strong>di</strong> Trento, ed in epoca moderna<br />
con le dottrine <strong>di</strong> Rahner, Teilhard de Char<strong>di</strong>n e Henri de Lubac.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• G.L. Müller, Dogmatica cattolica, Milano 1999<br />
• Th. Schneider, Nuovo Corso <strong>di</strong> Dogmatica 2, Brescia 1995<br />
• G. Padoin, “Molti altri segni fece Gesù” (Gv 20,30). Sintesi <strong>di</strong> teologia dei sacramenti,<br />
Bologna 2006<br />
Fede e ragione<br />
Prof. Dr. Giorgio Sgubbi<br />
Sigla: TFCP Semestre autunnale Ects: 3<br />
Obiettivo corso: Partendo dall’osservazione storica che ragione e fede non hanno mai<br />
potuto ignorarsi, scopo del corso è indagare la reciproca circolarità <strong>di</strong> entrambe, evidenziando<br />
che, come la ragione, in fedeltà a sé stessa, non può escludere la fede, così<br />
come la fede, in fedeltà al proprio <strong>di</strong>namismo, non può non includere la ragione. Alla<br />
fine, sarà proprio l’orizzonte cristocentrico della Rivelazione ad attestarsi come fondamento<br />
sia della <strong>di</strong>stinzione che dell’unità <strong>di</strong> fede e ragione.<br />
Modalità <strong>di</strong> valutazione: Esame orale.<br />
Contenuto del corso: Dopo avere preso in considerazione la proposta <strong>di</strong> alcuni significativi<br />
teologi contemporanei (Barth, Von Balthasar, Ratzinger, Rahner) si osserverà<br />
che ragione e fede non sono grandezze conflittuali, ma quanto più ciascuna riflette<br />
sulla propria natura, tanto più comprenderà la sua “familiarità” con l’altra. De<strong>di</strong>cando<br />
poi particolare attenzione l’enciclica “Fides et ratio”, il corso si propone <strong>di</strong> mostrare il<br />
carattere specificamente cristocentrico della fede cristiana e, proprio a partire da qui,<br />
a considerare come sia la fede stessa a richiedere, motivare e valorizzare al massimo<br />
l’esercizio <strong>di</strong> una ragione aperta, integrale e armonica. Tutto ciò al <strong>di</strong> là <strong>di</strong> ogni riduzione<br />
o contrazione della fede, sia essa <strong>di</strong> natura razionalista o fideista.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• M. Delgado - G. Vergauwen, (Hg.), Glaube und Vernunft - Theologie und Philosophie.<br />
Aspekte ihrer Wechselwirkung in Geschichte und Gegenwart, Fribourg 2003.<br />
116
• F. Bousquet - P. Capelle, (edd.), Dieu et la raison. L’intelligence de la foi parmi les<br />
rationalités contemporaines, Paris 2005.<br />
• F. Ricken, Glauben weil es vernünftig ist, Stuttgart 2007.<br />
• Id., Ethik des Glaubens, Stuttgart-Berlin-Köln 2012.<br />
“Letture balthasariane”. Pagine scelte dalla “Theodramatik”<br />
Prof. Dr. Giorgio Sgubbi<br />
Sigla: TDSO Semestre autunnale Ects: 4<br />
N.B.: La partecipazione al seminario esige buona conoscenza della lingua tedesca.<br />
Obiettivo corso: La lettura e l’approfon<strong>di</strong>mento della riflessione <strong>di</strong> uno dei massimi<br />
teologi cattolici del XX secolo fa parte dell’offerta formativa della Facoltà Teologica <strong>di</strong><br />
<strong>Lugano</strong>. Il seminario si propone <strong>di</strong> accostare, comprendere e <strong>di</strong>scutere i punti caratteristici<br />
della cristologia balthasariana, così come sono stati fissati e or<strong>di</strong>nati nei “figli più<br />
cari”, definizione data dallo stesso Von Balthasar ai volumi della Theodramatik.<br />
Modalità <strong>di</strong> valutazione: Ogni partecipante dovrà relazionare in sede seminariale su un<br />
testo da lui scelto (fra quelli in<strong>di</strong>cati in bibliografia), offrendo ai partecipanti una traccia<br />
scritta della sua relazione.<br />
Contenuto del corso: Lo sviluppo della ricerca balthasariana evidenzia e conferma che<br />
origine, anima e scopo dell’attività del teologo svizzero fu la determinazione teologica<br />
della “singolarità” <strong>di</strong> Gesù Cristo, e dunque la cristologia quale chiave <strong>di</strong> volta della teologia<br />
cristiana come tale. Al tempo stesso, sarà evidenziato come la cristologia contiene<br />
e fonda l’antropologia teologica, la mariologia e l’escatologia.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• H.U. von Balthasar, Theodramatik I. Prolegomena, Einsiedeln 2009.<br />
• Id., Theodramatik II. Die Personen des Spiels. Teil I: Der Mensch in Gott, Einsiedeln 1976.<br />
• Id., Theodramatik. IV. Das Endspiel, Einsiedeln 1983.<br />
Corsi <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong><br />
<strong>Teologia</strong> naturale<br />
Prof. Dr. Giorgio Sgubbi<br />
Sigla: FFCP Semestre autunnale Ects: 3<br />
Obiettivo corso: Il corso si propone <strong>di</strong> mostrare come l’intelligenza dell’essere percepito<br />
nell’esistente trova nell’affermazione dell’Assoluto il suo esito naturale e necessario,<br />
unitamente alla consapevolezza che una “<strong>di</strong>mostrazione <strong>di</strong> Dio” non riduce Dio a<br />
dominio della ragione umana, ma piuttosto rivela quest’ultima come orizzonte della<br />
trascendenza e imposse<strong>di</strong>bilità del Mistero.<br />
Modalità <strong>di</strong> valutazione: Esame orale.<br />
Contenuto del corso: Accogliendo l’obiezione <strong>di</strong> Heidegger, secondo il quale un Dio<br />
“<strong>di</strong>mostrato” non è già più un “<strong>di</strong>o <strong>di</strong>vino” e dopo aver chiarito come va intesa una<br />
“prova <strong>di</strong> Dio”, saranno esaminate le posizioni <strong>di</strong> Anselmo, Tommaso e Kant quali passaggi<br />
significativi e obbligati della teologia naturale. Muovendo poi dall’esperienza ontologica,<br />
si <strong>di</strong>mostrerà che non è possibile affermare l’ente senza concludere all’Essere. La<br />
<strong>di</strong>mostrazione della necessità <strong>di</strong> Dio agli effetti dell’esistente coincide con la <strong>di</strong>mostrazione<br />
della libertà della creazione: Dio è necessario al mondo, ma non il mondo a Dio.<br />
117
Corsi <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong><br />
Dopo avere posto la questione se e come il linguaggio possa esprimere la Trascendenza,<br />
l’itinerario si concluderà con una riflessione sulla personalità, onnipotenza e onniscienza<br />
<strong>di</strong> Dio.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• Barry Miller, From existence to God. A Contemporary Philosophical Argument, London<br />
1992.<br />
• S. Vanni Rovighi, La filosofia e il problema <strong>di</strong> Dio, <strong>Lugano</strong> 2005.<br />
• A. Kreiner, Das wahre Antlitz Gottes oder was wir meinen, wenn wir Gott sagen,<br />
Freiburg i. B. 2006.<br />
Propedeuticità: L’accesso al corso è per gli studenti che hanno già svolto i corsi <strong>di</strong> filosofia<br />
della conoscenza e ontologia.<br />
Il mistero del Dio rivelato<br />
Prof. Dr. Giorgio Sgubbi<br />
Sigla: TDCP Semestre primaverile Ects: 6<br />
Obiettivo corso: Il Corso si propone come introduzione all’intelligenza teologica dell’affermazione<br />
neotestamentaria: “Dio è amore” (1Gv 4, 16), evidenziandone le implicazioni<br />
filosofiche, antropologiche ed ecclesiologiche.<br />
Modalità <strong>di</strong> valutazione: Esame orale.<br />
Contenuto del corso: Dopo una previa determinazione teologica dei termini “mistero”<br />
e “rivelazione” e dopo avere compreso l’Antico Testamento come testimonianza <strong>di</strong> una<br />
“prossimità trascendente e santificante” <strong>di</strong> Dio (Von Rad), si ricnoscerà nella cristologia<br />
del Nuovo Testamento il punto d’avvio della dottrina trinitaria; la “Triunità” non è infatti<br />
un rompicapo teologico o un “mysterium logicum”, quanto piuttosto un “mysterium<br />
salvificum”, la cui contemplazione coincide con la compiuta e matura riflessione cristologica<br />
e pneumatologica. Dopo avere esaminato alcuni fondamentali modelli teologici<br />
classici, il corso si occuperà del rapporto fra Trinità immanente e Trinità economica,<br />
per concludere con una sintesi sistematica finalizzata a mostrare “la dottrina trinitaria<br />
come para<strong>di</strong>gma, grammatica e somma della teologia” (W. Kasper).<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• W. Kasper, Il Dio <strong>di</strong> Gesù Cristo, Brescia 1984.<br />
• G. O’Collins, The Tripersonal God. Understan<strong>di</strong>ng and Interpreting the Trinity, New<br />
York 1999.<br />
• S. Grenz, Re<strong>di</strong>scovering the Triune God. The Trinity in Contemporary Theology, Minneapolis<br />
2004.<br />
• G. Emery, La Trinité. Introduction à la doctrine catholique sur Dieu Trinité, Paris<br />
2009.<br />
<strong>Teologia</strong> fondamentale - la Rivelazione<br />
Prof. Dr. Giorgio Sgubbi<br />
Sigla: TFCP Semestre primaverile Ects: 6<br />
Obiettivo corso: Il corso <strong>di</strong> teologia fondamentale ha come scopo mostrare che la fede,<br />
118
pur essendo dono <strong>di</strong> grazia che scaturisce dalla Rivelazione, esige e coinvolge l’esercizio<br />
della ragione al fine <strong>di</strong> evitare l’autoreferenzialità e l’autofondazione.<br />
Modalità <strong>di</strong> valutazione: Esame orale.<br />
Contenuto del corso: La “teologia fondamentale” è la <strong>di</strong>sciplina che indaga le con<strong>di</strong>zioni<br />
<strong>di</strong> possibilità della rivelazione <strong>di</strong> Dio e della sua accoglienza, libera e responsabile,<br />
da parte dell’uomo. Riconoscere all’autocomunicazione <strong>di</strong> Dio il carattere <strong>di</strong> mistero,<br />
gratuità e libertà, non significa affatto <strong>di</strong>chiarare la rivelazione infondata o assurda, ma,<br />
al contrario, ad impegnare ancora <strong>di</strong> più la ragione a riconoscerne il carattere <strong>di</strong> verità.<br />
Appartiene alla logica dell’amore che insieme al dono, in questo caso l’iniziativa <strong>di</strong> Dio,<br />
corrisponda una reale capacità <strong>di</strong> accoglienza da parte del destinatario. La “logica dell’amore”<br />
costituirà anche la struttura del corso: alla riflessione sulla natura e <strong>di</strong>namica della<br />
Rivelazione <strong>di</strong> Dio, seguirà e corrisponderà l’analisi della fede, cioè della risposta libera,<br />
motivata e responsabile dell’uomo. La riflessione conclusiva sui “motivi <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>bilità<br />
contribuirà a mostrare la profonda coerenza e l’affascinante bellezza della fede.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• W. Kern - H.J. Pottmeyer - M. Seckler (Edd.), Trattato sulla Rivelazione, Brescia<br />
1990.<br />
• S. Pié-Ninot, La teologia fondamentale, Brescia 2002.<br />
• M. Knapp, Die Vernunft des Glaubens. Einführung in <strong>di</strong>e Fundamentaltheologie, Freiburg<br />
i.B. 2009.<br />
• W. Klausnitzer, Glaube und Wissen. Lehrbuch der Fundamentaltheologie für Stu<strong>di</strong>erende<br />
und Religionslehrer, Regensburg 2011.<br />
Corsi <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong><br />
Amore ed emozioni nella filosofia moderna e contemporanea<br />
Prof. Dr. Gianfranco Soldati<br />
Sigla: SICO Semestre autunnale Ects: 2<br />
Obiettivo corso: Il corso offre un’introduzione generale alla filosofia delle emozioni<br />
nell’epoca moderna e contemporanea.<br />
Modalità <strong>di</strong> valutazione: Da definire.<br />
Contenuto del corso: La filosofia delle emozioni s’articola attorno a tre <strong>di</strong>mensioni principali.<br />
La prima <strong>di</strong>mesione concerne l’oggetto intenzionale delle emozioni. La seconda<br />
concerne il loro grado <strong>di</strong> razionalità. La terza il loro carattere fenomenico. Ci si chiede<br />
dunque se le emozioni portano su <strong>degli</strong> oggetti specifici, se le emozioni posso essere<br />
corrette o sbagliate, e se le sensazioni legate alle emozioni sono riducibili alle percezione<br />
delle mo<strong>di</strong>ficazioni corporee che le accompagnano. Utilizzeremo queste <strong>di</strong>mensioni<br />
nello <strong>stu<strong>di</strong></strong>o <strong>di</strong> alcuni autori delle epoca moderna e contemporanea.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• Deonna, Julien A., and Fabrice Teroni, 2012. The Emotions: A Philosophical Introduction,<br />
London<br />
• Calabi, Clotilde, 1996. Passioni e ragioni. Un itinerario nella filosofia della psicologia,<br />
Milano.<br />
• Lyons, William, 1980. Emotion, Cambridge.<br />
119
Corsi <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong><br />
Matrimoni misti con cristiani <strong>di</strong> altre confessioni<br />
Dr. Theol. Dr. iur. Can. Darius Bamuene Solo<br />
Sigla: DCCO Semestre primaverile Ects: 1.5<br />
Presentazione: I cann. 1124-1129 CIC1983 trattano <strong>di</strong> questi tipi <strong>di</strong> matrimonio. Un’analisi<br />
dettagliata <strong>di</strong> questi canoni con un’attenzione particolare all’importanza del consenso<br />
come stipulata nel <strong>di</strong>ritto canonico e della concezione del matrimonio nelle altre<br />
confessioni. Si articolerà <strong>di</strong> più sui problemi pastorali in relazione con la concessione<br />
della licenza.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• Aa.Vv., Diritto matrimoniale canonico, Vol. III, Città del Vaticano 2005, pp. 287-320;<br />
• V. De Paolis, I matrimoni misti, in Matrimonio e <strong>di</strong>sciplina ecclesiastica. XXI incontro<br />
<strong>di</strong> <strong>stu<strong>di</strong></strong>o, Milano 1996, pp. 141-168.<br />
Funzione <strong>di</strong> insegnare e santificare: CIC e CCEO comparati<br />
Lic. theol.; Lic. iur. can. Andrea Stabellini<br />
Responsabile scientifico: Prof. Dr. Libero Gerosa<br />
Sigla: DCCO Semestre autunnale Ects: 3<br />
Presentazione: La Parola <strong>di</strong> Dio ed il Sacramento sono, con il Carisma, elementi strutturanti<br />
e costitutivi della Communio Ecclesiae e, insieme, realtà sorgive del <strong>di</strong>ritto della<br />
Chiesa. L’or<strong>di</strong>namento giuri<strong>di</strong>co della Chiesa cattolica ha la sua pagina principale nelle<br />
co<strong>di</strong>ficazioni del CIC 1983 e del CCEO del 1990. L’unità non livella in uniformità la<br />
ricchezza della realtà ecclesiale che si esprime, anche canonicamente, in una legittima<br />
<strong>di</strong>fferenza e molteplicità <strong>di</strong> accenti. Il corso intende presentare questa unità e <strong>di</strong>fferenza<br />
nelle relazioni giuri<strong>di</strong>che che sorgono dai due elementi costitutivi della Parola e del Sacramento,<br />
esponendo alcuni temi relativi alla funzione <strong>di</strong> insegnare e <strong>di</strong> santificare della<br />
Chiesa così come appaiono nelle due co<strong>di</strong>ficazioni, in una sinossi che trova unità nella<br />
ecclesiologia del Concilio Vaticano II alla quale, secondo OT 16, sempre l’esposizione<br />
delle norme canoniche deve riferirsi.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• Co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> Diritto Canonico e Leggi complementari Commentato, e<strong>di</strong>zione italiana <strong>di</strong>retta<br />
da J.I. Arrieta, Roma, ultima e<strong>di</strong>zione;<br />
• L. Chiappetta, Il Co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> Diritto Canonico. Commento Giuri<strong>di</strong>co e Pastorale 2, F.<br />
Catozzella-A.Catta-C.Izzi-L.Sabbarese (a cura <strong>di</strong>), Bologna 2011;<br />
• D. Salachas, Il Magistero e l’Evangelizzazione dei popoli nei Co<strong>di</strong>ci latino e orientale.<br />
Stu<strong>di</strong>o teologico-giuri<strong>di</strong>co comparativo, Bologna 2001;<br />
• D. Salachas, <strong>Teologia</strong> e <strong>di</strong>sciplina dei sacramenti nei Co<strong>di</strong>ci latino e orientale. Stu<strong>di</strong>o<br />
teologico-giuri<strong>di</strong>co comparativo, Bologna 2005.<br />
120
La funzione <strong>di</strong> insegnare della Chiesa I<br />
Lic. theol.; Lic. iur. can. Andrea Stabellini<br />
Responsabile scientifico: Prof. Dr. Libero Gerosa<br />
Sigla: DCCO Semestre primaverile Ects: 1.5<br />
Presentazione: La Parola <strong>di</strong> Dio è, con il Sacramento ed il Carisma, elemento strutturante<br />
e costitutivo della Communio Ecclesiae e, insieme, realtà sorgiva del <strong>di</strong>ritto della<br />
Chiesa. Il corso intende analizzare la centralità della Parola <strong>di</strong> Dio nell’or<strong>di</strong>namento<br />
canonico, evidenziando le principali implicazioni giuri<strong>di</strong>che delle relazioni intraecclesiali<br />
che sorgono da questa realtà. Da una presentazione dei fondamenti teologici sottesi<br />
alla normativa del Libro III CIC De Ecclesiae Munere Docen<strong>di</strong>, si passerà ad illustrare la<br />
sistematica giuri<strong>di</strong>ca dello stesso Libro soffermandosi sui canoni introduttivi e sul Titolo<br />
I, relativo al ministero della Parola <strong>di</strong>vina nelle sue due gran<strong>di</strong> esplicitazioni: Pre<strong>di</strong>cazione<br />
e Catechesi.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• Co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> Diritto Canonico e Leggi complementari Commentato, e<strong>di</strong>zione italiana <strong>di</strong>retta<br />
da J.I. Arrieta, Roma, ultima e<strong>di</strong>zione;<br />
• L. Chiappetta, Il Co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> Diritto Canonico. Commento Giuri<strong>di</strong>co e Pastorale 2, F.<br />
Catozzella-A. Catta-C. Izzi-L. Sabbarese (a cura <strong>di</strong>), Bologna 2011;<br />
• P. Bux, Il Magistero della Chiesa nel Diritto Canonico, Roma 2002;<br />
• D. Cito – F. Puig, Parola <strong>di</strong> Dio e Missione della Chiesa. Aspetti giuri<strong>di</strong>ci, Milano<br />
2009;<br />
• B. Lima, Il Munus Docen<strong>di</strong> della Chiesa nei suoi fondamenti giuri<strong>di</strong>co-teologici. Commento<br />
al Libro III del Co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> Diritto Canonico, To<strong>di</strong> (PG) 2009;<br />
• A.G. Urru, La funzione <strong>di</strong> Insegnare della Chiesa. Nella legislazione attuale, Roma<br />
2001.<br />
Corsi <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong><br />
La funzione <strong>di</strong> insegnare della Chiesa II<br />
Lic. theol.; Lic. iur. can. Andrea Stabellini<br />
Responsabile scientifico: Prof. Dr. Libero Gerosa<br />
Sigla: DCCO Semestre primaverile Ects: 1.5<br />
Presentazione: La Parola <strong>di</strong> Dio è, con il Sacramento ed il Carisma, elemento strutturante<br />
e costitutivo della Communio Ecclesiae e, insieme, realtà sorgiva del <strong>di</strong>ritto della<br />
Chiesa. Il corso, proseguendo l’esposizione del modulo Funzione <strong>di</strong> Insegnare della<br />
Chiesa 1, affronta le norme co<strong>di</strong>ciali del Libro III, esponendo la normativa circa ‘l’azione<br />
missionaria della Chiesa’ (Titolo II), ‘l’Educazione Cattolica’ (Titolo III), ‘Gli strumenti <strong>di</strong><br />
comunicazione sociale e in specie i libri’ (Titolo IV) e ‘la Professione <strong>di</strong> Fede’ (Titolo V).<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• Co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> Diritto Canonico e Leggi complementari Commentato, e<strong>di</strong>zione italiana <strong>di</strong>retta<br />
da J.I. Arrieta, Roma, ultima e<strong>di</strong>zione;<br />
• L. Chiappetta, Il Co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> Diritto Canonico. Commento Giuri<strong>di</strong>co e Pastorale 2, F.<br />
Catozzella-A.Catta-C.Izzi-L.Sabbarese (a cura <strong>di</strong>), Bologna 2011;<br />
• D. Cito – F. Puig, Parola <strong>di</strong> Dio e Missione della Chiesa. Aspetti giuri<strong>di</strong>ci, Milano<br />
2009;<br />
121
Corsi <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong><br />
• J.P. Doss (a cura <strong>di</strong> ), Parola <strong>di</strong> Dio e Legislazione Ecclesiastica, Roma 2008;<br />
• C.J. Errazuriz M., Il “Munus Docen<strong>di</strong> Ecclesiae”: <strong>di</strong>ritti e doveri dei fedeli, Milano<br />
1991;<br />
• J.H. Espinoza, “Eccomi, manda me!”. Introduzione al Libro III del Co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> Diritto<br />
Canonico, Roma 2011;<br />
• B. Lima, Il Munus Docen<strong>di</strong> della Chiesa nei suoi fondamenti giuri<strong>di</strong>co-teologici. Commento<br />
al Libro III del Co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> Diritto Canonico, To<strong>di</strong> (PG) 2009;<br />
• A.G. Urru, La funzione <strong>di</strong> Insegnare della Chiesa. Nella legislazione attuale, Roma<br />
2001.<br />
Corso monografico <strong>di</strong> storia della filosofia moderna:<br />
Il Saggio sull’intelletto umano <strong>di</strong> John Locke<br />
Dott. Samuele Francesco Ta<strong>di</strong>ni<br />
Responsabile scientifico: Prof. Dr. Markus Krienke<br />
Sigla: FFCP Semestre autunnale Ects: 1.5<br />
Obiettivo corso: Analisi e commento <strong>di</strong> uno dei testi fondamentali della storia dell’empirismo<br />
inglese.<br />
Modalità <strong>di</strong> valutazione: Esame orale (20 minuti).<br />
Contenuto del corso: Il corso è rivolto principalmente a studenti desiderosi <strong>di</strong> conoscere<br />
i contenuti e la portata del Saggio lockiano attraverso una lettura attenta <strong>di</strong> brani<br />
scelti supportati da un puntuale commento e da <strong>di</strong>scussioni proposte nel contesto dello<br />
svolgimento del corso medesimo. Durante il corso verrà esposta la filosofia <strong>di</strong> Locke<br />
con particolare riguardo alle problematiche gnoseologiche del Saggio, per cui non si<br />
richiede una previa conoscenza del pensiero del filosofo inglese.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• Locke, John, Saggio sull’intelletto umano, a cura <strong>di</strong> M. G. D’Amico e V. Cicero,<br />
(testo inglese a fronte), Milano 2007.<br />
• Sina, Mario, Introduzione a Locke, Roma-Bari 2006.<br />
Altre in<strong>di</strong>cazioni bibliografiche verranno fornite durante il corso.<br />
Propedeuticità: Corsi <strong>di</strong> storia della filosofia antica e me<strong>di</strong>evale.<br />
Latinità I e II<br />
Prof. Dott. Antonio Tombolini<br />
Sigla: DICO Semestri autunnale/primaverile Ects: 3<br />
Obiettivo corso: Scopo precipuo del corso non è l’insegnamento <strong>di</strong> base della lingua<br />
latina, ma l’esposizione dei princìpi compositivi applicati a una determinata lingua speciale.<br />
Lo <strong>stu<strong>di</strong></strong>o proposto, dunque, presuppone una conoscenza fondamentale della<br />
morfologia e sintassi latine, insieme a una familiarità almeno minima con il mondo del<br />
<strong>di</strong>ritto canonico.<br />
Modalità <strong>di</strong> valutazione: Esame orale.<br />
Contenuto del corso: Parte I: Elementi fondamentali della grammatica e della sintassi<br />
latina. Iniziazione al vocabolario del Co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> Diritto Canonico.<br />
Parte II: Approfon<strong>di</strong>mento della grammatica e della sintassi latina. Iniziazione alla tradu-<br />
122
zione in lingue volgari delle sentenze e dei decreti del Supremo Tribunale della<br />
Segnatura Apostolica, delle sentenze della Rota Romana e <strong>di</strong> altri documenti della Curia<br />
Romana.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• M. Agosto, Latino per il <strong>di</strong>ritto canonico. Avvio allo <strong>stu<strong>di</strong></strong>o della microlingua, <strong>Lugano</strong><br />
2011.<br />
L’ulteriore bibliografia verrà concordata con gli studenti all’inizio delle lezioni.<br />
Lingua italiana<br />
Prof. Dott. Antonio Tombolini<br />
Sigla: DICP Semestri autunnale/primaverile Ects: -<br />
Obiettivo corso: Il corso si prefigge <strong>di</strong> condurre lo studente a una padronanza dei più<br />
semplici ed elementari aspetti della lingua italiana; in base agli obiettivi <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>mento<br />
in<strong>di</strong>cati dal Livello Waystage del Consiglio d’Europa, lo studente deve essere in<br />
possesso delle abilità necessarie a sod<strong>di</strong>sfare essenziali bisogni comunicativi in ricorrenti<br />
situazioni quoti<strong>di</strong>ane.<br />
Modalità <strong>di</strong> valutazione: Esame scritto (sud<strong>di</strong>viso in 4 test dell’Università per stranieri<br />
<strong>di</strong> Perugia).<br />
Contenuto del corso: Nel semestre autunnale saranno considerati gli aspetti morfologici,<br />
in quello primaverile si passerà allo <strong>stu<strong>di</strong></strong>o dei primi elementi <strong>di</strong> sintassi; oltre agli<br />
esercizi scritti, si riserverà anche uno spazio de<strong>di</strong>cato alla conversazione e si lavorerà<br />
sulla comprensione <strong>di</strong> testi scritti (soprattutto <strong>di</strong> carattere filosofico e teologico).<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• B. Storni, Vademecum italiano, Romano/Sabe, Kilchberg-Zürich.<br />
L’ulteriore bibliografia verrà concordata con gli studenti all’inizio delle lezioni.<br />
Corsi <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong><br />
Lingua latina<br />
Prof. Dott. Antonio Tombolini<br />
Sigla: DICP Semestri autunnale/primaverile/autunnale Ects: -<br />
Obiettivo corso: Il corso mira a fornire agli studenti le conoscenze linguistiche necessarie<br />
per la comprensione <strong>di</strong> testi latini relativamente semplici e per un adeguato accesso<br />
alla terminologia filosofica.<br />
Modalità <strong>di</strong> valutazione: Esame orale.<br />
Contenuto del corso: Nei primi due semestri si affronteranno lo <strong>stu<strong>di</strong></strong>o della morfologia<br />
del nome (le cinque declinazioni; gli aggettivi della prima e seconda classe; l’uso dei<br />
principali complementi), del verbo (le quattro coniugazioni attive e passive) e dei primi<br />
elementi <strong>di</strong> sintassi del periodo. Nel corso dell’anno accademico si terranno alcune<br />
verifiche del lavoro svolto, che confluiranno in una valutazione conclusiva utile anzitutto<br />
agli studenti per avere un’idea del livello <strong>di</strong> preparazione raggiunto.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
Il manuale sarà in<strong>di</strong>cato all’inizio del corso, previa verifica dei prerequisiti <strong>degli</strong> studenti<br />
iscritti.<br />
123
Corsi <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong><br />
Introduzione alla filosofia<br />
Prof.ssa Dr.ssa Lucia Urbani Ulivi in collaborazione con Prof. Dr. Giovanni Ventimiglia<br />
Sigla: FFCP Semestre autunnale Ects: 1.5+1.5<br />
Obiettivo corso: Il corso intende rendere chiari e <strong>di</strong>sponibili temi e problemi fondamentali<br />
del pensiero filosofico, fornire un chiarimento lessicale e concettuale dei più importanti<br />
termini utilizzati nella letteratura filosofica, mantenere un riferimento costante ad<br />
autori fondamentali classici e all’orizzonte contemporaneo.<br />
Modalità <strong>di</strong> valutazione: Esame orale.<br />
Contenuto del corso: La filosofia in relazione alle scienze. La teoria della conoscenza:<br />
il rapporto soggetto-oggetto; l’intenzionalità. Lo statuto dell’umano: l’irruzione dell’inconscio;<br />
le neuroscienze; l’uomo come sistema complesso; la libertà. Fondamenti metafisici<br />
dell’etica; etica prescrittiva e normativa.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• Lucia Urbani Ulivi, Introduzione alla filosofia, <strong>Lugano</strong> 2005.<br />
L’uomo alla luce del mistero del Dio unitrino<br />
Prof.ssa Dr.ssa Agnese Varsalona<br />
Sigla: DICP Semestre autunnale Ects: 3<br />
Obiettivo corso: L’approfon<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> alcune questioni attuali <strong>di</strong> antropologia teologica.<br />
Modalità <strong>di</strong> valutazione: Esame orale.<br />
Contenuto del corso: Le implicazioni derivanti dalla fede nel Dio unitrino sono ancora<br />
ampiamente da esplorare nella loro rilevanza per la comprensione dell’uomo e della sua<br />
ricerca <strong>di</strong> senso. A partire da questa consapevolezza, metteremo a tema la relazione tra<br />
cristologia e antropologia (cfr. GS 22), il concetto teologico <strong>di</strong> persona e la sua struttura<br />
<strong>di</strong>alogica, come anche la rilevanza che tale concezione ha per la convivenza nelle società<br />
multiculturali e per il vissuto umano in generale.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• L.F. Ladaria, Antropologia teologica, Casale Monferrato 1995.<br />
• G. Greshake, Il Dio unitrino, Brescia 2000.<br />
• W. Kasper, “Cristologia e antropologia”, in <strong>Teologia</strong> e Chiesa, Brescia 1989, 202-<br />
225.<br />
Antropologia filosofica<br />
Prof. Dr. Giovanni Ventimiglia e N.N. (assistente)<br />
Sigla: FFCP Semestre autunnale Ects: 4.5<br />
Presentazione: Dopo un excursus storico-filosofico, il corso si propone <strong>di</strong> introdurre<br />
alla comprensione <strong>di</strong> alcuni problemi classici della filosofia dell’uomo: l’uomo è solo<br />
corpo? Il corpo è un accidente dell’io? Si compie il male perché non si conosce il bene?<br />
L’uomo è libero?<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• Dispensa del corso<br />
• Platone, Fedro, a cura <strong>di</strong> G. Reale, Milano 2000.<br />
124
• Tommaso d’Aquino, La Somma Teologica, vol. 6: L’uomo, pensiero e origini, Bologna<br />
1985 (parti in<strong>di</strong>cate a lezione dal docente)<br />
Corso monografico <strong>di</strong> Antropologia filosofica: il soggetto umano<br />
nello spazio virtuale<br />
Prof. Dr. Giovanni Ventimiglia e N.N. (assistente)<br />
Sigla: FFCP Semestre autunnale Ects: 1.5<br />
Presentazione: Il corso affronterà alcune concezioni dell’uomo elaborate in seguito alla<br />
cosiddetta rivoluzione <strong>di</strong>gitale: i nuovi strumenti della comunicazione rappresentano un<br />
processo <strong>di</strong> “de-corporeizzazione” dell’uomo oppure <strong>di</strong> “potenziamento” della corporeità<br />
umana? La esperienza del mondo e <strong>degli</strong> altri me<strong>di</strong>ata da un nuovo mezzo <strong>di</strong> comunicazione<br />
è una esperienza “potenziale” rispetto alla comunicazione faccia a faccia,<br />
oppure è una esperienza “potenziata”?<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• G. Ventimiglia, Il soggetto umano nello spazio virtuale, in Nuove biotecnologie, bio<strong>di</strong>ritto<br />
e trasformazioni della soggettività, a cura <strong>di</strong> L. Palazzani, Roma 2008, pp.<br />
181-194.<br />
• G. Ventimiglia, Il virtuale fra gloria e vanagloria, in C. Vigna, Etica, politica e vita spettacolare.<br />
Atti del Convegno del Centro <strong>di</strong> Etica generale e applicata, Pavia, Almo<br />
Collegio Borromeo, 16-17 settembre 2011 (<strong>di</strong> prossima pubblicazione).<br />
Corsi <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong><br />
Introduzione alla filosofia<br />
Prof. Dr. Giovanni Ventimiglia in collaborazione con Prof.ssa Dr.ssa Lucia Urbani Ulivi<br />
Sigla: FFCP Semestre autunnale Ects: 1.5+1.5<br />
Presentazione: Il corso intende fornire agli studenti gli strumenti concettuali fondamentali<br />
per orientarsi nella comprensione dei più significativi problemi filosofici. Si partirà<br />
dalla questione dei rapporti tra filosofia, scienze e teologia. Si affronteranno i temi<br />
classici <strong>di</strong> teoria della conoscenza (soggetto e oggetto, intenzionalità, gli universali). Si<br />
rifletterà sullo statuto dell’umano nella sua unità. Si in<strong>di</strong>cheranno i fondamenti metafisici<br />
dell’etica e verrà posta la questione della libertà. Seguirà una introduzione ai problemi<br />
fondamentali dell’ontologia (ente, essenza ed esistenza; sostanza ed accidenti) e a quelli<br />
della metafisica (prove dell’esistenza <strong>di</strong> Dio). Infine si presenteranno gli strumenti fondamentali<br />
della filosofia: concetti e <strong>di</strong>mostrazioni.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• Lucia Urbani Ulivi, Introduzione alla filosofia, <strong>Lugano</strong> 2005.<br />
• Aristotele, Metafisica, IV libro, e<strong>di</strong>zioni a piacere, purché integrali.<br />
Ontologia<br />
Prof. Dr. Giovanni Ventimiglia e N.N. (assistente)<br />
Sigla: FFCP Semestre primaverile Ects: 4.5<br />
Presentazione: Il corso si propone <strong>di</strong> introdurre alla comprensione <strong>di</strong> alcuni problemi<br />
fondamentali dell’ontologia sia classica (ontologia aristotelico-tomistica) che contem-<br />
125
Corsi <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong><br />
poranea (ontologia analitica): l’ente, composto <strong>di</strong> esistenza (atto d’essere) ed essenza.<br />
Problemi legati all’esistenza (o problema del che cosa esiste?). Problemi legati all’essenza<br />
(o problemi dell’identità). Le categorie. Il principio <strong>di</strong> non contrad<strong>di</strong>zione. L’analogia.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• G. Ventimiglia, Ente, essenza, esistenza: prime nozioni <strong>di</strong> ontologia in prospettiva<br />
analitico-tomistica, <strong>Lugano</strong> 2012.<br />
• Aristotele, Metafisica, a cura <strong>di</strong> G. Reale, Milano 2000 (le parti in<strong>di</strong>cate a lezione<br />
dal docente).<br />
• Dispensa del corso (a cura <strong>di</strong> L. Bottani e G. Ventimiglia).<br />
Propedeuticità: Storia della filosofia antica e me<strong>di</strong>evale. Eventuali eccezioni saranno valutate<br />
dal docente.<br />
Corso monografico <strong>di</strong> Ontologia: Dio è l’Essere?<br />
Prof. Dr. Giovanni Ventimiglia e N.N. (assistente)<br />
Sigla: FFCP Semestre primaverile Ects: 1.5<br />
Presentazione: Il corso si propone anzitutto <strong>di</strong> introdurre gli studenti alla comprensione<br />
delle critiche <strong>di</strong> Aristotele alle cosiddette “dottrine non scritte <strong>di</strong> Platone”. Si propone<br />
inoltre, a partire da quelle critiche, <strong>di</strong> analizzare il <strong>di</strong>battito contemporaneo intorno alla<br />
nozione <strong>di</strong> “Esse ipsum subsistens”.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• S. Brock, L’ipsum esse è platonismo? in S. Brock (a cura <strong>di</strong>), Tommaso d’Aquino e<br />
l’oggetto della metafisica, Roma 2004, pp. 193-220;<br />
• E. Berti, Il “tomismo analitico” e il <strong>di</strong>battito sull’Esse ipsum, in “Giornale <strong>di</strong> Metafisica”,<br />
31, 2009, pp. 5-24;<br />
• E. Berti, La critica dei filosofi analitici alla concezione tomistica dell’essere, “Rivista <strong>di</strong><br />
Estetica”, 49 (2012), 1, pp. 7-21;<br />
• A. Kenny, Tommaso sull’essere, trad. it. <strong>di</strong> R. Saccenti e G. Ventimiglia, Roma <strong>2013</strong><br />
(in corso <strong>di</strong> stampa);<br />
• G. Ventimiglia, Tommaso d’Aquino e le dottrine non scritte <strong>di</strong> Platone, in “Me<strong>di</strong>oevo”,<br />
38 (<strong>2013</strong>) (in corso <strong>di</strong> stampa).<br />
I sensi dell’essere. Seminario progre<strong>di</strong>to<br />
Prof. Dr. Giovanni Ventimiglia, Prof. Dr. Alessandro Giordani e N.N. (assistente)<br />
Sigla: FFSO Semestre primaverile Ects: 4<br />
Seminario progre<strong>di</strong>to (per studenti del II e del III anno del bachelor in filosofia)<br />
Presentazione: Il tema dei sensi dell’essere e dell’analogia, originariamente aristotelico<br />
e tomistico, è tornato al centro <strong>degli</strong> interessi della filosofia contemporanea, a partire<br />
da F. Brentano e, poi, soprattutto da P. Geach.<br />
Il seminario intende approfon<strong>di</strong>re la questione dei sensi dell’essere dal punto <strong>di</strong> vista<br />
teoretico, ossia in particolare ontologico e logico, dal punto <strong>di</strong> vista semantico, e, infine<br />
dal punto <strong>di</strong> vista storico-filosofico.<br />
Esempi <strong>di</strong> questioni che saranno affrontate sono: quanti, ed eventualmente quali, sono<br />
i sensi dell’essere? C’è <strong>di</strong>fferenza fra sensi e mo<strong>di</strong> <strong>di</strong> essere? Quali sono i pre<strong>di</strong>cati <strong>di</strong><br />
126
“esistenza” a livello semantico? Esiste un denominatore comune fra tali pre<strong>di</strong>cati <strong>di</strong> esistenza?<br />
Qual è il fondamento della <strong>di</strong>stinzione fra i vari sensi e/o mo<strong>di</strong> <strong>di</strong> essere? In che<br />
modo sono collegati fra <strong>di</strong> loro i vari sensi e/o mo<strong>di</strong> <strong>di</strong> essere?<br />
È prevista la partecipazione al seminario <strong>di</strong> alcuni specialisti dell’argomento.<br />
Propedeuticità: La partecipazione al seminario è subor<strong>di</strong>nata ad un colloquio preliminare<br />
con i proff. Giordani e Ventimiglia.<br />
Metodologia della ricerca in filosofia<br />
Prof. Dr. Giovanni Ventimiglia e N.N. (assistente)<br />
Sigla: FFCO Semestre primaverile Ects: 1.5<br />
Presentazione: Come si fa una ricerca in filosofia? Basta semplicemente stabilire un<br />
tema, riflettervi per qualche mese e, finalmente, esprimere per iscritto i propri pensieri,<br />
la propria “tesi”? Naturalmente non basta. È necessario documentarsi su quanto è stato<br />
scritto su quell’argomento o su quell’autore. Ebbene, come ci si orienta nella ricerca dei<br />
testi da leggere? Ai nostri giorni ogni ricerca viene effettuata in internet. Gli strumenti<br />
della ricerca più utilizzati dagli studenti sono google e wikipe<strong>di</strong>a: niente <strong>di</strong> più errato per<br />
chi voglia fare una ricerca seria e <strong>di</strong> livello universitario nel campo della filosofia.<br />
Partendo da questa situazione, il corso si propone <strong>di</strong> introdurre gli studenti alla ricerca<br />
scientifica in filosofia, anche in rete.<br />
Verranno presentate: le opere <strong>di</strong> prima consultazione (Enciclope<strong>di</strong>a filosofica; Stanford<br />
Encyclope<strong>di</strong>a of Philosophy on line, Routledge Encyclope<strong>di</strong>a of Philosophy come risorsa<br />
elettronica, etc.); gli strumenti bibliografici imprescin<strong>di</strong>bili in filosofia (Philosopher’s<br />
Index on line, Répertoire bibliographique de la Philosophie, etc.); i servizi <strong>di</strong> ricerca e<br />
reperimento <strong>di</strong> libri e articoli della nostra e <strong>di</strong> altre biblioteche (Rero, prestito interbibliotecario,<br />
opac).<br />
Un’appen<strong>di</strong>ce al corso si soffermerà a spiegare come strutturare una relazione per<br />
un seminario o la tesina <strong>di</strong> bachelor in filosofia (Introduzione, status quaestionis, etc.),<br />
come fare le citazioni e, infine, come re<strong>di</strong>gere la bibliografia finale.<br />
Il corso conferisce 1,5 ects e prevede, al posto dell’esame finale orale, una breve esercitazione<br />
pratica. Il superamento <strong>di</strong> questo corso è con<strong>di</strong>zione in<strong>di</strong>spensabile per poter<br />
accedere all’esame finale del bachelor.<br />
Propedeuticità: Metodologia del lavoro scientifico (Dr. Alberto Palese). Il corso è opzionale<br />
per gli studenti <strong>di</strong> teologia e obbligatorio per quelli <strong>di</strong> filosofia.<br />
Corsi <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong><br />
Pluralità, <strong>di</strong>ssidenza, confronto nel <strong>di</strong>alogo religioso tra XI e XII<br />
Prof. Dr. Stefano Violi<br />
Sigla: SICO Semestre autunnale Ects: 1.5<br />
La descrizione sarà fornita all’inizio dell’anno accademico.<br />
127
Corsi <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong><br />
<strong>Teologia</strong> del matrimonio<br />
Prof. Dr. Ernesto William Volonté<br />
Sigla: TMCP Semestre autunnale Ects: 3<br />
Presentazione:<br />
Il sacramento del Matrimonio verrà proposto nei suoi fondamenti biblici e dogmatici. Il<br />
riconoscimento del costituirsi come sacramento sarà affrontato nella prospettiva storica,<br />
esaminando l’epoca patristica e me<strong>di</strong>evale, le sue varie espressioni liturgiche, fino<br />
all’esauriente definizione elaborata durante il Concilio <strong>di</strong> Trento. I fini e le proprietà<br />
<strong>di</strong> questo sacramento saranno letti attraverso la più recente riflessione del Magistero<br />
ecclesiastico, senza tralasciare le attuali problematiche teologiche e pastorali tuttora<br />
aperte.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• Testo <strong>di</strong> riferimento: le <strong>di</strong>spense del Professore;<br />
• L. Ligier, Il Matrimonio. Questioni teologiche e pastorali, Roma 1988;<br />
• A. Miralles, Il Matrimonio. <strong>Teologia</strong> e vita, Cinisello Balsamo 1996;<br />
• M.Ouellet, Mistero e sacramento dell’amore, Siena 2007.<br />
Liturgia delle Ore romana<br />
Prof. Dr. Nicola Zanini<br />
Sigla: LTCO Semestre autunnale Ects: 3<br />
Obiettivo corso: Scoprire il tesoro racchiuso nella Liturgia delle Ore del rito romano.<br />
Modalità <strong>di</strong> valutazione: Esame orale.<br />
Contenuto del corso: Si ripercorre la storia della Liturgia delle Ore, partendo da alcuni<br />
accenni alla preghiera nel Nuovo Testamento fino al Concilio Vaticano II. In seguito si<br />
scopriranno i contenuti della Liturgia delle Ore attraverso la lettura dei Principi e Norme<br />
della Liturgia delle Ore e attraverso l’eucologia contenuta nel libro liturgico.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• Ufficio <strong>di</strong>vino. Liturgia delle Ore secondo il rito romano, Principi e norme per la<br />
Liturgia delle Ore, I vol., Conferenza Episcopale Italiana, Città del Vaticano, 1989,<br />
6a rist. (1975, 1a ed.).<br />
• R. Taft, La liturgia delle Ore in Oriente e in Occidente, Cinisello Balsamo 1988.<br />
• A. Eleberti, Canto <strong>di</strong> lode per tutti i suoi fedeli - Origini e sviluppo della liturgia delle<br />
ore in Occidente, Milano 2011.<br />
• J. Ndoum, La liturgia delle ore - Un tesoro ancora inesplorato?, Padova, 2010.<br />
Liturgia pastorale e pratica<br />
Prof. Dr. Nicola Zanini<br />
Sigla: LTCP Semestre autunnale Ects: 3<br />
Obiettivo corso: Tradurre nella pratica pastorale i gran<strong>di</strong> principi della teologia liturgica<br />
eucaristica.<br />
Modalità <strong>di</strong> valutazione: Esame orale.<br />
Contenuto del corso: Si percorrerà interamente l’Or<strong>di</strong>namento Generale del Messale<br />
Romano secondo la terza e<strong>di</strong>zione tipica, promulgata il 20 aprile 2000, con uno sguardo<br />
128
pratico e pastorale. I vari elementi teologici evidenziati troveranno un applicazione alla<br />
vita liturgica concreta, affinché la lex creden<strong>di</strong> contenuta nella lex oran<strong>di</strong> coinvolga la vita<br />
(lex viven<strong>di</strong>).<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• Or<strong>di</strong>namento Generale del Messale Romano secondo la terza e<strong>di</strong>zione tipica, Città<br />
del Vaticano 2000.<br />
• Centro Nazionale Pastorale Liturgica Parigi, Exsultet. Enciclope<strong>di</strong>a pratica della<br />
liturgia, Brescia 2002.<br />
• G. Boselli, Il senso spirituale della Liturgia, Magnano 2011.<br />
Anno liturgico<br />
Prof. Dr. Nicola Zanini<br />
Sigla: LTCP Semestre primaverile Ects: 3<br />
Obiettivo corso: Comprendere l’attuale ciclo annuale liturgico romano.<br />
Modalità <strong>di</strong> valutazione: Esame orale.<br />
Contenuto del corso: Da alcune considerazioni antropologiche sul tempo si passerà a<br />
<strong>stu<strong>di</strong></strong>are le feste ebraiche, la domenica come nucleo neotestamentario <strong>di</strong> ogni celebrazione,<br />
la Pasqua annuale con la cinquantina pasquale, il Triduo pasquale e la Quaresima,<br />
il tempo della Manifestazione con la preparazione dell’Avvento, il Tempro per Annum<br />
con le feste del Signore fra l’Anno, il culto a Maria e dei Santi. Non mancherà un accenno<br />
all’anno liturgico ambrosiano.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• M. Augè, Anno liturgico. È Cristo stesso presente nella sua Chiesa, Città del Vaticano<br />
2009.<br />
• M. Navoni, Anno liturgico ambrosiano alla luce del nuovo lezionario, Milano 2009.<br />
• J. Ndoum, L’anno liturgico, Padova 2010.<br />
Corsi <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong><br />
Introduzione alla liturgia<br />
Prof. Dr. Nicola Zanini<br />
Sigla: LTCP Semestre primaverile Ects: 3<br />
Obiettivo corso: Offrire agli studenti una panoramica generale sulla <strong>di</strong>sciplina liturgica.<br />
Modalità <strong>di</strong> valutazione: Esame orale.<br />
Contenuto del corso: Verrà data risposta a 7 gran<strong>di</strong> domande: cos’è la liturgia (definizione);<br />
da dove nasce la liturgia (storia); chi sono i soggetti della liturgia (<strong>di</strong>namismo);<br />
quali sono i contenuti della liturgia (teologia liturgica); quali sono gli strumenti della liturgia<br />
(libri liturgici); come parla la liturgia (segni e simboli); quali spazi occupa la liturgia<br />
(arte sacra).<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• Concilio Ecumenico Vaticano II, Sacrosanctum Concilium. Costituzione sulla sacra<br />
liturgia, Enchiri<strong>di</strong>on Vaticanum, vol. 1, Bologna 1979, 16-95.<br />
• A. Chupungco (a cura <strong>di</strong>), Scientia Liturgica (Handbook for Liturgical Stu<strong>di</strong>es), 5 vol.,<br />
Casale Monferrato 1998.<br />
• M. Kunzler, La liturgia della Chiesa, amateca 10, <strong>Lugano</strong>-Milano 1996.<br />
129
Corsi <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong><br />
Introduzione alla critica testuale<br />
Prof. Dr. N.N.<br />
Sigla: DICO Semestre autunnale Ects: 3<br />
Obiettivo corso: Il corso si propone <strong>di</strong> fornire ai licenzian<strong>di</strong> e dottoran<strong>di</strong> in Sacra Scrittura<br />
gli strumenti <strong>di</strong> base riguardanti la critica textus tanto del Testo Massoretico che<br />
del Nuovo Testamento greco.<br />
Modalità <strong>di</strong> valutazione: Esame scritto.<br />
Contenuto del corso: Si prenderanno prima <strong>di</strong> tutto in considerazione i criteri generali<br />
che presiedono all’e<strong>di</strong>zione critica <strong>di</strong> un testo antico; si <strong>stu<strong>di</strong></strong>eranno in seguito le caratteristiche<br />
del testo ebraico massoretico e delle sue e<strong>di</strong>zioni critiche (BHS e BHQ) e si<br />
prenderanno in considerazione le altre forme del testo ebraico (Samaritano, Qumran) e<br />
delle sue versioni antiche (LXX, Peshitta, Volgata). Si <strong>stu<strong>di</strong></strong>erà poi la critica del testo del<br />
Nuovo Testamento nella sua storia e nel suo stato attuale. Parte essenziale del corso<br />
sarà l’utilizzo delle e<strong>di</strong>zioni critiche correnti. Ogni studente dovrà essere in possesso<br />
<strong>di</strong> BHS e <strong>di</strong> Nestle-Aland27. Per il corso è in<strong>di</strong>spensabile la conoscenza dell’ebraico e<br />
del greco biblico. Il corso è obbligatorio per i licenzian<strong>di</strong> e i dottoran<strong>di</strong> in Antico Testamento.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
• E. Tov, Textual Criticism of the Hebrew Bible, Minneapolis-Assen 2001 2<br />
• B.M. Metzger, Il testo del Nuovo Testamento, Introduzione allo <strong>stu<strong>di</strong></strong>o della Bibbia,<br />
Supplementi 1, Brescia 1996<br />
• W.R. Scott, A Simplified Guide to BHS, Berkeley 1995 3<br />
130
6. Informazioni varie<br />
6.1. Recapiti dei docenti, dei ricercatori e <strong>degli</strong> assistenti<br />
Docente <br />
Alborghetti Patrizio +39-035/782092 patrizio.alborghetti@teologialugano.ch<br />
Arroba Conde Manuel Jesús +39-06/69895627 mjconde@e<strong>di</strong>urcla.it<br />
Bassani Luigi Marco ― marcobassani@yahoo.com<br />
Battaglia Gino ― g.battaglia@chiesacattolica.it<br />
Bernasconi Rocco<br />
Bianchi Meda Letizia +41-(0)58/6664578 letizia.bianchi@teologialugano.ch<br />
Biffi Inos +39-02/875983 inos.biffi@teologialugano.ch<br />
inbiffi@alice.it<br />
Calanchini Carlo ― calanchinic@bluewin.ch<br />
Cattaneo Arturo +41-(0)91/9214651 arturo.cattaneo@montebre.net<br />
+41-(0)79/3896525<br />
Cattaneo Carlo +41-(0)91/6051367 carlo.cattaneo@teologialugano.ch<br />
carlo.cattaneo@bluewin.ch<br />
Chiappini Azzolino +41-(0)58/6664550 azzolino.chiappini@teologialugano.ch<br />
Corvi Roberta ― roberta.corvi@unicatt.it<br />
de Petris Paolo +41-(0)91/7515171 paolodepetris@ticino.com<br />
Di Marco Myriam Lucia ― myriam.<strong>di</strong>.marco@teologialugano.ch<br />
Diodato Roberto<br />
+39-02/7234 -2754 (<strong>stu<strong>di</strong></strong>o)<br />
-2623 (segreteria)<br />
roberto.<strong>di</strong>odato@unicatt.it<br />
roberto.<strong>di</strong>odato@isfi.ch<br />
Eisenring Gabriela ― g.eisenring@gmail.com<br />
Ejeh Bene<strong>di</strong>ct +39-041/27 43 911 benejeh@yahoo.it<br />
Fabris Adriano +39-050/2215006 fabris@fls.unipi.it<br />
adriano.fabris@isfi.ch<br />
Ferrari Silvio +39-02/5031.2496 silvio.ferrari@unimi.it<br />
Fidanzio Marcello +41-(0)58/6664568 fidanzio@libero.it<br />
+39-02/89123299<br />
Foglia<strong>di</strong>ni Emanuela ― foglia<strong>di</strong>ni@eikonmilano.org<br />
Francavilla Domenico +39-011/5683032 domenicofrancavilla@yahoo.it<br />
Gagliano Gabriella ― ―<br />
Gerosa Libero +41-(0)58/6664572 gerosa@teologialugano.ch<br />
Giordani Alessandro ― alessandro.giordani@unicatt.it<br />
alessandro.giordani@isfi.ch<br />
Gomarasca Paolo +39-02/72342903 paolo.gomarasca@unicatt.it<br />
Guerzoni Gianluca ― guerzonigianluca@gmail.com<br />
Manfred Hauke +41-(0)58/6664563<br />
+41-(0)91/9664238<br />
manfred.hauke@teologialugano.ch<br />
manfredhauke@bluewin.ch<br />
www.teologialugano.ch/docenti.php<br />
131
www.teologialugano.ch/docenti.php<br />
Docente <br />
Imbach Rue<strong>di</strong> ― ruedolf.imbach@isfi.ch<br />
Jerumanis André-Marie +41-(0)91/6497187<br />
+41-(0)58/6664570<br />
andre.marie.jerumanis@teologialugano.ch<br />
101994@ticino.com<br />
Kenny Anthony ― anthony.kenny@isfi.ch<br />
Kiroulos Hani Bakhoum +202/225 71 740 secrpatrcopt@gmail.com<br />
Krienke Markus +41-(0)58/6664564 markus.krienke@teologialugano.ch<br />
markus.krienke@isfi.ch<br />
Kukla Andrzej +48/122 60 97 01 kuklausa@gmail.com<br />
Laim Clau<strong>di</strong>o +41-(0)91/6839029 clau<strong>di</strong>olaim@yahoo.com<br />
Laras Giuseppe +39-024/8539560 giuseppelaras@gmail.com<br />
Lazzeri Valerio +41-(0)91/9210086 vlazzeri@bluewin.ch<br />
Lechner Jean-Claude ― jean-claude.lechner@ti.ch<br />
Lenoci Michele +39-02/7234 2274 michele.lenoci@unicatt.it<br />
michele.lenoci@isfi.ch<br />
Lottieri Carlo +39-339/3565067 lottieri@unisi.it<br />
Magarotto Varini Marina +41-(0)76/200 90 64 magarotto.varini@<strong>stu<strong>di</strong></strong>oecclesiastico.com<br />
Manzi Franco +39-0331/867204 francomanzi@seminario.milano.it<br />
Marabelli Costante +41-(0)58/6664566 costantemarabelli@gmail.com<br />
Mastromatteo Giuseppe ― giuseppe.mastromatteo@unicatt.it<br />
Milani Clau<strong>di</strong>a ― clau<strong>di</strong>a_milani@hotmail.com<br />
Monceri Flavia ― ryuko_2001@yahoo.it<br />
Mulligan Kevin +41-022/3797051 -1131 kevin.mulligan@lettres.unige.ch<br />
Musselli Luciano +39-0382/984619 musselli@unipv.it<br />
Negruzzo Simona +39-(0)30/2406325 simona.negruzzo@unicatt.it<br />
+39-339/7829696<br />
Orelli Luisa ― luisa.orelli@bluewin.ch<br />
Orsatti Mauro +41-(0)58/6664569<br />
+41-(0)91/9122762<br />
666777@libero.it<br />
mauro.orsatti@teologialugano.ch<br />
Ortelli Matasci Stefania ― stefania.ortelli@hispeed.ch<br />
Pacella Rosa Rita ― rosyrosita@hotmail.it<br />
Pacillo Vincenzo +39-392-3686143 pacillov@yahoo.it<br />
Palese Alberto ― alberto.palese@teologialugano.ch<br />
Paxima<strong>di</strong> Giorgio +41-(0)58/6664568 giorgio.paxima<strong>di</strong>@teologialugano.ch<br />
donpaxi@dplanet.ch<br />
Pellicioli Linda +41-(0)58/6664570 linda.pellicioli@me.com<br />
Perfetti Stefano ― perfetti@fls.unipi.it<br />
Pighin Bruno Fabio +39-(0)434/508653 pighinbruno@libero.it<br />
Sala Maura +39-335/6929574 maura.sala@libero.it<br />
Schmidbaur Hans Christian +41-(0)58/6664571 christian.schmidbaur@teologialugano.ch<br />
132
Docente <br />
Sgubbi Giorgio +41-(0)58/6664565 giorgio.sgubbi@teologialugano.ch<br />
Soldati Gianfranco ― gianfranco.soldati@isfi.ch<br />
Solo Darius Bamuene +41-(0)91/7461138 dbamuene@bluewin.ch<br />
Stabellini Andrea ― andreastabellini@gmail.com<br />
Ta<strong>di</strong>ni Samuele Francesco +39-(0)323/33088 sam.ta<strong>di</strong>ni@alice.it<br />
Tombolini Antonio +41-(0)58/6664559<br />
+39-0332/747491<br />
antonio.tombolini@teologialugano.ch<br />
a.tombolini@inwind.it<br />
Urbani Ulivi Lucia ― lucia.ulivi@unicatt.it<br />
Varsalona Agnese +41-(0)32/6235472 agnes.varsalona@gmail.com<br />
Ventimiglia Giovanni +41-(0)58/6664577 ventimiglia@teologialugano.ch<br />
ventimiglia@isfi.ch<br />
Violi Stefano ― stefanovioli@infinito.it<br />
Volonté Ernesto William +41-(0)91/9668712 ernesto.volonte@teologialugano.ch<br />
willy.volonte@gmail.com<br />
Zanar<strong>di</strong> Lan<strong>di</strong> Paola +41-(0)58/6664571 pzl@quipo.it<br />
Zanini Nicola +41-(0)91/9716076 zanini.nicola@gmail.com<br />
6.2. Associazione Alumni FTL<br />
In data 20 febbraio 2012 il comitato Pro-Associazione-Alumni, composto da ex studenti<br />
della Facoltà, ha dato il via all’iniziativa a favore <strong>di</strong> una Associazione Alumni della FTL,<br />
che raggruppi tutti gli ex studenti interessati alla medesima. Molti ex studenti hanno già<br />
aderito.<br />
L’Associazione Alumni è composta dagli studenti che hanno raggiunto un grado accademico<br />
della Facoltà <strong>di</strong> <strong>Teologia</strong> <strong>di</strong> <strong>Lugano</strong>, presso cui non hanno più <strong>stu<strong>di</strong></strong> in corso. Tutti<br />
i laureati e le laureate alla FTL, <strong>di</strong> qualsiasi percorso, possono farne parte. L’Associazione<br />
nasce da una esigenza della Facoltà stessa <strong>di</strong> mantenere soli<strong>di</strong> i rapporti con tutti<br />
coloro che, durante gli anni <strong>di</strong> <strong>stu<strong>di</strong></strong>o, hanno favorito gli scambi intellettuali all’interno<br />
della medesima, ma anche per una esigenza <strong>degli</strong> ex-studenti del Bachelor in Filosofia,<br />
dei Master DiReCom e ReTe e della Facoltà <strong>di</strong> <strong>Teologia</strong> (baccellieri, dottoran<strong>di</strong> etc.). Tra<br />
gli obiettivi dell’Associazione, infatti, vi sono: promuovere un legame duraturo tra la Facoltà<br />
e gli Alumni, e tra gli stessi membri dell’Associazione, in funzione dello scambio <strong>di</strong><br />
esperienze e delle conoscenze professionali acquisite dopo il grado accademico conseguito;<br />
fornire informazioni agli studenti e alle loro associazioni sulle possibilità formative<br />
offerte dalla Facoltà; promuovere l’apertura internazionale della Facoltà, potenziando<br />
ed estendendo la sua rete <strong>di</strong> scambi e relazioni con istituzioni, università e centri <strong>di</strong><br />
ricerca all’estero, promuovere la valorizzazione intellettuale e spirituale <strong>degli</strong> Alumni.<br />
Sito internet: www.wix.com/alumn3/alumniftl<br />
Per informazioni e iscrizioni: alumni@teologialugano.ch<br />
www.teologialugano.ch/docenti.php<br />
133
6.3. Associazione sostenitori<br />
Lo scopo dell’Associazione è quello <strong>di</strong> sostenere e sovvenzionare le attività culturali e<br />
accademiche della FTL, nonché quello <strong>di</strong> alimentare il fondo borse <strong>di</strong> <strong>stu<strong>di</strong></strong>o.<br />
Gli statuti dell’Associazione <strong>di</strong>stinguono tre or<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> soci: soci or<strong>di</strong>nari, sostenitori e benemeriti.<br />
Le quote sociali annue sono state stabilite in CHF 200.-- per i soci or<strong>di</strong>nari, CHF<br />
1.000.-- per i soci sostenitori e CHF 5.000.-- per i soci benemeriti. Per statuto ogni socio<br />
riceve la Rivista Teologica <strong>di</strong> <strong>Lugano</strong> e il <strong>Piano</strong> <strong>degli</strong> Stu<strong>di</strong> della Facoltà <strong>di</strong> <strong>Teologia</strong>.<br />
Presidente: Paolo Buzzi, Vezia<br />
In<strong>di</strong>rizzo postale dell’Associazione:<br />
c/o Facoltà <strong>di</strong> <strong>Teologia</strong> <strong>di</strong> <strong>Lugano</strong>, via G. Buffi 13, c.p. 4663, 6904 <strong>Lugano</strong><br />
Banca Raiffeisen <strong>Lugano</strong><br />
• IBAN CH44 8037 5000 1079 4374 4<br />
• BIC RAIFCH22<br />
a favore dell’Associazione Sostenitori della FTL<br />
6.4. Offerte alla FTL<br />
Da un punto <strong>di</strong> vista economico la Facoltà, pur essendo sempre alla ricerca della ottimizzazione<br />
del risparmio, è oberata da esigenze finanziarie sempre più pressanti, a cui<br />
può far fronte solo grazie all’aiuto <strong>di</strong> persone e istituzioni private benemerite. Siamo<br />
grati a chiunque voglia sostenere la nostra istituzione che, oltre a essere sede <strong>di</strong> <strong>stu<strong>di</strong></strong><br />
universitari teologici e filosofici <strong>di</strong> grande qualità scientifica fornisce, anche a livello culturale<br />
e sociale stimoli per una presenza cristiana al servizio <strong>di</strong> tutto il Paese.<br />
Per offerte <strong>di</strong>rette alla Facoltà:<br />
• conto corrente postale 69-8062-2<br />
• IBAN CH77 0900 0000 6900 8062 2<br />
• BIC POFICHBEXXX<br />
Intestato alla Facoltà <strong>di</strong> <strong>Teologia</strong> <strong>di</strong> <strong>Lugano</strong>.<br />
6.5. Seminari, Comunità, Convitti e altri alloggi per studenti della FTL<br />
Seminario Diocesano San Carlo<br />
Rettore: Don Ernesto W. Volonté<br />
In<strong>di</strong>rizzo: via Lucino 79, 6932 Breganzona<br />
Tel.: +41-(0)91/9676707<br />
Email: willy.volonte@gmail.com<br />
Seminario Diocesano Missionario “Redemptoris Mater”<br />
Rettore: Don Mario Trulio<br />
In<strong>di</strong>rizzo: via Cantonale, 6818 Melano<br />
Tel.: +41-(0)91/6481833<br />
E-mail: luganosrm@gmail.com<br />
134
Convitto ecclesiastico Santa Maria <strong>di</strong> Loreto<br />
Rettore: Don Giorgio Paxima<strong>di</strong><br />
In<strong>di</strong>rizzo: via Loreto 18, 6900 <strong>Lugano</strong><br />
Tel.: +41-(0)91/9804591 - Fax: +41-(0)91/9804592<br />
E-mail: giorgio.paxima<strong>di</strong>@teologialugano.ch<br />
Convento Cappuccini<br />
Guar<strong>di</strong>ano: Fra’ Ugo Orelli<br />
In<strong>di</strong>rizzo: Salita dei Frati 4, 6900 <strong>Lugano</strong><br />
Tel.: +41-(0)91/9235122<br />
E-mail: lugano@cappuccini.ch<br />
Web: www.cappuccini.ch<br />
Comunità delle Beatitu<strong>di</strong>ni<br />
Responsabile: Suor Sarah Blanchard<br />
In<strong>di</strong>rizzo: via Nassa 66, 6900 <strong>Lugano</strong><br />
Tel.: +41-(0)91/9211076<br />
E-mail: lugano.berger@beatitudes.org<br />
Web: www.beatitudes.org<br />
Comunità Cattolica Shalom<br />
Responsabile: Elton Da Silva Alves<br />
In<strong>di</strong>rizzo: via San Maurizio 15, 6934 Bioggio<br />
Tel.: +41-(0)91/9666917<br />
E-mail: lugano@comshalom.org<br />
Web: www.comshalom.org<br />
Comunità Mar a Dentro<br />
Responsabile: Padre Marcelo José da Silva<br />
In<strong>di</strong>rizzo: via Zurigo 1, 6900 <strong>Lugano</strong><br />
E-mail: lugano@maradentro.com.br<br />
Comunità Palavra Viva<br />
Responsabili: Aristeu Aparecido De Souza Rocha e Lílian Costa Venceslau<br />
In<strong>di</strong>rizzi:<br />
1) “Casa Santo Antônio”, via Simen 1, 6900 <strong>Lugano</strong><br />
Tel.: +41-(0)91/9210843; +41-(0)79/7654847<br />
2) Monastero San Giuseppe, corso Pestalozzi 1, 6900 <strong>Lugano</strong><br />
Tel.: +41-(0)91/9239022; +41-(0)77/449 64 44<br />
E-mail: lugano@palavraviva.com<br />
Web: www.palavraviva.com<br />
135
6.6. Pastorale universitaria<br />
Responsabile: p. Michele Scarso o.p. (frati domenicani)<br />
Collaboratrice: Jane Saldanha (janela63@gmail.com)<br />
E-mail: pastorale.unilu@gmail.com<br />
Facebook: pastorale universitaria lugano<br />
In<strong>di</strong>rizzo: Pastorale Universitaria, corso Elvezia 35, 6900 <strong>Lugano</strong><br />
Tel. 079/5214840 o 091/9214138<br />
Durante il periodo dei corsi alla Basilica del Sacro Cuore – Parrocchia Universitaria si<br />
propone:<br />
--<br />
Ogni martedì ore 12.25: S. Messa per gli universitari<br />
ore 13.00: pranzo <strong>di</strong> amicizia<br />
--<br />
Giorni feriali ore 7.30: S. Messa e Lo<strong>di</strong> mattutine<br />
ore 18.00: S. Messa con i Vespri<br />
La Pastorale Universitaria si propone come luogo <strong>di</strong> incontro per studenti e docenti<br />
della FTL e della USI me<strong>di</strong>ante alcune attività come:<br />
--<br />
pranzo settimanale (durante il calendario accademico)<br />
--<br />
serate per aree etnico-culturali<br />
--<br />
cene filosofiche (food & philosophy)<br />
--<br />
gite, escursioni...<br />
Si dà aiuto a chi cerca alloggio, in<strong>di</strong>cando alcune possibili soluzioni.<br />
Per le persone <strong>di</strong> fede cristiano-cattolica si propongono la Messa settimanale, momenti<br />
<strong>di</strong> preghiera, pellegrinaggi…<br />
136
08.30-09.15<br />
09.30-10.15<br />
10.30-11.15<br />
11.30-12.15<br />
13.30-14.15<br />
14.30-15.15<br />
15.30-16.15<br />
16.30-17.15<br />
17.30-18.15<br />
Orario semestre autunnale <strong>2013</strong><br />
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato<br />
138
Esami<br />
Corso Professore Data Ora<br />
................................................... ............................................ ................... ..............<br />
................................................... ............................................ ................... ..............<br />
................................................... .............................................. ................... ..............<br />
................................................... .............................................. ................... ..............<br />
................................................... .............................................. ................... ..............<br />
................................................... .............................................. ................... ..............<br />
................................................... .............................................. ................... ..............<br />
................................................... .............................................. ................... ..............<br />
................................................... .............................................. ................... ..............<br />
................................................... .............................................. ................... ..............<br />
................................................... .............................................. ................... ..............<br />
................................................... .............................................. ................... ..............<br />
................................................... .............................................. ................... ..............<br />
................................................... .............................................. ................... ..............<br />
139
08.30-09.15<br />
09.30-10.15<br />
10.30-11.15<br />
11.30-12.15<br />
13.30-14.15<br />
14.30-15.15<br />
15.30-16.15<br />
16.30-17.15<br />
17.30-18.15<br />
Orario semestre primaverile <strong>2014</strong><br />
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato<br />
140
Esami<br />
Corso Professore Data Ora<br />
................................................... ............................................ ................... ..............<br />
................................................... ............................................ ................... ..............<br />
................................................... .............................................. ................... ..............<br />
................................................... .............................................. ................... ..............<br />
................................................... .............................................. ................... ..............<br />
................................................... .............................................. ................... ..............<br />
................................................... .............................................. ................... ..............<br />
................................................... .............................................. ................... ..............<br />
................................................... .............................................. ................... ..............<br />
................................................... .............................................. ................... ..............<br />
................................................... .............................................. ................... ..............<br />
................................................... .............................................. ................... ..............<br />
................................................... .............................................. ................... ..............<br />
................................................... .............................................. ................... ..............<br />
141
In<strong>di</strong>ce dei nomi dei docenti, dei ricercatori e <strong>degli</strong> assistenti<br />
Le pagine in corsivo si riferiscono alle descrizioni dei corsi, quelle in grassetto ai recapiti<br />
dei docenti.<br />
A<br />
Alborghetti, Patrizio 10, 51, 53, 57, 58, 131<br />
Arroba Conde, Manuel Jesús 10, 131<br />
B<br />
Bassani, Luigi Marco 10, 53, 58, 59, 131<br />
Battaglia, Gino 10, 52, 59, 131<br />
Bernasconi, Rocco 10, 51, 53, 59, 60, 131<br />
Bianchi Meda, Letizia 10, 22, 52, 54, 60, 61,<br />
131<br />
Biffi, Inos 9, 15, 22, 51, 53, 61, 131<br />
C<br />
Calanchini, Carlo 10, 44, 61, 62, 131<br />
Cattaneo, Arturo 10, 22, 43, 49, 51, 52, 62,<br />
63, 131<br />
Cattaneo, Carlo 10, 42, 45, 46, 48, 64, 131<br />
Chiappini, Azzolino 9, 22, 39, 41, 48, 49, 54,<br />
64, 65, 72, 131<br />
Ciccone, Lino 9, 82<br />
Corvi, Roberta 10, 45, 47, 65, 66, 131<br />
Costa, Damiano 18<br />
D<br />
de Petris, Paolo 10, 51, 53, 66, 131<br />
Di Marco, Myriam Lucia 10, 13, 54, 65, 131<br />
Diodato, Roberto 10, 18, 51, 53, 67, 131<br />
E<br />
Eisenring, Gabriela 10, 22, 43, 49, 51, 52, 54,<br />
67, 68, 131<br />
Ejeh, Bene<strong>di</strong>ct 10, 52, 69, 131<br />
F<br />
Fabris, Adriano 10, 17, 18, 22, 45, 47, 51, 69,<br />
70, 110, 131<br />
Ferrari, Silvio 10, 22, 51, 52, 70, 72, 131<br />
Fidanzio, Marcello 10, 39, 41, 42, 44, 46, 48,<br />
49, 56, 70, 71, 131<br />
Foglia<strong>di</strong>ni, Emanuela 10, 51, 72, 131<br />
Francavilla, Domenico 10, 51, 52, 72, 131<br />
G<br />
Gagliano, Gabriella 10, 131<br />
Gerosa, Libero 9, 17, 20, 22, 23, 39, 41, 42,<br />
43, 46, 48, 49, 50, 51, 60, 61, 73, 74,<br />
107, 120, 121, 131<br />
Giordani, Alessandro 10, 18, 42, 44, 45, 55,<br />
75, 126, 127, 131<br />
Gomarasca, Paolo 10, 52, 76, 131<br />
Guerzoni, Gianluca 10, 131<br />
H<br />
Hauke, Manfred 9, 20, 21, 39, 42, 43, 44, 46,<br />
48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 76, 77, 78,<br />
79, 80, 131<br />
I<br />
Imbach, Rue<strong>di</strong> 10, 18, 52, 80, 132<br />
J<br />
Jerumanis, André-Marie 9, 18, 39, 41, 42, 43,<br />
46, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 80, 81, 82,<br />
83, 84, 132<br />
K<br />
Kenny, Anthony 10, 53, 84, 99, 126, 132<br />
Kiroulos, Hani Bakhoum 10, 52, 84, 132<br />
Krienke, Markus 9, 19, 42, 43, 44, 45, 47, 49,<br />
52, 54, 55, 84, 85, 86, 87, 88, 122,<br />
132<br />
Kukla, Andrzej 10, 51, 89, 132<br />
L<br />
Laim, Clau<strong>di</strong>o 10, 39, 41, 42, 49, 50, 90, 132<br />
Laras, Giuseppe 10, 51, 58, 91, 132<br />
Lazzeri, Valerio 9, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 52,<br />
54, 91, 92, 93, 132<br />
Lechner, Jean-Claude 10, 45, 47, 51, 53, 93,<br />
94, 132<br />
Lenoci, Michele 10, 18, 45, 47, 94, 95, 132<br />
Lottieri, Carlo 10, 18, 52, 95, 132<br />
M<br />
Magarotto Varini, Marina 10, 43, 49, 67, 132<br />
142
Manzi, Franco 10, 52, 53, 96, 132<br />
Marabelli, Costante 9, 20, 22, 42, 44, 47, 49,<br />
52, 54, 97, 98, 99, 132<br />
Mastromatteo, Giuseppe 10, 52, 53, 100,<br />
101, 102, 132<br />
Milani, Clau<strong>di</strong>a 10, 53, 102, 132<br />
Monceri, Flavia 10, 53, 102, 132<br />
Mulligan, Kevin 10, 18, 53, 102, 132<br />
Musselli, Luciano 10, 52, 103, 132<br />
N<br />
Negruzzo, Simona 10, 39, 41, 46, 48, 103,<br />
132<br />
O<br />
Orelli, Luisa 10, 53, 65, 103, 132<br />
Orsatti, Mauro 9, 39, 41, 46, 48, 49, 52, 53,<br />
54, 55, 71, 104, 105, 106, 132<br />
Ortelli Matasci, Stefania 10, 132<br />
Tombolini, Antonio 10, 11, 21, 22, 44, 45,<br />
47, 51, 53, 122, 123, 133<br />
U<br />
Urbani Ulivi, Lucia 10, 44, 47, 124, 125, 133<br />
V<br />
Varsalona, Agnese 10, 43, 49, 124, 133<br />
Ventimiglia, Giovanni 9, 18, 19, 20, 22, 23,<br />
44, 45, 47, 53, 55, 124, 125, 126, 127,<br />
133<br />
Violi, Stefano 10, 52, 127, 133<br />
Volonté, Ernesto William 10, 42, 49, 128,<br />
133, 134<br />
Z<br />
Zanar<strong>di</strong> Lan<strong>di</strong>, Paola 10, 133<br />
Zanini, Nicola 10, 42, 44, 48, 49, 50, 52, 128,<br />
129, 133<br />
P<br />
Pacella, Rosa Rita 10, 132<br />
Pacillo, Vincenzo 10, 22, 43, 53, 54, 107, 132<br />
Palese, Alberto 10, 44, 47, 53, 108, 127, 132<br />
Paxima<strong>di</strong>, Giorgio 9, 16, 20, 21, 39, 41, 45,<br />
46, 48, 49, 51, 53, 56, 108, 109, 132,<br />
135<br />
Pellicioli, Linda 10, 39, 41, 42, 43, 46, 48, 49,<br />
50, 52, 54, 55, 80, 81, 82, 83, 84, 132<br />
Perfetti, Stefano 10, 53, 110, 132<br />
Pighin, Bruno Fabio 10, 53, 63, 110, 132<br />
S<br />
Sala, Maura 10, 44, 48, 70, 132<br />
Sanzioni nella Chiesa, Le 62<br />
Schmidbaur, Hans Christian 9, 39, 41, 42, 43,<br />
46, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 111, 112,<br />
113, 114, 115, 116, 132<br />
Sgubbi, Giorgio 9, 39, 41, 45, 46, 47, 48, 49,<br />
54, 116, 117, 118, 133<br />
Soldati, Gianfranco 10, 18, 52, 119, 133<br />
Solo, Darius Bamuene 10, 53, 120, 133<br />
Stabellini, Andrea 10, 42, 43, 49, 51, 53, 73,<br />
120, 121, 133<br />
T<br />
Ta<strong>di</strong>ni, Samuele Francesco 10, 45, 47, 122,<br />
133<br />
143
In<strong>di</strong>ce delle descrizioni dei corsi<br />
I titoli vengono elencati senza l’articolo.<br />
Amore ed emozioni nella filosofia moderna e<br />
contemporanea 119<br />
Anno liturgico 129<br />
Antropologia filosofica 124<br />
Apparizioni mariane nella vita della Chiesa,<br />
Le 78<br />
Aquinas on being 84<br />
Armonia e tensioni nella comunità <strong>di</strong> Corinto.<br />
La Seconda Lettera <strong>di</strong> Paolo ai Corinti<br />
104<br />
“Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del<br />
mondo che verrà!” – Come saremo<br />
e come vivremo nell’al-<strong>di</strong>-là? – Un<br />
incontro con le varie teorie storiche<br />
sulla “risurrezione della carne” e sulla<br />
nuova vita con un corpo trasformato e<br />
glorificato in un “mondo nuovo” 111<br />
Bioetica e religioni 83<br />
Comunità cristiane negli Atti <strong>degli</strong> Apostoli,<br />
Le 106<br />
Corso monografico <strong>di</strong> Antropologia filosofica:<br />
il soggetto umano nello spazio virtuale<br />
125<br />
Corso monografico <strong>di</strong> Etica generale: Etica<br />
come conciliazione. I «Lineamenti» <strong>di</strong><br />
Hegel 87<br />
Corso monografico <strong>di</strong> Ontologia: Dio è<br />
l’Essere? 126<br />
Corso monografico <strong>di</strong> Storia della filosofia<br />
antica: Il Timeo, «mito scientifico» <strong>di</strong><br />
Platone 97<br />
Corso monografico <strong>di</strong> Storia della filosofia<br />
contemporanea: Fenomenologia e<br />
filosofia dell’esistenza 70<br />
Corso monografico <strong>di</strong> Storia della filosofia<br />
me<strong>di</strong>evale: L’opuscolo <strong>di</strong> S. Tommaso<br />
Sull’eternità del mondo: la posizione<br />
filosofica <strong>di</strong> un teologo su un tema <strong>di</strong><br />
grande <strong>di</strong>scussione e scontro 99<br />
Corso monografico <strong>di</strong> storia della filosofia<br />
moderna: Il Saggio sull’intelletto umano<br />
<strong>di</strong> John Locke 122<br />
Corso monografico <strong>di</strong> teoria della conoscenza:<br />
Il problema della verità nel<br />
<strong>di</strong>battito contemporaneo 95<br />
Creazione e il peccato originale, La 79<br />
Cristianesimo del <strong>di</strong>ssenso, Il 66<br />
Cristo glorioso e la storia universale in lui<br />
predestinata, Il 61<br />
Cristologia: parte biblico-storica 76<br />
Cristologia: parte sistematica 79<br />
Dalla profezia all’apocalittica nell’uno e<br />
nell’altro Testamento 96<br />
Dialettica d’amore tra Eloisa e Abelardo,<br />
premessa a un progetto <strong>di</strong> vita religiosa,<br />
La 97<br />
Dialogo interreligioso oggi: <strong>di</strong>fficoltà e prospettive<br />
59<br />
Didattica dell’istruzione religiosa 90<br />
Diritti e popoli nel Magistero <strong>di</strong> Giovanni<br />
Paolo II 73<br />
Diritto bud<strong>di</strong>sta 72<br />
Diritto canonico e pastorale 74<br />
Diritto canonico ortodosso 84<br />
Diritto costituzionale canonico I 74<br />
Diritto costituzionale canonico II (I e II parte)<br />
62<br />
Diritto <strong>degli</strong> Istituti <strong>di</strong> Vita Consacrata 63<br />
Diritto delle Società <strong>di</strong> Vita Apostolica e Prelature<br />
personali: <strong>di</strong>fferenze e analogie<br />
89<br />
Diritto e proce<strong>di</strong>mento amministrativo<br />
canonico 61<br />
Diritto ecclesiastico svizzero: parte generale<br />
107<br />
Diritto indù 72<br />
Diritto matrimoniale canonico. Esercizi <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>ritto matrimoniale canonico 67<br />
Diritto patrimoniale canonico 107<br />
Dottrina Sociale della Chiesa e mercato 100<br />
Ecclesiologia 113<br />
Economia e religione 58<br />
E<strong>di</strong>zioni patristiche da Erasmo ai Maurini<br />
(1516-1690), Le 94<br />
Escatologia 112<br />
Estetica applicata: l’“esperienza estetica” 67<br />
Estetica generale 67<br />
Etica generale. Il bene e il giusto 87<br />
144
Famiglia e le nuove forme famigliari del XXI<br />
secolo, La 82<br />
Fede e ragione 116<br />
Filosofia cristiana: Fides quaerens intellectum:<br />
L’impegno razionale della ricerca<br />
teologica <strong>di</strong> Anselmo d’Aosta 99<br />
Filosofia dell’amore nel Me<strong>di</strong>oevo (da<br />
Bernardo Di Chiaravalle a Marsilio<br />
Ficino), La 80<br />
Filosofia della natura, della scienza e della<br />
tecnica 75<br />
Filosofia e religione 69<br />
Filosofia ebraica. Antica e me<strong>di</strong>evale 57<br />
Filosofia politica 88<br />
Funzione <strong>di</strong> insegnare della Chiesa I, La 121<br />
Funzione <strong>di</strong> insegnare della Chiesa II, La 121<br />
Funzione <strong>di</strong> insegnare e santificare: CIC e<br />
CCEO comparati 120<br />
Globalizzazione ed etica cristiana: una globalizzazione<br />
al servizio dell’uomo 101<br />
Identità teologica del protestantesimo, L’ 66<br />
Iniziazione allo <strong>stu<strong>di</strong></strong>o della <strong>Teologia</strong> 92<br />
Introduzione ai libri storici 108<br />
Introduzione al <strong>di</strong>ritto costituzionale canonico:<br />
CCEO e CIC a confronto 63<br />
Introduzione al Nuovo Testamento 71<br />
Introduzione all’Antico Testamento 70<br />
Introduzione all’ebraismo 57<br />
Introduzione all’Islam 103<br />
Introduzione alla critica testuale 130<br />
Introduzione alla Dottrina sociale della<br />
Chiesa: la Chiesa e la sfida del postumanesimo<br />
84<br />
Introduzione alla filosofia 124, 125<br />
Introduzione alla liturgia 129<br />
Introduzione alla patrologia 91<br />
Introduzione alla teologia bizantino-ortodossa<br />
72<br />
Introduzione alla teologia spirituale 92<br />
Introduzione alle fonti del <strong>di</strong>ritto ebraico e<br />
temi scelti <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto matrimoniale<br />
ebraico 91<br />
Introduzione alle religioni orientali 102<br />
Istituzioni <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto romano 68<br />
Istituzioni generali <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto canonico 73<br />
Latinità I e II 122<br />
Lavoro come questione antropologica, Il 85<br />
Letteratura ebraica 60<br />
Letteratura giovannea 106<br />
Lettura <strong>di</strong> alcuni testi classici della tra<strong>di</strong>zione<br />
carmelitana 91<br />
“Letture balthasariane”. Pagine scelte dalla<br />
“Theodramatik” 117<br />
Lingua ebraica A 71<br />
Lingua ebraica B 109<br />
Lingua greca A 93<br />
Lingua greca B 94<br />
Lingua italiana 123<br />
Lingua latina 123<br />
Liturgia delle Ore romana 128<br />
Liturgia pastorale e pratica 128<br />
Logica classica 75<br />
Logica contemporanea 75<br />
Mariologia 77<br />
Matrimoni misti con cristiani <strong>di</strong> altre confessioni<br />
120<br />
Metodologia del lavoro scientifico 108<br />
Metodologia della ricerca in filosofia 127<br />
Ministero petrino, Il 77<br />
Mistero del Dio rivelato, Il 118<br />
Mistica ebraica, La 58<br />
Modelli <strong>di</strong> rapporto tra Stato e Chiesa in<br />
Europa 70<br />
Morale, democrazie e conformismo in Kenneth<br />
Minogue (Filosofia delle scienze<br />
sociali 3) 95<br />
Morte e immortalità come temi chiave<br />
dell’escatologia cristiana 79<br />
Musulmani in Europa: sfida ed opportunità<br />
per la libertà religiosa 70<br />
Nuovi modelli <strong>di</strong> <strong>Teologia</strong> trinitaria del XX<br />
secolo come riscoperta della rilevanza<br />
antropologica, soteriologia ed ecclesiologica<br />
d’un modello comunitario<br />
e relazionale <strong>di</strong> Dio, I 114<br />
Ontologia 125<br />
Pluralismo culturale e modelli <strong>di</strong> giustizia<br />
(Filosofia del <strong>di</strong>alogo interculturale)<br />
76<br />
Pluralità, <strong>di</strong>ssidenza, confronto nel <strong>di</strong>alogo<br />
religioso tra XI e XII 127<br />
Prassi amministrativa canonica 110<br />
Prassi giu<strong>di</strong>ziale canonica 69<br />
Pro-seminario <strong>di</strong> terminologia giuri<strong>di</strong>ca e<br />
canonistica 60<br />
Psicologia generale 61<br />
145
“Quale Islām?” La religione islamica a confronto<br />
65<br />
Questione “mistica” e l’università, La 92<br />
Questione della felicità nella filosofia contemporanea,<br />
La 102<br />
Racconto della Passione in Matteo, Il 105<br />
Ricerca <strong>di</strong> Gesù, Figlio <strong>di</strong> Dio, nel Vangelo<br />
secondo Luca, La 96<br />
Sacramento dell’Eucaristia nel <strong>di</strong>battito contemporaneo,<br />
Il 77<br />
Salmi 71<br />
Sapienza d’Israele 109<br />
Scienze naturali e teologia 108<br />
Seminario <strong>di</strong> Dottrina sociale. I partiti e i<br />
sindacati cristiani in Europa: le basi<br />
culturali, la loro storia, le sfide del<br />
futuro 88<br />
Seminario <strong>di</strong> filosofia: morte e immortalità nel<br />
pensiero moderno 86<br />
Seminario: Haec sublimis veritas: Dio come<br />
Essere verità imprescin<strong>di</strong>bile della<br />
filosofia cristiana 98<br />
Sensi dell’essere. Seminario progre<strong>di</strong>to, I 126<br />
Shabbat: norme, significato e liturgia, Lo 102<br />
“Signore dell’armonia” - Uno sguardo asiatico<br />
su Cristo - Parte V, Il 112<br />
Signore dell’universo (Lettera <strong>di</strong> san Paolo ai<br />
Colossesi), Il 106<br />
Storia dei dogmi 78<br />
Storia del pensiero politico contemporaneo<br />
59<br />
Storia della Chiesa I: antica 80<br />
Storia della Chiesa II: me<strong>di</strong>evale 64<br />
Storia della Chiesa III: riforma protestante e<br />
cattolica 103<br />
Storia della Chiesa IV: gli ultimi tre secoli 64<br />
Storia della filosofia antica 97<br />
Storia della filosofia contemporanea 65<br />
Storia della filosofia me<strong>di</strong>evale 98<br />
Storia della filosofia moderna. Da Cartesio a<br />
Hegel 86<br />
Storia delle istituzioni canoniche 103<br />
Storia delle religioni 110<br />
Talmud, Il 58<br />
Temi scelti <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto processuale II 68<br />
Temi scelti <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto sostantivo e processuale<br />
matrimoniale 68<br />
<strong>Teologia</strong> dei Padri 93<br />
<strong>Teologia</strong> del <strong>di</strong>ritto canonico e norme generali<br />
I 73<br />
<strong>Teologia</strong> del matrimonio 128<br />
<strong>Teologia</strong> dell’Olocausto 59<br />
<strong>Teologia</strong> della Grazia 116<br />
<strong>Teologia</strong> della misericor<strong>di</strong>a 81<br />
<strong>Teologia</strong> e spiritualità dell’Oriente cristiano<br />
64<br />
<strong>Teologia</strong> fondamentale - la Rivelazione 118<br />
<strong>Teologia</strong> morale fondamentale III. La <strong>di</strong>mensione<br />
drammatica dell’agire morale<br />
80<br />
<strong>Teologia</strong> morale orientale, La 83<br />
<strong>Teologia</strong> morale speciale I. Una morale del<br />
cuore filiale 81<br />
<strong>Teologia</strong> morale speciale II: Eros e agape 82<br />
<strong>Teologia</strong> morale speciale III: introduzione alla<br />
bioetica 84<br />
<strong>Teologia</strong> naturale 117<br />
<strong>Teologia</strong> pastorale: scopo e mezzi 90<br />
<strong>Teologia</strong> sacramentaria: Eucaristia 113<br />
<strong>Teologia</strong> sacramentaria: Or<strong>di</strong>ne, penitenza,<br />
unzione <strong>degli</strong> infermi 115<br />
Teoria della conoscenza 94<br />
Tesi e controversie sull’universo normativo<br />
(filosofia del <strong>di</strong>ritto 3) 95<br />
Uomo alla luce del mistero del Dio unitrino,<br />
L’ 124<br />
Uomo U<strong>di</strong>tore della Parola. Storia e sviluppo<br />
della <strong>Teologia</strong> della Parola come<br />
fondo e base dei documenti magisteriali<br />
Dei Verbum e Verbum Domini,<br />
L’ 115<br />
Vangeli dell’Infanzia, I 104<br />
Vangelo della domenica, Il 105<br />
146
147<br />
Appunti
Appunti<br />
148
149<br />
Appunti
Appunti<br />
150
151<br />
Appunti
Appunti<br />
152