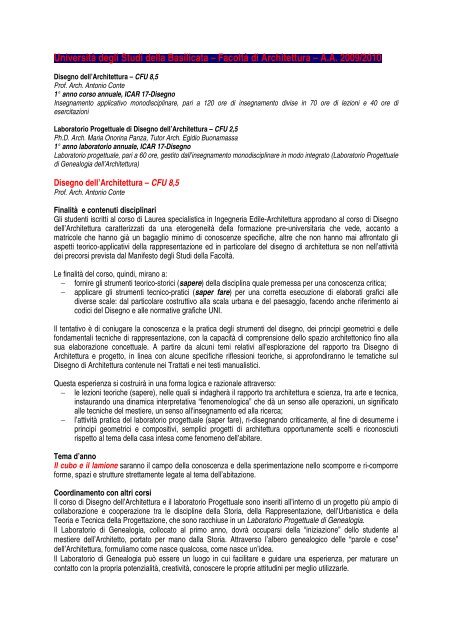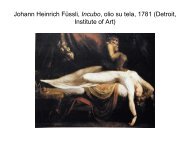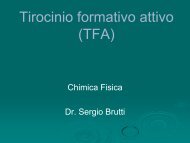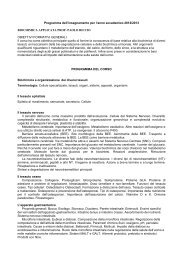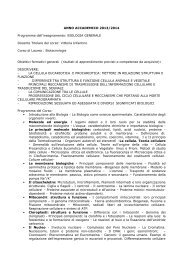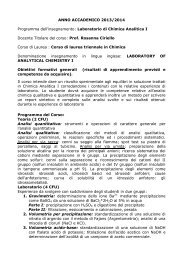Facoltà di Architettura – AA 2009/2010 - Università degli Studi della ...
Facoltà di Architettura – AA 2009/2010 - Università degli Studi della ...
Facoltà di Architettura – AA 2009/2010 - Università degli Studi della ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Università</strong> <strong>degli</strong> Stu<strong>di</strong> <strong>della</strong> Basilicata <strong>–</strong> <strong>Facoltà</strong> <strong>di</strong> <strong>Architettura</strong> <strong>–</strong> A.A. <strong>2009</strong>/<strong>2010</strong><br />
Disegno dell’<strong>Architettura</strong> <strong>–</strong> CFU 8,5<br />
Prof. Arch. Antonio Conte<br />
1° anno corso annuale, ICAR 17-Disegno<br />
Insegnamento applicativo mono<strong>di</strong>sciplinare, pari a 120 ore <strong>di</strong> insegnamento <strong>di</strong>vise in 70 ore <strong>di</strong> lezioni e 40 ore <strong>di</strong><br />
esercitazioni<br />
Laboratorio Progettuale <strong>di</strong> Disegno dell’<strong>Architettura</strong> <strong>–</strong> CFU 2,5<br />
Ph.D. Arch. Maria Onorina Panza, Tutor Arch. Egi<strong>di</strong>o Buonamassa<br />
1° anno laboratorio annuale, ICAR 17-Disegno<br />
Laboratorio progettuale, pari a 60 ore, gestito dall’insegnamento mono<strong>di</strong>sciplinare in modo integrato (Laboratorio Progettuale<br />
<strong>di</strong> Genealogia dell’<strong>Architettura</strong>)<br />
Disegno dell’<strong>Architettura</strong> <strong>–</strong> CFU 8,5<br />
Prof. Arch. Antonio Conte<br />
Finalità e contenuti <strong>di</strong>sciplinari<br />
Gli studenti iscritti al corso <strong>di</strong> Laurea specialistica in Ingegneria E<strong>di</strong>le-<strong>Architettura</strong> approdano al corso <strong>di</strong> Disegno<br />
dell’<strong>Architettura</strong> caratterizzati da una eterogeneità <strong>della</strong> formazione pre-universitaria che vede, accanto a<br />
matricole che hanno già un bagaglio minimo <strong>di</strong> conoscenze specifiche, altre che non hanno mai affrontato gli<br />
aspetti teorico-applicativi <strong>della</strong> rappresentazione ed in particolare del <strong>di</strong>segno <strong>di</strong> architettura se non nell’attività<br />
dei precorsi prevista dal Manifesto <strong>degli</strong> Stu<strong>di</strong> <strong>della</strong> <strong>Facoltà</strong>.<br />
Le finalità del corso, quin<strong>di</strong>, mirano a:<br />
− fornire gli strumenti teorico-storici (sapere) <strong>della</strong> <strong>di</strong>sciplina quale premessa per una conoscenza critica;<br />
− applicare gli strumenti tecnico-pratici (saper fare) per una corretta esecuzione <strong>di</strong> elaborati grafici alle<br />
<strong>di</strong>verse scale: dal particolare costruttivo alla scala urbana e del paesaggio, facendo anche riferimento ai<br />
co<strong>di</strong>ci del Disegno e alle normative grafiche UNI.<br />
Il tentativo è <strong>di</strong> coniugare la conoscenza e la pratica <strong>degli</strong> strumenti del <strong>di</strong>segno, dei principi geometrici e delle<br />
fondamentali tecniche <strong>di</strong> rappresentazione, con la capacità <strong>di</strong> comprensione dello spazio architettonico fino alla<br />
sua elaborazione concettuale. A partire da alcuni temi relativi all'esplorazione del rapporto tra Disegno <strong>di</strong><br />
<strong>Architettura</strong> e progetto, in linea con alcune specifiche riflessioni teoriche, si approfon<strong>di</strong>ranno le tematiche sul<br />
Disegno <strong>di</strong> <strong>Architettura</strong> contenute nei Trattati e nei testi manualistici.<br />
Questa esperienza si costruirà in una forma logica e razionale attraverso:<br />
− le lezioni teoriche (sapere), nelle quali si indagherà il rapporto tra architettura e scienza, tra arte e tecnica,<br />
instaurando una <strong>di</strong>namica interpretativa “fenomenologica” che dà un senso alle operazioni, un significato<br />
alle tecniche del mestiere, un senso all'insegnamento ed alla ricerca;<br />
− l’attività pratica del laboratorio progettuale (saper fare), ri-<strong>di</strong>segnando criticamente, al fine <strong>di</strong> desumerne i<br />
principi geometrici e compositivi, semplici progetti <strong>di</strong> architettura opportunamente scelti e riconosciuti<br />
rispetto al tema <strong>della</strong> casa intesa come fenomeno dell’abitare.<br />
Tema d’anno<br />
Il cubo e il lamione saranno il campo <strong>della</strong> conoscenza e <strong>della</strong> sperimentazione nello scomporre e ri-comporre<br />
forme, spazi e strutture strettamente legate al tema dell’abitazione.<br />
Coor<strong>di</strong>namento con altri corsi<br />
Il corso <strong>di</strong> Disegno dell’<strong>Architettura</strong> e il laboratorio Progettuale sono inseriti all’interno <strong>di</strong> un progetto più ampio <strong>di</strong><br />
collaborazione e cooperazione tra le <strong>di</strong>scipline <strong>della</strong> Storia, <strong>della</strong> Rappresentazione, dell’Urbanistica e <strong>della</strong><br />
Teoria e Tecnica <strong>della</strong> Progettazione, che sono racchiuse in un Laboratorio Progettuale <strong>di</strong> Genealogia.<br />
Il Laboratorio <strong>di</strong> Genealogia, collocato al primo anno, dovrà occuparsi <strong>della</strong> “iniziazione” dello studente al<br />
mestiere dell’Architetto, portato per mano dalla Storia. Attraverso l’albero genealogico delle “parole e cose”<br />
dell’<strong>Architettura</strong>, formuliamo come nasce qualcosa, come nasce un’idea.<br />
Il Laboratorio <strong>di</strong> Genealogia può essere un luogo in cui facilitare e guidare una esperienza, per maturare un<br />
contatto con la propria potenzialità, creatività, conoscere le proprie attitu<strong>di</strong>ni per meglio utilizzarle.
Articolazione dell'attività <strong>di</strong>dattica<br />
Il corso è annuale e prevede 11 cfu complessivi (8,5 cfu per l’insegnamento <strong>di</strong> Disegno dell’<strong>Architettura</strong> e 2,5 cfu<br />
per il Laboratorio progettuale). Per ogni cfu (pari a 25 ore) si prevede un impegno me<strong>di</strong>o da parte dello studente<br />
<strong>di</strong> 10 ore per la <strong>di</strong>dattica frontale (attività intra moenia)<br />
Sia le attività intra moenia che quelle extra moenia prevedono a loro volta una <strong>di</strong>stinzione fra attività destinate al:<br />
− sapere, e cioè alle lezioni ex cathedra e allo stu<strong>di</strong>o in<strong>di</strong>viduale <strong>della</strong> teoria;<br />
− saper fare, e cioè alle attività <strong>di</strong> esercizio del progetto, seminariali, <strong>di</strong> ricerca in biblioteca, <strong>di</strong> sopralluogo, <strong>di</strong><br />
esercitazione in aula, <strong>di</strong> viaggio <strong>di</strong> istruzione, ecc…<br />
Programmazione e organizzazione delle attivita' <strong>di</strong>dattiche<br />
Le lezioni e le esercitazioni riguarderanno le seguenti tematiche:<br />
− Fondamenti <strong>della</strong> rappresentazione.<br />
− Il Disegno come conoscenza: il Disegno dal vero.<br />
− Elementi <strong>di</strong> geometria proiettiva e proiezioni ortogonali.<br />
− Rappresentazione delle superfici generate da rotazione.<br />
− Gli archi e le volte semplici e composte.<br />
− Le proiezioni assonometriche. Il triangolo fondamentale delle tracce.<br />
− Prospettiva ed elementi riferimento.<br />
− Proiezioni quotate.<br />
− Rappresentazione dell’architettura e del territorio, lettura <strong>degli</strong> elementi cartografici <strong>di</strong> base.<br />
− Teoria delle ombre e applicazioni.<br />
− La comprensione <strong>degli</strong> elementi or<strong>di</strong>natori dell’architettura.<br />
− Disegno dell'architettura storica: gli or<strong>di</strong>ni e gli stili.<br />
− Co<strong>di</strong>ci e norme <strong>di</strong> unificazione.<br />
Modalità d'esame<br />
L’esame finale, consisterà nella valutazione dell’intero percorso formativo dello studente e nella valutazione <strong>della</strong><br />
qualità <strong>degli</strong> elaborati grafici prodotti durante l’anno. Le tavole dovranno essere redatte nelle tecniche e nei<br />
formati che saranno in<strong>di</strong>cati durante il corso. L’esame prevede altresì un colloquio sui temi teorici trattati tendente<br />
a valutare il livello critico raggiunto dallo studente sui temi <strong>della</strong> rappresentazione dell’architettura e del paesaggio.<br />
LABORATORIO PROGETTUALE DI GENEALOGIA DELL’ARCHITETTURA<br />
Laboratorio Progettuale <strong>di</strong> Disegno dell’<strong>Architettura</strong> - CFU 2,5<br />
Ph.D. Arch. Maria Onorina Panza, Tutor Arch. Egi<strong>di</strong>o Buonamassa<br />
Nell’ambito del LABORATORIO DI GENEALOGIA le attività del Laboratorio progettuale <strong>di</strong> Disegno<br />
dell’<strong>Architettura</strong>, nello specifico e secondo successivi momenti <strong>di</strong> avvicinamento, affronterà il tema <strong>della</strong> casa e<br />
dell’abitare, dalla concezione e rappresentazione geometrico-formale a quella poetico-espressiva dello spazio.<br />
Primo momento sarà quello <strong>della</strong> conoscenza <strong>della</strong> forma e dello spazio per mezzo <strong>di</strong> schede <strong>di</strong> presentazione <strong>di</strong><br />
architetture moderne e contemporanee, scelte in base alla specificità con cui ciascuna affronta e sviluppa il tema<br />
dell’abitazione; il secondo consisterà nel ri-<strong>di</strong>segno, e quin<strong>di</strong> nella rappresentazione delle stesse architetture al<br />
fine <strong>di</strong> condurre lo studente verso una sorta <strong>di</strong> appropriazione <strong>della</strong> realtà costruita o anche soltanto progettata, la<br />
quale avverrà sia attraverso la realizzazione <strong>di</strong> elaborati classici quali piante, prospetti, sezioni e viste<br />
prospettiche ed assonometriche, sia per mezzo <strong>di</strong> analisi grafiche tematizzate che mirano ad estrapolare i<br />
contenuti <strong>di</strong> natura spaziale, tipologica, strutturale delle architetture. La conoscenza spaziale sarà praticata<br />
attraverso la costruzione in scala <strong>di</strong> un modello <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o per agevolare la comprensione <strong>della</strong> composizione <strong>degli</strong><br />
elementi e delle parti e la loro corretta rappresentazione nel passaggio dalla realtà tri<strong>di</strong>mensionale alla sua<br />
immagine bi<strong>di</strong>mensionale e viceversa. L’esito finale porterà lo studente ad una conoscenza profonda delle<br />
architetture attraverso l’in<strong>di</strong>viduazione <strong>della</strong> geometria costruttiva in un processo <strong>di</strong> lettura critica dello spazio<br />
architettonico. L'obiettivo è quello <strong>di</strong> fornire gli strumenti teorici e pratici per affrontare la conoscenza del<br />
fenomeno architettonico attraverso proce<strong>di</strong>menti logico-descrittive e geometrico-formali.<br />
Tema d’anno<br />
Il cubo e il lamione saranno oggetto <strong>di</strong> sperimentazione ed esercizio nello scomporre e ri-comporre forme, spazi<br />
e strutture strettamente legate al tema dell’abitazione in un luogo in<strong>di</strong>viduato nei Sassi <strong>di</strong> Matera.
Contenuti integrati nel Laboratorio <strong>di</strong> Genealogia:<br />
− Il progetto architettonico: lettura critica e scomposizione <strong>di</strong> piccole opere architettoniche;<br />
− La creatività: l’ideazione dell’opera. Lo schizzo <strong>di</strong> architettura come atto fondativo;<br />
− L’arte: per leggere la realtà in maniera sensibile;<br />
− La cooperazione: come risorsa evolutiva del lavoro collettivo in architettura;<br />
− costruire la Comunità: la cooperazione nella costruzione delle gran<strong>di</strong> opere classiche fino alle cattedrali.<br />
− La genesi: l’albero genealogico dell’opera <strong>di</strong> architettura;<br />
− I modelli: innamorarsi <strong>di</strong> un maestro e imitarlo;<br />
− Eventi: un evento al mese: mostre, seminari, conferenze, viaggi, incontri con esperti, concorsi, workshop,<br />
visite guidate….<br />
Programmazione e organizzazione delle attività <strong>di</strong>dattiche<br />
Le esercitazioni riguarderanno le seguenti tematiche:<br />
1. Il <strong>di</strong>segno come conoscenza:<br />
1.1. il <strong>di</strong>segno dal vero, tecniche e strumenti. Il taccuino (architettura realizzata, <strong>di</strong>segno dell’antico,<br />
architettura <strong>di</strong>segnata, rione dei Sassi, variazioni sul tema, osservare il paesaggio; i segni<br />
dell’architettura e del paesaggio osservare e interpretare: ri-produzione <strong>di</strong> texture);<br />
1.2. ricerca sugli schizzi dei maestri. Ri<strong>di</strong>segno sperimentando le tecniche grafiche e compositive;<br />
2. Il <strong>di</strong>segno come <strong>di</strong>chiarazione d’amore:<br />
2.1. in<strong>di</strong>viduare le affinità, le vocazioni, le attitu<strong>di</strong>ni che ciascuno studente sente <strong>di</strong> avere nei confronti delle<br />
opere <strong>di</strong> un Maestro;<br />
3. Rapporti notevoli:<br />
3.1. <strong>Architettura</strong> storica, strutture geometriche e proporzioni: Il <strong>di</strong>segno <strong>degli</strong> or<strong>di</strong>ni;<br />
4. Convenzioni e norme grafiche:<br />
4.1. normativa UNI. La comunicazione <strong>della</strong> forma architettonica avviene attraverso il Disegno; esercizio <strong>di</strong><br />
ri<strong>di</strong>segno <strong>di</strong> pagine <strong>di</strong> manuali;<br />
5. Il rapporto aureo e la geometria del quadrato:<br />
5.1. esercizi <strong>di</strong> scomposizione e ricomposizione a partire dalla matrice quadrata;<br />
6. Osservare:<br />
6.1. lettura critica e ri<strong>di</strong>segno <strong>di</strong> case e ville del Palla<strong>di</strong>o;<br />
6.2. lettura critica e ri<strong>di</strong>segno <strong>di</strong> case <strong>di</strong> maestri del ‘900 (Mies, Kahn, Le Corbusier, Loos,……);<br />
6.3. riconoscimento ed in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong> una possibile matrice quadrata e cubica nelle abitazioni dei Sassi;<br />
7. Scomporre:<br />
7.1. <strong>di</strong>segnare e scomporre un elemento architettonico (porta, finestra, paramento murario, scala,<br />
camino ……..). Il modello nel dettaglio <strong>della</strong> costruzione;<br />
8. Comporre:<br />
8.1. il muro e la colonna, la porta e la finestra: elementi che definiscono un organismo architettonico;<br />
8.2. a partire da una matrice quadrata, impostare una maglia strutturale (continua, puntuale, mista), <strong>di</strong> un<br />
piccolo organismo architettonico;<br />
9. Montaggio: seminario sulle tecniche e sui materiali e le procedure costruttive per realizzare un buon<br />
modello <strong>di</strong> architettura.<br />
Elaborati finali<br />
Gli studenti dovranno presentare delle tavole in formato A3/A2/A1 (secondo un layout comune da concordare con<br />
le altre <strong>di</strong>scipline) al termine <strong>di</strong> ogni esercitazione. Il taccuino sarà presentato ogni venerdì e dovrà contenere<br />
almeno un <strong>di</strong>segno <strong>di</strong> una delle categorie in<strong>di</strong>cate.<br />
Bibliografia essenziale:<br />
Per la storia, le tecniche e i co<strong>di</strong>ci del <strong>di</strong>segno dell’architettura:<br />
− M. VITRUVIO POLLIONE, DE ARCHITECTURA, libri X.<br />
− L. B. ALBERTI, DE RE AEDIFICATORIA, libri X, 1450.<br />
− A. PALLADIO, I QUATTRO LIBRI DELL’ARCHITETTURA, 1570, riproduzione in fac-simile, Hoepli, Milano 1980.<br />
− D.DONGHI, MANUALE DELL'ARCHITETTO, G.Cilenti, Venezia 1905.
− A.A.V.V., MANUALE DELL'ARCHITETTO, ed.CNR 1946 e successive.<br />
− V. FASOLO, ANALISI GRAFICA DEI VALORI ARCHITETTONICI, Roma<br />
− G. DE FIORE, DIZIONARIO DEL DISEGNO, La Scuola, Brescia 1967.<br />
− G. DE FIORE, LA FIGURAZIONE DELLO SPAZIO ARCHITETTONICO, Genova 1967.<br />
− G. GUIDANO, P. CEROTTO, A. CONTE, E. TOLLA, DISEGNO. TEORIA E APPLICAZIONI, Ermes, Potenza 1991.<br />
− R. DE RUBERTIS, IL DISEGNO NELL’ARCHITETTURA, N.I.S., Roma 1994.<br />
− A. CONTE, IL DISEGNO DEI MANUALI, Ermes, Potenza 1996.<br />
− E. NEUFERT, ENCICLOPEDIA PRATICA PER PROGETTARE E COSTRUIRE, Hoepli, Milano 1999.<br />
− C.MEZZETTI, (a cura <strong>di</strong>), IL DISEGNO DELL’ARCHITETTURA ITALIANA NEL XX SECOLO, Kappa, Roma 2003.<br />
− G. DI NAPOLI, DISEGNARE E CONOSCERE, Einau<strong>di</strong>, Torino, 2004<br />
Per la geometria descrittiva:<br />
− U.SACCARDI, APPLICAZIONI DI GEOMETRIA DESCRITTIVA, E<strong>di</strong>trice Fiorentina, Firenze 1977.<br />
− M. DOCCI, R. MIGLIARI, LA SCIENZA DELLA RAPPRESENTAZIONE, N.I.S., Roma 1992<br />
− R. MIGLIARI, GEOMETRIA DEI MODELLI, E<strong>di</strong>zioni Kappa, Roma, 2003.