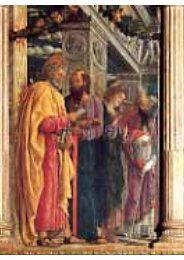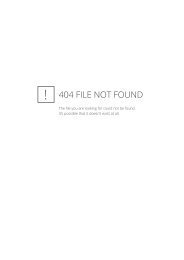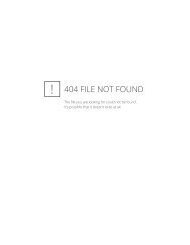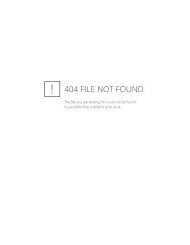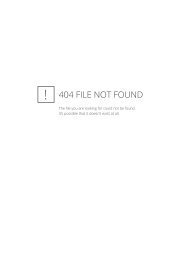Il detto di Anassimandro per Nietzsche e Heidegger - Liceo Classico ...
Il detto di Anassimandro per Nietzsche e Heidegger - Liceo Classico ...
Il detto di Anassimandro per Nietzsche e Heidegger - Liceo Classico ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Lezione 1.4<br />
<strong>Il</strong> <strong>detto</strong> <strong>di</strong> <strong>Anassimandro</strong> <strong>per</strong> <strong>Nietzsche</strong> e <strong>Heidegger</strong><br />
Nel saggio del 1946, <strong>Il</strong> <strong>detto</strong> <strong>di</strong> <strong>Anassimandro</strong>, raccolto in Sentieri interrotti, Martin <strong>Heidegger</strong><br />
riporta e commenta la traduzione del <strong>detto</strong> fatta da <strong>Nietzsche</strong> ne La filosofia nell’epoca tragica dei<br />
greci (1873):<br />
«Là da dove le cose hanno il loro nascimento, debbono anche andare a finire, secondo la necessità.<br />
Esse debbono infatti fare ammenda ed esser giu<strong>di</strong>cate <strong>per</strong> la loro ingiustizia, secondo l’or<strong>di</strong>ne del<br />
tempo» (pag.299). Aggiunge inoltre la traduzione fatta da Hermann Diels nei Frammenti dei<br />
presocratici, che non si <strong>di</strong>scosta molto dal testo <strong>di</strong> <strong>Nietzsche</strong>.<br />
<strong>Nietzsche</strong> aveva attribuito ad <strong>Anassimandro</strong> la nascita del pensiero astratto e della filosofia in<br />
quanto scrittura. Una scrittura tersa, alta, incontrovertibile che inaugurava la parola filosofica come<br />
parola metafisica. <strong>Nietzsche</strong> aveva <strong>per</strong>ò anche interpretato il <strong>detto</strong> come descrizione del destino<br />
umano, inevitabilmente portato a finire e <strong>per</strong>ciò “triste”. E aveva attribuito questa metafisica triste<br />
all’impossibilità <strong>di</strong> pensare un destino <strong>di</strong>verso <strong>per</strong> la natura umana.<br />
<strong>Nietzsche</strong> aveva anche rintracciato una possibilità dell’umano <strong>di</strong> fuoriuscire da quel destino qualora<br />
avesse inteso nascita e morte come facenti parti <strong>di</strong> un ciclo del ritorno, valevole <strong>per</strong> l’intero cosmo e<br />
in grado così <strong>di</strong> <strong>di</strong>ssolvere la tristezza della sorte precostituita dell’umanità.<br />
Egli aveva intuito, da una parte la natura umana come natura in generale, il cui tempo ciclico offre<br />
la chance della riconquista <strong>di</strong> sé che è negata allo storicismo e alla metafisica occidentale; dall’altra<br />
aveva scorto nel <strong>detto</strong> <strong>di</strong> <strong>Anassimandro</strong> il <strong>di</strong>venire, nel nucleo dell’eterno ritorno, in cui consiste la<br />
possibilità dell’umano <strong>di</strong> annullare la separatezza dalla natura e dalle astrazioni della storia.<br />
<strong>Heidegger</strong> accoglie l’interpretazione nietzscheana <strong>di</strong> <strong>Anassimandro</strong>, ma la completa, chiedendosi<br />
cosa davvero il <strong>detto</strong> voglia <strong>di</strong>re – ammettendo che siano proprio quelle le parole pronunciate dal<br />
filosofo <strong>di</strong> Samo – e <strong>per</strong>ché il pensiero successivo le abbia interpretate nel senso sud<strong>detto</strong>.<br />
Inizia con queste domande un <strong>per</strong>corso filologico e filosofico che tenta <strong>di</strong> trovare nelle due frasi del<br />
<strong>detto</strong> l’essenza del pensiero greco, a partire dalla inevitabile <strong>di</strong>storsione che <strong>di</strong> esso Platone,<br />
Aristotele e poi Hegel, hanno o<strong>per</strong>ato. «L’unico pensatore che abbia compreso, pensando, la storia<br />
del pensiero, è Hegel…(egli) è fra i sostenitori dell’opinione predominante sul carattere classico<br />
della filosofia <strong>di</strong> Platone e <strong>di</strong> Aristotele» (pag. 301.<br />
E’ anzitutto questa interpretazione del pensiero greco che <strong>Heidegger</strong> contesta, <strong>di</strong>mostrando che<br />
<strong>Anassimandro</strong> e i filosofi precedenti a Socrate avevano in realtà pensato la natura, il logos, e<br />
l’essenza dell’essere; il <strong>detto</strong> è <strong>per</strong>tanto una testimonianza <strong>di</strong> sviluppo del pensiero non una istanza<br />
prefilosofica o mitica.<br />
Nella concezione della natura, si misura la <strong>di</strong>stanza tra i presocratici e Aristotele che designa la<br />
φυσισ come una porzione dell’essere costituita da enti che nascono <strong>per</strong> virtù propria, e la<br />
contrappone alla τèkνε, i cui prodotti sono realizzati dall’uomo.<br />
Secondo questo pensiero, lontano dall’idea <strong>di</strong> φυσισ che avevano i filosofi precedenti a Platone,<br />
idea che non faceva <strong>di</strong>fferenza tra creazione e produzione, Teofrasto nelle Fusikon doxai, le<br />
opinioni dei fisici, impone il para<strong>di</strong>gma della filosofia greca che assegna a quei filosofi l’epiteto <strong>di</strong><br />
naturalisti <strong>per</strong> contrapporli allo sviluppo successivo della scienza.<br />
Secondo <strong>Heidegger</strong> è arrivato il tempo in cui l’Occidente, come terra del tramonto, della sera<br />
(Lands des Abends), in una caratteristica visione ciclica <strong>di</strong> ciò che ricorre, reinterpreti il <strong>detto</strong>,<br />
considerandolo una delle migliori testimonianze del tempo degli inizi, dell’alba del pensiero. Un<br />
tempo in cui veniva nominato e pensato l’essere e in cui si tentava una descrizione dell’essenza<br />
dell’essere, che la metafisica occidentale ha poi <strong>di</strong>menticato: « Se penseremo in base all’escatologia<br />
dell’essere, dovremo un giorno aspettare l’estremo del mattino nell’estremo della sera, e dovremo<br />
imparare oggi a me<strong>di</strong>tare così su ciò che è all’estremo» (pag.305).
Per far questo è necessario ricostruire, la verità del <strong>detto</strong> e tentare quin<strong>di</strong> un interpretazione<br />
dell’essenza dell’essere come adombrata dal <strong>detto</strong>.<br />
Secondo <strong>Heidegger</strong>, il <strong>detto</strong> che è composto <strong>di</strong> due parti, parla degli enti (τα οντα) e nomina la loro<br />
molteplicità. Gli enti sono tutti gli enti, in quanto φυσει οντα, enti <strong>di</strong> natura che comprendono<br />
anche «…gli uomini e le cose da essi prodotte, le situazione e le circostanze derivate dal fare…»<br />
(pag.308), cioè il tutto dell’ente.<br />
Gli enti dunque non sono solo i φυσει οντα intesi Teofrasto e Aristotele, ma la moltitu<strong>di</strong>ne degli<br />
enti. Inoltre gli enti hanno qui una qualità essenziale che nella traduzione è stata tralasciata: il <strong>detto</strong><br />
infatti parla della loro sorte: «…si parla dell’ente mentre si enuncia l’essere», e tale è il <strong>di</strong>venire<br />
degli enti, secondo l’intuizione <strong>di</strong> <strong>Nietzsche</strong> dell’identità <strong>di</strong> essere e <strong>di</strong>venire: «Imprimere al<br />
<strong>di</strong>venire il carattere dell’essere, questa è la suprema volontà <strong>di</strong> potenza… L’essere <strong>di</strong> cui <strong>Nietzsche</strong><br />
parla qui è “l’eterno ritorno dell’eguale”…» (pag.310).<br />
Tuttavia questo ente e quell’essere <strong>di</strong> cui nel <strong>detto</strong> si scorge il profilo, non sono nè manifesti nè<br />
comprensibili. Sono piuttosto nascosti, e il loro senso sfugge. Questa infatti è la loro essenza, il<br />
nascon<strong>di</strong>mento e la variabilità nella loro interpretazione, qualità che ineriscono alla verità<br />
dell’essere: La verità (Αλèτη) greca infatti è il non-nascon<strong>di</strong>mento dell’ente, ed è l’unica situazione<br />
in cui l’ente che si manifesta allude alla propra essenza. L’essere dell’ente come verità, cioè come<br />
non-nascon<strong>di</strong>mento, enuncia infatti sia il carattere nascosto dell’ente, sia la necessità <strong>di</strong> un ente<br />
particolare, l’essere umano (Da-sein), che, come Esser-ci istituisce una corrispondenza, attraverso<br />
l’interpretazione, con la storicità dell’essere, “il carattere epocale dell’essere”.<br />
Da questa argomentazione proviene la possibilità <strong>di</strong> una ricostruzione del <strong>detto</strong> più vicina alla sua<br />
realtà. <strong>Heidegger</strong> infatti accoglie la lezione <strong>di</strong> John Burnet secondo cui la prima parte del <strong>detto</strong> non<br />
sarebbe <strong>di</strong> <strong>Anassimandro</strong>, ma una aggiunta tarda <strong>di</strong> epoca aristotelica. <strong>Il</strong> vero <strong>detto</strong> si limiterebbe a<br />
queste parole: «…secondo la necessità: infatti esse pagano reciprocamente l’ammenda e il fio della<br />
loro ingiustizia». <strong>Heidegger</strong> lo interpreta come riferito alla nascita e al <strong>per</strong>ire <strong>di</strong> tutti gli enti; «<strong>di</strong> ciò<br />
che, venendo innanzi, <strong>per</strong>viene nel non-esser-nascosto e che, qui <strong>per</strong>venuto, andando via scompare»<br />
(pag.319).<br />
Troviamo questa determinazione dell’ente <strong>per</strong> la prima volta in Omero, secondo cui το òν, l’essente<br />
è tale nel duplice significato <strong>di</strong> essere un ente e un ente che è (cfr, pag.321). Το òν dunque significa<br />
sia l’essente presente, cioè ciò che è singolarmente presente, sia l’essente presente-presente, cioè<br />
tutto ciò che è in quanto presente. Esso comprende dunque anche l’essente non presente, come<br />
modalità dell’esser presente degli enti. <strong>Il</strong> veggente «sta <strong>di</strong> fronte all’essente presente e al non-esser<br />
nascosto che esso porta con sé e che ha illuminato anche l’esser nascosto dell’essente in quanto<br />
assente» (pag.323).<br />
<strong>Anassimandro</strong> in quanto veggente, conclu<strong>di</strong>amo noi, osserva l’ente nella sua interezza, vi si porta <strong>di</strong><br />
fronte come osservatore ed annuncia l’unicità <strong>di</strong> esso, come essente presente e assente (pag.324).<br />
Egli lo preserva, se ne prende cura, lo salvaguarda: egli infatti, come veggente ha visto tutto,<br />
l’intero tempo dell’ente e lo conosce: «La visione non è dterminata dagli occhi, ma<br />
dall’illuminazione dell’essere». Nel suo <strong>di</strong>venire l’essente-presente presente soggiorna nel<br />
<strong>per</strong>venire e nell’andar via e in questo mantenimento nel presente entra in conflitto con l’essenza del<br />
<strong>di</strong>venire, che non prevede alcun soggiorno, bensì la <strong>di</strong>namica continua degli enti dalla presenza<br />
verso l’assenza.<br />
Così, «…all’aurora del pensiero, essere significa l’esser presente, nel senso del raccoglimento<br />
illuminante-custodente che costituisce il Logos. <strong>Il</strong> Logos (legein, raccogliere, riunire), è concepito a<br />
partire dalla Aletheia, il custo<strong>di</strong>mento <strong>di</strong>svelante. Nella essenza contrastante <strong>di</strong> essa si nasconde<br />
l’essenza pensata <strong>di</strong> Eris e Moira, nomi coi quali è anche designata la Fusis» (pag. 328).<br />
<strong>Il</strong> quadro del <strong>detto</strong> dunque si compone: gli enti, rivelati nella loro essenza, si costituiscono in un<br />
conflitto produttivo tra il <strong>di</strong>venire cosmico e la volontà della loro <strong>per</strong>sistenza, conflitto raccolto nel<br />
Logos come verità del loro essere, verità che è fusis, totalità della natura.<br />
Ma <strong>di</strong> quale ingiustizia sono latori gli enti che devono pagare il fio? Essi sono soggetti della e alla<br />
non connessione, del e al contrasto tra <strong>per</strong>sistenza e <strong>di</strong>venire, rispetto a cui dovrebbero invece dare
connessione (διδοναι δικεν, pag. 333). <strong>Il</strong> <strong>di</strong>saccordo è quello tra e degli enti in relazione alla<br />
φυσισ in cui sono contenuti: «oggi soggiornante si erge contro gli altri», e tuttavia non ostinandosi<br />
in questa <strong>per</strong>sistenza (si) rendono giustizia. Questa giustizia è, secondo <strong>Heidegger</strong> una modalità del<br />
lasciar-appartenere degli enti alla φυσισ e tra loro.<br />
Dunque, benché irriguardosi gli uni gli altri, gli enti si lasciano appartenere secondo l’accordo del<br />
<strong>di</strong>venire e questo lasciar appartenere sarebbe il modo in cui il via via soggiornante soggiorna ed è<br />
presente come essente-presente (cfr., pag338). Così essere ed ente non risultano <strong>di</strong>stinti,<br />
<strong>di</strong>versamente da come li ha intesi la metafisica successiva, in cui l’«oblio dell’essere è l’oblio della<br />
<strong>di</strong>fferenza fra l’essere e l’ente» (pag.340).<br />
<strong>Il</strong> <strong>detto</strong> dunque menziona la con<strong>di</strong>zione della totalità degli enti a partire dalla loro essenza che è<br />
nominata, all’inizio del <strong>detto</strong>, come Το χρεον, secondo l’”uso”, il “bisogno”; <strong>Heidegger</strong> tuttavia<br />
traduce secondo il mantenimento, <strong>per</strong> cui il <strong>detto</strong> suonerebbe: «…lungo il mantenimento; essi<br />
lasciano infatti appartenere l’accordo e quin<strong>di</strong> anche la cura-riguardosa dell’uno <strong>per</strong> l’altro (nella<br />
risoluzione) del <strong>di</strong>saccordo.» (pag. 347).



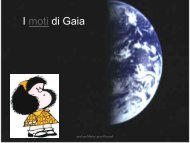





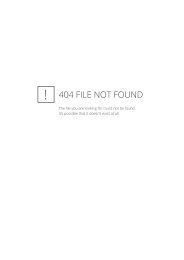
![programmazione 4 2012-2013[1].pdf](https://img.yumpu.com/38617259/1/190x245/programmazione-4-2012-20131pdf.jpg?quality=85)
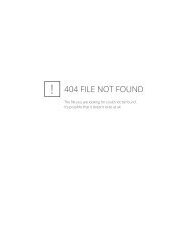
![PROGRAMMAZONE Italiano storia geo 2012 2013 IV D[1].pdf](https://img.yumpu.com/38617257/1/190x245/programmazone-italiano-storia-geo-2012-2013-iv-d1pdf.jpg?quality=85)