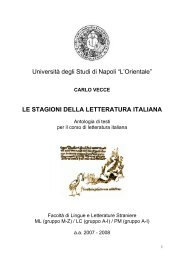1 L'APPROCCIO DI GOFFMAN ALL'INTERAZIONE ... - Sociologia
1 L'APPROCCIO DI GOFFMAN ALL'INTERAZIONE ... - Sociologia
1 L'APPROCCIO DI GOFFMAN ALL'INTERAZIONE ... - Sociologia
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
L’APPROCCIO <strong>DI</strong> <strong>GOFFMAN</strong>ALL’INTERAZIONE FACCIA A FACCIAAdam KendonTraduzione italiana di Maria GrazianoOriginal title: “Erving Goffman's approach to the study of face-to-faceinteraction.” In A. Wootton and P. Drew (a cura di), Erving Goffman:Exploring the Interaction Order. Cambridge: Polity Press, 1988, pp. 14-40.L’INTERAZIONE FACCIA A FACCIA COME CAMPO <strong>DI</strong> STU<strong>DI</strong>O AUTONOMOIn questo articolo passerò in rassegna alcuni concetti che Goffman hasviluppato per lo studio dell’interazione faccia a faccia. Il mio intento èquello di mostrare che questi concetti forniscono un’intelaiatura moltogenerale in base a cui può essere condotto uno studio completamenteintegrato dell’interazione.Come affermerò alla fine dell’articolo, una maggiore sfida teoricache gli studiosi dell’interazione affrontano è quella di mostrare come lecomponenti del comportamento umano, che hanno un ruolonell’interazione e che sono così apparentemente differenti, siano invecearticolate l’una in relazione all’altra. Specialmente nei suoi ultimi scritti,Goffman si è dato da fare per ricordarci che l’interazione faccia a faccia ingenerale, e la conversazione in particolare, è lungi dall’essere una questionedi sole parole. Così facendo, egli ha indicato la strada da seguire perarrivare ad una comprensione veramente integrata del comportamentocomunicativo umano. Io credo che un ulteriore sviluppo dell’intelaiaturache è implicita nel lavoro di Goffman su questo argomento sia il modomigliore per arrivare ad una teoria dell’interazione faccia a faccia checonsentirà di avere una visione integrata dell’interazione.Comincerò ad esaminare l’affermazione di Goffman secondo cui lostudio dell’interazione faccia a faccia dovrebbe essere considerata unabranca della sociologia a se stante. Lo studioso ha suggerito l’esistenza diciò che lui ha chiamato “ordine dell’interazione” (Goffman, 1983; trad. it.Goffman 1998) che può essere considerato come un campo di studio a sé.Questa convinzione è espressa in alcuni dei suoi primi scritti. La si può1
trovare nella sua tesi di dottorato (Goffman 1953) e costituisce la premessaprincipale di alcuni suoi primi articoli, come “On face work” (1955; trad. it.“Giochi di faccia” in Goffman 1971a) e “Alienation from interaction”(1957; trad. it. “Alienazione dall’interazione” in Goffman 1971a); ed èesplicita nella prefazione di “Encounters” (1961; trad. it. Espressione eidentità 2003). Egli sostiene ripetutamente la stessa idea nei lavorisuccessivi, come nelle pagine introduttive di Behavior in Public Places(1963; trad. it. Il comportamento in pubblico, 1971b), nella prefazione diInteraction ritual (1967; trad. it. 1971a) e nelle prefazioni di StrategicInteraction (1969; trad. it. Interazione strategica 1988) e Relations inPublic (1971c; trad. it. Relazioni in pubblico 1981). Il modo in cuipresenta e difende quest’idea cambia un po’ da un lavoro all’altro. Unconfronto tra loro è istruttivo, perché suggerisce come il contesto teorico, incui Goffman si aspetta che i suoi lavori siano inclusi, cambia da unapubblicazione all’altra.In Encounters (Espressione e identità), scritto nel 1961, quando lostudio dei “piccoli gruppi” era molto popolare in sociologia e nellapsicologia sociale, l’interesse di Goffman è di mostrare che lo studiodell’interazione, così come lui lo concepiva, è diverso dallo studio dei“piccoli gruppi”. Egli afferma che le unità di organizzazione, come iraggruppamenti focalizzati o gli incontri, non sono la stessa cosa dei“piccoli gruppi”, come le bande, la famiglia, i plotoni militari o i gruppidelle psicoterapie. Sebbene ci siano delle similitudini – per esempio igruppi, come i raggruppamenti, hanno delle regole di reclutamento e normedi comportamento a cui i membri devono aderire se vogliono continuare aparteciparvi – nello studio dell’interazione in quanto tale bisogna occuparsidi molte questioni che sembrano irrilevanti per lo studio dei gruppi. Questecomprendono la questione della gestione delle attività, come il problemadella regolazione del perdere o assumere il ruolo di parlante o ladistribuzione dei partecipanti nello spazio.In Behavior in Public Places (Il comportamento in pubblico)troviamo un’enfasi diversa, c’è il tentativo evidente di giustificare lo studiodell’interazione come una branca della sociologia indipendente. Goffmanqui propone una nozione di “ordine pubblico” con cui intende l’ordine cheregola il comportamento delle persone quando si trovano nell’immediatapresenza l’una dell’altra. L’ “ordine pubblico” è proposto come una speciedi “ordine sociale” e quest’ultimo è definito come “l’effetto di qualsiasiinsieme di norme morali che regoli il modo in cui le persone perseguono iloro obiettivi” (Goffman 1963: 8; trad. it., 1971, p. 10). E continua:“L’insieme di norme non specifica gli obiettivi che devono essereperseguiti, né lo schema formato da e per mezzo della coordinazione o2
integrazione di questi fini, ma semplicemente i mezzi per perseguirli”. Ilregolamento stradale ed il conseguente ordine del traffico ne sono un chiaroesempio. Il campo dell’interazione faccia a faccia, quindi, deve occuparsidelle “regole del traffico” dell’interazione e non del perché le personeinteragiscono o cosa ottengono quando lo fanno. L’ “ordine pubblico”,visto come una specie di “ordine sociale” si può paragonare all’ “ordinegiuridico” o all’ “ordine economico” di una società. In quanto tale ha lostesso diritto dell’ordine giuridico o dell’ordine economico di essere unostudio indipendente. Nel proporre un campo di studio in questi termini,credo che possiamo scoprire il primo tentativo più o meno chiaro diGoffman di proporre, pubblicamente, lo studio dell’interazione come unabranca della sociologia indipendente e di conseguenza il tentativo disostenere l’importanza dell’area di fronte ai colleghi sociologi (Goffmanaveva già sostenuto questa idea nella sua tesi, come è stato messo in rilievoda Leeds-Hurwitz, 1986).Nella prefazione di Interaction Ritual (Il rituale dell’interazione),scritto nel 1967, il suo interesse è dimostrare che ciò che sta propugnandonon deve essere confuso con la psicologia. In questa prefazione egli attiral’attenzione sull’allora recente comparsa di interesse per ciò che talvolta èchiamato “comportamento non-verbale” o “comunicazione non-verbale”(sebbene Goffman non usi questi termini). Questo interesse si sviluppò ingran parte grazie agli psicologi e qui Goffman afferma che nel campo dellostudio dell’interazione, così come lui lo intendeva, la psicologiadell’individuo non è l’interesse primario. In questo studio dobbiamooccuparci, certo, di “sguardi, gesti, atteggiamenti e affermazioni verbali”(Goffman, 1967: 1; trad. it., 1988, p. 3), che i partecipanti all’interazioneproducono continuamente, perché questi sono “i segni esterioridell’orientazione e della partecipazione”; tuttavia, ciò che interessa non è lapsicologia dell’orientazione e della partecipazione ma la loroorganizzazione sociale. Continua dicendo: “Io parto dal presupposto chel’oggetto dello studio della interazione non debba essere l’individuo e lasua psicologia, ma piuttosto le relazioni sintattiche esistenti fra gli atti dipersone che vengono a trovarsi a contatto diretto” (Goffman, 1967: 2; trad.it., 1988, p. 5).In Strategic Interaction (Interazione strategica) (1969) Goffman siinteressa di stabilire lo studio dell’interazione in modo ancora più esplicito.Nella prefazione a questo libro afferma che il suo “scopo primario” è“sviluppare lo studio dell’interazione faccia a faccia come camponaturalmente delimitato, analiticamente coerente – una sotto area dellasociologia” (p. ix). Continua poi sollevando la questione della“comunicazione” e, come era diventato un luogo comune in quel periodo,3
se fosse appropriato dire che ogni tipo di interazione è comunicazione.L’argomento di Goffman in Strategic Interaction è che ci sono dei limiti aciò che possiamo chiamare “comunicazione” e che questi limiti non sonogli stessi di ciò che possiamo chiamare “interazione”.Quando arriviamo a Relations in Public (Relazioni in pubblico)(1971; trad. it., 1981) vediamo che Goffman si rende conto che eracominciato ad emergere qualcosa di ciò che stava chiedendo. Nota chealcuni studiosi, in particolare alcuni linguisti ed etologi, erano impegnati inun’impresa parallela alla sua. Suggerisce di chiamare quest’area “etologiadell’interazione” sebbene si affanni a mettere in evidenza che noi “cisbarazziamo cortesemente” (Goffman, trad. it., 1981, p. 9) della visionedarwiniana degli etologi, pur riconoscendo che i loro metodi corrispondonobene al tipo di domande che spera di sollevare e perseguire. In particolare,appoggia i metodi di questo tipo di ricercatori, mentre critica severamente imetodi della psicologia e della sociologia sperimentale, da cui sembradistanziarsi consapevolmente.Dieci anni dopo, in Forms of Talk (1981b; trad. it. Forme del parlare1987) non c’è più bisogno di descrivere e giustificare il campo in quantotale. Gli articoli di questa raccolta sono ora rivolti ad altri che, come lui,hanno intrapreso lo studio delle pratiche dell’interazione. Le questionisollevate, riguardanti il ruolo del linguaggio nell’interazione, sonopresentate come questioni importanti da discutere in quello che èconsiderato un campo ormai già affermato.Alla fine della sua carriera, nel discorso come presidentedell’Associazione Sociologica Americana – intitolato “The interactionorder” (1983, trad. it. L’ordine dell’interazione (1998) – discute ancora ilposto che lo studio dell’ordine dell’interazione occupa nella sociologia. Inquesto discorso tenta di spiegare esaurientemente i modi in cui lo studiodell’ordine dell’interazione è allo stesso tempo distinto dallo studio deglialtri aspetti dell’ordine sociale ma anche collegato ad essi. Un problemacentrale in quest’articolo è la questione di come l’oggetto della macrosociologia– status, potere, strutture sociali ecc. – si collega al micro-studiodi particolari segmenti dell’interazione. Qui sembra interessato a mostrareche lo studio dell’ordine dell’interazione non solo è un interesse legittimodi per se stesso (in verità non c’è più bisogno di affermare questo perché ilcampo è oramai stabilito, almeno in modo informale), ma anche che puòdare un utile contributo per gli altri sotto-campi che interessano lasociologia.Vediamo allora come, nelle prime prefazioni e introduzioni,Goffman rende esplicito il suo scopo di stabilire un sotto-campo dellasociologia che deve occuparsi dell’interazione. Chiarisce l’oggetto di4
questo studio, ma si preoccupa di evidenziare che ciò che sta proponendonon fa parte dello studio dei “piccoli gruppi”, non fa parte dello studio dellapsicologia e non è lo studio della comunicazione. Scrivendo in questomodo, Goffman dà l’impressione di tentare di stabilire qualcosa dicompletamente nuovo. Afferma ripetutamente che si è prestata pocaattenzione allo studio dell’interazione, malgrado che il lavoro fatto suipiccoli gruppi, sulla psicologia sociale e sulla comunicazione avrebbedovuto suggerire il contrario.<strong>GOFFMAN</strong> E LO STU<strong>DI</strong>O DELL’INTERAZIONE NELLA SOCIOLOGIAAMERICANAA prima vista quest’enfasi sulla novità di questo campo sembra un po’strana. Lo studio della “interazione” come tradizione affermata nellescienze sociali americane era apparso molto prima che Goffman iniziasse lesue ricerche. Ad esempio, negli anni venti, i lettori americani poteronoleggere il lavoro di Georg Simmel (si veda Park e Burgess, 1924;Spykman, 1925). Il suo concetto di “sociologia formale” e il suo tentativodi descrivere le strutture della “pura socialità” che per lui si esemplificavanelle componenti del comportamento interpersonale è forse, nellasociologia americana, la prima esplicita presentazione dell’idea chel’interazione possa essere studiata come scienza a sé. Questo interesse siadattava bene alla linea di pensiero iniziata da William James (1890: vol. 2)e proseguita da George Herbert Mead (1934), nel cui lavoro l’ “io” non èvisto come attore ma come prodotto dell’interazione. Quest’idea favorìl’interesse per lo studio delle componenti dell’interazione e costituì unaparte importante dello sfondo che portò all’emergere dello studio empiricodell’interazione. Questo iniziò alla fine degli anni trenta, quando le primericerche furono condotte da studiosi come Eliot Chapple (1939, 1940),George Homans (1950), Robert Bales (1950; si veda anche Hare, Borgattae Bales, 1955) e Kurt Lewin e colleghi (per le “dinamiche nei piccoligruppi”) - il lavoro di Cartwright e Zander (1953) è il prodotto tipico diquesta tradizione. A questi primi studi seguì un gran numero di ricerchebasate sull’osservazione di occasioni naturali e su esperimenti fatti inlaboratorio. Sebbene Goffman mostri di essere influenzato dai primiricercatori, come Simmel e Mead, ad eccezione del lavoro basatosull’osservazione di situazioni naturali nella “ecologia psicologica” (adesempio, Barker e Wright 1955), lo studioso cita raramente questosuccessivo lavoro empirico sull’interazione. Leggendo fra le righe abbiamol’impressione che egli non debba molto a questa tradizione.5
Una più attenta riflessione mostra che Goffman aveva buone ragioniper non considerare questi lavori e per affermare che lo studiodell’interazione così come lui lo proponeva era qualcosa di nuovo.Vedremo che l’approccio di Goffman sollevava questioni completamentenuove. Nella tradizione a cui abbiamo appena fatto riferimento,l’interazione era studiata perché sembrava che potesse servire per risolverealtre questioni. Ad esempio, Chapple sviluppò l’ingegnoso metodo della“cronografia dell’interazione” come mezzo per “misurare le relazioniumane”. Come seguace dell’ “operazionalismo” di Percy Bridgman(Bridgman, 1936) non sopportava lo stile letterario degli antropologi sociali(era stato allievo di Lloyd Warner e aveva lavorato allo studio sulla“Yankee City”). Egli cercò di trovare un modo per osservare direttamentegli elementi di cui sono composti le relazioni umane; escogitò l’idea dimisurare il tempo che le persone passano ad interagire e, piùspecificamente, di misurare come le loro azioni sono organizzate nel tempol’una in relazione all’altra. Riuscì ad avere risultati molto interessanti; mapoiché usava lo studio dell’interazione come mezzo per arrivare ad unoscopo si limitò a misurare solo l’aspetto dell’interazione che gli serviva perraggiungere il risultato che più lo interessava. Similmente, Robert Bales, ilcui metodo dell’ “analisi del processo dell’interazione”, scatenò un vero eproprio fiume di articoli, sviluppò un sistema di categorizzazione degli“atti” interazionali, non perché fosse interessato all’interazione in sé maperché era interessato a comprendere aspetti come le dinamiche dileadership nei piccoli gruppi e come le persone in gruppo arrivassero arisolvere i problemi.Questi approcci si basavano sul concetto secondo cui i fenomeni diconsueto interesse della sociologia e della psicologia sociale – leadership,stratificazione sociale, organizzazione dell’autorità e simili – dovevanotrovare la loro ragion d’essere nell’adesione dei membri della società ad unmodello di atti interazionali specifici. Tali atti dovevano costituire i dati sucui la ricerca si doveva basare. Tuttavia, gli atti interazionali stessi nonerano studiati. Soltanto uno degli aspetti che li caratterizzava fu usato comemezzo attraverso cui studiare qualcos’altro. Goffman si rese conto diquesto e chiarì che ciò che interessava a lui era qualcosa di diverso:sollevare, cioè, la questione di come si verificasse l’interazione. Goffmanosservò, dunque giustamente, diverse volte nelle sue prefazioni, chel’interazione in quanto tale era stata poco considerata. Come scrive nellaprefazione di Relations in Public: “le pratiche dell’interazione sono stateutilizzare per chiarire altre cose, ma sono state trattate come se non ci fossebisogno di definirle o valga la pena di farlo” (Goffman, 1971: ix; trad. it.,1981, p. 3). E per Goffman, ovviamente, il problema consiste proprio nelle6
“pratiche dell’interazione”. Studiosi come Chapple e Bales semplicementedavano per scontato che le persone potessero interagire. Non studiarono ilmodo in cui le persone riuscissero a farlo o cosa fossero queste pratiche. Illoro interesse si concentrava interamente sui risultati dell’interazione;quello di Goffman sul modo in cui essa si realizzava, anzi, su come sipotesse verificare.Il tentativo di Goffman di stabilire lo studio delle pratichedell’interazione come campo indipendente non fu un tentativo isolato,sebbene egli si fosse reso conto, più chiaramente di molti altri, che ciò sistava cercando di fare era diverso da quello che normalmente siconsiderava come importante nell’interazione.Il riconoscimento dell’importanza delle questioni di comel’interazione si potesse verificare, il problema di cosa occorresse allepersone per essere in grado di interagire, era cominciato ad emergere nellavoro di diversi studiosi. Gregory Bateson era arrivato a formulare, nel1951, un approccio allo studio dell’interazione come sistema dicomunicazione e il suo interesse principale fu l’organizzazione di questosistema (Ruesch e Bateson, 1951). In questo fu molto influenzato daicontatti che ebbe con lo sviluppo della teoria dell’informazione e dellacibernetica (fu influenzato soprattutto da Norbert Weiner e von Neumann –si veda Heims, 1977) e dalla collaborazione con lo psichiatra interpersonaleJurgen Ruesch, (si veda Ruesch, 1972). Per Ruesch il problema nellapsicoterapia consisteva non tanto nelle dinamiche psicologiche interne delpaziente, quanto nel processo dell’interazione tra paziente e psichiatra.Similmente, alcuni sviluppi nella linguistica strutturale avevano portatostudiosi come Norman McQuown (1971) e Ray Birdwhistell (1952, 1970) acominciare ad esaminare il “materiale comportamentale” dell’interazionecon uno spirito completamente affine a quello che Goffman stesso avrebbeproposto in seguito.Molti studiosi di questa convinzione, sotto l’influsso della psichiatrainterpersonale Frieda Fromm-Reichmann, si riunirono all’Institute forAdvance Study a Stanford nel 1956 per intraprendere lo studio dettagliatodel filmato di un’interazione in cui ogni aspetto di ciò che veniva osservatodoveva essere minuziosamente annotato ed esaminato rispetto al posto cheoccupava nel processo comunicativo. Questo progetto, conosciuto colnome di “La storia naturale di un’intervista”, coinvolgeva tra gli altri,Gregory Bateson, Norman McQuown e Ray Birdwhistell, i quali sarebberotutti stati strettamente collegati con il successivo sviluppo di un approccioche avrebbe tentato di esplicare davvero, in modo microscopico, lecomponenti della pratica dell’interazione (McQuown, 1971; Zabor, 1978;Leeds-Hurwitz, 1987).7
Goffman mantenne un vivo interesse per lo sviluppo di questoapproccio e ne fu indubbiamente influenzato. Egli ha ammesso di esserestato influenzato da Gregory Bateson e fu allievo di Ray Birdwhistellquando era ancora studente all’Università di Toronto. Partecipò, insieme aGregory Bateson, al secondo convegno della Josiah Macy Jr FoundationGroup Processes Conference, tenutosi nel 1956; ebbe un ruolo importantenella discussione al Convegno sulla Paralinguistica e sulla Cinesicatenutosi alla Indiana University nel 1962 (Sebeok, Hayes e Bateson, 1964).Negli anni seguenti fu lui stesso ad organizzare convegni in cui l’interesseprincipale fosse lo studio dell’interazione secondo il cosiddetto approcciodella storia naturale o della “analisi del contesto”.Tra i primi maggiori esponenti dell’approccio allo studiodell’interazione, che tenta di esaminare il processo in sé e il modo in cui sirealizza, possiamo includere Gregory Bateson, Ray L. Birdwhistell e AlbertScheflen. Ciascuno a proprio modo ha tentato di sviluppare un’intelaiaturateorica in base a cui comprendere il processo o la pratica dell’interazionecome sistema di comportamento. Un aspetto particolarmente importante diquesto approccio è la visione integrata del processo dell’interazione: sipresta attenzione tanto all’organizzazione dell’attività del corpo, e il ruoloche questo ha nel processo interattivo, quanto agli enunciati verbali. Inoltre,questi autori, coerentemente con tale idea, lottano per formulare unavisione in cui l’interesse si concentri sul sistema di relazioni tra gli atti deipartecipanti piuttosto che sui partecipanti stessi. Potrebbe essere proprioquesto che Goffman aveva in mente quando, nel già citato passaggio dellaprefazione a Interaction Ritual, ha scritto che il vero e proprio studiodell’interazione richiede lo studio delle “relazioni sintattiche tra gli attidelle varie persone reciprocamente presenti”. L’uso di Goffman del termine“sintattico” è significativo qui, perché indica che ha già cominciato adimpiegare l’analogia linguistica nell’analisi dell’interazione. I concetti dellalinguistica ebbero un ruolo importante nello sviluppo dell’approccioall’interazione per studiosi come Birdwhistell e Scheflen (Birdwhistell,1952, 1970; Scheflen, 1963, 1964, 1974; McQuown, 1971. Per unadiscussione su questo approccio si veda Kendon, 1972, 1979, 1982;McDermott e Wertz, 1976 e McDermott e Roth, 1978).8
L’INTELAIATURA <strong>DI</strong> <strong>GOFFMAN</strong> PER LO STU<strong>DI</strong>O DELL’INTERAZIONEFACCIA A FACCIALa co-presenza e i modi per fornire l’informazioneIn generale, Goffman assume il raggruppamento come unità di studiodell’interazione faccia a faccia, definendolo come tutte le occasioni in cuidue o più persone sono, come lui dice, co-presenti l’una all’altra. Lostudioso definisce la co-presenza nel modo seguente: “Gli individui devonosentirsi abbastanza vicini agli altri tanto da essere percepiti qualsiasi cosastiano facendo, incluso anche il loro esperire gli altri; e abbastanza vicini da“essere percepiti” in questa sensazione di essere percepiti” (Goffman,1963: 17; trad. it., 1971, p. 19). Continua dicendo che generalmente ci siaspetta che le condizioni della co-presenza si trovino soprattutto tra iconfini di una stanza, ma nei posti non delimitati da muri i confini della copresenzanon sempre possono essere tracciati chiaramente. In un parco, peresempio, se è relativamente affollato, le persone che si trovano a 50 metridi distanza possono non percepirsi allo stesso modo in cui possono farlo sesi trovano a soli due metri.Quando le persone sono co-presenti, di regola, riescono a percepirsicon i sensi nudi. In tali circostanze ognuno può accorgersi di ciò che stafacendo l’altro, ma può anche vedere di essere visto nel momento in cuivede le azioni dell’altro; così si crea una speciale reciprocità. P puòvalutare le azioni di Q e adattare le proprie azioni di conseguenza, ma insituazioni di co-presenza Q può fare lo stesso, e sia P sia Q possono,quindi, adattare le proprie azioni per il fatto che l’altro le sta adattandorispetto a lui. In tali circostanze si crea un tipo di accordo secondo cuiciascuno prende sulla fiducia la linea d’azione dell’altro. Ciò significa chenon è necessario che le persone controllino continuamente l’altro, perchéquello che una persona fa è interpretato dall’altro come una linea d’azione ecosì può si presumere cosa farà in seguito; cioè, l’altro è visto come sefosse impegnato in un progetto, sul quale si può fare affidamento; diconseguenza colui che percepisce la linea d’azione dell’altro può costruirela sua linea d’azione in virtù di questo. Inoltre, ovviamente, può fare questoalla luce della sua stessa supposizione che l’altro supporrà che anche lui siaimpegnato in un progetto.Stabilendo la nozione della co-presenza, Goffman ci fa rendere contoche in tutte le situazioni in cui le persone si trovano in condizione di9
percepirsi reciprocamente è destinata a crearsi una sorta di interdipendenzadelle azioni. In questa maniera il concetto di “interazione” èimmediatamente ampliato in modo radicale. Fino a quel momento glistudiosi dell’interazione si erano occupati solo degli esempi in cui due opiù persone (ma generalmente due) parlavano effettivamente tra loro.Goffman mostrò che questa era una visione troppo ristretta.Nella sua discussione sulla co-presenza, inoltre, Goffman mise inrilievo un altro principio molto importante. E cioè che ogni volta che lepersone sono co-presenti sono, allo stesso tempo ed inevitabilmente, unafonte d’informazione per l’altro. Questo era un punto che Gregory Batesonaveva evidenziato qualche anno prima (si veda Watzlawick, Beavin eJackson, 1967: 51), ma Goffman gli diede nuova vita perché riuscì amostrare in quali diversi modi le persone davano informazioni l’unoall’altro e di che tipo di informazione si trattasse.Mise in evidenza che in ogni raggruppamento i partecipantisuppongono che essi danno informazioni in due modi: fornendoinformazioni ed emettendo informazioni. Quando una persona fornisceinformazioni lo fa attraverso azioni che sono considerate volontarie, per cuiè ritenuto responsabile di ciò che fornisce. Ciò significa che, di regola,l’informazione fornita è data attraverso l’uso di azioni simboliche – cioè,azioni che sono reciprocamente riconosciute come azioni che si riferisconoa qualcos’altro. In questo senso, quando parliamo, forniamo l’informazioneattraverso il contesto di ciò che diciamo – sebbene, oltre al parlare, ci sonomolti altri modi per fornire informazioni. Dall’altro lato, le informazioneche sono emesse sono considerate come informazioni che vengono date chela persona lo voglia o meno; è un prodotto immancabile ed inevitabile dellasua presenza e delle sue azioni. Posso indicarti la strada per arrivare allacattedrale ma nel farlo trasmetto, attraverso la scelta delle parole, attraversoil mio accento e così via, informazioni aggiuntive. Queste informazioniaggiuntive sono trasmesse piuttosto che fornite.È importante ricordare che qui la questione non è se l’informazionesia fornita di fatto volontariamente o involontariamente, ma piuttosto se ico-partecipanti al raggruppamento la considerano come volontaria o meno.In tutte le situazioni di interazione, sembra che i partecipanti trattino soloalcuni aspetti del comportamento degli altri come deliberatamenteintenzionali e destinati a trasmettere qualcosa. Nelle conversazione è quelloche generalmente è chiamato “contenuto della conversazione” ad essereconsiderato in questo modo, non il modo di parlare, e certamente non ladisposizione del corpo e le disposizioni ecologiche in cui la conversazioneè condotta. Tuttavia, non è che questi altri aspetti della situazione nonabbiano un ruolo nella strutturazione dell’interazione. Tutt’altro. Hanno un10
uolo decisivo nell’intera organizzazione dell’evento. Dobbiamo molto aGoffman per averci fatto scoprire questo.Goffman affronta questa fondamentale distinzione tra “fornire” e“emettere” l’informazione in svariati modi. Una delle sue più elaboratetrattazioni dell’argomento si trova in Frame Analysis (1974). In questolibro lo studioso sviluppa la nozione di “piste di attenzione”. Suggerisceche in ogni incontro sociale c’è sempre un aspetto dell’attività che si stasvolgendo che è considerato come facente parte di una “pista principale” odi una “trama”. Un campo d’azione è delineato come rilevante allo scopoprincipale dell’incontro ed è orientato in quanto tale ed è trattato diconseguenza. L’azione trattata in questo modo è considerata comevolontaria e l’informazione che data in questo caso è un’informazionefornita. Altri aspetti dell’attività che si sta svolgendo non sono trattati inquesto modo ma ciò non significa che essi non abbiamo un ruolo nelprocesso interattivo. Dunque Goffman propone di distinguere una “pistadirezionale” in cui, come lui stesso dice, “si trova un flusso di segni che èesso stesso escluso dal contenuto dell’attività ma che serve come mezzo perregolarla, delimitando, articolando e qualificando le sue varie componenti efasi” (Goffman, 1974: 210; trad. it., 2001, p. 143). Si può parlare anche diuna “pista della disattenzione” (Goffman, 1974: 210) alla quale sonoassegnati una varietà di azioni che sono considerate come se non avesseroaffatto un ruolo nell’interazione. Goffman ha fatto riferimento, inparticolare, alla “liberazione di bisogni umani” – grattarsi, cambiare laposizione del corpo e così via – che sono, per così dire, deviazioniconsentite della disciplina comportamentale che tutti i partecipanti in copresenzaseguono come prezzo da pagare per essere considerati come esseriumani normali e predicibili e che passano inosservati.Come lo stesso Goffman chiarisce, e come si può comprendere conuna breve riflessione, non è che i partecipanti non notino e non rispondanoalle azioni incluse nella pista della disattenzione. Al contrario, si puòmostrare che in molte situazioni esse svolgono un ruolo importante nelprocesso interattivo. È per mezzo delle azioni che sono trattatereciprocamente come appartenenti alla “pista della disattenzione”, peresempio, che i partecipanti ad un incontro conversazionale possonomettersi d’accordo su quando terminare l’incontro. Posso avvisarti che hobisogno di spostarmi in qualche altro posto con un certo cambiamento nelladirezione dello sguardo, con una certa irrequietezza nella postura, forsecambiando la velocità con cui svolgo un’attività collaterale, come bere ofumare. Questi cambiamenti non sono considerati in modo ufficiale, nonsono nemmeno considerati come parte della mia espressione, eppurepossono essere trattati, nondimeno, come elementi che trasmettono certe11
precise informazioni circa le mie intenzioni attuali e permettono all’altro diadattare la propria linea d’azione di conseguenza.Tipi di occasioni interazionali: interazione focalizzata e interazione nonfocalizzataIl raggruppamento, come abbiamo visto, è il termine che Goffman usa perdefinire un insieme di individui che sono co-presenti. I raggruppamentipossono essere organizzati in diversi modi. Goffman ha propostoun’importante generica distinzione tra ciò che ha chiamato raggruppamentifocalizzati e raggruppamenti non focalizzati. In un raggruppamentofocalizzato i partecipanti sono organizzati in modo da mantenere un puntofocale di attenzione in comune. In un raggruppamento non focalizzato unsimile punto focale non può essere percepito e i vari partecipantiperseguono linee di interessi indipendenti. I raggruppamenti non focalizzatiincludono, ad esempio, i pedoni per strada, gli utenti di una sala di lettura,persone che aspettano in una sala d’attesa. Esempi di raggruppamentifocalizzati sono occasioni di qualsiasi tipo di conversazione, partite ditennis, coppie di ballerini, coppie di lavoratori che cooperano per portare atermine un compito che richiede un’attenzione mantenuta in comune,interviste, colloqui, sedute di psicoterapia e simili.Operando questa distinzione, e mostrando che una gran varietà dioccasioni interazionali possono essere adattate in questo modo, Goffman hasuggerito che occasioni che a prima vista sembrano molto diverse hannocaratteristiche organizzative comuni. Attirando la nostra attenzione suqueste caratteristiche ci ha mostrato aspetti delle situazioni interazionaliche non erano mai stati presi in considerazione in modo sistematico prima.Inoltre, soprattutto attraverso la caratterizzazione degli aspetti delraggruppamento focalizzato, è riuscito a suggerire i modi in cui i variaspetti del comportamento, finora non considerati nello studiodell’interazione, dovevano invece giocare un ruolo cruciale.Se cominciamo a lavorare tenendo conto di questa dicotomia e,pensando ai diversi tipi di raggruppamento cerchiamo di stabilire se sianofocalizzati o non focalizzati, scopriremo molto presto che questadistinzione non può essere considerata molto più che una sempliceapprossimazione. Guardiamo alcuni esempi.Le persone che camminano per strada costituiscono un insieme diindividui che, sebbene co-presenti, perseguono ciascuno una linea d’azioneindipendente – sembrerebbe questo, un puro esempio di interazione nonfocalizzata. Tuttavia, come lo stesso Goffman ha mostrato nell’elegante12
discussione di questa situazione (in Behavior in Public Places, 1963: 83-8e poi in modo più elaborato in Relations in Public, 1971: 5-18), esiste unareciproca coordinazione tra le persone. Egli identifica un rituale interattivominimo, che egli chiama “disattenzione civile”, in cui ciascun passante sicomporta rispetto all’altro in modo da comunicare, allo stesso tempo, ilriconoscimento del passaggio di un altro essere umano e il riconoscimentodell’altrui diritto di seguire una propria e indipendente linea d’azione. Giàin questo minimo tipo di scambio, per esempio, lo sguardo che i passanti silanciano accordandosi reciprocamente sul non far incontrare i propri occhi,facendo in questo modo capire agli altri di non essere spaventati, ostili o dinon guardare l’altro come un automa, possiamo vedere che nella situazionedel camminare per strada c’è molto più che il semplice guidare il propriocorpo per passare tra gli altri. In quella che è apparentemente la più nonfocalizzata delle situazioni, possiamo tuttavia scorgere una serie di accordimomentanei sul non mantenere un punto focale d’attenzione comune ed inquesto, sembra, abbiamo un esempio di interazione che ha alcune delleproprietà degli scambi focalizzati. Si può osservare che in questi momentidi “disattenzione civile” due persone coordinano le loro azioni su uncomune obiettivo, pur accordandosi in questo caso sul non unirsi in unpunto focale d’attenzione comune.Consideriamo ora un altro tipo di raggruppamento, la coda. Si trattadi un esempio di raggruppamento focalizzato o non focalizzato? Una codasi forma laddove un certo numero di persone vogliono tutti fare qualcosache può essere fatta da una sola persona (o piuttosto, per usare un utileconcetto di Goffman, una “unità di partecipazione”) 1 per volta: comprare ilbiglietto per entrare nel cinema, ad esempio. A primo acchito, si potrebbepensare che una coda sia un raggruppamento focalizzato perché ognipartecipante è in attesa per fare la stessa cosa: tutti focalizzano la propriaattenzione sull’attività di comprare il biglietto. Ma ciò sarebbe sbagliatoperché, ovviamente, l’acquisto del biglietto è una transazione individualeche coinvolge i membri della coda come partecipanti indipendenti. La1 Il concetto di “unità di partecipazione” è stato introdotto in Relations in Public (1971:pp. 19-27). Goffman mette in evidenza che gli individui possono partecipare alleoccasioni interazionali come “singoli” e come membri di un “insieme”. Un buonesempio di un “insieme” è una “coppia” o un “gruppo familiare” composto da genitori efigli. In una coda al cinema, per esempio, i “posti” possono essere occupati da “coppie”o da “gruppi familiari”, e ad ogni individuo che costituisce una parte di queste unità èaccordata la stessa priorità nella coda. Le unità che compongono una coda, quindi, seconsiderate dal punto di vista della sua organizzazione come occasione interazionale,non sono individui ma “unità di partecipazione”, alcune delle quali possono essere“singoli”, altre “insiemi”.13
transazione dell’acquistare il biglietto in sé è un’interazione focalizzata,ovviamente, ma i membri della coda non sono i partecipanti ad unraggruppamento che collaborano per mantenere l’attività del comprare ilbiglietto. In una coda, ciò che abbiamo è un insieme di unità dipartecipazione, ciascuna focalizzata separatamente ed indipendentementesulla stessa cosa. In un’interazione focalizzata il punto focale comune deveessere la comune responsabilità dei partecipanti.Ciò nonostante la coda possiede alcuni aspetti non dissimili da quelliche possiamo osservare in un raggruppamento completamente focalizzato,come le conversazioni. Per esempio, una coda ha una caratteristica eparticolare organizzazione spaziale, ha dei confini e chi vuole esseremembro della coda deve rispettare questi confini altrimenti non verràconsiderato come un effettivo membro della coda e quindi non può tenereun “posto” in essa. Se una persona sta troppo a lato o troppo indietro allapersona vicina, possono sorgere dubbi circa il suo essere in coda. Per essereimpegnati nello stare in coda, quindi, i partecipanti devono unirsi nelmantenere una certa disposizione spaziale (o “formazione” come l’hochiamata altrove - Kendon, 1977) e questo deve essere fatto attraverso untipo di interazione che si possa considerare a tutti gli effetti come governatada un punto focale d’attenzione mantenuto in comune. Questo punto focaleè raramente formulato in quanto tale, non viene trattato come la “trama” diun’interazione. Tuttavia è qualcosa a cui tutti i membri della coda prestanoattenzione ed è facile osservare come essi cooperano affinché esso vengamantenuto. Non sarebbe corretto dire che una coda è un raggruppamentofocalizzato, eppure non possiamo negare che, almeno in termini di manovrespaziali ed orientazionali, ciò che avviene è un tipo di interazionefocalizzata.Un altro esempio che possiamo considerare da questo punto di vistaè un plotone militare in parata, o forse, gli allievi e l’insegnante duranteun’escursione o in classe. Qui abbiamo un insieme di individui cheseguono tutti un unico punto focale d’attenzione, l’ufficiale che dà gliordini o l’insegnante. Ancora una volta, queste occasioni hannoun’organizzazione spaziale che è mantenuta grazie alla cooperazione deimembri e a cui bisogna partecipare per essere considerati partecipanti.Anche in questi casi ci sono delle cose che è giusto aspettarsi, altre chesono invece inadeguate – vi sono adeguati modelli di sguardo e di posture eci sono delle disposizioni che governano l’organizzazione delle mosse edelle risposte come negli scambi verbali tra allievo ed insegnante o negliscambi enunciato-movimento tra l’ufficiale che dà l’ordine e gli uomini chelo eseguono. Vari sono, dunque, i modi in cui tutti i partecipanti devonocooperare per mantenere occasioni come le parate o le escursioni. Tuttavia,14
collegate e come, di conseguenza, esse sono organizzate in un certo tipo diunità coerente, come una “conversazione”, un “discorso”, un “incontro” dicombattimento, un “giro” di danza o una “partita” a carte.Implicito nell’azione dello scambio è il riconoscimento che ipartecipanti all’interazione prestano attenzione al comportamento dell’altroin modo molto differenziato. Prima ho discusso di questo in rapporto con ilgenerico punto del “fornire” e “emettere” informazioni e in rapporto alleosservazioni che Goffman fa circa le “piste di attenzione” nell’interazione.Sembra che le persone trattino alcuni aspetti del comportamento degli altrisempre come se fossero degli atti espliciti, mentre altre come se fossero oattività di “sfondo” o come se fossero irrilevanti. Nell’interazione ipartecipanti trattano alcuni aspetti di ciò che gli altri fanno come azioni“volute”, azioni che sono preparate come se necessitassero una rispostaesplicita, mentre altre azioni non sono affatto trattate allo stesso modo.Fondamentali per l’occorrenza degli scambi, come sono concepitiqui, allora, è l’abilità dei partecipanti di avviare il “consenso operativo”,circa ciò che è rilevante e ciò che non lo è in qualità di “atto esplicito”.L’accordarsi sulla cornice, quindi, deve essere visto come un processoprecedente e fondamentale nell’organizzazione di qualsiasi scambio(Kendon, 1985).Dato l’accordo sulla cornice, possiamo dunque considerare comesono strutturati gli atti espliciti nell’interazione. Goffman suggerisce diprendere in considerazione due aspetti: i requisiti del sistema e i requisitidel rituale. I requisiti sistemici sono quei requisiti che un sistemainterazionale deve avere, dato che i partecipanti hanno certe capacitàanatomiche, fisiologiche e di elaborazione delle informazioni. I requisitirituali si riferiscono alle regole che guidano l’interazione, dato che ipartecipanti sono essere morali che sono guidati da norme di buona edappropriata condotta che mantengono reciprocamente. Molto del lavoro diGoffman sugli scambi si è concentrato sulla spiegazione dei requisiti delrituale che guidano gli scambi. Tuttavia, in Forms of talk (Goffman, 1981b)egli delinea prima i requisiti sistemici e poi suggerisce come i requisitirituali e quelli sistemici si rafforzano a vicenda. Lo schema dei requisiti delsistema che egli fornisce, racchiude insieme molti degli esiti del dettagliatolavoro svolto in anni recenti sull’interazione faccia a faccia. È un buonsommario di molto di quello che oggi si sa su questa organizzazione. Egliriesce anche a mostrare molto chiaramente perché il concetto dei requisitidel rituale è indispensabile per una completa comprensionedell’interazione.Lo schema di Goffman comprende otto requisiti sistemici che sonoelencati sotto con alcuni commenti. Ho anche aggiunto alcuni riferimenti19
ad una selezione di lavori sull’interazione che stanno alla base dellesommarie affermazioni presentate qui.Primo, deve esserci una capacità nei due sensi di trasmettere ericevere messaggi chiari ed adeguati. Goffman specifica che questimessaggi devono essere “adeguati da un punto di vista acustico” mapossiamo supporre che Goffman accetterebbe la formulazione più genericache ne abbiamo dato, in quanto i messaggi possono anche essere visivi – unpunto a cui dà molta enfasi, in verità, come discuteremo sotto. Questacapacità di inviare e ricevere messaggi ovviamente dipende da adeguatecondizioni ambientali e dalle circostanze che permettono ai partecipanti siadi regolare l’apparato “trasmittente”, sia di orientare l’apparato “ricevente”.In questo modo si può comprendere l’ecologia dei raggruppamenticonversazionali: le persone devono essere abbastanza vicine da potersisentire e vedere, devono orientarsi in modo adeguato, ecc. (si veda Kendon,1977; Ciolek e Kendon, 1980).Secondo, è necessaria la presenza di segnali per informarel’emittente che la ricezione è in atto. Molti aspetti del comportamento degliascoltatori possono avere questa funzione. Per esempio, alcune disposizioniposturali ed orientazionali, normalmente usate dagli ascoltatori, servono adinformare che si sta prestando attenzione al parlante – Scheflen (1964,1972) fornisce alcune osservazioni pionieristiche su questo aspetto. Alcunimodelli di direzione dello sguardo, i gesti della testa e del volto e i brevienunciati vocali servono come feedback per il parlante per sapere come isuoi enunciati sono considerati e ricevuti (Yngve, 1970; Duncan e Fiske,1977; Goodwin, 1981).Terzo, ci devono essere segnali per annunciare la ricerca del canaledi comunicazione, per annunciare che un canale è aperto ed anche segnaliper chiudere un canale. Queste funzioni di apertura e chiusura forniscono,in parte, una spiegazione per la presenza degli scambi di saluto e dicongedo (Kendon e Ferber, 1973, Schegloff e Sacks, 1973).Quarto, dato che P non può rispondere a Q finché non sa quale saràl’azione pertinente di Q, vediamo che i partecipanti agli scambi esplicititendono ad alternarsi o a fare a turno quando sono impegnati in azioniesplicite. Ciò implica che occorreranno una serie di segnali o marcatoriattraverso cui indicare l’inizio e la fine di ogni turno e attraverso cuiindicare quale dei partecipanti avrà il turno successivo.Bisognerebbe aggiungere che la questione del “turn-taking”nell’interazione e la sua spiegazione è molto più complessa di quantoquesto paragrafo possa suggerire. Per esempio, P talvolta può iniziare il suoturno prima che il turno di Q sia terminato. Ciò può accadere non solo inquelle situazioni in cui P vuole interrompere Q, ma può capitare perché20
spesso P riesce a prevedere la natura dell’azione attinente di Q, che è incorso. Questa anticipazione può essere dovuta a diversi fattori, come il fattoche P può conoscere l’argomento di cui Q sta parlando, che P può avere lacapacità di afferrare la struttura dell’intonazione dell’enunciato di Q o diafferrare la ridondanza nella struttura del discorso di Q. Questo, talvolta, fasì che P completi l’enunciato di Q e che vi faccia delle aggiunte. In alcunecircostanze, inoltre, sembra che gli individui siano in grado di ascoltare edi parlare allo stesso tempo. Nonostante ciò, l’alternanza degli atticomunicativi espliciti è una caratteristica preminente di molte interazioni eciò probabilmente si può spiegare in gran parte tenendo conto dellelimitazioni della capacità di elaborazione delle informazioni che hanno ipartecipanti. Nelle misura in cui ciò è valido, possiamo aspettarci lapresenza di quegli aspetti del comportamento che funzionano come segnaliper la regolazione del turno, che probabilmente sono inclusi in tutte leinterazioni umane.Quinto, ci devono essere tecniche per ripetere, ritardare ointerrompere un messaggio.Sesto, ci devono essere modi attraverso cui i messaggi possonoessere inquadrati in una certa cornice; cioè ci devono essere segnalimetacomunicativi, per usare un termine di Gregory Bateson (si vedaBateson, 1956), che segnalano come leggere il messaggio inviato.Settimo, ci sono norme che regolano lo sviluppo del contenuto delmessaggio in modo che sia attinente a ciò che è stato detto in precedenza.Infine, ci devono essere regole che guidano la relazione tra gliindividui attivamente impegnati in uno scambio e coloro che, purtrovandosi a portata di ciò che è in atto, non sono partecipanti. Cioè, cidevono essere dei modi per distinguere gli effettivi emittenti-riceventi daipotenziali emittenti-riceventi. Ancora una volta troviamo un principio inbase a cui considerare la condotta spaziale ed orientazionale degli individuico-presenti, dove alcuni dei essi sono impegnati in uno scambio mentrealtri no o non nello stesso scambio. (Kendon, 1977; Ciolek e Kendon,1980).Questi requisiti sistemici possono contribuire in modo determinante aspiegare ciò che osserviamo dell’organizzazione del comportamento negliscambi espliciti. Tuttavia, essi ci sono utili se assumiamo che i partecipantihanno già, come dice Goffman stesso, “concordemente deciso di operare(di fatto) soltanto come nodi di comunicazione e di rendersi del tuttodisponibili a questo scopo” (Goffman, 1981b: 15; trad. it., 1987, p. 44).Se una persona deve impegnarsi ad operare come “nodo dicomunicazione”, tuttavia, può farlo solo rispetto ad un unico sistema pervolta (un altro “requisito del sistema”), e di conseguenza deve rinunciare a21
qualunque altra attività. Ricevere una richiesta di aprire un canale dicomunicazione con un’altra persona, significa ricevere la richiesta dimettere da parte le altre richieste. Questa richiesta è una violazione dellapropria autonomia, quindi, il ricevente potrebbe sentirsi offeso. Allo stessomodo, trasmettere una richiesta per l’apertura di un canale dicomunicazione ad un altro significa rischiare che l’altro la consideriun’offesa e ricevere un rifiuto, e significa rischiare che la propriarispettabilità, come persona individuale, venga negata. E ovviamentel’altro, nel rifiutare, è probabile che sia visto come una persona che nega ilvalore degli altri – buona ragione, questa, per non inviare, in futuro,richieste per aprire un canale di comunicazione a quella persona. Lerichieste per aprire un canale di comunicazione sono rischiose per la stimadi se stessi, quindi, ma rifiutare queste richieste equivale a mettere a rischiola rispettabilità che gli altri accorderanno a quella persona. Quindi ildestinatario ha un certo obbligo di rispondere ma l’emittente ha l’obbligo diformulare il suo discorso in modo da consentire all’altro di rifiutare, sedeve, con cortesia.Quindi possiamo vedere che gli scambi espliciti hanno dellecaratteristiche che non possono essere spiegate semplicemente in termini direquisiti sistemici. Nel cercare di aprire una conversazione, per esempio, lepersone rivolgono agli altri vari tipi di gesti e di enunciati che, pur avendola funzione di aprire un canale, servono anche come mezzi per riconoscerela rispettabilità dei partecipanti. Per chiudere una conversazione, unapersona non mette semplicemente fuori servizio i suoi organi di ricezione(cioè non si tappa le orecchie o chiude gli occhi), passa piuttosto attraversoun elaborato processo di avviso di chiusura. Si cerca prima un accordo sullachiusura e poi si avvia questo accordo; e la cerimonia della chiusura stessaè vincolata da espressioni che rassicurino reciprocamente i partecipanti chel’interruzione dei canali di comunicazione che sta per avere luogo nonimplica che essi non saranno disposti a riaprirli, se le circostanze dovesseropermetterlo. Dunque i processi di apertura e di chiusura di un canale dicomunicazione sono elaborati attraverso rituali di saluto e di congedo.Possiamo cercare di spiegarli in termini di requisiti sistemici ma unacomprensione della loro struttura richiede anche una comprensione deirequisiti rituali dell’interazione. La manovre pre-esplicite di saluto a cuiabbiamo alluso prima, spesso composte dal comportamento consideratoappartenente alla pista della disattenzione, richiedono l’aspetto ritualedell’interazione per essere comprese. Infatti, il modo stesso in cui lepersone scelgono di differenziare le azioni in “esplicite” e non “esplicite”, èuna funzione della struttura rituale dell’interazione. Certo, il modo selettivocon cui rispondiamo al comportamento degli altri è una conseguenza delle22
limitazioni delle capacità d’attenzione. La risposta differenziata, quindi, haorigine in un requisito del sistema. Ma ciò su cui le persone si accordano diprendere o non prendere in considerazione è parte dell’accordo generaleche essi hanno di considerarsi reciprocamente come persone rispettabili.Anche l’accordo a cui si arriva, quindi, è regolato da requisiti rituali.Atti esplicitiOra, deve essere discussa un’ultima questione sollevata dall’analisi diGoffman sugli scambi espliciti: si tratta della questione della natura diquesti atti espliciti, in virtù della quale sono organizzati. Ho cercato, perquanto possibile, di non specificare cosa siano gli “atti espliciti”. Lamaggior parte delle volte, naturalmente, sembra che assumiamo che ciò chesi considera un “atto esplicito” sia un atto linguistico o almeno unavocalizzazione, e virtualmente tutti gli studi che hanno tentato di fare unaprecisa analisi dell’interazione si sono limitati alle occasioni in cui gliscambi di enunciati verbali costituiscono il principale coinvolgimento deipartecipanti; ciò vale anche per quegli studi il cui principale interesse eranogli aspetti non-verbali della comunicazione. Il numero di indaginisull’interazione dove il parlato non è compreso o dove gioca un ruolominore sono davvero pochi, per quanto ne so.Goffman, tuttavia, si è dato sempre molto da fare per mettere inevidenza che gli atti espliciti, di cui sono composti gli scambi espliciti, nondevono essere necessariamente né atti linguistici né gesti, ma possonoessere qualsiasi cosa i partecipanti abbiano deciso di considerare comeesplicito. Ad un atto verbale si può rispondere in modo appropriato con ungesto, come quando dico “Passami il sale” ed il sale viene passato; adun’azione fisica si può rispondere adeguatamente con un atto verbale, comequando il cameriere muove il beccuccio della caffettiera ed io dico “Solometà tazza, per favore”; e ad un’azione fisica si può rispondereappropriatamente con un’altra azione fisica, come quando A prende unasigaretta, ne offre una a B, B la prende e tira fuori il suo accendino e loporge con la fiamma accesa ad A affinché possa accendere.O si consideri la transazione che ha luogo quando un cliente comprauna tavoletta di cioccolato in un bar. Il cliente può avvicinarsi alla cassa edire “Quanto costa?” e la cassiera può rispondere “50 centesimi”. Quiabbiamo una domanda verbale alla quale segue una risposta verbale.Tuttavia, il cliente può anche avvicinarsi alla cassa e mantenere la tavolettadi cioccolato tenendola in alto e in avanti in modo che sia bene in vista.23
Anche questa sarà presa come una mossa e la cassiera può dire ancora,semplicemente, “50 centesimi”. Qui un’azione fisica, combinata con ilmantenere un oggetto, riceve una risposta verbale. Infine, se il clienteconosce già il prezzo della tavoletta di cioccolato può avvicinarsi alla cassamantenendo sia la cioccolata che i soldi, a questo la cassiera puòsemplicemente stendere la mano, col palmo verso l’alto, il cliente vi puòdepositare il denaro e andarsene. Qui l’intera transazione è condotta senzadire una parola. Tuttavia, in tutti e tre i casi abbiamo un esempio discambio esplicito, uno scambio che, in ogni caso, ha fondamentalmente lastessa struttura.Per le transazioni di questo tipo possiamo identificare una mossa diapertura, per mezzo della quale il cliente stabilisce il suo desiderio di essereun acquirente, mosse attraverso cui è identificata la merce di cui si habisogno ed è stabilito il prezzo ed una serie di mosse finali attraverso cui ildenaro è offerto e ricevuto. Che queste mosse e risposte siano realizzateattraverso delle manovre spaziali e l’orientazione, attraverso i gesti faccialio manuali, attraverso la manipolazione e il passaggio degli oggetti,attraverso la parola o attraverso una combinazione di tutto ciò, il modelloorganizzativo della transazione resta lo stesso.Si può riconoscere, dunque, una struttura comune per queste transazioni divendita. Si può mostrare come, in varie circostanze, le mosse stesse sonoespresse in modi diversi: ora solamente come manovre spaziali e manipolazionedegli oggetti, ora come atti linguistici e gesti. Un’analisi di questo tipomostrerebbe come, “le sequenze interazionali stabiliscono una fessura, ed essapuò essere riempita con qualsiasi cosa sia disponibile: se non si ha una frase, unborbottio può andare bene, se non si ha un borbottio, una contrazione muscolarefarà lo stesso” (Goffman, 1971: 149, n. 38).Con esempi di questo tipo, Goffman riesce a concludere, come fa in“Replies and Responses” (Goffman, 1981b), che il parlato non è che un “esempiodi quell’organizzazione in virtù della quale gli individui si riuniscono esostengono una situazione che ha un centro di attenzione ratificato, reciproco e incontinuo sviluppo, il che li colloca insieme in qualche sorta di mondo mentaleintersoggettivo” (Goffman, 1981b: 70-1; trad. it., 1987, p. 111). Egli è d’accordosul fatto che “le parole sono il più importante strumento per portare parlante eascoltatore” nello stesso mondo mentale intersoggettivo, ma mette in evidenzache sebbene le parole possano essere il “mezzo migliore” per fare ciò, “nonsignifica che siano l’unico e neppure che l’organizzazione sociale che ne risultasia intrinsecamente verbale in natura”.L’organizzazione sociale che ne deriva è, come abbiamo visto, unprodotto dei processi sull’accordo sulla cornice, dei vincoli sistemici, e deirequisiti rituali.24
I processi sull’accordo della cornice permettono ai partecipanti diarrivare al “consenso operativo” dell’incontro, tramite il quale ci si accordasu quali aspetti del comportamento bisogna considerare come “mosse” ecosa sia pertinente al contenuto dell’incontro.I vincoli sistemici contribuiscono all’organizzazione ecologicadell’incontro e determinano anche il tipo di organizzazione basilare cheavranno le sequenze delle mosse, che sono condizionate dalla natura delcomportamento che è considerato come “azione esplicita”. Per esempio, seè coinvolto il parlato, possiamo aspettarci una struttura di “turn-taking”, sesono coinvolti i movimenti di una danza o azioni come le carezze o la lotta,è probabile che ci sia una struttura diversa.I requisiti rituali spiegano i modi in cui i partecipanti mostrano laloro volontà di partecipare all’incontro, i modi in cui mostrano livelli diattenzione appropriati e risposte appropriate e come negoziano ed arrivanoad un accordo per chiudere un incontro.I processi sull’accordo della cornice, la gestione dei vincoli sistemicie l’adempimento dei requisiti rituali includono una varietà di azioni chepuò includere il parlato, ma non sempre – ma che sempre include tipi dicomportamento diversi dal parlato. Il parlato quindi non è fondamentale perla produzione degli scambi espliciti, non sempre è necessario.Ciononostante, conserva un posto centrale nella nostra esperienza, chenessuno potrebbe negare. Il problema resta determinare che posto occupanell’interazione. La discussione di Goffman serve a sollevare questoproblema. La sua soluzione è una questione lasciata ai lavori futuri.ConclusioniCome si può riassumere il contributo di Goffman allo studiodell’interazione faccia a faccia e quali compiti ci ha lasciato per il futuro?Primo, credo che egli abbia dato ampia dimostrazione dellafondatezza della sua opinione di considerare le occasioni interazionalicome sistema che merita uno studio a parte. Egli ha espresso in modoparticolarmente chiaro il punto che i partecipanti possono impegnarsi inazioni in un’interazione nell’interesse del sistema in cui sono coinvolti, enon perché abbiano necessariamente qualcosa da esprimere. Ha mostratol’importanza di un approccio il cui punto di partenza per l’analisi non sial’individuo ma l’interazione tra gli atti. Ciò ha fornito, per molti di noialmeno, un’intelaiatura nuova, in base a cui interpretare le piccolecomponenti del comportamento interazionale, le quali finora erano stateconsiderate in termini puramente psicologici.25
Secondo, credo che egli ci abbia aperto gli occhi e ci abbia fattovedere che tutto ciò che le persone fanno quando sono in presenza deglialtri meritano di essere studiate minuziosamente, che la regolarità delcomportamento degli individui quando sono in co-presenza è meritevole diattenzione, e non solo quegli eventi che normalmente ci si aspetta che noiriportiamo. Ci ha mostrato sia la possibilità sia l’importanza di una storianaturale dell’interazione sociale e ha ampliato di molto il campodell’osservazione.Infine, ci ha fornito una terminologia che ci permette di parlare dellacomplessità dell’interazione. In particolare, ha proposto una serie di terminiche servono a mostrare come le caratteristiche comuni dell’interazionequotidiana siano rappresentative di un’intera classe di fenomeni che, fino aGoffman, non erano mai stati trattati in questo modo. Per fare giusto unesempio, chiamando la conversazione “interazione focalizzata”, ha in talmodo assegnato la conversazione ad una più vasta classe di occasioniinterazionali, di cui la conversazione non è che una specie. In questo modoha gettato le basi per una teoria generale dell’interazione faccia a faccia.Per il futuro ci sono molte questioni, ma ce ne sono tre che misembrano di particolare importanza.Primo, c’è la questione della generalità culturale dello schema diGoffman. Fino a che punto l’analisi delle pratiche dell’interazione diGoffman è appropriata solo alla cultura in cui visse e scrisse, o in chemisura può essere applicata più genericamente? La mia opinione è chel’analisi dell’interazione di Goffman può essere vista come il tentativo diuna formulazione applicabile all’interazione umana in generale. I principaliconcetti che egli ha sviluppato, incluso quelli di “raggruppamento”, “unitàdi partecipazione”, il contrasto tra interazione “focalizzata” e “nonfocalizzata”, l’analisi del lavoro di definizione della cornice che gliinteragenti devono fare per stabilire le occasioni di interazione focalizzata,gli scambi rituali che ha identificato, specialmente il “parentesizzare” o l’“accesso rituale” (Goffman, 1971: 73-80, trad. it., 1987, p. 50) tramite iquali le cornici interazionali vengono stabilite e alterate - possono essereconsiderate come proposte completamente generiche per le caratteristichedell’interazione faccia a faccia. Tuttavia, le analisi comparative dellepratiche dell’interazione sembrano essere ancora troppo rare affinchéqueste affermazioni possano essere maggiormente elaborate.Per intraprendere uno studio comparativo più sofisticato, credo che itentativi di creare una tassonomia dell’interazione sociale sarebbero di granvalore. C’è tutta una serie di termini che usiamo nella vita di tutti i giorniper riferirci a diversi tipi di occasioni sociali, diversi tipi di incontri; eGoffman stesso fa uso di alcuni di essi in modo quasi tecnico, suggerendo26
la possibilità di una sistematica delle occasioni interazionali, sebbene nonpresentandone una lui stesso. Così, ha distinto l’interazione in“focalizzata” e “non focalizzata” ma anche messo in evidenza come leoccasioni si distinguono anche per la cornice di partecipazione – come ladifferenza tra eventi “podio” e occasioni in cui i diritti alla partecipazionesono più equamente distribuiti. Goffman fornisce un punto di partenza peruna simile classificazione dei diversi tipi di occasioni interazionali. Sta adaltri sviluppare questo aspetto in futuri lavori.Infine, c’è la questione della natura delle unità di cui sono compostigli scambi espliciti. Ho fatto riferimento a questo, evidenziando comeGoffman, soprattutto in “Replies and Responses” e in “On Footing”,afferma che “tutto può bruciare nel fuoco della conversazione”. Goffmanha chiaramente ragione qui; tuttavia, essere lasciati con il punto moltogenerico che la conversazione – con cui presumibilmente egli intendequalunque tipo di interazione focalizzata – è “un prolungato segmento diriferimenti, dove ciascun riferimento tende ad avere, ma spesso in manieraindiretta, una qualche connessione percepibile retrospettivamente conquello immediatamente precedente” (Goffman, 1981b: 72; trad. it, 1987, p.113), significa essere lasciati con una sfida, non una risposta. La sfida èdecifrare i modi in cui sono elaborati i diversi tipi di azioni che possonoessere utilizzate come riferimenti. Quali sono i contesti, le situazioni, in cuigli individui seguono le giuste limitazioni del modello conversazionale,quando invece non lo fanno? Come possiamo esplicare che posto occupa ilparlato nell’interazione umana, dopo tutto?NotaVorrei ringraziare Mathew Ciolek, Charles Goodwin, Allen Grimshaw, Wendy Leeds-Hurwitz, Stephen Mugford e Emanuel Schegloff per gli utili commenti e suggerimenti.Sono molto grato a Anthony Wootton e Paul Drew per avermi suggerito di scriverequesto articolo. Il supporto finanziario, istituzionale e tecnico per questo articoloprovengono dall’Australian Institute for Aboriginal Studies, dal Dipartimento diAntropologia della Research School of Pacific Studies dell’Università NazionaleAustraliana, Camberra e dal National Science Foundation di Washington, DC.27
BibliografiaBales, R. F. 1950. Interaction Process Analysis. Cambridge, MA: AddisonWesleyBarker, R. e Wright, H. 1955. Midwest and its Children. New York: HenryHoltBirdwhistell, R. L. 1952. Introduction to Kinesics. Louisville, Kentucky:University of Louisville Press.Birdwhistell R. L. 1970. Kinesics and Context. Philadelphia: University ofPennsylvania Press.Bridgman, P. W. 1936. The Nature of Physical Theory. Princeton:Princeton University Press.Cartwright, D. e Zander, A. 1953. Group Dynamics: Research and Theory.Evanston, Illinois: Row, Peterson.Chapple, E. D. 1939. Quantitative analysis of the interaction of individuals.Proceedings of the National Academy of Science, USA, 25: 295-307.Chapple, E. D. 1940. Measuring human relations. Genetic PsychologyMonographs, 22:3-147.Ciolek, T. M. e A. Kendon 1980. Environment and the spatial arrangementof conversational encounters. Sociological Inquiry, 50: 237-271.Duncan, S. e D. Fiske 1977. Face-to-face Interaction: Research Methodsand Theory. Hillsdale, New Jersey: Erlbaum.Goffman, E. 1953. Communication conduct in an island community. Ph. D.dissertation. Department of Anthropology, University of Chicago.Goffman, E. 1955. On face-work: an analysis of ritual elements in socialinteraction. Psychiatry: Journal of Interpersonal Relations, 18: 213-231.Goffman, E. 1957. Alienation from interaction. Human Relations, 10: 47-59.Goffman, E. 1961.Encounters: Two Studies in the Sociology of Interaction.Indianapolis: Bobbs-Merril. Trad. it. Espressione e identità. Il Mulino2003Goffman, E. 1963. Behavior in Public Places: Notes on the SocialOrganization of Gatherings. New York: The Free Press. Trad it. Ilcomportamento in pubblico. Einaudi 1971/2003Goffman, E. 1967. Interaction Ritual. New York: Doubleday-Anchor. Tradit. Il rituale dell’interazione. Il Mulino 1988.Goffman 1969. Strategic Interaction. Philadelphia: University ofPennsylvania Press. Trad. it. Interazione strategica. Il Mulino 1988Goffman, E. 1971. Relations in Public: Microstudies of the Public Order. NewYork: Harper and Row. Trad it. Relazioni in pubblico. Bompiani 198128
Goffman, E. 1974. Frame Analysis: An Essay on the Organization ofExperience. New York: Harper and Row. Trad. it. Frame Analysis.Armando 2003Goffman 1981. Forms of Talk. Philadelphia: University of PennsylvaniaPres.; trad it. Forme del parlare. ll Mulino 1987Goffman 1983. The interaction order. American Sociological Review, 48:1-17.; trad it. L’ordine dell’interazione. Armando 1988Goodwin, C. 1981. Conversational Organization: Interaction betweenSpeakers and Hearers. New York: Academic Press.Hare, A. P., E. F. Borgatta e R. F. Bales 1955. Small Groups: Studies inSocial Interaction. New York: Knopf.Heims, S. P. 1977. Gregory Bateson and the mathematicians: frominterdisciplinary interaction to societal functions. Journal of theHistory of the Behavioural Sciences, 13: 141-159.Homans, G. 1950. The Human Group. London: Routledge, Kegan Paul.James, W. 1890. Principles of Psychology. New York: Henry Holt.Kendon 1972. A review of Kinesics and Context by R. L. Birdwhistell.American Journal of Psychology, 85: 441-455.Kendon, A. 1979. Some methodological and theoretical aspects of the useof film in the study of social interaction. In G. P. Ginsburg, ed.Emerging Strategies in Social Psychological Research. New York:John Wiley.Kendon, A. 1982. The organization of behavior in face-to-face interaction:observations on the development of a methodology. In K. R. Schererand P. Ekman, eds. Handbook of Methods in Nonverbal BehaviorResearch, pp. 440-305. Cambridge: Cambridge University Press.Kendon, A. 1977. Spatial organization in social encoutners: the F-formation system. Studies in the Behavior of Social Interaction. Lisse:Peter De Ridder Press [Reprinted in Kendon 1990].Kendon, A. 1985. Behavioural foundationsfor the process of frameattunementin face-to-face interaction. In G. P. Ginsburg, M. Brennerand M. von Cranach, eds. Discovery Strategies in the Psychology ofAction. London: Academic Press. [Reprinted in Kendon 1990].Kendon, A. e Ferber, A. 1973. A description of some human greetings. InR. P. Michael and J. H. Crook, eds. Comparative Behaviour ofPrimates. London: Academic Press. [Reprinted in Kendon 1990]Leeds-Hurwitz, W. 1986. Erving Goffman and the concept of social order.Paper prepared for the Conference: Erving Goffman: AnInterdisciplinary Appreciation, University of York, 8-11 July 1986.29
Leeds-Hurwitz, W. 1987. The social history of The Natural History of anInterview: A multidisciplinary investigation of social communication.Research on Language and Social Interaction, 20: 1-51.McDermott, R. P. e Roth, D. R. 1978. The social organization of behavior:interactional approaches. Annual Review of Anthropology, 7:321-345.McDermott, R. P. e Wertz, M. 1976. Doing the social order: someethnogrpahic advances from communicational analyses andethnomethodology. Reviews in Anthropology, 3: 160-174.McQuown, N. A. (ed). 1971. The Natural History of an Interview.Microfilm Collection of Manuscripts on Cultural Anthropology, 15thSeries, University of Chicago, Joseph Regenstein Library, Departmentof Photoduplication.Mead, G. H. 1934. Mind, Self and Society. Chicago: University of ChicagoPress.Park, R e Burgess E. W. (eds). 1924. Introdcution of the Science ofSociology, 2nd Edition. Chicago: Chicago University Press.Ruesch, J. 1972. Semiotic Approaches to Human Relations. The Hague:Mouton.Ruesch, J. e Bateson, G. 1951. Communication: The Social Matrix ofSociety. New York: Norton.Scheflen, E. 1963. Communication and regulation in psychotherapy.Psychiatry: Journal of Interpersonal Relations, 26: 126-136.Scheflen, A. E. 1964. The significance of posture in communicationsystems. Psychiatry: Journal of Interpersonal Relations, 27: 316-331.Scheflen, A. E. 1974. How Behavior Means. New York: Jason Aronson.Scheflen, A. E. e N. Ashcraft 1976. Human Territories: How We Behavein Space-Time. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.Schegloff, E. A. e H. Sacks 1973. Opening up closings. Semiotica, 8: 289-327.Sebeok, T. A., D. Hayes e M. C. Bateson 1964. Approaches to Semiotics.The Hague: Mouton.Spykman, N. J. 1925. The Social Theory of Georg Simmel. Chicago:University of Chicago Press.Watzlawick, P., J. Beavin e D. D. Jackson 1967. Pragmatics of HumanCommunication: A Study of Interactional Patterns, Pathologies andParadoxes. New York: Norton.Yngve, V. 1970. On getting a word in edgewise. In M. A. Campbell, et al. eds.Papers from the 6th Regional Meeting of the Chicago Linguistics Society, pp.567-578. Chicago: Department of Linguistics, University of Chicago.Zabor, M. 1978. Essaying metacommunication: a survey and contextualizationof communicative research. Ph.D thesis, Indiana University.30