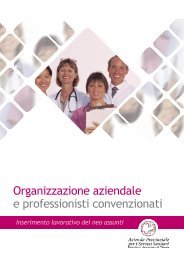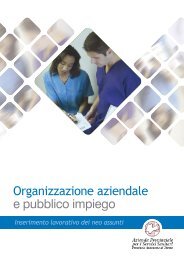fisiologia dell'invecchiamento
fisiologia dell'invecchiamento
fisiologia dell'invecchiamento
- No tags were found...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Fisiopatologiadell’invecchiamentoed attività motoriaProf. Federico SchenaCe.Bi.S.M.Polo di Rovereto, Università di Trento
700700Numeri indice (1950 = 100)60050040030020080 anni e più60-79 anni20-59 anni600500400300200Evoluzione dellapopolazione italianaper classi di età,1950-2020(da Lori et al., 1995, mod.)10010000-19 anni019501960197019801990200020102020
ITALIA: vita mediaISTAT, 1991MF73.9 80.3ISTAT, 2001M∼77F∼83
Invecchiamentodella popolazioneAumento di individui conmalattie croniche e disabili
Prevalenza di condizioni croniche in rapporto all’etàprevalenza x 1000persone (M e F)600500400300200100artrosisorditàipovedenzacardiopatiaischemicamalattiacerebrovascolaredemenza0< 45 45 - 64 > 75Età (anni)(U.S. Department of Health and Human Services, 1994)
Italian Longitudinal Study of Aging (ILSA - CNR):numero di patologie in rapporto all’età%8060MASCHIFEMMINE4020065-69 70-74 75-79 80-84 65-69 70-74 75-79 80-84nessuna patologiaEtà (anni)1-2 patologie ≥ 2 patologieRelazione al Parlamento sulla condizione dell’anziano 1996-1997
60555045403530252015105% di anziani non autosufficienti nellosvolgere attività quotidianeBasso rischioAlto rischioClassi di età61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 81-85lavarsi e fare il bagnospostarsi dal letto alla sediavestirsiandare alla toilettemangiare
Prevalenza difficoltà in attività basilari della vita quotidiana(ADL) in base all’età nei due sessidifficoltà ADL %30252015105MASCHIFEMMINE065-69 70-74 75-79 80-84 65-69 70-74 75-79 80-84difficoltà in una solaEtà (anni)difficoltà in 2 o piùRelazione al Parlamento sulla condizione dell’anziano 1996-1997
AustraliaAustriaCanadaFranciaOlandaSvizzeraMaschi, senzadisabilitàMaschi, condisabilitàFemmine, senzadisabilitàFemmine, condisabilitàGran BretagnaUSA0 5 10 15 20Aspettativa di vita a 65 anniWorld Health Organization, 1995
Declino funzionale emalattia sono inevitabilinell’anziano o esiste lapossibilità di un miglioreinvecchiamento?
INVECCHIAMENTODEFINIZIONEDal punto di vista biomedico, è un processo biologico,caratterizzato da cambiamenti che si realizzano nel corsodella vita dell'individuo, determinando una sempre minorecapacità di adattamento dell'organismo all'ambiente, unaconseguente ridotta probabilità di sopravvivere ed unacrescente probabilitàdi morire, ovvero un'aumentatafragilità.
BIOLOGIA DELL’INVECCHIAMENTOGENETICA↑↓AMBIENTE
BIOLOGIA DELL'INVECCHIAMENTOTIPI DI INVECCHIAMENTO1. Invecchiamento associato a malattia: è quello che riguardala maggior parte delle persone di età avanzata2. Invecchiamento usuale: è quello che si riscontra nellamaggior parte degli individui in assenza di malattia/e3. Invecchiamento di successo: è quello proprio di soggetti che,in assenza di malattia/e, hanno in età anche molto avanzataprestazioni fisiche e mentali non dissimili da quelle di soggettidi età giovane-adulta
Fisiologia dell’invecchiamento
Effetti dell’invecchiamento su alcuni indicifunzionali sulla base degli studi trasversali% Funzionalità residua1009080706050403020030 40 50 60 70 80 90Età (anni)velocità di conduzionedell’impulso nervosometabolismo basaleindice cardiacofiltrazione glomerulareflusso plasmatico renalecapacità vitalemassima capacitàrespiratoriaShock N., 1985
FISIOLOGIA DELL’INVECCHIAMENTOMODIFICAZIONI DI CARATTERE GENERALEStrutturali:• ↓ cellule parenchimali con comparsa di alterazionidellecellule superstiti ( mutazioni DNA, sintesi proteica, recettori,ecc.)
FISIOLOGIA DELL’INVECCHIAMENTOMODIFICAZIONI DI CARATTERE GENERALEStrutturali:• ↑ tessuto connettivo interstiziale• alterazioni dei tessuti connettivi interstiziale e tessutidifferenziati (cartilagine, osso, tendini,tessuto adiposo,vasi, cornea, derma)- ↑ componente collagena con comparsa dilegami crociati e alterazioni componente elastica- ↓ proteoglicani con ↓ della componenteglucidica (GAG) e ↑ di quella proteica
FISIOLOGIA DELL’INVECCHIAMENTOMODIFICAZIONI DI CARATTERE GENERALEFunzionali:• ↓ riserve funzionali• ↓ efficienza dei sistemi integrativi- sistema nervoso- sistema endocrino- sistema immunitario• ↓ capacità di adattamento = omeostenosi
100%Declinoetà-dipendenteLivello di massimafunzionalitàDeclino modulato dafattori ambientali0Livello di massimo disuso020 4060 80EtàInfluenza dei fattori ambientali sul declino età-dipendente dell’organismo (WilliamsM.F., 1994, mod.).
FISIOLOGIA DELL’INVECCHIAMENTOAPPARATO CARDIOVASCOLARECuoreStruttura:• ↑ dimensione atrio sinistro e spessore VS• ↓ numero miociti con ↑ dimensione miociti residui• ↑ tessuto adiposo, collageno, accumulo lipofuscina,amiloide• alterata produzione proteine contrattili e regolatrici• fibrosi dei nodi e tessuto di conduzione
FISIOLOGIA DELL’INVECCHIAMENTOAPPARATO CARDIOVASCOLARECuoreFunzione:• ↓ distensibilità VS• ↑ contributo atriale riempimento VS• ↓ efficienza formazione e conduzione impulso• ↓ risposta agli stimoli β-adrenergici- ↓ contrattilità- ↓ frequenza cardiaca massima sotto sforzo• ↓ la gittata cardiaca massimale mentre gittata cardiacaa riposo rimane invariata
FISIOLOGIA DELL’INVECCHIAMENTOAPPARATO CARDIOVASCOLAREVasiStruttura:grandi vasipiccoli vasi• ↑ spessore parete • ↑↑↑ spessore parete• ↑↑↑ calibro • ↓ lume• ↑ deposito calcio• ↑ rigidità parete
FISIOLOGIA DELL’INVECCHIAMENTOAPPARATO CARDIOVASCOLAREVasiFunzione:• ↑ resistenze periferiche• ↑ velocità di propagazione dell'onda sfigmica• ↓ efficienza meccanismi regolatori P.A.• ↓ efficienza meccanismi autoregolatori flussiparenchimaliImplicazioni cliniche:• ↑ pressione arteriosa sistolica• maggiore facilità ipotensione ortostatica• maggiore facilità ischemia d'organo
Modificazioni della funzionalità cardiacadurante sforzo massimale nell’anzianoVO 2maxEDVIFCMFEPAUomo↓↑↓↓↑ο ↔Donna↓↔↓↓↑ο ↔VO2 max = consumo massimo di ossigeno; EDVI= indice di volume telediastolico;FCM= frequenza cardiaca massima FE= frazione di eiezione; PA= pressione arteriosa.
Modificazioni della funzionalità cardiacain seguito ad attività fisica di tipoaerobico nell’anzianoUomoDonnaVO 2maxFCMFEFC riposo↑↔↑↓↑↔↔↓VO 2max = consumo massimo di ossigeno; FCM= frequenza cardiaca massima;FE= frazione di eiezione; PA= pressione arteriosa.
170PAS (mmHg)160150140130120donneuominiA11016-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75 +PAD (mmHg)888480767268donneuominiEtà (anni)B646016-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75 +Età (anni)
mmHg15Gruppo esercizioGruppo controllo10Variazione pressionesistolica50-5-10-15-20-25-303 mesi**6 mesi****9 mesimmHgVariazione pressionediastolica50-5-10-15-20-25**3 mesi*6 mesi*9 mesiConfronto della variazione della pressione sistolica e diastolica tra i soggettiipertesi che hanno preso parte all’attività fisica e quelli del gruppo controllo(*p< 0.5; **p< 0.01).Motoyama M. et al., 1998
190Pressione arteriosa (mmHg)180170160PRESSIONEARTERIOSASISTOLICA150Pressione arteriosa (mmHg)11010090800 4 8 12Settimane di allenamento aerobicoPRESSIONEARTERIOSADIASTOLICA700 4 8 12Settimane di allenamento aerobico
ATTIVITÀ FISICA EDIPERTENSIONE ARTERIOSA• Prevenzione- ↓ rischio di ipertensione arteriosa• Trattamento- ↓ valori pressori in soggetti ipertesi- ↓ fattori di rischio cardiovascolare(diabete, ipercolesterolemia, ecc.)
CAPACITÀ AEROBICA MASSIMA (VO 2max)2max )La capacitàmassima di produrre energia attraverso ilmetabolismo aerobico e quindi di compiere un’attivitàmotoria utilizzando il metabolismo aerobico.La funzione cardiovascolare, quella respiratoria, e quellamuscolare costituiscono i fattori determinanti la capacitàaerobica.La capacità aerobica si riduce con l'età, anche se, a parità dietà, è maggiore nei soggetti che praticano con regolaritàattività fisica.
80Studi trasversaliVO2 max (ml/kg/min)70605040302020 30 40 50 60 70 80 90Età (anni)atletisedentariModificazione della capacità aerobica massima (VO2 max), in un follow-up di 20anni, in atleti di sesso maschile che hanno continuato ad allenarsi ad elevata ( ),moderata ( ) o bassa ( ) intensità.Pollock M.L., J.Appl.Physiol., 1997
30*VO2 max ( (mlkg mlkg-lmin lmin-l)252015105InizialeFinale0*p
FISIOLOGIA DELL’INVECCHIAMENTOAPPARATO RESPIRATORIOStruttura:• alterazioni articolazioni costo-trasversarie e condrosternali• ↑ rigidità coste• alterazione connettivo interstiziale• alterazioni sistema ciliare• ↓ numero alveoli → ↓superficie alveolocapillare
FISIOLOGIA DELL’INVECCHIAMENTOAPPARATO RESPIRATORIOFunzione:• ↓ efficienza dei muscoli respiratori• ↓ compliance toracica• ↓ efficienza riflesso tosse e clearance mucociliare• ↓ elasticità polmonare• ↑ volume residuo, ↓ volume corrente, capacità vitale,VEMS• ↓ efficienza scambi gassosi- ↓ efficienza respiratoria (↓ PaO 2 )
Modificazione con l'invecchiamento dellafunzione respiratoria durante l'attività fisica.‣ ↓ ventilazione volontaria massima.‣ ↑ equivalente respiratorio (ventilazioneminuto/produzione di CO 2).‣ = frequenza respiratoria massima.‣ ↑ dispnea durante intenso esercizio.
FISIOLOGIA DELL’INVECCHIAMENTOAPPARATO MUSCOLARE (SARCOPENIA)Struttura:• ↓ numero fibre muscolari• ↓ sistemi enzimatici deputati produzione energia
Woman, 25 yrsWoman, 80 yrsInCHIANTI
statoinfiammatorioinattivitàfisicadeclino apparatoendocrino(↓insulina, androgeni,estrogeni, ormone dellacrescita)SARCOPENIAperditamotoneuronispinaliAlimentazionecarentedi proteineIpotesi relative alla patogenesi della sarcopenia
3025< 40 anniMuscolo8-OHdG/105 dG2015105*°*°*°40-50 anni51-60 anni61-70 anni> 70 anni0a b c d egruppi(Mecocci P. et al., 1999)* p
Conseguenze della sarcopenia nell’anziano• ↓ forza, potenza e resistenza muscolare• ↓ massa ossea• ↓ equilibrio• ↓ isolamento corporeo• ↓ produzione basale di calore• ↑ calore specifico• ↓ contenuto corporeo acqua• ↓ capacità dispersione cutanea calore• ↓ metabolismo base ed utilizzo glucosio
Implicazioni cliniche della sarcopenianell’anziano• ↓ autonomia funzionale, ↑ disabilità• ↑ osteoporosi• ↑ rischio cadute, ↑ rischio fratture• ↑ rischio ipotermia• ↑ rischio ipertermia• ↑ tessuto adiposo• ↑ rischio cardiovascolare
Strength conditioning in older men: skeletal musclehypertrophy and improved functionKg50454035302520151050Estensori ginocchio sin.Settimane di allenamentoFlessori ginocchio sin.0 2 4 6 8 10 12Frontera W.R. et al., Am. Physiol. Soc., 1988
150Gamba dxGamba sxArea (cm 2 )140130120****1101000 6 12 0 6 12Tempo (settimane)Modificazioni dell’area muscolare a livello della gamba destra e di quella sinistravalutate mediante tomografia computerizzata dopo 6 e 12 settimane di allenamentocontro resistenza. * p
10,9Probabilità cumulativa dirimanere liberi da diabete0,80,70,60,50,40 1 2 3 4 5 6Anni dall’inizio dello studioProporzione di individui con ridotta tolleranza glucidica che non hanno sviluppato diabete nel corso dellostudio. Il rischio relativo di diabete nel gruppo di intervento è risultato pari a 0,4 (p
FISIOLOGIA DELL’INVECCHIAMENTOAPPARATO OSTEOARTICOLAREStruttura:• ↓ massa ossea trabecolare e corticale- alterazioni quantitative e qualitative matrice ossea- ↓ attività osteoblastica• ↓ GAG, elastina e contenuto acqua nella cartilagine enei tendiniFunzione:• ↓ capacità biomeccaniche cartilagine e tendini• ↓ resistenza ossoImplicazioni cliniche:• ↑ incidenza fratture
4000Incidenza(per 100.000 invidui/anno)30002000100035MaschiFemmine>85 35>85Età (anni)Frattura femoreFrattura vertebraleFrattura di CollesIncidenza delle fratture di femore, vertebrali e dell’avambraccio distale (fratturadi Colles) in rapporto all’età ed al sesso. (Lips P., 1997)
Cambiamento densità ossea(g/cm 2 )0,020,01-0,01-0,02-0,03-0,040*§collofemoralecolonnalombareGruppocontrolloGruppoesercizioModificazioni della densità ossea a livello del collo femorale e della colonnalombare nel gruppo che ha praticato attività motoria ed in quello di controllo.(Nelson M.E. et al., 1994).* p =.02; § =.04
Tempo di equilibrio (secondi)7654ATE0 3 6 9 12 15 18mesiValore medio del tempo di equilibrio ad occhi aperti nei tre gruppi (A: esercizioaerobico; E: educazione sanitaria; T: allenamento contro resistenza). (MessierS.P. et al., 2000).
Effetti dell’attivitàfisica sul rischio di cadutenell’anziano(Province M.A., 1995)Scopo: determinare se la partecipazione ad unprogramma di attività fisica riduce il rischio dicadute e di lesioni conseguenti a cadutenell’anzianoMetodi:analisi combinata dei risultati di 7 studi (5 inanziani che vivevano nella propria abitazione, 2in anziani in casa di riposo)Conclusione: la partecipazione all’attività fisica, in particolarea quella che ha l’obiettivo di migliorarel’equilibrio, riduce il rischio di cadute.
Attività fisica e disabilitànell’anziano
Anziano↓ capacità fisiologica• neurologica• muscoloscheletrica• cardiovascolare e respiratoria(↓ forza muscolare, capacitàaerobica, flessibilità, equilibrioecc.)DISABILITÀBuchner D.M. Clin Geriat. Med.,1992
40100%100%15Capacità aerobica(ml/kg/min)30201050%50%7,5020 annidonne80 anni0Camminare a 4.8 km/hVestirsi/svestirsiStare seduta
UominiDonneAltezza scalino (cm)Altezza scalino (cm)503005432150-54 55-59 60-64 65-69 70-740Età (anni)Skelton D.A., 1999Potenza arti inferioiri (W/kg)Potenza arti inferioiri (W/kg)
invecchiamentomalattiestile di vita(sedentarietà, fumo)Anziano↓ capacità fisiologica• neurologica• muscoloscheletrica• cardiovascolare e respiratoria(↓ forza muscolare, capacitàaerobica, flessibilità, equilibrioecc.)DISABILITÀBuchner D.M. Clin Geriat. Med.,1992
UOMINI 75 anniAspettativa di vita (anni)141062FUMATORINON FUMATORIdisabileattivalieve mod. intensa lieve mod. intensaAttività fisicaFerrucci L., Am. J. Epidemiol., 1999
DONNE 75 anniFUMATRICI NON FUMATRICIAspettativa di vita (anni)161284lieve mod. intensa lieve mod. intensadisabileattivaAttività fisicaFerrucci L., Am. J. Epidemiol., 1999
1210controlliesercizioCS-PFP Unità86420-2-4Tot. Forza Forza Flessibilità Equilibrio Resistenzaarti arti &sup. Inf.Coordin.Cress M.E. et al., J Geront, 1999
Exercise training and nutritional supplementation forphysical frailty in very elderly peopleFiatarone M.A. et al., N. Engl. J. Med., 1994Randomized, placebo-controlled trial comparing progressive resistance exercise training,multinutrient supplementation, both interventions, and neither in 100 frail nursing homeresidents over a 10-week period.Baseline characteristics of the subjectsEXERCISE +EXERCISESUPPLEMENT SUPPLEMENT CONTROL(N.25) (N.25) (N.25) (N.25)Age (yr) 72-95 76-98 75-97 78-98Level of dependence (% of subj.)- Independent 32.0 36.0 41.7 38.5- Semidependent 64.0 56.0 54.2 53.9- Dependent 4.0 8.0 4.2 7.7Regular medications (no.) 4.5 5.3 6.4 5.1Diagnoses (no.) 5.6 4.9 5.0 4.7Mini-Mental State score 20.9 23.2 22.7 22.2Depression score (GDS) 8.2 9.9 9.5 12.7
Exercise training and nutritional supplementation forphysical frailty in very elderly peopleFiatarone M.A. et al., N. Engl. J. Med., 1994Change in musclestrength (%)2001751501251007550250-25-50P = 0.001P = 0.001Exercise Exercise +supplementSupplementControlMean (± SE) changes in muscle strength after exercise, nutritionalsupplementation, neither, or both
Study groupp valueEx. Ex. + suppl. Cont. Exer. Suppl.suppl.Gait (m/sec) 8.6 14.9 5.2 -7.2 0.02 0.31Stair (W) 33.8 23 12.5 -5.2 0.01 0.74Physical activity 51 17.6 -6.7 -2.6 0.03 0.34Fiatarone M.A. et al., N. Engl. J. Med., 1994
CONCLUSIONI (I)E’ ormai dimostrato che lo stato di salute e di autonomiafunzionale dell’anziano non dipende esclusivamentedall’invecchiamento ma è influenzato in misura importantedalle malattie e dallo stile di vita, ed in particolare dal livello diattività fisicaUna regolare attività fisica costituisce un fattore in grado dicontrastare la riduzione della riserva funzionale che si verificanei soggetti anziani e di consentire un invecchiamento incondizioni ottimali
CONCLUSIONI (II)Una regolare attività fisica costituisce un fattore protettivo neiconfronti della comparsa di numerose malattie e delladisabilità in età avanzataAnziani sani ed anziani fragili già disabili possono migliorareil loro stato di salute ed il livello di autonomia funzionaleattraverso la partecipazione ad un programma di attività fisicaI meccanismi attraverso i quali l'attività fisica agisce sonoalmeno due, da una parte il miglioramento dei parametri dicapacità fisiologica (capacità aerobica, forza muscolare,equilibrio, ecc.), dall'altra la prevenzione, il trattamento e lariabilitazione delle patologie disabilitanti
CONCLUSIONI (III)Le organizzazioni pubbliche statunitensi raccomandanoun’attività fisica moderata per almeno 30 minuti nellamaggior parte, meglio ancora se in tutti, i giorni dellasettimana.La prescrizione dell’attività fisica va sempre individualizzata,anche se un programma completo, comprendente attivitàaerobica, contro resistenza, cioèper aumentare la forzamuscolare, e per il miglioramento della flessibilità edell'equilibrio è di solito raccomandabile nell’anziano.
Claudia Benedetti>Maria Chiara Ceccucci>Emanuela Costanzi>Sara Ercolani>Patrizia RinaldiSezione di Gerontologia e Geriatria, Università di Perugia