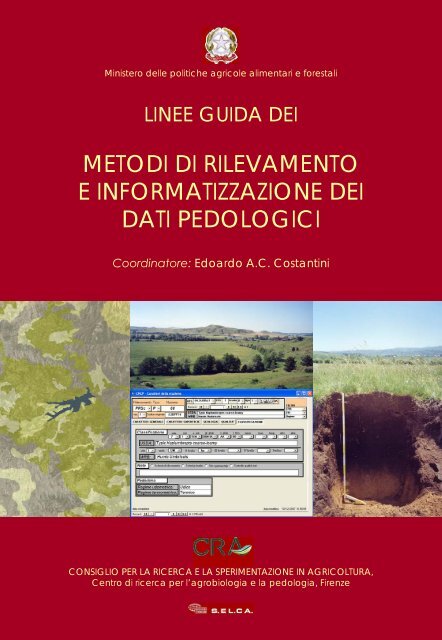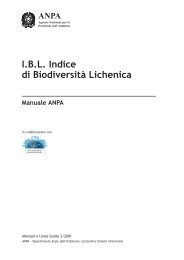metodi di rilevamento e informatizzazione dei dati pedologici
metodi di rilevamento e informatizzazione dei dati pedologici
metodi di rilevamento e informatizzazione dei dati pedologici
- No tags were found...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestaliLINEE GUIDA DEIMETODI DI RILEVAMENTOE INFORMATIZZAZIONE DEIDATI PEDOLOGICICoor<strong>di</strong>natore: Edoardo A.C. CostantiniCONSIGLIO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA,Centro <strong>di</strong> ricerca per l’agrobiologia e la pedologia, Firenze
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALILINEE GUIDA DEIMETODI DI RILEVAMENTOE INFORMATIZZAZIONEDEI DATI PEDOLOGICICoor<strong>di</strong>natore: Edoardo A.C. CostantiniCONSIGLIO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA,Centro <strong>di</strong> ricerca per l’agrobiologia e la pedologia, Firenze- Firenze
Al prof. Guido Sanesimaestro del <strong>rilevamento</strong> pedologicoIn copertina:scheda pedologica, geografia, suolo e paesaggio della Sila, CalabriaImpaginazione e<strong>di</strong>zione web (2011): Giovanni L’AbateStampa (2007): E<strong>di</strong>zioni SELCA, FirenzeCitazione dell’opera:Costantini E. A. C. (Ed.) 2007. Linee guida <strong>dei</strong> <strong>meto<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>rilevamento</strong> e<strong>informatizzazione</strong> <strong>dei</strong> <strong>dati</strong> <strong>pedologici</strong>, CRA-ABP, Firenze, Italia, pp. XV, 280
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICIPresentazione .................................................................................................................................... IVIntroduzione ...................................................................................................................................... VIPremessa..........................................................................................................................................VIIIRiconoscimenti....................................................................................................................................XIn<strong>di</strong>rizzo degli autori...........................................................................................................................XRiassunto.............................................................................................................................................XAbstract ...........................................................................................................................................XIII1. Il <strong>rilevamento</strong> <strong>dei</strong> suoli ................................................................................................................... 1In<strong>di</strong>ce................................................................................................................................................... 11.1 Il <strong>rilevamento</strong> <strong>dei</strong> suoli: l’oggetto del <strong>rilevamento</strong>....................................................................... 11.2 Le unità tipologiche <strong>di</strong> suolo......................................................................................................... 51.3 Il <strong>rilevamento</strong> pedologico GIS oriented...................................................................................... 212. Le banche <strong>dati</strong> geografiche ........................................................................................................... 29In<strong>di</strong>ce................................................................................................................................................. 292.1 La gerarchia <strong>dei</strong> pedopaesaggi.................................................................................................... 292.2 Le regioni pedologiche (soil regions) ......................................................................................... 302.3 Le province pedologiche (soil subregions) ................................................................................. 332.4 I sistemi <strong>di</strong> terre (soil systems) ................................................................................................... 332.5 I sottosistemi <strong>di</strong> terre (soil subsystems) ...................................................................................... 402.6 Le unità <strong>di</strong> terre e gli elementi territoriali (land units e land elements)...................................... 452.7 I co<strong>di</strong>ci geografici ....................................................................................................................... 493. Il software <strong>di</strong> <strong>informatizzazione</strong> <strong>dei</strong> <strong>dati</strong>....................................................................................... 64In<strong>di</strong>ce................................................................................................................................................. 643.1 Introduzione ................................................................................................................................ 663.2 Il software CNCP........................................................................................................................ 673.3 Il database CNCP_b.mdb............................................................................................................ 683.4 Il motore CNCP_m.mdb ............................................................................................................. 763.5 Il geodatabase CNCP_g.mdb .................................................................................................... 1363.6 Possibili errori........................................................................................................................... 1394. La descrizione del suolo.............................................................................................................. 143In<strong>di</strong>ce............................................................................................................................................... 1434.1 Introduzione .............................................................................................................................. 1464.2 Caratteri generali del sito pedologico ....................................................................................... 1474.3 Fattori della pedogenesi ............................................................................................................ 1544.4 Descrizione del profilo.............................................................................................................. 1824.5 Caratteri e qualità del suolo ...................................................................................................... 221Glossari ........................................................................................................................................... 230Termini geomorfologici .................................................................................................................. 230Termini relativi ai substrati consoli<strong>dati</strong> .......................................................................................... 242Termini relativi ai materiali genitori e substrati non consoli<strong>dati</strong>.................................................... 248Principali termini <strong>pedologici</strong> ed informatici ................................................................................... 252Bibliografia ..................................................................................................................................... 262In<strong>di</strong>ce analitico................................................................................................................................ 270Appen<strong>di</strong>ci........................................................................................................................................ 273Tavole sinottiche per la stima percentuale <strong>di</strong> copertura.................................................................. 273Tavole per la stima della <strong>di</strong>mensione degli aggregati..................................................................... 274Tavole per la stima della frequenza <strong>dei</strong> macropori......................................................................... 276La scheda <strong>di</strong> <strong>rilevamento</strong> ................................................................................................................ 276III
PresentazioneLa degradazione del suolo rappresenta ormai una emergenza a livello planetario. Si tratta <strong>di</strong> unaemergenza tanto più pressante in Italia, a causa dell’alta variabilità dell’ambiente, anche per lapresenza <strong>di</strong> molti tipi <strong>di</strong> suolo caratterizzati da vulnerabilità senza dubbio più alta rispetto a gli altriPaesi Europei. La maggior parte, anzi la totalità, <strong>dei</strong> <strong>di</strong>sastri ambientali, a cui troppo spesso ormaiassistiamo, sono riconducibili alla mancanza <strong>di</strong> attenzione al suolo nella gestione degli ecosistemiagrari e forestali. Ma oltre ai <strong>di</strong>sastri ambientali più eclatanti, l’intensificazione della pressioneantropica nelle particolari con<strong>di</strong>zioni climatiche me<strong>di</strong>terranee ha provocato una preoccupantedegradazione <strong>dei</strong> suoli, rendendo tangibile, in molte aree del nostro paese, il rischio <strong>di</strong>desertificazione.Inoltre, negli ultimi decenni stiamo assistendo a tangibili cambiamenti non solo climatici, maanche ambientali e del sistema agricolo: da un lato si assiste ad un intensificarsi <strong>dei</strong> processi <strong>di</strong>degradazione del suolo (erosione, compattamento, impermeabilizzazione, consumo <strong>di</strong> suolo, per<strong>di</strong>ta<strong>di</strong> sostanza organica e <strong>di</strong> struttura, salinizzazione, desertificazione, ecc.) dovuti senza dubbio ad unanon corretta gestione del territorio; dall’altro lato ad un ra<strong>di</strong>cale cambiamento del modo <strong>di</strong> fareagricoltura. L’agricoltura tra<strong>di</strong>zionale e intensiva sta lasciando il posto ad un’agricolturamultifunzionale il cui scopo primario non è più la quantità, ma, semmai, la qualità <strong>dei</strong> prodotti in uncontesto non solo <strong>di</strong> protezione dell’ambiente ma <strong>di</strong> valorizzazione dell’ambiente stesso:“agricoltura che produce paesaggio”.Il suolo rappresenta quin<strong>di</strong> l’elemento essenziale sia per la protezione dell’ambiente sia perconsentire meglio la multifunzionalità dell’agricoltura, attraverso la pianificazione <strong>di</strong> un correttouso del suolo stesso.É altrettanto vero che la suddetta non corretta gestione del suolo <strong>di</strong>pende anche da unainsufficiente conoscenza pedologica. Fortunatamente questa necessità <strong>di</strong> una maggiore conoscenzapedologica viene sempre più avvertita, non solo nei canonici ambienti scientifici, ma soprattutto inquegli ambienti preposti alla pianificazione e alla tutela del territorio. Infatti, proprio le Regioni,anche sotto il notevole e meritorio impulso dell’Osservatorio Nazionale Pedologico del Ministerodella Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, si sono de<strong>di</strong>cate alla formazione <strong>dei</strong> nuclei<strong>pedologici</strong> regionali e alla istituzione <strong>dei</strong> “Referenti per la pedologia”, i quali hanno sempremanifestato la necessità <strong>di</strong> un riferimento metodologico nazionale.Proprio in questo contesto sono nate queste “Linee guida <strong>dei</strong> <strong>meto<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>rilevamento</strong> e<strong>informatizzazione</strong> <strong>dei</strong> <strong>dati</strong> <strong>pedologici</strong>”, che pur non avendo la pretesa <strong>di</strong> essere vincolanti,rappresentano comunque uno strumento che può essere preso come tale o adattato alle <strong>di</strong>versenecessità.La necessità <strong>di</strong> una completa conoscenza e <strong>di</strong> una accurata caratterizzazione del suolo, al fine <strong>di</strong>programmarne un uso corretto, deriva anche dall’applicazione della nuova Politica AgricolaComune (PAC). Come è noto il 26 giugno 2003 il Consiglio <strong>dei</strong> Ministri dell’agricolturadell’Unione Europea ha approvato una ra<strong>di</strong>cale riforma a carico della PAC, la così detta“Con<strong>di</strong>zionalità”, destinata a rivoluzionare le modalità <strong>di</strong> sostegno dell’intero settore da parte dellaUE per i prossimi 10 anni; infatti l’erogazione degli incentivi sarà subor<strong>di</strong>nata al rispetto <strong>di</strong>specifiche norme in materia <strong>di</strong> salvaguar<strong>di</strong>a ambientale, sicurezza alimentare e protezione deglianimali.Altro aspetto è quello della sfida futura della nostra agricoltura, da giocarsi tutta sulle colture <strong>di</strong>qualità e sulle colture tipiche, così come il corretto uso del suolo basato sulla vocazione delterritorio, cioè sul conferimento al binomio coltura/terre <strong>di</strong> una connotazione <strong>di</strong> eccellenzaqualitativa che si fonda sulle sue peculiarità. Molto spesso la coltura <strong>di</strong> qualità <strong>di</strong>venta anchecoltura <strong>di</strong> riferimento come immagine trainante <strong>di</strong> un territorio. Oggi si parla infatti <strong>di</strong> “qualitàIV
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICItotale del territorio” cioè il territorio gestito in funzione della qualità <strong>dei</strong> prodotti, conservazione delsuolo e degli ecosistemi, salubrità dell’ambiente, bellezza del paesaggio.Le linee guida forniscono gli strumenti essenziali per la conoscenza del suolo per valorizzarne lepotenzialità e per una corretta zonazione e gestione del territorio.L’ISSDS - Istituto Sperimentale per lo Stu<strong>di</strong>o e la Difesa del Suolo (ora confluito nel CRA –Centro <strong>di</strong> ricerca per l’agrobiologia e la pedologia – CRA-ABP) da sempre impegnato in attività <strong>di</strong>cartografia pedologica e banca <strong>dati</strong>, si è adoperato in questi anni per venire incontro a questanecessità <strong>di</strong> uniformazione delle metodologie pedologiche, collaborando con vari pedologi,anzitutto regionali, ma anche liberi professionisti, ricercatori e docenti universitari.Il più vivo apprezzamento quin<strong>di</strong> al curatore <strong>di</strong> queste linee guida, Dr. Edoardo Costantini, perla splen<strong>di</strong>da realizzazione <strong>di</strong> quest’opera, prodotta con il contributo del Ministero delle PoliticheAgricole, Alimentari e Forestali, e in<strong>di</strong>stintamente a tutti coloro che, a vario titolo, hannocontribuito a questo lavoro.Giuseppe SerinoDirettore Generale dello Sviluppo Rurale del Dipartimento delle Politiche <strong>di</strong> Sviluppo del Ministerodelle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Presidente dell’Osservatorio Nazionale Pedologicoe per la Qualità del Suolo Agricolo e ForestalePaolo SequiDirettore del C.R.A. – Centro <strong>di</strong> ricerca per lo stu<strong>di</strong>o delle relazioni tra pianta e suolo <strong>di</strong> Roma.Coor<strong>di</strong>natore dell’Osservatorio Nazionale Pedologico e per la Qualità del Suolo Agricolo eForestaleMarcello PagliaiDirettore del C.R.A. – Centro <strong>di</strong> ricerca per l’agrobiologia e la pedologia <strong>di</strong> Firenze. Presidentedella Società Italiana della Scienza del Suolo e Vice Coor<strong>di</strong>natore dell’Osservatorio NazionalePedologico e per la Qualità del Suolo Agricolo e ForestaleV
IntroduzioneAnche se la Pedologia, la scienza che stu<strong>di</strong>a il suolo, in Italia non vanta antichissime origini (laSISS - Società Italiana della Scienza del Suolo ha celebrato i suoi 50 anni <strong>di</strong> attività nel 2001),possiamo affermare che la consapevolezza dell’importanza che lo stu<strong>di</strong>o del suolo riveste in campoagricolo e forestale è ormai un fatto acquisito anche nel nostro Paese.Il raggiungimento <strong>di</strong> tale consapevolezza si è rivelato tuttavia un cammino lento e <strong>di</strong>fficile seancora nel non lontano 1993, Fiorenzo Mancini in una breve nota dal titolo “Ma lo sai chel’orizzonte argillico può spesso far comodo all’agricoltore?”, illustrava con mirabili esempil’importanza che l’orizzonte argillico riveste nelle aree risicole della Lomellina o nelle aree ortive <strong>di</strong>terrazzi marini e fluviali dell’Italia meri<strong>di</strong>onale, metteva in risalto come la presenza <strong>di</strong> tale orizzonteconsentisse un consistente risparmio <strong>di</strong> acqua, cosa non <strong>di</strong>sprezzabile in ogni tempo, e concludevacon la seguente riflessione: “chissà se qualcuno ancora ritiene inutile lo stu<strong>di</strong>o del profilo (delsuolo), e qualche altro è fautore <strong>di</strong> lavorazioni molto profonde che sconvolgono una assaifavorevole successione naturale <strong>di</strong> orizzonti <strong>pedologici</strong>”.A quin<strong>di</strong>ci anni <strong>di</strong> <strong>di</strong>stanza da questa riflessione, i tempi sono maturi per operare un salto <strong>di</strong>qualità culturale che consenta <strong>di</strong> considerare il suolo un bene collettivo: una risorsa non solo per gliaddetti ai lavori (principalmente agronomi e forestali) ma per tutta la Società!La Scienza del Suolo ha oggi un ruolo insostituibile da compiere nell’attuare sistemi sostenibili <strong>di</strong>uso del territorio che sod<strong>di</strong>sfino la necessità <strong>di</strong> una società sempre più globale e tecnologica. Leattività della ricerca nella Scienza del Suolo, sia in Europa che in tutti i Paesi tecnologicamente esocialmente più avanzati, abbraccia settori notevolmente più ampi <strong>di</strong> quelli tra<strong>di</strong>zionali e includeoltre agli stu<strong>di</strong> fondamentali, ricerche sugli ecosistemi e applicazioni pedotecnologiche.Il suolo viene oggi considerato in una nuova ottica, non più limitata al campo agricolo e/oselvicolturale, ma ampliata al territorio poiché, espletando funzioni sia biotiche che abiotiche, esso è<strong>di</strong>venuto una componente vitale <strong>dei</strong> processi e <strong>dei</strong> cicli ecologici, un ricettacolo <strong>dei</strong> nostri rifiuti, unefficace filtro per le nostre acque sempre più inquinate, la base su cui poggiano le nostreinfrastrutture, un mezzo attraverso cui gli archeologi, con l’aiuto <strong>dei</strong> pedologi, leggono la storiadell’Uomo.La necessità della conoscenza <strong>dei</strong> suoli, sistemi aperti ed in quasi sempre lenta ma continuatrasformazione, è <strong>di</strong>venuta imperativa per “l’homo tecnologicus”, erede del “sapiens” che, costrettoa destreggiarsi e a convivere fra cemento, plastica e computers, <strong>di</strong>fficilmente si ferma a riflettere suquanto il suo benessere sia fondamentalmente connesso al suolo.Con la pubblicazione delle “Linee guida <strong>dei</strong> <strong>meto<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>rilevamento</strong> e <strong>informatizzazione</strong> <strong>dei</strong> <strong>dati</strong><strong>pedologici</strong>”, Edoardo A. C. Costantini, grande esperto ed appassionato stu<strong>di</strong>oso del suolo, fornisceoggi uno strumento <strong>di</strong> grande potenzialità e professionalità per lo stu<strong>di</strong>o <strong>dei</strong> suoli e per la lororappresentazione. L’opera, <strong>di</strong> facile lettura ed accompagnata da numerose immagini, figure e tabelle<strong>di</strong> notevole utilità pratica, si compone <strong>di</strong> quattro capitoli de<strong>di</strong>cati rispettivamente al <strong>rilevamento</strong>pedologico; alla geografia delle banche <strong>dati</strong>; ai co<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> queste; al software <strong>di</strong> gestione delle stesse.Nel testo si raccoglie l’esperienza maturata a livello internazionale in questi anni <strong>di</strong> rapidaevoluzione delle conoscenze pedologiche e delle tecnologie informatiche, la si adatta allecon<strong>di</strong>zioni italiane, in modo tale da agevolare lo scambio delle conoscenze sui suoli tra i pedologi econ gli altri specialisti delle <strong>di</strong>scipline ambientali.Il raggiungimento <strong>di</strong> questo traguardo non è stato semplice proprio perché non agevole è stata lastrada della affermazione della Pedologia come scienza autonoma nel nostro Paese.Lo stu<strong>di</strong>o del suolo, che pure può essere considerato anche per una sola delle sue <strong>di</strong>versecomponenti (fisiche, chimiche, biologiche, mineralogiche, idrologiche), non può fare a meno dellaosservazione <strong>di</strong> campo e cioè dello stu<strong>di</strong>o del profilo del suolo, dell’in<strong>di</strong>viduazione in esso <strong>dei</strong> suoiorizzonti costitutivi, in<strong>di</strong>catori <strong>di</strong> specifici o compositi processi pedogenetici, della definizione <strong>dei</strong>VI
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICI<strong>di</strong>versi parametri <strong>di</strong> qualità che, nel loro insieme, consentono <strong>di</strong> classificare il suolo e <strong>di</strong> esprimerevalutazioni compiute sulle sue attitu<strong>di</strong>ni, potenzialità e capacità in ambito agricolo, forestale, ingegneristico,urbanistico, economico, sociale.In altre parole occorre conoscere i suoli per correlarne le caratteristiche e le potenzialità con tuttigli altri aspetti ambientali naturali, fisici, economici ed antropici, si da pianificarne l’uso inun’ottica <strong>di</strong> gestione rispettosa della conservazione <strong>di</strong> una risorsa fondamentale per le generazionifuture. La Pedologia e la cartografia pedologica rappresentano pertanto elementi insostituibili per lagestione del territorio al pari delle altre <strong>di</strong>scipline che hanno valenza territoriale ed ambientale.Carmelo DazziOr<strong>di</strong>nario <strong>di</strong> Pedologia, Università <strong>di</strong> Palermo. Presidente della V Commissione della SocietàItaliana della Scienza del SuoloVII
PremessaLa messa a punto <strong>di</strong> metodologie <strong>di</strong> <strong>rilevamento</strong>, cartografia ed <strong>informatizzazione</strong> <strong>dei</strong> suoli èun’attività che si sviluppa continuamente nel tempo a seguito degli avanzamenti scientifici e delleinnovazioni tecnologiche. In Italia, la ricerca pedologica ha ricevuto un sostanziale impulsodall’attività promossa dall’allora Istituto <strong>di</strong> Geologia applicata della Facoltà <strong>di</strong> Agraria <strong>di</strong> Firenze,<strong>di</strong>retto a partire dal 1954 da Fiorenzo Mancini, succeduto a Paolo Principi, primo artefice dellapedologia italiana. In quegli anni l’attività <strong>di</strong> ricerca dell’istituto si è rivolta soprattutto allo stu<strong>di</strong>o ecartografia <strong>dei</strong> suoli, producendo il primo manuale italiano <strong>di</strong> <strong>rilevamento</strong> <strong>dei</strong> suoli (Mancini, 1957)a cui ha seguito la “Guida per servire allo stu<strong>di</strong>o del suolo in campagna” <strong>di</strong> Giovanni Ferrari eGuido Sanesi, assistenti <strong>di</strong> Mancini, che riprendeva ed adattava alle con<strong>di</strong>zioni italiane l’esperienzaanglosassone (Ferrari e Sanesi, 1965). In Sicilia, quasi contemporaneamente, Gian Pietro Ballatoree Giovanni Fierotti calibravano i <strong>meto<strong>di</strong></strong> <strong>rilevamento</strong> alle con<strong>di</strong>zioni locali e pubblicavano la primacarta <strong>dei</strong> suoli della Sicilia (1968).L’Istituto Sperimentale per lo Stu<strong>di</strong>o e la Difesa del Suolo <strong>di</strong> Firenze (attualmente CRA- Centro<strong>di</strong> ricerca per l’agrobiologia e la pedologia), fondato nel 1952 da Gino Passerini, ha anch’essode<strong>di</strong>cato da molto tempo una significativa parte della sua attività scientifica a questo filone <strong>di</strong>ricerca. Dopo la collaborazione <strong>di</strong> Luciano Lulli al manuale <strong>di</strong> <strong>rilevamento</strong> pedologico coor<strong>di</strong>natoda Guido Sanesi (1977) e gli stu<strong>di</strong> volti ad introdurre in Italia la metodologia <strong>di</strong> <strong>rilevamento</strong>per “serie” <strong>di</strong> suolo (Lulli et al., 1980) all’inizio degli anni ’90 sono stati pubblicati alcuniriferimenti (Costantini, 1991; Costantini et al., 1991) e nel 1995 è stato realizzato, in collaborazionecon le regioni del sud Italia, un manuale <strong>di</strong> <strong>rilevamento</strong> ed un primo software <strong>di</strong> <strong>informatizzazione</strong><strong>dei</strong> <strong>dati</strong> nell’ambito del progetto “Cartografia pedologica nelle Unità Operative Territorialidell’Italia meri<strong>di</strong>onale” (Gar<strong>di</strong>n et al., 1995 e 1996).Il manuale e il software riprendevano sia i riferimenti internazionali più importanti <strong>di</strong> queltempo (Van Wambeke e Forbes, 1986; FAO, 1990b; Soil Survey Staff, 1993) sia le primeesperienze <strong>di</strong> correlazione tipologica <strong>dei</strong> suoli realizzate in alcune regioni d’Italia (Fierotti, 1979;Dimase, 1983; Fierotti 1988; Fierotti et al., 1988; Aru, 1990; Aru et al., 1990; Filippi e Sbarbati,1994; RER-AIP, 1995; RER, 1995; Rasio e Vianello, 1995; Arangino et al., 1996). Il manuale e ilsoftware hanno avuto larga <strong>di</strong>ffusione tra i servizi <strong>pedologici</strong> regionali che si stavano alloraformando, per cui sono state realizzate versioni successive (Gar<strong>di</strong>n et al, 1998a e 1998b; Napoli etal., 1998 e 1999) e una riduzione appositamente configurata per le necessità della Regione Siciliana(Guaitoli et al., 1998).L’attività è poi continuata nell’ambito del sottoprogetto “Creazione della banca <strong>dati</strong> pedologica”del progetto S.I.N.A. - carta pedologica, coor<strong>di</strong>nato dalla Regione Emilia-Romagna (Sulli eCostantini, 1999a e 1999b), in cui sono stati recepiti alcuni avanzamenti metodologici internazionali(Soil Survey Staff, 1999) adattandoli all’ambiente italiano, alla luce delle molte esperienze <strong>di</strong>cartografia pedologica che si stavano allora realizzando.Dal 1999 al 2001 l’Istituto Sperimentale per lo Stu<strong>di</strong>o e la Difesa del Suolo ha coor<strong>di</strong>nato ilprogetto “Metodologie pedologiche: definizione <strong>di</strong> criteri e specifiche per la realizzazione,conservazione, aggiornamento e consultazione della carta <strong>dei</strong> suoli d’Italia in scala 1:250.000”(Costantini, 2002) nell’ambito del quale era previsto il sottoprogetto “Realizzazione del manuale <strong>di</strong><strong>rilevamento</strong> e <strong>di</strong> prototipi metodologici <strong>di</strong> <strong>di</strong>vulgazione delle informazioni” responsabile l’Ufficiopedologico della Regione Emilia-Romagna, il quale stipulò una convenzione con il Dipartimento <strong>di</strong>Scienza del Suolo e Nutrizione della Pianta dell’Università <strong>di</strong> Firenze per la realizzazione delmanuale <strong>di</strong> <strong>rilevamento</strong>. L’attività <strong>di</strong> calibrazione fu organizzata per aree test del nord, centro e sudItalia, coor<strong>di</strong>nate dagli uffici <strong>pedologici</strong> delle regioni Lombar<strong>di</strong>a, Abruzzo e Campania (Costantini eD’Antonio, 2001). Il manuale così ottenuto fu pubblicato sul sito del progetto nel 2001 (Carnicelliet al., 2001).VIII
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICISempre nell’ambito del progetto “Metodologie pedologiche” è stato creato il Centro Nazionale<strong>di</strong> Cartografia Pedologica (www.soilmaps.it) per la raccolta ed armonizzazione delle informazionipedologiche significative per la scala nazionale. Inoltre, in seguito ad una specifica convenzionestipulata con l’ufficio europeo <strong>dei</strong> suoli, è stata pubblicata la versione italiana del manuale europeo,nel quale i partecipanti al progetto metodologie pedologiche hanno armonizzato i <strong>meto<strong>di</strong></strong> italianicon quelli europei (Finke et al., 1999) ed è stata creata la banca <strong>dati</strong> delle regioni pedologiche,recependo le in<strong>di</strong>cazioni <strong>di</strong> tutte le regioni (Righini et al., 2001).Successivamente, l’Istituto Sperimentale per lo Stu<strong>di</strong>o e la Difesa del Suolo ha continuatol’attività <strong>di</strong> messa a punto <strong>di</strong> metodologie per la creazione <strong>di</strong> unità tipologiche <strong>di</strong> suolo e per la<strong>informatizzazione</strong> <strong>dei</strong> <strong>dati</strong> alfanumerici e geografici (Costantini et al., 2003; Napoli et al., 2003;Costantini et al., 2004; Napoli et al., 2005), <strong>di</strong> confronto tra la metodologia europea ed americana <strong>di</strong>creazione delle tipologie <strong>di</strong> suolo (Lachi e Costantini, 2002) e <strong>di</strong> calibrazione e validazione delmanuale <strong>di</strong> <strong>rilevamento</strong> nell’ambito <strong>di</strong> <strong>di</strong>versi progetti <strong>di</strong> ricerca, in particolare: “Realizzazionedella banca <strong>dati</strong> <strong>dei</strong> suoli a scala 1:250.000 della Regione Toscana” (Gar<strong>di</strong>n et al., 2002), “SoilProperty Data for Europe – SPADE 2” (SPADE 2, 2006), “Valutazione dell’attitu<strong>di</strong>ne del territorioall’olivicoltura e alla viticoltura in provincia <strong>di</strong> Siena” (Costantini et al., 2006), “Analisigeomorfologica e pedologica del territorio regionale in scala 1:250.000 della Regione Abruzzo”,“Atlante nazionale delle aree a rischio <strong>di</strong> desertificazione” (finanziamento del Ministerodell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare), “Gestione delle risorse idriche del sudItalia” (responsabile l’Istituto Nazionale <strong>di</strong> Economia Agraria), “Realizzazione degli strumentimetodologici per la realizzazione della carta <strong>dei</strong> suoli a scala 1:250.000 della Regione Lazio”,“Realizzazione <strong>di</strong> cartografia tematica <strong>di</strong> supporto alle attività <strong>di</strong> programmazione degli interventisul territorio – Carta <strong>dei</strong> Suoli regionale in scala 1:250.000 4/B” (finanziamento Regione Siciliana).Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, messo al corrente attraversol’Osservatorio Nazionale Pedologico e per la Qualità del Suolo Agricolo e Forestale dell’attivitàsvolta, nonché dell’esigenza sollecitata da molti referenti regionali <strong>di</strong> avere un documentocomplessivo, organico e <strong>di</strong> ampia <strong>di</strong>ffusione, ha deciso <strong>di</strong> finanziare la stampa <strong>di</strong> un testo cheraccolga i risultati ottenuti in questi ultimi anni. Il testo si presenta come “linee guida” persottolinearne la natura <strong>di</strong> riferimento culturale. In effetti, l’organizzazione delle informazionipedologiche può seguire logiche <strong>di</strong>verse, tutte pienamente legittime e motivate da esigenze <strong>di</strong> variotipo, non solo scientifico, ma anche tecnico-informatico ed organizzativo.Le presenti linee guida contengono sia materiale originale, frutto del lavoro <strong>dei</strong> ricercatori delCentro <strong>di</strong> ricerca per l’agrobiologia e la pedologia e <strong>di</strong> altri pedologi, sia materiale ripreso dallepubblicazioni citate e da altri lavori internazionali (principalmente: FAO, 2006; USDA-NRCS,2007). Il manuale e relativo software cercano <strong>di</strong> conciliare esigenze <strong>di</strong>verse, da quella del pedologoprofessionista, a quelle <strong>di</strong> un servizio regionale, a quella della costituzione <strong>di</strong> una banca <strong>dati</strong>nazionale, in modo da favorire la <strong>di</strong>ffusione delle informazioni pedologiche.Il testo è organizzato in quattro capitoli: il <strong>rilevamento</strong> <strong>dei</strong> suoli, le banche <strong>dati</strong> geografiche, ilsoftware <strong>di</strong> <strong>informatizzazione</strong> <strong>dei</strong> <strong>dati</strong>, la descrizione del suolo, seguono glossari, in<strong>di</strong>ce analitico etavole. L’ultimo capitolo, i glossari e le tavole, sono stati strutturati in modo tale da favorire l’usodel volume durante l’attività <strong>di</strong> campagna.Molte sono le innovazioni presenti nelle linee guida. Alcune tra le principali riguardano lametodologia <strong>di</strong> <strong>rilevamento</strong>, orientata ed agevolata dalla banca <strong>dati</strong> geografica, la creazioneautomatica <strong>di</strong> in<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> pedo<strong>di</strong>versità, per agevolare la correlazione tipologica, la creazione <strong>di</strong>tipologie pedologiche a <strong>di</strong>versa scala, l’in<strong>di</strong>cazione nella descrizione <strong>dei</strong> profili degli orizzontifunzionali, lo stretto legame ed interazione nel software tra suoli e geografia, adatto alla creazione<strong>di</strong> un sistema informativo pedologico.Al testo è infine allegato un CD-rom con il software per la memorizzazione e gestione <strong>dei</strong> <strong>dati</strong>puntuali e geografici <strong>dei</strong> suoli, la cui guida all’uso è implementata in linea e descritta nel terzocapitolo delle linee guida.IX
RiconoscimentiLe linee guida recepiscono il contributo <strong>di</strong> molte persone ed enti, che in tempi e mo<strong>di</strong> <strong>di</strong>versi hannolavorato sui temi del <strong>rilevamento</strong> ed <strong>informatizzazione</strong> <strong>dei</strong> <strong>dati</strong> <strong>pedologici</strong>. In particolare, gli autoririconoscono l’apporto culturale fornito da Nicola Filippi, Marina Guerman<strong>di</strong> e Paola Tarocco(Servizio Geologico, Sismico e <strong>dei</strong> Suoli, Regione Emilia Romagna), Romano Rasio e StefanoBrenna (Servizio <strong>dei</strong> suoli dell’ERSAF, Regione Lombar<strong>di</strong>a), Giuseppe Michelutti, StefanoBarbieri e Sara Zanolla (Servizio <strong>dei</strong> suoli dell’ERSA, Regione Friuli Venezia Giulia), GilbertoBragato (CRA-Centro <strong>di</strong> ricerca per lo stu<strong>di</strong>o delle relazioni tra pianta e suolo, Gorizia), MarcelloBrancucci (libero professionista, Regione Liguria), Ialina Vinci, Francesca Ragazzi e AdrianoGarlato (ARPAV, Veneto), Stefano Carnicelli, Ugo Wolf e Giovanni A. Ferrari (Dipartimento <strong>di</strong>Scienza del Suolo e Nutrizione della Pianta, Università degli Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> Firenze), Samantha Lorito(Centro Sperimentale per lo Stu<strong>di</strong>o e l'Analisi del Suolo, Università <strong>di</strong> Bologna), Lorenzo Gar<strong>di</strong>n(libero professionista, Regione Toscana), Rosario Napoli (CRA-Centro <strong>di</strong> ricerca per l’agrobiologiae la pedologia), Michele Bocci, Piero Magazzini e Fer<strong>di</strong>nando Urbano (liberi professionisti), MauroColtorti e Simone Priori (Dipartimento <strong>di</strong> Scienze della Terra, Università <strong>di</strong> Siena), IginoChiuchiarelli e Sergio Santucci (Nucleo pedologico ARSA, Regione Abruzzo), Tito Reale(Assessorato Agricoltura, Regione Molise), Amedeo D’Antonio (Assessorato per l’Agricoltura,Regione Campania), Francesco Bellino (Settore Agricoltura, Regione Puglia), Giovanni Aramini,Caterina Colloca e Raffaele Paone (Servizio Agropedologico, ARSA della Calabria), FabioGuaitoli, Gabriella Matranga e Marco Perciabosco (Assessorato Agricoltura, Regione Siciliana),Carmelo Dazzi e Alessandra Giorgianni (Università <strong>di</strong> Palermo), Salvatore Madrau (Università <strong>di</strong>Sassari), Mauro Piazzi (IPLA, Piemonte).In<strong>di</strong>rizzo degli autoriE. A. C. Costantini, R. Barbetti, M. Fantappiè, G. L’Abate, S. MaginiCRA-ABP Centro <strong>di</strong> ricerca per l’agrobiologia e la pedologiaPiazza M. D’Azeglio 3050121 Firenzeinfo@soilmaps.itM. Paolanti, R. RivieccioCHOROS sasVia P. Cuppari 3300134 RomaRiassuntoL’Istituto Sperimentale per lo Stu<strong>di</strong>o e la Difesa del Suolo <strong>di</strong> Firenze, attuale CRA-ABP, Consiglioper la ricerca e la sperimentazione in agricoltura - centro <strong>di</strong> ricerca per l’agrobiologia e lapedologia, ha de<strong>di</strong>cato da molto tempo una significativa parte della sua attività scientifica allamessa a punto <strong>di</strong> metodologie <strong>di</strong> <strong>rilevamento</strong>, cartografia ed <strong>informatizzazione</strong> <strong>dei</strong> <strong>dati</strong> <strong>pedologici</strong>.Più <strong>di</strong> recente, il gruppo <strong>di</strong> ricerca “Centro Nazionale <strong>di</strong> Cartografia Pedologica” (CNCP) hastu<strong>di</strong>ato le possibilità offerte alla pedologia dalle nuove tecnologie informatiche per l’archiviazionee la gestione <strong>dei</strong> <strong>dati</strong> territoriali (GIS e geodatabase). Le linee guida <strong>dei</strong> <strong>meto<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>rilevamento</strong> e<strong>di</strong>nformatizzazione <strong>dei</strong> <strong>dati</strong> <strong>pedologici</strong> sintetizzano lo stato dell’arte e forniscono un riferimento perX
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICIcoloro che si occupano <strong>di</strong> cartografia pedologica. Recepiscono molte delle in<strong>di</strong>cazioni presenti nellamanualistica internazionale, ma ere<strong>di</strong>tano anche le esperienze realizzate nei centri <strong>di</strong> ricerca italianie nei servizi <strong>pedologici</strong> regionali, che hanno contribuito alla creazione <strong>di</strong> una metodologia <strong>di</strong>correlazione e spazializzazione <strong>dei</strong> <strong>dati</strong> <strong>pedologici</strong> per molti aspetti innovativa.Il testo è strutturato in quattro capitoli ed altrettanti glossari ed appen<strong>di</strong>ci. Nel primo capitolo siforniscono i riferimenti generali circa le principali metodologie <strong>di</strong> <strong>rilevamento</strong> pedologico esistentie i relativi assunti teorici. In particolare, viene illustrato il cosiddetto “<strong>rilevamento</strong> ragionato”, checonsidera la particolare natura del suolo, allo stesso tempo continua e <strong>di</strong>scontinua, e che è alla basedell’esperienza <strong>di</strong> <strong>rilevamento</strong> tra<strong>di</strong>zionale; il <strong>rilevamento</strong> stocastico, che si basa sulla teoria dellevariabili regionalizzate e che privilegia l’aspetto continuo della copertura pedologica; alcunisviluppi recenti delle tecniche geostatistiche, che tendono a combinare i due approcci.L’applicazione del <strong>rilevamento</strong> ragionato, presa come riferimento, presuppone la creazione <strong>di</strong> unitàtipologiche <strong>di</strong> suolo (UTS), che si realizza per mezzo della correlazione pedologica. Nel capitoloviene presentato il sistema <strong>di</strong> correlazione agevolato dall’uso del geodatabase, dove è possibileattribuire ogni osservazione puntuale a <strong>di</strong>versi tipi <strong>di</strong> UTS, più o meno generalizzate secondo i<strong>di</strong>versi livelli geografici.Nella metodologia del CNCP, l’approccio geografico - pedopaesaggistico rappresenta il primocriterio <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduazione delle UTS. Le osservazioni puntuali vengono in primo luogo assegnate allivello geografico <strong>di</strong> riferimento e il primo raggruppamento è realizzato in base al tipo <strong>di</strong>pedopaesaggio. I successivi accorpamenti o sud<strong>di</strong>visioni delle osservazioni pedologiche vengonorealizzate con la finalità <strong>di</strong> ottenere UTS con organizzazione degli orizzonti funzionali eclassificazione simile. L’orizzonte funzionale è uno strato <strong>di</strong> suolo dato dall’accorpamento o dallasud<strong>di</strong>visione <strong>di</strong> orizzonti genetici effettuata sulla base <strong>di</strong> caratteri funzionali, in grado cioè <strong>di</strong>con<strong>di</strong>zionare la gestione e la risposta all’uso del suolo. I caratteri funzionali sono stabiliti dalpromotore della UTS, ma il software agevola la scelta evidenziando in rosso quelli per cui la me<strong>di</strong>anon è un in<strong>di</strong>ce statisticamente corretto della popolazione.Ogni UTS è costituita da almeno una sottounità tipologica <strong>di</strong> suolo (STS). La <strong>di</strong>fferenziazionedelle STS all’interno delle UTS avviene sulla base <strong>di</strong> criteri applicativi e gestionali specifici, fra cuiè privilegiato il criterio della classe <strong>di</strong> capacità d’uso. Una volta definite le STS e i relativi orizzontifunzionali, ad ognuno <strong>di</strong> essi vengono assegnati tutti gli orizzonti delle osservazioni afferentiall’STS, così che il software possa calcolare per ogni orizzonte funzionale la me<strong>di</strong>a, la deviazionestandard e la numerosità campionaria relativa ad un subset <strong>di</strong> <strong>dati</strong>: il limite inferiore, i <strong>dati</strong> analiticiroutinari e la permeabilità stimata. Il software CNCP calcola inoltre il valore modale <strong>dei</strong> caratteristazionali delle osservazioni relativo alla morfologia, litologia ed uso del suolo, alla capacità d’uso erelativa limitazione principale, alla quota, pendenza, numero <strong>dei</strong> giorni <strong>di</strong> secco e interferenzaclimatica, pietrosità, rocciosità, profon<strong>di</strong>tà della roccia, profon<strong>di</strong>tà utile e relativa natura dellalimitazione per l’approfon<strong>di</strong>mento ra<strong>di</strong>cale, limite superiore della falda e relativo tipo, drenaggioesterno ed interno, natura e grado <strong>di</strong> erosione del suolo.L’insieme delle elaborazioni formano un “suolo modale”, definito come un suolo caratterizzatodai valori modali, me<strong>di</strong> e deviazioni standard <strong>dei</strong> valori delle osservazioni pedologiche afferenti auna STS. Il suolo modale è la più affidabile rappresentazione dell’STS al fine dell’applicazione <strong>di</strong>modelli valutativi. Terminato il processo <strong>di</strong> correlazione, le UTS e STS create sono un dato arealeinterrogabile attraverso il geodatabase.Le STS vengono caratterizzate, infine, da un profilo caposaldo, che è il profilo pedologicoutilizzato principalmente a fini <strong>di</strong>vulgativi. Il profilo caposaldo viene selezionato tra i profili tipiciper rappresentare i suoli della STS e deve avere una buona documentazione analitica. Per facilitarela sua identificazione, è stato creato un apposito “in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> <strong>di</strong>versità”, grazie al quale si ha unain<strong>di</strong>cazione statistica della <strong>di</strong>stanza tra i caratteri del profilo e della stazione <strong>di</strong> ogni osservazionepedologica afferente alla STS e quelli del sito modale. Le osservazioni inoltre sono organizzate conun <strong>di</strong>verso grado <strong>di</strong> relazione con la STS. Si <strong>di</strong>stinguono osservazioni caposaldo, tipiche,XI
appresentative e correlate in base alla quantità <strong>di</strong> caratteri con valore superiore <strong>di</strong> 2 o 3 volte ladeviazione standard della STS.Nel primo capitolo viene anche presentata la metodologia <strong>di</strong> <strong>rilevamento</strong> GIS oriented, che è unnuovo tipo <strong>di</strong> <strong>rilevamento</strong>, in quanto non è né un <strong>rilevamento</strong> libero, né un <strong>rilevamento</strong> determinato,ma orientato a verificare le relazioni suolo-paesaggio postulate nell’analisi GIS. Il metodo prevede<strong>di</strong> selezionare i siti <strong>di</strong> <strong>rilevamento</strong> in funzione della occorrenza statistica <strong>dei</strong> pedopaesaggi, in mododa quantificare la variabilità pedologica al livello geografico <strong>di</strong> riferimento. Le informazioniraccolte dai siti sono quin<strong>di</strong> collegate alla geografia e più facilmente correlabili, così da facilitare lacreazione delle tipologie pedologiche alla scala <strong>di</strong> interesse.Il secondo capitolo è relativo alle banche <strong>dati</strong> geografiche. L’organizzazione spaziale delleinformazioni pedologiche avviene a <strong>di</strong>versi livelli geografici, cui corrispondono specifici livelli <strong>di</strong>generalizzazione dell’informazione: dal più generale, le regioni pedologiche (scala <strong>di</strong> riferimento1:5.000.000) finalizzata alla correlazione europea, fino a quella <strong>di</strong> dettaglio, le unità <strong>di</strong> terre (scala<strong>di</strong> riferimento 1:10.000-1:25.000) per applicazioni locali. Esiste quin<strong>di</strong> un sistema <strong>di</strong> banche <strong>dati</strong> incui sono co<strong>di</strong>ficati i legami tra suoli e paesaggio ai <strong>di</strong>versi livelli geografici e <strong>di</strong> generalizzazionepedologica. I livelli geografici vengono in<strong>di</strong>viduati in forma in<strong>di</strong>pendente, cioè utilizzando banche<strong>dati</strong> <strong>di</strong> supporto specifiche per ogni livello geografico. Per questo motivo le relazioni tra i livellipedopaesaggistici sono logiche e semantiche, più che topologiche.I pedopaesaggi sono composti da componenti territoriali, definite come insiemi <strong>di</strong> terre chemostrano caratteristiche configurazioni <strong>di</strong> morfologia, litologia ed uso suolo, descritti da legendespecifiche per quella scala. Nella banca <strong>dati</strong> geografica sono riportate tutte le principali componentiterritoriali apprezzabili alla scala <strong>di</strong> indagine. Le componenti territoriali sono prive <strong>di</strong> una geografiadefinita, fatta eccezione per le componenti territoriali del livello <strong>di</strong> maggior dettaglio, le unità <strong>di</strong>terre. In questo caso le componenti territoriali vengono chiamate “elementi territoriali”, in quantosono gli elementi fondamentali del pedopaesaggio.Il terzo capitolo è de<strong>di</strong>cato al software <strong>di</strong> <strong>informatizzazione</strong> <strong>dei</strong> <strong>dati</strong>: il “CNCP”. I primiparagrafi sono de<strong>di</strong>cati ad introdurre il modello concettuale, con una spiegazione approfon<strong>di</strong>ta <strong>di</strong>tutte le entità e relazioni che lo compongono. In particolare le tabelle sottounità e siti si colleganofra loro tramite la tabella sito_su, con la quale hanno una relazione uno a molti. In questa manieraesiste una relazione molti a molti fra osservazioni pedologiche puntuali ed STS, cioè è possibilelegare ogni <strong>rilevamento</strong> puntuale a più <strong>di</strong> una STS. Questo è il meccanismo che permette <strong>di</strong> creareSTS a <strong>di</strong>verse scale geografiche.Il software CNCP consente le funzioni <strong>di</strong> archiviazione e interrogazione <strong>dei</strong> <strong>dati</strong> areali e <strong>dei</strong><strong>dati</strong> <strong>pedologici</strong> puntuali; correlazione pedologica volta alla elaborazione delle UTS e STS; stampa<strong>dei</strong> profili, delle UTS e STS; gestione <strong>dei</strong> <strong>dati</strong> tramite pedofunzioni preconfigurate e/o tramite lenormali funzioni <strong>di</strong> Access (filtri e query); archiviazione della collocazione <strong>dei</strong> materiali relativi ai<strong>dati</strong> <strong>pedologici</strong>: schede <strong>di</strong> <strong>rilevamento</strong>, schede analitiche, campioni <strong>di</strong> suolo, sezioni sottili efotografie.Per quanto riguarda l’inserimento <strong>dei</strong> <strong>dati</strong> <strong>pedologici</strong> puntuali, l’attività è facilitata dallapresenza <strong>di</strong> menù a ten<strong>di</strong>na che richiamano e deco<strong>di</strong>ficano le legende e le classi <strong>dei</strong> vari caratteriutilizzate dalle linee guida. Sono fornite una serie <strong>di</strong> funzioni che verificano il corretto inserimento<strong>dei</strong> <strong>dati</strong>, in particolare per quanto riguarda i <strong>dati</strong> analitici, evidenziando le incongruenze.Grazie al software CNCP possono essere attivate anche una serie <strong>di</strong> pedofunzioni, in particolare:il calcolo della capacità <strong>di</strong> acqua <strong>di</strong>sponibile, sia del singolo orizzonte che del profilo; la stima dellacapacità <strong>di</strong> scambio cationico <strong>di</strong> ogni orizzonte; la determinazione della capacità depurativa <strong>dei</strong>suoli e della capacità protettiva <strong>dei</strong> suoli nei confronti delle acque profonde; la stima dellapermeabilità degli orizzonti e del gruppo idrologico <strong>dei</strong> suoli; la classe <strong>di</strong> capacità d’uso, sia delprofilo che della STS; la stima dell’interferenza climatica nei siti e del pedoclima; la stima delrischio <strong>di</strong> incrostamento superficiale e del rischio <strong>di</strong> compattamento superficiale. Un paragrafospecifico è de<strong>di</strong>cato alla spiegazione dettagliata <strong>dei</strong> moduli che consentono tali pedofunzioni.XII
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICIIl quarto ed ultimo capitolo è de<strong>di</strong>cato alla descrizione del suolo. Esso costituisce la guida <strong>di</strong>campagna e fa riferimento alla manualistica internazionale, integrata con i risultati delle esperienzerealizzate in Italia. Le legende <strong>di</strong> co<strong>di</strong>fica <strong>dei</strong> caratteri pedopaesaggistici sono state integrate con leconoscenze geologiche, geomorfologiche e <strong>di</strong> tipologie <strong>di</strong> copertura del suolo italiane. Le legendesono organizzate in forma gerarchica, in maniera da poter essere utilizzate con <strong>di</strong>versi livelli <strong>di</strong>generalizzazione, corrispondenti a <strong>di</strong>verse scale geografiche. In particolare, sono stati co<strong>di</strong>ficati 93substrati pedogenetici consoli<strong>dati</strong> e 66 non consoli<strong>dati</strong>, <strong>di</strong> cui 3 <strong>di</strong> origine organica. Le fisiografiericonosciute sono 218, i tipi <strong>di</strong> copertura del suolo 115 e le forme <strong>di</strong> vegetazione 70. La descrizionedel sito è articolata in 68 voci, comprendenti quelle previste dai più <strong>di</strong>ffusi manuali internazionali.La classificazione <strong>di</strong> forme, litologie e coperture del suolo raccoglie il frutto <strong>di</strong> anni <strong>di</strong> attività <strong>di</strong><strong>rilevamento</strong> e correlazione pedologica ed ha un significato pedologico, cioè, i caratteri paesaggisticihanno <strong>di</strong>mostrato <strong>di</strong> avere una possibile influenza sulle caratteristiche <strong>dei</strong> suoli.Le linee giuda sono corredate da quattro glossari: i) termini geomorfologici, ii) substraticonsoli<strong>dati</strong> e iii) non consoli<strong>dati</strong>, iv) principali termini <strong>pedologici</strong> e informatici; nonché daaltrettante appen<strong>di</strong>ci: i) tavole sinottiche per la stima delle percentuali <strong>di</strong> copertura del suolo, ii)tavole per la stima della <strong>di</strong>mensione degli aggregati, iii) tavole per la stima della frequenza <strong>dei</strong>macropori, iv) scheda <strong>di</strong> <strong>rilevamento</strong>. Il testo infine è corredato da un ampio in<strong>di</strong>ce analitico e da unCd-rom, grazie al quale è possibile installare il software CNCP su ogni computer ed accedere allaguida in linea. Nel Cd-rom sono contenuti anche due database aggiuntivi: il database ST500_2007,dove sono contenute le legende <strong>dei</strong> sistemi <strong>di</strong> terre italiani, e il DATABASE MICROMORPHO,per l’archiviazione delle descrizioni derivanti da analisi micromorfologica.AbstractGuidelines of the methods of soil survey and data informatizationThe Experimental Institute for Soil Study and Conservation of Florence, now CRA-ABP,Agricultural Research Council – Research Centre for Agrobiology and Pedology, has for manyyears de<strong>di</strong>cated a significant part of its scientific activity on the setting up of methodologies of soilsurvey, mapping and informatization. More recently, the research group “National Centre of soilmapping - Centro Nazionale <strong>di</strong> Cartografia Pedologica” (CNCP) has been studying the possibilitiesoffered to pedology from the new information technologies for land data storing and management(GIS and geodatabase). This Guidelines of the methods of soil survey and data informatization, withattached software, summarize the state of the art and give a reference to all who deal with pedologyand soil mapping. The Guidelines acknowledge many items of the most common internationalmanuals, but they also capture the experiences made in the Italian research centres and regional soilservices, which have contributed to the creation of a methodology of soil data correlation andspatialization that have many aspects of novelty.The Guidelines have four chapters and as many glossaries and appen<strong>di</strong>ces. The first chaptergives general references and principles about the most common and important soil surveymethodologies. In particular, the so-called “purposive sampling” is illustrated, which considers theparticular nature of soil, at the same time continuous and <strong>di</strong>scontinuous, and which is used in thetra<strong>di</strong>tional survey. Then the stochastic survey, which is based on the principle of the regionalizedvariables and privileges the continuity of the soil cover, finally some recent developments of thegeostatistical methods, looking towards merging the two approaches. The application of thepurposive sampling, taken as a reference from the guidelines, assumes the creation of soiltypological units (STUs), by means of a soil correlation activity. In the chapter, the system ofcorrelation used by CNCP is shown, where it is possible to allocate every observation to <strong>di</strong>fferentkind of STUs, which follow the <strong>di</strong>fferent generalization of the geographic data.XIII
The CNCP methodology uses the soilscape approach as first step to create a STU. The pits areassigned to a referenced geographic level and the first grouping is made accor<strong>di</strong>ng to the kind ofsoilscape. In the next step, soil observations are either grouped or sub<strong>di</strong>vided so as to obtain STUswith soil inside having similar classification and organization of functional horizons. The functionalhorizon is a layer obtained by grouping or partitioning genetic horizons, on the basis of functionalproperties that influence soil management and land use. The functional properties are stated by thesoil scientist, however, the software helps the choice highlighting in red the means that are a notcorrect statistical index of the population.Every STU has al least one typological subunit (STS). The separation of STSs inside a STU ismade on the basis of specific applicative ad management criteria, among them, the land capabilityclass is privileged. When STSs and their functional horizons are created, every horizon of eachobservation is allocated in a functional horizon, so that the software is able to calculate for everyfunctional horizon mean, standard deviation and number of samples of the lower limit, analyticalroutines data and estimated permeability. Furthermore, the CNCP software calculates the modalattribute of site qualities: morphology, lithology and land use, land capability and its mainlimitation, elevation, slope, cumulative days when soil moisture control section is dry, climaticinterference, rockiness, stoniness, rock depth, rooting depth, kind of limitation or impe<strong>di</strong>ment forrooting, upper depth of water table and related type, runoff, internal drainage, process and degree ofsoil erosion.The set of elaborations forms a “modal soil”, defined as a soil described by modal values, meanand standard deviation, of the data coming from the pedological observations that form a STS. Themodal profile constitutes the most reliable representation of a STS for the application of evaluationmodels. When the correlation process is finished, both STUs and STSs become a spatial data thatcan be queried in the geodatabase.The STS has also a benchmark profile, which is mainly used for <strong>di</strong>vulgation purposes. Thebenchmark profile is selected among typical profiles to represent the STS, therefore it should have aproper analytical documentation. A “<strong>di</strong>versity index” helps in its selection, by means of thestatistical value of the <strong>di</strong>stance between the profile and site characteristics of each soil observationand the characteristics of the modal soil of the STS. In ad<strong>di</strong>tion, each observation has a <strong>di</strong>fferentlinkage with the STS. There are benchmark, typical, representative and correlated observations, infunction of the quantity of characters with standard deviation value greater then 2 or 3 times that ofthe STS.The first chapter describes also the GIS oriented survey methodology, which is a new type ofsurvey, neither a free survey nor a grid survey, but oriented to verify the soil landscape relationshipspostulated in the GIS analysis. The method foresees a pit selection made in function of thestatistical occurrences of soilscapes, so as to evaluate soil variability at the reference geographicallevel. The collected soil information is joined to the geography and correlated, with the aim tocreate soil typologies at the reference scale.The second chapter deals with geographic databases. Spatial organization of soil data ismanaged at <strong>di</strong>fferent geographic levels, correspon<strong>di</strong>ng to specific levels of generalization: from themost general, the soil region (reference scale 1:5,000,000) finalized to European correlation, untilthe most detailed, the land unit (reference scales 1:10,000-1:25,000) for local applications. Linkagesbetween soil and landscape in the database are co<strong>di</strong>fied at each geographic level of generalization.The geographic levels are identified independently, using specific thematic layers for eachgeographic level. For this reason, the relationships between <strong>di</strong>fferent pedolandscape levels are logicand semantic, more than topologic. A soilscape is formed by land components, which are defined asset of lands showing characteristic morphological, lithological, and land cover patterns, which aredescribed making use of scale specific legends. The geographic database contains all the main landcomponents perceptible at the scale of investigation. The land components are not geographicallydelineated, except for the land components of the highest level of detail, the land units. In this casethe land components are called “land elements” as they are the basic elements of the soilscape.XIV
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICIThe third chapter describes the software “CNCP”. The first paragraphs introduce the conceptualmodel, with a detailed explanation of each entity and relation. The tables sottounità (STS) and siti(observations) are particularly relevant, because they are related through the table sito_s , with a oneto many relation. Therefore there is a many to many relation between observations (i.e. data store<strong>di</strong>n the table “siti”) and typological subunits (STU, i.e. data archived in the table “sottounità”). Thusit is possible to join each profile with more than one STU; this is the mechanism that permits tocreate independent STUs for each geographic scale.The software CNCP allows many functions: storing and querying spatial and point soil data,STUs and STSs creation; printing of STUs, STSs and profiles; data managing through alreadyavailable pedofunctions and/or common Access functions, such as filters and queries; storing theallocation of <strong>di</strong>fferent archival materials: soil survey forms, soil analysis forms, soil samples, thinsections and photographs.Storing pedological data is facilitated by the presence of combo box menus, which recall anddecode the items of all legends and classes used in the Guidelines. Functions have been set to verifythe correct data storing, especially analytical data, and to show possible errors.Many other pedofunctions are implemented in the CNCP software, i.e.: the estimated availablewater capacity of every horizon and for the whole profile; the estimated cations exchange capacity;the soil depurative and protective capability for groundwater; the class of horizon permeability andthe soil hydrological group; the land capability class for both site and STS; the site climaticinterference and the classification of pedoclimate; the risk of crusting and compaction. A specificparagraph is de<strong>di</strong>cated to the detailed explanation of the modules that allow the pedofunctions.The fourth and final chapter is de<strong>di</strong>cated to the soil description. It is a field soil survey manualthat refers to the international literature, integrated with the results coming from the Italianexperiences. International legends of soilscape characteristics have been integrated with Italiangeology, geomorphology and land cover specificities. The legends are hierarchically organized, sothat they can be used at <strong>di</strong>fferent generalization levels, correspon<strong>di</strong>ng to <strong>di</strong>fferent geographic scales.93 consolidated and 66 unconsolidated (3 of organic origin) soil parent materials have beenidentified. 218 landforms, 115 land covers, and 70 vegetation types have been found. Site andprofile description is articulated in 68 items. The proposed landform, lithology and land useclassification, resulting from many years of research activity in Italy in the field of soil survey andcorrelation, has pedological meaning, that is, the characters have demonstrated to possibly influencesoil characteristics.The Guidelines have four glossaries: i) geomorphological terms, ii) consolidated and iii)unconsolidated parent materials, iv) main pedological and informatics terms. Four appen<strong>di</strong>x are alsoadded: i) synoptic tables for the estimation of percentage cover, ii) tables for the estimation ofaggregates <strong>di</strong>mension and iii) macropores frequency, iv) field survey form. Finally, an analyticalindex is added and a Cd-rom containing the software CNCP installation kit, with its on line usermanual. In the Cd-rom, two further databases are included: the ST500_2007 database, containingthe specific legend used for the description of land systems of Italy, and the MICROMORPHOdatabase, created to archive data derived from micromorphological analysis.XV
IL RILEVAMENTO DEI SUOLI1. Il <strong>rilevamento</strong> <strong>dei</strong> suoliE. A. C. Costantini, M. Fantappiè, G. L’AbateIn<strong>di</strong>ce1.1 Il <strong>rilevamento</strong> <strong>dei</strong> suoli: l’oggetto del <strong>rilevamento</strong>....................................................................... 11.2 Le unità tipologiche <strong>di</strong> suolo......................................................................................................... 51.2.1 Le unità tipologiche <strong>di</strong> suolo nell’esperienza americana..................................................... 51.2.2 Il “soil body” dell’esperienza europea................................................................................. 71.2.3 Le unità tipologiche <strong>di</strong> suolo nell’esperienza italiana........................................................ 101.2.3.1 La correlazione tipologica nell’esperienza del Centro Nazionale <strong>di</strong> CartografiaPedologica......................................................................................................................... 101.2.3.2 Gestione dell’incertezza delle tipologie pedologiche ........................................... 141.2.3.3 Grado <strong>di</strong> relazione delle osservazioni pedologiche con le STS............................ 141.2.3.4 Descrizione delle UTS e delle STS....................................................................... 161.3 Il <strong>rilevamento</strong> pedologico GIS oriented...................................................................................... 211.3.1. Realizzazione della banca <strong>dati</strong> <strong>dei</strong> sottosistemi <strong>di</strong> terre.................................................... 231.3.2. Scelta delle finestre campione <strong>di</strong> <strong>rilevamento</strong> (aree pilota).............................................. 231.3.3. Realizzazione della banca <strong>dati</strong> delle unità <strong>di</strong> terre............................................................ 231.3.4. In<strong>di</strong>viduazione delle componenti territoriali delle unità <strong>di</strong> terre (elementi territoriali) daindagare....................................................................................................................................... 251.3.5. Rilevamento in campo ...................................................................................................... 251.1 Il <strong>rilevamento</strong> <strong>dei</strong> suoli: l’oggetto del <strong>rilevamento</strong>I caratteri e le qualità del suolo che misuriamo o stimiamo hanno tutte una loro variabilità. Hannoanzitutto una variabilità temporale, cioè variano nel tempo. É noto infatti che le proprietà del suolopossono variare in tempi più o meni brevi (ad esempio il contenuto idrico) o lunghi (la ritenzioneidrica al punto <strong>di</strong> appassimento) ed in modo <strong>di</strong>verso, ad esempio continuo, <strong>di</strong>scontinuo, o ciclico.I caratteri e le qualità del suolo hanno anche una struttura spaziale, cioè variano nelle tre<strong>di</strong>mensioni. Una variabile, ad esempio il contenuto in argilla, cambia in profon<strong>di</strong>tà (<strong>di</strong>mensione z)e, se per il campionamento del suolo viene utilizzato il <strong>rilevamento</strong> <strong>di</strong> campagna operato dalpedologo, questa viene descritta per ognuno <strong>dei</strong> <strong>di</strong>versi orizzonti riconosciuti nel profilo, oppure perognuna delle parti in cui è possibile <strong>di</strong>stinguere morfologicamente l’orizzonte. La stessa variabile, ilcontenuto in argilla, ha poi una variabilità orizzontale (in x e y), la quale può essere <strong>di</strong>versa perl’orizzonte <strong>di</strong> superficie rispetto a quelli <strong>di</strong> profon<strong>di</strong>tà. Vi sono infine altre fonti <strong>di</strong> variabilità legateal campionamento e all’errore <strong>di</strong> analisi o <strong>di</strong> stima.Non è facile apprezzare la variabilità spaziale <strong>di</strong> un carattere pedologico. Gli approcci utilizzatia tal fine possono essere molto <strong>di</strong>versi, ma i <strong>meto<strong>di</strong></strong> più <strong>di</strong>ffusi sono essenzialmente quelli <strong>di</strong> tipostocastico, <strong>di</strong> tipo ragionato (“purposive sampling”) e quelli che utilizzano varie loro combinazioni.Il <strong>rilevamento</strong> pedologico stocastico, o geostatistico, si basa sulla teoria delle variabiliregionalizzate (McBratney e De Gruijter, 1992) che privilegia l’aspetto continuo della coperturapedologica. Le tecniche geostatistiche considerano le variazioni delle proprietà del suolo comecontemporaneamente casuali e continue. La <strong>di</strong>stribuzione spaziale <strong>di</strong> una variabile è dunque vistacome una particolare manifestazione <strong>di</strong> un processo casuale, che può presentare una certa strutturaspaziale. Nella struttura spaziale si presuppone che siti vicini risultino più simili <strong>di</strong> altri posti a1
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICI<strong>di</strong>stanze maggiori; in altre parole, sussistono fra le osservazioni autocorrelazioni spaziali. Gliattributi del suolo che presentano <strong>di</strong>pendenza spaziale sono detti “variabili regionalizzate” edebbono sod<strong>di</strong>sfare una qualche ipotesi <strong>di</strong> “stazionarietà”, ovvero <strong>di</strong> omogeneità statisticaall’interno <strong>di</strong> un’area geografica.L’approccio ragionato è tutt’ora quello più <strong>di</strong>ffuso tra i pedologi geografi. Esso si basa sullaconstatazione che la struttura spaziale <strong>di</strong> alcune variabili non è casuale ed in<strong>di</strong>pendente rispetto allastruttura spaziale delle altre variabili, bensì può esserne più o meno correlata; ciò in <strong>di</strong>pendenzadell’azione operata su <strong>di</strong> esse da cause determinanti che agiscono in modo spesso correlato ocongiunto, i cosiddetti “fattori della pedogenesi” (Soil Survey Division Staff, 1993). Poiché i suolisono <strong>dei</strong> corpi naturali sensibili a variazioni anche piccole <strong>dei</strong> fattori della pedogenesi, e poichéalcuni <strong>di</strong> questi fattori, in particolare la morfologia, il materiale genitore e l’uso del suolo, varianoin natura in modo <strong>di</strong>scontinuo se si considera la scala <strong>di</strong> riferimento, quella cioè del paesaggiopedologico apprezzabile dal rilevatore <strong>di</strong> campagna, il risultato è che spesso alcune variabilipedologiche hanno congiuntamente delle sensibili variazioni in spazi orizzontali limitati, le quali simantengono per tratti estesi <strong>di</strong> territorio. Un esempio è quello delle proprietà <strong>dei</strong> suoli posti al <strong>di</strong>qua e al <strong>di</strong> là <strong>di</strong> un limite morfologico, quale quello costituito dall’orlo <strong>di</strong> scarpata <strong>di</strong> un terrazzofluviale, oppure <strong>di</strong> un limite se<strong>di</strong>mentario, ad esempio tra argille e sabbie. Questi limiti spazialiconsentono <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare degli oggetti suolo che hanno un certo campo <strong>di</strong> variazione per alcunicaratteri e proprietà.Alcuni sviluppi recenti delle tecniche geostatistiche tendono a combinare l’osservazione dellevariazioni pedologiche <strong>di</strong>scontinue con la modellazione <strong>di</strong> quelle continue, in modo da fornirein<strong>di</strong>cazioni sull’incertezza del valore <strong>di</strong> una caratteristica <strong>di</strong> un suolo all’interno del suopedopaesaggio (Lagacherie e Voltz, 2000).I suoli inoltre tendono ad essere “ricorrenti”. Se è esperienza comune che i suoli variano talvoltaanche “passo dopo passo” è altresì evidente che in paesaggi simili, anche se <strong>di</strong>stanti tra loro, sipossono ritrovare suoli con genesi, caratteri e proprietà simili (figg. 1.1 e 1.2).Figura 1.1. Ricorrenza <strong>dei</strong> tipi <strong>di</strong> suolo in un ambiente a morfologia ondulata: suoli erosi e suoliconservati si succedono nel paesaggio a seconda della posizione negli alti e bassi morfologici.2
IL RILEVAMENTO DEI SUOLISe i suoli sono spesso un <strong>di</strong>scontinuo geografico, è vero però che sono un continuo semantico, èpossibile cioè trovare suoli che, geograficamente <strong>di</strong>stanti tra loro, sono simili per molti caratteri. Leclassificazioni pedologiche propongono <strong>dei</strong> limiti semantici tra le classi (taxa) che, alle <strong>di</strong>versescale geografiche, in<strong>di</strong>viduano territori circoscritti.In alcuni casi si ricorre a tecniche stocastiche <strong>di</strong> <strong>rilevamento</strong> per la <strong>di</strong>fficoltà a percepire levariazioni pedologiche in campagna o con il tele<strong>rilevamento</strong>. Infatti, può essere <strong>di</strong>fficile vedere levariazioni geografiche tra due suoli perché nascoste dalla vegetazione o perché la superficie èuniformata dall’azione dell’uomo, ma questo non significa che non vi siano limiti geografici netti. Ilsignificato <strong>di</strong> limite geografico netto è comunque legato alla scala <strong>di</strong> osservazione. Se alla scala delrilevatore <strong>di</strong> campagna un passaggio tra due suoli <strong>di</strong> alcuni metri è un passaggio netto, infotointerpretazione e tele<strong>rilevamento</strong> le variazioni apprezzabili possono essere più ampie, in<strong>di</strong>pendenza dalla sensibilità <strong>dei</strong> sensori, ma anche dalla esperienza <strong>dei</strong> fotointerpreti.Figura 1.2. Ricorrenza <strong>dei</strong> tipi <strong>di</strong> suolo in un ambiente <strong>di</strong> collina: la catena <strong>di</strong> suoli su sommità, versante ecalanco si ripete per chilometri. I tipi <strong>di</strong> suolo passano l’uno all’altro nello spazio <strong>di</strong> pochi metri o alcunidecimetri.L’approccio ragionato si fonda sull’equazione a<strong>di</strong>mensionale formulata da Jenny nei primi anniquaranta (Jenny, 1941). Jenny stabilì che il suolo (S) è il risultato <strong>di</strong> cinque fattori <strong>di</strong> formazione: ilclima (cl), gli organismi (o), la morfologia o rilievo (r), il materiale genitore (p) e il tempo (t):S = f(cl, o, r, p, t)La stessa equazione può essere scritta anche:Sr = f(p (cl, o), t)3
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICIovvero, il suolo che noi osserviamo in una determinata posizione morfologica Sr è il risultato delletrasformazioni del materiale genitore avvenute per un determinato tempo, sotto l’azione del clima edegli organismi.Recentemente, gli stu<strong>di</strong> realizzati utilizzando l’approccio geostatistico hanno portato a<strong>di</strong>ntegrare l’equazione <strong>di</strong> Jenny aggiungendo la posizione geografica, in modo da esprimere ilconcetto che una proprietà del suolo sconosciuta può essere stimata attraverso la relazione che essaha con altre conosciute, poste nello stesso luogo (McBratney et al., 2003):Sa = f (S, C, O, R, P, A, N)dove Sa è l’attributo pedologico stimato, S è la proprietà pedologica conosciuta nello stesso luogo,C il clima, O gli organismi, R il rilievo, P il materiale genitore, A il tempo, N la posizionegeografica (coor<strong>di</strong>nate). In questo modo si è realizzato un approccio misto ragionato-stocasticomolto promettente, tutt’ora oggetto <strong>di</strong> numerosi stu<strong>di</strong> e ricerche. Per una efficace trattazione <strong>di</strong>questo approccio si rimanda a Dobos et al. (2006).Se si considera il suolo nella sua <strong>di</strong>mensione areale, anziché puntuale, si introduce il concetto <strong>di</strong>pedopaesagio (soilscape) cioè <strong>di</strong> paesaggio con un certo grado <strong>di</strong> omogeneità pedologica. Unaequazione a<strong>di</strong>mensionale che lo esprime è la seguente:PP = {cl, p, r, lc}dove il pedopaesaggio (PP) è l’insieme delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> clima (cl), materiale genitore (p),morfologia (r) e copertura del suolo (lc) che hanno una configurazione caratteristica, percepibiledall’osservatore nel momento in cui viene rilevata e co<strong>di</strong>ficabile in una banca <strong>dati</strong>. Nelpedopaesaggio vi è una certa probabilità <strong>di</strong> incontrare suoli simili, in <strong>di</strong>pendenza della omogeneità<strong>dei</strong> fattori della pedogenesi relativa alla scala <strong>di</strong> riferimento.Il concetto <strong>di</strong> pedopaesaggio si applica a qualunque scala e livello gerarchico nellaclassificazione <strong>dei</strong> paesaggi <strong>pedologici</strong>. Il pedopaesaggio può rappresentare geograficamente launità tipologica <strong>di</strong> suolo (UTS) che corrisponde ad uno <strong>dei</strong> taxa della classificazione pedologica,cioè l’unione degli in<strong>di</strong>vidui (Si) i cui caratteri e proprietà ricadono in uno specifico range previsto dallaclassificazione:nUTS = Taxa = U Sii=1Applicata alla scala <strong>di</strong> dettaglio, l’equazione sintetizza il concetto <strong>di</strong> “polipedon” proposto dalsistema americano <strong>di</strong> classificazione <strong>dei</strong> suoli, che verrà <strong>di</strong> seguito maggiormente descritto (SoilSurvey Division Staff, 1993).Alle scale <strong>di</strong> minor dettaglio, o nei territori dove la variabilità <strong>dei</strong> suoli è molto elevata, èpossibile considerare l’UTS come l’unione <strong>di</strong> pedopaesaggi che hanno delle specifiche relazionifunzionali tra loro. Combiando i due concetti <strong>di</strong> UTS come unione <strong>di</strong> pedopaesaggi e <strong>di</strong> pedon si ha:nUTS = U PPi, Sii=14
IL RILEVAMENTO DEI SUOLIdove l’UTS costituisce un insieme <strong>di</strong> osservazioni pedologiche, presenti in un tipo <strong>di</strong> pedopaesaggiocon certi attributi <strong>di</strong> clima, materiale genitore, morfologia e uso del suolo, che hanno unasignificativa somiglianza <strong>di</strong> caratteri e orizzonti pedogenetici.1.2 Le unità tipologiche <strong>di</strong> suolo1.2.1 Le unità tipologiche <strong>di</strong> suolo nell’esperienza americanaL’esperienza americana <strong>di</strong> <strong>rilevamento</strong> <strong>dei</strong> suoli vanta più <strong>di</strong> un secolo <strong>di</strong> attività e circa 19.000UTS stabilite, denominate “serie”. Il sistema americano <strong>di</strong> <strong>rilevamento</strong> pedologico ha però <strong>dei</strong> limiti<strong>di</strong> utilizzazione al <strong>di</strong> fuori degli Stati Uniti. Le serie infatti vengono create dai “soil scientists”(impiegati del National Resourcers Conservation Service federale che lavorano a livellocorrispondente al nostro comunale e provinciale) per fare interpretazioni e dare suggerimenti tecniciagli agricoltori, in funzione <strong>dei</strong> contributi che gli agricoltori possono ottenere per l’attuazione <strong>dei</strong>vari programmi e misure federali, statali ecc. É quin<strong>di</strong> un’informazione locale, rilevata da gente delposto, per gli agricoltori della zona. Problematiche pedologiche e ambientali <strong>di</strong> più vasto raggio(cioè investimenti, misure, <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge che investono vasti territori) vengono risoltetramite collaborazioni con altri organismi federali e statali preposti alla gestione del territorio.Nel Soil Survey Manual (Soil Survey Division Staff, 1993) è interessante notare come si pongal’accento sul fatto che il suolo è un <strong>di</strong>scontinuum più che un continuum. Si legge infatti: “più <strong>di</strong> 50anni fa, la definizione <strong>di</strong> Marbut del suolo come dello “strato esterno” della crosta terrestre implicòun concetto <strong>di</strong> suolo come un continuum (Marbut, 1935). La definizione attuale si riferisce al suolocome ad una collezione <strong>di</strong> corpi naturali posti sulla superficie della Terra, che <strong>di</strong>vide il continuum <strong>di</strong>Marbut in parti <strong>di</strong>screte e definite, che possono essere trattate come membri <strong>di</strong> una popolazione. Laprospettiva del suolo è cambiata da una in cui era enfatizzato l’insieme e le sue parti erano pocodefinite, in una nella quale le parti sono chiaramente definite e l’insieme è una collezioneorganizzata <strong>di</strong> queste parti”.Molto interessante è anche quanto espresso nel capitolo 5 della seconda e<strong>di</strong>zione della SoilTaxonomy e riassunto da Indorante et al. (1999): “vi è una <strong>di</strong>fferenza tra l’entità che i rilevatorimappano e l’entità che classificano, perché ciò che i rilevatori mappano sono pedopaesaggi. Ipedopaesaggi in<strong>di</strong>viduati applicando il para<strong>di</strong>gma suolo-paesaggio (Hudson, 1992) vengonoclassificati scegliendo con molta cura i profili che meglio rappresentano le con<strong>di</strong>zioni pedologichenelle unità cartografiche, così da fornire rilevamenti <strong>pedologici</strong> utili”.Le in<strong>di</strong>cazioni per la creazione delle serie sono riportate nel National Soil Survey Handbook(USDA-NRCS, 2007), voluminosa e molto dettagliata guida per i rilevatori, nella quale si affermachiaramente che la serie è un modello concettuale formato da un pedon <strong>di</strong> riferimento e da altrimolto simili. Il pedon che viene selezionato per la esemplificazione della serie deve rappresentarneil concetto centrale.Nell’Handbook vengono ripresi i concetti <strong>di</strong> pedon e polipedon espressi nella Soil Taxonomy(Soil Survey Staff, 1999), dove il primo è definito come il più piccolo volume <strong>di</strong> suolo abbastanzaesteso da rappresentare la natura e la <strong>di</strong>sposizione degli orizzonti, nonché la variabilità delleproprietà <strong>di</strong> un certo tipo <strong>di</strong> suolo, mentre il secondo è l’insieme <strong>di</strong> quest’ultimi. Infatti “il pedon èconsiderato troppo piccolo per presentare caratteristiche più estensive”, come la pendenza e lapietrosità superficiale. Il polipedon è presentato nella Soil Taxonomy come unità <strong>di</strong> classificazione,un corpo suolo, omogeneo a livello della serie, e grande abbastanza da mostrare tutte lecaratteristiche del suolo considerate nella descrizione e classificazione del suolo. Da notare che ilconcetto <strong>di</strong> polipedon (fig. 1.3), pur rimanendo presente nel Soil Survey Manual (USDA-NRCS,2007), non è più presente nella seconda e<strong>di</strong>zione (1999) della Soil Taxonomy.5
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICIFigura 1.3. Pedon e polipedon secondo il sistema americano (da Giordano, 1999, mo<strong>di</strong>ficato).La concettualizzazione della serie viene fatta anzitutto in riferimento ad una classe tassonomica,cioè in base ad una combinazione <strong>di</strong> caratteristiche e proprietà <strong>dei</strong> suoli già prevista nella SoilTaxonomy a livello <strong>di</strong> famiglia (o da creare se non prevista), stabilendo un determinato range <strong>di</strong>variazioni e riferendosi ad una unità cartografica, cioè ad un pedopaesaggio riconosciuto nel<strong>rilevamento</strong> al dettaglio o semidettaglio.La definizione <strong>di</strong> serie è quella <strong>di</strong> suoli con uguale classificazione fino al livello <strong>di</strong> famiglia,formati ed evoluti su uguali litologie, appartenenti ad uno stesso paesaggio e soggetti ad unagestione antropica molto simile, o coperti da un simile tipo <strong>di</strong> vegetazione; sono suoli con analogoarrangiamento degli orizzonti al loro interno. Il range <strong>di</strong> variazioni può essere ampio fino a quelloprevisto dalla famiglia e può anche sovrapporsi per alcuni caratteri a quello <strong>di</strong> altre serie, maandando in campagna deve essere possibile <strong>di</strong>re, esaminando un pedon, “questo è Miami”, cioèriconoscere che tutte le sue caratteristiche <strong>di</strong>scriminanti rientrano in quelle proprie della serieMiami (Soil Survey Staff, 1999). Per la Soil Taxonomy infatti è importante che l’oggetto suolo siadefinito, oltre che dalle caratteristiche proprie, anche da quelle degli altri oggetti che lo delimitano.In pratica, il <strong>rilevamento</strong> per serie avviene in campagna riconoscendo un pedopaesaggioricorrente, cioè una serie <strong>di</strong> ambienti che hanno una configurazione analoga per effetto <strong>di</strong> una similemanifestazione <strong>dei</strong> fattori della pedogenesi. I soil scientists scavano un profilo in un sito consideratorappresentativo <strong>di</strong> quel pedopaesaggio ricorrente, lo descrivono accuratamente e lo analizzano inlaboratorio (non sempre), descrivono anche il pedopaesaggio e la sua <strong>di</strong>ffusione, le qualità e leproblematiche <strong>di</strong> gestione, le possibili serie presenti nello stesso ambiente (serie associate e serieconcorrenti). Il pedopaesaggio viene correlato ad una serie già esistente, altrimenti si propone unanuova serie. Quando c’è un numero sufficiente <strong>di</strong> profili (circa 10 in teoria) e una <strong>di</strong>ffusione <strong>di</strong>almeno 1000 acri (405 ha) il “soil correlator” dell’ufficio competente <strong>di</strong> Major Land ResourcesArea può far <strong>di</strong>ventare serie stabilita la serie proposta; se gli acri sono meno <strong>di</strong> 1000, oppure leinformazioni sono giu<strong>di</strong>cate incomplete, può essere chiesto al soil scientist un supplemento <strong>di</strong>indagine (USDA-NRCS, 2007).6
IL RILEVAMENTO DEI SUOLIDa notare che nell’ultimo National Soil Survey Handbook (USDA-NRCS, 2007) la variante nonè più considerata. Fino al 1988 veniva usata per quelle serie potenziali che ancora non erano stateufficializzate in tempo prima della pubblicazione del <strong>rilevamento</strong>.Un altro concetto importante è quello <strong>di</strong> suoli simili che vengono aggiunti alla serie (unitàaggiuntive): “i suoli simili sono simili o molto simili nella maggior parte delle proprietà econ<strong>di</strong>vidono i limiti <strong>di</strong> quelle proprietà per cui <strong>di</strong>fferiscono [ ] le interpretazioni per gli usi piùcomuni sono simili o ragionevolmente simili e il valore interpretativo della cartografia non ècompromesso” (Soil Survey Division Staff, 1993).I suoli simili quin<strong>di</strong> hanno risposte all’uso e problematiche <strong>di</strong> gestione e <strong>di</strong> conservazione simili.Un esempio è quello <strong>di</strong> suoli classificati come Typic Argiaquoll e Udollic Ochraqualf per <strong>di</strong>fferenzein alcuni caratteri dell’orizzonte <strong>di</strong> accumulo <strong>di</strong> sostanza organica, oppure Oxic Rhodustalf e OxicPaleustult, <strong>di</strong>versi solo per la saturazione in basi (Van Wambeke e Forbes, 1986). É da evidenziareche “un’applicazione meccanica <strong>dei</strong> limiti <strong>di</strong> classe delle categorie più elevate per <strong>di</strong>fferenziare leserie presuppone la perfezione del sistema e deve essere evitata” (National Soil Handbook, 1983 e1997).Per la generalizzazione delle informazioni, cioè passando da una scala maggiore (<strong>di</strong> dettaglio) auna minore, vi è un certo cambiamento <strong>di</strong> rotta nella seconda e<strong>di</strong>zione della Soil Taxonomy rispettoal passato. In quest’ultima e<strong>di</strong>zione infatti si assume che le unità cartografiche possano essereespresse da associazioni <strong>di</strong> serie fino alla scala del 1:500.000, mentre dal 1:1.000.000 si debbanousare livelli gerarchici superiori. Nel passato si sottolineava molto <strong>di</strong> più la stretta correlazione trageneralizzazione geografica <strong>dei</strong> suoli e generalizzazione concettuale, mettendo in relazione i <strong>di</strong>versilivelli gerarchici della tassonomia con le <strong>di</strong>verse scale. Adesso le informazioni pragmatiche relativealle serie cosiddette “dominanti” in una certa unità cartografica possono essere convenientementeusate fino al livello <strong>di</strong> stato, mentre le carte allegate al volume, le Global Soil Regions e i suoli degliStati Uniti, dove sono riportati gli or<strong>di</strong>ni e sottor<strong>di</strong>ni della Soil Taxonomy, esprimonoessenzialmente la dominanza <strong>di</strong> alcune combinazioni <strong>dei</strong> fattori della pedogenesi, ed hanno quin<strong>di</strong>un significato essenzialmente ecologico, oltre che <strong>di</strong>dattico.1.2.2 Il “soil body” dell’esperienza europeaNel “Manuale delle procedure per un database georeferenziato <strong>dei</strong> suoli europei” (Finke et al.,1999) l’oggetto principale del <strong>rilevamento</strong> è costituito dal soil body, descritto come “una porzione<strong>di</strong> territorio con limiti geografici conosciuti in modo impreciso. Una entità tri<strong>di</strong>mensionaleartificiale ma riconoscibile nel continuum <strong>dei</strong> suoli, descritta unicamente dalla sua classificazionesecondo il World Reference Base for Soil Resources, dai materiali genitori, dalla profon<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> unostrato che ostacoli lo sviluppo delle ra<strong>di</strong>ci e dalla tessitura superficiale dominante”. Nel manualeviene proposto un parallelismo tra soil body e polipedon (polypedon in inglese) (tab. 1.1).Il soil body è anche l’oggetto principale, nonché la chiave d’ingresso al sistema informativocostituito dal Database Relazionale Georeferenziato Europeo, la cui struttura è compostaessenzialmente da tre parti:Dataset topologico: costituito da tabelle che descrivono le relazioni spaziali tra soil region,soilscape, soil body e orizzonti (insieme <strong>di</strong> <strong>dati</strong> topologico).Dataset semantico: costituito da tabelle che descrivono le proprietà <strong>di</strong> orizzonti, soil body,soilscape, e soil region (insieme <strong>di</strong> <strong>dati</strong> semantico).Dataset geometrico: costituito da tabelle che descrivono la geometria <strong>di</strong> soilscape e soilregion(insieme <strong>di</strong> <strong>dati</strong> geometrico).7
IL RILEVAMENTO DEI SUOLIFigura 1.4. Esemplificazione <strong>di</strong> organizzazione <strong>di</strong> soil body in un soilscape (da Finke et al., 1999)Figura 1.5. Esempio <strong>di</strong> relazioni tra <strong>di</strong>versi soilscape e loro soilbody (da Finke et al., 1999)In fig. 1.5 è interessante notare come lo stesso soilbody possa essere presente in soilscape <strong>di</strong>versi,con ciò rimarcando la netta separazione concettuale tra unità cartografica ed unità tipologicapresente nel sistema europeo.In uno stu<strong>di</strong>o realizzato in provincia <strong>di</strong> Siena sono stati messi a confronto la metodologia americana<strong>di</strong> organizzazione delle informazioni pedologiche per serie e quella europea per soil body (Lachie Costantini, 2002). Le tipologie <strong>di</strong> suolo risultate sono state in parte <strong>di</strong>verse, in quanto la definizione<strong>di</strong> soil body non in<strong>di</strong>vidua le relazioni tra suoli e paesaggi come avviene con la Soil Taxonomy; perquesto motivo è un oggetto maggiormente idoneo alla gestione <strong>dei</strong> <strong>dati</strong> <strong>di</strong> un <strong>rilevamento</strong> pedologicogià effettuato, piuttosto che alla organizzazione <strong>di</strong> quelli provenienti da un nuovo <strong>rilevamento</strong>.9
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICITabella 1.1. Alcune caratteristiche <strong>di</strong> <strong>di</strong>versi sistemi <strong>di</strong> classificazione e cartografia <strong>dei</strong> suoli (da Finke et al., 1999).FAO SOTER USDA MANUALE ESBGerarchiatassonomicaIdentificazionedell’unitàcartograficaScopo <strong>dei</strong> livellipiù elevati delsistemaCriteri prioritari<strong>di</strong> sud<strong>di</strong>visioneNome del livellopiù elevatoScala cartografica<strong>di</strong> riferimentoScopo del livellopiù basso delsistemaNome del livellopiù bassoScala cartografica<strong>di</strong> riferimentoMajor SoilGroupingSoil UnitsSoilSubunitsImpiantotassonomicodellalegendadella cartaGeografia,evoluzioneMajor SoilGroupingTerrain *TerrainComponent *Soil componentImpianto deldatabase e dellalegenda dellacartaGeografiaOrderSuborderGreat GroupSubgroupFamilySoil SeriesPolypedonPedonImpiantotassonomicoMorfologia,evoluzione,zonalitàSoil RegionSoilscapeSoil BodyImpianto del database edella legenda della cartaGeografia, zonalitàTerrain Soil Order Soil Region1:5.000.000 1:1.000.000 GeneralmentenoncartografatoUnitàcartograficaUnitàcartografica edatabaseCollegamentotra tassonomiae cartografiadel suolo1:5.000.000Soil Subunit Soil Component (Poly)pedon Soil Body1:100.000 -1:1.000.000* Oggetti che non sono <strong>di</strong> natura pedologica.1:100.000 -1:1.000.000NoncartografatoCollegamento trafunzionalità del suolo eunità cartografica,inserimento nel databaseNon cartografatoGli oggetti del database (orizzonti, soil body, soilscape e soil region) sono in<strong>di</strong>cati all’interno delletabelle (<strong>di</strong> tutti e tre i dataset) da elementi alfanumerici (come il co<strong>di</strong>ce del soil body) chedefiniscono anche le chiavi primarie (valore univoco per ogni record della tabella) <strong>di</strong> collegamentotra le tabelle.Nel sistema europeo, i soil body (fig. 1.4) non hanno geometria propria, ma vengono in<strong>di</strong>viduatiall’interno <strong>dei</strong> soilscape (fig. 1.5), definiti come una porzione della copertura pedologica contenentesoil body che hanno relazioni funzionali nel presente, o le hanno avute nel passato, e che può essererappresentato a scala 1:250.000.8
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICI1.2.3 Le unità tipologiche <strong>di</strong> suolo nell’esperienza italianaIn Italia sono state realizzate numerose esperienze riguardanti la creazione <strong>di</strong> tipologie pedologiche,sia da parte <strong>di</strong> istituzioni scientifiche che <strong>di</strong> enti regionali (Fierotti, 1979; Lulli et al., 1980; Dimase,1983; Aru et al., 1990; Filippi e Sbarbati, 1994; Rasio e Vianello, 1995). Alcune regioni, inparticolare, hanno anche prodotto delle linee guida per la creazione <strong>di</strong> tipologie <strong>di</strong> suoli regionali(RER, 1995; ERSAL, 1997; Michelutti et al., 2003; AA.VV., 2005; Chiuchiarelli et al., 2006;Michelutti et al., 2006). Il CRA-Istituto Sperimentale per lo Stu<strong>di</strong>o e la Difesa del Suolo <strong>di</strong> Firenze(attualmente Centro <strong>di</strong> ricerca per l’agrobiologia e la pedologia), attraverso l’esperienza maturata innumerosi progetti e collaborazioni internazionali, nazionali, regionali e provinciali, ha elaborato unametodologia <strong>di</strong> organizzazione e correlazione delle informazioni pedologiche per unità tipologiche<strong>di</strong> suolo (UTS) e sottounità tipologiche <strong>di</strong> suolo (STS), che prevede la loro organizzazione per duelivelli <strong>di</strong> generalizzazione, uno nazionale ed uno locale.La definizione data alle unità e sottounità tipologiche <strong>di</strong> suolo è la seguente:UTS: insieme <strong>di</strong> siti <strong>pedologici</strong> con attributi geografici comuni e con caratteri genetici simili, conuna certa variabilità <strong>di</strong> problematiche gestionali. Ogni UTS ha perlomeno una STS.STS: insieme <strong>di</strong> siti <strong>pedologici</strong> con caratteri applicativi simili.Per attributi geografici si intendono le <strong>di</strong>verse combinazioni <strong>di</strong> clima, morfologia, litologia e usodel suolo del livello geografico <strong>di</strong> riferimento. Per caratteri genetici si intendono i processipedogenetici, gli orizzonti genetici, le proprietà e i materiali <strong>di</strong>agnostici. Per caratteri applicativi siintendono le problematiche gestionali, <strong>di</strong> conservazione del suolo e <strong>di</strong> attitu<strong>di</strong>ne colturale.In altre parole, i caratteri guida per <strong>di</strong>stinguere le UTS sono in prima approssimazione gliattributi territoriali che determinano <strong>di</strong>versi tipi <strong>di</strong> paesaggio, poi la natura e il grado <strong>di</strong> espressione<strong>dei</strong> caratteri pedogenetici (ve<strong>di</strong> par. 1.1). Le STS si <strong>di</strong>stinguono all’interno delle UTS in quantosono caratterizzate da sostanziali <strong>di</strong>fferenze nei comportamenti, nelle qualità e nelle problematiche<strong>di</strong> gestione del suolo in ambito agro-forestale e ambientale e sono il contenitore <strong>di</strong> base delleinformazioni delle qualità <strong>dei</strong> suoli, quin<strong>di</strong> il mattone fondamentale delle valutazioni. Ogni UTS èsempre costituita da almeno una STS.Le UTS ed STS vengono definite in<strong>di</strong>pendentemente per ogni livello geografico <strong>di</strong> riferimento,cioè sulla base delle componenti territoriali <strong>dei</strong> <strong>di</strong>versi livelli <strong>di</strong> pedopaesaggio (ve<strong>di</strong> cap. 2). Cosìogni osservazione pedologica viene attribuita ad una UTS <strong>di</strong>versa a seconda del livello <strong>di</strong>pedopaesaggio a cui si sta lavorando: il software “CNCP” (Centro Nazionale <strong>di</strong> CartografiaPedologica, ve<strong>di</strong> cap. 3) permette <strong>di</strong> attribuire ogni osservazione a più <strong>di</strong> una UTS ed STS. Lacorrelazione pedologica, realizzata in forma in<strong>di</strong>pendente per ogni livello <strong>di</strong> riferimento, ha comeprodotto tipologie <strong>di</strong> suolo nazionali o locali, che rendono fruibili per gli utilizzatori interessati icaratteri rilevanti della natura del suolo alle <strong>di</strong>verse scale.1.2.3.1 La correlazione tipologica nell’esperienza del Centro Nazionale <strong>di</strong> CartografiaPedologicaL’attività <strong>di</strong> creazione delle UTS e STS, cioè la correlazione pedologica, è normalmente piuttostolunga, <strong>di</strong>fficoltosa e <strong>di</strong> tipo essenzialmente interpretativo, soprattutto a causa della grande <strong>di</strong>versità<strong>di</strong> tipi <strong>di</strong> suolo presenti in territori anche limitati (pedo<strong>di</strong>versità). Per favorire l’uso del mezzoinformatico, migliorare la qualità ed oggettività dell’informazione pedologica aggregata in tipologieed agevolare la sua utilizzazione nei modelli <strong>di</strong> valutazione, sono stati introdotti alcuni concetti chestanno alla base della correlazione e delle relative elaborazioni statistiche: il carattere e la qualitàfunzionale, nonché l’orizzonte funzionale.10
IL RILEVAMENTO DEI SUOLIPer caratteri e qualità funzionali si intendono tutti quei caratteri e qualità dell’osservazionepedologica che si rilevano in una indagine pedologica e che possono essere utilizzati come criteriper la correlazione, in particolare: morfologia, substrato, uso del suolo, pendenza, quota, falda,drenaggio interno ed esterno, erosione, profon<strong>di</strong>tà utile, <strong>dati</strong> analitici del suolo, classificazione ecapacità d’uso. Non tutti i caratteri e le qualità sono sempre rilevanti ai fini della correlazione. Aseconda degli ambienti alcuni assumono maggiore rilevanza applicativa rispetto agli altri. Percaratteri e qualità funzionali alla correlazione si intendono quelli che il correlatore ha consideratocome determinanti nella creazione <strong>di</strong> determinate UTS e relative STS. La correlazione privilegiaquelli che sono più caratterizzanti e importanti per un determinato ambiente: ad esempio lapendenza e la quota negli ambienti del modellamento erosivo; la falda idrica, la permeabilità e ildrenaggio interno in pianura; i processi erosivi in collina e in montagna; la tessitura superficiale, loscheletro e la pietrosità nei suoli lavorati; la rocciosità e la morfologia nei suoli forestali. I caratterimorfologia, substrato e uso del suolo, cioè i caratteri pedopaesaggistici sono sempre da ritenersicaratterizzanti.Il concetto <strong>di</strong> orizzonte funzionale sostituisce i concetti <strong>di</strong> topsoil e subsoil presenti in alcunimanuali <strong>di</strong> <strong>rilevamento</strong> (ve<strong>di</strong>, ad esempio, Finke et al., 1999). L’orizzonte funzionale è simileall’orizzonte genetico, ma un’orizzonte genetico può essere <strong>di</strong>viso in più orizzonti funzionaliquando cambino le con<strong>di</strong>zioni funzionali, o viceversa <strong>di</strong>versi orizzonti genetici possono essere unitiall’interno dello stesso orizzonte funzionale. Ad esempio, i vigneti e i meleti inerbiti del Trentinohanno un Ap1 (<strong>di</strong> solito 0-10 cm) funzionalmente (attività biologica, sostanza organica, elementinutritivi, metalli pesanti) ben <strong>di</strong>verso dall’Ap2 (10-30 cm), <strong>di</strong> solito realizzato con l’aratura e solosaltuariamente interessato da lavorazioni profonde quali la <strong>di</strong>scissura. Allo stesso modo, per altretipologie <strong>di</strong> suoli può avere senso unire orizzonti genetici simili dal punto <strong>di</strong> vista gestionale. Adesempio: orizzonte cambico Bw e orizzonti <strong>di</strong> transizione BA e BC; orizzonti C e CB. Orizzontifunzionali <strong>di</strong>versi dovrebbero segnalare un cambio significativo in con<strong>di</strong>zioni fisico - strutturaliimportanti per la ritenzione idrica e il drenaggio, oppure chimiche, quali accumulo <strong>di</strong> sali.Le UTS ed STS nazionali sono in via <strong>di</strong> definizione e sono il frutto per alcune regionidell’attività <strong>di</strong> correlazione realizzata dai pedologi regionali, per altre regioni dell’attività <strong>di</strong>correlazione realizzata in forma originale dal CNCP, sulla base della propria metodologia <strong>di</strong>correlazione <strong>di</strong> seguito descritta. Sia nell’uno che nell’altro caso le UTS vengono create avendocome base geografica <strong>di</strong> riferimento il livello pedopaesaggistico <strong>dei</strong> sistemi <strong>di</strong> terre (ve<strong>di</strong> cap. 2).Sulla base della propria attività <strong>di</strong> correlazione originale il CNCP ha definito e/o sta definendoanche UTS ed STS locali, come ad esempio quelle relative al progetto “Carta <strong>dei</strong> suoli della Siciliain scala 1:250.000”. In questo caso la metodologia è la stessa con la sola <strong>di</strong>fferenza che si ha comelivello geografico <strong>di</strong> riferimento quello <strong>dei</strong> sottosistemi <strong>di</strong> terre.Le UTS nazionali vengono nominate con un co<strong>di</strong>ce alfanumerico dato dalla regione pedologica<strong>di</strong> appartenenza, dal co<strong>di</strong>ce WRB (IUSS – ISRIC – FAO, 1998) relativo al gruppo pedologico <strong>di</strong>riferimento, dal co<strong>di</strong>ce WRB relativo al primo qualificatore, da un contatore per <strong>di</strong>fferenziaretipologie con stessa classificazione e presenti nella stessa regione pedologica (es: 62.2VRcc1, fig.1.6).Sia a livello nazionale che locale, la prima attività svolta dal CNCP è quella <strong>di</strong> raccogliere e<strong>di</strong>nserire tutte le informazioni pedologiche <strong>di</strong>sponibili, sia come osservazioni pedologiche, cheeventualmente come UTS ed STS nazionali già create dai pedologi regionali, seguita dal controllo<strong>di</strong> qualità e armonizzazione <strong>dei</strong> <strong>dati</strong>. Il passo successivo è quello della attribuzione semantica <strong>di</strong>ogni osservazione pedologica alle componenti territoriali del livello pedopaesaggistico <strong>di</strong>riferimento.Nel caso che si debbano creare le UTS nazionali, le informazioni pedologiche vengonoraggruppate in prima istanza per componente territoriale <strong>di</strong> sistema <strong>di</strong> terre e regione pedologica <strong>di</strong>appartenenza semantica. Per creare le UTS locali invece il primo raggruppamento avviene percomponente territoriale <strong>di</strong> sottosistema <strong>di</strong> terre, sistema <strong>di</strong> terre e regione pedologica <strong>di</strong>11
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICIappartenenza semantica. L’approccio geografico - pedopaesaggistico quin<strong>di</strong> rappresenta sempre ilprimo criterio <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduazione delle UTS.I primi raggruppamenti così ottenuti vengono in seguito sud<strong>di</strong>visi oppure accorpati sulla base <strong>di</strong>criteri genetici, al fine <strong>di</strong> ottenere tipologie con organizzazione degli orizzonti funzionali eclassificazione simile; questa attività prevede la identificazione degli orizzonti funzionali esuccessiva attribuzione <strong>di</strong> ogni orizzonte ai relativi orizzonti funzionali (ve<strong>di</strong> par. 3.4.2.4). In questomodo il software può calcolare la me<strong>di</strong>a, la deviazione standard e la numerosità campionariarelative al limite inferiore, ai <strong>dati</strong> analitici routinari e alla permeabilità (stima <strong>di</strong> campagna dellaclasse <strong>di</strong> conducibilità idraulica satura). Inoltre il software CNCP calcola i valori modali <strong>dei</strong>caratteri stazionali <strong>di</strong> morfologia, litologia ed uso del suolo; capacità d’uso e relativa limitazione;quota, pendenza, numero <strong>dei</strong> giorni <strong>di</strong> secco e interferenza climatica; pietrosità, rocciosità;profon<strong>di</strong>tà della roccia, profon<strong>di</strong>tà utile e relativa natura della limitazione per l’approfon<strong>di</strong>mentora<strong>di</strong>cale; limite superiore della falda e relativo tipo; drenaggio esterno ed interno; natura e grado <strong>di</strong>erosione del suolo. L’insieme delle elaborazioni forma la descrizione del sito modale, definito comequel sito caratterizzato dai valori modali, me<strong>di</strong> e deviazioni standard <strong>dei</strong> valori delle osservazionipedologiche afferenti alla STS, escludendo quelle correlate.La <strong>di</strong>fferenziazione delle STS all’interno delle UTS privilegia come valutazione applicativa <strong>di</strong>riferimento la capacità d’uso del suolo (Costantini, 2006), in quanto sintesi efficace dellecaratteristiche sia stazionarie che analitiche <strong>dei</strong> suoli, che consente <strong>di</strong> prevedere la risposta all'uso <strong>di</strong>suoli con caratteri funzionali simili (para<strong>di</strong>gma “suolo-risposta all’uso”, ve<strong>di</strong> glossario <strong>dei</strong> termini<strong>pedologici</strong>). A tal fine è stato implementato nel software un algoritmo per la stima della capacitàd’uso (ve<strong>di</strong> par. 3.4.4.5). Le osservazioni pedologiche per le quali non è possibile definire lacapacità d’uso per mancanza <strong>di</strong> tutti i <strong>dati</strong> necessari per la valutazione vanno attribuite all’STS sullabase <strong>dei</strong> <strong>dati</strong> <strong>di</strong>sponibili. Oltre ai caratteri funzionali definiti per la classificazione della capacitàd’uso, possono essere applicati attributi specifici per la correlazione <strong>dei</strong> suoli in particolari territori.Ad esempio, è possibile utilizzare il coefficiente <strong>di</strong> arrossamento (redness rating: Torrent et al.,1983) per alcune terre rosse delle piattaforme carbonatiche; l’adsorbimento fosfatico, il pH influoruro <strong>di</strong> so<strong>di</strong>o o il rapporto fra alluminio e ferro estratti in ossalato acido per <strong>di</strong>stinguere i suolisu rocce effusive; il contenuto <strong>di</strong> gesso per le tipologie <strong>di</strong> suolo degli ambienti ari<strong>di</strong> e semiari<strong>di</strong>dell’Italia meri<strong>di</strong>onale.I <strong>dati</strong> relativi al sito modale possono essere visualizzati grazie al report <strong>di</strong> stampa delle STS e inquesta maniera è possibile testare la vali<strong>di</strong>tà delle STS create, evidenziando eventuali incongruenze.Si può, ad esempio, controllare la coerenza delle classificazioni delle STS con i caratteri degliorizzonti funzionali e con le altre caratteristiche del sito modale. Si possono controllare le statisticherelative ai <strong>dati</strong> analitici degli orizzonti funzionali, verificando se il range <strong>di</strong> variabilità è accettabile.Si può controllare se esiste coerenza fra i caratteri modali del pedopaesaggio e quelli derivanti daisiti. Eventuali incongruenze possono essere sanate o definendo come correlate le osservazionipedologiche devianti, oppure decidendo <strong>di</strong> cambiare l’attribuzione tipologica delle stesseosservazioni (ve<strong>di</strong> par. 3.4.2.4). Il processo <strong>di</strong> correlazione infatti è un processo ciclico, in quantoun volta che si raggiungono <strong>dei</strong> primi risultati si acquisiscono anche maggiori conoscenze riguardoai legami suolo - paesaggio presenti negli ambienti in cui si sta lavorando e i raggruppamentipossono essere rivisti e corretti ricominciando il ciclo.Una volta elaborate le statistiche che portano alla creazione del sito modale, è possibilecontrollare la variabilità delle osservazioni pedologiche afferenti all’STS tramite un in<strong>di</strong>ce apposito,denominato in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> <strong>di</strong>versità, che esprime numericamente la <strong>di</strong>versità del profilo e del paesaggio<strong>di</strong> ogni osservazione rispetto alle caratteristiche del sito modale:V n = (Va n + Vp n )/212
IL RILEVAMENTO DEI SUOLIdove V n è l’ in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> <strong>di</strong>versità dell’osservazione n-esima; Va n è l’in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> <strong>di</strong>versità delle analisidell’osservazione n-esima; Vp n è l’ in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> <strong>di</strong>versità del paesaggio dell’osservazione n-esima.L’in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> <strong>di</strong>versità delle analisi dell’osservazione n-esima Va n è definito dalla seguente formula:Xvm| Xkin – Xki|Σ Σ _______________i = 1 k =1 s ki_________________________mVa n =_________________________________vdove kin è il valore del k-esimo tipo <strong>di</strong> analisi, dell’i-esimo orizzonte e dell’n-esima osservazione;Xki è il valore me<strong>di</strong>o del k-esimo tipo <strong>di</strong> analisi dell’i-esimo orizzonte del sito modale; s ki è ladeviazione standard del k-esimo tipo <strong>di</strong> analisi dell’i-esimo orizzonte del sito modale; m è il numerototale <strong>di</strong> tipi <strong>di</strong> analisi presi in considerazione; v è il numero totale <strong>di</strong> orizzonti dell’osservazione n-esima.L’in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> <strong>di</strong>versità delle analisi è dunque il valore dello scarto me<strong>di</strong>o dalla me<strong>di</strong>a <strong>dei</strong> vari tipi<strong>di</strong> analisi, standar<strong>di</strong>zzato rispetto agli orizzonti del profilo modale. Xkin vale 0 quando per quel tipo<strong>di</strong> analisi non c’è il dato e per questo motivo le osservazioni con il set <strong>di</strong> analisi più completoverranno favorite dall’in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> <strong>di</strong>versità. Si potranno dunque avere osservazioni che hanno valoriottimali per le analisi, ma che risultano <strong>di</strong>verse perché per molte analisi sono prive <strong>di</strong> dato.L’ in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> <strong>di</strong>versità del paesaggio dell’osservazione n-esima Vp n è definito dalla seguenteformula:m| Xkn – Xk|Σ ______________k =1 s kVp n = _______________________mdove X kn è il valore del k-esimo carattere paesaggistico (quota, pendenza, profon<strong>di</strong>tà utile) edell’n-esima osservazione; X k è il valore me<strong>di</strong>o del k-esimo carattere paesaggistico del sitomodale; s k è la deviazione standard del k-esimo carattere paesaggistico del sito modale; m è ilnumero totale <strong>di</strong> tipi <strong>di</strong> caratteri paesaggistici presi in considerazione per il computo dell’in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong><strong>di</strong>versità del paesaggio. L’in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> <strong>di</strong>versità del paesaggio è quin<strong>di</strong> il valore dello scarto me<strong>di</strong>odalla me<strong>di</strong>a standar<strong>di</strong>zzato <strong>dei</strong> vari caratteri paesaggistici.Nei paragrafi successivi e nel capitolo 3 verranno fornite alcune in<strong>di</strong>cazioni sull’uso degli in<strong>di</strong>ci<strong>di</strong> <strong>di</strong>versità.13
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICI1.2.3.2 Gestione dell’incertezza delle tipologie pedologicheNel processo <strong>di</strong> correlazione, le UTS sono definite secondo una gerarchia esemplificativa del grado<strong>di</strong> incertezza <strong>dei</strong> raggruppamenti creati. Il grado <strong>di</strong> definizione delle UTS, che è in<strong>di</strong>ce della loroqualità, <strong>di</strong>pende da vari fattori: dall’intensità del <strong>rilevamento</strong>, che incide sulla numerosità <strong>di</strong>osservazioni attribuite ad ogni UTS; dalla conoscenza dell’ambiente e delle relazioni funzionali tra isuoli in ogni ambiente, che permette <strong>di</strong> raggruppare le componenti territoriali caratterizzateeffettivamente da suoli simili; dalla variabilità naturale intrinseca all’interno degli stessi ambienti<strong>pedologici</strong>, che viene espressa dalle statistiche delle STS. Il concetto <strong>di</strong> grado <strong>di</strong> definizione delleUTS riprende quello <strong>di</strong> grado <strong>di</strong> fiducia delle serie, proposto dalla Regione Emilia-Romagna(R.E.R., 1995).La qualità delle UTS è definita tramite un processo logico, le cui fasi sono schematizzabili nelmodo seguente:1. creazione <strong>di</strong> UTS generiche: i primi raggruppamenti <strong>di</strong> osservazioni sono creati sulla base <strong>di</strong>legami funzionali geografici e genetici, generalmente con pochi <strong>dati</strong> e scarsa conoscenzadelle relazioni funzionali. Se l’incertezza permane, in quanto non si hanno sufficientiinformazioni pedologiche e/o non si ha abbastanza confidenza con le relazioni funzionali frapaesaggio e suoli, l’UTS si mantiene come generica. Come criterio generale, una UTSgenerica viene creata quando si ha almeno un profilo caposaldo descritto ed analizzato per iparametri necessari alla sua completa classificazione secondo la Soil Taxonomy e il WRB;2. promozione delle UTS generiche a UTS tentative, UTS proposte e UTS stabilite: mano amano che si analizzano ulteriori informazioni pedologiche, andando ad incrementare ilnumero <strong>di</strong> osservazioni pedologiche attribuite alla UTS, si comprendono meglio le relazionifunzionali fra i suoli e le componenti territoriali <strong>dei</strong> pedopaesaggi. Così le UTS generichesono promosse a UTS tentative, quin<strong>di</strong> a UTS proposte ed infine UTS stabilite. Per avereuna certa affidabilità statistica, le UTS dovrebbero avere un numero crescente <strong>di</strong> profili <strong>di</strong>riferimento (si può ipotizzare almeno 2 profili per le tentative, almeno 5 per le proposte ealmeno 10 per le stabilite) e una buona <strong>di</strong>stribuzione territoriale, cioè nei vari pedopaesaggiin cui si articola la tipologia nella regione pedologica.Le UTS nazionali sono un tipo speciale <strong>di</strong> tipologie che possono essere inserite come tali, quando siimmettono i <strong>dati</strong> <strong>di</strong> tipologie che non hanno nel database le relative osservazioni pedologiche,oppure possono essere create a partire da <strong>dati</strong> presenti nel database; in questo caso le lorostatistiche non potranno essere più aggiornate e i <strong>dati</strong> potranno essere mo<strong>di</strong>ficati solo <strong>di</strong>rettamente.Nel caso si voglia attribuire una nuova osservazione ad una UTS nazionale e calcolare nuovamentele statistiche, tale UTS dovrà tornare ad essere in<strong>di</strong>cata come stabilita, proposta o tentativa.1.2.3.3 Grado <strong>di</strong> relazione delle osservazioni pedologiche con le STSNon tutte le osservazioni pedologiche hanno la stessa rappresentatività territoriale. Alcune infattisono il frutto <strong>di</strong> variazioni locali o accidentali <strong>dei</strong> fattori della pedogenesi e sono <strong>di</strong>fficilmentecorrelabili. Le osservazioni quin<strong>di</strong> sono organizzate con un <strong>di</strong>verso grado <strong>di</strong> relazione rispetto allaSTS.14
IL RILEVAMENTO DEI SUOLISi <strong>di</strong>stinguono osservazioni:B caposaldo;T tipiche;R rappresentative;C correlate.L’osservazione caposaldo può essere solo un profilo. Il proce<strong>di</strong>mento logico per l’assegnazione delgrado <strong>di</strong> relazione è il seguente:1. tutte le osservazioni assegnate ad una determinata STS vengono inizialmente classificatecome tipiche, nel caso in cui abbiano le analisi, o come rappresentative, nel caso in cui nonle abbiano; questa attribuzione preliminare è necessaria in quanto altrimenti il software nonpuò calcolare le elaborazioni statistiche del sito modale;2. tutte quelle osservazioni che deviano anche per un solo carattere o qualità funzionale per≥3σ (deviazione standard) del valore me<strong>di</strong>o del sito modale vengono attribuite comecorrelate;3. delle rimanenti osservazioni, tutte quelle osservazioni che deviano anche per un solocarattere o qualità funzionale per ≥2σ, rispetto al valore me<strong>di</strong>o del sito modale vengonoattribuite come rappresentative;4. le restanti osservazioni sono quelle tipiche;5. fra le osservazioni tipiche si sceglie il profilo caposaldo. Il caposaldo andrà scelto fra tuttiquei profili che hanno l’in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> <strong>di</strong>versità V più basso. Il caposaldo dovrà rappresentarel’insieme <strong>dei</strong> suoli che la STS raccoglie e/o possedere una larga documentazionebibliografica/analitica. Infatti il profilo caposaldo è quello che viene utilizzato come profilo<strong>di</strong> riferimento ai fini <strong>di</strong>vulgativi.Per il calcolo delle elaborazioni statistiche del sito modale vengono presi in considerazione i <strong>dati</strong>relativi alle osservazioni attribuite come caposaldo, tipiche e rappresentative, mentre vengonoescluse le correlate.Riassumendo, per profilo caposaldo si intende quel profilo pedologico che viene utilizzato comeriferimento ai fini <strong>di</strong>vulgativi. Viene selezionato tra i profili tipici ed esprime pienamente l’insieme<strong>dei</strong> suoli della STS e/o possiede una larga documentazione bibliografica/analitica.Per osservazione tipica si intende ogni osservazione (profilo, pozzetto o trivellata) corredata daanalisi del suolo e i cui caratteri e qualità funzionali alla correlazione rientrano tutti nel range <strong>di</strong>variabilità per ±2σ.Per osservazione rappresentativa si intende ogni osservazione, corredata o meno da analisi delsuolo, i cui caratteri e qualità funzionali alla correlazione rientrano tutti nel range <strong>di</strong> variabilità per
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICI1.2.3.4 Descrizione delle UTS e delle STSLa UTS nazionale è qualificata da un co<strong>di</strong>ce alfanumerico <strong>di</strong> al massimo 10 <strong>di</strong>git, composto dallaregione pedologica semantica, dai co<strong>di</strong>ci WRB fino al secondo livello e da un contatore. Adesempio: 62.2VRcc1, cioè prima UTS fra i vertisuoli calcici della regione pedologica 62.2. Oltre alco<strong>di</strong>ce viene definito un nome che è dato dalla classificazione WRB, dalla caratteristica<strong>di</strong>fferenziante e dalla regione pedologica <strong>di</strong> appartenenza semantica. Ad esempio, il nome della 62.2VRcc1 è: Vertisuoli calcici in aree agricole della 62.2. Per le UTS locali non sono stati stabiliti unsistema <strong>di</strong> co<strong>di</strong>fica e <strong>di</strong> definizione del nome prestabiliti.Nel report della UTS (fig. 1.6) viene riportata la descrizione prosaica della regione pedologicasemantica e <strong>dei</strong> paesaggi <strong>pedologici</strong> modali. I paesaggi modali della UTS vengono elaborati dalsoftware CNCP in maniera da in<strong>di</strong>care le litologie, fisiografie e gli usi del suolo (fino ad unmassimo <strong>di</strong> 3 per ogni categoria) del livello geografico <strong>di</strong> riferimento (sistemi <strong>di</strong> terre per letipologie nazionali e sottosistemi <strong>di</strong> terre per le tipologie locali) a partire dai paesaggi piu frequentidelle STS afferenti alla UTS. La variabilità dell’UTS è caratterizzata dall’elenco delle STSafferenti, che nel report <strong>di</strong> stampa dell’UTS vengono descritte dal nome, dalle classificazioni USDAe WRB, dalla capacità d’uso (con limitazioni), da una foto del profilo tipico e da una foto delpaesaggio.Nel report delle STS (fig. 1.7) viene riportato il nome, il co<strong>di</strong>ce, le classificazioni USDA eWRB, la descrizione prosaica della regione pedologica semantica e del paesaggio modale, seguitadai <strong>dati</strong> relativi al sito modale. Il nome della STS dà una descrizione sintetica del caratterepedologico <strong>di</strong>scriminante rispetto alle altre STS dell’UTS. Le classificazioni USDA e WRBpossono essere mutuate dai profili caposaldo delle STS, oppure possono essere inseritemanualmente. I paesaggi modali della STS vengono elaborati dal software CNCP in modo dain<strong>di</strong>care le litologie, fisiografie e gli usi del suolo più frequenti del livello geografico <strong>di</strong> riferimento,(sistemi <strong>di</strong> terre per le tipologie nazionali e sottosistemi <strong>di</strong> terre per le tipologie locali) a partire daquelli attribuiti ad ogni osservazione pedologica assegnata all’STS (con esclusione delleosservazioni correlate).Il sito modale è caratterizzato da alcuni parametri quantitativi <strong>dei</strong> quali si calcolano me<strong>di</strong>a,deviazione standard e numerosità campionaria (quota, pendenza, pietrosità, limite superiore dellafalda, profon<strong>di</strong>tà della roccia, profon<strong>di</strong>tà utile, acqua <strong>di</strong>sponibile, rocciosità, in<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> incrostamentocompattamento e lavorabilità non tutti riportati nelle stampe) e da alcuni parametri qualitativi(drenaggio interno ed esterno, limitazioni all’approfon<strong>di</strong>mento ra<strong>di</strong>cale, tipo <strong>di</strong> erosione, tipo<strong>di</strong> falda, classe <strong>di</strong> interferenza climatica, capacità depurativa e <strong>di</strong> accettazione delle piogge, numero<strong>di</strong> giorni <strong>di</strong> secco) <strong>dei</strong> quali si calcola frequenza e numerosità campionaria. I giorni <strong>di</strong> secco sonostimati presupponendo assenza <strong>di</strong> falda e in base alla temperatura me<strong>di</strong>a annua, alla precipitazioneannuale ed alla acqua <strong>di</strong>sponibile del suolo (AWC), tramite una funzione implementatanel software (ve<strong>di</strong> par. 3.4.4.8). Il profilo modale è descritto tramite i propri orizzonti funzionaliper classe tessiturale e alcuni parametri analitici <strong>di</strong> uso frequente, <strong>di</strong> cui sono calcolati me<strong>di</strong>a,deviazione standard e numerosità campionaria (percentuale <strong>di</strong> sabbia, argilla, scheletro, pH, densitàapparente, contenuto in peso percentuale <strong>di</strong> acqua al punto <strong>di</strong> appassimento e alla capacità<strong>di</strong> campo, carbonio organico percentuale, capacità <strong>di</strong> scambio cationico, salinità, so<strong>di</strong>o <strong>di</strong> scambiopercentuale, calcare totale e attivo, saturazione in basi, classe <strong>di</strong> permeabilità, coefficiente <strong>di</strong> estensibilitàlineare percentuale). Anche il profilo caposaldo dell’STS ha finalità <strong>di</strong>vulgative e dunquene viene pubblicato il relativo report <strong>di</strong> stampa, con tutte le informazioni relative ai <strong>dati</strong> stazionari,orizzonti, analisi routinarie ed extra - routinarie, UTS ed STS <strong>di</strong> appartenenza e grado <strong>di</strong>correlazione, classificazioni USDA e WRB (IUSS – ISRIC – FAO, 1998; fig. 1.8).Nel presente paragrafo si presentano i report relativi alla UTS nazionale 62.2VRcc1, ricavatadai <strong>dati</strong> <strong>pedologici</strong> puntuali localizzati nella regione Sicilia, raccolti nell’ambito del progetto “Carta<strong>dei</strong> suoli della Sicilia in scala 1:250.000”. Questa tipologia è stata scelta per via della sua larga16
IL RILEVAMENTO DEI SUOLI<strong>di</strong>ffusione in Sicilia e per la sua rappresentatività alla scala <strong>dei</strong> sistemi <strong>di</strong> terre, in quanto presente sianella collina argillosa, sia sulle alluvioni (Fierotti, 1997). Questi suoli sono anche presenti comeinclusioni nelle incisioni <strong>dei</strong> terrazzi marini calcarenitici e <strong>dei</strong> ripiani carsificati. Per questo motivol’ambiente <strong>di</strong> <strong>di</strong>ffusione <strong>di</strong> questa tipologia <strong>di</strong> suoli è molto composito alla scala <strong>dei</strong> sistemi <strong>di</strong> terre,mentre le caratteristiche funzionali <strong>dei</strong> suoli sono piuttosto costanti. Un tratto genetico caratteristicodella tipologia è la sequenza degli orizzonti funzionali, a cui si è fatto riferimento prima ancora chealla classificazione. In molti casi, infatti, suoli molto simili, con la stessa sequenza <strong>di</strong> orizzontifunzionali, risultano essere classificati in maniera anche molto <strong>di</strong>versa per piccole variazioni <strong>dei</strong>propri caratteri. Nella sequenza <strong>di</strong> orizzonti funzionali <strong>dei</strong> suoli attribuiti alla 62.2VRcc1 è semprepresente un orizzonte vertico e calcico, anche se in alcuni casi i profili non possono essereclassificati come vertisuoli perché l’orizzonte vertico non si trova entro i primi 100 cm <strong>di</strong>profon<strong>di</strong>tà. In ogni caso, le eventuali variazioni nella classificazione non risultano essere associateal cambiamento <strong>di</strong> ambiente alla scala <strong>di</strong> riferimento.17
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICIFigura 1.6. Esempio <strong>di</strong> report <strong>di</strong> stampa <strong>di</strong> unità tipologica <strong>di</strong> suolo18
IL RILEVAMENTO DEI SUOLIFigura 1.7. Esempio <strong>di</strong> report <strong>di</strong> stampa <strong>di</strong> sottounità tipologica <strong>di</strong> suolo.19
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICIANALISI CHIMICHE E FISICHEOrizz. Profon<strong>di</strong>tàSabbia dag/kg Limo dag/kg Arg. CaCO3 dag/kg C.O. S.O. pHcm m. grossa grossa me<strong>di</strong>a fine m. fine totale grosso fine totale dag/kg totale attivo dag/kg dag/kg H2O CaCl2Ap0 20 0,5 0,8 1,5 3,7 6,0 12,5 12,4 28,5 40,946,6 31,4 13,2 0,480,82 8, 5Bkss120 57 0,7 0,9 1,4 3,7 6,4 13,1 13,8 28,6 42,444,5 33,3 14 0,470,81 8, 4KClBkss257 90 0,8 1,0 1,7 4,2 6,7 14,4 13,2 27,7 40,944,7 32,7 13,9 0,440,75 8, 2Orizz. Profon<strong>di</strong>tà Complesso <strong>di</strong> scambio cmol(+)/kgcm Ca Mg Ca+Mg Na K H Al CSC sc CSCTSB%Acid.totaleESP%N totg/kgP assmg/kgK assmg/kgd.a.g/cm3cond. C/NdS/mAp0 20 14,5 8,0 2,29 0,71 0,0 0 25,45 100 0,00 9,01,26 0,3942,5 26,7 157,6Bkss120 57 13,9 7,8 2,54 0,63 0,0 0 24,83 100 0,00 10,21,26 0,5641,3 25,3 159,4Bkss257 90 12,6 7,3 3,77 0,67 0,0 0 24,37 100 0,00 15,51,25 1,1541,2 25,4 157,5c.cg/gp.ag/gAWCmm/mOrizz. Profon<strong>di</strong>tà Ferro estraibile g/kg Alluminio estraib. g/kgcm ossal. <strong>di</strong>tion. pirof. totale ossal. <strong>di</strong>tion. pirof. totaleSi g/kgossal. tot.vetri%pHNaFFeMn Cu Zn P tot P ads CSCmg/kg g/kg % argMWDmmCOLEdm/mAp0 20Bkss1Bkss220 5757 90Figura 1.8. Esempio <strong>di</strong> report <strong>di</strong> stampa <strong>di</strong> profilo <strong>di</strong> suolo20
IL RILEVAMENTO DEI SUOLI1.3 Il <strong>rilevamento</strong> pedologico GIS orientedNel <strong>rilevamento</strong> pedologico tra<strong>di</strong>zionale, la fotointerpretazione ed il tele<strong>rilevamento</strong> conducono allaformulazione <strong>di</strong> una prima approssimazione <strong>di</strong> unità fisiografiche che, con l’approfon<strong>di</strong>mento delleconoscenze sugli altri fattori della pedogenesi e le indagini in campo, <strong>di</strong>ventano “unità <strong>di</strong>paesaggio”.Le unità fisiografiche delimitano aree con omogeneità <strong>di</strong> tipo ed intensità <strong>di</strong> processogeomorfologico, pertanto la relativa carta dovrebbe essere preceduta da un <strong>rilevamento</strong>geomorfologico <strong>di</strong> adeguato dettaglio. Sulla base della carta delle unità fisiografiche si realizzanoin campagna una serie <strong>di</strong> osservazioni, in genere con trivella manuale, per valutare la variabilitàpedologica presente. La variabilità riscontrata e la possibilità <strong>di</strong> apprezzare le relazioni tra suolo epaesaggio determinano la scelta <strong>dei</strong> siti da indagare in maniera più approfon<strong>di</strong>ta, tramite profili<strong>pedologici</strong>. Alla carta fisiografica si aggiungono le informazioni relative alla copertura del suolo edeventuali altri tematismi ambientali utili per <strong>di</strong>fferenziare i pedopaesaggi, in modo tale da creare lacarta delle unità <strong>di</strong> paesaggio. La carta <strong>dei</strong> suoli viene infine realizzata unendo le unità <strong>di</strong> paesaggiosimili per suoli, e <strong>di</strong>videndo invece quelle che nel <strong>rilevamento</strong> hanno mostrato suoli <strong>di</strong>versi alloro interno (fig.1.9). Al <strong>di</strong> là <strong>di</strong> questa semplice schematizzazione, la raccolta ed organizzazionedelle conoscenze pedologiche avviene in maniera ciclica ed autoalimentandosi con le esperienzeacquisite, è quin<strong>di</strong> un processo che normalmente richiede tempi piuttosto lunghi, anche sel’intensità del <strong>rilevamento</strong> con<strong>di</strong>ziona il numero <strong>di</strong> siti da stu<strong>di</strong>are e i cicli <strong>di</strong> <strong>rilevamento</strong> possibili.Nella nuova metodologia che utilizza le banche <strong>dati</strong> geografiche, il <strong>rilevamento</strong> è voltoessenzialmente a dare significato pedologico alle componenti territoriali (ve<strong>di</strong> cap. 2). É questo unnuovo tipo <strong>di</strong> <strong>rilevamento</strong>, in quanto non è né un <strong>rilevamento</strong> libero, né un <strong>rilevamento</strong> determinato(a griglia, a transetto), ma orientato a verificare le relazioni suolo-paesaggio postulate nell’analisiGIS, per cui viene definito GIS oriented. I vantaggi <strong>di</strong> questo nuovo metodo sono numerosi.Anzitutto la estrema funzionalità delle osservazioni <strong>di</strong> campagna. É noto infatti che i costi dellavoro in campagna sono sempre gravosi, da qui la necessità <strong>di</strong> un metodo che faccia risparmiaretempo, decidendo preventivamente i siti da indagare. Questi vengono scelti su base statistica, inmodo da coprire il territorio in maniera razionale e rappresentativa. In particolare, il metodoprevede <strong>di</strong> selezionare i siti <strong>di</strong> <strong>rilevamento</strong> in funzione della occorrenza statistica <strong>dei</strong> pedopaesaggi,in modo da quantificare la variabilità pedologica al livello geografico <strong>di</strong> riferimento. É anchepossibile scegliere quali tipi <strong>di</strong> pedopaesaggio indagare con maggiore o minore intensità, nonchéutilizzare prontamente tutte le informazioni preesistenti l’indagine. Le informazioni raccolte dai sitisono infatti imme<strong>di</strong>atamente collegate alla geografia alle <strong>di</strong>verse scale e facilmente correlabili. Ciòfacilita anche la estensione geografica delle informazioni e la creazione delle tipologie pedologiche.Ulteriore vantaggio è costituito dalla più facile cantierizzazione delle <strong>di</strong>verse fasi del lavoro.Di seguito vengono riportate come esempio le fasi operative del <strong>rilevamento</strong> GIS orientedrealizzato in Sicilia nell’ambito del progetto “Carta <strong>dei</strong> suoli della Sicilia in scala 1:250.000”:1. realizzazione della banca <strong>dati</strong> <strong>dei</strong> sottosistemi <strong>di</strong> terre;2. scelta delle finestre campione <strong>di</strong> <strong>rilevamento</strong> (aree pilota);3. realizzazione della banca <strong>dati</strong> delle unità <strong>di</strong> terre;4. in<strong>di</strong>viduazione delle componenti territoriali delle unità <strong>di</strong> terre (elementi territoriali) daindagare;5. <strong>rilevamento</strong> in campo.21
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICIa)b)c)d)Figura 1.9. La realizzazione della carta pedologica tramite <strong>rilevamento</strong> geomorfologico e pedologico integrati.a) esempio <strong>di</strong> carta geomorfologica in un area calcarea dell’Italia centrale; b) la carta delle unità fisiografiche generalizzale informazioni geomorfologiche puntali, c) sovrapposizione della carta fisiografica sulla geomorfologica; d)sovrapposizione della carta pedologica sulla fisiografica (ve<strong>di</strong> fig. 1.10).22
IL RILEVAMENTO DEI SUOLI1.3.1. Realizzazione della banca <strong>dati</strong> <strong>dei</strong> sottosistemi <strong>di</strong> terreLa prima attività svolta per la realizzazione della banca <strong>dati</strong> <strong>dei</strong> sottosistemi <strong>di</strong> terre è stata la fotointerpretazioneper la produzione <strong>di</strong> uno strato relativo alla fisiografia del territorio siciliano. Lafotointerpretazione fisiografica è stata testata tramite il confronto con altre fonti <strong>dati</strong> quali: cartegeomorfologiche <strong>di</strong> dettaglio; ortofoto; immagini Landsat TM e analisi NDVI delle stesse; litologia;DEM e uso del suolo. In seguito, tramite l’incrocio degli strati tematici fisiografia, litologiae uso del suolo sono state create la banca <strong>dati</strong> <strong>dei</strong> sottosistemi <strong>di</strong> terre e le relative componentiterritoriali.1.3.2. Scelta delle finestre <strong>di</strong> <strong>rilevamento</strong> (aree pilota)Tra le osservazioni pedologiche presenti in banca <strong>dati</strong>, sono state selezionate quelle <strong>di</strong> una qualitàsufficiente per la correlazione pedologica, cioè descritte ed analizzate in modo tale da consentirnela classificazione secondo la Soil Taxonomy e il WRB. Le stesse osservazioni sono state poiattribuite semanticamente alle componenti territoriali <strong>dei</strong> sottosistemi <strong>di</strong> terre, in base ai loroattributi <strong>di</strong> morfologia, litologia ed uso del suolo (ve<strong>di</strong> glossario e par. 3.4.2.6). Dopo<strong>di</strong>ché,utilizzando la tabella <strong>di</strong> attribuzione così creata e cioè la tabella geo_legame_osservazioni_sst (ve<strong>di</strong>tab. 3.1) si è potuto verificare quali componenti territoriali risultavano maggiormente scoperte, cioècarenti <strong>di</strong> informazione pedologica, in<strong>di</strong>viduando in questa maniera le finestre <strong>di</strong> <strong>rilevamento</strong>.Queste sono state definite dal seguente campo chiave, formato dalle occorrenze nei seguenti campi:poligono <strong>di</strong> sottosistema (POLY_ID), regione pedologica semantica (SR_ID), sistema <strong>di</strong> terresemantico (ST_ID), sottosistema <strong>di</strong> terre (SST_ID) e componente territoriale del suddettosottosistema (CT_ID) da indagare. Nella tabella 1.2 è riportato un esempio relativo a cinquecomponenti territoriali <strong>di</strong> altrettanti sottosistemi da indagare. Come verrà meglio illustrato inseguito, le componenti territoriali <strong>dei</strong> sottosistemi <strong>di</strong> terre sono solo attributi semantici <strong>dei</strong>sottosistemi, e non hanno una geografia propria (ve<strong>di</strong> par. 2.1). La geografia delle finestre <strong>di</strong><strong>rilevamento</strong> ottenute in questa fase è quin<strong>di</strong> data da quella <strong>dei</strong> sottosistemi <strong>di</strong> terre. Per ottenere unadelimitazione più ristretta, che faciliti il <strong>rilevamento</strong>, è necessario passare ad una terza fase.1.3.3. Realizzazione della banca <strong>dati</strong> delle unità <strong>di</strong> terreIn questa fase è stata effettuata una fotointerpretazione fisiografica <strong>di</strong> dettaglio nelle finestre <strong>di</strong><strong>rilevamento</strong> in<strong>di</strong>viduate nella fase precedente, ed è stata realizzata una banca <strong>dati</strong> delle unità <strong>di</strong>terre, utilizzando anche le banche <strong>dati</strong> <strong>di</strong> litologia e uso del suolo. La creazione della banca <strong>dati</strong>delle unità <strong>di</strong> terre ha come finalità quella <strong>di</strong> dare una geografia alle componenti <strong>di</strong> sottosistema <strong>di</strong>terre da indagare, attribuendo loro un certo numero <strong>di</strong> unità <strong>di</strong> terre e relativi elementi territoriali.Nella tab. 1.3 sono riportati gli elementi territoriali che si riferiscono alle componenti territoriali <strong>dei</strong>cinque sottosistemi riportati nella tab. 1.2. Nella stessa tabella gli elementi territoriali vengonocontrassegnati dal co<strong>di</strong>ce ET_ID, cioè da una combinazione <strong>dei</strong> co<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> fisiografia (MORFO),elemento morfologico (EL_MORFO), litologia (LITO) e uso del suolo (USO). Di ogni elementoterritoriale viene in<strong>di</strong>cata anche l’area <strong>di</strong> copertura in ettari (AREA_HA).23
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICITabella 1.2. Esempio <strong>di</strong> in<strong>di</strong>cazione univoca delle componenti territoriali <strong>di</strong> sottosistema da indagare in un <strong>rilevamento</strong> GIS oriented.POLY_ID SR_ID ST_ID SST_ID CT_ID MORFO LITO USO1900002 62.2 305EV6540 VAXXMAV100V2PP VAMAV10041 VA MAV100 411900011 59.9 464CAEV3065 ESDXXSE1108EMAV300 ESDSE1108E30 ESD SE1108E 301900023 59.9 445CAAM404320 SSOCRSE1108EXX CRSE1108E40 CR SE1108E 401900026 59.9 445CAAM404320 FABXXAFXX FABAF40 FAB AF 401900053 59.9 446CA204330 SSDXXSE1108EXX SSDSE1108E43 SSD SE1108E 43Tabella 1.3. Esempio <strong>di</strong> in<strong>di</strong>cazione univoca degli elementi territoriali rappresentativi delle componenti territoriali <strong>di</strong> sottosistema da indagare in un <strong>rilevamento</strong> GIS oriented.POLY_ID CT_ID ET_ID MORFO EL_MORFO LITO USO AREA_HA1900002 VAMAV10041 VAVMMAV10041* VA VM MAV100 41 96,961900011 ESDSE1108E30 ESDPRSE1108E30* ESD PR SE1108E 30 62,431900011 ESDSE1108E30 ESDPRMAV30040 ESD PR MAV300 30 102,711900023 CRSE1108E40 SSOVSSE1108E40 SSO VS SE1108E 40 21,541900023 CRSE1108E40 CRPRSE1108E40* CR PR SE1108E 40 186,051900023 CRSE1108E40 FASDAAF40 FAS DA AF 40 26,451900026 FABAF40 FAADAAF42 FAA DA AF 42 80,121900026 FABAF40 ELNVBSE1108E40 ELN VB SE1108E 40 21,821900026 FABAF40 FABDAAF40* FAB DA AF 40 25,291900026 FABAF40 FABDAAF40 FAB DA AF 40 20,301900053 SSDSE1108E43 SSOVMSE1108E43 SSO VM SE1108E 43 13,891900053 SSDSE1108E43 SSOVMSE1108E43* SSO VM SE1108E 43 119,391900053 SSDSE1108E43 EYVVSSE1108E43* EYV VS SE1108E 43 2,38* Elemento territoriale scelto per il <strong>rilevamento</strong> in campagna.24
IL RILEVAMENTO DEI SUOLI1.3.4. In<strong>di</strong>viduazione delle componenti territoriali delle unità <strong>di</strong> terre (elementiterritoriali) da indagareDurante la quarta fase sono stati scelti, fra tutti gli elementi territoriali in<strong>di</strong>viduati, quelli in cuiandavano localizzati i rilevamenti in campo, in<strong>di</strong>cati nell’esempio della tab. 1.3 con l’asterisco.Come è possibile osservare dagli esempi riportati, il criterio <strong>di</strong> scelta è stato in primo luogo quellodella corrispondenza semantica fra la componente territoriale <strong>di</strong> sottosistema <strong>di</strong> terre e l’elementoterritoriale, in secondo luogo, nel caso in cui gli elementi territoriali avessero uguale semantica, èstato usato un criterio <strong>di</strong> maggior copertura areale. Nell’ esempio vi è un caso in cui, per lapresenza <strong>di</strong> una fisiografia composita (SSD, cioè superficie strutturale <strong>di</strong>ssecata), si è scelto <strong>di</strong>in<strong>di</strong>care due elementi territoriali come rappresentativi, l’uno della parte stabile della superficiestrutturale (SSOVMSE1108E43) e l’altro dell’incisione (EYVVSSE1108E43). Gli elementiterritoriali possono essere geografizzati con una delineazione o anche solo con un centroide (ve<strong>di</strong>par. 2.6).1.3.5. Rilevamento in campoLa quinta ed ultima fase è quella del <strong>rilevamento</strong> in campagna, che si compone a sua volte <strong>di</strong> treattività:1. riconoscimento dell'elemento territoriale in<strong>di</strong>viduato in fotointerpretazione (fig 1.10) e suadescrizione <strong>di</strong> campagna tramite le specifiche previste dalla fisiografia e dall’elementomorfologico (ve<strong>di</strong> cap. 4);2. realizzazione <strong>di</strong> una serie <strong>di</strong> osservazioni spe<strong>di</strong>tive (almeno 3-4) per l'apprezzamento dellavariabilità pedologica locale dell’elemento territoriale. Queste potranno essere collocate nei<strong>di</strong>versi elementi morfologici presenti nell’elemento territoriale;3. scavo e descrizione del profilo (figg. 1.11 - 1.15) in corrispondenza dell'osservazioneconsiderata più rappresentativa, eventualmente più <strong>di</strong> una se i suoli rilevati non sono simili.Un possibile avanzamento metodologico nella procedura <strong>di</strong> <strong>rilevamento</strong> della variabilità pedologicalocale vede la sostituzione del <strong>rilevamento</strong> effettuato con la trivella manuale con un <strong>rilevamento</strong>effettuato utilizzando attrezzature <strong>di</strong> indagine elettromagnetica. In particolare, è ormai possibile edeconomicamente sostenibile l’uso <strong>di</strong> apparecchiature semoventi che misurano la conducibilità e laresistività elettrica del suolo fino ad oltre un metro e mezzo <strong>di</strong> profon<strong>di</strong>tà. La tecnologia è statamessa a punto nel settore geofisico, dove viene adoperata per misurare sia la conducibilità elettricache il parametro inverso alla conducibilità e cioè la resistività elettrica (ρ). Per misurare laresistività viene immessa nel sottosuolo, me<strong>di</strong>ante due elettro<strong>di</strong>, una corrente elettrica chedetermina una <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> potenziale, la quale viene misurata me<strong>di</strong>ante altri due elettro<strong>di</strong>.L’utilizzo <strong>di</strong> tecniche geofisiche non invasive permette <strong>di</strong> realizzare delle mappe dellaresistività elettrica apparente del suolo, ottenendo in<strong>di</strong>rettamente una mappa delle variabilitàspaziali <strong>dei</strong> parametri intrinseci del suolo ad essa correlati, che sono principalmente la tessitura,l’umi<strong>di</strong>tà e la salinità. Con l’uso <strong>di</strong> questi strumenti è possibile scegliere i siti dove scavare i profiliin modo certamente più rappresentativo della variabilità locale che con trivella manuale.25
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICIFigura 1.10. Riconoscimento degli elementi territoriali in campagna. Parte nord della carta pedologica in fig. 1.9d.26
IL RILEVAMENTO DEI SUOLIFigura 1.11. Suolo dell’ elemento territoriale 1 -versante convesso, parte alta, su calcarecavernoso, con foresta <strong>di</strong> latifoglie semprever<strong>di</strong> edecidue (co<strong>di</strong>ce EXVASE2101A61).Figura 1.12. Suolo dell’ elemento territoriale 2 -versante lineare regolare, parte me<strong>di</strong>a, su calcarecavernoso, con foresta <strong>di</strong> latifoglie sclerofile(co<strong>di</strong>ce ELRVMSE2101A65).Figura 1.13. Suolo dell’ elemento territoriale 3 - versante lineare aggradato,parte bassa, su colluvio <strong>di</strong> versante, con foresta <strong>di</strong> latifogliedecidue(co<strong>di</strong>ce ELAVBCOV61).27
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICIFigura 1.14. Suolo dell’ elemento territoriale 4 -terrazzo fluviale, ripiano, su alluvioni <strong>di</strong>versante, con foresta <strong>di</strong> latifoglie decidue(FTPRAVA61).Figura 1.15. Suolo dell’ elemento territoriale 5 -fondovalle con substrato roccioso sub affiorante,depressione aperta, su alluvioni <strong>di</strong> versante, conforesta <strong>di</strong> latifoglie decidue (co<strong>di</strong>ceFABDAAVA61).28
LE BANCHE DATI GEOGRAFICHE2. Le banche <strong>dati</strong> geograficheR. Barbetti, E. A. C. Costantini, M. Fantappiè, G. L’Abate, S. Magini, M. PaolantiIn<strong>di</strong>ce2.1 La gerarchia <strong>dei</strong> pedopaesaggi.....................................................................................................292.2 Le regioni pedologiche (soil regions) ..........................................................................................302.3 Le province pedologiche (soil subregions)..................................................................................332.4 I sistemi <strong>di</strong> terre (soil systems) ....................................................................................................332.5 I sottosistemi <strong>di</strong> terre (soil subsystems).......................................................................................402.6 Le unità <strong>di</strong> terre e gli elementi territoriali (land units e land elements) ......................................452.7 I co<strong>di</strong>ci geografici........................................................................................................................492.1 La gerarchia <strong>dei</strong> pedopaesaggiI contenitori geografici che esprimono la combinazione <strong>dei</strong> fattori pedogenetici e della loro strutturaspaziale ricorrente sono i pedopaesaggi. Il pedopaesaggio è un tratto <strong>di</strong> superficie terrestre che haun certo significato pedologico: raccoglie suoli che hanno in comune una o più caratteristiche,proprietà o processi, ed è in<strong>di</strong>viduabile da un insieme <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zioni climatiche, litologiche,morfologiche, pedologiche, <strong>di</strong> uso del suolo e <strong>di</strong> vegetazione (ve<strong>di</strong> cap. 1).L’organizzazione spaziale delle informazioni pedologiche avviene a <strong>di</strong>versi livelli geografici,cui corrispondono specifici livelli <strong>di</strong> generalizzazione dell’informazione: dal più generale (scala <strong>di</strong>riferimento 1:5.000.000) finalizzata alla correlazione europea (Finke et al., 1999), fino a quella <strong>di</strong>dettaglio (scala <strong>di</strong> riferimento 1:10.000-1:25.000) per applicazioni locali. Esiste quin<strong>di</strong> un sistema<strong>di</strong> banche <strong>dati</strong> in cui sono co<strong>di</strong>ficati in modo gerarchico i legami tra i suoli e il paesaggio ai <strong>di</strong>versilivelli geografici e <strong>di</strong> generalizzazione pedologica (tab. 2.1). Le relazioni tra i livellipedopaesaggistici sono logiche e semantiche, più che strettamente topologiche. Ad esempio, in unaregione pedologica (soil region) possono essere geograficamente contenuti sistemi <strong>pedologici</strong> cheappartengono semanticamente ad un’altra regione pedologica, ma che non è stato possibile<strong>di</strong>fferenziare, per problemi <strong>di</strong> dettaglio geometrico, nella delineazione <strong>dei</strong> poligoni alla scala <strong>di</strong>riferimento 1:5.000.000.I contenitori pedogeografici sono definiti <strong>di</strong> terre quando l’informazione sui suoli è generica edè trattata come descrivente all’interno della banca <strong>dati</strong> geografica. Sono invece <strong>pedologici</strong> quandol’informazione sui suoli è organizzata in una banca <strong>dati</strong> specifica ed è collegata alla banca <strong>dati</strong>geografica. Soil regions e subregions sono livelli pedopaesaggistici <strong>di</strong> cui esiste una banca <strong>dati</strong>europea.Ogni poligono <strong>di</strong> ogni livello geografico collegato ad una banca <strong>dati</strong> pedologica è in<strong>di</strong>viduatosia in funzione <strong>dei</strong> suoi attributi <strong>di</strong>scriminanti, sia dalla combinazione <strong>di</strong> componenti territorialiesistenti al suo interno. Ogni poligono contiene al suo interno un insieme <strong>di</strong> ambienti riconoscibili,ma non delineabili a quella scala <strong>di</strong> riferimento. Le componenti territoriali sono proprio tutte lecombinazioni <strong>di</strong> ambienti con uguale morfologia, litologia ed uso del suolo presenti all’interno <strong>di</strong>ogni poligono. Esse vengono identificate per mezzo delle informazioni territoriali tematicheutilizzate per la costruzione <strong>di</strong> ogni livello geografico ed hanno legende specifiche per ogni livello.Le componenti territoriali non sono mappate, cioè non hanno una geografia definita, e noncoincidono necessariamente con le unità del livello geografico inferiore. Le componenti territoriali<strong>dei</strong> sistemi, ad esempio, non necessariamente corrispondono ai sottosistemi.29
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICITabella 2.1. I livelli pedopaesaggistici.LIVELLO PEDOPAESAGGISTICOSCALA DIRIFERIMENTOORDINE DI GRANDEZZA DEIPOLIGONI (ha)Soil regions - Regioni pedologiche 1:5.000.000 10 5 -10 6Soil subregions - Province <strong>di</strong> terre 1:1.000.000 10 4 -10 5Soil systems - Sistemi <strong>di</strong> terre / <strong>pedologici</strong> 1:500.000 10 3 -10 5Sottosistemi <strong>di</strong> terre / <strong>pedologici</strong> 1:250.000 10 2 -10 5Unità <strong>di</strong> terre / pedologiche 1:50.000 10 1 -10 2Elementi territoriali 1:10.000-25.000 10 -1 -10 1Le regioni pedologiche, i sistemi <strong>di</strong> terre, i sottosistemi <strong>di</strong> terre e le unità <strong>di</strong> terre sono costituiti dastrati poligonali, mentre gli elementi territoriali sono in<strong>di</strong>viduati, ma in genere non cartografati.Ogni livello informativo ha una <strong>di</strong>versa generalizzazione <strong>dei</strong> fattori della pedogenesi, quin<strong>di</strong>, comeverrà meglio illustrato in seguito, le legende utilizzate per definire i fattori della pedogenesi nonsono le stesse per tutte le scale geografiche. Il livello pedopaesaggistico utilizzato a livellonazionale per spazializzare l’informazione pedologica puntuale contenuta nella banca <strong>dati</strong> è quello<strong>dei</strong> sistemi <strong>di</strong> terre.La banca <strong>dati</strong> geografica d’Italia è articolata in forma gerarchica, nel senso che i pedopaesaggi<strong>di</strong> livello inferiore vengono legati semanticamente 1 a quelli <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne superiore. Ad esempio: ognipoligono <strong>di</strong> sottosistema <strong>di</strong> terre viene attribuito semanticamente al poligono <strong>di</strong> sistema <strong>di</strong> terre che,con un maggior grado <strong>di</strong> generalizzazione, ha i suoi stessi attributi <strong>di</strong> litologia, fisiografia e uso delsuolo. Non esiste, invece, una corrispondenza geografica esatta fra i vari pedopaesaggi, in quanto ipedopaesaggi a scala maggiore non sono creati per sud<strong>di</strong>visione geografica <strong>di</strong> quelli a scala minore,ma vengono creati in<strong>di</strong>pendentemente, utilizzando strati informativi appropriati alla scala <strong>di</strong>riferimento. Il significato pedologico <strong>di</strong> questi contenitori geografici viene stabilito me<strong>di</strong>ante lacreazione <strong>dei</strong> legami suolo-geografia, cioè legando le unità tipologiche <strong>di</strong> suolo (UTS) e sottounitàtipologiche <strong>di</strong> suolo (STS) alle componenti territoriali <strong>dei</strong> poligoni <strong>dei</strong> vari pedopaesaggi (ve<strong>di</strong> cap.3).2.2 Le regioni pedologiche (soil regions)Le regioni pedologiche sono il primo livello della gerarchia <strong>dei</strong> pedopaesaggi (fig. 2.1). La scala <strong>di</strong>riferimento 1:5.000.000 consente un inquadramento pedologico generale a livello nazionale. Lacarta delle regioni pedologiche italiane (Righini et al., 2001; Costantini et al., 2004) è statarealizzata in collaborazione con l’European Soil Bureau e le linee guida per lo svolgimento dellavoro sono quelle descritte dal manuale europeo (Finke et al., 1999). Seguendo le in<strong>di</strong>cazioni delmanuale, i fattori fondamentali per la determinazione delle regioni pedologiche sono stati lecon<strong>di</strong>zioni climatiche e quelle geologiche; si presuppone, infatti, che tali elementi caratterizzino losviluppo <strong>dei</strong> <strong>di</strong>versi processi pedogenetici così da dar luogo a <strong>di</strong>fferenti suoli dominanti. In seguito,oltre che per clima e geologia principale, le regioni pedologiche sono state caratterizzate per ilpedoclima, vale a <strong>di</strong>re il regime idrico e termico <strong>dei</strong> suoli (Soil Survey Staff, 1999), per lamorfologia, per i tipi <strong>di</strong> suolo maggiormente presenti e relative capacità d'uso, limitazionipermanenti e processi <strong>di</strong> degradazione più importanti (tab. 2.2). Lo strato geografico vettoriale in1 L’aggettivo “semantico” viene usato per in<strong>di</strong>care il contenuto informativo (gli attributi del database) del livellogeografico. L’aggettivo “geografico” viene invece usato per in<strong>di</strong>care le delineazioni (la geometria) della geografia.30
LE BANCHE DATI GEOGRAFICHEformato .shp e relativa banca <strong>dati</strong> SoilRegion.mdb delle regioni pedologiche con tutta ladocumentazione sono <strong>di</strong>sponibili sul sito del CNCP (http://www.soilmaps.it). Nella banca <strong>dati</strong>SoilRegion.mdb sono riportate informazioni sul clima e sulla litologia del materiale genitore chesono riassunte nella tabella Sr_table. La lista completa delle regioni pedologiche italiane ècomunque riportata anche nel CNCP_b.mdb nella tabella soil_region.Figura 2.1. Regioni pedologiche d’Italia (la 62.2, in Sicilia, è quella da dove sono stati presi gli esempi riportati inquesto manuale). Le specifiche <strong>dei</strong> co<strong>di</strong>ci sono riportati in tabella 2.9.31
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICITabella 2.2. Attributi delle regioni pedologiche.Co<strong>di</strong>ce Tipo Descrizione Riferimento legenda EsempioSOIL_REG Testo Co<strong>di</strong>ce della Soil region Tabella Sr_table delCODE Testo Clima, materiale genitore e co<strong>di</strong>ceregionaleSR_NAME Testo Descrizione della soil region con itipi <strong>di</strong> suolo dominanti ed il nomedella regione.SR_PMASTestoMaterialegenitoredominanteSR_MATLO Numerico Temperatura me<strong>di</strong>a annua minima(°C)SR_MATHI Numerico Temperatura me<strong>di</strong>a annuamassima (°C)SR_MAPLO Numerico Precipitazione me<strong>di</strong>a annuaminima (mm)SR_MAPHI Numerico Precipitazione me<strong>di</strong>a annuaminima (mm)SR_HIPRECSR_DROUGTestoTestoMesiMesipiùpiùpiovosisiccitosiSR_LOWT Testo Mesi con temperature al <strong>di</strong> sotto <strong>di</strong>0 °CSR_ALTMINSR_ALTHISR_MLFNumericoNumericoTestoQuotaQuotaFormaminima (m s.l.m.)massima (m s.l.m.)del paesaggio principaleSoilRegion.mdb e tabellasoil_region del CNCP_b.mdbTabelle clima_descrizione etabella lito_descrizione delSoilRegion.mdb------------62.244.5.2Cambisol - Luvisol - Vertisol region withLeptosols and Regosols of southern SicilyTertiary clayey flysch, limestone,calcareous sandstone and gypsiferous rocks12,821,9450670NOV,MAY --0650SlopingDECSEPland32
LE BANCHE DATI GEOGRAFICHE2.3 Le province pedologiche (soil subregions)La scala <strong>di</strong> riferimento <strong>di</strong> questo livello pedopaesaggistico è 1:1.000.000. A livello europeo esisteuna banca <strong>dati</strong> delle soil subregions, <strong>di</strong>sponibile presso l’European Soil Bureau(http://eusoils.jrc.it/data.html). In Italia, le province pedologiche sono inserite in un processo<strong>di</strong>scendente che parte dalle regioni pedologiche, mantenendo il significato <strong>di</strong> contenitorepedogeografico complesso, in cui un insieme <strong>di</strong> paesaggi è legato da relazioni funzionali relative aifattori della pedogenesi e alla gestione <strong>dei</strong> suoli. Vengono in<strong>di</strong>viduate all’interno delle regionipedologiche inserendo la fisiografia come attributo <strong>di</strong>scriminante.In alcune regioni italiane, segnatamente dove le indagini a maggior dettaglio sono statecompletate per l’intero territorio regionale, le province pedologiche sono state costruite conproce<strong>di</strong>mento ascendente, cioè per generalizzazione delle informazioni pedologiche <strong>dei</strong> livellipedopaesaggistici inferiori.2.4 I sistemi <strong>di</strong> terre (soil systems)I sistemi <strong>di</strong> terre rappresentano una sud<strong>di</strong>visione del territorio italiano in paesaggi, ovvero in areericonosciute come omogenee in funzione <strong>di</strong> caratteri legati essenzialmente a morfologia, litologia ecopertura del suolo ad una scala <strong>di</strong> riferimento <strong>di</strong> 1:500.000. La loro delineazione geografica siavvale dell’utilizzo <strong>di</strong> una serie <strong>di</strong> banche <strong>dati</strong> <strong>di</strong> supporto che sono: i) il Modello Digitale delTerreno (250 m) riclassificato seguendo il riferimento del secondo livello SOTER (F.A.O., 1995) econ l’aggiunta <strong>di</strong> una <strong>di</strong>scriminazione in base alle fasce isometriche (figg. 2.2 e 2.3), ii) la carta “IlMondo (JOG) 1501” serie 250/G (I.G.M., 2004), iii) l’idrografia in scala 1:25.000 (cartografiaI.G.M.), iv) la Carta Geologica d’Italia in scala 1:500.000 (Servizio Geologico d’Italia, 1978) einfine v) le immagini da satellite (Landsat TM) sulla base delle quali sono apposti i limiti desuntidall’interpretazione. Per quanto riguarda invece la copertura del suolo, il riferimento è la banca <strong>dati</strong>del “Corine Land Cover” (Cumer, 1994) opportunamente riclassificata in funzione delle esigenzelegate alla scala e alle finalità essenzialmente pedologiche del lavoro.In una prima fase è eseguita una interpretazione del paesaggio sulla base essenzialmente dellacombinazione morfometrica <strong>di</strong> quota e pendenza e del “pattern” <strong>di</strong> drenaggio, con una valutazione<strong>dei</strong> principali agenti morfogenetici, ovvero quelli che maggiormente concorrono alla sua genesi emodellamento e descrivono l’unità fisiografica. Nella tab. 2.3 è riportato un esempio <strong>di</strong> come sonoorganizzate queste informazioni nella legenda “morfo_Italia” (allegato nel CD-romST500_2007.mdb) che comprendono: una descrizione prosaica del paesaggio con il tipo principale<strong>di</strong> drenaggio (St_morfo), le principali classi SOTER (cl_Soter), la località geografica in cui ilconcetto centrale del sistema è più evidente e i tre agenti morfogenetici principali con accanto irelativi co<strong>di</strong>ci.Contemporaneamente è valutata la natura litologica delle formazioni geologiche checaratterizzano il territorio, in modo da iniziare a <strong>di</strong>stinguere i vari tipi <strong>di</strong> paesaggio. Questi caratterifunzionano quin<strong>di</strong> da <strong>di</strong>scriminanti del territorio in termini geografici, ovvero sono la base per ladelineazione <strong>dei</strong> sistemi <strong>di</strong> terre, la cui verifica avviene sulle immagini satellitari per convergenza<strong>di</strong> evidenze (fig. 2.4). La copertura del suolo, che entra in gioco nella fase successiva, <strong>di</strong>scriminageneralmente solo a livello semantico, a parte alcune situazioni <strong>di</strong> alta montagna in cui,nell’in<strong>di</strong>viduare il limite, si tiene conto del cambio <strong>di</strong> vegetazione.33
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICIQUOTA0-200200-300300-400400-600600-15001500-3000Figura 2.2. Modello Digitale del Terreno riclassificato per ricavare classi <strong>di</strong> quota (m s.l.m)PENDENZA0-22-88-1515-3030-60> 60Figura 2.3. Modello Digitale del Terreno riclassificato per ricavare classi <strong>di</strong> pendenza %.34
LE BANCHE DATI GEOGRAFICHETabella 2.3 Esempio <strong>di</strong> descrizione del paesaggio nella legenda <strong>dei</strong> sistemi <strong>di</strong> terre.St_frprSt_morfo423 Pianure fluviali <strong>di</strong> bassa quota, versanti a bassapendenza e aree collinari a bassa quota e me<strong>di</strong>apendenza, con drenaggio subparalleloCl_soterLP1-LF1-SH1localitàFondovalle delF.Freddo (TP)Agente_ Co<strong>di</strong>ce_ag_ Agente_ Co<strong>di</strong>ce_ag_ Agente_ Co<strong>di</strong>ce_ag_morfog_I morf_I morfog_II morf_II morfog_III morf_IIIForme <strong>di</strong> fondovalle F00 Erosione idrica E00 Assente AssenteFigura 2.4. Immagine LANDSAT, pattern <strong>di</strong> drenaggio e sistemi <strong>di</strong> terre dell’area etnea.Nell’ambito del progetto “banca <strong>dati</strong> <strong>dei</strong> suoli d’Italia”, i sistemi <strong>di</strong> terre sono stati revisionati apartire dai sottosistemi forniti dai servizi regionali. Durante questa fase sono stati utilizzati stratiinformativi <strong>di</strong> maggior dettaglio (DEM regionali a passo 20-40 m; cartografie geologiche regionaliecc.) ed integrazioni con strati climatici regionali, che hanno permesso <strong>di</strong> comprendere meglio icambiamenti <strong>di</strong> pattern <strong>di</strong> copertura del suolo e <strong>di</strong> apporre <strong>dei</strong> limiti con un maggior grado<strong>di</strong> confidenza.Le unità cartografiche che risultano dall’utilizzo <strong>di</strong> tutte le conoscenze <strong>dei</strong> fattori dellapedogenesi sono identificate in modo univoco dagli attributi che descrivono la fisiografia e leprincipali litologie e coperture del suolo, riuniti in maniera sintetica nel co<strong>di</strong>ce ST_CODE dellatabella degli attributi (tab. 2.4). Gli attributi sono consultabili e deco<strong>di</strong>ficati grazie all’appositogeodatabase <strong>dei</strong> sistemi <strong>di</strong> terre (ve<strong>di</strong> par. 3.5). Accanto a questi esistono altri attributi definiti come35
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICIdescriventi, e come tali aggiunti a posteriori (tab. 2.4). Tra questi oltre a quelli relativi alla regionepedologica <strong>di</strong> appartenenza semantica, alla regione amministrativa, ad una descrizione geograficadell’area, ci sono quelli <strong>di</strong> “forma regionale” riferiti ad una legenda creata appositamente daipedologi <strong>dei</strong> servizi regionali per la correlazione nella Pianura Padana.Gli attributi fanno riferimento a legende che sono state opportunamente create in funzioneessenzialmente della scala <strong>di</strong> riferimento <strong>dei</strong> sistemi <strong>di</strong> terre e <strong>dei</strong> fini <strong>pedologici</strong> del lavoro e chesono riportate nel database ST500_2007.mdb. Nel par. 2.7 è possibile inoltre trovare le tabelle <strong>di</strong>deco<strong>di</strong>fica <strong>dei</strong> co<strong>di</strong>ci utilizzati per questo livello geografico (tabb. 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16 e2.17).Successivamente, sulla base delle combinazioni degli attributi relativi alla morfologia, allalitologia principale e secondaria e ai tre attributi <strong>di</strong> copertura del suolo, si ricavano le seicomponenti territoriali che compongono il sistema, riconosciute geograficamente, ma nondelineate, me<strong>di</strong>ante sovrapposizione delle banche <strong>dati</strong> relative (fig. 2.5). L’intersezione dellebanche <strong>dati</strong> <strong>di</strong> fisiografia, litologia e uso del suolo è volta a calcolare la percentuale <strong>di</strong> coperturadelle singole componenti territoriali e non alla creazione <strong>di</strong> uno strato poligonale a se stante: lecomponenti territoriali sono cioè definite come attributi dello strato poligonale <strong>dei</strong> sistemi <strong>di</strong> terre.In ambienti particolarmente complessi, può risultare una settima componente, derivante daattributi non identificativi del sistema, ma che sono comunque rilevanti nella descrizione delpaesaggio. Questa componente è descritta nel campo ALTRO_CT. Le componenti territorialirappresentano dunque porzioni <strong>di</strong> paesaggio “elementari” all’interno del sistema <strong>di</strong> terre,significative per la scala <strong>di</strong> riferimento, con una certa omogeneità <strong>di</strong> elementi fisiografici, litologicie <strong>di</strong> copertura del suolo.Il paesaggio così delineato, pur strettamente legato alla scala <strong>di</strong> osservazione, conserva unrapporto con gli altri livelli <strong>di</strong> riconoscimento territoriale, nel caso specifico con la soil region <strong>di</strong>appartenenza semantica. Rifacendosi al caso del sistema riportato in fig. 2.5, questo appartiene dalpunto <strong>di</strong> vista semantico (e in questo caso anche geografico) alla soil region 62.2, le cuicaratteristiche e la cui localizzazione sono deducibili dalla fig. 2.6.La componente territoriale del sistema riportata in fig. 2.7, caratterizzata dallo stesso attributo<strong>di</strong> morfologia principale del sistema cui appartiene, <strong>di</strong>scrimina un ambiente che, pur <strong>di</strong>stinguendosidagli altri per caratteri litologici e <strong>di</strong> copertura del suolo, mantiene con essi rapporti <strong>di</strong> vicinanzae reciproca interazione.36
LE BANCHE DATI GEOGRAFICHETabella 2.4. Tabella degli attributi <strong>dei</strong> sistemi <strong>di</strong> terre.Co<strong>di</strong>ce Tip o De cs rizioneST _ID Numerico Progressivo numerico che in<strong>di</strong>viduaunivocamente ogni poligonoRiferimento-legendaST_SREG Testo Co<strong>di</strong>ce della soil region semantica Tabella Sr_table del SoilRegion.mdb e tabellasoil_region del CNCP_b.mdbST_DESCR Testo Descrizione prosaica della geografiadel sistemaST_FRPR Numerico Morfologia principale Legenda originale specifica ST500_2007.mdbo tabella Deco<strong>di</strong>fiche del CNCP_b.mdbspecie_tabella MORFO_STST_LITPR Testo Litologia principale Legenda originale specifica ST500_2007.mdbo tabella Deco<strong>di</strong>fiche del CNCP_b.mdbspecie_tabella LITO_STST_LITSEC Testo Litologia secondaria (può esserevuoto)-Esempio19009262.2Pianurefluviali<strong>di</strong>bassaquota,versanti a bassapendenza e aree collinaria bassa quota e me<strong>di</strong>apendenza, con drenaggiosub-parallelo423AMCome sopra MAST_USUO1 Numerico Uso del suolo principale Legenda originale specifica ST500_2007.mdbo tabella Deco<strong>di</strong>fiche del CNCP_b.mdbspecie_tabella USO_STST_USUO2 Numerico Uso del suolo secondario (può esserevuoto)Come sopra 2041ST_USUO3 Numerico Uso del suolo terziario (può esserevuoto)ST_CODE Testo Co<strong>di</strong>ce del sistema <strong>di</strong> terre, dato dallacombinazione <strong>di</strong> massimo 6 campi:ST_FRPR (e ST_FRREG);ST_LITPR; ST_LISEC;ST_USOSUO1; ST_USOSUO2;ST_USOSUO3Come sopra -Legenda originale specifica ST500_2007.mdbo tabella Deco<strong>di</strong>fiche del CNCP_b.mdbspecie_tabella MORFO_ST, LITO_ST eUSO_ST423AMMA4120ST_FRREG Testo Co<strong>di</strong>ce per correlazione Nord Italia Legenda originale specifica ST500_2007.mdb -(Nord Italia)COMP_TERR1 Testo Combinazioni <strong>dei</strong> campi <strong>di</strong> fisiografia Legenda originale specifica ST500_2007.mdb 423AM4137
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICICOMP_TERR2COMP_TERR3COMP_TERR4COMP_TERR5COMP_TERR6(ST_FRPR), litologia (ST_LITPR eST_LISEC) e uso del suolo(ST_USOSUO1, ST_USOSUO2 eST_USOSUO3) del sistema <strong>di</strong> terre,denominate componenti territoriali (6combinazioni)ALTRO_CT Testo Possibile altra componente territorialenon proveniente dalla combinazione<strong>di</strong> fisiografia, litologia e uso del suoloprevisti per il sistema <strong>di</strong> terre, ma cheè riconoscibile alla scala <strong>di</strong>riferimento (una al massimo).COMP1_PERCCOMP2_PERCCOMP3_PERCCOMP4_PERCCOMP5_PERCCOMP6_PERCALTRO_PERCST_RAMM1ST_RAMM2ST_RAMM3Numerico Percentuale areale delle singolecomponenti territorialiTesto Co<strong>di</strong>ce della regione amministrativa<strong>di</strong> appartenenza del poligonoo tabella Deco<strong>di</strong>fiche del CNCP_b.mdbspecie_tabella MORFO_ST, LITO_ST eUSO_ST423AM20423MA41423MA20Legenda originale specifica ST500_2007.mdbo tabella Deco<strong>di</strong>fiche del CNCP_b.mdbspecie_tabella MORFO_ST, LITO_ST eUSO_ST-40-202018Tabella Regioni del CNCP_b.mdb SI38
LE BANCHE DATI GEOGRAFICHEComponenti TerritorialiLitologia, Uso del suoloMA, 41MA, 20AM, 41AM, 20Altri usi del suolo o litologieFigura 2.5. L’intersezione <strong>dei</strong> tematismi relativi alla litologia e alla copertura del suolo evidenzia la <strong>di</strong>stribuzionedegli ambienti che compongono il sistema <strong>di</strong> terre (ST_CODE: 423AMMA4120). Vedere le tabb. 2.12, 2.16 e 2.17per il significato <strong>dei</strong> co<strong>di</strong>ci.Legend59.962.262.366.466.5Figura 2.6. Sistema <strong>di</strong> terre 423AMMA4120 nella soil region 62.2.ST_CODE: 423AMMA4120COMP_TERR: Vigneti su se<strong>di</strong>menti marini argillosiComponenti territorialiMA, 41Altre componentiFigura 2.7. Componente territoriale 423MA41 all’interno del sistema <strong>di</strong> terre 423AMMA4120.39
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICI2.5 I sottosistemi <strong>di</strong> terre (soil subsystems)I sottosistemi <strong>di</strong> terre sono uno strato pedopaesaggistico utilizzabile alla scala <strong>di</strong> riferimento1.250.000 (tab. 2.1) ed è stato usato per costruire le banche <strong>dati</strong> pedologiche regionali. Le banche<strong>dati</strong> pedologiche in scala 1:250.000 sono state realizzate dalle regioni nell’ambito del progetto“Carta <strong>dei</strong> suoli d’Italia a scala 1:250.000” (Costantini, 1999; Costantini e D’Antonio, 2001).I sottosistemi <strong>di</strong> terre sono unità cartografiche caratterizzate da attributi geografici simili,definiti da legende proprie dello specifico livello pedopaesaggistico e in grado <strong>di</strong> esprimere lapercezione e l’influenza <strong>dei</strong> fattori della pedogenesi propri <strong>di</strong> questo livello <strong>di</strong> dettaglio (tab. 2.1).Essendo un prodotto realizzato in forma autonoma su scala regionale, la banca <strong>dati</strong> <strong>dei</strong> sottosistemi<strong>di</strong> terre, pur mantenendo un assetto metodologico sostanzialmente simile, assume mo<strong>di</strong> concreti <strong>di</strong>realizzazione peculiari per ogni regione, per cui si rimanda alle pubblicazioni regionali per lesingole metodologie <strong>di</strong> creazione (ve<strong>di</strong> ad esempio Giovagnotti et al., 2003; Longo et al., 2003;Michelutti et al., 2003; Brenna et al., 2004; AA.VV., 2005; AA.VV., 2006; Chiuchiarelli et a.,2006; Michelutti et al., 2006; Viviano e Cassi, 2006).In questa sede si fa riferimento alla metodologia usata per la creazione <strong>dei</strong> sottosistemi <strong>di</strong> terredella regione Sicilia, realizzata nell’ambito del progetto “Carta <strong>dei</strong> suoli della Sicilia in scala1:250.000”. In una prima fase è stata realizzata una fotointerpretazione utilizzando stereocoppie <strong>di</strong>aerofotografie in bianco e nero in scala 1:73.000 (Compagnia Generale delle Riprese aeree <strong>di</strong>Parma, 1994) <strong>di</strong> tutto il territorio regionale, volta alla delineazione <strong>di</strong> aree omogenee per fisiografiaalla scala <strong>di</strong> riferimento, utilizzando come legende quelle specifiche pre<strong>di</strong>sposte per il livello <strong>dei</strong>sottosistemi <strong>di</strong> terre tab. 2.5). Il criterio guida nella delimitazione <strong>dei</strong> poligoni è stato quello dellaricerca <strong>di</strong> variazioni fisiografiche <strong>di</strong> significato pedologico, prendendo come principale riferimentobibliografico la cartografia regionale <strong>di</strong> Fierotti del 1988. Lo strato poligonale così prodotto è statoin seguito sovrapposto alla carta litologica realizzata dall’Ente Minerario Siciliano nel 2002 e allabanca <strong>dati</strong> dell’uso del suolo dell’INEA del 2007. A <strong>di</strong>fferenza <strong>dei</strong> sistemi <strong>di</strong> terre, dove lacopertura del suolo viene considerata in genere solo nella fase successiva alla <strong>di</strong>gitalizzazione come<strong>di</strong>scriminante a livello semantico, per i sottosistemi <strong>di</strong> terre l’uso del suolo è un carattere<strong>di</strong>scriminante geografico, per cui può essere usato per l’in<strong>di</strong>viduazione <strong>dei</strong> poligoni.40
LE BANCHE DATI GEOGRAFICHETabella 2.5. Tabella degli attributi <strong>dei</strong> sottosistemi <strong>di</strong> terre.Co<strong>di</strong>ce Tipo DescrizionePOLY _ID Numerico Progressivo numerico che in<strong>di</strong>viduaunivocamente ogni poligonoRiferimento-legendaSR_ID Testo Co<strong>di</strong>ce della soil region semantica Tabella Sr_table del SoilRegion.mdbe tabella soil_region del CNCP_b.mdbST_ID Testo Co<strong>di</strong>ce del sistema <strong>di</strong> terre semantico Legenda originale specificaSST_ID Testo Co<strong>di</strong>ce del sottosistema <strong>di</strong> terre, dato dallacombinazione <strong>di</strong> 4-6 co<strong>di</strong>ci: SST_FRPR,SST_FRSEC, SST_LITPR, SST_LISEC,SST_USOSUO1 (da in<strong>di</strong>care solo se<strong>di</strong>scriminante), SST_USOSUO2 (da in<strong>di</strong>caresolo se <strong>di</strong>scriminante).SST_FRPRTestoFisiografiaprincipaleSST_FRSEC Testo Fisiografia secondaria (in<strong>di</strong>cata come XX senon presente)SST_LITPRTestoLitologiaprincipaleSST_LISEC Testo Litologia secondaria (in<strong>di</strong>cata come XX se nonpresente)ST500_2007.mdb o tabella deco<strong>di</strong>fichedel CNCP_b.mdbTabella Deco<strong>di</strong>fiche del CNCP_b.mdb,specie_tabella FISIOGR_FORMA,SUBSTRATO e USO_SSTTabella Deco<strong>di</strong>fiche del CNCP_b.mdb,specie_tabella FISIOGR_FORMACome sopraEsempio190326162.2423AMMA4120FAXXAFXXFAXXtabella Deco<strong>di</strong>fiche del CNCP_b.mdb, AFspecie_tabella SUBSTRATOCome sopra XXSST_USOSUO1 Testo Uso del suolo principale (se <strong>di</strong>scriminante) Tabella Deco<strong>di</strong>fiche del CNCP_b.mdb,specie_tabella USO_SSTSST_USOSUO2TestoUsodelsuolosecondario(se<strong>di</strong>scriminante)Comesopra--41
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICIUna volta creato lo strato poligonale, per ogni delineazione è stato definito il rispettivo co<strong>di</strong>ceidentificativo (SST_ID, tab. 2.5) dato dalla combinazione <strong>dei</strong> co<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> fisiografia principale esecondaria, litologia primaria e secondaria e uso del suolo primario e secondario. I co<strong>di</strong>ci <strong>di</strong>fisiografia e litologia vanno inseriti obbligatoriamente nel co<strong>di</strong>ce identificativo del sottosistema.Nel caso in cui non ci sia un secondario va in<strong>di</strong>cato il co<strong>di</strong>ce “XX”. I co<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> uso del suolo,invece, vengono in<strong>di</strong>cati obbligatoriamente solo in quei poligoni dove l’uso del suolo è statoeffettivamente <strong>di</strong>scriminante. L’uso del suolo secondario viene in<strong>di</strong>cato come “XX”, nel caso in cuisia presente nella co<strong>di</strong>fica del sottosistema un uso del suolo principale e non sia presente unsecondario <strong>di</strong>scriminante.Ad ogni poligono sono infine attribuiti la regione pedologica e il sistema <strong>di</strong> terred’appartenenza semantica (fig. 2.8). La combinazione del co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> sottosistema con quello <strong>di</strong>regione pedologica e <strong>di</strong> sistema <strong>di</strong> terre semantici identificano in maniera univoca i sottosistemi <strong>di</strong>terre. Ogni singolo sottosistema <strong>di</strong> terre può comunque essere composto da più <strong>di</strong> un poligono.Sottosistema <strong>di</strong> terre FAXXAFXXSistema <strong>di</strong> terre 423AMMA4120Figura 2.8. Sottosistema <strong>di</strong> terre: “Piana alluvionale <strong>di</strong> fondovalle con se<strong>di</strong>menti fluviali”.Analogamente ai sistemi <strong>di</strong> terre, anche per i sottosistemi sono state in<strong>di</strong>viduate le componentiterritoriali <strong>dei</strong> poligoni, espresse come combinazione <strong>di</strong> fisiografia, litologia e uso del suolo. Anchein questo caso non si ha una geografia definita, perché le componenti sono in<strong>di</strong>viduate solo inmaniera semantica e costituiscono un attributo <strong>dei</strong> poligoni <strong>dei</strong> sottosistemi <strong>di</strong> terre. Ad ognicomponente territoriale, il cui numero per ogni poligono non è vincolato ad un massimo, èassociata una percentuale <strong>di</strong> copertura rispetto all’area del poligono, stimata sulla base delle banche<strong>dati</strong> tematiche utilizzate.Nella tabella degli attributi <strong>dei</strong> sottosistemi <strong>di</strong> terre (tab. 2.5) sono in<strong>di</strong>cati i seguenti campi: ilnumero <strong>di</strong> poligono, il co<strong>di</strong>ce della regione pedologica semantica, il co<strong>di</strong>ce del sistema <strong>di</strong> terresemantico, il co<strong>di</strong>ce identificativo del sottosistema <strong>di</strong> terre, la fisiografia principale, la fisiografiasecondaria, la litologia principale, la litologia secondaria, l’uso del suolo principale e l’uso delsuolo secondario.La legenda utilizzata per la fisiografia e la litologia è la stessa che si usa nella descrizione delsuolo in campagna (ve<strong>di</strong> par. 4.3.1 e 4.3.2). La legenda <strong>di</strong> uso del suolo è simile a quella usata perla definizione <strong>dei</strong> sistemi <strong>di</strong> terre, con la <strong>di</strong>fferenza che per i sottosistemi si è resa necessaria la<strong>di</strong>stinzione tra seminativi irrigui e non irrigui e, all’interno delle aree naturali, la separazione travegetazione rada, aree colpite da incen<strong>di</strong>o e aree in fase <strong>di</strong> rigenerazione della vegetazione (tabb.42
LE BANCHE DATI GEOGRAFICHE2.17 e 2.18). Le legende e i relativi co<strong>di</strong>ci utilizzati per definire la morfologia e la litologia <strong>dei</strong>sottosistemi <strong>di</strong> terre sono dunque sia più aggregate rispetto a quelle utilizzate per la descrizione <strong>dei</strong>suoli in campagna, sia meno generalizzate <strong>di</strong> quelle usate nella definizione <strong>dei</strong> sistemi <strong>di</strong> terre.Da notare che nella tabella degli attributi <strong>dei</strong> sottosistemi <strong>di</strong> terre (tab. 2.5) non sono in<strong>di</strong>cate lecomponenti territoriali. Ciò è dovuto al fatto che è possibile attribuire ad ogni poligono <strong>di</strong>sottosistema un numero illimitato <strong>di</strong> componenti territoriali. La tabella CT_SST delle componentiterritoriali <strong>dei</strong> sottosistemi <strong>di</strong> terre risiede nel CNCP_b.mdb (ve<strong>di</strong> cap. 3). I campi della tabellaCT_SST (tab. 2.6) sono i seguenti: il numero <strong>di</strong> poligono, il co<strong>di</strong>ce della regione pedologicasemantica, il co<strong>di</strong>ce del sistema <strong>di</strong> terre semantico, il co<strong>di</strong>ce identificativo del sottosistema <strong>di</strong> terre,il co<strong>di</strong>ce della componente territoriale, il co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> fisiografia, il co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> litologia e il co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong>uso del suolo, la percentuale <strong>di</strong> superficie del poligono coperta dalla componente territoriale einfine la sua area.43
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICITabella 2.6. Campi della tabella CT_SST del CNCP_b.mdb, cioè delle componenti territoriali <strong>dei</strong> sottosistemi <strong>di</strong> terre.Tipo DescrizioneRiferimento legendaCo<strong>di</strong>ceNEW_IDNumericoProgressivo numerico che in<strong>di</strong>viduaunivocamente ogni poligono (chiave che permetteil legame uno a molti).SR_ID Testo Co<strong>di</strong>ce della soil region semantica Tabella Sr_table del SoilRegion.mdb etabella soil_region del CNCP_b.mdbST_ID Testo Co<strong>di</strong>ce del sistema <strong>di</strong> terre semantico Legenda originale specificaST500_2007.mdb o tabella deco<strong>di</strong>fiche delCNCP_b.mdbSST_ID Testo Co<strong>di</strong>ce del sottosistema <strong>di</strong> terre Tabella Deco<strong>di</strong>fiche del CNCP_b.mdb,specie_tabella FISIOGR_FORMASUBSTRATO e USO_SSTCT_IDTestoCo<strong>di</strong>ce<strong>di</strong>ognicomponenteterritorialeMORFO Testo Co<strong>di</strong>ce fisiografico della componente territoriale Tabella Deco<strong>di</strong>fiche del CNCP_b.mdb,specie_tabella FISIOGR_FORMA-ComeLITO Testo Co<strong>di</strong>ce litologico della componente territoriale Tabella Deco<strong>di</strong>fiche del CNCP_b.mdb,specie_tabella SUBSTRATOUSO Testo Co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> uso del suolo della componenteterritorialeCT_PERC Numerico Percentuale <strong>di</strong> superficie del poligono copertadalla componente territorialeAREA_HA Numerico Area in ettari <strong>di</strong> superficie del poligono copertadalla componente territorialesopraTabella Deco<strong>di</strong>fiche del CNCP_b.mdb,specie_tabella USO_SST--Esempio190326162.2423AMMA4120FAXXAFXXFAAF41FAAF41901656,944
LE BANCHE DATI GEOGRAFICHE2.6 Le unità <strong>di</strong> terre e gli elementi territoriali (land units e land elements)Le unità <strong>di</strong> terre sono ambienti omogenei per i caratteri <strong>di</strong> morfologia, litologia e uso del suoloin<strong>di</strong>viduabili alla scala <strong>di</strong> dettaglio e semidettaglio, corrispondente a 1:10.000-1:50.000 (tab. 2.1).Una banca <strong>dati</strong> delle unità <strong>di</strong> terre è dunque <strong>di</strong>sponibile solo per le aree dove è stato realizzato un<strong>rilevamento</strong> <strong>di</strong> dettaglio e semidettaglio (fig. 2.9) ed esistono le relative pubblicazioni. Quelleutilizzate per la banca <strong>dati</strong> della Regione Siciliana, utilizzate negli esempi riportati, sono state:Alliata e Dazzi 1986, Dazzi e Raimon<strong>di</strong> 1986, Raimon<strong>di</strong> e Dazzi 1986, Olivieri et al.1986, Fierottie Dazzi 1993, Bono et al. 1998, Guaitoli et al. 1998a, Guaitoli et al. 1998b, Bono 2001, Guaitoliet al. 2001. Per realizzare un <strong>rilevamento</strong> <strong>di</strong> tipo GIS oriented, nell’ambito del progetto “Carta <strong>dei</strong>Suoli della Sicilia in scala 1:250.000”, si è resa necessaria la delineazione <strong>di</strong> unità <strong>di</strong> terre,all’interno delle finestre <strong>di</strong> <strong>rilevamento</strong> in<strong>di</strong>viduate (ve<strong>di</strong> par. 1.3).La metodologia <strong>di</strong> creazione è stata simile a quella utilizzata per la delineazione <strong>dei</strong> sottosistemi<strong>di</strong> terre, con alcune particolarità: la prima è che per l’identificazione della natura della forma si èutilizzata oltre che la fisiografia anche l’elemento morfologico, utilizzando le stesse legende che siusano per la descrizione del suolo in campagna; la seconda è che per creare il relativo stratofisiografico-morfologico si sono utilizzate stereocoppie <strong>di</strong> fotografie aeree in bianco e nero a scala1:40.000 (Istituto Geografico Militare <strong>di</strong> Firenze 1992-1995); la terza è che per le unità <strong>di</strong> terrel’uso del suolo è sempre <strong>di</strong>scriminante e dunque viene sempre in<strong>di</strong>cato nel co<strong>di</strong>ce identificativo.Anche in questo caso il criterio guida nella delimitazione <strong>dei</strong> poligoni è stato quello della ricerca <strong>di</strong>variazioni territoriali <strong>di</strong> significato pedologico.Unità <strong>di</strong> terre FAXXDAPPAFXX4120Sottosistema <strong>di</strong> terre FAXXAFXXFigura 2.9. Unità <strong>di</strong> terre: piana alluvionale <strong>di</strong> fondovalle, depressione aperta, pianura, con se<strong>di</strong>menti fluviali e convigneti e seminativi.Nella tabella degli attributi (tab. 2.7) sono in<strong>di</strong>cati i seguenti campi: il numero <strong>di</strong> poligono, il co<strong>di</strong>cedella regione pedologica semantica, il co<strong>di</strong>ce del sistema <strong>di</strong> terre semantico, il co<strong>di</strong>ce delsottosistema <strong>di</strong> terre semantico, il co<strong>di</strong>ce identificativo dell’unità <strong>di</strong> terre, la fisiografia principale,la fisiografia secondaria, la litologia principale, la litologia secondaria, l’uso del suolo principale el’uso del suolo secondario. Il co<strong>di</strong>ce identificativo dell’unità <strong>di</strong> terre è a sua volta formato dallacombinazione <strong>dei</strong> co<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> fisiografia principale, fisiografia secondaria (in<strong>di</strong>cata come XX se nonpresente), elemento morfologico primario, elemento morfologico secondario (in<strong>di</strong>cato come XX senon presente), litologia principale, litologia secondaria (in<strong>di</strong>cata come XX se non presente), uso delsuolo primario e uso del suolo secondario (in<strong>di</strong>cato come “XX” se non presente).45
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICIDue poligoni con lo stesso co<strong>di</strong>ce identificativo <strong>di</strong> unità <strong>di</strong> terre, attribuiti semanticamente allostesso sottosistema <strong>di</strong> terre, allo stesso sistema <strong>di</strong> terre e alla stessa regione pedologica,appartengono alla stessa unità <strong>di</strong> terre. La legenda utilizzata per la fisiografia, l’elementomorfologico e la litologia è la stessa che si usa nella descrizione del suolo in campagna (ve<strong>di</strong> cap.4). L’in<strong>di</strong>cazione dell’elemento morfologico permette un maggior livello <strong>di</strong> approfon<strong>di</strong>mentorispetto ai sottosistemi <strong>di</strong> terre. La legenda <strong>di</strong> uso del suolo invece coincide con quella usata per isottosistemi <strong>di</strong> terre.Nella tabella degli attributi delle unità <strong>di</strong> terre (tab. 2.7) non sono in<strong>di</strong>cate le componentiterritoriali e ciò è dovuto al fatto che è possibile attribuire ad ogni poligono <strong>di</strong> unità <strong>di</strong> terre unnumero indefinito <strong>di</strong> componenti territoriali. Per questo motivo, le componenti territoriali devononecessariamente risiedere in una tabella a parte, presente nel CNCP_b.mdb e cioè la tabella CT_UT(tab. 2.8), i cui record possono essere legati a quelli della tabella degli attributi delle unità <strong>di</strong> terrecon un legame <strong>di</strong> uno a molti tramite il campo POLY_ID relativo al numero del poligono.Le componenti territoriali delle unità <strong>di</strong> terre, chiamati elementi territoriali perché sono il livelloelementare della gerarchia geografica, sono <strong>dati</strong> dalle combinazioni <strong>di</strong> fisiografia, elementomorfologico, litologia e uso del suolo più frequenti per ogni poligono <strong>di</strong> unità <strong>di</strong> terre. Questepossono essere geografizzate anche solo con un centroide. Nel caso siciliano, gli elementi territorialida indagare nel <strong>rilevamento</strong> GIS oriented sono stati delineati, al fine <strong>di</strong> favorire la loro identificazionein campagna e la collocazione <strong>dei</strong> profili da scavare.La tabella degli attributi degli elementi territoriali presente nel geodatabase è dunque la tabellaCT_UT, componenti territoriali delle unità <strong>di</strong> terre, che risiede nel CNCP_b.mdb (tab. 2.8). I campidella tabella CT_UT sono i seguenti: il numero <strong>di</strong> poligono, il co<strong>di</strong>ce della regione pedologicasemantica, il co<strong>di</strong>ce del sistema <strong>di</strong> terre semantico, il co<strong>di</strong>ce del sottosistema <strong>di</strong> terre semantico, ilco<strong>di</strong>ce identificativo dell’unità <strong>di</strong> terre, il co<strong>di</strong>ce dell’elemento territoriale, dato dalla combinazione<strong>dei</strong> successivi co<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> fisiografia, elemento morfologico, litologia e uso del suolo, la percentuale<strong>di</strong> superficie del poligono coperta dalla componente territoriale e infine la sua area.46
LE BANCHE DATI GEOGRAFICHE47Esempio19000016legendaRiferimentoTabella 2.7. Tabella degli attributi delle unità <strong>di</strong> terre.Co<strong>di</strong>ce Tipo Descrizione-POLY _ID Numerico Progressivo numerico che in<strong>di</strong>vidua univocamenteogni poligono62.2SR_ID Testo Co<strong>di</strong>ce della soil region semantica Tabella Sr_table del SoilRegion.mdb etabella soil_region del CNCP_b.mdb423AMMA4120ST_ID Testo Co<strong>di</strong>ce del sistema <strong>di</strong> terre semantico Legenda originale specificaST500_2007.mdb o tabella deco<strong>di</strong>fiche delCNCP_b.mdbFAXXAFXXTabella Deco<strong>di</strong>fiche del CNCP_b.mdb,SST_ID Testo Co<strong>di</strong>ce del sottosistema <strong>di</strong> terre semanticospecie_tabella FISIOGR_FORMASUBSTRATO e USO_SSTFAXXDAPPAFXX4120Tabella Deco<strong>di</strong>fiche del CNCP_b.mdb,specie_tabella FISIOGR_FORMA,ELEM_MORF, SUBSTRATO e USO_SSTUT_ID Testo Co<strong>di</strong>ce dell’unità <strong>di</strong> terre, dato dalla combinazione<strong>di</strong> 8 co<strong>di</strong>ci: SST_FRPR, SST_FRSEC, UT_ELPR;UT_ELSEC; SST_LITPR, SST_LISEC,SST_USUO1 e SST_USUO2FATabella Deco<strong>di</strong>fiche del CNCP_b.mdb,specie_tabella FISIOGR_FORMACome sopraprincipaleFisiografiaTestoUT_FRPRXXUT_FRSEC Testo Fisiografia secondaria (in<strong>di</strong>cata come XX se nonpresente)DATabella Deco<strong>di</strong>fiche del CNCP_b.mdb,specie_tabella ELEM_MORFCome sopraUT_ELPR Testo Elemento morfologico principalePPUT_ELSEC Testo Elemento morfologico secondario (in<strong>di</strong>cato comeXX se non presente)Tabella Deco<strong>di</strong>fiche del CNCP_b.mdb, AFspecie_tabella SUBSTRATOCome sopra XXprincipaleLitologiaTestoUT_LITPRUT_LISEC Testo Litologia secondaria (in<strong>di</strong>cata come XX se nonpresente)41CNCP_b.mdb,Tabella Deco<strong>di</strong>fiche delspecie_tabella USO_SSTCome sopraprincipalesuolodelUsoTestoUT_USUO120UT_USUO2 Testo Uso del suolo secondario (in<strong>di</strong>cato come XX se nonpresente)
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICITabella 2.8. Tabella degli attributi degli elementi territoriali, cioè delle componenti territoriali delle unità <strong>di</strong> terre.Co<strong>di</strong>ce Tipo DescrizioneRiferimento legendaEsempio19000016-62.2POLY _ID Numerico Progressivo numerico che in<strong>di</strong>viduaunivocamente ogni poligonoTabella Sr_table del SoilRegion.mdb e tabellasoil_region del CNCP_b.mdbLegenda originale specifica ST500_2007.mdb o tabelladeco<strong>di</strong>fiche del CNCP_b.mdb423AMMA4120SR_ID Testo Co<strong>di</strong>ce della soil region semanticaST_ID Testo Co<strong>di</strong>ce del sistema <strong>di</strong> terre semanticoFAXXAFXXTabella Deco<strong>di</strong>fiche del CNCP_b.mdb, specie_tabellaFISIOGR_FORMA SUBSTRATO e USO_SSTFAXXDAPPAFXX4120SST_ID Testo Co<strong>di</strong>ce del sottosistema <strong>di</strong> terresemanticoUT_ID Testo Co<strong>di</strong>ce dell’unità <strong>di</strong> terreFISIOGR_FORMA, ELEM_MORF, SUBSTRATO eUSO_SSTsopraCometerritorialecomponenteogni<strong>di</strong>Co<strong>di</strong>ceTestoET_IDFAPPAF41FATabella Deco<strong>di</strong>fiche del CNCP_b.mdb, specie_tabellaFISIOGR_FORMAMORFO Testo Co<strong>di</strong>ce fisiografico della componenteterritorialePPTabella Deco<strong>di</strong>fiche del CNCP_b.mdb, specie_tabellaELEM_MORFEL_MORFO Testo Co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> elemento morfologico dellacomponente territorialeAFTabella Deco<strong>di</strong>fiche del CNCP_b.mdb, specie_tabellaSUBSTRATO41LITO Testo Co<strong>di</strong>ce litologico della componenteterritorialeTabella Deco<strong>di</strong>fiche del CNCP_b.mdb, specie_tabellaUSO_SST95Tabella Deco<strong>di</strong>fiche del CNCP_b.mdb, specie_tabellaUSO Testo Co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> uso del suolo dellacomponente territoriale-CT_PERC Numerico Percentuale <strong>di</strong> superficie del poligonocoperta dalla componente territoriale-187AREA_HA Numerico Area in ettari <strong>di</strong> superficie del poligonocoperta dalla componente territoriale48
LE BANCHE DATI GEOGRAFICHE2.7 I co<strong>di</strong>ci geograficiDi seguito si riportano le tabelle <strong>di</strong> deco<strong>di</strong>fica <strong>dei</strong> co<strong>di</strong>ci utilizzati per tutti i livelli geografici,eccettuati quelli <strong>dei</strong> sottosistemi <strong>di</strong> terre, delle unità <strong>di</strong> terre ed elementi territoriali, poichécoincidono con i co<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> <strong>rilevamento</strong> in campo. Per le deco<strong>di</strong>fiche della fisiografia <strong>dei</strong>sottosistemi <strong>di</strong> terre, delle unità <strong>di</strong> terre e degli elementi territoriali si rimanda alla tab. 4.9 delcapitolo successivo. Per le deco<strong>di</strong>fiche dell’elemento morfologico delle unità <strong>di</strong> terre e deglielementi territoriali si rimanda alla tab. 4.10; per le deco<strong>di</strong>fiche della litologia <strong>dei</strong> sottosistemi <strong>di</strong>terre, delle unità <strong>di</strong> terre e degli elementi territoriali alle tabelle 4.14 e 4.15. La tabella 2.12 relativaalla fisiografia <strong>dei</strong> sistemi <strong>di</strong> terre non è esaustiva, ma riporta lo stato attuale delle conoscenze.Tabella 2.9 Deco<strong>di</strong>fica <strong>dei</strong> co<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> soil region presente nella tabella soil_region del CNCP_b.mdb.SOIL_REG Nome16.4 Appennino centrale su rocce carbonatiche e conche intramontane16.5 Alpi carniche18.7 Langhe, Monferrato e colline del Po18.8 Pianura Padana e colline moreniche del Piemonte e della Lombar<strong>di</strong>a34.2 Alpi occidentali su rocce se<strong>di</strong>mentarie calcaree34.3 Alpi centrali e orientali su rocce se<strong>di</strong>mentarie calcaree35.4 Colline friulane su rocce se<strong>di</strong>mentarie calcaree35.6 Alpi marittime35.7 Aree più elevate dell'Appennino settentrionale37.1 Alpi occidentali e centrali con rocce ignee e metamorfiche37.3 Alpi occidentali su rocce metamorfiche56.1 Aree collinari vulcaniche dell'Italia centrale e meri<strong>di</strong>onale59.1 Aree collinari della Sardegna su rocce basiche59.2 Rilievi montani e collinari della Sardegna su rocce in prevalenza cristalline acide59.7 Aree collinari e montane con formazioni calcaree e coperture vulcaniche con pianureincluse dell'Italia meri<strong>di</strong>onale59.8 Aree collinari della Sardegna sulle effusioni basaltiche e trachitiche59.9 Aree collinari e montane con formazioni calcaree e vulcaniti della Sicilia sud-orientale60.4 Dorsali antiappenniniche toscane60.7 Pianure costiere tirreniche dell'Italia centrale e colline incluse61.1 Rilievi appenninici e antiappenninici dell'Italia centrale e meri<strong>di</strong>onale su roccese<strong>di</strong>mentarie61.3 Colline dell'Italia centrale e meri<strong>di</strong>onale su se<strong>di</strong>menti pliocenici e pleistocenici62.1 Tavoliere e piane <strong>di</strong> Metaponto, del tarantino e del brin<strong>di</strong>sino62.2 Aree collinari e pianure costiere siciliane62.3 Aree collinari e montane della Calabria e della Sicilia con pianure incluse64.4 Versilia e pianure interne della Toscana, Umbria e Lazio66.4 Monte Etna66.5 Rilievi appenninici calabresi e siciliani su rocce ignee e metamorfiche67.2 Carso67.4 Rilievi montani e collinari della Sardegna su rocce metamorfiche72.2 Murge e Salento72.3 Gargano76.1 Campidano e altre piane del Sulcis e della Sardegna centrale78.1 Colline emiliano-romagnole e marchigiane sul flysch miocenico e margine appenninico78.2 Appennino settentrionale e centrale49
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICITabella 2.10. Deco<strong>di</strong>fica <strong>dei</strong> co<strong>di</strong>ci climatici usati nella tabella soil_region del CNCP_b.mdb.CODICETipoDescrizione32 Clima da temperato caldo oceanico a temperato caldosuboceanico, parzialmente subme<strong>di</strong>terraneoPrecipitazioni da me<strong>di</strong>e ad elevate con deficit in estate, inverno mite ed estatecalda, periodo vegetativo da 180 a più <strong>di</strong> 210 giorni33 C lima temperato suboceanicoPrecipitazioni da me<strong>di</strong>e a ( p arzialmente) elevate, inverno moderatamente freddoed estate moderatamente calda, periodo vegetativo da 180 a più <strong>di</strong> 210 giorni37 Clima temperato caldo subcontinentale Precipitazioni da me<strong>di</strong>e ad elevate, temperature e periodo vegetativo Dipendentidall’altitu<strong>di</strong>ne, inverno freddo ed estati da moderatamente calde a calde, periodovegetativo da 180 a più <strong>di</strong> 210 giorni38C lima temperato montanoPrecipitazioni da me<strong>di</strong>e ad elevate, temperature e periodo vegetativo <strong>di</strong>pendentidall’altitu<strong>di</strong>ne (da temperato a boreale), inverno da freddo a molto freddo edestate da moderatamente fredda a moderatamente calda41 Clima da me<strong>di</strong>terraneo a temperato caldo Precipitazioni da me<strong>di</strong>e ad elevate, inverni con temperature sotto lo zero, in estateperiodo secco molto breve, in parte senza periodo secco42 Clima da me<strong>di</strong>terraneo oceanico a me<strong>di</strong>terraneosuboceanico, parzialmente montano43 Clima da me<strong>di</strong>terraneo-subcontinentale ame<strong>di</strong>terraneo-continentalePrecipitazioni da me<strong>di</strong>e ad elevate in autunno, inverno e primavera, soloregionalmente un breve periodo secco in estatePrecipitazioni da me<strong>di</strong>e a molto basse in primavera, autunno e inverno, lungoperiodo secco in estate, parzialmente arido, inverno freddo ed estate torrida44 Clima da me<strong>di</strong>terraneo a subtropicale Precipitazioni molto basse durante tutto l’anno, inverno temperato ed estate calda,in parte torrida e arida, in parte con clima montano45Climame<strong>di</strong>terraneomontanoPrecipitazioni da me<strong>di</strong>e a<strong>di</strong>pendenti dall’altitu<strong>di</strong>neparzialmenteelevate,temperatureeperiodovegetativo50
LE BANCHE DATI GEOGRAFICHETabella 2.11. Deco<strong>di</strong>fica <strong>dei</strong> co<strong>di</strong>ci litologici usati nella tabella soil_region del CNCP_b.mdb.LITOCODE Descrizione1 Depositi quaternari marini, in parte con sabbie eoliche2 Depositi fluviali3 Depositi glaciali5 Rocce se<strong>di</strong>mentarie terziarie (in<strong>di</strong>fferenziate)8 Rocce se<strong>di</strong>mentarie mesozoiche (in<strong>di</strong>fferenziate)10 Rocce se<strong>di</strong>mentarie calcaree11 Rocce ignee e metamorfiche12 Alternanza <strong>di</strong> rocce ignee, metamorfiche e se<strong>di</strong>mentarieTabella 2.12. Deco<strong>di</strong>fica <strong>dei</strong> co<strong>di</strong>ci fisiografia <strong>dei</strong> sistemi <strong>di</strong> terre (provvisoria).Co<strong>di</strong>ce Descrizione0 Sconosciuto1 Altopiani <strong>di</strong> bassa montagna con drenaggio subparallelo2 Altopiani e bassa montagna a debole pendenza con drenaggio subdendritico3 Aree pedemontane degli e<strong>di</strong>fici vulcanici a bassa pendenza o pianeggianti, a drenaggio subparallelo4 Aree lagunari costiere con cordoni dunali e drenaggio artificiale arginato5 Aree pianeggianti e depresse <strong>di</strong> bonifica idraulica con drenaggio artificiale6 Bassa collina a pendenza bassa e me<strong>di</strong>a con drenaggio subparallelo7 Bassa collina a pendenza me<strong>di</strong>a con drenaggio subdendritico8 Bassa e me<strong>di</strong>a collina a bassa e me<strong>di</strong>a pendenza e drenaggio subdendritico9 Bassa e me<strong>di</strong>a collina a pendenza bassa e me<strong>di</strong>a con drenaggio subparallelo10 Bassa e me<strong>di</strong>a collina a pendenza me<strong>di</strong>a e drenaggio subparallelo11 Bassa e me<strong>di</strong>a collina e terrazzi sommitali incisi con drenaggio da subdendritico a subparallelo12 Rilievi <strong>di</strong> alta collina e bassa montagna ad alta pendenza con drenaggio da subdendritico a subparallelo13 Basse colline e forme <strong>di</strong> aggradazione (terrazzi, conoi<strong>di</strong>, ecc.) con drenaggio da subparallelo a subdendritico a bassa pendenza14 Rilievi <strong>di</strong> me<strong>di</strong>a e alta collina a me<strong>di</strong>a pendenza con drenaggio angolare16 Colline e altopiani carsificati con drenaggio a doline17 Colline e ripiani carsificati a bassa e me<strong>di</strong>a pendenza con drenaggio a doline18 Conche <strong>di</strong> riempimento complesso (carsico e alluvio-colluviale)19 Conche <strong>di</strong> riempimento complesso (carsico, fluvio-lacustre ed alluvio-colluviale)20 Conche montane <strong>di</strong> riempimento complesso (carsico, fluvio-lacustre ed alluvio-colluviale)21 Piana alluvionale con conoi<strong>di</strong>, falde <strong>di</strong> detrito e depositi <strong>di</strong> frana22 E<strong>di</strong>fici vulcanici isolati a me<strong>di</strong>a e alta pendenza51
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICI23 Fon<strong>di</strong>valle con drenaggio meandriforme24 Fon<strong>di</strong>valle, aree pianeggianti e depresse <strong>di</strong> bonifica idraulica con drenaggio artificiale25 Fon<strong>di</strong>valle, terrazzi e forme <strong>di</strong> aggradazione a bassa pendenza, con drenaggio subparallelo26 Fondovalle alluvionale27 Fondovalle alluvionale con drenaggio prevalentemente meandriforme e subor<strong>di</strong>natamente intrecciato28 Glacis d'accumulo, terrazzi incisi, me<strong>di</strong>e e alte colline a pendenza me<strong>di</strong>a con drenaggio subdendritico e subparallelo29 Piana alluvionale a forte influenza vulcanica30 Piana alluvionale con drenaggio meandriforme31 Piana alluvionale e terrazzi alluvionali32 Piana costiera con cordoni dunali e drenaggio artificiale rettificato33 Piana costiera con cordoni dunali e dune terrazzate a drenaggio artificiale rettificato e/o arginato34 Piana costiera con cordoni dunali e dune terrazzate e incise con drenaggio subparallelo35 Piana pedemontana <strong>di</strong> apparato vulcanico36 Piane in conche intermontane37 Piane in conche intermontane con conoi<strong>di</strong> coalescenti38 Piana glaciale39 Rilievi <strong>di</strong> alta montagna ad alta pendenza con forme carsiche40 Versanti e altopiani <strong>di</strong> alta quota con drenaggio scarsamente evoluto o assente41 Rilievi <strong>di</strong> alta collina a me<strong>di</strong>a pendenza con drenaggio subdendritico42 Rilievi <strong>di</strong> alta collina a me<strong>di</strong>a pendenza con drenaggio subparallelo43 Rilievi <strong>di</strong> alta collina a pendenza me<strong>di</strong>a con rilievi isolati e ripiani con drenaggio angolare44 Rilievi <strong>di</strong> bassa e alta collina ad alta pendenza con drenaggio subparallelo45 Rilievi <strong>di</strong> alta collina e bassa montagna a me<strong>di</strong>a e alta pendenza con drenaggio angolare46 Rilievi <strong>di</strong> alta collina e bassa montagna a me<strong>di</strong>a pendenza con drenaggio angolare47 Rilievi <strong>di</strong> alta collina e bassa montagna a me<strong>di</strong>a pendenza con drenaggio subdendritico48 Rilievi <strong>di</strong> alta collina e bassa montagna a me<strong>di</strong>a pendenza con drenaggio subparallelo49 Rilievi <strong>di</strong> alta montagna ad alta pendenza con drenaggio subparallelo50 Rilievi <strong>di</strong> bassa e alta montagna a me<strong>di</strong>a pendenza con drenaggio subparallelo51 Rilievi <strong>di</strong> bassa e alta montagna a me<strong>di</strong>a e alta pendenza con drenaggio subparallelo52 Rilievi <strong>di</strong> alta montagna ad alta pendenza con drenaggio subparallelo o angolare53 Rilievi <strong>di</strong> alta montagna ad alta pendenza e scoscesi con drenaggio angolare54 Rilievi <strong>di</strong> alta montagna ad alta pendenza e scoscesi con drenaggio da <strong>di</strong>sor<strong>di</strong>nato ad angolare55 Rilievi <strong>di</strong> bassa collina a bassa e me<strong>di</strong>a pendenza con drenaggio angolare56 Rilievi <strong>di</strong> bassa collina a bassa e me<strong>di</strong>a pendenza con drenaggio subdendritico57 Piana alluvionale con terrazzi e conoi<strong>di</strong>58 Rilievi <strong>di</strong> bassa collina e bassa pendenza con drenaggio subdendritico52
LE BANCHE DATI GEOGRAFICHE59 Rilievi <strong>di</strong> bassa e alta montagna ad alta pendenza e scoscesi con drenaggio da angolare a subparallelo60 Rilievi <strong>di</strong> bassa montagna ad alta pendenza e scoscesi con drenaggio da subparallelo ad angolare61 Rilievi <strong>di</strong> bassa montagna a me<strong>di</strong>a e alta pendenza con colline e drenaggio angolare62 Rilievi <strong>di</strong> alta collina e bassa montagna a me<strong>di</strong>a e alta pendenza con drenaggio parallelo63 Rilievi <strong>di</strong> bassa e me<strong>di</strong>a collina a bassa e me<strong>di</strong>a pendenza con drenaggio subdendritico64 Rilievi <strong>di</strong> bassa e me<strong>di</strong>a collina a me<strong>di</strong>a pendenza con drenaggio subdendritico65 Rilievi <strong>di</strong> bassa e me<strong>di</strong>a collina con scarpate e superfici strutturali sommitali66 Rilievi <strong>di</strong> bassa e alta montagna ad alta pendenza e scoscesi con drenaggio subdendritico e angolare67 Rilievi <strong>di</strong> bassa montagna ad alta pendenza con drenaggio subparallelo68 Rilievi <strong>di</strong> bassa montagna a debole e me<strong>di</strong>a pendenza con drenaggio subparallelo69 Rilievi <strong>di</strong> bassa montagna a me<strong>di</strong>a e alta pendenza con drenaggio subdendritico70 Rilievi <strong>di</strong> bassa montagna a me<strong>di</strong>a e alta pendenza con drenaggio subparallelo71 Rilievi <strong>di</strong> bassa montagna e alta collina a me<strong>di</strong>a e alta pendenza con ripiani con drenaggio subparallelo72 Rilievi <strong>di</strong> bassa montagna a me<strong>di</strong>a ed alta pendenza con drenaggio subparallelo o parallelo73 Rilievi <strong>di</strong> bassa montagna a me<strong>di</strong>a ed alta pendenza con forme carsiche e drenaggio <strong>di</strong>sor<strong>di</strong>nato74 Rilievi <strong>di</strong> alta collina e bassa montagna a me<strong>di</strong>a pendenza con drenaggio da subparallelo ad angolare75 Rilievi <strong>di</strong> bassa montagna (montano inferiore e superiore) ad alta pendenza e scoscesi con forme carsiche e drenaggio <strong>di</strong>sor<strong>di</strong>nato76 Rilievi <strong>di</strong> bassa montagna ad alta pendenza con drenaggio <strong>di</strong>sor<strong>di</strong>nato77 Rilievi <strong>di</strong> bassa montagna a me<strong>di</strong>a pendenza con drenaggio subdendritico78 Rilievi <strong>di</strong> bassa montagna a me<strong>di</strong>a pendenza con drenaggio subparallelo79 Rilievi <strong>di</strong> bassa montagna con ripiani a bassa e me<strong>di</strong>a pendenza con forme carsiche e drenaggio parallelo80 Rilievi <strong>di</strong> bassa montagna da bassa a me<strong>di</strong>a pendenza con drenaggio da subdendritico a subparallelo81 Rilievi <strong>di</strong> bassa montagna e alta collina a me<strong>di</strong>a ed alta pendenza con drenaggio da subdendritico a subparallelo82 Rilievi <strong>di</strong> bassa montagna e <strong>di</strong> alta collina a bassa pendenza con ripiani sommitali con drenaggio angolare o poco organizzato83 Rilievi <strong>di</strong> bassa, me<strong>di</strong>a e alta collina ad alta pendenza con drenaggio subparallelo84 Rilievi <strong>di</strong> me<strong>di</strong>a collina a me<strong>di</strong>a pendenza con drenaggio da subdendritico a subparallelo85 Rilievi <strong>di</strong> alta montagna ad alta pendenza con drenaggio angolare86 Rilievi <strong>di</strong> me<strong>di</strong>a e alta collina con forme carsiche a me<strong>di</strong>a pendenza con drenaggio <strong>di</strong>sor<strong>di</strong>nato87 Rilievi <strong>di</strong> alta collina a bassa e me<strong>di</strong>a pendenza con drenaggio subdendritico88 Rilievi <strong>di</strong> me<strong>di</strong>a e alta collina a me<strong>di</strong>a pendenza con drenaggio da subdendritico a subparallelo89 Rilievi <strong>di</strong> me<strong>di</strong>a e alta collina a me<strong>di</strong>a pendenza con drenaggio subdendritico90 Rilievi <strong>di</strong> alta collina e bassa montagna a me<strong>di</strong>a e alta pendenza con drenaggio subparallelo91 Rilievi <strong>di</strong> me<strong>di</strong>a e bassa collina a bassa e me<strong>di</strong>a pendenza con drenaggio dendritico92 Rilievi <strong>di</strong> me<strong>di</strong>a e bassa collina a me<strong>di</strong>a e alta pendenza con drenaggio da subdendritico a subparallelo93 Rilievi <strong>di</strong> me<strong>di</strong>a e bassa collina ad alta pendenza con drenaggio subdendritico94 Rilievi <strong>di</strong> alta collina e bassa montagna ad alta pendenza con drenaggio subparallelo53
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICI95 Rilievi <strong>di</strong> me<strong>di</strong>a ed alta collina a me<strong>di</strong>a pendenza con drenaggio dendritico96 Rilievi <strong>di</strong> me<strong>di</strong>a ed alta collina e basse colline a me<strong>di</strong>a pendenza con drenaggio subparallelo97 Rilievi montani ad alta pendenza con drenaggio ra<strong>di</strong>ale98 Rilievi vulcanici <strong>di</strong> alta montagna a pendenza me<strong>di</strong>a e scoscesi e bassa montagna a debole pendenza, con drenaggio scarsamente Espresso99 Rilievi <strong>di</strong> alta collina e bassa montagna ad alta pendenza e scoscesi con drenaggio da subparallelo ad angolare100 Rilievi vulcanici <strong>di</strong> bassa montagna a debole e me<strong>di</strong>a pendenza con drenaggio scarsamente evoluto101 Ripiani <strong>di</strong> bassa montagna a bassa pendenza con drenaggio subdendritico102 Ripiani <strong>di</strong> me<strong>di</strong>a quota103 Ripiani e basse colline a bassa pendenza con drenaggio subparallelo104 Ripiani e forme <strong>di</strong> aggradazione a bassa pendenza con rilievi collinari isolati a me<strong>di</strong>a pendenza105 Ripiani e versanti a bassa pendenza con drenaggio scarsamente evoluto106 Ripiani ed altopiani <strong>di</strong> me<strong>di</strong>a e alta collina e <strong>di</strong> bassa montagna con drenaggio rettangolare poco espresso107 Rilievi <strong>di</strong> bassa montagna ad alta pendenza con drenaggio angolare108 Superfici alluvionali terrazzate109 Superfici strutturali sostenute da depositi vulcanici110 Terrazzi alluvionali111 Terrazzi e ripiani112 Terrazzi incisi e ripiani113 Terrazzi marini incisi con drenaggio parallelo114 Terrazzi marini e piana costiera115 Terrazzi marini incisi116 Terrazzi marini debolmente incisi e piane costiere con cordoni dunali117 Terrazzi marini incisi e piane costiere118 Fondovalle alluvionale con conoi<strong>di</strong> e falde <strong>di</strong> detrito a me<strong>di</strong>a pendenza e me<strong>di</strong>a e alta quota, con tracce <strong>di</strong> glacializzazione119 Terrazzi strutturali con incisioni e drenaggio subparallelo120 Terrazzi, forme <strong>di</strong> aggradazione a bassa pendenza con drenaggio subparallelo121 Terrazzi, forme <strong>di</strong> aggradazione a bassa pendenza e basse colline con drenaggio subparallelo122 Rilievi <strong>di</strong> alta collina e bassa montagna ad alta pendenza con tracce <strong>di</strong> glacializzazione e drenaggio angolare123 Versanti <strong>di</strong> apparato vulcanico a bassa/me<strong>di</strong>a pendenza124 Versanti <strong>di</strong> apparato vulcanico prossimali al cratere a me<strong>di</strong>a/alta pendenza125 Versanti <strong>di</strong> apparato vulcanico prossimali alla caldera a me<strong>di</strong>a pendenza con drenaggio centrifugo126 Rilievi <strong>di</strong> bassa e alta montagna ad alta pendenza con drenaggio subparallelo o angolare127 Fon<strong>di</strong>valle, terrazzi e forme <strong>di</strong> aggradazione a me<strong>di</strong>a pendenza con drenaggio subparallelo128 Terrazzi fluvioglaciali con scarpate erosive e drenaggio subparallelo e incisioni a v129 Conoi<strong>di</strong> fluvioglaciali a debole convessità con drenaggio a canali anastomizzati130 Rilievi <strong>di</strong> bassa montagna ad alta pendenza con drenaggio parallelo54
LE BANCHE DATI GEOGRAFICHE131 Piana fluviale e/o fluvioglaciale a valle della linea delle risorgive con drenaggio meandriforme132 Piana fluviale in<strong>di</strong>fferenziata con evidenza <strong>di</strong> paleoalvei con drenaggio meandriforme133 Valli fluviali terrazzate incise nelle pianure fluviali e alvei drenanti con drenaggio a canali anastomizzati e meandriforme134 Piana alluvionale parzialmente incisa nella pianura e con locali terrazzamenti e alvei drenanti con drenaggio meandriforme135 Rilievi <strong>di</strong> me<strong>di</strong>a e alta collina a me<strong>di</strong>a ed alta pendenza con drenaggio da subdendritico a subparallelo136 Rilevi <strong>di</strong> bassa e alta montagna ad alta pendenza e bassa montagna a pendenza me<strong>di</strong>a, con drenaggio subparallelo137 Apparati deltizi e forme <strong>di</strong> deposito marino con drenaggio artificiale rettificato e <strong>di</strong> bonifica138 Piana alluvionale con alvei pensili con drenaggio da rettilineo a meandriforme139 Piana alluvionale con alvei pensili con drenaggio rettilineo140 Terrazzi rilevati sulla pianura, basculati in <strong>di</strong>rezione s_n con drenaggio subparallelo ed incisioni a v142 Rilievi <strong>di</strong> bassa e alta montagna a me<strong>di</strong>a pendenza con drenaggio dendritico, subdendritico e parallelo143 Spiagge attuali146 Piana alluvionale con incisioni fluviali a canali intrecciati, dossi e conoi<strong>di</strong>147 Piana alluvionale con drenaggio da intrecciato a meandriforme148 Piana alluvionale a valle della linea delle risorgive con drenaggio rettificato con dossi e incisioni fluviali149 Colline moreniche150 Bassa collina a pendenza me<strong>di</strong>a con drenaggio da subparallelo ad angolare151 Rilievi <strong>di</strong> me<strong>di</strong>a e alta collina a me<strong>di</strong>a e alta pendenza, a drenaggio angolare, con tracce <strong>di</strong> glacializzazione152 Bassa e me<strong>di</strong>a collina a pendenza me<strong>di</strong>a con drenaggio da subdendritico a subparallelo153 Rilievi <strong>di</strong> alta montagna ad alta pendenza e scoscesi con drenaggio ra<strong>di</strong>ale e morfologia glaciale154 Fondovalle alluvionale con conoi<strong>di</strong> e falde <strong>di</strong> detrito a me<strong>di</strong>a pendenza e me<strong>di</strong>a e alta quota155 Rilievi <strong>di</strong> bassa e alta montagna ad alta pendenza e scoscesi con fenomeni carsici156 Rilievi <strong>di</strong> alta collina e bassa montagna ad alta pendenza con drenaggio subdendritico157 Rilievi <strong>di</strong> alta collina e bassa montagna ad alta pendenza e scoscesi con tracce <strong>di</strong> glacializzazione e fenomeni carsici158 Rilievi <strong>di</strong> bassa e alta montagna ad alta pendenza e scoscesi con evidenti tracce <strong>di</strong> glacializzazione e drenaggio angolare159 Fondovalle alluvionale con conoi<strong>di</strong> e falde <strong>di</strong> detrito a bassa e me<strong>di</strong>a pendenza e me<strong>di</strong>a quota160 Alta collina e bassa montagna con forme <strong>di</strong> aggradazione (terrazzi, conoi<strong>di</strong>) a alta pendenza con drenaggio parallelo161 Rilievi <strong>di</strong> alta montagna ad alta pendenza e scoscesi con drenaggio angolare, evidenti tracce <strong>di</strong> glacializzazione e fenomeni carsici162 Rilievi <strong>di</strong> bassa e alta montagna ad alta pendenza e scoscesi con tracce <strong>di</strong> glacializzazione e drenaggio subparallelo163 Rilievi <strong>di</strong> me<strong>di</strong>a e alta collina a me<strong>di</strong>a e alta pendenza con drenaggio subparallelo164 Rilievi e altopiani <strong>di</strong> bassa e alta montagna da me<strong>di</strong>a ad alta pendenza con drenaggio da subparallelo ad angolare165 Rilievi <strong>di</strong> bassa e alta montagna ad alta pendenza con drenaggio da subdendritico a subparallelo166 Rilievi <strong>di</strong> bassa e alta montagna ad alta pendenza e scoscesi con tracce <strong>di</strong> glacializzazione e drenaggio subdendritico167 Piana alluvionale parzialmente incisa nella pianura e con alvei drenanti con drenaggio a canali anastomizzati e meandriforme168 Rilievi <strong>di</strong> alta collina e bassa montagna ad alta pendenza con drenaggio angolare169 Altopiani <strong>di</strong> me<strong>di</strong>a quota con drenaggio subparallelo55
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICI170 Terrazzi strutturali171 Terrazzi marini172 Altopiani <strong>di</strong> bassa montagna da bassa a me<strong>di</strong>a pendenza con forme carsiche e drenaggio <strong>di</strong>sor<strong>di</strong>nato173 Rilievi <strong>di</strong> me<strong>di</strong>a e alta collina carsificati a bassa e me<strong>di</strong>a pendenza174 Rilievi <strong>di</strong> alta collina e bassa montagna a me<strong>di</strong>a e alta pendenza carsificati con drenaggio a doline175 Conoi<strong>di</strong> e falde <strong>di</strong> detrito a me<strong>di</strong>a pendenza e me<strong>di</strong>a quota176 Piana costiera e cordoni dunali177 Rilievi <strong>di</strong> bassa montagna a me<strong>di</strong>a pendenza con drenaggio dendritico178 Piana alluvionale179 Rilievi <strong>di</strong> bassa montagna a me<strong>di</strong>a e alta pendenza con drenaggio da subparallelo ad angolare180 Rilievi <strong>di</strong> alta collina a me<strong>di</strong>a pendenza con drenaggio contorto181 Rilievi <strong>di</strong> alta collina a me<strong>di</strong>a e alta pendenza con drenaggio subparallelo182 Rilievi <strong>di</strong> bassa collina a pendenza bassa e me<strong>di</strong>a con drenaggio dendritico183 Bassa collina a pendenza me<strong>di</strong>a e alta con drenaggio da subparallelo ad angolare184 Bassa collina a pendenza me<strong>di</strong>a con drenaggio da subdendritico a subparallelo185 Rilievi <strong>di</strong> me<strong>di</strong>a collina a me<strong>di</strong>a pendenza con drenaggio subparallelo186 Rilievi <strong>di</strong> alta collina ad alta pendenza con drenaggio subparallelo187 Depressioni strutturali in settori <strong>di</strong> convergenza <strong>di</strong> versanti montani188 Rilievi <strong>di</strong> bassa montagna ad alta pendenza con drenaggio da subparallelo ad angolare189 Piana alluvionale incisa con conoi<strong>di</strong> fluvioglaciali190 Apparati deltizi e forme <strong>di</strong> deposito marino con alvei pensili e drenaggio da rettilineo a meandriforme191 Conoi<strong>di</strong> fluviali a debole convessità con drenaggio a canali anastomizzati e meandriforme192 Rilievi <strong>di</strong> alta montagna a alta pendenza e scoscesi con forme carsiche193 Rilievi <strong>di</strong> me<strong>di</strong>a e alta collina con forme carsiche a me<strong>di</strong>a e alta pendenza con drenaggio <strong>di</strong>sor<strong>di</strong>nato194 Ripiani e altopiani carsici <strong>di</strong> me<strong>di</strong>a quota ed aree <strong>di</strong> raccordo con altopiani <strong>di</strong> bassa montagna195 Rilievi <strong>di</strong> bassa e alta montagna ad alta pendenza con tracce <strong>di</strong> glacializzazione e drenaggio da angolare a subparallelo196 Rilievi <strong>di</strong> alta montagna ad alta pendenza e scoscesi con drenaggio subparallelo197 Rilievi <strong>di</strong> alta montagna ad alta pendenza e scoscesi con tracce <strong>di</strong> glacializzazione e drenaggio angolare198 Rilievi <strong>di</strong> bassa e alta montagna ad alta pendenza e scoscesi con drenaggio poco organizzato e angolare201 Rilievi <strong>di</strong> me<strong>di</strong>a e alta collina a pendenza me<strong>di</strong>a con drenaggio subparallelo202 Altopiani <strong>di</strong> alta quota con drenaggio subparallelo203 Conche <strong>di</strong> riempimento (alluvio-colluviale)204 Conoi<strong>di</strong> e falde <strong>di</strong> detrito a bassa pendenza e bassa quota205 Superfici subpianeggianti a bassa pendenza con reticolo idrografico subparallelo206 Superfici strutturali sostenute da depositi vulcanici con sommità tabulari e dorsali allungate con reticolo idrografico dendritico e incisioni a forra207 Caldera e versanti <strong>di</strong> apparati vulcanici a bassa e me<strong>di</strong>a pendenza e me<strong>di</strong>a quota, a drenaggio centrifugo e centripeto56
208 versanti <strong>di</strong> apparato vulcanico e caldere a pendenza da me<strong>di</strong>a ad alta con reticolo idrografico rispettivamente centrifugo e centripeto209 versanti a me<strong>di</strong>a pendenza <strong>di</strong> caldere vulcaniche coalescenti210 versanti irregolari a me<strong>di</strong>a e alta pendenza delle isole211 aree pianeggianti e depresse lagunari costiere212 terrazzi e ripiani <strong>di</strong> bassa quota a debole pendenza con drenaggio subparallelo213 colline costiere a bassa e me<strong>di</strong>a quota con versanti a bassa pendenza e drenaggio subparallelo214 rilievi <strong>di</strong> bassa e me<strong>di</strong>a collina a pendenza me<strong>di</strong>a con drenaggio dendritico215 rilievi <strong>di</strong> bassa e me<strong>di</strong>a collina a pendenza me<strong>di</strong>a e alta con drenaggio angolare216 Rilievi <strong>di</strong> bassa montagna ad alta pendenza e scoscesi con drenaggio da subdendritico ad angolato217 Rilievi <strong>di</strong> alta collina e bassa montagna a me<strong>di</strong>a e alta pendenza con drenaggio da angolato a <strong>di</strong>sor<strong>di</strong>nato218 Rilievi <strong>di</strong> bassa montagna ad alta pendenza con tracce <strong>di</strong> glacializzazione e drenaggio <strong>di</strong>sor<strong>di</strong>nato219 conche <strong>di</strong> riempimento complesso (carsico, fluvio-lacustre ed alluvio-colluviale) a drenaggio artificiale220 rilievi <strong>di</strong> me<strong>di</strong>a e alta collina a pendenza me<strong>di</strong>a e bassa montagna a pendenza me<strong>di</strong>a con drenaggio dendritico221 Rilievi <strong>di</strong> bassa montagna ad alta pendenza con drenaggio contorto222 rilievi <strong>di</strong> bassa e alta montagna a me<strong>di</strong>a ed alta pendenza, con drenaggio subparallelo e angolato223 Rilievi <strong>di</strong> alta montagna ad alta pendenza con tracce <strong>di</strong> glacializzazione e drenaggio da subparallelo ad angolato224 rilievi <strong>di</strong> bassa e me<strong>di</strong>a collina a pendenza me<strong>di</strong>a225 ripiani e versanti a bassa e me<strong>di</strong>a pendenza con drenaggio scarsamente evoluto o assente226 Versanti <strong>di</strong> bassa montagna a pendenza scoscesa con drenaggio subparallelo o contorto227 Rilievi <strong>di</strong> me<strong>di</strong>a e alta collina a me<strong>di</strong>a e alta pendenza con drenaggio subdendritico228 Rilievi costieri <strong>di</strong> bassa collina, a pendenza da bassa a me<strong>di</strong>a con drenaggio subparallelo229 Rilievi costieri <strong>di</strong> bassa collina, a pendenza da me<strong>di</strong>a ad alta con drenaggio da subparallelo a subdendritico230 Rilievi costieri <strong>di</strong> bassa e me<strong>di</strong>a collina, a pendenza da bassa a me<strong>di</strong>a con drenaggio subparallelo231 Rilievi costieri <strong>di</strong> bassa e me<strong>di</strong>a collina, a pendenza da me<strong>di</strong>a ad alta con drenaggio subparallelo232 Rilievi costieri <strong>di</strong> bassa e me<strong>di</strong>a collina, a pendenza da me<strong>di</strong>a ad alta con drenaggio da subparallelo a subdendritico233 Rilievi costieri <strong>di</strong> bassa e me<strong>di</strong>a collina, a pendenza da me<strong>di</strong>a ad alta con drenaggio subra<strong>di</strong>ale234 Rilievi costieri <strong>di</strong> bassa e me<strong>di</strong>a collina, a pendenza da me<strong>di</strong>a ad alta con drenaggio subparallelo che raccordano altopiani carsici con drenaggio a doline235 Rilievi costieri <strong>di</strong> bassa e me<strong>di</strong>a collina, a pendenza da me<strong>di</strong>a ad alta, con superfici <strong>di</strong> spianamento marino (terrazzi marini) a drenaggio subparallelo236 Rilievi costieri <strong>di</strong> bassa, me<strong>di</strong>a e alta collina a pendenza da alta a scoscesa (falesie) con drenaggio subparallelo237 Rilievi costieri <strong>di</strong> bassa, me<strong>di</strong>a e alta collina a pendenza me<strong>di</strong>a e alta, con drenaggio da subparallelo a subdendritico238 Rilievi <strong>di</strong> me<strong>di</strong>a ed alta collina a bassa e me<strong>di</strong>a pendenza con drenaggio da subparallelo a subdendritico239 Rilievi <strong>di</strong> bassa montagna a pendenza da me<strong>di</strong>a ad alta con ripiani strutturali e/o morfologici a bassa pendenza, drenaggio subdendritico240 Rilievi <strong>di</strong> bassa e alta montagna a pendenza da alta a scoscesa con drenaggio da subdendritico a subparallelo241 Rilievi <strong>di</strong> bassa e alta montagna a pendenza da alta a scoscesa con drenaggio subparallelo242 Piana alluvionale con drenaggio meandriforme e terrazzi alluvionali
243 Rilievi <strong>di</strong> me<strong>di</strong>a collina a bassa e me<strong>di</strong>a pendenza con drenaggio subparallelo244 Rilievi <strong>di</strong> alta montagna a me<strong>di</strong>a ed alta pendenza e drenaggio da subparallelo a subdendritico245 Rilievi <strong>di</strong> me<strong>di</strong>a e alta collina ad alta pendenza e drenaggio angolato246 Fon<strong>di</strong>valle e forme <strong>di</strong> aggradazione (terrazzi, conoi<strong>di</strong>, etc.) con drenaggio subparallelo a bassa e me<strong>di</strong>a pendenza247 Altopiani <strong>di</strong> bassa e alta montagna da bassa a me<strong>di</strong>a pendenza con forme carsiche e drenaggio <strong>di</strong>sor<strong>di</strong>nato248 Piana fluvio-glaciale249 Rilievi <strong>di</strong> bassa me<strong>di</strong>a e alta collina a pendenza me<strong>di</strong>a e alta con drenaggio angolato250 Piana alluvionale con dossi251 Piana deltizia252 Rilievi <strong>di</strong> me<strong>di</strong>a e alta collina ad alta pendenza con drenaggio subdendritico253 Bassa collina a pendenza me<strong>di</strong>a con drenaggio da subdendritico a subparallelo254 Rilievi <strong>di</strong> alta collina e bassa montagna a me<strong>di</strong>a e alta pendenza con con tracce <strong>di</strong> glacializzazione e drenaggio angolato255 Rilievi <strong>di</strong> bassa montagna a me<strong>di</strong>a e alta pendenza con colline, con tracce <strong>di</strong> glacializzazione e drenaggio angolato256 Rilievi <strong>di</strong> alta collina e bassa montagna a me<strong>di</strong>a e alta pendenza carsificati con drenaggio a doline304 versanti delle isole vulcaniche a me<strong>di</strong>a ed alta pendenza, con bocche o coni vulcanici305 versanti delle isole vulcaniche a pendenza bassa e me<strong>di</strong>a306 versanti delle isole a pendenza bassa e me<strong>di</strong>a con superfici strutturali e forme carsiche351 Aree depresse bonificate <strong>dei</strong> laghi costieri a drenaggio artificiale arginato e dune recenti352 Duna antica in parte terrazzata, a drenaggio artificiale rettificato353 Duna antica con incisioni e superfici a bassa e me<strong>di</strong>a pendenza354 Rilievi <strong>di</strong> bassa e me<strong>di</strong>a collina a pendenza bassa e me<strong>di</strong>a e drenaggio da subdendritico a subparallelo355 Superfici strutturali sostenute da depositi vulcanici molto incise con sommità tabulari strette e lunghe ed incisioni a forra356 Versanti delle incisioni profonde del plateaux vulcanico a pendenza me<strong>di</strong>a e bassa con scarpate sommitali357 Versanti delle incisioni profonde del plateaux vulcanico a pendenza me<strong>di</strong>a ed alta con scarpate sommitali358 Apparati vulcanici <strong>di</strong> alta collina e bassa montagna con caldera principale, coni o caldere secondarie e drenaggio centripeto o centrifugo360 Ripiani strutturali delle isole a bassa pendenza e pareti scoscese361 Versanti regolari delle isole con pendenza da bassa ad alta362 Versanti irregolari delle isole a me<strong>di</strong>a e alta pendenza o con pareti scoscese363 Rilievi <strong>di</strong> bassa e me<strong>di</strong>a collina a pendenza me<strong>di</strong>a e alta con drenaggio subdendritico364 Conche <strong>di</strong> riempimento complesso (carsico, fluvio-lacustre ed alluvio-colluviale) a drenaggio artificiale366 Rilievi <strong>di</strong> alta collina e bassa montagna con versanti ad alta pendenza o scoscesi e sommità a debole pendenza; drenaggio parallelo e subparallelo367 Rilievi <strong>di</strong> me<strong>di</strong>a e alta collina costituiti da superfici terrazzate subpianeggianti profondamente incise con versanti a me<strong>di</strong>a e alta pendenza e drenaggio subparallelo368 Rilievi <strong>di</strong> bassa e me<strong>di</strong>a collina a pendenza me<strong>di</strong>a e con frequenti scarpate sommitali che bordano crinali lunghi e stretti, drenaggio da subparallelo a subdendritico369 rilievi <strong>di</strong> me<strong>di</strong>a e alta collina a pendenza me<strong>di</strong>a e bassa, con drenaggio da subparallelo a subdendritico371 Ripiani incisi e forme <strong>di</strong> aggradazione a bassa pendenza
372 Rilievi <strong>di</strong> bassa e me<strong>di</strong>a collina a pendenza me<strong>di</strong>a e bassa, con drenaggio da subparallelo a subdendritico373 Rilievi <strong>di</strong> me<strong>di</strong>a e alta collina a pendenza me<strong>di</strong>a con drenaggio subdendritico374 Rilievi <strong>di</strong> bassa e me<strong>di</strong>a collina a pendenza me<strong>di</strong>a con falde <strong>di</strong> copertura detritica e drenaggio subparallelo375 Rilievi <strong>di</strong> bassa e me<strong>di</strong>a collina a pendenza me<strong>di</strong>a e alta e drenaggio da subdendritico a subparallelo376 Rilievi <strong>di</strong> bassa montagna con superfici strutturali a bassa o debole pendenza incise e talvolta terrazzate, con drenaggio subparallelo377 rilievi da bassa ad alta collina ad alta pendenza e drenaggio parallelo378 rilievi da bassa ad alta collina a pendenza me<strong>di</strong>a e alta e drenaggio parallelo e subparallelo379 Rilievi <strong>di</strong> bassa e me<strong>di</strong>a collina a me<strong>di</strong>a ed alta pendenza con forme carsiche e drenaggio <strong>di</strong>sor<strong>di</strong>nato380 Rilievi <strong>di</strong> alta collina e bassa montagna a me<strong>di</strong>a e alta pendenza, con drenaggio subparallelo e subdendritico381 Aree sommitali <strong>dei</strong> rilievi costituite da ripiani e altopiani carsici <strong>di</strong> me<strong>di</strong>a quota ed aree a debole o me<strong>di</strong>a pendenza384 Rilievi <strong>di</strong> bassa e alta montagna ad alta pendenza e scoscesi con drenaggio parallelo o subparallelo388 Rilievi <strong>di</strong> alta collina e bassa montagna a me<strong>di</strong>a e alta pendenza con forme carsiche e drenaggio <strong>di</strong>sor<strong>di</strong>nato389 Altopiani e rilievi <strong>di</strong> bassa montagna con drenaggio angolato390 Rilievi <strong>di</strong> alta montagna ad alta pendenza con drenaggio da <strong>di</strong>sor<strong>di</strong>nato ad angolato401 terrazzi e ripiani costieri incisi con drenaggio subparallelo e stretta fascia <strong>di</strong> pianura costiera402 aree costiere pianeggianti403 aree collinari costiere a me<strong>di</strong>a e alta pendenza con drenaggio da subparallelo a subdendritico404 rilievi <strong>di</strong> bassa, me<strong>di</strong>a collina e alta collina e drenaggio da subdendritico a subparallelo406 rilievi <strong>di</strong> alta collina a pendenza me<strong>di</strong>a e bassa montagna a pendenza me<strong>di</strong>a e alta, con drenaggio subparallelo407 rilievi <strong>di</strong> me<strong>di</strong>a e alta collina a pendenza me<strong>di</strong>a e <strong>di</strong> bassa montagna a pendenza me<strong>di</strong>a e alta, con drenaggio da subparallelo a subdendritico408 rilievi <strong>di</strong> me<strong>di</strong>a e alta collina a pendenza me<strong>di</strong>a e <strong>di</strong> bassa montagna a pendenza me<strong>di</strong>a, con drenaggio subdendritico409 rilievi <strong>di</strong> bassa, me<strong>di</strong>a e alta collina ad alta pendenza e bassa montagna ad alta pendenza, e con drenaggio subparallelo410 rilievi <strong>di</strong> me<strong>di</strong>a ed alta collina a pendenza me<strong>di</strong>a e drenaggio dendritico411 terrazzi e ripiani costieri profondamente incisi con drenaggio subparallelo413 aree costiere, terrazzi residuali incisi e versanti <strong>di</strong> bassa collina a me<strong>di</strong>a pendenza e drenaggio subdendritico414 rilievi <strong>di</strong> bassa montagna con pendenza me<strong>di</strong>a, alta o scoscesa, con drenaggio da subparallelo a subdendritico415 rilievi <strong>di</strong> bassa, me<strong>di</strong>a e alta collina a pendenza me<strong>di</strong>a, con drenaggio da subparallelo a subdendritico416 rilievi <strong>di</strong> alta collina e bassa montagna a pendenza me<strong>di</strong>a, con drenaggio da subdendritico a subparallelo417 rilievi <strong>di</strong> alta collina a pendenza me<strong>di</strong>a e <strong>di</strong> bassa montagna a pendenza me<strong>di</strong>a e alta, con drenaggio dendritico e subdendritico418 rilievi <strong>di</strong> me<strong>di</strong>a e alta collina a pendenza me<strong>di</strong>a e versanti a bassa pendenza e me<strong>di</strong>a quota, con drenaggio subdendritico419 versanti a bassa quota e bassa pendenza e rilievi collinari a bassa e me<strong>di</strong>a quota a me<strong>di</strong>a pendenza, con drenaggio subparallelo420 rilievi <strong>di</strong> bassa, me<strong>di</strong>a e alta collina a pendenza me<strong>di</strong>a, con sommità arrotondate o subpianeggianti, con drenaggio da subparallelo a subdendritico421 rilievi <strong>di</strong> bassa e me<strong>di</strong>a collina a me<strong>di</strong>a pendenza e versanti a bassa pendenza e me<strong>di</strong>a quota, con drenaggio subparallelo422 pianure costiere e versanti a bassa quota e bassa pendenza423 pianure fluviali <strong>di</strong> bassa quota, versanti a bassa pendenza e aree collinari a bassa quota e me<strong>di</strong>a pendenza, con drenaggio subparallelo
424 rilievi <strong>di</strong> bassa e me<strong>di</strong>a collina a me<strong>di</strong>a ed alta pendenza e superfici a bassa pendenza e bassa quota, con drenaggio da subparallelo ad angolare425 terrazzi marini con versanti <strong>di</strong> bordo scoscesi e con incisioni profonde a fondo piatto426 terrazzi costieri e rilievi <strong>di</strong> bassa collina a pendenza me<strong>di</strong>a debolmente incisi e con drenaggio parallelo e subparallelo427 pianure costiere parzialmente carsificate428 versanti <strong>di</strong> apparato vulcanico a me<strong>di</strong>a e alta quota a bassa e me<strong>di</strong>a pendenza, con drenaggio poco sviluppato subparallelo429 rilievi <strong>di</strong> bassa e me<strong>di</strong>a collina a me<strong>di</strong>a e alta pendenza, con drenaggio parallelo e subparallelo430 rilievi <strong>di</strong> bassa collina a me<strong>di</strong>a e alta pendenza con lembi <strong>di</strong> terrazzi sulle aree sommitali e aree <strong>di</strong> fondovalle, con drenaggio parallelo431 rilievi <strong>di</strong> bassa, me<strong>di</strong>a, alta collina e bassa montagna ad alta pendenza e con drenaggio parallelo e subparallelo432 rilievi <strong>di</strong> bassa, me<strong>di</strong>a e alta collina a me<strong>di</strong>a e alta pendenza con drenaggio subdendritico433 rilievi da bassa ad alta collina con sommità subpianeggianti o a pendenza me<strong>di</strong>a e versanti ad alta pendenza o scoscesi434 rilievi <strong>di</strong> me<strong>di</strong>a e alta collina a pendenza me<strong>di</strong>a e <strong>di</strong> bassa montagna a pendenza da me<strong>di</strong>a a scoscesa e drenaggio subparallelo435 rilievi da bassa ad alta collina a me<strong>di</strong>a e alta pendenza o scoscesi e bassa montagna a versanti scoscesi con drenaggio subparallelo436 rilievi <strong>di</strong> bassa e me<strong>di</strong>a collina con ripiani incisi a bassa e me<strong>di</strong>a pendenza e versanti a pendenza alta o scoscesi con drenaggio subparallelo437 rilievi <strong>di</strong> me<strong>di</strong>a e alta collina a me<strong>di</strong>a e alta pendenza e con drenaggio parallelo438 versanti <strong>di</strong> bassa e me<strong>di</strong>a quota a bassa pendenza e rilievi a bassa e me<strong>di</strong>a collina a me<strong>di</strong>a pendenza e drenaggio subdendritico439 rilievi <strong>di</strong> me<strong>di</strong>a e alta collina a pendenza me<strong>di</strong>a e bassa montagna a debole e me<strong>di</strong>a pendenza e drenaggio subdendritico440 rilievi <strong>di</strong> bassa e me<strong>di</strong>a collina a pendenza me<strong>di</strong>a e drenaggio subparallelo441 rilievi <strong>di</strong> me<strong>di</strong>a e alta collina a me<strong>di</strong>a pendenza e versanti a me<strong>di</strong>a quota e bassa pendenza e drenaggio da subparallelo a subdendritico442 rilievi <strong>di</strong> me<strong>di</strong>a e alta collina con ripiani incisi a bassa pendenza e versanti a me<strong>di</strong>a pendenza443 rilievi <strong>di</strong> alta collina e bassa montagna a pendenza me<strong>di</strong>a e con ripiani incisi sommitali <strong>di</strong> bassa montagna a debole e me<strong>di</strong>a pendenza444 ripiani a bassa e me<strong>di</strong>a pendenza con incisioni ad alta pendenza o scoscese e rilievi costituiti da ripiani erosi <strong>di</strong> bassa e me<strong>di</strong>a collina con versanti445 pianure <strong>di</strong> bassa quota, versanti <strong>di</strong> bassa quota a bassa pendenza e rilievi <strong>di</strong> bassa collina a pendenza me<strong>di</strong>a con drenaggio subparallelo446 pianure <strong>di</strong> bassa quota e versanti <strong>di</strong> bassa e me<strong>di</strong>a quota a bassa pendenza incisi, con drenaggio parallelo e subparallelo447 ripiani incisi <strong>di</strong> me<strong>di</strong>a quota pianeggianti o a bassa pendenza e aree <strong>di</strong> raccordo con altopiani <strong>di</strong> bassa montagna448 versanti delle incisioni delle superfici strutturali <strong>di</strong> me<strong>di</strong>a e alta collina a pendenza me<strong>di</strong>a e aree sommitali a pendenza bassa449 versanti delle incisioni delle superfici strutturali <strong>di</strong> me<strong>di</strong>a e alta collina a me<strong>di</strong>a e alta pendenza450 ripiani e versanti a bassa pendenza <strong>di</strong> me<strong>di</strong>a e alta collina con incisioni a me<strong>di</strong>a ed alta pendenza carsificate con drenaggio subparallelo451 versanti a bassa pendenza e superfici subpianeggianti <strong>di</strong> me<strong>di</strong>a e alta collina ed incisioni con versanti a me<strong>di</strong>a ed alta pendenza452 rilievi da bassa ad alta collina a me<strong>di</strong>a pendenza e versanti <strong>di</strong> bassa e me<strong>di</strong>a quota a bassa pendenza con drenaggio dendritico e subdendritico453 terrazzi marini <strong>di</strong>ssecati, con i versanti delle incisioni a me<strong>di</strong>a ed alta pendenza e drenaggio parallelo e subparallelo454 rilievi collinari <strong>di</strong> bassa e me<strong>di</strong>a quota con superfici sommitali <strong>di</strong> bassa e me<strong>di</strong>a quota a bassa pendenza e drenaggio parallelo e subparallelo455 rilievi <strong>di</strong> me<strong>di</strong>a e alta collina a me<strong>di</strong>a pendenza e versanti a bassa pendenza <strong>di</strong> me<strong>di</strong>a quota con drenaggio subdendritico456 rilievi <strong>di</strong> bassa e me<strong>di</strong>a collina a pendenza me<strong>di</strong>a con superfici residuali <strong>di</strong> terrazzi marini a bassa pendenza a bassa e me<strong>di</strong>a quota con drenaggio subparallelo457 rilievi <strong>di</strong> bassa e me<strong>di</strong>a collina a pendenza me<strong>di</strong>a e superfici terrazzate erose ed incise <strong>di</strong> bassa quota e bassa pendenza con drenaggio subparallelo458 rilievi <strong>di</strong> bassa e me<strong>di</strong>a collina a pendenza me<strong>di</strong>a e versanti a bassa pendenza e bassa quota con drenaggio subdendritico
459 rilievi <strong>di</strong> bassa e me<strong>di</strong>a collina a pendenza me<strong>di</strong>a e versanti <strong>di</strong> bassa e me<strong>di</strong>a quota a bassa pendenza con drenaggio subparallelo e subdendritico460 rilievi <strong>di</strong> me<strong>di</strong>a e alta collina a me<strong>di</strong>a pendenza, con drenaggio da subdendritico a subparallelo461 rilievi <strong>di</strong> bassa e me<strong>di</strong>a collina a pendenza me<strong>di</strong>a con drenaggio da subdendritico a subparallelo462 pianure costiere e superfici pianeggianti <strong>di</strong> abrasione marina464 superfici pianeggianti e versanti <strong>di</strong> bassa quota e <strong>di</strong> bassa pendenza465 pianure costiere con fondovalli e terrazzi pianeggianti e versanti a bassa pendenza e <strong>di</strong> bassa quota466 rilievi collinari <strong>di</strong> bassa e me<strong>di</strong>a quota a pendenza da me<strong>di</strong>a ad alta e drenaggio subparallelo467 rilievi collinari <strong>di</strong> me<strong>di</strong>a ed alta quota a me<strong>di</strong>a pendenza e <strong>di</strong> bassa montagna a me<strong>di</strong>a e alta pendenza con drenaggio subparallelo e subdendritico468 rilievi collinari da bassa ad alta quota a pendenza da me<strong>di</strong>a ad alta e drenaggio subparallelo469 rilievi collinari da bassa ad alta quota a pendenza me<strong>di</strong>a e drenaggio subdendritico e subparallelo470 pianure costiere a drenaggio artificiale rettificato e terrazzi marini residuali471 pianure costiere con cordoni dunali, fon<strong>di</strong>valle e terrazzi472 aree pedemontane degli e<strong>di</strong>fici vulcanici a bassa pendenza o pianeggianti, a drenaggio subparallelo473 rilievi <strong>di</strong> alta collina e bassa montagna ad alta pendenza e scoscesi con drenaggio da subdendritico a subparallelo474 piana alluvionale con drenaggio meandriforme in parte rettificato e terrazzi fluviali incisi475 piana costiera con drenaggio artificiale rettificato476 rilievi <strong>di</strong> alta collina a me<strong>di</strong>a pendenza con drenaggio subdendritico477 rilievi <strong>di</strong> bassa e me<strong>di</strong>a collina a me<strong>di</strong>a pendenza con drenaggio subdendritico e subparallelo478 rilievi <strong>di</strong> bassa e alta montagna a me<strong>di</strong>a e alta pendenza con drenaggio subparallelo479 versanti vulcanici <strong>di</strong> alta montagna a pendenza me<strong>di</strong>a e alta e aree scoscese, con drenaggio scarsamente sviluppato480 versanti vulcanici <strong>di</strong> bassa montagna a debole e me<strong>di</strong>a pendenza con piccoli coni vulcanici e drenaggio scarsamente evoluto481 ripiani e versanti pedemontani <strong>di</strong> apparato vulcanico a bassa e me<strong>di</strong>a pendenza e bassa e me<strong>di</strong>a quota con drenaggio parzialmente evoluto482 terrazzi incisi profondamente <strong>di</strong>ssecati e ripiani carsificati483 terrazzi marini debolmente incisi e degradanti verso il mare e piana costiera con cordoni dunali484 rilevi <strong>di</strong> bassa e alta montagna ad alta pendenza o scoscesa e <strong>di</strong> bassa montagna a pendenza me<strong>di</strong>a, localmente carsificati e con drenaggio subparallelo485 ripiani e versanti a bassa e me<strong>di</strong>a pendenza e bassa e me<strong>di</strong>a quota con drenaggio scarsamente evoluto486 terrazzi incisi e ripiani profondamente <strong>di</strong>ssecati487 terrazzi marini and coastal planes
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICITabella 2.13 Deco<strong>di</strong>fica <strong>dei</strong> co<strong>di</strong>ci relativi alle classi SOTER (mo<strong>di</strong>ficate) <strong>dei</strong> sistemi <strong>di</strong> terre.Pendenza(%)BassaCollina0-200Me<strong>di</strong>aCollina200-300Me<strong>di</strong>aCollina300-400Alta Collina400-600BassaMontagna600-1500AltaMontagna1500-30000-2 LP1 LP1 LP2 LP2 LL1 LL22-8 LF1 LF2 LF2 LF3 RL1 RL28-15 SH1 SH2 SH2 SH3 SU1 SU215-30 SH1 SH2 SH2 SH3 SM1 SM230-60 TH1 TH2 TH2 TH3 TM1 TM2>60 VH1 VH2 VH2 VH3 VM1 VM2Tabella 2.14 Deco<strong>di</strong>fica <strong>dei</strong> co<strong>di</strong>ci relativi agliagenti morfogenetici <strong>dei</strong> sistemi <strong>di</strong> terre.Co<strong>di</strong>ce Agente morfogeneticoA00W00E00F00P00M00S00C00G00V00BonificaDeposizione eolicaErosione idricaForme <strong>di</strong> fondovalleForme <strong>di</strong> origine fluvialeForme <strong>di</strong> origine marinaForme strutturaliProcessi carsiciProcessi glacialiProcessi vulcaniciTabella 2.15 Deco<strong>di</strong>fica <strong>dei</strong> co<strong>di</strong>ci relativi alla forma regionale (Nord Italia) <strong>dei</strong> sistemi <strong>di</strong> terre.Co<strong>di</strong>ce DescrizioneMO MorenePW Superfici terrazzate pedealpine pre-WurmTP Superfici terrazzate pedeappenniniche (pleistoceniche)TE Alta pianura pleistocenicaWE Me<strong>di</strong>a pianura pleistocenicaBE Bassa pianura pleistocenicaOI Reticolo idrografico olocenico incisoTO Alta pianura olocenicaBO Bassa pianura olocenicaPO Pianura a meandri del PoDU Pianura deltizia e litoranea, aree sotto l.m.m. e aree lagunariCE Colli EuganeiKA Carso60
Tabella 2.16. Deco<strong>di</strong>fica <strong>dei</strong> co<strong>di</strong>ci litologia <strong>dei</strong> sistemi <strong>di</strong> terre. (Substrato: ve<strong>di</strong> tabelle 4.14 e 4.15; composizione: ve<strong>di</strong> tabella 4.23).Co<strong>di</strong>ce Descrizione Deco<strong>di</strong>fica Substrato ComposizioneAA Depositi alluvionali, fluvio-lacustri, lacustri o fluvio-glaciali argillosi AF, AL, GLF, GLL AAAl Depositi alluvionali, fluvio-lacustri, lacustri o fluvio-glaciali argilloso-limosi AL, ALC, ALD, ALF, GLF, GLLAAs Depositi alluvionali, fluvio-lacustri, lacustri o fluvio-glaciali argilloso-sabbiosi AF, AL, GLF, GLL AAG Depositi alluvionali, fluvio-lacustri, lacustri o fluvio-glaciali ghiaiosi e conglomeratici AF, AL, ACC, AEC, AEG, AGG, FC, FG, FP, MEC, MEG,SEC, SEGAGl Depositi alluvionali, fluvio-lacustri, lacustri o fluvio-glaciali ghiaioso-limosi AF, AL, GLF, GLL MGG, MMGAGs Depositi alluvionali, fluvio-lacustri, lacustri o fluvio-glaciali ghiaioso-sabbiosi AF, AL, GLF, GLL SGG,SMGAL Depositi alluvionali, fluvio-lacustri, lacustri o fluvio-glaciali limosi AF, AL, GLF, GLL MALa Depositi alluvionali, fluvio-lacustri, lacustri o fluvio-glaciali limoso-argillosi AF, AL, GLF, GLL AAlg Depositi alluvionali, fluvio-lacustri, lacustri o fluvio-glaciali limoso-ghiaiosi AF, AL, GLF, GLL MGGALs Depositi alluvionali, fluvio-lacustri, lacustri o fluvio-glaciali limoso-sabbiosi AF, AL, GLF, GLL MAM Depositi alluvionali, fluvio-lacustri, lacustri o fluvio-glaciali a litologia mista AF, AFB, AFC, AFF, AFH, AFP, AL, AVA, GLF, GLLAR Dormazioni prevalentemente argillose SE1111, SE1107AS Depositi alluvionali, fluvio-lacustri, lacustri o fluvio-glaciali sabbiosi ALS, AF SASa Depositi alluvionali, fluvio-lacustri, lacustri o fluvio-glaciali sabbioso-argillosi AF, AL SASg Depositi alluvionali, fluvio-lacustri, lacustri o fluvio-glaciali sabbioso-ghiaiosi ALR, AF SGGASl Depositi alluvionali, fluvio-lacustri, lacustri o fluvio-glaciali sabbioso-limosi AF, AL SCA Formazioni prevalentemente calcaree, anidritiche o gessose ACB, SE1104, SE1109D, SE1110, SE2000, SE2100,SE2101, SE2101A, SE2101B, SE2101C, SE2101D,SE2102, SE2200, SE2201, SE2202, SE2203, SE2300,SE2301, SE2302CC Formazioni prevalentemente calcarenitiche SE1105DE Depositi eolici EO, EOF, EOS, EOL S, MDG Depositi glaciali e morenici GL, GLA, GLL, GLM, GLP, GLSDI Depositi superficiali incoerenti: depositi delle fasce pedemontane, depositi <strong>di</strong> versante CO, AV, CLT,CLD,AVG, CL, CF S,A,M, AGG,MEC, MEG,MMC, MGGDL Depositi litoranei e sublitoranei marini, alluvionali e deltizi prevalentemente sabbiosi o sabbiosolimosiC, G, CCAM, ACT, ACS, ACR, ACF, ACE, ACD, ACC , AC ACC, SDO Formazioni prevalentemente dolomitiche SE2103, SE2103ADR Depositi residuali e se<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> suolo RES, RED, REC, REDT Depositi limoso-argillosi e torbosi <strong>di</strong> depressione lagunare, retrodunale e deltizia, o <strong>di</strong> bonifica OT, OO, OF, AVP, APO, APM, AP, ACPEV Formazioni costituite prevalentemente da rocce effusive e vulcanoclastiche MAV306, MAV305, MAV304, MAV303, MAV302,MAV301, MAV300, MAV203, MAV202, MAV201,MAV200, MAV105, MAV104, MAV103, MAV102,MAV101, MAV100, MAV000, MAP203, MAP202,MAP201, MAP200, MAP102, MAP101, MAP100,MAP000, MA0000, DV, DR, DPP3, DPP2, DPP1, DPP,61
DPL, DPC, DP, DFFL Formazioni costituite da alternanze arenitico-pelitiche, marnoso-arenitiche e pelitico-arenitiche SE1106, SE1108, SE1108A, SE1108B, SE1108C, SE1108D,SE1108FFM Formazioni prevalentemente marnose, marnoso-pelitiche e pelitiche SE1108E, SE1108G, SE1109, SE1109A, SE1109B,SE1109CIS Formazioni costituite prevalentemente da alternanze <strong>di</strong> rocce ignee, metamorfiche e se<strong>di</strong>mentarie MES000, MES100IV Formazioni costituite prevalentemente da rocce intrusive e metamorfiche massive non calcaree MAI000, MAI100, MAI101, MAI102, MAI103, MAI104,MAI105, MAI106, MAI200, MAI201, MAI202, MAI203,MAI204, MAI205, MAI206MAI207, MEM000, MEM100, MEM101MA Se<strong>di</strong>menti marini argillosi AM, AMP AMAl Se<strong>di</strong>menti marini argilloso-limosi AM, AMP AMAs Se<strong>di</strong>menti marini argilloso-sabbiosi AM, AMP AMC Formazioni costituite prevalentemente da rocce metamorfiche calcaree MEC201, MES300, MES301, MES302, MET001MF Formazioni costituite prevalentemente da rocce metamorfiche scistose ME0000, MEM104, MES101, MES102, MES103MES201, MES303MG Se<strong>di</strong>menti marini ghiaiosi e conglomeratici AM, AMR ACC, AECAEG, AGGFC, FGFP, MECMEG, SECSEG, AECAEG, FCFG, FPMEC, MEGSEC, SEGMGl Se<strong>di</strong>menti marini ghiaioso-limosi (conglom-limosi) AM MCC, MECMGs Se<strong>di</strong>menti marini ghiaioso-sabbiosi (conglom-sabbiosi) AM, AMR SCC, SECML Se<strong>di</strong>menti marini limosi AM MMLa Se<strong>di</strong>menti marini limoso-argillosi AM, AMP AMLs Se<strong>di</strong>menti marini limoso-sabbiosi AM MMR Se<strong>di</strong>menti marini a litologia mista AMCMS Se<strong>di</strong>menti marini sabbiosi AM, AMS SMSa Se<strong>di</strong>menti marini sabbiosi sabbioso-argillosi AM SMSg Se<strong>di</strong>menti marini sabbiosi sabbioso-ghiaiosi AM, AMR SGG, SMGMSl Se<strong>di</strong>menti marini sabbiosi sabbioso-limosi AM, AMS SRU Formazioni costituite prevalentemente da rocce ru<strong>di</strong>tiche (ghiaie e conglomerati da parzialmentea molto cementati)SA Formazioni prevalentemente arenitiche (arenarie) SE1102, SE1103SE0000, SE1000, SE1100, SE110162
DPL, DPC, DP, DFFL Formazioni costituite da alternanze arenitico-pelitiche, marnoso-arenitiche e pelitico-arenitiche SE1106, SE1108, SE1108A, SE1108B, SE1108C, SE1108D,SE1108FFM Formazioni prevalentemente marnose, marnoso-pelitiche e pelitiche SE1108E, SE1108G, SE1109, SE1109A, SE1109B,SE1109CIS Formazioni costituite prevalentemente da alternanze <strong>di</strong> rocce ignee, metamorfiche e se<strong>di</strong>mentarie MES000, MES100IV Formazioni costituite prevalentemente da rocce intrusive e metamorfiche massive non calcaree MAI000, MAI100, MAI101, MAI102, MAI103, MAI104,MAI105, MAI106, MAI200, MAI201, MAI202, MAI203,MAI204, MAI205, MAI206MAI207, MEM000, MEM100, MEM101MA Se<strong>di</strong>menti marini argillosi AM, AMP AMAl Se<strong>di</strong>menti marini argilloso-limosi AM, AMP AMAs Se<strong>di</strong>menti marini argilloso-sabbiosi AM, AMP AMC Formazioni costituite prevalentemente da rocce metamorfiche calcaree MEC201, MES300, MES301, MES302, MET001MF Formazioni costituite prevalentemente da rocce metamorfiche scistose ME0000, MEM104, MES101, MES102, MES103MES201, MES303MG Se<strong>di</strong>menti marini ghiaiosi e conglomeratici AM, AMR ACC, AECAEG, AGGFC, FGFP, MECMEG, SECSEG, AECAEG, FCFG, FPMEC, MEGSEC, SEGMGl Se<strong>di</strong>menti marini ghiaioso-limosi (conglom-limosi) AM MCC, MECMGs Se<strong>di</strong>menti marini ghiaioso-sabbiosi (conglom-sabbiosi) AM, AMR SCC, SECML Se<strong>di</strong>menti marini limosi AM MMLa Se<strong>di</strong>menti marini limoso-argillosi AM, AMP AMLs Se<strong>di</strong>menti marini limoso-sabbiosi AM MMR Se<strong>di</strong>menti marini a litologia mista AMCMS Se<strong>di</strong>menti marini sabbiosi AM, AMS SMSa Se<strong>di</strong>menti marini sabbiosi sabbioso-argillosi AM SMSg Se<strong>di</strong>menti marini sabbiosi sabbioso-ghiaiosi AM, AMR SGG, SMGMSl Se<strong>di</strong>menti marini sabbiosi sabbioso-limosi AM, AMS SRU Formazioni costituite prevalentemente da rocce ru<strong>di</strong>tiche (ghiaie e conglomerati da parzialmentea molto cementati)SA Formazioni prevalentemente arenitiche (arenarie) SE1102, SE1103SE0000, SE1000, SE1100, SE110162
LE BANCHE DATI GEOGRAFICHETabella 2.17 Deco<strong>di</strong>fica <strong>dei</strong> co<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> uso del suolo <strong>dei</strong> sistemi <strong>di</strong> terre.Co<strong>di</strong>ce DescrizioneCorrispondenza co<strong>di</strong>ci Corine10 Attività extra-agricole111-112-121-122-123-124-131-20 Seminativi132-133-141-142211- 21231 Seminativi irrigui con risaie212- 21332 Risaie21340 Aree agricole eterogenee241-242-243-24441 Vigneti specializzati22142 Frutteti specializzati e colture permanenti da legno 222-22443 Oliveti specializzati22350 Prati stabili, prati-pascoli e pascoli 231- 32160 Aree con vegetazione rada o percorse da incen<strong>di</strong> 333-33461 Boschi <strong>di</strong> latifoglie31162 Boschi <strong>di</strong> conifere31263 Boschi misti31364 Brughiere e cespuglieti322-32465 Vegetazione sclerofila32370 Zone umide411-412-421-422-42380 Aree scoperte331-332-33590 Corpi idrici511-512-521-522-523Tabella 2.18 Deco<strong>di</strong>fica <strong>dei</strong> co<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> uso del suolo <strong>dei</strong> sottosistemi <strong>di</strong> terre, delle unità <strong>di</strong> terre e degli elementiterritoriali.Co<strong>di</strong>ce DescrizioneCorrispondenza co<strong>di</strong>ci Corine10 Attività extra-agricole111-112-121-122-123-124-131-20 Seminativi132-131-132-133-141-142211-21230 Seminativi irrigui212-21331 Seminativi irrigui con risaie212-21332 Risaie21340 Aree agricole eterogenee241-242-243-24441 Vigneti specializzati22142 Frutteti specializzati e colture permanenti da legno 222-22443 Oliveti specializzati22350 Prati stabili, prati-pascoli e pascoli 231- 32160 Aree in fase <strong>di</strong> rigenerazione della vegetazione 32461 Boschi <strong>di</strong> latifoglie31162 Boschi <strong>di</strong> conifere31263 Boschi misti31364 Brughiere e cespuglieti32265 Vegetazione sclerofila32366 Aree colpite da incen<strong>di</strong>o33467 Vegetazione rada33370 Zone umide411-412-421-422-42380 Aree scoperte331-332-33590 Corpi idrici511-512-521-522-52363
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICI3. Il software <strong>di</strong> <strong>informatizzazione</strong> <strong>dei</strong> <strong>dati</strong>M. Fantappiè, R. Barbetti, G. L’Abate, E. A. C. Costantini, S. MaginiIn<strong>di</strong>ce3.1 Introduzione.................................................................................................................................663.2 Il software CNCP.........................................................................................................................673.3 Il database CNCP_b.mdb.............................................................................................................683.3.1 Tabelle relative ai <strong>dati</strong> <strong>pedologici</strong> puntuali ........................................................................703.3.2 Tabelle relative alle tipologie .............................................................................................743.3.3 Tabelle relative ai <strong>dati</strong> areali...............................................................................................753.3.4 Altre tabelle relazionali.......................................................................................................753.4 Il motore CNCP_m.mdb..............................................................................................................763.4.1 Come iniziare......................................................................................................................773.4.2 Barra <strong>di</strong> START..................................................................................................................773.4.2.1 Gestione <strong>dei</strong> co<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> <strong>rilevamento</strong> ........................................................................773.4.2.2 Inserimento <strong>dei</strong> caratteri stazionali delle osservazioni pedologiche......................783.4.2.3 Inserimento <strong>dei</strong> caratteri relativi agli orizzonti delle osservazioni pedologiche ...883.4.2.4 Creazione ed inserimento delle UTS e STS ..........................................................933.4.2.5 Geografia .............................................................................................................1043.4.2.6 Meccanismi <strong>di</strong> attribuzione semantica delle osservazioni pedologiche ..............106Primo meccanismo <strong>di</strong> attribuzione (co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> atten<strong>di</strong>bilità o qualità 1) ..........................107Secondo meccanismo <strong>di</strong> attribuzione (co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> atten<strong>di</strong>bilità o qualità 2) ......................107Terzo meccanismo <strong>di</strong> attribuzione (co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> atten<strong>di</strong>bilità o qualità 3)...........................108Quarto meccanismo <strong>di</strong> attribuzione (co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> atten<strong>di</strong>bilità o qualità 4).........................109Quinto meccanismo <strong>di</strong> attribuzione (co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> atten<strong>di</strong>bilità o qualità 5).........................110Sesto meccanismo <strong>di</strong> attribuzione (co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> atten<strong>di</strong>bilità o qualità 6) ...........................1113.4.2.7 Meccanismi <strong>di</strong> attribuzione semantica delle STS................................................1113.4.3 Barra <strong>di</strong> menù ...................................................................................................................1133.4.3.1 Menù File.............................................................................................................113Carica <strong>dati</strong> esterni ............................................................................................................113Esporta .............................................................................................................................113Imposta stampante ...........................................................................................................113Anteprima <strong>di</strong> stampa........................................................................................................113Stampa .............................................................................................................................113Invia (x) ...........................................................................................................................113Esci ..................................................................................................................................113Importa.............................................................................................................................1133.4.3.2 Menù Gestioni .....................................................................................................114Aggiorna statistiche STS .................................................................................................114Aggiorna moda STS ........................................................................................................114Aggiorna moda UTS........................................................................................................114Deco<strong>di</strong>fiche......................................................................................................................114Meto<strong>di</strong> analitici................................................................................................................114Rilevatori .........................................................................................................................115Tipo <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>nate............................................................................................................115Tipo <strong>di</strong> analisi ..................................................................................................................11564
IL SOFTWARE DI INFORMATIZZAZIONE DEI DATIClassi <strong>di</strong> atten<strong>di</strong>bilità geografica .....................................................................................115Co<strong>di</strong>ci ISTAT <strong>dei</strong> comuni ...............................................................................................115Formazioni geologiche italiane........................................................................................115Regioni.............................................................................................................................115Gestioni foto STS ............................................................................................................1153.4.3.3 Menù stampe........................................................................................................115Anteprima UTS................................................................................................................115Anteprima STS ................................................................................................................115Anteprima profili .............................................................................................................116Stampa .............................................................................................................................116Crea PDF .........................................................................................................................1163.4.3.4 Menù Pedofunzioni..............................................................................................116AWC siti e analisi routinarie (Saxton).............................................................................116CSC analisi routinarie (Blume) .......................................................................................116Capacità depurativa siti....................................................................................................116Capacità protettiva siti .....................................................................................................117Permeabilità orizzonti (Rawls_Brakensiek) ....................................................................117Capacità d’uso siti e sottounità........................................................................................117Gruppo idrologico siti......................................................................................................117Interferenza climatica ......................................................................................................117Pedoclima siti...................................................................................................................117Rischio <strong>di</strong> incrostamento PRS .........................................................................................117Rischio <strong>di</strong> compattamento PRS .......................................................................................1173.4.3.5 Menù Utili............................................................................................................117Compatta DB ...................................................................................................................117Relazioni DB ...................................................................................................................117Filtro <strong>di</strong> ricerca ................................................................................................................117Fattori <strong>di</strong> conversione ......................................................................................................117Colori del suolo RGB ......................................................................................................117Statistiche descrittive (tab. siti e analisi) .........................................................................118Statistiche descrittive (tab. orizzonti) ..............................................................................118Calcolatrice......................................................................................................................118Diario Aggiornamenti......................................................................................................118Query correlazione...........................................................................................................1183.4.4 Moduli...............................................................................................................................1183.4.4.1 Determinazione delle osservazioni devianti per 1, 2 o 3 σ per i caratteri funzionalialla correlazione (modulo 2_sigma) ................................................................................1193.4.4.2 Calcolo delle classi tessiturale e granulometrica (modulo Classitessiturali).......1193.4.4.3 Determinazione del colore dell’orizzonte (modulo Colori_rgb) .........................1213.4.4.4 Determinazione della fertilità dell’orizzonte superficiale (modulo fertilità).......1213.4.4.5 Determinazione della classe <strong>di</strong> capacità d’uso e dell’interferenza climatica(modulo Funzione Capacità d’Uso).................................................................................1253.4.4.6 Controllo dell’inserimento <strong>dei</strong> <strong>dati</strong> (modulo Funzioni <strong>di</strong> controllo issds) ..........1253.4.4.7 Funzioni generali (modulo funzioni generali) .....................................................1253.4.4.8 Funzioni varie issds (modulo funzioni varie issds) .............................................125Funzione <strong>di</strong> conversione dal valore <strong>di</strong> conducibilità elettrica .........................................125Stima del pedoclima .......................................................................................................1263.4.4.9 Stima delle proprietà idrologiche <strong>dei</strong> <strong>dati</strong> <strong>pedologici</strong> puntuali (modulo Proprietàidrologiche)......................................................................................................................127Stima della conducibilità idraulica satura (permeabilità) ................................................12765
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICI3.4.4.10 Stima del rischio <strong>di</strong> incrostamento e compattamento superficiale e stima dellacapacità <strong>di</strong> scambio cationico (modulo PRS) ..................................................................127Stima del rischio <strong>di</strong> incrostamento superficiale...............................................................127Stima del rischio <strong>di</strong> compattamento superficiale.............................................................129Stima della C.S.C.............................................................................................................1293.4.4.11 Capacità depurativa e capacità protettiva nei confronti delle acque profonde(modulo qualità derivate).................................................................................................130Funzione proposta dalla Regione Emilia Romagna.........................................................130Funzione proposta dall’Ente Regionale <strong>di</strong> Sviluppo Agricolo della Regione Lombar<strong>di</strong>a.........................................................................................................................................1313.4.4.12 Relazione agronomica (moduli Issds e Xrapp_agronomico).............................1333.5 Il geodatabase CNCP_g.mdb.....................................................................................................1363.5.1 Il geodatabase in ArcGIS..................................................................................................1363.6 Possibili errori............................................................................................................................1393.6.1 Cosa fare se i file CNCP_m.mdb, CNCP_b.mdb o CNCP_g.mdb non si aprono............1393.6.2 Cosa fare se il CNCP_g.mdb o CNCP_m.mdb non si aprono correttamente richiamando ariferimenti <strong>di</strong> librerie mancanti..................................................................................................1393.6.3 Cosa fare se il CNCP_m.mdb va in crash.........................................................................1403.6.4 Il software in Microsoft Office Access 2007....................................................................1403.1 IntroduzioneLa <strong>di</strong>ffusione dell’uso <strong>dei</strong> sistemi informativi geografici (GIS) e <strong>dei</strong> database ha cambiatora<strong>di</strong>calmente la produzione <strong>di</strong> carte pedologiche e derivate. Non solo, come è stato spiegato neicapitoli precedenti del presente manuale, in molti casi è cambiata l’impostazione stessa del<strong>rilevamento</strong> pedologico. Infatti, l’utilizzazione degli strumenti informatici da parte del gestoredell’informazione pedologica porta alla creazione <strong>di</strong> un sistema informativo pedologico dal qualericavare in ogni momento tutte le informazioni territoriali desiderate in termini numerici, logici ecartografici; un sistema aperto a nuove immissioni <strong>di</strong> <strong>dati</strong>, che consente sempre nuove elaborazionied è compatibile con i GIS messi a punto da altri settori delle amministrazioni pubbliche. Il sistemasi articola fondamentalmente in due settori principali: il database e il GIS, ovvero il database <strong>dei</strong><strong>dati</strong> puntuali e tipologici e il geodatabase <strong>dei</strong> <strong>dati</strong> areali.Come è noto, gli stu<strong>di</strong> <strong>pedologici</strong> comportano l’acquisizione <strong>di</strong> un gran numero <strong>di</strong>informazioni, <strong>di</strong>fficilmente gestibile con i <strong>meto<strong>di</strong></strong> tra<strong>di</strong>zionali. Il CNCP è un sistema <strong>di</strong> gestione <strong>di</strong>database operante in Access 2000 ed Access XP progettato dal Centro Nazionale <strong>di</strong> CartografiaPedologica dell'Istituto Sperimentale per lo Stu<strong>di</strong>o e la Difesa del Suolo <strong>di</strong> Firenze (attualmenteCRA-ABP, Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura, Centro <strong>di</strong> ricerca perl’agrobiologia e la pedologia). Il sistema aggiorna le precedenti versioni del software (ISSDS97,CNCP2001, CNCP2003) (Gar<strong>di</strong>n et al., 1996), già largamente sperimentate in Italia, facilitando lacorrelazione a livello nazionale e regionale e la creazione delle UTS (unità tipologiche <strong>di</strong>suolo) e STS (sottounità tipologiche <strong>di</strong> suolo). Come nelle versioni precedenti, l’applicazioneCNCP è stata creata per la raccolta e la gestione <strong>dei</strong> <strong>dati</strong> <strong>pedologici</strong> puntuali (profili, trivellate,pozzetti e osservazioni spe<strong>di</strong>tive), areali (delineazioni cartografiche <strong>dei</strong> pedopaesaggi a <strong>di</strong>versascala) e tipologici (unità e sottounità tipologiche <strong>di</strong> suolo).Il CNCP riprende alcuni principi sviluppati nel Database Georeferenziato <strong>dei</strong> Suoli Europei(Finke et al., 1999). Il modello è spaziale, dal momento che gli oggetti che lo compongono sonocollocati nello spazio, ma non è strettamente “cartografico”, nel senso che i <strong>dati</strong> areali non sono66
IL SOFTWARE DI INFORMATIZZAZIONE DEI DATInecessariamente cartografati, ma possono essere consultati <strong>di</strong>rettamente anche dal formato <strong>di</strong>gitale.La traduzione cartografica è comunque sempre possibile e rimane un “output” prioritario.Per l’utilizzo del CNCP sono necessari il software Access (Microsoft Office 2000) o superiori eil software ArcGIS 8.2 o superiori. La scelta <strong>di</strong> Access ed ArcGIS come ambienti per lo sviluppodel database e del geodatabase è stata fatta per la loro larga <strong>di</strong>ffusione commerciale e per la facilitàdel loro uso, la struttura della banca <strong>dati</strong> è comunque traducibile in altri sistemi, anche open source.3.2 Il software CNCPIl software CNCP è composto da tre componenti: la banca <strong>dati</strong> CNCP_b.mdb (ve<strong>di</strong> par. 3.3) e duegestionali: il CNCP_m.mdb (ve<strong>di</strong> par. 3.4) e il CNCP_g.mdb (ve<strong>di</strong> par. 3.5). Il CNCP_m.mdb(database management system) è un motore, cioè un’interfaccia utente per l’immissione <strong>dei</strong> <strong>dati</strong> ela loro visualizzazione. Il CNCP_m.mdb, per mezzo degli appositi strumenti messi a <strong>di</strong>sposizioneda Access (Query, Schede, Report, Macro e Moduli), permette l’applicazione responsabiledell’architettura del sistema e la gestione delle tabelle <strong>di</strong> residenza <strong>dei</strong> <strong>dati</strong>. Il CNCP_g.mdb(geodatabase) invece consente <strong>di</strong> gestire la componente geografica, in quanto è il contenitore dovesi archiviano i <strong>dati</strong> areali (cioè i pedopaesaggi alle varie scale: regioni pedologiche, sistemi <strong>di</strong> terre,sottosistemi <strong>di</strong> terre e unità <strong>di</strong> terre) e dove gli stessi possono essere interrogati. Il fileCNCP_b.mdb è il contenitore <strong>dei</strong> <strong>dati</strong> <strong>pedologici</strong> puntuali e tipologici e delle relazioni con i <strong>dati</strong>areali. I <strong>dati</strong> <strong>pedologici</strong> possono essere gestiti o <strong>di</strong>rettamente dalle tabelle del databaseCNCP_b.mdb oppure attraverso l’utilizzo del motore CNCP_m.mdb.Grazie alla configurazione del CNCP numerosi computer presenti in rete possono lavorarepuntando sulla stessa banca <strong>dati</strong>. Infatti la banca <strong>dati</strong> comune CNCP_b.mdb può risiedere su <strong>di</strong> ununico computer presente in rete, mentre il CNCP_m.mdb può essere installato su tutti i computer,ognuno <strong>dei</strong> quali può “puntare” sulla stessa banca <strong>dati</strong> CNCP_b.mdb.L’architettura concettuale del CNCP si basa su un modello <strong>di</strong> tipo Entità-Relazione (ER) checonsente <strong>di</strong> raccogliere informazioni sulle singole entità e sul rapporto fra <strong>di</strong> esse (Gar<strong>di</strong>n et al.,1996) ed è rappresentata in figura 3.1, dove sono raffigurate come rettangoli le principali entità e comerombi le principali relazioni e le tabelle relazionali. Sono evidenziate in grassetto gli oggettiresidenti nel software CNCP. La pedoteca, l’archivio delle sezioni sottili, l’archivio delle schede el’archivio fotografico non sono evidenziati in quanto sono oggetti esterni al software CNCP.Nel CNCP_g.mdb risiedono le entità areali, cioè le feature classes delle regioni pedologiche,<strong>dei</strong> sistemi <strong>di</strong> terre, <strong>dei</strong> sottosistemi <strong>di</strong> terre e delle unità <strong>di</strong> terre. I vari livelli geografici sono legatisemanticamente (ve<strong>di</strong> cap. 2).Il software CNCP consente le seguenti funzioni:1) archiviazione e interrogazione <strong>dei</strong> <strong>dati</strong> areali;2) archiviazione <strong>dei</strong> <strong>dati</strong> <strong>pedologici</strong> puntuali;3) correlazione pedologica volta alla elaborazione delle UTS e STS;4) stampa <strong>dei</strong> profili, delle UTS e delle STS in versione prosaica;5) gestione <strong>dei</strong> <strong>dati</strong> tramite pedofunzioni preconfigurate e/o tramite le normali funzioni <strong>di</strong>Access (filtri e query);6) archiviazione della collocazione <strong>dei</strong> materiali relativi ai <strong>dati</strong> <strong>pedologici</strong>: schede <strong>di</strong><strong>rilevamento</strong>, schede analitiche, campioni <strong>di</strong> suolo, sezioni sottili e fotografie.Caricando il geodatabase CNCP_g.mdb in ArcMap è possibile attivare le funzioni <strong>di</strong> archiviazionee interrogazione <strong>dei</strong> <strong>dati</strong> areali (ve<strong>di</strong> par. 3.5). All’archiviazione <strong>dei</strong> <strong>dati</strong> areali (feature classes)segue l’importazione delle tabelle degli attributi nel CNCP_b.mdb. La funzione <strong>di</strong> archiviazione <strong>dei</strong>67
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICI<strong>dati</strong> puntuali si realizza tramite l’inserimento <strong>dei</strong> <strong>dati</strong> nelle tabelle co<strong>di</strong>ci_<strong>rilevamento</strong>, siti,orizzonti, analisi_routinarie e analisi_extra del CNCP_b.mdb, che può avvenire in forma <strong>di</strong>retta otramite l’ausilio del motore CNCP_m.mdb. La funzione <strong>di</strong> correlazione pedologica si realizzatramite l’attribuzione <strong>dei</strong> <strong>dati</strong> <strong>pedologici</strong> puntuali alle componenti territoriali <strong>dei</strong> pedopaesaggi esuccessiva aggregazione <strong>di</strong> osservazioni simili in ambienti simili (ve<strong>di</strong> cap. 1).Il software CNCP permette quin<strong>di</strong> <strong>di</strong> elaborare le statistiche delle STS e UTS, i cui risultatisono archiviati nelle tabelle unita, sottounita, Orizz_funzionali e Orizz_funzionali_extra. Il legamefra i <strong>dati</strong> <strong>pedologici</strong> puntuali e le elaborazioni tipologiche si realizza tramite la tabella relazionalesiti_su che permette <strong>di</strong> avere una relazione <strong>di</strong> tipo uno a molti, cosicché i <strong>dati</strong> <strong>pedologici</strong> puntualipossono essere raggruppati secondo <strong>di</strong>versi livelli <strong>di</strong> generalizzazione. La relazione fra i <strong>dati</strong><strong>pedologici</strong> puntuali e i <strong>dati</strong> areali si realizza tramite le tabelle relazionaliGeo_legame_osservazioni_st, Geo_legame_osservazioni_sst e Geo_legame_osservazioni_ut, in cuii <strong>dati</strong> <strong>pedologici</strong> puntuali sono legati a quelli areali tramite i poligoni <strong>di</strong> appartenenza geografica.La relazione fra le STS e i <strong>dati</strong> areali si realizza tramite le tabelle relazionali Geo_legame_sts_st,Geo_legame_sts_sst e Geo_legame_sts_ut, in cui le STS sono legate ai <strong>dati</strong> areali tramite i poligoni<strong>di</strong> appartenenza geografica. Le STS sono legate ai <strong>dati</strong> areali anche tramite le tabelle relazionaliCT-ST_STS, CT-SST_STS e CT-UT_STS, in cui le STS sono legate ai <strong>dati</strong> areali tramite lecomponenti territoriali <strong>di</strong> attribuzione semantica (fig. 3.1).La funzione <strong>di</strong> archiviazione della collocazione fisica (stanza, scaffale, ecc.) delle schede <strong>di</strong><strong>rilevamento</strong>, schede analitiche, campioni <strong>di</strong> suolo e sezioni sottili si realizza tramite la tabellarelazionale collocazione, che mette in relazione le tabelle Co<strong>di</strong>ci <strong>rilevamento</strong>, siti e Orizzonti con irelativi archivi esterni al CNCP: archivio delle schede <strong>di</strong> <strong>rilevamento</strong>, archivio delle schede <strong>di</strong>analisi, pedoteca e archivio delle sezioni sottili.3.3 Il database CNCP_b.mdbPer spiegare la struttura tabellare della banca <strong>dati</strong> CNCP_b.mdb si riporta in figura 3.2 la schermatarelativa alle relazioni che esistono fra le sue principali tabelle (a cui si può accedere tramite il menùStrumenti del CNCP_b.mdb) raggruppate in riquadri <strong>di</strong> <strong>di</strong>versi colori. Vi sono, infatti, tre tipi <strong>di</strong>tabelle: le tabelle delle entità, le tabelle relazionali e le tabelle descriventi. Nelle tabelle delle entitàsono contenuti gli oggetti del CNCP e il loro attributi. Gli oggetti del software CNCP sono i <strong>dati</strong><strong>pedologici</strong> puntuali, i <strong>dati</strong> tipologici e quelli areali (feature classes). Nel CNCP_b.mdb sonopresenti fisicamente le tabelle relative agli oggetti <strong>pedologici</strong> puntuali e loro attributi (riquadromarrone) e quelle relative agli oggetti tipologici e loro attributi (riquadro verde). Gli oggetti fisiciareali, feature classes, e relative tabelle degli attributi sono contenuti nel CNCP_g.mdb e non nelCncp_b.mdb, in cui sono presenti, invece, le corrispondenti tabelle delle componenti territoriali(riquadro arancione). Le tabelle relazionali descrivono le relazioni esistenti: fra gli oggetti interni alCNCP_b.mdb (ad esempio, sito_su che relaziona siti e sottounita evidenziata con riquadro giallo);fra gli oggetti interni al CNCP_b.mdb e gli oggetti areali del CNCP_g.mdb (riquadro azzurro); fragli oggetti interni al CNCP_b.mdb e gli altri oggetti esterni, quali la pedoteca, l’archivio dellesezioni sottili, l’archivio delle schede e l’archivio fotografico (riquadri in viola). Le tabelledescriventi sono quelle che contengono i co<strong>di</strong>ci predefiniti usati nel software CNCP. Poiché nontutte le tabelle del CNCP_b.mdb sono raffigurate in figura 3.2, si fornisce anche una tabellariassuntiva <strong>di</strong> tutte le tabelle presenti in banca <strong>dati</strong> e delle relative funzionalità (tab. 3.1).68
IL SOFTWARE DI INFORMATIZZAZIONE DEI DATIPedoteca e archivio delle sezioni sottilicollocazionequalificanoAnalisi routinarieCo<strong>di</strong>ci <strong>rilevamento</strong>Orizzontianalisi_extra_noteArchivi delle schedecollocazionein<strong>di</strong>viduanoAnalisi_extrasiticompongonosi aggreganoFoto_profilisito_suqualificanoOrizz_funzionaliArchivio fotograficofoto_susottounitàcompongonounitaGeo_legame_osservazioni_utunità <strong>di</strong> terre(features)descritteCT_UTCT-UT_STSGeo_legame_sts_utGeo_legame_osservazioni_sstGeo_legame_sts_sstlegatesemanticamentesottosistemi<strong>di</strong> terre(features)descrittiCT_SSTCT-SST_STSGeo_legame_osservazioni_stGeo_legame_sts_stlegatisemanticamentesistemi <strong>di</strong>terre(features)descrittiCT_STCT-ST_STSlegatisemanticamenteregionipedologiche(features)Figura 3.1. Schema concettuale del software CNCP69
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICI3.3.1 Tabelle relative ai <strong>dati</strong> <strong>pedologici</strong> puntualiLe principali tabelle relative ai <strong>dati</strong> <strong>pedologici</strong> puntuali sono evidenziate dal riquadro marronenella figura 3.2. La tabella entità principale è la tabella siti, in cui vengono inseriti i <strong>dati</strong> relativi allastazione <strong>di</strong> <strong>rilevamento</strong> (profilo, trivellata, pozzetto, osservazione spe<strong>di</strong>tiva). Ogni <strong>rilevamento</strong> èdefinito univocamente dai tre campi: co<strong>di</strong>ce_<strong>rilevamento</strong>, tipo_osservazione enumero_osservazione. L’elenco <strong>dei</strong> co<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> <strong>rilevamento</strong> è inserito nella tabella Co<strong>di</strong>ci <strong>rilevamento</strong>ed esiste una relazione <strong>di</strong> tipo uno a molti fra il campo Rilev_id della tabella Co<strong>di</strong>ci <strong>rilevamento</strong> e ilcampo co<strong>di</strong>ce_<strong>rilevamento</strong> della tabella siti. Perché l’oggetto <strong>dati</strong> <strong>pedologici</strong> puntuali sia unoggetto geografico è strettamente necessario e obbligatorio che per ogni osservazione siano inseritele coor<strong>di</strong>nate e il relativo sistema <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>nate nella tabella siti. La localizzazione geograficapermette <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare per ogni osservazione i poligoni <strong>di</strong> sistema, sottosistema e unità <strong>di</strong> terre <strong>di</strong>appartenenza geografica, che vanno inseriti nei campi Poly_geo_st, Poly_geo_sst e Poly_geo_utdella tabella siti. Questi sono i campi che permettono la relazione fra l’oggetto pedologico puntualee quello areale, che si realizza attraverso le tabelle <strong>di</strong> relazione Geo_legame_osservazioni_st,Geo_legame_osservazioni_sst e Geo_legame_osservazioni_ut (fig. 3.2, riquadro azzurro).I <strong>dati</strong> relativi agli orizzonti vengono inseriti nella tabella Orizzonti. Ogni orizzonte è definitounivocamente dai quattro campi: co<strong>di</strong>ce_<strong>rilevamento</strong>, tipo_osservazione, numero_osservazione,numero_orizzonte. Fra la tripletta <strong>di</strong> co<strong>di</strong>ce_<strong>rilevamento</strong>, tipo_osservazione, numero_osservazionedella tabella siti e i corrispondenti campi della tabella Orizzonti esiste una relazione <strong>di</strong> uno a molti.I <strong>dati</strong> relativi alle analisi del suolo effettuate vengono inseriti nelle tabelle Analisi routinarie,Analisi routinarie metodologie e Analisi_extra. Ogni set <strong>di</strong> analisi routinarie è definitounivocamente dai cinque campi: co<strong>di</strong>ce_<strong>rilevamento</strong>, tipo_osservazione, numero_osservazione,numero_orizzonte e numero_analisi. Il numero_analisi è stato inserito in quanto è prevista lapossibilità <strong>di</strong> effettuare ripetizioni delle stesse analisi sugli stessi orizzonti. La tabellaAnalisi_extra_note è una tabella relazionale fra la tabella Orizzonti e la tabella Analisi_extra nellaquale si possono in<strong>di</strong>care il tipo <strong>di</strong> orizzonte e lo spessore <strong>di</strong> suolo analizzato tramite il limitesuperiore e inferiore. In analisi_extra si può inserire un set <strong>di</strong> analisi variabile e facilmenteintegrabile con tipologie <strong>di</strong> analisi anche non convenzionali.Per la correlazione tipologica, cioè per l’elaborazione delle tipologie <strong>di</strong> suolo, è necessarioattribuire ad ogni osservazione la componente territoriale <strong>di</strong> appartenenza semantica, ricavandola apartire dai <strong>dati</strong> <strong>di</strong> fisiografia, substrato e uso del suolo rilevati in campagna e inserendola neirelativi campi della tabella siti: CT_st, CT_sst e CT_ut. Non è necessario che questa siariconosciuta nel poligono <strong>di</strong> appartenenza geografica (ve<strong>di</strong> par. 3.4.2.6).70
IL SOFTWARE DI INFORMATIZZAZIONE DEI DATIFigura 3.2. Schema fisico semplificato del CNCP_b.mdb.71
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICITabella 3.1. Nome delle tabelle presenti nel CNCP_b e rispettive funzionalità.Nome FunzionalitàTABELLE DELLE ENTITÁARCHIVIAZIONE DEI DATI PEDOLOGICI PUNTUALICo<strong>di</strong>ci <strong>rilevamento</strong> Co<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> <strong>rilevamento</strong>SitiDatistazionaridelleosservazioniRilevatori Co<strong>di</strong>fica <strong>dei</strong> rilevatori che hanno eseguito e descritto in campo le osservazioniOrizzonti Dati relativi agli orizzonti delle osservazioni pedologichepH_NAF_campo Stima in campagna del pH degli orizzonti eseguita col NaFAnalisi routinarie Dati <strong>di</strong> analisi del suolo routinarieAnalisi routinarie metodologie Meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> analisi routinarie utilizzatiAnalisi_extra Dati <strong>di</strong> analisi del suolo extra routinarie e relativi <strong>meto<strong>di</strong></strong>Campioni Tipi <strong>di</strong> campionamenti del suolo effettuati per ogni orizzontecap_uso_siti Classi <strong>di</strong> capacità d’uso delle osservazionicrustability_siti Valutazione del rischio <strong>di</strong> incrostamento delle osservazioniARCHIVIAZIONE DELLE ELABORAZIONI TIPOLOGICHESottunita Nome, tipo e <strong>dati</strong> stazionari modali delle sottounità tipologiche <strong>di</strong> suoloUnitaNome,tipoe<strong>dati</strong>paesaggisticimodalidelleunitàtipologicheOrizz_funzionali Statistiche (me<strong>di</strong>a, deviazione standard e numerosità campionaria) delle analisi del suolo routinarie e dellestime <strong>di</strong> campo relative agli orizzonti funzionali delle sottounità tipologiche <strong>di</strong> suoloOrizz_funzionali_extra Statistiche (me<strong>di</strong>a, deviazione standard e numerosità campionaria) delle analisi del suolo extra routinarierelative agli orizzonti funzionali delle sottounità tipologiche <strong>di</strong> suolo_flagCaratteri funzionali alla correlazione per ogni sottounità tipologica <strong>di</strong> suoloAttitu<strong>di</strong>ni Classi attitu<strong>di</strong>nali <strong>di</strong> ogni sottounità tipologica <strong>di</strong> suoloARCHIVIAZIONE DEGLI ATTRIBUTI DEI DATI AREALICT_STComponenti territoriali <strong>dei</strong> poligoni <strong>di</strong> sistema <strong>di</strong> terre con le relative soil region semanticheCT_SSTComponenti territoriali <strong>dei</strong> poligoni <strong>di</strong> sottosistema <strong>di</strong> terre con relativa semantica <strong>dei</strong> sistemi <strong>di</strong> terre e regione pedologicaC T_UTComponenti territoriali <strong>dei</strong> poligoni <strong>di</strong> unità <strong>di</strong> terre c on relativa semantica <strong>dei</strong> sottosistemi <strong>di</strong> terre,sistemi <strong>di</strong> terre e regione pedologicaTABELLE RELAZIONALIRELAZIONI FRA OGGETTI INTERNI AL CNCP_banalisi_extra_note Relazioni uno a molti fra gli orizzonti e le analisi extra routinariesiti_suRelazioni uno a molti fra i <strong>dati</strong> <strong>pedologici</strong> puntuali e le tipologieRELAZIONI FRA I DATI PEDOLOGICI PUNTUALI E LE TIPOLOGIE (OGGETTI INTERNI AL CNCP_b) E L’ARCHIVIOFOTOGRAFICO (OGGETTO ESTERNO SIA AL CNCP_b CHE AL CNCP)<strong>di</strong>suolo72
IL SOFTWARE DI INFORMATIZZAZIONE DEI DATIFoto_profiliCollegamenti ipertestuali fra i <strong>dati</strong> <strong>pedologici</strong> puntuali e l’archivio fotograficoRELAZIONI FRA I DATI PEDOLOGICI PUNTUALI (OGGETTO INTERNO AL CNCP_b) E LA PEDOTECA(OGGETTO ESTERNO SIA AL CNCP_b CHE AL CNCP)Collocazionecollocazione delle schede <strong>di</strong> <strong>rilevamento</strong>, delle schede <strong>di</strong> analisi, <strong>dei</strong> campioni <strong>di</strong> suolo e delle sezioni sottili,in relazione ai lotti <strong>di</strong> <strong>rilevamento</strong>, ai <strong>dati</strong> <strong>pedologici</strong> puntuali e/o ai singoli orizzontiRELAZIONI FRA I DATI PEDOLOGICI PUNTUALI E LE TIPOLOGIE (OGGETTI INTERNI AL CNCP_b) E I DATI AREALI(OGGETTIESTERNI AL CNCP_b MA INTERNI AL CNCP)Geo_legame_osservazioni_st Localizzazione geografica <strong>dei</strong> <strong>dati</strong> <strong>pedologici</strong> puntuali nei poligoni <strong>di</strong> sistema <strong>di</strong> terre e attribuzione semantica<strong>dei</strong> <strong>dati</strong> <strong>pedologici</strong> puntuali alla componente territoriale <strong>dei</strong> sistemi <strong>di</strong> terre, con relativo livello <strong>di</strong> attribuzioneGeo_legame_osservazioni_sst Localizzazione geografica <strong>dei</strong> <strong>dati</strong> pe dologici puntuali nei poligoni <strong>di</strong> sottosistema <strong>di</strong> terre e attr ibuzione semantica<strong>dei</strong> <strong>dati</strong> <strong>pedologici</strong> puntuali alla componente territoriale <strong>dei</strong> sottosistemi <strong>di</strong> terre, con relativo livello <strong>di</strong> attribuzioneGeo_legame_osservazioni_ut Localizzazione geografica <strong>dei</strong> <strong>dati</strong> <strong>pedologici</strong> puntuali nei poligoni <strong>di</strong> unità <strong>di</strong> terre e attribuzione semantica<strong>dei</strong> <strong>dati</strong> <strong>pedologici</strong> puntuali alla componente territoriale delle unità <strong>di</strong> terre, con relativo livello <strong>di</strong> attribuzioneGeo_legame_sts_stGeo_legame_sts_sstCT-ST_STSCT-SST_STSCT-UT_STSTABELLE DESCRIVENTIAtten<strong>di</strong>bilitàCoor<strong>di</strong>nateComuniDeco<strong>di</strong>ficheMeto<strong>di</strong> analiticiProvinceRegionisoil_regionLocalizzazione geografica delle sottounità tipologiche <strong>di</strong> suolo nei poligoni <strong>di</strong> sistema <strong>di</strong> terre e attribuzioni semantichedelle sottounità tipologiche <strong>di</strong> suolo alle componenti territoriali <strong>dei</strong> sistemi <strong>di</strong> terre, con i relativi livelli <strong>di</strong> attribuzioneLocalizzazione geografica delle sottounità tipologiche <strong>di</strong> suolo nei poligoni <strong>di</strong> sottosistema <strong>di</strong> terre eattribuzioni semantiche delle sottounità tipologiche <strong>di</strong> suolo alle componenti territoriali <strong>dei</strong> sottosistemi <strong>di</strong> terre,con i relativi livelli <strong>di</strong> attribuzione.Geo_legame_sts_ut Localizzazione geografica delle sottounità tipologiche <strong>di</strong> suolo nei poligoni <strong>di</strong> unità <strong>di</strong> terre e attribuzioni semantichedelle sottounità tipologiche <strong>di</strong> suolo alle componenti territoriali delle unità <strong>di</strong> terre, con i relativi livelli <strong>di</strong> attribuzione.Attribuzione semantica delle sottounità tipologiche <strong>di</strong> suolo alle componenti territoriali <strong>dei</strong> sistemi <strong>di</strong> terre.Attribuzione semantica delle sottounità tipologiche <strong>di</strong> suolo alle componenti territoriali <strong>dei</strong> sottosistemi <strong>di</strong> terre.Attribuzione semantica delle sottounità tipologiche <strong>di</strong> suolo alle componenti territoriali delle unità <strong>di</strong> terre.Atten<strong>di</strong>bilitàClassi <strong>di</strong> atten<strong>di</strong>bilità <strong>di</strong> attribuzione semantica <strong>dei</strong> <strong>dati</strong> <strong>pedologici</strong> puntuali e delle sottounità tipologiche<strong>di</strong> suolo alla geografiaCoor<strong>di</strong>nateTipi e sistemi <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>nate utilizzabiliComuniitalianierelativico<strong>di</strong>ciistatDeco<strong>di</strong>ficheTutti i co<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> deco<strong>di</strong>fica utilizzati nel databaseMeto<strong>di</strong> analiticiMetodologie per l’esecuzione delle analisi extra routinarie e relative deco<strong>di</strong>ficheProvinceProvince italiane e relative deco<strong>di</strong>ficheRegioni italiane e relative deco<strong>di</strong>fichesoil_regionCo<strong>di</strong>ci e descrizione delle regione pedologica d’Italia.73
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICI3.3.2 Tabelle relative alle tipologieLe principali tabelle relative alle tipologie sono evidenziate dal riquadro verde nella figura 3.2. Perl’inserimento delle UTS e STS sono state create le seguenti tabelle: sottounita, unita, Orizz_funzionali,Orizz_funzionali_extra, _flag e attitu<strong>di</strong>ni. Le descrizioni delle STS con le relative statistiche dellastazione risiedono nella tabella delle sottounità, in cui ogni STS è definita univocamente dai campiCODICE_UNITA e S_UNITA. Esiste una relazione <strong>di</strong> uno a molti fra i campi co<strong>di</strong>ce_<strong>rilevamento</strong>,tipo_osservazione e numero_osservazione della tabella siti e i corrispettivi della tabella siti_su. Quin<strong>di</strong>,sia la tabella sottounita, che quella siti si collegano con una relazione uno a molti alla tabella siti_su (fig.3.2, riquadro giallo). In questa maniera è possibile legare ogni <strong>rilevamento</strong> puntuale a più <strong>di</strong> una STS equesto permette <strong>di</strong> creare STS a <strong>di</strong>verse scale <strong>di</strong> generalizzazione, creando raggruppamenti più o menonumerosi a partire dagli stessi <strong>dati</strong> puntuali. Le descrizioni delle UTS risiedono nella tabella unita, in cuiogni UTS è definita univocamente dal campo CODICE_UNITA. Tale campo è correlato con unarelazione <strong>di</strong> uno a molti con il rispettivo campo CODICE_UNITA della tabella sottounita, ciò in quanto leSTS sono sottogruppi delle UTS. Come verrà spiegato più ampiamente in seguito, una volta definita perun sito pedologico la sua STS <strong>di</strong> appartenenza, vengono definiti anche gli orizzonti funzionali, inserendoil relativo cod_orizz_funzion nella tabella Orizzonti. Dopo<strong>di</strong>ché sono le query <strong>di</strong> aggiornamento dellestatistiche delle STS presenti nel software che calcolano e aggiornano i <strong>dati</strong> analitici e stazionali modalidelle STS, i cui risultati risiedono nelle tabelle Orizz_funzionali e Orizz_funzionali_extra.Una volta create le STS, queste possono essere legate alle componenti territoriali <strong>di</strong> ogni livellogeografico tramite le tabelle Geo_legame_sts_st, Geo_legame_sts_sst e Geo_legame_sts_ut (fig. 3.2,riquadro azzurro), in cui le STS sono legate ai <strong>dati</strong> areali tramite i poligoni <strong>di</strong> appartenenza geografica,oppure tramite le tabelle CT-ST_STS, CT-SST_STS, CT-UT_STS, nelle quali le STS sono legatesemanticamente alle componenti territoriali <strong>di</strong> sistema, sottosistema e unità <strong>di</strong> terre. Al loro interno, sia letabelle Geo_legame_sts_st, Geo_legame_sts_sst e Geo_legame_sts_ut, che le tabelle CT-ST_STS, CT-SST_STS, CT-UT_STS, sono strutturate in maniera che possa esistere una relazione <strong>di</strong> tipo complesso,cioè <strong>di</strong> tipo molti a molti fra le STS e le componenti territoriali <strong>di</strong> ogni livello <strong>di</strong> pedopaesaggio. In altreparole, ogni componente territoriale può essere legata a più <strong>di</strong> una STS e ogni STS può essere legata a più<strong>di</strong> una componente territoriale.Ad esempio, ogni componente territoriale <strong>di</strong> sistema <strong>di</strong> terre, definita univocamente nella tabella CT-ST_STS dai campi soil_region, sistema_terre e CT-st (fig. 3.3), può essere attribuita a più <strong>di</strong> una STS,definita univocamente nella tabella CT-ST_STS dai campi unita e s_unita. Allo stesso modo ogni STSnella tabella CT-ST_STS (fig. 3.4) può essere attribuita a più <strong>di</strong> una componente territoriale <strong>di</strong> sistema <strong>di</strong>terre (fig. 3.4). Lo stesso tipo <strong>di</strong> relazione vale anche per i sottosistemi e le unità <strong>di</strong> terre.Figura 3.3. Filtro <strong>di</strong> selezione dalla tabella CT-ST_STS esemplificativo del legame uno a molti fra una componenteterritoriale <strong>di</strong> un sistema <strong>di</strong> terre e <strong>di</strong>verse STS74
IL SOFTWARE DI INFORMATIZZAZIONE DEI DATIFigura 3.4. Filtro <strong>di</strong> selezione dalla tabella CT-ST_STS esemplificativo del legame uno a molti fra una STS e <strong>di</strong>versecomponenti territoriali <strong>di</strong> sistemi <strong>di</strong> terre .3.3.3 Tabelle relative ai <strong>dati</strong> arealiLe tabelle del CNCP_b.mdb relative alle componenti territoriali degli oggetti areali sono evidenziate dalriquadro arancione nella figura 3.2: CT_ST, CT_SST, CT_UT. In queste tabelle sono presenti campi relativia: le componenti territoriali (cioè le combinazioni <strong>di</strong> fisiografia, litologia e uso del suolo presenti in ognipoligono); la regione pedologica semantica; il sistema <strong>di</strong> terre geografico (nel caso della tabella CT_ST) osemantico (nel caso delle tabelle CT_SST e CT_UT); il sottosistema <strong>di</strong> terre geografico (nel caso dellatabella CT_SST) o semantico (nel caso della tabella CT_UT); l’unità <strong>di</strong> terre geografica nel caso dellatabella CT_UT. Le tabelle degli attributi <strong>dei</strong> <strong>dati</strong> areali si relazionano agli oggetti <strong>dati</strong> <strong>pedologici</strong> puntualie tipologie tramite le tabelle relazionali interne al CNCP (Geo_legame_osservazioni_st,Geo_legame_osservazioni_sst, Geo_legame_osservazioni_ut, Geo_legame_osservazioni_ut,Geo_legame_sts_st, Geo_legame_sts_sst, Geo_legame_sts_ut, CT-ST_STS, CT-SST_STS e CT-UT_STS) già descritte nei paragrafi precedenti.3.3.4 Altre tabelle relazionaliOltre alle tabelle relazionali descritte in precedenza, che relazionano gli oggetti interni al software CNCP,ve ne sono altre che relazionano gli oggetti interni al CNCP con oggetti esterni, quali l’archivio delleschede <strong>di</strong> <strong>rilevamento</strong>, l’archivio delle schede delle analisi, l’archivio fotografico, l’archivio delle sezionisottili e la pedoteca, cioè le tabelle collocazione e Foto_profili (fig. 3.2, riquadro rosso). Con l’ausiliodella tabella relazionale collocazione è possibile compiere varie operazioni <strong>di</strong> archiviazione quali:collocazione delle schede analitiche e delle schede <strong>di</strong> <strong>rilevamento</strong> <strong>di</strong> un intero lotto <strong>di</strong> <strong>rilevamento</strong>definito da uno specifico co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> <strong>rilevamento</strong>; collocazione delle schede analitiche e delle schede <strong>di</strong><strong>rilevamento</strong> <strong>di</strong> ogni singolo sito pedologico; collocazione <strong>dei</strong> campioni <strong>di</strong> suolo e delle sezioni sottilirealizzate per un determinato orizzonte. La funzione <strong>di</strong> archiviazione delle fotografie relative ai <strong>dati</strong><strong>pedologici</strong> puntuali si realizza tramite la tabella Foto_profili, che per mezzo <strong>di</strong> un hyperlink relaziona isiti all’archivio fotografico esterno. Tramite una attribuzione <strong>di</strong> rappresentatività delle foto <strong>dei</strong> siti alletipologie pedologiche si selezionano le fotografie più idonee per la stampa <strong>dei</strong> report.75
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICI3.4 Il motore CNCP_m.mdbPer l’utilizzo dell'applicazione è necessario il software Access (Microsoft Office 2000) o superiori. Il fileCNCP_b.mdb può risiedere nel proprio computer o su un computer centrale (server) presente in rete. Siconsiglia, invece, <strong>di</strong> copiare sul proprio computer i file CNCP_m.mdb e CNCP_g.mdb. Al fine <strong>di</strong>semplificare la gestione della banca <strong>dati</strong> si suggerisce <strong>di</strong> gestire la cartella del server che contiene la banca<strong>dati</strong> CNCP_b.mdb come risorsa del proprio computer chiamandola N://. Per far ciò sarà necessario andarenel menù strumenti <strong>di</strong> “Risorse del computer” e selezionare “Connetti unità <strong>di</strong> rete …”, impostare l’Unitàcome “N://”, cercare con sfoglia la cartella che contiene la banca <strong>dati</strong> CNCP_b.mdb, e infine selezionarel’opzione “Riconnetti all’avvio”. Per poter gestire più basi <strong>dati</strong> è necessario avere alcune accortezze. Ébene ricordare che il nome del file della base <strong>dati</strong> deve essere CNCP_b.mdb, e non può essere mo<strong>di</strong>ficato,altrimenti il CNCP_m.mdb non lo riconoscerà come tale. Se si vogliono gestire banche <strong>dati</strong> <strong>di</strong>verse ènecessario usare più cartelle, nominarle in modo <strong>di</strong>verso, ed in ognuna <strong>di</strong> esse porre le varie banche <strong>dati</strong>nominandole sempre allo stesso modo e cioè come CNCP_b.mdb. Il motore CNCP_m.mdb potrà <strong>di</strong> voltain volta essere connesso alle <strong>di</strong>verse banche <strong>dati</strong> oppure si potrà scegliere <strong>di</strong> inserirne una copia in ognicartella contenente le <strong>di</strong>verse banche <strong>dati</strong> a cui potrà dunque essere connesso in forma stabile. Unesempio <strong>di</strong> questa organizzazione è rappresentato nella fig. 3.5.-DB TOSCANADB SIENACncp_b.mdbDB FIRENZECncp_b.mdb-DB LAZIODB ROMA 1Cncp_b.mdbDB ROMA 2Cncp_b.mdbDB ROMA2_newCncp_b.mdbFigura 3.5. Organizzazione delle cartelle per la gestione <strong>di</strong> <strong>di</strong>verse banche <strong>dati</strong>76
IL SOFTWARE DI INFORMATIZZAZIONE DEI DATI3.4.1 Come iniziareL’apertura del software è ottenibile o facendo doppio clic sul file CNCP_m.mdb oppure, da Accessscegliendo l’opzione apri file esistente e cercando il file CNCP_m.mdb nella relativa cartella dove è statosalvato. All’apertura del software CNCP_m.mdb apparirà una maschera introduttiva recante la versionecorrente utilizzata. Gli elementi che permettono <strong>di</strong> gestire le maschere <strong>di</strong> immissione e visualizzazione <strong>dei</strong><strong>dati</strong> sono la barra <strong>dei</strong> menú (File, Gestioni, Stampe report, Pedofunzioni, Utili, Finestra, Info) e la barra <strong>di</strong>start (Cambia DB, CODICI RILEVAMENTO, SCHEDE PEDOLOGICHE, ORIZZONTI, UNITA’TIPOLOGICHE, SOTTUNITA’, GEOGRAFIA) (fig. 3.6).Figura 3.6. Barra menù e barra start del CNCP_m.mdb3.4.2 Barra <strong>di</strong> STARTDopo aver avviato il CNCP_m.mdb è necessario allegare la base <strong>dati</strong> CNCP_b.mdb attraverso l’uso delpulsante Cambia DB che si trova nella barra <strong>di</strong> start. Appena cliccato sul pulsante Cambia DB appare lamaschera che permette <strong>di</strong> navigare all’interno del nostro computer alla ricerca della cartella contenente lanostra base <strong>di</strong> <strong>dati</strong>, ossia il file CNCP_b.mdb. Sarà sufficiente ora selezionare <strong>di</strong>rettamente la cartelladove è contenuto il file CNCP_b.mdb (che sarà l’unità N:// nel caso abbiate creato questa risorsa delcomputer come vi abbiamo consigliato) e cliccare sul pulsante OK, così il software provvederàautomaticamente ad allineare tutte le tabelle. Il software “ricorda” l’ultimo database allegato (percorsocorrente), per cui non sarà necessario dopo ogni riavvio dover allegare la base <strong>dati</strong> CNCP_b.mdb.Al momento in cui viene aperto il software, alcuni elementi della barra <strong>di</strong> start rimangono inattivi,infatti esistono delle sincronizzazioni tra le maschere che si possono aprire con la barra stessa. Adesempio, una prima sincronizzazione è quella che esiste tra la maschera CNCP-Caratteri della stazione,che si apre cliccando sul pulsante SCHEDE PEDOLOGICHE e quella CNCP-Orizzonti che si aprecliccando sul pulsante ORIZZONTI. Il pulsante ORIZZONTI viene attivato solo quando è aperta lamaschera CNCP-Caratteri della stazione. In questa maniera si andranno a visualizzare e/o aggiornare soloi <strong>dati</strong> relativi agli orizzonti dell’osservazione pedologica che si sta inserendo e/o visualizzando nellamaschera CNCP-Caratteri della stazione. Nel caso in cui si cambiasse osservazione pedologica, attraversoil pulsante <strong>di</strong> scorrimento <strong>dei</strong> record presente in basso nella maschera CNCP-Caratteri della stazione e sipassasse ad una <strong>di</strong>versa osservazione pedologica, la maschera CNCP-Orizzonti si chiuderebbeautomaticamente e il pulsante ORIZZONTI <strong>di</strong>verrebbe nuovamente inattivo. Lo stesso vale per lemaschere CNCP-UTS e CNCP-STS e i relativi pulsanti UNITA’ TIPOLOGICHE e SOTTOUNITA’della barra <strong>di</strong> start. L’ultimo pulsante presente nella barra <strong>di</strong> start è il pulsante GEOGRAFIA che apre lamaschera CNCP-Geografia <strong>di</strong> cui si parlerà più avanti.3.4.2.1 Gestione <strong>dei</strong> co<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> <strong>rilevamento</strong>Prima <strong>di</strong> iniziare ad inserire i <strong>dati</strong> è necessario definire uno o più co<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> <strong>rilevamento</strong>. Questaoperazione si esegue cliccando sul pulsante CODICI RILEVAMENTO della barra <strong>di</strong> start, che apre lamaschera CNCP-Co<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> <strong>rilevamento</strong> (fig. 3.7). Il co<strong>di</strong>ce può essere composto da numeri e/o letterepurché non ecceda le 6 unità. Una volta compilata la maschera si deve cliccare su OK e il nuovo co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong><strong>rilevamento</strong> verrà archiviato nella relativa tabella Co<strong>di</strong>ci <strong>rilevamento</strong> del CNCP_b.mdb. La parte centraledella maschera è riservata per la compilazione del metadato; ovvero la ubicazione geografica, le modalitàd'accesso, con le eventuali limitazioni e la presenza o meno <strong>di</strong> schede con la relativa collocazione.77
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICISe si vuole procedere ad archiviare la collocazione delle schede <strong>di</strong> <strong>rilevamento</strong> e/o delle schede <strong>di</strong>analisi del lotto <strong>di</strong> rilievi relativo al Co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> <strong>rilevamento</strong> che si sta inserendo, si dovrà “flaggare” suSchede, andando così ad aprire la sottomaschera per l’inserimento della collocazione.Figura 3.7. Maschera CNCP-Co<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> <strong>rilevamento</strong>.ionali delle osservazioni pedologiche3.4.2.2 Inserimento <strong>dei</strong> caratteri stazCliccando sul pulsante SCHEDE PEDOLOGICHE che si trova nella barra <strong>di</strong> start si aprirà la mascheraCNCP-Caratteri della stazione (fig. 3.8). I <strong>dati</strong> inseriti in questa maschera vanno ad aggiornare la tabellasiti del CNCP_b.mdb. I primi <strong>dati</strong> da inserire obbligatoriamente in questa maschera, in quanto sono campichiave, si trovano nel riquadro in alto a sinistra (fig. 3.9) e sono la tripletta identificativa dell’osservazionepedologica: co<strong>di</strong>ce_<strong>rilevamento</strong>, tipo_osservazione e numero_osservazione. Tutti i co<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> <strong>rilevamento</strong>presenti nella tabella Co<strong>di</strong>ci <strong>rilevamento</strong> del CNCP_b.mdb sono selezionabili dal menù a ten<strong>di</strong>na delsuddetto riquadro (fig. 3.9), che si aggiorna automaticamente ogni volta che viene aggiunto un nuovoco<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> <strong>rilevamento</strong>.78
IL SOFTWARE DI INFORMATIZZAZIONE DEI DATIFigura 3.8. Maschera CNCP-Caratteri della stazione.Figura 3.9. Riquadro in alto a sinistra della maschera CNCP-Caratteri della stazione.I primi <strong>dati</strong> in<strong>di</strong>spensabili da inserire nella sottomaschera CARATTERI GENERALI (fig. 3.8) sono quellirelativi all’anagrafe e alle coor<strong>di</strong>nate, così il database pedologico assume una effettiva valenza geografica.Cliccando sul pulsante presente nel riquadro coor<strong>di</strong>nate si andrà a creare un collegamentoipertestuale al sito http://maps.google.it (Google, 2007), che permetterà <strong>di</strong> visualizzare l’immaginesatellitare del sito (fig. 3.10), a con<strong>di</strong>zione che sia <strong>di</strong>sponibile e che siano state compilate le coor<strong>di</strong>nategeografiche in gra<strong>di</strong> decimali nel sistema WGS84. Allo stesso modo cliccando sul pulsante presentenel riquadro coor<strong>di</strong>nate si andrà a creare un collegamento ipertestuale al sito http://www.flashearth.com(Flashearth, 2007), che permetterà <strong>di</strong> visualizzare svariati formati <strong>di</strong> immagini aeree del sito provenientida <strong>di</strong>versi fornitori: Google, Yahoo, NAVTEQ e NASA.79
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICIFigura 3.10. Immagine aerea del sito da http://maps.google.itDopo<strong>di</strong>chè si potranno inserire i <strong>dati</strong> relativi al Riferimento geografico, andando nel riquadro centraledella maschera CNCP-Caratteri della stazione (fig. 3.8). Cliccando nel medesimo riquadro Riferimentogeografico sul pulsante si aprirà la sottomaschera CNCP-Geografia-Siti (fig. 3.11) che permettel’aggiornamento <strong>dei</strong> campi relativi alla geografia della tabella siti, cioè i campi Poly_geo_st,Poly_geo_sst e Poly_geo_ut relativi ai poligoni <strong>di</strong> ST, SST e UT <strong>di</strong> appartenenza geografica, e i campiCT-st, CT-sst e CT-ut della tabella siti relativi alle componenti territoriali <strong>dei</strong> pedopaesaggi a cuil’osservazione pedologica è attribuibile semanticamente.80
IL SOFTWARE DI INFORMATIZZAZIONE DEI DATIFigura 3.11. Sottomaschera CNCP-Geografia-Siti.Il primo dato da inserire nella sottomaschera CNCP-Geografia-Siti (fig. 3.11) è il numero <strong>di</strong> poligono <strong>di</strong>ST, SST o UT in cui il <strong>rilevamento</strong> pedologico ricade geograficamente. Per far questo basterà compilareil riquadro Num. poligono del livello pedopaesaggistico <strong>di</strong> riferimento e si andranno così ad aggiornare icampi Poly_geo_st, Poly_geo_sst e Poly_geo_ut della tabella siti. Poi vanno inserite le componentiterritoriali semantiche, cioè la combinazione <strong>di</strong> morfologia, litologia e uso del suolo a cui il sito èattribuibile semanticamente. Cliccando sul pulsante Lista CT si può accedere alla lista <strong>di</strong> CT presenti nelpoligono <strong>di</strong> appartenenza geografica. Cliccando sul pulsante Caratteristiche sito si va ad aprire lasottomaschera CT-sito (fig. 3.12) che fornisce uno schema riassuntivo delle caratteristiche <strong>di</strong> fisiografia,substrato e uso del suolo del sito. Non è necessario, ma è comunque preferibile, che la componenteterritoriale semantica sia presente nel poligono <strong>di</strong> sistema, sottosistema o unità <strong>di</strong> terre <strong>di</strong> appartenenzageografica. Esistono, infatti, vari livelli <strong>di</strong> attribuzione (ve<strong>di</strong> par. 3.4.2.6). Se la componente territorialeattribuita semanticamente al sito non è presente nel poligono <strong>di</strong> appartenenza geografica è possibileandare a cercare la sua presenza in altri poligoni grazie ai riquadri denominati “localizzazione CT” (fig. 3.11).Figura 3.12. Sottomaschera CT_sito.81
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICIUna volta compilati i <strong>dati</strong> nella sottomaschera CNCP-Geografia-Siti, sarà possibile aggiornare iriferimenti semantici cliccando sul pulsante Aggiorna riferimenti, grazie al quale il software inautomatico in<strong>di</strong>vidua la regione pedologica, i sistemi <strong>di</strong> terre (e/o i sottosistemi <strong>di</strong> terre e/o le unità <strong>di</strong>terre e/o gli elementi territoriali) a cui l’osservazione è legata semanticamente, che verranno visualizzatinel riquadro Riferimenti semantici della sottomaschera CARATTERI GENERALI (figg. 3.8 e 3.13) esaranno registrati nei campi soil_region, sistema_terre, s_sist_terre, un_terre, elem_territoriale dellatabella siti.Figura 3.13. Maschera CNCP-Caratteri della stazione <strong>di</strong> un sito non rappresentativo per il suo ST geografico.Nel caso preso in esame nelle figure 3.8 e 3.11 il sito risulta essere legato semanticamente ad una delle CTdel sistema <strong>di</strong> terre in cui ricade geograficamente (e anche ad una delle CT del sottosistema <strong>di</strong> terre in cuiricade geograficamente) e per questo nel riquadro Concordanza – geografia - semantica si legge che il sitoè legato alla CT <strong>di</strong> ST (e anche CT <strong>di</strong> SST) (fig. 3.8). Nel caso preso in esame nella fig. 3.13 il sito risultanon essere legato semanticamente ad una delle CT del sistema <strong>di</strong> terre in cui ricade geograficamente(mentre è legato semanticamente ad una delle CT del sottosistema <strong>di</strong> terre in cui ricade geograficamente)e per questo nel riquadro Concordanza – geografia - semantica si legge che il sito non è legato alla CT <strong>di</strong>ST ed è stato posto un flag su “verificata altra appartenenza semantica” per in<strong>di</strong>care che il sito èrappresentativo della CT <strong>di</strong> un altro sistema <strong>di</strong> terre presente nella stessa regione pedologica. Nel caso incui il sito non fosse rappresentativo <strong>di</strong> nessuna CT <strong>di</strong> ST fra quelle presenti in baca <strong>dati</strong>, allora siandrebbe a porre un flag su “da verificare” nel riquadro Concordanza – geografia - semantica.Per ogni osservazione pedologica è possibile inserire il riferimento alle relative fotografie,aggiornando i <strong>dati</strong> della tabella relazionale Foto_profili. Le foto, per le loro <strong>di</strong>mensioni, non possonorisiedere all’interno del software CNCP, ma devono risiedere invece in un archivio fotografico esterno. Siconsiglia comunque <strong>di</strong> farle risiedere nella stessa cartella dove si trova il CNCP_b.mdb. Cliccando sulpulsante Apri nel riquadro Galleria della sottomaschera CARATTERI GENERALI si apre lasottomaschera subFotos (fig. 3.14). In questa sottomaschera si devono inserire la tripletta identificativadell’osservazione (Co<strong>di</strong>ce <strong>rilevamento</strong>, tipo osservazione e numero osservazione) il Soggetto foto e82
IL SOFTWARE DI INFORMATIZZAZIONE DEI DATIquin<strong>di</strong> si deve creare l’iperlink cliccando sul pulsante in<strong>di</strong>cato dalla freccia blu, con il quale si apre unasottomaschera che permette <strong>di</strong> cercare la fotografia, nella sua cartella <strong>di</strong> localizzazione, e inserire così ilcollegamento.Figura 3.14. Sottomaschera subFotos.Successivamente si andranno a compilare i <strong>dati</strong> relativi alle sottomaschere CARATTERI SUPERFICIE,GEOLOGIA, QUALITÁ (fig. 3.15), CLASSIFICAZIONE (fig. 3.16) e COLLOCAZIONE (fig. 3.17).L’inserimento <strong>dei</strong> <strong>dati</strong> in queste sottomaschere è facilitato dalla presenza <strong>dei</strong> menù a ten<strong>di</strong>na in cui èpossibile trovare le deco<strong>di</strong>fiche usate nel CNCP_b.mdb. I campi colorati <strong>di</strong> grigio e altri campi, quali ilgruppo idrologico, l’interferenza climatica, la capacità depurativa e protettiva, la capacità d’uso, i regimiudometrico e termometrico, sono campi che si aggiornano automaticamente quando entrano in azione lefunzioni visual basic automatiche del software (fig. 3.15).83
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICIFigura 3.15. Sottomaschera QUALITA’ della Maschera CNCP-Caratteri della stazione.La sottomaschera COLLOCAZIONE (fig. 3.17) si apre solo se si va a porre un flag su Scheda <strong>di</strong><strong>rilevamento</strong> e/o su Scheda analisi nella sottomaschera CLASSIFICAZIONE (fig. 3.16). Nellasottomaschera COLLOCAZIONE si inseriscono i <strong>dati</strong> relativi alla collocazione delle schede <strong>di</strong><strong>rilevamento</strong> e/o delle schede <strong>di</strong> analisi delle osservazioni.Nell’intestazione della maschera CNCP-Caratteri della stazione (fig. 3.18) sono presenti ulterioririquadri che necessitano <strong>di</strong> una specifica spiegazione. Una volta che sono stati inseriti i <strong>dati</strong> relativi allesottomaschere CARATTERI GENERALI, CARATTERI SUPERFICIE, CARATTERI PROFONDI,QUALITÁ e CLASSIFICAZIONE il software aggiorna in automatico il riquadro relativo allaclassificazione presente nell’intestazione della maschera Caratteri della stazione, evidenziato in magentanella fig. 3.18.Cliccando sul pulsante del riquadro evidenziato in giallo in fig. 3.18 è possibile avere l’anteprima<strong>di</strong> stampa del report dell’osservazione pedologica (fig. 1.8), cliccando sul pulsante del medesimoriquadro è possibile avere l’anteprima <strong>di</strong> stampa del report dell’osservazione pedologica in inglese,cliccando sul pulsante del medesimo riquadro è possibile avere l’anteprima si stampa della relativarelazione agronomica (fig. 3.19).84
IL SOFTWARE DI INFORMATIZZAZIONE DEI DATIFigura 3.16. Sottomaschera CLASSIFICAZIONE della Maschera CNCP-Caratteri della stazione.Infine, utilizzando il riquadro evidenziato in verde nella fig. 3.18 è possibile in<strong>di</strong>care la UTS ed STS <strong>di</strong>appartenenza dell’osservazione pedologica e il relativo grado <strong>di</strong> relazione (caposaldo, correlato,rappresentativo e tipico, ve<strong>di</strong> par. 1.2.3.3). I record che si andranno ad accodare e/o aggiornarecompilando il riquadro evidenziato in verde nella fig. 3.18 saranno contenuti nella tabella siti_su delCNCP_b.mdb. Utilizzando i filtri presenti nel riquadro circondato da bordo grigio della stessaintestazione (fig. 3.18) è possibile filtrare tutte le osservazioni pedologiche relative ad una determinataUTS o STS.85
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICIFigura 3.17. Sottomaschera COLLOCAZIONE della Maschera CNCP-Caratteri della stazione.Figura 3.18. Intestazione della maschera CNCP-Caratteri della stazione.86
IL SOFTWARE DI INFORMATIZZAZIONE DEI DATIFigura 3.19. Report <strong>di</strong> stampa della relazione agronomica delle osservazioni pedologiche.87
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICI3.4.2.3 Inserimento <strong>dei</strong> caratteri relativi agli orizzonti delle osservazioni pedologicheCliccando sul pulsante ORIZZONTI della barra <strong>di</strong> start, che come già detto si attiva solo dopo l’aperturadella maschera CNCP-Caratteri della stazione, si apre la maschera CNCP-Orizzonti (figg. 3.20 e 3.21)che serve per l’inserimento e/o la visualizzazione <strong>dei</strong> <strong>dati</strong> relativi agli orizzonti dell’osservazionepedologica che si sta inserendo. In questa maschera si dovrà prima <strong>di</strong> tutto compilare l’intestazione,in<strong>di</strong>cando il numero <strong>di</strong> orizzonte progressivo, il co<strong>di</strong>ce dell’orizzonte, il co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> orizzonte funzionale eobbligatoriamente il limite inferiore me<strong>di</strong>o. L’orizzonte funzionale viene in<strong>di</strong>cato me<strong>di</strong>ante menù aten<strong>di</strong>na, al momento in cui l’osservazione pedologica viene attribuita ad una STS. Si potranno, inoltre,in<strong>di</strong>care lo spessore dell’orizzonte, il tipo e l’andamento del limite inferiore dell’orizzonte e l’orizzonte<strong>di</strong>agnostico secondo la Soil taxonomy e la WRB. Una volta compilata l’intestazione, si andranno acompilare i <strong>dati</strong> relativi alle sottomaschere DATI1 (fig. 3.20), DATI2 e DATI3 (fig. 3.21). Anche inqueste sottomaschere sono presenti <strong>dei</strong> menù a ten<strong>di</strong>na che permettono <strong>di</strong> accedere alle deco<strong>di</strong>fiche delCNCP_b.mdb. Tutti i <strong>dati</strong> inseriti fino a questo momento aggiornano i <strong>dati</strong> della tabella Orizzonti delCNCP_b.mdb.Figura 3.20. Sottomaschera DATI1 della maschera CNCP-Orizzonti.Nella sottomaschera DATI 3, il riquadro grigio relativo alla conducibilità idraulica si aggiornaautomaticamente azionando la pedofunzione del software per la stima della conducibilità idraulica, che sibasa sul metodo <strong>di</strong> Rawls e Brakensiek del 1983. Questo algoritmo funziona solo se sono presenti perl’orizzonte i <strong>dati</strong> relativi alle variabili previste dalla pedofunzione stessa. Sempre nella sottomascheraDATI 3 è possibile accedere anche ad una funzione <strong>di</strong> controllo <strong>dei</strong> <strong>dati</strong>, che evidenzia eventuali errori <strong>di</strong>inserimento. Se il sito è stato campionato si dovrà mettere un flag nel riquadro Campione Prelievo, dellasottomaschera DATI 3, circondato in verde nella figura 3.21, in<strong>di</strong>cando per quale tipo <strong>di</strong> analisi è statoeffettuato il campionamento. Se si è in possesso <strong>dei</strong> risultati delle analisi effettuate, si dovrà mettere unflag nei rispettivi campi del riquadro Campione Analisi della sottomaschera DATI 3, circondato in rossonella figura 3.21, in<strong>di</strong>cando se si tratta <strong>di</strong> analisi routinarie, analisi extra o analisi delle sezioni sottili. In88
IL SOFTWARE DI INFORMATIZZAZIONE DEI DATIquesta maniera vengono attivate le sottomaschere per l’inserimento <strong>dei</strong> <strong>dati</strong> analitici routinari e/o extraroutinari (ANALISI ROUTINARIE, ROUT. METODO E ANALISI EXTRA).Figura 3.21. Maschera CNCP-Orizzonti con le sottomaschere per l’inserimento delle analisi routinarie e per la collocazioneattive.I <strong>dati</strong> analitici delle sezioni sottili non vengono inseriti nel presente database ma nel databaseMicromorpho, allegato al presente manuale. Se i campioni <strong>di</strong> suolo o le sezioni sottili sono archiviati inpedoteca o nell’archivio delle sezioni sottili si dovrà mettere un flag su Pedoteca/S.s nel riquadroCampione Archivio della sottomaschera DATI 3, evidenziato in giallo nella figura 3.21, in modo da attivarecosì la sottomaschera COLLOCAZIONE.Per l’inserimento delle analisi routinarie si dovrà dunque accedere alla relativa sottomascheraANALISI ROUTINARIE, dove la prima cosa da inserire saranno il numero <strong>di</strong> analisi e la profon<strong>di</strong>tà delcampione <strong>di</strong> suolo nel riquadro evidenziato in magenta nella figura 3.22. I campi bianchi sono compilabilied è bene che siano completi. I campi grigi, invece, non sono compilabili in quanto sono calcolatiautomaticamente dal software. La tabella che viene aggiornata con questa sottomaschera è la tabellaAnalisi routinarie del CNCP_b.mdb. Da sottolineare che nel caso in cui per ogni orizzonte sia stataeseguita una sola analisi, il numero dell’analisi sarà sempre uno; sarà <strong>di</strong>verso da uno e progressivo (2, 3,ecc.) solo nel caso in cui per ogni orizzonte del medesimo profilo siano state eseguite le stesse analisi insuccessive repliche. Nelle figure 3.22 è portato <strong>di</strong> proposito come esempio un caso in cui il dato della CSC èin<strong>di</strong>cato in rosso. Questa segnalazione ci sta ad in<strong>di</strong>care che il valore <strong>di</strong> CSC fuoriesce da un rangestandard <strong>di</strong> valori dato dalla seguente formula empirica (Sbaraglia e Sbaraglia, 2007):CSC = ±20% (0,6* % <strong>di</strong> argilla + 3* % sostanza organica)89
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICIFigura 3.22. Sottomaschera delle ANALISI ROUTINARIE della maschera CNCP-Orizzonti.Le metodologie usate per effettuare le analisi routinarie andranno inserite nella sottomaschera ROUT.METODO. Dopo<strong>di</strong>ché, per l’inserimento delle analisi extra routinarie, si dovrà accedere alla relativasottomaschera ANALISI EXTRA (fig. 3.23) in cui per prima cosa si dovranno inserire il numero <strong>di</strong>analisi extra, i limiti superiore e inferiore e il co<strong>di</strong>ce dell’orizzonte. In questa maniera si andranno adaggiornare i <strong>dati</strong> della tabella analisi_extra_note del CNCP_b.mdb.Cliccando poi sul pulsante Immissione analisi si aprirà la sottomaschera Immissione analisi extra (fig.3.24) dove si potranno visualizzare e/o aggiornare i <strong>dati</strong> della tabella Analisi_extra relativi all’orizzonteche si sta inserendo. Il numero dato sarà intero progressivo. Il tipo <strong>di</strong> analisi dovrà essere prima <strong>di</strong> tuttoricercato fra quelli contemplati nel menù a ten<strong>di</strong>na della sottomaschera Immissione analisi extra, in casonegativo dovrà essere inserito cliccando sul pulsante Gestione tipo analisi e aprendo così la sottomascheraGESTIONE TIPO ANALISI (fig. 3.25). Compilando questa sottomaschera si vanno ad accodare nuovirecord e/o aggiornare i record della tabella Deco<strong>di</strong>fiche del CNCP_b.mdb.90
IL SOFTWARE DI INFORMATIZZAZIONE DEI DATIFigura 3.23. Sottomaschera ANALISI EXTRA della maschera CNCP-Orizzonti.É possibile inserire anche il tipo <strong>di</strong> metodo analitico utilizzato, ricercandolo prima <strong>di</strong> tutto fra gli Standarde i Titoli già previsti nel menù a ten<strong>di</strong>na della sottomaschera Immissione analisi extra oppure, dove nonfosse previsto, cliccando sul pulsante Gestione <strong>meto<strong>di</strong></strong> analitici della sottomaschera Immissione analisiextra e aprendo così la sottomaschera Meto<strong>di</strong> analitici (fig. 3.26). Anche compilando la sottomascheraMeto<strong>di</strong> analitici si accodano nuovi record e/o aggiornano i record della tabella Deco<strong>di</strong>fiche delCNCP_b.mdb.Si noti che la struttura delle tabelle per l’inserimento delle analisi extra routinarie è <strong>di</strong>versa da quelladelle tabelle per l’inserimento dell’analisi routinarie. Infatti, per le analisi routinarie si è previsto un set <strong>di</strong>analisi fisso, che sono le analisi effettuate <strong>di</strong> routine sui campioni <strong>di</strong> suolo. Per le analisi extra routinarienon è possibile stabilire un set fisso <strong>di</strong> analisi, in quanto vengono realizzate in maniera <strong>di</strong>versa a secondadel fine del <strong>rilevamento</strong> e del tipo <strong>di</strong> suolo.Grazie alla tabella relazionale Analisi_extra_note ed alla maschera <strong>di</strong> aggiornamento <strong>dei</strong> <strong>meto<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong><strong>rilevamento</strong> e degli standard utilizzati, si hanno <strong>di</strong>versi vantaggi: la possibilità <strong>di</strong> inserire le sole analisiextra routinarie che sono state eseguite sul campione <strong>di</strong> suolo, evitando inutili campi vuoti nella tabellaAnalisi_extra, la possibilità <strong>di</strong> inserire qualsiasi tipo <strong>di</strong> analisi extra routinaria che sia stata eseguita sulcampione <strong>di</strong> suolo e la possibilità <strong>di</strong> inserire risultati <strong>di</strong> analisi effettuate con qualsiasi metodologia,evitando così l’inserimento <strong>di</strong> questi <strong>dati</strong> (originariamente non presenti nella tabella Deco<strong>di</strong>fiche) comecampo testuale in nota.91
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICIFigura 3.24. Sottomaschera Immissione analisi extra.Figura 3.25. Sottomaschera GESTIONE TIPO ANALISI.L’ultima sottomaschera della maschera CNCP-Orizzonti è la sottomaschera COLLOCAZIONE (fig.3.27), che si attiva mettendo un flag su Pedoteca/S.s nel riquadro Campione Archivio della sottomascheraDATI 3, evidenziato in giallo nella figura 3.21. In questa sottomaschera si può inserire la collocazione <strong>dei</strong>campioni <strong>di</strong> suolo che stati archiviati archiviati in pedoteca e/o delle sezioni sottili che sono statiarchiviati nel relativo archivio. Compilando questa sottomaschera si aggiornano i <strong>dati</strong> relativi alla tabellacollocazione del CNCP_b.mdb.92
IL SOFTWARE DI INFORMATIZZAZIONE DEI DATIFigura 3.26. Sottomaschera Meto<strong>di</strong> analitici. La co<strong>di</strong>fica <strong>dei</strong> <strong>meto<strong>di</strong></strong> analitici fa riferimento al manuale delleprocedure europeo (Finke et al., 1999).Figura 3.27 . Sottomaschera COLLOCAZIONE della maschera CNCP-Orizzonti.3.4.2.4 Creazione ed inserimento delle UTS e STSLa correlazione tipologica, volta alla creazione delle UTS e STS, è una delle principali funzioni delsoftware CNCP. La correlazione è facilitata dall’uso del software in quanto si possono creare delle queryapposite per raggruppare le osservazioni pedologiche secondo determinati criteri, così come riportato nelprimo capitolo del presente manuale. Il software CNCP permette sia <strong>di</strong> creare UTS ed STS ex novo, sia <strong>di</strong>inserire manualmente UTS ed STS già conosciute. Nel primo caso, una volta che i siti (le osservazionipedologiche) sono stati attribuiti alle UTS ed STS, il software CNCP fornisce le funzioni per il calcolodelle relative statistiche che le caratterizzano.Le UTS nazionali possono anche essere inserite manualmente, senza inserire le relative osservazionipedologiche (ve<strong>di</strong> par. 1.2.3.2). Anche le tipologie create a partire da <strong>dati</strong> presenti nel database possonoessere in ogni momento definite come nazionali, ma in quel caso le loro statistiche non potranno piùessere aggiornate e i <strong>dati</strong> potranno, invece, essere mo<strong>di</strong>ficati in forma manuale. Nel caso si voglia93
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICIattribuire una nuova osservazione ad una UTS nazionale e calcolare nuovamente le statistiche, tale UTSdovrà tornare ad essere in<strong>di</strong>cata come stabilita, proposta o tentativa.Figura 3.28. Sottomaschera SOTTUNITA’ della maschera CNCP-UTS.Nel presente paragrafo si presenteranno le maschere relative alla UTS nazionale, co<strong>di</strong>ficata come62.2VRcc1 e denominata Calcic Vertisols agrari della soil region 62.2, che è stata già presentata nelprimo capitolo del manuale. Si noti che le osservazioni pedologiche non possono essere assegnate ad unaSTS se la stessa non esiste già come record delle tabelle sottounita e unita del CNCP_b.mdb. Per questomotivo, una volta in<strong>di</strong>viduati per mezzo <strong>di</strong> query i primi raggruppamenti tentativi <strong>di</strong> osservazionipedologiche che si ipotizzano appartenere alla stessa tipologia <strong>di</strong> suolo, prima <strong>di</strong> poter assegnare leosservazioni così in<strong>di</strong>viduate alle propria STS ed UTS, si dovranno creare i relativi record nelle tabellesottounita e unita del CNCP_b.mdb. Per far questo si utilizzeranno le maschere CNCP-UTS (fig. 3.28) eCNCP-STS (fig. 3.31). Per aprire queste maschere si deve cliccare sui pulsanti UNITA’ TIPOLOGICHEe SOTTOUNITA’ della barra <strong>di</strong> start, quest’ultimo si attiva solo se è aperta la maschera CNCP-UTS.Compilando la maschera CNCP-UTS (fig. 3.28) si aggiornano i <strong>dati</strong> relativi alla tabella unita delCNCP_b.mdb. Il primo dato da inserire è il co<strong>di</strong>ce, che aggiorna il campo chiave della tabella unita e cioèil CODICE_UNITA, che è un campo <strong>di</strong> testo con una <strong>di</strong>mensione massima <strong>di</strong> 11 caratteri.Poi vanno inseriti il nome, il tipo <strong>di</strong> unità e la regione pedologica <strong>di</strong> appartenenza semantica.94
IL SOFTWARE DI INFORMATIZZAZIONE DEI DATIFigura 3.29. Sottomaschera DESCRIZIONE della maschera CNCP-UTS.A questo punto si andranno ad inserire tutte le STS che appartengono all’UTS. Nella sottomascheraDESCRIZIONE (fig. 3.29) della maschera CNCP-UTS si potranno inserire manualmente (nel caso delleUTS nazionali) o si potranno visualizzare (nel caso delle altre UTS) i <strong>dati</strong> relativi alla fisiografia, alsubstrato e all’uso del suolo modali della UTS. Naturalmente, per le UTS non nazionali, questi campisaranno vuoti, se ancora nessuna osservazione è stata attribuita alle relative STS e si dovrà dunqueprocedere ad attribuire le relative osservazioni utilizzando il riquadro evidenziato in verde nella figura 3.18(ve<strong>di</strong> par. 3.4.2.2). Un volta inserite le UTS, si potranno sempre filtrare utilizzando il menù a ten<strong>di</strong>naFitro UTS presente nel riquadro in alto a sinistra della maschera CNCP-UTS. Cliccando su Stampa, nelriquadro in alto a destra si ottiene la visualizzazione del report riassuntivo dell’UTS (fig. 1.6), che potràessere salvato in formato .rtf cliccando sul report stesso col tasto destro del mouse e andando su Esporta,oppure potrà essere stampato selezionando l’icona <strong>di</strong> stampa <strong>di</strong> Access. La scelta delle fotografie dainserire nel report <strong>di</strong> stampa delle UTS è facilitata dall’uso della funzione Gestione Foto STS, presentenel menù Gestioni, che permette <strong>di</strong> aprire la maschera Gestione Foto STS (fig. 3.30) per mezzo dellaquale si possono visionare tutte le fotografie <strong>di</strong>sponibili per le varie UTS ed STS, potendo così flaggarequelle che sono rappresentative per l’UTS e relative STS.95
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICIFigura 3.30. Maschera Gestione Foto STS.Una volta inserite le STS appartenenti alla UTS, cliccando sul pulsante SOTTOUNITA’ della barra <strong>di</strong>start si aprirà la maschera CNCP-STS (fig. 3.31) in cui si potranno inserire i <strong>dati</strong> relativi alle STS.Compilando la maschera CNCP-STS si aggiornano i <strong>dati</strong> relativi alla tabella sottounita del CNCP_b.mdb.Compilando i riquadri dell’intestazione in<strong>di</strong>cati come CODICE si andranno a inserire i campi chiave dellatabella e cioè il campo CODICE_UNITA dell’UTS <strong>di</strong> appartenenza e il campo S_UNITA, cioè il co<strong>di</strong>cenumerico intero progressivo della STS. Poi vanno inseriti il nome e il tipo <strong>di</strong> STS: fase o variante. Tutte leoperazioni descritte fino a questo momento sono uguali per tutti i tipi <strong>di</strong> UTS ed STS, siano esse inseritemanualmente oppure definite a partire da originale attività <strong>di</strong> correlazione.Nel processo <strong>di</strong> correlazione, tutte le osservazioni assegnate ad una determinata STS vengonoinizialmente attribuite come tipiche, nel caso in cui abbiano le analisi, e come rappresentative nel caso incui non le abbiano; questa attribuzione preliminare è necessaria in quanto altrimenti il software non puòcalcolare le elaborazioni statistiche del sito modale (ve<strong>di</strong> par. 1.2.3.3).96
IL SOFTWARE DI INFORMATIZZAZIONE DEI DATIFigura 3.31. Sottomaschera CLASSIFICAZIONI della maschera CNCP-STS.Una volta che questa prima attribuzione sarà stata effettuata, il numero totale <strong>di</strong> osservazioni afferenti adogni STS verrà calcolato automaticamente dal software e riportato nella maschera CNCP-STS nelriquadro OSSERVAZIONI (nel caso, invece, delle STS inserite manualmente anche questo dato andràcompilato a mano). Quando avremo attribuito tutte le osservazioni pedologiche alle STS e relative UTS, ilpasso successivo sarà quello <strong>di</strong> determinare gli orizzonti funzionali <strong>di</strong> ogni STS, utilizzando lasottomaschera ORIZ. FUNZIONALI E ATTITUDINI della maschera CNCP-STS (fig. 3.32). Cliccandosul pulsante Gestione nella sottomaschera ORIZ. FUNZIONALI E ATTITUDINI della maschera CNCP-STS (fig. 3.32) si accede alla sottomaschera mo<strong>di</strong>fica/ve<strong>di</strong> orizzonti funzionali (fig. 3.33), che è unamaschera a due finestre: nella finestra superiore possono essere attribuiti o mo<strong>di</strong>ficati i co<strong>di</strong>ci degliorizzonti funzionali delle osservazioni afferenti alla STS che si sta inserendo, nella finestra inferiore sonoevidenziati gli orizzonti funzionali già attribuiti alle osservazioni afferenti alla STS. Sarà possibile aquesto punto assegnare agli orizzonti delle osservazioni dell’STS i relativi orizzonti funzionali <strong>di</strong>appartenenza, <strong>di</strong>rettamente dalla maschera CNCP-Orizzonti (figg. 3.20 e 3.21). Nel caso delle STSnazionali inserite manualmente non sarà necessario determinare gli orizzonti funzionali e quin<strong>di</strong> non sidovrà accedere alla funzione <strong>di</strong> gestione degli orizzonti funzionali, ma si dovrà semplicemente inserirli amano nella scheda ORIZ. FUNZIONALI E ATTITUDINI della maschera CNCP-STS.97
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICIFigura 3.32. Sottomaschera ORIZ. FUNZIONALI E ATTITUDINI della maschera CNCP-STS.Nella scheda ORIZ. FUNZIONALI E ATTITUDINI della maschera CNCP-STS è possibile ancheinserire i caratteri funzionali che sono stati presi in considerazione per la correlazione. I caratterifunzionali inseriti andranno ad aggiornare il relativo record della tabella _flag del CNCP_b.mdb. Nelriquadro Attitu<strong>di</strong>ni è possibile in<strong>di</strong>care le classi attitu<strong>di</strong>nali dell’STS che andranno ad aggiornare i recorddella tabella attitu<strong>di</strong>ni del CNCP_b.mdb. L’inserimento <strong>dei</strong> caratteri funzionali e della attitu<strong>di</strong>ni è unaoperazione manuale e dunque è equivalente per tutti i tipi <strong>di</strong> STS.Per favorire il processo <strong>di</strong> correlazione, il gestionale CNCP_m.mdb fornisce il calcolo delle statistichedelle UTS e STS quale strumento per la verifica della rappresentatività delle UTS ed STS.Figura 3.33. Sottomaschera mo<strong>di</strong>fica/ve<strong>di</strong> orizzonti funzionali.98
IL SOFTWARE DI INFORMATIZZAZIONE DEI DATIPer accedere a queste funzioni bisogna andare alla barra <strong>di</strong> menù nei moduli <strong>di</strong> Gestioni: Aggiornastatistiche STS, Aggiorna moda STS e Aggiorna moda UTS. É grazie a queste funzioni che il softwaredetermina le mode relative ai <strong>dati</strong> stazionari delle STS e UTS e le statistiche <strong>dei</strong> <strong>dati</strong> analitici degliorizzonti funzionali, calcolando le statistiche me<strong>di</strong>a, deviazione standard, moda e numerosità campionariadelle UTS ed STS, che fino a questo momento erano solo <strong>dei</strong> semplici raggruppamenti <strong>di</strong> osservazioni.Quando nelle sottomaschere SITO MODALE (fig. 3.34), PROFILO MODALE (fig. 3.35) e EXTRA (fig.3.36) della maschera CNCP-STS, presenti nel caso <strong>di</strong> STS non nazionali, i valori sono in colore rosso, ilsoftware segnala che per quel dato la me<strong>di</strong>a non è un in<strong>di</strong>ce statisticamente corretto della popolazione.Nel caso delle STS nazionali, le suddette sottomaschere non ci sono, perché sostituite da sottomaschereanaloghe compilabili manualmente, denominate SITO MODALE BD (fig. 3.37), PROFILO MODALEBD (fig. 3.38) e EXTRA BD (fig. 3.39). Per le STS nazionali i cui valori statistici provengono da <strong>dati</strong>presenti nel database, i <strong>dati</strong> del sito e del profilo modale, con le relative segnalazioni in rosso, simantengono anche nelle maschere SITO MODALE BD, PROFILO MODALE BD e EXTRA BD.Ricor<strong>di</strong>amo, come già segnalato, che quando una UTS, con relative STS, è in<strong>di</strong>cata come nazionale ilsoftware non esegue più sui suoi <strong>dati</strong> nessun aggiornamento statistico. Le elaborazioni statistichecalcolate dal software sono me<strong>di</strong>a, moda, numerosità campionaria e deviazione standard. In particolare lavarianza è data dal rapporto fra gli scarti dalla me<strong>di</strong>a al quadrato e i gra<strong>di</strong> <strong>di</strong> libertà (v = Σ (x – µ)²/n-1,dove x sono tutti i valori assunti dal dato, µ è la me<strong>di</strong>a e n la numerosità campionaria, n-1 sono i gra<strong>di</strong> <strong>di</strong> libertà).La deviazione standard (σ = v -2 ) è la ra<strong>di</strong>ce quadrata della varianza. Un basso valore della deviazionestandard in<strong>di</strong>ca che i valori sono concentrati intorno alla me<strong>di</strong>a e che i suoli attribuiti ad una STS per undato carattere sono relativamente omogenei; al contrario una deviazione standard alta in<strong>di</strong>ca che i suolidella STS per quel carattere sono piuttosto <strong>di</strong>somogenei, per cui va usata cautela nel considerare il datome<strong>di</strong>o <strong>di</strong> quel carattere per le valutazioni agronomiche ed ambientali della tipologia.Figura 3.34. Sottomaschera SITO MODALE della maschera CNCP-STS <strong>di</strong> una STS non nazionale.99
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICICome si è detto in precedenza, tutte le osservazioni assegnate ad una determinata STS vengonoclassificate inizialmente come tipiche, nel caso in cui abbiano le analisi, o come rappresentative nel casoin cui non le abbiano. Una volta che si sono fatti girare gli aggiornamenti delle statistiche sarà possibilein<strong>di</strong>viduare un <strong>di</strong>verso grado <strong>di</strong> relazione (ve<strong>di</strong> par. 1.2.3.3) per le osservazioni assegnate all’STS. Per leSTS nazionali inserite manualmente, l’eventuale grado <strong>di</strong> relazione delle osservazioni <strong>di</strong> una determinataSTS viene fornito dall’autore della tipologia e dunque dovrà essere semplicemente inserito cliccando sulpulsante Assegna della maschera CNCP-STS (fig. 3.31), andando ad aprire la sottomaschera Ve<strong>di</strong>osservazioni STS (fig. 3.40). Per le STS non nazionali si dovrà controllare invece quali sono i caratterifunzionali alla correlazione, per i quali ci si attende che le osservazioni pedologiche non abbiano <strong>dati</strong> chedeviano per più <strong>di</strong> 3σ (deviazione standard) rispetto alla me<strong>di</strong>a, perché in caso contrario dovranno essereassegnate come correlate, oppure osservazioni i cui <strong>dati</strong> deviano per più <strong>di</strong> 2σ (deviazione standard)rispetto alla me<strong>di</strong>a, che dovranno essere assegnate come rappresentative. Per far questo basterà cliccaresopra ai caratteri funzionali, andando ad aprire le sottomaschere <strong>dati</strong> incerti della STS-sigma3 (fig. 3.41),<strong>dati</strong> incerti della STS-sigma2 (fig. 3.42), <strong>dati</strong> incerti della STS-sigma e controllare se ci sono osservazionidevianti. Queste, cliccando sui pulsanti R o C, potranno essere classificate come rappresentative ocorrelate.Figura 3.35. Sottomaschera PROFILO MODALE della maschera CNCP-STS <strong>di</strong> una STS non nazionale.100
IL SOFTWARE DI INFORMATIZZAZIONE DEI DATIFigura 3.36. Sottomaschera EXTRA della maschera CNCP-STS <strong>di</strong> una STS non nazionali.Figura 3.37. Sottomaschera SITO MODALE BD della maschera CNCP-STS <strong>di</strong> una STS nazionale.A questo punto si faranno girare nuovamente le statistiche dal menù Gestioni Aggiorna statistiche STS eAggiorna moda STS quin<strong>di</strong>, cliccando sul pulsante Assegna della maschera CNCP-STS (fig. 3.31), siaprirà la sottomaschera Ve<strong>di</strong> osservazioni STS (fig. 3.40) dove si potranno in<strong>di</strong>viduare, fra le osservazionitipiche, quelle con in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> <strong>di</strong>versità (ve<strong>di</strong> cap. 1) minore e fra <strong>di</strong> esse si potrà scegliere quella che andràa costituire il caposaldo dell’STS.Una volta assegnato il profilo caposaldo all’STS, cliccando nella maschera CNCP-STS (fig. 3.31) suiriquadri grigi relativi alle classificazioni Soil taxonomy o WRB del profilo caposaldo, il software andrà aricercare automaticamente le classificazioni Soil taxonomy e WRB, che appariranno nel riquadri grigi.Per aggiornare la classificazione della STS si deve cliccare sui riquadri bianchi delle classificazioni Soiltaxonomy e WRB e in questa maniera verranno copiate le classificazioni del profilo caposaldo. Nel casoin cui la classificazione del sito modale dell’STS sia <strong>di</strong>versa da quella del caposaldo, si dovranno inserire101
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICImanualmente le classificazioni nei riquadri bianchi. Cliccando sul pulsante Apri scheda della mascheraCNCP-STS si potrà accedere alla maschera Caratteri della stazione del profilo caposaldo.Figura 3.38. Sottomaschera PROFILO MODALE BD della maschera CNCP-STS <strong>di</strong> una STS nazionale.Figura 3.39. Sottomaschera EXTRA BD della maschera CNCP-STS <strong>di</strong> una STS nazionale.Figura 3.40. Sottomaschera ve<strong>di</strong> osservazioni STS.102
IL SOFTWARE DI INFORMATIZZAZIONE DEI DATIFigura 3.41. Sottomaschera <strong>dati</strong> incerti della STS-sigma3.Figura 3.42. Sottomaschera <strong>dati</strong> incerti della STS-sigma2.Cliccando sul pulsante Stampa la STS nella maschera CNCP-STS si ha la visualizzazione del reportriassuntivo dell’STS (fig. 1.7), che potrà essere salvato in formato .rtf cliccando sul report stesso col tastodestro del mouse e andando su esporta, oppure potrà essere stampato andando sull’icona <strong>di</strong> stampa <strong>di</strong>Access. Cliccando sul pulsante Stampa le STS <strong>di</strong> UTS nella maschera STS avremo la visualizzazione <strong>dei</strong>report riassuntivi <strong>di</strong> tutte le STS dell’UTS. Ciccando su Stampa i caposaldo avremo la visualizzazione <strong>dei</strong>report <strong>di</strong> stampa <strong>di</strong> tutti i caposaldo dell’UTS.Una volta create le STS, queste possono essere legate alle componenti territoriali <strong>di</strong> ogni livellogeografico tramite le tabelle relazionali, Geo_legame_sts_st, Geo_legame_sts_sst e Geo_legame_sts_ut,in cui le STS sono legate ai <strong>dati</strong> areali tramite i poligoni <strong>di</strong> appartenenza geografica e le tabelle relazionaliCT-ST_STS, CT-SST_STS e CT-UT_STS, in cui le STS sono legate ai <strong>dati</strong> areali tramite le componentiterritoriali <strong>di</strong> attribuzione semantica. Per creare le tabelle relazionali CT-ST_STS, CT-SST_STS e CT-UT_STS basta cliccare sui pulsanti CT Unità, CT Sottosistemi e CT Sistemi presenti in basso a destraall’interno <strong>di</strong> un riquadro dal bordo giallo nella maschera CNCP-STS (fig. 3.31). Cliccando su questipulsanti si apriranno le relative sottomaschere denominate Componenti territoriali delle sottounità (fig.3.43). In esse cliccando sul pulsante importa CT osservazioni il software importerà automaticamente lecomponenti territoriali e i pedopaesaggi (regione pedologica, sistema, sottosistema, unità <strong>di</strong> terre) a cuisono attribuiti semanticamente i profili che appartengono alla STS, che <strong>di</strong>venteranno quelli attribuiti allaSTS. Nei campi “% STS in CT” può essere in<strong>di</strong>cato il grado <strong>di</strong> copertura percentuale delle STSall’interno della componente territoriale (in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> purezza), che nell’esempio della figura 3.43 non è statodeterminato. Nel caso i <strong>dati</strong> dell’STS siano inseriti manualmente, e in tutti gli altri casi in cui lecomponenti territoriali <strong>di</strong> attribuzione semantica siano <strong>di</strong> provenienza bibliografica, questa informazionepotrà essere inserita nel campo Fonte.103
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICIFigura 3.43. sottomaschera Componenti territoriali delle sottounità.3.4.2.5 GeografiaCliccando sul pulsante GEOGRAFIA della barra <strong>di</strong> start si apre la maschera CNCP-Geografia (fig. 3.44).Con questa maschera è possibile ottenere le tabelle riassuntive <strong>dei</strong> caratteri geografici e <strong>pedologici</strong>associati ai poligoni <strong>dei</strong> vari livelli pedopaesaggistici. Cliccando sui pulsanti visualizza componentiterritoriali <strong>dei</strong> poligoni ST, SST e UT si aprono le maschere che visualizzano i <strong>dati</strong> delle tabelle CT_ST,CT_SST e CT_UT. Cliccando sui pulsanti osservazioni nei riquadri CREA TABELLA DI LEGAMECON ST, SST e UT, il software crea le tabelle Geo_legame_osservazioni_st,Geo_legame_osservazioni_sst e Geo_legame_osservazioni_ut del CNCP_b.mdb, dove vengono in<strong>di</strong>catetutte le osservazioni pedologiche attribuite ad ogni componente territoriale <strong>dei</strong> poligoni <strong>di</strong> ST, SST e UT.Cliccando sui pulsanti sottounità tipologiche nei riquadri CREA TABELLA DI LEGAME CON ST, SSTe UT, il software crea le tabelle Geo_legame_sts_st, Geo_legame_sts_sst e Geo_legame_sts_ut delCNCP_b.mdb, dove vengono in<strong>di</strong>cate tutte le STS attribuite ad ogni componente territoriale <strong>dei</strong> poligoni<strong>di</strong> ST, SST e UT. Per visualizzare le tabelle create basta andare nei riquadri VISUALIZZA TABELLA DILEGAME DEI DATI PEDOLOGICI CON ST, SST e UT e cliccare su osservazioni o sottounitàtipologiche e si apriranno così le relative maschere <strong>di</strong> visualizzazione (figg. 3.45 e 3.46).104
IL SOFTWARE DI INFORMATIZZAZIONE DEI DATIFigura 3.44. Maschera CNCP-Geografia.Figura 3.45. Maschera CNCP-Geo_legame_osservazioni_st.105
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICIFigura 3.46. Maschera CNCP-Geo_legame_sts_st.3.4.2.6 Meccanismi <strong>di</strong> attribuzione semantica delle osservazioni pedologicheI meccanismi <strong>di</strong> attribuzione delle osservazioni pedologiche alle componenti territoriali <strong>dei</strong> poligoni <strong>di</strong> ST, SSTe UT hanno <strong>di</strong>versi gra<strong>di</strong> <strong>di</strong> atten<strong>di</strong>bilità. Il principio ispiratore <strong>dei</strong> meccanismi <strong>di</strong> attribuzione delleosservazioni pedologiche alla geografia, cioè alle componenti territoriali <strong>dei</strong> sistemi, sottosistemi e unità<strong>di</strong> terre, è che l’osservazione rappresenta più fedelmente i suoli <strong>di</strong> un’area quanto maggiore è la vicinanzasemantica e geografica tra l’osservazione e la componente territoriale. La massima affidabilità si haquando il sito descrive proprio quella combinazione <strong>di</strong> morfologia, litologia e uso del suolo presente inquel poligono. L’atten<strong>di</strong>bilità <strong>di</strong>minuisce man mano che ci si allontana geograficamente (l’osservazionerappresenta i suoli <strong>di</strong> poligoni <strong>di</strong>versi da quello indagato) e semanticamente (poligoni appartenenti alivelli geografici più generalizzati).I suddetti meccanismi <strong>di</strong> attribuzione semantica vengono azionati per mezzo della maschera CNCP-Geografia (fig. 3.44) e come abbiamo detto nel paragrafo precedente vanno ad aggiornare le tabelle <strong>di</strong>geo-legame fra le osservazioni e le componenti territoriali <strong>dei</strong> vari livelli <strong>di</strong> pedopaesaggio(geo_legame_osservazioni_st, geo_legame_osservazioni_sst e geo_legame_osservazioni_ut). È benericordare che il presupposto per il funzionamento <strong>di</strong> tutto il sistema è sempre quello <strong>di</strong> avere inseritocorrettamente i <strong>dati</strong> <strong>di</strong> partenza per quanto riguarda la localizzazione geografica, il poligono <strong>di</strong>appartenenza geografica e l’attribuzione semantica alla componente territoriale del livello geografico <strong>di</strong>riferimento <strong>di</strong> ogni osservazione pedologica. In generale il meccanismo <strong>di</strong> funzionamento è il seguente:inizialmente il software crea delle tabelle temporanee dove vengono accodate tutte le attribuzionisemantiche possibili fra le osservazioni e le componenti territoriali <strong>dei</strong> poligoni; in seguito a partire dalletabelle temporanee create il software crea le tabelle <strong>di</strong> geo-legame nelle quali, fra tutte le attribuzionipossibili per ogni coppia osservazione-componente territoriale <strong>di</strong> ogni poligono <strong>di</strong> pedopaesaggio,vengono scelte quelle con migliore atten<strong>di</strong>bilità.Grazie alle tabelle <strong>di</strong> geo-legame così create è possibile verificare i legami molti a molti che esistonofra le osservazioni pedologiche e le componenti territoriali del livello geografico <strong>di</strong> riferimento, con lerelative qualità <strong>di</strong> attribuzione. Questo sistema è basilare per l’estensione dell’informazione pedologicapuntuale al numero maggiore possibile <strong>di</strong> componenti territoriali <strong>di</strong> ogni livello pedopaesaggistico epermette, così, <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare le componenti territoriali maggiormente prive <strong>di</strong> informazione pedologicaper ogni livello qualitativo. Questa operazione è alla base del <strong>rilevamento</strong> pedologico GIS oriented (ve<strong>di</strong>par. 1.3).106
IL SOFTWARE DI INFORMATIZZAZIONE DEI DATIPrimo meccanismo <strong>di</strong> attribuzione (co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> atten<strong>di</strong>bilità o qualità 1)É dato dalla corrispondenza semantica e geografica della osservazione pedologica alla componenteterritoriale del livello geografico <strong>di</strong> riferimento. Si verifica nel caso in cui il sito viene attribuito ad unaCT presente nel poligono dello strato geografico <strong>di</strong> riferimento in cui il sito ricade. Nel caso <strong>dei</strong> sistemi <strong>di</strong>terre, ad esempio, l’osservazione ha la stessa co<strong>di</strong>fica geografica della componente territoriale delpoligono in cui ricade. Per ogni osservazione il software va a ricercare i casi in cui l’istanza nel campoCT_st (o CT_sst o CT_ut) e nel campo Poly_geo_st (o Poly_geo_sst o Poly_geo_ut) della tabella siti èuguale a quella <strong>dei</strong> corrispettivi campi CT_ID e POLY_ID (o NEW_ID per i sottosistemi) della tabellaCT_ST (o CT_SST o CT_UT). La figura 3.47 riporta la query <strong>di</strong> accodamento geo_attribuzione1_st, che èquella relativa al meccanismo <strong>di</strong> attribuzione con classe <strong>di</strong> atten<strong>di</strong>bilità uno delle osservazionipedologiche alle componenti territoriali <strong>dei</strong> sistemi.Figura 3.47. Struttura della query <strong>di</strong> accodamento geo_attribuzione1_st.Secondo meccanismo <strong>di</strong> attribuzione (co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> atten<strong>di</strong>bilità o qualità 2)É dato dalla corrispondenza semantica, ma non geografica, della osservazione alla componenteterritoriale del livello geografico <strong>di</strong> riferimento. Si verifica nel caso in cui il sito venga attribuito ad unaCT presente nei poligoni con co<strong>di</strong>ci identificativi dello strato geografico <strong>di</strong> riferimento e degli stratisuperiori-uguali a quelli propri del sito. Ad esempio, nel caso <strong>dei</strong> sistemi <strong>di</strong> terre, per ogni osservazionepedologica il software va a ricercare i casi in cui l’istanza <strong>dei</strong> campi CT_st, soil_region e sistema_terredella tabella siti è uguale a quella <strong>dei</strong> corrispettivi campi CT_ID, SR_ID e ST_ID della tabella CT_ST(fig. 3.48). Quando si lavora con i sottosistemi <strong>di</strong> terre, per ogni osservazione pedologica il software va aricercare i casi in cui l’istanza <strong>dei</strong> campi CT_sst, soil_region, sistema_terre e s_sist_terre della tabella sitiè uguale a quella <strong>dei</strong> corrispettivi campi CT_ID, SR_ID, ST_ID e SST_ID della tabella CT_SST. Quandosi lavora con le unità <strong>di</strong> terre, per ogni osservazione pedologica il software va a ricercare i casi in cuil’istanza <strong>dei</strong> campi CT_ut, soil_region, sistema_terre, s_sist_terre e un_terre della tabella siti è uguale aquella <strong>dei</strong> corrispettivi campi CT_ID, SR_ID, ST_ID, SST_ID e UT_ID della tabella CT_UT.107
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICIFigura 3.48. Struttura della query <strong>di</strong> accodamento geo_attribuzione2_st.Terzo meccanismo <strong>di</strong> attribuzione (co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> atten<strong>di</strong>bilità o qualità 3)É dato dalla corrispondenza semantica della osservazione con una componente territoriale ad un livellogeografico superiore a quello <strong>di</strong> riferimento. Si verifica nel caso in cui il sito viene attribuito ad una CTpresente nei poligoni con co<strong>di</strong>ci identificativi degli strati geografici superiori a quello <strong>di</strong> riferimento,uguali a quelli del sito. Ad esempio, nel caso <strong>dei</strong> sistemi <strong>di</strong> terre, per ogni osservazione pedologica ilsoftware verifica i casi in cui l’istanza <strong>dei</strong> campi CT_st e soil_region della tabella siti è uguale a quella<strong>dei</strong> corrispettivi campi CT_ID e SR_ID della tabella CT_ST (fcon i sottosistemi <strong>di</strong> terre, per ogni osservazionepedolcampi CT_sst, soil_region e sistema_terre della tabella siti è uguale a quella <strong>dei</strong> corrispettivicampi CT_ID, SR_ID e ST_ID della tabella CT_SST. Quosservazione pedologica il software va aricercare i casi in cui l’istanza <strong>dei</strong> campi CT_ut, soil_region, sistema_terre e s_sist_terre della tabellasiti è uguale a quella <strong>dei</strong> corrispettivi campi CT_ID, SR_ID, ST_ID e SST_ID della tabella CT_UT.108
IL SOFTWARE DI INFORMATIZZAZIONE DEI DATIFigura 3.49. Struttura della query <strong>di</strong> accodamento geo_attribuzione3_st.Quarto meccanismo <strong>di</strong> attribuzione (co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> atten<strong>di</strong>bilità o qualità 4)É dato dalla corrispondenza semantica della osservazione con una componente territoriale ad un livellogeografico <strong>di</strong> due livelli superiore a quello <strong>di</strong> riferimento. Ciò si verifica nel caso in cui il sito vieneattribuito ad una CT presente nei poligoni con co<strong>di</strong>ci identificativi degli strati geografici <strong>di</strong> due livellisuperiori rispetto al livello <strong>di</strong> riferimento uguali a quelli del sito ed è presente, dunque, solo per il livellogeografico <strong>dei</strong> sottosistemi e delle unità <strong>di</strong> terre. Ad esempio, nel caso <strong>dei</strong> sottosistemi <strong>di</strong> terre, per ogniosservazione pedologica il software verifica i casi in cui l’istanza <strong>dei</strong> campi CT_sst e soil_region dellatabella siti è uguale a quella <strong>dei</strong> corrispettivi campi CT_ID e SR_ID della tabella CT_SST (fig.3.50). Quando si lavora con le unità <strong>di</strong> terre, per ogni osservazione pedologica il software va a ricercarei casi in cui l’istanza <strong>dei</strong> campi CT_ut, soil_region e sistema_terre della tabella siti è uguale a quella <strong>dei</strong>corrispettivi campi CT_ID, SR_ID e ST_ID della tabella CT_UT.109
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICIFigura 3.50. Struttura della query <strong>di</strong> accodamento geo_attribuzione4_sst.Quinto meccanismo <strong>di</strong> attribuzione (co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> atten<strong>di</strong>bilità o qualità 5)É dato dalla corrispondenza semantica della osservazione con una componente territoriale ad un livellogeografico <strong>di</strong> tre gra<strong>di</strong> superiore a quello <strong>di</strong> riferimento. É il caso in cui il sito viene attribuito ad una CTpresente nei poligoni con uguale co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> soil region. Questo meccanismo <strong>di</strong> attribuzione è applicatosolo quando si lavora con le unità <strong>di</strong> terre. Per ogni osservazione pedologica il software va controllare sel’istanza <strong>dei</strong> campi CT_ut e soil_region della tabella siti è uguale a quella <strong>dei</strong> campi CT_ID e SR_IDdella tabella CT_UT (fig. 3.51).110
IL SOFTWARE DI INFORMATIZZAZIONE DEI DATIFigura 3.51. Struttura della query <strong>di</strong> accodamento geo_attribuzione5_ut.Sesto meccanismo <strong>di</strong> attribuzione (co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> atten<strong>di</strong>bilità o qualità 6)É dato dalla mancanza <strong>di</strong> qualsiasi corrispondenza semantica della osservazione con tutti i livelligeografici. In questo caso il sito viene attribuito con atten<strong>di</strong>bilità 6 al poligono dello strato geografico <strong>di</strong>riferimento in cui ricade geograficamente.3.4.2.7 Meccanismi <strong>di</strong> attribuzione semantica delle STSPer l’attribuzione semantica delle STS vengono utilizzati dal software meccanismi analoghi a quelliadoperati per le osservazioni pedologiche, così come riassunti nella tabella 3.2 e che si azionano graziea query come quelle <strong>di</strong> esempio riportate nelle figure 3.52, 3.53, 3.54 e 3.55. Anche questi meccanismi,come quelli relativi alle osservazioni pedologiche, vengono azionati per mezzo della maschera CNCP-Geografia (fig. 3.44) e vanno ad aggiornare le tabelle <strong>di</strong> geo-legame fra le STS e le componenti territoriali<strong>dei</strong> vari livelli <strong>di</strong> pedopaesaggio (geo_legame_sts_st, geo_legame_sts_sst e geo_legame_sts_ut).Anche inquesto caso è bene ricordare che il presupposto per il funzionamento <strong>di</strong> tutto il sistema è sempre quello <strong>di</strong>avere inserito per ogni STS l’attribuzione semantica alla componente territoriale del livello geografico <strong>di</strong>riferimento, avvalendosi, degli strumenti <strong>di</strong> gestione delle maschere Componenti territoriali dellesottounità (fig. 3.43). Grazie alle tabelle <strong>di</strong> geo-legame così create è possibile verificare i legami molti amolti che esistono fra le STS e le componenti territoriali del livello geografico <strong>di</strong> riferimento, conle relative qualità <strong>di</strong> attribuzione.Tabella 3.2. Significato <strong>dei</strong> co<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> atten<strong>di</strong>bilità <strong>di</strong> attribuzione semantica delle STS alle componenti territoriali.Co<strong>di</strong>ce Descrizione1 Attribuzione della STS a CT presenti nei poligoni con co<strong>di</strong>ci identificativi dello stratogeografico <strong>di</strong> riferimento e degli strati superiori-uguali a quelli delle osservazioni che compongonol'STS stessa2 Attribuzione della STS a CT presenti nei poligoni con co<strong>di</strong>ci identificativi degli strati geografici111
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICIsuperiori a quello <strong>di</strong> riferimento, uguali a quelli delle osservazioni che compongono l'STS stessa3 Attribuzione della STS a CT presenti nei poligoni con co<strong>di</strong>ci identificativi degli strati geografici<strong>di</strong> due livelli superiori a quello <strong>di</strong> riferimento,uguali a quelli delle osservazioni che compongonol'STS stessa (livello <strong>di</strong> attribuzione presente solo per i sottosistemi <strong>di</strong> terre e le unità <strong>di</strong>terre)4 Attribuzione della STS a CT presenti nei poligoni con co<strong>di</strong>ce dello strato geografico <strong>di</strong> soilregion uguale a quello delle osservazioni che compongono l'STS stessa (livello <strong>di</strong> attribuzionepresente solo per le unità <strong>di</strong> terre)Figura 3.52. Struttura della query <strong>di</strong> accodamento geo_attribuzione2_st_sts per l’attribuzione con grado 1 <strong>di</strong>atten<strong>di</strong>bilità delle STS alle CT_ST.Figura 3.53. Struttura della query <strong>di</strong> accodamento geo_attribuzione3_st_sts per l’attribuzione con grado 2 <strong>di</strong>atten<strong>di</strong>bilità delle STS alle CT_ST.Figura 3.54. Struttura della query <strong>di</strong> accodamento geo_attribuzione4_sst_sts per l’attribuzione con grado 3 <strong>di</strong>atten<strong>di</strong>bilità delle STS alle CT_SST.112
IL SOFTWARE DI INFORMATIZZAZIONE DEI DATIFigura 3.55. Struttura della query <strong>di</strong> accodamento geo_attribuzione5_ut_sts per l’attribuzione con grado 4 <strong>di</strong>atten<strong>di</strong>bilità delle STS alle CT_UT.3.4.3 Barra <strong>di</strong> menùNei paragrafi seguenti vengono illustrate le funzionalità previste grazie all’uso della barra <strong>di</strong> menù.3.4.3.1 Menù FileCarica <strong>dati</strong> esterniImportazione in Access <strong>di</strong> file <strong>di</strong> vari formati; dbf, rtf, xls, html, txt ecc.EsportaÉ simile al salva con nome: permette <strong>di</strong> salvare un oggetto <strong>di</strong> Access all’interno dell’applicazioneCNCP_m.mdb in un altro formato. Ad esempio, si può trasformare una tabella in una maschera o in unreport oppure salvare un maschera come report, convertire una macro in co<strong>di</strong>ce VBA ecc.Imposta stampantePermette <strong>di</strong> impostare le modalità della pagina da stampare.Anteprima <strong>di</strong> stampaApre l’anteprima <strong>di</strong> stampa della maschera o report selezionato.StampaSetta il tipo <strong>di</strong> stampante da usare per stampa della pagina corrente, settando preliminarmente le proprietà.Invia (x)Permette <strong>di</strong> inviare la maschera o il report selezionato ad un in<strong>di</strong>rizzo e-mail.EsciChiude l’applicazione CNCP_m.mdb.ImportaApre la finestra <strong>di</strong> gestione per l’importazione <strong>di</strong> oggetti da altri database.113
3.4.3.2 Menù GestioniLINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICIAggiorna statistiche STSInnesca la macro che avvia una serie <strong>di</strong> azioni automatiche (che nel CNCP_m.mdb corrispondono ad unasequenza <strong>di</strong> query <strong>di</strong> aggiornamento) per mezzo delle quali si ottengono 3 risultati:- il calcolo <strong>di</strong> alcuni semplici in<strong>di</strong>ci statistici, quali numerosità campionaria, me<strong>di</strong>a e deviazione standard,relativi alle caratteristiche degli orizzonti funzionali;- l’aggiornamento del campo codex della tabella siti del CNCP_b.mdb (stringa <strong>di</strong> testo dove si accorpanoi campi co<strong>di</strong>ce_<strong>rilevamento</strong>, tipo_osservazione e numero_osservazione);- l’aggiornamento della classe <strong>di</strong> Capacità d’uso e <strong>di</strong> fertilità LCC delle STS (solo se tutti i parametriprevisti sono inseriti).Le me<strong>di</strong>e e le deviazioni standard degli orizzonti funzionali sono eseguite su <strong>dati</strong> analitici e su alcuni <strong>dei</strong>caratteri stimati in campagna (es. pietrosità) a partire da una query che seleziona tutti i <strong>dati</strong> e poi liraggruppa per co<strong>di</strong>ce UTS, co<strong>di</strong>ce STS e co<strong>di</strong>ce Orizzonte funzionale. Il risultato è visibile sia nellamaschera CNCP – STS (figg. 3.34 e 3.35), sia in forma riassunta nel report <strong>di</strong> stampa delle STS (fig. 1.7).Dal calcolo sono escluse le osservazioni correlate.Aggiorna moda STSInnesca la macro che avvia una serie <strong>di</strong> azioni automatiche (che nel CNCP_m.mdb corrispondono ad unasequenza <strong>di</strong> query <strong>di</strong> aggiornamento) per mezzo delle quali si ottengono 2 risultati:- la determinazione <strong>dei</strong> valori stazionali modali (ve<strong>di</strong> par. 1.2.3.1);- l’aggiornamento delle classificazioni delle STS una volta definiti i profili caposaldo.Le mode <strong>dei</strong> caratteri stazionali sono eseguite a partire da una query che seleziona tutti i <strong>dati</strong> e poi liraggruppa per co<strong>di</strong>ce UTS e co<strong>di</strong>ce STS. Il risultato è visibile sia nella maschera CNCP – STS (figg. 3.34e 3.35), sia in forma riassunta nel report <strong>di</strong> stampa delle STS (fig. 1.7). Dal calcolo sono escluse leosservazioni correlate.Aggiorna moda UTSAttiva la macro che avvia una serie <strong>di</strong> azioni automatiche (che nel CNCP_m.mdb corrispondono ad unasequenza <strong>di</strong> query <strong>di</strong> aggiornamento) per mezzo delle quali si ottiene l’aggiornamento <strong>dei</strong> valoristazionali modali delle UTS. Il risultato è visibile sia nella maschera CNCP – UTS (fig. 3.29), sia informa riassunta nel report <strong>di</strong> stampa delle UTS (fig. 1.6).Deco<strong>di</strong>ficheApre la maschera Gruppi tabellari con le relative tre finestre:- la finestra superiore (SPECIE TABELLA) che visualizza la tabella Specie Tabelle del CNCP_m.mdb,dove sono in<strong>di</strong>cati i co<strong>di</strong>ci relativi a tutte le aggregazioni <strong>di</strong> attributi della banca <strong>dati</strong>, che riprendono lespecifiche illustrate nel capitolo 3 del presente manuale;- la finestra interme<strong>di</strong>a, che visualizza e permette <strong>di</strong> aggiornare la tabella Deco<strong>di</strong>fiche del CNCP_b.mdb;- la finestra inferiore, che visualizza e permette <strong>di</strong> aggiornare la tabella Abbinamenti del CNCP_b.mdb.Nel campo descrizione_in_stampa viene mostrata la stringa <strong>di</strong> testo che viene stampata dal report quandoviene deco<strong>di</strong>ficato un certo attributo; nel campo tipo_ deco<strong>di</strong>fica si <strong>di</strong>stingue quali campi hanno un co<strong>di</strong>cefisso a valore (esempio drenaggio interno) e quali invece co<strong>di</strong>ficano con intervalli <strong>di</strong> valore (esempio<strong>di</strong>mensione <strong>dei</strong> pori).Meto<strong>di</strong> analiticiApre la tabella Meto<strong>di</strong> analitici del CNCP_b.mdb con i co<strong>di</strong>ci “ISO” delle metodologie <strong>di</strong> analisi.114
IL SOFTWARE DI INFORMATIZZAZIONE DEI DATIRilevatoriApre la tabella Rilevatori del CNCP_b.mdb dove è presente l’elenco <strong>dei</strong> rilevatori che hanno realizzato leosservazioni presenti in banca <strong>dati</strong>, ad ognuno <strong>dei</strong> quali viene assegnato un co<strong>di</strong>ce.Tipo <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>nateApre la tabella coor<strong>di</strong>nate del CNCP_b.mdb con l’elenco <strong>dei</strong> sistemi <strong>di</strong> riferimento più comuni. Ildatabase offre la possibilità <strong>di</strong> memorizzare 2 tipi <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>nate: metriche (in qualsiasi sistema <strong>di</strong>riferimento) e geografiche (latitu<strong>di</strong>ne e longitu<strong>di</strong>ne espresse in gra<strong>di</strong> decimali nel sistema wgs84).Quest’ultimo è il sistema <strong>di</strong> riferimento standard che viene usato per le operazioni <strong>di</strong> join geografico tra isuoli ed i livelli geografici (ve<strong>di</strong> par. 3.4.2.2 e par. 3.5).Tipo <strong>di</strong> analisiApre e permette <strong>di</strong> aggiornare la tabella Deco<strong>di</strong>fiche del CNCP_b.mdb filtrata per la specie_tabellaanalisi_extra, permettendo <strong>di</strong> inserire analisi non previste dalla banca <strong>dati</strong>, ma utili per la gestione <strong>dei</strong>suoli. É necessario assegnare un co<strong>di</strong>ce univoco alla analisi immessa ed una descrizione.Classi <strong>di</strong> atten<strong>di</strong>bilità geograficaApre la tabella Atten<strong>di</strong>bilità del CNCP_b.mdb con le descrizioni delle atten<strong>di</strong>bilità con cui viene attribuitauna certa osservazione pedologica o una certa STS alle componenti territoriali <strong>dei</strong> sistemi <strong>di</strong> terre, <strong>dei</strong>sottosistemi <strong>di</strong> terre e delle unità <strong>di</strong> terre.Co<strong>di</strong>ci ISTAT <strong>dei</strong> comuniVisualizza la tabella Comuni del CNCP_b.mdb con i co<strong>di</strong>ci ISTAT <strong>dei</strong> comuni <strong>di</strong> Italia aggiornati al 1gennaio 2008. Sono consentite aggiunte e mo<strong>di</strong>fiche in caso <strong>di</strong> variazioni.Formazioni geologiche italianeApre la Tabella formaz_geo_ita del CNCP_b.mdb che contiene un elenco delle formazioni geologichepresenti in Italia e la relativa sigla inseribile nella sottomaschera CARATTERI PROFONDI dellamaschera Caratteri della Stazione del CNCP_m.mdb.Tramite un collegamento ipertestuale al sito http://www.accordo-carg.it (APAT et al., 2004) c’è lapossibilità <strong>di</strong> visualizzare i file .pdf relativi al catalogo delle formazioni geologiche italiane, realizzato dalDipartimento Difesa del suolo dell’APAT.RegioniApre la tabella Regioni del CNCP_b.mdb, dove c’è l’elenco <strong>di</strong> tutte le regioni italiane e relativadeco<strong>di</strong>fica.Gestioni foto STSApre la maschera Gestione Foto STS per la scelta delle fotografie rappresentative delle STS (ve<strong>di</strong> 3.4.2.2)3.4.3.3 Menù StampeAnteprima UTSApre l’anteprima <strong>di</strong> stampa <strong>dei</strong> report <strong>di</strong> tutte le UTS.Anteprima STSApre l’anteprima <strong>di</strong> stampa <strong>dei</strong> report delle STS:- tutte, apre l’anteprima <strong>di</strong> stampa <strong>di</strong> tutte le STS presenti nel database;- STS <strong>di</strong> UTS, apre l’anteprima <strong>di</strong> stampa delle sole STS appartenenti ad una certa UTS a scelta;115
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICI- STS <strong>di</strong> UTS in inglese, come sopra con deco<strong>di</strong>fiche in inglese.Anteprima profiliApre l’anteprima <strong>di</strong> stampa del report <strong>di</strong> stampa <strong>dei</strong> profili. L’apertura del report attiva l’applicazione“Pubblica con MS word” (in alto nei menù <strong>di</strong> Access) che permette <strong>di</strong> esportare il contenuto del report informato .rtf, precisando che la inevitabile per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> formattazione, rende tale documento <strong>di</strong> qualità nonottimale. Access permetterebbe anche l’esportazione del report in formato HTML (Macro/nuova macro/output su – opzione salva in HTML) ma la per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> formattazione in questo caso è ancora piùaccentuata. Esistono due opzioni <strong>di</strong> apertura:- per STS , apre una maschera nella quale possiamo scegliere una o più descrizioni <strong>di</strong> profili da stamparein un certo intervallo <strong>di</strong> STS;- in italiano, apre una maschera nella quale possiamo scegliere una o più descrizioni <strong>di</strong> profili dastampare, in<strong>di</strong>cando il co<strong>di</strong>ce <strong>rilevamento</strong> e numero <strong>di</strong> osservazione si apre l’anteprima <strong>di</strong> stampadell’intervallo <strong>di</strong> profili scelto;- in inglese, come sopra con deco<strong>di</strong>fiche in inglese.StampaUna volta create le anteprime esistono tre possibili uscite <strong>di</strong> stampa: 1) <strong>di</strong>rettamente da Access, con leimpostazioni relative alla stampante istallata; 2) in .pdf se nel sistema è installato Adobe Acrobat o PDFCreator; 3) in .rtf, con lo strumento analizza con microsoft Word <strong>di</strong> Access.Il secondo metodo richiede che dal menù file si selezioni il sottomenù stampe e nel nome dellastampante si scelga Acrobat <strong>di</strong>stiller o Acrobat PDF writer. Queste sono due applicazioni che simulanouna stampante, creando un file .pdf. Per creare tale file si può agire <strong>di</strong>rettamente da Crea PDF del Menùstampe.Crea PDFTramite questa funzione che si appoggia al modulo PDF Creator da installare separatamente alla banca<strong>dati</strong> (scaricabile gratuitamente su http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/) si può creare un file .pdf contutte le UTS o con tutte le STS.3.4.3.4 Menù PedofunzioniAWC siti e analisi routinarie (Saxton)Avvia la query per la stima dell’AWC <strong>di</strong> ogni sito e <strong>di</strong> ogni orizzonte effettuata con il metodo Saxton(Saxton et al., 1986). Il calcolo esegue automaticamente la correzione per lo scheletro e considera solo gliorizzonti compresi nella profon<strong>di</strong>tà utile. Il risultato della pedofuzione è visibile sia nella sottomascheraQUALITA’ della Maschera CNCP-Caratteri della stazione (fig 3.15) sia nella sottomaschera ANALISIROUTINARIE della maschera CNCP-Orizzonti (fig. 3.22) andando a cliccare sul pulsantepresente nel riquadro relativo ai <strong>dati</strong> <strong>di</strong> AWC.CSC analisi routinarie (Blume)Avvia la query <strong>di</strong> selezione per la stima della CSC <strong>di</strong> ogni orizzonte effettuata con il metodo Blume(Blume et al., 1990) presupponendo una mineralogia mista. Non è stato implementato il metodo, invece,per le altre mineralogie.Capacità depurativa sitiAvvia la query per la stima della capacità depurativa <strong>dei</strong> siti secondo il metodo definito dalla RegioneEmilia Romagna (R.E.R., 1995).116
IL SOFTWARE DI INFORMATIZZAZIONE DEI DATICapacità protettiva sitiAvvia la query per la stima della capacità protettiva <strong>dei</strong> suoli nei confronti dalle acque profonde secondoil metodo definito dall’Ente Regionale <strong>di</strong> Sviluppo agricolo della Regione Lombar<strong>di</strong>a (ERSAL, 2000).Permeabilità orizzonti (Rawls_Brakensiek)Avvia la query per la stima della conducibilità idraulica satura degli orizzonti secondo il metodo propostodal Soil Survey Manual dell’USDA (Rawls e Brakensiek, 1983).Capacità d’uso siti e sottounitàAvvia la query per la stima della capacità d’uso <strong>dei</strong> siti e delle STS (Costantini, 2006).Gruppo idrologico sitiAvvia la query per la stima del gruppo idrologico <strong>dei</strong> siti (Soil Survey Division Staff, 1993).Interferenza climaticaAvvia la query per la stima della interferenza climatica <strong>dei</strong> siti (Costantini, 2006).Pedoclima sitiAvvia la query per la stima del pedoclima <strong>dei</strong> siti (Costantini et al., 2001; L’Abate et al., 2004).Rischio <strong>di</strong> incrostamento PRSAvvia la query per la stima del rischio <strong>di</strong> incrostamento superficiale <strong>dei</strong> siti (Pellegrini et al., 2005).Rischio <strong>di</strong> compattamento PRSAvvia la query per la stima del rischio <strong>di</strong> compattamento superficiale <strong>dei</strong> siti (Vignozzi et al., 2005).3.4.3.5 Menù UtiliCompatta DBApre una Utility <strong>di</strong> Access che permette <strong>di</strong> comprimere le <strong>di</strong>mensioni del file CNCP_m.mdbRelazioni DBApre una finestra che mostra come sono relazionate tra loro le tabelle. La variazione <strong>dei</strong> Join tra questedeve essere effettuata con la massima cautela e con la competenza necessaria, in quanto la variazionedelle relazioni può pregiu<strong>di</strong>care il funzionamento del database e dell’applicazione stessa.Filtro <strong>di</strong> ricercaPermette <strong>di</strong> applicare filtri complessi sul campo attivo premendo il tasto F5 della tastiera. In ognimaschera, rendendo attiva qualsiasi casella <strong>di</strong> testo/combinata, si può richiamare con il tasto F5 un filtroche permette <strong>di</strong> selezionare i record con opportuni operatori <strong>di</strong> selezione (es: contiene, inizia, terminaecc.). Questa opzione è preferibile rispetto ai filtri standard, per evitare <strong>di</strong> commettere degli errori,mo<strong>di</strong>ficando inopportunamente i valori <strong>dei</strong> campi.Fattori <strong>di</strong> conversioneApre una tabella riassuntiva <strong>dei</strong> fattori <strong>di</strong> conversione <strong>di</strong> alcuni elementi chimici del suolo.Colori del suolo RGBApre una maschera <strong>di</strong> visualizzazione della tabella soilcolor del CNCP_m.mdb in cui si possono vedere lecorrispondenze tra i principali colori delle Munsell soil color charts ed il sistema RGB.117
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICIStatistiche descrittive (tab. siti e analisi)Apre la maschera Statistiche_descrittive che permette <strong>di</strong> confrontare i valori statistici (me<strong>di</strong>a, minimo,massimo, deviazione standard e varianza) <strong>di</strong> ogni campo delle tabelle siti e Analisi routinarie <strong>di</strong> tutte leosservazioni assegnate ad una certa STS, con esclusione delle osservazioni correlate, rispetto a quellidella popolazione totale del database.Statistiche descrittive (tab. orizzonti)Apre la maschera Statistiche_descrittive che permette <strong>di</strong> confrontare i valori statistici (me<strong>di</strong>a, minimo,massimo, deviazione standard e varianza) <strong>di</strong> ogni campo della tabella Orizzonti <strong>di</strong> tutte le osservazioniassegnate ad una certa STS, con esclusione delle osservazioni correlate, rispetto a quelli della popolazionetotale del database.CalcolatriceApre la calcolatrice <strong>di</strong> Windows.Diario aggiornamentiApre una tabella che permette <strong>di</strong> archiviare in forma descrittiva tutti i cambiamenti rilevanti che vengonoapportati a qualsiasi aspetto del database, es: variazione <strong>di</strong> struttura; aggiunta <strong>di</strong> tabelle; aggiornamento <strong>di</strong>nuovi <strong>dati</strong> o mo<strong>di</strong>fica <strong>di</strong> quelli esistenti.Query correlazioneApre un esempio <strong>di</strong> query che può essere usata per la correlazione <strong>dei</strong> suoli.3.4.4 ModuliL’ uso del motore CNCP_m.mdb, grazie alla organizzazione interna <strong>dei</strong> suoi oggetti tabelle, query,maschere, report, macro e moduli, facilita svariate funzioni quali: l’inserimento <strong>dei</strong> <strong>dati</strong> <strong>pedologici</strong>puntuali, l’inserimento degli attributi <strong>dei</strong> <strong>dati</strong> areali, la correlazione pedologica, la stampa <strong>dei</strong> report,l’archiviazione della collocazione <strong>dei</strong> materiali relativi ai <strong>dati</strong> <strong>pedologici</strong> e la gestione <strong>dei</strong> <strong>dati</strong> tramitepedofunzioni preconfigurate, che sono una funzionalità speciale rispetto alla gestione <strong>dei</strong> <strong>dati</strong> tramite inormali filtri e query <strong>di</strong> Access. Le pedofunzioni sono già state prese in considerazione nei precedentiparagrafi in quanto sono alla base del funzionamento <strong>di</strong> alcune delle funzionalità delle mascherepresentate e del menù pedofunzioni. Nel presente paragrafo vogliamo, però, fornirne il relativoriferimento procedurale e bibliografico e dare una spiegazione <strong>di</strong> come sono state tradotte in linguaggiovisual basic nei moduli (fig. 3.56) del motore CNCP_m.mdb.118
IL SOFTWARE DI INFORMATIZZAZIONE DEI DATIFigura 3.56. Moduli del CNCP_m.mdb.Questi moduli, come abbiamo detto, sono implementati nelle maschere <strong>di</strong> funzionamento del software e/onel menù pedofunzioni, ma possono anche essere richiamati nel momento in cui si costruiscono le queryin visualizzazione struttura, utilizzando il pulsante per la generazione <strong>di</strong> espressioni . Qui <strong>di</strong> seguitoforniremo la spiegazione del funzionamento e della teoria che sta alla base <strong>dei</strong> principali moduli delCNCP_m.mdb. La base per la formulazione <strong>dei</strong> moduli <strong>di</strong> base necessari al funzionamento del motoreCNCP_m.mdb è stato il sito comune (Sito comune, 2007) <strong>di</strong> applicativi gestionali in ambiente MicrosoftAccess http://www.sitocomune.com.3.4.4.1 Determinazione delle osservazioni devianti per 1, 2 o 3 σ per i caratteri funzionalialla correlazione (modulo 2_sigma)Si tratta <strong>di</strong> un modulo che determina per ogni orizzonte funzionale delle STS quali sono le osservazioniche deviano per 1, 2 o 3 σ (deviazione standard) rispetto al valore me<strong>di</strong>o del “sito modale” per queldeterminato orizzonte funzionale e per i seguenti caratteri funzionali: quota, pendenza, pietrosità,rocciosità, profon<strong>di</strong>tà utile, profon<strong>di</strong>tà della roccia, argilla, sabbia, pH, calcare totale e attivo, scheletro,carbonio organico, salinità, densità apparente, C.S.C., T.S.B., E.S.P., punto <strong>di</strong> appassimento, capacità <strong>di</strong>campo e A.W.C. Il risultato <strong>di</strong> questo calcolo automatico viene visualizzato nelle sottomaschere <strong>dati</strong>incerti della STS-sigma3, <strong>dati</strong> incerti della STS-sigma2 (figg. 3.41 e 3.42) e <strong>dati</strong> incerti della STS-sigma.3.4.4.2 Calcolo delle classi tessiturale e granulometrica (modulo Classitessiturali)Questo modulo contiene le funzioni per il calcolo delle classi tessiturali e granulometrica. Utilizzando lafunzione per il calcolo della classe tessiturale contenuta in questo modulo è possibile calcolarla per ogniorizzonte sulla base <strong>dei</strong> <strong>dati</strong> <strong>di</strong> contenuto percentuale <strong>di</strong> sabbia, argilla e limo, secondo la classificazionefornita dall’USDA (Soil Survey Staff, 2006), della quale riportiamo le soglie nella seguente tabella 3.3.119
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICITabella 3.3. Principali classi tessiturali USDA della terra fine.Co<strong>di</strong>ce Descrizione Soglie <strong>di</strong> contenuto <strong>di</strong> argilla, sabbia e limoA Argilla 40% o più <strong>di</strong> argilla, 45 % o meno <strong>di</strong> sabbia e meno del 40%(escluso) <strong>di</strong> limoAL Argilla limosa 40% o più <strong>di</strong> argilla e 40 % o più <strong>di</strong> limoAS Argilla sabbiosa 35% o più <strong>di</strong> argilla e 45 % o più <strong>di</strong> sabbiaFLA Franco limoso argillosa Dal 27% (compreso) al 40 % (escluso) <strong>di</strong> argilla e 20% o meno <strong>di</strong>sabbiaFA Franco argillosa Dal 27% (compreso) al 40 % (escluso) <strong>di</strong> argilla e dal 20% (escluso)al 45 % (compreso) <strong>di</strong> sabbia.FSA Franco sabbioso argillosa Dal 20 % (compreso) al 35 % (escluso) <strong>di</strong> argille, meno del 28 %(escluso) <strong>di</strong> limo e più del 45 % (escluso) <strong>di</strong> sabbiaFL Franco limosa 50% o più <strong>di</strong> limo e dal 12 % (compreso) al 27 % (escluso) <strong>di</strong>argilla , o dal 50 % (compreso) al 80 % (escluso) <strong>di</strong> limo e meno del12 % (escluso) <strong>di</strong> argilla.L Limo 80 % o più <strong>di</strong> limo e meno del 12 % (escluso) <strong>di</strong> argillaF Franca Dal 7 % (escluso) al 27 % (escluso) <strong>di</strong> argilla, dal 28 % (compreso)al 50 % (escluso) <strong>di</strong> limo e 52 % o meno <strong>di</strong> sabbia.FS Franco sabbiosa Dal 7 (compreso) al 20 % (escluso) <strong>di</strong> argilla, più del 52% (escluso)<strong>di</strong> sabbia, e % <strong>di</strong> limo più 2 volte % <strong>di</strong> argilla è maggiore o uguale<strong>di</strong> 30; o meno del 7% (compreso) <strong>di</strong> argilla, meno del 50 %(escluso) <strong>di</strong> limo e più del 43% (escluso) <strong>di</strong> sabbia.SF Sabbie franche Tra il 70 (escluso) e il 91 % (escluso) <strong>di</strong> sabbia e % <strong>di</strong> limo più 1,5volte % <strong>di</strong> argilla è uguale o maggiore <strong>di</strong> 15; e % <strong>di</strong> limo più 2 volte% <strong>di</strong> argilla è minore <strong>di</strong> 30S Sabbie Più dell’ 85% (escluso) <strong>di</strong> sabbia e % <strong>di</strong> limo più 1,5 volte % <strong>di</strong>argilla è minore <strong>di</strong> 15.Il risultato <strong>di</strong> questo calcolo automatico viene visualizzato nella maschera CNCP-Orizzonti nellesottomaschere DATI1 (riquadro evidenziato in rosa nella fig. 3.20) e ANALISI ROUTINARIE (fig.3.22). In quella stessa sottomaschera è presente anche un utile controllo sui <strong>dati</strong> <strong>di</strong> contenuto percentuale<strong>di</strong> argilla, sabbia e limo inseriti, grazie al quale è possibile verificare imme<strong>di</strong>atamente al momentodell’inserimento se i <strong>dati</strong> inseriti sommano effettivamente a 100.In questo modulo è implementata una funzione per la stima della classe granulometrica dell’orizzonte,secondo la metodologia del Soil Survey Staff (2006). Con la funzione <strong>di</strong> calcolo automatico <strong>di</strong> questomodulo è possibile conoscere la classe granulometrica <strong>dei</strong> singoli orizzonti, con l’esclusione, però, <strong>di</strong>alcuni tipi <strong>di</strong> suoli: suoli con caratteristiche an<strong>di</strong>che, vertisuoli, suoli con famiglia <strong>di</strong> profon<strong>di</strong>tà“shallow”, suoli con sottogruppo “lithic”, “arenic” o “grossarenic” o suoli in cui l’orizzonte è parte <strong>di</strong> unaclasse granulometrica fortemente contrastante (“strongly contrasting particle-size class”). Anche ilrisultato <strong>di</strong> questo calcolo automatico viene visualizzato nella maschera CNCP-Orizzonti nellesottomaschere DATI1 (riquadro evidenziato in rosa nella fig. 3.20). Le chiavi <strong>di</strong> attribuzione sonoschematizzate nella tabella. 3.4, dove l’attribuzione della classe granulometrica si fa andando a verificaresistematicamente a partire dalla prima classe e proseguendo in or<strong>di</strong>ne con le successive, fino a trovare peresclusione quella per cui si applicano i criteri descritti.120
Tabella 3.4. Chiavi <strong>di</strong> attribuzione delle classi granulometriche USDA implementate nel motore CNCP_m.mdb.Co<strong>di</strong>ce Descrizione Chiavi <strong>di</strong> attribuzioneFRM Frammentale Suoli minerali <strong>di</strong> origine non vulcanica con scheletro ≥ 90%SKSScheletricosabbiosaIL SOFTWARE DI INFORMATIZZAZIONE DEI DATISuoli minerali <strong>di</strong> origine non vulcanica con scheletro ≥ 35%, tessitura S oSFe sabbia molto fine < 50%SKF ScheletricofrancaSuoli minerali <strong>di</strong> origine non vulcanica con scheletro ≥ 35% e argilla
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICITabella 3.5. Caratteri funzionali della fertilità chimica dell’orizzonte superficiale.Descrizione Classe pH TSB CaCO3totalebuona I ≥6,6 e ≤8,4 e ≥50 e ≤40% e ≥10 e
IL SOFTWARE DI INFORMATIZZAZIONE DEI DATITabella 3.7. Classi <strong>di</strong> capacità d’uso.PROPRIETA’ I II III IV V VI VII VIIIProfon<strong>di</strong>tà utileper le ra<strong>di</strong>ci cmTessitura USDAorizzontesuperficialeScheletroorizzontesuperficiale %Pietrositàsuperficiale %≥100elevata e moltoelevataS, SF, FS, F,FA50estremamenteroccioso ependenza≥5%molto bassa qualsiasi8 - - - -8 >8 - - - -123
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICIRischio <strong>di</strong>inondazionePendenza %
IL SOFTWARE DI INFORMATIZZAZIONE DEI DATI3.4.4.5 Determinazione della classe <strong>di</strong> capacità d’uso e dell’interferenza climatica (moduliCapacità d’Uso siti e sottounità ed Interferenza climatica siti)Si tratta <strong>di</strong> due moduli in<strong>di</strong>pendenti per la determinazione della classe <strong>di</strong> capacità d’uso e dell’interferenzaclimatica (Costantini, 2006) delle osservazioni e/o sottounità che si basano sullo schema delle tabb. 3.7 e3.8. Il calcolo automatico <strong>di</strong> questi viene avviato dal menù pedofunzioni ed il risultato è visibile nellasottomaschera QUALITÁ della maschera CNCP-Caratteri della stazione (fig. 3.15). L’interferenzaclimatica può essere assegnata manualmente da maschera ed in questo caso non verrà sovrascritta dallarelativa pedofunzione. La sua in<strong>di</strong>cazione è funzionale ma facoltativa ai fini del determinazione dellacapacità d’uso.3.4.4.6 Controllo dell’inserimento <strong>dei</strong> <strong>dati</strong> (modulo Funzioni <strong>di</strong> controllo issds)Questo modulo permette <strong>di</strong> controllare la correttezza dell’inserimento <strong>dei</strong> <strong>dati</strong> <strong>pedologici</strong> puntuali perquanto riguarda i seguenti caratteri: verifica dell’uso del suffisso k in relazione alla presenza, assenza e/oquantità <strong>di</strong> concrezioni <strong>di</strong> carbonato <strong>di</strong> calcio; verifica dell’inserimento <strong>dei</strong> <strong>dati</strong> relativi al contenuto <strong>di</strong>scheletro; verifica dell’uso del suffisso t in relazione alla presenza o assenza <strong>di</strong> pellicole e/o rivestimenti<strong>di</strong> argilla e in relazione al contenuto <strong>di</strong> argilla; verifica della struttura in relazione al tipo <strong>di</strong> orizzonte;verifica della sommatoria a cento delle percentuali <strong>di</strong> argilla, sabbia e limo; verifica della classificazionein presenza <strong>di</strong> contatto litico; verifica del tasso <strong>di</strong> saturazione in basi in relazione al pH. Il risultato <strong>di</strong>queste verifiche è visibile nella maschera CNCP-Orizzonti e relative sottomaschere (figg. 3.20 e 3.21).3.4.4.7 Funzioni generali (modulo funzioni generali)Questo modulo permette una serie <strong>di</strong> funzioni generali per il funzionamento del motore CNCP_m.mdbcome: la precedenza nella scelta <strong>dei</strong> colori value e chroma umi<strong>di</strong> sui rispettivi secchi; la precedenza dellaCSC calcolata per somma cationica rispetto a quella misurata; la precedenza del dato <strong>di</strong> calcio e magnesiocome somma rispetto ai valori singoli <strong>di</strong> calcio e magnesio nel calcolo della CSC per somma cationica; laprecedenza del dato <strong>di</strong> aci<strong>di</strong>tà totale rispetto ai valori singoli <strong>di</strong> idrogeno e alluminio nel calcolo dellaCSC per somma cationica.3.4.4.8 Funzioni varie issds (modulo funzioni varie issds)Questo modulo permette una serie <strong>di</strong> funzioni fra cui le più importanti sono: la funzione <strong>di</strong> conversionedal valore <strong>di</strong> conducibilità elettrica misurata fra i <strong>di</strong>versi tipi <strong>di</strong> soluzione acquosa e la funzione perl’attribuzione del pedoclima alle osservazioni pedologiche.Funzione <strong>di</strong> conversione dal valore <strong>di</strong> conducibilità elettricaConverte il valore <strong>di</strong> conducibilità elettrica fra <strong>di</strong>versi tipi <strong>di</strong> soluzione acquosa e si basa sulle seguentiformule.CEe = CE 1:2,5 *4 (Sbaraglia e Lucci, 1994)CEe = 6,08 * (CE 1:5 ) – 0,937 (Barberis, 2007)e quin<strong>di</strong> CE 1:2,5 = 1,52 * (CE 1:5 ) - 0,23452dove CE 1:2,5 è la conducibilità elettrica misurata in soluzione acquosa con rapporto suolo - acqua <strong>di</strong> 1 a2,5, CE 1:5 è la conducibilità elettrica misurata in soluzione acquosa con rapporto suolo - acqua <strong>di</strong> 1 a 5 eCEe è la conducibilità elettrica misurata in soluzione acquosa in pasta satura.125
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICIQueste funzioni <strong>di</strong> conversione <strong>dei</strong> <strong>dati</strong> <strong>di</strong> conducibilità elettrica, sono solo in<strong>di</strong>cative e si azionano almomento in cui si inserisce il dato nella sottomaschera ANALISI ROUTINARIE della maschera CNCP-Orizzonti (fig. 3.22).Stima del pedoclimaFunzione che assegna ai <strong>dati</strong> <strong>pedologici</strong> puntuali il regime termometrico ed il regime udometricoapplicando le formule riportate <strong>di</strong> seguito.Il regime termometrico viene stimato a partire dal calcolo della temperatura me<strong>di</strong>a del suolo a 50 cm <strong>di</strong>profon<strong>di</strong>tà ottenuta tramite la seguente formula (Costantini et al., 2001)TMS = [TMA]+(([CC]*100)-20.7)/7.9dove TMS = temperatura me<strong>di</strong>a del suolo (°C), TMA = temperatura me<strong>di</strong>a annua del sito (°C), CC =capacità <strong>di</strong> campo a 50 cm <strong>di</strong> profon<strong>di</strong>tà (% in volume) misurata o, eventualmente, stimata tramite lafunzione proposta da Saxton (Saxton et al., 1986).Tabella 3.9. Co<strong>di</strong>fica del regime termometrico <strong>dei</strong> suoli.Regime termometrico del suolo Temperatura me<strong>di</strong>a del suolo a 50 cm (°C)Frigido≤8Mesico>8 e ≤15Termico>15 e ≤22Hypertermico>22Il regime udometrico viene stimato a partire dal numero <strong>dei</strong> giorni <strong>di</strong> secco (cioè il numero <strong>di</strong> giorni in cuiil suolo resta secco) ottenuto a partire dalla seguente formula (L’Abate et al., 2004)DYSD = 48.817+[TMA]*7.153 - [PA]*0.061 - [AWC]*0.13666dove TMA = temperatura me<strong>di</strong>a annua (°C), PA = precipitazione annua (mm/anno), AWC = availablewater capacity (mm/m) misurata o, eventualmente, stimata tramite la funzione proposta da Saxton(Saxton et al., 1986).Tabella 3.10. Co<strong>di</strong>fica del regime udometrico <strong>dei</strong> suoli.Regime udometrico del suolo Numero annuo <strong>di</strong> giorni <strong>di</strong> seccoU<strong>di</strong>co>0 e ≤65Ustico>65 e ≤80Xerico>80 e ≤115Xerico-secco>115Le funzioni <strong>di</strong> assegnazione del pedoclima si visualizzano nella sottomaschera CLASSIFICAZIONEdella maschera CNCP-Caratteri della stazione (fig. 3.16).126
IL SOFTWARE DI INFORMATIZZAZIONE DEI DATI3.4.4.9 Stima delle proprietà idrologiche <strong>dei</strong> <strong>dati</strong> <strong>pedologici</strong> puntuali (modulo Proprietàidrologiche)Le funzioni <strong>di</strong> questo modulo riguardano le proprietà idrologiche come la conducibilità idraulica satura eil gruppo idrologico.Stima della conducibilità idraulica saturaFunzione che permette la determinazione a livello <strong>di</strong> orizzonte, utilizzando il metodo <strong>di</strong> Rawls eBrakensiek del 1983, proposto dal Soil Survey Manual (Soil Survey Division Staff, 1993) ed elaborato inseguito ad analisi statistica <strong>di</strong> varie migliaia <strong>di</strong> misurazioni in vari tipi <strong>di</strong> suoli, che utilizza come variabilipre<strong>di</strong>ttive la densità apparente e la tessitura. Le originali funzioni non lineari proposte da Rawls eBrakensiek sono state trasformate per como<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> calcolo, nel modulo proprietà idrologiche, in funzionilineari secondo gli schemi presentati nelle figg. 3.57, 3.58 e 3.59, tradotti in forma tabellare nelle tabb.3.11, 3.12 e 3.13. Il risultato della stima è visibile come valore <strong>di</strong> confronto nella maschera CNCP-Orizzonti (fig. 3.21)In questo modulo c’è anche la funzione per il calcolo automatico del gruppo idrologico a partire dal dato<strong>di</strong> conducibilità interna, che viene ricavato a partire dalla stima effettuata col metodo <strong>di</strong> Rawls eBrakensiek considerando i valori me<strong>di</strong> delle classi: 55 µm/s se la conducibilità idraulica stimata è alta; 5µm/s se la conducibilità idraulica stimata è moderatamente alta; 0,5 µm/s se la conducibilità idraulicastimata è moderatamente bassa; 0,55 µm/s se la conducibilità idraulica stimata è bassa. Dopo<strong>di</strong>chè ilgruppo idrologico viene determinato secondo lo schema della tab. 3.14 (Soil Survey Division Staff,1993). Il risultato <strong>di</strong> questo modulo è visibile nella sottomaschera QUALITÁ della maschera CNCP-Caratteri della stazione (fig. 3.15).3.4.4.10 Stima del rischio <strong>di</strong> incrostamento e compattamento superficiale e stima dellacapacità <strong>di</strong> scambio cationico (modulo PRS)Stima del rischio <strong>di</strong> incrostamento superficialeFunzione proposta da Pellegrini e collaboratori (2005) per stimare il rischio <strong>di</strong> incrostamento superficialericavata a partire da <strong>dati</strong> rilevati su suoli italiani.La funzione è data dalla seguente formula:i = 0,68 + 0,0013 L – 0,42 Log 10 SOdove i è il rischio <strong>di</strong> incrostamento, dato dalle classi <strong>di</strong> tab. 3.15, L è la percentuale <strong>di</strong> limo della terra finedell’orizzonte superficiale, SO è il contenuto in sostanza organica percentuale dell’orizzonte superficiale.Questa funzione è richiamabile dal menù pedofunzioni e il risultato è visibile nella sottomascheraQUALITÁ della maschera CNCP-Caratteri della stazione (fig. 3.15).127
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICIFigura 3.57. Stima della classe <strong>di</strong> conducibilità idraulicain relazione alla tessitura (trasformazione lineare <strong>di</strong> Rawlse Brakensiek, 1983)Figura 3.58. Stima della classe <strong>di</strong> conducibilità idraulicasatura in relazione alla tessitura (trasformazione lineare <strong>di</strong>Rawls e Brakensiek, 1983)Figura 3.59. Stima della classe <strong>di</strong> conducibilità idraulicasatura in relazione alla tessitura (trasformazione lineare <strong>di</strong>Rawls e Brakensiek, 1983)Tabella 3.11. Stima della conducibilità idraulica satura percampioni <strong>di</strong> suolo ad alta densità apparente (>1,4 g/cm³) inrelazione alla tessitura. A= argilla %, S= sabbia %.Descrizione Valore Con<strong>di</strong>zioni(µm/s)Bassa 0,01 - A≥20%, S
IL SOFTWARE DI INFORMATIZZAZIONE DEI DATITabella 3.14. Classi <strong>di</strong> gruppo idrologico (Soil Survey Division Staff, 1993).Co<strong>di</strong>ce Parametri <strong>di</strong> stimaA Conducibilità idraulica satura molto alta o nella metàsuperiore della classe alta e la presenza <strong>di</strong> acqua liberainterna è molto profondaB Conducibilità idraulica satura nella metà inferioredella classe alta o nella metà superiore della classemoderatamente alta e/o la presenza <strong>di</strong> acqua liberainterna è profonda o molto profondaCDConducibilità idraulica satura nella metà inferioredella classe moderatamente alta o nella metà superioredella classe moderatamente bassa e/o la presenza <strong>di</strong>acqua libera interna è più profonda della classesuperficialeConducibilità idraulica satura è inferiore alla metàsuperiore della classe moderatamente bassa e/o lapresenza <strong>di</strong> acqua libera interna è superficiale o moltosuperficiale e da transitoria a permanenteParametri <strong>di</strong> stimaksat ≥55 µm/s elimite superiore falda ≥ 150 mksat ≥5 e
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICIcomposizione mineralogica del materiale genitore (che si presuppone essere mista nel moduloimplementato), la tessitura, il pH in CaCl 2 e il contenuto in sostanza organica. I valori <strong>di</strong> C.S.C. sonoespressi in meq/100g. La tessitura è espressa in classi tessiturali USDA. I valori stimati in base allaquantità <strong>di</strong> sostanza organica (tab. 3.18) devono essere sommati a quelli ottenuti in base alla tessitura ealla mineralogia del materiale genitore (tab. 3.17). Questa funzione è presente nel menù pedofunzioni e ilrisultato è visibile per ogni orizzonte nella sottomaschera ANALISI ROUTINARIE della mascheraCNCP-Orizzonti (fig. 3.22) andando a cliccare sul pulsantepresente nel riquadro relativo ai<strong>dati</strong> <strong>di</strong> CSC.Tabella 3.17. Stima della CSC in base alla mineralogia dominante del materiale genitore e dalla tessitura.Mineralogia Mista Illite Caolinite Smectite AllofaneEsempio <strong>di</strong>Graniti Arenarie silicee Alluvioni o Materiale vulcanicomaterialegenitoreoSuperfici relitteVulcaniti inclima aridoTessitura pH 7,5 pH 6,5 pH 5,5S 2 2 0,6 2 10 8 6SF 4,5 4,5 1,4 11,5 22,5 18 13,5FS, FSA 6 7 2 18 35 28 21L 9 10 3 25 50 40 30F 10 12 3,6 30 60 48 36FL 12 13 4 32,5 75 60 45FLA 15 16 4,8 40 80 64 48FA 18 20 6 50 100 80 60AS 18 24 7,2 60 120 96 72AL 24 26 7,8 65 130 104 78A 32 35 10,5 87,5 175 140 105Tabella 3.18. Stima della CSC in base al contenuto <strong>di</strong> sostanza organica e al pH in CaCl2. Valori da sommare a quelli ottenutitramite la tab. 3.17.SostanzapH (CaCl 2 )organica (%) > 7,5 6,5 5,5 3,5 3,5 2,51-2 3 2,4 1,8 1,2 0,8 0,52-4 7 6 4 3 2 14-8 15 12 9 6 4 28-15 25 20 15 10 6 415-30 50 40 30 20 12,5 7,5>30 200 160 120 80 50 303.4.4.11 Capacità depurativa e capacità protettiva nei confronti delle acque profonde(modulo qualità derivate)Funzione proposta dalla Regione Emilia RomagnaValuta le classi <strong>di</strong> capacità depurativa <strong>dei</strong> suoli (R.E.R., 1995), dove la capacità depurativa è intesa comela capacità del suolo <strong>di</strong> degradare rapidamente la sostanza organica apportata con i liquami, liberando glielementi nutritivi in forma assimilabile dalle colture, e la capacità <strong>di</strong> adsorbire i composti a potenzialeazione inquinante, ad esempio i metalli pesanti (tab. 3.19). Le variabili pre<strong>di</strong>ttive in<strong>di</strong>viduate (tab. 3.20)sono: il contenuto <strong>di</strong> scheletro entro 1 m <strong>di</strong> profon<strong>di</strong>tà, la profon<strong>di</strong>tà utile per le ra<strong>di</strong>ci, la capacità <strong>di</strong>scambio cationico e il pH (in acqua). Questa funzione è richiamabile dal menù pedofunzioni e il risultatoè visibile nella sottomaschera QUALITÁ della maschera CNCP-Caratteri della stazione (fig. 3.15).130
IL SOFTWARE DI INFORMATIZZAZIONE DEI DATITabella 3.19. Classi <strong>di</strong> capacità depurativa del suolo.Co<strong>di</strong>ce Classe1 Molto alta2 Alta3 Moderata4 Bassa5 Molto bassaTabella 3.20. Stima delle classi <strong>di</strong> capacità depurativa del suolo.Scheletro Capacità <strong>di</strong> Profon<strong>di</strong>tà utile alle ra<strong>di</strong>ciscambio cationico
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICITabella 3.21. Stima della capacità protettiva <strong>dei</strong> suoli nei confronti delle acque profonde. Valori <strong>di</strong> pH e C.S.C. maggiori o i 100 entr cm.CapacitàFATTORI LIMITANTIprotettiva(classe)ELEVATA(1)MODERATA(2)BASSA(3)Permeabilità(classi)BASSA(4, 5, 6)MODERATA(3)ELEVATA(1, 2)Profon<strong>di</strong>tà falda(cm)≥100≥50 e
IL SOFTWARE DI INFORMATIZZAZIONE DEI DATI3.4.4.12 Relazione agronomica (moduli Issds e Xrapp_agronomico)In questo modulo sono implementate le funzioni <strong>di</strong> deco<strong>di</strong>fica delle classi delle principali caratteristiche<strong>dei</strong> suoli (tab. 3.22 e tabb. del par. 3.4), necessarie al software per stilare, in maniera automatica a partiredai <strong>dati</strong>, la descrizione delle caratteristiche del suolo nei report <strong>di</strong> stampa (fig. 1.8) e la relazione prosaicadel rapporto agronomico (fig. 3.19) delle osservazioni pedologiche, la quale si aziona cliccando sulpulsante della maschera CNCP-Caratteri della stazione (fig. 3.13). Le fonti bibliografiche sono:Costantini et al., 2006; FAO, 1990a, Gar<strong>di</strong>n et al., 2002; Giar<strong>di</strong>ni, 1986; Mi.P.A.F., 2000; Sbaraglia eLucci, 1994; Lorimer e Rowan, 1982).Tabella 3.22. Deco<strong>di</strong>fiche delle soglie delle classi <strong>di</strong> descrizione della relazione agronomica.Classi DescrizioneSostanza organica (%)≥ 3 Ben fornito <strong>di</strong> sostanza organica≥2 e 1 e ≤2 Conducibilità elettrica causa salinità: forte>0,5 e ≤1 Conducibilità elettrica causa salinità: forte moderata≤0,5 Conducibilità elettrica causa salinità: trascurabileRapporto <strong>di</strong> assorbimento <strong>di</strong> so<strong>di</strong>o (S.A.R.)30 Pericolo <strong>di</strong> alcalinizzazione forteCoefficiente <strong>di</strong> estensibilità lineare (C.O.L.E.)9 Il coefficiente <strong>di</strong> estensibilità lineare è molto altoPercentuale <strong>di</strong> so<strong>di</strong>o scambiabile (E.S.P.)>15 Il so<strong>di</strong>o nel complesso <strong>di</strong> scambio è molto forte>8 e ≤15 Il so<strong>di</strong>o nel complesso <strong>di</strong> scambio è forte≤8 Il so<strong>di</strong>o nel complesso <strong>di</strong> scambio è trascurabileRapporto fra magnesio e potassio>10 Il rapporto fra magnesio e potassio è alto>6 e ≤10 Il rapporto fra magnesio e potassio è leggermente alto>2 e ≤6 Il rapporto fra magnesio e potassio è ottimale>1 e ≤2 Il rapporto fra magnesio e potassio è leggermente basso>0,5 e ≤1 Il rapporto fra magnesio e potassio è basso≤0,5 Il rapporto fra magnesio e potassio è molto bassoRapporto fra carbonio e azoto>11 I processi <strong>di</strong> umificazione accelerati rendono la quantità <strong>di</strong> azoto insufficiente(rapporto carbonio/azoto alto >11)>9 e ≤11 Rapporto carbonio/azoto normale (9-11) con equilibrio fra mineralizzazione e sintesi≤9 Scarsa umificazione e liberazione del carbonio dalla sostanza organica (rapportocarbonio/azoto basso
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICI
Contenuto <strong>di</strong> potassio scambiabile (meq/100g)
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICI3.5 Il geodatabase CNCP_g.mdb3.5.1 Il geodatabase in ArcGISPer mettere in relazione le informazioni pedologiche della banca <strong>dati</strong> con quelle geografiche, cioè relativeai pedopaesaggi, è stato messo a punto, per il livello geografico <strong>dei</strong> sistemi <strong>di</strong> terre e delle regionipedologiche, un apposito geodatabase in ambiente ArcGIS. Tale modello potrà essere poi esteso agli altrilivelli geografici a cui i suoli presenti in banca <strong>dati</strong> sono legati (sottosistemi <strong>di</strong> terre e unità <strong>di</strong> terre). Ilgeodatabase è un sistema relazionale che permette <strong>di</strong> gestire un insieme <strong>di</strong> <strong>dati</strong> <strong>di</strong> vario tipo. In questocaso, gli oggetti che sono stati opportunamente legati tra loro sono: le feature classes (shapefiles), con leloro tabelle degli attributi, le legende, che permettono la comprensione degli attributi co<strong>di</strong>ficati, e latabella della banca <strong>dati</strong> che deriva dal legame tra le STS e le componenti territoriali <strong>dei</strong> sistemi <strong>di</strong> terre(fig. 3.60).Figura 3.60. Struttura del geodatabase.Cncp_bCaricando il geodatabase in ArcMap tutte le informazioni tra loro relazionate sono facilmente accessibili<strong>di</strong>rettamente dalla geografia (fig. 3.61).Figura 3.61. Il geodatabase in ArcMap.Infatti, interrogando ogni poligono della feature class <strong>di</strong> interesse, cioè cliccandovi con il pulsante siaccede alla deco<strong>di</strong>fica <strong>di</strong> tutti quegli attributi che descrivono il pedopaesaggio quali la litologia, la136
IL SOFTWARE DI INFORMATIZZAZIONE DEI DATIfisiografia e l’uso del suolo (fig. 3.62). La stessa cosa può essere applicata alle informazioni pedologiche.Infatti, una volta che le STS, utilizzando il motore CNCP_m.mdb (ve<strong>di</strong> par. 3.4.2.4 e par. 3.4.2.5) sonostate legate alle componenti territoriali <strong>dei</strong> sistemi <strong>di</strong> terre (o degli altri livelli pedopaesaggistici), sipotrànno visualizzare le relative tabelle <strong>di</strong> geo-legame fra le componenti territoriali <strong>dei</strong> sistemi(sottosistemi e unità <strong>di</strong> terre) e le STS (fig. 3.63) in cui si potrà controllare anche il livello <strong>di</strong> attribuzione(ve<strong>di</strong> par. 3.4.2.7) cioè la qualità.In queste tabelle sono presenti tutte le informazioni sulle relazioni tra le varie STS e le componentiterritoriali cui risultano legate, ovvero: l’identificativo del poligono <strong>di</strong> sistema <strong>di</strong> terre, la percentualeareale della componente all’interno <strong>di</strong> tale poligono, la qualità del legame, e infine, se presente, lapercentuale <strong>di</strong> presenza della STS in riferimento alla componente territoriale <strong>di</strong> sistema <strong>di</strong> terre a cui èlegata.Figura 3.62. Interrogazione del geodatabase e deco<strong>di</strong>fica dell’attributo morfologico in ArcMap.Figura 3.63. Tabella <strong>di</strong> collegamento fra le componenti territoriali <strong>dei</strong> sistemi e le STS.137
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICIIn ArcMap cliccando sul poligono (pulsante ) è possibile visualizzare <strong>di</strong>rettamente un elenco <strong>di</strong> tutte leSTS legate alle componenti territoriali che lo descrivono. Inoltre la selezione <strong>di</strong> ognuno <strong>dei</strong> valori delmenù a ten<strong>di</strong>na <strong>di</strong> “Geo_legame” che compaiono nella finestra “Identify”, consente <strong>di</strong> evidenziare i <strong>dati</strong>relativi ad ognuna delle componenti del poligono sopra descritte (fig. 3.64).Figura 3.64. Interrogazione del geodatabase per visualizzare le STS in ArcMap .138
IL SOFTWARE DI INFORMATIZZAZIONE DEI DATI3.6 Possibili errori3.6.1 Cosa fare se i file CNCP_m.mdb, CNCP_b.mdb o CNCP_g.mdb non si apronoTalvolta può capitare che il file con estensione .ldb (informazioni <strong>di</strong> blocco record <strong>di</strong> access) rimangaattivo tra i processi <strong>di</strong> windows dopo la chiusura del file .mdb, impedendo una sua successiva apertura. Inquesti casi bisogna richiamare il task manager <strong>di</strong> windows (tasti: CTRL+ALT+CANC); selezionare lascheda processi; selezionare dalla lista “MSACCESS.EXE” e premere “termina processo”.3.6.2 Cosa fare se il CNCP_g.mdb o CNCP_m.mdb non si aprono correttamenterichiamando riferimenti <strong>di</strong> librerie mancantiLe librerie necessarie perché il software CNCP funzioni correttamente e normalmente presenti <strong>di</strong> defaultin Access 2000 sono le seguenti:- visual basic for application;- microsoft access 10.0 object library;- ole automation;- microsoft visual basic for application extensibility 5.3;- microsoft DAO 3.6 object library;- microsoft activeX data objects 2.7 library;Può succedere che una delle suddette librerie sia mancante. In quel caso, se si utilizza una routinecontenente funzioni <strong>di</strong> Visual Basic, Applications E<strong>di</strong>tion e nel database è presente un riferimento aquella libreria <strong>di</strong> oggetti o <strong>dei</strong> tipi mancante, è possibile che le funzioni <strong>di</strong> Visual Basic ApplicationsE<strong>di</strong>tion (VBA) interrompono il processo e venga visualizzato uno <strong>dei</strong> seguenti messaggi <strong>di</strong> errore:Messaggio <strong>di</strong> errore 1“Il database o il progetto <strong>di</strong> Microsoft Access include un riferimento mancante o errato al file”Messaggio <strong>di</strong> errore 2“Errore <strong>di</strong> compilazione:Impossibile trovare il progetto o la libreria”In quei casi la procedura da seguire è la seguente:1. Aprire il database;2. Premere ALT+F11 per aprire Visual Basic E<strong>di</strong>tor;3. Scegliere Riferimenti dal menu Strumenti;4. Deselezionare la casella <strong>di</strong> controllo relativa alla libreria <strong>dei</strong> tipi o alla libreria <strong>di</strong> oggetticontrassegnata come MANCANTE: .139
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICI3.6.3 Cosa fare se il CNCP_m.mdb va in crashSvolgendo alcune operazioni può succedere che il motore CNCP_m.mdb vada in “crash” e si chiudaimprovvisamente lanciando in automatico il messaggio <strong>di</strong> errore riportato in figura 3.65. Per evitare questoproblema si raccomanda <strong>di</strong> installare i “service pack” della versione in uso <strong>di</strong> microsoft office, scaricabiligratuitamente dal sito della microsoft. Per accertarsi sulla versione <strong>di</strong> access e se i “service pack” sonocorrettamente installati, bisogna aprire il file CNCP_b.mdb, andare su ?/informazioni su microsoft accesse verificare che ci sia SP-X nella intestazione accanto alla sigla “Microsoft Access® xxxx(xx.xxxx.xxxx)”.Figura 3.65. Messaggio <strong>di</strong> errore per mancata installazione <strong>dei</strong> “service pack” <strong>di</strong>microsoft office.3.6.4 Il software in Microsoft Office Access 2007Al fine <strong>di</strong> valutare il software sulle più recenti piattaforme <strong>di</strong>sponibili sul mercato, ne abbiamo testato lefunzionalità con Microsoft Office Access 2007. Tutte le funzionalità sembrano eseguirsi normalmenteove le librerie necessarie risultino installate (ve<strong>di</strong> par. 3.6.2). Si elencano <strong>di</strong> seguito una serie <strong>di</strong>informazioni utili nel caso <strong>di</strong> utilizzo del software con questa versione <strong>di</strong> Office.Tutte le funzionalità ed i menù <strong>di</strong> gestione propri del motore Cncp_m vengono raccolti nella scheda"Componenti aggiuntivi" nella barra multifunzione (ve<strong>di</strong> fig. 3.66).In Microsoft Office Access 2007 sono <strong>di</strong>sponibili <strong>di</strong>verse funzionalità che consentono <strong>di</strong> proteggere i<strong>dati</strong> e il computer. Se si tenta <strong>di</strong> eseguire il co<strong>di</strong>ce pubblicato non conforme ai criteri <strong>di</strong> protezione, ilCentro protezione <strong>di</strong>sattiva il co<strong>di</strong>ce per impostazione predefinita e viene visualizzata la barra messaggiper informare l'utente che l'e<strong>di</strong>tore è potenzialmente non sicuro.Quando viene visualizzata una finestra <strong>di</strong> <strong>di</strong>alogo <strong>di</strong> protezione, è possibile attivare il componenteaggiuntivo solo per la sessione corrente selezionando “Attiva il componente aggiuntivo solo per questasessione oppure lasciarlo <strong>di</strong>sattivato”. In alternativa, è possibile fare clic su “Attiva tutto il co<strong>di</strong>cepubblicato da questo e<strong>di</strong>tore” per impostare l'e<strong>di</strong>tore come atten<strong>di</strong>bile in modo esplicito. In questo modoil componente aggiuntivo verrà attivato e qualsiasi software pubblicato da tale e<strong>di</strong>tore verrà consideratosempre atten<strong>di</strong>bile.140
IL SOFTWARE DI INFORMATIZZAZIONE DEI DATIFigura 3.66. Le funzionalità ed i menù <strong>di</strong> gestione propri del motore Cncp_m vengono raccolti nella scheda "Componentiaggiuntivi" nella barra multifunzione.Al fine <strong>di</strong> riconoscere come atten<strong>di</strong>bile il file Cncp_m, è necessario attivare il certificato <strong>di</strong> protezionefirmato dell'e<strong>di</strong>tore CNCP allegato alla banca <strong>dati</strong>.Altra soluzione è impostare un percorso atten<strong>di</strong>bile. Per impostare un percorso come atten<strong>di</strong>bile:Pulsante Office 2007 > Opzioni <strong>di</strong> Access > Centro <strong>di</strong> protezione > Impostazione Centro Protezione >Percorsi Atten<strong>di</strong>bili > Aggiungi nuovo percorso. Quin<strong>di</strong> selezionare la <strong>di</strong>rectory CNCP3.0 o la risorsa <strong>di</strong>rete N:// .Ancora è <strong>di</strong>sponibile un nuovo metodo per lavorare con le tabelle, le maschere, i report e gli altrioggetti <strong>di</strong> un database. Anziché aprire ogni oggetto in una finestra <strong>di</strong>versa, gli oggetti e i coman<strong>di</strong>vengono infatti inseriti in un unico riquadro (detto barra multifunzione) all'interno del quale sonosud<strong>di</strong>visi me<strong>di</strong>ante schede (ve<strong>di</strong> fig. 3.67). La barra multifunzione risiede nella parte superiore dellafinestra dell'applicazioni che vengono aperte. Con Access 2007 è possibile decidere <strong>di</strong> personalizzare labarra multifunzione per semplificare l'utilizzo <strong>di</strong> un'applicazione. Ad esempio, è possibile nasconderealcune o tutte le schede della barra multifunzione predefinita in modo che gli utenti non possano utilizzaredeterminati coman<strong>di</strong>, quin<strong>di</strong> creare nuove schede personalizzate contenenti solo i coman<strong>di</strong> che si desiderarendere <strong>di</strong>sponibili. In tutte le applicazioni <strong>di</strong> Microsoft Office System 2007 in cui l'interfaccia è costituitadalla barra multifunzione, è possibile utilizzare il linguaggio XML (Extensible Markup Language) perpersonalizzare la barra multifunzione.Nel caso si desideri impostare solo le funzionalità necessarie per l'uso del file Cncp_m, cliccare sulpulsante <strong>di</strong> Office in alto a sinistra; scegliere Opzioni <strong>di</strong> access; database corrente e deselezionare la voce"menu completi" (ve<strong>di</strong> fig. 3.68).141
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICIFigura 3.67. Visualizzazione degli oggetti tramite barra multifunzione: gli oggetti e i coman<strong>di</strong> vengono inseriti in ununico riquadro all'interno del quale sono sud<strong>di</strong>visi me<strong>di</strong>ante schede.Figura 3.68. É possibile nascondere i menù predefiniti <strong>di</strong> Access.142
LA DESCRIZIONE DEL SUOLO4. La descrizione del suoloM. Paolanti, E. A. C. Costantini, M. Fantappiè, R. BarbettiIn<strong>di</strong>ce4.1 Introduzione...............................................................................................................................1464.2 Caratteri generali del sito pedologico........................................................................................1474.2.1 Anagrafe dell’osservazione ..............................................................................................147Co<strong>di</strong>ce del <strong>rilevamento</strong>....................................................................................................147Tipo <strong>di</strong> osservazione........................................................................................................147Descrizione del suolo me<strong>di</strong>ante profilo ...........................................................................147Descrizione del suolo me<strong>di</strong>ante trivellata........................................................................148Descrizione del suolo me<strong>di</strong>ante pozzetto ........................................................................149Osservazione spe<strong>di</strong>tiva o superficiale..............................................................................149Numero dell’osservazione ...............................................................................................150Origine della sezione .......................................................................................................1504.2.2 Carta <strong>di</strong> localizzazione......................................................................................................150Tipo <strong>di</strong> carta e denominatore della scala .........................................................................150Sigla della carta................................................................................................................1504.2.3 Fotografie dell’osservazione.............................................................................................1514.2.4 Data...................................................................................................................................1514.2.5 Co<strong>di</strong>ce <strong>dei</strong> rilevatori .........................................................................................................1514.2.6 Comune e provincia..........................................................................................................1524.2.7 Località .............................................................................................................................1524.2.8 Ubicazione dell’osservazione ...........................................................................................152Coor<strong>di</strong>nate piane..............................................................................................................152Sistema <strong>di</strong> riferimento e fuso...........................................................................................152Coor<strong>di</strong>nate piane valori....................................................................................................152Coor<strong>di</strong>nate geografiche....................................................................................................1524.2.9 Caratteri dell’osservazione ...............................................................................................152Quota................................................................................................................................152Pendenza..........................................................................................................................153Esposizione......................................................................................................................1534.3 Fattori della pedogenesi.............................................................................................................1544.3.1 Morfometria e fisiografia..................................................................................................154Morfometria (curvatura del sito) .....................................................................................154Fisiografia........................................................................................................................155Forma...............................................................................................................................155Elemento morfologico .....................................................................................................160Erosione e deposizione ....................................................................................................161Erosione reale: tipo e intensità.........................................................................................161Area interessata da erosione ............................................................................................161Deposizione .....................................................................................................................1614.3.2 Geologia............................................................................................................................162Formazione geologica......................................................................................................162Substrato ..........................................................................................................................163Substrato consolidato.......................................................................................................163Substrato non consolidato................................................................................................165Struttura del substrato......................................................................................................167143
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICIStato <strong>di</strong> alterazione ..........................................................................................................168Qualità <strong>dei</strong> materiali ........................................................................................................169Composizione granulometrica.........................................................................................169Soluzioni <strong>di</strong> continuità.....................................................................................................169Durezza............................................................................................................................170Descrizione del parent material (materiale genitore).......................................................170Origine .............................................................................................................................170Composizione granulometrica.........................................................................................170Qualità del materiale genitore..........................................................................................172Relazioni fra materiale genitore e substrato ....................................................................1724.3.3 Uso del suolo e vegetazione .............................................................................................172Uso del suolo ...................................................................................................................172Tipo <strong>di</strong> vegetazione reale.................................................................................................177Grado <strong>di</strong> copertura della vegetazione ..............................................................................1784.3.4 Caratteri <strong>di</strong> superficie .......................................................................................................179Aspetti superficiali...........................................................................................................179Copertura <strong>di</strong> materiale organico ......................................................................................180Rocciosità ........................................................................................................................180Pietrosità superficiale.......................................................................................................180Fessure superficiali ..........................................................................................................1814.4 Descrizione del profilo ..............................................................................................................1824.4.1 Profon<strong>di</strong>tà, spessore e limite inferiore ..............................................................................184Profon<strong>di</strong>tà del limite inferiore dell'orizzonte...................................................................184Spessore ...........................................................................................................................186Tipo..................................................................................................................................186Andamento.......................................................................................................................1864.4.2 Orizzonti eterogenei..........................................................................................................1874.4.3 Umi<strong>di</strong>tà .............................................................................................................................1884.4.4 Colore della massa............................................................................................................188Colore ..............................................................................................................................188Modalità <strong>di</strong> determinazione e localizzazione ..................................................................1884.4.5 Figure redox e litocromie..................................................................................................189Colore ..............................................................................................................................190Abbondanza .....................................................................................................................190Tipo e localizzazione .......................................................................................................190Dimensioni.......................................................................................................................190Evidenza ..........................................................................................................................1914.4.6 Tessitura............................................................................................................................191Stima in campo ................................................................................................................191Classe tessiturale..............................................................................................................192Classe granulometrica......................................................................................................1954.4.7 Frammenti grossolani .......................................................................................................196Abbondanza .....................................................................................................................196Dimensioni.......................................................................................................................196Forma...............................................................................................................................196Litotipo ............................................................................................................................197Stato <strong>di</strong> alterazione ..........................................................................................................1974.4.8 Reazione del suolo (pH), misura in campo.......................................................................197pH in acqua......................................................................................................................197pH in floruro <strong>di</strong> so<strong>di</strong>o ......................................................................................................1984.4.9 Consistenza.......................................................................................................................198Resistenza a rottura e grado <strong>di</strong> cementazione..................................................................198144
LA DESCRIZIONE DEL SUOLOModalità <strong>di</strong> rottura ...........................................................................................................199Adesività..........................................................................................................................199Plasticità...........................................................................................................................1994.4.10 Struttura ..........................................................................................................................203Forma...............................................................................................................................203Dimensione......................................................................................................................205Grado <strong>di</strong> aggregazione.....................................................................................................205Relazione fra la struttura primaria e la struttura secondaria ............................................2064.4.11 Permeabilità...................................................................................................................2074.4.12 Concentrazioni................................................................................................................208Natura e composizione ....................................................................................................208Abbondanza .....................................................................................................................209Dimensioni.......................................................................................................................2094.4.13 Vuoti ...............................................................................................................................210Pori...................................................................................................................................210Abbondanza .....................................................................................................................210Dimensioni.......................................................................................................................211Fessure .............................................................................................................................211Abbondanza .....................................................................................................................211Dimensioni.......................................................................................................................2114.4.14 Pellicole ..........................................................................................................................212Tipo..................................................................................................................................212Abbondanza, spessore, localizzazione.............................................................................2124.4.15 Facce <strong>di</strong> pressione e scorrimento....................................................................................213Tipo..................................................................................................................................213Abbondanza .....................................................................................................................2134.4.16 Ra<strong>di</strong>ci..............................................................................................................................214Dimensioni.......................................................................................................................214Quantità, andamento ........................................................................................................2144.4.17 Attività biologica ............................................................................................................217Tipo..................................................................................................................................217Quantità............................................................................................................................2174.4.18 Effervescenza all’HCl.....................................................................................................217Grado ...............................................................................................................................217Localizzazione .................................................................................................................2184.4.19 Stima della densità apparente .........................................................................................2184.4.20 Classificazione................................................................................................................2194.4.21 Campionamento..............................................................................................................2194.5 Caratteri e qualità del suolo .......................................................................................................2214.5.1 Falda superficiale..............................................................................................................221Tipo <strong>di</strong> falda.....................................................................................................................221Tipo <strong>di</strong> alimentazione ......................................................................................................222Profon<strong>di</strong>tà dal piano campagna al limite superiore .........................................................222Durata annuale cumulativa ..............................................................................................2234.5.2 Rischio <strong>di</strong> inondazione .....................................................................................................223Frequenza.........................................................................................................................223Durata ..............................................................................................................................2244.5.3 Scorrimento superficiale (runoff) .....................................................................................2244.5.4 Profon<strong>di</strong>tà utile alle ra<strong>di</strong>ci ................................................................................................2254.5.5 Limitazioni ed impe<strong>di</strong>menti all’approfon<strong>di</strong>mento delle ra<strong>di</strong>ci.........................................2254.5.6 Profon<strong>di</strong>tà della roccia......................................................................................................2264.5.7 Gestione delle acque .........................................................................................................226145
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICITipo..................................................................................................................................226Scopo ...............................................................................................................................2274.5.8 Drenaggio interno .............................................................................................................2274.1 IntroduzioneLa descrizione <strong>di</strong> campo è fondamentale per la classificazione e la valutazione e del suolo, così come perla comprensione <strong>dei</strong> processi pedogenetici e delle caratteristiche funzionali. Solo se l’attività <strong>di</strong> campo èsvolta con scrupolo ed adeguata professionalità è possibile eseguire un corretto campionamento e regolarel’attività <strong>di</strong> laboratorio, scegliendo le analisi da effettuare e i <strong>meto<strong>di</strong></strong> più appropriati. Il <strong>rilevamento</strong> delsuolo è quin<strong>di</strong> assimilabile ad una “ricerca <strong>di</strong> campagna” (Ferrari e Sanesi, 1965).Questo manuale raccoglie il frutto delle esperienze realizzate da molte persone ed istituzioni,soprattutto in Italia, solo in parte pubblicate (tra gli altri: FAO, 1990b; Costantini et al., 1991; Sulli eCostantini, 1999a; Sulli e Costantini, 1999b; Carnicelli et al., 2001; Costantini et al., 2003; Chiuchiarelliet al., 2004; FAO, 2006). Il progetto “Realizzazione della Banca Dati <strong>dei</strong> Suoli d’Italia (BADASUOLI)”,finanziato dal ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con D.M. 10102 del 20 Maggio2004, ha fornito l’occasione per valorizzare tali esperienze, co<strong>di</strong>ficando le voci del <strong>rilevamento</strong> ecreando il software CNCP, descritto nel capitolo 3. Per l’elaborazione <strong>di</strong> questo manuale è stata preziosal’esperienza maturata da alcuni nuclei <strong>pedologici</strong> presenti nelle amministrazioni regionali e la manualisticache gli stessi hanno validato nei recenti rilevamenti condotti nell’ambito del progetto “realizzazionedella carta pedologica nazionale a scala 1:250.000”, finanziato dal Comitato Interministeriale per laProgrammazione Economica nel programma interregionale denominato “Agricoltura e Qualità”.Sebbene il presente manuale sia stato concepito per essere funzionale al popolamento della banca <strong>dati</strong><strong>dei</strong> suoli d’Italia, esso consente la descrizione dell’osservazione in maniera funzionale a <strong>di</strong>versi tipi <strong>di</strong><strong>rilevamento</strong>. Può quin<strong>di</strong> essere utilizzato per rilevare il suolo <strong>di</strong> un singolo appezzamento <strong>di</strong> terrenonell’ambito <strong>di</strong> uno stu<strong>di</strong>o professionale specifico, oltre che nell’ambito <strong>di</strong> un progetto <strong>di</strong> <strong>rilevamento</strong> ecartografia pedologica. I <strong>dati</strong> possono essere <strong>di</strong>rettamente informatizzati in campo, oppure esseretemporaneamente memorizzati in un’apposita scheda <strong>di</strong> <strong>rilevamento</strong> in formato cartaceo. Il manuale èquin<strong>di</strong> completato da un’apposita scheda <strong>di</strong> <strong>rilevamento</strong>, ove è anche possibile riportare note e <strong>di</strong>segniche possono riguardare il suolo, il paesaggio o le loro relazioni.Per alcune variabili il dato <strong>di</strong> campo dovrà essere archiviato secondo grandezze continue, ossia nonsud<strong>di</strong>viso per classi, per altre variabili invece sono in<strong>di</strong>cate classi <strong>di</strong>screte. Nel primo caso dovrannoessere riportati <strong>di</strong>rettamente i valori, misurati o stimati in campo (percentuale <strong>di</strong> scheletro, <strong>di</strong>mensionedelle fessure ecc.); nel secondo caso dovrà essere riportato un co<strong>di</strong>ce alfanumerico (forma della struttura,grado <strong>di</strong> effervescenza all’acido cloridrico ecc.). Nel caso <strong>di</strong> una variabile espressa per valori continuil’assenza dovrà essere riportata come valore 0 (zero).146
SITOLA DESCRIZIONE DEL SUOLO4.2 Caratteri generali del sito pedologico4.2.1 Anagrafe dell’osservazioneCo<strong>di</strong>ce del <strong>rilevamento</strong>Sigla che identifica il <strong>rilevamento</strong>, lunga al massimo 6 caratteri. L’attribuzione <strong>di</strong> tale co<strong>di</strong>ce deve tenereconto delle caratteristiche dell’archivio. Se si tratta <strong>di</strong> un <strong>rilevamento</strong> regionale è bene inserire semprecome primo carattere la lettera minuscola presente come co<strong>di</strong>ce regionale nella tabella Regioni deldatabase CNCP_b.mdb.Tipo <strong>di</strong> osservazioneLe osservazioni pedologiche sono ricondotte alle quattro tipologie principali riportate in tabella.Tabella 4.1. Tipi <strong>di</strong> osservazioni pedologiche.Co<strong>di</strong>ce DescrizioneP ProfiloT TrivellataQ Pozzetto o minipitO Osservazione superficiale o spe<strong>di</strong>tivaDescrizione del suolo me<strong>di</strong>ante profiloCome profilo (fig. 4.1) si intende uno scavo <strong>di</strong> adeguate <strong>di</strong>mensioni e profon<strong>di</strong>tà, utile per descrivere lamorfologia derivante dallo sviluppo genetico-evolutivo del suolo e per prelevare campioni per le analisi<strong>di</strong> laboratorio. Il profilo è una sezione verticale che può essere concepita sia come un piano verticaleformante un angolo alfa con la superficie, sia come la faccia verticale <strong>di</strong> un parallelepipedoideale, il “pedon, composto da una sequenza <strong>di</strong> orizzonti risultanti dall’evoluzione pedogenetica eche rappresenta la minima unità ideale <strong>di</strong> campionamento (Soil Survey Staff, 1993).147Figura 4.1. Profilo pedologico.
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICISITOLa trincea deve esser abbastanza larga per cogliere la variabilità laterale del suolo (per convenzione, finoa un massimo <strong>di</strong> 7 m, (Soil Survey Staff,1993) ed abbastanza profonda da poter osservare il suolo fino alproprio “materiale genitore” e se possibile anche il substrato pedogenetico. Generalmente però, anche permotivi <strong>di</strong> sicurezza, non si supera la profon<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> 2 - 2,5 metri e la larghezza <strong>di</strong> 2 - 7 metri.La scelta del punto dove eseguire lo scavo e la descrizione del profilo deve essere effettuata in mododa in<strong>di</strong>viduare il concetto centrale (modale) del suolo rappresentativo dell’elemento territoriale che sivuole indagare. Devono essere escluse situazioni anomale quali fossi, canalette, scoline, bor<strong>di</strong> <strong>di</strong> terrazzi,ciglioni antropici, aree <strong>di</strong> <strong>di</strong>scarica, aree contigue a cave e a strade, ma anche superfici con riporti <strong>di</strong>materiali o interessate da lavorazioni straor<strong>di</strong>narie profonde recenti, o comunque zone dove appaionoevidenti mo<strong>di</strong>fiche rispetto a situazioni naturali, a meno che ovviamente non siano proprio questel’oggetto dell’ indagine. Nel caso esistano sezioni artificialmente aperte <strong>di</strong> recente, queste potranno essereusate previa pulitura ed approfon<strong>di</strong>mento del fronte del profilo per almeno 20-30 cm.Descrizione del suolo me<strong>di</strong>ante trivellataGeneralmente viene utilizzata una trivella manuale <strong>di</strong> tipo “olandese”, che estrae “carote <strong>di</strong> suolo” (fig.4.2). Il materiale è molto <strong>di</strong>sturbato e solo alcune caratteristiche o qualità possono essere osservate conprecisione. É un tipo <strong>di</strong> osservazione che può essere effettuata in maniera molto più rapida ed economicadella precedente. Questo tipo <strong>di</strong> osservazione è utilizzato soprattutto per in<strong>di</strong>viduare il sito idoneo alloscavo <strong>di</strong> un profilo pedologico. Si può rilevare utile anche per verificare la corretta apposizione <strong>dei</strong> limititra suoli, validare cartografie <strong>dei</strong> suoli o per acquisire informazioni su caratteristiche specifiche <strong>dei</strong> suoli(es. profon<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> strati con forti cambi <strong>di</strong> tessitura o profon<strong>di</strong>tà del substrato ecc.). La trivella devepenetrare nel terreno verticalmente e non in corrispondenza <strong>di</strong> fessure, tane <strong>di</strong> animali o altri vuoti.Figura 4.2. Carote <strong>di</strong> terreno estratte tramite trivella manuale.Delle porzioni <strong>di</strong> suolo estratte non deve essere considerata la parte superiore, i primi 5 cm circa, alloscopo <strong>di</strong> eliminare il materiale caduto o comunque asportato dalle pareti del foro. Tale accorgimento nonva però seguito per la prima "carota". Per la scelta del sito della trivellata valgono le stesse considerazionifatte per il profilo. I caratteri che vengono più comunemente riportati in scheda sono i seguenti:148
SITOLA DESCRIZIONE DEL SUOLO- designazione dell'orizzonte- spessore degli orizzonti- umi<strong>di</strong>tà del suolo- colore della massa- presenza <strong>di</strong> figure <strong>di</strong> ossido-riduzione e screziature- tessitura- presenza <strong>di</strong> scheletro- concentrazioni- reazione (pH)- reazione all’HCl <strong>di</strong>luito- consistenza- classificazione tentativa- osservazione <strong>di</strong> riferimento- tipologia <strong>di</strong> riferimentoDescrizione del suolo me<strong>di</strong>ante pozzettoIl pozzetto o minipit (fig. 4.3) consiste in uno scavo profondo 50-70 cm e largo circa 100 cm. Questatipologia <strong>di</strong> osservazione è utile per progetti specifici che non siano interessati alla conoscenza degli stratiprofon<strong>di</strong> del suolo, oppure per indagare ambiti ove non sia possibile effettuare scavi con mezzi meccanici(accesso <strong>di</strong>fficoltoso, ambiti tutelati ecc.). Partendo dal fondo dello scavo altre informazioni possonoessere acquisite tramite trivella manuale. Per la scelta del sito del pozzetto valgono le stesseconsiderazioni fatte per il profilo.Figura 4.3. Pozzetto o minipit.Osservazione spe<strong>di</strong>tiva o superficialeRappresenta un casistica varia che può andare dall’annotazione delle con<strong>di</strong>zioni superficiali del suolo o <strong>di</strong>altre caratteristiche della stazione, alla descrizione spe<strong>di</strong>tiva <strong>di</strong> sezioni naturali o artificiali, oppure alladescrizione <strong>di</strong> situazioni <strong>di</strong>sturbate che possono però dare informazioni relative ad alcune caratteristiche oproprietà del suolo (verifica <strong>di</strong> processi pedogenetici in orizzonti profon<strong>di</strong> o sepolti, caratteristiche <strong>dei</strong>substrati, ecc.).149
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICISITONumero dell’osservazioneVariabile non co<strong>di</strong>ficata. Deve essere attribuito un numero progressivo all’osservazione pedologica. Ilco<strong>di</strong>ce alfanumerico composto dalla concatenazione del co<strong>di</strong>ce del <strong>rilevamento</strong>, tipo e numerodell’osservazione deve essere univoco nell’intero archivio delle osservazioni e quin<strong>di</strong> non confon<strong>di</strong>bilecon alcuna osservazione né del <strong>rilevamento</strong> in atto né <strong>di</strong> rilevamenti passati.Origine della sezioneViene richiesto <strong>di</strong> in<strong>di</strong>care la modalità con cui è stata realizzata la sezione <strong>di</strong> suolo oggetto delladescrizione. Come si è detto, nel corso <strong>dei</strong> rilevamenti si possono utilizzare, con le dovute accortezze,sezioni già esistenti generate, dall’azione dell’uomo o da fenomeni naturali. Le casistiche co<strong>di</strong>ficate sonoin<strong>di</strong>cate in tabella.Tabella 4.2. Origine della sezione.Co<strong>di</strong>ce Descrizione1 Scavo appositamente effettuato2 Sezione stradale3 Sezione <strong>di</strong> conduttura (per cavidotti)4 Parete <strong>di</strong> cava5 Scavo per manufatto (es. scavo per fondamenta)6 Altri scavi (specificare in nota)7 Scarpata <strong>di</strong> erosione (es. nicchia <strong>di</strong> frana)8 Sezione <strong>di</strong> terrazzo9 Altro naturale (specificare in nota)AgenteAntropicoNaturale4.2.2 Carta <strong>di</strong> localizzazioneSi intende il supporto cartaceo e/o <strong>di</strong>gitale eventualmente utilizzato in campo per ubicare le osservazionipedologiche ed altre informazioni relative al <strong>rilevamento</strong> in atto. Segnalare in nota nel caso si utilizzi untipo <strong>di</strong> cartografia od un scala attualmente non prevista.Tipo <strong>di</strong> carta e denominatore della scalaIn<strong>di</strong>care il tipo <strong>di</strong> cartografia utilizzata.Tabella 4.3. Co<strong>di</strong>ci delle basi topografiche.Co<strong>di</strong>ce Descrizione1 IGMI2 CTR, ortofotocarte3 AltreTabella 4.4. Classi <strong>dei</strong> denominatori <strong>di</strong> scala.Co<strong>di</strong>ce Descrizione1 5.0002 10.0003 25.0004 50.0005 100.0006 250.000Sigla della cartaVariabile non co<strong>di</strong>ficata; es 119 III NO.150
SITOLA DESCRIZIONE DEL SUOLO4.2.3 Fotografie dell’osservazioneÉ importante acquisire immagini <strong>di</strong> buona qualità relative al profilo e al paesaggio che lo circonda e <strong>di</strong> cuil’osservazione è rappresentativa. Qualunque sia il sistema <strong>di</strong> acquisizione in campo, è opportuno che leimmagini siano archiviate in formato <strong>di</strong>gitale con buona risoluzione. Ai fini dell’archiviazione ogniimmagine avrà un suo ID che è composto dal codex dell’osservazione <strong>di</strong> riferimento (concatenazione <strong>di</strong>co<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> <strong>rilevamento</strong>, tipo <strong>di</strong> osservazione e numero dell’osservazione), soggetto della foto ed un numeroprogressivo.Tabella 4.5. Co<strong>di</strong>ficazione delle immagine per il <strong>rilevamento</strong> pedologico.Co<strong>di</strong>ce del <strong>rilevamento</strong> Co<strong>di</strong>ce attribuito al <strong>rilevamento</strong> pedologicoTipo <strong>di</strong> osservazione <strong>di</strong> Seconda le specifiche del manuale (P, T; Q, O), N se svincolata da ogniriferimentoosservazioneNumero <strong>di</strong> osservazione Progressivo per ogni tipologia <strong>di</strong> osservazioneSoggetto della fotografia Tipo <strong>di</strong> osservazione (P, T, Q, O), oppure ambito geografico (ST: sistema,SST: sottosistema, UT: unità <strong>di</strong> terre, ET, elemento <strong>di</strong> terre.), S (stazioneattorno al profilo), D (dettaglio o particolarità della osservazione), N (foto nonrappresentativa della osservazione)Numero della fotografia Nel caso si fotografi più volte lo stesso soggettoÈ bene comunque pre<strong>di</strong>sporre una descrizione sintetica che metta in risalto le caratteristiche essenziali delsoggetto della foto. Per quanto riguarda specificatamente i profili <strong>pedologici</strong>, è importante la qualità dellapreparazione della trincea. Può essere raccomandato l’utilizzo <strong>di</strong> un metro, possibilmente a nastro ebicolore, con alternanza del colore ogni 10 cm. La lavagna deve garantire un buona leggibilità dellescritte (ad esempio fondo nero) e verrà <strong>di</strong>sposta sullo scavo, lateralmente e sopra il metro. Su questadovranno essere riportati almeno le informazioni relative all’anagrafe del profilo.Tutti i profili devono essere accompagnati da immagini frontali, escludendo possibilmente le paretilaterali dello scavo. In caso <strong>di</strong> luminosità insufficiente è consigliabile l'uso del flash. Inoltre, qualora ilprofilo si presentasse eccessivamente asciutto, è consigliabile inumi<strong>di</strong>rlo me<strong>di</strong>ante un nebulizzatore edeffettuare la ripresa prima e dopo questa operazione. La preparazione del profilo per la sua fotografia edescrizione può contemplare <strong>di</strong>verse possibilità, ma le due più comuni sono la “scalpellatura” e la“lisciatura”. Con la prima si tende a mettere in evidenza gli aggregati naturali, tramite lavorazione concoltello o martello, ed è in<strong>di</strong>cata per suoli ben strutturati o con orizzonti a <strong>di</strong>versa strutturazione. Nel casoinvece <strong>di</strong> suoli poco strutturati, è preferibile lisciare il profilo con pala o vanghetta, in modo da farrisaltare le <strong>di</strong>fferenze <strong>di</strong> colore tra gli orizzonti.4.2.4 DataVariabile non co<strong>di</strong>ficata. Devono essere riportati giorno, mese ed anno in cui è eseguita la descrizionedell’osservazione.4.2.5 Co<strong>di</strong>ce <strong>dei</strong> rilevatoriA ciascun rilevatore deve essere assegnato un co<strong>di</strong>ce numerico.151
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICISITO4.2.6 Comune e provinciaDevono essere in<strong>di</strong>cati comune e provincia in cui ricade il sito dell’osservazione.4.2.7 LocalitàVariabile non co<strong>di</strong>ficata. In<strong>di</strong>care il nome della località cui è possibile riferire l’osservazione. Épreferibile attingere l’informazione dalla cartografia topografica a <strong>di</strong>sposizione (Toponimi locali).4.2.8 Ubicazione dell’osservazioneDebbono essere acquisite, con la maggiore precisione possibile, le informazioni inerenti la posizioneesatta dell’osservazione pedologica. In considerazione della rapida evoluzione della strumentazionetecnica, ogni <strong>rilevamento</strong> dovrà stabilire l’errore tollerato. Si consiglia l’utilizzo <strong>di</strong> strumenti GPS <strong>di</strong>buona precisione. Le coor<strong>di</strong>nate possono essere piane o geografiche.Coor<strong>di</strong>nate pianeSistema <strong>di</strong> riferimento e fusoDebbono essere in<strong>di</strong>cati sistema <strong>di</strong> riferimento, il “datum” e il fuso (es. UTM-WGS84 32).Coor<strong>di</strong>nate piane valoriVariabile non co<strong>di</strong>ficata. In<strong>di</strong>care i valori con la massima precisione possibile.Coor<strong>di</strong>nate geograficheVariabile non co<strong>di</strong>ficata. La latitu<strong>di</strong>ne e la longitu<strong>di</strong>ne è espressa in gra<strong>di</strong>, minuti e secon<strong>di</strong> o in gra<strong>di</strong>decimali. Il riferimento è lo standard World Geodetic System84 (WGS84), su cui si basa anche il GlobalPositioning System (GPS). Lo standard WGS84 si basa su un modello geodetico geocentrico della Terrastandard.4.2.9 Caratteri dell’osservazioneSi intende per stazione o sito l’area ristretta intorno all’osservazione puntuale. Nel caso del <strong>rilevamento</strong> <strong>di</strong>tipo GIS oriented la stazione deve essere rappresentativa dell’elemento territoriale, ossia dellacomponente territoriale dell’unità <strong>di</strong> terre (ve<strong>di</strong> par. 1.3).QuotaVariabile non co<strong>di</strong>ficata. Si esprime in metri sul livello del mare. Specificare se valore negativo.152
SITOLA DESCRIZIONE DEL SUOLOPendenzaVariabile non co<strong>di</strong>ficata. Rilevare con appositi strumenti il valore della pendenza della stazione .Tabella 4.6. Classi in uso per la valutazione delle terre(Costantini, 2006).Valutazione Pendenza (%)Superficie pianeggiante < 0,2Superficie subpianeggiante 0,2 - 2Superficie a pendenza debole 3 - 5Superficie a pendenza moderata 6 - 13Superficie a pendenza rilevante 14 - 20Superficie a pendenza forte 21 - 35Superficie a pendenza molto forte 36 - 60Superficie a pendenza scoscesa 61 - 90Superficie a pendenza ripida > 90Tabella 4.7. Corrispondenza tra i valori <strong>di</strong> pendenza espressi:da percentuale a gra<strong>di</strong> e primi sessagesimali e viceversa.% Gra<strong>di</strong> Gra<strong>di</strong> %0 0,00 0,1 0,21 0,34 1 1,72 1,09 2 3,55 2,52 5 8,710 5,43 7 12,315 8,32 10 17,620 11,19 12 21,325 14,02 15 26,830 16,42 20 36,435 19,17 25 46,640 21,48 30 57,750 26,34 35 70,060 30,58 40 83,970 34,60 45 100,080 38,40 50 119,290 41,59 55 142,8100 45,00 60 173,2110 47,44 65 214,5120 50,12 70 274,7EsposizioneVariabile non co<strong>di</strong>ficata. Immettere il valore dell’azimut nord in gra<strong>di</strong> sessagesimali. es. esposizione nord= 360°, esposizione sud = 180°, esposizione nord-ovest = 270°; per pendenze
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICI4.3 Fattori della pedogenesiLa descrizione del suolo inizia con l’esame <strong>dei</strong> fattori che definiscono tipo ed intensità <strong>dei</strong> processipedogenetici. Le informazioni possono derivare dall’osservazione <strong>di</strong>retta in campo ma possono essereintegrate dalla consultazione <strong>di</strong> altri strati informativi. Non viene richiesta la determinazione in campo <strong>di</strong>informazioni relative all’età delle superfici, al clima o ai regimi pedoclimatici, ma la segnalazione nellenote <strong>di</strong> considerazioni per questi due aspetti potrà risultare utile nelle successive fasi lavoro.GEOMORF.4.3.1 Morfometria e fisiografiaMorfometria (curvatura del sito)In<strong>di</strong>care la geometria prevalente del sito rispetto alle sezioni verticale ed orizzontale passanti per il punto<strong>di</strong> osservazione. In generale le <strong>di</strong>mensioni areali cui fare riferimento per la stima della curvatura sono intermini metrici o decametrici, e quin<strong>di</strong> la curvatura va riferita al sito.Figura 4.5. Esempio <strong>di</strong> definizione della curvatura in ambiente collinare e montano (da : Shoenberger et al. 2002 mo<strong>di</strong>ficato).Figura 4.6. Esempio della curvatura del sito sulla carta topografica.154
LA DESCRIZIONE DEL SUOLOGEOMORF.Tabella 4.8. Classi descrittive della curvatura del sito.Co<strong>di</strong>ce Sezione verticale Sezione orizzontaleLL Lineare LineareLC Lineare ConcavoLV Lineare ConvessoCL Concavo LineareCC Concavo ConcavoCV Concavo ConvessoVL Convesso LineareVC Convesso ConcavoVV Convesso ConvessoFisiografiaLa fisiografia del sito <strong>di</strong> <strong>rilevamento</strong> è descritta in<strong>di</strong>cando la forma e l’elemento morfologico. Sonoomessi i termini descrittivi <strong>di</strong> natura geometrica, poiché questa informazione viene già fornita dallacurvatura del sito. Le forme sono generate dai processi morfogenetici mentre l’informazione relativaall’elemento morfologico sintetizza la posizione della osservazione nella forma e la morfometria delsito (Carnicelli et al. , 2001).Forma ed elemento morfologico sono da valutare per <strong>di</strong>fferenti scale <strong>di</strong> percezione. Generalmenteun unico elemento morfologico non può spaziare in termini uniformi per chilometri, mentre la formanon può essere apprezzata compiutamente su una superficie <strong>di</strong> poche decine <strong>di</strong> m 2 , per cui si consiglia<strong>di</strong> valutare la forma a scala ettometrica o chilometrica e l’elemento morfologico a scala decametrica.FormaLa co<strong>di</strong>fica è su più livelli. Nel caso che si adattino più definizioni, fare riferimento alla definizioneche influenza maggiormente i caratteri e la <strong>di</strong>stribuzione <strong>dei</strong> suoli (tab. 4.9).Tabella 4.9. Co<strong>di</strong>fica delle forme.Co<strong>di</strong>ce Descrizione0 SconosciutaA00 Forme <strong>di</strong> origine antropicaAA Area <strong>di</strong> accumulo AAD Discarica <strong>di</strong> rifiuti o inertiAAR Riporto <strong>di</strong> materiali terrosiAE Area estrattiva AEA Cava abbandonataAEC Cava attivaAG Arginatura per canale o altra operaAT Versante terrazzato ATC Versante ciglionatoATD Versante terrazzato degradatoATI Versante terrazzato integroATM Terrazzamento meccanizzabile, a piani raccor<strong>dati</strong>AV Livellamento, versante rimodellatoC00 Forme <strong>di</strong> origine carsicaCD Depressione carsica CDA Dolina apertaCDC Dolina <strong>di</strong> crolloCDD Dolina a fondo piattoCDE Uvala apertoCDH Rilievo residuale, humCDI Rilievo residuale, chicot155
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICICDP PoljeCDR Uvala <strong>di</strong> crolloCDT Polje apertoCDU UvalaCDV Dolina <strong>di</strong> subsidenzaCI Versante carsificatoCP Pietraia carsica (griza o grisè)CR Ripiano carsificatoCT Ripiano con tracce <strong>di</strong> reticolo fluvio carsicoCV Valle fluvio-carsica CVA Valle cieca o valle <strong>di</strong> sorgenteCVC Canyon carsicoCVV Valle seccaE00 Forme del modellamento erosivoEA Forme <strong>di</strong> accumulo EAC Cono (o coni coalescenti) <strong>di</strong> EACa Attivo/idetrito EACs Stabilizzato/iEAP Glacis d’accumuloEAS Falda <strong>di</strong> detrito da crollo EASa Attiva(talus) EASs StabilizzataEAT Torbiera <strong>di</strong> versanteEAV Cono <strong>di</strong> valangaEC Canale <strong>di</strong> valangaED Versante <strong>di</strong>ssestato * EDB Versante con biancaneEDC Versante con calanchiEDF Versante con frane <strong>di</strong> suolo (soil slips)EDI Incisione catastroficaEDL Colata da trasporto in massaEDR Versante con creep (reptazione)EDS Versante con soliflussoGEOMORF.EE Versante eroso EER Versante con incisioni e solchi permanenti (rill e gullyerosion)EES Versante con erosione <strong>di</strong>ffusa (sheet erosion)EF Versante in frana EFC Corpo <strong>di</strong> franaEFN Nicchia <strong>di</strong> franaEG Pe<strong>di</strong>ment o glacis d’erosioneEL Versante lineare ELA Versante lineare aggradatoELN Versante lineare non aggradatoELR Versante lineare regolareEP Scarpata EPS Piede <strong>di</strong> scarpataER Resto <strong>di</strong> terrazzoES Superficie <strong>di</strong>ESD Forma <strong>di</strong>ssecataspianamentoESP Forma spianataESS Forma semispianataET Rilievo residuale (tor)EV Versante con vallecolenon cartografabiliEVA Versante con vallecole non aggradato, in incisionecatastroficaEVC Versante con vallecole aggradato, in incisione catastroficaEVE Versante con vallecole aggradato, con vallecole reinciseEVG Versante con vallecole aggradato, con vallecole riempite aconcaEVI Versante con vallecole aggradatoEVN Versante con vallecole non aggradato156
LA DESCRIZIONE DEL SUOLOGEOMORF.EXEYF00FAFCFEFLFRFTG00GBGCGDGFGGGM157EVP Versante con vallecole aggradato, con vallecole riempite afondo piattoEVR Versante con vallecole regolareEVS Versante con vallecole regolare, in incisione catastroficaEVTVersante con vallecole aggradato, con vallecole inreincisione catastroficaVersante convesso, sommità arrotondataValleEYA Valle a V asimmetricaEYC Valle a U (a conca)EYN Valle molto incisa a pareti subverticaliEYV Valle a VForme <strong>di</strong> fondovallePiana alluvionale <strong>di</strong> FAA Fondovallefondovalle (in piana FAB Fondovalle con substrato roccioso sub affiorantebonificata sostituire la FAF Alveo attivo a canali intrecciatilettera A della sigla con FAM Alveo <strong>di</strong> corso effimero o semi effimerola B; ad es. FBA, FBB.) FAR Fondovalle riempitoFAS Fondovalle sospesoFAX Fondovalle con tracce <strong>di</strong> canali intrecciatiFAY Fondovalle con tracce <strong>di</strong> canali singoliConoi<strong>di</strong>FCC ConoideFCD Depressione <strong>di</strong> interconoideFCE Conoi<strong>di</strong> coalescentiFCF Glacis d’accumulo in conoi<strong>di</strong>Terrazzo d’erosionePiana <strong>di</strong> riempimento FLM Piana <strong>di</strong> riempimento e/o prosciugamento lacustre ae/o prosciugamentoprevalenza mineralelacustre (in piana FLO Piana <strong>di</strong> riempimento e/o prosciugamento lacustre abonificata sostituire laprevalenza organica (torbiera)lettera L della sigla con FLS Piana <strong>di</strong> riempimento e/o prosciugamento lacustre ala D; ad es. FDM, FDS, prevalenza minerale, sospesaecc.)Conca <strong>di</strong> riempimento FRS Conca <strong>di</strong> riempimento complesso, sospesacomplessoTerrazzo fluviale in FTI Terrazzo fluviale <strong>di</strong>ssecatofondovalleFTO Terrazzo fluviale con superficie ondulataFTS Scarpata <strong>di</strong> erosione fluvialeFTX Terrazzo fluviale con tracce <strong>di</strong> canali intrecciatiFTY Terrazzo fluviale con tracce <strong>di</strong> canali singoliForme glaciali e periglacialiColata <strong>di</strong> blocchi (e rock glaciers)Circo glacialeSuperficie interessata da crioturbazioneForme <strong>di</strong> accumulo GFK EskerfluvioglacialiGFR Rilievi <strong>di</strong> alluvionamento supraglaciale (kame)GFS Piana <strong>di</strong> alluvionamento proglaciale (sandur)Valli glacialiGGS Valle glaciale sospesaGGU Valle glaciale ad URilievo morenico GMA Morena <strong>di</strong> fondo, morena <strong>di</strong> ablazioneGMD DrumlinGMF Morena frontale
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICIGMI Depressione intermorenicaGML Morena lateraleGMN NivomorenaGN Nicchia <strong>di</strong> nivazioneGS Conca <strong>di</strong>GSR Conca <strong>di</strong> sovraescavazione riempitasovraescavazioneGT Terrazzo <strong>di</strong> erosione glacialeM00 Forme <strong>di</strong> origine marina, lagunare e lacustreMA Piattaforma d’abrasione MAP Piede <strong>di</strong> falesia (talus)ML Terrazzo lacustreMP Piana costiera MPA Piana <strong>di</strong> mareaMPC CordoneMPF Piana <strong>di</strong> fangoMPL Fascia <strong>di</strong> oscillazione lacustreMPM Canale <strong>di</strong> mareaMPP PaludeMPS Piana <strong>di</strong> sabbiaMT Terrazzo marino MTI Terrazzo marino <strong>di</strong>ssecatoP00 Forme <strong>di</strong> origine fluviale (in pianura)PC Piana alluvionale (in PCA Area <strong>di</strong> transizione (pianura modale o argine <strong>di</strong>stale)pianura bonificata PCC Ventaglio <strong>di</strong> rotta <strong>di</strong>stalesostituire la lettera C PCD Dosso o argine naturale (levee)della sigla con la B; ad PCE Piana alluvionale elevataes. PBA, PBD, ecc.) PCF Alveo attivoPCG GolenaPCI Isola fluvialePCM Paleoalveo a canale singoloPCR Bassura <strong>di</strong> risorgivaPCS Piana a meandriPCT Area <strong>di</strong> tracimazionePCV Ventaglio o canale <strong>di</strong> rottaPCW Paleoalveo a canali intrecciatiPCX Area con tracce <strong>di</strong> canali intrecciatiPCY Area con tracce <strong>di</strong> canali singoliPCZ Depressione (bacino intercanale)PD Delta (in delta PDA Area <strong>di</strong> transizione (pianura modale o argine <strong>di</strong>stale)bonificato sostituire la PDD Dosso o argine naturale (levee) in deltalettera D della sigla con PDT Area <strong>di</strong> tracimazione in deltala E; ad es. PEP, PED, PDV Ventaglio <strong>di</strong> rotta in deltaecc.)PDW Alveo inattivo in deltaPDZ Depressione (bacino intercanale) in deltaPP Piana pedemontana PPC ConoidePPD Depressione <strong>di</strong> interconoidePPE Conoi<strong>di</strong> coalescentiPPF Glacis d’accumuloPPT Parte <strong>di</strong>stale del conoide (transizione con la bassa pianura)PPW Conoide con tracce <strong>di</strong> canali intrecciatiPPX Paleoalveo a canali intrecciati, su conoidePPY Paleoalveo a canale singolo, su conoidePT Terrazzo fluviale in PTB Paleoalveo a canali intrecciati, su terrazzo fluvialepianura PTI Terrazzo fluviale <strong>di</strong>ssecato158GEOMORF.
LA DESCRIZIONE DEL SUOLOGEOMORF.PTM Paleoalveo a canale singolo, su terrazzo fluvialePTO Terrazzo fluviale con superficie ondulataPTR Basso terrazzo fluvialePTX Terrazzo fluviale con tracce <strong>di</strong> canali intrecciatiPTY Terrazzo fluviale con tracce <strong>di</strong> canali singoliS00 Forme derivanti da struttura e tettonicaSC CuestaSD Depressione tettonica (graben)SG Versante molto irregolare per strutture geologicheSR Rilievo tettonico (horst)SS Superficie strutturale SSD Superficie strutturale <strong>di</strong>ssecataSSO Superficie strutturale ondulataSV Versante <strong>di</strong> fagliaV00 Forme <strong>di</strong> origine vulcanicaVA CalderaVC Cono vulcanico VCC Cono <strong>di</strong> cenereVCL Cono <strong>di</strong> lavaVCP Cono poligenicoVCS Cono <strong>di</strong> scorieVD Cupola o domo lavicoVL Colata lavicaVP Plateau vulcanicoVR Cratere VRM Cratere <strong>di</strong> esplosione (maar)VT Depressione vulcano-tettonicaW00Forme <strong>di</strong> origine eolicaWA Area <strong>di</strong> accumulo eolicoWD DuneWDA Duna appoggiataWDP Dune spianateWDS Dune stabilizzateWE Superficie o conca <strong>di</strong> deflazioneWI Area interdunale WIL Area interdunale perio<strong>di</strong>camente allagata (lama)* I versanti <strong>di</strong>ssestati sono spesso interessati da più forme <strong>di</strong> erosione contemporaneamente. Le specifiche riportate al livello <strong>di</strong>maggior dettaglio in<strong>di</strong>cano il fenomeno prevalente, non escludendo la presenza <strong>di</strong> altre forme <strong>di</strong> erosione superficiale e <strong>di</strong>massa.159
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICIElemento morfologicoTabella 4.10. Co<strong>di</strong>fica degli elementi morfologici.La superficie èpianeggiante ed estesaP Piano abbastanza da renderetrascurabili i processi <strong>di</strong>versanteLe superfici a<strong>di</strong>acentisono più alte, conD Depressione pendenza maggiore inalmeno due <strong>di</strong>rezioniopposteSSommitàV Versante AltroLe superfici a<strong>di</strong>acentisono più basse, conpendenza maggiore inalmeno due <strong>di</strong>rezionioppostePP Pianura Le superfici a<strong>di</strong>acenti sonoanch'esse pianeggianti ocorpi d'acquaPR Ripiano AltroDCDADepressionechiusaDepressioneapertaLe superfici a<strong>di</strong>acenti sonopiù alte in tutte le <strong>di</strong>rezioniLe superfici a<strong>di</strong>acenti sonopiù alte in due o tre <strong>di</strong>rezioniSU Culmine Le superfici a<strong>di</strong>acenti sonopiù basse in tutte le <strong>di</strong>rezioniSC Cresta Le superfici a<strong>di</strong>acenti sonopiù basse in due o tre<strong>di</strong>rezioni, e poco <strong>di</strong>versenelle altreSS Sella Le superfici a<strong>di</strong>acenti sonopiù basse in due <strong>di</strong>rezioniopposte e più alte nelle altreVSVAVBVMVersantesempliceParte alta delversanteParte bassadel versanteParte me<strong>di</strong>adel versantedueUna superficie a<strong>di</strong>acente piùalta è una sommità, piano odepressione aperta, le piùbasse sono depressioni opianiLa superficie a<strong>di</strong>acente piùalta è una sommità o pianoLa superficie a<strong>di</strong>acente piùbassa è una depressione opianoAltroGEOMORF.160
LA DESCRIZIONE DEL SUOLOGEOMORF.Erosione e deposizioneErosione reale: tipo e intensitàVerificare se esistano e quin<strong>di</strong> qualificarli (agente ed intensità) processi <strong>di</strong> asporto del suolo a causa <strong>di</strong>agenti quali acqua, vento, ghiaccio e gravità.Area interessata da erosioneTabella 4.11.Classi <strong>di</strong> erosione.Co<strong>di</strong>ce Descrizione0 Assenza <strong>di</strong> erosione1 Erosione idrica <strong>di</strong>ffusa (sheet erosion)*2 Erosione idrica incanalata per rivoli (rill erosion)3 Erosione idrica incanalata per burronamenti (gully erosion)4 Erosione idrica sottosuperficiale (tunnel)5 Erosione <strong>di</strong> massa per crollo6 Erosione <strong>di</strong> massa per scivolamento e scoscen<strong>di</strong>mento7 Soliflussione e creeping8 Erosione eolica9 Erosione carsica10 Erosione <strong>di</strong> sponda11 Erosione per lavorazione meccanica* Presenza <strong>di</strong> testimoni <strong>di</strong> erosione quali, ad esempio: assenza <strong>di</strong> orizzonti O od A,presenza <strong>di</strong> pinnacoli <strong>di</strong> erosione, <strong>di</strong> scheletro o pietrosità circondata da terrenosigillato dalla destrutturazione e dalla rimozione delle particelle fini per flussoidrico superficiale.In<strong>di</strong>care la percentuale <strong>di</strong> superficie (co<strong>di</strong>ce della classe) dell’elemento territoriale che è interessata daifenomeni erosivi sopra in<strong>di</strong>cati.DeposizioneIn<strong>di</strong>care se sono presenti processi <strong>di</strong> deposizione. Nel caso in<strong>di</strong>care l’agente secondo le classi previstein tabella.Tabella 4.12. Classi <strong>di</strong> area <strong>di</strong>superficie in erosione.Co<strong>di</strong>ce Classe (%)1 0 - 52 5 - 103 10 - 254 25 - 505 > 50Tabella 4.13. Co<strong>di</strong>fica della tipologia <strong>di</strong> deposizione.Co<strong>di</strong>ce Descrizione0 Assenza <strong>di</strong> deposizione1 Deposizione idrica2 Deposizione eolica3 Deposizione gravitazionale161
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICI4.3.2 GeologiaPer quanto riguarda questa voce si richiede <strong>di</strong> fornire informazioni sulla formazione geologica, sullecaratteristiche del substrato e del materiale genitore. L’informazione sulla formazione geologica fasempre riferimento alla cartografia geologica ufficiale. Per substrato invece si intende la formazionerocciosa, consolidata o no, che si trova al <strong>di</strong> sotto del materiale genitore e che è intervenuta nellaformazione del suolo in<strong>di</strong>rettamente o non è intervenuta affatto.La natura del substrato è osservabile <strong>di</strong>rettamente o può essere ricavata da quanto riportato dauna carta geologica. La maggior parte delle informazioni relative al substrato è reperibile in legendee memorie delle carte geologiche; anche se non è utile duplicarla, in certi casi una descrizione delsubstrato può essere necessaria. In<strong>di</strong>cazioni sulla stratificazione del substrato possono o no esserericavate dalla carta geologica ed essere specifiche per l’ambiente dell’osservazione; l’osservazione<strong>di</strong>retta in campagna potrà fornire <strong>dati</strong> non ricavabili dalla carta, come assetto, strutture e alterazionedel substrato. In caso <strong>di</strong> formazioni litologiche composte da più litotipi <strong>di</strong>versi sarà necessario (sepossibile) registrare il litotipo specifico nel sito. Se si osserva <strong>di</strong>rettamente un substrato <strong>di</strong>verso daquello in<strong>di</strong>cato dalla carta geologica, sarà opportuno registrare tutti i <strong>dati</strong> osservabili. I substraticonsoli<strong>dati</strong> si descrivono utilizzando le co<strong>di</strong>fiche relative ai litotipi, mentre i substrati nonconsoli<strong>dati</strong> si descrivono usando le co<strong>di</strong>fiche in<strong>di</strong>cate per “materiali genitori”. Sia per i materialigenitori che per il substrato può essere necessario ricorrere a modalità <strong>di</strong> osservazione che non silimitino a quanto visibile <strong>di</strong>rettamente sul profilo. L’osservazione va integrata riferendosi, adesempio, ad un fronte <strong>di</strong> frana, incisione o scavo non molto <strong>di</strong>stanti, che possono aiutare a stimare lasequenza <strong>dei</strong> materiali geologici.Per materiale genitore o materiale pedogenetico (parent material) si intende il materiale nonconsolidato (incoerente, debolmente coerente, pseudocoerente od anche coerente, se lacementazione è <strong>di</strong> origine pedogenetica) da cui il suolo deriva.La maggior parte delle carte geologiche non riporta i depositi superficiali; alcune carte liriportano, almeno in parte, ma la qualità della descrizione è comunque limitata. L’analisi edescrizione approfon<strong>di</strong>ta <strong>dei</strong> depositi superficiali è quin<strong>di</strong> compito dell’indagine pedologica.In molti suoli il substrato non è il materiale genitore. Se vi sono evidenze però che il suoloderivi dal substrato, si identifica il materiale genitore come detrito in posto, residuo o saprolite. Conil termine detrito in posto si in<strong>di</strong>ca un prodotto <strong>di</strong> alterazione prevalentemente fisica del substrato(es: arenaria <strong>di</strong>sgregata dall’azione del gelo e <strong>di</strong>sgelo), con saprolite un prodotto <strong>di</strong> alterazioneprevalentemente chimica (es: alterazione profonda del granito), mentre residuo fa riferimento alresiduo insolubile <strong>di</strong> una roccia che subisce <strong>di</strong>ssoluzione (es: calcare, gesso).La scheda <strong>di</strong> campagna (pag. 277) prevede la possibilità <strong>di</strong> in<strong>di</strong>care e descrivere un solo materialegenitore; in caso <strong>di</strong> materiali <strong>di</strong>versi e sovrapposti, si descrivono sotto forma <strong>di</strong> nota nell’appositospazio della scheda stessa (ad esempio: colluvio su residuo, o loess su saprolite). Se il rilevatore sitrova <strong>di</strong> fronte a materiali genitori finemente stratificati <strong>di</strong> origine omogenea, come ad esempio certitipi <strong>di</strong> alluvioni o se<strong>di</strong>menti lacustri, descriverà in<strong>di</strong>vidualmente soltanto livelli <strong>di</strong> spessorealmeno decimetrico (20-25 cm). L’identificazione del materiale genitore ha in parte naturasintetica, cioè risulta da una correlazione <strong>di</strong> <strong>dati</strong> <strong>di</strong> vario tipo relativi al suolo, oltre che al sito eall'ambiente. È consigliabile quin<strong>di</strong> in<strong>di</strong>care la natura del materiale genitore una volta ultimata ladescrizione del profilo.GEOLOGIAFormazione geologicaIn<strong>di</strong>care le informazioni ricavabili dagli strati informativi <strong>di</strong>sponibili (<strong>di</strong>gitali od informatizzati). Èopportuno in<strong>di</strong>care sempre la formazione geologica riportata da una fonte cartografica per il luogo162
LA DESCRIZIONE DEL SUOLOdell’osservazione. “Formazioni” in<strong>di</strong>cate come detrito, alluvioni, riempimenti ecc. non sono moltosignificative, trattandosi in effetti <strong>di</strong> materiali genitori, nel senso qui usato. In questi casi èpreferibile, in sede <strong>di</strong> archiviazione, riferirsi a una carta geologica a scala inferiore, che dovrebberiportare il substrato al <strong>di</strong> sotto <strong>dei</strong> depositi superficiali.GEOLOGIASubstratoSi descriva ciò che è osservabile <strong>di</strong>rettamente in campagna, nel profilo o in posizioni limitrofe. Aseconda del tipo <strong>di</strong> substrato si descrivono <strong>di</strong>fferenti caratteri. Esso può essere consolidato o nonconsolidato (quest’ultimo può essere minerale od organico). I co<strong>di</strong>ci del substrato non consolidatocoincidono con quelli del parent material.Substrato consolidatoTabella 4.14. Co<strong>di</strong>fica <strong>dei</strong> substrati consoli<strong>dati</strong>.Co<strong>di</strong>ce TipoY Non rilevabileSE0000 ROCCE SEDIMENTARIESE1000 ROCCE SEDIMENTARIE CLASTICHESE1100 ROCCE SEDIMENTARIE CLASTICHE CONSOLIDATE O POCOCONSOLIDATESE1101 Conglomerato o ru<strong>di</strong>teSE1102 AreniteSE1103 Silcarenite a cemento siliceoSE1104 Silcarenite a cemento calcareoSE1105 CalcareniteSE1106 SiltiteSE1107 ArgilliteSE1108 Torbi<strong>di</strong>teSE1108A Torbi<strong>di</strong>te prevalentemente arenaceaSE1108B Torbi<strong>di</strong>te prevalentemente argilloso e siltosaSE1108C Torbi<strong>di</strong>te prevalentemente conglomeraticaSE1108D Torbi<strong>di</strong>te prevalentemente arenaceo-calcareaSE1108E Torbi<strong>di</strong>te prevalentemente calcareo-marnosaSE1108F Torbi<strong>di</strong>te prevalentemente arenaceo-argillosaSE1108G Torbi<strong>di</strong>te prevalentemente argilloso-calcareaSE1109 MarnaSE1109A Argilla marnosaSE1109B Marna argillosaSE1109C Marna calcareaSE1109D Calcare marnosoSE1110 Calcare clastico (calciru<strong>di</strong>te)SE1111 DiaspriSE1112 LigniteSE2000 ROCCE SEDIMENTARIE DI DEPOSITO CHIMICO E ORGANOGENESE2100 DI DEPOSITO CHIMICO PRECIPITATIVOSE2101 CalcareSE2101A Calcare cavernosoSE2101B Calcare oolitico e pisoliticoSE2101C Calcare lacustre163
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICISE2101DSE2102SE2103SE2103ASE2200SE2201SE2202SE2203SE2300SE2301SE2302SE2303SE2304MA0000MAI000MAI100MAI101MAI102MAI103MAI104MAI105MAI106MAI200MAI201MAI202MAI203MAI204MAI205MAI206MAI207MAV000MAV100MAV101MAV102MAV103MAV104MAV105MAV200MAV201MAV202MAV203MAV300MAV301MAV302MAV303MAV304MAV305MAV306MAP000MAP100MAP101Calcare dolomiticoTravertinoDolomiaDolomia calcareaDI DEPOSITO CHIMICO EVAPORITICOCalcare evaporiticoGesso e anidriteAliteORGANOGENECalcare fossiliferoCalcare selciferoDiatomiteSelceROCCE MAGMATICHEROCCE MAGMATICHE INTRUSIVE E IPOABISSALIROCCE PLUTONICHE DA ACIDE AD INTERMEDIEGranitoGrano<strong>di</strong>oriteDioriteTonaliteSieniteMonzoniteROCCE PLUTONICHE DA BASICHE AD ULTRABASICHEGabbroAnortositePeridotitePirosseniteDiabaseSerpentinite*OfiolaceROCCE EFFUSIVE VULCANICHE E SUBVULCANICHEROCCE EFFUSIVE ACIDEOssi<strong>di</strong>anaRiolitePorfidoDaciteTrachiteROCCE EFFUSIVE INTERMEDIEAndesiteLatiteFonoliteROCCE EFFUSIVE BASICHE E ULTRABASICHETefriteBasaltoBasaniteFoi<strong>di</strong>teNefeliniteLeucititeROCCE VULCANICHE PIROCLASTICHERocce vulcaniche piroclastiche consolidate da materiali <strong>di</strong> <strong>di</strong>ametro
LA DESCRIZIONE DEL SUOLOGEOLOGIAMAP102 IgnimbritiMAP200 Rocce vulcaniche piroclastiche consolidate da materiali <strong>di</strong> <strong>di</strong>ametro >2 mmMAP201 TufiMAP202 AgglomeratiMAP203 BrecceMAP300 Surge piroclasticoME0000 ROCCE METAMORFICHEMES000 ORIGINATE DA ROCCE SEDIMENTARIEMES100 ORIGINATE DA ROCCE SEDIMENTARIE PELITICHEMES101 Argilloscisti (tipo: ardesia o lavagna)MES102 Filla<strong>di</strong> (o filliti) e scisti sericitico-cloriticiMES103 MicascistiMES104 CornubianitiMES200 ORIGINATE DA ROCCE SEDIMENTARIE ARENITICHEMES201 QuarziteMES300 ORIGINATE DA ROCCE SEDIMENTARIE CALCAREEMES301 CalcescistiMES302 MarmiMES303 Scisti sericitico- cloritici calcareiMEC201 Rocce calcisilicatiche (skarn)ME0000 ROCCE METAMORFICHEMEM000 ROCCE METAMORFICHE ORIGINATE DA ROCCE MAGMATICHEMEM100 ORIGINATE DA ROCCE QUARZO-FELDSPATICHEMEM101 Gneiss e gneiss occhia<strong>di</strong>no (paragneiss e ortogneiss)MEM102 Migmatite (tipo: embrechiti, anteriti, agmatiti)MEM103 Granulite feldspaticaMEM104 Scisti bianchi e quarzo-scistiMEM105 MetagrovaccaMEM200 ORIGINATE DA ROCCE FEMICHEMEM201 Scisti ver<strong>di</strong> (prasiniti, cloritoscisti, talcoscisti)MEM202 AnfibolitiMEM203 EclogitiMEM204 MetagabbroMEM205 Granulite basicaMEM300 ORIGINATE DA ROCCE ULTRAFEMICHEMEM301 Serpentinite* e serpentinoscistiMET000 CATACLASTICHEMET001 Brecce tettoniche a cemento calcareoMET002 Brecce tettoniche a cemento siliceo* La serpentinite compare sia come roccia ultrabasica che come roccia metamorfica, a causa del livello <strong>di</strong> metamorfismolocale e della interpretazione che ne viene data nei vari fogli geologici d’Italia.Substrato non consolidatoTabella 4.15. Co<strong>di</strong>fica del materiale genitore e <strong>dei</strong> substrati non consoli<strong>dati</strong>.DEPOSITI EOLICI (Non vulcanici)EO Deposito eolico EOS Sabbie eolicheEOL LoessEOF Deposito eolico fineDEPOSITI GLACIALIGL GLA Deposito glaciale assiale165
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICILA DESCRIZIONE DEL SUOLODEPOSITI GLACIALIGL Depositi glaciali o GLA Deposito glaciale assialefluvioglaciali GLS Deposito glaciale lateraleGLM Deposito glaciale frontaleGLF Deposito glaciofluvialeGLL Deposito glaciolacustreGLP Deposito periglacialeMATERIALI NON TRASPORTATIRE ResiduoRED Detrito in postoRES SaproliteREC Residuo <strong>di</strong> <strong>di</strong>ssoluzioneDEPOSITI PREVALENTEMENTE GRAVITATIVICOV Colluvio <strong>di</strong> versanteCO ColluvioCOA Depositi da lavorazioni agricoleAVG Glacis d’accumulo 1CR Depositi <strong>di</strong> crolloCF Depositi <strong>di</strong> franaCL Depositi <strong>di</strong> colata CLD Colata <strong>di</strong> detritoCLT Colata <strong>di</strong> fangoMATERIALI ORGANICIOO Depositi organiciOF Fanghi lacustri organici (ve<strong>di</strong> anche se<strong>di</strong>menti lacustri, o fluviolacustri)OT TorbaMATERIALI DIVERSIDA Depositi antropici COA Depositi da lavorazioni agricoleDAA Riporti <strong>di</strong> terra a fini agricoliDAU Riporti <strong>di</strong> terra a fini non agricoliDAR RifiutiDAC Inerti <strong>di</strong> cavaDAI Scarti <strong>di</strong> miniera o industrialiY Depositi <strong>di</strong> originesconosciutaDEPOSITI IN O DA ACQUEAC Se<strong>di</strong>menti marini ACE Depositi <strong>di</strong> estuariolitoraneiACS Depositi <strong>di</strong> spiaggiaACD Sabbie <strong>di</strong> cordoneACP Depositi <strong>di</strong> palude salmastraACC Depositi <strong>di</strong> canale tidaleACT Depositi <strong>di</strong> piana tidaleACF Depositi <strong>di</strong> falesia o costa altaACB Depositi cementati da carbonatiACR Depositi cementati da sostanza organica e/o ossi<strong>di</strong>AM Se<strong>di</strong>menti marini AMR Se<strong>di</strong>menti marini grossolaniAMS Sabbie marineAMP Argille e limi mariniAMC Se<strong>di</strong>menti marini con assetto caotico, o in<strong>di</strong>fferenziatoAL Se<strong>di</strong>menti lacustri, ALR Se<strong>di</strong>menti lacustri grossolanio fluviolacustri ALS Sabbie fluviolacustriGEOLOGIA166
LA DESCRIZIONE DEL SUOLOGEOLOGIAALC Fanghi calcareiOF Fanghi organici (ve<strong>di</strong> anche materiali organici)AP Se<strong>di</strong>menti palustri APM Prevalentemente mineraliAPO Prevalentemente organiciAPV MistiAF Se<strong>di</strong>menti fluviali AFC Depositi <strong>di</strong> canaleAFP Depositi <strong>di</strong> piena ad alta energiaAFB Depositi <strong>di</strong> piena a bassa energiaAFH ColmateAFF Depositi <strong>di</strong> conoide 2AV Depositi <strong>di</strong> AFF Depositi <strong>di</strong> conoideversanteAVA Alluvioni <strong>di</strong> versanteAVG Glacis d’accumulo 3DEPOSITI VULCANICI 4DV DEPOSITIVULCANICI(Tephra)Termine generale per in<strong>di</strong>care frammenti <strong>di</strong> rocce vulcaniche e lava, <strong>di</strong>qualsiasi <strong>di</strong>mensione, da inferiori ai 2 mm <strong>di</strong> <strong>di</strong>ametro fino a più <strong>di</strong> unmetro, che vengono deposti nelle forme più svariate: eruzioniesplosive, risalita <strong>dei</strong> gas e colate laviche.DP Depositi del vulcanismo esplosivo (piroclastico)DPC Materiali <strong>di</strong> Ceneri da caduta o da flusso piroclastico (surge)<strong>di</strong>ametro 2mmDPP1 Pomici Rocce vetrose vescicolate, generalmente <strong>di</strong> colorechiaro e bassa densità.DPP2 Scorie Rocce vetrose vescicolate più scure e più densedelle pomici.DPP3 Brecce Depositi costituiti da frammenti <strong>di</strong> rocciavulcanica a spigoli vivi in matrice fine da scarsaad assente.DPL LaharDFDRDepositi delvulcanismo freatomagmaticoDepositipiroclasticirimaneggiatiEsplosioni <strong>di</strong> vapore acqueo misto a materiali vulcanici.Da processi fluviali, lacustri o marini1 Ripetuto nei depositi prevalentemente gravitativi e nei depositi <strong>di</strong> versante; da usare esclusivamente nel caso in cui ilmodo <strong>di</strong> messa in posto sia ignoto; altrimenti usare colluvio o alluvioni <strong>di</strong> versante2 Ripetuto nei se<strong>di</strong>menti fluviali e nei depositi <strong>di</strong> versante3 Ripetuto nei depositi prevalentemente gravitativi e nei depositi <strong>di</strong> versante; da usare esclusivamente nel caso in cui ilmodo <strong>di</strong> messa in posto sia ignoto; altrimenti usare colluvio o alluvioni <strong>di</strong> versante4 da Schoeneberg et al.,1998 mo<strong>di</strong>ficato.Struttura del substratoDeve essere in<strong>di</strong>cata la classe che meglio descrive la struttura del substrato.167
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICILA DESCRIZIONE DEL SUOLOStato <strong>di</strong> alterazioneTabella 4.16. Co<strong>di</strong>fica della struttura del substrato.Co<strong>di</strong>ce DescrizioneCM consolidato massivoCS consolidato stratificatoCV consolidato caoticoIM non consolidato massivoIS non consolidato stratificatoIV non consolidato caoticoDeve essere in<strong>di</strong>cata la classe che meglio descrive lo stato <strong>di</strong> alterazione del substrato.Tabella 4.17. Co<strong>di</strong>fica dello stato <strong>di</strong> alterazione del substrato minerale.Co<strong>di</strong>ce Definizione DescrizioneLA Fresco o Alterazione assente o molto debole.leggermentealteratoAA Poco alterato L’alterazione parziale è evidenziata da cambiamento <strong>di</strong> colore tral’interno e l’esterno; il nucleo interno rimane relativamente inalterato ela consistenza originale è perduta in piccola parte.RA Me<strong>di</strong>amentealteratoL’alterazione della parte esterna induce arrotondamento <strong>di</strong> frammenti inorigine angolari e/o riduzione <strong>di</strong>mensionale.MAFortemente(molto) alteratoTutti i minerali primari (esclusi i più resistenti) sono alterati; i materialigrossolani si possono rompere o ad<strong>di</strong>rittura sbriciolare con un debolesforzo.GEOLOGIATabella 4.18. Co<strong>di</strong>fica dello stato <strong>di</strong> alterazione <strong>dei</strong> materiali organici.Distinguibilità Caratteri Materialedelle strutture del liquido cheCo<strong>di</strong>ce<strong>dei</strong> tessuti che cola fuoriescevegetali dalle <strong>di</strong>ta tra le <strong>di</strong>taH0H1H2Ottima(inalterate)Molto buonaBuonaPulito ebrunogiallastrochiaroTorbido,brunoNessunoResiduo cherimane inmanoNon pastosoStato <strong>di</strong>decomposizioneAssentePraticamenteassenteMolto scarsoH3Pastoso ScarsoH4 Moderata Molto poco Molto pastoso ModeratoScarsa, piùevidente neiCirca 1/3H5Estremamentematerialiin volumepastosostrizzatiMoltoElevatoH6 Scarsa Circa 1/2torbidoH7 Circa 2/3AssenteAssente, soloresidui legnosipocodecompostiPraticamentenessunoMolto elevatoH8 Quasi tutto Quasi completoH9TuttoCompletoOrizzontigenetici<strong>dei</strong> suoliorganiciFibric (Hi)Hemic(He)Sapric(Ha)168
LA DESCRIZIONE DEL SUOLONB. Le classi sono definite in base alla scala <strong>di</strong> Von Post (Von Post, 1924). Le sigle per orizzonti <strong>di</strong> suolo organicoriportate in questa tabella sono quelle in<strong>di</strong>cate da ST, anche se non esiste una perfetta coincidenza tra le definizioni<strong>di</strong> Von Post ed i criteri <strong>di</strong>scriminanti usati dalla Soil taxonomy (Soil Survey Staff, 1999).GEOLOGIAQualità <strong>dei</strong> materialiLa variabile consente <strong>di</strong> <strong>di</strong>chiarare la composizione <strong>dei</strong> materiali minerali anche quando il litotiponon sia riconoscibile. Come se<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> suolo si intende materiale che mostra caratterichiaramente dovuti alla pedogenesi, ma la cui organizzazione non è quella <strong>di</strong> un orizzonte <strong>di</strong> suolo;è interpretato come materiale <strong>di</strong> suolo trasportato dopo la pedogenesi.Tabella 4.19. Co<strong>di</strong>fica <strong>dei</strong> materiali minerali.Co<strong>di</strong>ce DescrizioneAL AltroCA CalcareoCD Calcareo e dolomiticoDO DolomiticoGS GessosoMM Misto, molto eterogeneoPC PiroclasticoSA SalinoSI SilicaticoSS Se<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> suoloY Non determinabile, ignotoTabella 4.20. Co<strong>di</strong>fica della qualità <strong>dei</strong> materiali organici.Co<strong>di</strong>ce DescrizioneEF Depositi emiorganici fibrosiEP Depositi emiorganici non fibrosiOE Depositi organici erbacei (in genere)OG Depositi organici da graminaceeOS Depositi organici a sfagni e/o muschiOL Depositi organici legnosiMI Depositi organici eterogeneiAL Altri depositi organici (specificare in nota)Composizione granulometricaSolo per substrati non consoli<strong>dati</strong>. Ve<strong>di</strong> tab. 4.23.Soluzioni <strong>di</strong> continuitàDeve essere in<strong>di</strong>cata la classe che meglio descrive questa con<strong>di</strong>zione per il substrato del sito inesame.169Tabella 4.21. Co<strong>di</strong>fica delle soluzioni <strong>di</strong> continuità del substrato.Co<strong>di</strong>ce DescrizioneCA AssentiCF Fessurato CFE fratture <strong>di</strong>stanti 10 e 100 cm
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICIDurezzaCVCOCIVacuolarenon valutata per materiali organicisubstrato incoerente scioltoDeve essere in<strong>di</strong>cata la classe che meglio descrive questa con<strong>di</strong>zione per il substrato del sito inesame.Tabella 4.22. Co<strong>di</strong>fica della durezza del substrato.Co<strong>di</strong>ce DescrizioneD Duro L’escavazione con piccone con colpi da sopra la testa è da moderatamente emarcatamente <strong>di</strong>fficile a impossibileS Soffice Criteri del contatto paralitico secondo la Soil taxonomy (Soil Survey Staff, 2006)GEOLOGIADescrizione del parent material (materiale genitore)Per materiale genitore si intende il materiale non consolidato (incoerente, debolmente coerente,pseudocoerente od anche coerente, se la cementazione è dovuta a processi pedogenetici) da cui ilsuolo deriva.OrigineVe<strong>di</strong> tab. 4.15. Il materiale <strong>di</strong> suolo organico consiste in residui organici che si accumulano allasuperficie in con<strong>di</strong>zioni sia umide che asciutte ed in cui la frazione minerale non influenzasignificativamente le proprietà del suolo. Di seguito vengono in<strong>di</strong>cati i criteri <strong>di</strong>agnostici secondo ilSoil Conservation Service dell’USDA (Soil Survey Staff, 1999): “Il materiale <strong>di</strong> suolo organicodeve avere una delle due seguenti con<strong>di</strong>zioni se saturato con acqua per lunghi perio<strong>di</strong> (a meno cheartificialmente drenato), ed escludendo le ra<strong>di</strong>ci viventi, (valori percentuali riferiti al peso secco)o: il 18 % <strong>di</strong> carbonio organico (30 % <strong>di</strong> sostanza organica) o più se la frazione minerale ha il 60 %o più <strong>di</strong> argilla;oppure: il 12 % <strong>di</strong> carbonio organico (20 % <strong>di</strong> sostanza organica) o più se la frazione minerale nonha argilla;oppure: un limite inferiore del contenuto in carbonio organico proporzionale, tra il 12 e il 18 % , seil contenuto in argilla della frazione minerale è tra lo 0 e il 60 %;oppure: se mai saturato con acqua per più <strong>di</strong> pochi giorni, il 20 % o più <strong>di</strong> carbonio organico.”Composizione granulometricaLa classificazione granulometrica è adattata dal Soil Survey Manual (Soil Survey Staff, 1993) edalla Field Guide for Soil Description (Soil Survey Staff, 2006). Per i frammenti grossolani(scheletro) i termini fanno solo riferimento alle classi <strong>di</strong>mensionali. La quantità si intende in volumesull’intero volume dello strato (vuoti compresi). La classe <strong>di</strong>mensionale da usare nelladenominazione è la più grande, a meno che una classe inferiore non rappresenti almeno (circa) ildoppio in volume. Esempio: una sabbia con il 30% <strong>di</strong> ghiaia e il 14% <strong>di</strong> ciottoli è una sabbia moltoghiaiosa, mentre con il 20% <strong>di</strong> ghiaia e il 12% <strong>di</strong> ciottoli è una sabbia ciottolosa. Per le definizionidella classi <strong>di</strong> materiali grossolani, vedere al capitolo relativo ai frammenti grossolani.170
LA DESCRIZIONE DEL SUOLOGEOLOGIATabella 4.23. Composizione granulometrica <strong>dei</strong> materiali genitori e <strong>dei</strong> substrati non consoli<strong>dati</strong>.Co<strong>di</strong>ce ClasseDescrizioneMATERIALI FINI Frammenti grossolani 15% e 90%, sia ghiaia che ciottoli 2 mm 2 mm 15-65%, elementi >2 mm per oltre i 2/3 2 mm 15-65%, elementi >2 mm per oltre i 2/3 2 mm 15-65%, elementi >2 mm per oltre 1/3 >64 mmTP Pomici Elementi >2 mm >65%, per oltre i 2/3 2 mm >65%, per oltre i 2/3 2 mm >65%, per oltre 1/3 >64 mm* tipiche del vulcanismo acido/me<strong>di</strong>o. ** tipiche del vulcanismo basico171
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICIQualità del materiale genitoreVe<strong>di</strong> tab. 4.19.Relazioni fra materiale genitore e substratoIn<strong>di</strong>care il tipo <strong>di</strong> rapporto esistente fra il materiale genitore dal quale si è originato il suolo e ilsubstrato sottostante.Tabella 4.24. Relazioni fra substrato e materiale genitore.Co<strong>di</strong>ce Tipo Descrizione1 Assente Non esiste nessun rapporto fra i due; es. copertura loessica su roccia calcarea2Imperfetto Esiste un rapporto debole fra i due; es. colluvio <strong>di</strong> materiale a litologiacalcarea su substrato calcareo3Stretto Esiste un rapporto totale fra i due; es. materiale <strong>di</strong> alterazione in posto delsubstrato sottostante4.3.3 Uso del suolo e vegetazioneIn<strong>di</strong>care l’uso del suolo e se possibile anche la vegetazione <strong>di</strong> cui l’osservazione è geograficamenterappresentativa. In alcuni casi le due informazioni si sovrappongono, ma in altri le stesse sicompletano.USO/VEG.Uso del suoloSecondo le co<strong>di</strong>fiche sotto elencate, usare il livello con maggiore (es. 2113) o minore (es. 211)approssimazione a seconda dell’opportunità (Bossard et al., 2000; Regione Lazio, 2003; APAT,2005).172
LA DESCRIZIONE DEL SUOLOUSO/VEG.Tabella 4.25. Classi <strong>di</strong> uso del suolo.Co<strong>di</strong>ce Descrizione1. SUPERFICI ARTIFICIALI. Ambiente urbanizzato1.1. Inse<strong>di</strong>amento residenziale1.2. Inse<strong>di</strong>amento produttivo (servizi generali pubblici e privati), reti e aree infrastrutturali1.3. Aree estrattive, cantieri, <strong>di</strong>scariche e terreni artefatti e abbandonati1.3.1. Aree estrattive, estrazione <strong>di</strong> materiali inerti a cielo aperto (es. cave <strong>di</strong> sabbia e <strong>di</strong> pietre)1.3.2. Discariche1.3.3. Cantieri: Spazi in costruzione, scavi e suoli rimaneggiati1.4. Aree ver<strong>di</strong> urbanizzate (aree ver<strong>di</strong> urbane, aree ricreative e sportive, cimiteri)1.4.1. Aree ver<strong>di</strong> urbane (comprende i cimiteri)1.4.2. Aree sportive, ricreative e archeologiche2. SUPERFICI AGRICOLE UTILIZZATE. Ambiente coltivato2.1. Seminativi2.1.1. Seminativi in aree non irrigue2.1.1.1. Seminativi semplici in aree non irrigue2.1.1.2. Vivai in aree non irrigue2.1.1.3. Colture orticole in pieno campo. in serra e sotto plastica in aree non irrigue2.1.2. Seminativi in aree irrigue2.1.2.1. Seminativi semplici in aree irrigue2.1.2.2. Vivai in aree irrigue2.1.2.3. Colture orticole in pieno campo, in serra e sotto plastica in aree irrigue2.1.3. Risaie2.2. Colture permanenti2.2.1. Vigneti2.2.1.1. Vigneti specializzati2.2.1.2. Vigneti misti ad altre colture permanenti2.2.2. Frutteti. frutti minori e piccoli frutti2.2.2.1. Drupacee2.2.2.2. Pomacee2.2.2.3. Agrumi2.2.2.4. Frutti <strong>di</strong> bosco o piccoli frutti (es. lampone, rovo, ibri<strong>di</strong> <strong>di</strong> rovo e lampone, ribes rosso, ribes bianco, uva spina, mirtillo ecc.)2.2.2.5. Frutti minori2.2.2.5.1. Carrubeti2.2.2.5.2. Fichi2.2.2.5.3. Kiwi173
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICI2.2.2.5.4. Fichi d'in<strong>di</strong>a2.2.2.5.5. Pistacchi2.2.3. Oliveti2.2.3.1. Oliveti specializzati2.2.3.2. Oliveti misti ad altre colture permanenti (in nota specificare quali)2.2.4. Altre colture permanenti2.2.4.1. Arboricoltura da legno2.2.4.1.1. Pioppeti, saliceti, altre latifoglie2.2.4.1.1.1. Pioppeti2.2.4.1.1.2. Saliceti2.2.4.1.1.3. Altre latifoglie (in nota specificare quali)2.2.4.1.2. Conifere a rapido accrescimento2.2.4.2. Castagneti da frutto2.2.4.3. Corileti da frutto (noccioli)2.2.4.4. Noceti da frutto2.3. Prati stabili (foraggere permanenti)2.3.1. Superfici a copertura erbacea densa a composizione floristica rappresentata principalmente da graminacee non soggette a rotazione2.3.1.1. Prato permanente asciutto2.3.1.2. Prato permanente irriguo2.4. Zone agricole eterogenee2.4.1. Colture temporanee associate a colture permanenti2.4.1.1. Colture temporanee associate a olivi2.4.1.2. Colture temporanee associate a viti2.4.1.3. Colture temporanee associate a olivi e viti2.4.1.4. Colture temporanee associate a frutteti misti2.4.2. Sistemi colturali e particellari complessi2.4.3. Aree prevalentemente occupate da colture agrarie con presenza <strong>di</strong> spazi naturali importanti2.4.4. Aree agroforestali3. SUPERFICI BOSCATE ED ALTRI AMBIENTI SEMINATURALI3.1. Aree boscate3.1.1. Boschi <strong>di</strong> latifoglie3.1.1.1. Bosco <strong>di</strong> leccio e sughera3.1.1.2. Bosco <strong>di</strong> querce caducifoglie3.1.1.3. Bosco <strong>di</strong> latifoglie mesofile3.1.1.4. Bosco <strong>di</strong> castagno3.1.1.5. Bosco <strong>di</strong> faggioSUPERFIC.174
LA DESCRIZIONE DEL SUOLOUSO/VEG.3.1.1.6. Bosco <strong>di</strong> specie igrofile3.1.1.7. Bosco <strong>di</strong> latifoglie non native3.1.2. Boschi <strong>di</strong> conifere3.1.2.1. Bosco <strong>di</strong> pini me<strong>di</strong>terranei3.1.2.2. Bosco <strong>di</strong> pini montani e orome<strong>di</strong>terranei3.1.2.3. Bosco <strong>di</strong> ab bianco e/o ab rosso3.1.2.4. Bosco <strong>di</strong> larice e/o pino cembro3.1.2.5. Bosco <strong>di</strong> conifere non native3.1.3. Boschi misti <strong>di</strong> conifere e latifoglie3.1.3.1. Boschi misti a prevalenza <strong>di</strong> latifoglie3.1.3.1.1. Boschi misti a prevalenza <strong>di</strong> leccio3.1.3.1.2. Boschi misti a prevalenza <strong>di</strong> querce caducifoglie3.1.3.1.3. Boschi misti a prevalenza <strong>di</strong> latifoglie mesofile3.1.3.1.4. Boschi misti a prevalenza <strong>di</strong> castagno3.1.3.1.5. Boschi misti a prevalenza <strong>di</strong> faggio3.1.3.1.6. Boschi misti a prevalenza <strong>di</strong> specie igrofile3.1.3.1.7. Boschi misti a prevalenza <strong>di</strong> latifoglie non native3.1.3.2. Boschi misti a prevalenza <strong>di</strong> conifere3.1.3.2.1. Boschi misti a prevalenza <strong>di</strong> pini me<strong>di</strong>terranei3.1.3.2.2. Boschi misti a prevalenza <strong>di</strong> pini montani e/o orome<strong>di</strong>terranei3.1.3.2.3. Boschi misti a prevalenza <strong>di</strong> ab bianco e/o ab rosso3.1.3.2.4. Boschi a prevalenza <strong>di</strong> larice e/o pino cembro3.1.3.2.5. Boschi a prevalenza <strong>di</strong> conifere non native3.2. Ambienti caratterizzati da copertura vegetale prevalentementearbustiva e/o erbacea in evoluzione naturale3.2.1. Aree a pascolo naturale e praterie <strong>di</strong> alta quota3.2.2. Cespuglieti e arbusteti3.2.3. Aree a vegetazione sclerofilla3.2.3.1. Macchia alta3.2.3.2. Macchia bassa e garighe3.2.4. Aree a vegetazione arborea e arbustiva in evoluzione (superfici che derivano da degradazione della foresta o darinnovazione della stessa per ricolonizzazione <strong>di</strong> aree non forestali)3.2.4.1. Aree a ricolonizzazione naturale3.2.4.2. Aree a ricolonizzazione artificiale (rimboschimenti nella fase <strong>di</strong> novelleto)3.3. Zone aperte con vegetazione rada o assente3.3.1. Spiagge, dune e sabbie175
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICI3.3.2. Rocce nude, falesie e affioramenti3.3.3. Aree con vegetazione rada (comprende le steppe xerofile, le steppe alofile e le aree calanchive con parziale copertura vegetale)3.3.4. Aree interessate da incen<strong>di</strong> o da altri eventi dannosi3.3.4.1. Boschi percorsi da incen<strong>di</strong>3.3.4.2. Altre aree della classe 3 percorse da incen<strong>di</strong>3.3.4.4. Aree degradate per altri eventi3.3.5. Ghiacciai e nevi perenni4. AMBIENTE UMIDO4.1. Zone umide interne4.1.1. Palu<strong>di</strong> interne4.1.2. Torbiere4.2. Zone umide marittime4.2.1. Palu<strong>di</strong> salmastre4.2.2. Saline4.2.3. Zone intertidali marineUSO/VEG.176
LA DESCRIZIONE DEL SUOLOTipo <strong>di</strong> vegetazione realeÉ possibile usare i co<strong>di</strong>ci con maggiore (es. B13) o minore (es. B00) approssimazioneUSO/VEG.Tabella 4.26. Classi <strong>di</strong> vegetazione reale.Co<strong>di</strong>ce DescrizioneA00 Formazione <strong>di</strong> latifoglie semprever<strong>di</strong>A01 LeccetaA02 Prevalenza <strong>di</strong> leccio con semprever<strong>di</strong>A03 Prevalenza <strong>di</strong> leccio con decidueA04 Prevalenza <strong>di</strong> sugheraA05 Prevalenza <strong>di</strong> semprever<strong>di</strong> secondarieA06 Formazione mista solo semprever<strong>di</strong>A07 Formazione mista con decidueA08 Piantagione <strong>di</strong> eucaliptoB00 Formazione <strong>di</strong> latifoglie a riposo invernaleB01 Prevalenza <strong>di</strong> roverellaB02 Prevalenza <strong>di</strong> cerroB03 Prevalenza <strong>di</strong> farniaB04 Prevalenza <strong>di</strong> rovereB05 Prevalenza <strong>di</strong> frainettoB06 Prevalenza <strong>di</strong> robiniaB07 Prevalenza <strong>di</strong> olmoB08 Prevalenza <strong>di</strong> pioppo tremuloB09 Prevalenza <strong>di</strong> castagnoB10 Prevalenza <strong>di</strong> carpino nero e frassinoB11 Prevalenza <strong>di</strong> carpino biancoB12 Prevalenza <strong>di</strong> faggioB13 FaggetaB14 Faggeto abetinaB15 Mista solo decidueB16 Formazione mista con latifoglie semprever<strong>di</strong>B17 Mista con conifereB18 Prevalenza <strong>di</strong> ontano napoletanoC00 Formazione <strong>di</strong> latifoglie igrofileC01 SalicetoC02 Saliceto a pioppiC03 Alneto (ontano nero e bianco)C04 Formazione a frassino angustifoliaD00 Formazione <strong>di</strong> aghifoglie termofileD01 Pineta <strong>di</strong> pino domesticoD02 Pineta <strong>di</strong> pino d’AleppoD03 Formazione dominata da pino marittimoD04 CipressetaD05 Formazione mista con latifoglie semprever<strong>di</strong>D06 Formazione mista con latifoglie decidueD07 Formazione a pino insigneE00 Formazione <strong>di</strong> aghifoglie meso e microtermicheE01 Bosco <strong>di</strong> pino silvestreE02 Formazione <strong>di</strong> pino nero d'AustriaE03 Pineta <strong>di</strong> pino laricio177
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICIE04E05E06E07E08E09F00F01F02F03F04G00G01G02G03G04G05G06H00H01H02H03H04H05I00I01I02I03I04I05I06I07I08I09Pineta <strong>di</strong> pino calabroAbetinaPiantagione <strong>di</strong> douglasiaPecceteLaricetoFormazione chiusa arbustiva (mugheto)Formazione arbustiva termoxerofilaMacchia me<strong>di</strong>terraneaSta<strong>di</strong>o più o meno aperto <strong>di</strong> bassi arbustiEricetoGinestreto (Genista, Ulex)Formazione arbustiva mesotermofilaCoriletoGinestreto a Cytisus scopariusCallunetoRovetoFelcetoMistoFormazione arbustiva microtermicaOntaneto (ontano verde)RodoretoVaccinietoMugo-ericetoFormazione <strong>di</strong> arbusti prostratiFormazione erbaceaFormazione erbacea infestante <strong>dei</strong> coltivi abbandonatiPrateria me<strong>di</strong>terraneaPrateria montanaFormazione erbacea pioniera su detritoFormazione erbacea pioniera su greto fluvialePrateria pioniera <strong>di</strong> altitu<strong>di</strong>neFormazione erbacea nitrofila e ruderaleErbe e suffrutici alofiti costieriErbe acquatiche e palustriSUPERFIC.Grado <strong>di</strong> copertura della vegetazioneIn<strong>di</strong>care il grado <strong>di</strong> copertura che esercita sul suolo la vegetazione naturale.Tabella 4.27. Grado <strong>di</strong> copertura della vegetazione.Co<strong>di</strong>ce Descrizione Copertura (%)1 Estremamente basso 75178
LA DESCRIZIONE DEL SUOLO4.3.4 Caratteri <strong>di</strong> superficieAspetti superficialiIn<strong>di</strong>care, secondo la tabella seguente, gli aspetti pedo biologici, antropogenici e <strong>di</strong> stato dellasuperficie del suolo.SUPERFIC.Tabella 4.28. Aspetti superficiali del suolo.PEDO BIOLOGICI ANTROPOGENICI STATO DEL SUOLOCo<strong>di</strong>ce Descrizione Co<strong>di</strong>ce Descrizione Co<strong>di</strong>ce DescrizioneAL Altro AL Altri AR Arato <strong>di</strong> recenteASCumuli da animaliscavatoriCACD Croste se<strong>di</strong>mentarie CMCS Croste strutturali LSCompattato daanimaliCompattato damacchineLivellato ospianatoCCLLNEColtura o inerbimento in attoAltre lavorazioniVegetazione spontanea susuolo agricoloES Efflorescenze saline SS Assolcato NN Nudo post raccolto o sfalcioGLGallerie interfacciaSpan<strong>di</strong>mento recente <strong>di</strong>OOsuolo-nevesostanza organicaRIRimescolamento damammiferiPP PacciamatoSM Self-mulchingTTCopertura <strong>di</strong> materialitecnologici <strong>di</strong> scartoTL Turricole da lombrichiUSComplessi organoso<strong>di</strong>ci<strong>di</strong>spersiFigura 4.7. Self mulching.Figura 4.8. Efflorescenze saline.179
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICICopertura <strong>di</strong> materiale organicoVariabile non co<strong>di</strong>ficata. In<strong>di</strong>care la percentuale <strong>di</strong> copertura <strong>di</strong> materiale organico nei suoli sottocopertura forestale. La superficie del suolo forestale può essere più o meno coperta da materialiorganici morti, quali lettiera, rami, tronchi. Questi proteggono il suolo dall'azione battente dellapioggia, regolano l'infiltrazione e il ruscellamento e limitano l'erosione del suolo. Il grado <strong>di</strong>copertura del suolo è richiesto da molti modelli <strong>di</strong> simulazione dell'erosione in ambito forestale ed èvariabile sia in funzione della copertura forestale che <strong>dei</strong> fattori stazionali (es. pendenza, processi inatto), ma soprattutto dalla gestione selvicolturale.RocciositàVariabile non co<strong>di</strong>ficata. In<strong>di</strong>care la percentuale <strong>di</strong> copertura degli affioramenti rocciosi (materialecon <strong>di</strong>ametro > 500 mm, non rimuovibile con le normali lavorazioni). Nella tabella seguentevengono in<strong>di</strong>cate le classi <strong>di</strong> riferimento riportate in bibliografia (Costantini, 2006).Tabella 4.29. Classi <strong>di</strong> rocciosità percentuale.Descrizione Classe (%)Assente 0Scarsamente roccioso 0,1-2,0Roccioso 2,1-10,0Molto roccioso 10,1-25,0Estremamente roccioso 25,1-90,0Roccia affiorante >90Pietrosità superficialeVariabile non co<strong>di</strong>ficata. Deve essere in<strong>di</strong>cata la percentuale <strong>di</strong> pietre o altri materiali, <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni>2 mm presenti sulla superficie del suolo e non ricadenti nella casistica compresa nella rocciosità.La percentuale <strong>di</strong> copertura deve essere espressa per ciascuna delle seguenti classi <strong>di</strong>mensionali(Soil Survey Staff, 1993).SUPERFIC.Tabella 4.30. Classi <strong>di</strong>mensionali <strong>di</strong> pietre o altri materiali.DescrizioneClasse (cm)Pietrosità piccola (ghiaia) 90,0180
LA DESCRIZIONE DEL SUOLOLa tabella successiva può servire come aiuto nella stima della pietrosità superficiale, secondo leclassi <strong>di</strong>mensionali <strong>di</strong> appartenenza. I valori <strong>di</strong> <strong>di</strong>stanza sono intesi come <strong>di</strong>stanza me<strong>di</strong>a in metri trai bor<strong>di</strong> <strong>di</strong> un elemento ed i 5 elementi più vicini della stessa <strong>di</strong>mensione (Carnicelli et al. , 2001).SUPERFIC.Tabella 4.32 Stima della pietrosità superficiale, secondo le classi <strong>di</strong>mensionali <strong>di</strong> appartenenza.Frequenza (%)Distanza (m) tra elementi grossolani <strong>di</strong> <strong>di</strong>ametro (cm):1.2 1 7.5 14 2 25 400,01 1 7 13 23 360,1 0,35 2,2 4 7 110,3 0,2 1,3 2,3 4,2 6,51 0,11 0,7 1,3 2,3 3,52 0,08 0,5 0,9 1,6 2,53 0,06 0,4 0,7 1,3 25 0,05 0,3 0,5 1 1,515 0,03 0,16 0,3 0,5 0,825 0,02 0,12 0,2 0,4 0,640 0,013 0,08 0,15 0,25 0,450 0,01 0,06 0,12 0,21 0,3370 0,006 0,035 0,06 0,12 0,1980 0,003 0,02 0,04 0,07 0,1185 0,001 0,01 0,017 0,03 0,051 Ø me<strong>di</strong>o geometrico; classe 0.2-7.5 cm. 2 Ø me<strong>di</strong>o geometrico; classe 7.5-25 cm.Nella tabella non sono elaborati valori percentuali superiori ad 85 perché per occupare uno spaziomaggiore i frammenti grossolani devono presentarsi accatastati (spazio a tre <strong>di</strong>mensioni e non più adue, come nel modello utilizzato per il calcolo percentuale tramite <strong>di</strong>stanze), oppure in miscele conmolte <strong>di</strong>mensioni.Fessure superficialiVariabile non co<strong>di</strong>ficata. In<strong>di</strong>care per un’area <strong>di</strong> circa 100 m 2 il numero, la lunghezza, la larghezzae la profon<strong>di</strong>tà (valori più frequenti <strong>di</strong> circa 10 misurazioni) in cm delle fessure presenti insuperficie; se le fessure sono assenti immettere 0 (zero) al numero <strong>di</strong> fessure.181Figura 4.9. Rappresentazione tri<strong>di</strong>mensionale del suolo con fessure nella parte <strong>di</strong> crosta superficiale.
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICI4.4 Descrizione del profiloNel profilo pedologico è normalmente possibile riconoscere una serie <strong>di</strong> strati con andamentoparallelo alla superficie: essi prendono nome <strong>di</strong> orizzonti che si <strong>di</strong>stinguono per caratteristichepeculiari <strong>di</strong>pendenti dai processi pedogenetici. Vengono pertanto detti anche orizzonti genetici e laloro designazione è basata su un giu<strong>di</strong>zio qualitativo dell’origine del suolo. Descrivere il profilopedologico consiste essenzialmente nel descrivere i suoi orizzonti.In questo paragrafo viene in<strong>di</strong>cata la co<strong>di</strong>ficazione da utilizzarsi per definire gli strati <strong>di</strong> suolo egli orizzonti genetici che compongono il profilo pedologico. Gli orizzonti genetici non sonoequivalenti agli orizzonti <strong>di</strong>agnostici, utilizzati nelle classificazioni. Gli orizzonti genetici, infatti,esprimono un giu<strong>di</strong>zio qualitativo circa il tipo <strong>di</strong> processi che si suppone abbiano avuto corso nelsuolo. Gli orizzonti <strong>di</strong>agnostici, al contrario, hanno lineamenti quantitativamente definiti.Per l’in<strong>di</strong>cazione degli orizzonti minerali e organici in questo testo viene fatto riferimento alledefinizioni definite dall’ USDA, Soil Conservation Service (Soil Survey Staff, 2006). Percompletezza vengono fornite alcune in<strong>di</strong>cazioni che si riferiscono alle definizioni e co<strong>di</strong>ficazioniutilizzate dalla FAO (FAO, 2006). Per approfon<strong>di</strong>menti si rimanda alla bibliografia citata.Le lettere maiuscole O, L, A, E, B, C, R, M e W rappresentano i principali orizzonti e strati <strong>dei</strong>suoli. Queste lettere sono i simboli base ai quali altri caratteri sono aggiunti per completare ladesignazione. La maggior parte degli orizzonti e degli strati viene definito con unico simbolo <strong>di</strong>lettera maiuscola, ma qualcuno ne richiede due. Nella classificazione americana sono in<strong>di</strong>cati noveprincipali orizzonti del suolo.Orizzonti o strati O: strati dominati da materiale organico. Alcuni possono essere saturati da acquaper lunghi perio<strong>di</strong>, oppure lo erano ma ora sono artificialmente drenati, altri non sono mai statisaturati.Orizzonti o strati L: l’orizzonte o strato limnico include materiali limnici organici o minerali chepossono essere sia stati deposti in acqua per precipitazione che attraverso l’azione <strong>di</strong> organismiacquatici, quali alghe o <strong>di</strong>atomee. Oppure possono derivare da piante subacquee o galleggiantisull’acqua e successivamente mo<strong>di</strong>ficati da animali acquatici.ORIZZONTIOrizzonti A: orizzonti minerali che si sono formati alla superficie o sotto un orizzonte O, nei qualil’originale struttura della roccia è stata completamente o quasi completamente obliterata, e che sonocaratterizzati da una o più delle seguenti con<strong>di</strong>zioni:1. un accumulo <strong>di</strong> sostanza organica umificata intimamente legata alla frazione minerale senzamostrare le proprietà caratteristiche <strong>di</strong> orizzonti E o B (ve<strong>di</strong> sotto), oppure2. proprietà risultanti dalla coltivazione, pascolamento, o <strong>di</strong>sturbi affini.Orizzonti E: orizzonti minerali nei quali la caratteristica principale è la per<strong>di</strong>ta d’argilla silicata,ferro, alluminio, o <strong>di</strong> alcune combinazioni <strong>di</strong> questi, con una concentrazione residuale <strong>di</strong> sabbia elimo. In questi orizzonti l’originale struttura della roccia è stata completamente o quasicompletamente obliterata.Orizzonti B: orizzonti che si sono formati sotto un orizzonte A, E, O. In questi orizzonti principalil’originale struttura della roccia è stata completamente o quasi completamente obliterata, emostrano un o più delle seguenti con<strong>di</strong>zioni:1. concentrazione illuviale <strong>di</strong> argilla silicatica, ferro, alluminio, humus, carbonati, gesso osilice, soli o in combinazione ;182
LA DESCRIZIONE DEL SUOLO2. evidenza <strong>di</strong> rimozione o accumulo <strong>di</strong> carbonati;3. concentrazione residuale <strong>di</strong> sesquiossi<strong>di</strong>;4. rivestimenti <strong>di</strong> sesquiossi<strong>di</strong> tali da far sì che l’orizzonte sia notevolmente più basso in value,più alto in chroma, o più rosso in hue degli orizzonti soprastanti e sottostanti, senzaapparente illuviazione <strong>di</strong> ferro;5. alterazione tale da produrre argilla silicatica o liberare ossi<strong>di</strong>, oppure entrambi, e da creareuna struttura granulare, o poliedrica, o prismatica se a cambiamenti in contenuto idrico siaccompagnano cambiamenti <strong>di</strong> volume;3. fragilità (consistenza tipica degli orizzonti fragici, o fragipan);4. forte gleyficazione.Orizzonti o strati C: orizzonti o strati, ad esclusione <strong>di</strong> quelli fortemente cementati e della rocciadura, che sono debolmente interessati da processi pedogenetici e mancano delle proprietà degliorizzonti O, A, E, o B. La maggior parte sono strati minerali. Il materiale costituente gli orizzonti Cpuò essere sia simile che <strong>di</strong>ssimile da quello dal quale il solum si è presumibilmente formato. Unorizzonte C può essere stato mo<strong>di</strong>ficato anche se non c'è evidenza <strong>di</strong> pedogenesi. Da intendersicome strati C sono se<strong>di</strong>menti, saprolite, la roccia non consolidata e altri materiali geologici non opoco cementati. La <strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong> escavazione <strong>di</strong> questi materiali è bassa o moderata. Alcuni suoli siformano in materiale già molto alterato e questo materiale, che non sod<strong>di</strong>sfa i requisiti degliorizzonti A, E o B, è designato come C. I cambiamenti non considerati come pedogenetici sonoquelli non correlati agli orizzonti soprastanti. Alcuni strati che hanno accumuli <strong>di</strong> silice, carbonati,gesso, o sali più solubili, anche induriti, possono essere inclusi tra gli orizzonti C. Se uno stratocementato si è formato invece attraverso un processo pedogenetico è considerato un orizzonte B.ORIZZONTIStrati R: roccia dura sottostante il suolo. Granito, basalto, quarzite e calcare o arenaria induriti sonoesempi <strong>di</strong> roccia che viene designata R. La roccia può avere delle fessure, ma queste sono così radee così piccole che poche ra<strong>di</strong>ci possano infiltrarsi. Le fessure possono essere rivestite o riempited’argilla o da altro materiale.Strati M: strati profon<strong>di</strong> quasi continui, <strong>di</strong>sposti orizzontalmente e limitanti lo sviluppo ra<strong>di</strong>calecostituiti da manufattiStrati W: acqua. Questo simbolo in<strong>di</strong>ca uno strato <strong>di</strong> acqua entro o al <strong>di</strong> sotto del suolo. L’acqua èdesignata come Wf se è permanentemente congelata e W in caso contrario. W o Wf non sono usatiper sottili strati <strong>di</strong> acqua, ghiaccio o neve sopra la superficie del suolo.L’orizzonte può essere <strong>di</strong> transizione (ad esempio AB, BC) o può esservi la compresenza <strong>di</strong> piùorizzonti (ad esempio A/B, E/B ).Gli orizzonti <strong>di</strong> transizione sono orizzonti dominati da proprietà <strong>di</strong> un orizzonte principale ma chehanno in subor<strong>di</strong>ne proprietà <strong>di</strong> un altro orizzonte principale. In questo caso vanno utilizzate duelettere maiuscole, la prima si riferisce all’orizzonte che domina la transizione. Un orizzonte AB, adesempio, presenta sia le caratteristiche <strong>di</strong> un soprastante orizzonte A, che <strong>di</strong> un sottostante orizzonteB, ma è più simile ad un orizzonte A. Si possono in<strong>di</strong>care anche transizioni verso un orizzonteprincipale che nel suolo in oggetto in effetti non è presente. Ad esempio un orizzonte BE può esserericonosciuto in un suolo troncato ove l’erosione ha rimosso l’orizzonte E.Gli orizzonti compresenti sono orizzonti ove vi è la compresenza <strong>di</strong> due parti <strong>di</strong>stinte conproprietà riconoscibili <strong>di</strong> due orizzonti principali. Il primo simbolo in<strong>di</strong>ca l’orizzonte dominantecome volume <strong>di</strong> suolo, ad esempio B/C o B/E. Non sempre è possibile o utile descrivere ognisingolo strato. Ad esempio gli Argic U<strong>di</strong>psamments hanno lamelle che sono separate le une dallealtre da strati eluviali e non sarebbe pratico descrivere separatamente ogni strato e lamella.183
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICILa FAO (FAO, 2006), propone alcune <strong>di</strong>fferenze nella designazione degli orizzonti principali, cherisultano essere i seguenti: H, O, L, A, E, B, C, R, I e W.Per l’esatta verifica delle <strong>di</strong>fferenze si rimanda ai testi originali (FAO, 2006).Le lettere minuscole sono utilizzate come suffissi per designare specifici tipi <strong>di</strong> orizzonti o stratiprincipali. Nella tabella che segue vi è l’elenco <strong>dei</strong> simboli ed una definizione sintetica. È possibileconfrontare la simbologia prevista dalla classificazione americana e quella utilizzata dalla FAO.Prevale la corrispondenza, ma vi sono alcune <strong>di</strong>fferenze. Il simbolo in<strong>di</strong>ca l’utilizzazione delsuffisso nei due manuali citati.In ambiente forestale può essere utile dare in<strong>di</strong>cazioni più specifiche sull’episolum umifero,“insieme degli orizzonti superiori <strong>di</strong> un suolo contenenti sostanza organica, la cui organizzazione<strong>di</strong>pende essenzialmente dall’attività biologica” (AFES, 1995), dando in<strong>di</strong>cazioni in nota circa lecaratteristiche degli orizzonti <strong>di</strong>agnostici necessarie ai fini della classificazione delle forme <strong>di</strong>humus. Tale classificazione si riferisce agli orizzonti olorganici (dal greco holos = tutto) ed agliorizzonti organo-minerali, caratterizzati da una mescolanza più o meno intima tra materialeorganico e materiale minerale. La classificazione francese, Référentiel Pédologique (AFES, 1995),<strong>di</strong> tipo essenzialmente morfogenetico, si adatta abbastanza bene ad alcuni ambienti forestali Italiani.Pur esistendo alcune positive applicazioni, queste sono state compiute solo in alcune realtà regionalie quin<strong>di</strong> al momento attuale non è stata prevista la descrizione <strong>dei</strong> profili <strong>di</strong> humus nel presentemanuale.4.4.1 Profon<strong>di</strong>tà, spessore e limite inferiorePer la misura della profon<strong>di</strong>tà, il valore 0 (zero) da utilizzare varia secondo le caratteristiche dellasuperficie del suolo; la superficie del suolo va intesa come limite superiore del primo strato che puòpermettere la crescita <strong>di</strong> piante e ra<strong>di</strong>ci, secondo la seguente casistica (Shoeneberger et al. , 2002):a) suolo minerale nudo, con copertura <strong>di</strong> elementi grossolani inferiore all’80%, l’interfacciaatmosfera-terra fine;b) quando la superficie coperta da elementi grossolani supera l’80% e non sono presenti orizzontiorganici, il livello me<strong>di</strong>o <strong>di</strong> campagna della parte superiore <strong>dei</strong> frammenti;c) quando la superficie coperta da elementi grossolani supera l’80% e sono presenti orizzontiorganici, il limite superiore del primo strato che permette lo sviluppo <strong>di</strong> apparati ra<strong>di</strong>cali, conl’esclusione della lettiera fresca, ma l’inclusione della lettiera compattata e con evidenze <strong>di</strong>alterazione; ad esempio: orizzonte Oe. L’orizzonte Oi ha quin<strong>di</strong> il suo limite inferiore alla quota0 (zero);d) suolo minerale coperto da vegetazione: il limite superiore del primo strato che permette losviluppo <strong>di</strong> apparati ra<strong>di</strong>cali, con l’esclusione della lettiera fresca, ma l’inclusione della lettieracompattata e con evidenze <strong>di</strong> alterazione; ad esempio: orizzonte Oe;e) suoli sommersi: come a), ma si riferisce al contatto suolo-acqua e si estende dalla riva al limite<strong>di</strong> esistenza <strong>di</strong> piante ra<strong>di</strong>cate emergenti.ORIZZ. LIMITEProfon<strong>di</strong>tà del limite inferiore dell'orizzonteVariabile non co<strong>di</strong>ficata. Deve essere in<strong>di</strong>cato, in cm, il limite inferiore, me<strong>di</strong>o dell’orizzonte essendoi limiti minimo e massimo facoltativi. Per gli orizzonti/strati posti al <strong>di</strong> sopra della superficie delsuolo, il limite inferiore si in<strong>di</strong>ca con valore 0 (zero) in tutti i campi, mentre va in<strong>di</strong>cato lo spessore.In caso <strong>di</strong> limite inferiore non visibile (limite inferiore sconosciuto), cioè al <strong>di</strong> sotto della profon<strong>di</strong>tà<strong>di</strong> scavo, in<strong>di</strong>care la misura minima e me<strong>di</strong>a (coincidenti) della profon<strong>di</strong>tà della parte visibile elasciare valori nulli nel campo MASSIMA.184
LA DESCRIZIONE DEL SUOLOORIZZ. LIMITE185Tabella 4.33. Suffissi, secondo Soil Taxonomy (Soil Survey Staff, 2006) e FAO (FAO, 2006).Suffisso ST, 2006 Definizione sintetica FAO, 2006 Definizione sinteticaa Materiale organico fortemente decomposto Materiale organico fortemente decompostob Orizzonte genetico sepolto Orizzonte genetico sepoltoc Concrezioni o noduli Concrezioni o noduli (orizzonti minerali)c Materiali coprogeni (solo con L)co Materiali coprogeni (solo con L)d Limitazione fisica all’approfon<strong>di</strong>mento delle ra<strong>di</strong>ci Strato denso (limitazione fisica all’approfon<strong>di</strong>mento delle ra<strong>di</strong>ci inorizzonte minerale, non cementato)d Terra <strong>di</strong> <strong>di</strong>atomee (solo con L)<strong>di</strong> Terra <strong>di</strong> <strong>di</strong>atomee (solo con L)e Materiale organico moderatamente decomposto Materiale organico moderatamente decompostof Suoli permanentemente congelati (escluso permanfrost secco) Suoli permanentemente congelati.ff Permafrost secco.g Forte gleyificazione Con<strong>di</strong>zioni stagnicheh Accumulo illuviale <strong>di</strong> materiale organico Accumulo <strong>di</strong> materiale organico in orizzonte mineralei Materiale organico debolmente decomposto Presenza <strong>di</strong> “slickensides” (orizzonti minerali)i Materiale organico debolmente decomposto (orizzonti H e O)j Accumulo <strong>di</strong> jarosite Accumulo <strong>di</strong> jarositejj Evidenze <strong>di</strong> crioturbazionek Accumulo <strong>di</strong> carbonati secondari Accumulo <strong>di</strong> carbonati secondarim Forte cementazione, indurimento Forte cementazione, indurimentom Strato limnico <strong>di</strong> marna (solo con L)ma Strato liminico <strong>di</strong> marna (solo con L)n Accumulo pedogenetico <strong>di</strong> so<strong>di</strong>o scambiabile Accumulo pedogenetico <strong>di</strong> so<strong>di</strong>o scambiabileo Accumulo residuale <strong>di</strong> sesquiossi<strong>di</strong> Accumulo residuale <strong>di</strong> sesquiossi<strong>di</strong>p Strato arato o con altri <strong>di</strong>sturbi <strong>di</strong> origine antropica Strato arato o con altri <strong>di</strong>sturbi <strong>di</strong> origine antropicaq Accumulo <strong>di</strong> silice pedogenetica Accumulo <strong>di</strong> silice pedogeneticar Roccia alterata o soffice Forte riduziones Accumulo illuviale <strong>di</strong> sesquiossi<strong>di</strong> e sostanza organica Accumulo illuviale <strong>di</strong> sesquiossi<strong>di</strong>ss Presenza <strong>di</strong> “slickensides”t Accumulo <strong>di</strong> argilla silicatica per illuviazione Accumulo <strong>di</strong> argilla silicatau Presenza <strong>di</strong> manufatti umani Presenza <strong>di</strong> manufatti umaniv Presenza <strong>di</strong> plinthite Presenza <strong>di</strong> plinthitew Sviluppo <strong>di</strong> aggregazione e evidenze <strong>di</strong> colorazione (all’interno <strong>di</strong> B) Sviluppo <strong>di</strong> aggregazione e evidenze <strong>di</strong> colorazione (all’interno <strong>di</strong> B)x Caratteri <strong>di</strong> fragipan Caratteri <strong>di</strong> fragipany Accumulo pedogenetico <strong>di</strong> gesso Accumulo pedogenetico <strong>di</strong> gessoz Accumulo pedogenetico <strong>di</strong> sali più solubili del gesso Accumulo pedogenetico <strong>di</strong> sali più solubili del gesso@ Evidenze <strong>di</strong> crioturbazione
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICISpessoreVariabile non co<strong>di</strong>ficata. Si riporti lo spessore minimo, me<strong>di</strong>o e massimo dell’orizzonte (in cm). Inquesto caso l’orizzonte Oi è al <strong>di</strong> sopra della profon<strong>di</strong>tà 0. Il limite inferiore dell’orizzonte C èsconosciuto.Tabella 4.34 Esempio <strong>di</strong> annotazione <strong>di</strong> profon<strong>di</strong>tà e spessore degli orizzonti.OrizzontiProfon<strong>di</strong>tà limite inferiore(cm)Spessore (cm)minimo me<strong>di</strong>o massimo minimo me<strong>di</strong>o massimoOi 0 0 0 3 3 3Ap 40 40 40 40 40 40Btx 60 65 80 20 25 40BC 100 115 120 40 50 60C 130 10TipoIn<strong>di</strong>care le caratteristiche del tipo <strong>di</strong> limite tra un orizzonte ed il sottostante.AndamentoTabella 4.35. Co<strong>di</strong>fica tipo <strong>di</strong> limite dell’orizzonte.Co<strong>di</strong>ce Descrizione1 Abrupto Se il passaggio avviene entro 2 cm2 Chiaro Se il passaggio avviene tra 2 - 5 cm3 Graduale Se il passaggio avviene tra 5 - 15 cm4 Diffuso Se il passaggio avviene tra oltre 15 cm5 Sconosciuto Non raggiuntoIn<strong>di</strong>ca le caratteristiche dell’andamento del limite dell’orizzonteTabella 4.36. Co<strong>di</strong>fica dell’andamento del limite dell’orizzonte.Co<strong>di</strong>ce Descrizione1 Lineare Senza ondulazioni.2 Ondulato Ondulazioni più larghe che profonde.3 Irregolare Ondulazioni più profonde che larghe.4 Discontinuo Con interruzioni.5 A glosse Con penetrazioni a forma <strong>di</strong> lingua; tipicamente <strong>di</strong> un orizzonte eluviale inun orizzonte illuviale sottostante.ORIZZ. LIMITE186
LA DESCRIZIONE DEL SUOLOFigura 4.10. Rappresentazione dell’andamento del limite <strong>di</strong> un orizzonte (Shoeneberger et al. , 2002, mo<strong>di</strong>ficato).4.4.2 Orizzonti eterogeneiORIZZ. LIMITESe siamo in presenza <strong>di</strong> orizzonti eterogenei e si ritiene importante separarne la descrizione, sidescrivano i due orizzonti in sequenza con le stesse profon<strong>di</strong>tà. Si potrà aggiungere in nota la naturae le caratteristiche del loro rapporto. Es. Ap2/Bk (40-80 cm) si descrive l’Ap2 da 40 a 80 cm con lesue caratteristiche e il Bk da 40 a 80 cm con le sue caratteristiche. In nota si potrà riportare lapercentuale dell’uno e dell’altro e tutte le altre specifiche ritenute importanti.Tabella 4.37. Esempio <strong>di</strong> designazione, definizione <strong>di</strong> profon<strong>di</strong>tà e descrizione <strong>di</strong> orizzonti eterogenei.EsempioProfon<strong>di</strong>tà limiteDesignazioneDescrizione <strong>dei</strong> caratteriinferiore (cm)orizzontedell’orizzonteminimo me<strong>di</strong>o massimoAp Ap 40 40 40 Descrizione dell’ApAp2/Bk Ap2/Bk (Ap2/) 80 80 80 Descrizione dell’Ap2Ap2/Bk (/Bk) 80 80 80 Descrizione del Bk187
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICI4.4.3 Umi<strong>di</strong>tàIn<strong>di</strong>care la classe <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> umi<strong>di</strong>tà dell’orizzonte al momento della descrizione.Tabella 4.38. Co<strong>di</strong>fica contenuto <strong>di</strong> umi<strong>di</strong>tà.Co<strong>di</strong>ce DefinizioneDescrizione1 Secco Contenuto idrico inferiore o uguale al punto <strong>di</strong> appassimento2 UmidoContenuto idrico tra il punto <strong>di</strong> appassimento e la capacità <strong>di</strong>campo3Molto umidoContenuto idrico prossimo alla capacità <strong>di</strong> campo(senza acqua libera)4Bagnato (con acqua Contenuto idrico superiore alla capacità <strong>di</strong> campo, presenza <strong>di</strong>libera)acqua libera4.4.4 Colore della massaDeterminare il colore principale, il tipo <strong>di</strong> determinazione e la localizzazione degli orizzonti o strati<strong>di</strong> suoli riconosciuti.ColoreDeve essere determinato sempre il colore allo stato umido e quando possibile o quando richiestodalla classificazione (es. orizzonte mollico) anche allo stato secco. Il riferimento sono le tavolecolorimetriche Munsell (Munsell Soil Color Charts) (Munsell, 2000). Il colore allo stato umido sivuole riferire ad un contenuto <strong>di</strong> umi<strong>di</strong>tà pari alla con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> capacità <strong>di</strong> campo. Per ottenere talestato si deve inumi<strong>di</strong>re il campione e effettuare la lettura non appena sono scomparse le pellicolevisibili <strong>di</strong> umi<strong>di</strong>tà.La determinazione del colore non dovrebbe essere fatta esponendo il campione <strong>di</strong>rettamenteall’esposizione della luce solare. Se possibile andrebbero inoltre evitati momenti <strong>di</strong> luce naturaleparticolari quali l’alba ed il tramonto.Ciascun colore è contrad<strong>di</strong>stinto da una sigla (es. 7,5YR 5/8) che descrive quantitativamente treproprietà: hue, colore dominante o tinta (7,5YR); value, luminosità (5/) e chroma, tono del colore (/8).Per hue si intende il colore dominante dello spettro, ed è in relazione con la lunghezza d’ondadominante della luce (rosso, giallo, verde, blu o violetto). Il value si riferisce alla luminosità relativadel colore e varia da 1 (scuro) a 8 (chiaro). Il chroma è dato dalla purezza o “potenza “ del colore evaria da 1 a 8 con il <strong>di</strong>minuire del grigio.Modalità <strong>di</strong> determinazione e localizzazioneScegliere la modalità <strong>di</strong> descrizione più opportuna secondo le caratteristiche del suolo e le finalitàdel <strong>rilevamento</strong>.SCREZIATURE188
LA DESCRIZIONE DEL SUOLOTabella 4.39. Co<strong>di</strong>ci relativi alla modalità e alla localizzazione del colore della massa.Co<strong>di</strong>ce Modalità e localizzazione NoteMS Superfici <strong>di</strong> piccoli aggregatiGli aggregati <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni me<strong>di</strong>e o gran<strong>di</strong> devono esseresempre rotti per il/i colore/i <strong>di</strong> massa internoMB Faccia <strong>di</strong> rottura (broken)Colore della superficie non naturale, ottenuta con larottura dell'aggregato o massa non aggregataMF Frantumato Con campioni mineraliMLMRMPFrantumato e lisciato (rubbed,crushed & smoothed), solo umidoFrantumato e lisciato (rubbed)Pressato, da umido a bagnatoCon materiali minerali, umi<strong>di</strong> od inumi<strong>di</strong>tiappositamente, e colori troppo variegati. Serve perin<strong>di</strong>viduare un colore me<strong>di</strong>o dominanteCon materiali organici4.4.5 Figure redox e litocromieLe figure redox (idromorfia) sono quelle screziature <strong>di</strong> colore del suolo che sono causate dai fenomeni<strong>di</strong> ossidazione e riduzione del ferro, manganese ed altri elementi a seguito delle variazioni <strong>di</strong>umi<strong>di</strong>tà nel profilo. Le litocromie invece sono macchie <strong>di</strong> colore che non derivano da tali processi,ma dal colore del materiale genitore.Le figure redoximorfiche sono <strong>di</strong>stinte in principali e secondarie; se sono presenti altre ancora,queste vanno specificate in nota.SCREZIATUREFigura 4.11. Evidenze <strong>di</strong> fenomeni riduttivi e <strong>di</strong> ossidazione. Parti decolorate econcentrazioni <strong>di</strong> ferro-manganese.189
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICIColoreVariabile non co<strong>di</strong>ficata. In<strong>di</strong>care il colore utilizzando le tavole Munsell (Munsell, 2000), in<strong>di</strong>candohue, value e chroma.AbbondanzaVariabile non co<strong>di</strong>ficata. In<strong>di</strong>care il valore percentuale rilevato; se assenti immettere 0 (zero); siriporta per confronto le seguenti classi <strong>di</strong> abbondanza.Tipo e localizzazioneTabella 4.40. Descrizione dell’abbondanza dellefigure <strong>di</strong> ossido-riduzione e delle screziature.Descrizione Classe (%)Assenti 0Molto scarse 0-2Scarse 2-5Comuni 5-15Molte 15-30Abbondanti 30-50Dominanti >50Tabella 4.41. Co<strong>di</strong>ci del tipo e della localizzazione delle figure <strong>di</strong> ossido-riduzione e delle screziature.Co<strong>di</strong>ce DescrizioneOMR Masse in con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> riduzione, o impoverite, in assenza <strong>di</strong> aree <strong>di</strong> arricchimento <strong>di</strong> Fe +++o Mn visibiliOMI Masse impoverite <strong>di</strong> ferro, in presenza <strong>di</strong> aree <strong>di</strong> arricchimento <strong>di</strong> Fe +++ o Mn visibiliOMF Masse arricchite <strong>di</strong> Fe +++(*)OCI Masse intorno a pori o strutture organiche, con impoverimento <strong>di</strong> ferroOCF Masse intorno a pori o strutture organiche, con arricchimento <strong>di</strong> Fe +++OFI Facce <strong>di</strong> aggregati, con impoverimento <strong>di</strong> ferroOFF Facce <strong>di</strong> aggregati, con arricchimento <strong>di</strong> Fe +++LIT Screziature dovute a litocromia(*) si intendono materiali <strong>di</strong> suolo in cui la percentuale prevalente sia comunque costituita dalla massa originaria.DimensioniVariabile non co<strong>di</strong>ficata. In<strong>di</strong>care il valore me<strong>di</strong>o in mm delle screziature; si riportano le seguenticlassi <strong>di</strong>mensionali.Tabella 4.42. Descrizione delle <strong>di</strong>mensioni dellefigure <strong>di</strong> ossido-riduzione e delle screziature.Descrizione Classe (mm)Piccole < 5Me<strong>di</strong>e 5 -15Grossolane > 15SCREZIATURE190
LA DESCRIZIONE DEL SUOLOEvidenzaVariabile co<strong>di</strong>ficata.Tabella 4.43. Co<strong>di</strong>ci dell’evidenza delle figure <strong>di</strong> ossido-riduzione e delle screziature.Co<strong>di</strong>ce Descrizione1 Debole Screziature con stesso hue della matrice che <strong>di</strong>fferiscono per 1 chroma o 2 value2 DistintaScreziature con stesso hue della matrice che <strong>di</strong>fferiscono per 2-4 chroma o 3-4value o che hanno hue <strong>di</strong> una pagina vicina (2.5 unità) e non più <strong>di</strong> 1 chroma e 2<strong>di</strong> value3Screziature con hue <strong>di</strong> due pagine vicine (5 unità) e stesso chroma e value, oMarcataalmeno 1 chroma e 2 value se hue <strong>di</strong>fferisce <strong>di</strong> una pagina (2.5 unità)4.4.6 TessituraIn questo manuale vengono utilizzate la classe tessiturale (textural class) e la classe granulometrica(particle-size class) così come definite nella tassonomia americana (Soil Survey Staff, 2006), cui sirimanda per approfon<strong>di</strong>menti, mentre <strong>di</strong> seguito ne sono in<strong>di</strong>cate solo le informazioni principali. Laclasse tessiturale si basa sulla percentuale in peso della frazione minore <strong>di</strong> 2,0 mm <strong>di</strong> <strong>di</strong>ametro. Lagranulometria si riferisce all’intero suolo includendo “terra fine” e scheletro (frammentigrossolani), fino alla <strong>di</strong>mensione del pedon, ma esclude sostanza organica e sali più solubili delgesso. Classi sostitutive sono utilizzate per suoli che hanno proprietà an<strong>di</strong>che od un alto contenutoin vetri vulcanici, pomici e ceneri.Stima in campoVariabile non co<strong>di</strong>ficata. Si richiede <strong>di</strong> stimare in campo i valori percentuali delle frazionigranulometriche (argilla, sabbia totale, sabbia molto fine e scheletro < 75 mm). Per la terra fine (∅< 2mm), vengono utilizzati le misure delle particelle in accordo con il triangolo USDA:Tabella 4.44. Dimensioni e denominazionidelle particelle <strong>di</strong> terra fine secondo iltriangolo USDA.ParticellaClasse (mm)Argilla
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICILA DESCRIZIONE DEL SUOLOOperativamente, si procede nel modo seguente: un campione <strong>di</strong> terra <strong>di</strong> circa un cucchiaio involume va bagnato fin quasi al limite <strong>di</strong> liqui<strong>di</strong>tà e, lavorandolo tra pollice, in<strong>di</strong>ce e me<strong>di</strong>o, eaiutandosi con un coltello, si cerca <strong>di</strong> farlo <strong>di</strong>ventare una pasta omogenea. Dopo aver eliminato ipezzetti <strong>di</strong> scheletro si cerca <strong>di</strong> stabilire anzitutto la sensazione prevalente. La sabbia si sentesoprattutto quando il campione è molto bagnato e provoca la sensazione <strong>di</strong> grattare, se grossa, o <strong>di</strong>smerigliare, se fine; se in quantità limitata può essere meglio apprezzata passando l'in<strong>di</strong>ce con unpo' <strong>di</strong> pasta liquefatta sulla parte larga del coltello. Il limo conferisce la sensazione <strong>di</strong> saponosità e<strong>di</strong> scivolosità al campione; è molto plastico, ma non adesivo, ed asciugandosi è simile al talco, nonaderisce alle <strong>di</strong>ta e si stacca facilmente. L'argilla si sente quando il campione comincia ad asciugare,è fortemente adesiva, oltre che plastica, si attacca alle <strong>di</strong>ta e, quando si asciuga, si stacca<strong>di</strong>fficilmente. Usando la trivella in un suolo umido, la tessitura argillosa è riconoscibile dallabrillantezza delle superfici delle carote prelevate. Quin<strong>di</strong> si può procedere alla stima dellepercentuali <strong>di</strong> sabbia, limo e argilla. Poiché il contenuto in limo è in alcuni casi mascherato dallapresenza <strong>di</strong> molta sostanza organica, o <strong>di</strong> carbonati, è meglio stimare anzitutto la sabbia e l'argilla, ericavare il limo per <strong>di</strong>fferenza.La stima della tessitura può essere resa più agevole facendo riferimento alle classi tessiturali,con le quali è possibile restringere il campo <strong>di</strong> variazione <strong>dei</strong> valori percentuali.Classi USDA:1: argilloso2: argilloso limoso3: franco argilloso limoso4: argilloso sabbioso100 05: franco argilloso sabbioso6: franco argilloso90 107: limoso80208: franco limoso70309: franco110: sabbioso argilla% 604011: sabbioso franco 50502limo%12: franco sabbioso40 460306 3570209808101290111070100100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0sabbia%Figura 4.13. Triangolo delle tessiture con le 12 principali classi tessiturali.TESSITURAClasse tessituraleLe classi tessiturali usate nella tassonomia americana sono elencate nella tabella seguente, ove leclassi franco sabbiosa, sabbioso franca e sabbiosa sono ulteriormente sud<strong>di</strong>vise in ragione delleclassi <strong>di</strong>mensionali delle sabbie.192
LA DESCRIZIONE DEL SUOLOTESSITURA193Tabella 4.45. classi tessiturali.Co<strong>di</strong>ce Classe DescrizioneA Argilla 40% o più <strong>di</strong> argilla, 45 % o meno <strong>di</strong> sabbia e meno del 40% <strong>di</strong> limoAL Argilla limosa 40% o più <strong>di</strong> argilla e 40 % o più <strong>di</strong> limoAS Argilla sabbiosa 35% o più <strong>di</strong> argilla e 45 % o più <strong>di</strong> sabbiaFLA Franco limoso argillosa Dal 27% (compreso) al 40 % (escluso) <strong>di</strong> argilla e 20% o meno <strong>di</strong> sabbiaFA Franco argillosa Dal 27% (compreso) al 40 % (escluso) <strong>di</strong> argilla e dal 20% (escluso) al 45 % (compreso) <strong>di</strong> sabbia.FSA Franco sabbioso argillosa Dal 20 % (compreso) al 35 % (escluso) <strong>di</strong> argille, meno del 28 % <strong>di</strong> limo e più del 45 % <strong>di</strong> sabbiaFL Franco limosa 50% o più <strong>di</strong> limo e dal 12 % (compreso) al 27 % (escluso) <strong>di</strong> argilla , o dal 50 % al 80 % (escluso) <strong>di</strong> limoe meno del 12 % <strong>di</strong> argilla.argilla% <strong>di</strong>12delmenoelimo<strong>di</strong>più% o80LimoLF FrancaDal 7 % (compreso) al 27 % (escluso) <strong>di</strong> argilla, dal 28 % (compreso) al 50 % (escluso) <strong>di</strong> limo e 52 % o meno <strong>di</strong> sabbia.FS Franco sabbiose Dal 7 al 20 % <strong>di</strong> argilla, più del 52% <strong>di</strong> sabbia, e % <strong>di</strong> limo più 2 volte % <strong>di</strong> argilla è maggiore o uguale <strong>di</strong> 30;o meno del 7% <strong>di</strong> argilla, meno del 50 % <strong>di</strong> limo e più del 43% <strong>di</strong> sabbia.FSG Franco sabbioso grossolana 25% o più <strong>di</strong> sabbia molto grossa e grossa e meno del 50% <strong>di</strong> ogni altro tipo <strong>di</strong> sabbiaFSM Franco sabbiosa 30% o più <strong>di</strong> sabbia molto grossa, grossa e me<strong>di</strong>a, ma meno del 25% <strong>di</strong> sabbia molto grossa e meno del 30%<strong>di</strong> sabbia fine e molto fineFSF Franco sabbioso fine 30% o più <strong>di</strong> sabbia fine e meno del 30% <strong>di</strong> sabbia molto fine o 15-30% <strong>di</strong> sabbia molto grossa, grossa e me<strong>di</strong>aFSV Franco sabbioso molto fine 30% o più <strong>di</strong> sabbia molto fine o 40% o più <strong>di</strong> sabbia fine e molto fine metà della quale è costituita da sabbia molto fine, e<strong>di</strong>noltre meno del 15% <strong>di</strong> sabbia molto grossa, grossa e me<strong>di</strong>aSF Sabbie franche Tra il 70 e il 91 % <strong>di</strong> sabbia e % <strong>di</strong> limo più 1,5 volte % <strong>di</strong> argilla è uguale o maggiore <strong>di</strong> 15; e % <strong>di</strong> limo più2 volte % <strong>di</strong> argilla è minore <strong>di</strong> 30SFG Sabbia franca grossolana 25% o più <strong>di</strong> sabbia molto grossa e grossa e meno del 50% <strong>di</strong> ogni altro tipo <strong>di</strong> sabbiaSFM Sabbia franca 25% o più <strong>di</strong> sabbia molto grossa, grossa e me<strong>di</strong>a e meno del 50% <strong>di</strong> sabbia fine e molto fineSFF Sabbia franca fine 50% o più <strong>di</strong> sabbia fine; oppure meno del 25% <strong>di</strong> sabbia molto grossa, grossa e me<strong>di</strong>a e meno del 50%<strong>di</strong> sabbiaSFV Sabbia franca molto fine molto fine 50% o più <strong>di</strong> sabbia molto fineS Sabbie Più dell’ 85% <strong>di</strong> sabbia e % <strong>di</strong> limo più 1,5 volte % <strong>di</strong> argilla è minore <strong>di</strong> 15.SAG Sabbia grossolana 25% o più <strong>di</strong> sabbia molto grossa e grossa e meno del 50% <strong>di</strong> ogni altro tipo <strong>di</strong> sabbiaSAM Sabbia 25% o più <strong>di</strong> sabbia molto grossa, grossa e me<strong>di</strong>a e meno del 50% <strong>di</strong> sabbia fine e molto fineSAF Sabbia fine50% o più <strong>di</strong> sabbia fine; oppure meno del 25% <strong>di</strong> sabbia molto grossa, grossa e me<strong>di</strong>a e meno del 50% <strong>di</strong> sabbia molto fineSAV Sabbia molto fine 50% o più <strong>di</strong> sabbia molto fine
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICITESSITURAFigura 4.13. Schema semplificato per la stima della tessitura in campo.194
LA DESCRIZIONE DEL SUOLOClasse granulometricaDeve essere in<strong>di</strong>cata la classe granulometrica, ad eccezione della casistica prevista nel caso <strong>di</strong> suoliche hanno proprietà an<strong>di</strong>che od un alto contenuto in vetri vulcanici, pomici e ceneri, per le qualisono previste classi sostituitve. Nelle classi granulometriche la sabbia molto fine è lasciata“fluttuante”. Essa viene considerata sabbia se la tessitura è sabbiosa fine, sabbiosa fine franca o unaclasse più grossolana. Viene, invece, considerata come limo se la tessitura è sabbiosa molto fine,sabbiosa molto fine franca, franco-sabbiosa, franco-limosa, o una classe più fine.a) scheletro (frammenti <strong>di</strong> roccia con <strong>di</strong>ametro ≥ 2 mm) ≥ 90%;Co<strong>di</strong>ce Classe DescrizioneFRM Frammentale Pietre, ciottoli, ghiaia e sabbia molto grossolana; la quantità <strong>di</strong> terra fine è troppopiccola per riempire alcuni degli interstizi più larghi <strong>di</strong> 1 mm <strong>di</strong> <strong>di</strong>ametrola terra fine è sufficiente a riempire alcuni degli interstizi più larghi <strong>di</strong> 1 mm <strong>di</strong> <strong>di</strong>ametrob) scheletro (frammenti <strong>di</strong> roccia con <strong>di</strong>ametro ≥ 2 mm) ≥ 35 % e < 90%;Tabella 4.46. Classi granulometriche Soil Taxonomy con scheletro ≥ 35%.Co<strong>di</strong>ce Classe DescrizioneSKF Scheletrico franca La terra fina è francaSKA Scheletrico argillosa La terra fine è argillosaSKS Scheletrico sabbiosa La terra fine è sabbiosac) scheletro (frammenti <strong>di</strong> roccia con <strong>di</strong>ametro >= 2 mm)
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICILA DESCRIZIONE DEL SUOLO4.4.7 Frammenti grossolaniFrammenti grossolani litoi<strong>di</strong> superiori a 2 mm <strong>di</strong> <strong>di</strong>ametro. Nella scheda sono previste due classi:scheletro principale e secondario, una terza classe può essere archiviata nelle note, in quantoprevista nel database associato.AbbondanzaVariabile non co<strong>di</strong>ficata. Deve essere in<strong>di</strong>cata la percentuale in volume. Se il carattere è assenteimmettere 0 (zero); si riportano le classi <strong>di</strong> abbondanza più <strong>di</strong>ffuse:DimensioniTabella 4.48. Classi <strong>di</strong> abbondanza dello scheletro.Descrizione Valori (%)Assente 0Scarso 0,1 – 5,0Comune 5,1 – 15,0Frequente 15,1 -35,0Abbondante 35,1 – 70,0Molto abbondante >70,0Variabile non co<strong>di</strong>ficata. Devono essere in<strong>di</strong>cate le <strong>di</strong>mensioni in mm del <strong>di</strong>ametro (forma delloscheletro da 1 a 4) o della lunghezza (forma dello scheletro piatta) più frequenti; si riportano leclassi <strong>di</strong>mensionali più in uso.Tabella 4.49. Classi <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensione dello scheletro a formearrotondate, subarrotondate, angolari, irregolari.Forme arrotondate, subarrotondate,angolari, irregolariDescrizioneClasse (mm)Ghiaia fine 2,0 – 5,0Ghiaia me<strong>di</strong>a 5,1 – 20,0Ghiaia grossolana 20,1 – 75,0Ciottoli 75,1 – 250,0Pietre 250,1 – 600,1Massi > 600,0Tabella 4.50 Classi <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensionedello scheletro a forma piatta.Forma piattaDescrizione Classe (mm)Schegge 2,0 – 150,0Scaglie 150,1 – 380,0Pietre 380,1 – 600,0Massi > 600,0FormaDeve essere in<strong>di</strong>cata la forma dello scheletro riferendosi ai seguenti criteri:196SCHELETRO
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICILA DESCRIZIONE DEL SUOLOTabella 4.51 Classi della forma dello scheletro.Co<strong>di</strong>ce Definizione Descrizione1 Arrotondata La superficie dello scheletro è regolare e le linee <strong>di</strong> raccordo non presentanospigoli vivi.2 SubarrotondataLa superficie presenta lievi irregolarità (profon<strong>di</strong>tà delle cavità sempreinferiore ad un terzo della loro <strong>di</strong>mensione minore) ma le linee <strong>di</strong> raccordonon presentano spigoli vivi.3 Angolare La superficie delle facce è regolare o lievemente irregolare e le linee <strong>di</strong>raccordo presentano spigoli vivi.4 Irregolare La superficie è irregolare e le linee <strong>di</strong> raccordo presentano spigoli vivi e/oarroton<strong>dati</strong>.5 Piatta Lo scheletro presenta una <strong>di</strong>mensione inferiore alla metà delle altre.LitotipoVariabile co<strong>di</strong>ficata; ve<strong>di</strong> tab. 4.14 (substrato consolidato minerale).Stato <strong>di</strong> alterazioneLe classi previste sono elencate nella tabella seguente.Tabella 4.52. Classi dello stato <strong>di</strong> alterazione dello scheletro.Co<strong>di</strong>ce Definizione DescrizioneLA Fresco o Alterazione assente o molto deboleleggermentealteratoAA Poco alterato L’alterazione parziale è evidenziata da cambiamento <strong>di</strong> colore tral’interno e l’esterno; il nucleo interno rimane relativamente inalteratoe la consistenza originale è perduta in piccola parteRA Me<strong>di</strong>amentealteratoL’alterazione della parte esterna induce arrotondamento <strong>di</strong> frammentiangolari in origine e/o riduzione <strong>di</strong>mensionale.MA Fortemente(molto) alteratoTutti i minerali primari (esclusi i più resistenti) sono alterati; imateriali grossolani si possono rompere o ad<strong>di</strong>rittura sbriciolare conun debole sforzo.4.4.8 Reazione del suolo (pH), misura in campoIl pH del suolo generalmente si misura in laboratorio, ma una misura in<strong>di</strong>cativa può essereeffettuata in campo con apposita attrezzatura o reagenti. Questa può essere utile per una migliorecomprensione in campo <strong>di</strong> caratteristiche e genesi <strong>dei</strong> suoli, per una prima classificazione tentativa<strong>dei</strong> suoli, o nelle fasi <strong>di</strong> campagna preliminare o <strong>di</strong> verifica.SCHELETROpH in acquaVariabile non co<strong>di</strong>ficata. Per la misurazione possono essere utilizzati vari sistemi. In campo sipossono usare delle provette trasparenti da 50 ml ove introdurre 8 cm 3 <strong>di</strong> suolo (~10 g) e 25 ml <strong>di</strong>soluzione. Dopo aver agitato la soluzione aspettare 15 minuti prima <strong>di</strong> effettuare lettura.197
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICIpH in floruro <strong>di</strong> so<strong>di</strong>oUn test in<strong>di</strong>cativo per verificare la presenza <strong>di</strong> caratteristiche an<strong>di</strong>che nel suolo, può essere il testdel pH NaF . Valori superiori a 9,5 in<strong>di</strong>cano la presenza <strong>di</strong> abbondanti prodotti allofanici e/ocomplessi tra sostanza organica e alluminio. Il test è in<strong>di</strong>cativo per molti strati con proprietà an<strong>di</strong>chead eccezione <strong>di</strong> quelli molto ricchi in sostanza organica. Non può essere considerata una prova<strong>di</strong>agnostica poiché la stessa reazione avviene negli orizzonti spo<strong>di</strong>ci ed in certi suoli aci<strong>di</strong> argillosi,ove le argille mineralogiche sono caratterizzate da interstrati con ottaedri <strong>di</strong> alluminio. Anche i suolicon carbonati liberi hanno reazione simile. Prima <strong>di</strong> applicare questo test è bene fare la misura delpH in acqua e la reazione con HCl (il test non è adatto per i suoli alcalini). Il rapporto suolosoluzione è <strong>di</strong> 1:50 (50 ml 1 M NaF tamponata a pH 7,5) e la lettura va effettuata dopo 2 minuti(IUSS working group WRB, 2006; FAO, 2006).4.4.9 ConsistenzaLa consistenza si riferisce all'intensità ed alla natura delle forze <strong>di</strong> coesione ed adesione del suolo,alla sua resistenza ad essere frantumato meccanicamente, ad essere deformato oppure rotto. Sidescrive in campagna descrivendone la facilità <strong>di</strong> manipolazione fra le <strong>di</strong>ta e la sensazione che ilsuolo trasmette attraverso le seguenti valutazioni: resistenza, grado <strong>di</strong> cementazione, adesività eplasticità.Resistenza a rottura e grado <strong>di</strong> cementazioneLa resistenza a rottura su aggregati va in parte a sostituire ed integrare in modo più articolato ivecchi termini <strong>di</strong> struttura "incoerente" (single grain) e "massiva". La verifica della resistenza arottura si realizza su uno o più cubetti iso<strong>di</strong>mensionali <strong>di</strong> ~3 cm <strong>di</strong> lato. Se il campione non èottenibile perché le particelle non sono aggregate e si separano prontamente, oppure l'evidenzadell'aggregazione è molto debole, la resistenza a rottura è <strong>di</strong> tipo "sciolto" (SC), mentre se èpossibile ottenere uno o più blocchetti standard si eseguirà la prova <strong>di</strong> resistenza, assegnandoall'orizzonte la classe <strong>di</strong> competenza secondo i co<strong>di</strong>ci e le istruzioni che seguono.Figura 4.14. Rappresentazione della modalità <strong>di</strong> rottura degli aggregati.Nel caso <strong>di</strong> orizzonti con grado <strong>di</strong> aggregazione moderato o forte (co<strong>di</strong>ci 4 o 5 della tabella relativaal grado <strong>di</strong> aggregazione) e con aggregati <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni inferiori a ~1 cm, la resistenza a rottura vasempre considerata <strong>di</strong> tipo "sciolto, soffice, molto friabile, estremamente o molto debole", secondole con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> umi<strong>di</strong>tà e le forme dominanti.Soltanto nei casi in cui le <strong>di</strong>mensioni degli aggregati siano ben superiori ad 1 cm la variabileresistenza a rottura può essere riferita al comportamento <strong>di</strong> singoli aggregati, ma l'esecuzione dellaprova è considerata opzionale. Se le <strong>di</strong>mensioni <strong>dei</strong> blocchetti/aggregati campionabili noncorrispondono ai 2.8÷3 cm <strong>di</strong> lato standard, lo sforzo in Newton si potrà correggere con questocalcolo:198CONSISTENZA
LA DESCRIZIONE DEL SUOLON cercato = (2.8 [cm] / <strong>di</strong>mensione del campione [cm] ) 2 x N stimatoAd esempio, con aggregati poliedrici subangolari umi<strong>di</strong> <strong>di</strong> ∅ equivalente corrispondente a circa 15mm (aggregazione poliedrica subangolare me<strong>di</strong>a) che si deformano con uno sforzo "estremamentemodesto" (N=5) il calcolo darà N cercato = 17 [(2.8 cm/1.5 cm) 2 x 5 = 17], per cui la resistenza arottura dell'aggregato umido rientrerà nella classe "friabile" (FR), mentre con gli stessi aggregatisecchi, che si deformano con uno sforzo "modesto" (N=30) il calcolo darà N cercato = 105, per cuila resistenza a rottura dell'aggregato secco rientrerà nella classe "molto duro" (MD). (Carnicelli etal., 2001).Modalità <strong>di</strong> rotturaLa prova si svolge in orizzonti minerali ed emiorganici, in con<strong>di</strong>zioni naturali da umido a bagnato,su uno o più cubetti <strong>di</strong> ≅3 cm <strong>di</strong> lato ed esercitando una pressione crescente tra pollice ed in<strong>di</strong>cetenuti <strong>di</strong>stesi (in pratica è la stessa prova sullo stesso campione per la resistenza a rottura, se lecon<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> umi<strong>di</strong>tà naturale all'atto del <strong>rilevamento</strong> sono quelle adatte).Per la prova <strong>di</strong> flui<strong>di</strong>tà non è necessario un vero e proprio cubetto, basta una manciata <strong>di</strong>campione allo stato bagnato che viene stretto progressivamente con la mano a pugno.La descrizione <strong>di</strong> questa variabile può essere particolarmente utile nei seguenti casi:qualora si sospetti che l'orizzonte in questione sia un fragipan (o fragipan-like), per definirela fragilità;qualora si sospetti che l'orizzonte in questione abbia caratteri an<strong>di</strong>ci o tixotropici ( ad es. inAndosols, Oxisols e Spodosols), per definire la viscosità;qualora l'orizzonte sia emiorganico o minerale entro un suolo con caratteri molto idromorfied in falda (od in aree depresse in cui i materiali genitori sono depositi fluviolacustri, deltizi,o torbosi), per definire la flui<strong>di</strong>tà.AdesivitàPer verificare questa con<strong>di</strong>zione si può fare riferimento alla tab. 4.53.CONSISTENZA199PlasticitàPer verificare questa con<strong>di</strong>zione si lavori un piccolo campione <strong>di</strong> suolo <strong>di</strong> c.a. 4cm 3 e si aggiungaacqua fino al punto in cui non aderisce più alle <strong>di</strong>ta ed è possibile formare una pallina ± stabile.A questo contenuto <strong>di</strong> umi<strong>di</strong>tà (corrispondente circa alla capacità <strong>di</strong> campo del campione) si èsuperato il limite <strong>di</strong> adesività (sticky point). Si continua a lavorare il piccolo campione, eventualmentecon piccole aggiunte d'acqua, fino a che non si manifestano più cambiamenti nel comportamentodella pallina (normalmente 1-2 minuti <strong>di</strong> manipolazioni, secondo il contenuto idricoiniziale ed il contenuto nella frazione più fine). A questo punto viene raggiunta la massima plasticità,cioè il limite <strong>di</strong> plasticità (plasticity point), dal momento che il piccolo campione è in grado<strong>di</strong> cambiare costantemente forma quando sottoposto ad una forza e <strong>di</strong> mantenere la nuova forma alcessare della forza applicata. Al punto <strong>di</strong> massima plasticità il piccolo campione viene pressato edarrotolato tra le palme delle mani formando, se possibile, un cilindretto <strong>di</strong> 4 cm <strong>di</strong> lunghezzae 6 mm <strong>di</strong> <strong>di</strong>ametro. Secondo il comportamento del cilindretto fatto scorrere tra in<strong>di</strong>ce e pollice, èpossibile assegnare il campione alle classi <strong>di</strong> plasticità in tab. 4.54.Dal momento che adesività e plasticità sono caratteri sensoriali legati soprattutto alla quantità equalità della frazione argillosa, è possibile stimare in campagna il contenuto percentuale <strong>di</strong> argillatenendo conto sinteticamente delle sensazioni e reazioni prodotte dalla manipolazione del piccolocampione.
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICITabella 4.53. Co<strong>di</strong>fica e criteri <strong>di</strong> definizione dell’adesività.Co<strong>di</strong>ce Definizione Applicando una pressione tra pollice ed in<strong>di</strong>ce e separando poi le <strong>di</strong>ta:31 Non adesivo Nessuna particella <strong>di</strong> suolo aderisce.32 DebolmenteadesivoIl campione aderisce sia al pollice che all’in<strong>di</strong>ce in modo ben percepibile,ma quando le <strong>di</strong>ta si separano esso tende a staccarsi nettamente dall’una odall’altra e non si estende in modo apprezzabile.33 Adesivo Il campione aderisce chiaramente sia al pollice che all’in<strong>di</strong>ce e tende ad34 MoltoAdesivoestendersi fino a staccarsi da una sola parte anziché da ambedue.Il campione aderisce così fortemente tra pollice ed in<strong>di</strong>ce che quando siSeparano le <strong>di</strong>ta esso tende decisamente ad allungasi, fino a rompersi inparte sul pollice ed in parte sull’in<strong>di</strong>ce.Tabella 4.54. Co<strong>di</strong>fica e criteri <strong>di</strong> definizione della plasticità.Co<strong>di</strong>ce Definizione Arrotolando il cilindretto tra pollice ed in<strong>di</strong>ce:41 Non plastico Non si riesce a formare un cilindretto lungo 4 cm e spesso 6 mm.42 DebolmenteplasticoSi riesce a formare un cilindretto lungo 4 cm e spesso 6 mm, che sopportail proprio peso, ma <strong>di</strong>minuendo lo spessore a 4 mm il cilindretto nonsopporta il proprio peso.43 Plastico Si può formare un cilindretto lungo 4 cm e spesso 4 mm, che sopporta ilproprio peso, ma un cilindretto spesso 2 mm non è in grado <strong>di</strong>sopportarlo.44 MoltoplasticoSi può formare un cilindretto lungo 4 cm e spesso 2 mm, che sopporta ilproprio peso.200CONSISTENZA
LA DESCRIZIONE DEL SUOLOCONSISTENZA201Tabella 4.55. Co<strong>di</strong>fica e criteri <strong>di</strong> determinazione della resistenza a rottura e del grado <strong>di</strong> cementazione.Caratteristiche <strong>di</strong> resistenza alla rotturaCementazion eAggregati e campionistandard iso<strong>di</strong>mensionali <strong>di</strong>~3 cm <strong>di</strong> latoCroste ed aggregatilamellari lunghi ~1 ÷1.5 cmResistenzaAggregati e campioni standar<strong>di</strong>so<strong>di</strong>mensionali <strong>di</strong> ~3 cm <strong>di</strong> latoIl campione <strong>di</strong> riferimento si frantuma (si deforma)applicando uno sforzo per il tempo <strong>di</strong> 1 secondoCon<strong>di</strong>zioni secche(1) Con<strong>di</strong>zioni umide(2) Con<strong>di</strong>zioni secche(1) Dopo un’ora <strong>di</strong> immersione inacqua-Campione non ottenibile SC Sciolto SC Sciolto DE Estremamentedebole1 Non cementatoDM Molto deboleSO Soffice MF Molto friabileSi ottiene a malapena un campione; nessuno sforzotra pollice ed in<strong>di</strong>ce (
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICITabella 4.56. Co<strong>di</strong>fica e criteri <strong>di</strong> determinazione della modalità <strong>di</strong> rottura.è :l'orizzonteUmidoCo<strong>di</strong>ce DefinizioneDescrizione delle modalità della prova.FRAGILITÀ (Brittleness)FR FragileMantiene <strong>di</strong>mensioni e forma finché non si rompe improvvisamente.SF S emi-fragileSi comprime, ma si osservano f e n<strong>di</strong>ture; si rompe prima <strong>di</strong> esserecompresso a circa la metà dello spessore originario.DE DeformabilePuò essere compresso oltre la metà dello spessore originario senzafen<strong>di</strong>ture o rotture.1VISCOSITÁ (Smeariness)/ caratteri <strong>di</strong> TIXOTROPIANV Non viscoso (non tixotropico) A rottura non flui<strong>di</strong>fica, le <strong>di</strong>ta non scivolano.PV Poco viscoso (poco tixotropico) A rottura flui<strong>di</strong>fica, le <strong>di</strong>ta scivolano, ma sulle <strong>di</strong>ta nonrimangono tracce d’acqua.VV Moderatamente viscoso (moderatamente A rottura flui<strong>di</strong>fica, le <strong>di</strong>ta scivolano e rimangono tracce d’acqua sulle <strong>di</strong>ta.tixotropico)MV Molto viscoso (molto tixotropico) A rottura flui<strong>di</strong>fica, le <strong>di</strong>ta scivolano ed il materiale è untuoso; acquafacilmente visibile sulle <strong>di</strong>ta.FLUIDITÁNF Non fluidoNessun materiale fluisce tra le <strong>di</strong>ta.PF P oco fluidoTende a fluire tra le <strong>di</strong>ta, ma s t ringendo con forte pressione la maggiorparte del materiale rimane nella mano.BagnatoFF Moderatamente fluidoFluisce facilmente tra le <strong>di</strong>ta, ma una parte del materiale rimane nel palmodopo una forte pressione.MF M olto fluidoLa maggior parte fluisce tra le d ita e ben poco materiale rimane nel palmoanche dopo una debole pressione.1 Per tixotropia si intende una caratteristica tipica <strong>dei</strong> suoli collassabili, in cui la massa del suolo allo stato bagnato passa improvvisamente allo stato liquido quando sottoposta a vibrazioni.202CONSISTENZA
STRUTTURALA DESCRIZIONE DEL SUOLO4.4.10 StrutturaIl termine struttura del suolo (ped) si riferisce alla forma, alle <strong>di</strong>mensioni ed al grado <strong>di</strong> sviluppodell’eventuale aggregazione <strong>di</strong> particelle <strong>di</strong> suolo primarie in unità strutturali <strong>di</strong> origine naturale oartificiale (aggregati, zolle, frammenti naturali o artificiali) ed alla <strong>di</strong>sposizione spaziale <strong>di</strong> questeunità, inclusi i vuoti (pori e fessure) fra gli aggregati ed al loro interno (Sanesi, 1977). In campagnaviene descritta la macrostruttura, ossia la <strong>di</strong>sposizione spaziale naturale o artificiale <strong>di</strong> aggregati <strong>di</strong><strong>di</strong>mensioni variabili da pochi millimetri a <strong>di</strong>versi centimetri.FormaNella tabella seguente le classi da utilizzare.Tabella 4.57. Co<strong>di</strong>fica forma della struttura.Co<strong>di</strong>ce Definizione Descrizione0 Assente Suolo privo <strong>di</strong> strutturazione1 Lamellare A forma <strong>di</strong> lamelle, con la <strong>di</strong>mensione verticale molto ridotta rispetto aquelle orizzontali.2 Prismatica I ped sono prismi con le due <strong>di</strong>mensioni orizzontali <strong>di</strong> lunghezzainferiore a quella verticale. In genere le facce sono ben <strong>di</strong>stinguibili e ivertici angolari.3 PoliedricaangolareI ped sono poliedri iso<strong>di</strong>ametrali dotati <strong>di</strong> superfici piane e curve; ivertici sono aguzzi e le facce piane.4 PoliedricasubangolareI ped sono poliedri iso<strong>di</strong>ametrali dotati <strong>di</strong> superfici piane e curve;predominano le facce arrotondate con vertici smussati.5 Granulare I ped sono poco porosi (pori da molto scarsi a comuni) e sferoidali, leloro superfici sono poco in contatto.6 Grumosa I ped sono porosi (pori da abbondanti a molto abbondanti) e sferoidali,le loro superfici sono poco in contatto.7 Cuneiforme I ped sono a forma <strong>di</strong> cuneo con spigoli acuti (wedge-shaped).8 Nuciforme I ped sono tendenzialmente cubici, con facce lucenti; questa struttura ègeneralmente associata ai suoli ricchi in argilla e in ossi<strong>di</strong> <strong>di</strong> ferro(nitisols).9 Colonnare I ped hanno le due <strong>di</strong>mensioni orizzontali <strong>di</strong> lunghezza inferiore aquella verticale. In genere le estremità sono arrotondate.10 Di roccia Stratificazioni <strong>di</strong> se<strong>di</strong>mentazione.incoerente11 Di rocciacoerenteRoccia da molto alterata a non alterata.203
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICISTRUTTURAFigura 4.15. Rappresentazioni del tipo <strong>di</strong> struttura. (Shoeneberger et al. , 2002, mo<strong>di</strong>ficato).Figura 4.16. Esempi <strong>di</strong> alcuni tipi <strong>di</strong> struttura. Da sinistra in alto a destra in basso: strutturagranulare, poliedrica, prismatica e colonnare.204
STRUTTURALA DESCRIZIONE DEL SUOLOFigura 4.17. Esempio <strong>di</strong> struttura lamellare.Figura 4.18. Orizzonte C sabbioso, con grado <strong>di</strong>aggregazione sciolto.DimensioneDeve essere inserito il co<strong>di</strong>ce relativo alle <strong>di</strong>mensioni degli aggregati secondo la seguente tabella.Tabella 4.58. Classi <strong>di</strong>mensionali degli aggregati.FormaCo<strong>di</strong>ce Classe LamellarePrismatica e Poliedrica e Granularecolonnare nuciforme e grumosaCuneiformeDimensioni (mm)1 Fine 100Grado <strong>di</strong> aggregazioneSi definisce in base alla facilità con cui il suolo si separa in aggregati ed alla loro stabilità quandosono separati. Questa con<strong>di</strong>zione varia con il contenuto in acqua del suolo ed è descritto, in genere,in relazione allo stato in cui viene trovato il suolo.205
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICITabella 4.59. Co<strong>di</strong>fica grado <strong>di</strong> aggregazione.Co<strong>di</strong>ce Definizione Descrizione1 Sciolto oincoerentenon è osservabile alcuna aggregazione e neppure una chiara<strong>di</strong>sposizione or<strong>di</strong>nata <strong>di</strong> linee naturali <strong>di</strong> minore resistenza. Questisuoli, se smossi, si separano in particelle elementari in<strong>di</strong>viduali. Inalcuni casi le particelle elementari possono essere tenute insieme dallatensione superficiale dell’acqua.2 Massivo non è osservabile alcuna aggregazione e neppure una chiara<strong>di</strong>sposizione or<strong>di</strong>nata <strong>di</strong> linee naturali <strong>di</strong> minore resistenza. Questisuoli, se smossi, si spezzano in masse che possono essere facilmentesbriciolate (o rotte) in pezzi più piccoli, o possono rimanere ben unite.3 Debolmentesviluppata4 Moderatamentesviluppata5 Fortementesviluppatagli aggregati sono poco formati, poco durevoli, e sono evidenti ma non<strong>di</strong>stinti in un suolo in<strong>di</strong>sturbato. Se smosso, il suolo si rompe in uncerto numero <strong>di</strong> aggregati interi, molti aggregati spezzati e una grandequantità <strong>di</strong> materiale <strong>di</strong>saggregato.gli aggregati sono ben formati, poco durevoli e sono evidenti ma non<strong>di</strong>stinti in un suolo in<strong>di</strong>sturbato. Se smosso, il suolo si rompe in uninsieme composto <strong>di</strong> molti aggregati interi e <strong>di</strong>stinti, alcuni spezzati eduna parte <strong>di</strong> materiale non aggregato.gli aggregati sono durevoli, ben evidenti se il suolo è in<strong>di</strong>sturbato,aderiscono debolmente l’uno con l’altro e possono venire separati conuna separazione netta quando il suolo è smosso. Il materiale del suolosmosso è composto per la maggior parte da aggregati interi ed includeun po’ <strong>di</strong> aggregati rotti ed una piccola parte, o niente, <strong>di</strong> materialenon aggregato.STRUTTURARelazione fra la struttura primaria e la struttura secondariaViene descritta una struttura primaria ed una secondaria; per struttura primaria si intende quellamaggiormente evidente, oppure un tipo <strong>di</strong> struttura può contenerne un altro. Sono previste tre classi,che sono descritte nella successiva tabella.Tabella 4.60. Relazione tra struttura primaria e secondaria.Co<strong>di</strong>ce Descrizione1 Strutture compresenti2 Primaria dentro secondaria3 Primaria tendente a secondaria206
LA DESCRIZIONE DEL SUOLOCOND. I. (Ksat)4.4.11 PermeabilitàSi intende per permeabilità la stima in campagna della conducibilità idraulica satura, che inveceviene misurata in laboratorio.Tabella 4.61. Permeabilità e conducibilità idraulica satura (Ksat).Permeabilità Co<strong>di</strong>ce Ksat (µm/s) Proprietà dell’orizzonteElevata12Me<strong>di</strong>a 3Me<strong>di</strong>a 4Bassa56Molto alta>100Alta(100-10)Moderatamentealta(10-1)Moderatamentebassa(1-0,1)Bassa(0,1-0,01)Molto bassa(
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICILA DESCRIZIONE DEL SUOLO4.4.12 ConcentrazioniDebbono essere identificate presenza (abbondanza), composizione e stato fisico delleconcentrazioni presenti nel suolo. È possibile identificare concentrazioni principali e secondarie.CONCENTRAZ.Natura e composizioneLa casistica prevista è la seguente:Cristalli: concentrazioni formatesi nel suolo, singole o a gruppi, che appaiano con forme cristalline.Noduli: concentrazioni facilmente separabili dalla massa del suolo che hanno bor<strong>di</strong> ben definiti manon presentano una chiara organizzazione interna.Concrezioni: concentrazioni facilmente separabili dalla massa del suolo con bor<strong>di</strong> ben definiti econ un’organizzazione interna simmetrica intorno ad un punto, ad una linea o ad un pianoConcentrazioni soffici: concentrazioni che non possono essere rimosse dal suolo come unità<strong>di</strong>screte e che non hanno bor<strong>di</strong> ben definiti.Pendenti: concentrazioni, generalmente <strong>di</strong> carbonato <strong>di</strong> calcio, <strong>di</strong> forma verticale allungata, che siformano sulle superfici inferiori dello scheletro.Geoi<strong>di</strong>: detti anche “occhi <strong>di</strong> civetta”.Croste: stato del suolo superficiale indurito dall'accumulo <strong>di</strong> sali, in genere per movimentoascensionale.Figura 4.19. Concentrazioni nel suolo (Shoeneberger et al. , 2002, mo<strong>di</strong>ficata).208
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICILA DESCRIZIONE DEL SUOLOCONCENTRAZ.Tabella 4.62. Natura e composizione delle concentrazioni.ComposizioneNaturaCristalli Noduli ConcrezioniConc.sofficiPendenti Croste Geoi<strong>di</strong>Non identificata 1 2 3 4 5 6Carbonato <strong>di</strong> calcio 11 12 13 14 15 16 17Gessosa 21 22 23 24Ferrosa 32 33 34 36 37Ferro-manganesifera 42 43 44 46Cloruro <strong>di</strong> so<strong>di</strong>o 51 52 53 54Altri ossi<strong>di</strong> e62 63 64 66idrossi<strong>di</strong>Sostanza organica,74ferro e alluminioSilice 82 83 87Figura 4.20. Concrezione <strong>di</strong> carbonato <strong>di</strong> calcioFigura 4.21. Concrezioni ferro manganesifereAbbondanzaIn<strong>di</strong>care il valore percentuale stimato; se il carattere è assente immettere 0 (zero). Si riportano perconfronto le classi <strong>di</strong> abbondanza più in uso:Tabella 4.63. Classi <strong>di</strong> abbondanza delle concentrazioni.Classe (%) Descrizione0 Assenti0,1-2,0 Poche2,1-20,0 Comuni20,1-40,0 Abbondanti>40,0 Molto abbondantiTabella 4.64. Classi <strong>di</strong>mensionali delle concentrazioni.Classe (mm) Descrizione76,0 Gran<strong>di</strong>DimensioniIn<strong>di</strong>care il valore in mm delle concentrazioni più comuni. Si riportano per confronto le classi<strong>di</strong>mensionali più in uso.209
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICI4.4.13 VuotiLa descrizione <strong>dei</strong> vuoti prende in considerazione i macropori e le fessure.PoriLa porosità valutabile in campagna è ristretta alla macroporosità (pori <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensione maggiori <strong>di</strong>60µm). L’osservazione è limitata a quello che può essere osservato con una lente da 10-20ingran<strong>di</strong>menti. Può essere in<strong>di</strong>cata una casistica principale ed una secondaria.VUOTIFigura 4.22. Rappresentazioni <strong>dei</strong> tipi <strong>di</strong> vuoti nel suolo (Shoeneberger et al. , 2002, mo<strong>di</strong>ficata).AbbondanzaIn<strong>di</strong>care la percentuale <strong>di</strong> pori stimata. Se il carattere è assente immettere 0 (zero). Si riportano perconfronto le classi <strong>di</strong> abbondanza percentuale più in uso:210
LA DESCRIZIONE DEL SUOLOVUOTITabella 4.65. Classi <strong>di</strong> abbondanza <strong>dei</strong> pori.Classe (%) Descrizione0 Assenti0-0.1 Molto scarsi0.1-0.5 Scarsi0.5-2,0 Comuni2,1-5,0 Abbondanti>5,0 Molto abbondantiDimensioniTabella 4.66. Classi <strong>di</strong>mensionali <strong>dei</strong> pori.Classe (mm) Descrizione5,0 Molto gran<strong>di</strong>Variabile non co<strong>di</strong>ficata. In<strong>di</strong>care il valore in mm <strong>dei</strong> pori più <strong>di</strong>ffusi. Si riportano per confronto leclassi <strong>di</strong>mensionali più in uso:FessureVuoti planari compresi interamente nell’ambito dell’orizzonte.AbbondanzaVariabile non co<strong>di</strong>ficata. In<strong>di</strong>care il numero <strong>di</strong> fessure presenti per dm 2 ; se il carattere è assenteimmettere 0 (zero). Si allegano per confronto le classi più in uso.DimensioniVariabile non co<strong>di</strong>ficata. In<strong>di</strong>care il valore della larghezza in mm. Si allegano per confronto leclassi attualmente in uso.Tabella 4.67. Classi <strong>di</strong> quantità delle fessure.Classe (numero/dm 2 ) Descrizione0 Assenti1-10 Scarse11-25 Comuni>25 AbbondantiTabella 4.68: Classi <strong>di</strong>mensionali delle fessure.Classe (mm) Descrizione< 1,0 Molto sottili1,0-3,0 Sottili3,1-5,0 Me<strong>di</strong>e5,1-10,0 Larghe>10,0 Molto larghe211
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICI4.4.14 PellicoleLe pellicole sono figure pedogenetiche prodotte dalla deposizione, in orizzonti più o meno profon<strong>di</strong>,<strong>di</strong> materiali provenienti dagli orizzonti soprastanti in seguito a processi <strong>di</strong> eluviazione eilluviazione. Si possono avere <strong>di</strong>versi tipi quali: ponti <strong>di</strong> argilla (tra i granuli <strong>di</strong> sabbia), pellicole <strong>di</strong>argilla (cutans), pellicole ferromanganesifere, pellicole <strong>di</strong> sostanza organica. Pellicole <strong>di</strong> sabbia olimo biancastre (skeletans) possono formarsi per asportazione preferenziale <strong>di</strong> argilla e ossi<strong>di</strong> <strong>di</strong>ferro, Gli agricutans sono accumuli <strong>di</strong> materiale relativamente grossolano e ricco <strong>di</strong> sostanzaorganica formatosi al <strong>di</strong> sotto <strong>di</strong> orizzonti lavorati.TipoPossono essere in<strong>di</strong>cate sia le pellicole principali che le secondarie.Tabella 4.69. Co<strong>di</strong>fica del tipo <strong>di</strong> pellicole.Co<strong>di</strong>ce Descrizione1 Argilla2 Sabbia o limo3 Sostanza organica4 Ferro e argilla5 Ferromanganese6 Agricutans7 AltroPELLICOLEFigura 4.23. Pellicole <strong>di</strong> argilla (cutans). Ingran<strong>di</strong>mento.Abbondanza, spessore, localizzazioneVariabile non co<strong>di</strong>ficata. In<strong>di</strong>care il valore percentuale <strong>di</strong> abbondanza. Se il carattere è assenteimmettere 0 (zero). Si riportano, per confronto le classi più in uso:Tabella 4.70. Classi <strong>di</strong>abbondanza delle pellicole.Classe Descrizione(%)0 Assenti0-10,0 Scarse10,1-50,0 Comuni>50,0 AbbondantiTabella 4.71. Classi <strong>di</strong> spessore dellepellicole.Co<strong>di</strong>ce Descrizione1 Sottili 0,5 mmTabella 4.72. Co<strong>di</strong>fica <strong>di</strong>localizzazione delle pellicole.Co<strong>di</strong>ce Descrizione1 tra i granuli (ponti)2 nei pori3 sulle facce degliaggregati4 a lamelle5 sullo scheletro212
LA DESCRIZIONE DEL SUOLO4.4.15 Facce <strong>di</strong> pressione e scorrimentoSi tratta <strong>di</strong> pellicole che si formano per pressione (facce <strong>di</strong> pressione) o pressione e scorrimento(facce <strong>di</strong> scivolamento, “slickensides”) tra aggregati del suolo. Facce <strong>di</strong> pressione e scorrimentoangolate abbastanza da in<strong>di</strong>viduare piani intersecatisi, collegate ad una struttura a cuneo con spigoliacuti (wedge-shaped peds) sono tipiche <strong>dei</strong> “vertisuoli”.FACCEFigura 4.24. Rappresentazioni del tipi facce <strong>di</strong> pressione escivolamento nel suolo. (Schoeneberg et al. , 2002, mo<strong>di</strong>ficata).Figura 4.25. Facce <strong>di</strong> pressione e scorrimento(slickensides).TipoLa co<strong>di</strong>ficazione del tipo <strong>di</strong> facce è elencata nella tabella seguente.Tabella 4.73. Co<strong>di</strong>fica del tipo <strong>di</strong> facce <strong>di</strong> pressione e scorrimento.Co<strong>di</strong>ce Descrizione1 Facce <strong>di</strong> pressione2 Facce <strong>di</strong> pressione e scorrimento (slickensides)Facce <strong>di</strong> pressione e scorrimento (slickensides)3 angolate abbastanza da in<strong>di</strong>viduare pianiintersecatisiTabella 4.74. Classi <strong>di</strong> abbondanzadelle facce <strong>di</strong> pressione e scorrimento.Classe (%) Descrizione0 Assenti0-10 Scarse10-50 Comuni>50 AbbondantiAbbondanzaVariabile non co<strong>di</strong>ficata. In<strong>di</strong>care il valore percentuale <strong>di</strong> abbondanza. Se il carattere è assenteimmettere 0 (zero). Si riportano le classi più in uso in tab. 4.74.213
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICI4.4.16 Ra<strong>di</strong>ciSud<strong>di</strong>vise in principali e secondarie, secondo la frequenza.DimensioniVariabile non co<strong>di</strong>ficata. In<strong>di</strong>care le <strong>di</strong>mensioni in mm delle ra<strong>di</strong>ci più frequenti. Si allega, perutilità del rilevatore, una tabella che riporta una classificazione (Soil Survey Staff, 1993).Tabella 4.75. Classi <strong>di</strong>mensionali delle ra<strong>di</strong>ci.Classe (mm) Descrizione10 Molto grossolaneQuantità, andamentoVariabile non co<strong>di</strong>ficata; specificare il numero <strong>di</strong> ra<strong>di</strong>ci presenti in 100 cm 2 . Se il carattere è assenteimmettere 0 (zero). Si allegano per confronto le classi attualmente in uso:Tabella 4.76. Quantità delle ra<strong>di</strong>ci.Classe (numero <strong>di</strong> ra<strong>di</strong>ci/100 cm 2 )Descrizione Ra<strong>di</strong>ci fini emolto finiRa<strong>di</strong>ci da me<strong>di</strong>ea molto grossolaneAssenti 0 0Poche 1-10 1-2Comuni 11-25 3-5Molte 26-200 >5Abbondanti >200Tabella 4.77: Andamento delle ra<strong>di</strong>ci.Co<strong>di</strong>ce Descrizione1 Orizzontale2 Suborizzontale3 Verticale4 SubverticaleRADICI214
LA DESCRIZIONE DEL SUOLORADICI215Tabella 4.78. Criteri identificativi del tipo <strong>di</strong> attività biologica.Co<strong>di</strong>ce Descrizione Criteri identificativi (esempio)1 Mammiferi Tipi: talpe, ro<strong>di</strong>tori in genere, ecc.. Tracce: canali <strong>di</strong> escavazione <strong>di</strong> sezione da 5 cm o più, microrilievi, ecc..2 Anelli<strong>di</strong> Tipi: lombrichi, entrichei<strong>di</strong>. Descrizione: vermi cilindroi<strong>di</strong> <strong>di</strong>visi in segmenti, ecc.. Tracce: canali <strong>di</strong>escavazione <strong>di</strong> 1 - 2 cm, coproliti allungati, ecc..Famiglia Enchytreidae: vermi <strong>di</strong> ridottissima taglia, nelle regioni temperate la loro <strong>di</strong>mensione varia daqualche millimetro fino a 2-3 cm; il loro aspetto è filiforme. In genere sono lunghi 8-10 mm e larghi quantoun capello, Questi anelli<strong>di</strong> presentano metameria ed appaiono generalmente biancastri e trasparenti, si cibanoprincipalmente <strong>di</strong> residui vegetali e, in particolare <strong>dei</strong> tessuti parenchimatici delle lamine fogliari. Tracce:generalmente le loro <strong>dei</strong>ezioni, <strong>di</strong> forma ovoidale con contorni irregolari e <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni inferiori o uguali aqualche decimo <strong>di</strong> millimetro, si accumulano nell’orizzonte organico ben decomposto e sono costituite dallamescolanza <strong>di</strong> residui vegetali (Zanella et al. 2001, Galvan et al. 2005).21 Vermienchitrei<strong>di</strong>22 Vermi epigei Famiglia Lumbricidae: hanno <strong>di</strong>mensioni comprese tra 0.5 e 5 cm, pigmentazione rossa e tollerano bassivalori <strong>di</strong> pH del suolo. Vivono nella porzione superficiale del terreno, cibandosi principalmente <strong>di</strong> lettiera;talvolta scendono anche negli orizzonti più profon<strong>di</strong> dando origine ad escrementi organominerali. Tracce: gliescrementi hanno <strong>di</strong>mensioni variabili da qualche decimo <strong>di</strong> millimetro a 2 mm ed appaiono cilindrici conpunta conica.23 Vermi anecici Famiglia Lumbricidae: la loro lunghezza è superiore a 5 cm, la colorazione è rosa bruno e sono moltosensibili ai bassi valori <strong>di</strong> pH del suolo. Durante la loro attività compiono migrazioni dalla superficie delsuolo agli orizzonti minerali, creando gallerie che possono raggiungere profon<strong>di</strong>tà notevoli (fino a 1 m).Sono in grado <strong>di</strong> riciclare la lettiera in modo molto rapido e sono i principali artefici dell’intima unione tramateria minerale e materia organica. Tracce: le <strong>dei</strong>ezioni, <strong>di</strong> un centimetro ed oltre, hanno formaglomerulare.3 Artropo<strong>di</strong> Tipi: larve <strong>di</strong> insetti (mosche, coleotteri, lepidotteri), formiche, termiti, crostacei terrestri (porcellini <strong>di</strong> terra),aracni<strong>di</strong>, acari (zecche e simili). Descrizione: animali previsti <strong>di</strong> arti (6 le formiche, 8 i ragni) e articolazioniin genere. Tracce: ni<strong>di</strong>, canali, coproliti e uova millimetriche.
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICICo<strong>di</strong>ce Descrizione Criteri identificativi (esempio)314 Molluschi Tipi: gasteropo<strong>di</strong> terrestri (lumache e simili). Descrizione: animali provvisti <strong>di</strong> conchiglia con corpo molle,ecc..5 Nemato<strong>di</strong> Descrizione: vermi millimetrici. Tracce: danni agli apparati ra<strong>di</strong>cali delle colture.6 Funghi Tracce: alterazione fungina del materiale vegetale, miceli fungini, tuberi (tartufi), ecc..7 Non determinato8 CarboniAcari oribati<strong>di</strong>9 Manufatti Laterizi, plastiche o altro.Ove possibile, <strong>di</strong>stinguere l’attività <strong>di</strong> questi acari. Nelle regioni temperate le loro <strong>di</strong>mensioni variano da0.1 a 2 mm. Normalmente si trovano al <strong>di</strong> sotto della lettiera e si nutrono <strong>di</strong> materiale vegetale, <strong>di</strong> ife funginee <strong>di</strong> batteri. Il loro apparato boccale è dotato <strong>di</strong> potenti appen<strong>di</strong>ci capaci <strong>di</strong> triturare il cibo. Tra gli acari delsuolo, gli oribati<strong>di</strong> assumono una particolare importanza nei processi legati all’umogenesi. Particolareimportanza riveste la loro azione nella degradazione degli aghi delle resinose: essi penetrano nell’agoattraverso un minuscolo forellino praticato ad un’estremità, si nutrono <strong>dei</strong> tessuti parenchimatici efuoriescono. Tracce : i loro escrementi presentano colore bruno/nero, forma cilindrica e piccole <strong>di</strong>mensioni(30-50 µm - Zanella et al. 2001, Galvan et al. 2005).RADICI216
LA DESCRIZIONE DEL SUOLO4.4.17 Attività biologicaComprende il riconoscimento <strong>di</strong> segni legati ad attività biologica attuale o passata, compresi imateriali derivanti dall’attività antropica.TipoSi richiede <strong>di</strong> fare riferimento alla tipologia delle tracce (coproliti, canali, alterazione <strong>dei</strong> restivegetali, ecc.) o al <strong>rilevamento</strong> <strong>di</strong>retto degli esseri viventi. Per il riconoscimento delle tracce e <strong>dei</strong>tipi sarebbe utile una descrizione molto sintetica <strong>di</strong> uno specialista; si riporta una sud<strong>di</strong>visione inbase ai phylum principali della fauna che interessa il suolo (con in più i funghi). Le voci carboni emanufatti si riferiscono a materiali imputabili <strong>di</strong>rettamente all’attività antropica.QuantitàVa compilata almeno per le ife fungine, le muffe e le <strong>dei</strong>ezioni, la presenza <strong>di</strong> artropo<strong>di</strong>. È segnalatacon i seguenti termini generali:ATT.BIO./EFF.Tabella 4.79. Co<strong>di</strong>fica della quantità dell’attività biologica.Co<strong>di</strong>ce Descrizione0 Assente Le <strong>dei</strong>ezioni e/o i miceli non sono visibili in quantità sufficienti perdefinire una presenza %1 Scarsa Meno del 5% in volume sulla sostanza organica fine2 Comune 5-70% in volume sulla sostanza organica fine3 Abbondante Più del 70% in volume sulla sostanza organica fine; nel caso <strong>dei</strong> micelifungini questi spesso compattano il materiale e danno al tatto unasensazione feltrosa4.4.18 Effervescenza all’HClI sali nel suolo possono essere visibili ed in questo caso debbono essere descritti secondo lein<strong>di</strong>cazioni fornite per le concentrazioni. Ma possono essere finemente sud<strong>di</strong>visi nella massa delsuolo. In questo caso, se si tratta <strong>di</strong> carbonati, è possibile rilevarne la presenza con l’ausilio <strong>di</strong> alcuniaci<strong>di</strong> a debole concentrazione, a causa dell’effervescenza provocata dalla rapida liberazione <strong>di</strong> CO 2 .Il metodo per stabilire il grado <strong>di</strong> effervescenza prevede l’utilizzo <strong>di</strong> acido cloridrico ad unaconcentrazione del 10%. Valori <strong>di</strong> carbonati superiori al 10% non sono valutabili in campagna.GradoTabella 4.80. Grado <strong>di</strong> effervescenza e criteri per la sua identificazione.Co<strong>di</strong>ce Descrizione Carbonati totali stimati (%) Effetti all’u<strong>di</strong>to Effetti alla vista0 Nessuna 0 Nessuno Nessuno1 Molto debole 0,5 Scarsamente u<strong>di</strong>bile Nessuno2 Debole 2ModeratamenteU<strong>di</strong>bileAppena visibile3 Notevole 5 Facilmente u<strong>di</strong>bile Bolle fino a 3 mm4 Violenta >10 Facilmente u<strong>di</strong>bile Bolle fino a 7 mm217
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICILocalizzazioneIn<strong>di</strong>care la localizzazione.Tabella 4.81. Co<strong>di</strong>fica della localizzazione dell’effervescenza.Co<strong>di</strong>ce Descrizione1 Generalizzata (matrice e frammenti)2 Localizzata alla terra fine3 Localizzata nei frammenti grossolani4 Localizzata nelle concentrazioni secondarie4.4.19 Stima della densità apparenteLa densità apparente del suolo fa riferimento a due stati <strong>di</strong> contenuto idrico: quello corrispondentealla “capacità <strong>di</strong> campo” e quello corrispondente allo stato <strong>di</strong> “secco in stufa a 105°C”. Esprimequin<strong>di</strong> il rapporto (generalmente espresso in g/cm 3 ) fra la massa ed il volume <strong>di</strong> un campione <strong>di</strong>suolo in<strong>di</strong>sturbato. I <strong>meto<strong>di</strong></strong> utilizzati tra<strong>di</strong>zionalmente richiedono campionamenti da effettuarsisecondo <strong>meto<strong>di</strong></strong>che specifiche e determinazioni <strong>di</strong> laboratorio. É possibile, comunque stimare incampo il parametro ed in<strong>di</strong>care le classi come nella tabella successiva.Tabella 4.82 Stima della densità apparente.Co<strong>di</strong>ce Classe1 Bassa (1,4)La densità apparente può essere stimata con il seguente metodo, valido per i suoli secchi all’aria ecorrelato alle classi tessiturali USDA.Tabella 4.83. Metodo per la stima della densità apparente per i suoli secchi all’aria in relazione alle classi tessiturale USDA.Classi tessiturali USDAS, SF, FSA, F, FL , A, AL,Caratteristiche del suoloAS, L , FS 1 FS 2 FLA, FADensitàapparente(g/cm3)ClasseIl coltello penetra nel suolo limitatamente e solo con>uno sforzo notevole, il campione prelevato rimane > 1,91,8integro e non si <strong>di</strong>sgrega con la pressione delle <strong>di</strong>ta.> 1,6 AltaIl coltello penetra nel suolo con <strong>di</strong>fficoltà per 1-2 cm, ilcampione prelevato si <strong>di</strong>vide in pochi frammenti che si 1,8 1,6 1,4rompono con una notevole pressione delle <strong>di</strong>ta.Il coltello si può introdurre con uno sforzo limitato, ilMe<strong>di</strong>acampione prelevato si <strong>di</strong>vide in pochi frammenti che sirompono con una moderata pressione delle <strong>di</strong>ta.1,6 1,4 1,2Con una debole pressione del coltello il suolo si<strong>di</strong>sgrega in molti frammenti.1,4 1,2 1,0Il campione si <strong>di</strong>sgrega completamente ad una deboleBassapressione delle <strong>di</strong>ta, si vedono molti pori grossi e moltogrossi.1,2 1,0 -DENS. APP.1Parte della classe: con limo < 30 %. 2 Parte della classe: con limo > 30 %218
LA DESCRIZIONE DEL SUOLODa notare che si ritiene che un contenuto <strong>di</strong> sostanza organica > 2% riduca la densità apparente <strong>di</strong>0,03 g/cm 3 per ogni punto percentuale. Nel caso <strong>di</strong> suoli con caratteri tixotropici la densitàapparente si riduce <strong>di</strong> valori compresi tra 0,2 e 0,5 g/cm 3 in funzione della quantità <strong>di</strong> alluminioattivo.4.4.20 ClassificazioneIn campagna deve essere definita una classificazione tentativa del suolo, che dovrà essere la piùprecisa possibile sulla base <strong>dei</strong> caratteri rilevati in campo. Sulla scheda <strong>di</strong> campo si dovrà riportarela classificazione per esteso. Nel database è possibile archiviare in maniera co<strong>di</strong>ficata i sistemi <strong>di</strong>classificazione WRB (World Reference Base for soil resources) e Soil taxonomy (Keys to SoilTaxonomy). Altri sistemi <strong>di</strong> classificazione saranno comunque archiviabili nelle note. Per ogniclassificazione utilizzata dovrà essere riportato l’anno o l’e<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> riferimento. La classificazionefinale sarà possibile definirla successivamente, confrontando i <strong>dati</strong> acquisti in campo con i risultatiprovenienti dal laboratorio.4.4.21 CampionamentoDENS. APP.Il campionamento è molto importante poiché nessuna analisi <strong>di</strong> laboratorio può avere significato seil campione non rappresenta la popolazione da cui è stato estratto. L’attività <strong>di</strong> campionamento delsuolo si può definire statisticamente come un campionamento stratificato casuale, nel senso che gliorizzonti separati durante la descrizione del pedon definiscono strati omogenei nella popolazione.Gli orizzonti o strati possono essere campionati per le prove che debbono essere effettuate inlaboratorio. I campioni <strong>di</strong> suolo non debbono mai essere trasversali a <strong>di</strong>versi orizzonti. La quantitàgeneralmente in<strong>di</strong>cata per le analisi routinarie <strong>di</strong> laboratorio è <strong>di</strong> 1 Kg. Il campione è generalmentepreso per essere rappresentativo dell’intero orizzonte. I contenitori utilizzati per il trasporto <strong>dei</strong>campioni debbono riportare le co<strong>di</strong>fiche relative al co<strong>di</strong>ce del <strong>rilevamento</strong>, sigla del tipo <strong>di</strong>osservazione, numero dell’osservazione, profon<strong>di</strong>tà, eventualmente, co<strong>di</strong>ce dell’orizzonte o strato,parte dell’orizzonte campionata, finalità del campionamento e data del campionamento.Alcuni accorgimenti da usare nel prelievo del campione possono essere:iniziare sempre dagli orizzonti più profon<strong>di</strong> per evitare <strong>di</strong> inquinare gli orizzonti sottostanticon quelli superiori;separare subito e il più possibile i ped del campione prelevato, soprattutto se il suolo èargilloso, in modo da evitare <strong>di</strong> creare masse molto compatte e dure durante il <strong>di</strong>sseccamento inlaboratorio;eliminare la materia organica vivente quali: fauna e ra<strong>di</strong>ci vive, foglie e rami ver<strong>di</strong>;eliminare i frammenti grossolani, se non è prevista l’analisi degli stessi;adottare una strategia <strong>di</strong> sottocampionamento.Il sottocampionamento può essere volto a campionare <strong>di</strong>stintamente parti <strong>di</strong>verse dellostesso orizzonte, ad esempio, aree ridotte e aree ossidate, penetrazioni e massa circostante,parte limitrofa al limite dell’orizzonte che presenta un salto tessiturale. Oppure può esserevolto a campionare campioni parziali, da riunire nel campione da mandare al laboratorio.Se nell’orizzonte non vi sono variazioni importanti, è consigliabile prelevare a caso unadecina <strong>di</strong> sottocampioni in <strong>di</strong>verse parti nell’orizzonte. Se l’orizzonte appartiene ad unprofilo con un evidente trend <strong>di</strong> variazione, ad esempio verticale, è bene che i sottocampionisiano presi in successione dal limite inferiore a quello superiore dell’orizzonte. Seinvece si stanno campionando orizzonti sottili i sottocampioni possono essere presi tutti alla219
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICIstessa profon<strong>di</strong>tà, o in una successione lineare parallela al limite dell’orizzonte.Per finalità specifiche quali il prelievo <strong>di</strong> campioni in<strong>di</strong>sturbati, <strong>di</strong> parti <strong>di</strong> suolo da cui ricavaresezioni sottili o altro si dovranno adottare accorgimenti e tecniche coerenti con le finalità delcampionamento.Nella scheda deve essere in<strong>di</strong>cato l’orizzonte o strato campionato ed il tipo <strong>di</strong> analisi per cui ilcampione è stato prelevato, segnando S per gli orizzonti che sono stati campionati per le varieanalisi <strong>di</strong> laboratorio ed N per il caso contrario. In scheda è prevista la seguente casistica:Campionamento analisi routinariaCampionamento sezione sottileCampionamento densità apparenteCampionamenti per altre finalità (extra, specificare in nota).DENS. APP.220
LA DESCRIZIONE DEL SUOLO4.5 Caratteri e qualità del suoloIl <strong>rilevamento</strong> <strong>dei</strong> caratteri e qualità del suolo è frutto <strong>di</strong> una valutazione in genere complessa, chetiene conto <strong>di</strong> varie caratteristiche del suolo, del sito e dell’ambiente in cui si colloca. Per questomotivo la valutazione deve necessariamente seguire una accurata descrizione del sito e del profilo.4.5.1 Falda superficialeIl <strong>rilevamento</strong> della falda è riferito al solo spessore <strong>di</strong> suolo indagato (1,5-2 m <strong>di</strong> profon<strong>di</strong>tà, maanche oltre se alla base della fossa si usa la trivella) e dovrebbe provenire da una combinazione <strong>di</strong>osservazioni <strong>di</strong>rette in campagna e da altre informazioni in<strong>di</strong>rette come interviste ad agricoltori,consorzi <strong>di</strong> bonifica, articoli, pubblicazioni. Citare in nota la fonte dell'informazione e segnalare, sepossibile, se si tratta <strong>di</strong> corpo d'acqua continuo o limitato nello spazio. Nel caso <strong>di</strong> falde temporanee<strong>di</strong> ambienti collinari e montani è importante poter in<strong>di</strong>care i caratteri relativi alla durata della faldastessa.Tipo <strong>di</strong> faldaNella tabella seguente è in<strong>di</strong>cata la casistica prevista.QUALITA’Tabella 4.84. Co<strong>di</strong>fica del tipo <strong>di</strong> falda.Co<strong>di</strong>ce Definizione DescrizioneZ AssenteQuesto co<strong>di</strong>ce va usato quando si è certi che il sito non sia interessato da una faldasuperficiale.NC Non ConfinataQuesta situazione si verifica quando gli strati <strong>di</strong> suolo che sono imme<strong>di</strong>atamentesopra il limite superiore della falda hanno permeabilità uguale o superiore aglistrati che costituiscono l'acquifero. Il livello dell'acqua non risale una volta apertoil profilo o eseguita una trivellata.SC Semi ConfinataQuesta situazione si verifica quando gli strati <strong>di</strong> suolo che sono imme<strong>di</strong>atamentesopra il limite superiore della falda non sono impermeabili, ma hanno permeabilitàinferiore agli strati che costituiscono l'acquifero. Il livello dell'acqua risale unavolta aperto il profilo o eseguita una trivellata.CO ConfinataQuesta situazione si verifica quando gli strati <strong>di</strong> suolo che sono imme<strong>di</strong>atamentesopra il limite superiore della falda sono impermeabili. Strati completamenteimpermeabili raramente si trovano vicino alla superficie, ma può succederequando suoli con strati a tessitura molto fine sovrastano strati a tessitura sabbiosa.Il livello dell’acqua risale una volta aperto il profilo o eseguita una trivellata. Inquesto caso è <strong>di</strong>fficile <strong>di</strong>stinguere la falda confinata dalla semiconfinata. In generela falda semiconfinata ha una frangia capillare più alta rispetto a quella della faldaconfinata).YConfinata osemiconfinataVariabile da utilizzare quando non si è certi del tipo <strong>di</strong> falda (specialmente in caso<strong>di</strong> trivellata) ma vi siano evidenze della sua presenza.221
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICIFigura 4.26. Esempi <strong>di</strong>: falda confinata, semiconfinata e non confinata.Tipo <strong>di</strong> alimentazioneTabella 4.85. Co<strong>di</strong>fica del tipo <strong>di</strong> alimentazione della falda.Co<strong>di</strong>ce DefinizioneS SuperficialeP ProfondaMista. In alcuni casi, in certi perio<strong>di</strong> dell'anno, può succedere che alla falda adMalimentazione superficiale si aggiunga anche l'effetto della falda ad alimentazione profondaW Non rilevante, non pertinenteSe alla variabile tipo <strong>di</strong> falda sono stati assegnati i co<strong>di</strong>ci Z oppure Y, usare qui il co<strong>di</strong>ce W.Profon<strong>di</strong>tà dal piano campagna al limite superioreVariabile non co<strong>di</strong>ficata. In<strong>di</strong>care il dato stagionale istantaneo (riferito all'epoca del <strong>rilevamento</strong>)misurato sul posto (espresso in cm). La profon<strong>di</strong>tà va misurata subito senza aspettare che la faldarisalga, specialmente nel caso <strong>di</strong> falda confinata in pressione. Si allegano per confronto le classiattualmente in uso:QUALITA’Tabella 4.86. Profon<strong>di</strong>tà del livello della falda dal piano campagna.DescrizioneClasse (cm)Molto superficiale150Se alla variabile tipo <strong>di</strong> falda sono stati assegnati i co<strong>di</strong>ci Z, (falda assente), non compilare questocampo.222
LA DESCRIZIONE DEL SUOLODurata annuale cumulativaVariabile non co<strong>di</strong>ficata. In<strong>di</strong>care il valore stimato espresso in numero <strong>di</strong> mesi. Si allegano perconfronto le classi attualmente in uso:Tabella 4.87. Stima della presenza della falda nel tempo <strong>di</strong> un anno.Descrizione ClasseMolto transitoria Presente 6 ma
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICIDurataUtilizzare le classi riportate <strong>di</strong> seguito. In<strong>di</strong>ca il tempo <strong>di</strong> durata dell’inondazione; valgono gli stessicriteri <strong>di</strong> accertamento della voce precedente.Tabella 4.89. Tempi <strong>di</strong> durata delle inondazioni.Co<strong>di</strong>ce Descrizione Tempo1 Estremamente breve 30 g6 Non determinata -4.5.3 Scorrimento superficiale (runoff)Lo scorrimento superficiale (già detto “drenaggio esterno” o “runoff”) si definisce come per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong>acqua da un’ area per scorrimento sopra la superficie del suolo. Le classi sotto elencate vanno intesecome una stima per determinate con<strong>di</strong>zioni stazionali.Tabella 4.90. Classi dello scorrimento superficiale.Co<strong>di</strong>ce Descrizione1 Trascurabile2 Molto basso3 Basso4 Me<strong>di</strong>o5 Alto6 Molto altoPer la determinazione della classe <strong>di</strong> scorrimento superficiale si deve definire la pendenza dellastazione e la permeabilità dell’orizzonte meno permeabile entro un metro <strong>di</strong> profon<strong>di</strong>tà, cosìcome riportato precedentemente in questo manuale.Tabella 4.91. Schema <strong>di</strong> riferimento per la determinazione della classe <strong>di</strong> scorrimento superficiale in relazione allapendenza ed alla permeabilità dell’orizzonte meno permeabile entro un metro <strong>di</strong> profon<strong>di</strong>tà.PendenzaPermeabilità(%) Molto alta Alta Moder. alta Moder. bassa Bassa Molto bassaConcavità * 1 1 1 1 1 1
LA DESCRIZIONE DEL SUOLO4.5.4 Profon<strong>di</strong>tà utile alle ra<strong>di</strong>ciVariabile non co<strong>di</strong>ficata. In<strong>di</strong>care la profon<strong>di</strong>tà reale in cm dello spessore <strong>di</strong> suolo esplorabile dallera<strong>di</strong>ci. Si assume <strong>di</strong> includere in questo spessore <strong>di</strong> suolo gli orizzonti dalla superficie fino alraggiungimento <strong>di</strong> un orizzonte che presenta una ra<strong>di</strong>cabilità inferiore al 30%. La ra<strong>di</strong>cabilità èintesa come percentuale <strong>di</strong> volume <strong>di</strong> suolo esplorabile dalle ra<strong>di</strong>ci e può essere stimata dacaratteristiche del profilo e dalla <strong>di</strong>stribuzione delle ra<strong>di</strong>ci presenti (se presenti) nel suolo. Orizzontiimpenetrabili o <strong>di</strong>fficilmente penetrabili possono essere: la roccia, i se<strong>di</strong>menti consoli<strong>dati</strong>, idensipan, i fragipan, i duripan e gli orizzonti petrocalcici, petrogipsici, petroferrici, placici, orizzonticon falda permanente. Si allegano per confronto le classi attualmente in uso:Tabella 4.92. Classi della profon<strong>di</strong>tà utile alle ra<strong>di</strong>ci.Descrizione Classe (cm)Molto scarsa 1504.5.5 Limitazioni ed impe<strong>di</strong>menti all’approfon<strong>di</strong>mento delle ra<strong>di</strong>ciIl carattere descrive le cause che concorrono alla valutazione sulla profon<strong>di</strong>tà utile alle ra<strong>di</strong>ci.QUALITA’Tabella 4.93. Co<strong>di</strong>fica delle cause che concorrono alla valutazione sulla profon<strong>di</strong>tà utile alle ra<strong>di</strong>ci.LIMITAZIONI 12IMPEDIMENTICo<strong>di</strong>ce Descrizione Co<strong>di</strong>ce DescrizioneLCCompattazione e bassa macroporosità Compattazione elevata e macroporositàIC(o contatto paralithic)praticamente assenteLE Movimenti <strong>di</strong> contrazione-espansione IFScarsità <strong>di</strong> ossigeno e fenomeni riduttivi(falda)LE Bassa capacità d’aria INChimismo sfavorevole (ad es. nutrienti,eccesso <strong>di</strong> so<strong>di</strong>o, ecc.)LA Bassa ritenuta idrica IMContatto litico continuo od orizzontecementato in continuitàLSQuantità critiche <strong>di</strong> frammentigrossolani o concentrazioniIX Cause sconosciute 3LNChimismo sfavorevole (ad es.nutrienti)LF Contatto litico fessuratoLM Orizzonte cementato <strong>di</strong>scontinuo Z Nessuna limitazione o impe<strong>di</strong>mentoLX Cause sconosciute (3)ALAltre cause, <strong>di</strong> limitazioni oimpe<strong>di</strong>menti (aggiungere in nota)1 Per limitazioni si intende che l'orizzonte/strato presenta cause che non impe<strong>di</strong>scono lo sviluppo ra<strong>di</strong>cale, ma lolimitano fortemente. 2 Per impe<strong>di</strong>menti si intende che l'orizzonte/strato non permette assolutamente la penetrazione <strong>di</strong>ra<strong>di</strong>ci. 3 Quando in un orizzonte non si osserva nessuna delle causa note <strong>di</strong> limitazione od impedenza all’accesso dellera<strong>di</strong>ci, ma l’andamento delle ra<strong>di</strong>ci stesse, in relazione agli orizzonti sopra e sottostanti, in<strong>di</strong>ca una con<strong>di</strong>zionesfavorevole.225
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICI4.5.6 Profon<strong>di</strong>tà della rocciaIn<strong>di</strong>ca la profon<strong>di</strong>tà in cm dell’orizzonte R inteso come roccia integra (o comunque coerente), chesottostà al suolo o a materiali incoerenti. Si allegano per confronto le classi attualmente in uso:Tabella 4.94. Profon<strong>di</strong>tà dell’orizzonte R.ClasseValore (cm)Molto superficiale 1504.5.7 Gestione delle acqueIl riconoscimento del tipo <strong>di</strong> gestione delle acque riguarda sia il drenaggio che l’irrigazione. Per ildrenaggio, in particolare, sia la gestione delle acque <strong>di</strong> scorrimento superficiale che le falde idrichesottosuperficiali. Per quest’ultime, sia quelle permanenti o semi-permanenti, tipiche degli ambientiagricoli <strong>di</strong> pianura, che le falde sospese e temporanee, frequenti negli ambienti collinari e montani.TipoUtilizzare le classi riportate <strong>di</strong> seguito:Tabella 4.95. Tipo <strong>di</strong> gestione delle acque.Co<strong>di</strong>ce Descrizione01 Con pompe02 Con fossi03 Con tubi drenanti interrati04 Drenaggi con aratro-talpa05 Rippatura o scasso profondo06 Baulatura <strong>dei</strong> campi07 Irrigazione permanente per sommersione e/o scorrimento superficiale08 Irrigazione permanente a pioggia09 Irrigazione permanente a goccia10 Irrigazione non permanente <strong>di</strong> soccorso11 Baulatura e fossati12 Fossetti in traverso e fossi <strong>di</strong> guar<strong>di</strong>a (in versante)13 Sistemazioni idraulico-forestali <strong>di</strong> versante14 Sistemazioni idrauliche <strong>di</strong> fondo (su corso/i d’acqua)15 Sistemazioni con paravalanghe (sia attive che passive)16 Sistemazioni idrauliche <strong>di</strong> ripristino ambientaleQUALITA’226
LA DESCRIZIONE DEL SUOLOScopoUtilizzare le classi riportate <strong>di</strong> seguito:Tabella 4.96.Scopo della gestione delle acque.Co<strong>di</strong>ce Descrizione1 Diminuire il ristagno (drenaggi)2 Diminuire gli stress da siccità (irrigazione)3 Diminuire la salinità (interventi <strong>di</strong> drenaggio)4 Diminuire sia il ristagno che gli stress da siccità5 Diminuire sia il ristagno che la salinità6 Limitare l’erosione idrica superficiale (in collina)7 Limitare i movimenti <strong>di</strong> massa (in collina e montagna)8 Limitare l’erosione <strong>di</strong> fondo e <strong>di</strong> sponda4.5.8 Drenaggio internoPer drenaggio interno si intende una qualità del suolo relazionata alla frequenza e alla durata <strong>dei</strong>perio<strong>di</strong> durante i quali il suolo non è saturo o è parzialmente saturo <strong>di</strong> acqua. La valutazione si deveriferire alle con<strong>di</strong>zioni stagionali più limitanti. La velocità e la modalità del drenaggio interno<strong>di</strong>pendono dalla conducibilità idraulica degli orizzonti del suolo, dalla profon<strong>di</strong>tà della falda e dallafisiografia del sito e del territorio circostante. La tabella che segue fornisce le in<strong>di</strong>cazioni perin<strong>di</strong>viduare in campo la classe <strong>di</strong> drenaggio interno del suolo (Costantini, 2006). La fig. 4.27fornisce alcune in<strong>di</strong>cazioni che possono aiutare a valutare la presenza <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> idromorfiadel suolo.QUALITA’227
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICITabella 4.97. Classi <strong>di</strong> drenaggio interno in relazione al comportamento idrologico.ValutazioneDescrizione del comportamento idrologicoDisponibilità <strong>di</strong>ossigenoCo<strong>di</strong>ce DrenaggiointernoQuesti suoli hanno una conducibilità idraulica alta (da 10 a 100 µm s -1 ) e molto alta (>100 µm s -1 ) e un basso valored’acqua utilizzabile (AWC bassa o molto bassa, < 100 mm). Non sono adatti alle colture almeno che non venganoirrigati. Sono suoli privi <strong>di</strong> screziature redox.BuonaEccessivamentedrenato1Questi suoli hanno un’alta conducibilità idraulica (da 10 a 100 µm s -1 ) ed un più alto valore d’acqua utilizzabile (AWCbassa o moderata, > 50 mm, ma < 150 mm). Senza irrigazione possono essere coltivate solo un ristretto numero <strong>di</strong>piante e con basse produzioni. Sono suoli privi <strong>di</strong> screziature.Questi suoli trattengono una quantità ottimale <strong>di</strong> acqua (AWC elevata o molto elevata, > 150 mm), l'acqua è rimossa dalsuolo prontamente, e/o non si verificano durante la stagione <strong>di</strong> crescita delle piante eccessi <strong>di</strong> umi<strong>di</strong>tà limitanti per illoro sviluppo. Sono suoli <strong>di</strong> solito privi <strong>di</strong> screziature nella zona ra<strong>di</strong>cata.Questi suoli sono abbastanza umi<strong>di</strong> in superficie per un periodo sufficientemente lungo da con<strong>di</strong>zionare negativamentele operazioni d’impianto e raccolta delle colture mesofitiche, a meno che non venga realizzato un drenaggio artificiale. Isuoli moderatamente ben drenati hanno comunemente uno strato a bassa conducibilità idraulica (da 0,1 a 0,01 µm s -1 )nel primo metro, un apporto d’acqua per infiltrazione o alcune combinazioni fra queste con<strong>di</strong>zioni. Hanno figured’ossidoriduzione comuni (più del 4-5%) almeno nella parte bassa della zona ra<strong>di</strong>cata.Questi suoli sono abbastanza umi<strong>di</strong> in superficie o per un periodo sufficientemente lungo da ostacolare gravemente leoperazioni d’impianto, <strong>di</strong> raccolta o <strong>di</strong> crescita delle piante, a meno che non venga realizzato un drenaggio artificiale. Isuoli piuttosto mal drenati hanno comunemente uno strato a bassa conducibilità idraulica, un elevato stato d’umi<strong>di</strong>tà nelprofilo, un apporto d’acqua per infiltrazione o una combinazione fra queste con<strong>di</strong>zioni. Generalmente hanno figured’ossidoriduzione da comuni ad abbondanti nella zona ra<strong>di</strong>cata; possono anche mostrare screziature da ristagnotemporaneo dovute alla presenza <strong>di</strong> una suola d’aratura.Questi suoli sono generalmente umi<strong>di</strong> vicino o in superficie per una parte considerevole dell'anno, cosicché le colture apieno campo non possono crescere in con<strong>di</strong>zioni naturali. Le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> scarso drenaggio sono dovute ad una zonasatura, ad un orizzonte con bassa conducibilità idraulica, ad infiltrazione <strong>di</strong> acqua o ad una combinazione fra questecon<strong>di</strong>zioni. Generalmente hanno figure d’ossidoriduzione da comuni ad abbondanti entro i primi 50 cm.Questi suoli sono umi<strong>di</strong> vicino o in superficie per la maggior parte del tempo. Sono abbastanza umi<strong>di</strong> da impe<strong>di</strong>re lacrescita d’importanti colture (ad eccezione del riso), a meno che non vengano drenati artificialmente. Generalmentehanno screziature con chroma ≤ 2 abbondanti fin dalla superficie del suolo.BuonaPiuttostoeccessivamentedrenato23 Ben drenato BuonaModerataModeratamenteben drenato45 Piuttosto Imperfettamal drenato6 Mal drenato Scarsa7 Molto Molto scarsamal drenato228QUALITA’
LA DESCRIZIONE DEL SUOLOSTADIO 0 STADIO 1 STADIO 2 STADIO 3 STADIO 4Grado <strong>di</strong> idromorfia Assente Iniziale Debole Forte EstremoQUALITA’MacromorfologiaColore degli orizzonti Rosso/bruno Rosso/bruno Bruno/gialloScreziato:Rosso/giallo/grigioPresenza <strong>di</strong> screziature No Scarse Poche Molto abbondanteMoltoabbondanteColore delle screziature No Nere Decolorate Decolorate DecolorateMicromorfologiaColore della massa Rosso/bruno Rosso/bruno Giallo Giallo decolorato Grigio/verdeAccumulo No Mn, scarsoFe/Mn,Fe/Mn,abbondante abbondanteFe/Mn, scarsoDilavamento No Scarso Poco Molto abbondante L’intera matriceRegime idrologicoSaturazione completaUmidoMolti pochigiorniParecchi mesiPochi giorni Molti pochi mesi Parecchi mesi Quasi sempreParecchimesiMolti mesi Quasi sempre Quasi sempreRegime fisico-chimicoOssidazione Intensa Intensa Intensa Me<strong>di</strong>a NullaRiduzione Nulla Nulla Debole Me<strong>di</strong>a IntensaFigura 4.27. Sta<strong>di</strong> <strong>di</strong> idromorfia nei suoli (Aguilar et al., 2003 mo<strong>di</strong>ficato). Visione macroscopica e microscopica eregime idrologico. Riferiti all’orizzonte, corrispondono alle classi da 3 a 7 <strong>di</strong> drenaggio interno.229
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICIGlossariTermini geomorfologiciE. A. C. Costantini e M. Fantappiè, con il contributo del prof. Mauro Coltorti, Università <strong>di</strong> SienaIl seguente glossario <strong>dei</strong> termini geomorfologi fa riferimento alla tab. 4.9. Co<strong>di</strong>fica delle forme,presente nel capitolo 4, relativo alla descrizione del suolo. Il glossario non riporta il significato <strong>di</strong>tutti i termini presenti nella tabella, tralasciando i più noti e quelli <strong>di</strong> imme<strong>di</strong>ata comprensione. Perquesto glossario è stata usata la seguente bibliografia: Carnicelli et al., 2001; Castiglioni, 1991;Fairbridge, 1968; Panizza, 1995.AEAGATAVCDCDACDCCDDCDHCDICDPCDUFORME DI ORIGINE ANTROPICAArea estrattiva (cava): sito <strong>di</strong> estrazione <strong>di</strong> materiale in cave a cielo aperto, generalmentea mezza costa o a fossa.Arginatura per canale o altra opera: rialzo in terra realizzato dall’uomo ai margini <strong>di</strong>canali o corsi d’acqua.Versante con terrazzamenti antropici: si intende in generale un versante modellatome<strong>di</strong>ante una serie <strong>di</strong> ripiani in genere sostenuti da muretti a secco e da terrapieni, in cui losmaltimento dell'acqua piovana può avvenire per mezzo <strong>di</strong> fosse <strong>di</strong> scolo Si <strong>di</strong>stingue fraterrazzamento e ciglionamento: nel primo caso, la funzione <strong>di</strong> sostegno del ripiano èaffidata a muretti a secco; nel secondo caso, alla parete esterna del terrapieno (“ciglione”)opportunamente inerbita per renderla stabile. La scelta <strong>di</strong> una tipologia o dell'altra è spesso<strong>di</strong>pendente dalla natura del suolo e del substrato. La sistemazione a terrazze prevede lospietramento del terreno e il reimpiego <strong>dei</strong> sassi tolti per innalzare i muri <strong>di</strong> sostegno,altezza e <strong>di</strong>stanza <strong>dei</strong> quali <strong>di</strong>pendono dall'inclinazione del terreno.Livellamento, versante rimodellato: un versante rimodellato dall’azione dell’uomo ha ilprofilo naturale variato dall’azione in genere <strong>di</strong> potenti macchine, che asportano edaccumulano il terreno per livellare ed uniformare la superficie.FORME DI ORIGINE CARSICADepressione carsica, dolina: depressione morfologica associata a processi <strong>di</strong> <strong>di</strong>ssoluzionecarsica.Depressione carsica aperta: depressione carsica che, per evoluzione successiva allaformazione, ha visto smantellato una parte del rilievo che la racchiudeva, trasformandosiin conca sospesa prospiciente il versante.Dolina <strong>di</strong> crollo: a fondo irregolare e colmata <strong>di</strong> depositi <strong>di</strong> crollo anche grossolani;spesso delimitata da pareti verticali, formatasi in seguito al ce<strong>di</strong>mento del soffitto <strong>di</strong>cavità carsiche ipogee.Dolina a fondo piatto: depressione carsica modellata su roccia o in corrispondenza <strong>di</strong>una forma ad imbuto successivamente colmata da depositi fini.Hum: rilievo residuale all’interno in ambiente carsico sotto forma <strong>di</strong> “catasta <strong>di</strong>blocchi”.Chicot: rilievo residuale in ambiente carsico, che può assumere le forme più svariate dalla“cresta <strong>di</strong> gallo” alla “catasta <strong>di</strong> blocchi”.Polje: depressione carsica <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni chilometriche, con fondo piano e versantirelativamente ripi<strong>di</strong>, prodotti dall’associazione <strong>di</strong> processi <strong>di</strong> <strong>di</strong>ssoluzione con motivistrutturali; nella maggior parte <strong>dei</strong> casi associati con depressioni tettoniche.Uvala: depressione carsica formata dalla coalescenza <strong>di</strong> più doline. Terminegeomorfologico in via <strong>di</strong> abbandono.230GEOMORF.
LA DESCRIZIONE DEL SUOLOGEOMORF.CDVCICPCRCTCVCVACVCCVVEAEACEAPEASEATEC231Dolina <strong>di</strong> subsidenza: depressioni morfologiche formatesi su se<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> varia origine(fluviale, costiera, ecc.) che ricoprono un substrato calcareo in via <strong>di</strong> carsificazione; conforma simile alla dolina a fondo piatto, ma in cui i materiali <strong>di</strong> riempimento hanno origininon legate ai processi carsici.Versante carsificato: versante che presenta una alta frequenza <strong>di</strong> forme carsiche <strong>di</strong> piccole<strong>di</strong>mensioni; si tratta generalmente <strong>di</strong> sculture in roccia dovute a fenomeni <strong>di</strong> corrosione,come inghiottitoi, scannellature, campi carreggiati, ecc.Pietraia carsica: tipico esempio <strong>di</strong> fenomeno carsico <strong>di</strong> superficie rappresentato da solchipiù o meno paralleli e più o meno profon<strong>di</strong> (karren: campi solcati o carreggiati). Quando ilreticolo <strong>dei</strong> crepacci è ben sviluppato si formano delle creste sottili ed affilate che tendonoa collassare e a degradarsi fino a trasformarsi in una “griza” ossia in una pietraia in cui simescolano caoticamente massi, pietrisco e terra rossa.Ripiano carsificato: superficie sub-orizzontale <strong>di</strong> origine strutturale o <strong>di</strong> spianamento inpaesaggio carsico, genericamente caratterizzata dalla presenza <strong>di</strong> forme e depressionicarsiche <strong>di</strong> piccole <strong>di</strong>mensioni (scannellature, campi solcati, inghiottitoi, ecc.), nonsingolarmente cartografabili alla scala <strong>di</strong> rilievo, può essere caratterizzato in misura minoreanche dalla presenza valli secche, morte o cieche.Ripiano con tracce <strong>di</strong> reticolo fluvio-carsico: superficie sub-orizzontale <strong>di</strong> originestrutturale o <strong>di</strong> spianamento in paesaggio carsico, caratterizzata dalla presenza <strong>di</strong> <strong>di</strong>versevalli secche, morte o cieche <strong>di</strong> piccole <strong>di</strong>mensioni. Vi sono associate talvolta anche dolinepoco delineate.Valle fluvio-carsica: valle sul cui fondo scorre un corso d’acqua che attraversa un’areacarsica. L’alveo si presenta generalmente vegetato in quanto vi è poco materiale alluvionalein transito, con un deflusso superficiale molto saltuario.Valle fluvio-carsica cieca: è una valle sviluppatasi in ambiente carsico il cui corso d’acquanon arriva a defluire alla foce per una via superficiale, in quanto confluisce in uningiottitotio che assorbe tutta l’acqua del fiume.Canyon carsico: profonda forra dai ripi<strong>di</strong> versanti in roccia calcarea, il cui fiume puòessere percorso da un fiume oppure asciutto (valle secca o morta).Valle fluvio-carsica secca (o morta): è una valle fluviale sviluppatasi in ambiente carsicoche non presenta oggigiorno scorrimento <strong>di</strong> corsi d’acqua al suo interno, in quanto lo stessoè stato assorbito da vari punti del fondo.FORME DEL MODELLAMENTO EROSIVO IDRICOForme <strong>di</strong> accumulo: termine più generalizzato <strong>di</strong> quelli successivi, usato per in<strong>di</strong>careforme caratterizzate dall’accumulo <strong>di</strong> materiale prodotto dagli agenti deposizionali (adesempio, alluvionale, colluviale, detritico, antropico) presenti al piede <strong>di</strong> versanti.Cono <strong>di</strong> detrito: espressione morfologica <strong>di</strong> un corpo se<strong>di</strong>mentario costituito da materialigrossolani depositati allo sbocco <strong>di</strong> una incisione su un versante ripido.Glacis d’accumulo: superficie <strong>di</strong> raccordo graduale tra un versante e una sottostantesuperficie pianeggiante, generalmente concavo lungo la pendenza, costruito da variprocessi <strong>di</strong> deposizione.Falda <strong>di</strong> detrito da crollo (talus): accumulo <strong>di</strong> materiale detritico al piede <strong>di</strong> versanticostituiti da rocce litoi<strong>di</strong>, generalmente fratturate, soggetti al progressivo arretramento aseguito <strong>di</strong> fenomeni <strong>di</strong> erosione della parete (processi gravitativi).Torbiera <strong>di</strong> versante: per la definizione <strong>di</strong> torbiera ve<strong>di</strong> FLO.Cono <strong>di</strong> valanga: materiale accumulato alla base <strong>di</strong> un canale <strong>di</strong> valanga generalmente aforma <strong>di</strong> cono e talora con dossi allungati o irregolari.Canale <strong>di</strong> valanga: i canali e canaloni <strong>di</strong> valanga si formano lungo il percorso abitualedelle valanghe, secondo la <strong>di</strong>rezione <strong>di</strong> massima pendenza <strong>dei</strong> versanti, per effettodell’erosione combinata operata dalla massa <strong>di</strong> neve e detriti e del ruscellamento nivale.L’erosione può interessare sia il substrato che i detriti accumulati ai pie<strong>di</strong> del versante.
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICIEDEDBEDCEDFEDIEDLEDREDSEEEEREESVersanti <strong>di</strong>ssestati: versanti caratterizzati dalla presenza <strong>di</strong> <strong>di</strong>ssesti superficiali qualireptazione, soliflussione, evoluzioni <strong>di</strong> calanchi e biancane, incisioni <strong>di</strong> gran<strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni ecolate da trasporto in massa. Sono da associare a questa voce le deformazioni gravitativeprofonde <strong>di</strong> versante che presentano aree con <strong>di</strong>ssesti superficiali senza una generaleevoluzione in frana. Questa voce viene utilizzata quando le classi che la compongono nonsono singolarmente cartografabili alla scala del <strong>rilevamento</strong> o fotointerpretazione.Versanti con biancane: versanti interessati da forme <strong>di</strong> erosione caratterizzate da dossiarroton<strong>dati</strong> a cupoletta, detti anche mammelloni, separati da una fitta rete <strong>di</strong> brevi corsid’acqua a carattere stagionale.Versanti con calanchi: versanti acclivi profondamente incisi e notevolmente ramificati,separati da creste strette, in genere privi o quasi <strong>di</strong> vegetazione, impostati su terreniargillosi. Si tratta <strong>di</strong> forme modellate dall’azione congiunta dell’erosione concentrata(gully erosion) e dell’azione gravitativa (colate <strong>di</strong> fango).Versante con frane <strong>di</strong> suolo (soil slips): versanti con movimenti franosi che interessanole sole coperture pedogenetiche e non interessano il substrato sottostante.Incisione cartografabile alla scala della fotointerpretazione, ad esempio, gully <strong>di</strong> gran<strong>di</strong><strong>di</strong>mensioniColata da trasporto da massa: tipo <strong>di</strong> frana che coinvolge terreni poco coerenti in cuil’acqua si mescola a fango, pietre e blocchi effettuando un trasporto non selettivo.Versante con creep (reptazione): versante a pendenza in genere inferiore al 70% ecaratterizzato da movimento lento a carico <strong>di</strong> una roccia non coerente o <strong>di</strong> un suolo in cuigli aggregati sono interessati da movimenti <strong>di</strong> spostamento e <strong>di</strong> <strong>di</strong>scesa in<strong>di</strong>viduali, nondovuti alla sola forza <strong>di</strong> gravità ma anche a processi <strong>di</strong> gelo-<strong>di</strong>sgelo, umi<strong>di</strong>ficazione edessiccazione, <strong>di</strong>latazioni e contrazioni termiche, crescita e movimento delle ra<strong>di</strong>ci vegetali,azione <strong>di</strong> animali scavatori o da pascolo, lavori antropici <strong>di</strong> aratura e così via. Si manifestain genere con piccole scarpate e decorticazioni del manto vegetale.Versante con soliflusso: versante caratterizzato dalla presenza <strong>di</strong> soliflusso, cioè da unmovimento lento su pendenze non elevate della porzione alterata <strong>di</strong> una roccia non coerenteo <strong>di</strong> un suolo il cui materiale costitutivo è limoso e argilloso, eventualmente inglobantedetriti più grossolani. La massa, in quanto suscettibile a saturarsi <strong>di</strong> acqua, può <strong>di</strong>ventareplastica e/o quasi fluida e per azione della gravità colare verso valle. Si tratta <strong>di</strong> un processolento (dell’or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> qualche decimetro l’anno) che genera lobi, ondulazioni, decorticazionie terrazzamenti caratteristici.Versanti erosi: termine più generale <strong>dei</strong> seguenti, che in<strong>di</strong>ca la presenza <strong>di</strong> versanti con<strong>di</strong>verse forme <strong>di</strong> erosione superficiale (sheet, rill, gully erosion). Si trova per lo più inversanti a pendenza da moderata a forte.Versanti con incisioni e solchi permanenti: sono versanti caratterizzati da erosione idricaincanalata (rill e gully) cioè forme <strong>di</strong> erosione che si verificano quando l’afflussoidrometeorico supera l’infiltrazione dell’acqua nel suolo, con formazione <strong>di</strong> rigagnolievidenti. In particolare, l’erosione per fossi (gully erosion) è quella forma <strong>di</strong> erosioneincanalata nella quale le depressioni non possono essere eliminati attraverso le normalilavorazioni agricole. Oltre agli agenti <strong>di</strong> <strong>di</strong>stacco e trasporto presenti nell’erosione laminaresi aggiunge l’azione della turbolenza dell’acqua durante il suo scorrimento, che determinail <strong>di</strong>stacco <strong>di</strong> macroaggragati (zolle) e perfino del substrato ed il loro trasporto a <strong>di</strong>stanza.L’erosione per solchi (rill erosion) è quella forma <strong>di</strong> erosione incanalata che si <strong>di</strong>stingue daquella per fossi in quanto i rigagnoli possono essere eliminati attraverso le normalilavorazioni agricole.Versanti con erosione <strong>di</strong>ffusa: sono versanti caratterizzati da erosione laminare (sheeterosion) cioè quella forma <strong>di</strong> erosione che si verifica quando l’afflusso idrometeoricosupera l’infiltrazione dell’acqua nel suolo e comincia ad essere presente una componentedovuta al deflusso laminare dell’acqua, ma che non forma ancora rigagnoli evidenti.GEOMORF.232
LA DESCRIZIONE DEL SUOLOGEOMORF.EFEFCEFNEGELELAELNELREPERESESDETEVEVAEVC233Versante in frana: versante caratterizzato dalla presenza <strong>di</strong> uno o più corpi <strong>di</strong> frana, cioèdepositi originati dal movimento verso il basso <strong>di</strong> roccia o detriti, <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni variabili. Imovimenti franosi (frane) si considerano profon<strong>di</strong> quando interessano in modosignificativo la roccia, superficiali quando sono limitati al suolo o ai depositi colluviali <strong>di</strong>limitato spessore.Corpo <strong>di</strong> frana: forma generata da una massa <strong>di</strong> suolo, roccia o se<strong>di</strong>mento, franata.Nicchia <strong>di</strong> frana: superficie semicircolare generata da un fenomeno franoso <strong>di</strong> massa.Pe<strong>di</strong>ment o glacis d'erosione: forma erosiva tabulare su roccia debolmente inclinata,originatasi per arretramento parallelo <strong>di</strong> un rilievo montuoso.Versanti lineari: termine più generalizzato <strong>di</strong> quelli che seguono, usato per caratterizzareversanti privi <strong>di</strong> vallecole (ve<strong>di</strong> EV) e <strong>di</strong> <strong>di</strong>ssesti e/o fenomeni <strong>di</strong> erosione superficiale.Versante lineare aggradato: è aggradato quel versante in cui la fascia <strong>di</strong> deposizione sitrova nella parte bassa e occupa una parte significativa della lunghezza del versante(orientativamente più <strong>di</strong> un terzo).Versante lineare non aggradato: versante che non presenta fasce o aree <strong>di</strong> deposizione;anche le eventuali vallecole non sono riempite; la convessità nel senso della pendenza è lamorfometria dominante.Versante lineare regolare: versante a profilo sinusoidale, o convesso-concavo; la fascia <strong>di</strong>deposizione si trova nella parte bassa (piede del versante, footslope) e non occupa una partesignificativa della lunghezza del versante.Scarpata: versante ad elevata acclività, verticale o subverticale, <strong>di</strong> origine tettonica oerosiva.Resto <strong>di</strong> terrazzo: porzione <strong>di</strong> terrazzo fluviale che, per erosione, risulta completamenteisolata dall’originario sistema o sequenza <strong>di</strong> terrazzi e piana alluvionale.Superficie <strong>di</strong> spianamento: forma spianata o semispianata, in genere relitta, modellata aspese <strong>di</strong> un substrato variamente deformato. Si genera per l’azione <strong>di</strong> molteplici fattori, cheproducono una superficie pianeggiante non correlata con la <strong>di</strong>sposizione degli stratigeologici. Successivamente i movimenti tettonici possono sollevarla ed i processi erosivismembrarla a vario grado. Si può perciò rinvenire sia sui fianchi che alla sommità <strong>di</strong> rilievi.Superficie <strong>di</strong> spianamento <strong>di</strong>ssecata: <strong>di</strong>ssecato/a è detto <strong>di</strong> varie forme (ESD, FTI,PTI, MTI e SSD) e si riferisce a una forma in origine pianeggiante o subpianeggiante(terrazzo, superficie strutturale, superficie <strong>di</strong> spianamento) che, in seguito a un cambiamentodel livello <strong>di</strong> base o delle caratteristiche ed entità delle precipitazioni, vieneinteressata da fenomeni <strong>di</strong> incisione più o meno profonda che origina pareti ripide. Lasuperficie originale è ancora riconoscibile e raccordabile tra i <strong>di</strong>versi rilievi dove si puòriconoscere. In mancanza <strong>di</strong> una superficie originale riconoscibile, usare le forme <strong>di</strong>versante appropriate.Rilievo residuale (tor): rilievo risultante da processi molto spinti <strong>di</strong> alterazione/erosione ecostituito da varie combinazioni <strong>di</strong> pinnacoli rocciosi e/o ammassi <strong>di</strong> frammenti <strong>di</strong> gran<strong>di</strong><strong>di</strong>mensioni.Versanti con vallecole: termine generale per descrivere versanti con incisioni daruscellamento concentrato. Le incisioni hanno in genere <strong>di</strong>sposizione a pettine e pendenza<strong>di</strong> fondo molto simile a quella del versante stesso; i versanti con vallecole sono impostatigeneralmente su substrati piuttosto facilmente ero<strong>di</strong>bili (depositi su versante, litologiesabbiose o argilloso-sabbiose).Versante con vallecole non aggradato, in <strong>di</strong>ssesto: per la definizione <strong>di</strong> versante convallecole ve<strong>di</strong> EV. Per la definizione <strong>di</strong> non aggradato ve<strong>di</strong> ELN. Per la definizione <strong>di</strong>versante <strong>di</strong>ssestato ve<strong>di</strong> ED.Versante con vallecole aggradato, in <strong>di</strong>ssesto: per la definizione <strong>di</strong> versante con vallecoleve<strong>di</strong> EV. Per la definizione <strong>di</strong> aggradato ve<strong>di</strong> ELA. Per la definizione <strong>di</strong> versante<strong>di</strong>ssestato ve<strong>di</strong> ED.
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICIEVEEVGEVIEVNEVPEVREVSEVTEXEYEYVFAFAAFABFAFFAMVersante con vallecole aggradato, con vallecole reincise: per la definizione <strong>di</strong>versante con vallecole ve<strong>di</strong> EV, per la definizione <strong>di</strong> aggradato ve<strong>di</strong> ELA, per ladefinizione <strong>di</strong> vallecole reincise ve<strong>di</strong> EVT.Versante con vallecole aggradato, con vallecole riempite a conca: per la definizione <strong>di</strong>versante con vallecole ve<strong>di</strong> EV, per la definizione <strong>di</strong> aggradato ve<strong>di</strong> ELA. Si definisconocome vallecole riempite a conca quelle vallecole (ve<strong>di</strong> EV) con fondo concavo,incise e in seguito riempite da se<strong>di</strong>menti provenienti dai versanti (“colluvio” senso lato) oda trasporto <strong>di</strong> suolo da lavorazioni agricole.Versante con vallecole aggradato: per la definizione <strong>di</strong> versante con vallecole ve<strong>di</strong> EV,per la definizione <strong>di</strong> aggradato ve<strong>di</strong> ELA.Versante con vallecole non aggradato: per la definizione <strong>di</strong> versante con vallecole ve<strong>di</strong>EV, per la definizione <strong>di</strong> non aggradato ve<strong>di</strong> ELN.Versante con vallecole aggradato, con vallecole riempite a fondo piatto: per ladefinizione <strong>di</strong> versante con vallecole ve<strong>di</strong> EV, per la definizione <strong>di</strong> aggradato ve<strong>di</strong> ELA. Sidefiniscono come vallecole riempite a fondo piatto quelle vallecole (ve<strong>di</strong> EV) con fondopiatto, incise e in seguito riempite da se<strong>di</strong>menti, con contributo dominante <strong>di</strong> corsi d’acquaoperanti una erosione laterale significativa .Versante con vallecole regolare: per la definizione <strong>di</strong> versante con vallecole ve<strong>di</strong> EV, perla definizione <strong>di</strong> versante regolare ve<strong>di</strong> ELR.Versante con vallecole regolare, in <strong>di</strong>ssesto: per la definizione <strong>di</strong> versante con vallecoleve<strong>di</strong> EV, per la definizione <strong>di</strong> versante regolare ve<strong>di</strong> ELR, per la definizione <strong>di</strong> versante<strong>di</strong>ssestato ve<strong>di</strong> ED.Versante con vallecole aggradato, con vallecole in reincisione: per la definizione <strong>di</strong>versante con vallecole ve<strong>di</strong> EV, per la definizione <strong>di</strong> aggradato ve<strong>di</strong> ELA. Le vallecole inreincisione sono vallecole (ve<strong>di</strong> EV) che sono state riempite da se<strong>di</strong>menti, ma cheattualmente sono interessate da rinnovata incisione.Versante convesso, sommità arrotondata: il versante convesso è la parte del versantecaratterizzata da geometria convessa; la sommità arrotondata e la forma risultantedall’incontro <strong>di</strong> due versanti convessi prospicienti due valli opposte. In pianta, la sommitàarrotondata può avere forma più o meno allungata e delimitare due bacini idrografici.Valle: forma incisa derivata dalla coesistenza <strong>di</strong> fenomeni <strong>di</strong> denudazione <strong>dei</strong> versanti e <strong>di</strong>incisione lungo l’asta fluviale, il cui sviluppo può essere con<strong>di</strong>zionato dalla presenza <strong>di</strong>lineamenti strutturali. Si <strong>di</strong>stingue dalla vallecola (ve<strong>di</strong> EV) in quanto l’incisione piùprofonda comporta la presenza <strong>di</strong> un fondo a pendenza minore rispetto ai versanti che lafiancheggiano.Valle molto incisa a pareti verticali e/o subverticali (canyon): valle in cui si ha laprevalenza <strong>dei</strong> fenomeni <strong>di</strong> erosione <strong>di</strong> fondo, in genere in corrispondenza <strong>di</strong> un substratolitologico poco ero<strong>di</strong>bile.FORME DI FONDOVALLE: forme che caratterizzano aree <strong>di</strong> pianura delimitate da rilieviposti a breve <strong>di</strong>stanza.Piana alluvionale <strong>di</strong> fondovalle (letto <strong>di</strong> piena or<strong>di</strong>naria): area pianeggiante, costruita eattualmente interessata da prevalenti fenomeni <strong>di</strong> deposizione alluvionale.Fondovalle: pianura <strong>di</strong> un corso d’acqua delimitato da rilievi posti a breve <strong>di</strong>stanza.Fondovalle: con substrato roccioso subaffiorante: fondovalle dominato da processi erosiviche hanno condotto all’affioramento del substrato ed alla mancanza <strong>di</strong> una estesa coperturase<strong>di</strong>mentaria; si può generare per processi se<strong>di</strong>mentari o per erosione laterale da parte <strong>di</strong> corsid’acqua con carico solido ridotto (terrazzi orografici).Alveo attivo a canali intrecciati: per la definizione <strong>di</strong> canali intrecciati ve<strong>di</strong> PCW.Alveo <strong>di</strong> corso effimero o semieffimero: alveo caratterizzato da scorrimento idricospora<strong>di</strong>co che si presenta a <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> anni (effimero) o in maniera irregolare (semieffimero)tipico <strong>di</strong> regioni aride e semi aride (ad es. fiumara, wa<strong>di</strong>).234GEOMORF.
LA DESCRIZIONE DEL SUOLOFARFASFAXFAYFCCFCDFCEFCFFEFLOFLSFRFTFTIFTOFTXFTYGBFondovalle riempito: fondovalle in cui i processi <strong>di</strong> aggradazione (alluvionale e/o colluviale)hanno superato la capacità <strong>di</strong> trasporto del corso/i d’acqua; è caratterizzato da topografia pianao leggermente concava.Fondovalle sospeso: fondovalle <strong>di</strong> una valle o vallecola secondaria il cui profilo longitu<strong>di</strong>naleè posto a quote più elevate della limitrofa valle principale, in genere in seguito ad una forteincisione.Fondovalle con tracce <strong>di</strong> canali intrecciati: per la definizione <strong>di</strong> fondovalle ve<strong>di</strong> FA, per ladefinizione <strong>di</strong> canali intrecciati ve<strong>di</strong> PCW.Fondovalle con tracce <strong>di</strong> canali singoli: per la definizione <strong>di</strong> fondovalle ve<strong>di</strong> FA, per ladefinizione <strong>di</strong> canale singolo ve<strong>di</strong> PCM.Conoide alluvionale: corpo se<strong>di</strong>mentario a forma <strong>di</strong> ventaglio costituito da depositi <strong>di</strong> un corsod’acqua in corrispondenza <strong>di</strong> una brusca <strong>di</strong>minuzione della pendenza <strong>di</strong> fondo. Le pendenze delconoide sono in funzione del rapporto tra carico solido e portata. Viene chiamato cono nel casosi formi per processi <strong>di</strong> versante.Depressione <strong>di</strong> interconoide: depressione che si forma tra due conoi<strong>di</strong> contigui in seguitoall’aggradazione verticale e laterale <strong>di</strong> questi ultimi.Conoi<strong>di</strong> coalescenti: per la definizione <strong>di</strong> conoide ve<strong>di</strong> FC, sono coalescenti i conoi<strong>di</strong> che siintersecano lateralmente fondendosi l’uno nell’altro e colmando la depressione <strong>di</strong> interconoide.Glacis d’accumulo su conoide: per la definizione <strong>di</strong> glacis <strong>di</strong> accumulo ve<strong>di</strong> EAP, per ladefinizione <strong>di</strong> conoide ve<strong>di</strong> FC.Terrazzo d’erosione: forma simile ad un terrazzo fluviale, ma modellato a spese del substratoroccioso. Si <strong>di</strong>stingue dalla superficie strutturale per la mancanza <strong>di</strong> relazione con livellifacilmente ero<strong>di</strong>bili.Piana <strong>di</strong> riempimento e/o prosciugamento lacustre a prevalenza organica (torbiera): pertorbiera si intende un ambiente lacustre, palustre o lagunare carente <strong>di</strong> ossigenazione delleacque. Con il termine torba si fa riferimento ad un prodotto derivante da residui <strong>di</strong> Briofite,Ciperacee e Graminacee o <strong>di</strong> altre specie vegetali, trasformatesi in con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> anaerobiosi. Inquesti ambienti viene rallentato o inibito il processo <strong>di</strong> decomposizione e mineralizzazionedella sostanza organica.Piana <strong>di</strong> riempimento e/o prosciugamento lacustre a prevalenza minerale, sospesa: per ladefinizione <strong>di</strong> sospesa ve<strong>di</strong> FS.Conca <strong>di</strong> riempimento complesso: conca riempita da materiali <strong>di</strong> origine <strong>di</strong>versa (processicarsici, glaciali, frana, ecc.), susseguitisi nel tempo o agenti in contemporanea su parti <strong>di</strong>versedella stessa.Terrazzo fluviale: forma creata dall’incisione e parziale erosione <strong>di</strong> una piana alluvionale o <strong>di</strong>conoide alluvionale in seguito ad abbassamento importante del livello <strong>di</strong> base o per le mutatecon<strong>di</strong>zioni climatiche.Terrazzo fluviale <strong>di</strong>ssecato: terrazzo fluviale <strong>di</strong>ffusamente inciso da solchi <strong>di</strong> erosione.Superfici formanti ripiani possono presentarsi contemporaneamente <strong>di</strong>ssecate e ondulate. Per ladefinizione <strong>di</strong> terrazzo fluviale ve<strong>di</strong> FT. Per la definizione <strong>di</strong> <strong>di</strong>ssecato si veda ESD.Terrazzo fluviale con superficie ondulata: terrazzo fluviale che presenta una superficiedolcemente ondulata a causa della successione <strong>di</strong> cicli evolutivi comprendenti fasi <strong>di</strong> incisionee riempimento.Terrazzo con tracce <strong>di</strong> canali intrecciati: terrazzo fluviale la cui superficie presenta tracce <strong>di</strong>un reticolo idrografico a canali intrecciati (braided) non più attivo. Per la definizione <strong>di</strong> canaliintrecciati si veda PCW.Terrazzo con tracce <strong>di</strong> canale singolo: terrazzo fluviale la cui superficie presenta tracce <strong>di</strong> unreticolo idrografico a canale singolo, non più attivo. Per la definizione <strong>di</strong> canale singolo si vedaPCM.FORME DI ACCUMULO FLUVIOGLACIALEColata <strong>di</strong> blocchi e rock glaciers: corpo <strong>di</strong> deposito non selezionato, contenente anche235
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICImateriali molto grossolani, risultante da trasporto in massa associato sia a processi glacialiche gravitativi.GC Circo glaciale: nicchia scavata alla sommità <strong>dei</strong> versanti e più raramente sui fianchi vallivi,occupata oggigiorno o in passato da ghiacciai a circo. Essi presentano una depressione(ombelico) ed una contropendenza (verruca) che li separa dalla valle limitrofa.GD Superficie interessata da crioturbazione: forma caratterizzata da morfologie prodotte dalgelo e <strong>di</strong>sgelo, quali suoli poligonali, cerchi e strisce <strong>di</strong> frammenti rocciosi (patternedround, sorted circles e sorted stripes).GF Forme <strong>di</strong> accumulo fluvioglaciali: termine più generale, comprendente i successivi,riconosciuti al maggior dettaglio.GFK Esker: dorsale lunga e sinuosa formatasi sotto un ghiacciaio, per riempimento <strong>di</strong> galleriapercorsa da un torrente subglaciale.GFR Rilievi <strong>di</strong> alluvionamento supraglaciale (kame): superfici <strong>di</strong> deposizione fluvioglacialecreata dai torrenti <strong>di</strong> ablazione sui fianchi o nella parte sommitale <strong>di</strong> un ghiacciaio, talora informa <strong>di</strong> conoi<strong>di</strong>. Dopo lo scioglimento del ghiacciaio si preservano sotto forma <strong>di</strong> terrazzial contatto con il substrato o come ponticelli e dossi irregolari quando sovrastavano ilghiacciao stesso.GFS Piana <strong>di</strong> alluvionamento proglaciale (sandur, outwash plain): piana <strong>di</strong> deposizionefluvioglaciale formata dai torrenti e fiumi che escono dalla fronte <strong>di</strong> un grande ghiacciaio.GG Valli glaciali: termine più generale, comprendente i successivi, riconosciuti al maggiordettaglio.GGS Valle glaciale sospesa: valle glaciale laterale separata tramite un gra<strong>di</strong>no dalla valleprincipale più profonda.GGU Valle glaciale a U (anche doccia glaciale o truogolo): valle con sezione trasversale ad U.Risulta da un rimodellamento, per erosione sui fianchi e sul fondo del ghiacciaio talora aspese <strong>di</strong> solchi vallivi preesistenti.GM Rilievi morenici: forme create da materiali accumulati o deposti <strong>di</strong>rettamente dai ghiacciai,tipicamente con granulometria molto varia.GMA Morena <strong>di</strong> fondo e morena <strong>di</strong> ablazione: la morena <strong>di</strong> fondo è quel deposito clasticoeterometrico generato alla base del ghiacciaio. La morena <strong>di</strong> ablazione è un depositoclastico eterogeneo ed eterometrico trasportato all’interno del ghiacciaio ed accumulatodurante il ritiro dello stesso. É caratterizzato dalla scarsità <strong>di</strong> se<strong>di</strong>menti fini e da unamorfologia irregolare.GMD Drumlin: forma allungata nella <strong>di</strong>rezione <strong>di</strong> movimento del ghiacciaio, con versante amonte più ripido, formato dall’erosione glaciale su materiali non coerenti.GMF Morena frontale: deposito clastico eterometrico con una morfologia sommitalecaratterizzata da un dosso arcuato posto sulla fronte del ghiacciaio ed originato dalla spintadel ghiacciaio durante la sua avanzata.GMI Depressione intermorenica: depressione presente tra due rilievi morenici.GML Morena laterale: deposito clastico eterometrico con una morfologia sommitalecaratterizzata da un dosso parallelo al versante che alimentava il ghiacciaio.GMN Nivomorena: dosso generato dall’accumulo <strong>di</strong> materiali franati dalla parete della nicchianivale o del versante che la sovrasta prodotti da processi gravitativi e criogenici edaccumulatisi per gravità ai pie<strong>di</strong> del versante .GN Nicchia <strong>di</strong> nivazione: superficie semicircolare generata dall’erosione nivale in generesenza contropendenza alla base e più estesa sui versanti esposti a nord e nord-est(nell’emisfero nord) dove la neve perdura più a lungo.GS Conca <strong>di</strong> sovraescavazione: conca chiusa verso valle, originata dall’erosione glaciale.GSR Conca <strong>di</strong> sovraescavazione riempita: conca <strong>di</strong> sovraescavazione glaciale riempita dadepositi <strong>di</strong> varia natura (glaciale, fluviale, detritici o lacustri).GT Terrazzo d’erosione glaciale: (o spalla glaciale) gra<strong>di</strong>no o sequenza <strong>di</strong> gra<strong>di</strong>ni risultantiGEOMORF.236
LA DESCRIZIONE DEL SUOLOGEOMORF.237MAMAPMLMPMPAMPCMPFMPLMPMMPPMPSMTMTIPCPCAPCCPCDePDDdalla reincisione <strong>di</strong> una valle glaciale a U.FORME DI ORIGINE MARINA, LAGUNARE E LACUSTREPiattaforma d’abrasione: superficie pianeggiante, prodotta dall’erosione marina o lacustrea carico <strong>di</strong> materiali preesistenti l’innalzamento del livello del mare o lago. Quando emersaè fossile o inattiva, cioè non è più interessata da processi erosivi, in seguito adabbassamento del livello del mare o lago, o a innalzamento tettonico della costa.Piede <strong>di</strong> falesia: linea posta al limite interno (verso terra) <strong>di</strong> una piattaforma d’abrasione alraccordo con la falesia, cioè una scarpata a forte pendenza che non ospita suolo. Può esserepresente un accumulo <strong>di</strong> detriti, anche grossolani, prodotti dall’azione della gravità.Terrazzo lacustre: antichi depositi lacustri, o superfici <strong>di</strong> abrasione lacustre, sollevati sullivello lacustre attuale. Può essere costituito da depositi lacustri e successiva regressionedel livello relativo del lago. Si <strong>di</strong>stingue dalla piattaforma <strong>di</strong> abrasione per la sua naturaaggradante, cioè costruita da se<strong>di</strong>menti, e non erosiva, cioè formata dall’erosione <strong>di</strong>materiali preesistenti La <strong>di</strong>stinzione tra terrazzi fluviali e lacustri è basata sulriconoscimento dell’agente che ha operato il terrazzamento.Piana costiera: pianura costiera che subisce o ha subito processi <strong>di</strong> modellamento edeposizione dovuti all’azione del mare o <strong>di</strong> un lago.Piana <strong>di</strong> marea: superficie subpianeggiante interessata dall’azione delle maree, condepositi caratteristici. Il flusso e riflusso della marea può generare canali più profon<strong>di</strong> incorrispondenza <strong>dei</strong> cordoni litorali (canale <strong>di</strong> marea).Cordoni litoranei: dossi poco rilevati allungati paralleli o obliqui alla linea <strong>di</strong> costaattuale, costituiti da materiali <strong>di</strong> spiaggia.Piana <strong>di</strong> fango: area posta tra cordoni o dune, oppure a monte <strong>di</strong> cordoni o dune; ècostruita (per azione attuale o passata) dalla deposizione <strong>di</strong> materiali fini in ambientepalustre o litoraneo.Fascia <strong>di</strong> oscillazione lacustre: fascia pianeggiante compresa tra i livelli massimi e minimi<strong>di</strong> un lago, che rimane emersa o sommersa in seguito a variazioni <strong>di</strong> livello stagionali oclimatiche a breve termine.Canale <strong>di</strong> marea: via d’acqua tra una laguna costiera e il mare, percorsa dall’acqua insensi opposti secondo la marea.Palude: zona lacustre caratterizzata da bassa profon<strong>di</strong>tà caratterizzata da un’altaproduttività organica e scarsa ossigenazione. In queste zone si depositano i se<strong>di</strong>menti siltosied argillosi prodotti durante le esondazioni. É anche frequente la deposizione <strong>di</strong> se<strong>di</strong>mentiorganici (torbe).Piana <strong>di</strong> sabbia: area a deposizione sabbiosa in ambiente tidale in genere incorrispondenza della spiaggia intertidale.Terrazzo marino: antichi depositi costieri, o superfici <strong>di</strong> abrasione, sollevati sul livello delmare attuale. Ve<strong>di</strong> terrazzo lacustre.Terrazzo marino <strong>di</strong>ssecato: terrazzo marino inciso da corsi d’acqua o da altri agentimodellatori.FORME DI ORIGINE FLUVIALE IN PIANURA: forme la cui origine è da ricondurreall’azione <strong>dei</strong> corsi d’acqua e ai <strong>di</strong>versi processi <strong>di</strong> erosione, trasporto e se<strong>di</strong>mentazione chesi localizzano in aree <strong>di</strong> pianura, cioè in vaste aree pianeggianti.Piana alluvionale (letto <strong>di</strong> piena or<strong>di</strong>naria): area pianeggiante, costruita o attualmenteinteressata da fenomeni <strong>di</strong> deposizione alluvionale, nell’ambito <strong>di</strong> una pianura.Area <strong>di</strong> transizione tra dossi e depressioni in piana alluvionale.Ventaglio <strong>di</strong> rotta <strong>di</strong>stale: parte <strong>di</strong>stale <strong>di</strong> un ventaglio <strong>di</strong> rotta in genere creato al termine<strong>di</strong> canale <strong>di</strong> rotta.Dosso o argine naturale (levee), in piana alluvionale (PCD) o deltizia (PDD): rilievonastriforme convesso, a sinuosità variabile e costituito da deposizioni <strong>di</strong> un fiume contendenza a corso pensile, in un contesto <strong>di</strong> aggradazione verticale della pianura. È
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICIPCEPCGPCMPCRPCSPCTPCVPCWPCXPCZePDZPDPDAPDDPDTPDVcostituito da un complesso <strong>di</strong> corpi se<strong>di</strong>mentari <strong>di</strong> alveo e <strong>di</strong> argine naturale e dunqueda depositi tendenzialmente sabbiosi e limoso sabbiosi.Piana alluvionale elevata (letto <strong>di</strong> piena straor<strong>di</strong>naria): porzione <strong>di</strong> piana alluvionalesoggetta a esonondazione con frequenze <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne da decennale a centenario,posta a quota più elevata rispetto al canale; possono coesistere <strong>di</strong>verse piane alluvionalielevate, a frequenza <strong>di</strong> inondazione decrescente con la quota.Golena: porzione <strong>di</strong> piana alluvionale soggetta a inondazione con frequenze <strong>di</strong> or<strong>di</strong>neannuale, non separata dal corso d’acqua da un argine naturale.Paleoalveo a canale singolo o monocursale: il paleoalveo è una traccia <strong>di</strong> alveofluviale abbandonato e/o relitto <strong>di</strong> un corso d’acqua. I depositi all’interno del canaleabbandonato sono solitamente più grossolani rispetto alla piana circostante, ma èanche comune che il canale non più attivo, essendo depresso, abbia accolto acque <strong>di</strong>esondazione provenienti da alvei attivi vicini. Si è così riempito <strong>di</strong> depositi sabbiosi,limosi ed argillosi.Bassura <strong>di</strong> risorgiva: area depressa circostante una risorgiva (fontanile) <strong>di</strong> pianura.Piana a meandri: piana interessata dalla presenza <strong>di</strong> meandri cioè canali fluviali singoli(detti anche monocursali) ad andamento sinuoso. Per avere un tracciato a meandri l’in<strong>di</strong>ce<strong>di</strong> sinuosità (rapporto tra lunghezza del canale e lunghezza della valle) deve superare 1,5.Area <strong>di</strong> tracimazione: porzione <strong>di</strong> piana alluvionale, generalmente depressa, soggetta aesondazione con frequenze elevate per superamento <strong>di</strong> argini naturali o artificiali.Ventaglio o canale <strong>di</strong> rotta: il ventaglio <strong>di</strong> rotta è un corpo deposizionale a formaconoidale generato al termine <strong>di</strong> un canale <strong>di</strong> rotta in genere scolpito a spese <strong>dei</strong> depositi <strong>di</strong>argini naturali o artificiali. Il termine ventaglio <strong>di</strong> rotta può essere usato anche per ventaglinon più attivi o collegati a canali abbandonati; in tal caso le inondazioni frequenti siriferiscono a con<strong>di</strong>zioni non più attuali e non si tratta più <strong>di</strong> aree golenali. Il canale <strong>di</strong> rottaè un canale scavato dal corso d’acqua durante una tracimazione a spese degli argini naturalie/o artificiali . Se il processo <strong>di</strong> rotta prosegue si può giungere ad un cambiamento deltracciato fluviale (<strong>di</strong>versione).Paleoalveo a canali intrecciati: per la definizione <strong>di</strong> paleoalveo ve<strong>di</strong> PCM. Si definisconocanali intrecciati quei canali multipli, detti anche pluricursali, che si intersecanoripetutamente e che sono separati da barre mobili. I canali migrano e mutano posizionedopo ogni piena, sono in genere caratterizzati da un elevato carico solido totale. Il terminecorrisponde al termine anglosassone <strong>di</strong> “braided”.Area con tracce <strong>di</strong> canali intrecciati o anastomizzati: sistema <strong>di</strong> canali multipli. Per ladefinizione <strong>di</strong> canali intrecciati ve<strong>di</strong> PCW, i canali anastomizzati si intersecanoripetutamente e al contrario degli intrecciati sono caratterizzati da una elevata stabilità deltracciato ed un ridotto carico solido. Sono separati da argini e aree esondabili relativamentestabili. Si tratta <strong>di</strong> forme <strong>di</strong> transizione tra i canali intrecciati e quelli a meandro.Depressione in piana alluvionale o deltizia: questa forma si trova in aree <strong>di</strong> minoreaggradazione verticale della piana alluvionale (ad es. tra argini naturali <strong>di</strong> vari ramialimentatori); la forma depressa può essere accentuata dal fenomeno della subsidenza<strong>di</strong>fferenziale, che in genere si manifesta con modalità più evidenti proprio nelle areedepresse a causa della presenza <strong>di</strong> depositi fini e <strong>di</strong> depositi organici.Delta: prisma generato dal rapido accumulo <strong>di</strong> se<strong>di</strong>menti fluviali allo sbocco nel mare. Laforma è variabile in funzione dell’importanza della rielaborazione da parte delle correnticostiere (delta arcuato, lobato, cuspidato, <strong>di</strong>gitato, delta-conoide.Area <strong>di</strong> transizione tra dossi e depressioni in piana deltizia.Dosso in piana deltizia: ve<strong>di</strong> PCD.Area <strong>di</strong> tracimazione in delta: per la definizione <strong>di</strong> area <strong>di</strong> tracimazione ve<strong>di</strong> PCT, per ladefinizione <strong>di</strong> delta ve<strong>di</strong> PD.Ventaglio <strong>di</strong> rotta in delta: per la definizione <strong>di</strong> ventaglio <strong>di</strong> rotta ve<strong>di</strong> PCV. Per laGEOMORF.238
LA DESCRIZIONE DEL SUOLOGEOMORF.PDWPDZPPPPCPPDPPEPPFPPTPPWPPXPPYPTPTBPTIPTMPTOPTRPTXPTYSCSDSGSR239definizione <strong>di</strong> delta ve<strong>di</strong> PD.Paleoalveo in delta: ve<strong>di</strong> PCM e PDW.Depressione in piana deltizia: ve<strong>di</strong> PCZ.Piana pedemontana: fascia più o meno continua situata ai pie<strong>di</strong> <strong>di</strong> rilievi montuosi. Sitratta <strong>di</strong> aree frequentemente caratterizzate dalla presenza <strong>di</strong> depositi <strong>di</strong> conoidealluvionale.Conoide: espressione morfologica <strong>di</strong> un corpo se<strong>di</strong>mentario costituito da depositi <strong>di</strong> uncorso d’acqua in una piana pedemontana, in corrispondenza <strong>di</strong> una brusca <strong>di</strong>minuzionedella pendenza <strong>di</strong> fondo. Le pendenze sono in funzione del rapporto tra carico solido eportata.Depressione <strong>di</strong> interconoide: depressione che si forma tra due conoi<strong>di</strong> contigui in seguitoall’aggradazione verticale e laterale <strong>di</strong> questi ultimi.Conoi<strong>di</strong> coalescenti: Per la definizione <strong>di</strong> conoide ve<strong>di</strong> PPC, per la definizione <strong>di</strong>coalescenti ve<strong>di</strong> FCE.Glacis <strong>di</strong> accumulo su conoide: Per la definizione <strong>di</strong> glacis <strong>di</strong> accumulo ve<strong>di</strong> EAP, perquella <strong>di</strong> conoide ve<strong>di</strong> PPC.Parte <strong>di</strong>stale del conoide (transizione con la bassa pianura).Conoide con tracce <strong>di</strong> canali intrecciati: per la definizione <strong>di</strong> conoide ve<strong>di</strong> PP, per ladefinizione <strong>di</strong> canali intrecciati ve<strong>di</strong> PCW.Paleoalveo a canali intrecciati, su conoide: per la definizione <strong>di</strong> paleoalveo ve<strong>di</strong> PCM,per la definizione <strong>di</strong> canali intrecciati ve<strong>di</strong> PCW, per la definizione <strong>di</strong> conoide ve<strong>di</strong> PP.Paleoalveo a canale singolo, su conoide: per la definizione <strong>di</strong> paleoalveo e <strong>di</strong> canalisingoli ve<strong>di</strong> PCM, per la definizione <strong>di</strong> conoide ve<strong>di</strong> PP.Terrazzo fluviale: ve<strong>di</strong> FT.Paleoalveo a canali intrecciati, su terrazzo fluviale: per la definizione <strong>di</strong> paleoalveo ve<strong>di</strong>PCM, per la definizione <strong>di</strong> canali intrecciati ve<strong>di</strong> PCW.Terrazzo fluviale <strong>di</strong>ssecato: ve<strong>di</strong> FTI.Paleoalveo a canale singolo, su terrazzo fluviale: per la definizione <strong>di</strong> paleoalveo e <strong>di</strong>canali singoli ve<strong>di</strong> PCM.Terrazzo fluviale ondulato: ve<strong>di</strong> FTO.Basso terrazzo fluviale: terrazzo fluviale a<strong>di</strong>acente il letto <strong>di</strong> piena or<strong>di</strong>naria estraor<strong>di</strong>naria, caratterizzato da basso <strong>di</strong>slivello (tipicamente
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICISSSSDSSOSVVAVCVCCVCLVCPVCSVDVLVPVRVRMVTWAWDin geologia strutturale si identifica un pilastro tettonico, ovvero una porzione <strong>di</strong> crostaterrestre relativamente rialzata a causa <strong>di</strong> un sistema <strong>di</strong> faglie <strong>di</strong>rette in regime tettonico<strong>di</strong>stensivo. Un horst è delimitato da graben (ve<strong>di</strong> depressione tettonica).Superficie strutturale: superficie tabulare sia pianeggiante che variamente inclinata; puòrinvenirsi alla sommità <strong>di</strong> un rilievo (mesa) che lungo un versante (a gra<strong>di</strong>ni).Superficie strutturale <strong>di</strong>ssecata: per la definizione <strong>di</strong> superficie strutturale ve<strong>di</strong> SS, per ladefinizione <strong>di</strong> <strong>di</strong>ssecata ve<strong>di</strong> ESD.Superficie strutturale ondulata: superficie strutturale dolcemente ondulata, in genere percicli evolutivi comprendenti fasi <strong>di</strong> incisione e riempimento. Le superfici strutturali cheformano ripiani possono presentarsi contemporaneamente <strong>di</strong>ssecate e ondulate.Versante <strong>di</strong> faglia: versante fortemente con<strong>di</strong>zionato nella geometria dalla presenza <strong>di</strong> unao più faglie.FORME DI ORIGINE VULCANICA: forme connesse con l’attività recente <strong>dei</strong> vulcani nellesue varie forme.Caldera: depressione spesso più o meno circolare, <strong>di</strong> gran<strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni, formata dalcollasso <strong>di</strong> un e<strong>di</strong>ficio vulcanico per svuotamento della camera magmatica; possono essereeccentriche e contenere un lago.Cono vulcanico: rilievo <strong>di</strong> forma conica formatosi per accumulo e successivoconsolidamento, al <strong>di</strong> sopra <strong>di</strong> una bocca eruttiva, <strong>di</strong> prodotti <strong>di</strong> emissione vulcanica <strong>di</strong>vario tipo: lave, ceneri e scorie.Cono vulcanico <strong>di</strong> cenere: cono vulcanico costituito prevalentemente da ceneri.Cono vulcanico <strong>di</strong> lava: cono vulcanico costituito prevalentemente da lave.Cono vulcanico poligenico: cono vulcanico a composizione mista.Cono vulcanico <strong>di</strong> scorie: cono vulcanico costituito prevalentemente da scorie.Cupola o domo lavico: emissione <strong>di</strong> lava ad alta viscosità (lave <strong>di</strong> tipo acido) che perrapido raffreddamento è rimasta prossima al centro eruttivo.Colata lavica: dosso variamente rilevato ed esteso connesso con emissione <strong>di</strong> lava. Ingenere si riconoscono i fianchi ed il fronte.Plateau vulcanico: tipo particolare <strong>di</strong> superficie strutturale derivante dalla deposizione <strong>di</strong>lave o piroclastiti in ampie superfici pianeggianti o ondulate, in genere basaltiche (bassaviscosità), prodotte da attività <strong>di</strong> tipo fissurale (trappi, giare in Sardegna). Possono avereacquisito morfologie più complesse in seguito a evoluzione tettonica e/o erosiva successivaalla deposizione.Cratere: depressione caratterizzata da forma negativa conica, prodotta in corrispondenzadel camino eruttivo.Cratere <strong>di</strong> esplosione: depressione più o meno circolare formata dall’esplosione e/ocollasso <strong>di</strong> un e<strong>di</strong>ficio vulcanico, con scarsa o quasi nulla emissione <strong>di</strong> magma; spessocontiene un lago (lago <strong>di</strong> maar).Depressione vulcano-tettonica: sprofondamenti dovuti ad attività tettonica che siproducono in una area vulcanica a seguito <strong>di</strong> attività eruttiva. Fanno parte <strong>dei</strong> più genericifenomeni vulcano-tettonici che comprendono anche fratture ra<strong>di</strong>ali, tangenziali o anularidel corpo <strong>di</strong> un e<strong>di</strong>ficio vulcanico e sollevamenti vulcano-tettonici con formazione <strong>di</strong> horst.FORME DI ORIGINE EOLICA: forme la cui origine è dovuta alla deflazione eall’accumulo eolico.Area <strong>di</strong> accumulo eolico: area caratterizzata dall’accumulo <strong>di</strong> materiali trasportati dalvento che generano morfologie uniformi e dolcemente ondulate e cioè prive della tipicaforma delle dune.Duna: rilievo allungato, costruito dall’azione del vento. Si identifica facilmente dallabuona classazione delle sabbie e dalla loro stratificazione incrociata, inoltre nellafotointerpretazione si <strong>di</strong>stinguono per l’asimmetria <strong>dei</strong> fianchi (meno ripido il latosopravento) e per i toni chiari del suolo.240GEOMORF.
LA DESCRIZIONE DEL SUOLOWDAWDPWEWILDuna appoggiata: (o duna d’ostacolo) duna che, nella sua migrazione, si è arrestata controun rilievo, perdendo la caratteristica forma. Può essere stata successivamente erosa edessere sospesa, cioè separata dal fondovalle da un tratto <strong>di</strong> versante su materiali <strong>di</strong>versi. Siidentifica soprattutto dai materiali e dal loro assetto.Duna spianata: duna obliterata nella forma e talvolta nelle peculiarità del se<strong>di</strong>mento acausa <strong>di</strong> processi erosivi sia generati da azioni antropiche che naturali; ancora riconoscibilein foto aerea nelle sue forme essenziali.Superficie o conca <strong>di</strong> deflazione: superfici o conce che si formano a seguito <strong>di</strong>prelevamento <strong>di</strong> materiali incoerenti dal suolo a carico del vento, <strong>di</strong>stinguibili in quanto ingenerale il materiale residuo è costituito soltanto da materiale grossolano che il vento non èriuscito a sollevare.Area interdunale perio<strong>di</strong>camente allagata (lama): area tra dune posta in prossimità <strong>di</strong>corpi idrici. I suoli hanno falda idrica poco profonda, che raggiunge la superficie nellastagione piovosa.GEOMORF.241
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICITermini relativi ai substrati consoli<strong>dati</strong>R. Rivieccio, M. Paolanti, E. A. C. CostantiniIl seguente glossario <strong>dei</strong> termini relativi ai substrati consoli<strong>dati</strong> fa riferimento alla tab. 4.14.“Co<strong>di</strong>fica <strong>dei</strong> substrati consoli<strong>dati</strong>”, presente nel capitolo 4, relativo alla descrizione del suolo. Ilglossario non riporta il significato <strong>di</strong> tutti i termini presenti nella tabella, tralasciando i più noti. Perquesto glossario è stata usata la seguente bibliografia: Carnicelli et al., 2001; Carumati et al., 1987;D’Amico et al., 1991; Shoeneberger et al., 2002.ROCCE MAGMATICHEMA0000 Rocce magmatiche o ignee: rocce formate dal consolidamento <strong>di</strong> magmi o <strong>di</strong> flui<strong>di</strong> daessi derivati e sono <strong>di</strong>stinte in rocce intrusive, effusive e filoniane (o ipoabissali).MAI000 Rocce magmatiche intrusive e ipoabissali: le rocce intrusive (o plutoniche) sono ilprodotto della cristallizzazione del magma all'interno della crosta terrestre e sonocaratterizzate da strutture granulari; le rocce ipoabissali sono invece cristallizzate aprofon<strong>di</strong>tà interme<strong>di</strong>e tra le rocce plutoniche e quelle vulcaniche. Sono <strong>di</strong>stinte in base a<strong>di</strong>verse caratteristiche come la quantità <strong>di</strong> silice o la quantità modale <strong>di</strong> minerali sialicio mafici, ecc.MAI100 Rocce magmatiche intrusive (o plutoniche) da acide (o sialiche) ad interme<strong>di</strong>e: sonorispettivamente le rocce intrusive soprassature o granitoi<strong>di</strong> che contengono unapercentuale <strong>di</strong> silice, libera o combinata, superiore al 65%, e quelle che ne contengonouna percentuale tra il 65% ed il 52% in peso.MAI101 Granito: roccia plutonica acida costituita da ortoclasio, plagioclasio (albite -oligoclasio), quarzo, biotite e minerali accessori; ha struttura granulare i<strong>di</strong>omorfa congrana da me<strong>di</strong>a a grossa; il colore <strong>di</strong>pende generalmente da quello dell'ortoclasiopresente ed è variabile da bianco a rosa a rosso.MAI102 Grano<strong>di</strong>orite: roccia plutonica interme<strong>di</strong>a costituita da plagioclasio (oligoclasio -andesina), ortoclasio, quarzo, biotite e anfibolo (orneblenda); ha struttura granulare dai<strong>di</strong>omorfa ad allotriomorfa con grana da me<strong>di</strong>a a grossa ed il colore è più scuro che neigraniti (da grigio a nero).MAI103 Diorite: roccia plutonica costituita da plagioclasio (oligoclasio - andesina), anfibolo(orneblenda) e biotite; ha struttura granulare i<strong>di</strong>omorfa con grana da me<strong>di</strong>a a fine ed è <strong>di</strong>colore grigio scuro.MAI104 Tonalite: roccia magmatica intrusiva composta principalmente da plagioclasio equarzo, orneblenda e biotite; è <strong>di</strong> colore grigio, con inclusioni più scure.MAI105 Sienite: roccia plutonica interme<strong>di</strong>a costituita da ortoclasio, plagioclasio (oligoclasio),biotite, anfibolo (orneblenda) e quarzo (poco); ha struttura granulare i<strong>di</strong>omorfa congrana me<strong>di</strong>a e colore chiaro (violaceo) con punteggiatura nera.MAI106 Monzonite: roccia intrusiva della famiglia delle sieniti, composta essenzialmente daortoclasio e plagioclasio del tipo labradorite (in parti uguali) e da minerali femici qualiaugite, orneblenda e biotite (mentre è priva <strong>di</strong> quarzo).MAI200 Rocce plutoniche da basiche (o femiche) ad ultrabasiche (o ultrafemiche): sono lerocce intrusive sottosature che contengono una percentuale <strong>di</strong> silice combinata(mancano in genere <strong>di</strong> silice libera) inferiore rispettivamente al 52% o al 45% in peso.MAI201 Gabbro: roccia plutonica basica costituita da plagioclasio (labradorite), iperstene(pirosseno) e olivina; ha struttura granulare i<strong>di</strong>omorfa con grana me<strong>di</strong>a e colore scuro:nero, verde.MAI202 Anortosite: roccia della famigla <strong>dei</strong> gabbri composta prevalentemente (più del 90%) daun plagioclasio quasi sempre simile a quello presente nei gabbri stessi.SUB. CONSOL.242
LA DESCRIZIONE DEL SUOLOSUB. CONSOL.MAI203MAI204MAI205MAI206MAI207MAV000MAV100MAV101MAV102MAV103MAV104MAV105MAV200MAV201MAV202MAV203MAV300243Peridotite: roccia plutonica basica costituita da olivina (spesso alterata in serpentino) epirosseno; ha struttura granulare i<strong>di</strong>omorfa e è <strong>di</strong> colore nerastro, verde molto scuro.Pirossenite: roccia intrusiva fortemente basica costituita da un minerale del gruppo <strong>dei</strong>pirosseni, accompagnato da olivina, anfiboli e poco plagioclasio. A seconda delpirosseno presente si <strong>di</strong>vide ulteriormente (bronzite, <strong>di</strong>allagite, <strong>di</strong>opsi<strong>di</strong>te, iperstenite ewebsterite).Diabase: roccia a composizione mineralogica identica a quella <strong>dei</strong> gabbri, masussistenti in giacitura filoniana o subvulcanica.Serpentiniti : originate da rocce ultrafemiche (composte essenzialmente <strong>di</strong> olivine,pirosseni e anfiboli), <strong>di</strong> colore verde, con serpentino, olivina, pirosseno, anfibolo emagnetite. La voce è presente anche nelle rocce metamorfiche a seconda del grado <strong>di</strong>metamorfismo locale e dell’interpretazione che ne viene data nei Fogli Geologici.Ofioliti: insieme <strong>di</strong> rocce eruttive e metamorfiche basso grado, derivate dallaricristallizzazione in ambiente ricco d’acqua <strong>di</strong> rocce ultrafemiche, da materialicostituenti sezioni del mantello superiore, <strong>di</strong> crosta oceanica o come intrusione nelleparti profonde della crosta continentale.Rocce effusive vulcaniche e subvulcaniche: sono rocce formatesi sulla superficieterrestre perché il magma è portato in superficie attraverso il fenomeno del vulcanismo;la rapi<strong>di</strong>tà del raffreddamento del magma impe<strong>di</strong>sce le reazioni <strong>di</strong> cristallizzazione conla conseguente formazione <strong>di</strong> una struttura porfirica, caratterizzata da una massa <strong>di</strong>fondo composta da minutissimi cristalli in cui sono inclusi pochi gran<strong>di</strong> cristalli benformati (fenocristalli)Rocce effusive acide: sono le rocce effusive soprassature che contengono unapercentuale <strong>di</strong> silice, libera o combinata, superiore al 65% in peso.Ossi<strong>di</strong>ana: vetro vulcanico che si forma con il rapido raffreddamento delle lave.Riolite (o liparite): roccia vulcanica ignea estrusiva corrispondente effusivo del granito,composta solitamente da quarzo, feldspato alcalino e plagioclasio (generalmenteoligoclasio) in rapporto <strong>di</strong> 1:2; a volte si possono trovare anche biotite e pirosseni. Èlargamente impiegata come pietra da costruzione, con il nome <strong>di</strong> porfido.Porfido: roccia vulcanica <strong>dei</strong> cosiddetti filoni in<strong>di</strong>fferenziati che contengonofenocristalli <strong>di</strong> feldspati alcalini; generalmente si fa seguire l’aggettivo della rocciaintrusiva <strong>di</strong> composizione corrispondente (porfido granitico, porfido sienitico, ecc.).Termine in <strong>di</strong>suso corrispondente alla riolite.Dacite: roccia effusiva <strong>di</strong> chimismo interme<strong>di</strong>o, corrispondente della <strong>di</strong>orite intrusiva;sono essenzialmente costituite da quarzo e feldspati, cui si accompagnano piccolequantità <strong>di</strong> minerali mafici (comunemente biotite, orneblenda e pirosseni).Trachite: roccia effusiva <strong>di</strong> composizione interme<strong>di</strong>a, corrispondente effusiva dellasienite.Rocce effusive interme<strong>di</strong>e: sono le rocce effusive che contengono una percentuale <strong>di</strong>silice, libera o combinata, tra il 65% ed il 52% in peso.Andesite: roccia effusiva <strong>di</strong> composizione interme<strong>di</strong>a, corrispondente della <strong>di</strong>oriteintrusiva.Latite: roccia effusiva <strong>di</strong> composizione interme<strong>di</strong>a, corrispondente effusiva dellamonzonite.Fonolite: roccia effusiva <strong>di</strong> composizione interme<strong>di</strong>a, corrispondente alle sieniti afeldspatoi<strong>di</strong> intrusive, a struttura porfirica con fenocristalli <strong>di</strong> nefelina, sani<strong>di</strong>no,ortoclasio, leucite, olivina e pirosseno (<strong>di</strong>opside) e massa <strong>di</strong> fondo <strong>di</strong> sani<strong>di</strong>no; il suocolore è grigio, verde.Rocce effusive basiche (o femiche) e ultrabasiche (o ultrafemiche): sono le rocceeffusive sottosature che contengono una percentuale <strong>di</strong> silice combinata (mancano ingenere <strong>di</strong> silice libera) inferiore rispettivamente al 52% o al 45% in peso.
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICIMAV301 Tefrite: roccia vulcanica basica; ha struttura porfirica con fenocristalli <strong>di</strong> augite(pirosseno), nefelina, leucite, sodalite e plagioclasio (bytownite) e massa <strong>di</strong> fondo <strong>di</strong>plagioclasio e leucite; il suo colore è grigio scuro.MAV302 Basalto: roccia vulcanica a struttura variabile (per lo più intersetale - struttura a cristalliallungati con orientazione a caso) con fenocristalli <strong>di</strong> olivina, plagioclasio (labradorite)e pirosseno (augite) e massa <strong>di</strong> fondo <strong>di</strong> plagioclasio (andesina); il suo colore è nero.MAV303 Basanite (tefriti oliviniche): sono tefriti contenenti olivina in quantità superiore al 5%in volume della roccia.MAV304 Foi<strong>di</strong>te: roccia sottosatura che contiene feldspatoi<strong>di</strong>.MAV305 Nefelinite: roccia effusiva mesocrate costituita essenzialmente da un pirosseno,comunemente augitico, e da un feldspatoide, che è comunemente da nefelina.MAV306 Leucitite: roccia effusiva mesocrate costituita essenzialmente da un pirosseno,comunemente augitico, e da un feldspatoide, che è comunemente leucite.MAP000 Rocce vulcaniche piroclastiche: rocce formate per il consolidamento <strong>di</strong> depositivulcanici piroclastici.MAP101 Cineriti: rocce formate per consolidamento <strong>di</strong> materiali piroclastici <strong>di</strong> <strong>di</strong>ametro 2 mm(generalmente fino a 30mm) e densità >2 g/cm 3 (lapilli), in matrice fine da scarsa adassente.MAP202 Agglomerati: rocce formate per consolidamento <strong>di</strong> materiali piroclastici <strong>di</strong> <strong>di</strong>ametro > 2mm arroton<strong>dati</strong> (bombe), in matrice fine da scarsa ad assente.MAP203 Brecce vulcaniche: rocce formate per consolidamento <strong>di</strong> materiali piroclastici <strong>di</strong><strong>di</strong>ametro > 2 mm a spigoli vivi (blocchi), in matrice fine da scarsa ad assente.MAP300 Surge consolidato: roccia formata per consolidamento <strong>di</strong> depositi da surge.ROCCE SEDIMENTARIESE0000 Rocce se<strong>di</strong>mentarie: rocce originatesi dall’accumulo e dalla <strong>di</strong>agenesi <strong>di</strong> se<strong>di</strong>menti <strong>di</strong>varia origine derivati dal <strong>di</strong>sfacimento ed erosione <strong>di</strong> rocce preesistenti.SE1000 Rocce se<strong>di</strong>mentarie clastiche: rocce formate dall’accumulo <strong>di</strong> detriti che nel tempo sisono consoli<strong>dati</strong>.SE1101 Conglomerato o ru<strong>di</strong>te: roccia costituita per più del 25% da granuli <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni >2mm.SE1102 Arenite: roccia costituita da granuli della classe granulometrica dominante delle sabbie,<strong>di</strong> qualsiasi origine e composizione.SE1103 Silcarenite a cemento siliceo: arenaria con un contenuto <strong>di</strong> granuli silicoclastici >50%ed a cemento siliceo.SE1104 Silcarenite a cemento calcareo: arenaria con un contenuto <strong>di</strong> granuli silicoclastici>50% ed a cemento calcareo.SE1105 Calcarenite: calcare detritico costituito prevalentemente (>>50%) da granulicarbonatici delle <strong>di</strong>mensioni comprese tra 1/16 e 2 mm; la matrice ed il cemento sonosolitamente <strong>di</strong> natura carbonatica.SE1106 Siltite: roccia costituita da granuli della classe granulometrica dominante del limo, <strong>di</strong>qualsiasi origine e composizione.SE1107 Argillite: roccia costituita da se<strong>di</strong>menti, cementati o sovraconsoli<strong>dati</strong>, con granuli dellaclasse granulometrica dominante dell’argilla.SE1108 Torbi<strong>di</strong>te: roccia costituita da se<strong>di</strong>menti depositati da correnti <strong>di</strong> torbida, generalmentea struttura gradata e ricchi <strong>di</strong> strutture se<strong>di</strong>mentarie estrerne.SE1109 Marna: roccia clastica o mista (clastico / chimiche) composte da argilla e carbonato <strong>di</strong>calcio in quantità comprese tra circa 35 e 65%.SUB. CONSOL.244
LA DESCRIZIONE DEL SUOLOSUB. CONSOL.SE1109A Argilla marnosa: roccia clastica o mista (clastico/chimiche) composta da argilla perl’85 e il 95% e la parte rimanente (15-5%) <strong>di</strong> carbonato <strong>di</strong> calcio.SE1109B Marna argillosa : roccia clastica o mista (clastico/chimiche) composta da argilla per65 e l’85% e la parte rimanente (35-15 %) <strong>di</strong> carbonato <strong>di</strong> calcio.SE1109C Marna calcarea : roccia clastica o mista (clastico/chimiche) composta da argilla percalcio per il 65 e l’85% e la parte rimanente (35-15 %) <strong>di</strong> argilla.SE1109D Calcare marnoso: roccia clastica o mista (clastico/chimiche) composta da argilla percalcio per l’85 e il 95% e la parte rimanente (15-5%) <strong>di</strong> argilla.SE1110 Calcare clastico (calciru<strong>di</strong>te): roccia costituita per più del 25% da granuli maggiori <strong>di</strong>2 mm, con composizione prevalente carbonatica (es. brecce legate ad ambienti <strong>di</strong>piattaforma carbonatica).SE1111 Diaspri: roccia silicea criptocristallina contenente resti <strong>di</strong> ra<strong>di</strong>olari, generalemnte <strong>di</strong>colore rosso o verde.SE1112 Lignite: carbone fossile <strong>di</strong> colore bruno contenente il 50-60% <strong>di</strong> carbonio e numerosicomposti organici, non ha subito un’intensa carbonizzazione ed è più recente dellalitantrace e dell’antracite.SE2000 Rocce se<strong>di</strong>mentarie <strong>di</strong> deposito chimico e organogene: rocce formate dall’accumulo<strong>di</strong> depositi consoli<strong>dati</strong> rispettivamente <strong>di</strong> sostanze minerali contenuti nell’acqua o <strong>di</strong>resti <strong>di</strong> animali e vegetali.SE2100 Rocce se<strong>di</strong>mentarie <strong>di</strong> deposito chimico precipitativo: rocce formate dall’accumulo<strong>di</strong> depositi consoli<strong>dati</strong> <strong>di</strong> sostanze minerali contenuti nell’acqua, in seguito a reazionichimiche favorite da particolari con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> temperatura e pressione.SE2101 Calcare: roccia se<strong>di</strong>mentaria costituita per la maggior parte da carbonato <strong>di</strong> calcio.SE2101A Calcare cavernoso: calcare a “cellette” legato a <strong>di</strong>ssoluzione <strong>di</strong> clasti carbonatici perdedolomitizzazione accompagnata da precipitazione <strong>di</strong> calcite <strong>di</strong> neoformazione invene.SE2101B Calcare oolitico e pisolitico: roccia se<strong>di</strong>mentaria costituita per la maggior parte daooliti e pisoliti, elementi rotondeggianti formati da un nucleo e da una serie <strong>di</strong> involucriconcentrici, <strong>di</strong> carbonato <strong>di</strong> calcio.SE2101C Calcare lacustre: calcare a grana fine, in genere biancastro, deposto da acque dolci inambiente lacustre.SE2101D Calcare dolomitico: calcare con una quantità <strong>di</strong> dolomite inferiore al 50%.SE2102 Travertino: roccia bianca o giallastra che formatasi presso sorgenti o cascate, contipico aspetto poroso dovuto alla putrefazione <strong>di</strong> resti vegetali inclusi nella roccia.SE2103 Dolomia: roccia se<strong>di</strong>mentaria costituita per la maggior parte da dolomite (carbonatodoppio <strong>di</strong> calcio e magnesio).SE2103A Dolomia calcarea: dolomia con una quantità <strong>di</strong> carbonato <strong>di</strong> calcio inferiore al 50%.SE2200 Rocce se<strong>di</strong>mentarie <strong>di</strong> deposito chimico evaporitico: rocce formate dall’accumulo <strong>di</strong>depositi consoli<strong>dati</strong> in seguito all’evaporazione dell’acqua in bacini chiusi.SE2201 Calcare evaporitico: calcare con una quantità <strong>di</strong> evaporiti inferiore al 50%.SE2202 Gesso e anidrite: rispettivamente solfato <strong>di</strong> calcio bi-idrato e sua trasformazione perper<strong>di</strong>ta d’acqua. In questa categoria si includono calcari gessosi, solfiferi, salgemma edaltri sali in quantità minore spesso associati.SE2203 Alite: corpi rocciosi la cui composizione principale è data da cloruro <strong>di</strong> so<strong>di</strong>o edeventualmente altri sali <strong>di</strong> natura evaporitica.SE2300 Rocce se<strong>di</strong>mentarie organogene: rocce formate dall’accumulo <strong>di</strong> resti <strong>di</strong> animali evegetali (gusci, scheletri o strutture organiche vegetali).SE2301 Calcare fossilifero: roccia composta principalmente da frammenti carbonatici <strong>di</strong>origine biologica.SE2302 Calcare selcifero: calcare con una quantità <strong>di</strong> selce inferiore al 50%.SE2303 Diatomite: massa pulverulenta bianca, lacustre o marina, formata da gusci <strong>di</strong> <strong>di</strong>atomee245
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICISE2304ME0000MES101MES102MES103MES104MES201MES301MES302MES303MEC201MEM101MEM102MEM103(vegetali unicellulari).Selce: rocce se<strong>di</strong>mentarie costituite da silice o concentrazioni silicee in noduli, bande eletti entro rocce <strong>di</strong> <strong>di</strong>versa composizione. La silice può essere sotto forma <strong>di</strong> opale,calcedonio o quarzo ed ha struttura da criptocristallina a microcristallina.ROCCE METAMORFICHERocce metamorfiche (o metamorfiti): rocce formate dall’azione del metamorfismo suse<strong>di</strong>menti e rocce preesistenti; in base al tipo litologico originario sono sud<strong>di</strong>vise inpara-metamorfiti (derivate da rocce se<strong>di</strong>mentarie) e orto-metamorfiti (derivate da rocceignee). Ulteriori sud<strong>di</strong>visioni considerano il tipo <strong>di</strong> metamorfismo (termico o <strong>di</strong>namico)ed i grado metamorfico (in base alla quale viene definita la facies metamorfica).Argilloscisti (tipo: ardesia o lavagna): rocce metamorfiche originate da roccese<strong>di</strong>mentarie pelitiche, con minerali argillosi, miche e quarzo, struttura scistosa, colorescuro e granulometria fine.Filla<strong>di</strong> (o filliti) e scisti sericitico- cloritici: rocce metamorfiche originate da roccese<strong>di</strong>mentarie pelitiche, con mica muscovite, ossi<strong>di</strong> <strong>di</strong> ferro e minerali <strong>di</strong> neoformazione(sericite e clorite), struttura scistosa, lucentezza sericea in superficie e granulometriafine.Micascisti: rocce metamorfiche originate da rocce se<strong>di</strong>mentarie pelitiche, conmuscovite e quarzo, struttura scistosa o fibrosa, colore scuro e granulometria da me<strong>di</strong>a agrossolana.Cornubianiti: rocce metamorfiche originate da rocce se<strong>di</strong>mentarie pelitiche, con albite,epidoto, cor<strong>di</strong>erite, andalusite e sillimanite, struttura non scistosa, colore grigio egranulometria fine.Quarziti : rocce metamorfiche originate da rocce se<strong>di</strong>mentarie arenitiche, con quarzo epoca muscovite, struttura non scistosa, colore chiaro e granulometria da me<strong>di</strong>a agrossolana e con minerali visibili.Calcescisti: rocce metamorfiche originate da rocce se<strong>di</strong>mentarie calcaree, con calcite,mica e quarzo, struttura scistosa, colore grigiastro e granulometria fine e minerali nonvisibili.Marmi: rocce metamorfiche originate da rocce se<strong>di</strong>mentarie calcaree, con calcite edolomite (ma possono essere presenti svariati altri minerali nelle venature), strutturanon scistosa, colore bianco, grigio venato, rosa, giallo grigiastro e granulometria dame<strong>di</strong>a a grossolana e minerali visibili.Scisti sericitico - cloritici calcarei: rocce metamorfiche originate da rocce se<strong>di</strong>mentariecalcaree, mica muscovite, ossi<strong>di</strong> <strong>di</strong> ferro e minerali <strong>di</strong> neoformazione (sericite e clorite)e calcite, struttura scistosa, lucentezza sericea in superficie, granulometria fine eminerali non visibili.Rocce calcisilicatiche (skarn): rocce metamorfiche originate da rocce se<strong>di</strong>mentariecalcaree ed, a partire dalle siltiti, contengogo calcite, e vari altri minerali (granati,pirosseno), struttura non scistosa, matrice chiara con inseriti minerali <strong>di</strong> vario colore,matrice <strong>di</strong> calcite fine, con gran<strong>di</strong> aggregati <strong>di</strong> minerali.Gneiss e gneiss occhia<strong>di</strong>no (paragneiss e ortogneiss): rocce metamorfiche originate darocce quarzo-feldspatiche, <strong>di</strong> colore grigio chiaro, con quarzo, feldspati e mica, scistoseo fibrose, granulometria me<strong>di</strong>a a grossolana, minerali visibili.Migmatiti (tipo: embrechiti, anteriti, agmatiti): rocce metamorfiche originate da roccequarzo-feldspatiche, <strong>di</strong> colore grigio chiaro, con quarzo, feldspati e mica, scistose ofibrose, deformate, granulometria me<strong>di</strong>a a grossolana, minerali visibili.Granuliti feldspatiche :rocce metamorfiche originate da rocce quarzo-feldspatiche, <strong>di</strong>colore grigio chiaro, con Ortoclasio, plagioclasio e quarzo, granuli separati da aggregatiquarzoso feldspatici in bande parallele, granulometria me<strong>di</strong>a a grossolana, mineralivisibili.246SUB. CONSOL.
LA DESCRIZIONE DEL SUOLOMEM104MEM105MEM201MEM202MEM203MEM204MEM205MEM301MET000MET001MET002Scisti bianchi e quarzo-scisti: rocce metamorfiche originate da rocce quarzofeldspatiche,<strong>di</strong> colore chiaro, con quarzo e feldspati, scistose o fibrose, granulometriame<strong>di</strong>a a grossolana, minerali visibili.Metagrovacche : rocce metamorfiche originate da rocce quarzo-feldspatiche, <strong>di</strong> colorechiaro, con quarzo e feldspati, non scistose, granulometria me<strong>di</strong>a a grossolana, mineralivisibili.Scisti ver<strong>di</strong> (prasiniti, cloritoscisti, talcoscisti): rocce metamorfiche originate da roccefemiche, <strong>di</strong> colore verde, con clorite, quarzo, magnetite; epidoto, anfibolo e talco,scistose o fibrose, granulometria me<strong>di</strong>a a grossolana, minerali visibili.Anfiboliti: rocce metamorfiche originate da rocce femiche, <strong>di</strong> colore scuro, conorneblenda e plagioclasio, non scistose, granulometria me<strong>di</strong>a a grossolana, mineralivisibili.Eclogiti: rocce metamorfiche originate da rocce femiche, <strong>di</strong> colore verde chiaro, biancoe rosso, con pirosseno, quarzo, cianite e rutilo, non scistose, granulometria fine eminerali non visibili.Metagabbri : rocce metamorfiche originate da rocce femiche, <strong>di</strong> colore verde chiaro,bianco, con pirosseno, plagioclasio <strong>di</strong> calcio, mica, lawsonite, albite, anfibolo e biotite,non scistose, granulometria me<strong>di</strong>a a grossolana, minerali visibili.Granuliti basiche: rocce metamorfiche originate da rocce femiche, <strong>di</strong> colore nero, conortoclasio, plagioclasio e pirosseno, granuli separati da aggregati quarzoso feldspatici inbande parallele, granulometria me<strong>di</strong>a a grossolana e minerali visibili.Serpentiniti e serpentinoscisti: rocce metamorfiche originate da rocce ultrafemiche(composte essenzialmente <strong>di</strong> olivine, pirosseni e anfiboli), <strong>di</strong> colore verde, conserpentino, olivina, pirosseno, anfibolo e magnetite, scistose o non scistose,granulometria fine e minerali non visibili.Rocce metamorfiche originate da rocce cataclastiche: rocce originate dametamorfismo cataclastico, detto anche tettonico o <strong>di</strong>namico, in quanto è causatodall'aumento <strong>di</strong> pressione in prossimità <strong>di</strong> zone <strong>di</strong> frattura o <strong>di</strong> faglia (aree tettoniche);interessa zone molto limitate.Brecce tettoniche (cataclasiti, brecce <strong>di</strong> frizione, miloniti, oficalciti) a cementocalcareo: rocce originate da metamorfismo cataclastico, a matrice chiara calcarea conall’interno frammenti <strong>di</strong> rocce metamorfiche <strong>di</strong> vario colore, non scistose e conframmenti spigolosi in matrice fine.Brecce tettoniche (cataclasiti, brecce <strong>di</strong> frizione, miloniti, oficalciti) a cemento siliceo:rocce originate da metamorfismo cataclastico, a matrice chiara silicea con all’internoframmenti <strong>di</strong> rocce metamorfiche <strong>di</strong> vario colore, non scistose e con frammentispigolosi in matrice fine.SUB. CONSOL.247
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICITermini relativi ai materiali genitori e substrati non consoli<strong>dati</strong>M. Paolanti, E. A. C. Costantini e M. Fantappiè, con il contributo del prof. Mauro Coltorti,Università <strong>di</strong> SienaIl seguente glossario <strong>dei</strong> termini relativi ai materiali genitori e substrati non consoli<strong>dati</strong> fariferimento alla tab. 4.15. “Co<strong>di</strong>fica del materiale genitore e <strong>dei</strong> substrati non consoli<strong>dati</strong>”, presentenel capitolo 4, relativo alla descrizione del suolo. Il glossario non riporta il significato <strong>di</strong> tutti itermini presenti nella tabella, tralasciando i più noti. Per questo glossario è stata usata la seguentebibliografia: Carnicelli et al., 2001; Shoeneberger et al., 2002.ACACSACPACCACTACFACBACRAMALDALCAFAFCAFPAFBAFHAFFAVDEPOSITI IN O DA ACQUESe<strong>di</strong>menti marini litoranei: termine generico per in<strong>di</strong>care se<strong>di</strong>menti deposti in ambientecostiero.Depositi <strong>di</strong> spiaggia: depositi tipici <strong>dei</strong> <strong>di</strong>versi microambienti costituenti il sistemaspiaggia (esclusi i cordoni), generalmente sabbiosi o più grossolani.Depositi <strong>di</strong> palude salmastra: depositi delle depressioni retrostanti o intervallate a dunelitoranee o cordoni. Normalmente dominati da limi o argille, possono talvolta essere piùgrossolani.Depositi <strong>di</strong> canale tidale: depositi vari in ambiente <strong>di</strong> canale tidale, o <strong>di</strong> marea.Depositi <strong>di</strong> piana tidale: depositi vari in ambiente <strong>di</strong> piana tidale, o <strong>di</strong> marea.Depositi <strong>di</strong> falesia o costa alta: depositi, normalmente grossolani, originati dallarielaborazione in ambiente marino <strong>dei</strong> prodotti gravitativi risultanti dell’erosione <strong>di</strong> unacosta rocciosa.Depositi cementati da carbonati: depositi cementati da carbonati, spesso sulla spiaggia(“panchina”, “beach rock”).Depositi cementati da sostanza organica e/o ossi<strong>di</strong>: depositi litoranei cementati dasostanza organica e ossi<strong>di</strong>, formatisi dall’interazione tra orizzonti illuviali molto profon<strong>di</strong>e falde salateSe<strong>di</strong>menti marini: termine generico per in<strong>di</strong>care se<strong>di</strong>menti deposti in ambiente marino.Fanghi <strong>di</strong>atomitici: depositi lacustri organogeni, da precipitazione <strong>di</strong> gusci (silicei) <strong>di</strong><strong>di</strong>atomee; si presentano come materiali molto fini, <strong>di</strong> colore chiaro, non reattivi all’acidocloridrico (chiamati anche “farina fossile”).Fanghi calcarei: depositi lacustri organogeni o misti, in genere qualsiasi depositolacustre limoso o più fine, ricco <strong>di</strong> calcare.Se<strong>di</strong>menti fluviali: termine generico per in<strong>di</strong>care se<strong>di</strong>menti deposti da acque incanalate.Depositi <strong>di</strong> canale: materiali tipici del letto <strong>di</strong> canali abbandonatiDepositi <strong>di</strong> piena ad alta energia: materiali soprattutto sabbiosi, ma anche piùgrossolani, tipici delle aree prossimali al canale in genere.Depositi <strong>di</strong> piena a bassa energia: materiali da argillosi a limoso-sabbiosi tipici dellearee <strong>di</strong> tracimazione, <strong>di</strong> ristagno e delle porzioni <strong>di</strong>stali <strong>di</strong> ventagli <strong>di</strong> rotta e argininaturali.Colmate: materiali simili ai depositi <strong>di</strong> piena a bassa energia, ma risultanti dall’azionedell’uomo, a scopo <strong>di</strong> bonifica idraulica.Depositi <strong>di</strong> conoide: se<strong>di</strong>menti a composizione rapidamente variabile e stratificazionecomplessa, tipici degli ambienti <strong>di</strong> conoide alluvionale; utilizzati sia nella categoriase<strong>di</strong>menti fluviali sia nella categoria depositi <strong>di</strong> versante per la <strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong> stabilire unlimite preciso.Depositi <strong>di</strong> versante: termine generico per in<strong>di</strong>care se<strong>di</strong>menti deposti da acqueprovenienti da versanti.248SUB. NON CONS.
LA DESCRIZIONE DEL SUOLOAVA Alluvioni <strong>di</strong> versante: depositi <strong>di</strong> versante da trasporto idraulico più o meno canalizzato.Si riconoscono soprattutto per avere evidenze <strong>di</strong> selezione granulometrica estratificazione; queste possono anche essere deboli, ma se riconosciute sono comunquein<strong>di</strong>catrici <strong>di</strong> trasporto idraulico.AVG Glacis d’accumulo * : depositi <strong>di</strong> versante <strong>di</strong> cui è impossibile identificare la natura,gravitativa o idraulica, o composti da una mescolanza inestricabile <strong>dei</strong> due tipi.DEPOSITI EOLICI (Non vulcanici)EOS Sabbie eoliche: deposito eolico con composizione granulometrica sabbiosaEOL Loess: deposito eolico con composizione granulometrica a limo grossolano dominante esabbia fine subdominante.EOF Deposito eolico fine: deposito eolico contenente significative quantità <strong>di</strong> argilla (secondoalcuni autori, oltre un quartile della <strong>di</strong>stribuzione granulometrica ha <strong>di</strong>mensioni 2 mm, debris flow) e CLT, colata <strong>di</strong> fango, con prevalenza<strong>di</strong> materiali fini (2 mm, mudflow).DEPOSITI ORGANICIDepositi organici generici: per la <strong>di</strong>stinzione tra materiali organici e minerali, ve<strong>di</strong> laSUB. NON CONS.* Ripetuto nei depositi prevalentemente gravitativi e nei depositi <strong>di</strong> versante; da usare esclusivamente nel caso in cui ilmodo <strong>di</strong> messa in posto sia ignoto; altrimenti usare colluvio o alluvioni <strong>di</strong> versante249
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICIOFOTDVDPDPCDPPDPSDPLDEDFDRREREDRESRECdefinizione <strong>di</strong> orizzonti organici.Fanghi lacustri organici: materiali organici generici depositati in ambiente lacustre,normalmente con contenuto minerale piuttosto elevato. In<strong>di</strong>cati sia tra i depositi organiciche tra i depositi lacustri.Torba: deposito organico <strong>di</strong> ambiente palustre, lacustre o lagunare.DEPOSITI VULCANICIDepositi vulcanici (tephra): termine generale per in<strong>di</strong>care frammenti <strong>di</strong> roccevulcaniche e lava, <strong>di</strong> qualsiasi <strong>di</strong>mensione, da inferiori ai 2 mm <strong>di</strong> <strong>di</strong>ametro fino a più <strong>di</strong>un metro, che vengono deposti nelle forme più svariate: eruzioni esplosive, risalita <strong>dei</strong>gas e colate laviche. Termine da usare quando manchi una identificazione più accurata.Depositi del vulcanismo esplosivo (piroclastico)Materiali <strong>di</strong> <strong>di</strong>ametro 2mmvescicolari, con densità > 2 g/cm 3 più scuri delle pomici.DPP3 Blocchi: depositi piroclasitici costituiti da frammenti <strong>di</strong> rocciavulcanica a spigoli vivi.DPP4 Bombe: depositi piroclasitici costituiti da frammenti <strong>di</strong> rocciavulcanica arroton<strong>dati</strong>.DPP5 Lapilli: depositi piroclasitici costituiti da frammenti <strong>di</strong> rocciavulcanica, con densità > 2 g/cm 3 .Depositi da surge: deposito <strong>di</strong> materiali piroclastici derivati da correnti ad alta velocità,caratterizzate da un alto rapporto gas/solido e con flusso essenzialmente turbolento; ingenerale sono costituiti da clasti che variano in <strong>di</strong>mensione da pochi micron a qualchecm, e possono contenere clasti balistici <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni anche metriche. Sonogeneralmente stratificati con sottili strati caratterizzati sovente da laminazione incrociatae con spessori variabili, hanno inoltre un grado variabile <strong>di</strong> classazione, mostrando ingenere un sorting migliore <strong>dei</strong> depositi da flusso, ma più scarso rispetto a quelli dacaduta.Lahar: deposito derivante dal trasporto idraulico catastrofico <strong>di</strong> depositi piroclastici noncementati; simile ad un mudflowDepositi del vulcanismo effusivo, colate lavicheDepositi del vulcanismo freato-magmatico: depositi <strong>di</strong> composizione caotica sul fondo<strong>di</strong> una caldera creata da una esplosione freato-magmatica, cioè caratterizzata da gas,vapore acqueo misto a materiali vulcanici; depositi tipici <strong>dei</strong> vulcani laziali.Depositi piroclastici rimaneggiati da processi fluviali, lacustri o mariniMATERIALI NON TRASPORTATIResiduo: prodotti del <strong>di</strong>sfacimento, fisico o chimico, <strong>di</strong> substrati consoli<strong>dati</strong> o meno, infasi precedenti la pedogenesi vera e propria. Da utilizzare in tutti i casi in cui si ritiene ilsuolo <strong>di</strong>rettamente derivato dal substrato.Detrito in posto: prodotto del <strong>di</strong>sfacimento, prevalentemente fisico, <strong>di</strong> substraticonsoli<strong>dati</strong> o meno, in fasi precedenti la pedogenesi vera e propria; non ha subitosignificativi processi <strong>di</strong> trasporto. Ad esempio, grus.Saprolite: prodotto dell’alterazione prevalentemente chimica <strong>di</strong> substrati, consoli<strong>dati</strong> omeno; privo <strong>di</strong> struttura ma può presentare figure pedogenetiche. Spesso caratterizzato daper<strong>di</strong>ta completa delle caratteristiche meccaniche del substrato, conservandone però lestrutture (stratificazione, elementi grossolani).Residuo <strong>di</strong> <strong>di</strong>ssoluzione: materiale fine (
LA DESCRIZIONE DEL SUOLODADAADAUDARDACDAIcalcari. Il contributo <strong>di</strong> depositi eolici e/o vulcanici e colluviali può essere importante,ma può essee <strong>di</strong>fficilmente identificabile in campagna.MATERIALI DIVERSIDepositi antropici: depositi originati dall’attività dell’uomoRiporti <strong>di</strong> terra a fini agricoli: materiali accumulati da azioni deliberate, finalizzate ascopi agricoli, come livellamenti, terrazzamenti e simili.Riporti <strong>di</strong> terra a fini non agricoli: come sopra, ma a fini non agricoli.Rifiuti: materiali accumulati a scopo <strong>di</strong> smaltimento, anche quando riutilizzati neltempo.Inerti <strong>di</strong> cava: materiali accumulati come scarti <strong>di</strong> coltivazione <strong>di</strong> cave <strong>di</strong> inerti.Scarti <strong>di</strong> miniera o industriali: materiali accumulati come scarti <strong>di</strong> coltivazione <strong>di</strong>miniere o <strong>di</strong> lavorazioni industriali.SUB. NON CONS.251
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICIPEDOL./INF.Principali termini <strong>pedologici</strong> ed informaticiE. A. C. Costantini, M.Paolanti, M. Fantappiè, G. L’AbatePer questo glossario è stata usata la seguente bibliografia: Finke et al., 1999; Soil Survey Staff,1993; Soil Survey Staff, 1999.Accuratezza: assenza <strong>di</strong> errori sistematici. L'accuratezza posizionale è il grado <strong>di</strong> affidabilità nelposizionamento <strong>di</strong> linee e punti sulla carta. Molti fattori influenzano l'accuratezza con cui glielementi geografici possono essere <strong>di</strong>segnati su una carta: la scala <strong>di</strong> apposizione, la qualitàdella fonte <strong>dei</strong> <strong>dati</strong>, eventuali errori nella conversione <strong>dei</strong> sistemi <strong>di</strong> riferimento, ecc..Arco: elemento lineare archiviato in formato vettoriale costituito da una coppia <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>nated'inizio (nodo iniziale) , una coppia <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>nate finali (nodo finale) e da una serie <strong>di</strong> coppie<strong>di</strong> coor<strong>di</strong>nate interme<strong>di</strong>e dette vertici. Ogni arco ha una <strong>di</strong>rezione ed una lunghezza. Unendopiù archi fra loro tramite i no<strong>di</strong> è possibile costruire <strong>dei</strong> grafi utilizzabili, ad esempio, permolti tipi <strong>di</strong> analisi (stradale, idrografica, ecc.).Attributo: informazione descrittiva associata ad un oggetto geografico e che lo caratterizza.Generalmente nei GIS in<strong>di</strong>ca le caratteristiche non grafiche dell'elemento o quelle grafichenon rappresentabili nella scala d'acquisizione. Ad esempio potrebbero essere attributi <strong>di</strong> unelemento lineare (arco) in transito, la larghezza, ecc. (ve<strong>di</strong> tabella <strong>di</strong> attributi).Banca <strong>dati</strong> geografica: banca <strong>dati</strong> dove vengono archiviate le delineazioni cartografiche e i relativiattributi.Banca <strong>dati</strong> pedologica: banca <strong>dati</strong> dove vengono archiviate le informazioni sui suoli e relativeelaborazioni.Carattere ambientale: termine generico usato in riferimento a un tematismo dell’ambiente naturaleed antropico (es. pendenza, quota, esposizione, suoli, litologia, morfologia, vegetazione, usodel suolo, sistemazioni idrauliche, tipo ed intensità degli inse<strong>di</strong>amenti ecc.).Caratteri e qualità del suolo: tutti quei caratteri e qualità dell’osservazione pedologica che sirilevano in una indagine pedologica e che possono essere utilizzati come criteri per lacorrelazione, in particolare: morfologia, substrato, uso del suolo, pendenza, quota, falda,drenaggio interno ed esterno, erosione, profon<strong>di</strong>tà utile, <strong>dati</strong> analitici del suolo, classificazionee capacità d’uso. Sono caratteri e qualità funzionali alla correlazione quelli che ilcorrelatore ha considerato come determinanti nella creazione <strong>di</strong> determinate unità tipologiche<strong>di</strong> suolo e relative sottounità tipologiche <strong>di</strong> suolo.Carta geografica: una carta geografica è una rappresentazione grafica <strong>di</strong> elementi geografici o altrifenomeni spaziali (laghi, fiumi, strade, città) che fornisce due tipi <strong>di</strong> informazioni circa l'arearappresentata: la posizione e l'aspetto. La posizione consente <strong>di</strong> capire dov'è un particolareelemento geografico sulla superficie della terra e quali sono le sue relazioni con gli altrielementi. L'aspetto illustra sia le caratteristiche qualitative (nome, tipo) che quelle quantitative(area, lunghezza) dell'elemento rappresentato. Ciascuna carta geografica presenta, oltre alleinformazioni spaziali e descrittive, alcune caratteristiche tecniche che la definiscono e nedeterminano l'uso. Tali caratteristiche includono la scala, l'accuratezza, il sistema <strong>di</strong>proiezione, il sistema <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>nate.Cartografia <strong>di</strong> base: è l'insieme delle carte che riguardano un certo territorio, costruite contecniche topografiche e fotogrammetriche, che rappresentano le planimetrie (corsi d'acqua,strade, ferrovie, ponti, case, ecc.) e l'altimetria composta da punti quotati o curve <strong>di</strong> livello.Cartografia <strong>di</strong>gitale: nella versione <strong>di</strong>gitale <strong>di</strong> una carta geografica tra<strong>di</strong>zionale, la posizione e ladescrizione degli elementi sono memorizzate in una serie <strong>di</strong> file su computer. Per in<strong>di</strong>viduarela posizione degli elementi geografici è utilizzato un sistema <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>nate cartesiane x,y ox,y,z: ogni punto è rappresentato con una singola coppia <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>nate x,y; ogni linea èmemorizzata come una serie or<strong>di</strong>nata <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>nate x,y; ogni area è memorizzata come una252
PEDOL./INF.LA DESCRIZIONE DEL SUOLO253serie or<strong>di</strong>nata <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>nate x,y che definiscono i segmenti perimetrali della figura chiusa. Conle coor<strong>di</strong>nate x,y è possibile rappresentare punti, linee e poligoni come liste <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>nate,invece che come un <strong>di</strong>segno. Nella maggior parte <strong>dei</strong> casi, la memorizzazione degli elementigeografici utilizza coor<strong>di</strong>nate del mondo reale: queste coor<strong>di</strong>nate rappresentano unalocalizzazione reale sulla superficie della terra, in uno <strong>dei</strong> tanti sistemi <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>nate. Lerelazioni tra elementi geografici sono espresse, su una carta <strong>di</strong>gitale, con l'uso della topologia.Le caratteristiche degli elementi geografici sono memorizzate nel computer in un file, dettogeneralmente tabella, come set <strong>di</strong> numeri e caratteri.Componenti territoriali: combinazioni <strong>di</strong> morfologia, litologia ed uso suolo presenti all’interno <strong>di</strong>ogni poligono, in<strong>di</strong>viduate come attribuzioni semantiche e prive <strong>di</strong> una geografia definita(eccettuato che per il caso degli elementi territoriali). La definizione si realizza in formain<strong>di</strong>pendente e con legende specifiche per ogni livello pedogeografico.Contenitori pedogeografici: termine usato per definire la geografia <strong>dei</strong> pedopaesaggi, cioè lerelative delineazioni cartografiche. Vengono definiti <strong>di</strong> terre quando l’informazione sui suoli ègenerica ed è trattata come descrivente all’interno della banca <strong>dati</strong> geografica, come<strong>pedologici</strong> (eccettuato il caso delle regioni pedologiche) quando l’informazione sui suoli èorganizzata in una banca <strong>dati</strong> pedologica collegata alla banca <strong>dati</strong> geografica.Correlazione pedologica: attività volta al collegamento e raggruppamento <strong>di</strong> <strong>dati</strong> <strong>pedologici</strong>puntuali con caratteristiche simili e presenti in ambienti simili, in riferimento al livellogeografico <strong>di</strong> interesse, che ha come risultato la creazione <strong>di</strong> unità e sottounità tipologiche <strong>di</strong>suolo.Curva <strong>di</strong> livello: è l'insieme <strong>di</strong> linee a quota costante che descrivono l'andamento planimetrico delterreno ottenute generalmente per interpolazione manuale o automaticamente a partire da unTIN, un DEM o un DTM.DEM (Digital Elevation Model) : è un modello <strong>di</strong> <strong>dati</strong> raster che rappresenta l'elevazione delterreno. Può essere generato a partire da piani quotati o da curve <strong>di</strong> livello ed è generalmenteutilizzato per condurre analisi <strong>di</strong> visibilità, generare profili longitu<strong>di</strong>nali, effettuare analisi <strong>di</strong>pendenza e <strong>di</strong> esposizione, cliviometrie, ecc.Delineazione cartografica: area chiusa da una linea in una carta tematica ed avente una sigla <strong>di</strong>riferimento in legenda (ve<strong>di</strong> anche: unità cartografica).Descrivente: carattere ambientale che viene utilizzato per descrivere una delineazione o una unitàcartografica, ma non per in<strong>di</strong>viduare delineazioni cartografiche <strong>di</strong>verse.Digitale: un dato <strong>di</strong>gitale è un'informazione esprimibile me<strong>di</strong>ante numeri interi che è possibilememorizzare su un supporto magnetico.Discriminante: carattere ambientale che viene utilizzato per sud<strong>di</strong>videre l’area <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o indelineazioni e unità cartografiche <strong>di</strong>verse. Può essere o no utilizzato per l’apposizione <strong>dei</strong>limiti geografici.Elementi territoriali: sono allo stesso tempo sia componenti territoriali delle unità <strong>di</strong> terre, chepedopaesaggi dotati <strong>di</strong> una propria geografia e in<strong>di</strong>viduabili alla scala <strong>di</strong> dettaglio (in genere1:10.000).Fase <strong>di</strong> serie: definizione della Soil Taxonomy (Soil Survey Staff, 1999) data per in<strong>di</strong>care lesingole "faccette" geografiche e "sfaccettature" applicative in cui si articola una serie <strong>di</strong> suoli.Le fasi non in<strong>di</strong>viduano importanti <strong>di</strong>fferenze <strong>di</strong> paesaggio rispetto a quello della serie a cuiappartengono, così come non se ne <strong>di</strong>stinguono a livello tassonomico (confronta con:variante <strong>di</strong> serie). La definizione <strong>di</strong> fase può essere usata nella metodologia del presentemanuale solo per la definizione delle sottounità tipologiche <strong>di</strong> suolo definite al livello <strong>di</strong>dettaglio.Fattori o agenti della morfogenesi: forze endogene (sismica, vulcanica, bra<strong>di</strong>sismo), roccia, clima,organismi (incluso l'uomo), durata ed intensità <strong>dei</strong> processi.Fattori della pedogenesi (detti anche "fattori <strong>di</strong> stato"): roccia, clima, organismi (inclusol'uomo), morfologia, tempo.
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICIPEDOL./INF.Fisiografia o natura della forma: aspetto che la superficie terrestre assume in seguito all'operadegli agenti della morfogenesi.Fotointerpretazione: tecnica che consente ad esperti <strong>di</strong> determinare e classificare fenomeniterritoriali dalla lettura <strong>di</strong> foto aeree o immagini telerilevate, quali ad esempio, tipi <strong>di</strong>vegetazione, determinazione <strong>di</strong> faglie o aggiornamento <strong>di</strong> basi cartografiche esistenti.Gauss-Boaga: è un sistema <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>nate in proiezione cilindrica inversa, tipicamente utilizzato perla cartografia del territorio in Italia (IGMI, Catasto, Carte Tecniche Regionali, ecc.).Geografia del suolo: se per suolo si intende l’osservazione pedologica puntuale allora la suageografia si determina per mezzo della definizione del poligono <strong>di</strong> appartenenza geografica edella componente territoriale <strong>di</strong> appartenenza semantica. Se per suolo, invece, si intende unadeterminata unità o sottounità tipologica, allora la geografia del suolo sono gli elementidescrittivi della sua presenza, frequenza, posizione e limiti all'interno <strong>di</strong> un pedopaesaggio.Georeferenziare o georiferire: procedura software che consiste nel posizionare, me<strong>di</strong>ante punti acoor<strong>di</strong>nate note (punti <strong>di</strong> controllo), <strong>dati</strong> vettoriali o un'immagine raster nella rispettiva zonadel territorio reale, secondo un determinato sistema <strong>di</strong> riferimento.Gerarchia <strong>dei</strong> pedopaesaggi: organizzazione <strong>dei</strong> pedopaesaggi su <strong>di</strong>versi livelli <strong>di</strong>generalizzazione caratterizzati da una <strong>di</strong>versa scala. Ogni pedopaesaggio <strong>di</strong> livello inferiore èlegato a quelli superiori da attribuzioni semantiche.GIS (Geographical lnformation System) : un insieme complesso <strong>di</strong> componenti hardware, software,umane ed intellettive per acquisire, processare, analizzare, immagazzinare e restituire informa grafica ed alfanumerica <strong>dati</strong> riferiti ad un territorio.GPS (Global Positioning System): è un sistema che consente, per mezzo <strong>di</strong> un ricevitore, unsoftware de<strong>di</strong>cato e una costellazione <strong>di</strong> satelliti, <strong>di</strong> determinare la posizione al suolo el'altimetria <strong>di</strong> un punto con una precisione che varia da pochi millimetri ad alcuni metri infunzione del tipo <strong>di</strong> apparecchiatura e delle procedure operative <strong>di</strong> rilievo.GRID: è il nome dell'estensione <strong>di</strong> ARC/INFO della ESRI che elabora database in formato raster edè utilizzato anche per definire il corrispondente formato <strong>di</strong> <strong>dati</strong>.Immagine raster: qualsiasi immagine può essere pensata come formata da un insieme <strong>di</strong> piccolearee uguali (pixel), or<strong>di</strong>nate secondo linee e colonne, tali da costituire una matrice. I valoriassociati ad ogni cella possono esprimere sia informazioni <strong>di</strong> tipo grafico (colore, tono <strong>di</strong>grigio, ecc.), sia <strong>di</strong> tipo descrittivo (temperatura, pendenza, ecc.).Incertezza dell'informazione pedologica: grado <strong>di</strong> approssimazione nel fornire informazioni realiriguardo il tipo, il numero e la <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> suoli presenti in una delineazione o in unaunità cartografica, la accuratezza <strong>dei</strong> limiti geografici, la confidenza della classificazionetassonomica, l'attribuzione delle qualità, la valutazione delle attitu<strong>di</strong>ni e limitazioni d'uso.In<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> determinazione dell'incertezza: in<strong>di</strong>ci che forniscono una stima quantitativa, semiquantitativao qualitativa dell'incertezza dell'informazione pedologica tipologica e/ocartografica e/o della valutazione. Ad esempio:− In<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> atten<strong>di</strong>bilità, funzione dell'incertezza presente nella relazione tra suoli ecaratteri del paesaggio in cui si ritrovano, che esprime per ogni delineazionel’atten<strong>di</strong>bilità della reale presenza <strong>dei</strong> suoli in<strong>di</strong>cati;− In<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> purezza, funzione del contenuto in suoli in<strong>di</strong>cati in ogni delineazione o unitàcartografica, viene generalmente espresso come percentuale;− Grado <strong>di</strong> definizione delle tipologie pedologiche, in<strong>di</strong>ce della qualità delle tipologiepedologiche che <strong>di</strong>pende da vari fattori: dall’intensità del <strong>rilevamento</strong>, dalla conoscenzadell’ambiente e delle relazioni funzionali tra i suoli in ogni ambiente, della variabilitànaturale intrinseca all’interno degli stessi ambienti <strong>pedologici</strong>. Sulla base del loro grado<strong>di</strong> definizione le unità tipologiche <strong>di</strong> suolo vengono definite come generiche, tentative,poposte e stabilite;− Grado <strong>di</strong> relazione fra le osservazioni pedologiche e le sottounità tipologiche <strong>di</strong>suolo, in<strong>di</strong>ce che definisce il livello <strong>di</strong> appartenenza <strong>di</strong> ogni osservazione pedologica ad254
PEDOL./INF.LA DESCRIZIONE DEL SUOLO255una determinata sottounità tipologica <strong>di</strong> suolo per cui le osservazioni vengono attribuitecome caposaldo, tipiche, rappresentative e correlate.Lambert: è una proiezione conica che può essere conforme o equivalente, particolarmenteutilizzata negli U.S.A. dal Geological Survey, in Italia e in Francia.Latitu<strong>di</strong>ne: ve<strong>di</strong> proiezione geografica.Layer: ve<strong>di</strong> strato informativo geografico.Longitu<strong>di</strong>ne: ve<strong>di</strong> proiezione geografica.Livello <strong>di</strong> generalizzazione o <strong>di</strong> dettaglio (ve<strong>di</strong> anche "modello <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione <strong>dei</strong> suoli"):grado <strong>di</strong> generalizzazione <strong>di</strong> un carattere o processo ambientale. Un esempio <strong>di</strong> <strong>di</strong>versi livelli<strong>di</strong> generalizzazione, nell'ambito dell'uso del suolo, può essere: erba me<strong>di</strong>ca → pratiavvicen<strong>dati</strong> irrigui → seminativi irrigui → seminativi → terreni agricoli.Per quanto riguarda lo stu<strong>di</strong>o <strong>dei</strong> processi, un esempio relativo a quelli geomorfologici ed inparticolare alle acque incanalate può essere: a scala <strong>di</strong> dettaglio, versante inciso da gullies, alminor dettaglio, terrazzo alluvionale, a dettaglio ancora inferiore, pianura alluvionale.Un esempio concreto, riferito alla pianura padana veronese, è il seguente: i suoli nei campi(cioè al grande dettaglio, 1:2.000-5.000) variano essenzialmente a seconda dell'idrologia edelle opere dell'uomo, a livello un po' più elevato (dettaglio, 1:10.000-20.000) si percepiscecome la litologia delle <strong>di</strong>verse alluvioni <strong>di</strong>stingua le sequenze evolutive <strong>dei</strong> suoli, ma se sipassa a livello comprensoriale (ad esempio 1:25.000-50.000) ciò che <strong>di</strong>scriminaprincipalmente le associazioni <strong>di</strong> suoli è la fisiografia (terrazzo, paleoalveo, alveo, dosso,ecc.). Se poi si vuole ulteriormente generalizzare, ad esempio a scala 1:100.000-1:250.000, isuoli si <strong>di</strong>stribuiscono in funzione della combinazione tra forme (più o meno drenanti, più omeno conservate) e litotipi dominanti (più o meno sabbiosi, più o meno torbosi); alriconoscimento (1:500.000-1:1.000.000) le forme spariscono ed è la litologia dominante, cioènon quella imputabile ai singoli eventi alluvionali, bensì alla moda dell'insieme <strong>di</strong> essi inperio<strong>di</strong> geologici <strong>di</strong>versi, cui corrispondono associazioni <strong>di</strong> tipologie pedologiche <strong>di</strong>verse(suoli su sabbie e ghiaie prevalenti, suoli su sabbie, limi e torbe). A livello <strong>di</strong> sintesi infine(1:5.000.000-1:10.000.000) rimane solo la morfologia dominante, la pianura alluvionale, cheabbraccia tutti i suoli in essa presenti.Materiale genitore: detto anche materiale parentale o substrato pedogenetico. Si intende ilmateriale non consolidato (incoerente, debolmente coerente, pseudocoerente od anchecoerente, se la cementazione è <strong>di</strong> origine pedogenetica) da cui il suolo deriva.Metodo ascendente: il raggruppamento e la generalizzazione <strong>di</strong> informazioni pedologiche,acquisite e spazializzate ad un maggior dettaglio, in aree <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni più gran<strong>di</strong>,appartenenti a pedopaesaggi <strong>di</strong> livelli gerarchici superiori.Metodo <strong>di</strong>scendente: l'analisi del paesaggio pedologico per approssimazioni successive, scendendoda livelli gerarchici più elevati, cioè a minor dettaglio, a livelli via via <strong>di</strong> maggior dettaglio eminore generalizzazione.Modello <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione <strong>dei</strong> suoli (ve<strong>di</strong> anche "livello <strong>di</strong> generalizzazione"): descrizione <strong>di</strong>come variano i suoli a seconda delle variazioni <strong>dei</strong> fattori <strong>di</strong> stato. Il pedologo deve essere ingrado <strong>di</strong> riconoscere ed esplicitare le variazioni <strong>dei</strong> fattori che operano a grande scala daquelle che operano a scala più piccola.Morfologia: tipo, intensità e <strong>di</strong>namica degli agenti della morfogenesi.Morfometria: forma e <strong>di</strong>mensione delle forme della superficie terrestre.Mosaicatura: è l'insieme <strong>di</strong> operazioni che, in ambito GIS, consente <strong>di</strong> unire tra loro più mappe informato <strong>di</strong>gitale per realizzare una continuità territoriale.Nodo: è un punto con caratteristiche topologiche che descrive l'inizio o la fine <strong>di</strong> un arco.Orizzonti funzionali: L’orizzonte funzionale è uno strato <strong>di</strong> suolo dato dall’accorpamento o dallasud<strong>di</strong>visione <strong>di</strong> orizzonti genetici effettuata sulla base <strong>di</strong> caratteri funzionali, in grado cioè <strong>di</strong>con<strong>di</strong>zionare la gestione e la risposta all’uso del suolo. Ad esempio, i vigneti e i meletiinerbiti del Trentino hanno un Ap1 (<strong>di</strong> solito 0-10 cm) funzionalmente (attività biologica,
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICIPEDOL./INF.sostanza organica, elementi nutritivi, metalli pesanti) ben <strong>di</strong>verso dall’Ap2 (10-30 cm), <strong>di</strong>solito realizzato con l’aratura e solo saltuariamente interessato da lavorazioni profonde qualila <strong>di</strong>scissura. Allo stesso modo, per altre tipologie <strong>di</strong> suoli può avere senso unire orizzontigenetici simili dal punto <strong>di</strong> vista gestionale, ad esempio: orizzonte cambico Bw e orizzonti <strong>di</strong>transizione BA e BC; orizzonti C e CB. I cambiamenti tra gli orizzonti funzionali dovrebberosegnalare un cambio significativo in con<strong>di</strong>zioni fisico - strutturali importanti per la ritenzioneidrica e il drenaggio, oppure chimiche, quali accumulo <strong>di</strong> sali.Osservazione pedologica: osservazione <strong>di</strong> campagna volte a riconoscere la natura del suolo in undeterminato sito. Sono ricondotte a quattro tipologie principali: profilo <strong>di</strong> suolo, trivellata,pozzetto o minipit, osservazione superficiale o spe<strong>di</strong>tiva.Osservazione spe<strong>di</strong>tiva o superficiale: è spesso una descrizione spe<strong>di</strong>tiva <strong>di</strong> sezioni naturali oartificiali, oppure una descrizione <strong>di</strong> situazioni <strong>di</strong>sturbate che possono però dare informazionirelative ad alcune caratteristiche o proprietà del suolo (verifica <strong>di</strong> processi pedogenetici inorizzonti profon<strong>di</strong> o sepolti, caratteristiche <strong>dei</strong> substrati, ecc.).Osservazione correlata: si intende ogni osservazione (profilo, pozzetto o trivellata), corredata omeno da analisi del suolo, che anche per un solo carattere o qualità funzionale alla correlazionedevia rispetto al valore me<strong>di</strong>o del sito modale per ≥3σ.Osservazione rappresentativa: si intende ogni osservazione (profilo, pozzetto o trivellata),corredata o meno da analisi del suolo, i cui caratteri e qualità funzionali alla correlazionerientrano tutti nel range <strong>di</strong> variabilità per
PEDOL./INF.LA DESCRIZIONE DEL SUOLO257hanno una configurazione caratteristica, percepibile dall’osservatore, con <strong>di</strong>verso livello <strong>di</strong>generalizzazione in corrispondenza delle <strong>di</strong>verse scale <strong>di</strong> <strong>rilevamento</strong>. Esiste, cioè, unagerarchia <strong>di</strong> pedopaesaggi. Nel pedopaesaggio vi è una certa probabilità <strong>di</strong> incontrare suolisimili, in <strong>di</strong>pendenza della omogeneità <strong>dei</strong> fattori della pedogenesi relativa alla scala <strong>di</strong>riferimento.Pixel: contrazione <strong>di</strong> “picture element”, è il componente elementare <strong>di</strong> un’immagine rastercaratterizzato da un valore associato.Poligono: termine usato nel linguaggio GIS per in<strong>di</strong>care un'area con degli attributi memorizzati, èequivalente al termine delineazione presente nel linguaggio pedologico tra<strong>di</strong>zionale.Polypedon: unione <strong>dei</strong> pedon i cui fattori della pedogenesi sono così simili da far sì che lecaratteristiche morfologiche e funzionali <strong>dei</strong> pedon ricadano in specifici campi <strong>di</strong> variazione(range).Pozzetto o minipit : consiste in uno scavo profondo 50-70 cm e largo circa 100 cm. Questatipologia <strong>di</strong> osservazione è utile per per indagare ambiti ove non sia possibile effettuare scavicon mezzi meccanici (accesso <strong>di</strong>fficoltoso, ambiti tutelati ecc.). Partendo dal fondo delloscavo altre informazioni possono essere acquisite tramite trivella manuale.Proiezione: ve<strong>di</strong> sistema <strong>di</strong> proiezione. Proiezione geografica: è un sistema <strong>di</strong> proiezione globale,utilizzato storicamente per primo, basato sulla sud<strong>di</strong>visione della terra in meri<strong>di</strong>ani e paralleli.Il suo sistema <strong>di</strong> riferimento, latitu<strong>di</strong>ne/longitu<strong>di</strong>ne, misura le <strong>di</strong>stanze angolari partendorispettivamente dal piano <strong>di</strong> riferimento dell’equatore e da quello del meri<strong>di</strong>ano <strong>di</strong> Greenwich.Profilo caposaldo: quel profilo pedologico che viene utilizzato come riferimento ai fini <strong>di</strong>vulgativi<strong>di</strong> una determinata sottounità tipologica <strong>di</strong> suolo. Viene selezionato tra i profili tipici edesprime pienamente l’insieme <strong>dei</strong> suoli della STS e/o possiede una larga documentazionebibliografica/analitica.Profilo <strong>di</strong> suolo: si intende uno scavo <strong>di</strong> adeguate <strong>di</strong>mensioni e profon<strong>di</strong>tà, utile per descrivere lamorfologia derivante dallo sviluppo genetico-evolutivo del suolo e per prelevare campioni perle analisi <strong>di</strong> laboratorio. Il profilo è una sezione verticale che può essere concepita sia comeun piano verticale ad angolo retto con la superficie, sia come la faccia verticale <strong>di</strong> unparallelepipedo ideale, il “pedon”, composto da una sequenza <strong>di</strong> orizzonti risultantidall’evoluzione pedogenetica e che rappresenta la minima unità ideale <strong>di</strong> campionamento(Soil Survey Staff, 1993).Profilo modale: profilo caratterizzato dai valori modali, me<strong>di</strong> e deviazioni standard, <strong>dei</strong> valori delleosservazioni pedologiche afferenti alla STS (sottounità tipologica <strong>di</strong> suolo).Province <strong>di</strong> terre: contenitori pedogeografici <strong>di</strong> terre in<strong>di</strong>viduati e riconoscibili ad una scaladell’or<strong>di</strong>ne dell’1:1.000.000. Corrispondono alle soil sub-regions definite a livello europeo. Sidefiniscono come pedologiche quando l’informazione sui suoli è organizzata in una banca<strong>dati</strong> pedologica collegata alla banca <strong>dati</strong> geografica.Punto: elemento geometrico utilizzato per definire la posizione <strong>di</strong> elementi che nella scala <strong>di</strong>acquisizione sono puntiformi, definito da una coppia <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>nate (x,y) ed eventualmente dauna quota (z).Punto <strong>di</strong> controllo: un punto <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>nate note riconoscibile sull’immagine o carta che si vuolegeoreferenziare. Normalmente gli algoritmi <strong>di</strong> georeferenziazione richiedono più punti <strong>di</strong>controllo (almeno quattro) per ciascun foglio.Raster: Ve<strong>di</strong> immagine raster.Rasterizzazione: operazione che consente in modo automatico <strong>di</strong> ricavare un’ immagine raster apartire da <strong>dati</strong> vettoriali o da documenti cartacei (scanner).Regioni pedologiche: contenitori pedogeografici <strong>di</strong> terre in<strong>di</strong>viduati e riconoscibili ad una scaladell’or<strong>di</strong>ne dell’1:5.000.000. L’informazione sui suoli è sempre generica ed è trattata comedescrivente all’interno della banca <strong>dati</strong> geografica. Corrisponde essenzialmente al significatoche viene dato al termine inglese soil region, utilizzato nella metodologia per la costruzionedella banca <strong>dati</strong> europea (Finke et al., 1999).
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICIPEDOL./INF.Relazioni pedologiche funzionali: funzionalità <strong>di</strong> carattere <strong>di</strong>verso (fisico, chimico, biologico,umano) che legano i suoli all'interno <strong>di</strong> un pedopaesaggio. Possono variare a seconda dellafinalità del <strong>rilevamento</strong>, della scala <strong>di</strong> indagine e dell'ambiente stu<strong>di</strong>ato. In un'area collinare,ad esempio, le relazioni funzionali tra suoli possono essere espresse, alla scala del grandedettaglio, dagli scambi <strong>di</strong> energia e <strong>di</strong> materia, in particolare dai flussi idrici e dai processierosivi. Nello stesso ambiente, a minor dettaglio, le relazioni funzionali tra i suoli <strong>di</strong> unpedopaesaggio possono essere invece relative alla risposta agronomica delle colture, oppure aproblematiche gestionali o <strong>di</strong> conservazione del suolo simili.Relazioni spaziali: ve<strong>di</strong> topologia, continuità e connessione.Rilevamento pedologico <strong>di</strong> dettaglio: stu<strong>di</strong>o della natura e <strong>di</strong>stribuzione <strong>dei</strong> suoli nel paesaggiotramite rilievo <strong>di</strong>retto, effettuato soprattutto in campagna.Rilevamento pedologico <strong>di</strong> riconoscimento: stu<strong>di</strong>o della natura e <strong>di</strong>stribuzione <strong>dei</strong> suoli nelpaesaggio tramite riconoscimento <strong>di</strong>retto ed in<strong>di</strong>retto, cioè per mezzo dell'in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong>relazioni tra i suoli ed altri elementi del paesaggio apprezzabili in fotointerpretazione etele<strong>rilevamento</strong> (ve<strong>di</strong> anche pattern).Rilevamento pedologico GIS oriented: nella metodologia che utilizza le banche <strong>dati</strong> geografiche, il<strong>rilevamento</strong> è volto essenzialmente a dare significato pedologico alle componenti territorialiprecedentemente in<strong>di</strong>viduate. Questo tipo <strong>di</strong> <strong>rilevamento</strong> non è né un <strong>rilevamento</strong> “libero”, néun <strong>rilevamento</strong> determinato (a griglia , a transetto), ma funzionale a quanto interpretato construmenti GIS.Risoluzione: è un parametro <strong>di</strong> qualità locale <strong>di</strong> una cartografia. Risoluzione geometrica:corrisponde alle <strong>di</strong>mensioni del più piccolo particolare rappresentato nella cartografiavettoriale e alla lunghezza del lato della cella (pixel nel formato raster).Scala: la scala <strong>di</strong> una carta geografica in<strong>di</strong>ca, in pratica, quante volte una porzione della superficieterrestre è stata ridotta per poter essere rappresentata su un foglio <strong>di</strong> carta. É espressa, ingenere, come il rapporto tra una <strong>di</strong>stanza sulla carta e la corrispondente <strong>di</strong>stanza sul terreno. Ilrapporto <strong>di</strong> scala utilizzato per una carta geografica determina il contenuto <strong>di</strong> informazioni ela <strong>di</strong>mensione dell’area che può ragionevolmente essere rappresentata. Scala delpedopaesaggio: livello <strong>di</strong> percezione delle caratteristiche del pedopaesaggio (ad esempio:generalizzazione degli attributi climatici, morfologici, litologici e/o <strong>di</strong> copertura del suolo;similitu<strong>di</strong>ne o eterogeneità <strong>dei</strong> suoli e loro relazioni pedologiche funzionali) che varia aseconda della scala del <strong>rilevamento</strong> e del relativo livello <strong>di</strong> generalizzazione. Scala nominale:è un parametro che definisce la scala <strong>di</strong> riferimento <strong>di</strong> una cartografia numerica in funzionedella corrispondente scala <strong>di</strong> una cartografia tra<strong>di</strong>zionale realizzata seguendo gli stessirequisiti <strong>di</strong> precisione metrica.Semantica: detto <strong>di</strong> quella attribuzione che non viene effettuata su base geografica. Ad esempio ipedopaesaggi <strong>di</strong> livello gerarchico inferiore vengono attribuiti in maniera semantica a quelli<strong>di</strong> livello superiore. Sono attribuzioni semantiche le stesse . Ancora, le osservazionipedologiche e le sottounità tipologiche <strong>di</strong> suolo vengono attribuite in maniera semantica allecomponenti territoriali stesse.Serie <strong>di</strong> suoli: definizione della Soil Taxonomy (Soil Survey Staff, 1999) data per in<strong>di</strong>care suolicon uguale classificazione fino al livello <strong>di</strong> famiglia, formati ed evoluti su uguali litologie,appartenenti ad uno stesso paesaggio, e soggetti ad una gestione antropica molto simile ocoperti da un simile tipo <strong>di</strong> vegetazione; sono suoli con analogo arrangiamento degli orizzontial loro interno.Sistema <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>nate: ve<strong>di</strong> sistema <strong>di</strong> riferimento.Sistema <strong>di</strong> proiezione: sono sistemi che consentono <strong>di</strong> rappresentare la superficie quasi sfericadella Terra su un piano, mantenendo alcune conformità (isogonia, equivalenza, equi<strong>di</strong>stanza,ecc.): le più conosciute sono la Geografica, l’UTM, la GAUSS-BOAGA, la LAMBERT, altresono la Conica, la Polare, la Stereografica, la Cilindrica e la Planare anche variamentecombinate.258
PEDOL./INF.LA DESCRIZIONE DEL SUOLO259Sistema <strong>di</strong> riferimento: ogni proiezione ha un proprio sistema <strong>di</strong> riferimento, dal quale si parte percalcolare le <strong>di</strong>stanze. Ad esempio la Proiezione Geografica ha come riferimenti l’incrocio trail meri<strong>di</strong>ano <strong>di</strong> Greenwich e l’Equatore, la UTM prevede spicchi predeterminati <strong>di</strong> sei gra<strong>di</strong>,detti fusi, a loro volta <strong>di</strong>visi in zone (l’Italia è a cavallo <strong>dei</strong> fusi 32, 33 e 34), la GAUSS-BOAGA, tutta italiana, parte da Monte Mario (a Roma) e utilizza coor<strong>di</strong>nate chilometrichemisurate convenzionalmente partendo da 1500 a sinistra e da 2520 a destra del meri<strong>di</strong>ano <strong>di</strong>riferimento.Sistema GIS ni<strong>di</strong>ficato (nested): sistema GIS in cui gli oggetti geografici sono organizzati in livelligerarchici, cui corrispondono <strong>di</strong>verse scale <strong>di</strong> rappresentazione e <strong>di</strong>versi gra<strong>di</strong> <strong>di</strong>generalizzazione delle informazioni. In esso possono coesistere oggetti con <strong>di</strong>verso grado <strong>di</strong>conoscenze, ad esempio: aree campione stu<strong>di</strong>ate a grande dettaglio, assieme ad altre aree pococonosciute, possono formare un livello geografico superiore, il cui contenuto informativo èformato o da solo una parte degli attributi degli oggetti <strong>di</strong> livello inferiore, oppure dagli stessiattributi, ma con un maggior grado <strong>di</strong> generalizzazione.Sistema <strong>di</strong> terre: contenitore pedogeografico <strong>di</strong> terre in<strong>di</strong>viduato e riconoscibile ad una scaladell’or<strong>di</strong>ne dell’1:500.000. Si definisce come pedologico quando l’informazione sui suoli èorganizzata in una banca <strong>dati</strong> pedologica collegata alla banca <strong>dati</strong> geografica.Sistema informativo pedologico: traduzione in italiano del corrispondente anglosassone soil GIS.Sito modale sito risultante dai valori modali, me<strong>di</strong> e deviazioni standard, <strong>dei</strong> valori delleosservazioni pedologiche (escluse le correlate) afferenti ad una determinata STS, escludendoquelle correlate.Sito pedologico: insieme delle informazioni relative all’osservazione pedologica e alla stazione <strong>di</strong><strong>rilevamento</strong>.Soil body: termine inglese specifico utilizzato nel manuale delle procedure del Georeferenced soildatabase of Europe con il seguente significato “una porzione <strong>di</strong> territorio con limiti geograficiconosciuti in modo impreciso. Una entità tri<strong>di</strong>mensionale artificiale ma riconoscibile nelcontinuum <strong>dei</strong> suoli, descritta unicamente dalla sua classificazione WRB, dai materialiparentali, profon<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> uno strato che ostacoli lo sviluppo delle ra<strong>di</strong>ci e tessitura superficialedominante”. Per definire un soil body è necessario avere almeno due profili descritti edanalizzati (Finke et al., 1999).Soilscape: termine inglese equivalente a pedolandscape. E’utilizzato nel manuale delle proceduredel Georeferenced soil database of Europe con il seguente significato “una porzione dellacopertura pedologica che contiene soil body che hanno relazioni funzionali nel presente, o lehanno avute nel passato, e che può essere rappresentata a scala 1:250.000”.Soil region: termine inglese specifico utilizzato nel manuale delle procedure del Georeferenced soildatabase of Europe con il seguente significato “una porzione della copertura pedologica alivello regionale, caratterizzata da un clima e da una associazione <strong>di</strong> materiali parentali tipici”(Finke et al., 1999). Corrisponde essenzialmente al significato che viene dato al termineitaliano regione pedologica.Sottosistema <strong>di</strong> terre: contenitore pedogeografico <strong>di</strong> terre in<strong>di</strong>viduato e riconoscibile ad una scaladell’or<strong>di</strong>ne dell’1:250.000. Si definisce come pedologico quando l’informazione sui suoli èorganizzata in una banca <strong>dati</strong> pedologica collegata alla banca <strong>dati</strong> geografica.STS (Sottounità tipologica <strong>di</strong> suolo): sottoinsieme <strong>di</strong> osservazioni con problematiche gestionalisimili in<strong>di</strong>viduato all’interno <strong>di</strong> una certa unità tipologica <strong>di</strong> suolo.Spazializzazione: proce<strong>di</strong>mento con il quale vengono generalizzate arealmente le informazionipuntuali.Standard <strong>di</strong> <strong>rilevamento</strong>: in<strong>di</strong>ci che esplicitano l'intensità delle informazioni pedologiche raccolte.Variano a seconda della scala del <strong>rilevamento</strong>, delle sue finalità e della complessità delterritorio. Tra i più comuni vi sono: numero <strong>di</strong> osservazioni per unità <strong>di</strong> superficie (adesempio: n/ha), numero <strong>di</strong> osservazione per unità tipologica <strong>di</strong> suolo (n/n), numero <strong>di</strong>osservazioni per unità cartografica o per poligono (n/n). Nel caso del <strong>rilevamento</strong> GIS
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICIPEDOL./INF.oriented si parla <strong>di</strong> numero <strong>di</strong> osservazioni per elemento territoriale o per componenteterritoriale.Stazione <strong>di</strong> <strong>rilevamento</strong>: intorno del luogo dove viene realizzata l'osservazione, <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensionevariabile nell'or<strong>di</strong>ne delle decine o alcune centinaia <strong>di</strong> metri quadri. È sinonimo del terminesito, corrispondente al termine inglese site.Strato informativo, geografico o layer: lo strato informativo o layer è l’unità base della gestione<strong>dei</strong> <strong>dati</strong> e definisce attributi posizionali e tematici per gli elementi <strong>di</strong> mappa <strong>di</strong> una data area.Lo strato informativo, o strato geografico, è l’insieme degli elementi omogenei checompongono una mappa, come per esempio strade, corsi d’acqua, foreste, ecc.Strato (<strong>di</strong> suolo): sinonimo <strong>di</strong> orizzonte pedologico.Tabella degli attributi: le tabelle sono una parte integrante dello strato informativo. Ogni tabella èrelativa ad un gruppo omogeneo <strong>di</strong> elementi geografici della carta (le strade, i fiumi, le curve<strong>di</strong> livello, ecc.) ed è costituita da un numero variabile <strong>di</strong> righe e colonne. Ogni riga (record)contiene la descrizione <strong>di</strong> un singolo elemento geografico ed ogni colonna (campo o attributo)memorizza uno specifico tipo <strong>di</strong> informazione. Le caratteristiche degli elementi geograficisono generalmente tradotte in co<strong>di</strong>ci numerici o alfabetici, prima <strong>di</strong> essere inserite nellarelativa tabella.TIFF (Tag lmage File Format): è un formato standard per l’interscambio <strong>di</strong> <strong>dati</strong> raster.Topologia: la topologia è un insieme <strong>di</strong> regole per definire in maniera esplicita le relazioni, irapporti <strong>di</strong> connessione e <strong>di</strong> continuità tra gli elementi spaziali e per collegare tali elementialle relative descrizioni (attributi). In un modello <strong>dati</strong> topologico, ad esempio, è possibilericonoscere le aree contigue e identificare le linee che delimitano ciascuna superficieTrivellata: osservazione pedologica che consiste nello scavo tramite carotatore in genere manuale<strong>di</strong> una serie successiva in profon<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> carote. Questo tipo <strong>di</strong> osservazione è utilizzatosoprattutto per in<strong>di</strong>viduare il sito idoneo allo scavo <strong>di</strong> un profilo pedologico. Si può rilevareutile anche per verificare la corretta apposizione <strong>dei</strong> limiti tra suoli, validare cartografie <strong>dei</strong>suoli o per acquisire informazioni su caratteristiche specifiche <strong>dei</strong> suoli (es. profon<strong>di</strong>tà <strong>di</strong>strati con forti cambi <strong>di</strong> tessitura o profon<strong>di</strong>tà del substrato ecc.).Unità cartografica: insieme delle delineazioni aventi la stessa sigla nella legenda della carta.Unità <strong>di</strong> paesaggio: termine usato da esperti <strong>di</strong> varie <strong>di</strong>scipline per in<strong>di</strong>care una superficie con uncerto grado <strong>di</strong> omogeneità per alcuni caratteri, problematiche o processi alla scala <strong>di</strong>riferimento. In pedologia viene più spesso utilizzato alle scale <strong>di</strong> dettaglio e semidettaglio perin<strong>di</strong>care superfici con un grado <strong>di</strong> omogeneità nei fattori e processi della pedogenesi per cui èpossibile trovare al loro interno suoli simili. Operativamente, si realizzano considerandocaratteri ambientali <strong>di</strong>versi (litologia, uso del suolo, falda freatica, processi erosivi, ecc.) come<strong>di</strong>scriminanti e descriventi delle unità fisiografiche.Unità <strong>di</strong> terre: contenitori pedogeografici <strong>di</strong> terre in<strong>di</strong>viduati e riconoscibili ad una scaladell’or<strong>di</strong>ne dell’1:50.000. Si definiscono come <strong>pedologici</strong> quando l’informazione sui suoli èorganizzata in una banca <strong>dati</strong> pedologica collegata alla banca <strong>dati</strong> geografica.Unità fisiografica: tratto della superficie terrestre omogeneo per tipo ed intensità del processogeomorfologico dominante alla scala <strong>di</strong> riferimento.UTS (Unità tipologica <strong>di</strong> suolo): insieme <strong>di</strong> osservazioni con attributi geografici comuni e concaratteri genetici simili, con una certa variabilità <strong>di</strong> problematiche gestionali. Ogni UTS haperlomeno una STS.Variabilità pedologica: termine usato in riferimento alle possibili variazioni <strong>di</strong> caratteri e proprietàall’interno <strong>di</strong> una Unità Tipologica <strong>di</strong> Suolo.Variante <strong>di</strong> serie: definizione della Soil Taxonomy (Soil Survey Staff, 1999) data per in<strong>di</strong>caresuoli con caratteri e classificazione <strong>di</strong>verse da quelle della serie <strong>di</strong> riferimento, ma <strong>di</strong> limitataestensione. In<strong>di</strong>viduano porzioni <strong>di</strong> territorio sensibilmente <strong>di</strong>ssimili per caratteri ambientalida quelle in<strong>di</strong>viduate dalle fasi della serie <strong>di</strong> riferimento (confronta con: fase <strong>di</strong> serie). La260
PEDOL./INF.LA DESCRIZIONE DEL SUOLOdefinizione <strong>di</strong> variante può essere usata nella metodologia del presente manuale solo per ladefinizione <strong>di</strong> unità e sottounità tipologiche <strong>di</strong> suolo definite a livello <strong>di</strong> dettaglio.Vettoriale: è un sistema <strong>di</strong> archiviazione <strong>di</strong> <strong>dati</strong> grafici secondo il quale gli oggetti vengonomemorizzati in base alle coor<strong>di</strong>nate cartesiane <strong>dei</strong> punti e linee che li compongono.Vettorializzazione: operazione che consente in modo automatico o semiautomatico (cioè conl’assistenza <strong>di</strong> un operatore) <strong>di</strong> ricavare un insieme <strong>di</strong> vettori a partire da una immagine raster.261
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICIBibliografiaAA.VV. 2005. Carta <strong>dei</strong> suoli del Veneto, note illustrative. Regione Veneto - Agenzia regionale perla prevenzione e la protezione ambientale del Veneto, Padova, Italia, p. 30-42.AA.VV. 2006. Suoli e paesaggi delle marche. Agenzia servizi settore agroalimentare delle Marche.Ancona, pp. 304.AFES (Association Francaise pour l’Étude du Sol) 1995. Référentiel Pédologique. Coll. Techniqueset Practiques, INRA, Paris, France, pp. 218.Aguilar J., Fernandez J., Dorronsoro C., Stoops G., Dorronsoro B. 2004. Hydromorphy in soils.[Online] http://edafologia.ugr.es/hidro/indexw.htm (verificato il 16/11/2007).Alliata V., Dazzi C. 1986. Gli entisuoli dell’azienda Pietranera (AG). Estratto da “Quaderni <strong>di</strong>agronomia 11”, Istituto <strong>di</strong> agronomia generale e coltivazioni erbacee dell’Università degli Stu<strong>di</strong><strong>di</strong> Palermo, Palermo, Italia, p. 5-32.Angelelli A., Arcozzi R., Baratozzi L., Filippi N., Guerman<strong>di</strong> M., Mandolesi P., Pignone R., PretiD. 1981. Capacità d'uso <strong>dei</strong> suoli della Regione Emilia-Romagna. Regione Emilia-Romagna -Servizio Geologico Sismico e <strong>dei</strong> Suoli, Bologna, Italia, pp. 35.APAT 2005 La realizzazione in Italia del progetto europeo Corine Land Cover 2000. Dipartimentostato dell’ambiente e metrologia ambientale. Servizio gestione modulo nazionaleSINAnet.Rapporti 36/2005, pp. 86.APAT, CNR-IGG, CIS 2003. Catalogo delle formazioni geologiche italiane. Agenzia per laprotezione dell’ambiente e per i servizi tecnici, Istituto <strong>di</strong> Geoscienze e Georisorse del ConsiglioNazionale delle Ricerche e Commissione Italiana <strong>di</strong> Stratigrafia. [Online] http://www.accordocarg.it(verificato il 16/11/2007).Arangino F., Aru A., Baldaccini P., Vacca S. 1986. I suoli delle aree irrigabili della Sardegna.Regione Sardegna, Ente autonomo Flumendosa, Cagliari, Italia.Aru A. 1990. Nota illustrativa alla Carta <strong>dei</strong> suoli della Sardegna, SELCA, Firenze, Italia, pp. 83.Aru A., Baldaccini P., Delogu G., Dessena M.A., Madrau S., Melis R. 1990. Carta <strong>dei</strong> Suoli dellaSardegna, in scala 1/250.000. Assessorato alla programmazione e all’assestamento del territorio,Centro Regionale Programmazione, Dip. Sc. della Terra, Università <strong>di</strong> Cagliari, Italia.Ballatore G. 1968. Carta <strong>dei</strong> suoli della Sicilia. (Scala 1:250.000) con nota illustrativa. Ind. Graf.Naz., Palermo, Italia.Barberis E. 2007. Problematiche analitiche per la classificazione <strong>dei</strong> suoli salini, in Atti dellagiornata <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o sulla scelta e interpretazione <strong>dei</strong> <strong>meto<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> analisi <strong>dei</strong> suoli al fine dellaclassificazione pedologica, CRA, AIP, SIIS, UNIFI, Aprile 2007, pp. 29. [Online]http://www.aip-suoli.it/download/atti/SISS_%20apr07_Barberis.pdf (verificato il 16/11/2007).Blume L., Schumacher B., Schaffer P., Cappo K., Papp M., Van Remortel R., Coffey D., JohnsonM., Chaloud D. 1990. Handbook of methods for acid deposition stu<strong>di</strong>es laboratory analyses forsoil chemistry, EPA/600/4-90/023. U.S. EPA, Las Vegas, NV, USA, p. 4-90.Bono G. 2001. Le unità <strong>di</strong> paesaggio del territorio <strong>dei</strong> comuni <strong>di</strong> Sciacca e Caltabellotta (AG).Assessorato agricoltura e foreste - servizi allo sviluppo – unità operativa pedologica, Palermo,Italia, pp. 96.262
LA DESCRIZIONE DEL SUOLOBono G., Cipri G., Guaitoli G., Matranga M. G., Pala<strong>di</strong>no A., Perciabosco M., Pumo A. 1998. Isuoli dell’area Castelvetrano est. Assessorato agricoltura e foreste - servizi allo sviluppo – unitàoperativa pedologica, Palermo, Italia, pp. 116.Bossard M., Feranec J., Otahel J. 2000. CORINE land cover technical guide. Addendum 2000.Technical report N°40. Copenhagen. European Environment Agency, pp. 105.Brenna S., D’Alessio M., Solaro S. 2004. Carta <strong>dei</strong> suoli della Lombar<strong>di</strong>a – Scala 1:250.000.Regione Lombar<strong>di</strong>a – Direzione generale agricoltura – U.O. Programmazione e ricerca per lefiliere agronidustriali – Struttura ricerca e innovazione tecnologica, Milano, Italia, pp. 41.Carnicelli S., Wolf U., Ferrari G. A. 2001. Progetto “Metodologie pedologiche”, sottoprogetto 2,gruppo <strong>di</strong> lavoro “Manuale <strong>di</strong> <strong>rilevamento</strong>”, pp. 56.Carumati R., Potenza R., Testa B. 1987. Scienza e tecnologia. Dizionario enciclope<strong>di</strong>co. Geologia.Gruppo e<strong>di</strong>toriole Jackson. pp. 273.Castiglioni G. B. 1991 Geomorfologia. UTET, Torino, Italia, pp. 436.Chiuchiarelli I., Paolanti M., Rivieccio R., Santucci S. 2004. Manuale per la descrizione del Suolo.Centro SAPA, ARSSA Abruzzo, Italia, pp. 88.Chiuchiarelli I., Paolanti M., Rivieccio R., Santucci S. 2006. Carta <strong>dei</strong> suoli d’Abruzzo, in scala1:250.000 – Ambiente e Territorio. Agenzia Regionale per i Servizi <strong>di</strong> Sviluppo Agricolo, dellaRegione Abruzzo. Centro per lo Stu<strong>di</strong>o del Suolo Ambiente e Paesaggio Abruzzese. RegioneAbruzzo, MiPAF e Unione Europea, pp. 332.Costantini E. A. C. 1991. Rilevamento e cartografia <strong>dei</strong> suoli, da Il Suolo - Pedologia nelle scienzedella terra e nella valutazione del territorio, a cura <strong>di</strong> Cremaschi M. e Rodolfi G., La NuovaItalia Scientifica, p. 259-275.Costantini E. A. C. 1999. Preparing the soil survey of Italy at scale 1:250,000. Boll. S.I.S.S., 48, p.655-665.Costantini E. A. C. 2006. La classificazione della capacità d'uso delle terre (Land CapabilityClassification). In: Costantini, E. A. C. (Ed.), Meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> valutazione <strong>dei</strong> suoli e delle terre,Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Osservatorio Nazionale Pedologico e per laQualità del Suolo Agricolo e Forestale, Cantagalli, Siena, Italia, p. 53-62.Costantini E. A. C. (coor<strong>di</strong>natore) 2006. Meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> valutazione <strong>dei</strong> suoli e delle terre. E<strong>di</strong>zioniCantagalli, Siena, Italia, pp. 922.Costantini E. A. C., Barbetti R., Bucelli P., Cimato A., Franchini E., L’Abate G., Pellegrini S.,Storchi P. Vignozzi N. 2006. Zonazione viticola ed olivicola della provincia <strong>di</strong> Siena. GraficheBoccacci e<strong>di</strong>tore, Colle val d’Elsa (SI) , Italia, pp. 224.Costantini E. A. C., Barbetti R., L’Abate G., Magini S., Urbano F. 2004. A Soil GIS LinkingPedolandscapes at Different Scales to a National Soil Database. EUROSOIL Conference,Freiburg i.Br., September 4-12, 2004 (CD-ROM computer file).Costantini E. A. C., Castelli F., Iori M., Magini S., Lorenzoni P., Raimon<strong>di</strong> S. 2001. Regimetermico del suolo in alcuni campi sperimentali del nord, centro e sud Italia. Atti del convegnoSISS “La scienza del suolo in Italia: bilancio <strong>di</strong> fine secolo.” Gressoney Saint Jean, 1999, ISNP,Roma, Italia, p. 125-132. [CD-ROM computer file].Costantini E. A. C., D’Antonio A. 2001. Attualità e prospettive <strong>dei</strong> progetti “Metodologiepedologiche” e “Carta <strong>dei</strong> suoli d’Italia a scala 1:250.000”. Boll. Soc. It. Sc. del Suolo, L, 2, p.205-218.263
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICICostantini E. A. C., Favi E., Lulli L., Rodolfi G. 1991. I suoli in campagna, da Il Suolo -Pedologia nelle scienze della terra e nella valutazione del territorio, a cura <strong>di</strong> Cremaschi M. eRodolfi G., La Nuova Italia Scientifica, p. 17-60.Costantini E. A. C., Gar<strong>di</strong>n L., Napoli R. 2004. Guida alla descrizione <strong>dei</strong> suoli in campagna e alladefinizione delle loro qualità. Istituto Sperimentale per lo Stu<strong>di</strong>o e la Difesa del Suolo Sezione<strong>di</strong> Genesi, Classificazione e Cartografia del Suolo. Centro Nazionale <strong>di</strong> Cartografia Pedologica.Regione Toscana Dipartimento Sviluppo Economico Servizio Foreste e patrimonioagroforestale, pp. 101.Costantini E. A. C., L’Abate G., Urbano F. 2004. Soil Regions of Italy. CRA-ISSDS, Firenze. pp. 8.[Online] http://www.soilmaps.it/ita/downloads.html (verificato il 16/11/2007).Costantini E. A. C., Magini S., Napoli R. 2003. A Land System database of Italy. 4th EuropeanCongress on Regional Geoscientific Cartography and Information Systems. Procee<strong>di</strong>ngs v.1,p.124-126. [Online] http://www.regione.emilia-romagna.it/ wcm/geologia/canali/convegni_e_seminari/congresso_europeo/congresso_04.htm (verificato il 20/11/2007).Cumer A. 1994. Il progetto CORINE land cover in Italia: un modello da seguire. Documenti delTerritorio, VIII, p. 28-29.D’Amico C., Innnocenti F., Fassi F. P. 1991. Magmatismo e metamorfismo. UTET. pp. 536.Dazzi C., Raimon<strong>di</strong> S. 1986. I vertisuoli della Sicilia. Nota II: i vertisuoli dell’azienda Pietranera(AG). Estratto da “Quaderni <strong>di</strong> agronomia 11”, Istituto <strong>di</strong> agronomia generale e coltivazionierbacee dell’Università degli Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> Palermo, Palermo, Italia, p. 66-102.Dimase A.C. 1983. Il <strong>rilevamento</strong> <strong>dei</strong> suoli dell’azienda agricola “Il Monte”. Un esempio <strong>di</strong>cartografia <strong>di</strong> dettaglio per il reperimento <strong>di</strong> <strong>dati</strong> per ricerche <strong>di</strong> valutazioni a scopi agricoli. In:"Risultati sperimentali per la valutazione <strong>dei</strong> suoli agricoli e forestali in Toscana". Progettofinalizzato "Conservazione del suolo" , Centro <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o per la Genesi, Cartografia eClassificazione del Suolo, C.N.R., Firenze, Italia, p. 61-101.Dobos E., Carré F., Hengl T., Reuter H.I., Tóth G. 2006. Digital Soil Mapping as a support toproduction of functional maps. EUR 22123 EN. Office for Official Publications of the EuropeanCommunities, Luxemburg, pp. 68.Ente Minerario Siciliano 2002. Carta litologica della Sicilia.ERSAL (Ente Regionale <strong>di</strong> Sviluppo agricolo della Regione Lombar<strong>di</strong>a) 1997. Manuale per lacompilazione delle schede delle unità cartografiche, Italia, pp. 55ERSAL (Ente Regionale <strong>di</strong> Sviluppo agricolo della Regione Lombar<strong>di</strong>a) 2000. I suoli della pianuracremonese centrale, progetto “Carta pedologica”, Italia, pp. 93European Soil Bureau 2007. European Soil Database. [Online]. http://eusoils.jrc.it/data.html(verificato il 16/11/2007).Fairbridge R. W. 1968. The Encyclopae<strong>di</strong>a of geomorphology. Reinhold Book Corporation, NewYork, USA, pp. 1295.FAO 1990a. Management of gypsiferous soils dal FAO soils bulletin 62. Food and AgricultureOrganization of the United Nations, Soil Resources Management and Conservation Service,FAO Land and water development <strong>di</strong>vision, p. 70-71.FAO 1990b. FAO - Guidelines for Soil Description FAO, Roma, Italy, pp. 140.FAO 1995. Global and National Soils and Terrain Digital Database (SOTER) - Procedures Manual.FAO World Soil Resources Reports No.74, Rev.1. Roma, Italia.FAO 2006 Guidelines for soil description. Fourth e<strong>di</strong>tion. Roma, Italia, pp. 92.264
LA DESCRIZIONE DEL SUOLOFerrari G.A., Sanesi G. 1965. Guida per servire allo stu<strong>di</strong>o del suolo in campagna. Ed. Istituto <strong>di</strong>Geologia applicata, Facoltà <strong>di</strong> Agraria, Firenze, Italia.Fierotti G. 1979. Il Fuciligno. Sviluppo Agricolo n. 4. Palermo, Italia.Fierotti G. 1988. Carta <strong>dei</strong> suoli della Sicilia. Regione Siciliana, Università degli Stu<strong>di</strong>, Palermo,Italia, (cartografia).Fierotti G. 1997. I suoli della Sicilia: con elementi <strong>di</strong> genesi, classificazione e valutazione <strong>dei</strong> suoli,Dario Flaccovio E<strong>di</strong>tore, pp. 359.Fierotti G., Dazzi C. 1993. Il quadro pedologico del comprensorio del Consorzio <strong>di</strong> Bonificadell’alto e me<strong>di</strong>o Belice ed esempi <strong>di</strong> valutazione dell’attitu<strong>di</strong>ne <strong>dei</strong> suoli all’irrigazione.Estratto da “Ricerca pilota a valenza interregionale sulla riconversione colturale edammodernamento delle strutture nel comprensorio dell'alto e me<strong>di</strong>o Belice”. Ministerodell’agricoltura e foreste, consorzio <strong>di</strong> bonifica del bacino dell'alto e me<strong>di</strong>o Belice. Palermo,Italia, p. 109-178.Fierotti G., Dazzi C., Raimon<strong>di</strong> S. 1988 Commento alla carta <strong>dei</strong> suoli della Sicilia. RegioneSiciliana, Università degli Stu<strong>di</strong>, Palermo, Italia, pp. 19.Filippi N., Sbarbati L. 1994. I suoli dell’Emilia-Romagna. Regione Emilia-Romagna, ServizioGeologico, Sismico e <strong>dei</strong> Suoli. pp. 383.Finke P., Hartwich R., Dudal R., Ibàñez J., Jamagne M., King D., Montanarella L., Yassoglou N.1999. Database georeferenziato <strong>dei</strong> suoli europei. Manuale delle procedure. Versione 1.1.Versione italiana a cura <strong>di</strong> Edoardo A.C. Costantini. Commissione Europea. EUR 18092 pp.176.Flashearth 2007. [Online] http://www.flashearth.com (verificato il 16/11/2007).Galvan P., Scattolin L., Ponge J.F., Zanella A., Viola F. 2005. Le forme <strong>di</strong> humus e la pedofauna -Interpretazione e chiave <strong>di</strong> riconoscimento. Sherwood - Foreste ed Alberi Oggi, v. 112, p. 33-39.Gar<strong>di</strong>n L., Costantini E. A. C., Napoli R. 2002. Guida alla descrizione <strong>dei</strong> suoli in campagna e alladescrizione delle loro qualità. Istituto Sperimentale per lo Stu<strong>di</strong>o e la Difesa del Suolo eRegione Toscana, Firenze, Italia, pp. 83. [Online] www.soilmaps.it\download (verificato il20/11/2007).Gar<strong>di</strong>n L., Napoli R., Costantini E. A. C. 1996. Architettura <strong>di</strong> un database relazionale per unsistema informativo pedologico. Bollettino della Società Italiana <strong>di</strong> Scienza del Suolo, 8, p. 165-182.Gar<strong>di</strong>n L., Napoli R., Costantini E. A. C. 1998. L’archiviazione e la gestione <strong>dei</strong> <strong>dati</strong> <strong>pedologici</strong> conil software “ISSDS” ver.2. Genio Rurale, 4, 1998, p. 50-56.Gar<strong>di</strong>n, L., Napoli R., Primavera F., Gregori E., Costantini E. A. C. 1995. Guida al Rilevamento <strong>dei</strong>Suoli, Versione II. Progetto UOT, ISSDS Firenze, Italia, pp. 84.Gar<strong>di</strong>n L., Sulli L., Napoli R., Gregori E., Costantini E. A. C. 1998b. Manuale per il <strong>rilevamento</strong>del suolo. Istituto Sperimentale per lo Stu<strong>di</strong>o e la Difesa del Suolo, Firenze, Italia, pp. 83.Giar<strong>di</strong>ni L. 1986. Agronomia generale. Patron e<strong>di</strong>tore, Bologna, Italia, pp. 597.Giordano A. 1999. Pedologia. UTET, Torino, Italia, p. 364.Giovagnotti C., Calandra R., Leccese A., Giovagnotti E. 2003. I paesaggi <strong>pedologici</strong> e la carta <strong>dei</strong>suoli dell’Umbria. Camera <strong>di</strong> commercio, industria, artigianato e agricoltura <strong>di</strong> Perugia, Italia,pp. 192.265
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICIGoogle 2007. Google maps italia. [Online]. http://maps.google.it (verificato il 16/11/2007).Guaitoli F., Matranga M. G., Pala<strong>di</strong>no A., Perciabosco M., Pumo A. 1998a. I suoli dell’area MonteMagaggiaro. Assessorato agricoltura e foreste - servizi allo sviluppo – unità operativapedologica, Palermo, Italia, pp. 110.Guaitoli F., Matranga M. G., Pala<strong>di</strong>no A., Perciabosco M., Pumo A. 1998b. I suoli dell’area Paternòsud. Assessorato agricoltura e foreste - servizi allo sviluppo – unità operativa pedologica,Palermo, Italia, pp. 96.Guaitoli F., Matranga M.G., Pala<strong>di</strong>no A., Perciabosco M., Pumo A., Costantini E. A. C. 1998.Manuale per l’esecuzione e la descrizione della trivellata. Regione Siciliana, Ass. Agricoltura eForeste. Sez. operativa n. 8 - S. Agata Militello (ME), Italia, pp. 67.Guaitoli F., Matranga M. G., Perciabosco M., Pumo A., Ferraro V., Di Marco D. 2001. I suolidell’area <strong>di</strong> Platani - Tumarrano (AG). Assessorato agricoltura e foreste - servizi allo sviluppo –unità operativa pedologica, Palermo, Italia, pp. 96.Hudson B.D. 1992. The soil survey as para<strong>di</strong>gm-based science. Soil. Sc. Soc. Am. J. 56, USA, p.836-841.Indorante S.J., Kabrik J.M., Hudson B.D. 1999. The soils that we map. SSSA annual meeting, SaltLake City, USA.INEA (Istituto Nazionale <strong>di</strong> Economia Agraria) 2007. Cartografie del P.O. "Risorse idriche".[Online] http://www.inea.it/irri/carte.cfm (verificato il 16/11/2007).IGM (Istituto Geografico Militare) <strong>di</strong> Firenze. 2004. Carta “Il Mondo (JOG) 1501” serie 250/G.IUSS working group WRB 2006. World reference base for soil resources 2006. World SoilResources Reports No. 104. Rome, FAO, pp. 121.IUSS – ISRIC – FAO 1998. World Reference Base for Soil Resources. World Soil ResourcesReports n 84, FAO, Rome, Italia, pp. 92.Jenny H. 1941. Factors of soil formation - a system of quantitative pedology. McGraw-Hill, NewYork, USA, pp. 281.L’Abate G., Costantini E. A. C., Urbano F. 2003. Estimating soil drought risk in Italy using theEPIC model and a pedoclimatic GIS. Experimental Institute for Soil Study and Conservation,pp. 5. [Online] http://www.soilmaps.it/download/cli-icdl3.pdf (verificato il 16/11/2007).Lagacherie P., Voltz M. 2000. Pre<strong>di</strong>cting soil properties over a region using sample informationfrom a mapped reference area and <strong>di</strong>gital elevation data: a con<strong>di</strong>tional probability approach.Geoderma 97, Deutschland, pp. 187-208.Longo F., Coglitore M., Aramini G., Colloca C., Corea A.M., Paone R. 2003. I suoli della Calabria.Carta <strong>dei</strong> suoli in scala 1:250.000 della Regione Calabria. Monografia <strong>di</strong>vulgativa. RegioneCalabria - Assessorato agricoltura caccia e pesca - Agenzia regionale per lo sviluppo e per iservizi in agricoltura. Cosenza, Italia, pp. 387.Lorimer M.S., Rowan J.N. 1982. Study of the Land in the Cachment of the Avoca River. T.C. 15.Soil Conservation Authority, Appen<strong>di</strong>x VI - Methods of Land System Description, Vic.,Australia. [Online] http://www.dpi.vic.gov.au/dpi/vro/nthcenregn.nsf/pages/nthcen_landform_avoca_river/ (verificato il 16/11/2007).Lulli L., Lorenzoni P., Arretini A. 1980. Esempi <strong>di</strong> cartografia tematica e <strong>di</strong> cartografia derivata(Sezione Luicignano – Foglio Firenze). La carta <strong>dei</strong> suoli, la loro capacità d’uso, l’attitu<strong>di</strong>ne <strong>dei</strong>suoli all’olivo e al Sangiovese. Messa a punto <strong>di</strong> metodologie <strong>di</strong> <strong>rilevamento</strong> e <strong>di</strong>266
LA DESCRIZIONE DEL SUOLOrappresentazione. Istituto Sperimentale per lo Stu<strong>di</strong>o e la Difesa del Suolo, Firenze, Italia, pp.95.Mancini F. 1957. Piccola guida per chi stu<strong>di</strong>a il suolo in campagna. Istituto <strong>di</strong> geologia applicata,Università degli stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> Firenze, Firenze, Italia, pp. 36Marbut C.F. 1935. Soils of the United States. Part III. In Atlas of American agriculture. U.S. Dep.Agr., USA, p. 1-98.McBratney A.B. e De Gruijter J.J., 1992. A continuum approach to soil classification by mo<strong>di</strong>fiedfuzzy k-means with extragrades. J. Soil Sci., 43. Soil Conservation Service, 1983 e 1997.National Soil Handbook, USDA, Washington D.C., USA, p. 159-175.McBratney A.B., Mendoça Santos M.L., Minasny B. 2003. On <strong>di</strong>gital soil mapping. Geoderma,117(1-2), Deutschland, p. 3-52.Michelutti G., Barbieri S., Bianco D., Zanolla S., Casagrande G. 2006. Suoli e paesaggi del FriuliVenezia Giulia: 2. province <strong>di</strong> Gorizia e Trieste. Note illustrative. Agenzia regionale per losviluppo rurale - Servizio della sperimentazione agraria - Ufficio del suolo, U<strong>di</strong>ne, Italia, pp.638.Michelutti G., Zanolla S., Barbieri S. 2003. Suoli e paesaggi del Friuli Venezia Giulia: 1. pianura ecolline del pordenonese. Note illustrative. Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - Serviziodella sperimentazione agraria - Ufficio del suolo, U<strong>di</strong>ne, Italia, pp. 512.MiPAF 2000. Meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> analisi chimica del suolo. Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.Franco Angeli, Milano, Italia, (fascicolato).Munsell Color Company 2000. Munsell soil color charts. Revised washable e<strong>di</strong>tion.GretagMacbeth, New Windsor, NY, USA, (fascicolato).Napoli R., Costantini E. A. C., Bazzoffi P., Vinci A., Bocci M., Gar<strong>di</strong>n L. 2003. Tuscany regionSoil Information System: structure, multiscale soil data integration and applied thematic models.European Congress on Regional Geoscientific Cartography and Information Systems.Procee<strong>di</strong>ngs v.1, p.270-272. [Online] http://www.regione.emilia-romagna.it/wcm/geologia/canali/convegni_e_seminari/congresso_europeo/congresso_04.htm (verificato il 20/11/2007).Napoli R., Costantini E. A. C., Castellani F., Gar<strong>di</strong>n L. 2005. New proposals towards a WRBsystem for soil cartography: the soil map at 1:250,000 scale of the Tuscany region (CentralItaly). Eurasian Soil Science, 2005, v. 38, Suppl.1, p 20-26.Napoli R., Costantini E. A. C., Gar<strong>di</strong>n L. 1999. Un sistema informativo pedologico per levalutazioni agro-ambientali a scala <strong>di</strong> dettaglio e semi-dettaglio. Agricoltura Ricerca, XXI, p.159-176.Napoli R., Gar<strong>di</strong>n L., Costantini E. A. C., Fais A. 1998. Risultati metodologici e operativi delprogetto cartografia pedologica nelle Unità Operative Territoriali delle regioni meri<strong>di</strong>onali:innovazioni e prospettive. Boll. Soc. It. Sc. Suolo, XLVII, 3, p. 393-408.NASIS 2007. Pedon PC. National Soil Information System. [Online]http://nasis.usda.gov/downloads/home.shtml (verificato il 16/11/2007).Olivieri G., Dazzi C., Raimon<strong>di</strong> S. 1986. Stu<strong>di</strong> sui suoli della Sicilia. Nota IX: I suoli dell’aziendaPietranera (AG). Estratto da “Quaderni <strong>di</strong> agronomia 11”, Istituto <strong>di</strong> agronomia generale ecoltivazioni erbacee dell’Università degli Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> Palermo, Palermo, Italia, p. 102-162.Panizza M. 1995. Geomorfologia applicata. La Nuova Italia Scientifica, pp. 342.267
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICIPellegrini S., Vignozzi N., Batistoni E., Rocchini A. 2005. Valutazione della suscettibilitàall’incrostamento tramite torbi<strong>di</strong>metria. Estratto dal bollettino della Società Italiana dellaScienza del Suolo, 50, Italia, p. 96-102.Raimon<strong>di</strong> S., Dazzi C. 1986. Gli inceptisuoli dell’azienda Pietranera (AG). Estratto da “Quaderni <strong>di</strong>agronomia 11”, Istituto <strong>di</strong> agronomia generale e coltivazioni erbacee dell’Università degli Stu<strong>di</strong><strong>di</strong> Palermo, Palermo, Italia, p. 23-66.Rasio R., Vianello G. 1995. Classificazione e cartografia del suolo. CLUEB, Bologna, Italia, pp.322.Rawls W.J., Brakensiek D.L. 1983. A procedure to pre<strong>di</strong>ct Green and Ampt. infiltration parameters.In Advances in infiltration. Proc. of the Nat'l Conference on Advances in Infiltration. Dec. 12-13. Chicago, IL, USA. [Online] http://soils.usda.gov/technical/manual/images/fig3-12_large.jpg(verificato il 16/11/2007).Regione Lazio 2004. Carta dell’uso del suolo. Assessorato Urbanistica e Casa. Direzione RegionaleTerritorio e Urbanistica. Area Pianificazione Paesistica e Territorio (carta stampata).RER-AIP (Regione Emilia Romagna, Associazione Italiana Pedologi) 1995. Esperienze sull’usodelle serie nei progetti <strong>di</strong> <strong>rilevamento</strong> e cartografia <strong>dei</strong> suoli. Giunta Regione Emilia Romagna,Bologna, Italia, fascicolato.RER (Regione Emilia Romagna) 1995. Carta <strong>dei</strong> suoli regionale scala 1:50.000. Normativa tecnicagenerale. Regione Emilia-Romagna - Ufficio pedologico servizio cartografico, Bologna, Italia,p. 2-22.Righini G., Costantini E. A. C., Sulli L. 2001. La banca <strong>dati</strong> delle regioni pedologiche italiane. Boll.Soc. It. Scienza del Suolo, 50, suppl., p. 261-271.Sanesi G. 1977. Guida alla descrizione del suolo. Progetto finalizzato “Conservazione del suolo”.CNR, Firenze, Italia, pp. 157.Saxton K.E., Rawls W. J., Romberger J. S., Papen<strong>di</strong>ck R. I. 1986. Estimating generalized soil-watercharacteristics from texture. Soil Sci. Soc. Am. J., 50(4), USA, p. 1031-1036.Sbaraglia M., Lucci E. 1993. Guida all’interpretazione delle analisi del terreno ed allafertilizzazione, Stu<strong>di</strong>o Pedon, Pomezia, Italia, pp. 123.Sbaraglia M., Sbaraglia L. 2007. La capacità <strong>di</strong> scambio cationico nelle analisi podologiche. Attidella giornata <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o sulla scelta e interpretazione <strong>dei</strong> <strong>meto<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> analisi <strong>dei</strong> suoli al fine dellaclassificazione pedologica, CRA, AIP, SIIS, UNIFI, Aprile 2007, Italia, pp. 29. [Online]http://www.aip-suoli.it/download/atti/SISS_apr07_Sbaraglia.pdf (verificato il 16/11/2007).Servizio Geologico d’Italia 1978. Carta Geologica d’Italia in scala 1:500.000.Shoeneberger P. J., Wysocki D. A., Benham E. C., Broderson W. D. 2002. Field Book fordescribing and sampling soils – ver. 2.0 NSSC USDA, Lincoln , NE., USA, pp. 225.Sito comune 2007. Sito <strong>di</strong> sviluppo <strong>di</strong> applicativi gestionali in ambiente Microsoft Access. [Online]http://www.sitocomune.com (verificato il 16/11/2007).Soil Survey Division Staff 1993. Soil Survey Manual. Agricultural Handbook N° 18, USDA,Natural Resources Conservation Service, Washington D.C., USA, pp. 438.Soil Survey Staff 1994. Soil Survey Manual, Agricultural Handbook N° 18, USDA, NaturalResources Conservation Service, Washington D.C., USA, pp. 437.Soil Survey Staff 1999. Soil Taxonomy (Second E<strong>di</strong>tion), USDA, National natural resourcesConservation Service, Washington D.C., USA, pp. 869.268
LA DESCRIZIONE DEL SUOLOSoil Survey Staff 2006. Keys to Soil Taxonomy (Tenth E<strong>di</strong>tion), USDA, Natural ResourcesConservation Service, Washington D.C., USA, pp. 332. [Online]http://soils.usda.gov/technical/classification/tax_keys/keys.pdf (verificato il 16/11/2007).SPADE-2: The Soil Profile Analytical Database for Europe (version 1.0) 2006. John M. Hollis,Robert J.A. Jones, Charles J. Marshall, Ann Holden, Jan Renger van de Veen and LucaMontanarella. EUR 22127 EN. [Online] http://eusoils.jrc.it/projects/spade/Doc_Appl.html(verificato il 20/11/2007).Sulli L., Costantini E. A. C. 1999a. Progetto SINA, Sottoprogetto “Banca <strong>dati</strong> <strong>dei</strong> suoli”. Caratteridegli orizzonti minerali ed organici. Bozza finale – Versione 2.0b. Stampato in proprio, ISSDS,Firenze, Italia, pp. 36. [Online] http://www.issds.it/cncp (verificato il 16/11/2007).Sulli L., Costantini E. A. C. 1999b. Progetto SINA, Sottoprogetto “Banca <strong>dati</strong> <strong>dei</strong> suoli”. Dizionariodelle co<strong>di</strong>fiche caratteri della stazione e del suolo. Bozza finale – Versione 2.2b. Stampato inproprio, ISSDS, Firenze, Italia, pp. 68. [Online] http://www.issds.it/cncp (verificato il16/11/2007).Torrent J., Schwertmann U., Fechter H., Alferez F. 1983. Quantitative relationships between soilcolor and hematite content. Soil Sci. 136, p. 354–358.U.S. Department of Agriculture, Natural Resources Conservation Service 2007. National SoilSurvey Handbook, title 430-VI. [Online] Available: http://soils.usda.gov/technical/handbook/Van Wambeke A., Forbes T., 1986. Guidelines for using Soil Taxonomy in the names of soilmapping units. SMSS Technical Monograph N° 10, USDA, Washington D.C., USA.Vignozzi N., Pellegrini S., Batistoni E., Rocchini A., L’Abate G., Costantini E. A. C. 2005.Suscettibilità al compattamento <strong>di</strong> Inceptisuoli vertici: messa a punto <strong>di</strong> un nuovo in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong>stima. Bollettino della Società Italiana della Scienza del Suolo, Atti del Convegno annuale, Bari,Italia, p. 203-210.Viviano L., Cassi F. 2006. I suoli della Basilicata. Carta pedologica della regione Basilicata in scala1:250.000, note illustrative. Regione Basilicata – Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale,economia montana – Ufficio risorse naturali in agricoltura, Potenza, Italia, pp. 343.Von Post L. 1924. Das Genetische System der Organogenen Bildugen Shwedens, Memoires sur lanomentwe et la Classification des sols. Int. Committee Soil Sci. (1924), p. 287–304.Wallkillcolor 2008. Munsell Conversion Software - V8.0.1. [Online] Available:http://livingstonmanor.net/Munsell/index.htmZanella A., Tomasi M., De Siena C., Frizzera L., Jabiol B., Nicolini G. 2001. Humus Forestali.Manuale per il riconoscimento e l’interpretazione. Applicazione alle faggete. Ed. Centro <strong>di</strong>Ecologia Alpina, Trento, Italia, pp. 321.269
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICIIn<strong>di</strong>ce analiticoAccuratezza................................................252Adesività ....................................................199Arco ...................................................252; 255Argilla, pellicole ........................................212Aspetti antropogenici.................................179Aspetti pedo-biologici................................179Aspetti superficiali.....................................179Attività biologica .......................................217Attributo.....................................................252Banca <strong>dati</strong> geografica.................. 29; 252; 253Banca <strong>dati</strong> pedologica............... VIII; 29; 252;253; 257; 259; 260Campionamento.........................................219Carattere ambientale ..........................252; 253Caratteri e qualità funzionali.... XI; 10; 11; 12;13; 15; 98; 100; 119;146; 221; 252; 256; 257Carta geografica.................................252; 258Cartografia <strong>di</strong> base.....................................252Cementazione, grado <strong>di</strong> .............................198Ciottoli .......................................................196Classificazione...........................................219Colore.........................................................188Componenti territoriali 10; 11; 14; 23; 25; 29;36; 42; 46; 68; 74; 75; 80; 81; 103;104; 106; 111; 115; 136; 137; 253; 258Composizione granulometrica ...................170Concentrazioni...........................................208Concrezioni................................................208Conducibilità idraulica satura ....................207Consistenza ................................................198Contenitori pedogeografici . 29; 253; 257; 260Coor<strong>di</strong>nate..................................................152Correlazione pedologica ...............XII; 10; 23;67; 68; 118; 253Cristalli.......................................................208Croste.........................................................208Curvatura del sito.......................................154Datum.........................................................152DEM........................................ 23; 33; 35; 253Deposizione ...............................................161Descrivente, carattere.................. 29; 253; 257Digitale................ 67; 150; 151; 252; 253; 255Discriminante, carattere................. 16; 33; 40;42; 45; 253Durezza ......................................................170Elementi territoriali.................. 23; 25; 30; 45;46; 82; 253Elemento morfologico.......................155; 160Erosione..................................................... 161Esposizione................................................ 153Facce <strong>di</strong> pressione...................................... 213Falda superficiale....................................... 221Fase <strong>di</strong> serie .......................................253; 260Fattori <strong>di</strong> stato....................................253; 255Ferromanganesifere, pellicole ................... 212Fessure....................................................... 211Fessure superficiali.................................... 181Fisiografia.................... 23; 33; 40; 45; 49; 81;95; 137; 154; 155; 254; 255Forma......................................................... 155Fotointerpretazione.....................3; 21; 23; 40;254; 256; 258Frammenti grossolani ........................170; 196Gauss-Boaga......................................254; 258Geografia del suolo..................................254Geologia .................................................... 162Georeferenziare ......................................... 257Gerarchia <strong>dei</strong> pedopaesaggi...........29; 30; 254Gestione delle acque.................................. 226Ghiaia ........................................................ 196GIS.............. 21; 254; 255; 257; 258; 259; 260GPS....................................................152; 254Granulometrica, classe .............................. 195Idromorfia, sta<strong>di</strong> <strong>di</strong> ......................................... 229Incertezza dell'informazione pedologica ......2;14; 254In<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> atten<strong>di</strong>bilità.........................106; 254In<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> purezza................................103; 254In<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> determinazione dell'incertezza .... 254Lambert..............................................255; 258Latitu<strong>di</strong>ne...........................115; 152; 255; 257Layer..........................................255; 256; 260Limite dell'orizzonte.................................. 184Limiti granulometrici USDA..................... 191Limo, pellicole........................................... 212Livello <strong>di</strong> generalizzazione.XII; 7; 10; 29; 30;33; 68; 74; 254; 255; 257; 258; 259Longitu<strong>di</strong>ne........................115; 152; 255; 257Macropori .................................................. 210Manufatti ................................................... 217Massi.......................................................... 196Materiale genitore.. 2; 3; 4; 31; 129; 148; 162;170; 172; 189; 248; 255; 256Materiale organico, copertura.................... 180Metodo ascendente ..............................33; 255270
LA DESCRIZIONE DEL SUOLOMetodo <strong>di</strong>scendente .............................33; 255Minipit .............................. 147; 149; 256; 257Modello <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione <strong>dei</strong> suoli .............255Morfogenesi, fattori o agenti della.....253; 255Morfologia .....XI; XII; 2; 3; 4; 10; 11; 12; 29;30; 33; 36; 43; 81; 106; 252; 253; 255; 256Morfometria.............................. 154; 155; 255Mosaicatura................................................255Munsell, tavole colorimetriche ..................188Nodo...................................................252; 255Noduli ........................................................208Orizzonti ....................................................182Orizzonti <strong>di</strong>agnostici..................................182Orizzonti eterogenei...................................187Orizzonti funzionali .....IX; XI; 10; 11; 12; 16;17; 74; 97; 99; 114; 255Orizzonti genetici.......................................182Osservazione pedologica ... 10; 11; 16; 77; 78;80; 82; 84; 88; 106; 107; 108; 109;110; 115; 150; 152; 252; 254; 256; 260Osservazione spe<strong>di</strong>tiva ..............................149Osservazione spe<strong>di</strong>tiva ........................70; 256Osservazione tipica..............................15; 256Osservazione, tipo <strong>di</strong>..................................147Paesaggio pedologico ................... 2; 255; 256Para<strong>di</strong>gma ......................................................5Para<strong>di</strong>gma suolo-paesaggio .......................256Para<strong>di</strong>gma suolo-risposta all'uso................256Parent material ...........................................162Pattern ................................... 33; 35; 256; 258Pedo<strong>di</strong>versità................................. IX; 10; 256Pedogenesi, fattori della............. 2; 4; 6; 7; 14;21; 30; 33; 35; 40; 154; 253; 256; 257; 260Pedon ................5; 6; 147; 191; 219; 256; 257Pedopaesaggio ...................2; 4; 6; 10; 12; 29;74; 106; 111; 136; 254; 256; 276Pedopaesaggio, scala del............................258Pendenti .....................................................208Pendenza ....................................................153Permeabilità ...............................................207pH...............................................................197Pietre ..........................................................196Pietrosità superficiale.................................180Pixel .......................................... 254; 257; 258Plasticità.....................................................199Poligono... XII; 23; 29; 30; 42; 45; 46; 70; 75;81; 106; 111; 136; 138; 253; 254; 257Pori ............................................................210Porosità .....................................................210Pozzetto................. 15; 70; 147; 149; 256; 257Processi pedogenetici.................................154Profilo........................................................ 147Profilo caposaldo....................15; 16; 85; 101;103; 114; 257Profilo <strong>di</strong> suolo ..XI; 1; 6; 15; 25; 70; 89; 147;148; 151; 162; 163; 182; 189;219; 221; 225; 256; 257Profilo modale ...................12; 13; 16; 99; 257Profon<strong>di</strong>tà .................................................. 226Proiezione..................252; 254; 255; 257; 259Province <strong>di</strong> terre ..................................30; 257Punto..................................252; 254; 255; 257Punto <strong>di</strong> controllo ...................................... 257Qualità <strong>dei</strong> materiali .................................. 169Quota ......................................................... 152Raster.........................253; 254; 257; 258; 260Raster, immagine.......................254; 257; 261Regioni pedologiche................ IX; 30; 33; 67;136; 253; 257Relazioni pedologiche funzionali .......4; 8; 14;33; 254; 258; 259Relazioni spaziali...................................7; 258Resistenza a rottura.................................... 198Rilevamento pedologico...............21; 23; 106;152; 258; 260Rischio <strong>di</strong> inondazione .............................. 223Risoluzione........................................151; 258Rocciosità .................................................. 180Sabbia, pellicole ........................................ 212Scala .........VIII; IX; 2; 3; 4; 7; 11; 16; 30; 33;36; 40; 45; 66; 150; 155; 252; 253;254; 255; 256; 257; 258; 259; 260Scala nominale........................................... 258Scala, carta topografica ............................. 150Scheletro............................................170; 196Screziature, abbondanza ............................ 190Screziature, colore................................... 190Screziature, <strong>di</strong>mensioni ............................. 190Screziature, evidenza................................. 191Semantica ........ 11; 16; 25; 36; 42; 68; 70; 82;94; 103; 106; 111; 254; 258Serie <strong>di</strong> suoli...... VIII; 5; 6; 14; 253; 258; 260Sezione, origine ......................................... 150Sigla della carta ......................................... 150Sistema <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>nate ..........70; 252; 254; 258Sistema <strong>di</strong> proiezione ................252; 257; 258Sistema <strong>di</strong> riferimento ............................... 152Sistema <strong>di</strong> riferimento .......115; 254; 257; 259Sistema <strong>di</strong> terre... 11; 23; 36; 74; 82; 137; 259Sistema GIS ni<strong>di</strong>ficato............................... 259Sistema informativo pedologico....IX; 66; 259Sito pedologico ...............68; 74; 75; 147; 259271
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICISkeletans ....................................................212Soil body........................................... 7; 8; 259Soil region.7; 8; 29; 30; 36; 94; 110; 257; 259Soilscape ....................................... 7; 8; 9; 259Soluzioni <strong>di</strong> continuità...............................169Sostanza organica, pellicole.......................212Sottosistema <strong>di</strong> terre....................... 11; 23; 30;42; 75; 82; 259Spessore .....................................................186Standard <strong>di</strong> analisi........................................91Standard <strong>di</strong> <strong>rilevamento</strong>.............................259Stato del suolo............................................179Stato <strong>di</strong> alterazione.....................................168Stazione......................................................152Stazione <strong>di</strong> <strong>rilevamento</strong> ..... 70; 74; 77; 84; 88;102; 115; 116; 125; 126;149; 152; 224; 260; 269Strati <strong>di</strong> suolo.............................................182Strato informativo, geografico o layer. 23; 30;36; 40; 42; 107; 111; 256; 260Strato.....7; 170; 182; 183; 184; 219; 259; 260Struttura .....................................................203Struttura del substrato ................................167Struttura primaria.....................................206Struttura secondaria................................... 206STS .......................XII; 10; 14; 16; 66; 67; 74;85; 93; 111; 136; 254; 259; 260Substrato.................................................... 162Substrato non consolidato.......................... 165Tabella degli attributi ........35; 42; 43; 46; 260Tessitura .................................................... 191Tessitura, classi.......................................... 192Tessitura, stima in campo.......................... 191Topologia...................................253; 258; 260Trivellata............... 15; 70; 147; 148; 256; 260Umi<strong>di</strong>tà’..................................................... 188Unità cartografica ..... 6; 9; 253; 254; 259; 260Unità <strong>di</strong> paesaggio .......................21; 260; 262Unità <strong>di</strong> terre........ 23; 45; 67; 70; 74; 81; 103;106; 107; 115; 136; 152; 253; 260Unità fisiografica.................................33; 260Uso del suolo ............................................. 172UTS............XII; 4; 10; 14; 16; 66; 67; 74; 260Variabilità pedologica ...................21; 25; 260Variante <strong>di</strong> serie.................................253; 260Vegetazione ............................................... 172Vettoriale .............................30; 252; 258; 261Vuoti.......................................................... 210272
LA DESCRIZIONE DEL SUOLOTAVOLEAppen<strong>di</strong>ciTavole sinottiche per la stima percentuale <strong>di</strong> coperturaSi usa prevalentemente per la stima percentuale dell’abbondanza <strong>dei</strong> macropori, dello scheletro edelle screziature (Sanesi, 1977).273
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICITavole per la stima della <strong>di</strong>mensione degli aggregatiPrismatica e ColonnareTAVOLEMolto fine (< 1 cm <strong>di</strong> larghezza)Fine ( 1 – 2 cm <strong>di</strong> larghezza)Me<strong>di</strong>a ( 2 – 5 cm <strong>di</strong> larghezza)Grossolana ( 5 - 10 cm <strong>di</strong> larghezza)Molto grossolana ( > 10 cm <strong>di</strong> larghezza)[ 10 cm – non mostrato ]CuneiformeMolto fine (< 1 cm <strong>di</strong> spessore)1Fine ( 1 – 5 cm <strong>di</strong> spessore)5Me<strong>di</strong>a ( 5 – 10 cm <strong>di</strong> spessore)Grossolana ( 10 - 60 cm <strong>di</strong> spessore)[10 cm – non mostrato]Molto grossolana ( > 60 cm <strong>di</strong> spessore)[60 cm – non mostrato]274
LA DESCRIZIONE DEL SUOLOTAVOLEGrumosa e granulareMolto fine (< 0.1 cm <strong>di</strong> <strong>di</strong>ametro)Fine ( 0.1 – 0.2 cm <strong>di</strong> <strong>di</strong>ametro)Me<strong>di</strong>a ( 0.2 – 0.5 cm <strong>di</strong> <strong>di</strong>ametro)Grossolana ( 0.5 - 1 cm <strong>di</strong> <strong>di</strong>ametro)Molto spessa grossolana ( > 1 cm <strong>di</strong> <strong>di</strong>ametro)Molto fine (< 0.5 cm <strong>di</strong><strong>di</strong>ametro)Fine ( 0.5 – 1 cm <strong>di</strong><strong>di</strong>ametro)Me<strong>di</strong>a ( 1 – 2 cm <strong>di</strong><strong>di</strong>ametro)Poliedrica angolare e subangolareGrossolana ( 2 - 5 cm <strong>di</strong><strong>di</strong>ametro)Molto grossolana ( > 5 cm<strong>di</strong> <strong>di</strong>ametro)[ 5 cm – non mostrato ]Molto sottile (< 0.1 cm <strong>di</strong> spessore)LamellareSottile ( 0.1 – 0.2 cm <strong>di</strong> spessore)Me<strong>di</strong>a ( 0.2 – 0.5 cm <strong>di</strong> spessore)Spessa ( 0.5 - 1 cm <strong>di</strong> spessore)Molto spessa ( > 1 cm <strong>di</strong> spessore)275
LINEE GUIDA DEI METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICITavole per la stima della frequenza <strong>dei</strong> macroporiLe tavole possono essere utilizzate anche per la stima <strong>di</strong> altre caratteristiche <strong>di</strong> forma rotonda(Sanesi, 1977).TAVOLE0.1% 0.5%2 % 5%La scheda <strong>di</strong> <strong>rilevamento</strong>Nella scheda <strong>di</strong> <strong>rilevamento</strong> alcune parti sono riservate alla possibilità <strong>di</strong> riportare annotazioni sottoforma <strong>di</strong> schemi, <strong>di</strong>segni o scritto, per descrivere quelle caratteristiche relative al paesaggio, al suoloo alle loro relazioni che il rilevatore reputa importante sottolineare. In particolare, si raccomanda <strong>di</strong>riportare le caratteristiche del pedopaesaggio, della geografia del suolo nell’elemento territoriale ese occorre anche del profilo. Vi sono <strong>dei</strong> campi nei quali è possibile evidenziare, sotto forma <strong>di</strong>co<strong>di</strong>ci, le caratteristiche semantiche del sito per i caratteri geografici superiori a quellidell’elemento territoriale. É inoltre possibile riferire l’osservazione a tipologie <strong>di</strong> suolo già definiteod anche ad un’altra osservazione. In quest’ultimo caso occorre riportare il co<strong>di</strong>ce dell’osservazione.276
CODICI DELL'OSSERVAZIONE - CARATTERI DELLA STAZIONECODICE DEL RILEVAMENTO: COM1 TIPO DI OSSERVAZIONE: P NUMERO: 72COMUNE E PROVINCIA:Vigano San Martino SienaRILEVATORI: Angelo RasuloDATA: 04/10/2007LOCALITA': casolareORIGINE DELLA SEZIONE: 5 CARTA, Tipo:2 CARTA, Scala: 2 CARTA, Sigla: 327100S.Rif.Fuso/Datum: utm 33 wgs84 Y (N): 4746144X (E): 402006 LAT.:LONG.:QUOTA: 20 PENDENZA (%): 1ESPOSIZIONE:CAR.SUP., Ped-bio: CAR.SUP., Antr.: CAR.SUP., Stato: NE Cop.S.O:USO DEL SUOLO: 133 VEGETAZIONE:COP. VEGET: ROCC.(%): 0 PIETR.(%):
CODICI DELL'OSSERVAZIONE - CARATTERI DELLA STAZIONECODICE DEL RILEVAMENTO: COM1 TIPO DI OSSERVAZIONE: P NUMERO: 72COMUNE E PROVINCIA:Vigano San Martino SienaRILEVATORI: Angelo RasuloDATA: 04/10/2007LOCALITA': casolareORIGINE DELLA SEZIONE: 5 CARTA, Tipo:2 CARTA, Scala: 2 CARTA, Sigla: 327100S.Rif.Fuso/Datum: utm 33 wgs84 Y (N): 4746144X (E): 402006 LAT.:LONG.:QUOTA: 20 PENDENZA (%): 1ESPOSIZIONE:CAR.SUP., Ped-bio: CAR.SUP., Antr.: CAR.SUP., Stato: NE Cop.S.O:USO DEL SUOLO: 133 VEGETAZIONE:COP. VEGET: ROCC.(%): 0 PIETR.(%):
CARATTERI DEGLI ORIZZONTICODICE DEL RILEVAMENTO: 0 TIPO DI OSSERVAZIONE: 0 NUMERO: 0LIMITI COLORE MASSAFIGURE OSS.RID. E SCREZIATUREFRAMMENTI GROSSOLANIUMIDOSECCOPRINCIPALI SECONDARIEPRINCIPALISECONDARIIATT.BIOHCLABBONDANZA %DIMENSIONE mmEVIDENZAABBONDANZA %DIMENSIONE mmEVIDENZAABBONDANZA %FORMAALTERAZIONEABBONDANZA %FORMAALTERAZIONETIPOQUANTITA'EFFERVESCENZALOCALIZZAZ.1 Ap 30 30 30 30 30 30 2 1 2 2,5Y5/3 MS07,5 2 1 4 12 Bw1 65 70 75 35 40 45 2 2 2 2,5Y5/4 MS2,5Y61 1 OMR 8 107,5 2 1 4 13 Bw2 100 110 115 25 40 50 2 2 2 2,5Y6/4 MS07,54 14 Bw3 200 90 5 2 2,5Y5/3 MS2,5Y61 5 OMR 10 1 2,5Y6/6 2 OMF 10 1 07,54 15678CL. GRANUL. S.T.FORMADIMENSIONIGRADO AGGREG.FORMADIMENSIONIGRADO AGGREG.CONDUC. IDRAULICAABBONDANZA %DIMENSIONI mmABBONDANZA %DIMENSIONI mmABBONDANZADIMENSIONI mmABBONDANZA %DIMENSIONI mmQUANTITA'DIMENSIONI mmTIPOSPESSORELOCALIZZAZ.TIPOSPESSORELOCALIZZAZ.TIPODIMENSIONE mmQUANTITA'ANDAMENTODIMENSIONE mmQUANTITA'ANDAMENTOUMIDITA'pH (H 2 O)CONSIST.STRUTTURAPRINC. SEC.PRINC.SEC.RADICI CAMPION.PRINC. SEC.NUMERO ORIZZONTEARGILLA %SABBIA TOTALE %SABBIA
87654321NUMERO ORIZZONTEARGILLA %SABBIA TOTALE %87654321NUMERO ORIZZONTECODICE ORIZZONTESABBIA
Finito <strong>di</strong> stamparenel mese <strong>di</strong> Maggio 2008da- Firenze
Le linee guida <strong>dei</strong> <strong>meto<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>rilevamento</strong> ed <strong>informatizzazione</strong> <strong>dei</strong> <strong>dati</strong> <strong>pedologici</strong>sintetizzano lo stato dell’arte e forniscono un riferimento per coloro che sioccupano <strong>di</strong> cartografia pedologica. Recepiscono molte delle in<strong>di</strong>cazionipresenti nella manualistica internazionale, ma ere<strong>di</strong>tano anche le esperienzerealizzate nei centri <strong>di</strong> ricerca italiani e nei servizi <strong>pedologici</strong> regionali, che hannocontribuito alla creazione <strong>di</strong> una metodologia <strong>di</strong> correlazione e spazializzazione<strong>dei</strong> <strong>dati</strong> <strong>pedologici</strong> per molti aspetti innovativa.Il testo è strutturato in quattro capitoli ed altrettanti glossari ed appen<strong>di</strong>ci. Nelprimo capitolo si forniscono i riferimenti generali circa le principali metodologie <strong>di</strong><strong>rilevamento</strong> pedologico esistenti e i relativi assunti teorici. L’applicazione del<strong>rilevamento</strong> ragionato, presa come riferimento, presuppone la creazione <strong>di</strong> unitàtipologiche <strong>di</strong> suolo (UTS), che si realizza per mezzo della correlazione pedologica.Nel capitolo viene presentato il sistema <strong>di</strong> correlazione agevolato dall’uso delgeodatabase. Il secondo capitolo è relativo alle banche <strong>dati</strong> geografiche.L’organizzazione spaziale delle informazioni pedologiche avviene a <strong>di</strong>versi livelligeografici, cui corrispondono specifici livelli <strong>di</strong> generalizzazione dell’informazione:dal più generale, le regioni pedologiche finalizzata alla correlazione europea, finoa quella <strong>di</strong> dettaglio, le unità <strong>di</strong> terre per applicazioni locali. Esiste quin<strong>di</strong> unsistema <strong>di</strong> banche <strong>dati</strong> in cui sono co<strong>di</strong>ficati i legami tra suoli e paesaggio ai<strong>di</strong>versi livelli geografici e <strong>di</strong> generalizzazione pedologica.Il terzo capitolo è de<strong>di</strong>cato al software “CNCP”. Per quanto riguarda l’inserimento<strong>dei</strong> <strong>dati</strong> <strong>pedologici</strong> puntuali, l’attività è facilitata dalla presenza <strong>di</strong> menù a ten<strong>di</strong>nache richiamano e deco<strong>di</strong>ficano le legende e le classi <strong>dei</strong> vari caratteri utilizzatedalle linee guida. Sono fornite una serie <strong>di</strong> funzioni che verificano il correttoinserimento <strong>dei</strong> <strong>dati</strong>, in particolare per quanto riguarda i <strong>dati</strong> analitici,evidenziando le incongruenze. Grazie al software CNCP possono essere attivateanche una serie <strong>di</strong> pedofunzioni, in particolare: il calcolo della capacità <strong>di</strong> acqua<strong>di</strong>sponibile; la stima della capacità <strong>di</strong> scambio cationico; la determinazione dellacapacità depurativa <strong>dei</strong> suoli e della capacità protettiva <strong>dei</strong> suoli nei confrontidelle acque profonde; la stima della permeabilità degli orizzonti e del gruppoidrologico <strong>dei</strong> suoli; la classe <strong>di</strong> capacità d’uso; la stima dell’interferenza climaticanei siti e del pedoclima; la stima del rischio <strong>di</strong> incrostamento superficiale e delrischio <strong>di</strong> compattamento superficiale.Il quarto capitolo è de<strong>di</strong>cato alla descrizione del suolo. Esso costituisce la guida <strong>di</strong>campagna e fa riferimento alla manualistica internazionale, integrata con i risultatidelle esperienze realizzate in Italia. Le legende sono organizzate in formagerarchica, in maniera da poter essere utilizzate con <strong>di</strong>versi livelli <strong>di</strong>generalizzazione, corrispondenti a <strong>di</strong>verse scale geografiche. Le linee giuda sonocorredate da quattro glossari: i) termini geomorfologici, ii) substrati consoli<strong>dati</strong> e iii)non consoli<strong>dati</strong>, iv) principali termini <strong>pedologici</strong> e informatici; nonché daaltrettante appen<strong>di</strong>ci: i) tavole sinottiche per la stima delle percentuali <strong>di</strong>copertura del suolo, ii) tavole per la stima della <strong>di</strong>mensione degli aggregati, iii)tavole per la stima della frequenza <strong>dei</strong> macropori, iv) scheda <strong>di</strong> <strong>rilevamento</strong>. Iltesto infine è corredato da un ampio in<strong>di</strong>ce analitico e da un Cd-rom, grazie alquale è possibile installare il software CNCP su ogni computer ed accedere allaguida in linea. Nel Cd-rom sono contenuti anche due database aggiuntivi: ildatabase ST500_2007, dove sono contenute le legende <strong>dei</strong> sistemi <strong>di</strong> terre italiani,e il database MICROMORPHO, per l’archiviazione delle descrizioni derivanti daanalisi micromorfologica.
METODI DI RILEVAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI PEDOLOGICI