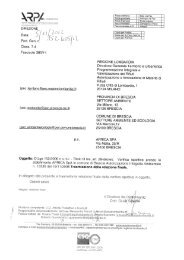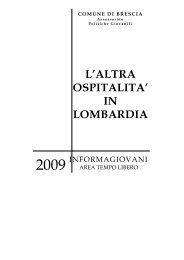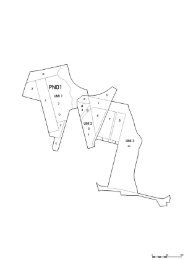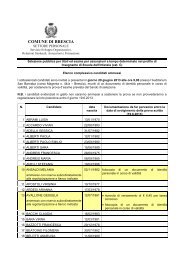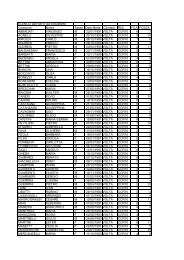Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>VIA</strong> <strong>TOSIO</strong><br />
1. palazzo san Paolo già Chizzola, n.1<br />
2. palazzo Beretta già Martinengo da Barco, n.6<br />
3. palazzo già Bonoris, n.8<br />
4. palazzo Tosio (sede dell’Ateneo), n.10-12-14<br />
5. casa Archetti, n.18<br />
6. casa Gan<strong>di</strong>ni, n.20<br />
7. casa Mazzola già Lupatini, n.24<br />
8. palazzo Sigismon<strong>di</strong> già Conter, n.28<br />
Toponomastica e cenni storici<br />
Poco a sud <strong>di</strong> via Tosio correvano nel XII secolo le mura<br />
citta<strong>di</strong>ne e la loro demolizione portò alla formazione dei<br />
<strong>di</strong>slivelli e dei terragli su cui sorsero vari palazzi nei secoli<br />
successivi. Nella zona <strong>di</strong> via Gabriele Rosa si apriva<br />
la porta urbica detta porta Nuova, mentre più a est, in<br />
corrispondenza <strong>di</strong> via Crispi, esisteva porta Matolfa,<br />
che, secondo alcuni storici, era originariamente de<strong>di</strong>cata ai santi patroni Faustino<br />
e Giovita e denominata successivamente Matolfa perché riformata da un duca<br />
Longobardo <strong>di</strong> nome Matolfo. Proprio all’incrocio <strong>di</strong> porta Matolfa, poi detta<br />
porta Cremonensis, sul lato destro della via si scorge una porzione <strong>di</strong> colonna murata<br />
nell’angolo <strong>di</strong> un palazzo, sormontata da un piccolo riquadro che racchiude<br />
un mezzo busto romano.<br />
Questa zona era ricca <strong>di</strong> monasteri e luoghi <strong>di</strong> culto. All’inizio del tracciato, sul<br />
versante settentrionale, era la chiesa trecentesca <strong>di</strong> santa Maria <strong>di</strong> Passione, demolita<br />
per lasciare posto al palazzo che fino al 1806 fu della famiglia Chizzola.<br />
All’inizio del Novecento fu acquistato dalla Banca san Paolo che ne fece la propria<br />
sede. Nel 1902, per volere <strong>di</strong> Giuseppe Tovini, vi ebbero sede anche numerose<br />
organizzazioni cattoliche e l’e<strong>di</strong>ficio fu chiamato palazzo san Paolo. Qui si<br />
trovavano anche le <strong>di</strong>rezioni del quoti<strong>di</strong>ano Il citta<strong>di</strong>no <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong> e della casa<br />
e<strong>di</strong>trice Morcelliana. L’e<strong>di</strong>ficio fu abbattuto all’inizio degli anni Sessanta ed al<br />
suo posto sorse l’attuale palazzo che del precedente ha conservato solo alcune<br />
cornici alle finestre del primo piano.<br />
Nel tratto compreso tra via Gabriele Rosa e via Cereto esisteva il complesso mo-<br />
12
nasteriale dei santi Felice e Fortunato, nel quale furono trasferite dal vescovo Berardo<br />
Maggi nel 1294 le suore benedettine <strong>di</strong> Manerbio. La chiesa annessa fu prima<br />
intitolata santa Pace e poi santa Maria della Pace. Il vecchio monastero <strong>di</strong><br />
santa Maria della Pace, dopo le espoliazioni del 1797, fu in parte acquistato dalla<br />
famiglia <strong>di</strong> Rodolfo Vantini. In una parte dell’e<strong>di</strong>ficio nel 1805 Giovanni Donegani<br />
aveva progettato <strong>di</strong> inse<strong>di</strong>are gli uffici <strong>di</strong> Finanza con il deposito <strong>di</strong> sali e<br />
tabacchi, progetto che non trovò però realizzazione. Il complesso fu completamente<br />
<strong>di</strong>strutto negli anni Cinquanta.<br />
L’altro antico complesso è l’ex monastero <strong>di</strong> santo Spirito, acquistato dal <strong>Comune</strong><br />
nel 1878 per inse<strong>di</strong>arvi l’istituto magistrale «Veronica Gambara» ancora oggi<br />
esistente.<br />
Via Tosio fu oggetto <strong>di</strong> numerosi progetti demolitori, a partire da quello quattrocentesco<br />
che portò all’abbattimento della cinta muraria del XII secolo, per giungere<br />
a quello ottocentesco, solo in parte realizzato, che prevedeva un allargamento<br />
sia <strong>di</strong> questa via che <strong>di</strong> via Trieste, su proposta <strong>di</strong> Luigi Basiletti. Buon esito<br />
ebbe invece il progetto dell’architetto Piacentini, che in epoca fascista voleva fare<br />
<strong>di</strong> via Tosio l’asse centrale est-ovest della città. Venne così attuato un ampliamento<br />
dell’imbocco su piazzale Arnaldo tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio degli<br />
anni Sessanta. La via infatti proseguiva lungo tutta l’attuale parete nord <strong>di</strong><br />
piazzale Arnaldo e sboccava in asse con porta Torrelunga, poi porta Venezia.<br />
All’inizio dell’Ottocento la strada aveva numerose denominazioni, tra cui anche<br />
quella <strong>di</strong> contrada della Pace. La via venne intitolata a Paolo Tosio poco dopo la<br />
morte del conte (1842) che proprio su questo tracciato aveva la sua <strong>di</strong>mora e che<br />
morendo aveva lasciato la sua ricca collezione <strong>di</strong> opere d’arte al <strong>Comune</strong>, compreso<br />
il suo palazzo, dove dal 1851 ebbe sede la prima Pinacoteca civica bresciana.<br />
Passeggiando per via Tosio<br />
All’angolo con via Gabriele Rosa al civico 1 si trova palazzo san Paolo (1). Verso<br />
la fine del XV secolo un ramo della famiglia Chizzola aveva acquistato, in<br />
prossimità delle mura urbiche, una casa che nel secolo successivo venne sostituita<br />
da un più grande palazzo con fattezze secentesche. Nella seconda metà del Settecento,<br />
forse l’architetto Marchetti apportò ulteriori mo<strong>di</strong>fiche. Un basso androne<br />
conduce al cortile con due lati porticati scan<strong>di</strong>ti da eleganti colonne dai capitelli<br />
ionici. Tra i rifacimenti settecenteschi era anche l’ampio scalone con balaustra<br />
che conduce al piano nobile <strong>di</strong>videndo il palazzo in due parti caratterizzate<br />
dal susseguirsi <strong>di</strong> ambienti elegantemente affrescati. Numerosi furono i passaggi<br />
13
<strong>di</strong> proprietà fino all’inizio del Novecento quando il palazzo fu acquistato dalla<br />
Banca San Paolo per farne la propria sede. Da qui la denominazione <strong>di</strong> palazzo<br />
san Paolo. La banca poi lo cedette alla Curia negli anni Cinquanta e nel 1956 fu<br />
<strong>di</strong>strutto per innalzare una nuova grande casa. Alcuni elementi del palazzo vennero<br />
conservati all’interno, come lo scalone e le colonne, mentre all’esterno vennero<br />
riutilizzate alcune cornici barocche per decorare le finestre del primo piano.<br />
Percorrendo il lato sud della via, al numero 6 si incontra l’imponente facciata <strong>di</strong><br />
palazzo Beretta già Martinengo da Barco (2). Il lungo prospetto è scan<strong>di</strong>to da<br />
una fascia marcapiano in pietra bianca che separa l’or<strong>di</strong>ne inferiore da quello superiore.<br />
Al centro si apre il portale dalle fattezze ancora rinascimentali, pur essendo<br />
la costruzione già pienamente barocca. L’androne con volta a botte conduce al<br />
portico scan<strong>di</strong>to da cinque arcate con volte a crociera e colonne tuscaniche. Il palazzo<br />
è costruito su pianta<br />
ad U e nel corpo centrale,<br />
sopra le finestre del<br />
piano nobile, corre un<br />
cornicione oltre il quale<br />
si apre un attico con balaustra<br />
e due statue alle<br />
estremità. Fra le due ali<br />
del palazzo, chiude il<br />
cortile una cancellata con<br />
quattro colonne sulle<br />
quali poggiano piccole<br />
statue. Oltre il giar<strong>di</strong>no,<br />
su corso Magenta si innalza<br />
la maestosa cancellata<br />
barocca. Un alto stilobate<br />
sostiene tutta la<br />
cancellata ed è interrotto<br />
dall’apertura <strong>di</strong> due cancelli<br />
che danno accesso al<br />
giar<strong>di</strong>no. Gli scomparti<br />
sono scan<strong>di</strong>ti da colonne<br />
doriche il cui capitello è<br />
sormontato da una sfera<br />
Palazzo Beretta già Martinengo da Barco: facciata su<br />
corso Magenta<br />
14<br />
ed una lancia. Nella parte<br />
superiore dei due cancel-
li apribili fa da coronamento lo stemma della famiglia Martinengo da Barco. Tornando<br />
al corpo centrale del palazzo uno scalone conduce al piano nobile dove si<br />
apre una galleria con pareti e soffitto decorati. Alle pareti corrono fregi e cornici<br />
in stucco bianco e oro mentre nel soffitto stucchi della fine del Seicento <strong>di</strong>segnano<br />
una sorta <strong>di</strong> finto pergolato con graticci, foglie e uccelli. Decorazioni successive<br />
hanno contribuito ad abbellire il nobile palazzo. Le più recenti sono ad opera<br />
<strong>di</strong> Gaetano Cresseri, in due sale del pian terreno (1920 ca.). Numerosi furono<br />
i passaggi <strong>di</strong> proprietà finché negli anni Trenta del Novecento il palazzo fu acquistato<br />
dall’industriale Giuseppe Beretta, proprietario <strong>di</strong> una delle più antiche fabbriche<br />
d’armi <strong>di</strong> Gardone Valtrompia.<br />
Sullo stesso lato della via, confinante con palazzo Beretta, si incontra palazzo già<br />
Bonoris (3), fatto costruire nel Settecento dalla famiglia Salvi. In questo tratto <strong>di</strong><br />
via, per un lungo periodo vi furono parecchie abitazioni sostituite nel Settecento<br />
da questa che fu della famiglia Salvi e nell’Ottocento da quella a<strong>di</strong>acente fatta sistemare<br />
dal conte Paolo Tosio ad opera dell’architetto Vantini. I principali proprietari<br />
<strong>di</strong> queste <strong>di</strong>more dovevano essere i Maggi, da cui la famiglia Salvi acquistò<br />
per dare forma all’attuale palazzo demolendo le costruzioni precedenti. Tra i<br />
successivi vari passaggi <strong>di</strong> proprietà nell’Ottocento il palazzo fu venduto alla famiglia<br />
Bonoris <strong>di</strong> origini mantovane. Un <strong>di</strong>scendente, Gaetano Bonoris, abitando<br />
tra Mantova e Montichiari dove si era fatto costruire un castello, vendette questo<br />
palazzo al <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong> che prima lo a<strong>di</strong>bì ad istituto educativo femminile<br />
e poi, dal 1925, affittato a partiti politici. Attualmente è <strong>di</strong>ventato sede della segreteria<br />
e della presidenza dell’Ateneo <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong> (aperto da lunedì a venerdì, dalle<br />
15.00 alle 18.00; per informazioni telefono 030/41006). Esternamente la facciata<br />
si presenta sobria, interrotta al centro da un portone che introduce nell’atrio<br />
sostenuto da quattro colonne. Un ampio scalone a due rampe conduce al piano<br />
nobile dove si apre il salone decorato. Nel soffitto un’elaborata architettura illusionistica<br />
fa da cornice alla trionfante composizione centrale dove un guerriero<br />
sale all’Empireo accolto dalla Fama e dalla Luce mentre le pareti sono decorate<br />
con prospettive e riquadri a monocromo.<br />
Dove oggi sorge il palazzo dell’Ateneo (4), ai numeri 10, 12 e 14, originariamente<br />
era la <strong>di</strong>mora del nobile conte Paolo Tosio e della moglie contessa Paolina Bergonzi,<br />
<strong>di</strong>ventata poi la prima sede della Pinacoteca Tosio. Il palazzo sorgeva su<br />
un’area in cui, agli inizi del XIX secolo, esistevano e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> proprietari <strong>di</strong>versi.<br />
Erano costruzioni modeste che si sviluppavano con le loro facciate sul lato <strong>di</strong> via<br />
Tosio, partendo dall’angolo con contrada Fontana Coperta (ora via Crispi). Procedendo<br />
verso ovest vi era la casa <strong>di</strong> Giambattista Filippini, poi quella della famiglia<br />
dei conti Tosio, <strong>di</strong> proporzioni piuttosto ridotte, che originariamente ap-<br />
15
parteneva ai conti Maggi; infine la famiglia Colpani possedeva l’ultimo e<strong>di</strong>ficio<br />
confinante con palazzo Bonoris. Dei tre e<strong>di</strong>fici, il più significativo era quello centrale,<br />
con il fabbricato più alto verso la strada, dotato <strong>di</strong> portico a tre arcate con<br />
volte a crociera. Dal portico si accedeva a varie sale, in parte conservate nella<br />
successiva ristrutturazione. Le prime opere <strong>di</strong> sistemazione del palazzo furono<br />
iniziate dal conte Ottavio Tosio, affiancato dal figlio Paolo, che <strong>di</strong>venne suo erede<br />
nel 1815. La ricostruzione del palazzo avvenne per gra<strong>di</strong> e li impegnò dal 1810<br />
circa al 1846. Il conte Tosio seguiva personalmente i lavori <strong>di</strong> ristrutturazione ed<br />
in modo particolare si de<strong>di</strong>cava alle decorazioni, all’arredamento delle sale ed all’acquisto<br />
<strong>di</strong> numerose opere per la sua collezione, tanto che quest’attività costituì<br />
il principale scopo della sua<br />
vita. Il suo intento era quello <strong>di</strong><br />
creare un ambiente raffinato,<br />
ricco <strong>di</strong> opere d’arte e <strong>di</strong> oggetti<br />
preziosi, ove accogliere amici,<br />
monarchi, principi, eru<strong>di</strong>ti<br />
ed artisti <strong>di</strong> passaggio. Voleva<br />
un e<strong>di</strong>ficio non troppo vasto,<br />
dove tutto fosse armonico e<br />
perfetto; doveva essere adatto<br />
per abitazione e nello stesso<br />
tempo sede delle sue raccolte<br />
con ambienti <strong>di</strong> ricevimento e<br />
rappresentanza senza però assumere<br />
l’aspetto <strong>di</strong> un museo. I<br />
primi documenti che attestano<br />
la sistemazione del palazzo risalgono<br />
agli anni 1810-14,<br />
quando Tosio affidò a Luigi<br />
Basiletti l’incarico <strong>di</strong> ristrutturare<br />
alcune sale al piano nobile,<br />
nell’ala nord e in quella orientale<br />
del palazzo.<br />
Numerose furono le varianti<br />
apportate ai progetti fino al<br />
1824 quando Luigi Basiletti fu<br />
sostituito dall’architetto Rodolfo<br />
Vantini. Il motivo <strong>di</strong> tale so-<br />
Palazzo Tosio: sala Renica<br />
16
stituzione non è certo, forse perché Basiletti in quel periodo aveva accettato l’incarico<br />
<strong>di</strong> presiedere gli scavi archeologici del Capitolium bresciano.<br />
Nel 1824 Tosio acquistò la vicina casa Colpani e nello stesso anno l’architetto<br />
Vantini presentò il progetto per il rinnovamento della facciata comprendente le<br />
due case, così che <strong>di</strong> lì a poco iniziò la costruzione dell’appartamento nuovo, vale<br />
a <strong>di</strong>re l’ala occidentale dell’attuale palazzo, sorta appunto sull’area <strong>di</strong> casa Colpani.<br />
Seguì nel 1825 l’acquisto <strong>di</strong> casa Filippini la cui ristrutturazione da parte <strong>di</strong><br />
Vantini durò parecchi anni. Iniziò così una lunga serie <strong>di</strong> interventi che trasformarono<br />
ra<strong>di</strong>calmente l’immagine del palazzo.<br />
Vantini realizza per Tosio una serie <strong>di</strong> ambienti dalle <strong>di</strong>mensioni contenute, ma<br />
caratterizzati per forma e funzione. La decorazione dei soffitti eseguita a monocromo<br />
con motivi ricorrenti ad imitazione <strong>di</strong> rilievi in stucco, viene affidata a<br />
Giovambattista Dragoni sotto la <strong>di</strong>rezione del Vantini stesso.<br />
L’appartamento vantiniano possiede una sua peculiarità nei confronti <strong>di</strong> altri<br />
esempi realizzati a <strong>Brescia</strong> in questo periodo, proprio per la doppia funzione <strong>di</strong><br />
abitazione e <strong>di</strong> galleria: l’apparato decorativo è sempre contenuto, limitato esclusivamente<br />
ai soffitti e tale da non prevaricare sulle opere esposte. Particolare attenzione<br />
era data alla <strong>di</strong>stribuzione della luce proveniente dalle finestre, dai lucernari<br />
e riflessa dalle specchiere. L’utilizzo simultaneo <strong>di</strong> fonti luminose primarie<br />
e secondarie ricorre nelle sale destinate all’esposizione <strong>di</strong> statue per attenuare<br />
i contrasti chiaroscurali. L’aspetto museografico si integrava con quello abitativo<br />
secondo il volere dello stesso Tosio.<br />
Nel 1840 il palazzo iniziava ad assumere un aspetto definitivo e a <strong>Brescia</strong> era<br />
considerato un esempio <strong>di</strong> architettura residenziale, <strong>di</strong> decorazione scultoreo-pittorica<br />
e <strong>di</strong> arredamento per la stretta fusione <strong>di</strong> tutte le componenti tecniche usate.<br />
Vantini, nella progettazione della facciata, cercò <strong>di</strong> conferirle unità con la rigorosa<br />
simmetria rispetto all’elemento centrale del portone e della sovrastante finestra<br />
con balcone a colonne e timpano. L’e<strong>di</strong>ficio presenta un corpo centrale rivestito<br />
inferiormente <strong>di</strong> marmo <strong>di</strong> Botticino e nei due piani superiori <strong>di</strong> intonaco, su cui<br />
spiccano le incorniciature marmoree delle finestre architravate. I due corpi laterali,<br />
tra loro identici, presentano maggiore compattezza, con un accentuato gioco<br />
<strong>di</strong> chiaroscuri per la decorazione a finti bugnati.<br />
All’inizio dell’Ottocento, sull’angolo tra via Crispi e via Tosio, l’antica fontana<br />
collocata sotto il portico a due colonne, era parzialmente in <strong>di</strong>suso. Solo con<br />
l’esecuzione della nuova facciata del palazzo, il conte Tosio decise <strong>di</strong> ripristinarla.<br />
Il portone centrale introduce all’androne dalla volta a botte. Il portico è in stile<br />
17
cinquecentesco, ma assume un aspetto neoclassico per la presenza <strong>di</strong> porte architravate,<br />
<strong>di</strong> finestre con inferiate e <strong>di</strong> un piccolo scalone che sulla sinistra conduce<br />
al piano superiore.<br />
Sotto il portico, sono posti medaglioni a bassorilievo in marmo <strong>di</strong> Carrara, raffiguranti<br />
il volto <strong>di</strong> Raffaello e quello <strong>di</strong> Galileo, commissionati dal conte Tosio<br />
allo scultore bolognese Democrito Gandolfi nel 1832.<br />
Di fronte all’entrata si apre il cortile, chiuso sul lato meri<strong>di</strong>onale da una parete e<br />
da una terrazza, a sua volta sormontata da una balaustra. Questa parete nasconde<br />
un corridoio <strong>di</strong> raccordo fra i due lati del palazzo. Con questa soluzione Vantini<br />
ha saputo movimentare il cortile dandogli così un aspetto <strong>di</strong> maggiore profon<strong>di</strong>tà.<br />
Al centro della parte inferiore, in una nicchia, vi è una fontana con vasca in<br />
botticino, sormontata dalla statua in marmo <strong>di</strong> Carrara raffigurante una Naiade<br />
eseguita da Gaetano Monti <strong>di</strong> Ravenna e collocata nel 1817. Tosio de<strong>di</strong>cò particolare<br />
cura a questa parte dell’e<strong>di</strong>ficio, infatti, per la lieve concavità della pavimentazione,<br />
il cortile poteva essere trasformato in laghetto grazie ad uno speciale<br />
congegno idraulico, fatto ancora oggi documentato da un piccolo <strong>di</strong>pinto ad<br />
olio <strong>di</strong> Giuseppe Renica. Il Conte aveva infatti promesso alla moglie che nel palazzo<br />
ci sarebbe stato un laghetto per le anitre, ed un orto pensile sul terrazzo in<br />
fondo al cortile.<br />
Alcuni ambienti a pian terreno mantengono le forme architettoniche e la decorazione<br />
originaria <strong>di</strong> quando il palazzo apparteneva alla famiglia Maggi. La sala, a<br />
sinistra dell’androne conserva l’elegante camino della fine del secolo XVI, con<br />
mensole a zampe <strong>di</strong> leone ed una raffinata trabeazione.<br />
Intatta e restaurata è la saletta ad occidente del portico, con ricca scenografia architettonica<br />
del Settecento alle pareti, mentre nella volta la complessa riquadratura<br />
architettonica è del Seicento.<br />
Nel 1908 palazzo Tosio <strong>di</strong>venta sede dell’Ateneo, dopo la fusione della Pinacoteca<br />
Tosio e <strong>di</strong> quella Martinengo nell’unico complesso presso palazzo Martinengo<br />
da Barco.<br />
La <strong>di</strong>sposizione attuale degli ambienti al piano nobile corrisponde all’originale,<br />
come descritta nelle antiche guide compilate da Federico Odorici negli anni 1854<br />
e 1863. L’unico cambiamento rilevante è quello apportato al salone delle adunanze<br />
nel 1908, quando alla Pinacoteca Tosio subentrò l’Ateneo. Questo ambiente<br />
nasce infatti dall’unione <strong>di</strong> due sale <strong>di</strong>stinte, originariamente separate da una parete;<br />
lo prova la <strong>di</strong>versità dei pavimenti, la decorazione dei soffitti e dei raffinati<br />
motivi decorativi alle pareti. E’ da notare come la parete <strong>di</strong>visoria fra le due sale,<br />
poi abbattuta, fosse collocata in mezzo alla finestra centrale, quella del balcone.<br />
Evidentemente Vantini conservò le due sale <strong>di</strong>stinte senza però rinunciare alla so-<br />
18
luzione della facciata con apertura centrale.<br />
Salendo la scala a due rampe, si giunge alla galleria del piano nobile, progettata<br />
da Luigi Basiletti tra il 1810 e il 1814. Sopra le quattro porte vi sono riquadri con<br />
rilievi in stucco bianco raffiguranti le allegorie dell’Architettura, Pittura, Scultura<br />
e Musica eseguite da Gaetano Monti. Lungo le pareti vi sono parecchi busti <strong>di</strong><br />
marmo, in onore dei benefattori bresciani ed artisti che hanno contribuito ad arricchire<br />
la storia dell’Ateneo.<br />
Attraverso le due porte del lato nord della galleria si accede al salone delle adunanze<br />
con affaccio su via Tosio, chiamato anche Sala Rossa dal colore della tappezzeria<br />
<strong>di</strong> carta simile a seta damascata degli anni Venti del Novecento. Ad est<br />
e ad ovest, sempre con affaccio su strada, si aprono sale dalle eleganti decorazioni<br />
neoclassiche e dalle pareti con tappezzerie colorate.<br />
La galleria fa da elemento <strong>di</strong> raccordo tra l’ala orientale e quella occidentale del<br />
palazzo. Partendo proprio dalla<br />
galleria si accede all’ala<br />
ovest, chiamata da Tosio<br />
“l’appartamento nuovo” interamente<br />
sistemato da Rodolfo<br />
Vantini. Questo lato è caratterizzato<br />
da una forte unità stilistica<br />
in quanto è il risultato <strong>di</strong><br />
elementi architettonici simili,<br />
<strong>di</strong> ambienti <strong>di</strong>versi, <strong>di</strong> raffinatezza<br />
nella <strong>di</strong>sposizione e <strong>di</strong><br />
un intersecarsi <strong>di</strong> fughe prospettiche<br />
in cui si riconosce lo<br />
stile dell’architetto Vantini, in<br />
contrasto con la delicatezza e<br />
la semplicità dello stile <strong>di</strong> Basiletti.<br />
Il primo ambiente dell’appartamento<br />
nuovo è la sala denominata<br />
da Tosio “sala dei<br />
chiaroscuri” dovuta al tipo <strong>di</strong><br />
decorazione del soffitto e delle<br />
sovrapporte, attualmente<br />
chiamata Sala dei presidenti e<br />
dei segretari dell’Accademia.<br />
Cappella <strong>di</strong> palazzo Tosio:<br />
Pompeo Marchesi, Redentore fanciullo, 1833<br />
19
Il soffitto a monocromo è opera <strong>di</strong> Giovan Battista Dragoni, le pareti sono in stucco<br />
marmorizzato <strong>di</strong> tonalità rosata, i cinque riquadri a monocromo sopra le porte<br />
e le finte porte, raffigurano giochi <strong>di</strong> putti eseguiti da Giuseppe Lavelli. Alle pareti<br />
sono appesi ritratti dei presidenti e dei segretari dell’Accademia.<br />
Da qui si può accedere alla piccola cappella. Nonostante lo spazio sia modesto<br />
Vantini è riuscito a dare una notevole gran<strong>di</strong>osità grazie al contrasto chiaroscurale<br />
tra il presbiterio, investito dalla luce che scende dall’alto della cupoletta e da<br />
una finestra a semiluna sull’altare, e la navata che invece riceve la luce in<strong>di</strong>retta<br />
e quin<strong>di</strong> rimane in penombra. L’attenzione è concentrata sull’altare neoclassico<br />
<strong>di</strong>segnato da Vantini ed eseguito da Giovanni Franceschetti, sormontato dalla statua<br />
del Redentore fanciullo in marmo <strong>di</strong> Carrara, opera <strong>di</strong> Pompeo Marchesi del<br />
1833. Il motivo iconografico non è molto comune, ma era caro ai Nazareni ed ai<br />
Preraffaelliti.<br />
Dalla cappella si accede alla galleria delle incisioni oggi chiamata Sala dorica o<br />
Sala Renica. La parte centrale <strong>di</strong> questa stanza è molto alta, con volta a botte dotata<br />
<strong>di</strong> ampio lucernario; le estremità invece, separate da due colonne doriche con<br />
architrave, sono due ambienti piuttosto piccoli e bassi, con soffitto piano, alle pareti<br />
vi sono nicchie in stucco lucido <strong>di</strong> colore grigio. Nel 1892 la raccolta delle<br />
incisioni del conte Tosio fu trasportata nella Pinacoteca Tosio Martinengo e fusa<br />
con quella <strong>di</strong> altri lasciti, cosicché questo ambiente nel 1903 fu destinato a raccogliere<br />
una parte dei numerosi <strong>di</strong>pinti <strong>di</strong> vario formato lasciati all’Ateneo da Giovanni<br />
Renica, noto paesaggista bresciano.<br />
Segue il gabinetto ottagonale che conduce alla Sala ionica, ambiente elegante con<br />
le pareti in stucco marmorizzato grigio chiaro su cui spiccano le lesene con capitello<br />
corinzio in stucco bianco. Il soffitto è adorno <strong>di</strong> lacunari in monocromo grigio<br />
nella parte centrale, mentre nelle fasce che fanno da contorno ci sono medaglioni<br />
con teste <strong>di</strong> profilo, opera <strong>di</strong> Luigi Basiletti. La parte decorativa è <strong>di</strong> Gian<br />
Battista Dragoni. La sala è arricchita da un elegante camino sormontato da specchiera<br />
e da tele sovrapporta <strong>di</strong>pinte da Giacomo Trecourt, raffiguranti scene relative<br />
all’educazione infantile.<br />
Attraverso la porta nel lato sud della sala ionica si accede al Gabinetto a sera, ambiente<br />
<strong>di</strong> piccole proporzioni, con raffinati <strong>di</strong>segni <strong>di</strong> filosofi e personaggi classici.<br />
Nella nicchia <strong>di</strong> fronte all’ingresso oggi è collocato il busto in marmo raffigurante<br />
Saffo eseguito da Giacinto Baruzzi. I lavori del piccolo ambiente sono gli<br />
ultimi eseguiti da Rodolfo Vantini per il palazzo, terminati nel 1840. Le due porte<br />
specchiere immettono, quella ad ovest in un piccolo corridoio che porta al gabinetto<br />
ottagonale, e quella ad est nel corridoio <strong>di</strong>etro la terrazza in fondo al cortile<br />
che unisce l’ala occidentale a quella orientale.<br />
20
Oltre la sala ionica, tornando verso nord si incontra la Sala Ovale, anch’essa opera<br />
<strong>di</strong> Vantini, elegante e raffinata, con volta a calotta emisferica e con quattro nicchie<br />
semicircolari alle pareti entro cui sono collocati, per volere del Conte, due<br />
preziosi vasi cinesi e due giapponesi.<br />
Dalla galleria, andando verso est, si giunge all’appartamento oggetto della prima<br />
sistemazione compiuta da Luigi Basiletti nel secondo decennio dell’Ottocento. E’<br />
composto da tre sale ed un piccolo an<strong>di</strong>to che, da quando subentrò l’Ateneo furono<br />
destinati a sede della biblioteca accademica qui rimasta fino al 1959, quando<br />
fu trasportata a pianterreno. In origine l’intenzione del Conte era <strong>di</strong> posizionare<br />
in questa parte del palazzo i suoi quadri antichi.<br />
Dopo il 1959, le prime due sale furono destinate a mostre temporanee, mentre la<br />
terza ed il piccolo an<strong>di</strong>to a sede <strong>di</strong> Archivio dell’Ateneo.<br />
Il piccolo an<strong>di</strong>to posto in fondo alle tre sale, apre il passaggio al corridoio dalla<br />
volta a botte decorata da tralci <strong>di</strong> vite e spighe <strong>di</strong> grano, che collega le due ali del<br />
palazzo <strong>di</strong>etro la terrazza.<br />
Palazzo Tosio, che dal 1908 è sede dell’Ateneo, non è visitabile dal pubblico. Si<br />
può accedere solo alla biblioteca a pian terreno, per consultare la ricca collezione<br />
<strong>di</strong> libri, manoscritti e opere uniche, provenienti da svariati lasciti (per accedere<br />
alla biblioteca, dalle 15.00 alle 19.00, telefonare al numero 030/41006). Scopo<br />
dell’Ateneo è quello <strong>di</strong> promuovere e <strong>di</strong>ffondere, nella nostra provincia, le scoperte<br />
e le conoscenze che riguardano l’agricoltura, il commercio, le scienze, le<br />
lettere e le arti. Organizza pubbliche esposizioni artistiche ed industriali, pubblica<br />
i commentari annuali dei propri atti e conferisce premi a bresciani benemeriti<br />
per opere filantropiche.<br />
Nuovi progetti coinvolgono palazzo Tosio; tra i più recenti è la proposta <strong>di</strong> recupero<br />
come casa-museo dove potrebbero trovare collocazione le collezioni civiche<br />
<strong>di</strong> arte moderna e contemporanea.<br />
Al numero 18 è casa Archetti (5) che all’inizio del Novecento era <strong>di</strong> proprietà<br />
della famiglia Piazza, come <strong>di</strong>mostrano le iniziali poste al centro dell’arco del<br />
portale: “P.F.” cioè Francesco Piazza. Non molto è rimasto della struttura originaria<br />
dell’e<strong>di</strong>ficio. Da segnalare una sala al piano nobile con soffitto ligneo a travetti<br />
policromi, secondo lo stile in voga nel XVII secolo.<br />
Segue casa Gan<strong>di</strong>ni (6) al numero 20. Anche questa abitazione ha perso, in seguito<br />
ai numerosi restauri, le sue caratteristiche settecentesche. Semplice il portale,<br />
reso originale però dal mascherone in pietra posto nella chiave <strong>di</strong> volta, raffigurante<br />
un volto umano che trattiene con la bocca una corona d’alloro. Elegante<br />
è la fontana neoclassica che si scorge dal portale ed è posta in fondo al cortile,<br />
contro un muro <strong>di</strong>visorio.<br />
21
Dove oggi sorge casa Mazzola (7), al civico 24, probabilmente esisteva già nel<br />
XV secolo un e<strong>di</strong>ficio abbastanza importante. L’attuale fabbricato, della seconda<br />
metà del Cinquecento, fu restaurato all’inizio dell’Ottocento dal pittore ed architetto<br />
Luigi Basiletti che per un certo periodo ne fu il proprietario. Interessante <strong>di</strong><br />
questo palazzo è la sala al piano nobile, che conserva un fregio cinquecentesco in<br />
alto e che corre lungo tutte quattro le pareti. Difficile attribuire questo affresco<br />
che sembra richiamare lo stile bizzarro ed originale <strong>di</strong> Lattanzio Gambara. La decorazione<br />
ospita figure umane, ma anche animali feroci, mostri, cavalli marini in<br />
un intreccio continuo e singolare. Questa casa venne fatta costruire dalla famiglia<br />
Lupatini, che all’inizio del Cinquecento avevano acquistato un terreno sugli antichi<br />
terragli delle mura urbiche che proprio qui avevano il loro tracciato. La casa<br />
fu poi ere<strong>di</strong>tata dalla famiglia Sala e acquistata, come si è detto, dal pittore Basiletti.<br />
Questa famiglia si incrociò poi, all’inizio del Novecento, con quella dei<br />
Mazzola.<br />
Sempre sui terrapieni delle mura romane e me<strong>di</strong>evali doveva sorgere anche l’antico<br />
palazzo, oggi al civico 28, fatto e<strong>di</strong>ficare dalla famiglia Maggi nel XVI secolo.<br />
I resti <strong>di</strong> questa costruzione, i porticati e una sala a volta situata a pianterreno,<br />
furono incorporati nel palazzo settecentesco oggi <strong>di</strong> proprietà della famiglia<br />
Sigismon<strong>di</strong> (8). Gli ere<strong>di</strong> della famiglia Maggi, verso la fine del Seicento vendettero<br />
la casa ai Conter, ricca famiglia proveniente da Salò che vi si stabilì definitivamente<br />
negli anni venti del Settecento. L’ultimo erede, verso la metà dell’Ottocento,<br />
vendette a sua volta l’intero palazzo alla nobile famiglia Sigismon<strong>di</strong> della<br />
Valle Camonica. La facciata su via Tosio è particolare per la sua asimmetria: il<br />
portale infatti è posto in asse con via Veronica Gambara, cui fa da sfondo, ma non<br />
è al centro della facciata, tanto che questa si sviluppa con tre finestre verso est e<br />
solo due verso ovest. Particolare è anche la decorazione delle finestre al piano nobile;<br />
infatti le tre verso est hanno stipiti sagomati con forme barocche arricchiti<br />
da piccoli trofei in rilievo, mentre le due a ovest hanno forme più semplici, con<br />
frontone a linea mista che accoglie valve <strong>di</strong> conchiglia. Queste <strong>di</strong>versità sono probabilmente<br />
dovute all’intervento <strong>di</strong> due <strong>di</strong>versi architetti, uno che ha operato in<br />
un primo momento nella realizzazione del corpo centrale ed uno intervenuto in<br />
un secondo momento per l’esecuzione del corpo occidentale, dove sorge lo scalone,<br />
fino alla casa confinante. Elegante è l’ampio balcone che sormonta il portale,<br />
con balaustra sagomata e colonnine in pietra. La finestra che si apre al centro<br />
presenta nel timpano spezzato un busto in pietra. Dal portale, attraverso l’androne,<br />
si giunge al portico <strong>di</strong> epoca rinascimentale che si sviluppa ad angolo retto a<br />
destra dell’ingresso. E’ caratterizzato da snelle colonne tuscaniche che in alcuni<br />
capitelli portano ancora lo stemma della famiglia Maggi. L’ampio cortile è chiu-<br />
22
so dai corpi <strong>di</strong> fabbrica e verso sud da due archi <strong>di</strong> porticato oltre i quali si scorge<br />
il giar<strong>di</strong>no esteso fino a corso Magenta. Dal porticato, verso destra, si accede<br />
allo scalone settecentesco a due rampe, che conduce al piano nobile. Al centro<br />
della volta molto alta si apre un grande medaglione sagomato con un affresco che<br />
raffigura Fetonte, opera che per lo stile <strong>di</strong> esecuzione potrebbe essere attribuita al<br />
pittore bresciano Scalvini. Sicuramente meglio riusciti sono i quattro ovali con figure<br />
muliebri posti agli angoli della composizione centrale e i sei medaglioni a<br />
monocromo ai lati. Le pareti sono invece decorate finemente con trofei in stucco<br />
entro gran<strong>di</strong> riquadri. Le sale che si aprono al piano nobile presentano buone decorazioni<br />
settecentesche ed eleganti stucchi.<br />
23