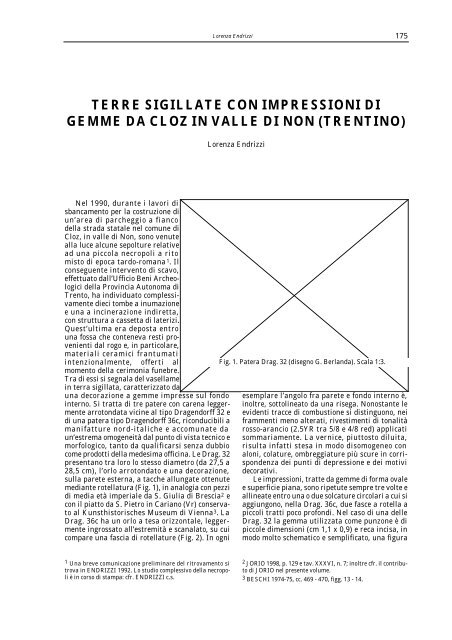L. ENDRIZZI, Terre sigillate con impressioni di gemme - BibAr
L. ENDRIZZI, Terre sigillate con impressioni di gemme - BibAr
L. ENDRIZZI, Terre sigillate con impressioni di gemme - BibAr
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
TERRE SIGILLATE CON IMPRESSIONI DI<br />
GEMME DA CLOZ IN VALLE DI NON (TRENTINO)<br />
Nel 1990, durante i lavori <strong>di</strong><br />
sbancamento per la costruzione <strong>di</strong><br />
un’area <strong>di</strong> parcheggio a fianco<br />
della strada statale nel comune <strong>di</strong><br />
Cloz, in valle <strong>di</strong> Non, sono venute<br />
alla luce alcune sepolture relative<br />
ad una piccola necropoli a rito<br />
misto <strong>di</strong> epoca tardo-romana 1. Il<br />
<strong>con</strong>seguente intervento <strong>di</strong> scavo,<br />
effettuato dall’Ufficio Beni Archeologici<br />
della Provincia Autonoma <strong>di</strong><br />
Trento, ha in<strong>di</strong>viduato complessivamente<br />
<strong>di</strong>eci tombe a inumazione<br />
e una a incinerazione in<strong>di</strong>retta,<br />
<strong>con</strong> struttura a cassetta <strong>di</strong> laterizi.<br />
Quest’ultima era deposta entro<br />
una fossa che <strong>con</strong>teneva resti provenienti<br />
dal rogo e, in particolare,<br />
materiali ceramici frantumati<br />
intenzionalmente, offerti al<br />
momento della cerimonia funebre.<br />
Tra <strong>di</strong> essi si segnala del vasellame<br />
in terra sigillata, caratterizzato da<br />
una decorazione a <strong>gemme</strong> impresse sul fondo<br />
interno. Si tratta <strong>di</strong> tre patere <strong>con</strong> carena leggermente<br />
arrotondata vicine al tipo Dragendorff 32 e<br />
<strong>di</strong> una patera tipo Dragendorff 36c, ri<strong>con</strong>ducibili a<br />
manifatture nord-italiche e accomunate da<br />
un’estrema omogeneità dal punto <strong>di</strong> vista tecnico e<br />
morfologico, tanto da qualificarsi senza dubbio<br />
come prodotti della medesima officina. Le Drag. 32<br />
presentano tra loro lo stesso <strong>di</strong>ametro (da 27,5 a<br />
28,5 cm), l’orlo arrotondato e una decorazione,<br />
sulla parete esterna, a tacche allungate ottenute<br />
me<strong>di</strong>ante rotellatura (Fig. 1), in analogia <strong>con</strong> pezzi<br />
<strong>di</strong> me<strong>di</strong>a età imperiale da S. Giulia <strong>di</strong> Brescia 2 e<br />
<strong>con</strong> il piatto da S. Pietro in Cariano (Vr) <strong>con</strong>servato<br />
al Kunsthistorisches Museum <strong>di</strong> Vienna 3. La<br />
Drag. 36c ha un orlo a tesa orizzontale, leggermente<br />
ingrossato all’estremità e scanalato, su cui<br />
compare una fascia <strong>di</strong> rotellature (Fig. 2). In ogni<br />
1 Una breve comunicazione preliminare del ritrovamento si<br />
trova in <strong>ENDRIZZI</strong> 1992. Lo stu<strong>di</strong>o complessivo della necropoli<br />
è in corso <strong>di</strong> stampa: cfr. <strong>ENDRIZZI</strong> c.s.<br />
Lorenza Endrizzi 175<br />
Lorenza Endrizzi<br />
Fig. 1. Patera Drag. 32 (<strong>di</strong>segno G. Berlanda). Scala 1:3.<br />
esemplare l’angolo fra parete e fondo interno è,<br />
inoltre, sottolineato da una risega. Nonostante le<br />
evidenti tracce <strong>di</strong> combustione si <strong>di</strong>stinguono, nei<br />
frammenti meno alterati, rivestimenti <strong>di</strong> tonalità<br />
rosso-arancio (2.5YR tra 5/8 e 4/8 red) applicati<br />
sommariamente. La vernice, piuttosto <strong>di</strong>luita,<br />
risulta infatti stesa in modo <strong>di</strong>somogeneo <strong>con</strong><br />
aloni, colature, ombreggiature più scure in corrispondenza<br />
dei punti <strong>di</strong> depressione e dei motivi<br />
decorativi.<br />
Le <strong>impressioni</strong>, tratte da <strong>gemme</strong> <strong>di</strong> forma ovale<br />
e superficie piana, sono ripetute sempre tre volte e<br />
allineate entro una o due solcature circolari a cui si<br />
aggiungono, nella Drag. 36c, due fasce a rotella a<br />
piccoli tratti poco profon<strong>di</strong>. Nel caso <strong>di</strong> una delle<br />
Drag. 32 la gemma utilizzata come punzone è <strong>di</strong><br />
piccole <strong>di</strong>mensioni (cm 1,1 x 0,9) e reca incisa, in<br />
modo molto schematico e semplificato, una figura<br />
2 JORIO 1998, p. 129 e tav. XXXVI, n. 7; inoltre cfr. il <strong>con</strong>tributo<br />
<strong>di</strong> JORIO nel presente volume.<br />
3 BESCHI 1974-75, cc. 469 - 470, figg. 13 - 14.
176<br />
PRODUZIONE CERAMICA IN AREA PADANA TRA IL II SECOLO a.C. E IL VII SECOLO d.C.: NUOVI DATI E PROSPETTIVE DI RICERCA<br />
alata <strong>con</strong> timone e patera (?), riferibile al tipo della<br />
Vittoria/Fortuna (Fig. 3), se<strong>con</strong>do un’i<strong>con</strong>ografia<br />
sincretistica molto <strong>di</strong>ffusa a partire dal II sec.<br />
d.C. 4 Sui restanti pezzi la gemma è piuttosto grande<br />
(cm 2 x 1,4) e riporta la figura <strong>di</strong> un personaggio<br />
maschile nudo, in corsa verso destra, nell’atto,<br />
pare, <strong>di</strong> trattenere o <strong>di</strong> aggrapparsi per le briglie<br />
ad un cavallo alato che lo sovrasta (Fig. 4). Il soggetto,<br />
per il quale fino ad ora non si sono trovati<br />
<strong>con</strong>fronti, è forse ri<strong>con</strong>ducibile al mito <strong>di</strong> Bellerofonte<br />
ma rimane comunque <strong>di</strong> incerta interpretazione.<br />
Questo tipo <strong>di</strong> vasellame che, come è noto,<br />
trova attestazioni soprattutto in ambito nor<strong>di</strong>talico<br />
centro orientale, <strong>con</strong> una cospicua <strong>con</strong>centrazione<br />
nel v i c u s <strong>di</strong> B e d r i a c u m- C a l v a t o n e 5, è rappresentato<br />
a livello trentino da altri otto frammenti,<br />
<strong>di</strong> cui cinque dall’area urbana (p.zza Bellesini: un<br />
fr. <strong>con</strong> raffigurazione <strong>di</strong> Marte Ultore e uno <strong>con</strong><br />
Elios/Sole; teatro Sociale: un fr. <strong>con</strong> raffigurazione<br />
<strong>di</strong> Marte Ultore; p.zza Cesare Battisti: un fr. <strong>con</strong><br />
figura seduta; p.zza Duomo: un fr. <strong>con</strong> un elemento<br />
fitomorfo, forse un giglio) e tre dal territorio gardesano<br />
(Arco-via Passirone: un fr. <strong>con</strong> raffigurazione<br />
<strong>di</strong> Mercurio 6; monte S. Martino: due patere<br />
frammentarie <strong>con</strong> l’impressione <strong>di</strong> stampiglie a<br />
palmetta 7), tutti provenienti da <strong>con</strong>testi non databili.<br />
Solitamente la cronologia delle <strong>sigillate</strong><br />
impresse non viene posta oltre l’inizio del II sec.<br />
d.C., anche in <strong>con</strong>siderazione <strong>di</strong> analogie tecnicodecorative<br />
e morfologiche <strong>con</strong> la ceramica a vernice<br />
nera, che indu<strong>con</strong>o, come nel caso <strong>di</strong> Calvatone,<br />
a sottolineare una possibile <strong>con</strong>tinuità tra le due<br />
p r o d u z i o n i 8. L’elemento <strong>di</strong> particolare interesse<br />
Fig. 3. Gemme impresse <strong>con</strong> raffigurazione <strong>di</strong> Vittoria/Fortuna<br />
(foto E. Munerati).<br />
4 SENA CHIESA 1966, p. 48.<br />
5 Le <strong>sigillate</strong> impresse <strong>di</strong> Calvatone, <strong>con</strong>siderato un possibile<br />
centro <strong>di</strong> smistamento <strong>di</strong> tale materiale, sono state più volte<br />
oggetto <strong>di</strong> pubblicazione. Da ultimo si veda VOLONTÉ 1998,<br />
pp. 501-502, a cui si rimanda anche per i riferimenti bibliografici<br />
relativi ai rinvenimenti noti.<br />
Fig. 2. Patera Drag. 36 (<strong>di</strong>segno G. Berlanda).<br />
Scala 1:3.<br />
che emerge dall’esame del ritrovamento <strong>di</strong> Cloz è<br />
fornito dall’associazione dei quattro esemplari <strong>con</strong><br />
una coppetta emisferica tipo Hayes 44 in sigillata<br />
africana C, testimoniata tra il 220/240 circa e la<br />
fine del III sec. d.C., che <strong>con</strong>sentirebbe dunque <strong>di</strong><br />
protrarre la loro datazione almeno fino alla metà<br />
del III sec. d.C. Questo dato <strong>con</strong>corderebbe, tra<br />
l’altro, <strong>con</strong> la cronologia tarda proposta per i ritrovamenti<br />
<strong>di</strong> Ravenna 9 e per quelli <strong>di</strong> Santa Giulia a<br />
Brescia 10.<br />
Fig. 4. Gemme impresse <strong>con</strong> raffigurazione <strong>di</strong> un personaggio<br />
maschile sovrastato da un cavallo alato (foto E.<br />
Munerati).<br />
6 CAVADA 1988, p. 34, fig. 5.<br />
7 GUELLA 1979, Tav. LXVI, fig. 6.<br />
8 VOLONTÉ 1998, pp. 501-502.<br />
9 MAIOLI 1973, pp. 3 - 9; VOLONTÉ 1998, p. 502.<br />
10 JORIO 1998, p. 129.
BIBLIOGRAFIA<br />
L. BESCHI 1974-1975, Corre<strong>di</strong> funerari da S. Pietro Incariano<br />
a Vienna, “Aquileia Nostra”, XLC - XLVI, cc. 445 -<br />
478.<br />
E. CAVADA 1988, Aggiornamento 1987. Scavi archeologici nel<br />
Basso Sarca, “Sommolago”, V, 3; pp. 27 - 38.<br />
L. <strong>ENDRIZZI</strong> 1992, Le tombe <strong>di</strong> Cloz, “Archeologia Viva”, XI,<br />
34, pp. 52 - 57.<br />
L. <strong>ENDRIZZI</strong> c.s., Cloz in Valle <strong>di</strong> Non (Trentino): la necropoli<br />
<strong>di</strong> via S. Maria e altri ritrovamenti, “ArcheoAlp-<br />
Archeologia delle Alpi”.<br />
A. GUELLA 1979, Inse<strong>di</strong>amento romano del monte <strong>di</strong> S. Marti -<br />
no (Riva del Garda), in Atti della Accademia Roveretana<br />
degli Agiati, aa. 229 (1979), s. VI, vol. 19, f. A,<br />
(= Atti <strong>con</strong>gresso Romanità del Trentino e <strong>di</strong> zone<br />
limitrofe, II), pp. 273 - 278.<br />
Lorenza Endrizzi 177<br />
S. JORIO 1998, Terra sigillata <strong>di</strong> età me<strong>di</strong>o e tardo imperiale,<br />
in G. OLCESE (a cura <strong>di</strong>), Ceramiche in Lombar<strong>di</strong>a<br />
tra II secolo a.C. e VII secolo d.C. Raccolta dei dati<br />
ine<strong>di</strong>ti, Mantova, pp. 125 - 132.<br />
M. G. MAIOLI 1973, <strong>Terre</strong> <strong>sigillate</strong> ravennati <strong>con</strong> <strong>impressioni</strong><br />
<strong>di</strong> gemma, “Felix Ravenna”, V -VI, pp. 3 - 9.<br />
G. SENA CHIESA 1966, Gemme del Museo Nazionale <strong>di</strong> Aqui -<br />
leia, Padova.<br />
M. VOLONTÉ 1998, La ceramica decorata a <strong>gemme</strong> impresse,<br />
in Tesori della Postumia, Archeologia e storia intor -<br />
no a una grande strada romana alle ra<strong>di</strong>ci<br />
dell’Europa (Cremona, Santa Maria della Pietà, 4<br />
aprile – 26 luglio 1998), Milano, pp. 501 - 502.