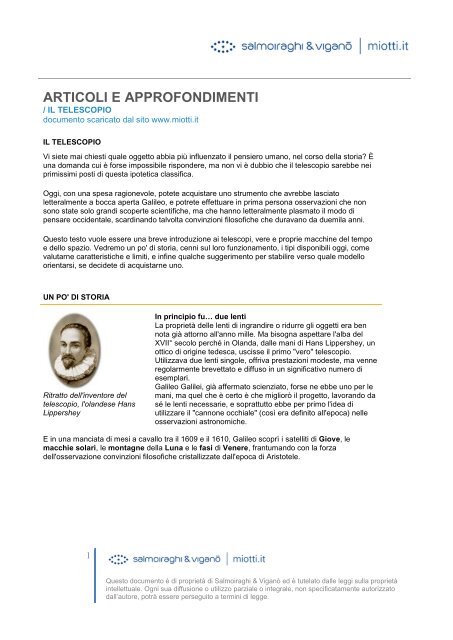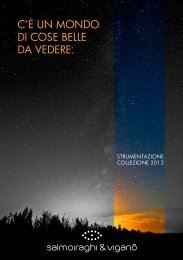IL MICROSCOPIO - Miotti Ottica
IL MICROSCOPIO - Miotti Ottica
IL MICROSCOPIO - Miotti Ottica
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
ARTICOLI E APPROFONDIMENTI<br />
/ <strong>IL</strong> TELESCOPIO<br />
documento scaricato dal sito www.miotti.it<br />
<strong>IL</strong> TELESCOPIO<br />
Vi siete mai chiesti quale oggetto abbia più influenzato il pensiero umano, nel corso della storia? È<br />
una domanda cui è forse impossibile rispondere, ma non vi è dubbio che il telescopio sarebbe nei<br />
primissimi posti di questa ipotetica classifica.<br />
Oggi, con una spesa ragionevole, potete acquistare uno strumento che avrebbe lasciato<br />
letteralmente a bocca aperta Galileo, e potrete effettuare in prima persona osservazioni che non<br />
sono state solo grandi scoperte scientifiche, ma che hanno letteralmente plasmato il modo di<br />
pensare occidentale, scardinando talvolta convinzioni filosofiche che duravano da duemila anni.<br />
Questo testo vuole essere una breve introduzione ai telescopi, vere e proprie macchine del tempo<br />
e dello spazio. Vedremo un po' di storia, cenni sul loro funzionamento, i tipi disponibili oggi, come<br />
valutarne caratteristiche e limiti, e infine qualche suggerimento per stabilire verso quale modello<br />
orientarsi, se decidete di acquistarne uno.<br />
UN PO' DI STORIA<br />
Ritratto dell'inventore del<br />
telescopio, l'olandese Hans<br />
Lippershey<br />
1<br />
In principio fu… due lenti<br />
La proprietà delle lenti di ingrandire o ridurre gli oggetti era ben<br />
nota già attorno all'anno mille. Ma bisogna aspettare l'alba del<br />
XVII° secolo perché in Olanda, dalle mani di Hans Lippershey, un<br />
ottico di origine tedesca, uscisse il primo "vero" telescopio.<br />
Utilizzava due lenti singole, offriva prestazioni modeste, ma venne<br />
regolarmente brevettato e diffuso in un significativo numero di<br />
esemplari.<br />
Galileo Galilei, già affermato scienziato, forse ne ebbe uno per le<br />
mani, ma quel che è certo è che migliorò il progetto, lavorando da<br />
sé le lenti necessarie, e soprattutto ebbe per primo l'idea di<br />
utilizzare il "cannone occhiale" (così era definito all'epoca) nelle<br />
osservazioni astronomiche.<br />
E in una manciata di mesi a cavallo tra il 1609 e il 1610, Galileo scoprì i satelliti di Giove, le<br />
macchie solari, le montagne della Luna e le fasi di Venere, frantumando con la forza<br />
dell'osservazione convinzioni filosofiche cristallizzate dall'epoca di Aristotele.<br />
Questo documento è di proprietà di Salmoiraghi & Viganò ed è tutelato dalle leggi sulla proprietà<br />
intellettuale. Ogni sua diffusione o utilizzo parziale o integrale, non specificatamente autorizzato<br />
dall’autore, potrà essere perseguito a termini di legge.
Due dei "cannoni occhiali" di Galileo.<br />
Il più lungo ha 30 mm di diametro e<br />
ingrandisce circa 20 volte<br />
2<br />
Aspetto di un tipico telescopio di fine<br />
XVII° secolo. I limiti operativi di uno<br />
strumento simile sono abbastanza ovvi!<br />
Il grande pisano costruì vari telescopi, capaci al massimo di una trentina di ingrandimenti, e tutti<br />
affetti da un severo cromatismo (una aberrazione dovuta all'uso di lenti semplici, che si manifesta<br />
con aloni colorati attorno agli oggetti più brillanti). Ma la diffusione delle sue osservazioni aveva<br />
avviato una catena inarrestabile.<br />
Nel 1616 un altro italiano, Niccolò Zucchi, ebbe l'idea di utilizzare uno specchio concavo invece di<br />
una lente come obiettivo, risolvendo il problema del cromatismo, in quanto gli specchi non ne<br />
soffrono.<br />
Nel 1668 il grande Isaac Newton perfezionò il progetto di Zucchi, e creò il primo telescopio<br />
Newtoniano, il design più antico che sia ancora usato oggi.<br />
Nello stesso anno un francese, Laurent Cassegrain, ideò un diverso arrangiamento degli specchi<br />
per ottenere strumenti più compatti e leggeri a parità di prestazioni.<br />
Un grosso Schmidt-Cassegrain computerizzato. Qui è<br />
in configurazione altazimutale, ma con un accessorio<br />
diventa "magicamente" equatoriale. Il computer di<br />
bordo, con GPS, punta letteralmente da solo centinaia<br />
di oggetti, sin dalla prima sera di utilizzo.<br />
I telescopi erano quindi già allora divisi in due grandi famiglie.<br />
Un telescopio Newtoniano con montatura<br />
equatoriale, motorizzabile con accessori. Ottimo<br />
strumento per cominciare, richiede forse un po'<br />
più di impegno, ma è una scuola ideale per le<br />
tecniche osservative.<br />
Questo documento è di proprietà di Salmoiraghi & Viganò ed è tutelato dalle leggi sulla proprietà<br />
intellettuale. Ogni sua diffusione o utilizzo parziale o integrale, non specificatamente autorizzato<br />
dall’autore, potrà essere perseguito a termini di legge.
I rifrattori (in cui l'elemento ottico principale, cioè l'obiettivo, è una lente) e i riflettori (obiettivo a<br />
specchio).<br />
Ma entrambi i gruppi soffrivano di pesanti limiti. Per ridurre il cromatismo i telescopi a lente<br />
dovevano essere lunghissimi (si videro strumenti lunghi trenta metri e oltre) con gli immaginabili<br />
problemi costruttivi.<br />
Per quel che riguarda gli specchi, quelli dell'epoca erano metallici. Delicati, costosi, si ossidavano<br />
rapidamente, e dovevano essere lucidati ogni pochi mesi. Ma grandi progressi arrivarono con i<br />
decenni seguenti.<br />
Nel 1757 John Dollond, un ottico inglese, apportò un'importante innovazione ai telescopi a lente.<br />
Brevettò il doppietto acromatico, ovvero una combinazione di lenti realizzate con vetri diversi in<br />
grado di offrire un'immagine quasi completamente priva di cromatismo mantenendo le dimensioni<br />
del telescopio maneggevoli. Inizia l'epoca d'oro dei grandi rifrattori, che culminò nel "mostro" da 102<br />
cm di diametro dell'osservatorio di Yerkes, entrato in funzione nel 1897. Ma quaranta anni prima,<br />
nel 1857 (cento anni esatti dopo il brevetto di Dollond) il grande fisico francese Lèon Focault, ben<br />
noto per il famoso pendolo, aveva illustrato il metodo per deporre un sottilissimo strato di argento<br />
su specchi in vetro, nettamente più precisi, economici e pratici di quelli in metallo. Dall'inizio del<br />
'900 ai giorni nostri, tutti i grandi telescopi professionali sono stati riflettori.<br />
Nel corso del XX° secolo sono stati introdotti molti altri tipi di telescopi, alcuni dei quali utilizzano sia<br />
lenti che specchi per formare l'immagine.<br />
Sono detti catadiottrici.<br />
Ne esistono tipi diversi, ma tutti sono accomunati dall'avere una grande lente, di potere<br />
generalmente piuttosto basso, come primo elemento ottico, mentre l'obiettivo è uno specchio. Di<br />
norma la lente frontale sostiene anche uno specchio secondario, e l'immagine si forma dietro lo<br />
specchio principale (l'obiettivo), che è forato al centro. Questi strumenti permettono di conciliare<br />
grande diametri con notevole compattezza, e sono tra i preferiti degli appassionati di tutto il mondo.<br />
COS'E' UN TELESCOPIO<br />
In estrema sintesi i telescopi sono insiemi di ottica e meccanica, costruiti per far vedere ingranditi<br />
(oppure fotografare) gli oggetti lontani.<br />
"<strong>Ottica</strong>" è tutto ciò che concorre alla formazione dell'immagine.<br />
La "meccanica" è tutto il resto.<br />
Non solo sostiene il tubo che alloggia l'ottica, ma consente di puntarlo nelle varie direzioni ed<br />
eventualmente di inseguire, ovvero compensare il moto apparente della volta celeste dovuto alla<br />
rotazione della Terra.<br />
I telescopi più sofisticati includono un computer di puntamento, che consente all'utente di chiedere,<br />
per esempio, di puntare Giove oppure la nebulosa di Orione, ma anche una remota galassia, con la<br />
pressione di pochi tasti (dopo una breve regolazione iniziale).<br />
I modelli più evoluti rendono semplicissima o addirittura automatica perfino la fase preparatoria, che<br />
consente al telescopio di "capire" dove si trova e dove è puntato (questa fase è detta<br />
stazionamento).<br />
Quando si osserva visualmente l'obiettivo del telescopio (lente o specchio che sia) genera<br />
un'immagine di ciò verso cui lo strumento è puntato. Tale immagine viene osservata con l'oculare,<br />
che in pratica è una sofisticata lente di ingrandimento.<br />
Se invece si riprendono fotografie (tradizionali o digitali non importa), l'immagine generata<br />
dall'obiettivo del telescopio viene raccolta direttamente dalla pellicola o sensore (sistema di ripresa<br />
3<br />
Questo documento è di proprietà di Salmoiraghi & Viganò ed è tutelato dalle leggi sulla proprietà<br />
intellettuale. Ogni sua diffusione o utilizzo parziale o integrale, non specificatamente autorizzato<br />
dall’autore, potrà essere perseguito a termini di legge.
detto fuoco diretto) oppure prima ingrandita da un oculare e poi focalizzata (sistema di ripresa in<br />
proiezione). Se la macchina fotografica non ha obiettivo rimovibile, si può comunque effettuare<br />
alcuni tipi di riprese non troppo sofisticate (metodo afocale).<br />
I telescopi sono "macchine ottiche" piuttosto semplici. Anche un modello molto sofisticato<br />
difficilmente ha più di quattro elementi ottici prima del piano focale, e molti ne hanno solo due. Per<br />
confronto, il normale obiettivo zoom della vostra macchina fotografica ha magari 7-10 lenti, o anche<br />
più. Ma rispetto al "comune" obiettivo il telescopio è ottimizzato per lavorare per soggetti posti<br />
all'infinito (e questo è abbastanza ovvio) ma soprattutto è lavorato con precisione nettamente più<br />
elevata di strumenti ottici "comuni", come occhiali, binocoli o l'obiettivo della vostra compatta.<br />
COSA FA (E COSA NON FA) UN TESCOPIO<br />
Utilizzare un telescopio, rispetto ad osservare ad occhio nudo, o anche con un binocolo, apporta<br />
due vantaggi sostanziali:<br />
Il grande diametro dell'obiettivo consente di raccogliere molta luce e quindi di vedere<br />
stelle più deboli di quelle visibili ad occhio nudo. Ovviamente le stelle che già si vedono ad<br />
occhio nudo, al telescopio appaiono estremamente brillanti. Effettuando osservazioni di<br />
soggetti terrestri, entro certi limiti, "vedete nel buio".<br />
Aumenta il potere risolutivo, o risoluzione, ovvero la capacità di distinguere particolari fini.<br />
In altre parole, con un telescopio potete leggere il giornale da 50 metri di distanza, o vedere<br />
minuti dettagli sulla Luna.<br />
Entrambe queste possibilità del telescopio sono legate al diametro dell'obiettivo, che è quindi il<br />
parametro principale per valutare la "potenza" di un telescopio. Contrariamente a quanto si crede,<br />
gli ingrandimenti non hanno molta importanza. In tutti i telescopi si può variare ingrandimento quasi<br />
a piacimento, cambiando oculare o utilizzando accessori appositi. Tuttavia solo di rado l'atmosfera<br />
terrestre è tanto tranquilla da permettere di utilizzare con profitto più di 400 ingrandimenti, e spesso<br />
si osserva a soli 100 o anche 50 ingrandimenti, e anche meno.<br />
Principale svantaggio dell'osservazione telescopica è che il campo inquadrato è molto piccolo.<br />
Pensate alla Luna piena. Mentre ad occhio nudo la Luna è "piccola" nel cielo, al telescopio<br />
riuscirete ad osservare al massimo una zona poco più grande della Luna stessa. Essendo piccolo il<br />
campo inquadrato, è difficile "puntare" il telescopio verso il soggetto che si desidera osservare. Se<br />
lo strumento non ha il puntamento automatico, ha in parallelo un piccolo cannocchiale, chiamato<br />
cercatore, che ingrandisce poco (4-10 volte) ma abbraccia un campo maggiore, e che viene usato<br />
esattamente come il mirino di un fucile.<br />
Poiché ingrandisce "molto", certo più di comuni binocoli, il telescopio mette anche in evidenza il<br />
fatto che la nostra atmosfera spesso è un po' agitata. Solo raramente le immagini sono<br />
perfettamente "ferme", ma a questo si fa rapidamente l'abitudine.<br />
Anche se può apparire scontato sottolineiamo alcune cose che il telescopio non può fare.<br />
Il telescopio non permette di osservare attraverso le nuvole e la foschia.<br />
Il campo visivo è sempre un cerchio (se fotografate può comparire vignettatura, ovvero<br />
l'immagine è un cerchio al centro del fotogramma mentre gli angoli sono neri).<br />
Il telescopio ha un limite minimo di messa a fuoco. In genere la distanza minima di messa a<br />
4<br />
Questo documento è di proprietà di Salmoiraghi & Viganò ed è tutelato dalle leggi sulla proprietà<br />
intellettuale. Ogni sua diffusione o utilizzo parziale o integrale, non specificatamente autorizzato<br />
dall’autore, potrà essere perseguito a termini di legge.
fuoco di un telescopio non è meno di 10-15 metri. Tuttavia, con molti telescopi, si possono<br />
effettuare interessanti osservazioni naturalistiche (animali, piante inaccessibili, nidi di<br />
uccelli). Dato che normalmente un telescopio fornisce un'immagine rovesciata, cosa che è<br />
irrilevante in astronomia ma sarebbe scomoda in osservazioni terrestri, esiste un apposito<br />
accessorio per avere una visione diritta, ed in una posizione comoda per l'osservatore.<br />
Non si possono ottenere ingrandimenti illimitati. Nessun telescopio vi permette di leggere<br />
un giornale da 200 chilometri di distanza!<br />
L'unica osservazione cui bisogna dedicare una certa cautela è quella del Sole, per il quale<br />
è tassativo l'uso di un filtro di provata qualità, da applicarsi davanti all'obiettivo.<br />
Inutile sottolineare che nessun telescopio è l'ideale per ogni osservazione, così come<br />
un'automobile non può conciliare grande capacità di carico con dimensioni contenute.<br />
PARAMETRI ESSENZIALI<br />
Non si può parlare di telescopi se non si conoscono alcune definizioni, che ci permettono di<br />
"leggerne" le caratteristiche.<br />
Diametro. Come detto è senza dubbio il parametro fondamentale del telescopio. È il<br />
diametro dell'obiettivo, specchio o lente che sia. Di norma si considera un telescopio<br />
amatoriale "piccolo" sotto gli 80 mm di diametro, medio da 80 a 200 mm, grande fino a<br />
300-350 mm e molto grande oltre. La presenza di uno specchio secondario che "fa ombra"<br />
sull'obiettivo, e in effetti toglie parte della luce, non influenza il diametro.<br />
Focale (o "lunghezza focale"). È la distanza tra l'obiettivo e la superficie dove si forma<br />
l'immagine dell'oggetto su cui l'obiettivo "punta", quando l'oggetto è posto a distanza<br />
infinita. Se una lente ha una focale di 600 mm ciò significa che l'immagine che essa forma<br />
di un soggetto all'infinito si forma a 600 mm dal centro della lente. Ci si può facilmente<br />
rendere conto di cosa sia la focale facendo formare l'immagine su un foglio di carta<br />
tenendo una comune lente di ingrandimento puntata verso qualcosa di riconoscibile (un<br />
albero, un palazzo, ecc). L'immagine si formerà circa 20 cm dietro la lente. Tra specchi e<br />
lenti vi è la ovvia differenza che la lente produce l'immagine dalla parte opposta del<br />
soggetto, mentre uno specchio dalla stessa parte. Un sistema ottico non deve avere<br />
necessariamente delle dimensioni fisiche pari alla focale. I telescopi catadiottrici, ad<br />
esempio, includono spesso nello schema ottico un elemento che allunga la focale<br />
"nominale" dello specchio obiettivo (specchio primario) ed avere magari 2 metri di focale<br />
con un tubo di appena 60-80 cm. Quando si applica una macchina fotografica al telescopio<br />
al "fuoco diretto", si usa la focale del telescopio come se fosse quella di un obiettivo. Si<br />
capisce immediatamente che anche un telescopio piccolo è un potente teleobiettivo, ed un<br />
telescopio "medio", diciamo da due metri di focale (2000 mm) è un teleobiettivo molto<br />
potente.<br />
Rapporto focale. È il rapporto tra la lunghezza focale e il diametro. Si indica con f/.<br />
Essendo un rapporto tra due lunghezze, f/ è un numero puro (cioè non ha unità di misura).<br />
Rapporto focale, lunghezza focale e diametro sono legati dalla semplice relazione<br />
5<br />
f/ = F / D<br />
Per esempio, un telescopio da 150 mm di diametro e 1200 mm di focale è un f/8. Infatti 1200 diviso<br />
150 fa 8. Il rapporto focale è una caratteristica determinante del telescopio, ed è importante per<br />
Questo documento è di proprietà di Salmoiraghi & Viganò ed è tutelato dalle leggi sulla proprietà<br />
intellettuale. Ogni sua diffusione o utilizzo parziale o integrale, non specificatamente autorizzato<br />
dall’autore, potrà essere perseguito a termini di legge.
stabilire in quali osservazioni un telescopio sia più sfruttabile<br />
Pupilla d'uscita. È il diametro del telescopio diviso per l'ingrandimento in uso, ed è anche<br />
il diametro del fascio luminoso che esce dall'oculare e investe il nostro occhio. Dato che la<br />
pupilla umana, al massimo, raggiunge i 6-7 millimetri di diametro, pupille d'uscita più grandi<br />
vanificano parte del potere di raccolta di luce del telescopio. All'altro estremo, pupille<br />
d'uscita di diametro inferiore al mezzo millimetro risultano difficili da utilizzare.<br />
Magnitudine limite. È la luminosità (magnitudine) della stella più debole osservabile con un<br />
determinato strumento. Dipende solo dal diametro, e ovviamente dalle condizioni in cui si osserva.<br />
La scala delle magnitudini è un po' complicata, essendo stata creata prima di Cristo e modificata<br />
più volte nel corso dei secoli. In sintesi, la luminosità di un oggetto celeste è espressa da un<br />
numero tanto più grande quanto più debole è l'oggetto. Oggetti molto brillanti hanno magnitudini<br />
negative, e una differenza di 5 magnitudini significa che un oggetto è esattamente 100 volte più<br />
brillante di un altro. Qualche esempio:<br />
OGGETTO MAGNITUDE APPROSSIMATIVA<br />
Sole -26,7<br />
Luna piena -12<br />
Luna al quarto -9<br />
Venere al massimo splendore -4,4<br />
Giove al massimo splendore -2,5<br />
Stella più brillante (Sirio) -1,4<br />
Vega 0<br />
Stella polare 2<br />
Albireo (beta del Cigno) 3<br />
Stelle più deboli visibili ad occhio nudo 6<br />
Limite visuale di un telescopio da 80 mm 11,5<br />
Limite visuale di un telescopio da 250 mm 14<br />
Telescopio da 30 cm, ripresa CCD 19,5<br />
Telescopio da 4 metri con pellicola 22<br />
Limite telescopio spaziale 27 circa<br />
È senz'altro interessante notare come l'uso di un sensore elettronico (CCD) avvicini le prestazioni<br />
di un telescopio amatoriale ancora trasportabile (un 30 cm) a quello che ottiene un telescopio<br />
gigante professionale, alto come un palazzo e del peso di centinaia di tonnellate, usato con le<br />
tradizionali pellicole chimiche!<br />
Queste poche caratteristiche di base ci permettono di capire un po' meglio la "specializzazione" dei<br />
vari telescopi:<br />
I telescopi a basso rapporto focale (sotto f/6): offrono un grande campo visuale e sono<br />
fotograficamente luminosi (o "veloci"). Il basso rapporto focale permette di effettuare<br />
esposizioni fotografiche in tempi molto ridotti (a scapito però della risoluzione). Questi<br />
6<br />
Questo documento è di proprietà di Salmoiraghi & Viganò ed è tutelato dalle leggi sulla proprietà<br />
intellettuale. Ogni sua diffusione o utilizzo parziale o integrale, non specificatamente autorizzato<br />
dall’autore, potrà essere perseguito a termini di legge.
telescopi non sono generalmente adatti per gli alti ingrandimenti, ma danno belle immagini<br />
a grande campo di oggetti deboli e immagini a medio ingrandimento della Luna e dei<br />
pianeti.<br />
I telescopi ad alto rapporto focale (oltre f/10): danno alti ingrandimenti con oculari più<br />
comodi da usare, e di solito forniscono immagini molto contrastate, sia in visuale che<br />
fotograficamente, specie della superficie lunare e dei pianeti, ma anche degli oggetti<br />
terrestri. Questi telescopi sono fotograficamente meno luminosi ("lenti") e non sono<br />
generalmente adatti alla fotografia astronomica degli oggetti deboli (nebulose, galassie).<br />
Telescopi a medio rapporto focale (tra f/6 e f/10): sono strumenti universali, e<br />
racchiudono le caratteristiche di entrambe le categorie viste sopra, ovviamente con qualche<br />
compromesso. Questi telescopi sono adatti a tutti i tipi di osservazioni sia visuali che<br />
fotografiche.<br />
Un'altra formuletta da tenere a mente è quella che consente di calcolare che ingrandimento<br />
fornisce un particolare oculare con un particolare telescopio. Non è difficile. Ogni oculare riporta,<br />
chiaramente stampigliato sul barilotto, la propria lunghezza focale. L'ingrandimento fornito da<br />
quell'oculare è dato da:<br />
7<br />
I = Ft / Fo<br />
Dove I è l'ingrandimento, Ft è la focale del telescopio e Fo è la focale dell'oculare. Così, un oculare<br />
da 20 mm utilizzato su un telescopio da tre metri di focale (3000 mm) fornisce 3000 / 20 = 150<br />
ingrandimenti (si scrive "150´" e si legge "150 per").<br />
Esistono molti tipi di oculari diversi, e i vari schemi ottici influiscono sul campo che l'oculare<br />
consente di inquadrare, sulla definizione dell'immagine, ed altri parametri, ma l'ingrandimento è<br />
dettato solo dalla focale.<br />
Gli oculari A e B hanno focali diverse (A è più corto di B, ed ingrandisce di più) ma hanno lo stesso campo<br />
apparente, ovvero, guardandoci dentro, il cerchio-immagine appare grande uguale. L'oculare C ha la stessa<br />
focale di B (stesso ingrandimento) ma abbraccia un campo più modesto (il cerchio è più piccolo).<br />
Il limite massimo degli ingrandimenti vale circa due volte il diametro dell'obiettivo espresso in<br />
millimetri. Circa 2,5 volte se il telescopio è un rifrattore. Quindi 200´ per un riflettore da 100 mm e<br />
circa 300´ per un rifrattore da 120. Vi è poi un limite pratico, che come accennato prima è dato<br />
sostanzialmente dalla stabilità atmosferica. Di rado si riesce ad utilizzare più di 400´,<br />
indipendentemente dal telescopio. Ma ogni tanto ci sono notti che consentono 1000´ e anche più, e<br />
in quelle occasioni si osservano dettagli straordinari.<br />
Questo documento è di proprietà di Salmoiraghi & Viganò ed è tutelato dalle leggi sulla proprietà<br />
intellettuale. Ogni sua diffusione o utilizzo parziale o integrale, non specificatamente autorizzato<br />
dall’autore, potrà essere perseguito a termini di legge.
Meno ovvio è il limite minimo degli ingrandimenti, di solito considerato pari al diametro del<br />
telescopio, sempre in millimetri, diviso 7. Questo limite nasce, come accennato prima, dalla pupilla<br />
d'uscita che altrimenti diviene più grande di quella dell'occhio e fa "sprecare" luce.<br />
Ogni telescopio deve avere un corredo di almeno tre o quattro oculari, per permettere di variare gli<br />
ingrandimenti in base alle condizioni di osservazione. L'ingrandimento "giusto" per ogni<br />
osservazione è dettato dall'esperienza, ma in linea di massima si parte sempre con l'ingrandimento<br />
minimo e poi si aumenta progressivamente, fino a quello che offre il contrasto più alto per il tipo di<br />
oggetto in esame.<br />
Esistono accessori ottici sia per "allungare" la focale (aumentare il rapporto f/) che per accorciarla<br />
(diminuire f/), ma non per tutti gli strumenti. In linea di massima il dispositivo ottico per allungare la<br />
focale (lente di Barlow) è più economico ed efficiente di quelli per accorciarla. Naturalmente dover<br />
interporre un altro elemento ottico può ridurre un minimo la qualità dell'immagine rispetto ad uno<br />
strumento di focale "nativamente" più lunga (o più corta).<br />
TIPI TELESCOPI<br />
Come già accennato, in base allo schema ottico i telescopi moderni si dividono in tre "famiglie":<br />
Rifrattori, ossia strumenti il cui obiettivo è una lente (o meglio, un doppietto o anche un<br />
tripletto, per ridurre il cromatismo). Il loro campo d'elezione sono le osservazioni di Sole,<br />
Luna, pianeti e stelle doppie e la fotografia a grande / medio campo. Sono adatti alle<br />
osservazioni di cielo profondo solo se sono di diametro sufficiente (almeno 8-10 cm). In<br />
commercio si trovano modelli dai 6 ai 15-18 cm di diametro. Compatti e leggeri nei diametri<br />
modesti, divengono ingombranti e costosi in quelli importanti. Tuttavia offrono una incisione<br />
d'immagine che nessun altro schema ottico può offrire.<br />
Schema di un telescopio rifrattore:<br />
La luce entra da sinistra l'obiettivo (1), in questo caso un doppietto, genera direttamente l'immagine al<br />
fuoco (F). Un secondo tubo scorrevole nel primo, il focheggiatore (2) consente di mettere a fuoco i<br />
diversi oculari. Uno o più diaframmi (3) lungo il tubo migliorano il contrasto, mentre il paraluce (4)<br />
protrude davanti all'obiettivo per evitare la formazione di condensa.<br />
Riflettori, basati su specchi. Lo schema più classico è quello di Newton, ma esistono<br />
diverse varianti, come il Cassegrain, dove l'immagine si forma dietro lo specchio principale,<br />
che è forato al centro (quasi tutti gli schemi ottici prendono il nome dal loro inventore o da<br />
chi li perfezionò). Sono gli strumenti che offrono la massima raccolta di luce per unità di<br />
costo, e quindi i preferiti dagli appassionati di oggetti di "cielo profondo" (galassie,<br />
nebulose, comete). Vengono offerti in diametri dai 10 ai 40 cm e anche più. Oltre i 20-25<br />
cm sono trasportabili solo se la montatura è altazimutale (vedi oltre), il che preclude di<br />
8<br />
Questo documento è di proprietà di Salmoiraghi & Viganò ed è tutelato dalle leggi sulla proprietà<br />
intellettuale. Ogni sua diffusione o utilizzo parziale o integrale, non specificatamente autorizzato<br />
dall’autore, potrà essere perseguito a termini di legge.
usarli per fotografia.<br />
Schema di un telescopio Newton:<br />
La luce entra da sinistra e lo specchio primario (1) crea direttamente l'immagine nel fuoco (F). Lo<br />
specchio piano (2) fa sì che l'immagine si formi a lato del tubo (altrimenti l'osservatore farebbe ombra<br />
sullo specchio).<br />
Catadiottrici, o composti, che sfruttano sia lenti che specchi (come già accennato, sono<br />
sostanzialmente dei riflettori con una grande lente frontale di basso potere, che annulla<br />
alcune aberrazioni). Veri telescopi tuttofare, sono la scelta obbligata per chi vuole un<br />
diametro importante ma ancora trasportabile e per eseguire fotografie dal "campo aperto".<br />
Esistono dai 9 ai 40 cm circa di diametro. Purtroppo la loro complessità ottica e meccanica<br />
si paga, specie nei diametri maggiori. I tipi più diffusi sono lo Schmidt-Cassegrain, che ha<br />
una lente frontale sottile che sostiene uno specchio secondario indipendente, ed il<br />
Maksutov, che ha invece una lente frontale più spessa (chiamata menisco per la sua<br />
forma), e dove lo specchio secondario è ottenuto alluminando la parte centrale del<br />
menisco. Progetti recenti hanno portato lo sviluppo di schemi derivati da questi, di cui è<br />
certamente interessante l'ACF (Advanced Coma Free), particolarmente indicato per la<br />
fotografia. Tutti i catadiottrici danno buoni risultati in ogni tipo di osservazione, tranne i<br />
Maksutov, che a causa del loro rapporto f/ solitamente elevato (12 o più) riescono meglio<br />
nelle osservazioni di dettaglio (Sole, Luna, pianeti, stelle doppie) che non nella fotografia di<br />
oggetti deboli.<br />
Schema di un telescopio catadiottrico (un Maksutov):<br />
La luce entra da sinistra, attraversa la prima lente (lastra o menisco, 1) e poi lo specchio primario (2)<br />
la indirizza sullo specchio secondario (3), che genera l'immagine al fuoco (F), posto dietro il primario.<br />
Lo Schmidt-Cassegrain è molto simile, tranne che la prima lente è più sottile e meno curva, e lo<br />
specchio secondario ha un suo sostegno, non è solidale al menisco come nel Maksutov<br />
Non solo ottica…<br />
9<br />
Questo documento è di proprietà di Salmoiraghi & Viganò ed è tutelato dalle leggi sulla proprietà<br />
intellettuale. Ogni sua diffusione o utilizzo parziale o integrale, non specificatamente autorizzato<br />
dall’autore, potrà essere perseguito a termini di legge.
Prima abbiamo accennato che i telescopi sono insiemi di ottica e meccanica. Le due cose vanno<br />
sempre considerate assieme, e non devono essere sproporzionate. Uno stupendo telescopio su<br />
una montatura traballante o sottodimensionata è come una macchina di Formula 1 con ruote da<br />
bicicletta. Non potrà mai esprimere appieno le proprie potenzialità. Vediamo quindi i vari tipi di<br />
montatura:<br />
La più semplice è la montatura altazimutale. Consente solo i movimenti alto-basso e<br />
destra-sinistra. Va benissimo per osservazioni visuali, ma non può essere utilizzata per<br />
l'esecuzione di fotografie impegnative. Molto diffusa per i telescopi più piccoli, esiste<br />
viceversa anche per i grandi riflettori (montatura Dobson), dedicati agli osservatori "puristi"<br />
di oggetti deboli. Di norma queste montature non hanno regolazioni micrometriche, ma<br />
questo è un problema relativo, in quanto di norma si utilizzeranno ingrandimenti modesti, e<br />
quindi campi di vista ragionevolmente ampi. Se computerizzate, sono indicate per<br />
cominciare.<br />
I telescopi con possibilità fotografiche hanno quasi tutti una montatura equatoriale, più<br />
ingombrante e più complicata da usare (richiede che uno degli assi venga orientato al polo<br />
celeste) ma permette l'esecuzione di ogni fotografia. Queste montature hanno di serie, o<br />
almeno come opzione, un motorino elettrico che fa compiere al telescopio un giro al giorno<br />
in senso opposto alla rotazione della Terra, compensando così la rotazione della volta<br />
celeste. Quelle di livello appena superiore hanno due motori, permettendo il moto elettrico<br />
in ogni direzione.<br />
La semplicità della montatura Dobson indica che<br />
tutto, in questi strumenti, è sacrificato al diametro<br />
maggiore possibile a parità di costo.<br />
10<br />
Un piccolo rifrattore su montatura altazimutale, ma<br />
dotato di sistema di puntamento automatico.<br />
Compatto e leggero, è un buon primo<br />
L'uno e l'altro tipo di montatura possono avere un sistema di puntamento elettronico, e alcuni<br />
telescopi possono addirittura "trasformarsi" da altazimutali in equatoriali con l'aggiunta di un pezzo<br />
meccanico, detto "testa equatoriale", che verrà montato solo quando si intende fotografare.<br />
Questo lascia notevole libertà all'utilizzatore, che porta con sé solo le parti necessarie,<br />
risparmiando in peso, e tempo necessario per montare o smontare il telescopio.<br />
<strong>IL</strong> CIELO D'AUTUNNO. OTTIMO PER AVVICINARSI ALLE STELLE!<br />
Probabilmente nessuno spettacolo della natura supera per maestosità quello offerto dal cielo<br />
notturno. Il firmamento, apparentemente immutabile, ma in realtà sempre diverso, affascina<br />
chiunque.<br />
Questo documento è di proprietà di Salmoiraghi & Viganò ed è tutelato dalle leggi sulla proprietà<br />
intellettuale. Ogni sua diffusione o utilizzo parziale o integrale, non specificatamente autorizzato<br />
dall’autore, potrà essere perseguito a termini di legge.
Purtroppo, oggi, non è facile godersi una bella notte stellata.<br />
Da un lato l'inquinamento luminoso, ovvero l'uso spropositato delle luci artificiali, ha reso lattescenti i<br />
cieli cittadini, nascondendoci le stelle più deboli.<br />
Dall'altro, viviamo ormai staccati dal cielo notturno e, al contrario dei nostri antenati, solo poche<br />
persone sono in grado di distinguere una stella da un pianeta, oppure di trovare anche costellazioni<br />
famosissime, come Orione oppure l'Orsa Maggiore.<br />
E questo sebbene oggi i progressi dell'astronomia e le possibilità di comunicazione ci rendano<br />
disponibile una quantità di informazioni sugli oggetti celesti che Galileo non avrebbe mai nemmeno<br />
osato sognare. Per fortuna, basta allontanarsi dai maggiori centri abitanti per vedere un cielo<br />
discreto, e quasi tutti ne abbiamo l'occasione, almeno durante le vacanze.<br />
Ma una volta sotto le stelle, se la nostra curiosità viene solleticata, come soddisfarla? Quale delle<br />
tante stelle in cielo sarà Giove? E quanto è lontano? Certamente libri e cartine possono aiutare, ma<br />
nulla può sostituire una persona esperta che ci indichi dove si trova Marte, o la Polare, o che ci<br />
racconti la mitologia della costellazione del Leone.<br />
Ma se un amico simile non è disponibile, cosa si fa?<br />
UNA COMPLETA GUIDA AL CIELO… IN UNA MANO<br />
Lo SkyScout si presenta con un design<br />
accattivante, e pochi semplici comandi. Due<br />
batterie AA (non incluse) assicurano molte ore di<br />
uso continuo<br />
11<br />
La tecnologia ha risolto anche questo problema,<br />
creando lo SkyScout, uno stupefacente<br />
strumento, compatto e leggero, che integra una<br />
enorme quantità di funzioni, e - letteralmente - vi<br />
guida alla scoperta del cielo notturno.<br />
SkyScout è costituito da una semplice mira ottica<br />
(non ha lenti e non ingrandisce) e da una serie di<br />
sensori, coordinati da un microcomputer.<br />
Basta accenderlo e in pochi secondi, grazie al<br />
GPS, stabilisce la vostra posizione sulla Terra e<br />
l'ora esatta. Poi, utilizzando la bussola e<br />
l'inclinometro elettronici interni, lo SkyScout<br />
"capisce" dove lo state dirigendo, e può<br />
identificare ogni stella verso cui lo puntate.<br />
E questo è solo l'inizio! Può indicarvi stelle e pianeti, aiutarvi a puntarli con una serie di LED visibili<br />
attraverso la mira ottica, e descriverli in dettaglio sia come testo, tramite l'ampio display<br />
retroilluminato, che con descrizioni vocali, fruibili grazie alle cuffiette incluse. SkyScout può<br />
addirittura organizzarvi dei "tour" del cielo, fornendo informazioni di carattere storico e fisico su<br />
centinaia di oggetti celesti. Come se non bastasse, un vastissimo glossario vi permette di<br />
impratichirvi con i termini specifici della scienza del cielo, in modo chiaro e rigoroso.<br />
Il tardo autunno e l'inizio dell'inverno, quando il cielo è più limpido, è probabilmente il momento<br />
migliore per accostarsi al cielo stellato. SkyScout vi può raccontare (e non per modo di dire) della<br />
compagna di Sirio, la stella più brillante di tutte. Dell'ammasso di stelle delle Pleiadi, ben visibile<br />
anche ad occhio nudo, nel Toro. Della maestosa nebulosa di Orione, e della grande galassia di<br />
Andromeda, tutti oggetti percepibili ad occhio nudo e ben visibili col più modesto ausilio ottico.<br />
SkyScout vi permette di crearvi da soli, in poco tempo, una conoscenza vasta e precisa del cielo<br />
visibile ad occhio nudo. Quella competenza iniziale, potremmo dire l'ABC del cielo notturno, che è<br />
tanto difficile da farsi da soli partendo solo da informazioni stampate, con questo prodigio<br />
Questo documento è di proprietà di Salmoiraghi & Viganò ed è tutelato dalle leggi sulla proprietà<br />
intellettuale. Ogni sua diffusione o utilizzo parziale o integrale, non specificatamente autorizzato<br />
dall’autore, potrà essere perseguito a termini di legge.
tecnologico divengono naturali. Tutti sanno che la Luna gira attorno alla Terra, ma dopo averne<br />
seguito il percorso tra le stelle per qualche giorno (ed avendo individuato le costellazioni dello<br />
zodiaco grazie allo SkyScout) vi possiamo assicurare che il cielo notturno non sarà mai più lo stesso.<br />
Non una cupola scura con tanti puntini luminosi, ma un Universo vivo, in continuo movimento,<br />
popolato di astri caldi e freddi, pianeti giganti, nebulose dove le stelle nascono e resti di stelle morte.<br />
In un certo senso vi sentirete più partecipi del creato, una sensazione difficile da spiegare, ma che<br />
accomuna i milioni di astrofili (appassionati di astronomia) di tutto il mondo.<br />
E, ve lo auguriamo, utilizzare lo SkyScout può instillarvi la curiosità di saperne di più.<br />
Tramite libri e conferenze, magari, oppure investendo una piccola cifra per acquistare la vostra<br />
personale macchina del tempo e dello spazio. Un piccolo telescopio, che vi permette di vedere con<br />
maggior chiarezza quello che lo SkyScout vi indica e descrive.<br />
APPUNTO, UN PICCOLO TELESCOPIO.<br />
Un tipico rifrattore da 60 mm, una buona<br />
scelta per iniziare.<br />
12<br />
Con una cifra modesta, oggi, potete acquistare un<br />
telescopio che avrebbe lasciato a bocca aperta tutti i<br />
sapienti del passato.<br />
Da Aristotele, le cui concezioni astronomiche sono<br />
rimaste quelle "ufficiali" per quasi due millenni, a Galileo,<br />
che quelle concezioni ha rivoluzionato, a Newton, che ha<br />
stabilito i fondamenti matematici del Cosmo.<br />
Un telescopio amatoriale moderno, piccolo e leggero, dal costo assolutamente accessibile, è di gran<br />
lunga più potente di ogni telescopio costruito per tutti i cento anni successivi al lavoro di Galileo, che<br />
realizzò i primi strumenti astronomici all'inizio del XVII° secolo.<br />
Una buona scelta per accostarsi all'astronomia pratica, osservativa, è un rifrattore da 60 mm, ossia<br />
un telescopio il cui obiettivo è un sistema di lenti da 60 mm di diametro.<br />
Un "telescopietto" del genere permette di ripetere facilmente innumerevoli osservazioni che hanno<br />
plasmato la storia dell'astronomia, e in alcuni casi perfino cambiato concezioni filosofiche. Non ci<br />
credete? Potete osservare le macchie solari, il loro evolvere, e misurare il periodo di rotazione del<br />
Sole.<br />
Potete osservare centinaia di dettagli sulla superficie della Luna (crateri, mari, rime). Potete<br />
osservare i satelliti principali di Giove e Saturno, e verificarne l'orbita giorno dopo giorno.<br />
Osservare centinaia di stelle doppie, vederne i diversi colori, e vedere con i vostri occhi i principali<br />
ammassi di stelle, aperti e globulari, nebulose brillanti e oscure, galassie, di cui leggete in ogni testo<br />
che parli di astronomia.<br />
E molto altro! Ma se non vi bastasse?<br />
Questo documento è di proprietà di Salmoiraghi & Viganò ed è tutelato dalle leggi sulla proprietà<br />
intellettuale. Ogni sua diffusione o utilizzo parziale o integrale, non specificatamente autorizzato<br />
dall’autore, potrà essere perseguito a termini di legge.
TELESCOPI PIÙ POTENTI<br />
Una versione ricca e<br />
robusta del classico "114",<br />
qui in versione compatta<br />
Un 114 a controllo<br />
elettronico. Punta da solo<br />
gli oggetti celesti!<br />
13<br />
Esistono decine di modelli di telescopi, per tutte le esigenze e per<br />
tutte le tasche.<br />
Se volete spingervi un po' oltre quello che offre il piccolo rifrattore che<br />
abbiamo citato prima, non c'è che l'imbarazzo della scelta. La prima<br />
alternativa, ovviamente, è un telescopio un po' più potente. Il parametro<br />
principale per valutare la "potenza" di un telescopio è il diametro del<br />
suo obiettivo.<br />
Dai 10 cm di diametro in su quasi tutti gli strumenti usano uno specchio,<br />
e non più una lente, come obiettivo.<br />
Si chiamano allora riflettori e fu proprio Newton a costruirne il primo<br />
esemplare realmente fruibile. Un telescopio più grande permette di<br />
vedere dettagli più fini (per esempio crateri lunari più piccoli) ma<br />
soprattutto permette di apprezzare stelle più deboli, col risultato che gli<br />
oggetti celesti osservabili, ossia ammassi, nebulose e galassie, sono più<br />
numerosi e meglio definiti che con un telescopio piccolo.<br />
Tra i telescopi di buon diametro adatti come primo strumento spicca una<br />
nutrita famiglia di strumenti accomunati dal diametro dello specchio di<br />
114 mm. Sono talmente diffusi che si chiamano "i 114", e praticamente<br />
tutti gli appassionati del cielo ne hanno usato almeno uno.<br />
Particolarmente interessanti i modelli compatti, che uniscono alla buon<br />
diametro dimensioni esterne limitate e grande leggerezza, fattore non<br />
trascurabile quando si desidera lasciare la città alla ricerca di un cielo<br />
scuro, o deve conciliare, in vacanza, telescopio e esigenze familiari. Per<br />
chi desidera cominciare col meglio, infine, non c'è che da unire il<br />
"classico" 114 ad un supporto (montatura) che include un computer di<br />
puntamento e motorini elettrici.<br />
Il telescopio diventa "intelligente", ed in grado di trovare da solo i<br />
soggetti che si desidera osservare, richiedendo al più una brevissima<br />
fase iniziale di sincronizzazione col cielo notturno. Strumenti di questo<br />
genere, in sostanza, sono il complemento perfetto allo SkyScout, e ne<br />
condividono parte della tecnologia.<br />
Usare un telescopio, infatti, all'inizio richiede un po' di pazienza, e se succede di non riuscire ad<br />
osservare qualcosa, resta sempre il dubbio di aver puntato male lo strumento (un telescopio<br />
inquadra una zona di cielo molto piccola, al più grande come due lune piene affiancate). Con gli<br />
strumenti a puntamento elettronico, questa difficoltà viene superata. Ad un costo accessibile, si può<br />
avere il meglio che la tecnologia offre oggi per avvicinarsi al cielo.<br />
Questo documento è di proprietà di Salmoiraghi & Viganò ed è tutelato dalle leggi sulla proprietà<br />
intellettuale. Ogni sua diffusione o utilizzo parziale o integrale, non specificatamente autorizzato<br />
dall’autore, potrà essere perseguito a termini di legge.
VIAGGIARE NEL TEMPO? NO PROBLEM<br />
Se continuate a provare interesse per il cielo, oppure la vostra curiosità per l'astronomia è più<br />
orientata alla teoria che alla pratica osservativa, troverete un ausilio indispensabile in un planetario<br />
software, ovvero un programma per computer che è in grado di riprodurre o predire l'aspetto del<br />
cielo visto da luogo della Terra, per ogni epoca passata o futura. Particolarmente interessante è<br />
Perseus, un prodotto interamente italiano, di costo estremamente contenuto, dotato di grafica e<br />
ricchezza di dati sorprendente. Perseus è un valido supporto all'atlante celeste, permette di "giocare"<br />
con viaggi nel tempo e nello spazio, e nella versione più completa permette addirittura di preparare<br />
presentazioni e generare filmati di fenomeni astronomici che per loro natura (magari richiedono<br />
tempi lunghissimi o di essere in un luogo particolare) sono praticamente impossibili da osservare<br />
dal vivo.<br />
Una schermata tipica del software Perseus<br />
14<br />
Questo documento è di proprietà di Salmoiraghi & Viganò ed è tutelato dalle leggi sulla proprietà<br />
intellettuale. Ogni sua diffusione o utilizzo parziale o integrale, non specificatamente autorizzato<br />
dall’autore, potrà essere perseguito a termini di legge.