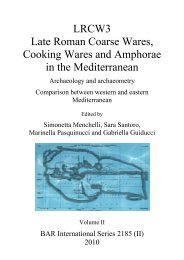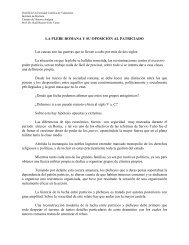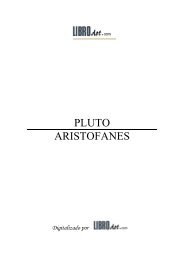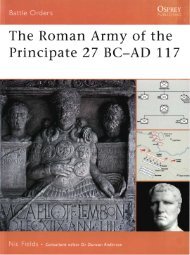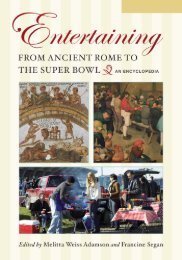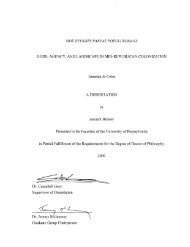Polverini 1..1 - Historia Antigua
Polverini 1..1 - Historia Antigua
Polverini 1..1 - Historia Antigua
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
L. POLVERINI<br />
L’estensione del nome Italia fino alle Alpi<br />
e la provincia Gallia Cisalpina<br />
estratto da<br />
«Geographia Antiqua»<br />
XIX, 2010<br />
# LEO S. OLSCHKI
GEOGRAPHIA ANTIQUA<br />
rivista di geografia storica<br />
del mondo antico<br />
e di storia della geografia<br />
GEOGRAFIA E POLITICA IN GRECIA E A ROMA<br />
B. VIRGILIO, La corrispondenza del re ellenistico............................................................. 5<br />
A. LARONDE, Les Ptolémées et la Méditerranée .............................................................. 19<br />
P. F. MITTAG, Das Indienbild des Ptolemaios ................................................................<br />
D. MARCOTTE, La mer Érythrée et le Sud de l’œkoumène, thème politique dans l’ethnographie<br />
25<br />
hellénistique ............................................................................................................<br />
F. K. MAIER, ,,... zu vertrauten Vorstellungen führen‘‘. Die Funktion der Geographie im<br />
39<br />
didaktischen Geschichtskonzept des Polybios................................................................ 47<br />
S. PANICHI, Lo spazio geografico nella storia dei diadochi (Diodoro XVIII-XX) ................. 65<br />
G. AUJAC, L’urbanisme entre géographie et politique........................................................<br />
B. DREYER, ‘L’asilo territoriale’ dal periodo tardo-classico fino al dominio degli imperatori<br />
77<br />
romani ...................................................................................................................<br />
E. MIGLIARIO, Anticipi di romanizzazione: pianificare, dividere, delimitare gli spazi nel mondo<br />
91<br />
veneto .................................................................................................................... 99<br />
L. POLVERINI, L’estensione del nome Italia fino alle Alpi e la provincia Gallia Cisalpina...... 115<br />
O. DALLY, Die Grenzen Roms .................................................................................... 123<br />
F. CADIOU, Géographie et pompa triumphalis à Rome .................................................<br />
Saggi<br />
141<br />
D. MARCOTTE, Le commentaire de Leto à Denys le Périégète retrouvé .............................<br />
P. ARNAUD, Notes sur le StadiasmedelaGrandeMer(2): rose des vents, systèmes<br />
151<br />
d’orientation et Quellenforschung ...........................................................................<br />
F. J. GÓMEZ ESPELOSÍN, El problema de la credibilidad de los relatos de viaje en la literatura<br />
157<br />
griega ..................................................................................................................... 163<br />
Note e discussioni<br />
P. JANNI, Ne sappiamo più degli Antichi? Considerazioni su una ‘notizia’ della stampa<br />
quotidiana............................................................................................................... 183<br />
Recensioni e notizie ...................................................................................................... 185<br />
Pubblicazioni ricevute .................................................................................................... 209<br />
Lista dei collaboratori ..................................................................................................... 211<br />
XIX<br />
2010
GEOGRAPHIA ANTIQUA<br />
rivista di geografia storica<br />
del mondo antico<br />
e di storia della geografia<br />
Direttore responsabile<br />
FRANCESCO PRONTERA<br />
Comitato scientifico<br />
GERMAINE AUJAC, ANNA MARIA BIRASCHI, GUIDO CLEMENTE, MICHAEL H. CRAWFORD,<br />
ALBRECHT DIHLE, EMILIO GABBA, PATRICK GAUTIER DALCHÉ,<br />
HANS-JOACHIM GEHRKE, PIETRO JANNI, GIANFRANCO MADDOLI, MARICA MILANESI,<br />
FRANCESCO PRONTERA, MIRJO SALVINI, PIERLUIGI TOZZI<br />
Direzione e Redazione<br />
DIPARTIMENTO DI SCIENZE STORICHE<br />
Università degli Studi di Perugia - Via dell’Aquilone 7, 06123 Perugia<br />
Tel. 075.585.31.11 - Fax 075.585.31.38 - E-mail: prontera@unipg.it<br />
Segreteria di Redazione<br />
LUCIA PALLARACCI, SILVIA PANICHI, ILARIA SERPOLLI<br />
Amministrazione<br />
CASA EDITRICE LEO S. OLSCHKI<br />
C.P. 66 - 50123 Firenze . Viuzzo del Pozzetto 8, 50126 Firenze<br />
E-mail: periodici@olschki.it . c.c.p. 12.707.501<br />
Tel. (+39) 055.65.30.684 . Fax (+39) 055.65.30.214<br />
2010: ABBONAMENTO ANNUALE -ANNUAL SUBSCRIPTION<br />
ISTITUZIONI - INSTITUTIONS<br />
La quota per le istituzioni è comprensiva dell’accesso on-line alla rivista,<br />
Indirizzo IP e richieste di informazioni sulla procedura di attivazione dovranno essere inoltrati a periodici@olschki.it<br />
Subscription rates for institutions includes on-line access to the journal.<br />
The IP address and requests for information on the activation procedure should be sent to periodici@olschki.it<br />
Italia: e 96,00 . Foreign e 116,00<br />
PRIVATI - INDIVIDUALS<br />
solo cartaceo - print version only<br />
Italia: e 74,00 . Foreign e 95,00<br />
Composizione, impaginazione e stampa<br />
CDC ARTI GRAFICHE -Cittàdi Castello<br />
Le opere per recensione vanno spedite a:<br />
«Geographia Antiqua» Dipartimento di Scienze Storiche<br />
Università degli Studi di Perugia - Via dell’Aquilone 7, 06123 Perugia<br />
Articoli e note vengono pubblicati previo giudizio di due studiosi (secondo la procedura peer review),<br />
di cui almeno uno esterno al Comitato scientifico. L’elenco dei revisori verrà reso noto ogni due anni.<br />
Pubblicazione periodica - Reg. Cancell. Trib. Perugia n. 35-99 del 22/6/1999<br />
Iva assolta dall’Editore a norma dell’art. 74/DPR 633 del 26/10/72<br />
ISSN 1121-8940<br />
# LEO S. OLSCHKI, Firenze<br />
In copertina: Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana. Ms. Laur. San Marco 190, c. 74r.<br />
Su concessione del Ministero per i beni culturali e le attività culturali.<br />
È vietata ogni ulteriore riproduzione con qualsiasi mezzo.
LEANDRO POLVERINI<br />
L’estensione del nome Italia fino alle Alpi<br />
e la provincia Gallia Cisalpina<br />
Prima della storia d’Italia, c’è la storia del nome Italia: la storia della progressiva espansione<br />
geografica del nome nel corso di vari secoli. 1 All’inizio, Italia è solo la parte meridionale<br />
dell’odierna Calabria (antico Bruzio), dallo stretto di Messina ai golfi di S. Eufemia (sul<br />
Tirreno) e di Squillace (sullo Ionio), là dove la distanza fra Tirreno e Ionio è minima, e costituisce<br />
praticamente un istmo. Alla metà del V secolo, 2 lo spazio geografico chiamato Italia<br />
si è esteso sul Tirreno fino al fiume Lao, includendo così quasi tutta l’attuale Calabria (e tutto<br />
l’antico Bruzio 3 ), e sullo Ionio fino a Metaponto o a Taranto. 4 Alla fine del V secolo, ne<br />
fanno ormai parte tutte le città greche orientali; a metà del IV, anche le città greche tirreniche<br />
fino a Posidonia (Paestum), seguite presto da quelle della Campania. Il nome geografico<br />
Italia coincideva così, difatto,conilnomestoricoMagna Graecia. Poi, l’espansione geografica<br />
del nome seguì di pari passo l’espansione territoriale di Roma, che a metà del III secolo<br />
aveva unificato l’Italia propriamente peninsulare, fino all’Arno e all’Esino (cioè,finoallimite<br />
settentrionale rispettivamente dell’Etruria e del Piceno). La fase successiva, e conclusiva, della<br />
storia antica del nome (anzi, della storia del nome tout court) ècostituita dalla sua estensione<br />
all’Italia continentale, o settentrionale, fino alla catena alpina. Il relativo problema cronologico<br />
è stato discusso molte volte; lo si richiama, ora, in quanto direttamente connesso con lo<br />
specifico argomento di questo contributo.<br />
Un notissimo frammento delle Origines di Catone, conservato nel commento virgiliano<br />
di Servio 5 (Alpes [...] quae secundum Catonem et Livium muri vice tuebantur Italiam), trova conferma<br />
esplicita in un altro frammento delle Origines, conservato da Varrone 6 (de magnitudine<br />
gallicarum succidiarum Cato scribit his verbis: in Italia Insubres etc.), e conferma problematica in<br />
due frammenti di orazioni. 7 Famosa quanto il citato frammento di Catone, e di esso più im-<br />
1 E. WISTRAND, Per la storia del nome d’Italia nell’antichità,<br />
in Mélanges de philologie romane offerts à M. Karl Michaelsson, Göteborg,<br />
Bergendahls Boktryckeri 1952, pp. 469-481; D. MU-<br />
STI, Italia. Storia del nome, inEV, III, 1987, pp. 34-40; E. PACK,<br />
s.v. Italia I, inRACh, XVIII, 1998, cc. 1051-1059.<br />
2 Sulla fondamentale testimonianza di Antioco di Siracusa,<br />
per quanto riguarda la storia del nome fino alla metà del V<br />
secolo: F. PRONTERA, Antioco di Siracusa e la preistoria dell’idea<br />
etnico-geografica di Italia, «GeogrAnt», I, 1992, pp. 109-135;<br />
ID., Die Grenzen von Italía bei Antiochos von Syrakus, inGrenze<br />
und Grenzland: 4. Stuttgarter Kolloquium zur historischen Geographie<br />
des Altertums (2.-6. Mai 1990), hrsg. von E. OLSHAUSEN<br />
* 115 *<br />
und H. SONNABEND (Geographica historica, 7), Amsterdam,<br />
Hakkert 1994, pp. 423-430.<br />
3 Il fiume Lao segnava il confine fra Lucania e Bruzio:<br />
Strab. VI 1, 1 (C 253); Plin. Nat. hist., III 72.<br />
4 Sul problema del confine orientale: MUSTI, Italia. Storia<br />
del nome cit., p. 36; PACK, s.v.Italia I cit., c. 1054.<br />
5 Aen., X 13 (= Cato Orig., fr. 85 Peter = IV 10 Chassi-<br />
gnet).<br />
6 De re rust., II4,11(= Cato Orig., fr. 39 Peter = II 9<br />
Chassignet).<br />
7 Uno (De Achaeis, fr. 187 Malcovati = 142 Sblendorio:<br />
cumque Hannibal terram Italiam laceraret atque vexaret)èconservato
portante (sia perché più diffusa ed esplicita, sia perché possiamo leggerla direttamente, nel<br />
suo contesto), è la descrizione dell’Italia che Polibio presenta nel II libro, come introduzione<br />
geografica alla guerra fra Roma e i Galli Cisalpini degli anni 225-222: «Avendo l’Italia nel<br />
suo insieme una forma triangolare, un lato di essa, quello vòlto a oriente, è delimitato dallo<br />
stretto Ionio e [...] dal golfo Adriatico, quello rivolto verso mezzogiorno e occidente [...] dal<br />
mare di Sicilia e dal Tirreno [...]. Delimita, invece, senza interruzione il restante lato, che si estende<br />
dalla parte del nord e del continente, la catena montuosa delle Alpi». 8 Così Polibio anche nel III<br />
libro: Annibale, vedendo i soldati atterriti dalle nevi alpine, «cercò di incoraggiarli con l’unico<br />
mezzo che aveva a questo scopo, la vista dell’Italia: essa, infatti, è situata ai piedi di queste<br />
montagne, sicché, se si osservano insieme l’una e le altre, le Alpi paiono occupare la posizione<br />
di acropoli dell’intera Italia». 9 Egiànel I libro, nel capitolo che costituisce un<br />
sommario del contenuto dei primi due libri, le operazioni militari degli anni 225-222 sono<br />
«i conflitti con i Celti d’Italia». 10 Sono queste, di Catone e di Polibio, le fondamentali attestazioni<br />
relative all’estensione del nome Italia fino alle Alpi: a quando risalgono?<br />
Catone cominciò a comporre le Origines prima (non molto prima) del 168, l’anno della<br />
battaglia di Pidna; 11 Polibio fu portato ostaggio a Roma l’anno seguente e, quando tornò in<br />
Grecia (nel 150), aveva già composto e pubblicato i libri da cui sono tratti i passi in questione.<br />
12 Le attestazioni di Catone e di Polibio si lasciano, insomma, datare fra gli anni Sessanta<br />
(o la fine degli anni Settanta, per quanto riguarda Catone) e gli anni Cinquanta del II secolo.<br />
13 Ma, per gli eventi dell’anno 225 e seguenti, Polibio dipende quasi sicuramente da Fabio<br />
Pittore, 14 che scriveva alla fine del III secolo. Si può pensare che la dipendenza di Polibio da<br />
Fabio Pittore per quanto riguarda la narrazione degli eventi implichi una qualche dipendenza<br />
anche per quanto riguarda le descrizioni e le concezioni geografiche? Se così fosse (è ipotesi<br />
problematica, alla luce del trattato di alleanza stipulato da Annibale e Filippo V nel<br />
215 15 ), l’estensione del nome Italia fino alle Alpi risalirebbe alla fine del III secolo, e si spie-<br />
da Gell. II 6, 7; Macr. VI 7, 10; Serv. Buc., VI 76. L’altro (De b.<br />
Carthag., fr.*195b Malcovati: qui sunt, qui Italiam deformaverunt?<br />
Carthaginienses), riconosciuto in Rhet. ad Her., IV14,20<br />
(e Quint. IX 3, 31), non è stato accolto nell’edizione della<br />
Sblendorio: M. Porci Catonis Orationum reliquiae. Introduzione,<br />
testo critico e commento filologico, acuradiM.T.SBLENDORIO<br />
CUGUSI (Historica, politica, philosophica. Il pensiero antico.<br />
Studi e testi, 12), Torino, Paravia 1982, pp. 371-372. Su La nozione<br />
di ‘Italia’ in Catone: G.MASSA, La formazione del concetto<br />
d’Italia. Tradizioni politiche e storiografiche nell’età precedente la ‘rivoluzione<br />
romana’ (Biblioteca di Athenaeum, 33), Como, New<br />
Press 1996, pp. 9-10. In più ampia prospettiva, si ricorda P. CA-<br />
TALANO, Appunti sopra il più antico concetto giuridico di Italia,<br />
«AAT», XCVI, 1961-62, pp. 198-228, poi in ANRW, XVI<br />
1, 1978, pp. 525-547, e si segnala F. RUSSO, Il concetto di Italia<br />
nelle relazioni di Roma con Cartagine e Pirro, «<strong>Historia</strong>»,LIX,<br />
2010, pp. 74-105.<br />
8 Polyb. II 14, 4 e 6: Sg& |dg+ rtlpa* rg| $ Isaki* a| s{& rvg* lasi<br />
sqicomoeidot& | t< paqvot* rg|, sg+ m le+ m li* am o< qi* fei pketqa+ m<br />
at$ sg& |sg+ m pqo+ | sa+ |a$ masoka+ | jejkile* mgm o% s $ $ Io* mio| po* qo|<br />
jai+ [...] o< jasa+ so+ m $Adqi* am jo* kpo|, sg+ mde+ pqo+ | lerglbqi* am<br />
jai+ dtrla+ | sesqalle* mgm so+ Rijekijo+ mjai+ Stqqgmijo+ mpe* kaco|<br />
[...]. (6) sg+ mde+ koipg+ msg+ mpaqa* se sa+ |a> qjsot| jai+ sg+ m lero* -<br />
caiam paqasei* motram o< qi* fei jasa+ so+ rtmeve+ |g< sx& m >Akpexm<br />
paqx* qeia. – La traduzione nel testo è di Manuela Mari, in Polibio,<br />
Storie, a cura di D. MUSTI, I (libri I-II), Milano, Rizzoli<br />
2001, pp. 443 e 445 (il corsivo è mio).<br />
9 Polyb. III 54, 2: [$Ammi* ba|] e$ peiqa& so [...] paqajakei& m,<br />
li* am e> vxm a$ uoqlg+ mei$ |sot& so sg+ msg& | $ Isaki* a| e$ ma* qceiam" ot% sx|<br />
ca+ qt< popepsx* jei soi& | pqoeiqgle* moi| o> qerim x% rse rtmhexqotle*<br />
mxm a$ luoi& ma$ jqopo* kex| uai* merhai dia* herim e> veim sa+ | >Akpei|<br />
LEANDRO POLVERINI<br />
* 116 *<br />
sg& |o% kg| $ Isaki* a|. – La traduzione nel testo è tratta dall’edizione<br />
citata nella nota precedente: II (libri III-IV), 2001, p. 131.<br />
10 Polyb. I 13, 4: oi< pqo+ |sot+ |e$ m $ Isaki* y Jeksot+ |a$ cx& me|.<br />
11 Vedi A. E. ASTIN, Cato the Censor, Oxford, Clarendon<br />
Press 1978, p. 212; M. CHASSIGNET, Introduction, nella sua edizione<br />
di Caton, Les Origines (Fragments), Paris, Les Belles Lettres<br />
1986, p. IX: «LesOrigines ont donc été écrites entre 170 au plus<br />
tôt et 149». Come terminus post quem della composizione delle<br />
Origines propone l’anno 174 («nach 174?») W. SUERBAUM, M.<br />
Porcius Cato (Censorius), inHandbuch der lateinischen Literatur der<br />
Antike, hrsg. von R. HERZOG und P. L. SCHMIDT,I,Die archaische<br />
Literatur von den Anfängen bis Sullas Tod, hrsg. von W.<br />
SUERBAUM, München, Beck 2002, pp. 380-418: 389.<br />
12 Vedi D. MUSTI, Introduzione, nella sua citata edizione<br />
di Polibio, Storie, I, pp. 10-12. – Sulle fasi di composizione dell’opera<br />
di Polibio: K. ZIEGLER, s.v.Polybios, inRE, XXI 2,<br />
1952, cc. 1485-1489 (e P. PÉDECH, nella sua edizione di Polybe,<br />
Histoires. Livre I, Paris, Le Belles Lettres 1969, pp. XIV-XV:<br />
«La première partie dans son ensemble [libri I-XXIX] a été rédigée<br />
entre 167 et 151 à Rome [...]. La seconde partie [...] a été<br />
rédigée enGrèce après 146»).<br />
13 Se anche la famosa descrizione della Gallia Cisalpina (II<br />
14-17) può aver trovato forma completa e definitiva nella redazione<br />
finale dell’opera di Polibio (P. PÉDECH, La méthode historique<br />
de Polybe, Paris, Les Belles Lettres 1964, p. 567), gli essenziali<br />
dati e concetti geografici che ne stanno alla base non<br />
potevano mancare nella descrizione del conflitto romano-gallico<br />
degli anni 225-222, prevista nel piano originale dell’opera.<br />
14 Vedi P. PÉDECH, Notice, nella sua edizione di Polybe,<br />
Histoires. Livre II, Paris, Les Belles Lettres 1970, pp. 19-20.<br />
15 Nel trattato di alleanza stipulato da Annibale e Filippo
L’ESTENSIONE DEL NOME ITALIA FINO ALLE ALPI E LA PROVINCIA GALLIA CISALPINA<br />
gherebbe come effetto della prima, pur parziale e provvisoria, espansione romana in Italia<br />
settentrionale seguìta alla battaglia di Clastidium (del 222). 16 È certo, in ogni caso, che la<br />
nuova e definitiva concezione geografica dell’Italia era ormai acquisita nella prima metà<br />
del II secolo, come assicurano Catone e Polibio. 17<br />
Fin qui si sono ricordate cose note, anche se in vario modo problematiche. Mi sembra,<br />
invece, che non sia stata rilevata una conseguenza di ordine politico (in senso lato) dell’ampliamento<br />
fino alle Alpi del concetto geografico di Italia. Riguarda la provincia denominata<br />
Gallia Cisalpina, la decima (in ordine cronologico) delle provincie romane, che si distingue<br />
nettamente dalle precedenti già per quanto riguarda la sua istituzione.<br />
Si riepilogano, per chiarezza, i dati essenziali sull’istituzione delle prime dieci provincie. 18<br />
La prima – Sicilia – fu istituita quattro anni dopo il trattato di pace con Cartagine del 241,<br />
cioè nel 237 (ma il primo pretore è attestato nel 227); la seconda – Sardinia (Sardegna e Corsica)<br />
– fu istituita poco dopo l’occupazione delle due isole nel 238 e 237, forse insieme con la<br />
Sicilia nel 237. Le due provincie iberiche (Hispania Citerior e Hispania Ulterior, terza e quarta<br />
della serie cronologica) furono istituite quattro anni, anch’esse, dopo il trattato di pace con<br />
Cartagine del 201, nel 197. Le provincie Macedonia e Africa (quinta e sesta) furono istituite al<br />
termine rispettivamente delle guerre macedoniche, nel 148, e delle guerre puniche, nel 146<br />
(nello stesso anno fu aggregata alla Macedonia una parte della Grecia, costituita in provincia<br />
autonoma – Achaia – da Augusto 19 ). Poi, la crisi della repubblica non mancò di riflettersi<br />
anche nello svolgimento del sistema provinciale. 20 Se l’annessione del regno di Pergamo, lasciato<br />
in eredità ai Romani da Attalo III nel 133, già nel 127 fu seguìta dall’istituzione formale<br />
di una provincia (Asia), la provincia Gallia Narbonensis fu bensì annessa a conclusione<br />
della conquista, forse nel 120, ma istituita formalmente solo alcuni decenni più tardi. 21 Diverso<br />
comportamento ebbe il governo romano anche nei confronti, rispettivamente, della<br />
Cilicia e della Cyrenaica. LaCilicia risulta già annessa come provincia alla fine del II secolo,<br />
nel 102 o 101, 22 mentre la Cyrenaica – lasciata in eredità ai Romani da Tolomeo Apione nel<br />
96 – fu annessa e redacta in formam provinciae solo nel 74. 23 L’elenco delle prime dieci provincie<br />
si conclude, dunque, con la Gallia Cisalpina, 24 istituita negli anni Ottanta del I secolo<br />
V nell’estate del 215 (Polyb. VII 9: resta fondamentale l’analisi<br />
di E. J. BICKERMAN, An oath of Hannibal, «TAPhA», LXXV,<br />
1944, pp. 87-102, e Hannibal’s covenant, «AJPh», LXXIII,<br />
1952, pp. 1-23), con «Italia» si fa riferimento alla parte peninsulare,<br />
con «Gallia (Cisalpina)» e «Liguria» alla parte settentrionale:<br />
pa* ra| po* kei| jai+ e> hmg, pqo+ |a> e$ rsim g% se uiki* asx& me$ m $ Isaki*<br />
y jai+ Jeksi* y jai+ e$ m sz& Kictrsi* mz (VII9,6:vediF.W.<br />
WALBANK, A historical commentary on Polybius, II, Oxford, Clarendon<br />
Press 1967, p. 54). Il testo riportato da Polibio sembra<br />
riprodurre la versione greca del trattato: G. DE SANCTIS, Storia<br />
dei Romani, III 2, Torino, Bocca 1917, p. 407, nota 22 (= III 2<br />
2, Firenze, La Nuova Italia 1968, p. 393, nota 22); sarebbe,<br />
dunque, una conferma ‘ufficiale’ che nel 215 il nome Italia indicava<br />
ancora solo la parte peninsulare. Ma questo poteva essere<br />
il punto di vista dei Cartaginesi e dei Greci, non necessariamente<br />
dei Romani, suggerisce W. V. HARRIS, inCAH, VIII 2 ,<br />
1989, p. 118, nota 53.<br />
16 Sulla prima espansione romana in Italia settentrionale:<br />
G. DE SANCTIS, Storia dei Romani, III 1, Torino, Bocca<br />
1916, pp. 313-320 (= III 2 1, Firenze, La Nuova Italia 1967,<br />
pp. 304-311).<br />
17 Nell’impossibilità di accertarne la fonte (Polibio?), ci si<br />
limita a ricordare i due passi liviani (XXXIX 22, 6-7 e 54, 10-<br />
12) nei quali, con riferimento a vicende degli anni rispettivamente<br />
186 e 183, la regione abitata dai Veneti è definita Italia<br />
in termini ufficiali, cioè giuridico-politici oltre che geografici.<br />
18 Con la fondamentale trattazione di J. MARQUARDT,<br />
* 117 *<br />
Römische Staatsverwaltung, I 2 , Leipzig, Hirzel 1881, pp. 241-<br />
496 (in particolare, il prospetto a p. 493: Provinzen der Republik),<br />
vedi spec. G. I. LUZZATTO, Roma e le province (Istituto<br />
Nazionale di Studi Romani, Storia di Roma, XVII 1), Bologna,<br />
Cappelli 1985, pp. 46-93 e 103-134; M. H. CRAWFORD, Origini<br />
e sviluppi del sistema provinciale romano, inStoria di Roma, diretta<br />
da A. SCHIAVONE, II 1, Torino, Einaudi 1990, pp. 91-121<br />
(= Storia di Roma, a cura di A. GIARDINA eA.SCHIAVONE,Torino,<br />
Einaudi 1999, pp. 177-202); J.-L. FERRARY, Provinces,<br />
magistratures et lois: la création des provinces sous la République, in<br />
Die Römischen Provinzen. Begriff und Gründung, hrsg. von J. PI-<br />
SO, Cluj-Napoca, Editura Mega 2008, pp. 7-18.<br />
19 Nel 27, quando divenne provincia autonoma anche<br />
l’Illyricum, oggetto di parziali annessioni fin dalla III Guerra macedonica<br />
(assegnate alle provincie finitime: Macedonia e, poi,<br />
Gallia Cisalpina).<br />
20 LUZZATTO, Le province romane cit., pp. 92-103.<br />
21 Ivi, p. 127: «Se possiamo dire che la fondazione della colonia<br />
di Narbo Martius [nel 118] suggellò la fondazione della provincia,<br />
non abbiamo tuttavia alcuna traccia di un atto formale di<br />
redactio, e per molti decenni organizzazione e strutture della provincia<br />
presentarono considerevoli oscillazioni e incertezze».<br />
22 CRAWFORD, Origini e sviluppi del sistema provinciale romano<br />
cit., pp. 106-107 (= pp. 192-193); FERRARY, Provinces,<br />
magistratures et lois cit., pp. 13-14.<br />
23 LUZZATTO, Roma e le province cit., pp. 146-149.<br />
24 Sono, appunto, queste – dalla Sicilia alla Gallia Cisal-
a.C., quando era trascorso almeno mezzo secolo dal compimento della conquista. 25 Perché<br />
tanto ritardo?<br />
Sottolineo l’entità del ritardo, perché «spesso passava un considerevole periodo di tempo<br />
prima che il senato procedesse all’annessione di un determinato territorio, e talora tra l’annessione<br />
e la redactio in formam provinciae, e tra quest’ultima e l’emanazione in forma definitiva<br />
della lex provinciae». 26 Nella rassegna cronologica dell’istituzione delle prime dieci provincie<br />
si è rilevato come già la sistemazione giuridica delle prime due provincie – Sicilia e Sardinia –<br />
fosse definitiva forse solo nel 227 (la questione è controversa; 27 ma si trattava, appunto, delle<br />
prime due provincie, che non avevano un exemplum a cui rifarsi: la circospezione del governo<br />
romano nella creazione di un exemplum di tale portata sarebbe facilmente comprensibile).<br />
E, scendendo dall’età più antica dell’istituto provinciale a quella in cui fu fatta provincia la<br />
Gallia Cisalpina, sono particolarmente vistosi i casi della Gallia Narbonensis e della Cyrenaica.<br />
Quello della Cyrenaica è, peraltro, di natura particolare: nel 74, trascorsi ventidue anni dall’acquisizione<br />
per eredità,lasuaredactio in formam provinciae sembra infatti coincidere, si è detto,<br />
con l’effettiva incorporazione; e il ritardo ha trovato plausibile spiegazione nella politica<br />
senatoria del I secolo. 28 È problematico, invece, il caso della Gallia Narbonensis: il solo precedente<br />
che potrebbe illuminare il caso della Gallia Cisalpina, per l’intrinseca connessione fra<br />
idueproblemi. 29<br />
Ora, per quanto riguarda l’istituzione della Gallia Cisalpina, fra le due prevalenti teorie<br />
che l’attribuiscono a Pompeo Strabone (nell’89) o a Silla (nell’81), «la seconda ipotesi pare<br />
la più verosimile». 30 Era trascorso almeno mezzo secolo dalla conquista del territorio (si è<br />
detto). Perché, dunque,tanto ritardo? Propongo una risposta: il sistema provinciale era stato<br />
escogitato per i territori extraitalici (a cominciare, appunto, dalla Sicilia) 31 in luogo del sistema<br />
federale, che aveva caratterizzato l’organizzazione costituzionale dell’Italia romana; 32 in<br />
pina – le dieci provincie, in funzione del cui governo Silla<br />
avrebbe aumentato il numero dei pretori da sei a otto (e dunque,<br />
con i due consoli, da otto a dieci il numero dei promagistrati):<br />
così già TH. MOMMSEN, Römische Geschichte, II,Berlin,<br />
Weidmann 1855, p. 338. – Sul rapporto fra l’aumento del<br />
numero dei pretori, da due (quanti erano prima del 227) a otto<br />
(con la riforma sillana), e la creazione di nuove provincie:<br />
FERRARY, Provinces, magistratures et lois cit., pp. 8-10.<br />
25 Vedi E. GABBA, La conquista della Gallia Cisalpina, in<br />
Storia di Roma, diretta da A. SCHIAVONE, II 1 cit., pp. 69-77:<br />
73: «verso il 150 praticamente tutta la Gallia Cisalpina a sud<br />
del Po era variamente sotto il dominio romano ed oramai oggetto<br />
di un intenso processo di romanizzazione». E già nel 148<br />
l’inizio della costruzione della via Postumia, da Genova ad<br />
Aquileia (attraverso Piacenza e Cremona), preludeva alla definitiva<br />
sottomissione militare e conseguente romanizzazione<br />
dei territori traspadani. – Sulla conquista dell’Italia settentrionale<br />
nel II secolo, con la fondamentale trattazione di G. DE<br />
SANCTIS, Storia dei Romani, IV 1, Torino, Bocca 1923, pp. 410-<br />
428 (= IV 2 1, Firenze, La Nuova Italia 1969, pp. 398-415), vedi<br />
W. V. HARRIS, The subjugation of Cisalpine Gaul, inCAH,<br />
VIII 2 , 1989, pp. 107-118.<br />
26 LUZZATTO, Roma e le province cit., p. 40; e vedi pp. 25-<br />
26, per la distinzione semantica del termine provincia: «originariamente<br />
la sfera di competenza esclusiva di un magistrato, sia<br />
in Italia che fuori», poi – a partire dal II secolo – «un territorio<br />
extraitalico [...] annesso per conquista o pacificamente, e soggetto<br />
alla competenza esclusiva di un magistrato proconsolare<br />
o propretorio».<br />
27 Per quanto in particolare riguarda la Sicilia, la bibliografia<br />
è imponente: i contributi più recenti sono elencati da RUS-<br />
SO, Il concetto di Italia nelle relazioni di Roma con Cartagine e Pirro<br />
cit., p. 86, nota 30.<br />
LEANDRO POLVERINI<br />
* 118 *<br />
28 E. BADIAN, Roman imperialism in the late Republic 2 ,Oxford,<br />
Blackwell 1968, pp. 29-30.<br />
29 Vedi spec. FERRARY, Provinces, magistratures et lois cit.,<br />
p. 11: la Gallia Narbonensis «ne devint pas une province prétorienne<br />
régulière en dépit des campagnes consulaires menées à la<br />
demande de Marseilles en 154 puis surtout de 125 à 120, en<br />
dépit de la fondation de la colonie de Narbo Martius en 118,<br />
en dépit de la menace des Cimbres et des Teutons qui provoqua<br />
de nouveau l’envoi des consuls au-delà des Alpes de 109 à<br />
102. Mais il ne s’agit pas seulement ici, ni même surtout, de répugnance<br />
du Sénat à créer de nouvelles provinces [come nel<br />
caso della Cyrenaica, sièvisto]. Si une province prétorienne de Narbonnaise<br />
tarda à êtremiseenplace,c’estquelecontrôle de la Gaule<br />
restait avant tout de la compétence des magistrats de rang consulaire<br />
chargés de la protection du nord de l’Italie» (il corsivo è mio).<br />
30 Così U. LAFFI, La provincia della Gallia Cisalpina, «Athenaeum»,<br />
LXXX, 1992, pp. 5-23: 13 (= ID., Studidistoriaromana<br />
e di diritto, [Storia e Letteratura. Raccolta di studi e testi,<br />
206], Roma, Edizioni di Storia e Letteratura 2001, pp. 209-<br />
235: 220).<br />
31 F. DE MARTINO, Storia della costituzione romana, II 2 ,<br />
Napoli, Jovene 1973, p. 325: «Soltanto in seguito all’espansione<br />
romana fuori d’Italia, la provincia, da temporanea attribuzione<br />
di una sfera territoriale per l’esercizio dell’imperium da<br />
parte dei magistrati divenne in modo permanente un distretto<br />
fuori d’Italia, sottoposto al potere del magistrato romano».<br />
32 Ivi, pp. 108-112. E si ricorda – nell’intenso percorso<br />
storiografico aperto da J. BELOCH, Der italische Bund unter Roms<br />
Hegemonie. Staatsrechtliche und statistische Forschungen, Leipzig,<br />
Teubner 1880 – la vigorosa sintesi di P. FRACCARO, L’organizzazione<br />
politica dell’Italia romana, inAtti del Congresso internazionale<br />
di Diritto romano (Bologna e Roma, 17-27 aprile 1933), I<br />
(Roma), Pavia, Fusi 1934, pp. 195-208.
L’ESTENSIONE DEL NOME ITALIA FINO ALLE ALPI E LA PROVINCIA GALLIA CISALPINA<br />
quanto escogitato per i popoli extraitalici, non poteva essere applicato a territori geograficamente<br />
e concettualmente italiani, come (almeno dall’inizio del II secolo) erano considerati<br />
tutti quelli a sud delle Alpi. Che se poi si addivenne lo stesso, dopo la guerra sociale (nell’89<br />
o nell’81, non importa), all’istituzione della provincia, ciò si dovette senza dubbio alle difficoltà<br />
pratiche di governo di regioni in gran parte sprovviste (a nord del Po) o solo parzialmente<br />
provviste (a sud del Po) di adeguate strutture cittadine, indispensabili al governo dell’Italia<br />
romana. In effetti, alla cosiddetta lex Pompeia Strabonis de Transpadanis, che nell’89<br />
concedeva la cittadinanza romana agli abitanti a sud del Po e i diritti latini agli abitanti fra<br />
il Po e le Alpi (ma si può ben credere che il discrimine non fosse costituito dal confine geografico<br />
del Po, bensì dal precedente status giuridico delle comunità cisalpine 33 ), fece séguito<br />
un grandioso programma di urbanizzazione e sistemazione del territorio, sostanzialmente attuato<br />
nel corso di quattro decenni, fra l’89 e il 49, 34 quando (in forza, appunto, dei risultati di<br />
quel programma di urbanizzazione) una lex Iulia concesse la cittadinanza romana a quanti<br />
non l’avevano ottenuta dal provvedimento di Pompeo Strabone. 35<br />
Con la conclusione del programma di urbanizzazione, e con la conseguente estensione<br />
della cittadinanza romana fino alle Alpi, venivano meno le esigenze pratiche che avevano<br />
imposto l’istituzione di una provincia in territorio italico. In effetti, la provincia Gallia Cisalpina<br />
fu abolita nel 42. 36 La straordinaria brevità della sua durata (meno di quarant’anni, se la<br />
provincia fu istituita – come è probabile – nell’81) conferma che la sua istituzione, decenni<br />
dopo la conquista del territorio, era stata imposta da problemi contingenti di governo. In<br />
quanto tali (cioè, contingenti), essi avevano lasciato intatto il principio costituzionale non<br />
scritto che il sistema provinciale riguardava i territori extraitalici, al di là del mare e al di<br />
là delle Alpi, che almeno dalla prima metà del II secolo costituivano il confine settentrionale<br />
dell’Italia, in termini geografici e concettuali. Questo principio sarebbe rimasto intatto per<br />
oltre tre secoli, fino alla provincializzazione dell’Italia attuata da Diocleziano.<br />
Il ricordo della provincializzazione dioclezianea dell’Italia, alla fine del III secolo, suggerisce<br />
un breve epilogo alle precedenti considerazioni. Con l’abolizione della provincia Gallia<br />
Cisalpina, l’unificazione d’Italia era compiuta – oltre che in termini geografici e territoriali –<br />
in termini giuridici, amministrativi e almeno formalmente politici. 37 Ci si chiede se all’indubbia<br />
unificazione giuridica e amministrativa (e almeno formalmente politica) dell’Italia<br />
augustea corrispondesse anche una sostanziale unificazione delle due parti d’Italia, l’Italia peninsulare<br />
e l’ex Gallia Cisalpina.<br />
La provincializzazione dioclezianea dell’Italia dà vistosa conferma ad una serie di indizi<br />
che, nel corso della storia altoimperiale, mostrano come l’unificazione delle due parti d’Italia<br />
fosse piuttosto giuridica e amministrativa che sostanziale, diciamo pure strutturale. 38 Come è<br />
33 Come riconobbe (con cautela forse eccessiva) G. E. F.<br />
CHILVER, Cisalpine Gaul. Social and economic history from 49 B.C.<br />
to the death of Trajan, Oxford, Clarendon Press 1949, p. 7:<br />
«Probably then Pompeius dealt with all Cisalpine towns, granting<br />
civitas to the old Latin colonies and Latin rights to the native<br />
oppida». Sulla «questione relativa all’ambito geografico di applicazione<br />
della legge ed alla individuazione dei destinatari»: G.<br />
LURASCHI, Foedus, ius Latii, civitas. Aspetti costituzionali della romanizzazione<br />
in Transpadana (Pubblicazioni della Università di<br />
Pavia. Studi nelle Scienze giuridiche e sociali, N. S. 29), Padova,<br />
Cedam 1979, pp. 147-156.<br />
34 Dopo i fondamentali studi di Plinio Fraccaro, si ricordano<br />
specialmente alcuni dei contributi raccolti nei volumi di<br />
E. GABBA, Italia romana (Biblioteca di Athenaeum, 25), Como,<br />
New Press 1994; G. TIBILETTI, Storie locali dell’Italia romana, Pavia,<br />
Istituto di Storia antica 1978; P. TOZZI, Storia padana antica,<br />
Milano, Ceschina 1972.<br />
* 119 *<br />
35 Cass. D. XLI 36, 3. Vedi LURASCHI, Foedus, ius Latii,<br />
civitas cit., pp. 394-399.<br />
36 App. Bell. civ., V 12, con il commento di E. GABBA, ad<br />
l., nella sua edizione: Appiani Bellorum civilium liber quintus (Biblioteca<br />
di Studi superiori. Storia antica ed epigrafia, 49), Firenze,<br />
La Nuova Italia 1970, p. 10. Vedi LAFFI, La provincia della<br />
Gallia Cisalpina cit., p. 16 (= pp. 224-225).<br />
37 A differenza dell’unificazione giuridica ed amministrativa,<br />
l’unificazione politica risultava sostanzialmente teorica,<br />
perché «la costituzione continuava ad essere quella di una piccola<br />
città-stato, dal governo della quale di fatto continuava a<br />
restar fuori la maggioranza della popolazione italica» (F. DE<br />
MARTINO, Storia della costituzione romana, III 2 , Napoli, Jovene<br />
1973, p. 341; e vedi ivi, pp. 56-59).<br />
38 A. GIARDINA, L’identità incompiuta dell’Italia romana, in<br />
L’Italie d’Auguste à Dioclétien. Actes du colloque international organisé<br />
par l’École française de Rome etc. (25-28 mars 1992) (Collec-
noto, le provincie dioclezianee, molto ridotte in estensione rispetto alle provincie tradizionali,<br />
furono raccolte in diocesi. Le provincie italiane (create sulla base delle regioni augustee<br />
o dell’accorpamento di alcune di esse) furono raccolte in una dioecesis Italiciana, formalmente<br />
unica, ma sostanzialmente divisa in due parti, affidate ciascuna ad un vicario: l’Italia suburbicaria<br />
el’Italia annonaria. 39 La prima, che corrisponde – pur in presenza di modificazioni varie<br />
nel tempo – all’Italia peninsulare, dipendeva dal vicarius Urbis, residente a Roma; la seconda,<br />
che corrisponde dunque all’Italia settentrionale (con la Rezia), dipendeva dal vicarius Italiae,<br />
residente a Milano. 40<br />
Come dopo l’abolizione della provincia Gallia Cisalpina, nel 42 a.C., anche dopo la provincializzazione<br />
dell’Italia, alla fine del III secolo d.C., l’unità formale dell’Italia coesiste<br />
dunque con la sua sostanziale (ora anche istituzionalizzata) divisione in due parti: le stesse.<br />
E potrebbe forse sorprendere tale continuità, atresecoliemezzodidistanza,seessanon<br />
trovasse spiegazione nelle fondamentali categorie della longue durée: geografia,antropologia,<br />
economia (il famoso capitolo di Polibio sull’economia del territorio abitato dai Galli Cisalpini<br />
41 trova singolari corrispondenze nelle fonti sull’economia dell’Italia annonaria 42 ). E si<br />
tratta davvero di longue durée, se tale continuità si lascia in qualche misura riconoscere, è<br />
in vario modo attiva ancora oggi, nonostante che alle «due Italie» di origine romana (e preromana)<br />
43 si siano poi vistosamente sovrapposte le «due Italie», centrosettentrionale e meridionale,<br />
emerse nel corso dei successivi tredici secoli: dalla fine dell’unità dell’Italia romana<br />
(con l’invasione dei Longobardi, nel 568) alla proclamazione del Regno d’Italia (nel<br />
1861). 44<br />
tion de l’École française de Rome, 198), Rome, École française<br />
de Rome 1994, pp. 1-89 (= ID., L’Italia romana. Storia di un’identità<br />
incompiuta, Roma – Bari, Laterza 1997, pp. 3-116).<br />
39 R. THOMSEN, The Italic regions from Augustus to the Lombard<br />
invasion (Classica et mediaevalia. Dissertationes, IV), København,<br />
Gyldendalske Boghandel 1947, pp. 196-260. Per<br />
una sintesi degli essenziali dati storici rinvio ad un saggio in<br />
questa rivista: L. POLVERINI, Le regioni nell’Italia romana, «GeogrAnt»,<br />
VII, 1998, pp. 23-33: 31.<br />
40 «Fa meraviglia che la denominazione Italia, dopo aver<br />
acquistato il significato ben delimitato della penisola italiana fino<br />
al confine naturale delle Alpi ed essersi attestata con questa<br />
accezione, poi si sia potuta ridurre al senso ristretto dell’Italia<br />
del nord»: così WISTRAND, Per la storia del nome d’Italia cit.,<br />
p. 470, recuperava un’osservazione già di Godefroy (ivi,<br />
pp. 477-478). Vedi poi L. CRACCO RUGGINI –G.CRACCO,<br />
L’eredità di Roma, inStoria d’Italia, coordinata da R. ROMANO<br />
eC.VIVANTI, V 1, Torino, Einaudi 1987, pp. 3-45: 37-38.<br />
41 Polyb. II 15.<br />
42 Vedi L. RUGGINI, Economia e società nell’«Italia Annonaria».<br />
Rapporti fra agricoltura e commercio dal IV al VI secolo d.C.<br />
(Fondazione Guglielmo Castelli, 30), Milano, Giuffrè 1961,<br />
pp. 20-22: «Una notevole attività commerciale nell’Italia Annonaria<br />
esistette di fatto [...] secondo la linea di una tradizione<br />
economica locale che [...] perdurò ininterrotta fino alle soglie<br />
dell’età longobarda. E le sue basi [...] furono essenzialmente<br />
agricole. In tutta l’antichità infatti, e specialmente a quest’epoca,<br />
l’agricoltura continuò a rappresentare il fondamento di ogni<br />
più importante manifestazione della vita economica; ciò vale<br />
poi in maniera del tutto particolare per l’Italia Settentrionale,<br />
che ancor oggi si distingue – quanto ai tempi di Polibio, di<br />
Strabone e di Plinio – per la fertilità del suolo, l’estensione<br />
dei terreni coltivabili e la alta percentuale delle aree a grano,<br />
vigneto, oliveto, frutteto e ortaggi rispetto alle terre di minor<br />
valore, a selve e pasture». La «ristampa anastatica» del fondamentale<br />
volume di Lellia Cracco Ruggini – Bari, Edipuglia<br />
LEANDRO POLVERINI<br />
* 120 *<br />
1995 (Munera. Studi storici sulla Tarda Antichità diretti da<br />
D. VERA, 2) – presenta vari complementi; è di notevole interesse<br />
storico e storiografico l’Introduzione alla ristampa, pp. IX-<br />
XIV. 43 A. GIARDINA, Le due Italie nella forma tarda dell’impero,in<br />
Società romana e impero tardoantico, I,Istituzioni, ceti, economie, a<br />
cura di ID., Roma – Bari, Laterza 1986, pp. 1-36 (= ID., L’Italia<br />
romana cit., pp. 265-381).<br />
44 Sul passaggio dalle «due Italie» di età romana (pur variamente<br />
connotate) al progressivo frazionamento di età medievale:<br />
CRACCO RUGGINI – CRACCO, L’eredità di Roma<br />
cit., pp. 27-45. Vedi poi, sull’origine del dualismo innanzitutto<br />
economico negli anni intorno al 1200, D. ABULAFIA, The<br />
two Italies. Economic relations between the Norman kingdom of Sicily<br />
and the northern communes (Cambridge studies in medieval<br />
life and thought. Third series, 9), Cambridge, Cambridge<br />
University Press 1977; edizione italiana: Le due Italie. Relazioni<br />
economiche fra il regno normanno di Sicilia e i comuni settentrionali<br />
(L’altra Europa, 5), Napoli, Guida 1991, con una Nota introduttiva<br />
di G. GALASSO (pp. 1-4). Quanto alla sopravvivenza<br />
delle «due Italie» di eredità medievale e moderna, si ricorda<br />
l’intenso dibattito – più politico che storiografico, del resto –<br />
sollecitato da R. D. PUTNAM, Making democracy work. Civic traditions<br />
in modern Italy, Princeton, Princeton University Press<br />
1993; edizione italiana: La tradizione civica nelle regioni italiane,<br />
Milano, Mondadori 1993. Nella Prefazione all’edizione italiana<br />
(pp. VII-XII) si legge non senza sorpresa: «A molti lettori italiani,<br />
alcune delle nostre ‘‘scoperte’’ risulteranno ovvie – per<br />
esempio, che il Sud è governato meno bene che il Nord –<br />
mentre altre sono così lontane dall’ovvietà che potranno suscitare<br />
controversie – per esempio, che l’attuale scarso rendimento<br />
dei governi regionali del Meridione può essere fatto risalire<br />
ad avvenimenti di quasi mille anni fa». Per il lettore italiano<br />
non privo di formazione storica la seconda «scoperta» è altrettanto<br />
ovvia.
L’ESTENSIONE DEL NOME ITALIA FINO ALLE ALPI E LA PROVINCIA GALLIA CISALPINA<br />
Sono argomenti troppo importanti (in prospettiva politica non meno che storica) per essere<br />
relegati nell’epilogo di un contributo, il cui problema specifico ha già trovato conclusione.<br />
Ma l’epilogo offre opportuna occasione di ricordare – nel quadro e in funzione del<br />
vivace dibattito che nella stampa italiana preannuncia il 150º anniversario dell’Unità –quanto<br />
siano antiche le radici di essenziali aspetti e problemi dell’Italia attuale. 45<br />
45 Il dibattito a cui facevo riferimento il 7 ottobre 2009,<br />
presentando questo contributo al convegno di Villa Vigoni, è<br />
andato poi crescendo di intensità e di spessore (come era facile<br />
prevedere), ma ha continuato a privilegiare la prospettiva poli-<br />
* 121 *<br />
tica e – per quanto riguarda la prospettiva storica – i 150 anni<br />
della seconda esperienza unitaria nella storia d’Italia (dopo quella<br />
di età romana, dal II secolo a.C. al VI d.C., e la successiva ‘frattura’<br />
di ben tredici secoli).