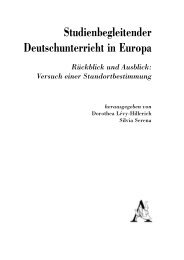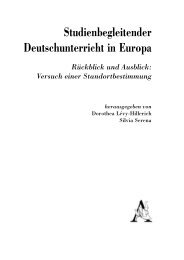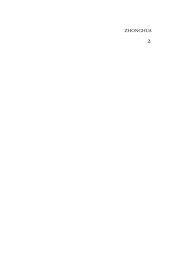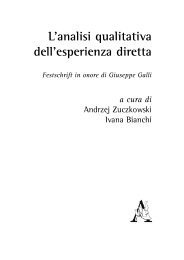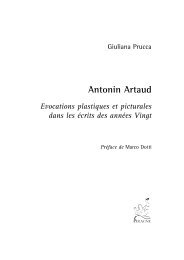i classici italiani - Aracne editrice
i classici italiani - Aracne editrice
i classici italiani - Aracne editrice
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
i <strong>classici</strong> <strong>italiani</strong><br />
Collana diretta da Antonio Lanza<br />
1
sezione prima<br />
dal dugento al cinquecento<br />
Comitato editoriale<br />
Corrado Bologna (Roma) Marcello Ciccuto (Pisa),<br />
Riccardo Bruscagli (Firenze), Domenico Cofano (Foggia),<br />
Enrico Fenzi (Genova), Francesco Furlan (Parigi),<br />
Guglielmo Gorni (Roma), Luciano Rossi (Zurigo),<br />
Pasquale Sabbatino (Napoli), Luigi Surdich (Genova),<br />
Diego Zancani (Oxford)
DOMENICO DI GIOVANNI<br />
detto IL BURCHIELLO<br />
LE POESIE<br />
AUTENTICHE<br />
a cura di<br />
Antonio Lanza<br />
ARACNE
Copyright © 2010<br />
ARACNE <strong>editrice</strong> S.r.l.<br />
www.aracne<strong>editrice</strong>.it<br />
info@aracne<strong>editrice</strong>.it<br />
via Raffaele Garofalo, 133/A-B<br />
00173 Roma<br />
(06) 93781065<br />
isbn 978-88-548-3243-5<br />
I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,<br />
di riproduzione e di adattamento anche parziale,<br />
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.<br />
Non sono assolutamente consentite le fotocopie<br />
senza il permesso scritto dell’Editore.<br />
i edizione: maggio 2010
A Guglielmo Gorni,<br />
mio grandissimo amico,
INDICE<br />
Introduzione ......................................................... xi<br />
Nota biografica ..................................................... xxvii<br />
Nota bibliografica ................................................. xxxv<br />
Nota al testo .............................................................. xliii<br />
Opere citate in forma abbreviata .......................... xcix<br />
Le poesie autentiche ..................................................... 1<br />
Indice delle voci annotate ..................................... 595<br />
Indice dei nomi propri .............................................. 659<br />
Incipitario .................................................................. 671
INtRODuZIONE<br />
L’edizione del Burchiello era una promessa alla quale<br />
non potevo mancare. Si trattava, infatti, di un appuntamento<br />
troppo cogente per uno studioso come me,<br />
che era partito sin dagli esordi della sua carriera dall’indagine<br />
appassionata della poesia comico-realistica, giocosa,<br />
burlesca e satirica dal Dugento al Quattrocento,<br />
come di mostrano il mio primo saggio Polemiche e<br />
berte letterarie nella Firenze del primo Quattrocento.<br />
Storia e testi (Roma, Bulzoni, 1971), 1 la mia<br />
edi zione commentata dei sonetti di Cecco Angiolieri, 2<br />
quelle dei poemetti di Stefano di Tommaso Finiguerri<br />
detto il Za, 3 il quale del Burchiello è, con Andrea Orcagna,<br />
il principale punto di riferimento, dell’Acquatti-<br />
1 Ripubblicato poi in seconda edizione completamente rifatta<br />
nel 1989 col titolo Polemiche e berte letterarie nella Firenze del primo<br />
Rinascimento (1375-1449). Ed ormai urge una terza edizione,<br />
che ho in preparazione.<br />
2 C. Angiolieri, Le Rime, a c. di A. Lanza, Roma, Archivio<br />
Guido Izzi, 1989.<br />
3 S. Finiguerri detto il Za, I Poemetti, a c. di A. Lanza,<br />
Roma, Zauli, 1994.
xii antonio lanza<br />
no di ser Domenico da Prato, 1 delle anonime Bellezze<br />
di Camaldoli, 2 dello stesso Libro de’ ghiribizzi<br />
di Giovanni di Zanobi di Manno Betti, 3 nonché di una<br />
lunga serie di poeti pre- e postburchielleschi compresi<br />
nella mia ampia silloge di poeti quattrocenteschi. 4<br />
Il Burchiello rappresenta il vertice della creatività<br />
poetica nel periodo della nostra letteratura che mi ha<br />
sempre maggiormente interessato, quello compreso tra<br />
la morte del Boccaccio (1375) e il Certame coronario<br />
(1441), con un’estensione doverosa sino alla morte del<br />
Burchiello (1449): un periodo segnato, in politica estera,<br />
dalla lunga e rovinosa guerra tra Firenze e Milano,<br />
conclusasi il 29 giugno del 1440 con il trionfo dell’esercito<br />
fiorentino ad Anghiari; in politica interna, dal<br />
tumulto dei Ciompi (1378) e dalla successiva restaurazione<br />
oligarchica sino alla presa del potere da parte dei<br />
Medici (1434), che trasformarono il libero Comune fiorentino<br />
in una signoria sempre meno mascherata; in<br />
campo culturale, dallo scontro tra la cultura tradizio-<br />
1 L’Acquattino di ser Domenico da Prato, in A. Lanza, Freschi e<br />
minii del Due, Tre e Quattrocento, Firenze, Cadmo, 2002, pp. 203-37.<br />
2 Un poemetto osceno di metà Quattrocento: Le bellezze di<br />
Camaldoli, in A. Lanza, Freschi e minii, cit., pp. 315-28. Ivi, pp.<br />
253-313 vd. anche il mio studio Aspetti e figure della poesia comico-realistica<br />
toscana del secolo xv [già in «La Rassegna della letteratura<br />
italiana», lxxxix, 1985, pp. 403-43].<br />
3 In «Letteratura italiana antica», ii, 2001, pp. 127-326.<br />
4 Lirici toscani del Quattrocento, a c. di A. Lanza, Roma, Bulzoni,<br />
1973-1975, 2 voll.
introduzione xiii<br />
nalista – fondata sull’aristotelismo scolastico e sulla<br />
dialettica nominalistica, nonché sul culto delle “tre corone”<br />
e del volgare – e la cultura umanistica, che suscitò<br />
polemiche asperrime, alle quali intervennero con invettive<br />
e libelli i massimi esponenti dell’ambiente culturale<br />
fiorentino del tempo; nel settore artistico, dall’avvento<br />
della scintillante arte tardogotica, che rispondeva appieno<br />
alle aspirazioni aristocratiche della ricca borghesia<br />
capitalistica fiorentina, la quale amava vivere nel<br />
lusso e nello sfarzo e promoveva, di conseguenza, uno<br />
stile fastoso e dorato, totalmente disimpegnato, che influenzò<br />
non poco anche la coeva produzione letteraria<br />
e alla quale fece presto da contraltare la nuova maniera<br />
rinascimentale, misurata, armoniosa e realistica; e, infine,<br />
sul versante musicale, dall’affermazione dello stile<br />
polifonico imposto dagli esponenti dell’Ars nova, primo<br />
fra tutti quel Francesco Landini, il massimo musicista<br />
del tempo, che fu tra i protagonisti delle riunioni<br />
al Paradiso degli Alberti – la splendida villa di Antonio<br />
degli Alberti posta sul piano di Ripoli, che rappresenta<br />
l’esempio più perfetto dalla magione tardogotica – immortalate<br />
da ser Giovanni Gherardi nel suo romanzo,<br />
capolavoro della letteratura tradizionalista e tardogotica,<br />
e che glorificò Guglielmo Occam in un poemetto visionistico<br />
che si risolve in una durissima stroncatura<br />
di Niccolò Niccoli, il più radicale detrattore del dialettico<br />
inglese e delle “tre corone”, malato di un inguaribile<br />
egotismo e di uno snobismo tanto estremo quanto<br />
stolido.
xiv antonio lanza<br />
Si tratta, dunque, di un periodo essenziale per la<br />
comprensione della storia politica, culturale ed artistica<br />
del tardo Medioevo e del primo Rinascimento. Ad esso,<br />
come è noto, dedicai il citato Polemiche e berte;<br />
e poi altri due volumi editi dalla De Rubeis di Anzio:<br />
Firenze contro Milano. Gli intellettuali fiorentini<br />
nelle guerre con i Visconti (1390-1440) e La letteratura<br />
tardogotica. Arte e poesia a Firenze e Siena<br />
nell’autunno del Medioevo, apparsi, rispettivamente,<br />
nel 1990 e nel 1994.<br />
Come s’è detto, di quel periodo il Burchiello rappresenta<br />
di gran lunga la voce più creativa ed originale, il<br />
solo degno corrispettivo di Masaccio in campo poetico,<br />
per nulla inferiore al celebrato François villon.<br />
Dopo secoli di attesa e dopo la promessa edizione<br />
critica di Michele Messina – che si limitò a pubblicare<br />
alcuni sonetti inediti, 1 uno solo dei quali è di paternità<br />
burchiellesca, e ad alcune utili ricerche nei fondi<br />
manoscritti –, 2 finalmente nel 2000 è apparso, nella<br />
prestigiosa collana della Commissione per i testi di lingua<br />
di Bologna, il testo critico della vulgata per le cure<br />
di Michelangelo Zaccarello, cui nel 2004 ha fatto ségui-<br />
1 Domenico di Giovanni detto il Burchiello, Sonetti inediti,<br />
a c. di M. Messina, Firenze, Olschki, 1952.<br />
2 M. Messina, In margine all’edizione critica dei sonetti del Burchiello.<br />
Di due manoscritti sino a oggi ignorati, in «La Bibliofilia», liv,<br />
1952, pp. 35-46; Id., Per l’edizione delle Rime del Burchiello. i. Censimento<br />
dei manoscritti e delle stampe, in «Filologia e critica», iii, 1978,<br />
pp. 196-296.
introduzione xv<br />
to un’edizione commentata edita a Torino da Einaudi,<br />
sempre a cura di Zaccarello. E tuttavia, pur nell’indubbio<br />
progresso testuale rispetto alla gloriosa, ma<br />
in parte infida – specie sul piano delle attribuzioni –<br />
edizione pseudolondinese del 1757 curata da Anton<br />
Maria Biscioni, 3 Zaccarello – il cui scopo era quello di<br />
presentare non il testo critico delle poesie del Burchiello,<br />
ma quello della vulgata quattrocentesca – ha la sciato<br />
irrisolti proprio quei problemi attributivi, comprendendo<br />
troppi sonetti di sicura paternità di altri autori ed<br />
escludendone altri che invece risalgono certamente alla<br />
penna del poeta-barbiere. Inoltre, nonostante la sua<br />
profonda conoscenza della tradizione manoscritta, il<br />
fatto che si sia fondato essenzialmente sulla stampa<br />
fiorentina del 1481 di Francesco di Dino cartolaio è<br />
operazione che fa desiderare un approccio diverso, in<br />
quanto i testimoni manoscritti più antichi consentono<br />
di restituire con assai maggiore aderenza la veste originaria<br />
delle poesie del Burchiello.<br />
Del 2005 è l’ampio volume del Crimi, 4 che, ri percor<br />
rendo, con enorme ricchezza di dati, la sto ria del<br />
3 Sonetti del Burchiello, del Bellincioni e d’altri poeti fiorentini alla<br />
burchiellesca, Londra [ma Lucca-Pisa], s.e., 1757.<br />
4 G. Crimi, L’oscura lingua e il parlar sottile: tradizione e fortuna<br />
del Burchiello, Manziana, Vecchiarelli, 2005. Dello stesso vd. anche<br />
Noterelle burchiellesche, in «La Cultura», xl, 2002, 1, pp. 109-19;<br />
«L’augurio se lo portò il vento». L’edizione del Burchiello preparata<br />
da vittorio Rossi, in «Letteratura italiana antica», vii, 2006, *Studi<br />
in memoria di Mirella Moxedano Lanza, i, pp. 355-403; e Burchiel-
xvi antonio lanza<br />
genere burchiellesco, offre una serie di notazioni e di interpretazioni<br />
spesso illuminanti della poesia del Burchiello,<br />
tenendo sempre ben presenti i risultati della più<br />
accreditata lette ratura critica, che ha avuto in Curzio<br />
Mazzi, 5 in vittorio Rossi – che pure aveva annunciato<br />
un’edizione, anch’essa mai uscita, la cui vicenda è stata<br />
puntualmente ricostruita dal Crimi –, 6 in Domenico<br />
Guerri, 7 in Curt Sigmar Gutkind, 8 in Leo Spitzer, 9 in<br />
Domenico De Robertis, 10 in Mario Martelli, 11 in Emilio<br />
lerie. In margine ad un’edizione commentata dei sonetti del Burchiello,<br />
ivi, viii, 2007, *Studi in memoria di Mirella Moxedano Lanza, ii,<br />
pp. 363-80.<br />
5 C. Mazzi, Il Burchiello. Saggio di studi sulla sua vita e sulla sua<br />
poesia, Bologna, Fava e Garagnani, 1877.<br />
6 V. Rossi, Un sonetto e la famiglia del Burchiello [1900], in Scritti di<br />
critica letteraria, Firenze, Sansoni, 1930, ii, pp. 359-69. E cfr. la n. 11.<br />
7 D. Guerri, La corrente popolare nel Rinascimento. Berte, burle<br />
e baie nella Firenze del Brunellesco e del Burchiello, Firenze, Sansoni,<br />
1931.<br />
8 C.S. Gutkind, Burchiellana. Studien zur volkstumlichen Kehrseite<br />
der italienische Renaissance, in «Archivum Romanicum», xv,<br />
1931, pp. 1-34.<br />
9 L. Spitzer, Zur Nachwirkung von Burchiellos Priameldichtung,<br />
in «Zeitschrift für romanische Philologie», lii, 1932, pp. 484-89.<br />
10 D. De Robertis, Una proposta per Burchiello, in Carte d’identità,<br />
Milano, Feltrinelli, 1974, pp. 105-35 [1968]; Id., L’esperienza poetica<br />
del Quattrocento, in *Storia della letteratura italiana, a c. di E.<br />
Cecchi e N. Sapegno, ivi, Garzanti, 1966, iii, pp. 427-36.<br />
11 M. Martelli, Firenze, in *Letteratura italiana. Storia e geografia,<br />
II, i, torino, Einaudi, 1988, pp. 21-37.
introduzione xvii<br />
Pasquini, 12 in Luca Boschetto 13 e in Danilo Poggiogalli 14<br />
le altre voci più significative. Quest’ultimo, in un articolo<br />
particolarmente brillante, ha insistito con acume e<br />
con grande rigore metodologico sull’importanza della<br />
componente oscena nel corpus del Burchiello e dell’operazione<br />
parodica antipetrarchesca e antipetrarchista<br />
esemplarmente condotta dal poeta-barbiere.<br />
Al Burchiello il sottoscritto aveva dedicato un ampio<br />
capitolo nel suo Polemiche e berte, fin dal 1971,<br />
radicalmente rinnovato nel 1989, ma oggi bisognoso di<br />
una nuova, profonda messa a punto alla luce di tanto<br />
fervore di iniziative verificatosi nell’ultima decade. In<br />
esso, oltre ad eliminare dal corpus del Burchiello una<br />
prima ricca serie di testi spuri, offrivo un’interpretazione<br />
della poesia del barbiere fiorentino che regge ancor<br />
oggi molto bene e che si basa sulla suddivisione dei<br />
suoi componimenti in tre grandi filoni, che spesso si in-<br />
12 E. Pasquini, Letteratura popolareggiante, comica e giocosa, lirica<br />
minore e narrativa volgare del Quattrocento, in *Storia della letteratura<br />
italiana. Il Quattrocento, Roma, Salerno ed., 1996, pp. 803ss.<br />
13 L. Boschetto, Un documento sul soggiorno del Burchiello a<br />
Roma, in «Nuova rivista di letteratura italiana», i, 1998, 1, pp.<br />
271-75 (ivi è edito l’atto notarile); Id., L. Boschetto, Burchiello e<br />
il suo ambiente sociale: esplorazioni d’archivio sugli anni fiorentini,<br />
in *La fantasia fuor de’ confini. Burchiello e dintorni a 550 anni dalla<br />
morte (1449-1999). Atti del Convegno (Firenze, 26 novembre<br />
1999), a c. di M. Zaccarello, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura,<br />
2002, pp. 35-57.<br />
14 D. Poggiogalli, Dalle acque ai nicchi. Appunti sulla lingua burchiellesca,<br />
in «Studi di lessicografia italiana», xx, 2003, pp. 65-126.
xviii antonio lanza<br />
tersecano tra loro dando vita a sonetti genialmente eterodossi:<br />
i componimenti realistici, quelli di polemica e<br />
di satira letteraria e quelli alla burchia.<br />
Ma la chiave più importante per decrittare il complesso<br />
linguaggio burchiellesco, costantemente pieno di<br />
salacissimi doppi sensi osceni, è indubbiamente rappresentato<br />
dal poderoso repertorio del linguaggio erotico<br />
da Burchiello a Marino allestito da Jean Toscan. 15 Stranamente<br />
sia Zaccarello che Crimi tendono a limitare<br />
fortemente l’uso di questa chiave di lettura, ravvisando<br />
nell’operazione burchiellesca artifici quali «la rianalisi<br />
paretimologica, la reinterpretazione sub- o soprasegmentale,<br />
il gioco di parole su omofoni, la coniazione<br />
analogica […] che estraggono dalla materia verbale valori<br />
occulti o dimenticati, ostacolando e interrompendo<br />
ogni tipo di continuità semantica e sequenzialità logica,<br />
con un effetto irritante di frantumazione del discorso<br />
atto a intralciare l’argomentazione logica e filosofica<br />
come la comune conversazione». 16<br />
Tutto vero. Ma non c’è dubbio che la poesia del Bur -<br />
chiello possa essere ricondotta ad una immensa, sconfinata<br />
metafora erotica, con particolare attenzione alla<br />
sodomia etero ed omosessuale, da parte di un poeta per-<br />
15 J. toscan, Le carnaval du langage. Le léxique érotique des poètes<br />
de l’equivoque de Burchiello à Marino, Lille, Presse universitaire,<br />
1981, 4 voll.<br />
16 M. Zaccarello, in I Sonetti del Burchiello, a c. di M.Z., torino,<br />
Einaudi, 2004, p. xxi.
introduzione xix<br />
fettamente bisessuale, la cui natura lùbrica si mescola<br />
a quella eversiva, antiaccademica e antiaulica, specialmente<br />
nella direzione di un antipetrarchismo radicale.<br />
Alla vacuità assoluta dei seriali prodotti petrarchisti<br />
e alla goffaggine insulsa delle mediocri opere dei tradizionalisti,<br />
infarcite di una mal digerita erudizione,<br />
dalla veste linguistica risibilmente iperculta e dal tono<br />
insopportabilmente tronfio e retorico, il Burchiello risponde<br />
con una poesia violentemente realistica, graffiantemente<br />
parodistica e antiletteraria, e soprattutto<br />
totalmente reificata, fatta com’è dei più disparati oggetti<br />
della realtà quotidiana – con particolare attenzione<br />
al mondo botanico e zoologico, agli arnesi degli<br />
artigiani, alle cose più umili e neglette – mescolati, apparentemente<br />
alla rinfusa, con entità geografiche e con<br />
personaggi del mondo antico e moderno: dagli eroi più<br />
celebrati di tutti i tempi ai più insigni scrittori, artisti,<br />
scienziati, sino ai più oscuri individui della Firenze e<br />
della Siena contemporanee. Le molteplici componenti<br />
di questo universo si trasformano d’incanto, sotto la<br />
bacchetta magica del poeta-barbiere, in una moltitudine<br />
di falli, ani e vulve sapientemente assemblati in<br />
un’inedita, caleidoscopica e vitalistica orgia parossistica,<br />
che spiazza completamente il lettore, frastornato<br />
da tanti oggetti in apparente contrasto tra loro e da un<br />
cromatismo surreale di raro fascino e di inedita, rivoluzionaria<br />
raffinatezza (Sospiri azzurri di speranze<br />
bianche, Zolfane’ bianchi colle ghiere gialle ecc.).<br />
La sua poesia rappresenta la risposta più concreta ai
xx antonio lanza<br />
componimenti impersonalmente ciclostilati dei petrarchisti<br />
e ai ridicoli prodotti dei rimatori tradizionalisti,<br />
questi ultimi costruiti facendo ricorso, per mascherare<br />
la totale assenza di idee e d’ispirazione, all’accumulazione,<br />
che generò rime fabbricate su interminabili liste<br />
di personaggi della storia classica e della mitologia, ma<br />
anche su curiosi elenchi enciclopedici, cari, ad esempio,<br />
ad un Bonciani.<br />
E il Burchiello riuscì perfettamente in questa operazione<br />
di camuffamento di dati, di immagini e di suoni<br />
che apparivano in contrasto stridente e insanabile tra<br />
loro, e che invece erano assolutamente coerenti e funzionali.<br />
L’equivoca materia trattata richiedeva un abile<br />
procedimento di simulazione, tanto abile da ingannare<br />
tutti i lettori per oltre cinque secoli e mezzo.<br />
Per un progetto di così ampia portata la stravagante<br />
maniera lanciata da Andrea Orcagna e ripresa sporadicamente,<br />
ma con efficacia, da Franco Sacchetti si<br />
prestava a meraviglia. Bisognava solo perfezionarla e<br />
rilanciarla su vasta scala, facendone una vera e propria<br />
scuola poetica da opporre, polemicamente, alla scuola<br />
dei petrarchisti fioriti e a quella dei tradizionalisti più<br />
estremi, incarnata soprattuto dal Gherardi e da Domenico<br />
da Prato.<br />
Le prime cavie da testare per verificare se tale opera<br />
funzionasse o meno furono i vari amici e conoscenti<br />
poe ti con cui era in contatto, poco importa se come<br />
clienti di bottega o in altri luoghi: Leonardo Dati, Giovanni<br />
Gherardi, Rosello Roselli, Anselmo Calderoni,
introduzione xxi<br />
Niccolò Tinucci, Leon Battista Alberti, Francesco Filelfo,<br />
Mariotto Davanzati, Francesco d’Altobianco Alberti,<br />
Domenico da Prato, Jacopo d’Albizzotto Guidi,<br />
Giovanni di Zanobi di Manno Betti e, forse, lo stesso<br />
Za, ormai anziano, Filippo Brunelleschi, Piero de’<br />
Ricci, Branca Brancacci, Antonio di Meglio, Francesco<br />
Scambrilla e Giovanni Pigli, molti dei quali appartenenti<br />
a quelle scuole poetiche che egli intendeva<br />
mettere alla berlina. Le reazioni furono varie: adesione<br />
entusiastica, presa di distanze, critiche, divertito interesse.<br />
Certo è che la sua poesia non passò inosservata,<br />
ma, proprio come s’era prefisso, s’impose in maniera<br />
straordinaria.<br />
Al di fuori di questa prospettiva critica, ossia continuando<br />
a negare l’importanza decisiva delle metafore<br />
erotiche, ci si preclude completamente la comprensione<br />
del Burchiello e si continua a cadere nel suo gioco<br />
diabolico. Se letti in chiave lùbrica, al contrario, i<br />
suoi versi si spiegano tutti, per filo e per segno. Per questo<br />
il repertorio del Toscan – opportunamente seguito<br />
da quello di Boggione e Casalegno, 17 che a questo punto<br />
merita una revisione profonda (anche sulla base del<br />
glossario della mia edizione dei poemetti dello Za) –<br />
rappresenta uno strumento indispensabile, che tutta-<br />
17 Dizionario letterario del lessico amoroso, a c. di V. Boggione e<br />
G. Casalegno, torino, u.t.E.t., 2000, che è la riedizione aggiornata<br />
del Dizionario storico del lessico erotico italiano, Milano, Longanesi,<br />
1996.
xxii antonio lanza<br />
via va impiegato con cautela, perché in molti casi offre<br />
interpretazioni errate. E questo per l’effettiva difficoltà<br />
insita nell’operazione burchiellesca, che inclina marcatamente<br />
alla polisemia allo scopo di confondere sempre<br />
di più le già torbidissime acque e di spiazzare i lettori<br />
stupendoli con un vortice metaforico che non ha mai fine<br />
perché uno stesso vocabolo spesso può significare due<br />
o tre cose differenti.<br />
Alla luce di tutto ciò la poesia del Burchiello cessa<br />
dunque di essere ciò che è sempre stata considerata: un<br />
insieme di parole senza senso accozzate alla rinfusa.<br />
Niente di tutto questo. Al contrario, sembra preparata<br />
scientificamente, chimicamente, mediante un alambicco<br />
delle immagini, dei colori e dei suoni d’incredibile efficienza.<br />
Alla stanca serialità dei vacui prodotti proposti dai<br />
petrarchisti egli oppone una varietà incredibile di metafore<br />
erotiche tutte fortemente realistiche, che connotano<br />
con una ricchezza lessicale stupefacente gli<br />
organi sessuali maschili e femminili. La polemica con<br />
Petrarca e con i suoi continuatori è, dunque, alla base<br />
della sua poesia, così come la satira del Dante comico<br />
e degli autori di poemi visionistici era stata alla base<br />
delle operette di quello straordinario poeta che fu lo Za,<br />
il quale, con l’Orcagna, rappresenta il precedente diretto<br />
del poeta-barbiere. E il rigoroso saggio di Fabio Carboni,<br />
che dimostra in maniera ineccepibile che si tratta<br />
proprio di Andrea Orcagna e non di Mariotto di Nardo,<br />
sposta la cronologia della poesia alla burchia ad
introduzione xxiii<br />
una data notevolmente più alta, con acquisizioni decisive<br />
per la storia della rimeria comico-realistica antica,<br />
che a questo punto deve essere riscritta. 18<br />
A guardar bene, quella del Burchiello è un’operazione<br />
simile a quella condotta da Cecco Angiolieri nei<br />
confronti dei lirici aulici tutti: siciliani, siculo-toscani<br />
e stilnovisti. 19 Il trasamare di Cecco è riproposto in<br />
maniera infinitamente più ardita, graffiante e radicalmente<br />
estrema dal Burchiello, che crea una nuova maniera<br />
poetica con al centro, come s’è detto, gli organi<br />
sessuali maschili e femminili, in una girandola, mai seriale<br />
e mai pre vedibile, di continue, ossessive allusioni<br />
a rapporti eterosessuali ed omosessuali, e, nel campo<br />
stesso dell’eterosessualità, sia a quelli secondo natura<br />
che a quelli sodomitici.<br />
Solo Rustico – l’altro grande originatore, con Cecco,<br />
della maniera burlesca – aveva tentato qualche apertura<br />
in direzione realmente lùbrica, ma si tratta di fatti<br />
sporadici: importanti sì per quei tempi remoti, ma non<br />
decisivi. In questo campo il vero precursore del Burchiello<br />
fu sicuramente lo Za, con le sue sapide rassegne<br />
di sodomiti, costruite con un linguaggio allusivo che costituirà<br />
una base imprescindibile per il Burchiello, il<br />
18 F. Carboni, L’Orcagna e il Frusta, in «Cultura neolatina»,<br />
lxix, 2009, 1-2, pp. 111-65.<br />
19 Cfr. A. Lanza, Il pungiglione della poesia aulica e la sua battaglia<br />
con monna Malinconia, in Freschi e minii, cit., pp. 23-62 [già<br />
come introduzione alla citata edizione delle Rime].
xxiv antonio lanza<br />
quale, a sua volta, andrà molto al di là del maestro, che<br />
pure resta un poeta di grande statura, purtroppo ancora<br />
niente affatto compresa.<br />
Già i contemporanei si resero invece im me dia ta mente<br />
conto della portata rivoluzionaria della poesia del<br />
Burchiello, che considerarono ben pre sto un maestro,<br />
degno di figurare, come quarta co rona, addirittura accanto<br />
a Dante, a Petrarca e a Boccaccio. Lo dimostrano<br />
i numerosi compianti scritti per la sua morte da Francesco<br />
d’Altobianco Alberti, da Betto Busini, da Mariotto<br />
Davanzati, da Migliore Cresci, da Piero de’ Ricci e<br />
da Antonio Manetti. Ma lo comprovano ancora di più<br />
i tanti imitatori che ebbe già durante la sua vita, come<br />
Francesco Scambrilla, Giovanni Pigli, Jacopo Borgianni<br />
e, successivamente, in modo più o meno diretto, poeti<br />
diversi e di differente livello quali Filippo Scarlatti, il<br />
Bellincioni, il Pistoia, il Baldinotti, il Pulci, il Franco, il<br />
Berni, il Lasca, il Bronzino, il Caro, il Redi, il Lippi…<br />
sino al Fagiuoli, a Gasparo Gozzi e al Goldoni.<br />
* * *<br />
La presente edizione comprende solo i testi sicuramente<br />
usciti dalla penna del Burchiello e non la sterminata<br />
mèsse di quelli che infondatamente gli vengono<br />
attribuiti. Ho ritenuto quindi opportuno non gravare<br />
di un ciarpame non solo inutile ma dannoso il corpus<br />
autentico del poeta-barbiere, dotando l’edizione di un<br />
commento diverso da quello fornito da Zaccarello, cui
introduzione xxv<br />
va riconosciuto il grande merito di aver rilanciato gli<br />
studi sul poeta-barbiere.<br />
Diversamente da Zaccarello intitolo il volume non<br />
Sonetti, ma Le poesie autentiche, perché non si tratta<br />
di soli sonetti, in quanto vi è compresa anche l’importante<br />
canzone.<br />
Avverto che, diversamente dalla moda invalsa da<br />
circa un ventennio, non ho voluto sprecare pagine su<br />
pagine per inserire sequele di improbabilissime fonti<br />
che, senza alcuna fatica, si ricavano da Internet: come<br />
se un autore medievale o rinascimentale avesse sott’occhio<br />
da mane a sera i più moderni strumenti tecnologici<br />
o le con cordanze di testi, magari stampati in<br />
edizioni critiche.<br />
Il commento fa ampio riferimento al repertorio del<br />
Toscan ed a quello di Boggione e Casalegno, ai quali si<br />
rimanda per l’approfondimento di molte specifiche metafore,<br />
che per ragioni di spazio sarebbe stato impossibile<br />
trattare in maniera esaustiva.<br />
* * *<br />
Mi è caro in questa sede ricordare tre amici con i quali discussi<br />
a lungo della poesia del Burchiello: il carissimo Fabio Carboni,<br />
competente come pochi in codicologia burchiellesca; il compianto<br />
Ruggero Stefanini, acuto interprete della poesia comico-realistica;<br />
ed il giovanissimo Daniele Simoncini, avviato ad una brillante<br />
carriera di studioso, purtroppo interrotta, il 4 febbraio del 1996,<br />
da un triste destino.<br />
Antonio Lanza