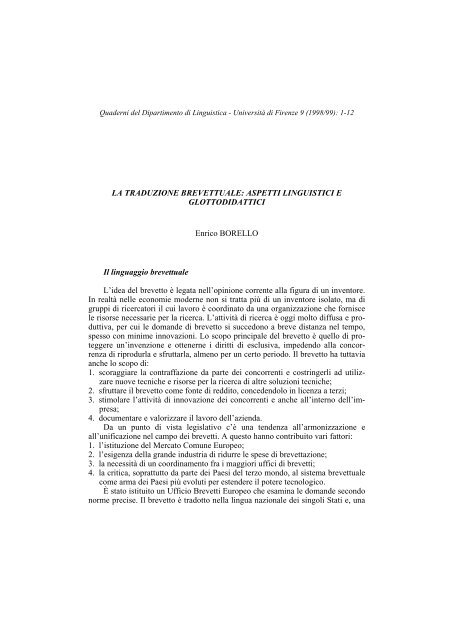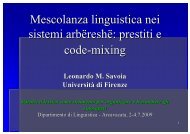LA TRADUZIONE BREVETTUALE: ASPETTI ... - Linguistica
LA TRADUZIONE BREVETTUALE: ASPETTI ... - Linguistica
LA TRADUZIONE BREVETTUALE: ASPETTI ... - Linguistica
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Quaderni del Dipartimento di <strong>Linguistica</strong> - Università di Firenze 9 (1998/99): 1-12<br />
<strong>LA</strong> <strong>TRADUZIONE</strong> <strong>BREVETTUALE</strong>: <strong>ASPETTI</strong> LINGUISTICI E<br />
GLOTTODIDATTICI<br />
Il linguaggio brevettuale<br />
Enrico BORELLO<br />
L’idea del brevetto è legata nell’opinione corrente alla figura di un inventore.<br />
In realtà nelle economie moderne non si tratta più di un inventore isolato, ma di<br />
gruppi di ricercatori il cui lavoro è coordinato da una organizzazione che fornisce<br />
le risorse necessarie per la ricerca. L’attività di ricerca è oggi molto diffusa e produttiva,<br />
per cui le domande di brevetto si succedono a breve distanza nel tempo,<br />
spesso con minime innovazioni. Lo scopo principale del brevetto è quello di proteggere<br />
un’invenzione e ottenerne i diritti di esclusiva, impedendo alla concorrenza<br />
di riprodurla e sfruttarla, almeno per un certo periodo. Il brevetto ha tuttavia<br />
anche lo scopo di:<br />
1. scoraggiare la contraffazione da parte dei concorrenti e costringerli ad utilizzare<br />
nuove tecniche e risorse per la ricerca di altre soluzioni tecniche;<br />
2. sfruttare il brevetto come fonte di reddito, concedendolo in licenza a terzi;<br />
3. stimolare l’attività di innovazione dei concorrenti e anche all’interno dell’impresa;<br />
4. documentare e valorizzare il lavoro dell’azienda.<br />
Da un punto di vista legislativo c’è una tendenza all’armonizzazione e<br />
all’unificazione nel campo dei brevetti. A questo hanno contribuito vari fattori:<br />
1. l’istituzione del Mercato Comune Europeo;<br />
2. l’esigenza della grande industria di ridurre le spese di brevettazione;<br />
3. la necessità di un coordinamento fra i maggiori uffici di brevetti;<br />
4. la critica, soprattutto da parte dei Paesi del terzo mondo, al sistema brevettuale<br />
come arma dei Paesi più evoluti per estendere il potere tecnologico.<br />
È stato istituito un Ufficio Brevetti Europeo che esamina le domande secondo<br />
norme precise. Il brevetto è tradotto nella lingua nazionale dei singoli Stati e, una
2<br />
Enrico Borello<br />
volta convalidato, viene equiparato a un brevetto nazionale concesso nei singoli<br />
Stati 1 .<br />
La letteratura brevettuale<br />
La letteratura brevettuale è costituita dalle descrizioni e dai disegni delle domande<br />
di brevetto. Il testo dei brevetti deve essere reso noto al pubblico in genere<br />
entro 18 mesi dalla data di deposito, per informare in merito a ciò per cui si ha la<br />
protezione brevettuale. Inoltre costituisce una fonte importante di informazioni<br />
tecnico-scientifiche. La letteratura brevettuale comprende anche i documenti relativi<br />
alle procedure di esame, costituiti per la maggior parte dalle anteriorità, che<br />
forniscono gli esempi delle tecniche note. Poiché la legislazione in materia di brevetti<br />
prevede che la descrizione delle domande di brevetto sia tale da permettere la<br />
riproduzione della nuova invenzione, le informazioni tecniche della letteratura<br />
brevettuale sono complete e analitiche.<br />
La letteratura brevettuale si presenta sotto forma di informazione strutturata.<br />
L’esigenza di una legislazione uniforme a livello nazionale e internazionale ha favorito<br />
la stessa impostazione redazionale dei documenti brevettuali: 1. un titolo<br />
descrittivo dell’invenzione; 2. una descrizione particolareggiata dell’invenzione;<br />
3. una eventuale serie di disegni; 4. le rivendicazioni; 5. un riassunto che sintetizza<br />
il contenuto dell’invenzione.<br />
Il diffondersi dei brevetti in ambito internazionale fa sì che lo stesso documento<br />
brevettuale risulti disponibile in lingue diverse. Oggi per tutti i brevetti di<br />
una certa risonanza è disponibile una versione in una delle lingue più conosciute<br />
(inglese, tedesco o francese).<br />
Il brevetto quindi è un titolo di protezione di natura tecnico-legale per un’invenzione,<br />
che sancisce un diritto di esclusiva, cioè il diritto per l’inventore o la società,<br />
di realizzare e commercializzare una nuova soluzione tecnica per un certo<br />
periodo di tempo. Il brevetto descrive tecnicamente l’invenzione, oggetto dell’esclusiva.<br />
Per questo motivo il diritto di esclusiva deve essere fondato su tre requisiti:<br />
l. novità, 2. originalità o attività inventiva, 3. industrialità.<br />
I dati che formano un brevetto sono:<br />
1. i dati anagrafici: il nome dell’inventore, quello del titolare, la data di deposito,<br />
il numero della domanda, il numero e la data di pubblicazione, la<br />
classificazione ai sensi della classificazione internazionale e la possibile<br />
esistenza di documenti corrispondenti presentati in altri Paesi;<br />
1 L’Ufficio Brevetti Europeo ha sede a Monaco, c’è un Dipartimento per le ricerche all’Aja e<br />
ci sono agenzie a Berlino e a Vienna. Comprende Divisioni di esame, Divisioni di opposizioni e<br />
Commissioni di ricorso. È un grande centro di raccolta di informazioni tecnico-scientifiche. Il<br />
brevetto europeo però, una volta concesso, deve tradursi in una pluralità di brevetti che esplicano la<br />
loro efficacia a livello nazionale.
La traduzione brevettuale: aspetti linguistici e glottodidattici 3<br />
2. i dati informativi sul contenuto della domanda (in genere un abstract), di 100-<br />
200 parole;<br />
3. la dichiarazione di scienza, cioè la descrizione dell’invenzione;<br />
4. la dichiarazione di volontà cioè la rivendicazione del diritto di esclusiva.<br />
Traduzione del linguaggio brevettuale<br />
Vediamo in concreto le difficoltà che comporta la traduzione di un brevetto,<br />
attraverso l’analisi del linguaggio utilizzato. Il primo insieme di dati illustrato in<br />
un brevetto è quello dei dati anagrafici, che include:<br />
1. il nome dell’inventore, o degli inventori (inventor);<br />
2. l’identificazione del titolare del brevetto che presenta la domanda (applicant);<br />
3. la data di deposito del documento (date of filing);<br />
4. il numero della domanda di brevetto (application number);<br />
5. il numero di pubblicazione del brevetto (publication number);<br />
6. la data di pubblicazione della domanda di brevetto (date of publication of<br />
application);<br />
7. la classificazione attribuita ai sensi della classificazione internazionale dei brevetti<br />
(int. cl.);<br />
8. la priorità (priority).<br />
Nella traduzione italiana sono indicati i dati basilari per l’identificazione del<br />
brevetto tradotto. Il secondo insieme di dati presenti è quello costituito<br />
dall’abstract, che riassume il contenuto del brevetto, in 100-200 parole. Qui viene<br />
data una descrizione di natura tecnica degli elementi principali dell’invenzione e<br />
delle loro funzioni. L’ultimo paragrafo riassume con chiarezza il risultato che si<br />
può ottenere con l’invenzione (questo paragrafo viene introdotto da as a result), e<br />
quindi lo scopo principale. Già nell’abstract troviamo alcune caratteristiche fondamentali<br />
del linguaggio brevettuale: il largo uso di forme passive e la tendenza a<br />
ripetere gli stessi verbi. In particolare i verbi che si trovano nell’abstract sono presenti<br />
nel brevetto in percentuale alta.<br />
La terza parte, chiamata dichiarazione di scienza, è rappresentata dalla descrizione<br />
dell’invenzione, e si articola secondo una precisa struttura. Prima di tutto<br />
è identificato il campo dell’invenzione affinché il destinatario possa collocarla nel<br />
contesto appropriato. Viene identificato il campo dell’invenzione prima in generale<br />
e poi in particolare (the present invention generally relates to ... and more<br />
particularly to ..., la presente invenzione si riferisce in generale a ..., e più specificatamente<br />
a...). Il lessico usato è quello che tornerà frequentemente in tutto il brevetto.<br />
In secondo luogo viene descritta la nota per affrontare il problema che l’invenzione<br />
vuole risolvere. I problemi che le tecniche già note non hanno risolto<br />
sono trattati nella parte introdotta da however (tuttavia), e il loro elenco è fatto attraverso<br />
le espressioni in addition (inoltre), e furthermore (inoltre). A questo
4<br />
Enrico Borello<br />
punto viene evidenziata l’aspetto fondamentale che le tecniche note non hanno risolto<br />
e che invece questa invenzione potrà risolvere, rivendicando così un requisito<br />
importante dell’invenzione, cioè la novità. La congiunzione conclusiva<br />
therefore introduce appunto la conclusione del discorso attirando su questo punto<br />
l’attenzione del destinatario. Ed è qui che viene presentata l’invenzione come innovativa<br />
e necessaria: the present invention satisfies this need in a manner not<br />
heretofore known in the art (la presente invenzione soddisfa questa esigenza in<br />
una maniera fino ad ora sconosciuta nella tecnica).<br />
Segue, l’elenco degli scopi dell’invenzione, tutti introdotti da una espressione<br />
fissa ripetuta con variazioni minime, per ogni singolo scopo:<br />
- it is an object of the present invention to provide a (È uno scopo della presente<br />
invenzione fornire un …),<br />
- it is another object of the invention to provide a (È un altro scopo dell’invenzione<br />
fornire un …),<br />
- it is a still further object of the invention to provide a (È ancora un ulteriore<br />
scopo dell’invenzione fornire un …),<br />
- it is an even further object of the invention to provide a (È uno scopo ancora<br />
ulteriore dell’invenzione fornire un …).<br />
A questo punto troviamo la parte in cui l’invenzione è descritta in tutti gli<br />
elementi che la compongono. Il discorso assume la forma di un elenco introdotto<br />
da comprising. Da questo punto fino alla fine dell’elenco non si trova un punto,<br />
solo virgole o punti e virgole. La maggior parte dei verbi appare sotto forma di<br />
participi presenti: comprising, defining, having, being, allowing. Le restanti forme<br />
verbali sono participi passati, l’ausiliare essere in frasi relative introdotte da<br />
which, che dipendono da un participio presente. La struttura del discorso è<br />
semplice, ed è evidente la ripetizione di said accanto ai sostantivi che indicano gli<br />
elementi già descritti.<br />
Dopo la descrizione delle parti statiche dell’invenzione viene descritto, se è il<br />
caso, il suo funzionamento: il paragrafo inizia con in operation (durante il funzionamento).<br />
Viene quindi ribadito in sintesi lo scopo dell’invenzione e la sua novità<br />
rispetto a quei sistemi già noti che provocano gli inconvenienti descritti.<br />
La sezione successiva è dedicata alla descrizione dei disegni presentati insieme<br />
al brevetto. Il lessico è quello delle didascalie che descrivono le prospettive<br />
delle figure disegnate: perspective view (vista prospettica); exploded perspective<br />
view (vista prospettica esplosa); cross-sectional view (vista in sezione trasversale);<br />
a view taken along line (vista presa lungo la linea).<br />
Dopo aver illustrato i principi generali dell’invenzione si passa alla descrizione<br />
dettagliata di un esempio, che viene definito come preferred embodiment.<br />
La descrizione della realizzazione è fatta con continuo riferimento alle figure.<br />
Ecco allora che ricorrono espressioni come: with reference to fig. ... (in riferimento<br />
alla figura ...), as shown in fig. ... (come mostrato nella figura ...),<br />
illustrated in fig. … (illustrato nella figura ...), with continued reference to fig. ...
La traduzione brevettuale: aspetti linguistici e glottodidattici 5<br />
(con continuo riferimento alla figura ...). Altre espressioni tipiche per chiarire ciò<br />
a cui ci si riferisce sono: with respect to (rispetto a), relative to, in accordance<br />
with (secondo).<br />
L’ultima parte del brevetto è formata dalle rivendicazioni (claims) ed identifica<br />
quanto forma diritto di esclusiva: è evidente ancora una volta la mancanza di<br />
verbi di modo finito.<br />
Caratteristiche del linguaggio brevettuale<br />
Il linguaggio brevettuale deve rispondere ad esigenze particolari tra cui quella<br />
di coniare nuovi termini, in quanto i prodotti descritti sono nuovi. Altra esigenza è<br />
quella della chiarezza e della compiutezza nella descrizione affinché il nuovo prodotto<br />
sia inequivocabilmente inteso: da qui la necessità di adeguarsi a norme precise<br />
che limitano l’uso della punteggiatura in alcune parti testo. L’eleganza e la<br />
correttezza formale passano dunque in secondo piano rispetto alla necessità di<br />
esprimere chiaramente i concetti. Le ripetizioni per esempio vengono impiegate in<br />
larga misura per insistere sugli scopi dell’invenzione. Il lessico è povero perché lo<br />
scopo principale è la descrizione completa dell’invenzione, evitando divagazioni<br />
che potrebbero avere un effetto negativo. Nel linguaggio brevettuale troviamo dei<br />
costrutti standard, come:<br />
- almeno uno (at least one) usato quando un certo elemento può essere presente<br />
singolarmente o insieme ad altri identici;<br />
- sostanzialmente (substancially) viene impiegato con il significato di “in misura<br />
preponderante, ma non in modo assoluto”;<br />
- comprende (comprise) è l’espressione usata quando non si vuole escludere altri<br />
elementi;<br />
- è costituito da (constitute) comporta invece l’esclusione di qualsiasi altro elemento.<br />
Altre caratteristiche sono:<br />
1. La sezione del brevetto in cui viene identificato il campo dell’invenzione si<br />
apre sempre con l’espressione this invention relates to …;<br />
2. improved è l’espressione spesso usata per sottolineare la novità dell’invenzione<br />
in certe caratteristiche che apparecchiature simili già note non avevano;<br />
3. i verbi comprise e include (comprendere, includere) si trovano sempre nei brevetti<br />
e servono ad introdurre l’elenco delle parti dell’invenzione;<br />
4. all’invenzione che si presenta nel brevetto ci si riferisce quasi sempre con<br />
l’espressione the present invention o this invention;<br />
5. quando vengono descritte le tecniche già note si usa sempre il verbo know al<br />
passivo: is/are known;<br />
6. viene sempre fatto riferimento puntuale alle invenzioni precedenti nello stesso<br />
campo, e la descrizione di queste è sempre introdotta dai verbi disclose o<br />
describe (descrivere);
6<br />
Enrico Borello<br />
7. largo uso del verbo avere, soprattutto nella forma participiale having quando si<br />
vuole aggiungere una serie di particolari alla descrizione che stiamo facendo;<br />
8. la parola embodiment è sempre usata in riferimento alle realizzazioni dell’invenzione<br />
e preferred embodiment si riferisce alla realizzazione migliore;<br />
9. quando vengono descritte le figure, di solito vengono introdotte con l’espressione<br />
figure (n) is a view, e spesso si usano le espressioni sectional view,<br />
cross-section view, exploded view, a view taken along;<br />
10. si ricorre spesso all’uso della parola means che significa mezzi;<br />
11. nelle rivendicazioni si trovano le espressioni according to the claim (n), o<br />
according to any one of preceeding claims.<br />
12. quando si descrivono i vantaggi dell’invenzione si ripete according to this<br />
invention;<br />
13. largo uso di frasi finali per descrivere gli scopi dell’invenzione e le funzioni<br />
delle parti che la compongono. Queste vengono formate in due modi: a) for +<br />
ing form; b) infinito + to;<br />
14. largo uso di frasi consecutive implicite formate da thereby + ing form;<br />
15. largo uso di frasi con valore strumentale formate con by + ing form;<br />
16. le forme verbali più usate sono quelle del simple present, participi e infinito.<br />
Quando si descrivono operazioni che si sono svolte nel passato si usa il past<br />
tense. Esigua è la presenza delle forme di futuro, present perfect e dei modali;<br />
17. largo uso delle forme passive;<br />
18. estrema ripetitività delle singole parole e di intere espressioni;<br />
19. i sostantivi presenti nell’abstract sono ripetuti con estrema frequenza: questo<br />
significa che il traduttore una volta tradotto l’abstract, ha già tradotto più<br />
della metà dei sostantivi del testo.
La traduzione brevettuale: aspetti linguistici e glottodidattici 7
8<br />
Il traduttore della lingua tecnica<br />
Enrico Borello<br />
Tentare di approfondire la conoscenza di una lingua straniera attraverso la<br />
traduzione è importante ma non è sufficiente a formare il traduttore. Questi ha bisogno<br />
di una preparazione particolare che consideri la traduzione non come un<br />
mezzo per migliorare genericamente la conoscenza di una lingua ma un fine preciso<br />
da proporre allo studente che già deve avere delle nozioni di base. Inoltre anche<br />
quando lo studente abbia raggiunto la capacità di riflettere su tutti quei fatti<br />
linguistici e culturali che permettono di decodificare e codificare nuovamente in<br />
un’altra lingua certi messaggi e operare a tutti quei livelli (morfosintattico, semantico,<br />
stilistico) descritti in precedenza, si troverà in difficoltà di fronte a testi che<br />
usano una lingua specialistica.<br />
Il problema che il traduttore si trova ad affrontare in questi testi è prima di<br />
tutto quello della conoscenza del contenuto di cui si parla. La traduzione di un testo<br />
di chimica richiederà la conoscenza di alcune nozioni fondamentali di quella<br />
materia, così come la traduzione di un manuale di informatica sarà abbastanza difficile<br />
per chi non conosce questo settore. D’altra parte il campo della tecnica e<br />
quello della scienza si sono divisi in tanti settori specializzati ed è praticamente<br />
impossibile per il traduttore di professione, che in molti casi ha avuto una formazione<br />
di tipo umanistico, avere una conoscenza di tante materie specialistiche. È<br />
più facile e più veloce fornire certe conoscenze linguistiche ad un tecnico del settore<br />
che già abbia una preparazione di base in una certa lingua, e addestrarlo a tradurre<br />
sempre quel particolare tipo di testi anziché rivolgersi a chi abbia una buona<br />
conoscenza della lingua in questione ma non abbia familiarità con quei tipi di testo.<br />
Il buon traduttore non può essere identificato automaticamente con chi conosce<br />
bene una lingua. Il linguaggio brevettuale ha certe caratteristiche, come la lunghezza<br />
dei periodi senza segni di punteggiatura o l’uso continuo di forme non finite<br />
dei verbi che lo rendono del tutto diverso dalla lingua comune. Traduttori che<br />
non facciano uso della lingua in nessun altro modo perdono, con il tempo, l’abilita<br />
di parlare una lingua.<br />
Non solo dunque la traduzione è un’abilità speciale, che quindi richiede una<br />
organizzazione specifica ma occorre anche una specializzazione sul tipo di testo<br />
che si vuole affrontare. L’approccio fraseologico è molto importante nel campo<br />
scientifico dove abbiamo a che fare con i linguaggi speciali. La specializzazione<br />
da parte del traduttore non è sempre possibile e per questo motivo è importante<br />
fornire completa informazione sull’uso dei termini in un campo particolare. Su<br />
questo tipo di testi si potrebbe anche tentare l’impiego di nuove tecniche.<br />
È proprio nella traduzione del linguaggio tecnico tutto denotativo e altamente<br />
specializzato che potrebbe risultare utile l’impiego del computer, non solo perché<br />
potrebbe essere tentata una sorta di traduzione automatica per lo meno parziale,<br />
grazie proprio alle caratteristiche principali di questo linguaggio (un lessico limi-
La traduzione brevettuale: aspetti linguistici e glottodidattici 9<br />
tato e ripetitivo, una sintassi ristretta e il fatto che evita tutte le ambiguità del linguaggio)<br />
ma anche per aiutare il traduttore in altre operazioni.<br />
Dizionari, glossari, liste di parole sono strumenti indispensabili per un traduttore<br />
e consultarli richiede molto tempo. Inoltre i dizionari specializzati normalmente<br />
prodotti sono di solito già superati quando sono pubblicati. Il computer<br />
ha la capacità di memorizzare e ordinare dati, può produrre velocemente una serie<br />
di glossari e liste di parole, può fornire la terminologia e la fraseologia equivalente<br />
nella lingua target e può fornire informazioni sulla materia stessa.<br />
Attraverso il computer si potrebbero memorizzare per esempio interi testi con<br />
la relativa traduzione, collezionando velocemente i termini e agevolando il lavoro<br />
sulla terminologia. Il traduttore può essere colui che ha una grande competenza<br />
nella L2 ma possiede poca o nessuna conoscenza nel campo della materia specializzata,<br />
oppure chi è altamente competente nel suo campo e possiede solo una conoscenza<br />
passiva della lingua straniera. È raro trovare un traduttore che abbia la<br />
competenza linguistica e specialistica della materia in questione. Ecco che il compito<br />
del linguista potrebbe essere utile in due tipi di intervento:<br />
1. lo studio comparativo dei documenti permette di ricavare equivalenti reali<br />
dell’uso della lingua professionale. Da questo tipo di analisi si può procedere per<br />
costituire delle terminology banks che raccolgano equivalenze a livello della frase<br />
e definizioni dei termini. Inoltre fornire informazioni complete su un termine e sul<br />
suo uso, aiuta il traduttore a penetrare l’idiom del linguaggio specializzato, e a<br />
scoprire le correlazioni tra entità semantiche della L1 e di quella target.<br />
Le liste di sinonimi sono utili per i traduttori. I linguaggi speciali producono<br />
sinonimi perché:<br />
- diversi ricercatori sviluppano lo stesso tipo di ricerca in parallelo, descrivendo le<br />
innovazioni con termini propri;<br />
- c’è bisogno di trovare etichette differenziate per competere con prodotti dello<br />
stesso tipo;<br />
- l’uso della lingua varia all’interno della stessa lingua. Per esempio il British<br />
English è differente dall’American English così come il francese parlato in Francia<br />
è differente da quello parlato in Belgio o in altri Paesi francofoni, e lo spagnolo<br />
è differente dall’ispano americano.<br />
2. D’altra parte il linguista può preparare programmi di insegnamento della lingua<br />
straniera per il tecnico che traduce, fornendo gli elementi necessari per<br />
approfondire e chiarire la conoscenza, anche solo passiva, della lingua straniera,<br />
delle sue strutture grammaticali e sintattiche.<br />
Teorie linguistiche e preparazione dei traduttori<br />
Allo stato attuale, non vi sono pareri unanimi su come insegnare a tradurre, ed<br />
il metodo maggiormente impiegato, anche se non sempre si rivela il più efficace<br />
consiste nel procedere per approssimazioni successive con esercitazioni pratiche
10<br />
Enrico Borello<br />
durante le quali gli studenti rifanno il lavoro fino a quando non hanno appreso ad<br />
operare come previsto. Nell’insegnamento della traduzione equivale a seguire il<br />
principio di “imparare a tradurre traducendo”. Il docente presenta agli allievi un<br />
testo da tradurre, corregge gli errori, poi dà loro un altro testo e così via, sperando<br />
che la quantità produca un mutamento di qualità. Una situazione simile si verifica<br />
quando qualcuno intraprende il lavoro del traduttore senza un precedente tirocinio<br />
professionale.<br />
Il metodo di “procedere per tentativi” richiede molta fatica da parte dell’allievo,<br />
e se il discente non riesce a sviluppare per proprio conto le capacità necessarie,<br />
il docente può solo spingere l’allievo a fare altre traduzioni, nella speranza<br />
che presto o tardi riesca nel suo intento.<br />
Un sistema di preparazione dei traduttori più efficace implica da parte dell’insegnante<br />
la conoscenza della meta finale e delle vie per raggiungerla. Se la meta è<br />
preparare professionisti che siano in grado di affrontare la traduzione di testi impegnativi<br />
gli allievi devono sviluppare le appropriate capacità e gli automatismi<br />
funzionali basati sulla conoscenza specialistica.<br />
Per controllare il processo di insegnamento e garantire i risultati dovremmo<br />
specificare il tipo di conoscenza, capacità ed automatismi da includere negli studi<br />
sulla traduzione. La realizzazione di questo processo dipende in larga misura dalla<br />
concezione di quello che significa tradurre e di che cosa serva per formare un<br />
buon traduttore: di qui l’ovvio legame tra la ricerca teorica e la pratica dell’insegnamento,<br />
e infatti molti postulati della teoria della traduzione in linguistica sono<br />
applicati con successo nei corsi pratici nei corsi di avviamento alla traduzione.<br />
Un buon insegnante di traduzione non si accontenterà mai di dire all’allievo<br />
che la sua traduzione non è di buon livello e farlo riprovare, ma cercherà di spiegargli<br />
le differenze esistenti fra le parti del testo originale e le corrispondenti del<br />
testo di arrivo. Una simile dimostrazione è impossibile se insegnante e studenti<br />
non dispongono dello stesso bagaglio di strumenti d’analisi e se l’allievo non possiede<br />
una certa padronanza dei concetti e dei termini metalinguistici usati dall’insegnante<br />
per descrivere gli elementi significativi del testo.<br />
Un altro aspetto importante nel tirocinio dei traduttori è quello relativo<br />
all’individuazione dei problemi tipici all’interno dei testi scelti per le<br />
esercitazioni: è ovvio che i futuri traduttori durante il periodo di tirocinio<br />
traducano solo un numero limitato di testi, e che lo scopo non è quello di<br />
insegnare a tradurre questi testi ma assicurarsi che siano in grado di tradurre<br />
qualsiasi testo. Ciò si ottiene anche grazie all’uso della teoria linguistica, rendendo<br />
più facile la ricerca della soluzione ogni volta che l’allievo si troverà di fronte allo<br />
stesso problema in un altro testo.<br />
Tipici problemi di traduzione si possono identificare con le espressioni linguistiche<br />
che caratterizzano il segmento del testo originale o quello corrispondente<br />
del testo d’arrivo, o entrambi. Ad esempio, si è notato che le stesse situazioni sono<br />
descritte in francese molto più genericamente che non in inglese, che a sua volta è
La traduzione brevettuale: aspetti linguistici e glottodidattici 11<br />
assai più generico del russo: traducendo dal francese in inglese o dall’inglese al<br />
russo, si ricorrerà quindi ad uso più preciso dei termini.<br />
Queste considerazioni permettono di stabilire due principi relativi all’insegnamento<br />
della traduzione: tutte le decisioni e le scelte operative devono essere<br />
spiegate e comprovate. In secondo luogo, l’insegnamento deve evidenziare le tecniche<br />
peculiari di traduzione e non quelle soluzioni che sono valide solo per un<br />
singolo testo.<br />
Qualsiasi lavoro presenta delle difficoltà e queste non mancano certo nel lavoro<br />
del traduttore che tende sempre ad essere sottovalutato e spesso viene considerato<br />
e svolto come secondo lavoro. Si tratta invece di una professione qualificata<br />
e che, per essere ben fatta, deve costituire l’occupazione principale. Nel<br />
campo della traduzione tecnica, questa prevede anzitutto una solida formazione di<br />
base, che non può essere universale ma che, con la sempre maggiore specializzazione<br />
delle scienze e delle tecniche, richiede conoscenze vaste e diversificate, che<br />
devono essere sostenute con un aggiornamento continuo. Lo stesso vale per le lingue:<br />
una sola lingua straniera è utile, ma non sufficiente. Il linguaggio tecnico e<br />
scientifico tende sempre più ad essere trasversale e molte volte espressioni sono<br />
oramai una sorta di lingua franca. Quindi, la conoscenza di molte lingue aiuta non<br />
poco nell’interpretazione dei testi più impegnativi.<br />
Si può ritenere che, con un paio di anni di applicazione assidua, si possa cominciare<br />
ad operare, mai dimenticando la prudenza e l’umiltà che consigliano di<br />
scegliere un campo di attività ben definito e di appoggiarsi inizialmente a tutta la<br />
documentazione possibile prima di crearsi la propria. Non bisogna poi stupirsi di<br />
fatti che sono del tutto fisiologici: come abbiamo detto che l’interprete, a lungo<br />
andare, può incontrare più difficoltà del previsto nella lingua scritta, così il traduttore<br />
è anche più esposto a trovarsi in difficoltà nella lingua parlata. Se non si<br />
frequentano abitualmente Paesi stranieri, quando si ha occasione di andarci succede<br />
spesso che i primi giorni si abbiano vere difficoltà a intendere discorsi che,<br />
scritti, non presenterebbero problemi. È una prova di più di quanto si debbano fare<br />
convergere le nostre capacità per far bene il nostro lavoro ed un timido richiamo ai<br />
nostri limiti.<br />
Bibliografia<br />
AA.VV. 1983 La traduzione nell’insegnamento delle lingue straniere, Brescia, La<br />
Scuola.<br />
Ballard, M. (a cura di) 1990 La traduction. De la théorie à la didactique, Lille,<br />
Presses Universitaires.<br />
Besse, H. 1976 Traduction et didactique des langues, LR: 128-43.<br />
Borello, E. 1997 “Computer-Assisted Translation”, Tchérednytchenco: 54-68.
12<br />
Enrico Borello<br />
Borello, E. 1998 Traduzione e glottodidattica, Urbino, Quattroventi.<br />
De Besse, B. 1977 “Terminologie et traduction”, Le langage et l’homme 34: 18-29.<br />
Emery, P. 1991 “Text Analysis in Advanced Translation Teaching” Meta 36, 4:<br />
567-77.<br />
Finch, C. A 1969 An approach to technical translation. An introductory guide for<br />
scientific readers, Oxford, Pergamon Press.<br />
Horguelin, P. A. (a cura di) 1978 Translating, a Profession (Atti dell’VIII Congresso<br />
della Federation of Translators), Ottawa.<br />
Lefevere, A. 1993 “Discourse on Translation: Recent, Less Recent, and to Come”,<br />
Target 5, 2: 229-42.<br />
Maillot, J. 1969 La traduction scientifique et technique, Paris, Eyrolles.<br />
Martin, J. 1980 “Traduction et interprétance”, Sigma 5: 89-113.<br />
Nergaard, S. 1995 Teorie contemporanee della traduzione, Milano, Bompiani.<br />
Nida E. A., Taber C. R. 1969 The theory and practice of translation, Leiden, Brill.<br />
Pinchuck, I. 1977 Scientific and technical translation, London, Deutsch.<br />
Seleskovitch, D. 1968 L’interprète dans les conférences internationales. Problèmes<br />
de langage et de communication, Cahiers Champollion 1, Lettres<br />
Modernes, Paris, Minard.<br />
Selinker L., Trimble J. 1980 Scientific and technical writing, Washington.<br />
Tchérednytchenco, O. (a cura di) 1997 La traduction au seuil du XXI e siècle:<br />
histoire, théorie, méthodologie, Strasbourg – Florence – Grenade – Kyiv,<br />
Tempus – Tacis.<br />
Ulrich, M. 1997 Tradurre. Un approccio multidisciplinare, Torino, UTET.<br />
Van Hoof, H. 1979 International Bibliography of Specialized Dictionaries Saur<br />
München.<br />
Vidos, B. E. 1977 “La traduzione come criterio del prestito dei termini tecnici”,<br />
SILTA 6, 1-2: 59-73.<br />
Abstract<br />
Patent’s goal is to protect and invention and to obtain the exclusive rights, not allowing the<br />
competitors to reproduce and/or exploit it for a given time. The patents have its rule of linguistic<br />
construction, shown in this article. The present article shows also the way to form patents translators.