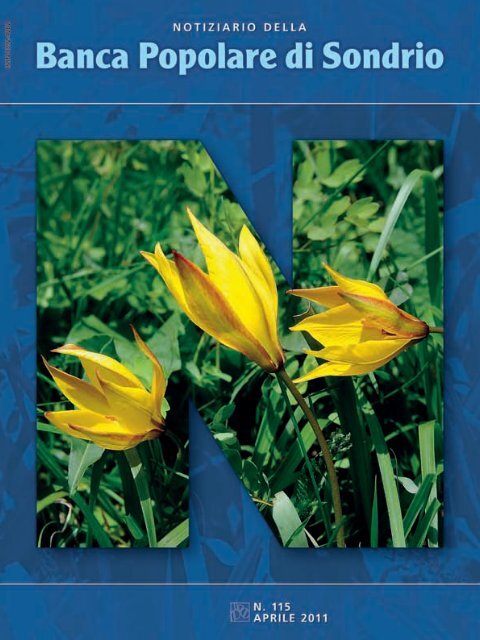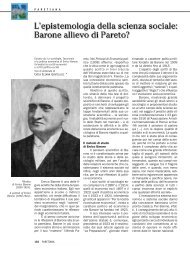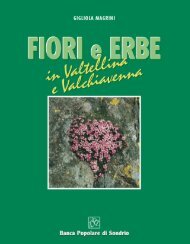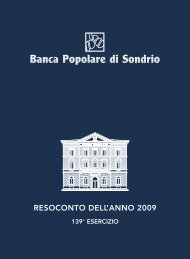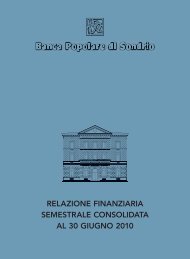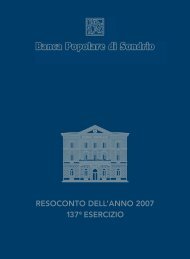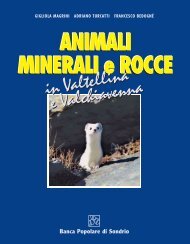e scorbutico - Banca Popolare di Sondrio
e scorbutico - Banca Popolare di Sondrio
e scorbutico - Banca Popolare di Sondrio
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
NOTIZIARIO DELLA<br />
BANCA POPOLARE<br />
DI SONDRIO<br />
N. 115 - APRILE 2011<br />
Tel.: 0342 528 467<br />
Fax: 0342 528 316<br />
E-mail: notiziario@popso.it<br />
La rivista è consultabile in Internet<br />
all’in<strong>di</strong>rizzo: www.popso.it<br />
Direttore<br />
Mario Alberto Pedranzini<br />
Direttore responsabile<br />
Luciano Giacomelli<br />
Capo redazione<br />
Paolo Lorenzini<br />
Vice Capo redazione<br />
Mina Bartesaghi<br />
Redazione<br />
Antonio Del Felice, Maura Poloni,<br />
Chiara Previsdomini,<br />
Italo Spini, Graziella Venturoli<br />
Impaginazione e grafi ca<br />
Grafi ca e Pubblicità Marcassoli srl<br />
Nembro BG<br />
Stampa<br />
Castelli Bolis Poligrafi che spa<br />
Cenate Sotto BG<br />
La <strong>di</strong>rezione della rivista resta<br />
a <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> tutti gli eventuali<br />
detentori <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti d’immagine<br />
non in<strong>di</strong>viduati o che non sia stato<br />
possibile raggiungere per<br />
l’assolvimento degli obblighi <strong>di</strong> legge.<br />
Gli articoli non impegnano la rivista<br />
e rispecchiano il pensiero dell’autore.<br />
Pubblicazione quadrimestrale<br />
Anno 39° - N. 1<br />
Registrato presso il Tribunale<br />
<strong>di</strong> <strong>Sondrio</strong> al N. 108/73 Reg. Period.<br />
ASSOCIATA ALL’UNIONE U SSTAMPA<br />
PERIODICA<br />
ITALIANA (U.S.P.I.)<br />
Informativa sul trattamento dei dati personali<br />
resa dalla <strong>Banca</strong> <strong>Popolare</strong> <strong>di</strong> <strong>Sondrio</strong>, titolare<br />
del trattamento ai sensi del D.Lgs. 196/03<br />
Per spe<strong>di</strong>re le pubblicazioni della <strong>Banca</strong> ai destinatari<br />
ci serviamo dei relativi nominativi e in<strong>di</strong>rizzi <strong>di</strong><br />
corrispondenza. I dati necessari vengono acquisiti,<br />
conservati e trattati, per questi scopi, con modalità<br />
elettroniche e manuali, da nostro personale e<br />
collaboratori specifi camente incaricati. Vengono<br />
anche trattati, per svolgere determinate attività (a<br />
esempio, imbustamento e spe<strong>di</strong>zione), da società<br />
esterne che operano sulla base <strong>di</strong> nostre apposite<br />
istruzioni. I dati non vengono ceduti a terzi né resi<br />
pubblici, né utilizzati per altre fi nalità. È assicurato<br />
l’eventuale esercizio, da parte delle persone cui i<br />
dati si riferiscono, dei <strong>di</strong>ritti previsti dall’art. 7 del<br />
D.Lgs. 196/03 - Co<strong>di</strong>ce in materia <strong>di</strong> protezione dei<br />
dati personali.<br />
Per ulteriori informazioni o per l’esercizio dei cennati<br />
<strong>di</strong>ritti è possibile rivolgersi, per iscritto, al<br />
Responsabile del trattamento c/o <strong>Banca</strong> <strong>Popolare</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>Sondrio</strong> - Uffi cio Privacy - Piazza Garibal<strong>di</strong> 16 -<br />
23100 <strong>Sondrio</strong> SO. E-mail: privacy@popso.it
In copertina:<br />
il Tulipano alpino (Tulipa australis)<br />
rara varietà botanica<br />
delle Orobie valtellinesi<br />
(foto Mauro Lanfranchi)<br />
Terza pagina<br />
Divagazioni sul tempo<br />
4 UMBERTO ECO<br />
Italia 150<br />
Il Risorgimento e la Valtellina<br />
10 FRANCO MONTEFORTE<br />
Tre umili preti<br />
che hanno fatto grande l’Italia<br />
26 Mons. DANIELE ROTA<br />
Economia - Finanza<br />
Il listino azionario è in ven<strong>di</strong>ta<br />
41 ALESSANDRO BOLOGNESI<br />
Indagine conoscitiva<br />
sui mercati degli strumenti fi nanziari<br />
42 GIUSEPPE MUSSARI<br />
André Meyer,<br />
banchiere leggendario (e <strong>scorbutico</strong>)<br />
49 GIANCARLO GALLI<br />
La Cina e i Fon<strong>di</strong> sovrani:<br />
la crescita <strong>di</strong> una potenza geo-economica<br />
ALBERTO QUADRIO CURZIO<br />
52 VALERIA MICELI<br />
SOMMARIO<br />
Personaggi<br />
Peter Peter.<br />
Quando il palato si mette in viaggio<br />
57 ALESSANDRO MELAZZINI<br />
Gianrico Tedeschi o della vitalità geniale<br />
64 EDGARDA FERRI<br />
Franz e il suo doppio: i gemelli Liszt<br />
68 MELANIA G. MAZZUCCO<br />
Giustizia<br />
La me<strong>di</strong>cina <strong>di</strong>fensiva danneggia<br />
il paziente e la fi nanza pubblica<br />
77 ALFONSO MARRA<br />
La Costituzione Italiana.<br />
Conoscerla per amarla<br />
80 FRANCESCO SAVERIO CERRACCHIO<br />
Incontri BPS<br />
Fede e scienza<br />
86 Card. GIANFRANCO RAVASI<br />
Quale futuro per l’economia in Europa<br />
90 GUIDO TABELLINI<br />
Attualità<br />
Tibet Tawo Tadra<br />
98 FAUSTO SASSI<br />
La nuova meccanica<br />
e la ricerca inter<strong>di</strong>sciplinare<br />
110 EDOARDO MAZZA
Elzeviri<br />
In viaggio con Brunilde e Rosamunda<br />
116 GIORGIO TORELLI<br />
Tortura per adolescenti<br />
122 LUCA GOLDONI<br />
Immanuel Kant. La pace della ragione<br />
123 GAVINO MANCA<br />
Società e costume<br />
La lingua italiana si trasforma<br />
126 VITTORIO MATHIEU<br />
Salute<br />
Cos’è la buona me<strong>di</strong>cina?<br />
128 ALESSANDRO BERTOLINI<br />
Provincia ieri e oggi<br />
Il senso del non senso<br />
134 REMO BRACCHI<br />
Il giro della Valle Poschiavina<br />
LUISA ANGELICI e<br />
140 ANTONIO BOSCACCI<br />
Paesaggi senza tempo<br />
Piacenza, a fi anco del Po<br />
142 GIGLIOLA MAGRINI<br />
Reportage<br />
Impressioni <strong>di</strong> un viaggio in Corsica<br />
150 ROBERTO RUOZI<br />
Notiziario della<br />
BANCA POPOLARE DI SONDRIO<br />
N. 115 - APRILE 2011<br />
Gli amici dell’uomo<br />
Allevare correttamente<br />
una tartarughina acquatica<br />
160 PIERO M. BIANCHI<br />
Oltre la Valle<br />
Honoré II, premier Seigneur de Monaco<br />
à porter le titre de Prince<br />
164 RENÉ NOVELLA<br />
Le trasformazioni economiche e sociali<br />
del Chiavarese dall’Unità d’Italia al 1914<br />
168 MARCO DORIA<br />
Momenti Pirovano<br />
Tutti all’appello a 3.000 metri<br />
per assistere alle lezioni...<br />
175 e non solo <strong>di</strong> sci<br />
Dalla “Suisse”<br />
Un costruttore <strong>di</strong> futuro<br />
181 CARLO DE BENEDETTI<br />
Adriano Olivetti e il “secolo breve”<br />
182 FABRIZIO FAZIOLI<br />
Adriano Olivetti,<br />
ritratto <strong>di</strong> un impren<strong>di</strong>tore illuminato<br />
186 VALERIO CASTRONOVO<br />
Adriano Olivetti: tra sogno e realtà<br />
MAURO LEO BARANZINI e<br />
190 FABRIZIO FAZIOLI<br />
Comunità e Cantoni:<br />
alla ricerca <strong>di</strong> libertà politica<br />
196 DAVIDE CADEDDU<br />
La Fondazione Adriano Olivetti<br />
200 LAURA OLIVETTI<br />
Cronache aziendali<br />
Acqua del Burkina<br />
202 WAIDER VOLTA<br />
204 Fatti <strong>di</strong> casa nostra
4 TERZA PAGINA<br />
Divagazioni<br />
sul tempo<br />
Archivi Alinari<br />
UMBERTO ECO<br />
NOTIZIARIO<br />
Terza pagina<br />
Che cosa faceva Dio, prima<br />
<strong>di</strong> fare il cielo e la<br />
terra? Preparava l’inferno<br />
per chi vuole occuparsi<br />
<strong>di</strong> problemi troppo <strong>di</strong>ffi cili. Colui<br />
che ha citato questa battuta (evidentemente<br />
già antica ai suoi tempi),<br />
avvertendo che si trattava <strong>di</strong><br />
uno scherzo, parlava con molta<br />
serietà ed affrontava uno dei massimi<br />
problemi della fi losofi a <strong>di</strong> tutti<br />
i secoli: il tempo. Si trattava <strong>di</strong><br />
sant’Agostino, che appunto al tempo<br />
de<strong>di</strong>ca il libro XI delle sue Confessioni.<br />
Già nel citare quella battuta<br />
scherzosa, Agostino anticipava<br />
una conclusione su cui si troverebbe<br />
oggi d’accordo anche un<br />
teorico del Big Bang: il tempo nasce<br />
in quel preciso istante, solo<br />
dal Big Bang in avanti si può parlare<br />
<strong>di</strong> “prima” e <strong>di</strong> “dopo”, e quin<strong>di</strong><br />
non ci si può chiedere che cosa<br />
avvenisse “prima” della nascita<br />
del tempo.<br />
Del tempo si erano occupati<br />
i fi losofi greci, e la defi nizione che<br />
aveva avuto più fortuna era stata<br />
quella <strong>di</strong> Aristotele (Fisica IV, 11,<br />
219 b 1): «Il tempo è il numero del<br />
movimento secondo il prima e il<br />
dopo». Non molto <strong>di</strong>versamente<br />
secondo Crisippo il tempo era<br />
«l’intervallo del movimento del<br />
mondo» – dove intervallo non deve<br />
intendersi come «spazio vuoto tra<br />
due cose», perché il termine greco<br />
era <strong>di</strong>ástêma, il termine che si<br />
usava per l’intervallo musicale (e<br />
cioè il “rapporto” tra due suoni), e<br />
dunque non era un “vuoto”, un silenzio,<br />
bensì un “pieno” che l’orecchio<br />
sentiva. Locke, nel correggere<br />
parzialmente Aristotele (Saggio<br />
sull’intelletto umano, II, XIV, 19),<br />
<strong>di</strong>ceva che il tempo non misura<br />
necessariamente il movimento,<br />
ma «ogni apparenza o alterazione<br />
<strong>di</strong> idee costante e perio<strong>di</strong>ca», così<br />
che se il sole, invece <strong>di</strong> muoversi
Mauro Lanfranchi<br />
nel cielo, semplicemente aumentasse<br />
o <strong>di</strong>minuisse l’intensità della<br />
sua luce, questo alternarsi regolato<br />
potrebbe servire come parametro<br />
per misurare il tempo. Ottima<br />
correzione, perché legittima anche<br />
gli orologi non meccanici come<br />
quelli atomici. Ma siamo sempre a<br />
una idea del tempo come or<strong>di</strong>ne e<br />
successione, e questa concezione<br />
del tempo non cambia neppure<br />
con Leibniz e Newton. In effetti<br />
non cambia neppure da Kant a<br />
Einstein, quando nel tempo si vede<br />
l’or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> una catena causale<br />
– salvo che, e uso una defi nizione<br />
<strong>di</strong> Reichenbach, a cui torneremo<br />
più avanti, «la teoria della relatività<br />
non presuppone una <strong>di</strong>rezione ma<br />
solo un or<strong>di</strong>ne del tempo» (The<br />
Direction of Time. Berkeley and Los<br />
Angeles: University of California<br />
Press 1954, p. 42).<br />
Se il tempo è la misura precisa<br />
<strong>di</strong> una successione or<strong>di</strong>nata <strong>di</strong><br />
stati, era dunque ovvio che, come<br />
è avvenuto in tutte le civiltà, il primo<br />
criterio oggettivo <strong>di</strong> misura<br />
fosse stato dato dal movimento<br />
degli astri (che è movimento, ma<br />
anche ritorno e “apparenza perio<strong>di</strong>ca<br />
e costante”). Ma se il tempo<br />
fosse solo questo, allora sarebbe<br />
interessante chiederci perché per<br />
tanti secoli gli uomini hanno misurato<br />
gli anni, i mesi e i giorni, ma<br />
hanno tardato molto a misurare le<br />
ore e i minuti. È che per misurare<br />
ore e minuti è stato necessario<br />
attendere strumenti meccanica-<br />
Per misurare ore<br />
e minuti è stato<br />
necessario attendere<br />
strumenti<br />
meccanicamente<br />
precisi. Nella pagina<br />
a fianco: Giorgio<br />
Vasari (1511-74):<br />
Allegoria del tempo,<br />
particolare del<br />
Giu<strong>di</strong>zio universale.<br />
Firenze, Duomo <strong>di</strong><br />
Santa Maria del<br />
Fiore.<br />
Hours and minutes<br />
could not be<br />
measured until there<br />
were mechanically<br />
precise instruments.<br />
On the facing page:<br />
Giorgio Vasari<br />
(1511-74): Allegory of<br />
time, detail of the<br />
Last Judgement.<br />
Florence, Cathedral<br />
of Santa Maria del<br />
Fiore.<br />
mente precisi, e quanto fosse arduo<br />
<strong>di</strong>videre l’anno in un numero<br />
preciso <strong>di</strong> giorni ce lo <strong>di</strong>cono le vicissitu<strong>di</strong>ni<br />
dei vari calendari. Per<br />
millenni l’unico orologio sicuro è<br />
rimasto il canto del gallo e a una<br />
economia eminentemente agricola<br />
bastava ritmare la vita in<strong>di</strong>viduale<br />
sul sorgere e sul tramontare del<br />
sole, e quella sociale sulla successione<br />
delle stagioni. Per millenni il<br />
concetto <strong>di</strong> puntualità è rimasto<br />
assai vago, e al massimo si misuravano<br />
alcune parti del giorno sui<br />
ritmi della preghiera e sul suono<br />
delle campane.<br />
Quanto a noi, fi gli della civiltà<br />
degli orologi, talora <strong>di</strong>mostriamo<br />
ancora <strong>di</strong> avere idee molto imprecise<br />
sulla misurazione del tempo.<br />
Basta controllare quanti articoli e<br />
quanti libri più o meno seri erano<br />
usciti all’approssimarsi della fi ne<br />
del secondo millennio per <strong>di</strong>scute-<br />
Digressions on time<br />
Thinkers and philosophers have endeavoured for years to give a<br />
definition to the concept of time. For Aristotle, time is the number<br />
of motion in respect of before and after. For Chrysippus, it is the<br />
interval of the world’s motion. For Locke, on the other hand, time<br />
does not measure motion, but each constant and perio<strong>di</strong>c<br />
appearance or alteration of ideas. The first criterion of measurement<br />
in this perspective was the motion of the stars. Basing the evaluation<br />
of time on the motion of the sun, it was not until the introduction of<br />
the first accurate mechanical clocks in relatively recent times that a<br />
meaning could be given to the idea of punctuality. But measuring<br />
does not mean understan<strong>di</strong>ng what time is. St. Augustine said that<br />
before the creation of the world, God prepared hell for those who<br />
wanted to deal with problems that were too <strong>di</strong>fficult.<br />
re se esso terminasse il 31 <strong>di</strong>cembre<br />
1999 o il 31 <strong>di</strong>cembre 2000.<br />
Sembra impossibile che ci fosse<br />
<strong>di</strong>saccordo: è ovvio che il millennio<br />
fi nisce con il <strong>di</strong>cembre dell’anno<br />
2000, così come la prima decina<br />
fi nisce con il numero 10 e la seconda<br />
inizia con il numero 11.<br />
Queste cose le sanno molto bene<br />
i bibliofi li: una volta deciso che gli<br />
incunaboli sono i libri a stampa<br />
prodotti entro la fi ne del XV secolo,<br />
si considerano incunaboli i libri<br />
stampati entro il 31 <strong>di</strong>cembre<br />
1500 (e non il 31 <strong>di</strong>cembre 1499).<br />
Ma è la cifra tonda che fa effetto,<br />
ed è a causa <strong>di</strong> quei due zeri che<br />
si temeva (ricordate?) che entrasse<br />
in scena il Millennium Bug, il<br />
verme del millennio che avrebbe<br />
bloccato i computer <strong>di</strong> tutto il mondo<br />
i quali, costruiti per calcolare gli<br />
anni in due cifre, dopo il 99 avrebbero<br />
contrassegnato l’anno Duemila<br />
con 00, confondendolo così<br />
col 1900.<br />
Sul problema <strong>di</strong> quando fi nisse<br />
il secolo ci sono state <strong>di</strong>scussioni<br />
tra fi ne XVII secolo e inizio<br />
XVIII, tra fi ne XVIII e inizio XIX, e tra<br />
fi ne XIX e inizio XX – e credo che<br />
continueremo la <strong>di</strong>scussione anche<br />
nel <strong>di</strong>cembre 2999. Non c’è<br />
nulla da fare, il sentimento popolare<br />
vince sul buonsenso e sulla<br />
scienza e, come i nostri antenati<br />
hanno festeggiato l’inizio del Ventesimo<br />
secolo al primo gennaio<br />
1900, così abbiamo fatto noi (sbagliando)<br />
per il Ventunesimo – e<br />
TERZA PAGINA 5<br />
Fotolia
forse abbiamo fatto bene, altrimenti<br />
il millennio sarebbe iniziato<br />
nel 2001, sotto il segno catastrofi<br />
co dell’attentato alle Due Torri.<br />
Il computo del tempo fa perdere<br />
la testa anche alle persone<br />
colte. Ho letto vari articoli, sul fi nire<br />
del 1999, in cui la colpa del<br />
<strong>di</strong>battito sulla fi ne del millennio<br />
sarebbe risalita a Dionigi il Piccolo,<br />
che nel sesto secolo d.C. aveva<br />
proposto <strong>di</strong> far cominciare il<br />
computo degli anni dalla nascita<br />
<strong>di</strong> Cristo. Prima si calcolavano dal<br />
regno <strong>di</strong> Diocleziano, e in molti<br />
casi dalla data dell’inizio del mondo,<br />
immaginatevi con quale precisione.<br />
Ora è certo che Dionigi<br />
aveva nettamente sbagliato la<br />
data della nascita <strong>di</strong> Gesù, che<br />
dovrebbe aver avuto luogo da<br />
quattro a sei anni prima, per cui è<br />
legittimo sospettare che il nostro<br />
millennio avesse dovuto fi nire nel<br />
1997 o giù <strong>di</strong> lì. Quello che è tuttavia<br />
curioso è che molti attribuivano<br />
a Dionigi un secondo errore:<br />
siccome egli non poteva conoscere<br />
lo zero (che – passato dagli<br />
in<strong>di</strong>ani agli arabi – è stato introdotto<br />
in Occidente solo secoli<br />
dopo), avrebbe fatto iniziare la<br />
storia della cristianità dall’anno 1.<br />
6 TERZA PAGINA<br />
Se avesse considerato un anno<br />
zero, si <strong>di</strong>ce, non avremmo avuto<br />
<strong>di</strong> che <strong>di</strong>scutere, e il secondo millennio<br />
sarebbe fi nito incontestabilmente<br />
col 31 <strong>di</strong>cembre 1999.<br />
Grande bestialità (non imputabile<br />
a Dionigi ma ai suoi cattivi<br />
interpreti). Immaginiamo per assurdo<br />
che Dionigi fosse stato competente<br />
in matematica in<strong>di</strong>ana, e<br />
avesse fatto nascere Gesù nell’anno<br />
Zero. Forse che Maria e Giusep-<br />
pe, dopo do<strong>di</strong>ci mesi, avrebbero<br />
detto che Gesù compiva zero anni,<br />
e che ne avrebbe compiuto uno<br />
solo allo scadere dell’anno seguente?<br />
Evidentemente non è così<br />
che noi calcoliamo i nostri anni,<br />
perché nel momento in cui nasciamo<br />
(e chiamiamolo pure “istante<br />
zero”) stiamo iniziando il nostro<br />
primo anno <strong>di</strong> vita; e non si vede<br />
perché dovremmo fare in modo<br />
<strong>di</strong>verso coi secoli. Ma ho citato<br />
l’episo<strong>di</strong>o per <strong>di</strong>re che, con tutti i<br />
nostri orologi, meccanici e atomici,<br />
<strong>di</strong> fronte al computo del tempo noi<br />
siamo ancora capaci <strong>di</strong> perdere la<br />
testa.<br />
Il fatto è che noi misuriamo il<br />
tempo ma questo non ci consente<br />
affatto <strong>di</strong> capire che cosa sia, e se<br />
sia giusto misurarlo metricamen-<br />
Noi misuriamo il<br />
tempo ma questo<br />
non ci consente<br />
affatto <strong>di</strong> capire che<br />
cosa sia, e se sia<br />
giusto misurarlo<br />
metricamente.<br />
Mauro Lanfranchi<br />
We measure time<br />
but this does not let<br />
us understand at all<br />
what it is and<br />
whether it is right to<br />
measure it metrically.<br />
te. Torniamo a sant’Agostino.<br />
All’inizio della sua rifl essione egli<br />
sembra con<strong>di</strong>videre l’idea aristotelica,<br />
e infatti <strong>di</strong>ce che, a <strong>di</strong>fferenza<br />
dell’eternità, che è immobile, un<br />
tempo è lungo per la successione<br />
<strong>di</strong> molti movimenti, che non possono<br />
estendersi nello stesso tempo.<br />
Anzi, egli <strong>di</strong>ce «per molti movimenti<br />
che passano oltre, che ci oltrepassano».<br />
Pare dunque che ciò<br />
che lo colpisce nello scorrere <strong>di</strong><br />
questi movimenti, è che essi <strong>di</strong>ventano<br />
tempo passato. E proprio<br />
da questa considerazione egli inizia<br />
a rifl ettere che, mentre nell’eternità<br />
tutto è presente, il tempo sia<br />
un curioso fenomeno per cui ogni<br />
passato è come cacciato via dal<br />
futuro, ed ogni futuro consegue dal<br />
passato, e sia passato che futuro<br />
fl uiscono dal presente. Eppure, si<br />
chiede Agostino, come possono<br />
esistere passato e futuro se il<br />
passato non è più e il futuro non è<br />
ancora? Avremo dunque un eterno<br />
presente? Ma un eterno presente<br />
sarebbe eternità, e non tempo. E<br />
infi ne, anche a voler considerare il<br />
presente, possiamo <strong>di</strong>re che il<br />
mese in corso sia presente, mentre<br />
ne sono presenti solo un giorno,<br />
un’ora, un minuto, un secondo?<br />
Non appena cerca <strong>di</strong> defi nire<br />
la durata <strong>di</strong> questo secondo presente,<br />
Agostino si rende conto che<br />
anch’essa può essere infi nitamente<br />
sud<strong>di</strong>visa in entità sempre più<br />
brevi e che, quand’anche la più<br />
breve <strong>di</strong> queste unità fosse defi nibile,<br />
essa passerebbe così rapidamente<br />
dal futuro al passato da<br />
non avere la minima durata, «nullum<br />
habet spatium» – e si noti come<br />
anche qui, per in<strong>di</strong>care una<br />
durata temporale, egli usasse un<br />
termine spaziale.<br />
Ed ecco che ogni defi nizione<br />
del tempo in termini <strong>di</strong> entità misurabile<br />
entra in crisi, e Agostino lo<br />
<strong>di</strong>ce a chiare lettere (XIII, 29). Egli<br />
non è d’accordo sul fatto che il<br />
tempo <strong>di</strong>penda dal moto del sole,<br />
della luna e degli astri. Perché il<br />
tempo non potrebbe essere il moto<br />
<strong>di</strong> qualsiasi corpo, persino (e qui<br />
Agostino anticipa Locke, e quin<strong>di</strong><br />
non solo l’idea <strong>di</strong> orologio meccanico<br />
ma anche quella <strong>di</strong> orologio<br />
atomico) il moto circolare e perio-
<strong>di</strong>co della ruota <strong>di</strong> un vasaio? Ma<br />
Agostino fa <strong>di</strong> più. In XIII, 30 ricorda<br />
il «fermati o sole!» <strong>di</strong> Giosuè: in<br />
quel momento il sole, e con lui<br />
tutti gli astri, si era fermato, eppure<br />
il tempo continuava ad andare<br />
avanti (e ancora una volta egli usa<br />
un termine spaziale, ibat).<br />
Quale era il tempo che “andava<br />
avanti” quando il sole si era<br />
fermato? Direi che era il tempo<br />
della coscienza (e forse del corpo)<br />
<strong>di</strong> Giosuè. E infatti Agostino, nel<br />
negare la connessione <strong>di</strong>retta del<br />
tempo coi moti celesti, subito avanza<br />
l’ipotesi che esso sia l’estensione,<br />
l’estendersi dell’anima.<br />
Dunque, <strong>di</strong>ceva Agostino, noi<br />
non possiamo misurare né il passato,<br />
né il presente, né il futuro<br />
(che non ci sono mai) e tuttavia<br />
misuriamo il tempo, quando <strong>di</strong>ciamo<br />
che un certo tempo è lungo,<br />
che non passa mai, o che è passato<br />
molto in fretta. Agostino stava<br />
dunque parlando <strong>di</strong> una misura<br />
non metrica del tempo, quella che<br />
mettiamo in opera quando ci pare<br />
che una giornata noiosa sia durata<br />
moltissimo, e un’ora piacevole sia<br />
passata troppo in fretta. E qui avviene<br />
il colpo <strong>di</strong> scena agostiniano:<br />
questa misura avviene nella memoria.<br />
La vera misura del tempo è<br />
Photo Oilime<br />
Le pagine che<br />
sant’Agostino<br />
(350-430) de<strong>di</strong>ca<br />
al tema del tempo<br />
appaiono tra le più<br />
moderne, concise e<br />
rivelatrici <strong>di</strong> tutta la<br />
storia del pensiero<br />
filosofico.<br />
The pages by St.<br />
Augustine (350-430)<br />
on the subject of<br />
time are some of the<br />
most modern,<br />
concise and revealing<br />
in the whole of the<br />
history of<br />
philosophical<br />
thought.<br />
Nel celebre passo<br />
biblico del «Fermati<br />
o sole», il tempo che<br />
andava avanti era<br />
forse il tempo della<br />
coscienza – e anche<br />
del corpo – <strong>di</strong><br />
Giosuè.<br />
In the famous Biblical<br />
passage of “Sun,<br />
stand thou still”, the<br />
time which moved<br />
forward was perhaps<br />
the time of Joshua’s<br />
conscience – and<br />
also of his body.<br />
una misura interiore. Secoli dopo<br />
Bergson opporrà al tempo metrico<br />
degli orologi il tempo della coscienza,<br />
la durata interiore. Potremmo<br />
leggere le bellissime pagine<br />
<strong>di</strong> Bergson (per esempio nel<br />
Saggio sui dati imme<strong>di</strong>ati della coscienza<br />
– e interrogarci sui rapporti<br />
tra il tempo <strong>di</strong> Bergson e il tempo<br />
<strong>di</strong> Proust) ma è certo che Agostino<br />
ha parlato per primo, e le<br />
sue pagine sul tempo appaiono<br />
tra le più moderne, concise e rivelatrici<br />
<strong>di</strong> tutta la storia del pensiero<br />
fi losofi co.<br />
Nessuno intende negare l’utilità<br />
del tempo degli orologi, ma è<br />
certo che esso s’intreccia (se non<br />
nella scienza, almeno nella nostra<br />
vita quoti<strong>di</strong>ana) con il tempo della<br />
coscienza e della memoria. E qui<br />
occorrerebbe aprire un nuovo paragrafo<br />
sul tempo della fenomenologia<br />
(Husserl) o sul tempo <strong>di</strong> Heidegger:<br />
il quale non è così lontano<br />
da un tempo oggettivo, che è quello<br />
biologico, e quello fi sico dell’entropia,<br />
per cui tutti i viventi tendono<br />
al nulla, ovvero (non c’era bisogno<br />
<strong>di</strong> Heidegger per scoprirlo)<br />
tutti gli uomini sono mortali. Ma<br />
Heidegger cerca <strong>di</strong> far convivere<br />
questo tempo biologico e fi sico,<br />
spietato, con il tempo del progetto<br />
o dell’unica possibilità che ci è<br />
concessa: come si può vivere accettando<br />
quello che si è stati, ed<br />
essere-per-la-morte?<br />
Non ci si attenda da queste<br />
poche note una ricostruzione globale<br />
del problema del tempo. Non<br />
lo si può fare per mancanza <strong>di</strong><br />
tempo. Qui si vogliono solo esprimere<br />
alcune perplessità. E molte<br />
delle nostre perplessità sono manifestate<br />
dal linguaggio che usiamo<br />
per parlare del tempo. Certo<br />
non siamo perplessi quando <strong>di</strong>ciamo<br />
che sono le nove meno<br />
<strong>di</strong>eci del 21 <strong>di</strong>cembre. Infatti ci<br />
pare che il tempo degli orologi e<br />
quello dell’astronomia non c’ingannino<br />
mai – anche se il Phileas<br />
Fogg del Giro del mondo in ottanta<br />
giorni <strong>di</strong> Jules Verne credeva <strong>di</strong><br />
essere tornato a Londra il 21 <strong>di</strong>cembre,<br />
e dunque in ritardo rispetto<br />
alla sua scommessa, mentre<br />
quel giorno per i lon<strong>di</strong>nesi era<br />
ancora il 20, poiché Fogg, compiendo<br />
il giro del mondo da ovest<br />
a est, aveva guadagnato un giorno.<br />
In ogni caso siamo sempre<br />
imbarazzati a nominare il tempo<br />
della durata interiore.<br />
Il tempo cammina davanti a<br />
noi o <strong>di</strong>etro a noi? Non è domanda<br />
oziosa, visto che – se guar<strong>di</strong>amo<br />
sempre verso oriente – <strong>di</strong>ciamo<br />
che sono, poniamo, le 6 <strong>di</strong> mattina<br />
quando il sole è in un certo punto<br />
del cielo davanti ai nostri occhi, e<br />
che saranno le 6 del pomeriggio<br />
quando il sole sarà in un altro<br />
punto alle nostre spalle. Noi dunque<br />
pensiamo <strong>di</strong> avere il passato<br />
TERZA PAGINA 7<br />
Photo Oilime
davanti a noi e il futuro alle spalle?<br />
Pare che in alcune culture sia così,<br />
perché il passato lo conosciamo<br />
già (e quin<strong>di</strong> lo abbiamo davanti<br />
agli occhi) mentre del futuro non<br />
sappiamo ancora nulla. Ma basta<br />
esaminare le nostre abitu<strong>di</strong>ni linguistiche<br />
occidentali per accorgerci<br />
che in realtà, quando parliamo,<br />
sembra che noi ragioniamo nel<br />
modo opposto: noi parliamo delle<br />
settimane che abbiamo davanti a<br />
noi prima <strong>di</strong> fi nire un certo lavoro,<br />
dei mesi che ci siamo lasciati alle<br />
spalle, e <strong>di</strong>ciamo «se mi volto a ricordare<br />
i giorni della mia infanzia...».<br />
Sicuro? Però parliamo anche<br />
delle settimane seguenti, e pare<br />
che pensiamo a qualcosa che ci<br />
segue, e dunque da <strong>di</strong>etro, e non<br />
che ci precede. Allora è <strong>di</strong> nuovo il<br />
futuro che sta alle nostre spalle?<br />
Ma non basta. Noi parliamo<br />
come se pensassimo che il futuro<br />
è qualcosa che prima o poi verrà<br />
qui, dove siamo ora, mentre il passato<br />
si è allontanato da noi. Noi<br />
<strong>di</strong>ciamo che «verrà (qui) il tempo in<br />
cui...» e che gli anni della fanciullezza<br />
se ne sono andati (lontano<br />
da qui). Non c’è nulla <strong>di</strong> meno razionale<br />
<strong>di</strong> questo modo <strong>di</strong> esprimersi<br />
perché, se anche dovessimo<br />
vedere futuro e passato in<br />
termini spaziali, il futuro dovrebbe<br />
essere un posto dove noi andremo,<br />
prima o poi, non una cosa che<br />
viene nel posto in cui siamo ora. E,<br />
del pari, dovremmo <strong>di</strong>re che noi<br />
siamo andati via dal passato in cui<br />
eravamo, non che il passato se ne<br />
è andato via da dove siamo ora.<br />
Adatto liberamente un bell’esperimento<br />
mentale (Derek Bickerton,<br />
The Roots of Language.<br />
Ann Arbor: Karoma, 1981, p. 270):<br />
supponiamo che mi trovi a interagire<br />
da un anno con una tribù<br />
molto ma molto primitiva, <strong>di</strong> cui<br />
conosco il linguaggio in modo assai<br />
rozzo (nomi <strong>di</strong> oggetti e azioni<br />
elementari, verbi all’infi nito, nomi<br />
propri senza pronomi, eccetera).<br />
Sto accompagnando a caccia Og<br />
e Ug: essi hanno appena ferito un<br />
orso, che si è rifugiato sanguinante<br />
nella sua caverna. Ug vuole inseguire<br />
l’orso nella tana per fi nirlo.<br />
Ma io ricordo che qualche mese<br />
8 TERZA PAGINA<br />
prima Ig aveva ferito un orso, lo<br />
aveva seguito baldanzoso nella<br />
tana, e l’orso aveva avuto ancora<br />
forza suffi ciente per <strong>di</strong>vorarlo. Vorrei<br />
ricordare a Ug quel precedente,<br />
ma per farlo dovrei potere <strong>di</strong>re che<br />
ricordo un fatto passato, ma non<br />
so esprimere né tempi verbali né<br />
concetti come ricordo che. Così mi<br />
limito a <strong>di</strong>re Eco vede orso. Ug e Og<br />
credono ovviamente che abbia<br />
avvistato un altro orso, e si spaventano.<br />
Io cerco <strong>di</strong> rassicurarli:<br />
Orso non qui. Ma i due traggono<br />
solo la conclusione che faccio<br />
scherzi <strong>di</strong> pessimo gusto nel momento<br />
meno adatto. Io insisto:<br />
Orso uccide Ig. Ma gli altri mi rispondono:<br />
No, Ig morto! Insomma,<br />
dovrei desistere, e Ug sarebbe<br />
perduto.<br />
Ricorro allora a una interpretazione<br />
non verbale, bensì visiva.<br />
Dicendo Ig e orso mi batto con un<br />
<strong>di</strong>to sul capo, o sul cuore, o sul<br />
ventre (a seconda <strong>di</strong> dove presuma<br />
che essi collochino la memoria).<br />
Poi <strong>di</strong>segno sul terreno due fi gure,<br />
e le in<strong>di</strong>co come Ig e orso; alle<br />
spalle <strong>di</strong> Ig <strong>di</strong>segno immagini <strong>di</strong><br />
fasi lunari, sperando che essi capiscano<br />
che voglio <strong>di</strong>re “molte lune<br />
fa” e infi ne ri<strong>di</strong>segno l’orso che<br />
uccide Ig. Se provo è perché presumo<br />
che i miei interlocutori abbiano<br />
Nella pagina a<br />
fianco: per Henri<br />
Louis Bergson<br />
(1859-1941) al tempo<br />
metrico degli orologi<br />
si oppone il tempo<br />
della coscienza, la<br />
durata interiore.<br />
On the facing page:<br />
for Henri Louis<br />
Bergson (1859-1941)<br />
the metric time of<br />
clocks was opposed<br />
to the time of the<br />
conscience, the inner<br />
duration.<br />
Fototeca Gilar<strong>di</strong><br />
Forse il vero<br />
protagonista del<br />
viaggio straor<strong>di</strong>nario<br />
<strong>di</strong> Phileas Fogg è<br />
proprio il tempo,<br />
scan<strong>di</strong>to dal battito<br />
<strong>di</strong> orologi che<br />
segnano ore <strong>di</strong>verse<br />
nelle più <strong>di</strong>sparate<br />
zone geografiche<br />
del pianeta.<br />
Time is perhaps the<br />
real protagonist of<br />
the extraor<strong>di</strong>nary<br />
journey made by<br />
Phileas Fogg: marked<br />
by the ticking of the<br />
clocks showing<br />
<strong>di</strong>fferent times<br />
in the <strong>di</strong>fferent<br />
geographical areas.<br />
le nozioni del ricordare, e quelle <strong>di</strong><br />
presente, passato e futuro. Ma<br />
siccome debbo interpretare quelle<br />
nozioni visivamente, non so se per<br />
essi il futuro sia davanti o <strong>di</strong> <strong>di</strong>etro.<br />
Può darsi che la mia interpretazione<br />
risulti incomprensibile ai nativi.<br />
Se io pongo l’orso che uccide Ig a<br />
sinistra e per essi il passato sta a<br />
destra, la mia scommessa sarà<br />
perduta – e perduto sarà Ug.<br />
Ecco un caso interessante in<br />
cui passato, futuro, vita e morte<br />
<strong>di</strong>pendono da convenzioni semiotiche.<br />
E – si ba<strong>di</strong> bene – non c’è<br />
nulla nella mia concezione del<br />
passato e del futuro che mi possa<br />
<strong>di</strong>re come i miei interlocutori lo<br />
concepiscono spazialmente.<br />
Naturalmente uno scienziato<br />
potrebbe <strong>di</strong>rmi che questi sono<br />
incidenti dovuti alla varietà dei linguaggi,<br />
e che il mio imbarazzo (e<br />
quello <strong>di</strong> Og e Ug) non ha nulla a<br />
che fare con una concezione scientifi<br />
ca del tempo. Certamente non<br />
sto scrivendo per <strong>di</strong>re che le nostre<br />
concezioni ingenue, e i <strong>di</strong>fetti<br />
delle nostre lingue, possono incidere<br />
sulle concezioni scientifi che<br />
del tempo. Ho elaborato un rispetto<br />
quasi religioso per le concezioni<br />
scientifi che (e non ingenue) del<br />
tempo sin da quando ho letto The<br />
<strong>di</strong>rection of time <strong>di</strong> Reichenbach,<br />
secondo cui nell’universo della<br />
nostra esperienza esistono catene<br />
causali aperte (A causa B, B causa<br />
C, C causa D e così all’infi nito) ma<br />
si possono concepire catene causali<br />
chiuse (A causa B, B causa C<br />
e C causa A): in tali situazioni io<br />
potrei viaggiare nel passato, incontrare<br />
mia nonna ancora ragazza,<br />
sposarla, e <strong>di</strong>ventare nonno <strong>di</strong> me<br />
stesso.<br />
Queste cose non accadono<br />
nel mondo della nostra esperienza,<br />
ma certamente accadono nei<br />
romanzi <strong>di</strong> Science Fiction, e in<br />
tali casi noi lettori siamo obbligati<br />
a concepire tempi con catene causali<br />
chiuse, in cui dunque la freccia<br />
del tempo può invertire la propria<br />
<strong>di</strong>rezione. Come facciamo a pensare<br />
questi universi, come facciamo<br />
a immaginarceli, visto che <strong>di</strong><br />
fatto li immaginiamo, altrimenti<br />
non potremmo capire le storie che<br />
li riguardano?
Esaminiamo una situazione<br />
analoga a quella raccontata, per<br />
esempio, da fi lm come Ritorno al<br />
futuro. Sintetizzando la storia al<br />
massimo, si pensi a un personaggio,<br />
che chiameremo Tom1, il quale<br />
viaggia nel futuro dove arriva<br />
come Tom2 (un Tom <strong>di</strong> poche ore<br />
più anziano <strong>di</strong> Tom1, e che noi<br />
possiamo immaginare così come<br />
se Tom1 fosse partito da Parigi per<br />
arrivare come Tom2 a New York<br />
sette ore dopo). Ma a questo punto<br />
Tom2 viaggia all’in<strong>di</strong>etro nel<br />
tempo, e torna come Tom3 nel<br />
tempo <strong>di</strong> partenza poche ore prima<br />
<strong>di</strong> esserne partito. Tom3, arrivato<br />
nel passato, incontra Tom1<br />
proprio mentre stava per partire<br />
per il futuro. A questo punto Tom3<br />
decide <strong>di</strong> inseguire Tom1, torna nel<br />
futuro e (avendo una macchina<br />
temporale più potente) vi arriva<br />
come Tom4 pochi minuti prima<br />
che vi arrivi Tom1.<br />
Ci sono ottime ragioni per<br />
affermare che il lettore non riesca<br />
a concepire una situazione del<br />
genere. Invece accade che, nel<br />
racconto scritto, il Tom con cui il<br />
lettore si identifi ca (quello dal cui<br />
punto <strong>di</strong> vista sono guardati gli altri<br />
Tom) sia sempre quello con l’esponente<br />
più alto – e nella trasposizione<br />
cinematografi ca il Tom con cui<br />
lo spettatore si identifi ca è quello,<br />
per così <strong>di</strong>re, sulle cui spalle è<br />
collocata la camera. Insomma, in<br />
qualsiasi incontro tra TomX e<br />
TomX+1, chi <strong>di</strong>ce “io” (e chi guarda)<br />
è sempre TomX+1.<br />
Quin<strong>di</strong>, come già accadeva<br />
con le espressioni linguistiche citate<br />
prima – per cui nel linguaggio<br />
quoti<strong>di</strong>ano noi leghiamo il tempo<br />
alla nostra corporalità, e lo pensiamo<br />
vicino e <strong>di</strong>stante dal nostro<br />
corpo, legato insomma alla nostra<br />
coscienza – anche qui il tempo e i<br />
suoi paradossi sono percepiti dal<br />
punto <strong>di</strong> vista della nostra situazione<br />
corporale.<br />
Ma, a pensarci bene, a una<br />
situazione corporale erano legati<br />
tutti gli “orologi” <strong>di</strong> cui si è servita<br />
l’umanità prima dell’invenzione degli<br />
orologi meccanici: si misurava il<br />
tempo sul moto visibile degli astri<br />
e il “sorgere” o il “calare” del sole<br />
erano movimenti solo rispetto al<br />
nostro punto <strong>di</strong> vista (in effetti, al<br />
<strong>di</strong> fuori del nostro punto <strong>di</strong> vista,<br />
era la Terra a muoversi, ma non lo<br />
sapevamo e non ce ne importava<br />
nulla). Con l’avvento degli orologi si<br />
è cercato <strong>di</strong> rendere simili al nostro<br />
corpo anche quelle macchine<br />
non antropomorfe, dando loro dei<br />
tratti animaleschi. Il XVIII secolo ci<br />
offre una serie <strong>di</strong> belle poesie sugli<br />
orologi visti come mostri dai denti<br />
<strong>di</strong>grignanti, che masticano o sillabano<br />
i secon<strong>di</strong> che ci separano<br />
dalla morte – la nostra, non quella<br />
delle galassie. E basti citare questo<br />
terribile sonetto <strong>di</strong> Ciro <strong>di</strong> Pers:<br />
Fotolia<br />
Shutterstock<br />
Nobile or<strong>di</strong>gno <strong>di</strong> dentate rote<br />
lacera il giorno e lo <strong>di</strong>vide in ore,<br />
ed ha scritto <strong>di</strong> fuor con fosche note<br />
a chi legger le sa: SEMPRE SI MORE.<br />
Mentre il metallo concavo percuote,<br />
voce funesta mi risuona al core;<br />
né del fato spiegar meglio si puote<br />
che con voce <strong>di</strong> bronzo il rio tenore.<br />
Perch’io non speri mai riposo o pace,<br />
questo, che sembra in un timpano e tromba,<br />
mi sfi da ognor contro all’età vorace.<br />
E con que’ colpi onde ’l metal rimbomba,<br />
affretta il corso al secolo fugace,<br />
e perché s’apra, ognor picchia alla tomba.<br />
È pur vero che oggi non riusciamo<br />
più a pensare da un punto<br />
<strong>di</strong> vista umano (o almeno animale)<br />
un orologio atomico, e nemmeno<br />
quello del nostro computer, tuttavia<br />
non si deve temere. Non smetteremo<br />
mai <strong>di</strong> pensare il tempo dal<br />
punto <strong>di</strong> vista del nostro corpo.<br />
Dopotutto noi, che invecchiamo<br />
giorno per giorno, siamo l’orologio<br />
<strong>di</strong> noi stessi. Basta fare quattro<br />
fl essioni, scendere le scale <strong>di</strong> corsa,<br />
cercare <strong>di</strong> saltare una siepe, e<br />
ci accorgiamo che è passato tempo<br />
da quando avevamo vent’anni.<br />
Come siamo fortunati a essere<br />
animali mortali! Teniamo il tempo<br />
sotto controllo.<br />
Noi, figli della civiltà<br />
degli orologi,<br />
<strong>di</strong>mostriamo ancora<br />
<strong>di</strong> avere idee molto<br />
imprecise sulla<br />
misurazione del<br />
tempo.<br />
As children of<br />
the civilization of<br />
clocks, we show that<br />
we still have very<br />
inaccurate ideas on<br />
measuring time.<br />
TERZA PAGINA 9
Il Risorgimento e la Valtellina<br />
Appello <strong>di</strong> clero e liberali ai patrioti valtellinesi durante l’insurrezione<br />
contro gli austriaci nella primavera del ’48. A destra: Antonio Caimi,<br />
Ritratto <strong>di</strong> Antonio Maffei, olio su tela, 1847 (<strong>Sondrio</strong>, Museo valtellinese<br />
<strong>di</strong> storia e arte).<br />
Appeal by the clergy and liberals to the Valtellina patriots during the<br />
uprising against the Austrians in the spring of 1848. On the right:<br />
Antonio Caimi, Portrait of Antonio Maffei, oil on canvas, 1847 (<strong>Sondrio</strong>,<br />
Valtellina Museum of History and Art).<br />
La partecipazione dei valtellinesi e valchiavennaschi<br />
al Risorgimento fu attiva e corale e<br />
riguardò tutte le classi sociali. Essa non si limitò<br />
al solo territorio provinciale, ma si <strong>di</strong>spiegò<br />
sull’intero scenario nazionale con uomini<br />
come Luigi Torelli, Giovanni ed Emilio<br />
Visconti Venosta, Maurizio Quadrio e Ulisse<br />
Salis, esponenti delle due anime del Risorgimento,<br />
quella liberal-moderata e quella democratico-mazziniana,<br />
che nei momenti decisivi<br />
si ritrovarono insieme nel comune obiettivo<br />
dell’Unità d’Italia.<br />
10 ITALIA 150<br />
FRANCO MONTEFORTE<br />
Storico e giornalista<br />
Il clero liberale<br />
Nel 1852 l’arciprete <strong>di</strong> <strong>Sondrio</strong>,<br />
Antonio Maffei, organizzava il<br />
solenne trasporto delle spoglie del<br />
suo lontano predecessore, Nicolò<br />
Rusca, morto nel 1618 sotto tortura<br />
a Thusis per mano dei protestanti<br />
grigioni, dalla chiesa della<br />
Sassella, dove erano murate, nella<br />
Collegiata <strong>di</strong> <strong>Sondrio</strong>. In quella<br />
occasione, lo stesso Maffei pronunciava<br />
un <strong>di</strong>scorso in cui, esaltando<br />
la lotta del Rusca per la libertà<br />
religiosa dei cattolici valtellinesi<br />
nel ’600, fi niva per esaltare<br />
tutte le lotte per la libertà e l’in<strong>di</strong>pendenza.<br />
Nel clima patriottico <strong>di</strong><br />
quegli anni, la fi gura <strong>di</strong> Nicolò Rusca<br />
si trasfi gurava così in quella <strong>di</strong><br />
un eroe risorgimentale ante litteram<br />
e l’arciprete Maffei poneva il<br />
Risorgimento valtellinese sotto il<br />
segno della continuità con la battaglia<br />
combattuta dalla valle, nei<br />
secoli precedenti, contro il dominio<br />
straniero dei Grigioni, una battaglia<br />
che, alla fi ne del Settecento,<br />
nel clima della Lombar<strong>di</strong>a napoleonica,<br />
aveva visto il clero valtellinese<br />
mettersi alla testa del popolo<br />
assecondandone le aspirazioni <strong>di</strong><br />
libertà.<br />
E in effetti, una delle particolarità<br />
più clamorose del Risorgimento<br />
in Valtellina fu appunto<br />
l’orientamento liberale e fi lorisorgimentale<br />
del clero, in consonanza<br />
con quello <strong>di</strong> gran parte del clero<br />
lombardo e in aperto <strong>di</strong>ssenso<br />
con l’orientamento generale della<br />
Chiesa, che del Risorgimento fu<br />
acerrima avversaria, e con quello<br />
dello stesso vescovo <strong>di</strong> Como,<br />
monsignor Angelo Romanò, <strong>di</strong><br />
fronte al quale l’arciprete Maffei<br />
pronunziò nel 1852 il suo <strong>di</strong>scorso<br />
sulla libertà.<br />
Proprio all’arciprete Antonio<br />
Maffei dobbiamo quel Sommario<br />
delle vicende politiche della Valtellina<br />
dal marzo 1848 a tutto il 1859<br />
(<strong>Sondrio</strong>, Brughera ed Ar<strong>di</strong>zzi,<br />
1873) che costituisce una delle<br />
principali fonti storiche per la ricostruzione<br />
delle vicende risorgimentali<br />
in provincia <strong>di</strong> <strong>Sondrio</strong> e il documento<br />
più significativo <strong>di</strong><br />
quell’orientamento liberal-moderato<br />
del clero <strong>di</strong> cui il Maffei fu in<br />
Valtellina il capofi la riconosciuto.<br />
Non si contano, infatti, in Valtellina,<br />
i preti, i curati e i sottocurati<br />
delle più sperdute frazioni che appoggiarono<br />
allora il movimento<br />
patriottico. Fin dal ’48 in molte<br />
chiese valtellinesi si bene<strong>di</strong>rono le<br />
ban<strong>di</strong>ere italiane dei volontari che<br />
partivano e si cantava il Te Deum<br />
dopo ogni vittoria sugli austriaci.<br />
Don Martino Anzi, il celebre botanico<br />
bormino, don G. B. De Picchi,<br />
prevosto <strong>di</strong> Chiavenna, don Giuseppe<br />
Rizzetti, prevosto <strong>di</strong> Ardenno,<br />
don Tommaso Valenti a Bormio,<br />
il canonico Giuseppe Salis a<br />
Tirano, non sono che i primi nomi<br />
che vengono in mente <strong>di</strong> questi<br />
preti liberali in Valtellina. Nel 1861,<br />
all’indomani dell’Unità, su 298<br />
ecclesiastici presenti in Valtellina<br />
Cortesia MVSA <strong>Sondrio</strong> - Foto Pollini
solo tre verranno segnalati nei<br />
rapporti della Prefettura per le loro<br />
posizioni intransigenti contro il<br />
nuovo Stato unitario.<br />
Fu grazie a questo orientamento,<br />
d’altronde, se, come ha<br />
notato Giulio Spini, il mondo conta<strong>di</strong>no<br />
valtellinese non fu ostile,<br />
come in Meri<strong>di</strong>one, al moto risorgimentale,<br />
ma vi partecipò anzi attivamente<br />
come <strong>di</strong>mostra il numero<br />
dei combattenti valtellinesi nelle<br />
guerre d’in<strong>di</strong>pendenza, che si aggirò<br />
tra i quattro e i cinquemila uomini,<br />
quasi tutti volontari.<br />
L’Irlanda d’Italia<br />
Del resto la Valtellina non<br />
aveva certo <strong>di</strong> che essere sod<strong>di</strong>sfatta<br />
del governo lombardo-veneto.<br />
Le strade dello Stelvio, dello<br />
Spluga e dell’Aprica, fatte essenzialmente<br />
per motivi militari, non<br />
avevano per nulla incrementato il<br />
traffi co commerciale della provincia.<br />
I comuni, obbligati a far fronte<br />
a proprie spese a quasi tutti i servizi,<br />
compresi quelli della manutenzione<br />
delle strade, erano carichi <strong>di</strong><br />
debiti cui cercavano <strong>di</strong> far fronte<br />
con la ven<strong>di</strong>ta dei boschi dove da<br />
secoli gli abitanti esercitavano<br />
quegli usi civici (legnatico, raccolta<br />
<strong>di</strong> frutti selvatici, allevamento del<br />
maiale, ecc.) che erano un potente<br />
integratore economico del magro<br />
bilancio della famiglia conta<strong>di</strong>na.<br />
La privatizzazione dei boschi aveva,<br />
a sua volta, favorito il forte <strong>di</strong>boscamento<br />
che era all’origine<br />
delle frequenti alluvioni, mentre le<br />
opere <strong>di</strong> sistemazione idraulica del<br />
corso dell’Adda sul fondovalle era-<br />
no procedute con esasperante<br />
lentezza, come del resto tutta la<br />
macchina amministrativa del governo<br />
lombardo-veneto, che mirava<br />
più all’or<strong>di</strong>ne pubblico e al controllo<br />
sociale che allo sviluppo del<br />
territorio.<br />
Tutte le inchieste condotte<br />
dopo il 1830, dalla Topografi a statistico-me<strong>di</strong>ca<br />
della Valtellina<br />
(1834) del dottor Lodovico Balar<strong>di</strong>ni,<br />
regio me<strong>di</strong>co provinciale, alla<br />
Descrizione statistica della provincia<br />
<strong>di</strong> Valtellina (1835) <strong>di</strong> Pietro<br />
Rebuschini, alle Notizie statistiche<br />
sulla Valtellina (1844) <strong>di</strong> Francesco<br />
Visconti Venosta, alle Osservazioni<br />
sulla con<strong>di</strong>zione presente della Valtellina<br />
(1845) <strong>di</strong> Luigi Torelli, ne<br />
avevano messo in risalto l’endemica<br />
povertà e il desolante sottosviluppo<br />
che aveva nel gozzo e nel<br />
cretinismo la sua piaga più evidente.<br />
Ma nel 1859, alla vigilia del<br />
The Risorgimento and Valtellina<br />
The inhabitants of Valtellina and Valchiavenna actively participated in the Risorgimento,<br />
and involved all social classes and the clergy as well, guided by <strong>Sondrio</strong> archpriest Antonio<br />
Maffei who, compare to the rest of Italy, was liberal and pro-Unitarist. The patriotic<br />
de<strong>di</strong>cation of the people of Valtellina was not limited solely to the provincial territory and<br />
the Stelvio and del Tonale fronts. In fact, it covered the entire national scenario with men of<br />
the likes of Luigi Torelli, Giovanni and Emilio Visconti Venosta, Maurizio Quadrio and Ulisse<br />
Salis, exponents of the two sides of the Risorgimento, the liberal-moderate side and the<br />
democratic-Mazzinian side which, in the decisive moments, were reunited with the mutual<br />
objective of uniting Italy. Starting in 1860, the new provincial establishment, together with<br />
the reconstruction of the farming economy, concentrated on creating a modern scholastic<br />
system and a solid fabric of cultural structures with the foundation, in <strong>Sondrio</strong> and<br />
Chiavenna, with newspapers, libraries and workers companies. 1871, ten years after the<br />
Unification, marked the foun<strong>di</strong>ng of the <strong>Banca</strong> <strong>Popolare</strong> <strong>di</strong> <strong>Sondrio</strong>,<br />
the expression of the valley’s economic revival.<br />
Biglietto della<br />
“Lotteria pei poveri<br />
<strong>di</strong> Valtellina”,<br />
promossa nel 1858<br />
dal Governo del<br />
Lombardo-Veneto per<br />
venire incontro allo<br />
stato <strong>di</strong> in<strong>di</strong>genza<br />
della valle.<br />
Ticket of the<br />
“Lottery for the poor<br />
of Valtellina”, held by<br />
the Government of<br />
Lombardy-Veneto<br />
in 1858 to help the<br />
state of need in<br />
the valley.<br />
NOTIZIARIO<br />
Italia 150<br />
crollo del Lombardo-Veneto, la situazione<br />
<strong>di</strong> in<strong>di</strong>genza della provincia,<br />
conosciuta per la sua povertà<br />
in tutt’Europa come “l’Irlanda d’Italia”,<br />
era <strong>di</strong>ventata talmente preoccupante<br />
da indurre il governo austriaco<br />
a in<strong>di</strong>re una “Lotteria dei<br />
poveri <strong>di</strong> Valtellina” e a promuovere<br />
due gran<strong>di</strong> inchieste, una affi data<br />
a Stefano Jacini (che la pubblicherà<br />
nel 1858 a proprie spese),<br />
Sulle con<strong>di</strong>zioni economiche della<br />
Provincia <strong>di</strong> <strong>Sondrio</strong>, e l’altra, rimasta<br />
ine<strong>di</strong>ta, condotta da Diego<br />
Guicciar<strong>di</strong>, nipote e omonimo del<br />
più famoso Guicciar<strong>di</strong> morto nel<br />
1837. In entrambe le inchieste si<br />
in<strong>di</strong>cavano rime<strong>di</strong> ra<strong>di</strong>cali per alleviare<br />
il peso del fi sco, stimolare il
commercio e migliorare la<br />
con<strong>di</strong>zione dei conta<strong>di</strong>ni,<br />
che restava quella più<br />
drammatica, insieme a<br />
provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> carattere<br />
apertamente liberale, come<br />
quelli reclamati nel corso<br />
<strong>di</strong> tutto il Risorgimento,<br />
rime<strong>di</strong> che avrebbero richiesto<br />
un governo ben più<br />
in<strong>di</strong>pendente e risoluto <strong>di</strong><br />
quello allora inse<strong>di</strong>ato a<br />
Milano. Le due inchieste<br />
erano state volute da Massimiliano<br />
I, fratello dell’imperatore<br />
Francesco Giuseppe, che<br />
nel 1857 era stato nominato viceré<br />
del Lombardo-Veneto, in sostituzione<br />
del maresciallo Radetzky,<br />
nel <strong>di</strong>sperato tentativo <strong>di</strong> arginare<br />
il movimento risorgimentale. Ma<br />
alla fama <strong>di</strong> liberale e <strong>di</strong> progressista,<br />
Massimiliano I univa, purtroppo,<br />
un carattere debole e velleitario<br />
che nel 1859, dopo il trattato<br />
<strong>di</strong> Villafranca che ne provocò la<br />
destituzione e il congedo da Milano,<br />
lo portò ad accettare la corona<br />
imperiale del Messico; dove qualche<br />
anno dopo, malgrado le riforme<br />
liberali attuate, verrà fucilato,<br />
suscitando una forte ondata <strong>di</strong><br />
emozione in Europa, <strong>di</strong> cui il celebre<br />
quadro <strong>di</strong> Manet sulla sua<br />
esecuzione e la marcia funebre <strong>di</strong><br />
Liszt inserita nei suoi Années de<br />
pèlerinage, non sono che le testimonianze<br />
più note.<br />
Ma nel 1859 non era più il<br />
governo austriaco che poteva determinare<br />
il futuro della Valtellina,<br />
perché questa, proprio quell’anno,<br />
insieme a tutta la Lombar<strong>di</strong>a si<br />
univa al Piemonte e da lì a poco<br />
sarebbe entrata a far parte dell’Italia<br />
unita, per cui si era battuta fi n<br />
dal 1848.<br />
Le aspirazioni patriottiche<br />
<strong>di</strong> una nuova classe <strong>di</strong>rigente<br />
Sarebbe però sicuramente<br />
fuorviante cercare i motivi dell’adesione<br />
della Valtellina al moto<br />
risorgimentale solo nelle sue con<strong>di</strong>zioni<br />
economico-sociali durante<br />
il Lombardo-Veneto, separate dalle<br />
più generali aspirazioni <strong>di</strong> libertà<br />
e <strong>di</strong> in<strong>di</strong>pendenza che animarono<br />
gran parte <strong>di</strong> quegli esponenti<br />
giovani e meno giovani della nobil-<br />
12 ITALIA 150<br />
Pio IX. Le speranze<br />
suscitate tra i<br />
patrioti italiani dalla<br />
sua elezione nel<br />
1846 e l’appoggio<br />
inizialmente dato<br />
all’insurrezione del<br />
’48 furono decisivi<br />
per l’orientamento<br />
filorisorgimentale del<br />
clero valtellinese.<br />
Pius IX. The hopes<br />
raised amongst the<br />
Italian patriots by his<br />
election in 1846 and<br />
the support initially<br />
given to the 1848<br />
uprising were<br />
decisive for the<br />
pro-Risorgimento<br />
orientation of the<br />
Valtellina clergy.<br />
tà e della borghesia terriera<br />
e commerciale locale, quei<br />
me<strong>di</strong>ci, giuristi, avvocati e<br />
uomini <strong>di</strong> scienza – Luigi Torelli,<br />
Maurizio Quadrio, Romualdo<br />
Bonfa<strong>di</strong>ni, Francesco<br />
ed Enrico Guicciar<strong>di</strong>, Giovanni<br />
e Emilio Visconti Venosta,<br />
Ulisse e Giovanni Salis, Carlo<br />
ed Enrico Sertoli, Aristide e<br />
Pietro Caimi, Giacomo Merizzi,<br />
ecc. – formatisi nelle università<br />
<strong>di</strong> Pavia, <strong>di</strong> Padova o<br />
ad<strong>di</strong>rittura, come nel caso <strong>di</strong><br />
Torelli, Caimi e Giacomo Merizzi,<br />
al Teresianum <strong>di</strong> Vienna, ma<br />
vissuti poi negli ambienti liberali <strong>di</strong><br />
Milano o, come Maurizio Quadrio,<br />
in giro per l’Europa a stretto contatto<br />
con le idee <strong>di</strong> libertà e <strong>di</strong> in<strong>di</strong>pendenza<br />
che ovunque vi si respiravano.<br />
Erano uomini animati da forti<br />
aspirazioni ideali e ambizioni<br />
personali e molti <strong>di</strong> essi, durante<br />
e dopo il Risorgimento, avrebbero<br />
avuto un ruolo importante nella<br />
società e nella politica italiana,<br />
ma tutti rimasero sempre ben<br />
ra<strong>di</strong>cati nel tessuto provinciale<br />
che ne costituì il costante punto<br />
<strong>di</strong> riferimento.<br />
Torelli, ad esempio, non riuscendo<br />
a sopportare il lavoro <strong>di</strong><br />
funzionario pubblico del governo<br />
austriaco, fi n dal 1836 aveva preferito<br />
tornare a vivere a Tirano,<br />
dove nel 1846 scriverà i Pensieri<br />
sull’Italia <strong>di</strong> un anonimo lombardo<br />
– ripubblicati nel 1853 col proprio<br />
nome – con cui si inserisce nel<br />
<strong>di</strong>battito sull’unità nazionale sulla<br />
scia dell’idea federalista.<br />
Maurizio Quadrio, allievo <strong>di</strong> G.<br />
Domenico Romagnosi a Pavia,<br />
dopo aver partecipato ai moti del<br />
1820-21 nel Napoletano e in Piemonte<br />
e combattuto per le libertà<br />
costituzionali in Spagna e in Polonia<br />
nel 1831, era fuggito in Crimea<br />
dove aveva insegnato lingue straniere<br />
a Odessa, ma nel 1835 era<br />
tornato in Italia e, scontati i sei<br />
mesi <strong>di</strong> prigione in cui gli era stata<br />
commutata la pena capitale, si era<br />
stabilito nella sua casa <strong>di</strong> Chiuro,<br />
sorvegliato a vista dalla polizia<br />
austriaca. Sia Torelli sia Maurizio<br />
Quadrio si <strong>di</strong>stingueranno in Valtellina<br />
per l’opera <strong>di</strong> infaticabile aiuto<br />
che svolgeranno nell’epidemia <strong>di</strong><br />
colera del 1836, guadagnandosi a<br />
Tirano e a Chiuro una grande popolarità<br />
che, nel caso <strong>di</strong> Maurizio<br />
Quadrio lo porterà a tenere a battesimo,<br />
tra il 1836 e il 1848, ben<br />
34 bambini, tutti fi gli <strong>di</strong> conta<strong>di</strong>ni,<br />
falegnami, muratori, fabbri e calzolai,<br />
come si ricava dai Registri<br />
parrocchiali <strong>di</strong> Chiuro.<br />
Anche nei più giovani valtellinesi<br />
allora studenti a Milano, come<br />
i fratelli Giovanni ed Emilio Visconti<br />
Venosta, un tale ra<strong>di</strong>camento<br />
nella realtà popolare della provincia<br />
è in quegli anni altrettanto<br />
sentito.<br />
Come narra Giovanni Visconti<br />
Venosta nei suoi Ricor<strong>di</strong> <strong>di</strong> gioventù<br />
(Milano, Tipografi a E<strong>di</strong>trice L. F.<br />
Cogliati, 1904), ancora nel ’47<br />
essi trascorrevano i loro mesi <strong>di</strong><br />
vacanza scolastica in Valtellina,<br />
girando per la valle insieme agli<br />
amici milanesi e valtellinesi «fermandoci<br />
in tutti i paesi e paeselli<br />
che si attraversavano, entrando<br />
nei casolari dei conta<strong>di</strong>ni, conversando,<br />
spiegando all’ingrosso la<br />
quistione italiana, e <strong>di</strong>stribuendo a<br />
profusione certe medaglie con<br />
l’effi gie <strong>di</strong> Pio IX e col motto viva<br />
l’Italia. Poi, se nessuno ci vedeva,<br />
armati <strong>di</strong> un pezzo <strong>di</strong> carbone si<br />
scriveva su qualche muro: viva<br />
l’Italia, viva Pio IX».<br />
Appena eletto nel 1846 al<br />
soglio pontifi cio, papa Mastai Ferretti,<br />
già noto per le sue idee liberali,<br />
aveva, infatti, promulgato per<br />
prima cosa l’amnistia per i reati<br />
politici e acceso in tutta Italia le<br />
speranze che avevano portato Gioberti<br />
a teorizzare quella federazione<br />
italiana <strong>di</strong> Stati sotto la presidenza<br />
del papa, passata alla storia<br />
col nome <strong>di</strong> neoguelfi smo, cui<br />
molti liberal-moderati, compreso<br />
Torelli, credettero fi no dal 1859 e<br />
che costituì anche la base dell’adesione<br />
del clero valtellinese al moto<br />
risorgimentale.<br />
Il 1848 e la libera Repubblica<br />
<strong>di</strong> Stelvio e Tonale<br />
E così, grazie al clero e all’azione<br />
<strong>di</strong> questi intellettuali e<br />
notabili, tutti esponenti dell’aristocrazia<br />
possidente locale, il malcontento<br />
verso l’Austria si era venuto
lentamente colorando anche in<br />
Valtellina delle idealità proprie<br />
dell’età risorgimentale.<br />
Non c’è da meravigliarsi, perciò,<br />
se il 18 marzo 1848, alla notizia<br />
dell’insurrezione milanese<br />
delle Cinque giornate, anche la<br />
Valtellina insorgeva schierandosi<br />
subito a fi anco del governo provvisorio<br />
costituitosi sotto la presidenza<br />
<strong>di</strong> Gabrio Casati. Già la mattina<br />
del 19 marzo, a Chiavenna, Francesco<br />
Dolzino e i suoi amici <strong>di</strong>sarmavano<br />
i gendarmi austriaci e la<br />
guar<strong>di</strong>a doganale con l’appoggio<br />
della folla che quella sera stessa<br />
dava vita a una grande festa popolare.<br />
A <strong>Sondrio</strong> il podestà G. B.<br />
Botterini de’ Pelosi costituiva imme<strong>di</strong>atamente<br />
la guar<strong>di</strong>a civica,<br />
<strong>di</strong>venuta poi guar<strong>di</strong>a nazionale,<br />
nelle cui mani si consegnava la<br />
polizia austriaca. A Morbegno i<br />
250 uomini della nuova guar<strong>di</strong>a<br />
civica avevano in breve tempo ragione<br />
del reggimento austriaco del<br />
capitano Prosch. A Tirano Giuseppe<br />
Guicciar<strong>di</strong> già il 21 marzo formava<br />
una sorta <strong>di</strong> governo provvisorio.<br />
E mentre sullo Stelvio, a <strong>di</strong>fesa<br />
del confi ne con l’Austria, cominciavano<br />
ad affl uire volontari da<br />
ogni angolo della Valtellina e della<br />
Lombar<strong>di</strong>a, a Milano un’altra fetta<br />
Cortesia MVSA, <strong>Sondrio</strong> - Foto Pollini<br />
On the left: Antonio<br />
Caimi, Portrait of<br />
Luigi Torelli, oil on<br />
canvas, 1848<br />
(<strong>Sondrio</strong>, Valtellina<br />
Museum of History<br />
and Art).<br />
On the right: Carlo<br />
Bossoli, Luigi Torelli<br />
raises the tricolour<br />
on the Duomo of<br />
Milan, watercolour.<br />
The episode was<br />
reconstructed by<br />
Torelli in his Memoirs<br />
around the Five Days<br />
of Milan (Milan,<br />
Hoepli, 1876).<br />
Antonio Caimi,<br />
Ritratto <strong>di</strong> Francesco<br />
Guicciar<strong>di</strong>, olio su<br />
tela (<strong>Sondrio</strong> Museo<br />
valtellinese <strong>di</strong> storia<br />
e arte).<br />
Antonio Caimi,<br />
Portrait of Francesco<br />
Guicciar<strong>di</strong>, oil on<br />
canvas (<strong>Sondrio</strong>,<br />
Valtellina Museum<br />
of History and Art).<br />
A sinistra: Antonio<br />
Caimi, Ritratto <strong>di</strong><br />
Luigi Torelli, olio su<br />
tela, 1848 (<strong>Sondrio</strong>,<br />
Museo valtellinese <strong>di</strong><br />
storia e arte).<br />
A destra: Carlo<br />
Bossoli, Luigi Torelli<br />
alza il tricolore sul<br />
duomo <strong>di</strong> Milano,<br />
acquerello. L’episo<strong>di</strong>o<br />
è stato ricostruito<br />
dallo stesso Torelli<br />
nei suoi Ricor<strong>di</strong><br />
intorno alle cinque<br />
giornate <strong>di</strong> Milano<br />
(Milano, Hoepli,<br />
1876).<br />
<strong>di</strong> Valtellina si batteva sulle barricate.<br />
Qui c’era Luigi Torelli, capo<br />
del Consiglio <strong>di</strong> guerra citta<strong>di</strong>no,<br />
che si conquistava il suo quarto<br />
d’ora <strong>di</strong> celebrità issando il tricolore<br />
sul pinnacolo più alto del Duomo,<br />
e c’erano Maurizio Quadrio, i<br />
due fratelli Visconti Venosta, Romualdo<br />
Bonfa<strong>di</strong>ni, Ulisse Salis,<br />
Enrico Guicciar<strong>di</strong>, il giovanissimo<br />
tiranese (aveva solo un<strong>di</strong>ci anni)<br />
Pietro Pievani insieme ai fratelli,<br />
Giuseppe Parravicini De Picchi e<br />
Foto Pollini<br />
Stefano Parravicini <strong>di</strong> Morbegno,<br />
che a Milano <strong>di</strong>venterà capitano<br />
della guar<strong>di</strong>a nazionale. Presto<br />
sarebbero arrivati anche i cento<br />
chiavennaschi <strong>di</strong> Francesco Dolzino,<br />
posti <strong>di</strong> stanza a Erba a presi<strong>di</strong>are<br />
il versante brianzolo del capoluogo<br />
lombardo. La Valtellina<br />
entrava così nell’orbita della sollevazione<br />
lombarda contro gli austriaci<br />
e al plebiscito del 29 maggio,<br />
svoltosi contemporaneamente<br />
in tutta la Lombar<strong>di</strong>a, votava l’annessione<br />
al Piemonte con soli tre<br />
voti contrari su 20.186 votanti. Il<br />
sondriese Azzo Carbonera veniva<br />
perciò chiamato a far parte del<br />
Governo provvisorio lombardo in<br />
rappresentanza della provincia,<br />
mentre Francesco Guicciar<strong>di</strong> veniva<br />
nominato presidente della nuova<br />
Congregazione provinciale e<br />
Maurizio Quadrio <strong>di</strong>ventava commissario<br />
per la <strong>di</strong>fesa militare della<br />
linea Stelvio-Tonale, che Ulisse<br />
Salis si era per primo incaricato <strong>di</strong><br />
organizzare.<br />
Abolita la censura austriaca,<br />
nasceva in quei giorni, ad opera <strong>di</strong><br />
Francesco Romegialli, Vincenzo<br />
Quadrio e Giuseppe Pedrazzini, il<br />
primo giornale locale, Il Libero Valtellinese,<br />
un settimanale il cui ricavato<br />
fu destinato alle famiglie dei<br />
ITALIA 150 13
volontari dello Stelvio. Sullo Stelvio,<br />
dopo i primi successi contro gli<br />
austriaci, ai primi <strong>di</strong> luglio c’erano<br />
già 750 volontari valtellinesi, ma<br />
ad agosto tra Stelvio e Tonale i<br />
valtellinesi erano circa 1.600 sul<br />
totale dei circa 3.500 uomini <strong>di</strong> cui<br />
si componevano i due corpi d’ar-<br />
14 ITALIA 150<br />
mata agli or<strong>di</strong>ni del generale D’Apice.<br />
Ma più aumentavano i volontari<br />
più crescevano la <strong>di</strong>sorganizzazione<br />
e l’improvvisazione della<br />
macchina militare che in quei mesi<br />
precipitava nel caos, malgrado gli<br />
sforzi del Torelli che avrebbe dovuto<br />
sovrintendervi. Dopo le speran-<br />
IL PITTORE DEL<br />
RISORGIMENTO VALTELLINESE<br />
È forse esagerato defi nire Antonio Caimi (1811-78) il pittore del<br />
Risorgimento valtellinese e certamente egli stesso avrebbe rifi utato una<br />
simile etichetta, sia perché non si conosce nessuna sua <strong>di</strong>retta partecipazione<br />
alle vicende risorgimentali, sia perché dai suoi scritti non<br />
traspare alcuna convinzione su queste vicende.<br />
Egli, piuttosto, «la sua politica non la fece che con l’arte» come<br />
<strong>di</strong>sse Camillo Boito nella commemorazione funebre dell’artista. E dunque<br />
nella sua arte vanno ricercate le sue convinzioni. Non tanto nei<br />
soggetti religiosi e negli affreschi, <strong>di</strong> cui rimangono molte testimonianze<br />
in Valtellina, ma che non sono certo le sue cose migliori, quanto nei<br />
suoi ritratti, in cui, senza brillare per originalità, egli ci dà però uno<br />
spaccato della classe <strong>di</strong>rigente valtellinese <strong>di</strong> metà ’800, con quel suo<br />
castigato romanticismo in cui affi ora una certa vicinanza all’Hayez, <strong>di</strong><br />
cui fu ammiratore e amico e che gli de<strong>di</strong>cò un ritratto, rimasto incompiuto,<br />
e un’incisione.<br />
Tra i suoi ritratti spiccano quelli <strong>di</strong> alcuni dei maggiori protagonisti<br />
del Risorgimento valtellinese, come Luigi Torelli, Francesco Guicciar<strong>di</strong>,<br />
che fu nel ’48 il presidente della Congregazione provinciale inse<strong>di</strong>ato<br />
dal Governo provvisorio <strong>di</strong> Lombar<strong>di</strong>a dopo la cacciata <strong>di</strong> Radetzky, G.<br />
B. Botterini de’ Pelosi, podestà <strong>di</strong> <strong>Sondrio</strong> nel ’48 e organizzatore della<br />
prima guar<strong>di</strong>a nazionale, e l’arciprete Antonio Maffei, capofi la del clero<br />
fi lorisorgimentale e cronista del Risorgimento valtellinese, che con Caimi<br />
con<strong>di</strong>videva la comune passione artistica avendo anch’egli stu<strong>di</strong>ato<br />
pittura all’Accademia <strong>di</strong> Brera. Non manca, peraltro, anche il ritratto <strong>di</strong><br />
una donna, Teresa Calvi, moglie del conte e patriota mazziniano Ulisse<br />
Salis, esposto nella bella mostra allestita, in occasione del 150° dell’Unità,<br />
al Palazzo Salis <strong>di</strong> Tirano (Una famiglia nella storia: i Salis Zizers<br />
dal 1797 all’Unità d’Italia). Come ha scritto Valerio Della Ferrera, che <strong>di</strong><br />
Caimi è il maggiore stu<strong>di</strong>oso, «questi ritratti interessano per l’importanza<br />
storica dei personaggi [...] che si pongono alla guida della lotta risorgimentale<br />
in Valtellina» e «si collegano in un’ideale celebrazione <strong>di</strong><br />
questo momento <strong>di</strong> lotta politica e più precisamente <strong>di</strong> una linea moderata<br />
nello schieramento risorgimentale. E poiché il ritratto attesta solitamente,<br />
al <strong>di</strong> là della semplice commissione, un rapporto <strong>di</strong>retto <strong>di</strong> amicizia,<br />
o <strong>di</strong> conoscenza e <strong>di</strong> stima tra il pittore e l’effi giato, possono fare<br />
luce sulle convinzioni politiche del Caimi». (V. Della Ferrera, Antonio<br />
Caimi 1811/1878. L’arte del ritratto, cat. della mostra <strong>di</strong> <strong>Sondrio</strong>, Bergamo,<br />
Bolis E<strong>di</strong>zioni, 1996)». Il pittore sondriese, insomma, fu partecipe<br />
in qualche modo con la propria arte del moderatismo liberal-patriottico<br />
risorgimentale valtellinese, come sembrerebbe anche confermare Camillo<br />
Boito per il quale Caimi «amava ogni libertà giu<strong>di</strong>ziosa, ma non si<br />
sentiva inclinato ai chiassi delle <strong>di</strong>scussioni pubbliche, né alle febbri<br />
dell’azione violenta». E certo questo suo orientamento non dovette essere<br />
estraneo alla nomina nel 1860 a segretario dell’Accademia <strong>di</strong> Brera,<br />
una carica che fi no al 1854 era stata <strong>di</strong> un altro artista sondriese, Pietro<br />
Martire Rusconi, che <strong>di</strong> Caimi era lo zio. Fu in qualità <strong>di</strong> segretario <strong>di</strong><br />
Brera che Caimi scrisse nel 1862, in occasione dell’Esposizione <strong>di</strong> Londra,<br />
la sua opera più importante, Delle arti del <strong>di</strong>segno e degli artisti<br />
nelle province della Lombar<strong>di</strong>a dal 1777 al 1862.<br />
F. Hayez, Ritratto <strong>di</strong><br />
A. Caimi, olio su<br />
tela, 1877<br />
(collezione privata<br />
Cortese, <strong>Sondrio</strong>).<br />
F. Hayez, Portrait<br />
of A. Caimi, oil on<br />
canvas, 1877 (the<br />
Cortese private<br />
collection, <strong>Sondrio</strong>).<br />
ze suscitate dalla vittoria <strong>di</strong> Carlo<br />
Alberto a Pastrengo e dalla caduta<br />
<strong>di</strong> Peschiera con cui si era aperta<br />
la Prima guerra d’In<strong>di</strong>pendenza, il<br />
confl itto con l’Austria si era arenato<br />
nel lento tallonamento delle<br />
truppe <strong>di</strong> Radetzky che a giugno<br />
riuscivano a passare all’offensiva<br />
e a battere i piemontesi a<br />
Custoza e a Milano, costringendo<br />
Carlo Alberto<br />
alla resa. Il 9 agosto con<br />
la fi rma dell’armistizio <strong>di</strong><br />
Salasco, la guerra era<br />
perduta. Abbandonati da<br />
mesi a se stessi e privi <strong>di</strong><br />
rifornimenti i 3.500 volontari<br />
sullo Stelvio e sul Tonale<br />
si erano venuti così<br />
a trovare improvvisamente<br />
stretti nella morsa delle<br />
truppe austriache che avanzavano<br />
contemporaneamente dal Tirolo<br />
e da Colico dove erano giunte<br />
l’11 agosto. Anziché arrendersi,<br />
Maurizio Quadrio e il generale<br />
D’Apice avevano risposto proclamando,<br />
a Tirano, la Repubblica <strong>di</strong><br />
Stelvio e Tonale, «strana ed arrischiatissima<br />
risoluzione» scrive il<br />
Maffei, presa in segno <strong>di</strong> sfi da a<br />
Carlo Alberto e alla monarchia<br />
piemontese che aveva tra<strong>di</strong>to le<br />
speranze della Lombar<strong>di</strong>a.<br />
Resisteranno fi no al 21 agosto,<br />
poi, nella stanchezza e nello<br />
scoramento generale, «la questione<br />
della pulenta prevalse a quella<br />
dell’onore» scrisse il generale<br />
D’Apice. E così «i volontari D’Apice,<br />
che da quattro mesi <strong>di</strong>fendevano i<br />
varchi alpestri onde scendono l’Adda<br />
e l’A<strong>di</strong>ge, ebbero a <strong>di</strong>sperdersi<br />
per manco <strong>di</strong> vestimenta e <strong>di</strong> pane»,<br />
notava amaramente Carlo<br />
Cattaneo nella sua ricostruzio ne<br />
storica degli avvenimenti <strong>di</strong><br />
quell’anno (Dell’insurrezione <strong>di</strong> Milano<br />
nel 1848 e della successiva<br />
guerra, Bruxelles, 1849).<br />
Collezione privata Cortese, <strong>Sondrio</strong> - Foto Pollini<br />
La Repubblica <strong>di</strong> Chiavenna<br />
e la battaglia <strong>di</strong> Verceia<br />
Quadrio e D’Apice, attraverso<br />
Poschiavo, ripareranno in Svizzera,<br />
raggiungendo infi ne Lugano dove<br />
era giunto anche Francesco Dolzino<br />
e dove, insieme a Mazzini e al<br />
generale Me<strong>di</strong>ci, braccio destro <strong>di</strong><br />
Garibal<strong>di</strong>, ritesseranno una nuova,
ar<strong>di</strong>ta quanto velleitaria tela insurrezionale<br />
tra la Val d’Intelvi, la<br />
Valchiavenna, la Valtellina e le<br />
valli bergamasche. Sia Emilio Visconti<br />
Venosta – allora fervente<br />
mazziniano, che dopo la liberazione<br />
<strong>di</strong> Milano aveva seguito Garibal<strong>di</strong><br />
a Bergamo per ritrovarsi qualche<br />
mese dopo anch’egli lacero, affamato<br />
e febbricitante in una stalla<br />
<strong>di</strong> Lugano – sia Enrico Guicciar<strong>di</strong>,<br />
dopo aver tastato il polso degli<br />
umori popolari, si erano rifi utati <strong>di</strong><br />
partecipare a quell’impresa che si<br />
sarebbe esaurita nel nulla senza<br />
l’intraprendenza e l’audacia <strong>di</strong><br />
Francesco Dolzino.<br />
Rioccupata Chiavenna con<br />
una ventina <strong>di</strong> volontari, Dolzino vi<br />
aveva proclamato subito la repubblica.<br />
La sua popolarità era allora<br />
altissima nella citta<strong>di</strong>na, <strong>di</strong> cui era<br />
stato sindaco durante i mesi esaltanti<br />
della rivoluzione lombarda, e<br />
la sua stessa, imponente fi gura<br />
fi sica era una leggenda per i giovani<br />
che lo vedevano girare per le vie<br />
sul suo nero, grande cavallo. Non<br />
fece dunque fatica a radunare subito<br />
attorno a sé un piccolo battaglione<br />
e nell’ottobre del ’48, con<br />
200 uomini e un fi nto cannone,<br />
nella vana attesa dei rinforzi valtellinesi<br />
e dell’insurrezione delle valli<br />
comasche e bergamasche, tenne<br />
testa per una settimana agli 800<br />
croati del generale Haynau. Solo<br />
grazie a un tra<strong>di</strong>tore questi poté<br />
aver ragione <strong>di</strong> quell’audacissima<br />
resistenza che il generale austriaco<br />
fece pagare cara all’infame<br />
Chiavenna con una durissima taglia<br />
<strong>di</strong> 36 mila lire, cui si accompagnò<br />
la confi sca dei beni del Dolzino,<br />
fi glio <strong>di</strong> agiati commercianti, e<br />
della sua casa trasformata in caserma.<br />
L’episo<strong>di</strong>o <strong>di</strong> Verceia – cantato<br />
anche da Carducci e ricostrui to<br />
nel 1896 da Carlo Pedretti nel suo<br />
A destra dall’alto:<br />
Emilio Visconti<br />
Venosta (1829-1914).<br />
Giovanni Visconti<br />
Venosta (1831-1906).<br />
Maurizio Quadrio<br />
(1800-76).<br />
Decreto del Governo<br />
provvisorio della<br />
Lombar<strong>di</strong>a del 7<br />
luglio 1848 con cui<br />
Maurizio Quadrio<br />
viene nominato<br />
Commissario<br />
governativo per la<br />
Valtellina (<strong>Sondrio</strong>,<br />
Biblioteca civica Pio<br />
Rajna).<br />
Decree of the<br />
Provisional<br />
government of<br />
Lombardy of 7th July<br />
1848 which<br />
appointed Maurizio<br />
Quadrio Government<br />
Commissioner for the<br />
Valtellina (<strong>Sondrio</strong>,<br />
Pio Rajna Civic<br />
Library).<br />
ITALIA 150 15
scritto su Gli avvenimenti <strong>di</strong> Chiavenna<br />
del 1848 (in: Ferruccio Pedretti,<br />
Ricor<strong>di</strong> chiavennaschi, Chiavenna,<br />
Giovanni Ogna, 1929) – è<br />
giustamente una delle pagine più<br />
celebri e controverse <strong>di</strong> tutto il Risorgimento<br />
valtellinese. L’arciprete<br />
Maffei, ad esempio, lo giu<strong>di</strong>cò subito<br />
una «sciagurata impresa condotta<br />
con soverchia fi ducia e precipitazione»<br />
e Giovanni Visconti<br />
Venosta, nei suoi Ricor<strong>di</strong> <strong>di</strong> gioventù,<br />
lo liquidò come frutto <strong>di</strong> un<br />
gruppo <strong>di</strong> «avventati e illusi», mentre<br />
G. B. Crollalanza nella sua<br />
Storia del contado <strong>di</strong> Chiavenna<br />
(1867) e Ulrico Martinelli, che nel<br />
1899 ne riesumò il ricordo, ne<br />
esaltarono il signifi cato. Più recentemente<br />
Luigi Festorazzi lo ha defi<br />
nito «un moto <strong>di</strong> popolo», mentre<br />
Giulio Spini nella sua Storia della<br />
Valtellina, pur ritenendolo un episo<strong>di</strong>o<br />
«improvviso e temerario sul<br />
piano militare e politico» lo giu<strong>di</strong>ca<br />
comunque «un fatto idealmente<br />
positivo, che arricchì la partecipazione<br />
del Chiavennasco al Risorgimento,<br />
integrando il panorama<br />
moderato provinciale con una idealistica<br />
impennata mazziniana» (E.<br />
Mazzali, G. Spini, Storia della Valtellina,<br />
vol. III, <strong>Sondrio</strong>, Bissoni,<br />
1979).<br />
È vero che nel ’48 in Valtellina,<br />
come nel resto d’Italia e in<br />
Europa, tutti i tentativi insurrezionali,<br />
comprese le due effi mere repubbliche<br />
mazziniane, si erano<br />
conclusi con una sconfi tta, ma è<br />
16 ITALIA 150<br />
Il Libero valtellinese,<br />
il settimanale <strong>di</strong> cui<br />
uscirono solo quattro<br />
numeri tra il 10<br />
luglio e il 4 agosto<br />
del 1848.<br />
Le pubblicazioni<br />
cessarono con il<br />
ritorno degli austriaci<br />
a Milano il 7 agosto<br />
<strong>di</strong> quell’anno<br />
(<strong>Sondrio</strong>, Biblioteca<br />
civica Pio Rajna).<br />
Il Libero valtellinese,<br />
the weekly of which<br />
only four issues were<br />
published between<br />
10th July and 4th<br />
August, 1848.<br />
Publication ceased<br />
with the return of the<br />
Austrians to Milan on<br />
7th August of the<br />
same year<br />
(<strong>Sondrio</strong>, Pio Rajna<br />
Civic Library).<br />
Sebastiano<br />
De Albertis, Carica<br />
<strong>di</strong> carabinieri nella<br />
battaglia <strong>di</strong><br />
Pastrengo, tempera<br />
e puntasecca su tela<br />
(collezione <strong>Banca</strong><br />
<strong>Popolare</strong> <strong>di</strong> <strong>Sondrio</strong>).<br />
Sebastiano De<br />
Albertis, Charge of<br />
the carabinieri at the<br />
Battle of Pastrengo,<br />
tempera and dry<br />
point engraving on<br />
canvas (<strong>Banca</strong><br />
<strong>Popolare</strong> <strong>di</strong> <strong>Sondrio</strong><br />
collection).<br />
anche vero che proprio grazie alla<br />
ra<strong>di</strong>calità <strong>di</strong> quei moti rivoluzionari<br />
si capì che da quel momento in<br />
Europa nulla avrebbe più potuto<br />
essere come prima. Del resto,<br />
anche la guerra condotta dal Piemonte<br />
e l’organizzazione militare<br />
del governo provvisorio lombardo<br />
dopo le Cinque giornate erano<br />
state, a <strong>di</strong>r poco, un <strong>di</strong>sastro.<br />
Al <strong>di</strong> là del giu<strong>di</strong>zio storico,<br />
resta comunque il fatto che fra<br />
l’agosto e l’ottobre del ’48, con i<br />
coraggiosi tentativi <strong>di</strong> Maurizio<br />
Quadrio e <strong>di</strong> Francesco Dolzino, si<br />
consumava anche in Valtellina la<br />
frattura tra i democratico-repubblicani,<br />
fedeli a Mazzini e alla sua<br />
incon<strong>di</strong>zionata fi ducia nel popolo<br />
come protagonista dell’in<strong>di</strong>pen-<br />
denza italiana, e i liberal-moderati<br />
che vedevano nella monarchia piemontese<br />
l’unica forza su cui far<br />
leva per liberare l’Italia dagli austriaci,<br />
premessa militare <strong>di</strong> ogni<br />
<strong>di</strong>scorso sull’Unità.<br />
I primi si concentreranno soprattutto<br />
a Chiavenna, dove il mito<br />
<strong>di</strong> Francesco Dolzino continuerà<br />
ad alimentare, anche dopo l’Unità,<br />
le aspirazioni democratico-repubblicane<br />
all’autogoverno e a una<br />
maggiore giustizia sociale, i secon<strong>di</strong><br />
domineranno soprattutto la scena<br />
politica a <strong>Sondrio</strong> e in Valtellina<br />
e avranno in Luigi Torelli, in Aristide<br />
e Pietro Caimi, nell’arciprete Maffei<br />
e, quin<strong>di</strong>, in Guicciar<strong>di</strong> e nei<br />
fratelli Visconti Venosta i loro maggiori<br />
esponenti.<br />
Foto Pollini
QUANTI FURONO I COMBATTENTI<br />
VALTELLINESI E VALCHIAVENNASCHI<br />
NEL RISORGIMENTO?<br />
Diverse fonti hanno cercato <strong>di</strong> calcolare il numero dei valtellinesi<br />
che parteciparono alle <strong>di</strong>verse campagne militari per l’in<strong>di</strong>pendenza<br />
italiana tra il 1848 e il 1866, ma una cifra esatta è ancora oggi impossibile<br />
stabilirla.<br />
Un primo, approssimativo quadro numerico e nominativo ce lo<br />
fornisce l’Elenco degli in<strong>di</strong>vidui della Provincia <strong>di</strong> <strong>Sondrio</strong> che fecero<br />
parte della Campagne Nazionali dal 1848 in avanti, pre<strong>di</strong>sposto nel<br />
1885 e pubblicato nel 1960 dalla Società storica valtellinese nel suo<br />
Bollettino, in occasione del centenario della spe<strong>di</strong>zione dei Mille. Vi si<br />
trovano 2.353 nomi <strong>di</strong>visi per comune, con le date delle campagne cui<br />
parteciparono. Ma quanto è atten<strong>di</strong>bile questo elenco? Poco, molto<br />
poco. Vi mancano, ad esempio, molti nomi da noi ricordati in questo<br />
saggio, fra cui quelli <strong>di</strong> Carlo Pedretti, <strong>di</strong> Antonio Pescialli, <strong>di</strong> Nicola<br />
Mevio, <strong>di</strong> Antonio Cederna o <strong>di</strong> Antonio Pievani che sicuramente presero<br />
parte alla spe<strong>di</strong>zione dei Mille. Se si scorrono poi le pagine del<br />
Sommario delle vicende politiche della Valtellina dal marzo 1848 a<br />
tutto il 1859 del Maffei, salta subito all’occhio che parecchi nomi mancano<br />
ancora all’appello. L’Elenco del 1885, in realtà, sembra più atten<strong>di</strong>bile<br />
per la campagna del 1866 (oltre 2.100 combattenti) che per<br />
quelle più lontane del ’59 e soprattutto del ’48-49. Lo <strong>di</strong>mostra la scrupolosa<br />
ricostruzione fatta nel 1899 da Luigi Credaro nel suo saggio su<br />
I veterani valtellinesi del ’48-49, pubblicato nel volume collettivo Peregrinazioni<br />
(Milano, Tip. Confalonieri, 1899, pp. 136-170). Sulla base<br />
delle fonti militari, Credaro ha calcolato che alla data del 9 luglio 1848<br />
i valtellinesi presenti sullo Stelvio erano circa 750, ma che un mese<br />
dopo, tra volontari e bersaglieri, il loro numero era salito a 1.110 sullo<br />
Stelvio e a 500 volontari sul Tonale, in tutto 1.610 combattenti. Ad essi<br />
vanno aggiunti anche i 430/450 bersaglieri valtellinesi che combatterono<br />
nel ’49 a Novara nella compagnia guidata da Enrico Guicciar<strong>di</strong>, che<br />
portano a oltre duemila i combattenti nel solo ’48-49, un numero ben<br />
<strong>di</strong>verso da quello prospettato dall’Elenco del 1885 dove i combattenti<br />
del ’48-49 sono circa 320. Se uniamo gli oltre 2.100 valtellinesi del ’59-66,<br />
ai 2.000 circa del ’48-49 e ai garibal<strong>di</strong>ni della spe<strong>di</strong>zione dei Mille, otteniamo<br />
una cifra <strong>di</strong> circa 4.200 combattenti.<br />
Ma in quale elenco troveremmo mai il chirurgo <strong>di</strong> Morbegno<br />
Carlo Cotta (ve<strong>di</strong> scheda Un me<strong>di</strong>co valtellinese a Solferino), me<strong>di</strong>co<br />
militare a Magenta e a Solferino, che fu in Italia tra i pionieri della<br />
Croce Rossa internazionale? O Pietro Mossini <strong>di</strong> Grosotto, un altro<br />
me<strong>di</strong>co militare che morì in Crimea al seguito del battaglione piemontese<br />
inviatovi da Cavour? O il giovane Paolo Mariani <strong>di</strong> Morbegno,<br />
morto coi volontari lombar<strong>di</strong> <strong>di</strong> Luciano Manara nella <strong>di</strong>fesa della Repubblica<br />
romana del ’49? O i nomi dei cento e cento valchiavennaschi<br />
che seguirono Francesco Dolzino a Milano durante le Cinque giornate<br />
e gli furono poi accanto a Verceia? Senza contare i coscritti regolari che<br />
nel solo ’48 furono in Valtellina 584.<br />
Ci sembra corretto, perciò, ipotizzare un numero approssimativo<br />
fi nale <strong>di</strong> non meno 5.000 combattenti valtellinesi nel corso del Risorgimento.<br />
Una cifra molto alta per una provincia che al primo censimento<br />
dopo l’Unità, nel 1861, contava 106.040 abitanti, <strong>di</strong> cui 52.855 maschi<br />
che, escludendo i 17.655 fi no a 15 anni, si riducono a 35.200 compresi<br />
gli anziani. Ciò vuol <strong>di</strong>re che, insieme ai fi gli dell’aristocrazia agraria<br />
e della borghesia commerciale locale, anche molti giovani conta<strong>di</strong>ni<br />
parteciparono alle campagne militari del Risorgimento, malgrado queste<br />
si svolgessero proprio nei mesi estivi e autunnali dove si concentravano<br />
quasi tutti i lavori agricoli. Sono poche, insomma, le famiglie<br />
valtellinesi che non possano vantare tra i propri antenati un combattente<br />
per l’Unità d’Italia nel Risorgimento.<br />
A sinistra: Giuseppe<br />
Mazzini (1805-72).<br />
A destra: Camillo<br />
Benso conte <strong>di</strong><br />
Cavour (1810-61).<br />
On the left: Giuseppe<br />
Mazzini (1805-72).<br />
On the right: Camillo<br />
Benso, Count of<br />
Cavour (1810-61).<br />
I valtellinesi nel Risorgimento<br />
nazionale dopo il ’48-49<br />
Ma intanto alla fi ne del ’48 il<br />
sipario risorgimentale calava mestamente<br />
sullo scenario valtellinese<br />
e per molti dei suoi protagonisti<br />
esso si riapriva su quello nazionale.<br />
Luigi Torelli, cui era toccato<br />
l’amaro compito <strong>di</strong> scrivere e <strong>di</strong><br />
leggere ai milanesi il proclama <strong>di</strong><br />
resa <strong>di</strong> Carlo Alberto, inseguito dal<br />
mandato <strong>di</strong> cattura austriaco, si<br />
era rifugiato in Piemonte, dove era<br />
entrato nel Parlamento subalpino<br />
<strong>di</strong>ventando anche ministro dell’Agricoltura<br />
e del Commercio. Fautore<br />
<strong>di</strong> una politica estera più me<strong>di</strong>terranea<br />
da parte del Piemonte,<br />
nel 1854 entrerà nella <strong>di</strong>rezione<br />
del Comitato per il Canale <strong>di</strong> Suez,<br />
grazie all’amicizia con l’impren<strong>di</strong>tore<br />
e <strong>di</strong>plomatico francese Fer<strong>di</strong>nand<br />
de Lesseps, concessionario<br />
dei lavori per la sua costruzione.<br />
Enrico Guicciar<strong>di</strong>, che era stato<br />
fi no all’ultimo a fi anco <strong>di</strong> Maurizio<br />
Quadrio nell’eroica <strong>di</strong>fesa dello<br />
Stelvio e del Tonale, fuggendo attraverso<br />
Poschiavo, aveva anch’egli<br />
trovato riparo in Piemonte, dove<br />
nel gennaio del 1849, in vista<br />
della ripresa delle ostilità contro<br />
l’Austria, era stato nominato capitano<br />
dell’esercito regolare. In questa<br />
veste prenderà parte nel marzo<br />
del 1849 alla battaglia <strong>di</strong> Novara<br />
al comando <strong>di</strong> un battaglione <strong>di</strong><br />
430 volontari valtellinesi, tutti<br />
quelli che era riuscito a raccogliere<br />
dopo la <strong>di</strong>sastrosa avventura dello<br />
Stelvio, inquadrati nella brigata<br />
Solaroli, in cui ritroviamo come<br />
capo <strong>di</strong> stato maggiore Luigi Torelli.<br />
Un terzo <strong>di</strong> quei volontari valtellinesi<br />
resterà sul campo <strong>di</strong> batta-<br />
ITALIA 150 17<br />
Fototeca Gilar<strong>di</strong>
glia <strong>di</strong> Novara in quel 23 marzo<br />
1849 che vide la sconfi tta defi nitiva<br />
dell’esercito piemontese e l’ab<strong>di</strong>cazione<br />
<strong>di</strong> Carlo Alberto a favore<br />
<strong>di</strong> Vittorio Emanuele II.<br />
Maurizio Quadrio, che a Lugano<br />
si era strettamente legato a<br />
Mazzini, aveva poi seguito<br />
quest’ultimo a Roma. Qui Pio IX,<br />
dopo aver partecipato accanto al<br />
Piemonte alla Prima guerra d’in<strong>di</strong>pendenza,<br />
all’indomani della<br />
sconfi tta <strong>di</strong> Custoza aveva ritirato<br />
le truppe pontifi cie e cominciato a<br />
prendere le <strong>di</strong>stanze dalla causa<br />
italiana. Per sedare eventuali <strong>di</strong>sor<strong>di</strong>ni<br />
aveva, tuttavia, nominato<br />
alla guida del governo pontifi cio<br />
Pellegrino Rossi, aperto alle istanze<br />
patriottiche e liberali. Ma dopo<br />
l’assassinio <strong>di</strong> quest’ultimo nel<br />
novembre del ’48, il papa era fuggito<br />
da Roma rifugiandosi nella<br />
fortezza <strong>di</strong> Gaeta. I liberali, <strong>di</strong>chiarandolo<br />
decaduto dal potere temporale,<br />
avevano allora proclamato<br />
la Repubblica romana in soccorso<br />
della quale, dopo la battaglia <strong>di</strong><br />
Novara, erano subito accorsi Garibal<strong>di</strong><br />
e Mazzini. Eletto deputato <strong>di</strong><br />
Ferrara, Mazzini, insieme ad Aurelio<br />
Saffi , deputato <strong>di</strong> Forlì, e Carlo<br />
Armellini, deputato <strong>di</strong> Roma, aveva<br />
quin<strong>di</strong> dato vita al Triumvirato,<br />
<strong>di</strong> cui Maurizio Quadrio era stato<br />
nominato segretario.<br />
La Repubblica romana, che<br />
nel ’49 si era data la Costituzione<br />
più democratica d’Europa in cui si<br />
garantiva l’autorità spirituale del<br />
papa, fi niva, com’è noto, nel luglio<br />
del ’49 soffocata dalle armi francesi,<br />
dopo una <strong>di</strong>sperata <strong>di</strong>fesa in cui<br />
persero la vita più <strong>di</strong> 3.000 volontari,<br />
tra cui, a soli 21 anni, Goffredo<br />
Mameli, che nel ’47 aveva composto<br />
Fratelli d’Italia, e il giovanissimo<br />
valtellinese Paolo Mariani <strong>di</strong><br />
Morbegno, al seguito del battaglione<br />
lombardo <strong>di</strong> Luciano Manara.<br />
Abbandonata Roma, il Quadrio<br />
riprendeva con Mazzini la sua<br />
vita randagia <strong>di</strong> cospirazione che<br />
lo porterà prima in Svizzera, poi a<br />
Londra, quin<strong>di</strong> ancora a Losanna<br />
(dove salvò Mazzini da un attentato)<br />
e infi ne in Italia dove, a partire<br />
dal 1855, si <strong>di</strong>ede a un’intensa,<br />
quanto ricercatissima attività giornalistica,<br />
fondando anche due<br />
18 ITALIA 150<br />
Lettera <strong>di</strong> Giuseppe<br />
Mazzini al popolo <strong>di</strong><br />
Chiavenna spe<strong>di</strong>ta a<br />
Francesco Dolzino<br />
nell’ottobre del ’48<br />
durante i giorni della<br />
Repubblica <strong>di</strong><br />
Chiavenna.<br />
Letter from Giuseppe<br />
Mazzini to the people<br />
of Chiavenna sent to<br />
Francesco Dolzino in<br />
October 1848 during<br />
the days of the<br />
Republic of<br />
Chiavenna.<br />
giornali Dio e Popolo e Pensiero e<br />
Azione.<br />
Meno cosmopolita <strong>di</strong> Quadrio<br />
e più ostinatamente legato alla<br />
sua <strong>di</strong>mensione chiavennasca,<br />
Francesco Dolzino, dopo la sfortunata<br />
impresa <strong>di</strong> Verceia, si era rifugiato<br />
in Svizzera da dove, ai primi<br />
sentori <strong>di</strong> ripresa della guerra contro<br />
l’Austria nel marzo del 1849,<br />
era rientrato in Valtellina attraverso<br />
la Bregaglia, tentando la sollevazione<br />
<strong>di</strong> Morbegno e poi <strong>di</strong> <strong>Sondrio</strong>,<br />
nel quadro <strong>di</strong> un più vasto<br />
piano insurrezionale mazziniano<br />
che vedrà le contemporanee rivolte<br />
<strong>di</strong> Como e <strong>di</strong> Brescia. Quest’ultima<br />
resisterà <strong>di</strong>eci giorni, dal 23<br />
marzo al 1° aprile, meritandosi il<br />
titolo <strong>di</strong> “Leonessa d’Italia”, prima<br />
<strong>di</strong> arrendersi alla ferocia del generale<br />
Haynau, la “iena <strong>di</strong> Brescia”.<br />
Ma la Valtellina non era Brescia e<br />
l’in<strong>di</strong>fferenza, se non l’ostilità, con<br />
cui venne allora accolto Francesco<br />
Dolzino lo costrinsero a rientrare<br />
precipitosamente in Svizzera. Deluso,<br />
si trasferì defi nitivamente a<br />
Genova, patria del mazzinianesimo,<br />
dove visse povero lavorando<br />
come portuale e dove morì <strong>di</strong> colera<br />
nel 1855.<br />
1849-1859:<br />
il decennio <strong>di</strong> preparazione<br />
Con la caduta della Repubblica<br />
romana comincia in Italia quel<br />
“decennio <strong>di</strong> preparazione” in cui i<br />
liberal-moderati, sotto la guida <strong>di</strong><br />
Cavour, puntano tutto sull’azione<br />
politico-<strong>di</strong>plomatica internazionale<br />
attorno alla causa italiana, mentre<br />
Mazzini dalla Svizzera non cessa<br />
<strong>di</strong> contare sulla sollevazione popolare<br />
a colpi <strong>di</strong> tentativi insurrezionali.<br />
La frontiera con la Svizzera,<br />
che fi n dal ’48 si era rivelata provvidenziale<br />
per i patrioti italiani, <strong>di</strong>ventava<br />
in quegli anni un caso internazionale<br />
in Europa. L’Austria<br />
accusava la Confederazione <strong>di</strong><br />
essere la sentina <strong>di</strong> tutti i rivoluzionari<br />
europei e ne minacciava l’invasione.<br />
Radetzky espelleva dalla<br />
Lombar<strong>di</strong>a i ticinesi che vi lavoravano,<br />
chiudendo le frontiere nel<br />
tentativo <strong>di</strong> forzare la mano alle<br />
autorità elvetiche sull’espulsione<br />
dei rifugiati italiani. Per allentare la<br />
tensione le autorità <strong>di</strong> Berna avevano<br />
concentrato tutti i rifugiati<br />
politici in luoghi lontani dalle frontiere,<br />
ma quella misura non era<br />
valsa a fermare Mazzini che, all’inizio<br />
del ’53, tornava a or<strong>di</strong>re un’insurrezione<br />
a Milano, fi nita con decine<br />
<strong>di</strong> arresti e una stretta repressiva<br />
e poliziesca in cui rientrarono<br />
anche la confi sca in Valtellina dei<br />
beni <strong>di</strong> tutti i rifugiati in Piemonte,<br />
fra cui Filippo Caimi, Gerolamo<br />
Guicciar<strong>di</strong>, Bernardo Parravicini e<br />
Luigi Torelli.<br />
Maturava in quegli anni anche<br />
la svolta moderata <strong>di</strong> Emilio<br />
Visconti Venosta e il suo defi nitivo<br />
<strong>di</strong>stacco da Mazzini. Questi, dopo<br />
il fallimento dell’insurrezione milanese<br />
del 6 febbraio 1853, era<br />
tornato a immaginare un altro piano<br />
insurrezionale che prevedeva la<br />
<strong>di</strong>scesa su Milano attraverso le<br />
valli alpine, alla cui potenzialità rivoluzionaria<br />
Mazzini e Quadrio non<br />
smetteranno mai <strong>di</strong> credere. Aveva<br />
quin<strong>di</strong> inviato una lettera a Emilio<br />
Visconti Venosta pregandolo <strong>di</strong><br />
assumersene il comando, ma questi<br />
gli aveva risposto declinando<br />
l’invito e <strong>di</strong>segnando uno scenario<br />
della situazione europea e <strong>di</strong> quella<br />
dei partiti italiani in cui <strong>di</strong>mostra-
va come, dopo l’ondata rivoluzionaria<br />
degli anni precedenti, conveniva<br />
ora tentare per via <strong>di</strong>plomatica<br />
<strong>di</strong> impe<strong>di</strong>re all’Austria <strong>di</strong><br />
go vernare in attesa <strong>di</strong> un nuovo<br />
risveglio rivoluzionario che non sarebbe<br />
mancato. A 24 anni Emilio<br />
Visconti Venosta, lavorando a<br />
stretto contatto con Cavour <strong>di</strong> cui<br />
sposerà una parente, Maria Luisa<br />
Alfi eri <strong>di</strong> Sostegno, ragionava già<br />
con la mentalità del ministro degli<br />
Esteri, che presto sarebbe <strong>di</strong>ventato.<br />
Il conte Ulisse Salis<br />
Venuto meno l’appoggio <strong>di</strong><br />
Visconti Venosta, Mazzini, stabilitosi<br />
a Torino in casa del patriota<br />
dalmata Mirkovic, aveva allora<br />
affi dato il suo piano a Pietro Fortunato<br />
Calvi, che nel ’48 aveva<br />
guidato con successo l’insurrezione<br />
in Cadore. Calvi avrebbe dovuto<br />
raggiungere il Cadore attraverso<br />
la Valtellina, Bormio e il Trentino,<br />
avvalendosi, in caso <strong>di</strong> necessità,<br />
dell’appoggio <strong>di</strong> tre<br />
mazziniani valtellinesi, il conte<br />
Ulisse Salis <strong>di</strong> Tirano, e due bormini,<br />
Antonio Zanetti e Gervaso<br />
Stoppani per i quali gli aveva dato<br />
lettere <strong>di</strong> presentazione. I Salis<br />
Zizers <strong>di</strong> Tirano, ramo valtellinese<br />
<strong>di</strong> una delle più antiche e ramifi -<br />
cate famiglie aristocratiche d’Europa<br />
<strong>di</strong> origine grigione, erano<br />
stati fi n dagli anni ’40 fi lorisorgimentali<br />
e mazziniani.<br />
Dopo aver combattuto nel<br />
’48 a Milano e sullo Stelvio, insieme<br />
al fratello Giovanni, l’ingegnere<br />
Ulisse Salis, stretto amico dei Visconti<br />
Venosta e <strong>di</strong> Maurizio Quadrio,<br />
era stato dapprima esule in<br />
Piemonte e in Toscana, ma alla fi -<br />
ne del ’49 era rientrato a Tirano<br />
dove aveva assecondato i progetti<br />
insurrezionali <strong>di</strong> Mazzini, frenando<br />
quelli più azzardati, come aveva<br />
fatto all’inizio del ’53, quando aveva<br />
tenuto fuori la Valtellina dall’insurrezione<br />
<strong>di</strong> Milano. Alpinista,<br />
cacciatore, «d’aspetto bello e virile»<br />
e «dal carattere risoluto e deciso»,<br />
come lo descrive Giovanni Visconti<br />
Venosta, Ulisse Salis era il<br />
tipo del perfetto cospiratore. Come<br />
narra egli stesso nelle sue<br />
Memorie (ristampate nel 1955 sul<br />
n. 9 del “Bollettino della Società<br />
storica valtellinese”), «io era provvisto<br />
<strong>di</strong> una chiave che apriva uno<br />
scrittoio del Commissario <strong>di</strong> Tirano,<br />
ove la notte io ispezionava la<br />
corrispondenza della polizia segreta<br />
per essere al corrente delle sue<br />
trame». È, appunto, in una <strong>di</strong> queste<br />
furtive ispezioni che il Salis<br />
scopre come la polizia fosse a<br />
conoscenza del piano del Calvi,<br />
grazie a una spia, una donna<br />
amante del Mirkovic nella cui casa<br />
torinese era stato <strong>di</strong>scusso il piano.<br />
Ma quando era riuscito ad avvertire<br />
della trappola il Quadrio,<br />
Calvi era già stato arrestato con le<br />
tre lettere in tasca che porteranno<br />
all’arresto del Salis e degli altri due<br />
valtellinesi. Tra<strong>di</strong>to da uno <strong>di</strong> questi,<br />
lo Zanetti, Ulisse Salis sarà<br />
processato a Mantova e rinchiuso<br />
nella fortezza austriaca <strong>di</strong> Kufstein,<br />
al confi ne con la Germania, da cui<br />
sarebbe uscito nel 1857 grazie a<br />
un’amnistia. Dopo l’Unità <strong>di</strong>venterà<br />
ingegnere capo a Milano.<br />
Il 1859 e i Cacciatori delle Alpi<br />
Era stato questo l’ultimo,<br />
clamoroso episo<strong>di</strong>o cospiratorio<br />
in Valtellina prima della Seconda<br />
guerra <strong>di</strong> in<strong>di</strong>pendenza nell’aprile<br />
del 1859, che vide Napoleone III<br />
accanto al Piemonte in cambio<br />
della promessa <strong>di</strong> Nizza e della<br />
Savoia. In vista della guerra, Cavour<br />
aveva incaricato Garibal<strong>di</strong> <strong>di</strong><br />
organizzare i Cacciatori delle Alpi<br />
per favorire l’arruolamento dei<br />
Ambrogio Correnti,<br />
Il conte Ulisse Salis in<br />
prigione a Mantova,<br />
acquerello su carta,<br />
1854 (Tirano, coll.<br />
conti Sertoli Salis).<br />
Il Correnti fu<br />
compagno <strong>di</strong> prigionia<br />
del Salis durante il<br />
processo <strong>di</strong> Mantova.<br />
A sinistra: frontespizio<br />
delle Memorie <strong>di</strong> Ulisse<br />
Salis pubblicate nel<br />
1910 a cura della<br />
figlia, la contessa Rita<br />
Sertoli Salis (Tirano,<br />
coll. conti Sertoli<br />
Salis).<br />
Ambrogio Correnti,<br />
Count Ulisse Salis in<br />
prison in Mantua,<br />
watercolour on paper,<br />
1854 (Tirano, coll. of<br />
the Sertoli Salis<br />
counts). Correnti was a<br />
fellow prisoner of Salis<br />
during the Mantua<br />
trial. On the left:<br />
frontispiece of the<br />
Memoirs of Ulisse<br />
Salis published in 1910<br />
by his daughter,<br />
Countess Rita Sertoli<br />
Salis (Tirano, coll. of<br />
the Sertoli Salis<br />
counts).<br />
fuorusciti dal Lombardo-Veneto,<br />
ma gli aveva messo al fi anco come<br />
commissario politico Emilio<br />
Visconti Venosta. Insieme, Garibal<strong>di</strong><br />
e Visconti Venosta incontreranno<br />
a Como i rappresentanti<br />
della Valtellina per spingerli a insorgere,<br />
avvertendoli che, almeno<br />
per i primi tempi, avrebbero<br />
dovuto cavarsela da soli. E così il<br />
29 maggio la Valtellina insorgeva,<br />
ma l’insurrezione si fermava alle<br />
porte <strong>di</strong> Bormio. L’Alta Valtellina<br />
rimaneva, infatti, saldamente nelle<br />
mani degli austriaci e né l’arrivo<br />
<strong>di</strong> Giovanni Visconti Venosta,<br />
come commissario straor<strong>di</strong>nario<br />
alla guida del battaglione <strong>di</strong> volontari<br />
valtellinesi, né quello successivo<br />
<strong>di</strong> Enrico Guicciar<strong>di</strong> come<br />
prefetto, riusciranno a scalzarli e<br />
a sbloccare la situazione <strong>di</strong> stallo<br />
militare. Anche dopo l’arrivo <strong>di</strong><br />
Garibal<strong>di</strong> e del generale Me<strong>di</strong>ci<br />
con un migliaio <strong>di</strong> Cacciatori delle<br />
Alpi non si sarebbe andati oltre<br />
l’occupazione <strong>di</strong> Bormio. Solo<br />
l’armistizio <strong>di</strong> Villafranca il 12 luglio,<br />
dopo le vittorie <strong>di</strong> Solferino e<br />
San Martino, riuscirà a far sloggiare<br />
gli austriaci dai Bagni e<br />
dallo Stelvio.<br />
ITALIA 150 19
Non è dunque sul piano militare<br />
che va ricercato il rilievo storico<br />
<strong>di</strong> quanto avvenne in Valtellina<br />
nell’estate del ’59, quanto nel fatto<br />
che, in quei mesi, moderati e<br />
mazziniani, <strong>di</strong>visi nei mezzi e negli<br />
obiettivi per tutto il lungo decennio<br />
<strong>di</strong> preparazione, si ritrovavano nuovamente<br />
uniti ai pie<strong>di</strong> dello Stelvio<br />
e dell’Aprica nella comune battaglia<br />
contro gli austriaci.<br />
L’opera <strong>di</strong> Torelli, <strong>di</strong> Guicciar<strong>di</strong>,<br />
dei due Visconti Venosta e degli<br />
altri liberal-moderati rifugiati in<br />
Piemonte, era riuscita a preparare<br />
le con<strong>di</strong>zioni politiche per la ripresa<br />
della guerra contro l’Austria, ma<br />
i seguaci <strong>di</strong> Mazzini, nel loro ostinato<br />
idealismo, avevano mantenuto<br />
vivi nell’opinione pubblica gli<br />
ideali che ora tornavano a scaldare<br />
i cuori <strong>di</strong> tutti. Dopo la dura<br />
Carlo Pedretti (1836-1909) (Foto Francesco<br />
Prevosti).<br />
20 ITALIA 150<br />
sconfi tta del ’48, scrisse Ulisse<br />
Salis nelle sue Memorie, «sola in<br />
mezzo a tanto accasciamento sorgeva<br />
la ban<strong>di</strong>era <strong>di</strong> Mazzini, che<br />
pareva l’unica àncora <strong>di</strong> salvezza,<br />
l’unica via che potesse condurre<br />
alla meta agognata; e così pure<br />
nella Valtellina, si sperò in quella<br />
ban<strong>di</strong>era e le fi le sparpagliate si<br />
riunirono nel concetto <strong>di</strong> Mazzini e<br />
gli animi cominciarono a confortarsi<br />
ritenendo tutto non ancora perduto».<br />
Si doveva anche a questo<br />
se nel ’59 in Valtellina tornavano a<br />
ripetersi le scene della rivoluzione<br />
del ’48.<br />
A Chiavenna Carlo Pedretti,<br />
raccogliendo l’ere<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> Dolzino,<br />
all’inizio della guerra aveva <strong>di</strong>sarmato<br />
la gendarmeria austriaca e<br />
con decine <strong>di</strong> volontari era corso<br />
sul fronte dello Stelvio. Come nel<br />
’48 a decine arriveranno da ogni<br />
parte della valle i volontari per i<br />
quali però, ancora una volta, sarebbero<br />
mancate armi e <strong>di</strong>vise. E<br />
dovranno perciò essere rispolverate<br />
– e non basteranno – le vecchie<br />
carabine del ’48 che, dopo la ritirata<br />
dallo Stelvio, Ulisse Salis e il<br />
fratello prete Giuseppe avevano<br />
prudentemente raccolto e sistemato<br />
in alcune casse custo<strong>di</strong>te in<br />
tutti quegli anni dalle suore agostiniane<br />
del convento <strong>di</strong> Poschiavo,<br />
insieme al cannone austriaco che<br />
avevano sotterrato in un proprio<br />
campo.<br />
Ma, rispetto al ’48, ciò che<br />
maggiormente colpiva nel ’59 era<br />
il clima <strong>di</strong> entusiasmo popolare<br />
Autografo <strong>di</strong><br />
Garibal<strong>di</strong> nella<br />
campagna militare<br />
del 1859.<br />
In basso: manifesto<br />
con cui Emilio<br />
Visconti Venosta,<br />
Commissario regio<br />
straor<strong>di</strong>nario, rende<br />
pubblica nel 1859 la<br />
nomina del fratello<br />
Giovanni Visconti<br />
Venosta a proprio<br />
rappresentante per<br />
la provincia <strong>di</strong><br />
<strong>Sondrio</strong> (Archivio<br />
storico del Comune<br />
<strong>di</strong> <strong>Sondrio</strong>).<br />
Autograph of<br />
Garibal<strong>di</strong> in the<br />
military campaign<br />
of 1859.<br />
Below: the bill with<br />
which Emilio Visconti<br />
Venosta,<br />
Extraor<strong>di</strong>nary Royal<br />
Commissioner,<br />
announced, in 1859,<br />
the appointment<br />
of his brother<br />
Giovanni Visconti<br />
Venosta as his<br />
representative for the<br />
province of <strong>Sondrio</strong><br />
(<strong>Sondrio</strong>, Municipal<br />
archives).<br />
che ovunque accoglieva volontari<br />
e piemontesi. «Da per tutto – racconta<br />
Giovanni Visconti Venosta<br />
– si trovava gente in festa che ci<br />
veniva incontro con ban<strong>di</strong>ere, musiche,<br />
coi municipi e coi curati alla<br />
testa, i quali erano pressoché tutti<br />
patrioti». Il compassato colonnello<br />
piemontese SanFront, aiutante<br />
<strong>di</strong> campo <strong>di</strong> Vittorio Emanuele II,<br />
non riesce a fare a meno <strong>di</strong> esprimere<br />
in una lettera tutto il suo<br />
stupore per l’avanzata del proprio
attaglione tra «campane che suonano<br />
a festa», «balconi addobbati<br />
coi tre colori, ban<strong>di</strong>ere sul campanile,<br />
case e luoghi pubblici» e<br />
«mazzi <strong>di</strong> fiori perfino all’ultimo<br />
soldato» (Renzo Sertoli Salis,<br />
I Sardo-piemontesi in Valtellina in<br />
una lettera ine<strong>di</strong>ta del 1859, “Bollettino<br />
della Società storica valtellinese”,<br />
n. 12, anno 1958). Lo<br />
stesso arciprete Maffei, mai tenero<br />
coi mazziniani, si lascia prendere<br />
dall’entusiasmo al passaggio <strong>di</strong><br />
Garibal<strong>di</strong>, “il prode guerriero” che<br />
«veniva in mezzo a quattromila e<br />
più giovani e valenti soldati, e giungeva<br />
al chiarore d’improvvisa luminaria».<br />
Col ’59, del resto, tramontava<br />
l’idea dell’unità come federazione<br />
<strong>di</strong> Stati sotto la presidenza<br />
onoraria del papa, che era stata<br />
propria <strong>di</strong> tutto lo schieramento liberal-moderato<br />
e che, ancora nel<br />
’58, era stata sottoscritta dallo<br />
stesso Cavour con gli accor<strong>di</strong> <strong>di</strong><br />
Plombières come con<strong>di</strong>zione per<br />
l’intervento della Francia a fi anco<br />
del Piemonte. L’andamento della<br />
guerra aveva portato, però, non<br />
alla cacciata degli austriaci dalla<br />
penisola, come prevedevano que-<br />
Copertina delle<br />
Memorie <strong>di</strong> un<br />
volontario <strong>di</strong> Nicola<br />
Mevio (nella foto<br />
a lato), uno dei<br />
numerosi valtellinesi<br />
che seguì Garibal<strong>di</strong><br />
nella spe<strong>di</strong>zione<br />
dei Mille.<br />
Cover of the Memoirs<br />
of a volunteer by<br />
Nicola Mevio (in the<br />
photo alongside) one<br />
of the Valtellina men<br />
who followed<br />
Garibal<strong>di</strong> in the<br />
expe<strong>di</strong>tion of One<br />
Thousand.<br />
Il manifesto con cui<br />
Luigi Torelli,<br />
Governatore della<br />
Valtellina, annuncia<br />
l’annessione dell’Italia<br />
centrale al Regno <strong>di</strong><br />
Sardegna (Tirano,<br />
Archivio Torelli).<br />
The bill in which Luigi<br />
Torelli, Governor of<br />
Valtellina, announced<br />
the annexation of<br />
central Italy to the<br />
Kingdom of Sar<strong>di</strong>nia<br />
(Tirano, Torelli<br />
archive).<br />
gli accor<strong>di</strong>, ma alla sola unione<br />
della Lombar<strong>di</strong>a al Piemonte. Cavour,<br />
perciò, ritenendosi sciolto da<br />
quegli accor<strong>di</strong>, si convinceva che<br />
solo la monarchia sabauda, attraverso<br />
una sapiente tessitura <strong>di</strong>plomatica,<br />
avrebbe potuto condurre a<br />
termine l’unifi cazione del Paese.<br />
Sfi dando una fortissima impopolarità,<br />
aveva perciò ceduto Nizza (la<br />
patria <strong>di</strong> Garibal<strong>di</strong>) e Savoia alla<br />
Francia per averne il via libera<br />
all’annessione <strong>di</strong> Parma, Modena,<br />
Emilia, Romagna e Toscana, dove<br />
le rivolte popolari avevano cacciato<br />
i sovrani e <strong>di</strong>chiarato l’unione al<br />
Piemonte. Ma non sarebbe mai<br />
riuscito ad avere per via <strong>di</strong>plomatica<br />
il Regno delle due Sicilie, il più<br />
vasto dell’intera penisola, senza<br />
l’audacia e la forza <strong>di</strong> mobilitazione<br />
<strong>di</strong> Mazzini e <strong>di</strong> Garibal<strong>di</strong> cui, obtorto<br />
collo e sotto la spinta della<br />
stessa opinione pubblica liberale,<br />
dovette alla fi ne affi darsi. L’anima<br />
liberal-moderata del Risorgimento<br />
tornava così a riunirsi, per un momento,<br />
a quella democratico-mazziniana<br />
e insieme le due anime<br />
avrebbero portato a termine nel<br />
1860 il <strong>di</strong>segno unitario.<br />
Le Memorie<br />
<strong>di</strong> un garibal<strong>di</strong>no valtellinese<br />
Quell’anno saranno moltissimi<br />
i giovani valtellinesi fra i Mille<br />
che seguiranno Garibal<strong>di</strong> in Sicilia,<br />
nell’impresa che Maurizio Quadrio,<br />
travestito da commesso viaggiatore,<br />
aveva segretamente preparato<br />
insieme a Francesco Crispi e Ro-<br />
solino Pilo. Di alcuni <strong>di</strong> questi valtellinesi<br />
conosciamo anche i nomi:<br />
il chiavennasco Carlo Pedretti, il<br />
giovanissimo Antonio Cederna <strong>di</strong><br />
Ponte, il tiranese Antonio Pievani<br />
<strong>di</strong> cui Giuseppe Cesare Abba ci ha<br />
lasciato un curioso profi lo nelle<br />
sue Noterelle <strong>di</strong> uno dei Mille.<br />
Nel nutrito gruppo <strong>di</strong> giovani<br />
garibal<strong>di</strong>ni che il 30 luglio partiva<br />
da <strong>Sondrio</strong>, c’era anche un ragazzo,<br />
Nicola Mevio, che scriverà il<br />
dettagliato racconto <strong>di</strong> quell’avventura<br />
nelle Memorie <strong>di</strong> un volontario<br />
(Bissoni, <strong>Sondrio</strong>, 1973), dove ci<br />
dà preziose informazioni su altri<br />
giovani valtellinesi che si imbarcarono<br />
con lui a Genova sul Bizantino.<br />
«La lontana Valtellina – nota<br />
Nicola Mevio – come nel ’48, ’49<br />
e ’59, anche nel ’60 si scuote e<br />
fornisce alla madre patria il suo<br />
contingente. […] Dove adunque si<br />
deve rintracciare – si chiede – la<br />
cagione <strong>di</strong> tale manifestazione <strong>di</strong><br />
patriottismo» in una valle «situata<br />
all’estremo lembo settentrionale<br />
della Penisola, chiusa in mezzo ai<br />
monti» dove «entrar non potrebbero<br />
che a stento le idee <strong>di</strong> progresso,<br />
<strong>di</strong> patria, <strong>di</strong> civiltà?». Ripercorrendo<br />
la sua personale esperienza,<br />
Mevio ne in<strong>di</strong>cava la ragione<br />
nelle scuole e specialmente nel<br />
Ginnasio <strong>di</strong> <strong>Sondrio</strong>, da lui frequentato,<br />
«dove anche in tempi <strong>di</strong> oppressione<br />
straniera […] i precettori<br />
Romegialli, lo storico, Gualzetti,<br />
Miotti e Polatti ed altri ancor viventi<br />
[…] sfi dando le austriache segrete<br />
ci parlarono più e più volte <strong>di</strong><br />
ITALIA 150 21
22 ITALIA 150<br />
UN MEDICO VALTELLINESE A SOLFERINO<br />
Fra le personalità valtellinesi del Risorgimento italiano, merita senza dubbio <strong>di</strong> essere<br />
ricordato il chirurgo <strong>di</strong> Morbegno Carlo Cotta, anche se la sua attività patriottica si svolse<br />
quasi tutta al <strong>di</strong> fuori della Valle. Era nato a Morbegno il 14 <strong>di</strong>cembre 1809 e si era laureato<br />
a Pavia in me<strong>di</strong>cina e chirurgia <strong>di</strong>ventando subito assistente del professor Porta. Nel 1839 era<br />
già primario chirurgo all’ospedale <strong>di</strong> Lo<strong>di</strong> e nel 1847 vinceva la cattedra <strong>di</strong> chirurgia all’università<br />
<strong>di</strong> Padova dove pubblicava i suoi stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> anatomia microscopica sulle “malattie della<br />
mammella”. Allo scoppio delle Cinque giornate a Milano nel marzo del ’48, anche Padova<br />
insorse dandosi un governo provvisorio <strong>di</strong> cui Carlo Cotta, per la sua popolarità, fu messo a<br />
capo. Al ritorno degli austriaci, rimosso dall’insegnamento universitario, fuggì a Milano, dove<br />
continuò ad esercitare clandestinamente la sua professione <strong>di</strong> me<strong>di</strong>co, «liberissima – come<br />
scrisse – da ogni infl uenza governativa». All’inizio <strong>di</strong> giugno del 1859 lo ritroviamo a Magenta,<br />
nei giorni della battaglia, capo chirurgo e <strong>di</strong>rettore dell’ospedale militare del Monastero<br />
maggiore dove furono concentrati i feriti. Poche settimane dopo è sul campo <strong>di</strong> San Martino<br />
e <strong>di</strong> Solferino a curare senza <strong>di</strong>stinzione <strong>di</strong> nazionalità i 25.000 feriti della battaglia, una<br />
delle più sanguinose <strong>di</strong> tutta la storia del Risorgimento (29.000 morti, <strong>di</strong> cui 14.000 francopiemontesi<br />
e 15.000 austriaci). Alla battaglia aveva assistito per caso anche l’uomo d’affari<br />
svizzero Henri Dunant, venuto per incontrare Napoleone III e che, impressionato dalla carnefi<br />
cina e dall’abbandono dei feriti, <strong>di</strong> ritorno a Ginevra, darà vita al “Comitato dei cinque”<br />
da cui sarebbe nata nel 1864 la Croce Rossa internazionale.<br />
Della stessa battaglia a favore dei feriti in guerra <strong>di</strong> ogni nazionalità si fece in quegli<br />
stessi anni promotore in Italia Carlo Cotta, accanto al chirurgo napoletano Fer<strong>di</strong>nando Palasciano,<br />
che per primo nel 1861 aveva proclamato in Europa le tesi che nel 1864 sarebbero<br />
state alla base della Convenzione <strong>di</strong> Ginevra e della Croce Rossa internazionale. Morì improvvisamente<br />
a Milano il 10 luglio 1866, mentre era in pieno svolgimento la Terza guerra<br />
d’in<strong>di</strong>pendenza.<br />
questa amabil terra, de’ suoi personaggi,<br />
delle sue vicende, de’<br />
patimenti suoi» e «ci rivelarono la<br />
loro ferma credenza in un miglior<br />
avvenire, e nella patria redenzione».<br />
Questo giovane garibal<strong>di</strong>no –<br />
che in seguito avrebbe chiamato<br />
uno dei suoi fi gli col nome <strong>di</strong> tre<br />
campioni <strong>di</strong> libertà, Bruto Cristo<br />
Washington – metteva a nudo così<br />
un’altra delle componenti, la scuola,<br />
che, insieme al clero e alla sua<br />
classe <strong>di</strong>rigente aristocratica e<br />
borghese, aveva determinato<br />
l’orientamento fi lorisorgimentale<br />
della Valtellina. Ma egli sottolineava,<br />
allo stesso tempo, come lo<br />
stu<strong>di</strong>o della storia e delle vicende<br />
della piccola patria locale avesse<br />
preparato nel cuore dei giovani<br />
l’attaccamento alla grande patria<br />
nazionale.<br />
Gli esor<strong>di</strong> dell’Unità<br />
in provincia <strong>di</strong> <strong>Sondrio</strong><br />
Non è perciò un caso che<br />
proprio la scuola, l’istruzione e la<br />
cultura siano stati alcuni dei primi<br />
compiti che si sarebbe prefi ssata<br />
in Valtellina la nuova classe <strong>di</strong>rigente<br />
provinciale all’indomani della<br />
proclamazione del Regno d’Ita-<br />
lia il 17 marzo 1861, quando la<br />
ricostruzione dell’economia – stremata<br />
dalla crittogama che dal<br />
1852 aveva azzerato la produzione<br />
vinicola provinciale e dalla pebrina<br />
che aveva <strong>di</strong>mezzato quella<br />
dei bozzoli del baco da seta – si<br />
confi gurava da sola come un compito<br />
immane. «Figurati, mio caro,<br />
che la miseria è a tal grado <strong>di</strong><br />
spaventevole eccesso che vi sono<br />
centinaia <strong>di</strong> famiglie che vivono <strong>di</strong><br />
erba cotta senza sale», scriveva<br />
Torelli a Bettino Ricasoli. Eppure lo<br />
stesso Torelli, nel 1859, non appena<br />
nominato da Cavour governatore<br />
della Valtellina per guidare<br />
la fase <strong>di</strong> transizione, insieme alla<br />
<strong>di</strong>ffusione tra i conta<strong>di</strong>ni dei nuovi<br />
meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> solforazione della vite<br />
per combattere la crittogama e ai<br />
primi provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> alleggerimento<br />
del peso fi scale e dei debiti<br />
dei Comuni, aveva subito avviato<br />
il rior<strong>di</strong>no delle scuole elementari<br />
comunali e aveva affi ancato al<br />
Regio Ginnasio <strong>di</strong> <strong>Sondrio</strong> una<br />
scuola per maestri e un istituto<br />
tecnico.<br />
Nello stesso tempo, proprio<br />
uno dei professori del Ginnasio <strong>di</strong><br />
<strong>Sondrio</strong>, Luciano Sissa, pubblica-<br />
va da Vallar<strong>di</strong> nel 1860 una nuova<br />
Storia della Valtellina in cui, a riprova<br />
<strong>di</strong> quanto scritto da Nicola Mevio,<br />
il passato della provincia veniva<br />
riletto e reinterpretato alla luce<br />
del suo esito storico nazionale. Ma<br />
fra le primissime iniziative cui Torelli,<br />
l’arciprete Maffei e altri esponenti<br />
locali <strong>di</strong>edero allora vi ta a<br />
<strong>Sondrio</strong> ci fu, l’8 aprile 1861, la<br />
fondazione della Biblioteca civica,<br />
per cui lo stesso Maffei donò settanta<br />
volumi, mise a <strong>di</strong>sposizione<br />
i locali della propria casa <strong>di</strong> famiglia,<br />
e ci fu l’uscita, il 28 giugno<br />
dello stesso anno, <strong>di</strong> un nuovo<br />
giornale, La Valtellina, come palestra<br />
<strong>di</strong> <strong>di</strong>scussione dei problemi <strong>di</strong><br />
interesse pubblico della provincia<br />
e <strong>di</strong> formazione <strong>di</strong> una coscienza<br />
civica nazionale. C’era, insomma,<br />
un intento profondamente pedagogico<br />
nell’azione della classe <strong>di</strong>rigente<br />
liberal-moderata <strong>di</strong> <strong>Sondrio</strong>,<br />
unito alla coscienza dei problemi<br />
sociali che presto si sarebbero<br />
aperti. Non a caso nel primo numero<br />
del giornale La Valtellina appariva<br />
un appello, Agli operaj, in cui<br />
Torelli e Maffei in<strong>di</strong>cavano nell’associazionismo<br />
uno degli strumenti<br />
per l’esercizio della libertà in una<br />
società democratica e incitavano<br />
alla fondazione <strong>di</strong> una Società<br />
operaia, che a <strong>Sondrio</strong> sarebbe<br />
nata nel 1864.<br />
A Chiavenna, invece, essa<br />
era sorta già nel 1862, in contrapposizione<br />
con l’orientamento mo-
derato dell’amministrazione citta<strong>di</strong>na,<br />
ad opera <strong>di</strong> Carlo Pedretti,<br />
come espressione del movimento<br />
mazziniano che nell’Unità nazionale<br />
non vedeva solo il compimento<br />
<strong>di</strong> un ideale politico, ma l’inizio <strong>di</strong><br />
un rinnovamento sociale <strong>di</strong> cui le<br />
classi popolari avrebbero dovuto<br />
Luigi Torelli (foto<br />
Alinari). Il primo<br />
numero del<br />
settimanale La<br />
Valtellina. Fondato<br />
nel giugno 1861 il<br />
giornale vivrà per<br />
oltre un secolo, con<br />
la parentesi del<br />
ventennio fascista,<br />
fino agli anni<br />
Settanta del ’900.<br />
(<strong>Sondrio</strong>, Biblioteca<br />
civica Pio Rajna).<br />
Luigi Torelli (photo<br />
Alinari). The first<br />
issue of the weekly<br />
La Valtellina.<br />
Founded in June<br />
1861 the magazine<br />
was to live for over a<br />
century, with the<br />
parenthesis of the<br />
twenty years under<br />
the Fascist regime,<br />
until the 1970s.<br />
(<strong>Sondrio</strong>, Pio Rajna<br />
Civic Library).<br />
<strong>di</strong>ventare in prima persona protagoniste.<br />
Chiavenna, del resto, aveva<br />
una vivacità economica e commerciale<br />
che a <strong>Sondrio</strong> mancava.<br />
Se nella <strong>Sondrio</strong> liberal-moderata<br />
il movimento risorgimentale era<br />
stato opera soprattutto della vecchia<br />
aristocrazia terriera, nella<br />
Chiavenna mazziniana, dov’era<br />
nato Maurizio Quadrio, esso era<br />
stato innanzitutto espressione della<br />
nuova borghesia impren<strong>di</strong>toriale<br />
e commerciale. Commerciante era<br />
Francesco Dolzino, commerciante<br />
anche Carlo Pedretti e commercianti<br />
e impren<strong>di</strong>tori erano tutti<br />
quelli che, insieme a lui, avevano<br />
dato vita alla Società operaia.<br />
Nasce proprio da questa <strong>di</strong>versità<br />
economica e politica la<br />
battaglia che nel 1862 i chiaven-<br />
naschi conducono in Consiglio provinciale<br />
per la separazione dalla<br />
Valtellina e l’aggregazione alla provincia<br />
<strong>di</strong> Como – <strong>di</strong> cui il territorio<br />
chiavennasco si è sempre sentito<br />
il naturale retroterra alpino – trovando<br />
allora un muro invalicabile<br />
negli esponenti della destra storica<br />
provinciale.<br />
L’ultimo atto del Risorgimento:<br />
la guerra del 1866 sullo Stelvio<br />
Queste <strong>di</strong>visioni, però, avrebbero<br />
perso <strong>di</strong> colpo peso nel 1866,<br />
allo scoppio della Terza guerra <strong>di</strong><br />
in<strong>di</strong>pendenza, quando mazziniani<br />
e liberal-democratici valtellinesi si<br />
sarebbero trovati ancora una volta<br />
uniti sullo Stelvio a <strong>di</strong>fendere il<br />
confi ne con l’Austria.<br />
La guerra del ’66, nata da un<br />
ITALIA 150 23
pasticcio <strong>di</strong>plomatico, fu condotta<br />
ancor peggio sul piano militare.<br />
Mancava Cavour, morto nel 1861<br />
pochi mesi dopo l’Unità, e la sua<br />
assenza si faceva sentire. L’Italia,<br />
alleata della Prussia <strong>di</strong> Bismarck in<br />
cambio della promessa del Veneto<br />
che avrebbe potuto pacifi camente<br />
avere per via <strong>di</strong>plomatica dall’Austria<br />
e del tutto impreparata alla<br />
guerra, fu pesantemente sconfi tta<br />
prima a Custoza e poi anche sul<br />
mare a Lissa. Solo la vittoria del<br />
generale prussiano von Moltke a<br />
Sadowa riuscì a farle avere il Veneto,<br />
non dalle mani dell’Austria, cui<br />
l’Italia dovette anzi pagare un duro<br />
risarcimento bellico, ma da quelle<br />
<strong>di</strong> Napo leone III, cui l’impero austriaco<br />
lo aveva uffi cialmente ceduto.<br />
Non così <strong>di</strong>sastrosa fu, invece,<br />
la guerra sul fronte alpino dove<br />
combatterono i 30.000 Cacciatori<br />
delle Alpi <strong>di</strong> Garibal<strong>di</strong>. Vittoriosi a<br />
Bezzecca, i volontari garibal<strong>di</strong>ni<br />
erano stati fermati sulla via del<br />
Trentino dal telegramma del comando<br />
supremo, cui Garibal<strong>di</strong> rispose<br />
col celebre «Obbe<strong>di</strong>sco».<br />
Anche in Valtellina nel ’66 l’esercito<br />
piemontese non si fece vedere<br />
e la guar<strong>di</strong>a nazionale, imme<strong>di</strong>ata-<br />
24 ITALIA 150<br />
Pietro Pedranzini e,<br />
a destra, il<br />
colonnello Enrico<br />
Guicciar<strong>di</strong> con un<br />
gruppo <strong>di</strong> ufficiali e<br />
soldati della Legione<br />
nazionale sullo<br />
Stelvio durante la<br />
Terza guerra<br />
d’in<strong>di</strong>pendenza del<br />
1866.<br />
Pietro Pedranzini<br />
and, on the right,<br />
Colonel Enrico<br />
Guicciar<strong>di</strong> with a<br />
group of officers and<br />
sol<strong>di</strong>ers of the<br />
National Legion on<br />
the Stelvio during the<br />
Third War of<br />
Independence in<br />
1866.<br />
Il capitano Giovanni<br />
Salis e, a destra,<br />
Romualdo Bonfa<strong>di</strong>ni<br />
(1831-99).<br />
Captain Giovanni<br />
Salis and, on the<br />
right, Romualdo<br />
Bonfa<strong>di</strong>ni (1831-99).<br />
mente allestita da Enrico Guicciar<strong>di</strong><br />
coi volontari locali per fermare<br />
la <strong>di</strong>scesa dei 1.200 austriaci<br />
dallo Stelvio, fu anch’essa più volte<br />
sul punto <strong>di</strong> restare isolata e<br />
accerchiata fra Tresenda e il Ponte<br />
del Diavolo dalle forze austriache<br />
che avanzavano a tenaglia dallo<br />
Stelvio e dal Tonale, favoriti dalla<br />
nuova strada dell’Aprica che Radetzky<br />
aveva fortemente voluto. A<br />
risolvere allora la <strong>di</strong>ffi cile situazione,<br />
causata anche dai tentennamenti<br />
dell’autorità militare e prefettizia,<br />
fu la geniale azione del<br />
comandante Pietro Pedranzini, segretario<br />
comunale <strong>di</strong> Bormio, che<br />
con la sua colonna Zambelli, fatta<br />
per lo più <strong>di</strong> guar<strong>di</strong>e forestali, riuscì<br />
a risalire per un <strong>di</strong>ffi cile canalone<br />
la Reit e a catturare in un colpo<br />
solo, alla I cantoniera dello Stelvio,<br />
una settantina <strong>di</strong> austriaci, mettendo<br />
fuori combattimento l’intero<br />
schieramento avversario.<br />
Sullo Stelvio nel ’66 c’erano,<br />
tra gli altri, il cinquantatreenne<br />
veterano Enrico Guicciar<strong>di</strong>, Romualdo<br />
Bonfa<strong>di</strong>ni, Aristide Caimi,<br />
che <strong>di</strong>rigeva a <strong>Sondrio</strong> il giornale<br />
nazionale della Società <strong>di</strong> tiro a<br />
segno, La Palestra, G. B. Caimi,<br />
presidente dell’amministrazione<br />
provinciale, Enrico Sertoli, il futuro<br />
scopritore delle “cellule Sertoli”<br />
fresco della specializzazione in<br />
biologia a Vienna, il giovanissimo<br />
avvocato <strong>di</strong> <strong>Sondrio</strong> Carlo Sertoli,<br />
il notaio Noali <strong>di</strong> Morbegno, il chiavennasco<br />
Emilio Ploncher, il conte<br />
Giovanni Salis con una compagnia<br />
bene equipaggiata <strong>di</strong> volontari tiratori<br />
scelti raccolti a Milano.<br />
Gli altri protagonisti valtellinesi<br />
del Risorgimento erano allora<br />
sparsi per l’Italia. Luigi Torelli, dopo<br />
essere stato ministro dell’Agricoltura,<br />
era stato nominato nel 1866
Ufficiali <strong>di</strong> Stato maggiore della Legione nazionale <strong>di</strong> Enrico Guicciar<strong>di</strong> sul fronte dello Stelvio<br />
nel 1866. Da sinistra in pie<strong>di</strong>: il luogotenente Pietro Pedranzini, il sottotenente delle Guar<strong>di</strong>e<br />
doganali Enrico Panci, il sergente Giuseppe Colombo, il sergente Cesare Beruto, il dott. Innocente<br />
Regazzoni (me<strong>di</strong>co della Legione), Bertolini, il sergente <strong>di</strong> artiglieria Giovanni Baiotto, il<br />
sergente maggiore Romualdo Bonfa<strong>di</strong>ni, il sottotenente Guido Parravicini. In primo piano seduti:<br />
il capitano Aristide Caimi, il colonnello Enrico Guicciar<strong>di</strong>, il capitano Giovanni Morelli.<br />
Officers of the General Staff of the national Legion of Enrico Guicciar<strong>di</strong> on the front of the<br />
Stelvio in 1866. From the left, stan<strong>di</strong>ng: Lieutenant Pietro Pedranzini, Second Lieutenant of the<br />
Customs Guards Enrico Panci, Sergeant Giuseppe Colombo, Sergeant Cesare Beruto, Dr. Innocente<br />
Regazzoni (the Legion’s doctor), Bertolini, the artillery Sergeant Giovanni Baiotto, Sergeant-major<br />
Romualdo Bonfa<strong>di</strong>ni, Second Lieutenant Guido Parravicini. In the foreground, seated:<br />
Captain Aristide Caimi, Colonel Enrico Guicciar<strong>di</strong> and Captain Giovanni Morelli.<br />
prefetto <strong>di</strong> Palermo, Giovanni Visconti<br />
era a Modena, ed Emilio Visconti<br />
Venosta, all’inizio della guerra<br />
“ministro del re” a Costantinopoli,<br />
dopo la sconfi tta <strong>di</strong> Custoza era<br />
stato frettolosamente richiamato<br />
al ministero degli Esteri dal nuovo<br />
governo <strong>di</strong> Bettino Ricasoli.<br />
Dopo la parentesi bellica del<br />
’66, in provincia l’attenzione tornava<br />
a focalizzarsi sui problemi economici,<br />
<strong>di</strong> cui il nuovo prefetto,<br />
Giacinto Scelsi, aveva fornito l’anno<br />
prima un quadro esaustivo in<br />
una relazione al Consiglio provin-<br />
ciale che costituisce anche la<br />
maggiore fonte conoscitiva della<br />
realtà sociale dell’epoca (G. Scelsi,<br />
Statistica generale della Provincia<br />
<strong>di</strong> <strong>Sondrio</strong>, 1866, ristampa<br />
anastatica <strong>Sondrio</strong>, Amministrazione<br />
provinciale, 1999). In essa,<br />
il prefetto Scelsi, auspicava, tra le<br />
altre misure, anche la nascita <strong>di</strong><br />
una banca popolare in grado <strong>di</strong><br />
incanalare verso lo sviluppo provinciale<br />
l’alta capacità del risparmio<br />
dei valtellinesi che allora, attraverso<br />
gli unici tre sportelli esistenti<br />
della Cassa <strong>di</strong> Risparmio delle<br />
A destra: lapide<br />
posta sulla<br />
I Cantoniera dello<br />
Stelvio in memoria<br />
della vittoria sugli<br />
austriaci nel 1866.<br />
In basso: i cannoni<br />
Varese e Calatafimi<br />
al Museo del<br />
Risorgimento <strong>di</strong><br />
Milano sotto il<br />
grande <strong>di</strong>pinto della<br />
battaglia <strong>di</strong><br />
Bezzecca. I due<br />
cannoni, <strong>di</strong> proprietà<br />
del Comune <strong>di</strong><br />
<strong>Sondrio</strong>, fanno parte<br />
dei sei utilizzati dai<br />
volontari della<br />
Legione nazionale<br />
<strong>di</strong> Enrico Guicciar<strong>di</strong><br />
sullo Stelvio nel<br />
1866.<br />
On the right: the<br />
memorial stone on<br />
the I Cantoniera<br />
(roadman’s house)<br />
of the Stelvio in<br />
memory of the<br />
victory over the<br />
Austrians in 1866.<br />
Below: the Varese<br />
and Calatafimi<br />
cannons in the<br />
Risorgimento<br />
Museum, Milan,<br />
under the large<br />
painting of the Battle<br />
of Bezzecca. The two<br />
cannons, owned by<br />
the city of <strong>Sondrio</strong>,<br />
are part of the six<br />
used by the<br />
volunteers of the<br />
National Legion of<br />
E. Guicciar<strong>di</strong> on the<br />
Stelvio in 1866.<br />
Cortesia Museo del Risorgimento <strong>di</strong> Milano - Photo Saporetti Immagini d’Arte<br />
Province Lombarde, andava ad<br />
alimentare il cre<strong>di</strong>to fuori provincia.<br />
Cinque anni dopo, nel 1871<br />
nasceva la <strong>Banca</strong> <strong>Popolare</strong> <strong>di</strong> <strong>Sondrio</strong>,<br />
con cui iniziava la rinascita<br />
economica della valle nel quadro<br />
dell’Italia unita.<br />
A dar vita alla <strong>Banca</strong> <strong>Popolare</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>Sondrio</strong> erano stati, del resto,<br />
<strong>di</strong>versi protagonisti del Risorgimento<br />
in Valtellina – fra cui lo<br />
stesso arciprete Antonio Maffei –<br />
e molti esponenti dell’impren<strong>di</strong>toria<br />
agraria locale che avevano attivamente<br />
partecipato alle vicende<br />
risorgimentali e combattuto da ultimo<br />
sullo Stelvio nel ’66 come<br />
volontari fra i legionari del colonnello<br />
Enrico Guicciar<strong>di</strong>.<br />
Sullo Stelvio quell’anno, insieme<br />
ai due battaglioni della Legione<br />
nazionale, Guicciar<strong>di</strong> aveva<br />
potuto <strong>di</strong>sporre anche <strong>di</strong> otto cannoni<br />
la cui storia è stata recentemente<br />
ricostruita da Enrico G. Arrigoni<br />
(I cannoni <strong>di</strong> <strong>Sondrio</strong>, Centro<br />
stu<strong>di</strong> alpini <strong>di</strong> Isolaccia-Val<strong>di</strong>dentro,<br />
2003). Di sei <strong>di</strong> questi cannoni<br />
conosciamo anche i nomi garibal<strong>di</strong>ni<br />
con cui erano stati battezzati:<br />
Varese, Calatafi mi, Marsala,<br />
Palermo, Como e Milazzo. Dei<br />
primi quattro, oggi <strong>di</strong> proprietà del<br />
Comune <strong>di</strong> <strong>Sondrio</strong>, due, il Marsala<br />
e il Palermo, si trovano nel Palazzo<br />
Pretorio del capoluogo valtellinese,<br />
e due, il Varese e il Calatafi<br />
mi, in una sala del Museo del<br />
Risorgimento a Milano, sotto la<br />
grande tela della battaglia <strong>di</strong> Bezzecca,<br />
testimoni ormai muti del<br />
contributo della Valtellina e della<br />
Valchiavenna al Risorgimento italiano.<br />
ITALIA 150 25
A 150 anni dagli inizi dell’Unità Nazionale<br />
26 ITALIA 150<br />
Tre umili preti<br />
che hanno fatto grande l’Italia<br />
Don Luigi Sturzo – Don Primo Mazzolari – Don Lorenzo Milani<br />
MONS. DANIELE ROTA<br />
Canonico Onorario della<br />
Papale Basilica <strong>di</strong> San Pietro in Vaticano<br />
Premessa<br />
«La storia ha plasmato l’Italia in<br />
mille mo<strong>di</strong>, dando a ciascuna zona<br />
la sua personalità, la sua caratteristica,<br />
una e multipla nello stesso<br />
tempo». (Don Luigi Sturzo)<br />
Quando, il 17 marzo 1861, a<br />
Torino, venne proclamato il Regno<br />
d’Italia 1 e Vittorio Emanuele II, acclamato<br />
suo re «per la grazia <strong>di</strong> Dio<br />
e la volontà della Nazione», 2 evento<br />
storico che il prossimo anno<br />
s’intende commemorare, 3 unico<br />
elemento certo <strong>di</strong> unità nazionale<br />
era la religione cattolica, 4 da secoli<br />
ben ra<strong>di</strong>cata fra le <strong>di</strong>verse popolazione<br />
italiche. 5 Una religione che<br />
per la sua forte incidenza etica e<br />
assoluta trascendenza 6 aveva<br />
Three humble priests<br />
who made Italy magnificent<br />
The Church has always been a clear reference in our national<br />
history. And even politics has delineated precise boundary lines: a<br />
free Church in a free State, Cavour said. When then Rome is<br />
“conquered” the “Roman issue” pops out and who wants to<br />
support the usurped Pope invokes political abstention. But at the<br />
end of the Great War everyone believes that the line-up of<br />
Catholics as a political party is in<strong>di</strong>spensable: and don Luigi<br />
Sturzo’s participation in the Popular Party ratifies this intention.<br />
In the turbulent years of Fascism and the ruthless post-war<br />
contrasts don Primo Mazzolari foreshadows with his preaching<br />
some perspectives of the Second Vatican Council. And don<br />
Lorenzo Milani in his new idea of education attempts to compose<br />
the evangelical message that only truth sets free.<br />
esaltato Roma e l’Italia. Innumerevoli<br />
missionari del Vangelo hanno<br />
iniziato in epoche ben più remote<br />
<strong>di</strong> quelle risorgimentali e continuano<br />
nei tempi presenti la loro tenace<br />
e costruttiva azione nel segno<br />
dell’unica identità cristiana. 7 Un<br />
impegno che viene da lontano: si<br />
fa risalire ai tempi <strong>di</strong> Costantino il<br />
Grande (275-337), che, con il noto<br />
e<strong>di</strong>tto <strong>di</strong> Milano (313), aprì uffi cialmente<br />
le porte dell’Italia imperiale<br />
a quella Croce gloriosa che gli<br />
aveva dato vittoria. Nei secoli imme<strong>di</strong>atamente<br />
successivi, san Benedetto<br />
(480-547), fra i tanti, e il<br />
suo intrepido or<strong>di</strong>ne monastico ne<br />
<strong>di</strong>vennero gli antesignani: il loro<br />
generoso impegno apostolico in<br />
Italia e in Europa attraversa tutto<br />
il Me<strong>di</strong>oevo, tracima ai vertici<br />
dell’Età Moderna, lambisce, senza<br />
soluzione <strong>di</strong> continuità, la Contemporanea.<br />
Ogni terra, dal Nord al<br />
Sud d’Italia, conobbe operatori del<br />
culto cattolico che si <strong>di</strong>stinsero per<br />
la loro opera <strong>di</strong> pacifi cazione e <strong>di</strong><br />
libertà in nome del Vangelo, anche<br />
a prezzo della vita. Attorno al Crocifi<br />
sso e all’altare nacquero e prosperarono<br />
i Comuni e le Repubbliche<br />
marinare, le università e gli<br />
ospedali, le cattedrali e gli orfanotrofi<br />
, tutte o quasi tutte le realtà<br />
civili, umanitarie e culturali che<br />
onorarono e onorano il Vecchio<br />
Continente. Pure durante le ende-<br />
miche calamità delle pesti, delle<br />
guerre e carestie, la loro azione<br />
caritativa, unica sul territorio, fu per<br />
intere generazioni la salvezza. 8<br />
Nell’anno sacerdotale (2009-10)<br />
In tale contesto <strong>di</strong> antiche<br />
tra<strong>di</strong>zioni cristiane e <strong>di</strong> ininterrotte<br />
presenze assistenziali del clero,<br />
l’attuale Pontefi ce, che volle chiamarsi<br />
Benedetto, ha proclamato il<br />
primo anno sacerdotale nella storia<br />
della Chiesa, anticipando signifi<br />
cativamente le celebrazioni nazionali<br />
unitarie. L’occasione furono i<br />
centocinquant’anni dalla morte del<br />
santo Curato d’Ars, patrono dei<br />
parroci; lo scopo: richiamare l’attenzione<br />
e la devozione dei credenti<br />
all’apostolicità dei ministri dell’altare.<br />
Le vocazioni al sacerdozio in<br />
Europa sono in calo, gli stessi ministri<br />
vengono sottoposti in massa<br />
a un quoti<strong>di</strong>ano tiro me<strong>di</strong>atico,<br />
senza esclusione <strong>di</strong> colpi, per cancellarne<br />
cre<strong>di</strong>bilità e fi ducia. Sembra<br />
pertanto tempestivo il ricordo<br />
<strong>di</strong> questi tre umili preti che, come<br />
tanti confratelli del loro e <strong>di</strong> altri<br />
tempi, hanno grandemente nobilitato<br />
la Chiesa e la Patria, la religione<br />
e la cultura, l’esilio, i campi <strong>di</strong><br />
concentramento e l’Olocausto. 9<br />
Per rimanere negli ambiti storici<br />
del secolo scorso nel quale<br />
l’unità nazionale è andata consolidandosi<br />
dopo le precedenti guerre
<strong>di</strong> in<strong>di</strong>pendenza, 10 i loro tre nomi<br />
s’iscrivono in realtà nazionali <strong>di</strong>fferenti,<br />
ma tra loro complementari,<br />
al Sud: don Luigi Sturzo; al Centro:<br />
don Lorenzo Milani; al Nord: don<br />
Primo Mazzolari. Per non <strong>di</strong>re <strong>di</strong><br />
altri ecclesiastici contemporanei,<br />
parimenti benemeriti come, ad<br />
esempio, don Giovanni Calabria,<br />
don Carlo Gnocchi, padre Agostino<br />
Gemelli, padre David Maria Turoldo,<br />
per tacere degli innumerevoli<br />
preti-cappellani militari caduti in<br />
trincea, a fi anco dei loro battaglioni;<br />
ai quali si aggiungono i non<br />
pochi sacerdoti in cura d’anime,<br />
arrestati, deportati e mai più ritornati,<br />
talvolta per il semplice sospetto<br />
che avessero favorito le<br />
opposte fazioni, 11 oltre ai preti uccisi<br />
durante e dopo la Resistenza<br />
per il solo motivo <strong>di</strong> essere preti,<br />
in o<strong>di</strong>o a quella religione <strong>di</strong> cui<br />
erano ministri. 12 Semplici preti,<br />
senza titoli e senza aureola, sparsi<br />
su tutto il territorio nazionale, artefi<br />
ci silenziosi della composita grandezza<br />
d’Italia. Senza <strong>di</strong> loro, la<br />
nostra storia unitaria, preunitaria e<br />
postunitaria, sarebbe <strong>di</strong>versa, meno<br />
fulgida.<br />
Nella seguente, rapida rivisitazione<br />
dei tre ecclesiastici prescelti<br />
a titolo esemplifi cativo, nulla<br />
<strong>di</strong> nuovo si aggiunge a quanto già<br />
si conosce <strong>di</strong> loro: s’intende qui<br />
ulteriormente evidenziarne quel<br />
decisivo loro ministero che, dalla<br />
Sicilia alla Lombar<strong>di</strong>a, passando<br />
attraverso la Toscana, ha reso<br />
grande onore alla Chiesa e alla<br />
Nazione. Chi scrive ebbe la ventura<br />
<strong>di</strong> conoscerli: intende ora devotamente<br />
commemorarli, de<strong>di</strong>cando<br />
loro questa umile fatica.<br />
Il precedente Risorgimento<br />
tra auspici e realtà<br />
«Una d’arme, <strong>di</strong> lingua, 13 d’altar»,<br />
così il Manzoni avrebbe voluto<br />
l’Italia unita nella sua nota ode<br />
Marzo 1821, composta durante i<br />
moti piemontesi appunto del<br />
1821, allorquando parve, ma così<br />
non fu, che il giovane Carlo Alberto<br />
varcasse defi nitivamente il Ticino.<br />
14 Ancor più esplicito il sacerdote<br />
piemontese Vincenzo Gioberti:<br />
«Una <strong>di</strong> lingua, <strong>di</strong> lettere, <strong>di</strong> religione,<br />
<strong>di</strong> genio nazionale, <strong>di</strong> pensiero<br />
Il generoso impegno<br />
<strong>di</strong> San Benedetto<br />
(480-547) e del suo<br />
intrepido or<strong>di</strong>ne<br />
monastico contribuì<br />
a creare un’unica<br />
identità cristiana in<br />
Italia e in Europa.<br />
The generous<br />
commitment made<br />
by St Benedetto<br />
(480-547) and his<br />
intrepid monastic<br />
order helped create<br />
a unique Christian<br />
identity in Italy<br />
and Europe.<br />
1) Sembra, infatti, improprio fare<br />
riferimento all’Unità d’Italia in un momento<br />
storico, appunto il 1861, in cui<br />
nel Lazio era ancora in essere a tutti gli<br />
effetti lo Stato Pontifi cio e alla completezza<br />
territoriale della nazione mancavano<br />
le cosiddette terre irredente <strong>di</strong><br />
Trento e Trieste, aggregate con la Prima<br />
Guerra mon<strong>di</strong>ale. Il giorno dopo tale<br />
proclamazione, Pio IX emanava l’allocuzione<br />
Iandudum cernimus, in cui condannava<br />
la «vandalica spoliazione» del<br />
suo Stato, riferendosi alle recenti annessioni<br />
delle Marche e dell’Umbria.<br />
Con quella stessa allocuzione il papa<br />
deprecava anche la «laicizzazione forzata»<br />
degli occupanti, denunciando, fra<br />
l’altro, la lotta agli or<strong>di</strong>ni religiosi, alle<br />
opere pie, ai tanti vescovi costretti ad<br />
abbandonare le loro <strong>di</strong>ocesi. Il segretario<br />
<strong>di</strong> Stato, car<strong>di</strong>nal Giacomo Antonelli,<br />
il 15 aprile dello stesso anno, inviò nota<br />
<strong>di</strong> protesta a tutte le rappresentanze<br />
delle potenze straniere accre<strong>di</strong>tate<br />
presso la Santa Sede. Con il Breve poi<br />
del 26 marzo 1861, su tutti coloro che<br />
avevano (o che avrebbero) cooperato in<br />
qualsiasi modo alla spoliazione dello<br />
Stato della Chiesa, veniva comminata<br />
la più severa sanzione ecclesiastica, la<br />
scomunica maggiore.<br />
2) L’espressione “per la grazia <strong>di</strong><br />
Dio”, inserita nella proclamazione, fu<br />
oggetto <strong>di</strong> aspra contesa alla Camera<br />
dei deputati. Solo a seguito dell’intervento<br />
<strong>di</strong>retto <strong>di</strong> Cavour fu approvata con<br />
174 voti favorevoli e ben 58 contrari. Cfr.<br />
Luigi FENAROLI, Stato e Chiesa: dallo Stato<br />
Liberale agli accor<strong>di</strong> <strong>di</strong> Villa Madama, tesi<br />
<strong>di</strong> laurea, Università Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> Milano,<br />
anno accademico 2009-2010.<br />
Fototeca Gilar<strong>di</strong><br />
3) Il mondo delle istituzioni, a partire<br />
dal presidente della Repubblica, per la<br />
ricorrenza, sta preparando la mobilitazione<br />
della nazione; all’iniziativa anche<br />
la Conferenza episcopale italiana ha<br />
dato il suo assenso con le parole del<br />
presidente, il car<strong>di</strong>nal Angelo Bagnasco:<br />
«L’unità d’Italia è un bene comune…<br />
un tesoro che è nel cuore <strong>di</strong> tutti<br />
a cui spero tutti vogliano contribuire» (v.<br />
Oss. Rom., 4 maggio 2010). Il <strong>di</strong>battito<br />
storico, tuttavia, sulla “questione risorgimentale”<br />
sta vivendo anche momenti<br />
<strong>di</strong> qualche vivacità e controversia, almeno<br />
a livello politico e me<strong>di</strong>atico.<br />
4) Le <strong>di</strong>suguaglianze tra le sparse<br />
popolazioni italiche erano profonde,<br />
dalla lingua alle tra<strong>di</strong>zioni, dalla cultura<br />
alla fi nanza, dai costumi alle aspettative,<br />
tali e tante che un secolo e mezzo<br />
<strong>di</strong> storia non è ancora riuscito a sopire.<br />
5) Vero è che nel processo unitario<br />
poterono infi ltrarsi anche elementi <strong>di</strong><br />
ispirazione eterogenea, ma ciò non ha<br />
minimamente intaccato la fede cattolica<br />
e la pratica religiosa delle genti italiche.<br />
6) Pur non essendo religione dell’evasione,<br />
come il bud<strong>di</strong>smo o l’islamismo<br />
e molte altre <strong>di</strong> origine orientale,<br />
il cristianesimo sottende a una dottrina<br />
<strong>di</strong> alta spiritualità, che però riconosce<br />
anche alla storia e al tempo presente<br />
decisivo valore.<br />
7) «Un solo Signore, una sola fede,<br />
uno solo battesimo, una sola vocazione<br />
alla quale siete stati chiamati» (Ef. 4,4).<br />
8) Ve<strong>di</strong> la mitica fi gura <strong>di</strong> padre Cristoforo<br />
nei Promessi Sposi: personalità<br />
emblematica della tra<strong>di</strong>zione e della<br />
storia.<br />
9) Basti citare anche per tanti altri<br />
meno noti, padre Massimiliano Kolbe,<br />
polacco, frate minore conventuale, che<br />
durante l’occupazione tedesca della<br />
sua terra, nascose e salvò più <strong>di</strong> duemila<br />
ebrei, poi lui stesso fu internato<br />
ad Auschwitz, ove, il 14 agosto 1941<br />
chiese e ottenne <strong>di</strong> essere giustiziato<br />
in sostituzione <strong>di</strong> un socio <strong>di</strong> prigionia,<br />
padre <strong>di</strong> numerosa famiglia.<br />
10) Durante il Risorgimento innumerevoli<br />
furono i sacerdoti che si <strong>di</strong>stinsero<br />
fi no all’eroismo, basti ricordare, per<br />
tutti, don Enrico Tazzoli (1812-52), mazziniano<br />
convinto, primo tra i martiri <strong>di</strong><br />
Belfi ore. Un eroe <strong>di</strong> straor<strong>di</strong>naria grandezza.<br />
11) Vasta e documentata bibliografi a<br />
testimonia il sacrifi cio <strong>di</strong> una schiera<br />
ancora non quantifi cata <strong>di</strong> preti, immolati<br />
per motivi politici. Ve<strong>di</strong> anche: don<br />
Primo MAZZOLARI, I Preti sanno morire,<br />
E<strong>di</strong>zione Presbyterium, Padova 1958.<br />
12) Si contano almeno centotrenta<br />
sacerdoti assassinati durante la Resistenza<br />
semplicemente perché sacerdoti,<br />
a partire dall’8 settembre 1943, e<br />
non solo fi no al 25 aprile 1945, ma<br />
ad<strong>di</strong>rittura sino al 1951. Si sa <strong>di</strong> pattu-<br />
ITALIA 150 27
scientifi co, <strong>di</strong> costume citta<strong>di</strong>no, <strong>di</strong><br />
accordo pubblico e privato tra i varii<br />
Stati e abitanti…». 15 A sua volta,<br />
Massimo d’Azeglio, già presidente<br />
del Consiglio dei Ministri, avvertiva<br />
che: «Fatta l’Italia, occorre fare gli<br />
Italiani». A tutti sembra dar seguito,<br />
in tempi relativamente recenti,<br />
Giovanni Spadolini, presidente del<br />
Senato della prima Repubblica<br />
italiana, con una delle sue più fortunate<br />
pubblicazioni, che già nel<br />
titolo vuol essere una chiara proposta<br />
storica: Gli uomini che han fatto<br />
l’Italia. 16 L’insigne stu<strong>di</strong>oso e uomo<br />
politico vi <strong>di</strong>scorre da par suo,<br />
presentando i protagonisti della<br />
prima stagione unitaria italiana, in<br />
cui emergono personalità d’indubbio<br />
rilievo storico, quali Camillo<br />
Benso conte <strong>di</strong> Cavour, Giuseppe<br />
Garibal<strong>di</strong>, Giuseppe Mazzini. Poco<br />
vi si concede alla componente<br />
cattolica, anche perché, a seguito<br />
del <strong>di</strong>scusso Non expe<strong>di</strong>t <strong>di</strong> Pio IX,<br />
i credenti, in quegli anni decisivi,<br />
furono tagliati fuori dalla politica<br />
attiva. Non rimasero, tuttavia, inerti<br />
o estranei al <strong>di</strong>venire nazionale:<br />
basti accennare ai fondamentali<br />
contributi <strong>di</strong> pensiero e <strong>di</strong> proposte<br />
in ambito unitario, avanzati con<br />
lungimiranza e luci<strong>di</strong>tà, anche allora<br />
da due sacerdoti passati alla<br />
storia: Antonio Rosmini (1797-<br />
1855) 17 e Vincenzo Gioberti (1801-<br />
52) 18 le cui analisi e ipotesi <strong>di</strong> futuro<br />
nazionale rimangono esemplari<br />
nelle <strong>di</strong>atribe del tempo. 19<br />
Sembra pertanto indubbio<br />
che nel suo profi lo ideale, il Risor-<br />
28 ITALIA 150<br />
gimento italiano, almeno agli inizi,<br />
ebbe vocazione pluralista, fi glio <strong>di</strong><br />
più “padri” che si fecero portatori<br />
<strong>di</strong> progetti unitari <strong>di</strong>fferenti, tra i<br />
quali il pensiero e le ipotesi attuative<br />
dei cattolici, guidati da un<br />
clero illuminato, occupano una<br />
posizione <strong>di</strong> rilievo. 20<br />
Oltre l’unifi cazione nazionale<br />
I fatti e gli eventi che portarono<br />
all’Unità d’Italia sono sostanzialmente<br />
noti; la loro deco<strong>di</strong>fi cazione<br />
storica e ideale, un po’ meno.<br />
Certo è che fi n dai primi moti<br />
Fototeca Gilar<strong>di</strong><br />
Fototeca Gilar<strong>di</strong><br />
L’Italia prima<br />
dell’Unità, in un<br />
atlante del 1858.<br />
A sinistra: la presa<br />
<strong>di</strong> Porta Pia che per<br />
alcuni significò la<br />
volontà <strong>di</strong> annullare<br />
anche l’influenza del<br />
Vangelo sulla civiltà<br />
contemporanea.<br />
A destra: Pio IX<br />
(1792-1878) nel 1874<br />
promulgò il Non<br />
expe<strong>di</strong>t con il quale<br />
vietava ai cattolici la<br />
partecipazione alla<br />
vita politica.<br />
Italy before Unity,<br />
in a 1858 atlas.<br />
To the left: the<br />
taking of Porta Pia<br />
which, for some, even<br />
meant the will to<br />
cancel Gospel<br />
influence on modern<br />
civilisation.<br />
To the right: Pio IX<br />
(1792-1878) in 1874<br />
enacted the Non<br />
expe<strong>di</strong>t which<br />
forbade the Catholics<br />
to take any part<br />
in politics.<br />
piemontesi e lombar<strong>di</strong> apparve<br />
chiaro come l’aspirazione degli insorti<br />
fosse quella <strong>di</strong> una patria<br />
unita, con capitale Roma. Pure le<br />
brigate garibal<strong>di</strong>ne si mossero al<br />
grido «O Roma o morte». 21 Il teorema<br />
<strong>di</strong> Roma capitale <strong>di</strong>venne evidente<br />
nel settembre 1860, con<br />
l’occupazione militare delle Marche<br />
e dell’Umbria. La gravità dei<br />
fatti e <strong>di</strong>ffusi episo<strong>di</strong> <strong>di</strong> violenza,<br />
quali quelli che passarono alla<br />
storia con le Memorie dei Martiri <strong>di</strong><br />
Castelfi dardo, 22 colpirono la sensibilità<br />
dei cattolici, suscitando sdegno<br />
e <strong>di</strong>sapprovazione. Il presidente<br />
del Consiglio, tuttavia, il conte<br />
Camillo Benso <strong>di</strong> Cavour, abile<br />
“tessitore”, sperava <strong>di</strong> superare<br />
per via <strong>di</strong>plomatica le <strong>di</strong>ffi coltà internazionali<br />
della insorgente “Questione<br />
Romana” e quelle opposte<br />
<strong>di</strong>rettamente dalla Santa Sede,<br />
sostenuta dalla stragrande maggioranza<br />
dei cattolici <strong>di</strong> tutto il<br />
mondo. Preso poi atto delle persi-<br />
stenti contrarietà, lo stratega piemontese,<br />
appellandosi al principio<br />
da lui abilmente declinato: “Libera<br />
Chiesa in libero Stato”, 23 elaborò il<br />
noto <strong>di</strong>scorso del 25 marzo 1861<br />
alla Camera <strong>di</strong> Torino, concludendo<br />
che, in qualunque modo, per via<br />
<strong>di</strong> accor<strong>di</strong> o senza <strong>di</strong> essi, il Regno<br />
d’Italia sarebbe giunto a Roma e<br />
ne avrebbe fatto la sua capitale.<br />
Tali affermazioni per i cattolici suonarono<br />
come un chiaro inten<strong>di</strong>mento<br />
<strong>di</strong> portare fino alle sue<br />
estreme conseguenze la guerra <strong>di</strong><br />
aggressione in atto contro lo Stato<br />
Pontifi cio, privando <strong>di</strong> fatto il Papa<br />
della sua sovranità e autonomia.<br />
Anche altri convincimenti e<br />
timori andavano insorgendo nella<br />
sensibilità <strong>di</strong> taluni osservatori,<br />
cioè che l’astiosa lotta unilaterale
<strong>di</strong>chiarata al Papato in<br />
ciò che storicamente lo<br />
rappresentava, le sue<br />
terre, potesse nascondere<br />
inten<strong>di</strong>menti meno<br />
nobili, tesi ad annientare<br />
la Chiesa visibile,<br />
identifi cata appunto<br />
nello Stato Pontifi cio,<br />
per cancellare con esso<br />
la presenza del Vangelo<br />
dalla civiltà contemporanea.<br />
Sullo sfondo,<br />
l’ombra lunga della riforma<br />
protestante e<br />
quella più recente della<br />
rivoluzione francese.<br />
Ipotesi che stanno<br />
avendo qualche seguito<br />
tra ricercatori appassionati<br />
i quali si propongono<br />
<strong>di</strong> ricostruire e rivelare<br />
L’altro Risorgimento,<br />
24 cioè non quello uffi<br />
ciale che si legge sui<br />
manuali scolastici e <strong>di</strong>vulgativi,<br />
giu<strong>di</strong>cati retorici<br />
e reticenti, ma quello<br />
reale, meno laudativo,<br />
quale si evince da<br />
documentazioni, a loro<br />
<strong>di</strong>re, certe e volutamente sottaciute<br />
o travisate. 25<br />
È indubbio che anche all’epoca<br />
dei fatti il <strong>di</strong>sorientamento era<br />
profondo nelle coscienze non solo<br />
dei cattolici e si <strong>di</strong>ffondeva soprattutto<br />
tra le popolazioni <strong>di</strong>rettamente<br />
interessate agli acca<strong>di</strong>menti <strong>di</strong><br />
occupazione. I così detti Plebisciti<br />
popolari, si sa, furono improvvisazioni<br />
fi n troppo evidentemente illusorie.<br />
26 Nel contempo, le leggi<br />
piemontesi <strong>di</strong> laicizzazione, con il<br />
loro carico <strong>di</strong> durezze, furono applicate<br />
su tutto il territorio nazionale<br />
per limitare l’infl usso che la Chiesa<br />
esercitava sulla real tà sociale, occupando<br />
“spazi pubblici”, come la<br />
scuola, l’or<strong>di</strong>namento della famiglia,<br />
l’assistenza sanitaria, che il<br />
nuovo Stato liberale intendeva riven<strong>di</strong>care<br />
a sé.<br />
In questo clima <strong>di</strong> precarietà<br />
e sconcerto, per avviare i cattolici<br />
su una linea <strong>di</strong> condotta comune<br />
e coerente, scese in campo, fra gli<br />
altri, don Giacomo Margotti (1823-<br />
87) 27 il quale mutando il giornale<br />
Armonia che già <strong>di</strong>rigeva, in L’unità<br />
Fototeca Gilar<strong>di</strong> Photo Oilime<br />
Antonio Rosmini<br />
(1797-1855) e<br />
Vincenzo Gioberti<br />
(1801-52) <strong>di</strong>edero<br />
fondamentali<br />
contributi <strong>di</strong> pensiero<br />
e <strong>di</strong> proposte al<br />
<strong>di</strong>venire nazionale.<br />
Antonio Rosmini<br />
(1797-1855) and<br />
Vincenzo Gioberti<br />
(1801-52) made<br />
fundamental thought<br />
and proposal<br />
contributions to<br />
becoming a nation.<br />
glie esecutive che si proponevano <strong>di</strong><br />
eliminare almeno un prete per notte. È<br />
incomprensibile il muro <strong>di</strong> infasti<strong>di</strong>to<br />
silenzio con cui si cerca <strong>di</strong> sottacere la<br />
<strong>di</strong>ffusione del fenomeno. Sull’argomento<br />
si possono leggere le documentate<br />
pagine <strong>di</strong> Roberto BERRETTA, Storia dei<br />
Preti uccisi dai partigiani, Piemme, Casale<br />
M., 2005. Pure la popolare narrazione,<br />
ora anche in celluloide, <strong>di</strong> G.<br />
GUARESCHI: Don Camillo e l’onorevole Peppone,<br />
è in<strong>di</strong>cativa della presenza ra<strong>di</strong>cata<br />
del prete nella vicenda nazionale<br />
italiana.<br />
13) È noto che le armate sabaude<br />
parlavano francese: chi ha combattuto<br />
per l’Italia unita, dunque, non sapeva<br />
l’italiano, <strong>di</strong> qui, ma non solo, la preoccupazione<br />
del convinto e dotto italianista<br />
Alessandro Manzoni.<br />
14) L’apporto non solo letterario del<br />
Manzoni all’unità nazionale fu notevole<br />
anche se <strong>di</strong>vergente dalle strategie<br />
politiche poste in atto, ad esempio, da<br />
Cavour. Egli poteva apprezzare e con<strong>di</strong>videre<br />
l’aspirazione unitaria, ma restava<br />
sgomento all’idea che la patria<br />
si plasmasse attraverso l’aggressione,<br />
la violenza e la forza, specie se<br />
mercenaria. Rinunciò, non senza ripensamenti,<br />
alle tra<strong>di</strong>zioni linguistiche<br />
della sua terra lombarda per cercare<br />
in Arno un punto <strong>di</strong> comune<br />
confl uenza letteraria, perseguita con<br />
tenacia e talento, che gli valsero alti<br />
encomi. Nel 1859, su proposta <strong>di</strong><br />
Massimo d’Azeglio, che in prime nozze<br />
aveva sposato la primogenita <strong>di</strong> Manzoni,<br />
Giulia, e che fu poi presidente<br />
del Consiglio, in<strong>di</strong> Governatore a Milano,<br />
Vittorio Emanuele II gli decretava,<br />
a titolo <strong>di</strong> riconoscimento nazionale,<br />
l’annua pensione <strong>di</strong> lire do<strong>di</strong>cimila.<br />
L’anno seguente veniva nominato senatore<br />
del Regno. Egli, tuttavia, non<br />
partecipò mai in Roma alle sedute del<br />
Senato, nonostante le sollecitazioni<br />
dello stesso Garibal<strong>di</strong> durante la visita<br />
<strong>di</strong> omaggio che gli rese a casa sua,<br />
passando da Milano.<br />
15) Del primato morale e civile degli<br />
italiani, vol. I, Milano, Allegranza, 1944,<br />
p. 323.<br />
16) Monografi a e<strong>di</strong>ta da Longanesi<br />
nel 1993.<br />
17) Nel 1848 propugnò il costituirsi<br />
<strong>di</strong> una confederazione italiana sotto la<br />
presidenza del papa, retta da istituti<br />
liberali (cfr. la sua pubblicazione: La<br />
costituzione secondo la giustizia sociale,<br />
1948). Nello stesso anno ebbe da Carlo<br />
Alberto l’incarico <strong>di</strong> una missione<br />
<strong>di</strong>plomatica presso Pio IX per trattare<br />
l’adesione del papa alla lega degli Stati<br />
italiani e alla guerra <strong>di</strong> in<strong>di</strong>pendenza.<br />
Il pontefi ce lo trattenne in Vaticano per<br />
nominarlo car<strong>di</strong>nale, ma l’uccisione <strong>di</strong><br />
Pellegrino Rossi e il ritiro del papa a<br />
Gaeta interruppero bruscamente la già<br />
avanzata procedura.<br />
18) Esponente tra i maggiori del cosiddetto<br />
neoguelfi smo risorgimentale,<br />
conobbe l’esilio e, successivamente,<br />
occupò posizioni <strong>di</strong> rilievo in ambito politico.<br />
Nel suo noto trattato: Il Primato<br />
morale e civile degli Italiani (1843), anch’egli<br />
auspica una confederazione degli<br />
Stati italiani, con a capo il pontefi ce.<br />
Punto costante <strong>di</strong> riferimento e <strong>di</strong> forza:<br />
la gloriosa Roma dei papi, vanto e onore<br />
dell’intera nazione italiana e <strong>di</strong> tutto<br />
l’Occidente.<br />
19) Sulla loro ipotesi si mosse poi<br />
Napoleone III, che aveva assunto l’impegno<br />
<strong>di</strong> <strong>di</strong>fendere con le armi la persona<br />
del papa. Egli, il 14 luglio 1859,<br />
propose uffi cialmente a Pio IX <strong>di</strong> accettare<br />
la presidenza dell’erigenda confederazione<br />
italiana, mettendosi a capo<br />
del processo <strong>di</strong> unifi cazione nazionale.<br />
Una profferta che non ebbe, né poteva<br />
avere seguito.<br />
20) Che neppure Cavour, Mazzini e<br />
Garibal<strong>di</strong> avessero le stesse idealità<br />
politiche, è noto. Cfr. Alfonso SCIROCCO,<br />
In <strong>di</strong>fesa del Risorgimento, Bologna, il<br />
Mulino, 1998; “Civiltà Cattolica”, n.<br />
3839, 5 giugno 2010, L’unità d’Italia,<br />
pp. 423-429.<br />
21) Il motto fu inciso pure nella base<br />
del monumento equestre <strong>di</strong> Garibal<strong>di</strong><br />
sul Gianicolo, anche se nella notte precedente<br />
l’inaugurazione del 1895, la<br />
scritta venne ironicamente ridotta in «O<br />
Roma o Orte», imme<strong>di</strong>atamente ricomposta.<br />
22) Cfr. e<strong>di</strong>zione con pari titolo a cura<br />
della Tecnostampa <strong>di</strong> Recanati, giugno<br />
2009.<br />
23) In realtà, l’espressione era stata<br />
assai precedentemente elaborata dai<br />
cattolici francesi per <strong>di</strong>fendere la libertà<br />
della Chiesa dalle indebite ingerenze<br />
dello Stato secolare. Cavour la usurpò,<br />
stravolgendone il senso originale.<br />
24) A titolo esemplifi cativo si possono<br />
citare gli stu<strong>di</strong> e gli approfon<strong>di</strong>menti<br />
in tal senso condotti da Angela PELLICIA-<br />
RI, tra i quali: L’Altro Risorgimento, E<strong>di</strong>zione<br />
Piemme, collana Le Cattedrali del<br />
tempo. In apertura si legge: «Una guerra<br />
<strong>di</strong> religione <strong>di</strong>menticata, se si guarda<br />
alla storiografi a uffi ciale, quella insegnata<br />
nelle scuole…» come pure l’altra<br />
sua pubblicazione: Risorgimento da riscrivere,<br />
liberali e massoni contro la<br />
Chiesa, Ares, 1998.<br />
25) Sembra, infatti, evidente che,<br />
almeno fi no al 1859 gli insuccessi furono<br />
notevoli: le Cinque Giornate <strong>di</strong><br />
Milano fallirono; a Curtatone e Montanara<br />
i volontari vennero <strong>di</strong>spersi; i Comitati<br />
insurrezionali a Belfi ore furono<br />
sgominati. Bisogna attendere la battaglia<br />
<strong>di</strong> Solferino e San Martino del 24<br />
giugno 1859, l’anno della Seconda<br />
Guerra d’In<strong>di</strong>pendenza, con l’ausilio<br />
della consistente armata francese,<br />
perché le lotte risorgimentali volgano<br />
al meglio.<br />
ITALIA 150 29
cattolica, intese dar voce unitaria<br />
alla reazione dei fedeli al pontefi -<br />
ce. Correva l’anno 1863, poco<br />
dopo cioè la proclamazione del<br />
Regno Italico, in una nutrita serie<br />
<strong>di</strong> articoli lanciò e sostenne la tesi<br />
<strong>di</strong> una doverosa astensione <strong>di</strong><br />
protesta dei cattolici italiani dalla<br />
vita politica, anche per non rendersi<br />
conniventi della violenta azione<br />
usurpatrice e settaria in atto, decisamente<br />
condannata dalla morale<br />
cristiana e non solo. Quin<strong>di</strong> «Né<br />
eletti, né elettori» fu la sua conclusione.<br />
Porre in atto una resistenza<br />
attiva, a fronte delle prevaricazioni<br />
<strong>di</strong>laganti, appariva non solo ineffi -<br />
cace, ma controproducente.<br />
Le affermazioni <strong>di</strong> don Margotti,<br />
le quali convinsero ben presto<br />
le coscienze dei suoi lettori,<br />
non potevano avere che valore <strong>di</strong><br />
opinione personale o <strong>di</strong> consiglio<br />
morale, ma soprattutto a seguito<br />
della enfatizzata presa <strong>di</strong> Roma<br />
del 1870 <strong>di</strong>vennero convincimento<br />
<strong>di</strong>ffuso. In quello stesso anno<br />
alcuni deputati particolarmente<br />
sensibili e noti, con gesto <strong>di</strong> vasta<br />
risonanza, rinunciarono al<br />
mandato parlamentare. Primi fra<br />
essi, il barone palermitano Vito<br />
d’Ondes Reggio e poi il marchese<br />
emiliano Ottavio <strong>di</strong> Canossa. La<br />
linea astensionista andava decisamente<br />
consolidandosi a fronte<br />
delle sempre più audaci sopraffazioni<br />
nei confronti del pontefi ce e<br />
delle sovrane prerogative correlate<br />
al libero svolgimento del suo<br />
supremo ministero.<br />
Il Magistero<br />
e la “Questione Romana”<br />
La Santa Sede, tuttavia, fedele<br />
alla sua vocazione <strong>di</strong> paziente<br />
attesa, scelse <strong>di</strong> temporeggiare<br />
nella mai perduta speranza <strong>di</strong> un<br />
ripensamento da parte del potere<br />
invasore e <strong>di</strong> una soluzione concordata<br />
dell’aperta vertenza. I suoi<br />
interventi, tutti <strong>di</strong> principio, mai<br />
personalistici, furono misurati, graduali<br />
e <strong>di</strong>lazionati negli anni. 28<br />
Per una prima presa <strong>di</strong> posizione<br />
esplicita occorre attendere<br />
il decreto della Santa Penitenzieria<br />
Apostolica del 10 settembre<br />
1874, che, nella sostanza, faceva<br />
proprie le tesi astensionistiche <strong>di</strong><br />
30 ITALIA 150<br />
I pontificati <strong>di</strong><br />
Leone XIII<br />
(1810-1903),<br />
Pio X (1835-1914)<br />
e Benedetto XV<br />
(1854-1922) videro<br />
nascere nuovi<br />
orientamenti che<br />
favorirono la revoca<br />
dell’astensionismo<br />
politico dei cattolici.<br />
The pontificates of<br />
Leone XIII (1810-<br />
1903), Pio X<br />
(1835-1914) and<br />
Benedetto XV<br />
(1854-1922) led to<br />
new orientation<br />
favouring cancellation<br />
of political nonparticipation<br />
by<br />
Catholics.<br />
don Margotti. Ne seguirono, tra i<br />
cattolici, <strong>di</strong>scussioni e <strong>di</strong>atribe<br />
anche accese, sembrando a qualcuno<br />
che il Non expe<strong>di</strong>t proposto<br />
significasse inopportunità, ma<br />
non assoluto <strong>di</strong>vieto; vi furono<br />
anzi <strong>di</strong>ffusi tentativi <strong>di</strong> spingere i<br />
cattolici alle urne nell’imminenza<br />
delle elezioni politiche e, fra l’altro,<br />
dai più irriducibili si faceva osservare<br />
che il Papa non si era mai<br />
<strong>di</strong>rettamente pronunciato in proposito.<br />
Intervenne allora Pio IX, il<br />
quale, con un Breve del 29 gennaio<br />
1877 al Consiglio Superiore<br />
della Gioventù Cattolica, riprovava<br />
il tentativo <strong>di</strong> indurre i cattolici alle<br />
urne, mentre la Santa Sede non<br />
aveva ancora defi nito se fosse<br />
lecito e a quali con<strong>di</strong>zioni prendervi<br />
parte. L’autorevole intervento<br />
troncò l’azione interventista <strong>di</strong>retta,<br />
ma non la <strong>di</strong>scussione circa<br />
l’opportunità <strong>di</strong> agire in opposizione<br />
alle evidenti violenze e infl uenze<br />
settarie in atto, nell’interesse<br />
stesso della Santa Sede.<br />
Soltanto il 30 giugno 1888<br />
un Decreto della Congregazione<br />
del Sant’Uffi zio, approvato da Leone<br />
XIII, 29 sentenziò che, per ragioni<br />
<strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne superiore, il Non expe<strong>di</strong>t<br />
includeva una vera e propria proibizione,<br />
trasformando quin<strong>di</strong> l’astensione<br />
in comando. Nella comune<br />
coscienza cattolica, tuttavia,<br />
pur mostrando rispetto alla<br />
<strong>di</strong>sposizione papale, si fece strada<br />
il convincimento che, a causa<br />
del prevalere <strong>di</strong> correnti eversive,<br />
si rendeva sempre più doverosa<br />
una presenza attiva dei cattolici<br />
sullo scenario politico nazionale.<br />
Venne così alla ribalta, tra le altre,<br />
una personalità <strong>di</strong> singolare rilie-<br />
vo: Filippo Meda (1869-1939), 30<br />
oratore convincente ed eru<strong>di</strong>to,<br />
avvocato cattolico <strong>di</strong> rara coerenza<br />
e <strong>di</strong> pari modestia, che si mosse<br />
con accortezza e abilità, puntando<br />
decisamente ai vertici dell’azione<br />
politica. Fu, infatti, eletto<br />
deputato nel 1909: non ebbe né<br />
esitazione, né dubbi a can<strong>di</strong>darsi<br />
con la espressa volontà <strong>di</strong> raggiungere<br />
poi posizioni <strong>di</strong> massima<br />
responsabilità nella futura compagine<br />
governativa, mostrando così<br />
all’evidenza e in concreto che il<br />
preoccupante “sistema” nazionale<br />
si può e si deve migliorare dal<br />
<strong>di</strong> dentro, più che dal <strong>di</strong> fuori. Tale<br />
sua persuasione, soprattutto il<br />
suo esempio e la sua autorevolezza,<br />
in un contesto ormai avanzato,<br />
fecero strada a nuovi orientamenti.<br />
La morte <strong>di</strong> Leone XIII nel 1903<br />
e l’elezione <strong>di</strong> Pio X 31 portarono<br />
all’auspicato mutamento del Magistero.<br />
L’attesa tra i cattolici era<br />
viva, anche in vista delle elezioni<br />
politiche indette per il novembre<br />
del 1904. Pio X, d’animo mite e<br />
sommamente de<strong>di</strong>to al bene spirituale<br />
dei fedeli, confermò le precedenti<br />
proteste per l’usurpazione<br />
dello Stato Pontifi cio e, in linea <strong>di</strong><br />
massima, anche il <strong>di</strong>vieto ai cattolici<br />
<strong>di</strong> prendere parte alla politica<br />
attiva, ma concesse ampie deroghe<br />
in molti casi segnalati dai vescovi.<br />
Fu l’anticipo <strong>di</strong> quanto poi<br />
egli <strong>di</strong>spose con l’enciclica Il fermo<br />
proposito dell’11 agosto 1905<br />
nella quale, per riguardo ai suoi<br />
predecessori, ancora non abolì<br />
espressamente il Non expe<strong>di</strong>t,<br />
ma, <strong>di</strong> fatto, aperse ai cattolici<br />
l’a<strong>di</strong>to alla vita politica, a modo <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>spensa, tutte le volte che la loro
partecipazione fosse riconosciuta<br />
dai vescovi, autorizzati a concederla<br />
per il bene supremo della<br />
Chiesa e della società. Così egli,<br />
lasciando impregiu<strong>di</strong>cata la “Questione<br />
Romana”, con gesto coraggioso<br />
e lungimirante, si faceva<br />
carico del l’interesse morale non<br />
solo della Chiesa, ma dell’intera<br />
nazione italiana. Dopo più <strong>di</strong> un<br />
trentennio, si ebbero elettori cattolici<br />
e, se non deputati cattolici,<br />
sicuramente cattolici deputati. 32<br />
Pio X preparò così il terreno al suo<br />
successore Benedetto XV che, nel<br />
1919, consentendo ai credenti <strong>di</strong><br />
aderire al Partito <strong>Popolare</strong> <strong>di</strong> don<br />
Luigi Sturzo, <strong>di</strong> fatto revocò ogni<br />
precedente imposizione <strong>di</strong> astensionismo<br />
politico.<br />
Bisogna, tuttavia, aspettare il<br />
ra<strong>di</strong>omessaggio natalizio <strong>di</strong> Pio XII<br />
del 1942 su l’“Or<strong>di</strong>ne interno delle<br />
nazioni” perché il magistero pontifi<br />
cio riconosca elementi valoriali al<br />
principio della democrazia rappresentativa<br />
che legittimino l’impegno<br />
cattolico <strong>di</strong>retto nel l’agone<br />
politico. Il Concilio Vaticano II e il<br />
conseguente Magistero degli ultimi<br />
papi 33 hanno certamente incoraggiato<br />
i cattolici ad impegnarsi<br />
senza ambiguità nel l’ambito delle<br />
attuali democrazie politiche, sempre<br />
però sottolineando che è solo<br />
il riconoscimento e la tutela dei<br />
“valori forti” (quelli della persona<br />
umana e quelli riguardanti la giustizia<br />
sociale) che fondano un autentico<br />
or<strong>di</strong>namento politico e sociale<br />
in cui si giustifi chi l’impegno <strong>di</strong>retto<br />
dei credenti. 34<br />
Anche le trage<strong>di</strong>e della Prima<br />
e della Seconda Guerra mon<strong>di</strong>ale,<br />
con il loro immane carico <strong>di</strong> sofferenze<br />
e <strong>di</strong> morti da tutte le terre<br />
italiane e, negli anni del secondo<br />
dopoguerra, la nascita <strong>di</strong> nuove e<br />
gran<strong>di</strong> democrazie europee, il bisogno<br />
incontenibile <strong>di</strong> libertà e <strong>di</strong> una<br />
sempre maggiore partecipazione<br />
politica, impressero, all’azione dei<br />
cattolici italiani, vigore e determinazione,<br />
prelu<strong>di</strong>o alla formazione<br />
<strong>di</strong> partiti <strong>di</strong> massa a ispirazione<br />
cristiana.<br />
Questi, in breve, i precedenti<br />
storici ed etici che fanno da presupposto<br />
all’azione dei tre sacerdoti<br />
in esame.<br />
DON LUIGI STURZO<br />
Alla frontiera <strong>di</strong> due mon<strong>di</strong>:<br />
democrazia popolare<br />
o totalitarismo ateo<br />
«Il partito popolare <strong>di</strong> don Sturzo<br />
è l’avvenimento più notevole e tipico<br />
della storia italiana <strong>di</strong> questo<br />
secolo» (Federico Chabod)<br />
L’ingresso compatto e determinante<br />
dei cattolici nella politica<br />
dell’Italia unita si ebbe, in realtà,<br />
con l’azione decisiva <strong>di</strong> don Luigi<br />
Sturzo, sacerdote siciliano che<br />
raccolse con intelligenza e lungimiranza<br />
le precedenti aspirazioni e le<br />
potenzialità del mondo cristiano,<br />
realizzandole efficacemente. In<br />
particolare, attinse al patrimonio<br />
ideale <strong>di</strong> un altro sacerdote, parimenti<br />
sensibile, meno fortunato<br />
per l’asprezza del carattere e<br />
l’estremismo ideologico: don Romolo<br />
Murri, 35 egli pure assertore<br />
convinto della partecipazione attiva<br />
dei cattolici a tutti i livelli della<br />
vita politica nazionale, in tempi in<br />
cui tali convincimenti erano giu<strong>di</strong>cati<br />
con sospetto.<br />
Don Sturzo, una vita e una<br />
vocazione al sacerdozio come tante;<br />
i dati anagrafi ci e biografi ci so-<br />
Fototeca Gilar<strong>di</strong><br />
L’azione <strong>di</strong> don Luigi<br />
Sturzo (1871-1959),<br />
fondatore del Partito<br />
<strong>Popolare</strong>, favorì<br />
l’ingresso ufficiale e<br />
determinante dei<br />
cattolici nella vita<br />
politica italiana.<br />
The actions of don<br />
Luigi Sturzo<br />
(1871-1959), founder<br />
of the Popular Party,<br />
favoured official,<br />
decisive involvement<br />
of Catholics in the<br />
Italian political life.<br />
26) La partecipazione popolare agli<br />
acca<strong>di</strong>menti politici fu assai ristretta:<br />
all’inizio era chiamato alle urne solo il<br />
due-tre per cento della popolazione maschile.<br />
Soprattutto il ceto rurale notoriamente<br />
<strong>di</strong> militanza cattolica, veniva<br />
emarginato. Si cercò poi <strong>di</strong> blan<strong>di</strong>rlo<br />
abilmente promettendogli l’assegnazione<br />
delle terre che lavorava a mezzadria<br />
o in affi tto (Cfr. Idee <strong>di</strong> rappresentanza<br />
e sistemi elettorali in Italia tra Otto e<br />
Novecento, a cura <strong>di</strong> Pier Luigi BELLINI,<br />
Istituto Veneto <strong>di</strong> Scienze, Lettere ed<br />
Arti, 1997).<br />
27) La sua vita è legata a quella del<br />
giornale L’armonia della religione con la<br />
civiltà, che egli fondò e <strong>di</strong>resse dal<br />
1848 al 1863. Organo dell’opposizione<br />
cattolica al liberalismo cavouriano, <strong>di</strong>fese<br />
con decisione i <strong>di</strong>ritti della Santa<br />
Sede. La politica interna ed estera del<br />
Regno <strong>di</strong> Sardegna dettò a don Margotti,<br />
tempra eccezionale <strong>di</strong> polemista,<br />
violenti articoli, affrontando e denunciando<br />
i continui sequestri del giornale<br />
e le personali vessazioni, giunte più<br />
d’una volta all’arresto per vilipen<strong>di</strong>o delle<br />
costituzioni. Leale avversario <strong>di</strong> Cavour,<br />
il quale personalmente nutriva per<br />
lui sincera ammirazione, de<strong>di</strong>cò alla<br />
immatura scomparsa dell’uomo politico,<br />
avvenuta il 6 giugno 1861, un commosso<br />
necrologio, letto, ammirato e<br />
con<strong>di</strong>viso in Italia e in tutte le corti europee.<br />
Eletto deputato nel 1857, non<br />
poté sedere alla Camera perché canonico,<br />
avendo il governo <strong>di</strong>chiarato non<br />
eleggibili gli ecclesiastici in cura d’anime.<br />
Per espresso desiderio <strong>di</strong> Pio IX,<br />
nel 1863, lasciò la <strong>di</strong>rezione dell’Armonia,<br />
si trasferì a Firenze, per fondare e<br />
<strong>di</strong>rigere, con maggiore moderazione,<br />
L’unità cattolica.<br />
28) I gravi documenti pontifi ci <strong>di</strong> condanna<br />
dell’aggressione allo Stato della<br />
Chiesa non contengono nomi o riferimenti<br />
personali, mai citato Vittorio<br />
Emanuele II o Cavour, Garibal<strong>di</strong>, Mazzini.<br />
La questione non era personale, ma<br />
<strong>di</strong> principio.<br />
29) Con l’elezione <strong>di</strong> Leone XIII, dopo<br />
il lungo Pontifi cato <strong>di</strong> Pio IX, i cattolici<br />
moderati attendevano cambiamenti<br />
nell’in<strong>di</strong>rizzo politico circa il nuovo Stato<br />
unitario. I suoi primi interventi ne palesarono<br />
l’orientamento: fermezza sui<br />
principi, attenzione alle nuove emergenze<br />
sociali, per le quali soprattutto il<br />
laicato cattolico era chiamato a operare;<br />
nessuna ostilità nei confronti del<br />
nuovo Stato italiano, semmai dare alle<br />
questioni in atto un contenuto nuovo,<br />
non meramente riven<strong>di</strong>cativo, senza<br />
nulla rinnegare <strong>di</strong> quanto il suo predecessore<br />
aveva <strong>di</strong>sposto.<br />
30) Filippo Meda, presidente dell’Azione<br />
Cattolica milanese, <strong>di</strong>ede all’astensione<br />
dei cattolici dalle urne il valore <strong>di</strong><br />
un semplice <strong>di</strong>vieto pontifi cio, che non<br />
aveva carattere né dogmatico, né asso-<br />
ITALIA 150 31
no noti per cui possono bastare<br />
brevi cenni <strong>di</strong> riferimento. Nacque<br />
a Caltagirone <strong>di</strong> Catania il 26 novembre<br />
1871 da genitori ferventi<br />
cattolici, modesti proprietari terrieri,<br />
fi eri della loro atavica nobiltà e<br />
militanza in ambito ecclesiale. 36<br />
Dopo un regolare cursus stu<strong>di</strong>orum<br />
seminaristico, fu sacerdote il 19<br />
maggio 1894. Continuò gli stu<strong>di</strong> a<br />
Roma con il <strong>di</strong>ploma in fi losofi a e<br />
la laurea in teologia; nel contempo<br />
coltivò anche altre <strong>di</strong> scipline a lui<br />
care, quali la giurisprudenza, la<br />
sociologia e la musica, dando<br />
prova <strong>di</strong> notevole duttilità e apertura<br />
intellettuale.<br />
Durante il soggiorno romano<br />
incontrò personalità cattoliche<br />
convintamente votate al bene comune,<br />
quali Giuseppe Toniolo 37 e<br />
lo stesso don Romolo Murri, che<br />
lo avviarono ai problemi sociali <strong>di</strong><br />
carattere nazionale e politico. Per<br />
cui la realtà italiana interessò fi n<br />
dall’inizio il suo ministero e magistero.<br />
Fondò circoli e riviste, pubblicò<br />
articoli e libri, si pro<strong>di</strong>gò in<br />
conferenze e congressi. In tal modo,<br />
ancor giovane, si affermò come<br />
personalità politica <strong>di</strong> spicco<br />
nel mondo cattolico. Con il consenso<br />
della Santa Sede, nel 1904 fu<br />
nominato Commissario prefettizio<br />
<strong>di</strong> Caltagirone e l’anno dopo ne<br />
<strong>di</strong>venne pro-sindaco; conservò<br />
tale incarico per quin<strong>di</strong>ci<br />
anni, fi no al 1920, procurando<br />
alla sua città benefi -<br />
ci e progressi considerevoli,<br />
soprattutto per i ceti<br />
meno abbienti. Nel frattempo,<br />
entrò a far parte<br />
del Consiglio provinciale<br />
<strong>di</strong> Catania; nel 1915 <strong>di</strong>venne<br />
vicepresidente<br />
dell’Associazione fra i<br />
comuni d’Italia (ANCI),<br />
che lui stesso aveva<br />
contribuito a fondare.<br />
Negli anni<br />
1915-17, chiamato<br />
da Benedetto XV, fu<br />
segretario generale<br />
della giunta <strong>di</strong>rettivadell’Azione<br />
Cattolica. Nel<br />
contempo la<br />
scena politica<br />
italiana muta-<br />
32 ITALIA 150<br />
Nel 1952 don Luigi<br />
Sturzo venne<br />
nominato senatore<br />
della Repubblica<br />
Italiana con<br />
l’esplicito assenso <strong>di</strong><br />
Pio XII (1876-1958).<br />
In 1952 don Luigi<br />
Sturzo became a<br />
senator of the Italian<br />
Republic with the<br />
explicit consent of<br />
Pio XII (1876-1958).<br />
Photo Oilime<br />
va profondamente: il dopoguerra si<br />
presentava problematico e incerto,<br />
carico <strong>di</strong> rischi e <strong>di</strong> pericoli,<br />
primo fra tutti, il fascismo prorompente.<br />
Don Sturzo comprese che<br />
era giunta l’ora <strong>di</strong> agire. Il 18 gennaio<br />
1919, da una stanza dell’albergo<br />
S. Chiara in Roma, lanciava<br />
il suo appello «a tutti gli uomini liberi<br />
e forti» per dar vita al Partito<br />
<strong>Popolare</strong>, fondato «sulla morale<br />
cristiana e sulla libertà», ispirato al<br />
pensiero sociale della Chiesa, ma<br />
con un programma aconfessionale,<br />
così da non coinvolgere responsabilità<br />
ecclesiastiche. Frattanto<br />
l’ascesa del fascismo sembrava<br />
inarrestabile e il conseguente assolutismo<br />
politico <strong>di</strong> Benito Mussolini<br />
andava affermandosi senza<br />
esclusione <strong>di</strong> strategie, anche<br />
violente. 38 Chi non era con lui, era<br />
un nemico da eliminare. In questo<br />
clima <strong>di</strong>ttatoriale, don Sturzo, segretario<br />
<strong>di</strong> un partito popolare non<br />
allineato, era evidentemente un<br />
elemento <strong>di</strong> forte <strong>di</strong>sturbo. Sui<br />
giornali cominciarono ad apparire<br />
attacchi <strong>di</strong>retti e vignette caricaturali<br />
della sua persona; gli appellativi<br />
più benevoli: uomo nefasto,<br />
visionario, rimbambito… 39 Il 25<br />
ottobre 1924, don Sturzo, a 53<br />
anni, con un passaporto della<br />
Santa Sede, salì sul treno per<br />
Londra, facendo breve tappa a<br />
Parigi. Prese alloggio in un sobborgo<br />
lon<strong>di</strong>nese ove rimase fi no<br />
al 1940, quando, <strong>di</strong>chiarata guerra<br />
dall’Italia alla Gran Bretagna,<br />
dovette riparare negli Stati Uniti<br />
d’America. 40 Il 9 novembre 1926<br />
Mussolini d’autorità sciolse il Partito<br />
<strong>Popolare</strong> Italiano. 41<br />
Finita la guerra, dopo due<br />
rinvii forzati, il 27 agosto 1946,<br />
poté fi nalmente imbarcarsi sulla<br />
nave Vulcania per il ritorno in patria.<br />
Rivide Napoli, non senza<br />
commozione, il 6 settembre, <strong>di</strong><br />
sera. Aveva settantacinque anni,<br />
<strong>di</strong> cui ventidue passati in<br />
esilio. Incominciò un interminabile<br />
pellegrinaggio alle soglie <strong>di</strong><br />
casa sua, soglie che videro alternarsi,<br />
fra gli altri illustri, Benedetto<br />
Croce, Finocchiaro<br />
Aprile, Nenni e Togliatti. Vi si<br />
recò anche monsignor Montini,<br />
poi Paolo VI, allora prose-<br />
gretario <strong>di</strong> Stato <strong>di</strong> Sua Santità Pio<br />
XII; vi sarebbe ritornato appositamente<br />
da Milano il giorno del suo<br />
funerale. I frequentatori più assidui<br />
erano però i poveri e i bisognosi<br />
della sua terra, che il confl itto<br />
violento e l’occupazione straniera<br />
avevano ridotto in miseria. Presso<br />
l’Istituto “Luigi Sturzo” in via delle<br />
Coppelle a Roma sono conservati<br />
lunghi scaffali <strong>di</strong> cartelle che raccolgono<br />
missive <strong>di</strong> varia forma e<br />
<strong>di</strong>mensione, inviategli per lo più,<br />
da povera gente, che lui aveva<br />
benefi ciato. 42<br />
L’Italia stava vivendo una stagione<br />
<strong>di</strong> storici cambiamenti: dalla<br />
monarchia alla repubblica, al sorgere<br />
dei partiti nazionali, sud<strong>di</strong>visi<br />
nei loro interni schieramenti, in fi -<br />
loamericani e fi lorussi, rispettivamente<br />
la Democrazia Cristiana<br />
(DC) e il Partito Comunista Italiano<br />
(PCI). Il confronto apparve subito<br />
aspro e decisivo: la mobilitazione<br />
non solo politica e partitica, fu<br />
ampia e <strong>di</strong>ffusa; lo stesso Pio XII<br />
e il Vaticano seguivano con preoccupazione<br />
l’evolversi del quadro<br />
politico italiano, consapevoli delle<br />
conseguenze negative <strong>di</strong> un’affermazione<br />
del Fronte <strong>Popolare</strong>, che<br />
vedeva uniti socialisti e comunisti,<br />
i quali si andavano caratterizzando<br />
come forze politiche anticlericali e<br />
antireligiose, oltre che fi losovietiche.<br />
Per fronteggiare il pericolo,<br />
don Sturzo, con intuizione geniale,<br />
non rievocò il Partito <strong>Popolare</strong>,<br />
espressione politica d’altri tempi e<br />
da taluni giu<strong>di</strong>cato <strong>di</strong> stampo prettamente<br />
meri<strong>di</strong>onalista, ma, con<br />
altri fi dati collaboratori, tra i primi,<br />
Alcide De Gasperi, <strong>di</strong>ede vita alla<br />
Democrazia Cristiana come partito<br />
del l’Italia cattolica e moderata,<br />
strumento <strong>di</strong> coesione sociale intorno<br />
ai valori cristiani da immettere<br />
nella democrazia parlamentare.<br />
Il 18 aprile 1948 la nuova formazione<br />
politica vinse le elezioni, fi ssando<br />
la collocazione netta dell’Italia<br />
nella zona politica occidentale<br />
e cristiana.<br />
Don Sturzo poteva ritenersi<br />
appagato delle sue sofferenze e<br />
fatiche. La sua impostazione dell’Italia<br />
unita aveva trionfato, scongiurato<br />
anche il pericolo <strong>di</strong> un’egemonia<br />
sovietica sul nostro Paese.
Nessuna sorpresa<br />
pertanto suscitò<br />
la sua nomina<br />
a senatore da<br />
parte del primo<br />
presidente della<br />
Repubblica Italiana,<br />
Luigi Einau<strong>di</strong>,<br />
il 18 settembre<br />
1952, previo assenso<br />
esplicito <strong>di</strong><br />
Pio XII e del vescovo<br />
<strong>di</strong> Caltagirone,<br />
richiesti dallo<br />
stesso don Luigi.<br />
A seguito <strong>di</strong> tale nomina, entrò<br />
a far parte della V Commissione<br />
“Finanze e Tesoro” del Senato.<br />
Nell’aula <strong>di</strong> Palazzo Madama si<br />
contano una ventina <strong>di</strong> suoi interventi,<br />
tutti marcatamente <strong>di</strong> carattere<br />
programmatico per la rinascita<br />
del l’Italia unita. Non mancarono<br />
<strong>di</strong>ssensi e non solo fra l’opposizione,<br />
ma la sua linea rimase coerente<br />
ai principi cristiani e il suo pensiero<br />
sempre volto al bene e al<br />
progresso della nazione.<br />
Portata così a termine la sua<br />
storica missione, anche la sua<br />
giornata terrena volse al termine.<br />
Il 23 luglio 1959 celebrò la sua<br />
ultima Messa, al termine della<br />
quale fu colpito da collasso. L’agonia<br />
si protrasse per se<strong>di</strong>ci giorni,<br />
durante i quali ebbe il conforto<br />
della bene<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> Giovanni<br />
XXIII. 43 Sabato 8 agosto, alle ore<br />
16,45, spirò. Aveva da poco varcato<br />
la soglia degli ottantotto anni. I<br />
funerali segnarono il vertice della<br />
sua popolarità. Un’incontenibile<br />
folla rese devoto omaggio al venerando<br />
patriarca dei nostri tempi,<br />
Mosè re<strong>di</strong>vivo, guida <strong>di</strong> una nazione<br />
pericolante che egli seppe traghettare<br />
oltre il Mar Rosso del<br />
comunismo ateo e il deserto arido<br />
<strong>di</strong> una rovinosa guerra perduta. Le<br />
sue spoglie deposte temporaneamente<br />
nella cripta della basilica <strong>di</strong><br />
San Lorenzo al Verano, il 3 giugno<br />
1962 vennero traslate a Caltagirone,<br />
vicino alla casa paterna, in un<br />
monumentale mausoleo realizzato<br />
su proposta dei suoi <strong>di</strong>scepoli,<br />
dalla Presidenza del Consiglio dei<br />
Ministri nella chiesa del SS. Salvatore,<br />
ove aveva celebrato la sua<br />
prima Messa, nel 1894.<br />
Don Luigi Sturzo nel<br />
suo stu<strong>di</strong>o.<br />
Don Luigi Sturzo in<br />
his office.<br />
Fototeca Gilar<strong>di</strong><br />
luto, la cui sopravvivenza era legata<br />
esclusivamente alla volontà “privata”<br />
del pontefi ce. Di qui le sue decise e<br />
decisive iniziative politiche.<br />
31) Eletto in un conclave piuttosto<br />
agitato a seguito del veto dell’Austria<br />
nei confronti del noto car<strong>di</strong>nale Raffaele<br />
Mèrry del Val, nominato poi segretario<br />
<strong>di</strong> Stato, Giuseppe Sarto, trevisano<br />
<strong>di</strong> Riese, assunse come motto,<br />
l’espressione <strong>di</strong> san Paolo: «Instaurare<br />
omnia in Christo» e si <strong>di</strong>ede con tutte<br />
le forze al governo spirituale della<br />
Chiesa. D’animo mite e conciliante,<br />
cercò sempre la pacifi cazione e l’intesa,<br />
ispirandosi esclusivamente allo<br />
spirito evangelico.<br />
32) Un primo ingresso signifi cativo<br />
dei cattolici in politica si ebbe con il<br />
noto Patto Gentiloni dal nome del presidente<br />
dell’Unione Elettorale cattolica,<br />
stipulato nel 1913, in occasione delle<br />
prime elezioni politiche a suffragio universale<br />
maschile. L’avanzare delle sinistre<br />
rappresentava un pericolo reale<br />
per una loro totale occupazione del Parlamento.<br />
Pio X, consapevole del pericolo,<br />
temendo un inasprimento della<br />
“Questione Romana”, acconsentì che<br />
Gentiloni <strong>di</strong>ramasse una circolare ai<br />
<strong>di</strong>rigenti delle associazioni cattoliche in<br />
cui si enucleavano i sette punti che i<br />
can<strong>di</strong>dati ministeriali, per lo più <strong>di</strong> fede<br />
giolittiana, dovevano accettare per ricevere<br />
il sostegno cattolico. Tra le richieste<br />
più signifi cative fi gurava la tutela<br />
della scuola privata, l’istruzione religiosa<br />
nelle scuole pubbliche, un trattamento<br />
non <strong>di</strong>scriminatorio delle organizzazioni<br />
cattoliche. I can<strong>di</strong>dati liberali<br />
accettarono, contando sull’appoggio<br />
della rete capillare e organizzativa delle<br />
parrocchie. L’accordo, pur non arrestando<br />
l’avanzata della formazione socialista,<br />
che raddoppiò quasi i propri deputati,<br />
riuscì a garantire la stabilità ai<br />
governanti. Il patto aveva retto e funzionato,<br />
lasciando ben sperare anche per<br />
il futuro.<br />
33) Il Concilio Vaticano II, nel Decreto<br />
Gau<strong>di</strong>um et spes, così si esprime: «Tutti<br />
i cristiani devono prendere coscienza<br />
della propria speciale vocazione nella<br />
comunità politica […] affi nché tutti i<br />
citta<strong>di</strong>ni possano svolgere il loro ruolo<br />
nella vita della comunità» (n. 75). Paolo<br />
VI, parimenti nell’enciclica Octogesima<br />
advenies (1971), afferma che «la politica<br />
è una maniera esigente […] <strong>di</strong> vivere<br />
l’impegno cristiano al servizio degli altri»<br />
(46).<br />
34) In effetti, esistono Paesi che formalmente<br />
si <strong>di</strong>chiarano democratici,<br />
ma nei fatti non tutelano né i <strong>di</strong>ritti<br />
fondamentali delle persone, né attuano<br />
politiche <strong>di</strong> giustizia sociale. La recente<br />
enciclica sociale <strong>di</strong> Benedetto XVI, Caritas<br />
in veritate, che si muove nel solco<br />
tracciato nel post Concilio dalla costituzione<br />
apostolica Populorum progressio<br />
<strong>di</strong> Paolo VI, è un’ulteriore prova del cammino<br />
compiuto dal Magistero Pontifi cio<br />
in ambito sociale e politico.<br />
35) Figura poco nota e spesso fraintesa,<br />
ma degna <strong>di</strong> attenzione in merito<br />
all’inserimento dei cattolici in politica.<br />
Visse tra il 1870 e il 1944, or<strong>di</strong>nato<br />
sacerdote nel 1893, stu<strong>di</strong>ò lettere<br />
all’università <strong>di</strong> Roma e con acuta intelligenza<br />
si <strong>di</strong>ede all’apostolato sociale.<br />
Fondò circoli e riviste, si pro<strong>di</strong>gò in conferenze<br />
e congressi. Nel 1909 fu eletto<br />
deputato. Il suo pensiero riformista raggiunse<br />
punte d’estremismo esasperato,<br />
in contrasto con lo spirito evangelico,<br />
per cui venne scomunicato da Pio<br />
X. Si ravvide poi e morì in comunione<br />
con la Chiesa.<br />
36) A causa della sua fragilità, essendo<br />
nato gemello, si ebbe cura <strong>di</strong> amministrargli<br />
subito il battesimo. Prima <strong>di</strong><br />
lui erano nati Mario, primogenito, futuro<br />
vescovo <strong>di</strong> Piazza Armerina; Margherita,<br />
pia e attiva, alla sua morte lasciò<br />
un consistente legato per fondare la<br />
parrocchia <strong>di</strong> Maria SS.ma del Ponte;<br />
Remigia, consacrata al Signore tra le<br />
Figlie della Carità, e Rosa, che morì<br />
bambina. La gemella, Emanuela, fu il<br />
suo angelo tutelare, rimanendogli sempre<br />
accanto e accudendolo sino alla<br />
fi ne. Nell’ambito familiare vanno pure<br />
ricordati due zii paterni, i padri Luigi e<br />
Franco, entrambi gesuiti <strong>di</strong> singolari<br />
virtù, ai quali si associa lo zio materno,<br />
il padre benedettino Salvatore.<br />
37) Nacque a Treviso nel 1845, morì<br />
a Pisa nel 1918, sta per concludersi la<br />
sua causa <strong>di</strong> beatifi cazione. Sociologo<br />
ed economista <strong>di</strong> spicco in ambito cattolico,<br />
insegnò nelle università <strong>di</strong> Venezia,<br />
Modena e Pisa. Fautore della scuola<br />
etico-cristiana contro la concezione<br />
utilitaristico-liberale, ispirandosi alla<br />
dottrina <strong>di</strong> Leone XIII ideò una società<br />
<strong>di</strong> tipo collaborativo per assicurare a<br />
tutti i lavoratori un degno tenore <strong>di</strong> vita.<br />
Pio X, trevisano come lui, appena giunto<br />
al Soglio Pontifi cio, gli affi dò la riorganizzazione<br />
e <strong>di</strong>rezione politica del<br />
movimento cattolico sociale, dopo lo<br />
scioglimento della nota Opera dei Congressi<br />
e dei Comitati Cattolici, istituita<br />
da Pio IX. In tal modo il nuovo pontefi ce,<br />
che tenne una linea intransigente contro<br />
il modernismo, sul terreno socialpolitico,<br />
fi n dall’inizio, stimolò la nascita<br />
e lo sviluppo <strong>di</strong> un movimento sindacale<br />
cattolico, che conobbe una notevole<br />
<strong>di</strong>ffusione e <strong>di</strong> cui il Toniolo elaborò le<br />
linee programmatiche alle quali s’ispireranno<br />
(come implicitamente continuano<br />
ad ispirarsi) i sindacalisti cristiani<br />
(Cfr. Giovanni ZALIN, Economisti, po litici,<br />
fi lantropi nell’Italia liberale, Padova, Cedam,<br />
1997).<br />
38) Il caso <strong>di</strong> Giacomo Matteotti testimonia<br />
tragicamente il clima persecutorio<br />
instaurato dal fascismo. Segretario<br />
del Partito Socialista, egli il 30<br />
ITALIA 150 33
DON PRIMO MAZZOLARI<br />
«Voglio svegliare l’aurora» (Salmo 56)<br />
«Tromba dello Spirito Santo in terra<br />
mantovana» (Giovanni XXIII)<br />
«Custos, quid de nocte?». 44<br />
«Adhuc aurora est». 45 Il Concilio<br />
Vaticano II è <strong>di</strong> certo tra gli avvenimenti<br />
più signifi cativi del secolo<br />
scorso e non solo in ambito ecclesiale.<br />
Spinse l’universo cattolico<br />
ad andare al fondo <strong>di</strong> tutte le<br />
sue principali problematiche, a<br />
varcare soglie note e ignote per<br />
giungere a una visione globale,<br />
positiva e propositiva del Vangelo<br />
nell’oggi, dopo venti secoli <strong>di</strong> storia.<br />
Ebbe ampie ripercussioni a<br />
livello mon<strong>di</strong>ale e, come una nuova<br />
Pentecoste, cui viene <strong>di</strong> sovente<br />
ricondotto, segnò per la cattolicità<br />
una delle tappe più innovatrici<br />
della sua storia. La Chiesa<br />
si rivelò al mondo, spalancò le<br />
porte perché ogni uomo, 46 <strong>di</strong> tutte<br />
le civiltà, razze e religioni, vi<br />
trovasse accoglienza fraterna;<br />
casa tra le case, famiglia <strong>di</strong> famiglie.<br />
Non fu certo un’improvvisazione<br />
o un evento casuale: vi<br />
giunsero a maturazione germi <strong>di</strong><br />
bene riposti nel cuore della Chiesa<br />
da mani generose e profetiche<br />
attraverso una lunga stagione<br />
preparatoria. Tra i precursori più<br />
tempestivi e coraggiosi è sicuramente<br />
don Primo Mazzolari che,<br />
con la sua azione pastorale, ne<br />
prefi gurò lo spirito e ne anticipò<br />
le riforme. Una missione d’avanguar<strong>di</strong>a<br />
<strong>di</strong>sseminata <strong>di</strong> <strong>di</strong>ffi coltà,<br />
che le parole <strong>di</strong> Paolo VI, ricevendo<br />
in Vaticano la sorella con un<br />
gruppo <strong>di</strong> parrocchiani <strong>di</strong> Bozzolo,<br />
pochi anni dopo la morte del fratello,<br />
ben riassumono: «Hanno<br />
detto che non abbiamo voluto<br />
bene a don Primo. Non è vero.<br />
Anche noi gli abbiamo voluto bene.<br />
Ma voi sapete come andavano<br />
le cose. Lui aveva il passo<br />
troppo lungo e noi si stentava a<br />
stargli <strong>di</strong>etro. Così ha sofferto lui<br />
e abbiamo sofferto noi. Questo è<br />
il destino dei profeti». 47 Un passo,<br />
il suo, troppo lungo per gli altri,<br />
troppo lento per lui e ne soffriva.<br />
Molte ed esaurienti le biografi<br />
e <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>osi che lo hanno<br />
34 ITALIA 150<br />
Don Primo Mazzolari<br />
(1890-1959), con la<br />
sua azione pastorale<br />
innovatrice – <strong>di</strong>ffusa<br />
con gli scritti,<br />
oralmente e<br />
fattivamente – si<br />
<strong>di</strong>stinse come la<br />
sentinella del<br />
mattino che<br />
annuncia cieli nuovi<br />
e terre nuove.<br />
Don Primo Mazzolari<br />
(1890-1959), with his<br />
first innovative<br />
ministerial action<br />
– circulated through<br />
writings, orally and<br />
actively – who stood<br />
out as a morning<br />
sentinel announcing<br />
new skies and lands.<br />
Nella pagina<br />
a fianco: don Primo<br />
Mazzolari non vide<br />
l’apertura del<br />
Concilio Vaticano II,<br />
ma ne prefigurò lo<br />
spirito e le riforme.<br />
On the opposite<br />
page: don Primo<br />
Mazzolari <strong>di</strong>d not see<br />
the opening of the II<br />
Vatican Council, but<br />
prefigured both its<br />
spirit and the<br />
reforms.<br />
conosciuto e amato, ma sono<br />
soprattutto i suoi scritti e la sua<br />
pre<strong>di</strong>cazione a dare la misura <strong>di</strong><br />
un nuovo profetismo che va oltre<br />
ogni umano orizzonte. Le pubblicazioni<br />
e le omelie registrate <strong>di</strong><br />
don Primo sono una biblioteca<br />
immensa, un mare <strong>di</strong> rifl essioni,<br />
sensazioni, esperienze tutte volte<br />
al futuro, animate da un ottimismo<br />
cristiano che vede la Chiesa<br />
come una <strong>di</strong>vina realtà in cammino,<br />
sospinta dalla sua vocazione<br />
all’universalità; un luogo d’incontro<br />
per costruire insieme il Regno<br />
<strong>di</strong> Dio già presente in mezzo a noi,<br />
nel quale i privilegiati sono i lontani<br />
e gli ultimi.<br />
I dati anagrafici <strong>di</strong> questo<br />
profeta senza <strong>di</strong>aframmi, acuto<br />
veggente innamorato del Cristo<br />
universale e dei fratelli lontani, ripropongono<br />
la semplicità dei Vangeli<br />
quando parlano della chiamata<br />
degli Apostoli. Vive in un’epoca<br />
<strong>di</strong> crisi: tra il tramonto del modernismo<br />
e il primo sorgere del Concilio<br />
Vaticano II, che egli però non<br />
vide: morì, infatti, a Cremona il 12<br />
aprile 1959. La figura <strong>di</strong> Mosè<br />
anche in lui rivive e si ripropone:<br />
dopo aver guidato il suo popolo nel<br />
deserto infuocato dell’Esodo, giunto<br />
in prossimità della terra promessa,<br />
morì sul monte Nebo, donde<br />
poté semplicemente intravedere la<br />
patria promessa. I profeti e i condottieri,<br />
nell’antichità come nei<br />
nuovi tempi, sembrano accomunati<br />
da un’identica sorte che si arresta<br />
sulle soglie della promessa.<br />
Taluni biografi <strong>di</strong> don Mazzolari,<br />
per amore <strong>di</strong> semplifi cazione,<br />
ne sud<strong>di</strong>vidono la vita in tre essenziali<br />
tappe. La nascita il 13 gennaio<br />
1890 a Boschetto, frazione <strong>di</strong><br />
Cremona, in una famiglia conta<strong>di</strong>na,<br />
che viveva alla giornata, sui<br />
lavori dei campi cui il padre era<br />
de<strong>di</strong>to. 48 L’infanzia e la prima giovinezza,<br />
con l’esperienza in seminario<br />
a Cremona, trascorsero relativamente<br />
serene. Alla sua or<strong>di</strong>nazione<br />
sacerdotale, il 25 agosto<br />
1912, 49 fecero seguito le prime<br />
esperienze pastorali: servizio mili-<br />
Fototeca Gilar<strong>di</strong>
tare; 50 al termine, in cura d’anime,<br />
mentre l’Italia viveva il<br />
travaglio del primo dopoguerra.<br />
Segue il ventennio<br />
fascista che sfocia nella<br />
Seconda Guerra mon<strong>di</strong>ale.<br />
La Chiesa reagisce al<br />
modernismo, mentre<br />
don Mazzolari vive come<br />
parroco l’esperienza pastorale<br />
sul campo, prima<br />
a Bozzolo, poi a Cicognara,<br />
poi nuovamente<br />
a Bozzolo (1922-45).<br />
Dalla fine della<br />
guerra alla morte, oltre<br />
alla sua missione <strong>di</strong> parroco,<br />
partecipa con convinzione<br />
alla nascita e<br />
alla affermazione della<br />
democrazia. Esprime il<br />
suo pensiero attraverso varie<br />
pubblicazioni e, più compiutamente,<br />
sul <strong>di</strong>scusso quin<strong>di</strong>cinale<br />
Adesso, che gli procura qualche<br />
amarezza, 51 ma anche ampi consensi.<br />
La pre<strong>di</strong>cazione, appassionata<br />
e vibrante, si rivela la sua<br />
missione e lo porta a peregrinare<br />
dal Nord al Sud: ovunque le sue<br />
parole giungono come voce <strong>di</strong> rinnovamento,<br />
<strong>di</strong> fratellanza e profezia<br />
<strong>di</strong> futuro (1945-59).<br />
A Bozzolo, il parroco don Primo<br />
imposta la sua pastorale su<br />
<strong>di</strong>rettrici inusuali. Organizza in ca-<br />
Photo Oilime<br />
Giovanni XXIII<br />
concludeva il suo<br />
<strong>di</strong>scorso <strong>di</strong> apertura<br />
del Concilio<br />
paragonandolo<br />
all’aurora <strong>di</strong> una<br />
nuova era nella<br />
storia della Chiesa.<br />
Giovanni XXIII<br />
ended his opening<br />
speech for the<br />
Council by<br />
comparing it to the<br />
dawn of a new era<br />
for the Church.<br />
maggio 1924, in un accorato <strong>di</strong>scorso<br />
alla Camera dei deputati denunciò le<br />
violenze e i brogli dei fascisti per vincere<br />
le elezioni del 6 aprile. Fu l’ultimo<br />
suo intervento: <strong>di</strong>eci giorni dopo venne<br />
rapito, pugnalato e abbandonato in<br />
aperta campagna, dove il suo cadavere<br />
venne rinvenuto due mesi dopo.<br />
39) Don Luigi Sturzo non si presentò<br />
mai come can<strong>di</strong>dato al Parlamento, ma<br />
il Partito <strong>Popolare</strong> raccolse via via consensi<br />
sempre più vasti. Caduto nel febbraio<br />
del 1922 il governo Bonomi, Giolitti<br />
si <strong>di</strong>mostrò incapace <strong>di</strong> formarne<br />
uno nuovo e Mussolini ebbe via libera<br />
per l’ascesa al potere. Don Luigi, costretto<br />
a partecipare con due suoi uomini<br />
al nuovo Gabinetto Mussolini, non<br />
ebbe ce<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> sorta e, poco dopo,<br />
passò all’opposizione.<br />
40) Di questo periodo in esilio <strong>di</strong> don<br />
Sturzo viene ricordata in special modo<br />
la carità nei confronti degli altri esuli<br />
politici, ai quali devolveva i proventi dei<br />
<strong>di</strong>ritti d’autore per le sue numerose e<br />
red<strong>di</strong>tizie pubblicazioni. Il car<strong>di</strong>nale<br />
John Wright, già egli stesso suo penitente<br />
quando don Luigi era a New York,<br />
rivela quanto fosse ricercato dai sacerdoti<br />
e dai fedeli per il ministero della<br />
confessione e della <strong>di</strong>rezione spirituale:<br />
il miglior elogio per il suo sacerdozio e<br />
per la <strong>di</strong>mensione essenzialmente spirituale<br />
del suo ininterrotto ministero.<br />
41) In tutto questo periodo dell’esilio,<br />
don Sturzo, pur conservando corrispondenza<br />
con l’Italia, sempre rigorosamente<br />
controllata dalla censura fascista,<br />
esercitò prevalentemente l’attività a lui<br />
congeniale <strong>di</strong> pubblicista e scrisse le<br />
sue opere più importanti <strong>di</strong> carattere<br />
storico, politico e sociologico, tra le<br />
Olycom<br />
quali The true life (tradotta in italiano<br />
con il titolo La vera vita. Sociologia del<br />
Soprannaturale) che si può considerare<br />
la sintesi <strong>di</strong> tutto il suo pensiero.<br />
42) Anche per queste sue benemerenze<br />
assistenziali, universalmente note<br />
in Sicilia, il 27 agosto 1947 fu eletto<br />
all’unanimità dall’Assemblea Regionale<br />
Siciliana membro dell’Alta Corte per la<br />
Sicilia.<br />
43) Testimoni oculari riferiscono che<br />
quando gli riferirono le parole con cui<br />
Sua Santità gli impartiva la bene<strong>di</strong>zione,<br />
s’illuminò in volto e la gioia fu tale<br />
che i me<strong>di</strong>ci notarono come quel giorno<br />
stesse inspiegabilmente meglio.<br />
44) Isaia, 21,11. L’interrogativo è nella<br />
prima parte del libro <strong>di</strong> Isaia, probabilmente<br />
scritta nel 711 a.C., ove si<br />
legge: «Mi gridano da Seir: Sentinella,<br />
quanto resta della notte? La sentinella<br />
risponde: Viene il mattino…».<br />
45) È l’espressione con cui Giovanni<br />
XXIII, l’11 ottobre 1962, nella basilica<br />
<strong>di</strong> San Pietro, alla presenza <strong>di</strong> 2.500<br />
vescovi <strong>di</strong> tutto il mondo, concludeva il<br />
suo <strong>di</strong>scorso <strong>di</strong> apertura del Concilio<br />
Vaticano II, paragonandolo all’aurora<br />
dei tempi nuovi.<br />
46) Giovanni Paolo II, erede del Concilio,<br />
iniziò il suo pontifi cato con la nota<br />
esortazione: «Aprite le porte a Cristo!»<br />
47) A. CHIODI, Primo Mazzolari, un testimone<br />
“in Cristo” con l’anima del profeta,<br />
Centro Ambrosiano, Milano 1998,<br />
p. 90.<br />
48) I Mazzolari erano una famiglia<br />
socialista <strong>di</strong> piccoli fi ttavoli. Al Boschetto<br />
avevano poca terra. La nascita <strong>di</strong><br />
altri fi gli, e quin<strong>di</strong> le maggiori necessità,<br />
obbligarono il padre Luigi a cercare più<br />
terra altrove. L’11 novembre 1900 partirono,<br />
su due carri, con le poche cose<br />
che possedevano, per Verolanuova, un<br />
grosso centro bresciano.<br />
49) Non poté essere or<strong>di</strong>nato sacerdote<br />
con i con<strong>di</strong>scepoli il 1° giugno<br />
1912, perché troppo giovane, non aveva<br />
l’età canonica. Fu consacrato dal<br />
vescovo <strong>di</strong> Brescia Giacinto Gaggia,<br />
nella parrocchiale <strong>di</strong> Verolanuova, ove<br />
abitava con la famiglia.<br />
50) Il 24 maggio 1915 l’Italia entra in<br />
guerra. Don Primo viene arruolato e destinato<br />
all’ospedale militare <strong>di</strong> Genova.<br />
Mentre stava raggiungendo il reparto,<br />
gli giunge la notizia della morte del fratello<br />
Peppino, sul monte Sabotino, il 25<br />
novembre 1915. Dopo i tre mesi <strong>di</strong><br />
addestramento, viene trasferito al l’ospedale<br />
militare <strong>di</strong> Cremona, <strong>di</strong>slocato<br />
in Seminario. Ricevuto il grado <strong>di</strong> caporale,<br />
rimase a Cremona quasi due anni.<br />
Dopo Caporetto, chiese <strong>di</strong> essere nominato<br />
cappellano militare. Il 26 aprile<br />
1918 fu destinato, come cappellano<br />
con il grado <strong>di</strong> tenente, in Francia, sul<br />
fronte con la Germania. Vi rimase sino<br />
alla fi ne della guerra. Il 23 luglio 1920<br />
fu congedato.<br />
ITALIA 150 35
nonica una scuola serale <strong>di</strong> agricoltura,<br />
<strong>di</strong> zootecnia e <strong>di</strong> formazione<br />
civile. Iniziarono in otto e fi nirono<br />
in cinquanta. Istituisce e cura<br />
personalmente una pubblica biblioteca,<br />
abolisce le tariffe dei<br />
servizi religiosi, proponendo celebrazioni<br />
in<strong>di</strong>fferenziate per tutti i<br />
parrocchiani, senza più <strong>di</strong>stinzioni<br />
<strong>di</strong> classi; inventa le feste del grano<br />
(in occasione del Corpus Domini),<br />
e dell’uva (per la sagra <strong>di</strong> settembre).<br />
In ambito sociale, cercando<br />
più ciò che unisce <strong>di</strong> ciò che <strong>di</strong>vide,<br />
52 riesce a stabilire rapporti non<br />
conflittuali con i socialisti, che<br />
erano la gran maggioranza dei<br />
suoi parrocchiani, tutti o quasi<br />
tutti fi ttavoli. In ambito politico,<br />
con<strong>di</strong>vide l’impostazione sociopolitica<br />
<strong>di</strong> don Sturzo. Intrattiene rapporti<br />
anche con il giovane don Lorenzo<br />
Milani, che pure scrive su<br />
Adesso.<br />
La vigilia <strong>di</strong> Natale del 1921<br />
riceve l’or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> lasciare imme<strong>di</strong>atamente<br />
Bozzolo per Cicognara,<br />
un piccolo paese <strong>di</strong> circa mille<br />
abitanti, a quin<strong>di</strong>ci chilometri da<br />
Bozzolo, sull’argine del Po. Il parroco<br />
<strong>di</strong> quel paese era scappato <strong>di</strong><br />
notte, contestato violentemente<br />
dai parrocchiani per contrasti circa<br />
gli affi tti delle terre della parrocchia.<br />
Fu una scelta quasi obbligata<br />
quella del vescovo <strong>di</strong> Cremona. Ma<br />
in chiesa al Vangelo, quando si<br />
voltò, non c’erano più <strong>di</strong> venti persone.<br />
Parlò a quei pochi, col cuore<br />
oltre, verso la grande Chiesa dei<br />
lontani. La sua vocazione veniva<br />
così segnata nella sua anima <strong>di</strong><br />
sacerdote, in quel mattino <strong>di</strong> Circoncisione,<br />
53 nel gelido deserto<br />
della sua chiesa. Sarebbe stato il<br />
parroco dei lontani. Qualcosa incominciava.<br />
L’attesa. Il suo <strong>di</strong>namismo<br />
pastorale trovò a breve fertile<br />
terreno. Nell’estate del 1922 annegarono<br />
nel Po due bambini: un<br />
triste lutto parrocchiale che egli<br />
cercò <strong>di</strong> lenire e prevenire istituendo<br />
imme<strong>di</strong>atamente una colonia<br />
fl uviale per insegnare a nuotare e<br />
a scongiurare così altre <strong>di</strong>sgrazie.<br />
Era solo l’inizio <strong>di</strong> un apostolato<br />
<strong>di</strong>namico, innovatore, attento all’attualità,<br />
rivolto a tutti, per la redenzione<br />
dell’uomo, <strong>di</strong> ogni uomo,<br />
<strong>di</strong> tutto l’uomo, e così vivere inte-<br />
36 ITALIA 150<br />
gralmente il Vangelo. Stabilì poi<br />
una giornata d’incontro con i reduci<br />
della Grande Guerra, il 4 novembre,<br />
per rifl ettere sul martirio dei<br />
caduti e sui doveri dei reduci. Senza<br />
mai trascurare le nuove leve; la<br />
giornata dei coscritti <strong>di</strong>ciottenni,<br />
ogni anno, era la festa della primavera<br />
cristiana tra la sua gente:<br />
giovani e ragazze, li portava solennemente<br />
in chiesa, celebrava per<br />
loro la Messa durante la quale<br />
bene<strong>di</strong>va il tricolore che essi avrebbero<br />
custo<strong>di</strong>to e riportato l’anno<br />
dopo davanti all’altare a salutare la<br />
nuova classe che sopraggiungeva.<br />
Congiuntamente all’apostolato<br />
<strong>di</strong> rottura in campo aperto, don<br />
Primo affi da il suo messaggio <strong>di</strong><br />
redenzione universale agli scritti e<br />
alla pre<strong>di</strong>cazione. Le pubblicazioni<br />
si susseguono a ritmo incalzante<br />
e vengono accolte ovunque con<br />
entusiasmo: La Pieve sull’argine,<br />
L’uomo <strong>di</strong> nessuno, Il Compagno<br />
Cristo, Preti così, La più bella avventura<br />
(Sulla traccia del Pro<strong>di</strong>go), Tra<br />
l’argine e il bosco, Il samaritano,<br />
Tempo <strong>di</strong> credere, Anch’io voglio<br />
bene al Papa, Diario <strong>di</strong> una primavera<br />
– 1945, Lettera sulla Parrocchia…<br />
54 Un florilegio dal soffio<br />
ispirato, una sequenza <strong>di</strong> immagini<br />
e <strong>di</strong> idee, <strong>di</strong> proposte e <strong>di</strong> provocazioni<br />
per il credente e per il non<br />
credente, per i vicini e i lontani, per<br />
tutti. La sua attività <strong>di</strong> scrittore<br />
profetico <strong>di</strong>venta sempre più incisiva<br />
e inquietante. In ogni suo intervento<br />
è evidente lo sforzo crescen-<br />
La casa natale <strong>di</strong><br />
don Primo Mazzolari<br />
al Boschetto.<br />
The birthplace of<br />
don Primo Mazzolari<br />
in Boschetto.<br />
te <strong>di</strong> portare il fermento evangelico<br />
nelle strutture terrestri e le strutture<br />
terrestri a <strong>di</strong>a logare con l’eterno.<br />
Diviene così il portavoce <strong>di</strong> un laicato<br />
adulto, vivo e attivo nella<br />
Chiesa e nella società. Formatosi,<br />
come egli stesso afferma, alla<br />
scuola dei classici della letteratura<br />
europea e dei cattolici francesi<br />
d’avanguar<strong>di</strong>a, sempre più innamorato<br />
<strong>di</strong> un Vangelo senza frontiere,<br />
aperto sull’infi nito, riesce a<br />
fondere nei suoi scritti la violenza<br />
della verità con uno stile semplice<br />
e vivace che cattura anche il lettore<br />
meno incline. Cultura e vita,<br />
poesia e dogma non sono mai <strong>di</strong>sgiunti<br />
e nessun compiacimento<br />
letterario lo <strong>di</strong>strae dalla problematica<br />
religiosa, soprattutto dei non<br />
credenti. Giunge a considerare la<br />
presenza del sacerdote scrittore<br />
«in sostituibile», quando è «spiritualità<br />
penitente, sicura e audace».<br />
Ha presentato al mondo una Chiesa,<br />
madre e maestra, 55 che è la<br />
casa <strong>di</strong> ciascuno, dove c’è sempre<br />
un fratello sulla porta e un posto<br />
che attende. Il vuoto <strong>di</strong> chi manca<br />
è incolmabile e risucchia all’in<strong>di</strong>etro<br />
tutto l’apparato. Pensieri e sentimenti<br />
tumultuanti nel suo cuore<br />
<strong>di</strong> precursore, che troveranno ampia<br />
eco e adeguata sistemazione<br />
nei luci<strong>di</strong> e programmatici sillogismi<br />
del Concilio Vaticano II. Aprendo<br />
il quale, a qualche anno dalla<br />
morte <strong>di</strong> don Primo, 56 Giovanni<br />
XXIII esordì esclamando: «Gaudet<br />
Mater Ecclesia!». La Chiesa è in<br />
festa per i tempi nuovi che si annunciano,<br />
quelli che don Mazzolari<br />
aveva auspicato e anticipato. Papa<br />
Roncalli, come già asserito, concludeva<br />
il suo <strong>di</strong>re inaugurale con<br />
una affermazione pure passata<br />
alla storia e alla profezia: «Adhuc<br />
aurora est!». Quell’aurora cui il Papa<br />
buono alludeva, ebbe un astro<br />
mattutino che l’annunciò quando<br />
tutt’intorno era ancora buio: don<br />
Primo Mazzolari. Un esperto del<br />
Concilio, padre Ernesto Balducci,<br />
lo afferma esplicitamente: «Mazzolari<br />
rimane una fi gura unica nella<br />
storia del cattolicesimo del XX<br />
secolo. Senza retorica, io sono<br />
convinto che egli è l’unico vero<br />
“profeta” del Vaticano II che abbia<br />
avuto l’Italia <strong>di</strong> questo secolo».
Olycom<br />
LORENZO MILANI<br />
«In principio era la Parola»<br />
(Inizio del Vangelo <strong>di</strong> Giovanni)<br />
«Turpe est ignorare quod omnibus<br />
scire convenit» 57<br />
(Aristotele, Rhetorica, 11)<br />
Mentre le realtà associative,<br />
dalla famiglia ai vari circoli <strong>di</strong> <strong>di</strong>versa<br />
aggregazione, compresi quelli<br />
cattolici, sembrano <strong>di</strong>leguarsi, la<br />
scuola rimane e si afferma come<br />
punto <strong>di</strong> aggregazione e <strong>di</strong> riferimento,<br />
pietra sicura su cui posare<br />
il piede, soprattutto per le nuove<br />
generazioni. In tale prospettiva,<br />
l’istruzione con le sue multiformi<br />
infrastrutture educative, dalle elementari<br />
alla università, assume<br />
anche il ruolo vicario <strong>di</strong> colmare il<br />
vertiginoso vuoto delle istituzioni<br />
tra<strong>di</strong>zionali che va accumulandosi<br />
alle sue spalle. Un compito educante<br />
<strong>di</strong> enorme portata, senza<br />
precedenti nella storia della cultura<br />
e della civiltà. A don Lorenzo<br />
Milani il merito d’averlo intuito in<br />
anticipo, attribuendo alla scuola<br />
popolare rinnovata una centralità<br />
sociale determinante. «Dimmi<br />
quanti vocaboli conosci e ti <strong>di</strong>rò il<br />
grado <strong>di</strong> libertà che possie<strong>di</strong>», era<br />
uno dei suoi ricorrenti aforismi.<br />
La vita <strong>di</strong> questo precursore<br />
e profeta della nuova missione e<br />
<strong>di</strong>mensione del sapere scolastico<br />
si <strong>di</strong>spiega in para<strong>di</strong>gmi inusuali<br />
alla tra<strong>di</strong>zione presbiterale. 58 Nasce<br />
il 27 maggio 1923, nella Firenze<br />
colta, da una famiglia della<br />
borghesia, secondogenito <strong>di</strong> Albano<br />
e <strong>di</strong> Alice Weiss, <strong>di</strong> origine<br />
ebrea. Il bisnonno è un illustre<br />
stu<strong>di</strong>oso <strong>di</strong> linguistica comparata.<br />
Il nonno, un archeologo <strong>di</strong> fama.<br />
Da parte paterna, quin<strong>di</strong>, un vissuto<br />
molto dotto, da parte materna<br />
ere<strong>di</strong>ta una cultura ebraica che<br />
affonda nel mondo mitteleuropeo<br />
le proprie ra<strong>di</strong>ci.<br />
Adolescente versatile, attratto<br />
da mille interessi, rischia la <strong>di</strong>spersione<br />
e il profi tto scolastico<br />
dei primi tempi è piuttosto deludente<br />
per cui rischia anche la<br />
bocciatura, in quel severo liceo<br />
Berchet <strong>di</strong> Milano, ove cresce, accanto<br />
a studenti parimenti votati<br />
ad un avvenire d’impegno, come<br />
quell’Oreste Del Buono, 59 che in<br />
Don Lorenzo Milani<br />
(1923-67) si pro<strong>di</strong>gò<br />
per una scuola che<br />
risvegliasse nelle<br />
coscienze la verità<br />
che è in esse, e che<br />
le rendesse capaci <strong>di</strong><br />
ragionare da sé,<br />
<strong>di</strong> giu<strong>di</strong>care e <strong>di</strong><br />
farsi libere.<br />
Don Lorenzo Milani<br />
(1923-67) <strong>di</strong>d his<br />
best to create a<br />
school which could<br />
reawaken the truth<br />
in our awareness,<br />
make it able to<br />
reason, judge and<br />
become free.<br />
51) La sua pubblicazione verrà sospesa<br />
d’autorità dal car<strong>di</strong>nale <strong>di</strong> Milano<br />
Idelfonso Schuster nel 1951. Vi compaiono<br />
anche contributi <strong>di</strong> Lorenzo Milani.<br />
52) È uno degli aforismi più ricorrenti<br />
nel Pontifi cato <strong>di</strong> Giovanni XXIII, prima<br />
e durante il Concilio.<br />
53) Era, infatti, il 2 febbraio del 1922,<br />
in cui la liturgia commemora appunto<br />
la circoncisione <strong>di</strong> Gesù al tempio.<br />
54) L’elenco completo e ragionato<br />
delle pubblicazioni <strong>di</strong> don Primo Mazzolari<br />
è reperibile nelle innumerevoli sue<br />
biografi e. Ve<strong>di</strong>, ad esempio: Giuseppe<br />
MASSONE, Don Primo Mazzolari, Milano,<br />
Gribau<strong>di</strong> 2008, pp. 163 ss.<br />
55) Mater et magistra è l’incipit <strong>di</strong> una<br />
nota enciclica <strong>di</strong> Giovanni XXIII, che già<br />
recepisce taluni dei più incisivi e innovativi<br />
messaggi <strong>di</strong> don Mazzolari.<br />
56) Il 5 aprile 1959, Domenica in Albis,<br />
alla Messa solenne delle 11,15,<br />
don Primo, mentre teneva l’omelia, è<br />
colpito da ictus cerebrale nella sua<br />
chiesa <strong>di</strong> S. Pietro in Bozzolo, ove era<br />
ritornato dopo la breve esperienza pastorale<br />
<strong>di</strong> Cicognara. Ricoverato alla<br />
Clinica S. Camillo <strong>di</strong> Cremona, moriva<br />
dopo otto giorni <strong>di</strong> agonia, il 12 aprile<br />
1959.<br />
57) «È turpe ignorare ciò che tutti dovrebbero<br />
sapere», una delle massime più<br />
care al sommo fi losofo dell’antichità.<br />
58) Per una rivisitazione aggiornata e<br />
in parte innovativa, della figura e<br />
dell’opera <strong>di</strong> don Milani cfr. Marcello<br />
MANCINI-Giovanni PALLANTI, La preghiera<br />
spezzata. I cattolici fi orentini nella seconda<br />
metà del ’900, Libreria Ed. Fiorentina,<br />
2010.<br />
59) Narratore e giornalista tra i più<br />
noti del suo tempo, fu prigioniero nei<br />
lager tedeschi ai quali è ispirata molta<br />
della sua effi cace produzione memorialista.<br />
L’ amicizia con Lorenzo durò negli<br />
anni.<br />
60) Monsignor Mario Trapani, che aveva<br />
una concezione piuttosto militaresca<br />
del proprio uffi cio. Sembra pertanto non<br />
corrispondere al vero l’interpretazione<br />
dei fatti secondo cui don Milani sarebbe<br />
stato confi nato a Barbiana quasi per<br />
relegarlo in esilio, addossandone la responsabilità<br />
al coa<strong>di</strong>utore del car<strong>di</strong>nale,<br />
monsignor Er menegildo Florit, il quale,<br />
quando nel <strong>di</strong>cembre del 1954 giunse<br />
a Firenze, neppure conosceva don Milani,<br />
che in effetti, si rese noto alla sua<br />
<strong>di</strong>ocesi e alla Chiesa solo nel 1957 con<br />
la pubblicazione Esperienze pastorali.<br />
Vero è invece che qualche anno dopo<br />
monsignor Florit propose a don Milani<br />
una parrocchia suburbana, ricevendone<br />
però un cortese rifi uto, motivato<br />
principalmente dal grande affetto verso<br />
i suoi ragazzi <strong>di</strong> Barbiana e dalla volontà<br />
<strong>di</strong> portare a compimento quel progetto<br />
scolastico che con loro stava coltivando.<br />
ITALIA 150 37
un suo scritto memorialistico, defi<br />
nirà l’amico <strong>di</strong> sempre «ortodosso<br />
fi no all’eresia». L’Italia sta precipitando<br />
verso il secondo confl itto<br />
mon<strong>di</strong>ale. Il giovane Lorenzo lo sa<br />
e si rifugia idealmente nell’arte,<br />
che gli è congeniale. Tra il 1941 e<br />
il 1943 coltiva la pittura, stu<strong>di</strong>ando<br />
prima in privato, poi nell’Accademia<br />
Brera a Milano. Seguendo<br />
questo suo talento, nell’estate del<br />
1942, durante le vacanze estive,<br />
a Gigliola <strong>di</strong> Montespertoli, non<br />
lontano da Firenze, decide <strong>di</strong> affrescare<br />
una cappella <strong>di</strong>smessa.<br />
Durante il lavoro <strong>di</strong> ripulitura, gli<br />
capita in mano un vecchio messale<br />
che gli rivela un universo fi no<br />
allora sconosciuto: il Vangelo. Era<br />
cresciuto in una famiglia avversa<br />
alla religione cristiana; i fi gli furono<br />
battezzati solo per timore della<br />
rappresaglia fascista, essendo la<br />
madre ebrea. Il vecchio messale<br />
lo appassiona, lo convince. Nel<br />
1943 è seminarista a Firenze.<br />
Sono gli anni duri della guerra,<br />
della fame e del freddo. In seminario<br />
una <strong>di</strong>sciplina severa e con<strong>di</strong>visa<br />
lo tempra interiormente. E<br />
quando, il 13 luglio 1947, il car<strong>di</strong>nale<br />
Elia Della Costa lo or<strong>di</strong>na<br />
sacerdote, la sua scelta degli ultimi<br />
è matura. A Firenze è la stagione<br />
del sindaco La Pira, <strong>di</strong> don<br />
Enzo Mazzi, <strong>di</strong> don Divo Barsotti,<br />
<strong>di</strong> monsignor Facibeni: tutta una<br />
città scalpitante, a ridosso del<br />
Concilio Vaticano II, che fa da<br />
sfondo e da sponda al ministero<br />
<strong>di</strong> don Lorenzo.<br />
Dotato <strong>di</strong> una sensibilità che<br />
oggi defi niremmo interrazziale e<br />
intersoggettiva, viene inserito come<br />
coa<strong>di</strong>utore nella parrocchia <strong>di</strong><br />
San Donato <strong>di</strong> Calenzano. Imme<strong>di</strong>atamente<br />
si rivela come un precursore<br />
<strong>di</strong> tempi nuovi con una<br />
serie <strong>di</strong> iniziative pastorali avanzate,<br />
elogiate da alcuni, molto criticate<br />
da altri. Qualcuno lo vorrebbe<br />
subito parroco, ma il Vicario Generale<br />
dell’archi<strong>di</strong>ocesi 60 ne decise il<br />
trasferimento, seguendo sia la<br />
prassi che un viceparroco non<br />
succede mai al proprio parroco,<br />
sia le <strong>di</strong>rettive del car<strong>di</strong>nale Elia<br />
Della Costa, che voleva un parroco<br />
fi sso anche nelle parrocchie più<br />
piccole e isolate. Sul finire del<br />
38 ITALIA 150<br />
Fototeca Gilar<strong>di</strong><br />
1954 a don Lorenzo viene proposto<br />
<strong>di</strong> scegliere fra una <strong>di</strong> queste.<br />
Opta per Barbiana che non conosceva,<br />
semplicemente perché era<br />
la prima in or<strong>di</strong>ne alfabetico della<br />
lista, fi dando nella Provvidenza. 61<br />
Un minuscolo e sperduto paesino<br />
<strong>di</strong> montagna, pesantemente con<strong>di</strong>zionato<br />
da isolamento e povertà.<br />
Per giungervi, occorreva un fuoristrada<br />
che non temesse gli urti, i<br />
<strong>di</strong>slivelli e i ciottolati. Il 1° gennaio<br />
1955 don Lorenzo vi fece l’ingresso<br />
e ne <strong>di</strong>venne il Priore. Tiepida<br />
l’accoglienza, deserta la chiesa,<br />
fatiscente la canonica. L’impatto lo<br />
temprò alla preghiera e alla rifl essione.<br />
Non si perse né nei meandri<br />
della depressione, né in quelli<br />
della rassegnazione. A breve uscì<br />
la sua prima, sorprendente, <strong>di</strong>scussa<br />
pubblicazione: Esperienze<br />
Pastorali, 62 un saggio d’enorme<br />
interesse, che va alle ra<strong>di</strong>ci delle<br />
realtà ecclesiali. Fecero seguito<br />
altri scritti parimenti provocatori e<br />
innovativi: Lettera ai cappellani<br />
militari toscani, sull’obiezione <strong>di</strong><br />
coscienza, 63 e la conseguente Lettera<br />
ai Giu<strong>di</strong>ci, sull’educazione alla<br />
pace. 64<br />
Nel contempo approfon<strong>di</strong>va<br />
le problematiche <strong>di</strong> Barbiana.<br />
L’emigrazione e l’evasione scolastica<br />
vi regnavano sovrane e mietevano<br />
vittime. Comprese che occorreva<br />
partire da lì, da quei mali<br />
endemici e oscuri della sua povera<br />
gente: fu un’intuizione profetica.<br />
Alla luce del Vangelo che mette al<br />
centro l’uomo, maturò il suo piano<br />
Frontespizio <strong>di</strong><br />
Lettera a una<br />
professoressa<br />
(I e<strong>di</strong>zione).<br />
Title page<br />
of Letter to a<br />
teacher (I e<strong>di</strong>tion).<br />
Una fotografia<br />
giovanile <strong>di</strong> don<br />
Lorenzo Milani.<br />
Photo of don<br />
Lorenzo Milani<br />
as a young man.<br />
Olycom<br />
d’intervento nella convinzione che<br />
il peggior limite anche morale <strong>di</strong><br />
una società è l’ignoranza e la <strong>di</strong>sinformazione.<br />
Perciò al primo posto<br />
della gerarchia dei valori formativi<br />
occorre mettere l’insegnamento,<br />
la scuola, che è un <strong>di</strong>ritto-dovere<br />
per tutti, non solo per i fi gli dei<br />
ricchi o dei professionisti (i cosiddetti<br />
“Pierini”). Soprattutto gli in<strong>di</strong>genti<br />
e gli ultimi ne hanno necessità<br />
perché sono i più in<strong>di</strong>fesi, i più<br />
esposti. Una scuola che favorisca<br />
la crescita integrale dell’uomo.<br />
Quin<strong>di</strong> una scuola per gli alunni,<br />
non gli alunni per la scuola. Nell’attuarla<br />
occorre evitare che <strong>di</strong>venga<br />
il letto <strong>di</strong> Procuste, 65 che cioè faccia<br />
parti eguali tra ineguali: la peggior<br />
ingiustizia sociale. Alunni <strong>di</strong>versi<br />
per nascita, per tenore <strong>di</strong> vita,<br />
per livelli <strong>di</strong> partenza, non possono<br />
essere prima indottrinati e<br />
poi esaminati alla stessa stregua.<br />
E quin<strong>di</strong> il miglior maestro è chi fa<br />
avanzare ciascun alunno con il<br />
proprio passo, senza tarpare le ali<br />
ai migliori, senza perdere i meno<br />
dotati. Come in una cordata in cui<br />
ciascuno ha il suo posto e svolge<br />
il proprio compito. O tutti insieme<br />
salgono, movendo dal proprio livello,<br />
o l’impresa fallisce. Una scuola<br />
che sia vissuta dagli alunni, non da<br />
essi sopportata, che li coinvolga, li<br />
renda protagonisti, mai spettatori<br />
annoiati e <strong>di</strong>stratti. Di qui anche la<br />
tendenza <strong>di</strong> don Milani all’azione <strong>di</strong><br />
gruppo: pure le sue interviste, la<br />
elaborazione delle sue pubblicazio-
ni, i suoi vari interventi pubblici per<br />
la trasmissione del sapere collettivo,<br />
erano sempre partecipati e<br />
con<strong>di</strong>visi da tutti i suoi alunni: o si<br />
cresce insieme o non si cresce<br />
affatto. La società che vive, che<br />
progetta il futuro, ha bisogno che<br />
tutte le sue componenti interagiscano,<br />
<strong>di</strong>versamente vengono violati<br />
gli equilibri fondamentali del<br />
vivere civile e si ha il <strong>di</strong>sor<strong>di</strong>ne, in<br />
cui si afferma la legge della giungla<br />
e il più violento prevale. Idee e<br />
principi che don Milani sintetizza e<br />
riesce a <strong>di</strong>vulgare magistralmente<br />
nella più nota delle sue pubblicazioni:<br />
Lettera ad una professoressa<br />
del 1967. Né si tratta semplicemente<br />
<strong>di</strong> un rinnovamento formale<br />
della realtà scolastica: don Lorenzo<br />
giunge al cuore del problema:<br />
una scuola che semplicemente<br />
istruisce e non educa non ha ragion<br />
d’essere; l’educazione vera poi non<br />
consiste semplicemente nell’aggiornare<br />
la cultura e nel trasmetterla<br />
con effi cacia, perpetuandone il<br />
vizio intimo che è l’asservimento<br />
delle coscienze a un’unica verità:<br />
quella delle classi dominanti, ma è<br />
risvegliare nelle coscienze la verità<br />
che è in esse, in modo che <strong>di</strong>ven-<br />
Barbiana:<br />
la chiesa e la scuola<br />
dove viveva<br />
don Lorenzo Milani.<br />
Barbiana:<br />
the church and<br />
school where don<br />
Lorenzo Milani lived.<br />
«[…] Ma se è vero che Gesù voleva la Chiesa autorevole,<br />
perché ci vuole una verità oggettiva e non soggettiva, allora io<br />
non lascio la Chiesa a nessun prezzo al mondo: perché mi ricordo<br />
che cos’era vivere fuori dalla Chiesa. Così un <strong>di</strong>sgraziato studentello<br />
che tenta <strong>di</strong> trovare la verità con il Vangelo in mano, si trova<br />
davanti a un’infi nità <strong>di</strong> parole che possono essere interpretate in<br />
mille maniere e non sa dove sbattere la testa. La religione consiste<br />
nell’accettare la verità dall’alto e non credere che la verità si costruisca<br />
con la nostra testa: la verità va ricevuta dall’alto, dalla<br />
rivelazione, da un libro sacro, da una Chiesa. Quando uno entra<br />
in quest’or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> idee, se è un po’ coerente, non c’è pagina del<br />
Vangelo in cui non gli verrà continuamente il dubbio: “Ma questa<br />
è la mia interpretazione che fa comodo a me…”. Uno è religioso<br />
solo se nell’interpretazione del testo, che crede sia cascato dal<br />
cielo, ha qualcosa che casca dal cielo, non una sua scelta personale.<br />
Sennò siamo al punto <strong>di</strong> Capitini quando ci <strong>di</strong>ceva che del<br />
Vangelo lui accettava in pieno il <strong>di</strong>scorso della montagna… invece<br />
quell’altra pagina no… Questa è una fi losofi a qualsiasi, cioè<br />
con la propria mente si sceglie cosa è vero e cosa non è vero.<br />
Se tu ammetti che la defi nizione della religione è l’accettare<br />
le cose dall’alto, non c’è religione più rigorosa <strong>di</strong> quella cattolica…<br />
perché qui c’è il libro che viene dall’alto e l’interpretazione del<br />
libro che viene dall’alto. Pren<strong>di</strong> questo è il mio Corpo, questo è<br />
il mio Sangue! Se uno l’affronta da solo? [...] la Chiesa <strong>di</strong>ce che<br />
Gesù faceva sul serio.<br />
Uno che affronta il Vangelo con la mentalità critica <strong>di</strong> oggi,<br />
lo leggerebbe in un modo, uno, con un’altra mentalità, in un altro;<br />
così in un Paese o in un altro, in un’epoca o in un’altra, con men-<br />
61) In una lettera, in<strong>di</strong>rizzata ai ragazzi<br />
<strong>di</strong> Piadena, dei ragazzi <strong>di</strong> Barbiana<br />
– in cui la si descrive in quello stile che<br />
è tipico <strong>di</strong> don Milani – il paesino è<br />
così presentato: «Barbiana è sul fi anco<br />
nord del monte Giovi, a 470 metri sul<br />
mare; ve<strong>di</strong>amo, sotto <strong>di</strong> noi, tutto il Mugello<br />
che è la valle della Sieve, affl uente<br />
dell’Arno, dall’altra parte del Mugello<br />
ve<strong>di</strong>amo la catena dell’Appennino. Barbiana<br />
non è nemmeno un villaggio, perché<br />
la chiesa e le case sono sparse nei<br />
boschi e nei campi. I posti <strong>di</strong> montagna<br />
come questo sono rimasti <strong>di</strong>sabitati, se<br />
non ci fosse la nostra scuola a tener<br />
fermi i nostri genitori, anche Barbiana<br />
sarebbe un deserto».<br />
DON MILANI IN DIRETTA<br />
62) Libreria E<strong>di</strong>trice Fiorentina, Firenze<br />
1957.<br />
63) A seguito dei suoi interventi in<br />
<strong>di</strong>fesa dell’obiezione <strong>di</strong> coscienza, in cui<br />
si stacca decisamente dall’opinione comune,<br />
venne citato in giu<strong>di</strong>zio, ma morì<br />
prima che fosse emessa la sentenza.<br />
64) L. MILANI, L’obbe<strong>di</strong>enza non è più<br />
una virtù, Libreria E<strong>di</strong>trice Fiorentina,<br />
Firenze 1965.<br />
65) Secondo l’antica leggenda, il noto<br />
furfante dell’Attica assassinava i<br />
viandanti che gli chiedevano ospitalità<br />
facendoli prima coricare su un apposito<br />
letto a ciò pre<strong>di</strong>sposto e poi troncando<br />
loro le gambe se erano troppo lunghe,<br />
stirandole se erano più corte.<br />
talità tutta <strong>di</strong>versa. Questa Chiesa è quella che possiede i sacramenti.<br />
L’assoluzione dei peccati non me la dà mica l’Espresso.<br />
L’assoluzione dei peccati me la dà il prete. E se uno vuole il perdono<br />
dei suoi peccati, si rivolge al più stupido e più arretrato dei<br />
preti per averla, non si rivolge mica al borghese moderno, intellettuale,<br />
colto, che si crede mio amico e mio simile. Io non sono<br />
affatto simile a quella gente…<br />
Se dovessi scegliere una religione, sceglierei quella cattolica,<br />
perché tra le altre cose importantissime, fondamentali, c’è il sacramento<br />
della confessione, per il qual solo quasi, per quello solo,<br />
sono cattolico: per poter avere continuamente il perdono dei<br />
peccati e darlo. Il più piccolo litigio con la Chiesa mi toglie questo<br />
potere. E chi me lo rende? Benedetti, Falconi? E la comunione e<br />
la Messa me la danno loro? Se si mettessero nello stato d’animo<br />
<strong>di</strong> chi crede che la Chiesa ha il deposito delle fondamentali verità,<br />
non delle piccole verità politiche locali, ma <strong>di</strong> quelle fondamentali<br />
– se Dio esiste, se Gesù era il fi glio <strong>di</strong> Dio, se quando <strong>di</strong>ceva<br />
“questo è il mio corpo” faceva sul serio o faceva per <strong>di</strong>re, se risorgeremo,<br />
se c’è la vita eterna o no – se ci mettessimo in mente<br />
che la Chiesa è dalla parte del vero in queste cose e ha i mezzi<br />
per arrivarci, la dottrina e i sacramenti per arrivarci… allora<br />
perché vengono a domandarmi: “Perché non vieni via dalla <strong>di</strong>tta<br />
dove tu ti puoi salvare, visto che la pensi come noi?”. Dove la<br />
penso come voi? In qualche piccolissimo particolare esterno della<br />
vita politica e sociale. Questo è il motivo per cui ci penso neanche<br />
lontanamente <strong>di</strong> venire con voi…». (Conversazione registrata<br />
avventurosamente e riportata in Don Milani! chi era costui? <strong>di</strong><br />
Pecorini Giorgio, ed. Bal<strong>di</strong>ni e Castol<strong>di</strong>, Milano 1996).<br />
Olycom
tino capaci <strong>di</strong> ragionare da sé, <strong>di</strong><br />
giu<strong>di</strong>care, <strong>di</strong> farsi libere in un mondo<br />
in cui la libertà è un rischio, una<br />
quoti<strong>di</strong>ana conquista, <strong>di</strong>rettamente<br />
correlata al sapere, secondo<br />
l’affermazione evangelica: «...e la<br />
verità vi farà liberi». 66 Il sapere<br />
dunque come conoscenza della<br />
verità; una verità da vivere e da<br />
partecipare con coerenza e convinzione,<br />
affi nché ogni uomo abbia un<br />
futuro <strong>di</strong> libertà, un futuro migliore.<br />
Purtroppo queste illuminate<br />
intuizioni e lucide rivelazioni che<br />
sconvolgevano le tra<strong>di</strong>zioni non<br />
solo <strong>di</strong>dattiche, ma anche educative<br />
e formative della scuola istituzionale,<br />
incapparono nella temperie<br />
del 1968, che, come è noto, ne<br />
fece motivo <strong>di</strong> speculazione politica,<br />
stravolgendole. 67 Superato il<br />
momentaneo travisamento, il teorema<br />
<strong>di</strong>dattico <strong>di</strong> don Milani ha ri-<br />
40 ITALIA 150<br />
preso il suo interiore e spirituale<br />
slancio a livello planetario.<br />
Barbiana, quando don Lorenzo<br />
vi arrivò, contava 39 persone;<br />
<strong>di</strong>rla parrocchia signifi cava usare<br />
un eufemismo: era semplicemente<br />
una località irreperibile nelle<br />
mappe e che probabilmente doveva<br />
scomparire anche dalla geografi<br />
a ecclesiastica. Quasi a sorpresa<br />
vi giunse don Lorenzo, in un isolamento<br />
accentuato che avrebbe<br />
spento in chiunque ogni pur nobile<br />
aspirazione. Non fu così. Don Milani,<br />
incompreso e minato dal cancro,<br />
in quella situazione impossibile,<br />
operò l’impossibile. Raggranellati<br />
i ragazzi sperduti nei loro casolari,<br />
<strong>di</strong>spersi nei boschi e remoti<br />
nella campagna, fi gli <strong>di</strong> sottoproletari<br />
agricoli, realizzò con loro un<br />
organismo pensante che sta conquistando<br />
il mondo. È il miracolo<br />
Olycom<br />
Don Lorenzo Milani<br />
a Barbiana<br />
con i suoi ragazzi.<br />
Don Lorenzo Milani<br />
at Barbiana with his<br />
children.<br />
<strong>di</strong> Barbiana, la cui forza sta nella<br />
fedeltà alla propria vocazione, ben<br />
convinti che ogni realtà, quin<strong>di</strong><br />
anche la Chiesa, si rinnova restandoci<br />
e partendo dagli ultimi.<br />
La grandezza e la gloria d’Italia<br />
unita sono anche qui, in questo<br />
sperduto fazzoletto <strong>di</strong> arida terra<br />
fi orentina, ove un giovane sacerdote,<br />
giuntovi sulle ali del mistero che<br />
circonda le gran<strong>di</strong> opere <strong>di</strong> Dio,<br />
e<strong>di</strong>fi cò la prima cattedrale del sapere<br />
giovane e popolare: ha per<br />
altare appunto la cattedra e i fedeli<br />
furono, sono e saranno tutti gli<br />
alunni <strong>di</strong> buona volontà, sparsi nel<br />
mondo. Nati liberi per vivere in liberà.<br />
Sottratti alla peggior schiavitù:<br />
l’ignoranza. Redenti dalla Parola.<br />
La Parola rivelata e la parola<br />
imparata, compitando sui banchi<br />
<strong>di</strong> scuola.<br />
***<br />
La religione cristiana, del l’amore<br />
e della fraternità, della verità<br />
tutta intera, vissuta e pre<strong>di</strong>cata da<br />
tanti suoi apostoli più o meno noti,<br />
<strong>di</strong> ieri e <strong>di</strong> oggi, ancora si conferma<br />
come l’unico cemento attivo dei<br />
popoli, senza il quale, anche a <strong>di</strong>stanza<br />
<strong>di</strong> decenni, gli agglomerati<br />
umani, pur compresi entro i medesimi<br />
perimetri nazionali, rischiano<br />
<strong>di</strong> rimanere estranei a sé e confl ittuali<br />
agli altri.<br />
Parafrasando una nota affermazione<br />
<strong>di</strong> Francisco Goya, si può<br />
ben asserire che pure «il sonno<br />
della religione genera i mostri». Gli<br />
errori e gli orrori della laicizzazione<br />
in atto ne sono la riprova.<br />
Don Luigi Sturzo, don Primo<br />
Mazzolari, don Lorenzo Milani: tre<br />
umili preti, tre pietre miliari dell’Italia<br />
unita.<br />
66) Vangelo <strong>di</strong> Giovanni, 8,32.<br />
67) È noto che una delle espressioni<br />
care e programmatiche <strong>di</strong> don Milani<br />
era: “I care”, letteralmente signifi ca: “Io<br />
mi prendo cura” (in <strong>di</strong>chiarata opposizione<br />
al “Me ne frego” fascista); il motto<br />
era scritto su un cartello ben visibile<br />
all’ingresso della scuola <strong>di</strong> Barbiana e<br />
intendeva riassumere le sue fi nalità<br />
educative, orientate alla presa <strong>di</strong> coscienza<br />
civile e sociale dei suoi frequentatori.<br />
Il Partito Democratico della<br />
Sinistra (DS), nel suo primo convegno<br />
del 2000 ancora lo utilizzava come slogan<br />
propagan<strong>di</strong>stico (ve<strong>di</strong> l’intervento <strong>di</strong><br />
Luigi Berlinguer).
NOTIZIARIO<br />
Economia-Finanza<br />
ALESSANDRO BOLOGNESI<br />
Il listino azionario<br />
è in ven<strong>di</strong>ta<br />
Il risparmiatore attento, o che gestisca<br />
<strong>di</strong>rettamente il suo portafoglio<br />
titoli, oppure che segua,<br />
attraverso le gestioni l’andamento<br />
della Borsa, <strong>di</strong>ffi cilmente riesce ad<br />
avere un quadro esatto del valore del<br />
suo possesso azionario in un determinato<br />
momento. Se un comparto sale,<br />
favorito dai sintomi <strong>di</strong> ripresa che si<br />
vanno manifestando in un settore produttivo,<br />
resta incerto un altro settore,<br />
ove il risparmiatore ha investito buona<br />
parte dei suoi risparmi; e pertanto<br />
l’investimento azionario è rappresentato<br />
dagli in<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> Borsa, che riassumono<br />
i valori <strong>di</strong> gran parte dei titoli presenti<br />
nel listino azionario o meglio dai<br />
cosiddetti Etf-Excange trade fund, che<br />
riassumono in sé le caratteristiche<br />
proprie <strong>di</strong> un fondo o <strong>di</strong> una azione,<br />
consentendo così <strong>di</strong> contenere i rischi<br />
delle oscillazioni <strong>di</strong> mercato.<br />
Per meglio conoscere questo strumento<br />
<strong>di</strong> investimento, va sottolineato<br />
come altri ancora sono i vantaggi <strong>di</strong> chi<br />
utilizza gli Etf; come ad esempio le<br />
commissioni, che possono raggiungere<br />
la metà rispetto alle normali spese<br />
per acquisto <strong>di</strong> titoli, oppure <strong>di</strong> altri<br />
contratti che riguardano l’acquisto <strong>di</strong>retto<br />
<strong>di</strong> azioni ed obbligazioni.<br />
Ma la caratteristica preminente<br />
<strong>di</strong> questo strumento fi nanziario è quella<br />
<strong>di</strong> realizzare l’identica performance<br />
dell’in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> Borsa: l’Etf consente <strong>di</strong><br />
ottenere un ren<strong>di</strong>mento pari a quello<br />
del benchmark <strong>di</strong> riferimento, in virtù<br />
<strong>di</strong> una “gestione totalmente passiva”<br />
perché rifl ette, al suo interno, l’esatta<br />
composizione ed i pesi relativi dell’in-<br />
<strong>di</strong>ce, al quale si riferisce. Da tenere<br />
presente soltanto l’espressione del<br />
prezzo, qualora la valuta <strong>di</strong> riferimento<br />
dell’in<strong>di</strong>ce sia <strong>di</strong>versa da quella <strong>di</strong><br />
negoziazione (che per i nostri Etf resta<br />
sempre l’euro), e pertanto solo in questo<br />
caso, occorre tenere presente<br />
l’eventualità <strong>di</strong> una svalutazione, od<br />
apprezzamento, dell’Etf, rispetto<br />
all’euro.<br />
Tra gli altri vantaggi nell’investimento<br />
in Etf, rispetto all’acquisto <strong>di</strong>retto<br />
<strong>di</strong> azioni, vi è pure quello <strong>di</strong> una riduzione<br />
del costo rispetto ad un portafoglio<br />
titoli <strong>di</strong>versifi cato, perché non è<br />
prevista alcuna commissione extra,<br />
ma solo una commissione totale annua<br />
(Ter) ridotta rispetto alle normali spese<br />
bancarie per acquisto <strong>di</strong> titoli, ed<br />
applicata automaticamente con riferimento<br />
al periodo <strong>di</strong> detenzione.<br />
Nulla cambia invece rispetto ai<br />
proventi, o benefi ci, che provengono<br />
dall’investimento: i <strong>di</strong>viden<strong>di</strong> che l’Etf<br />
incassa, a fronte delle azioni possedute<br />
nel proprio portafoglio, possono venire<br />
<strong>di</strong>stribuiti perio<strong>di</strong>camente all’investitore,<br />
oppure capitalizzati stabilmente<br />
nel patrimonio dell’Etf, e sempre a<br />
<strong>di</strong>sposizione dell’investitore.<br />
Resta poi da considerare il rischio<br />
<strong>di</strong> possibili insolvenze cui va soggetto<br />
The share-list is for sale<br />
The only real in<strong>di</strong>cator that can sound out our<br />
stock investment are the Stock Market indexes,<br />
which show the value of the majority of the listed<br />
securities, or better the ETF (Exchange Trade Fund).<br />
This investment instrument summarizes the<br />
characteristics of a fund or of a stock, and allows<br />
keeping the oscillations of the market under<br />
control. A further advantage is that of a reduced<br />
cost compared to a <strong>di</strong>versified stock portfolio.<br />
un investimento <strong>di</strong>retto in titoli azionari,<br />
ciò che non può accadere per gli<br />
Etf, in quanto hanno un patrimonio<br />
separato da quello della Società emittente,<br />
e pertanto non sono esposti a<br />
situazioni critiche che invece sono<br />
sempre possibili per altre forme societarie.<br />
L’unica penalizzazione potrebbe<br />
derivare dal rischio che le azioni, le<br />
obbligazioni e gli altri strumenti che<br />
compongono il loro patrimonio, possano<br />
perdere valore.<br />
Vi è poi da considerare l’aspetto<br />
fi scale, che risulta essere chiaro e semplice:<br />
la ritenuta fi scale a titolo <strong>di</strong> impresa<br />
del 12,5% è applicata sui red<strong>di</strong>ti<br />
derivanti dall’Etf in possesso, e viene<br />
operata automaticamente dall’interme<strong>di</strong>ario.<br />
Perciò nessun provento deve<br />
essere riportato nella propria <strong>di</strong>chiarazione<br />
dei red<strong>di</strong>ti.<br />
Il risultato ottenuto da questo<br />
strumento fi nanziario è evidente: dalla<br />
loro prima apparizione gli Etf quotati<br />
hanno raggiunto <strong>di</strong>mensioni ragguardevoli,<br />
come appare del resto dai listini<br />
pubblicati dai maggiori quoti<strong>di</strong>ani, a<br />
conferma del loro gra<strong>di</strong>mento ottenuto<br />
presso i risparmiatori, e che attualmente<br />
sfi orano le 400 voci.<br />
Per quanto riguarda l’attività, gli<br />
scambi si sono consolidati negli ultimi<br />
anni. Di fronte ad un volume <strong>di</strong> 46.594<br />
milioni realizzati nel 2008, lo scorso<br />
anno si sono registrati affari in ulteriore<br />
crescita ad oltre 54 miliar<strong>di</strong>. Una<br />
conferma del crescente interesse degli<br />
scambi in Etf è venuta <strong>di</strong> recente da<br />
parte <strong>di</strong> istituti stranieri che hanno instaurato<br />
fl ussi <strong>di</strong> domanda ed offerta<br />
sul mercato italiano. A sostegno <strong>di</strong> una<br />
operatività non più casuale e che si<br />
accentra su un numero sempre più<br />
vasto <strong>di</strong> titoli.<br />
ECONOMIA-FINANZA 41
Indagine conoscitiva<br />
sui mercati<br />
degli strumenti fi nanziari<br />
Introduzione<br />
Nell’area dell’euro il peso dell’interme<strong>di</strong>azione<br />
cre<strong>di</strong>tizia nella gestione<br />
delle passività delle imprese è preponderante<br />
rispetto all’esperienza dei Paesi<br />
anglosassoni. Se da un lato ciò, come<br />
imprese bancarie, ci rende fi eri e ci<br />
carica <strong>di</strong> responsabilità, dall’altro in<strong>di</strong>ca<br />
un percorso che soprattutto in Italia<br />
possiamo e dobbiamo ancora compiere<br />
verso uno sviluppo armonico dell’insieme<br />
del mercato fi nanziario e <strong>di</strong> alcuni<br />
suoi segmenti in particolare, segmenti<br />
su cui peraltro le stesse banche<br />
svolgono spesso un ruolo rilevante (ad<br />
esempio quotazione delle imprese).<br />
Nella presente au<strong>di</strong>zione cercheremo<br />
<strong>di</strong> fornire qualche valutazione<br />
delle ragioni sottostanti ad un certo<br />
sotto<strong>di</strong>mensionamento del mercato<br />
azionario e suggeriremo qualche possibile<br />
opzione per superare gli elementi<br />
<strong>di</strong> criticità e favorire un maggiore ricorso<br />
da parte delle imprese a tale ca-<br />
Fact-fin<strong>di</strong>ng investigation on the<br />
markets of financial tool<br />
In Italy, banks are the main players in the field of<br />
financial interme<strong>di</strong>ation: from savings in fields with<br />
positive financial balances such as the family, on<br />
to those with a negative balance such as<br />
businesses. This virtuous mechanism today,<br />
however, shows several critical elements: the share<br />
market is of modest size indeed; businesses are not<br />
able to quote on the markets easily, also due to<br />
significant operating costs; there are very few<br />
domestic institutional investors; and there are<br />
deficiencies in the approval procedures of the offer<br />
profiles and admission to negotiation. The limited<br />
size of Italian businesses is a significant factor,<br />
which impacts research, technological innovation,<br />
export and productivity.<br />
42 ECONOMIA-FINANZA<br />
nale <strong>di</strong> fi nanziamento. L’intervento è<br />
sostanzialmente strutturato in tre parti:<br />
nella prima forniremo qualche dato<br />
macro <strong>di</strong> inquadramento; nella seconda<br />
ci concentreremo su vari aspetti del<br />
listing del mercato azionario (criticità,<br />
servizi, interme<strong>di</strong>ari specializzati, competenze),<br />
nella terza trarremo qualche<br />
breve conclusione.<br />
1. Quadro macro:<br />
modalità <strong>di</strong> fi nanziamento<br />
delle imprese e limiti<br />
del mercato azionario italiano<br />
Nella me<strong>di</strong>a dell’Eurozona, la percentuale<br />
degli strumenti <strong>di</strong> fi nanziamento<br />
<strong>di</strong>retto sui mercati (obbligazioni<br />
e azioni quotate) sul complesso delle<br />
risorse fi nanziarie utilizzate dalle imprese<br />
è pari a meno della metà <strong>di</strong> quanto<br />
si registra per i prestiti, mentre le<br />
due fonti <strong>di</strong> fi nanziamento tendono ad<br />
equivalersi nell’esperienza britannica.<br />
All’interno <strong>di</strong> questa caratterizzazione<br />
dell’Unione, estrema risulta la situazione<br />
italiana in cui la somma <strong>di</strong> obbligazioni<br />
e azioni quotate supera appena il<br />
12% delle passività totali, contro un<br />
Italia<br />
Germania<br />
Francia<br />
Spagna<br />
Euro Area<br />
UK (**)<br />
GIUSEPPE MUSSARI<br />
Presidente dell’ABI<br />
valore prossimo al 50% per i prestiti.<br />
A partire da questi dati non deve dunque<br />
sorprendere che nel confronto<br />
europeo le <strong>di</strong>mensioni del mercato<br />
azionario italiano si collochino nella<br />
fascia bassa della classifi ca come incidenza<br />
della capitalizzazione <strong>di</strong> Borsa<br />
sul prodotto interno lordo: con una incidenza<br />
<strong>di</strong> poco superiore al 27%, la<br />
Borsa italiana denuncia un <strong>di</strong>vario <strong>di</strong><br />
quasi 40 punti rispetto alla me<strong>di</strong>a europea<br />
e <strong>di</strong> oltre 100 punti percentuali rispetto<br />
all’esperienza me<strong>di</strong>a <strong>di</strong> Uk e<br />
Usa. In valori assoluti, a fi ne 2010 la<br />
capitalizzazione complessiva delle società<br />
quotate sui mercati gestiti da<br />
Borsa Italiana si è attestata a circa 430<br />
miliar<strong>di</strong> <strong>di</strong> euro (<strong>di</strong> cui oltre il 20% rappresentata<br />
da banche), contro i circa<br />
4.400 miliar<strong>di</strong> <strong>di</strong> euro <strong>di</strong> capitalizzazione<br />
delle società quotate sul London<br />
Stock Exchange.<br />
Che tale ristrettezza del mercato<br />
azionario italiano non sia un effetto<br />
solo <strong>di</strong> una sfavorevole congiuntura<br />
delle quotazioni è evidente se si considera<br />
il numero delle società quotate<br />
nelle principali piazze europee.<br />
Struttura del passivo delle imprese non fi nanziarie<br />
(in % del totale; dati al 2008)<br />
Cre<strong>di</strong>ti<br />
Obbligazioni Prestiti <strong>di</strong> cui a breve Azioni quotate commerciali<br />
2,5 49,4 22,1 9,7 1,7<br />
3,4 37,0 9,9 17,6 3,4<br />
9,2 30,9 11,8 19,1 4,6<br />
1,0 53,8 10,0 10,3 3,1<br />
3,3 37,1 11,9 12,9 3,2<br />
11,4 37,3 22,3 25,5 3,1<br />
Altro (*)<br />
36,6<br />
38,4<br />
36,2<br />
31,8<br />
43,5<br />
22,7<br />
(*) fon<strong>di</strong> <strong>di</strong> quiescenza ed altro (comprese azioni non quotate) (**) dati non consolidati<br />
Fonte: Eurostat
250,00<br />
200,00<br />
150,00<br />
100,00<br />
50,00<br />
0,00<br />
Svizzera<br />
Fonte: Eurostat<br />
Capitalizzazione <strong>di</strong> Borsa in quota del prodotto interno lordo (dati ad agosto 2010)<br />
Lussemburgo<br />
Regno Unito<br />
Stati Uniti<br />
Spagna<br />
Giappone<br />
In questo caso si può notare come<br />
non solo il numero <strong>di</strong> imprese quotate<br />
in Borsa risulti decisamente basso<br />
(296 imprese contro le 783 della Borsa<br />
tedesca e le oltre 600 della Borsa francese<br />
e per non parlare delle quasi 3.000<br />
della Borsa inglese), ma anche come<br />
nel quadriennio 2006-2009 il numero<br />
delle imprese quotate sia <strong>di</strong>minuito <strong>di</strong><br />
15 unità.<br />
Accanto al numero contenuto <strong>di</strong><br />
imprese quotate, è importante evidenziare<br />
che il <strong>di</strong>vario più rilevante rispetto<br />
ad altri listini europei si concentra<br />
nel numero <strong>di</strong> società <strong>di</strong> minori <strong>di</strong>mensioni<br />
quotate, che nel nostro Paese<br />
erano, a fi ne 2008, appena 39.<br />
2. Trend <strong>di</strong> quotazione sui<br />
principali mercati azionari<br />
negli ultimi anni<br />
La quotazione sui mercati azionari<br />
è un’attività caratterizzata da elevata<br />
ciclicità perché infl uenzata, tra l’altro,<br />
da una serie <strong>di</strong> variabili esterne alle<br />
imprese, quali ad esempio l’andamento<br />
del ciclo economico e la situazione dei<br />
mercati fi nanziari.<br />
Se si considera il triennio prima<br />
dell’inizio della crisi fi nanziaria (2005-<br />
2007), si rileva ad esempio che le società<br />
neoquotate su Borsa Italiana sono<br />
state in me<strong>di</strong>a oltre 20 all’anno, rispetto<br />
al totale <strong>di</strong> 17 operazioni <strong>di</strong> quotazione<br />
(IPO - Initial Public Offers) dell’ultimo<br />
triennio (2008-2010) attraversato dalla<br />
crisi fi nanziaria.<br />
Francia<br />
Norvegia<br />
Turchia<br />
Malta<br />
Polonia<br />
Germania<br />
Anche recenti stu<strong>di</strong> internazionali<br />
1 hanno messo in luce che in Europa<br />
negli ultimi 10 anni (1999-2009) c’è stato<br />
un andamento ciclico <strong>di</strong> quotazioni<br />
<strong>di</strong> nuove imprese sul mercato, con un<br />
generalizzato calo del numero me<strong>di</strong>o<br />
<strong>di</strong> operazioni <strong>di</strong> IPO nell’ultimo biennio<br />
Exchange<br />
Athens Exchange<br />
BME Spanish Exchanges<br />
Borsa Italiana<br />
Budapest SE<br />
Cyprus SE<br />
Deutsche Börse<br />
Irish SE<br />
Istanbul SE<br />
Ljubljana SE<br />
London SE<br />
Luxembourg SE<br />
Malta SE<br />
MICEX<br />
Nasdaq OMX Nor<strong>di</strong>c Exchange<br />
NYSE Euronext (Europe)<br />
Oslo Børs<br />
SIX Swiss Exchange<br />
Warsaw SE<br />
Wiener Börse<br />
Cipro<br />
Austria<br />
End 2006<br />
290<br />
3.378<br />
311<br />
41<br />
141<br />
760<br />
70<br />
316<br />
100<br />
3.256<br />
260<br />
14<br />
193<br />
791<br />
1.210<br />
229<br />
348<br />
265<br />
113<br />
Fonte: World Federation of Exchanges members<br />
Irlanda<br />
Italia<br />
Numero delle imprese quotate<br />
End 2007<br />
283<br />
3.537<br />
307<br />
41<br />
124<br />
73<br />
319<br />
87<br />
3.307<br />
261<br />
16<br />
207<br />
851<br />
1.155<br />
248<br />
341<br />
375<br />
119<br />
Unione europea (EU 27) = 64,7<br />
Grecia<br />
Repubblica Ceca<br />
Ungheria<br />
paragonabile all’analoga fase <strong>di</strong> crisi<br />
dei listini azionari, dovuta alla cosiddetta<br />
bolla dei titoli hi-tech (2000).<br />
La crisi fi nanziaria ha dunque giocato<br />
negli anni più recenti un ruolo<br />
negativo nello sviluppo del listino italiano<br />
(così come in quello degli altri<br />
End 2008<br />
292<br />
3.576<br />
300<br />
43<br />
119<br />
832<br />
68<br />
317<br />
84<br />
3.096<br />
262<br />
19<br />
233<br />
824<br />
1.238<br />
259<br />
323<br />
458<br />
118<br />
Slovenia<br />
Bulgaria<br />
Romania<br />
End 2009<br />
288<br />
3.472<br />
296<br />
46<br />
115<br />
783<br />
64<br />
315<br />
76<br />
2.792<br />
267<br />
20<br />
234<br />
797<br />
1.160<br />
238<br />
339<br />
486<br />
115<br />
Slovacchia<br />
Var. %<br />
2009 vs 2006<br />
-1<br />
3<br />
-5<br />
12<br />
-18<br />
3<br />
-9<br />
0<br />
-24<br />
-14<br />
3<br />
43<br />
21<br />
1<br />
-4<br />
4<br />
-3<br />
83<br />
2<br />
ECONOMIA-FINANZA 43
Paesi), interrompendo un trend positivo<br />
<strong>di</strong> accesso delle imprese al mercato<br />
dei capitali, avviato successivamente<br />
alla crisi <strong>di</strong> inizio decennio.<br />
3. Le principali criticità del listing<br />
nel mercato azionario italiano<br />
Il mercato azionario italiano presenta<br />
da sempre limiti strutturali e<br />
culturali che impe<strong>di</strong>scono <strong>di</strong> raggiungere<br />
livelli <strong>di</strong>mensionali paragonabili a<br />
quelli dei maggiori listini europei.<br />
a) Diffi coltà culturali delle imprese a<br />
quotarsi sui mercati<br />
Per un’impresa, il processo <strong>di</strong><br />
quotazione rappresenta un momento<br />
strategico, ma allo stesso tempo critico:<br />
richiede un cambio <strong>di</strong> mentalità<br />
soprattutto da parte degli azionisti,<br />
che devono accettare l’effetto <strong>di</strong>luitivo<br />
sul capitale della propria azienda, il<br />
confronto con altri azionisti e stakeholders,<br />
la <strong>di</strong>ffusione <strong>di</strong> informazioni (contabili,<br />
fi nanziarie, <strong>di</strong> business) al mercato,<br />
su base continuativa.<br />
Lo sforzo richiesto per effettuare<br />
questo cambio culturale è tanto più<br />
elevato quanto minori sono le <strong>di</strong>mensioni<br />
dell’impresa che vuole accedere<br />
al mercato. Nel nostro Paese oltre il<br />
90% delle imprese sono caratterizzate<br />
da ridotte <strong>di</strong>mensioni (meno <strong>di</strong> 50 <strong>di</strong>pendenti).<br />
A ciò si aggiunge una forte concentrazione<br />
della proprietà a livello<br />
familiare ed un elevato livello <strong>di</strong> indebitamento,<br />
anche a causa della ridotta<br />
dotazione <strong>di</strong> mezzi propri. 2 L’incidenza<br />
dello stock <strong>di</strong> debiti bancari rispetto al<br />
patrimonio raggiunge valori superiori<br />
al 100% (104,2%) per le imprese manifatturiere<br />
italiane con fatturato inferiore<br />
ai 10 milioni <strong>di</strong> euro. In Germania,<br />
Francia e Spagna tale incidenza è in<br />
me<strong>di</strong>a del 48%.<br />
La concentrazione della proprietà<br />
a livello familiare, le resistenze <strong>di</strong> tipo<br />
culturale legate prevalentemente al timore<br />
<strong>di</strong> perdere il controllo della società<br />
determinano una scarsa propensione<br />
all’apertura del capitale.<br />
Il carattere familiare delle imprese<br />
italiane non dovrebbe rappresentare<br />
peraltro, <strong>di</strong> per sé, un ostacolo alla<br />
quotazione, considerato che le imprese<br />
controllate da una famiglia hanno<br />
<strong>di</strong>mostrato negli anni scorsi <strong>di</strong> essere<br />
apprezzate dalla Borsa 3 e che la variazione<br />
degli assetti proprietari dopo la<br />
44 ECONOMIA-FINANZA<br />
quotazione non porta, nella maggior<br />
parte dei casi, a perdere il controllo<br />
dell’impresa. 4<br />
È importante pertanto, far crescere<br />
il mercato italiano dei capitali, mettendo<br />
in campo iniziative che favoriscano<br />
un’inversione <strong>di</strong> tendenza dal<br />
punto <strong>di</strong> vista culturale ed una crescita<br />
complessiva della <strong>di</strong>mensione del sistema<br />
impren<strong>di</strong>toriale italiano.<br />
Un primo passo potrebbe essere<br />
quello <strong>di</strong> introdurre misure volte a<br />
correggere alcune <strong>di</strong>storsioni nelle<br />
scelte <strong>di</strong> fi nanziamento delle imprese<br />
motivate dall’esistenza <strong>di</strong> un favore fi -<br />
scale per le forme <strong>di</strong> indebitamento rispetto<br />
al capitale proprio: in tal senso,<br />
potrebbero essere previste, ad esempio,<br />
forme <strong>di</strong> agevolazione fi scale degli<br />
utili destinati alla patrimonializzazione<br />
che consentano alle imprese <strong>di</strong> ottenere<br />
risparmi <strong>di</strong> imposta, parametrati<br />
alla quota <strong>di</strong> utile netto non <strong>di</strong>stribuito.<br />
Resta peraltro <strong>di</strong> fondamentale<br />
importanza superare la tra<strong>di</strong>zionale<br />
resistenza ad aprirsi al mercato attraverso<br />
la quotazione. In tale ottica, nel<br />
gennaio 2010, ABI e Borsa Italiana hanno<br />
siglato un accordo nell’ambito del<br />
quale sono state avviate specifiche<br />
iniziative (tra cui la previsione <strong>di</strong> una<br />
linea <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to de<strong>di</strong>cata ad imprese<br />
neoquotate per fi nanziare i programmi<br />
<strong>di</strong> crescita).<br />
b) Elevati oneri <strong>di</strong> quotazione e permanenza<br />
sul listino<br />
Un altro elemento che costituisce<br />
tra<strong>di</strong>zionale ostacolo al ricorso alla<br />
quotazione è rappresentato dai costi<br />
<strong>di</strong>retti ed in<strong>di</strong>retti che le imprese sostengono<br />
per realizzarla.<br />
Tali costi <strong>di</strong>pendono, fra l’altro,<br />
dalla complessità aziendale e dall’importanza<br />
del mercato <strong>di</strong> quotazione<br />
(<strong>di</strong>versa a seconda che si tratti del<br />
Mercato Telematico Azionario [MTA] o<br />
dell’Alternative Investment Market [AIM]<br />
Italia, ecc.).<br />
In via approssimativa, secondo<br />
Borsa Italiana, è possibile stimare che<br />
in Italia per emittenti che ricorrono<br />
all’MTA i costi complessivi <strong>di</strong> quotazione<br />
ammontano a circa 800/900 mila<br />
euro, tra il 2% e il 5% dell’ammontare<br />
raccolto in sede <strong>di</strong> IPO. Tali costi si<br />
aggirano invece attorno a 200-300 mila<br />
euro nel caso <strong>di</strong> quotazione sul listino<br />
delle piccole e me<strong>di</strong>e imprese (l’AIM<br />
Italia), corrispondente me<strong>di</strong>amente al<br />
5-6% dell’ammontare raccolto in sede<br />
<strong>di</strong> IPO.<br />
Va sottolineato che alcuni <strong>di</strong> questi<br />
costi (come ad esempio la pubblicità<br />
obbligatoria sui quoti<strong>di</strong>ani dei fattori<br />
<strong>di</strong> rischio presenti nei prospetti <strong>di</strong> offerta)<br />
non gravano sulle società che si<br />
quotano all’estero, non essendo previsti<br />
dalla normativa europea: se ne potrebbe<br />
valutare dunque la loro eliminazione.<br />
Naturalmente, il problema dei costi<br />
<strong>di</strong> quotazione è particolarmente<br />
sentito dalle imprese me<strong>di</strong>o-piccole.<br />
L’esperienza degli anni scorsi in Italia<br />
ha fornito evidenti prove <strong>di</strong> ciò e della<br />
conseguente scarsa attrazione dei mercati<br />
regolamentati 5 per le PMI. 6<br />
Di qui l’avvio nel 2008 del Mercato<br />
Alternativo del Capitale (MAC) e nel<br />
2009 dell’AIM Italia per facilitare la<br />
quotazione delle PMI grazie a costi <strong>di</strong><br />
quotazione complessivi inferiori a<br />
quelli previsti per un mercato regolamentato<br />
nonché a procedure <strong>di</strong> ammissione<br />
semplifi cate e più rapide ed a<br />
requisiti <strong>di</strong> informativa per gli emittenti<br />
più snelli.<br />
Il tema della semplifi cazione delle<br />
procedure <strong>di</strong> quotazione delle PMI è<br />
stato <strong>di</strong> recente oggetto <strong>di</strong> una iniziativa<br />
<strong>di</strong> carattere normativo a livello europeo,<br />
promossa dal Governo francese<br />
e da esperti della materia, fi nalizzata<br />
ad in<strong>di</strong>viduare alcune ipotesi <strong>di</strong><br />
semplifi cazione della <strong>di</strong>sciplina concernente<br />
le piccole e me<strong>di</strong>e imprese a<br />
vari livelli. 7<br />
In tale iniziativa <strong>di</strong> snellimento,<br />
che l’ABI con<strong>di</strong>vide, potrebbe rientrare<br />
anche l’eliminazione o la riduzione <strong>di</strong><br />
alcuni adempimenti critici tipici della<br />
<strong>di</strong>sciplina italiana, quali gli obblighi <strong>di</strong><br />
comunicazione al mercato al raggiungimento<br />
da parte degli investitori della<br />
soglia minima del 2%, che nel caso <strong>di</strong><br />
IPO <strong>di</strong> imprese <strong>di</strong> piccole <strong>di</strong>mensioni,<br />
determinano rilevanti criticità.<br />
Non va <strong>di</strong>menticato inoltre che gli<br />
oneri connessi alla quotazione non<br />
esauriscono quelli che un’impresa quotata<br />
deve affrontare per permanere nel<br />
listino. Lo status <strong>di</strong> emittente quotato<br />
nei mercati regolamentati comporta,<br />
infatti, l’applicazione <strong>di</strong> un plesso <strong>di</strong><br />
norme, per buona parte <strong>di</strong> derivazione<br />
comunitaria, la cui compliance è particolarmente<br />
onerosa. Si fa riferimento,<br />
tra gli altri, agli obblighi <strong>di</strong> trasparenza<br />
e segnalazione al mercato, agli obblighi
140%<br />
120%<br />
100%<br />
80%<br />
60%<br />
40%<br />
20%<br />
0%<br />
65%<br />
% capitalizzazione detenuta da investitori domestici ed esteri*<br />
su capitalizzazione totale<br />
% capitalizzazione detenuta da investitori istituzionali<br />
domestici ed esteri* /PIL<br />
76%<br />
65%<br />
42%<br />
USA Unione europea<br />
(27)<br />
(*) banche incluse tra gli investitori istituzionali; i dati sulla capitalizzazione si riferiscono al main market al<br />
31/8/2010; i dati sulla percentuale <strong>di</strong> capitalizzazione detenuta da investitori istituzionali si basano su elaborazioni<br />
ABI su dati <strong>di</strong> Borsa Italiana (dati 2008 per Italia e dati 2005 per altri Paesi; nel 2005 i dati italiani<br />
erano pari a 37% e 10%, al 2008 risultano pari a 28% e 7%); i dati del PIL si riferiscono al 31/12/2009.<br />
<strong>di</strong> segnalazione alla Consob, nonché<br />
alla pre<strong>di</strong>sposizione dell’informativa<br />
fi nanziaria perio<strong>di</strong>ca.<br />
c) Carenza <strong>di</strong> investitori istituzionali<br />
In Italia il ruolo degli investitori<br />
istituzionali domestici sul mercato<br />
azionario è molto contenuto. Dal grafi -<br />
co riportato sopra emerge che la quota<br />
<strong>di</strong> capitalizzazione <strong>di</strong> Borsa detenuta<br />
da investitori istituzionali (banche incluse)<br />
rispetto alla capitalizzazione totale<br />
del mercato è pari al 28%. Il confronto<br />
con la realtà europea ed internazionale<br />
mostra che negli Usa e nell’Unione<br />
europea tale rapporto è pari<br />
al 65% mentre nel Regno Unito raggiunge<br />
l’81%. Il grafi co mostra che anche<br />
rispetto al Pil, la capitalizzazione detenuta<br />
dagli investitori istituzionali è più<br />
bassa in Italia rispetto alle altre piazze<br />
fi nanziarie ed all’Europa nel suo complesso.<br />
In tale scenario si riscontra in<br />
particolare una specifi ca carenza <strong>di</strong><br />
fon<strong>di</strong> specializzati in imprese a ridotta<br />
capitalizzazione. Al momento, infatti,<br />
solo otto fon<strong>di</strong> <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto italiano sono<br />
de<strong>di</strong>cati in prevalenza alle small cap<br />
(investendo peraltro signifi cative quote<br />
del patrimonio in imprese <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni<br />
me<strong>di</strong>o-gran<strong>di</strong> negoziate sull’MTA).<br />
Dall’analisi dell’asset allocation <strong>di</strong> detti<br />
fon<strong>di</strong> emerge infatti che la capitalizza-<br />
28%<br />
7%<br />
81%<br />
Italia UK<br />
128%<br />
zione <strong>di</strong> mercato me<strong>di</strong>a dei primi cinque<br />
titoli in cui gli stessi investono è<br />
sempre superiore al miliardo <strong>di</strong> euro.<br />
La carenza <strong>di</strong> investitori small<br />
cap, determina <strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong> collocamento<br />
<strong>di</strong> titoli in sede <strong>di</strong> mercato primario<br />
nonché ridotti scambi sul mercato<br />
secondario (con conseguente riflesso<br />
sul corso dei prezzi dei titoli<br />
stessi) e costituisce anche un <strong>di</strong>sincentivo<br />
per le stesse imprese a quotarsi.<br />
Occorrono quin<strong>di</strong> strumenti che<br />
incentivino nel nostro Paese lo sviluppo<br />
<strong>di</strong> tali investitori istituzionali e aiutino<br />
a colmare il <strong>di</strong>vario attualmente<br />
esistente sul nostro mercato rispetto<br />
ad altre piazze fi nanziarie europee.<br />
Una strada perseguibile, ad esempio,<br />
è quella <strong>di</strong> introdurre agevolazioni<br />
<strong>di</strong> carattere fi scale per le persone fi siche<br />
e le imprese che sottoscrivono<br />
quote <strong>di</strong> veicoli specializzati nell’investimento<br />
in società small cap quotate<br />
su mercati non regolamentati quali<br />
l’AIM Italia e il MAC.<br />
Su tale strumento, peraltro già<br />
previsto in altri Paesi europei, l’ABI ha<br />
sviluppato una proposta concreta, che<br />
intende portare nelle se<strong>di</strong> competenti,<br />
anche con la con<strong>di</strong>visione degli altri<br />
stakeholder. Lo sviluppo <strong>di</strong> fon<strong>di</strong> <strong>di</strong> investimento<br />
specializzati in PMI potrebbe<br />
anche essere attuato utilizzando<br />
strumenti esistenti, quale ad esempio<br />
il Fondo Italiano <strong>di</strong> Investimento (FII),<br />
che potendo anche investire in<strong>di</strong>rettamente<br />
nelle imprese tramite altri fon<strong>di</strong><br />
(agendo come fondo <strong>di</strong> fon<strong>di</strong>), potrebbe<br />
creare un effetto leva con benefi ci<br />
sull’attività e lo sviluppo dei fon<strong>di</strong> specializzati<br />
in imprese small cap.<br />
Nell’ottica <strong>di</strong> favorire lo sviluppo<br />
<strong>di</strong> investitori istituzionali emerge poi<br />
l’esigenza <strong>di</strong> rime<strong>di</strong>are agli attuali squilibri<br />
nella tassazione dei fon<strong>di</strong> comuni,<br />
in particolare tra fon<strong>di</strong> <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto italiano<br />
(tassati per maturazione) e quelli <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>ritto estero (tassati per cassa), nonché<br />
alle conseguenti incertezze normative<br />
sulla classifi cazione dei ren<strong>di</strong>menti<br />
da essi generati (red<strong>di</strong>ti <strong>di</strong> capitale o<br />
red<strong>di</strong>ti <strong>di</strong>versi).<br />
A tal proposito, potrebbe fra l’altro<br />
essere valutata l’opportunità <strong>di</strong> una<br />
sostituzione del regime <strong>di</strong> tassazione<br />
per maturazione dei fon<strong>di</strong> <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto<br />
italiano con il regime della tassazione<br />
per cassa secondo uno schema analogo<br />
a quello attualmente seguito per i<br />
fon<strong>di</strong> esteri armonizzati UE, nonché <strong>di</strong><br />
apposite norme <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto transitorio<br />
per la sistemazione dei risparmi d’imposta<br />
accumulati dai fon<strong>di</strong>, trasformandoli<br />
in tempi brevi in nuova liqui<strong>di</strong>tà<br />
da investire, a vantaggio della<br />
performance del fondo.<br />
4. L’offerta dei servizi <strong>di</strong> listing<br />
da parte delle società mercato<br />
in Italia<br />
Il processo <strong>di</strong> modernizzazione<br />
dei mercati italiani prende avvio con la<br />
legge n. 1/1991, che da un lato scioglie<br />
i Comitati <strong>di</strong>rettivi delle se<strong>di</strong> della Borsa<br />
e costituisce il Consiglio <strong>di</strong> Borsa, dall’altro<br />
impone la concentrazione degli<br />
scambi in Borsa.<br />
Il passo successivo viene compiuto<br />
con l’emanazione nel 1998 del Testo<br />
Unico della Finanza (TUF) che sancisce<br />
la privatizzazione del mercato, con<br />
la trasformazione <strong>di</strong> un soggetto pubblico,<br />
il Consiglio <strong>di</strong> Borsa, in un soggetto<br />
privato. Nasce così la Borsa Italiana,<br />
società per azioni a carattere impren<strong>di</strong>toriale,<br />
partecipata dai principali<br />
operatori del mercato, cui scopo è<br />
l’organizzazione, la gestione e lo sviluppo<br />
dei mercati italiani.<br />
Non si può non riconoscere alla<br />
Borsa Italiana <strong>di</strong> aver svolto negli ultimi<br />
<strong>di</strong>eci anni un compito importante,<br />
gestendo il delicato passaggio da un<br />
modello basato su mercati <strong>di</strong> natura<br />
ECONOMIA-FINANZA 45
pubblica ad un modello, più moderno<br />
ed in linea con le principali esperienze<br />
estere, <strong>di</strong> mercati gestiti da soggetti<br />
impren<strong>di</strong>toriali.<br />
In questo compito, un ruolo importante<br />
è stato certamente svolto<br />
dall’obbligo della concentrazione degli<br />
scambi sul mercato regolamentato,<br />
che ha garantito uno sviluppo or<strong>di</strong>nato<br />
e solido del mercato azionario, prevenendo<br />
una frammentazione della liqui<strong>di</strong>tà<br />
degli scambi e delle informazioni.<br />
Tale principio ha tuttavia evitato<br />
che la Borsa Italiana fosse esposta alla<br />
competizione <strong>di</strong> altri mercati, confi gurando,<br />
almeno nei fatti, una situazione<br />
<strong>di</strong> esclusività nella offerta <strong>di</strong> servizi <strong>di</strong><br />
listing. Anche le esperienze <strong>di</strong> mercati<br />
regolamentati alternativi a Borsa Italiana<br />
hanno riguardato principalmente il<br />
mondo dei mercati non azionari (titoli<br />
<strong>di</strong> Stato e obbligazioni).<br />
Tale situazione, tuttavia, è in fase<br />
<strong>di</strong> cambiamento, da quando è stata introdotta<br />
in Europa la Direttiva sui Mercati<br />
<strong>di</strong> Strumenti Finanziari (Mifi d) che<br />
ha rappresentato per l’Italia un’ulteriore<br />
ed importante rivoluzione in tema <strong>di</strong><br />
mercati fi nanziari.<br />
La Mifi d ha infatti messo al bando<br />
defi nitivamente la possibilità per gli<br />
Stati membri <strong>di</strong> prorogare l’obbligo<br />
della concentrazione degli scambi.<br />
Questo sta determinando in Europa un<br />
passaggio, seppur graduale, degli<br />
scambi dei titoli quotati sul mercato<br />
azionario italiano su mercati alternativi.<br />
Si tratta soprattutto <strong>di</strong> un mero e<br />
preve<strong>di</strong>bile fenomeno <strong>di</strong> migrazione<br />
del tra<strong>di</strong>ng e non del listing.<br />
Per quanto riguarda poi l’offerta<br />
<strong>di</strong> mercati per le PMI, occorre ricordare,<br />
oltre all’avvio del mercato AIM Italia<br />
sulla base dell’esperienza inglese<br />
dell’AIM UK, la recente acquisizione da<br />
parte <strong>di</strong> Borsa Italiana della società <strong>di</strong><br />
promozione del Mercato Alternativo<br />
del Capitale (ProMAC).<br />
Sul tema va altresì segnalata la<br />
recente costituzione <strong>di</strong> un Advisory<br />
Board de<strong>di</strong>cato ai mercati delle piccole<br />
e me<strong>di</strong>e imprese – promosso da Borsa<br />
Italiana a cui partecipano tutte le categorie<br />
<strong>di</strong> soggetti coinvolti nel mercato<br />
– con l’obiettivo <strong>di</strong> ristrutturare i mercati<br />
italiani delle PMI e favorire l’offerta<br />
<strong>di</strong> quotazione de<strong>di</strong>cata a tali imprese<br />
nel contesto italiano, attraverso specifi<br />
che iniziative e strategie <strong>di</strong> sviluppo<br />
dei suddetti mercati, che prevedono<br />
46 ECONOMIA-FINANZA<br />
anche una revisione del ruolo dei <strong>di</strong>versi<br />
attori coinvolti.<br />
In defi nitiva, sembra potersi valutare<br />
positivamente l’operato <strong>di</strong> Borsa<br />
Italiana negli anni precedenti (dall’ampliamento<br />
dei listini e la <strong>di</strong>versifi cazione<br />
dei segmenti alla telematizzazione<br />
degli scambi, al passaggio a meccanismi<br />
più effi cienti <strong>di</strong> regolamento delle<br />
transazioni, alla privatizzazione del<br />
mercato).<br />
5. Gli interme<strong>di</strong>ari specializzati<br />
nel listing azionario<br />
Nel processo <strong>di</strong> quotazione <strong>di</strong><br />
azioni intervengono <strong>di</strong>versi interme<strong>di</strong>ari<br />
con specifi che funzioni. In Italia<br />
c’è un numero ristretto <strong>di</strong> operatori<br />
specializzati nel listing azionario (al<br />
momento circa 20 interme<strong>di</strong>ari fi nanziari,<br />
inclusi quelli esteri): a questi<br />
vanno poi aggiunte alcune società <strong>di</strong><br />
consulenza e revisione che offrono<br />
servizi <strong>di</strong> corporate fi nance. Tale carenza<br />
può essere attribuita, fra l’altro:<br />
– ad una ridotta domanda <strong>di</strong> quotazione<br />
da parte delle imprese, per i<br />
motivi già ricordati in precedenza;<br />
– al fatto che i servizi relativi alla<br />
quotazione sono servizi ad alta specializzazione<br />
con una forte componente<br />
<strong>di</strong> consulenza/assistenza, per cui,<br />
anche in considerazione della scarsa<br />
domanda <strong>di</strong> cui sopra, non tutti gli<br />
interme<strong>di</strong>ari sono in grado <strong>di</strong> svolgere<br />
tale attività;<br />
– al fatto che gli stessi interme<strong>di</strong>ari,<br />
nell’ambito del processo <strong>di</strong> quotazione<br />
<strong>di</strong> un’impresa, possono ricoprire più<br />
ruoli (sponsor, specialist, responsabile<br />
del collocamento, ecc.).<br />
Nelle operazioni <strong>di</strong> IPO effettuate<br />
negli ultimi anni emerge infatti, tra<br />
l’altro, una stretta coincidenza tra gli<br />
incarichi <strong>di</strong> sponsor e responsabile del<br />
collocamento. Ciò costituisce un limite<br />
alla nascita <strong>di</strong> nuovi operatori.<br />
Tra i vari ruoli svolti dagli interme<strong>di</strong>ari<br />
nel processo <strong>di</strong> quotazione sul<br />
mercato, le attività dello sponsor e del<br />
responsabile del collocamento sono<br />
quelle che recano le maggiori criticità<br />
in quanto soggetti ad una specifi ca <strong>di</strong>sciplina<br />
normativa, che attribuisce loro<br />
compiti e responsabilità.<br />
Lo sponsor, in particolare, collabora<br />
con l’emittente nella procedura <strong>di</strong><br />
ammissione a quotazione degli strumenti<br />
fi nanziari ai fi ni <strong>di</strong> un or<strong>di</strong>nato<br />
svolgimento della stessa. Esso è tenuto<br />
a rilasciare una serie <strong>di</strong> attestazio ni/<br />
<strong>di</strong>chiarazioni relative, fra l’altro, alla<br />
presenza <strong>di</strong> un adeguato sistema <strong>di</strong><br />
controllo <strong>di</strong> gestione.<br />
Si tratta <strong>di</strong> un incarico che richiede<br />
competenze <strong>di</strong>verse rispetto a quelle<br />
degli interme<strong>di</strong>ari che effettuano<br />
collocamenti, la cui attività si focalizza<br />
su valutazioni del business plan e su<br />
valutazioni <strong>di</strong> carattere economico/fi -<br />
nanziario e patrimoniale dell’emittente.<br />
Ciò ha quin<strong>di</strong> un impatto sull’attività<br />
degli interme<strong>di</strong>ari in termini <strong>di</strong><br />
maggiori responsabilità e, <strong>di</strong> conseguenza,<br />
in termini <strong>di</strong> maggiori costi <strong>di</strong><br />
due <strong>di</strong>ligence legale che si ripercuotono<br />
sugli emittenti.<br />
In tale prospettiva, è auspicabile<br />
un intervento sulla regolamentazione<br />
del l’attività dello sponsor nell’ottica <strong>di</strong><br />
circoscrivere le sue funzioni alle attività<br />
su cui lo stesso ha una competenza<br />
specifi ca e, dunque, le relative responsabilità.<br />
L’attività del responsabile del collocamento<br />
dell’offerta pubblica assume<br />
rilievo nei rapporti con la Consob<br />
in quanto tale interme<strong>di</strong>ario, in base al<br />
regolamento Emittenti, è tenuto a rilasciare,<br />
fra l’altro, una <strong>di</strong>chiarazione in<br />
cui attesta, al pari degli altri sottoscrittori<br />
del prospetto e per le parti <strong>di</strong> propria<br />
competenza, che il prospetto stesso<br />
«è conforme agli schemi applicabili e<br />
che, avendo essi adottato tutta la ragionevole<br />
<strong>di</strong>ligenza a tale scopo, le informazioni<br />
in esso contenute sono, per<br />
quanto a loro conoscenza, conformi ai<br />
fatti e non presentano omissioni tali da<br />
alterarne il senso».<br />
Su tale interme<strong>di</strong>ario grava altresì,<br />
ai sensi dell’art. 94, comma nono, del<br />
TUF, una presunzione <strong>di</strong> responsabilità<br />
per le informazioni false o le omissioni<br />
idonee ad infl uenzare le decisioni <strong>di</strong> un<br />
investitore ragionevole.<br />
Detta previsione non è peraltro in<br />
linea con la <strong>di</strong>rettiva n. 2003/71/CE in<br />
tema <strong>di</strong> prospetti – che non prevede né<br />
la fi gura del responsabile del collocamento<br />
né alcuna presunzione legale <strong>di</strong><br />
responsabilità a carico <strong>di</strong> un solo interme<strong>di</strong>ario<br />
per informazioni false o per<br />
omissioni nel prospetto – né con le<br />
prassi degli altri Paesi europei, in base<br />
alle quali gli interme<strong>di</strong>ari che effettuano<br />
la due <strong>di</strong>ligence dei prospetti rilasciano<br />
generalmente attestazioni solo<br />
nella forma <strong>di</strong> negative assurance (<strong>di</strong>chiarando,<br />
ad esempio, che dalle veri-
fi che svolte non sono emersi elementi<br />
signifi cativi da far ritenere che nel prospetto<br />
siano contenute informazioni<br />
false od omissioni).<br />
Anche in tali casi si è in presenza<br />
<strong>di</strong> una elevata responsabilità per l’interme<strong>di</strong>ario<br />
rispetto a quanto si riscontra<br />
a livello europeo, responsabilità<br />
che si traduce in un aumento dei<br />
costi <strong>di</strong> due <strong>di</strong>ligence legale per l’interme<strong>di</strong>ario<br />
stesso e, <strong>di</strong> conseguenza, per<br />
l’emittente.<br />
6. La ripartizione<br />
delle competenze in tema<br />
<strong>di</strong> ammissione a quotazione<br />
tra Consob e Borsa Italiana<br />
Con la privatizzazione dei mercati,<br />
attuata con il Testo Unico della Finanza,<br />
le competenze in tema <strong>di</strong> ammissione a<br />
quotazione (cosiddetto listing) tra la<br />
Consob e la società <strong>di</strong> gestione del<br />
mercato (la Borsa Italiana) sono state<br />
ripartite: la Consob approva il prospetto<br />
<strong>di</strong> offerta dei titoli, mentre Borsa<br />
Italiana delibera l’ammissione a quotazione<br />
del l’emittente, subor<strong>di</strong>natamente<br />
al l’approvazione da parte della Consob<br />
del prospetto <strong>di</strong> offerta e <strong>di</strong> una attenta<br />
attività <strong>di</strong> analisi e valutazione<br />
dell’impresa quotanda.<br />
La scelta operata da Borsa<br />
Italiana, responsabile<br />
dell’attività <strong>di</strong> ammissione a<br />
quotazione, è stata quella <strong>di</strong><br />
subor<strong>di</strong>nare l’ammissione a<br />
quotazione a concrete verifi -<br />
che <strong>di</strong> merito (due <strong>di</strong>ligence) e<br />
non solo all’esistenza <strong>di</strong> requisiti<br />
formali dell’emittente. 8<br />
Ad avviso dell’ABI, la sud<strong>di</strong>visione<br />
dei ruoli tra Borsa<br />
Italiana e Consob non ha mostrato<br />
in questi anni particolari<br />
criticità. La criticità principale<br />
nel processo <strong>di</strong> ammissione<br />
a quotazione riguarda invece i<br />
tempi lunghi <strong>di</strong> approvazione<br />
dei prospetti da parte <strong>di</strong><br />
quest’ultima.<br />
La <strong>di</strong>rettiva europea n.<br />
2003/71/EC prevede che le Autorità<br />
<strong>di</strong> vigilanza approvino i<br />
prospetti entro <strong>di</strong>eci giorni lavorativi<br />
dalla presentazione<br />
della documentazione completa<br />
all’Autorità. Il termine è esteso<br />
a venti giorni ove l’emittente,<br />
come nel caso delle IPO,<br />
non abbia già strumenti fi nan-<br />
ziari ammessi alla negoziazione in mercati<br />
regolamentati e non abbia offerto<br />
strumenti fi nanziari al pubblico in precedenza.<br />
Tale tempistica, peraltro, viene<br />
frequentemente <strong>di</strong>sattesa, anche a causa<br />
della ponderosità della documentazione<br />
<strong>di</strong> offerta da approvare. Un’analisi<br />
pubblicata nel 2008 dal Centre for<br />
Strategy & Evaluation Services per conto<br />
della Commissione europea ha evidenziato<br />
ad esempio che in Europa, in<br />
31 IPO effettuate nel periodo gennaiogiugno<br />
2007 il tempo me<strong>di</strong>o <strong>di</strong> approvazione<br />
è stato <strong>di</strong> cinque settimane<br />
circa. Lo stu<strong>di</strong>o evidenzia poi il caso<br />
eccezionale dell’Italia in cui i prospetti<br />
sono <strong>di</strong>venuti sempre più ponderosi e<br />
costosi con una signifi cativa <strong>di</strong>latazione<br />
dei tempi me<strong>di</strong> <strong>di</strong> approvazione che<br />
variano tra i 60 ed i 90 giorni.<br />
Tale circostanza ha creato uno<br />
svantaggio competitivo, nel processo<br />
<strong>di</strong> ammissione a quotazione, per il<br />
mercato italiano rispetto ai mercati <strong>di</strong><br />
quotazione degli altri Stati UE, che si<br />
ripercuote negativamente sulla competitività<br />
delle imprese italiane rispetto a<br />
quelle europee.<br />
Va tuttavia segnalato che nel 2009,<br />
nell’ambito delle mo<strong>di</strong>fi che al Regolamento<br />
Emittenti Consob volte a completare<br />
il recepimento della <strong>di</strong>rettiva in<br />
tema <strong>di</strong> prospetti, è stato fra l’altro<br />
previsto un limite temporale massimo<br />
per la procedura <strong>di</strong> approvazione dei<br />
prospetti. 9<br />
Resta ancora aperto il tema del<br />
ruolo svolto dalla Consob nell’iter <strong>di</strong><br />
approvazione dei prospetti, che negli<br />
ultimi anni ha rappresentato una delle<br />
cause della sua lunga tempistica. Le<br />
attività poste in essere dalla Consob<br />
continuano infatti ad essere più pervasive<br />
rispetto alle verifi che <strong>di</strong> completezza,<br />
coerenza e comprensibilità delle<br />
informazioni contenute nel prospetto<br />
previste dalla <strong>di</strong>rettiva comunitaria.<br />
Sarebbe opportuno, nell’ottica <strong>di</strong><br />
snellire il processo <strong>di</strong> quotazione delle<br />
imprese, in<strong>di</strong>viduare criteri e modalità<br />
che consentano <strong>di</strong> circoscrivere e garantire<br />
maggiori certezze in merito ai<br />
tempi <strong>di</strong> approvazione dei prospetti<br />
nel rispetto <strong>di</strong> elevati standard qualitativi<br />
<strong>di</strong> protezione degli investitori. Sarebbe<br />
altresì utile che i tempi me<strong>di</strong> <strong>di</strong><br />
approvazione, che rappresentano<br />
un’informazione importante<br />
per gli operatori, fossero resi<br />
noti da parte della Consob, ad<br />
esempio nella propria relazione<br />
annuale.<br />
Fotolia<br />
7. Conclusioni<br />
Nel nostro Paese la funzione<br />
<strong>di</strong> interme<strong>di</strong>azione fi nanziaria<br />
(raccolta del risparmio<br />
dai settori con saldo fi nanziario<br />
positivo – tipicamente le<br />
famiglie – e trasferimento ai<br />
settori con saldo negativo – tipicamente<br />
le imprese) viene<br />
esercitata prevalentemente<br />
dalle banche, mentre è relativamente<br />
scarso il ricorso <strong>di</strong>retto<br />
al mercato da parte delle<br />
imprese sia attraverso strumenti<br />
obbligazionari sia azionari.<br />
Modesto è in particolare<br />
il ruolo della Borsa nel fi nanziamento<br />
delle imprese.<br />
L’industria bancaria, nel<br />
sottolineare con orgoglio il<br />
ruolo decisivo che essa svolge,<br />
e che ha consentito <strong>di</strong> attutire<br />
gli effetti della crisi fi nanziaria<br />
prima ed economica poi (anche<br />
grazie ad un ricco insieme<br />
ECONOMIA-FINANZA 47
<strong>di</strong> iniziative specifi che a favore <strong>di</strong> famiglie<br />
e imprese) evidenzia l’esigenza che<br />
il sistema fi nanziario italiano superi<br />
alcune criticità che lo connotano ormai<br />
da molto tempo, tal che mercato cre<strong>di</strong>tizio<br />
e mercato finanziario in senso<br />
stretto possano assicurare assieme<br />
maggiori possibilità <strong>di</strong> sviluppo delle<br />
imprese e dell’economia.<br />
In estrema sintesi, il mercato fi -<br />
nanziario italiano presenta oggi le<br />
seguenti caratteristiche, in relazione<br />
alle quali sono necessarie azioni <strong>di</strong> policy<br />
volte al superamento <strong>di</strong> alcune fragilità:<br />
– Dimensioni modeste del mercato<br />
azionario italiano: tale mercato è caratterizzato<br />
da <strong>di</strong>mensioni modeste se<br />
rapportato ai principali Paesi europei<br />
(296 società quotate alla fi ne del 2009<br />
contro, ad esempio, le quasi 3.000 del<br />
London Stock Exchange), anche in<br />
considerazione del rilevante ruolo del<br />
canale bancario nelle passività delle<br />
imprese (la somma <strong>di</strong> obbligazioni e<br />
azioni quotate supera appena il 12%<br />
delle passività totali delle imprese,<br />
contro un valore prossimo al 50% per i<br />
prestiti). La quotazione resta comunque<br />
un’opzione rilevante per la crescita<br />
delle imprese, valorizzata anche dalle<br />
banche che, nel processo <strong>di</strong> listing,<br />
svolgono ruoli importanti.<br />
– Diffi coltà strutturali e culturali delle<br />
imprese a quotarsi sui mercati, tenuto<br />
conto fra l’altro, dei limiti <strong>di</strong>mensionali,<br />
della concentrazione della proprietà a<br />
livello familiare e delle resistenze <strong>di</strong> tipo<br />
culturale nei confronti dell’apertura del<br />
capitale a terzi: far crescere il mercato<br />
italiano dei capitali e mettere in campo<br />
iniziative che favoriscano un’inversione<br />
<strong>di</strong> tendenza dal punto <strong>di</strong> vista culturale<br />
ed una crescita complessiva della<br />
<strong>di</strong>mensione del sistema impren<strong>di</strong>toriale<br />
italiano. Al riguardo, un primo passo<br />
potrebbe essere quello <strong>di</strong> ridurre alcune<br />
<strong>di</strong>storsioni nelle scelte <strong>di</strong> fi nanziamento<br />
delle imprese motivate dall’esistenza<br />
<strong>di</strong> un favore fi scale per le forme<br />
<strong>di</strong> indebitamento rispetto al capitale<br />
proprio.<br />
– Elevati costi per la quotazione: favorire<br />
lo sviluppo dei mercati de<strong>di</strong>cati<br />
alle PMI per consentire alle imprese <strong>di</strong><br />
minori <strong>di</strong>mensioni la quotazione a costi<br />
inferiori e con procedure più snelle<br />
facendo tra l’altro ricorso ad iniziative<br />
<strong>di</strong> semplifi cazione del quadro normativo<br />
e procedurale.<br />
48 ECONOMIA-FINANZA<br />
– Carenza <strong>di</strong> investitori istituzionali<br />
domestici sul mercato azionario: introdurre<br />
strumenti che incentivino lo<br />
sviluppo <strong>di</strong> tali investitori nell’ottica <strong>di</strong><br />
colmare il “gap” attualmente esistente<br />
sul nostro mercato rispetto ad altre<br />
piazze europee, ad esempio introducendo<br />
agevolazioni <strong>di</strong> carattere fi scale<br />
per i sottoscrittori <strong>di</strong> quote <strong>di</strong> veicoli<br />
specializzati nell’investimento in società<br />
a ridotta capitalizzazione quotate su<br />
mercati quali l’AIM Italia. In tale ottica,<br />
dovrebbe essere operata altresì una<br />
revisione della <strong>di</strong>sciplina della tassazione<br />
dei fon<strong>di</strong> comuni, che possa rime<strong>di</strong>are<br />
agli squilibri attualmente esistenti<br />
tra i fon<strong>di</strong> <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto italiano e<br />
quelli <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto estero.<br />
– Responsabilità degli interme<strong>di</strong>ari:<br />
intervenire sulla regolamentazione<br />
dell’attività degli interme<strong>di</strong>ari coinvolti<br />
nel processo <strong>di</strong> quotazione, in particolare<br />
sponsor e responsabile del collocamento,<br />
nell’ottica <strong>di</strong> meglio bilanciare il<br />
rapporto tra le attività sulle quali gli<br />
stessi hanno competenze specifi che e<br />
le responsabilità attribuite dalla normativa;<br />
in tal modo si potrebbero ridurre<br />
anche i costi a carico degli emittenti.<br />
– Carenze nei processi <strong>di</strong> approvazione<br />
dei prospetti <strong>di</strong> offerta ed ammissione<br />
a negoziazione: in<strong>di</strong>viduare criteri<br />
e modalità che consentano alla Consob<br />
<strong>di</strong> effettuare le verifi che previste<br />
maggiormente in linea con la normativa<br />
e le prassi europee, garantendo<br />
maggiori certezze sui tempi <strong>di</strong> approvazione<br />
dei prospetti, nel rispetto <strong>di</strong><br />
elevati standard qualitativi <strong>di</strong> protezione<br />
degli investitori.<br />
Su molte delle caratteristiche<br />
menzionate incide signifi cativamente<br />
l’aspetto della scarsa <strong>di</strong>mensione delle<br />
imprese italiane. È questo tema molto<br />
rilevante anche sotto il profi lo macroeconomico,<br />
date le evidenti e provate<br />
correlazioni tra il fattore <strong>di</strong>mensionale<br />
e la propensione alla ricerca, all’innovazione<br />
tecnologica, all’export e, in ultima<br />
istanza, all’aumento della produttività,<br />
aspetto quest’ultimo che l’industria<br />
bancaria considera cruciale per<br />
vincere la vera sfi da che il Paese ha <strong>di</strong><br />
fronte; una maggiore crescita quantitativa<br />
e qualitativa del prodotto interno<br />
lordo.<br />
NOTE<br />
1) Evaluation of the Economic Impact of<br />
the Financial Services Action Plan (FSAP)<br />
CRA International, March 2009; and Study of<br />
the cost of compliance with selected FSAP<br />
measures, Europe Economics, January 2009.<br />
2) Riguardo alla concentrazione della<br />
proprietà, nel periodo 2004-06, il capitale<br />
sociale detenuto in me<strong>di</strong>a dal socio <strong>di</strong> maggioranza<br />
oscillava tra 50% e l’80%.<br />
3) Nel 76% dei casi relativi a società industriali<br />
quotate dal 1985 al 2005, la famiglia <strong>di</strong><br />
riferimento deteneva me<strong>di</strong>amente, al momento<br />
della quotazione, circa il 77% dei <strong>di</strong>ritti<br />
<strong>di</strong> voto (dati Borsa Italiana).<br />
4) Secondo dati <strong>di</strong> Borsa Italiana dello<br />
stesso periodo, a seguito della IPO la famiglia<br />
<strong>di</strong> riferimento ha continuato infatti a detenere<br />
il controllo della società con il 54% dei<br />
<strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> voto dopo tre anni dalla quotazione<br />
e con il 52% dopo <strong>di</strong>eci anni.<br />
5) Quelli in<strong>di</strong>viduati dall’art. 4, comma 1,<br />
punto 14 della <strong>di</strong>rettiva Mifi d n. 2004/39/EC.<br />
6) Alla fi ne del 2008, dopo circa quattro<br />
anni dall’avvio del mercato Expan<strong>di</strong> – il comparto<br />
del mercato <strong>di</strong> Borsa creato per dare<br />
impulso alla quotazione <strong>di</strong> imprese <strong>di</strong> minori<br />
<strong>di</strong>mensioni poi accorpato con l’MTA – risultavano<br />
quotate su detto mercato soltanto<br />
39 società, fra cui due banche (aventi entrambe<br />
una capitalizzazione <strong>di</strong> mercato superiore<br />
a due miliar<strong>di</strong> <strong>di</strong> euro).<br />
7) L’iniziativa denominata “listing SME”<br />
prevede <strong>di</strong>: I) favorire il private placement<br />
attraverso soglie più elevate <strong>di</strong> esenzione<br />
dalla pre<strong>di</strong>sposizione dei prospetti; II) snellimento<br />
dei prospetti stessi, nell’ottica <strong>di</strong> richiedere<br />
requisiti informativi proporzionati<br />
alla <strong>di</strong>mensione d’impresa; III) maggiore fl essibilità<br />
per gli aumenti <strong>di</strong> capitale; un regime<br />
IFRS7 proporzionato per la pubblicazione<br />
delle informazioni fi nanziarie; IV) favorire<br />
l’attività dei liqui<strong>di</strong>ty provider per incrementare<br />
la liqui<strong>di</strong>tà dei titoli sul mercato; V)<br />
creare fon<strong>di</strong> UCITS (Undertakings Collective<br />
Investment Transferable Securities) specializzati<br />
nell’investimento in PMI; VI) creare una<br />
piattaforma <strong>di</strong> mercato per le PMI a livello<br />
europeo.<br />
8) L’attività <strong>di</strong> Borsa si sostanzia, ad e -<br />
sempio, nell’esame del cosiddetto QMAT<br />
(Quotation Management Admission Test) –<br />
vale a <strong>di</strong>re il documento preliminare che<br />
deve essere pre<strong>di</strong>sposto dalla società quotanda<br />
per illustrare fra l’altro il business model<br />
della società stessa – nonché nelle verifi -<br />
che sul sistema <strong>di</strong> controllo <strong>di</strong> gestione e sul<br />
business plan dell’emittente.<br />
9) Rimane tuttavia dubbio se tale termine<br />
debba essere inteso come perentorio (e<br />
quin<strong>di</strong> se il prospetto debba essere comunque<br />
approvato entro i 40 o 70 giorni) ovvero<br />
come or<strong>di</strong>natorio (nel qual caso la Consob<br />
stessa potrebbe approvare il prospetto anche<br />
successivamente).<br />
Si ringrazia l’avvocato Giuseppe Mussari, presidente dell’Associazione <strong>Banca</strong>ria Italiana,<br />
che ha concesso la pubblicazione del testo dell’Au<strong>di</strong>zione tenuta il 12 gennaio 2011 alla VI<br />
Commissione Finanze della Camera dei Deputati.
GIANCARLO GALLI<br />
Scrittore economico-fi nanziario<br />
ed e<strong>di</strong>torialista <strong>di</strong> Avvenire<br />
ACrans-Montana, nelle Alpi<br />
svizzere, tra<strong>di</strong>zionale e secolare<br />
luogo d’incontro degli<br />
gnomi della fi nanza dell’emisfero<br />
capitalista, <strong>di</strong> fronte ai problemi<br />
che attanagliano il mondo, accade<br />
spesso <strong>di</strong> u<strong>di</strong>re una frase, accompagnata<br />
da un interrogativo: «Che avrebbe<br />
fatto André?». Il riferimento è all’ormai<br />
mitico banchiere André Meyer,<br />
leggendario tycoon che qui aveva una<br />
casetta dove, ad agosto, era uso ricevere<br />
la sua “miglior clientela”: dagli Agnelli<br />
ai Rockefeller, da Enrico Cuccia a<br />
François Michelin, da Jacqueline Kennedy<br />
allo Scià <strong>di</strong> Persia. Per poi ripartire,<br />
senza passare dalla Parigi in cui era<br />
nato il 3 settembre 1898, alla volta <strong>di</strong><br />
New York. Al do<strong>di</strong>cesimo piano del<br />
grattacielo <strong>di</strong> Wall Street, sede della<br />
Lazard Frères della quale era il dominus<br />
assoluto, ancora più potente dei<br />
Weill-Lazard, fondatori ed azionisti <strong>di</strong><br />
maggioranza.<br />
André Meyer<br />
banchiere leggendario (e <strong>scorbutico</strong>)<br />
André Meyer, legendary<br />
(and cantankerous) banker<br />
In the world of high finance, it’s not enough to be<br />
unpleasant to be respected, it’s better to be<br />
loathsome. So said A. Meyer. Naturally that’s not<br />
enough to be a great figure: you also need a<br />
specific genius, which he had shown since his<br />
adolescence, when he began with the modest role<br />
of procuring business. Then his capacity and his<br />
infallible intuition made him an appetizing<br />
consultant for many companies. He began to fly<br />
high and demanded becoming a “partner” of the<br />
financial battleship of the Lazards. During the<br />
Second World War he also took on the role of<br />
political me<strong>di</strong>ator and allowed a young Enrico<br />
Cuccia to relay to the American ambassador the<br />
proposals of Italian non-Communist anti-Fascism.<br />
He was also the “muse” who inspired Cuccia to<br />
create Me<strong>di</strong>obanca.<br />
André Benoit Mathieu Meyer (1898-1979) in una foto<br />
che lo ritrae all’apice della sua carriera (da: André<br />
Meyer, il genio della Finanza, Sperling & Kupfer E<strong>di</strong>tori).<br />
André Benoit Mathieu Meyer (1898-1979) in a photograph<br />
showing him at the peak of his career (from:<br />
André Meyer, Il genio della Finanza, Sperling & Kupfer<br />
E<strong>di</strong>tori).<br />
Cerchiamo allora <strong>di</strong> capire chi è<br />
stato e cosa abbia rappresentato André<br />
Meyer, per mezzo secolo autentico<br />
protagonista e regista della fi nanza su<br />
entrambe le sponde dell’Atlantico: Europa<br />
ed Usa.<br />
* * *<br />
Figlio <strong>di</strong> modesti commercianti<br />
ebraici che, da “liberi pensatori”, non<br />
frequentano la sinagoga, il piccolo André,<br />
anziché la Torah s’appassiona ai<br />
listini <strong>di</strong> Borsa. A tre<strong>di</strong>ci anni (siamo<br />
nel 1910), abbandonata la scuola, trova<br />
un posto da fattorino presso un agente<br />
<strong>di</strong> cambio israelita parigino. Auto<strong>di</strong>datta,<br />
apprende inglese, tedesco, italiano.<br />
Avendo compreso che la fi nanza non<br />
Richard Knapp<br />
ha confi ni, ogni mattino prima <strong>di</strong> entrare<br />
negli uffi ci della “Bauer et Fils”, fa il<br />
giro delle redazioni per ritirare non i<br />
giornali ma sottrarre i <strong>di</strong>spacci con le<br />
quotazioni estere. Prende <strong>di</strong> nascosto<br />
ad offrire suggerimenti (retribuiti) ai<br />
clienti della <strong>di</strong>tta. Monsieur Bauer, anziché<br />
in<strong>di</strong>gnarsi, vedendo il fatturato<br />
aumentare lo promuove procacciatore<br />
d’affari.<br />
La Francia entra in guerra. Nel<br />
1917 la patria <strong>di</strong>ssanguata lo chiama<br />
alle armi. È <strong>di</strong> bassa statura, grassoccio,<br />
occhialuto, con un vizio car<strong>di</strong>aco,<br />
ma probabilmente a favorire l’esonero<br />
è qualche relazione privilegiata al Ministero<br />
della Guerra. Detto brutalmente,<br />
“un imboscato”.<br />
Inidoneo alle trincee eppure dotato<br />
sia <strong>di</strong> un’eccezionale capacità lavorativa<br />
(anche venti ore quoti<strong>di</strong>ane), sia <strong>di</strong><br />
una irrefrenabile esuberanza sessuale.<br />
L’enfant pro<strong>di</strong>ge della Bauer provoca<br />
l’attenzione <strong>di</strong> Pierre David-Weill,<br />
coetaneo <strong>di</strong> André. Il rampollo della<br />
<strong>di</strong>nastia Lazard (ebrei boemi riparati in<br />
Francia nel 1792) gli propone un’assunzione<br />
facendo ponti d’oro. Stipen<strong>di</strong>o e<br />
provvigioni. L’astuto André rilancia,<br />
pretendendo <strong>di</strong> venire “associato”. Lo<br />
trattano da folle, da arrogante, da presuntuoso.<br />
Eppure dopo un paio <strong>di</strong> stagioni<br />
ci ripensano. Pare che nell’occasione<br />
André Meyer abbia pronunciato<br />
una delle frasi più taglienti del suo irriverente<br />
repertorio: «Perché essere antipatici<br />
quando, con un minimo <strong>di</strong> sforzo,<br />
si può essere o<strong>di</strong>osi?». Per inciso: è<br />
assai <strong>di</strong>ffuso a Parigi, ancorché inverifi<br />
cabile, il convincimento che il matrimonio<br />
Meyer-Lazard sia stato propiziato<br />
dal Grande Oriente <strong>di</strong> Francia. Di<br />
certo, quello dei Lazard è ambiente<br />
chiuso e particolarissimo. Secondo la<br />
biografa Anne Sabouret, «ebrei, banchieri<br />
<strong>di</strong> sinistra, ra<strong>di</strong>cal-socialisti, patrioti,<br />
anticlericali, visceralmente anticomunisti».<br />
André, sposatosi senza<br />
ECONOMIA-FINANZA 49
amore con Bella Lehman (altra<br />
<strong>di</strong>nastia <strong>di</strong> gnomi), reciterà da<br />
primattore su questo palcoscenico.<br />
Il primo colpo che mette a<br />
segno è da manuale. Nel 1934,<br />
la Citroën in piena crisi pare<br />
destinata al fallimento. È Meyer<br />
ad occuparsi del salvataggio in<br />
extremis: fa rilevare dai Michelin,<br />
esposti per oltre sei milioni<br />
<strong>di</strong> dollari, la società. Quin<strong>di</strong> realizza<br />
la fusione con Peugeot.<br />
Gloria e danaro per tutti!<br />
«Arricchirsi è un imperativo<br />
morale», proclamò sino alla fi ne<br />
dei suoi giorni André Meyer.<br />
Arriva la Seconda Guerra<br />
mon<strong>di</strong>ale. Pierre David-Weill,<br />
comandante <strong>di</strong> un reggimento <strong>di</strong> cavalleria<br />
corazzato, riesce a sottrarsi ai<br />
panzer tedeschi ripiegando nel Mi<strong>di</strong>.<br />
Nessuno peraltro, fra i membri della<br />
grande famiglia Lazard, crede alle persecuzioni<br />
razziali. André la pensa <strong>di</strong>versamente.<br />
Subito dopo l’invasione<br />
hitleriana della Polonia ha cominciato<br />
a trasferire segretamente capitali personali<br />
a New York. Alla vigilia dell’occupazione<br />
<strong>di</strong> Parigi, raggiunge Londra,<br />
stringe rapporti col generale Charles<br />
De Gaulle, ripara in America da dove<br />
<strong>di</strong>rige un circuito <strong>di</strong> sostegno alla Resistenza,<br />
mantenendo un “presi<strong>di</strong>o” nella<br />
neutrale Lisbona. E qui...<br />
Nella primavera del 1942, nonostante<br />
le sorti del confl itto ormai planetario<br />
appaiano ancora favorevoli all’Asse<br />
Berlino-Roma-Tokyo (le nostre truppe<br />
riconquistano Tobruk ed affi ancate<br />
dall’Afrika Korps <strong>di</strong> Rommel marciano<br />
verso il Cairo; le armate tedesche avanzano<br />
verso Stalingrado ed il Caucaso<br />
ricco <strong>di</strong> petrolio; i giapponesi <strong>di</strong>lagano<br />
nel Pacifi co), la Resistenza italiana si<br />
organizza. Il Partito d’Azione clandestino<br />
guidato da Ferruccio Parri, Ugo La<br />
Malfa ed Adolfo Tino, appoggiato dal<br />
dominus della <strong>Banca</strong> Commerciale Raffaele<br />
Mattioli, decide <strong>di</strong> prendere contatto<br />
con gli angloamericani. Per la<br />
“missione” viene scelto un funzionario<br />
della Comit, aggregato alla “sezione<br />
estera” che gode <strong>di</strong> passaporto <strong>di</strong>plomatico:<br />
Enrico Cuccia.<br />
Strabilianti gli esiti. Cuccia, poco<br />
più che trentenne, sposato con Idea,<br />
fi glia pre<strong>di</strong>letta <strong>di</strong> Alberto Beneduce,<br />
presidente dell’Iri, al tempo stesso 33<br />
massonico ed intimo <strong>di</strong> Mussolini, già<br />
50 ECONOMIA-FINANZA<br />
Il banchiere André Meyer fu “padrino” <strong>di</strong> due eroi del capitalismo: Margaret<br />
Thatcher e Ronald Reagan.<br />
The financier André Meyer was the “godfather” of two of capitalism’s<br />
heroes: Margaret Thatcher and Ronald Reagan.<br />
s’era <strong>di</strong>stinto in operazioni ad alto rischio,<br />
come la scoperta del traffi co <strong>di</strong><br />
valute in Africa Orientale che provocò<br />
il siluramento <strong>di</strong> Rodolfo Graziani, Viceré<br />
dell’Impero, sostituito dal Duca<br />
d’Aosta. Raggiunta la capitale lusitana<br />
in un avventuroso viaggio attraverso la<br />
Francia <strong>di</strong> Vichy e la Spagna, Cuccia<br />
trova nel fi nanziere André Meyer la<br />
persona che lo introduce presso l’ambasciatore<br />
americano George Kennan<br />
cui consegna il “messaggio” dell’antifascismo<br />
italiano non comunista. Si conoscevano<br />
Enrico ed André? Sulla questione<br />
s’è a lungo <strong>di</strong>battuto. Posso in<br />
questa sede riferire una confidenza<br />
fattami dallo stesso Cuccia, dopo che<br />
ne avevo scritto la biografi a (non autorizzata):<br />
«Meyer l’avevo incontrato a<br />
Parigi, nel ’38». Non una parola in più.<br />
Fra Cuccia e Meyer è sintonia totale.<br />
Sbocciata a Parigi, cementata a<br />
Lisbona. Le vicende belliche anziché<br />
spezzarla, la rafforzano. Liberata Roma<br />
mentre al Nord ancora si combatte,<br />
nell’ottobre del ’44 Cuccia, nessuno<br />
capisce con quali credenziali, è aggregato<br />
alla delegazione del governo <strong>di</strong><br />
Ivanoe Bonomi (succeduto a Badoglio)<br />
che deve <strong>di</strong>scutere con gli americani le<br />
modalità della Ricostruzione.<br />
I “nostri”, per <strong>di</strong>rla con Raffaele<br />
Mattioli partecipe della missione, a<br />
Washington e New York vengono «trattati<br />
quali cani in chiesa». Eccetto Cuccia.<br />
Fattosi lupo solitario, si rintana<br />
presso Meyer: all’Hotel Carlyle, al 120<br />
<strong>di</strong> Broadway, sede della Lazard Usa. Da<br />
quella postazione privilegiata tesse<br />
relazioni (dai Rockefeller ai Kennedy,<br />
dal sindaco Fiorello La Guar<strong>di</strong>a all’arci-<br />
vescovo Joseph Spellman),<br />
poiché Meyer dopo averlo investito<br />
del titolo <strong>di</strong> “proconsole<br />
per l’Italia” della grande fi -<br />
nanza internazionale, gli ispira<br />
la crea zione <strong>di</strong> Me<strong>di</strong>obanca.<br />
L’istituto, nonostante le <strong>di</strong>ffi -<br />
denze <strong>di</strong> Mattioli, verrà alla luce<br />
in via Filodrammatici a Milano<br />
nell’aprile 1946. Al battesimo<br />
i soci sono le tre banche<br />
d’interesse nazionale (Commerciale,<br />
Cre<strong>di</strong>to Italiano, <strong>Banca</strong><br />
<strong>di</strong> Roma). Dopo un decennio<br />
l’azionariato s’aprirà ai privati:<br />
Agnelli, Pirelli, Lazard, Lehman,<br />
Sofi na (fi nanziaria belga),<br />
Berliner Handel. Con appena il<br />
3,75 per cento del capitale, regista<br />
Cuccia, saranno gli artefi ci del<br />
“Miracolo Me<strong>di</strong>obanca”, che non si sarebbe<br />
però realizzato senza il sostegno<br />
<strong>di</strong> Meyer.<br />
Sarà André (1973) a propiziare<br />
l’operazione Euralux. La hol<strong>di</strong>ng lussemburghese,<br />
costituita da Meyer e<br />
dall’attuale presidente onorario delle<br />
Assicurazioni Generali Antoine Bernheim,<br />
che acquisì dalla Monte<strong>di</strong>son <strong>di</strong><br />
Eugenio Cefi s un robusto pacchetto <strong>di</strong><br />
azioni della compagnia triestina. Quei<br />
titoli, sommatisi ad altri custo<strong>di</strong>ti da<br />
Euralux per conto <strong>di</strong> un mai identifi cato<br />
con certezza grande impren<strong>di</strong>tore italiano,<br />
confl uirono infi ne in Me<strong>di</strong>obanca,<br />
facendone la “padrona” delle Generali.<br />
Tre anni più tar<strong>di</strong> Meyer è il tramite<br />
fra Cuccia e la famiglia Agnelli in<br />
gravissime <strong>di</strong>ffi coltà fi nanziarie. In Fiat<br />
entrano i capitali libici della Lafi co.<br />
Va da sé che per André Meyer<br />
l’Italia costituisce solo una “provincia”<br />
dell’impero fi nanziario della Lazard,<br />
sebbene da Me<strong>di</strong>obanca siano transitate<br />
anche operazioni <strong>di</strong> respiro sovrannazionale.<br />
Ad esempio il portage delle<br />
azioni della Hartford assicurazioni da<br />
parte dell’americana ITT gestito da<br />
Felix Rohatyn della Lazard (ribattezzato<br />
“Il gatto Felix”), delfi no <strong>di</strong> Meyer. La<br />
vicenda ITT mise in <strong>di</strong>ffi coltà lo stesso<br />
presidente Richard Nixon per un fi nanziamento<br />
al Partito Repubblicano, dopo<br />
che la stessa ITT era già stata in<strong>di</strong>ziata<br />
per avere avuto un ruolo nel golpe<br />
cileno contro Salvador Allende.<br />
Fu Meyer a, letteralmente, “inventare”<br />
le Conglomerate, enormi “contenitori”<br />
<strong>di</strong> aziende comprate-vendute <strong>di</strong><br />
cui l’ITT, all’origine società telefonica,
fu un esempio negli anni ’60-70. Fra le<br />
operazioni più geniali che fecero <strong>di</strong><br />
Meyer il mito <strong>di</strong> Wall Street, l’acquisto<br />
dell’Avis (numero uno nel noleggio auto)<br />
per sette milioni <strong>di</strong> dollari e rivenduta<br />
per venti. La gigantesca speculazione<br />
sulla texana Matador, proprietaria<br />
<strong>di</strong> sterminati ranch. Attraverso la<br />
lottizzazione, guadagni milionari.<br />
Di André Meyer, famoso per l’avi<strong>di</strong>tà,<br />
esiste tuttavia un coté umano poco<br />
esplorato, e per il quale il suo nome<br />
è ricordato come “inimitabile ed insostituibile”<br />
ai piani alti della politica e<br />
della fi nanza. Pur trasferitosi negli States,<br />
l’Europa restò sempre nel suo cuore:<br />
consulente personale del presidente<br />
francese Georges Pompidou, <strong>di</strong> Jean<br />
Monnet alla nascente Comunità europea,<br />
ed intimo <strong>di</strong> Jacqueline Kennedy,<br />
della quale era segretamente innamorato.<br />
Nell’autunno del ’68, a cinque anni<br />
dall’assassinio <strong>di</strong> John Kennedy e poco<br />
dopo l’uccisione <strong>di</strong> Robert, Jacqueline<br />
comunicò a Meyer, “tesoriere <strong>di</strong> famiglia”,<br />
la decisione <strong>di</strong> sposare Aristotele<br />
Onassis. La reazione fu violenta, scomposta.<br />
Fallito il tentativo <strong>di</strong> convincere<br />
Jackie a non con<strong>di</strong>videre il talamo con<br />
un miliardario giu<strong>di</strong>cato very rough,<br />
rozzo e privo <strong>di</strong> stan<strong>di</strong>ng, stese <strong>di</strong> suo<br />
pugno un contratto matrimoniale per<br />
garantire la pupilla. Oltre alle penali<br />
(cento milioni <strong>di</strong> dollari) in caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>vorzio,<br />
una serie <strong>di</strong> clausole a <strong>di</strong>sciplinare<br />
la vita intima. Col <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> Jackie<br />
a vivere lontana dal marito per lunghi<br />
perio<strong>di</strong>. Onassis, accettò, rivelandosi<br />
gran gentiluomo: alla morte (1975) lasciò<br />
alla donna un’ere<strong>di</strong>tà favolosa.<br />
Recuperando la fi gura del fi nanziere,<br />
è opinione <strong>di</strong>ffusa che alle gesta<br />
<strong>di</strong> Meyer, molto infl uente negli ambienti<br />
della stampa economico-fi nanziaria,<br />
vada attribuito il merito <strong>di</strong> avere nel<br />
dopoguerra “risvegliato” Wall Street<br />
dando l’avvio ad un ritorno dell’azionariato<br />
<strong>di</strong> massa, ancora sotto shock dopo<br />
la Grande Depressione degli anni<br />
Trenta. Due cifre. L’in<strong>di</strong>ce Dow Jones<br />
nel 1946 era <strong>di</strong> poco sopra “Quota 100”.<br />
Alla sua morte, s’avvicinava a “Quota<br />
1.000”. Successivamente, l’ulteriore<br />
grande balzo in avanti, sino a “Quota<br />
11-12 mila”. Pressappoco l’attuale, fermo<br />
da quasi un lustro.<br />
Nella Grande Mela che lo volle<br />
citta<strong>di</strong>no onorario e benemerito, ancora<br />
si ricorda la sobrietà del banchiere<br />
che <strong>di</strong>sdegnava i ristoranti alla moda,<br />
costringendo anche convitati illustri<br />
ad accontentarsi in più <strong>di</strong> un’occasione<br />
<strong>di</strong> un hamburger nei McDonald’s. Ne<br />
fece le spese pure Gianni Agnelli che<br />
ebbe a raccontarmi in questo modo la,<br />
a <strong>di</strong>r poco, bizzarra avventura. In sintesi:<br />
con gli stabilimenti occupati e la<br />
contestazione <strong>di</strong>lagante (siamo a metà<br />
degli anni Settanta), l’Avvocato è tentato<br />
<strong>di</strong> “gettare la spugna” (parole sue).<br />
Ugo La Malfa gli ha proposto <strong>di</strong> accettare<br />
la carica <strong>di</strong> ambasciatore in Usa.<br />
Cuccia, in<strong>di</strong>gnato, pronuncia la<br />
sferzante frase: «Lei è stato un uffi ciale,<br />
e gli uffi ciali muoiono in trincea ma non<br />
s’arrendono». Sbollita l’ira, suggerisce:<br />
«Vada da Meyer!». L’Avvocato, che ha<br />
per Cuccia stima incon<strong>di</strong>zionata, obbe<strong>di</strong>sce.<br />
Racconta: «In un postaccio <strong>di</strong>vertentissimo,<br />
dove si mangiava solo carne,<br />
tritata o ai ferri, insalata, birra e<br />
Coca Cola, Meyer mi <strong>di</strong>sse <strong>di</strong> star tranquillo.<br />
In politica e fi nanza tutto era<br />
sotto controllo...».<br />
Infatti Meyer propiziò l’ingresso<br />
dei libici in Fiat. Quanto alla politica,<br />
anticipò cambiamenti epocali.<br />
Aggre<strong>di</strong>to da un carcinoma prostatico,<br />
Meyer spese le ultime stagioni<br />
terrene facendo la spola fra Londra e<br />
l’America, “padrino” <strong>di</strong> due eroi del<br />
capitalismo: “Maggie” Thatcher e Ronald<br />
Reagan. La signora con la falce gli<br />
impe<strong>di</strong>rà <strong>di</strong> godere pienamente il trionfo<br />
della “Lady <strong>di</strong> ferro” e dell’ex <strong>di</strong>vo <strong>di</strong><br />
Hollywood entrato trionfalmente alla<br />
Casa Bianca. La stessa Lazard, rimasta<br />
orfana e tornata sotto il controllo totale<br />
dei David-Weill attraverso Michel,<br />
sarà chiamata a durissime prove con la<br />
conquista dell’Eliseo da parte del socialista<br />
François Mitterrand. Certo la<br />
Lazard <strong>di</strong> boulevard Haussmann andrà<br />
incontro ad un lento declino ma, sotto<br />
la pressione dell’establishment statunitense,<br />
Mitterrand la esclude dal piano<br />
<strong>di</strong> nazionalizzazione. È l’ultimo, postumo,<br />
“miracolo” <strong>di</strong> André Meyer.<br />
Morto il 9 settembre 1979, accu<strong>di</strong>to<br />
sino all’ultimo da Bella Lehman <strong>di</strong>mentica<br />
delle passate infedeltà, ha lasciato<br />
un testamento olografo in cui<br />
chiede <strong>di</strong> poter tornare in Francia, evitando<br />
cerimonie, <strong>di</strong>scorsi. Si sussurra<br />
abbia scritto in un toccante ad<strong>di</strong>o: «Sia<br />
rispettato quel silenzio che m’ha accompagnato<br />
dalla nascita alla morte».<br />
Verità o leggenda, comunque è la più<br />
alta espressione del pensiero <strong>di</strong> un<br />
adepto della confraternita dei sacerdoti<br />
del <strong>di</strong>o danaro.<br />
e prezioso consigliere dei Kennedy oltre che amico, confidente e cavaliere <strong>di</strong> Jacqueline.<br />
Endowed with an uncanny talent for financial success, André Meyer was also the Kennedy “ family treasurer”<br />
and valued advisor, as well as friend, confidant and escort to Jacqueline.<br />
Getty Images Dotato <strong>di</strong> uno spaventoso talento per il successo finanziario, André Meyer fu, tra l’altro, “tesoriere <strong>di</strong> famiglia”<br />
ECONOMIA-FINANZA 51
La Cina e i Fon<strong>di</strong> sovrani:<br />
la crescita<br />
<strong>di</strong> una potenza geo-economica<br />
ALBERTO QUADRIO CURZIO<br />
Presidente della Classe <strong>di</strong> Sc.m.s.f.,<br />
Accademia dei Lincei<br />
Presidente Centro <strong>di</strong> Ricerche in Analisi<br />
Economica Cranec dell’Università Cattolica<br />
VALERIA MICELI<br />
Ricercatore e Membro del Comitato Scientifi co del<br />
Centro <strong>di</strong> Ricerche in Analisi Economica Cranec,<br />
Università Cattolica; Visiting scholar alla University<br />
of Cambridge, UK.<br />
Con un Pil che sfiora quota<br />
5.750 miliar<strong>di</strong> <strong>di</strong> dollari correnti<br />
secondo le previsioni<br />
del Fondo Monetario per il<br />
2010 e che ha dunque superato persino<br />
l’economia giapponese così piazzandosi<br />
come seconda economia mon<strong>di</strong>ale,<br />
che continua a crescere a ragguardevoli<br />
tassi che non sono mai scesi negli<br />
ultimi anni sotto il 9% neanche in conseguenza<br />
della crisi economica globale,<br />
con una bilancia delle partite correnti<br />
cronicamente in avanzo prevista<br />
per il 2010 (sempre secondo le stime<br />
del FMI) a 270 miliar<strong>di</strong> <strong>di</strong> dollari ovvero<br />
il 4,7% del Pil, con un ammontare <strong>di</strong><br />
riserve valutarie che a giugno 2010<br />
sfi orava quota 2.500 miliar<strong>di</strong> <strong>di</strong> dollari,<br />
infi ne, dato più scontato, ma non per<br />
questo meno rilevante, con una popolazione<br />
<strong>di</strong> più <strong>di</strong> 1,3 miliar<strong>di</strong> <strong>di</strong> persone<br />
che rappresenta un bacino <strong>di</strong> manodopera<br />
ed un potenziale mercato <strong>di</strong> pressoché<br />
infi nite <strong>di</strong>mensioni, la Cina è oggi<br />
la potenza geo-economica emergente<br />
che lambisce da vicino il primato americano.<br />
52 ECONOMIA-FINANZA<br />
Per questo motivo, la nascita dei<br />
Fon<strong>di</strong> sovrani (o Fos) cinesi ha rappresentato<br />
un fatto nuovo in quanto gli<br />
stessi, più che per ogni altro Paese<br />
proprietario <strong>di</strong> Fos, si collocano al crocevia<br />
tra economia, fi nanza e geo-politica.<br />
I Fon<strong>di</strong> sovrani, infatti, oltre ad<br />
essere gran<strong>di</strong> attori della fi nanza internazionale,<br />
possono trasformarsi in<br />
gran<strong>di</strong> attori della geo-economia mon<strong>di</strong>ale<br />
se posseduti da potenze globali.<br />
Ed è proprio questo il caso cinese, come<br />
vedremo più approfon<strong>di</strong>tamente<br />
nel seguito <strong>di</strong> questo articolo, non prima<br />
però <strong>di</strong> avere fornito le principali<br />
coor<strong>di</strong>nate relative al fenomeno dei<br />
Fon<strong>di</strong> sovrani a livello globale.<br />
La situazione mon<strong>di</strong>ale<br />
dei Fon<strong>di</strong> Sovrani<br />
Presenteremo brevemente in questa<br />
sezione alcuni concetti chiave necessari<br />
per capire cosa sono i Fon<strong>di</strong><br />
Sovrani, quali Paesi li possiedono e che<br />
strategie <strong>di</strong> investimento seguono nei<br />
mercati fi nanziari. Per ulteriori approfon<strong>di</strong>menti<br />
riman<strong>di</strong>amo il lettore ai<br />
nostri più estesi lavori in materia (in<br />
particolare ai volumi I Fon<strong>di</strong> Sovrani <strong>di</strong><br />
Alberto Quadrio Curzio e Valeria Miceli<br />
pubblicato dal Mulino nel 2009 e Sovereign<br />
Wealth Funds. A complete guide<br />
to state-owned investment funds pubblicato<br />
nel 2010 da Harriman House nel<br />
Regno Unito). Successivamente tratteremo<br />
dei fon<strong>di</strong> sovrani cinesi evidenziando<br />
la rilevanza non solo economica,<br />
ma anche geo-politica <strong>di</strong> tali attori.<br />
I Fos cinesi infatti arrivano ad un totale<br />
<strong>di</strong> attività gestite che supera i 1.000<br />
miliar<strong>di</strong> <strong>di</strong> dollari.<br />
I Fos sono fon<strong>di</strong> <strong>di</strong> investimento<br />
<strong>di</strong> proprietà statale che gestiscono<br />
portafogli <strong>di</strong> attività finanziarie, in<br />
parte denominate in valuta estera,<br />
derivanti dalla ven<strong>di</strong>ta del petrolio e<br />
altre materie prime (Fos commo<strong>di</strong>ty) o<br />
da surplus valutari della bilancia dei<br />
pagamenti (Fos non-commo<strong>di</strong>ty). Si<br />
tratta <strong>di</strong> un universo molto variegato<br />
in cui si delineano <strong>di</strong>verse tipologie <strong>di</strong><br />
Fos che si <strong>di</strong>fferenziano per fi nalità,<br />
strategie, operatività sui mercati fi -<br />
nanziari, strutture legali, livelli <strong>di</strong> trasparenza.<br />
È possibile identifi care un totale<br />
<strong>di</strong> 53 Fos per un attivo complessivo<br />
che, a fi ne 2009, oscilla tra i 3.386 miliar<strong>di</strong><br />
<strong>di</strong> dollari e i 4.042 miliar<strong>di</strong> <strong>di</strong><br />
dollari a seconda delle stime più o meno<br />
prudenziali che si adottano per i<br />
fon<strong>di</strong> più opachi (esistono infatti Fos<br />
che non rendono pubblico neanche<br />
l’ammontare totale del loro attivo).<br />
Di seguito si fornisce la lista dei<br />
principali <strong>di</strong>eci Fos aggiornata a fi ne<br />
2009 con l’in<strong>di</strong>cazione del Paese <strong>di</strong><br />
appartenenza, dell’attivo totale gestito<br />
(<strong>di</strong> cui si forniscono gli estremi del<br />
range <strong>di</strong> stime esistenti), dell’anno <strong>di</strong><br />
creazione nonché della fonte della sua<br />
ricchezza se <strong>di</strong> tipo commo<strong>di</strong>ty o noncommo<strong>di</strong>ty.<br />
Come si evince dalla tabella 1, i<br />
Paesi ai quali i Fos appartengono sono<br />
principalmente emergenti e la maggior<br />
parte <strong>di</strong> essi è <strong>di</strong> proprietà <strong>di</strong> governi<br />
che possono considerarsi autoritari<br />
o semi-autoritari. Tra i primi<br />
<strong>di</strong>eci Fos solo quello norvegese appartiene<br />
ad una democrazia <strong>di</strong> tipo occidentale.
Tab. 1)<br />
I PRINCIPALI FONDI SOVRANI A FINE 2009<br />
(per alcuni fon<strong>di</strong> in<strong>di</strong>cati con asterisco che non pubblicano rapporti con cadenza annuale le stime risalgono a inizio 2009)<br />
Paese Nome Fondo<br />
EAU Abu Dhabi Investment Authority (ADIA)*<br />
Norvegia Norwegian Government Pension Fund Global (GPFG)<br />
I Fon<strong>di</strong> sovrani cinesi<br />
Nella lista <strong>di</strong> tabella 1 è evidente<br />
il ruolo notevole della Cina che, con i<br />
suoi quattro Fos per un ammontare<br />
totale <strong>di</strong> attivo che supera i mille miliar<strong>di</strong><br />
<strong>di</strong> dollari a fi ne 2009 (oscilla a<br />
seconda delle stime tra 1.007 e 1.086<br />
miliar<strong>di</strong>), è uno degli attori dominanti.<br />
Anche solo considerando il China Investment<br />
Corporation o Cic, con la<br />
sua dotazione <strong>di</strong> attivo <strong>di</strong> 332 miliar<strong>di</strong><br />
<strong>di</strong> dollari, esso rappresenta il quarto<br />
fondo per totale attivi dopo quello <strong>di</strong><br />
Abu Dhabi (le cui <strong>di</strong>mensioni non sono<br />
certe vista l’opacità che lo caratterizza),<br />
quello norvegese e dopo i fon<strong>di</strong><br />
dell’Arabia Sau<strong>di</strong>ta che però <strong>di</strong>ffi cilmente<br />
possono configurarsi come<br />
unico fondo sovrano. Inoltre il Cic è il<br />
primo Fos non-commo<strong>di</strong>ty per <strong>di</strong>mensione<br />
del suo attivo.<br />
Il Fos cinese per defi nizione è il<br />
Cic che è riconosciuto come tale anche<br />
dallo stesso governo cinese. Tuttavia la<br />
Cina può contare anche su una serie <strong>di</strong><br />
altri veicoli <strong>di</strong> investimento assimilabili<br />
a Fos per l’operatività sui mercati fi -<br />
nanziari, anche se non defi niti uffi cialmente<br />
tali dal Governo.<br />
Possibili fattori <strong>di</strong> rischio<br />
Il caso cinese è particolarmente<br />
interessante non solo per le impressionanti<br />
<strong>di</strong>mensioni fi nanziarie dei suoi<br />
veicoli <strong>di</strong> investimento statali, ma anche,<br />
e forse soprattutto, per lo status <strong>di</strong><br />
grande potenza emergente che la Cina<br />
riveste oggi nello scacchiere globale.<br />
Proprio questa considerazione accompagnata<br />
da un’iniziale opacità del fondo<br />
cinese aveva contribuito a suscitare<br />
notevoli preoccupazioni presso i governi<br />
dei Paesi occidentali ed in particolare<br />
presso gli Usa. Nei confronti dei<br />
fon<strong>di</strong> sovrani cinesi si erano palesate<br />
varie riserve. Si temeva innanzitutto<br />
per la sicurezza nazionale nei settori<br />
considerati sensibili, ritenendo che il<br />
Cic fosse animato più che da fi nalità<br />
commerciali, da fi nalità geopolitiche,<br />
mirando ad acquisire partecipazioni <strong>di</strong><br />
controllo/maggioranza in settori strategici<br />
quali trasporti, infrastrutture,<br />
China and Sovereign Wealth Funds:<br />
the growth of a<br />
geo-economic power<br />
Sovereign Wealth Funds (SWF) are state-owned<br />
investment funds that deal with financial activity<br />
portfolios. There are many <strong>di</strong>fferent types of SWF<br />
with various aims, strategies, legal frameworks, and<br />
levels of transparency. Their particular nature<br />
makes them a crossroads of economy, finance and<br />
geopolitics, giving their role an international<br />
breadth. Placed on the market in 2007, Chinese<br />
Investment Corporation funds are of notable<br />
interest. Their declared goals include maximizing<br />
long-term returns on investments with a balanced<br />
portfolio of foreign titles and recapitalising state<br />
banking institutions, thereby contributing to<br />
reforming the national financial system.<br />
Attivo (miliar<strong>di</strong> USD) Anno <strong>di</strong> creazione Tipologia<br />
282 627 1976 Commo<strong>di</strong>ty<br />
432 432 1990 Commo<strong>di</strong>ty<br />
Arabia Sau<strong>di</strong>ta Various funds within Sau<strong>di</strong> Arabian Monetary Agency (SAMA) 365 415<br />
- Commo<strong>di</strong>ty<br />
Cina China Investment Corporation (CIC) 332 332<br />
2007 Non-commo<strong>di</strong>ty<br />
Cina SAFE Investment Company 300 347<br />
1997 Non-commo<strong>di</strong>ty<br />
Cina - HK Hong Kong Monetary Authority - Investment Portfolio 228 260<br />
1998 Non-commo<strong>di</strong>ty<br />
Singapore Government Investment Corporation (GIC)* 180 248<br />
1981 Non-commo<strong>di</strong>ty<br />
Kuwait Kuwait Investment Authority (KIA)*<br />
169 228 1953<br />
Commo<strong>di</strong>ty<br />
Cina National Social Security Fund (NSSF) 147 147<br />
2000 Non-commo<strong>di</strong>ty<br />
Singapore Temasek Hol<strong>di</strong>ngs 133 133<br />
1974 Non-commo<strong>di</strong>ty<br />
Fonte: Quadrio Curzio, Miceli, 2010; Sovereign Wealth Fund Institute, accesso settembre 2010; Rapporti dei Fon<strong>di</strong> Sovrani ove esistenti (Norwegian Government Pension<br />
Fund, China Investment Corporation, National Social Security Fund [NSSF], Temasek Hol<strong>di</strong>ngs).<br />
telecomunicazioni, energia, <strong>di</strong>fesa,<br />
high-tech.<br />
In secondo luogo, si paventavano<br />
pratiche quasi-monopolistiche sui<br />
mercati in due <strong>di</strong>rezioni. Da un lato, si<br />
temeva che il Cic puntasse ad incrementare<br />
le quote <strong>di</strong> mercato globale <strong>di</strong><br />
campioni nazionali cinesi a scapito <strong>di</strong><br />
aziende <strong>di</strong> altri Paesi attraverso acquisizioni<br />
mirate o che tentasse <strong>di</strong> bloccare<br />
indesiderate fusioni/acquisizioni tra<br />
competitors per sostenere i propri campioni<br />
nazionali. Da un altro lato, si temeva<br />
che il Cic potesse garantire vantaggi<br />
competitivi nell’accesso al proprio<br />
mercato alle aziende partecipate a<br />
scapito <strong>di</strong> aziende concorrenti ma non<br />
partecipate.<br />
Senza contare le preoccupazioni<br />
<strong>di</strong> tipo geo-politico determinate dallo<br />
status della Cina <strong>di</strong> grande cre<strong>di</strong>tore<br />
degli Usa. La debolezza fi nanziaria del<br />
debitore può infatti <strong>di</strong>ventare, in alcuni<br />
casi, vulnerabilità strategica e politica<br />
del suo soft power. Il potere statunitense<br />
si riduce nei confronti degli altri<br />
Paesi nella misura in cui questi si approvvigionano<br />
<strong>di</strong> risorse fi nanziarie<br />
dalla Cina (o da altri Paesi detentori <strong>di</strong><br />
Fos). E anche le scelte Usa, per esempio<br />
nei confronti <strong>di</strong> Taiwan, potrebbero<br />
essere con<strong>di</strong>zionate dai rapporti <strong>di</strong><br />
forza fi nanziari. Lo stesso problema si<br />
pone per le istituzioni fi nanziarie sovrannazionali<br />
le cui stabilità e cre<strong>di</strong>bilità<br />
potrebbero essere vulnerate.<br />
ECONOMIA-FINANZA 53
La risposta<br />
della comunità internazionale:<br />
i Principi <strong>di</strong> Santiago del Fmi<br />
In risposta a queste preoccupazioni<br />
riguardanti non solo i Fos cinesi,<br />
ma quelli <strong>di</strong> tutti i Paesi non occidentali,<br />
preoccupazioni peraltro allo stato<br />
attuale non supportate da dati empirici,<br />
il Fmi ha istituito, nell’aprile 2008, un<br />
gruppo <strong>di</strong> lavoro internazionale (IWG)<br />
<strong>di</strong> cui fanno parte i rappresentanti <strong>di</strong><br />
26 governi dotati <strong>di</strong> Fos (tra cui la Cina),<br />
dei Paesi riceventi e <strong>di</strong> alcune istituzioni<br />
internazionali. Nell’ottobre 2008,<br />
l’IWG ha pubblicato 24 principi guida<br />
(Generally Accepted Principles and Practices,<br />
Gapp) detti anche Principi <strong>di</strong><br />
Santiago, dal nome della capitale cilena<br />
dove lo IWG li ha approvati, ai quali i<br />
Fos dovrebbero attenersi. Poiché ai<br />
principi citati si aderisce volontariamente,<br />
ci vorrà del tempo per valutarne<br />
l’effi cacia.<br />
Dopo avere delineato lo sfondo <strong>di</strong><br />
riferimento, ci apprestiamo a descrivere<br />
la storia del principale fondo sovrano<br />
cinese, China Investment Corporation<br />
e a fornire alcune informazioni<br />
sugli altri Fos cinesi (cfr. anche l’articolo<br />
pubblicato sul n. 50 <strong>di</strong> Aspenia<br />
dell’ottobre 2010 degli stessi Autori dal<br />
titolo “I Fon<strong>di</strong> Sovrani del Paese <strong>di</strong><br />
Mezzo”).<br />
Genesi del<br />
China Investment Corporation<br />
La creazione del Cic è il risultato<br />
<strong>di</strong> un <strong>di</strong>battito andato avanti per circa<br />
due anni in Cina e riguardante l’utilizzo<br />
delle enormi e crescenti riserve valutarie<br />
accumulate nell’ultimo decennio ad<br />
un tasso <strong>di</strong> crescita mensile oscillante<br />
tra il 2% e il 4%. Secondo la <strong>Banca</strong> Centrale<br />
cinese a fi ne 2009 le riserve valutarie<br />
ammontavano a 2.399 miliar<strong>di</strong> <strong>di</strong><br />
dollari e a fi ne giugno 2010 a 2.454 miliar<strong>di</strong>.<br />
L’accumulo <strong>di</strong> tali riserve è stato<br />
reso possibile soprattutto grazie ai<br />
surplus <strong>di</strong> bilancia commerciale verifi -<br />
catisi già dalla fi ne degli anni ’90. La<br />
Cina ha sempre investito gran parte<br />
delle sue riserve in titoli del debito<br />
pubblico americano caratterizzati da<br />
bassi rischi, ma anche da bassi ren<strong>di</strong>menti.<br />
È stato stimato che il loro ren<strong>di</strong>mento<br />
tra il 2001 e il 2007 si attestasse<br />
tra il 3% e il 6% (Federal Reserve, 2008),<br />
un ritorno modesto per un’economia<br />
che cresce al 10% me<strong>di</strong>o annuo e che<br />
garantisce agli investimenti esteri in<br />
54 ECONOMIA-FINANZA<br />
entrata un ren<strong>di</strong>mento che la <strong>Banca</strong><br />
Mon<strong>di</strong>ale ha stimato pari al 22% nel<br />
2005. Questo gap rappresenta per la<br />
Cina l’elevato costo opportunità <strong>di</strong> tenere<br />
enormi riserve <strong>di</strong> valuta e <strong>di</strong> investirle<br />
in titoli del Tesoro americano.<br />
L’obiettivo della Cina <strong>di</strong> tenere il renmimbi<br />
agganciato al dollaro aveva cioè<br />
determinato un meccanismo monetario-valutario<br />
molto costoso sia dal punto<br />
<strong>di</strong> vista economico-fi nanziario sia<br />
politico. La polemica tra ministero delle<br />
Finanze e <strong>Banca</strong> Centrale si era inasprita<br />
proprio intorno all’incapacità <strong>di</strong><br />
utilizzare meglio la ricchezza valutaria<br />
del Paese. Inoltre il possibile deprezzamento<br />
del dollaro comporta la svalutazione<br />
della ricchezza valutaria cinese e<br />
poiché dal 2005, a parte la parentesi<br />
della crisi, il renmimbi ha iniziato gradualmente<br />
ad apprezzarsi, il rischio <strong>di</strong><br />
vedere la propria ricchezza perdere<br />
drasticamente valore è oggi molto concreto.<br />
Tra le molte ipotesi elaborate per<br />
in<strong>di</strong>viduare un migliore utilizzo delle<br />
riserve valutarie cinesi il Governo ha<br />
deciso per un Fos, annunciato nel marzo<br />
2007, con l’obiettivo <strong>di</strong> investire la<br />
valuta in eccedenza <strong>di</strong>rettamente all’estero.<br />
Nel settembre 2007, quando il Cic<br />
è stato creato, il ministro delle Finanze<br />
ha emesso 200 miliar<strong>di</strong> <strong>di</strong> debito in<br />
buoni del tesoro cinese (con date <strong>di</strong><br />
scadenze tra <strong>di</strong>eci e quin<strong>di</strong>ci anni e<br />
tassi <strong>di</strong> interesse al 4,5%) che ha conferito<br />
in dotazione al Cic e che quest’ultimo<br />
ha utilizzato per acquistare valuta<br />
dalla <strong>Banca</strong> Centrale.<br />
Il Cic è interamente posseduto<br />
dal Governo cinese e riporta <strong>di</strong>rettamente<br />
al Consiglio <strong>di</strong> Stato, il maggior<br />
organo esecutivo ed amministrativo<br />
del Paese, e al premier. Questa soluzione<br />
sembra essere stata ideata per<br />
risolvere il confl itto determinatosi tra<br />
la <strong>Banca</strong> Centrale e il ministero delle<br />
Finanze a proposito dell’autorità che<br />
dovesse avere il mandato <strong>di</strong> gestire il<br />
nuovo fondo. Tuttavia, la composizione<br />
del comitato <strong>di</strong>rettivo e <strong>di</strong> quello <strong>di</strong><br />
gestione lasciano intendere che il Cic<br />
sia un’emanazione più del ministero<br />
delle Finanze che <strong>di</strong> altri enti. Il presidente<br />
è Lou Jiwei, ex ministro delle<br />
fi nanze cinese ed ex vice-segretario<br />
generale del Consiglio <strong>di</strong> Stato, personalità<br />
<strong>di</strong> alto profi lo. Il comitato <strong>di</strong>rettivo<br />
costituito da un<strong>di</strong>ci membri si<br />
compone <strong>di</strong> personalità politiche afferenti<br />
sia i ministeri coinvolti nell’attivi-<br />
Shutterstock
tà del Cic sia la <strong>Banca</strong> Centrale. I suoi<br />
membri devono essere approvati dal<br />
Consiglio <strong>di</strong> Stato. Invece il comitato<br />
<strong>di</strong> gestione è composto per lo più da<br />
tecnocrati dotati <strong>di</strong> rilevante esperienza<br />
nella gestione <strong>di</strong> investimenti<br />
pubblici e privati. Il comitato <strong>di</strong>rettivo<br />
defi nisce le strategie e le linee guida<br />
per l’attività <strong>di</strong> investimento. Il comitato<br />
<strong>di</strong> gestione le implementa. Infi ne<br />
un terzo organo, il comitato <strong>di</strong> supervisione,<br />
ha poteri <strong>di</strong> controllo. Dal<br />
punto <strong>di</strong> vista della vigilanza, il Cic<br />
non è sottoposto ad alcuna autorità <strong>di</strong><br />
regolazione ed è sullo stesso piano<br />
della <strong>Banca</strong> Centrale cinese.<br />
Obiettivi e strategie<br />
<strong>di</strong> investimento del Cic<br />
Obiettivi <strong>di</strong>chiarati del Fondo sovrano<br />
cinese sono sia massimizzare i<br />
ritorni <strong>di</strong> lungo termine sugli investimenti<br />
servendosi <strong>di</strong> un portafoglio <strong>di</strong><br />
titoli esteri ben bilanciato, sia ricapitalizzare<br />
importanti istituzioni bancarie<br />
domestiche <strong>di</strong> proprietà statale contribuendo<br />
a riformare il sistema fi nanziario<br />
nazionale.<br />
La strategia <strong>di</strong> investimento del<br />
Cic si svolge pertanto lungo un duplice<br />
binario: domestico ed estero. Per quanto<br />
riguarda gli investimenti domestici<br />
il Cic ha utilizzato un terzo all’incirca<br />
della sua iniziale dotazione per acquistare<br />
la Central Huijin Investment Company<br />
(Chic) subentrando in tutte le<br />
partecipazioni detenute da questa<br />
(China Development Bank, Industrial<br />
and Commercial Bank of China, Agricultural<br />
Bank of China, Bank of China,<br />
China Construction Bank).<br />
Il Cic è dunque <strong>di</strong> fatto proprietario<br />
<strong>di</strong> una gran parte del sistema bancario<br />
e fi nanziario cinese.<br />
Per quanto riguarda le partecipazioni<br />
estere bisogna <strong>di</strong>stinguere due<br />
<strong>di</strong>verse fasi. La prima che va dalla creazione<br />
nel 2007 alla prima metà del 2009,<br />
è il periodo in cui si manifesta la crisi<br />
fi nanziaria. Questa fase è caratterizzata<br />
da alcuni investimenti iniziali (nel<br />
fondo Blackstone Group e in Morgan<br />
Stanley ad esempio) che avevano determinato<br />
alcune per<strong>di</strong>te e dunque un<br />
successivo atteggiamento <strong>di</strong> cautela e<br />
un rallentamento nell’attività <strong>di</strong> investimento.<br />
A ciò si sommavano altri due<br />
fattori. Innanzitutto gli stimoli fi scali<br />
domestici che hanno assorbito risorse<br />
per 600 miliar<strong>di</strong> <strong>di</strong> dollari.<br />
In secondo luogo si è dato avvio<br />
ad un ripensamento delle strategie <strong>di</strong><br />
investimento e ad una riorganizzazione<br />
interna che ha prodotto una nuova<br />
struttura organizzativa e determinato<br />
assunzioni <strong>di</strong> numerose nuove fi gure<br />
professionali. A partire dal 2009 il Cic<br />
ha reso pubblica la sua nuova organizzazione<br />
interna che prevede quattro<br />
<strong>di</strong>visioni. Con la ripresa dei mercati<br />
fi nanziari e l’accumulo <strong>di</strong> risorse umane<br />
e cognitive, a partire dalla seconda<br />
metà del 2009 il Cic ha ripreso l’attività<br />
<strong>di</strong> investimento. Del resto il Cic iniziava<br />
il 2009 con una enorme dotazione<br />
<strong>di</strong> risorse fi nanziarie ancora da investire.<br />
A fi ne anno lo stock <strong>di</strong> investimenti<br />
in titoli esteri sia <strong>di</strong> Paesi avanzati sia<br />
emergenti ammontava a 81 miliar<strong>di</strong> <strong>di</strong><br />
dollari (escludendo le partecipazioni<br />
bancarie <strong>di</strong> Chic) <strong>di</strong> cui 60 effettuati nel<br />
solo 2009. Il portafoglio era allocato<br />
per il 36% in titoli azionari, per il 32% in<br />
liqui<strong>di</strong>tà imme<strong>di</strong>ata, per il 26% in titoli<br />
a red<strong>di</strong>to fi sso e infi ne per il 6% in investimenti<br />
alternativi. Dal punto <strong>di</strong> vista<br />
geografi co, il portafoglio azionario è<br />
allocato per il 44% nel Nord America,<br />
per il 28% in Asia, per il 20% in Europa,<br />
mentre la percentuale rimanente va<br />
all’America Latina. L’Africa è praticamente<br />
assente da questo portafoglio in<br />
quanto esistono in Cina veicoli <strong>di</strong> investimento<br />
specifici per il continente<br />
africano. L’allocazione geografi ca dei<br />
titoli a red<strong>di</strong>to fisso vede una netta<br />
predominanza <strong>di</strong> titoli del debito pubblico.<br />
Non è invece nota l’allocazione<br />
del portafoglio per valute. Tra gli investimenti<br />
<strong>di</strong>retti all’estero <strong>di</strong> tipo azionario<br />
la nuova strategia privilegia i settori<br />
energetico e delle risorse naturali,<br />
delle rinnovabili, delle infrastrutture e<br />
dei servizi fi nanziari. Questo trend è<br />
confermato dai dati sugli investimenti<br />
del 2009 e del 2010 presentati in tabella<br />
2 che vedono il prevalere <strong>di</strong> target appartenenti<br />
a settori reali, in particolare<br />
energetici e delle materie prime.<br />
A seguire si riporta la lista delle<br />
più signifi cative transazioni del periodo<br />
2009-2010 in or<strong>di</strong>ne cronologico inverso:<br />
Tab. 2) PRINCIPALI INVESTIMENTI DEL CIC NEL PERIODO 2009-2010<br />
Target Data Settore Valore (milioni USD)<br />
Penn West Energy Trust mag-2010 Petrolifero<br />
1.020<br />
Chesapeake Energy Corporation mag-2010 Petrolifero e gas 2.600<br />
Changsha Zoomlion Heavy<br />
Industry Science & Technology<br />
Development Co.<br />
feb-2010 Industriale<br />
815<br />
GCL-Poly Energy Hol<strong>di</strong>ngs Ltd. nov-2009 Energie rinnovabili 717<br />
The AES Corporation nov-2009 Energia<br />
1.581<br />
Iron Mining International Ltd. ott-2009 Estrattivo<br />
700<br />
South Gobi Energy Resources Ltd. ott-2009 Estrattivo<br />
500<br />
Oaktree Capital Management set-2009 Finanziario<br />
1.000<br />
Noble Group Ltd. set-2009 Materie prime<br />
858<br />
CJSC Nobel Oil set-2009 Petrolifero<br />
270<br />
PT Bumi Resources set-2009 Carbonifero<br />
1.900<br />
Songbird Estates ago-2009 Immobiliare<br />
450<br />
Goodman Group ago-2009 Immobiliare<br />
460<br />
CITIC Capital Hol<strong>di</strong>ngs Limited lug-2009 Finanziario<br />
258<br />
KazMunaiGas Exploration<br />
and Production<br />
Teck Resources Limited lug-2009 Estrattivo<br />
1.500<br />
Fonte: Capital IQ (Financial Database)<br />
lug-2009 Petrolifero e gas 940<br />
ECONOMIA-FINANZA 55
A fi ne 2009 Cic riportava nel suo<br />
rapporto annuale un utile pari a 42<br />
miliar<strong>di</strong> <strong>di</strong> dollari e un totale attivo <strong>di</strong><br />
332 miliar<strong>di</strong> con un ren<strong>di</strong>mento annuo<br />
dell’11,7% sul portafoglio <strong>di</strong> titoli esteri.<br />
Si tratta <strong>di</strong> cifre che rappresentano un<br />
successo se comparate alle performance<br />
dei principali operatori fi nanziari<br />
mon<strong>di</strong>ali per lo stesso periodo. La valutazione<br />
dell’attività e delle prospettive<br />
del fondo è dunque molto positiva.<br />
Ed infatti sembra che presto il Cic sia<br />
in grado <strong>di</strong> ottenere un’altra tranche <strong>di</strong><br />
riserve dalla banca centrale cinese.<br />
Infi ne va segnalato riguardo al Cic<br />
che, a seguito della sua partecipazione<br />
ai lavori dell’IWG, esso ha fatto notevoli<br />
progressi in termini <strong>di</strong> trasparenza.<br />
Nell’agosto 2009 il Fos cinese ha infatti<br />
pubblicato il suo primo rapporto annuale<br />
sulle attività relative all’anno<br />
2008 seguito, a luglio 2010, dal secondo<br />
rapporto relativo alle attività dell’anno<br />
2009. Inoltre il Cic è uno dei partecipanti<br />
al Forum dei Sovereign Wealth Funds<br />
(IFSWF) istituito nel 2009 per dare seguito<br />
alla redazione dei Principi <strong>di</strong><br />
Santiago. E proprio la Cina ospita<br />
nell’aprile 2011 a Pechino il meeting<br />
annuale del Forum.<br />
Gli altri Fon<strong>di</strong> sovrani cinesi<br />
Il Cic si inserisce in un più ampio<br />
<strong>di</strong>segno elaborato dal governo cinese<br />
al fi ne <strong>di</strong> organizzare e incoraggiare i<br />
fl ussi <strong>di</strong> investimenti <strong>di</strong>retti all’estero.<br />
Vi sono infatti almeno altri tre soggetti<br />
fi nanziari operanti come Fos in Cina,<br />
come visto in tabella 1.<br />
Tra gli enti autorizzati ad investire<br />
all’estero vi è infatti la Safe Investment<br />
Company, sussi<strong>di</strong>aria dello State Administration<br />
of Foreign Exchange (SAFE)<br />
che gestisce le riserve uffi ciali della<br />
<strong>Banca</strong> Centrale cinese. La Safe Investment<br />
Company, creata nel 1997 e<br />
dotata <strong>di</strong> un attivo <strong>di</strong> circa 347 miliar<strong>di</strong><br />
<strong>di</strong> dollari, è <strong>di</strong>ventata investitore attivo<br />
all’estero nella ricerca <strong>di</strong> più profi cui<br />
ren<strong>di</strong>menti per quella quota <strong>di</strong> riserve<br />
in valuta non necessarie alla politica<br />
monetaria. Il livello <strong>di</strong> trasparenza è<br />
molto basso e, non trattandosi uffi cialmente<br />
<strong>di</strong> un fondo sovrano, il Safe non<br />
è tenuto ad adeguarsi agli standard <strong>di</strong><br />
Santiago. Vista la sua implicita natura<br />
<strong>di</strong> Fos, è ragionevole immaginare una<br />
forte rivalità tra Cic e Safe. Tuttavia, se<br />
come si prevede, verrà assegnata al Cic<br />
un’altra tranche <strong>di</strong> riserve, ciò potreb-<br />
56 ECONOMIA-FINANZA<br />
be marcare uffi cialmente il ruolo del<br />
Cic come principale investitore cinese<br />
all’estero.<br />
Un altro Fos cinese è il National<br />
Social Security Fund, fondo pensione<br />
dotato <strong>di</strong> 147 miliar<strong>di</strong> <strong>di</strong> dollari derivanti<br />
da privatizzazioni <strong>di</strong> imprese pubbliche<br />
e da altri proventi fi scali, istituito<br />
nel 2000, che solo nel 2006 ha ricevuto<br />
l’autorizzazione ad investire il 20% delle<br />
proprie dotazioni all’estero. Essendo<br />
un fondo pensioni, anche se sui generis,<br />
il livello <strong>di</strong> trasparenza è più elevato<br />
che nel caso del Safe ed infatti il NSSF<br />
re<strong>di</strong>ge annualmente un rapporto perio<strong>di</strong>co<br />
sulle proprie attività. Nel 2008 ha<br />
riportato la sua prima per<strong>di</strong>ta dalla<br />
costituzione, ma le stime per il futuro<br />
vedono un incremento del valore degli<br />
asset.<br />
Sempre in ambito cinese menzioniamo<br />
un ultimo Fos, ovvero la <strong>di</strong>visione<br />
denominata Investment Portfolio<br />
della Hong Kong Monetary Authority,<br />
dotata <strong>di</strong> 260 miliar<strong>di</strong> <strong>di</strong> dollari: è un<br />
fondo <strong>di</strong> proprietà dell’Autorità Monetaria<br />
<strong>di</strong> Hong Kong autorizzato ad investire<br />
i propri asset all’estero anche in<br />
titoli azionari. Il livello <strong>di</strong> trasparenza è<br />
il più elevato tra i fon<strong>di</strong> cinesi.<br />
Infi ne anche le molteplici ex aziende<br />
<strong>di</strong> Stato cinesi hanno suffi cienti risorse<br />
per fare acquisizioni all’estero,<br />
oltre a poter attingere a ulteriori fi nanziamenti<br />
pubblici. Senza contare che le<br />
banche cinesi, godendo <strong>di</strong> un regime<br />
Shutterstock<br />
protetto e accumulando notevoli profitti,<br />
sono in grado <strong>di</strong> investire tali<br />
profi tti all’estero come ad esempio ha<br />
fatto l’Industrial and Commercial Bank<br />
of China comprando il 20% <strong>di</strong> Standard<br />
Chartered Bank. Non è un caso che il<br />
Cic si sia premurato <strong>di</strong> acquisire notevoli<br />
partecipazioni nelle principali banche<br />
cinesi, in modo tale da essere in<br />
grado <strong>di</strong> agire anche per via in<strong>di</strong>retta,<br />
inducendo le banche a fi nanziare acquisizioni<br />
estere o a supportare gli investimenti<br />
esteri da parte <strong>di</strong> aziende<br />
cinesi.<br />
In questa congerie <strong>di</strong> interventi,<br />
alcuni ravvisano, più che un piano<br />
strategico, la sovrapposizione <strong>di</strong> poteri<br />
politici <strong>di</strong>versi e la <strong>di</strong>sputa <strong>di</strong> lunga<br />
data tra il ministero delle Finanze e la<br />
<strong>Banca</strong> Centrale per l’aggiu<strong>di</strong>cazione<br />
della supremazia nella gestione delle<br />
riserve. Prova ne sarebbe il tentativo <strong>di</strong><br />
Safe <strong>di</strong> espandere i propri investimenti<br />
esteri occupando così gli stessi spazi <strong>di</strong><br />
investimento del Cic. A nostro avviso<br />
tuttavia, al <strong>di</strong> là delle possibili <strong>di</strong>ffi coltà<br />
interpretative, l’insieme delle iniziative<br />
sembra porsi come lo sta<strong>di</strong>o iniziale <strong>di</strong><br />
un’ampia strategia <strong>di</strong> investimenti esteri<br />
che potrebbe portare la Cina a <strong>di</strong>venire,<br />
nei prossimi anni, uno dei principali<br />
investitori mon<strong>di</strong>ali.<br />
Conclusioni<br />
La precedente rifl essione ha voluto<br />
dare una sintetica rappresentazione<br />
dei Fos cinesi. Per concludere, noi pensiamo<br />
che, con questa nuova strategia<br />
<strong>di</strong> investimenti all’estero, la Cina potrebbe<br />
inaugurare due nuove tendenze.<br />
Da un lato una nuova era <strong>di</strong> cooperazione<br />
per la governance globale sui<br />
mercati finanziari mon<strong>di</strong>ali in cui<br />
all’egemonia dei Paesi occidentali si<br />
affi anca la presenza del colosso asiatico<br />
oltre che <strong>di</strong> altri Paesi emergenti.<br />
Dall’altro una nuova fase <strong>di</strong> collaborazione<br />
tra Nord e Sud del mondo per lo<br />
sviluppo a lungo termine che vede il<br />
suo baricentro spostato ad Est.<br />
Siamo consapevoli che i fenomeni<br />
economici si soli<strong>di</strong>fi cano solo nel lungo<br />
termine e perciò non si può ancora <strong>di</strong>re<br />
con certezza quale sarà lo sviluppo cinese<br />
nel corso del mezzo secolo che ci<br />
attende anche perché la struttura istituzionale<br />
e sociale <strong>di</strong> quel grande Paese<br />
è davvero un unicum la cui transizione<br />
verso forme più democratiche presenta<br />
numerose incognite.
Peter Peter<br />
Quando<br />
NOTIZIARIO<br />
il palato<br />
si mette in viaggio<br />
Testo e foto <strong>di</strong><br />
ALESSANDRO MELAZZINI<br />
alessandro@melazzini.com<br />
www.melazzini.com<br />
Ma Monaco è davvero la città<br />
italiana più a Nord, come amano<br />
<strong>di</strong>re i suoi abitanti?<br />
Senz’altro è la città tedesca<br />
più infl uenzata dall’Italia. I motivi<br />
sono numerosi, innanzi tutto per il<br />
suo forte cattolicesimo, tanto che<br />
viene considerata la Roma tedesca.<br />
Poi basta guardare gli e<strong>di</strong>fi ci<br />
per trovare ovunque citazioni italiane:<br />
la Feldherrenhalle riprende la<br />
Loggia dei Lanzi <strong>di</strong> Firenze, al suo<br />
fi anco l’imponente chiesa dei Tea-<br />
Personaggi<br />
È <strong>di</strong> casa tanto nella natale Monaco, quanto a Roma, Palermo o<br />
Torino. Da anni, nei suoi articoli sulla Frankfurter Allgemeine<br />
Zeitung e nei suoi numerosi libri, svela al lettore tedesco la storia<br />
e le prelibatezze della cucina italiana, raccontando una nazione,<br />
la nostra, che ormai conosce a mena<strong>di</strong>to ma sempre continua<br />
ad affascinarlo. Da qualche tempo l’amore per la cucina<br />
nostrana ha innescato in lui il desiderio <strong>di</strong> riscoprire i sapori<br />
della propria Germania, a maggior vantaggio <strong>di</strong> chi ama seguirlo<br />
nei suoi viaggi gastronomici all’insegna del binomio tra cucina<br />
e cultura. È lo scrittore enogastronomico Peter Peter, premio<br />
Enit per la miglior guida sull’Italia in lingua tedesca, che incontriamo<br />
seduto al tavolo della sua cucina, nel cuore della capitale<br />
bavarese.<br />
tini, non molto <strong>di</strong>stante il Palazzo<br />
Reale che ricorda in una facciata<br />
Palazzo Pitti.<br />
Un’altra ragione è lo stile <strong>di</strong><br />
vita dei suoi abitanti, il loro modo<br />
<strong>di</strong> comportarsi. Già negli anni Sessanta<br />
Monaco era famosa per la<br />
Leopoldstrasse, l’ampio boulevard<br />
che parte dal centro e costeggia il<br />
grande parco del Giar<strong>di</strong>no Inglese.<br />
In quell’epoca la Leopoldstrasse<br />
era l’unico viale della Germania<br />
dove la gente sedeva in strada per<br />
gustarsi un gelato, come fosse<br />
una piccola Piazza Navona. Ormai<br />
questo si fa dappertutto, ma per<br />
primo accadde a Monaco. In questa<br />
città si respira una certa leggerezza<br />
della vita, un brio più italiano<br />
che tedesco.<br />
È sempre stato così?<br />
No, no. Fino agli anni Sessanta<br />
la Baviera era la regione più<br />
“regionale” della Germania, basta<br />
guardare le foto degli anni Cinquanta.<br />
Era una società ancora<br />
molto ancorata alle tra<strong>di</strong>zioni bavaresi,<br />
ai costumi alpini rustici e fortemente<br />
localisti. Certo, la Monaco<br />
cattolica ha sempre nutrito un<br />
Peter Peter, in<br />
viaggio tra i sapori.<br />
Peter Peter, travelling<br />
through flavours.<br />
Peter Peter, when the palate goes travelling<br />
That cuisine is an integral part of a country’s spirit is nothing new.<br />
If we are to believe the insiders, eating Italian food for Germans<br />
means taking on the spirit of the Bel Paese. Some might even call<br />
Munich the most Italian city in the north, because Italy in Teutonic<br />
territory enjoys un<strong>di</strong>sputed success. This explains how an<br />
enogastronomic writer could fall in love with a trattoria in<br />
Trastevere, then with Tuscany and Sicily’s culinary heritage.<br />
Food is good everywhere in Italy. In Germany, a certain austerity<br />
and the Protestant ethic of self-sacrifice have over the centuries<br />
given a secondary role to cuisine. It comes as no surprise that we<br />
have the perfect con<strong>di</strong>tions for a fatal attraction.<br />
PERSONAGGI 57
forte legame con l’Italia, ma questa<br />
leggerezza della vita prima si<br />
godeva tutt’al più bevendo birra.<br />
Ora invece assaporando in ogni<br />
dove un caffè espresso.<br />
Come mai è cambiata?<br />
Senz’altro per il fenomeno<br />
degli immigrati italiani, che hanno<br />
aperto centinaia <strong>di</strong> trattorie e pizzerie,<br />
anche piccoli espresso-bar.<br />
Non bisogna poi <strong>di</strong>menticare che il<br />
citta<strong>di</strong>no <strong>di</strong> Monaco trascorre<br />
spesso le vacanze nel Nor<strong>di</strong>talia.<br />
Da noi si <strong>di</strong>ce che i prussiani vanno<br />
in ferie nel Sud della Baviera,<br />
gli Olandesi in Austria e i Bavaresi<br />
in Alto A<strong>di</strong>ge o sul Lago <strong>di</strong> Garda:<br />
un lago che si potrebbe considerare<br />
il più meri<strong>di</strong>onale della Germania,<br />
quasi un gemello del nostro<br />
Starnberger See. La classica socializzazione<br />
<strong>di</strong> un bavarese, i suoi<br />
primi incontri amorosi, non <strong>di</strong> rado<br />
nascono durante un “grand Tour”<br />
sul Lago <strong>di</strong> Garda.<br />
La tua vita studentesca però l’hai<br />
trascorsa a Vienna...<br />
Sì, ho stu<strong>di</strong>ato letteratura<br />
comparata e filologia classica,<br />
anche se in realtà ho stu<strong>di</strong>ato poco<br />
e letto come un pazzo. Quasi<br />
ogni sera andavo all’opera o al teatro,<br />
mi sono letteralmente immerso<br />
in una città profondamente<br />
culturale come era Vienna negli<br />
anni Settanta.<br />
Monaco <strong>di</strong> Baviera, invece, a<br />
quell’epoca era una città ancora<br />
provinciale, che avendo appena<br />
ospitato le Olimpia<strong>di</strong> si era fatta<br />
prendere dal culto della modernizzazione<br />
architettonica. Io personalmente<br />
non ho mai amato lo stile<br />
e<strong>di</strong>lizio degli anni Settanta.<br />
A Vienna invece trovai quello<br />
che amavo: la storia, l’eleganza, il<br />
ballo, le donne che si vestivano<br />
con le gonne e non con i jeans e i<br />
parka. In quell’epoca Vienna era<br />
decisamente più elegante <strong>di</strong> Monaco.<br />
Ora il <strong>di</strong>vario si è certamente<br />
colmato.<br />
Come mai capitasti a fare il fotomodello<br />
per Bravo, la più nota rivista<br />
tedesca per adolescenti?<br />
Il tutto fu organizzato dai miei<br />
genitori: accadde quattro-cinque<br />
58 PERSONAGGI<br />
volte, ma ero troppo timido a<br />
quell’epoca per approfi ttarne. Bravo<br />
era la rivista su cui tutte le star<br />
si facevano fotografare, ed ebbe<br />
un ruolo importante nell’educazione<br />
sessuale dei miei coetanei <strong>di</strong><br />
quell’epoca. I ragazzi scrivevano a<br />
degli esperti su temi che in casa<br />
non si potevano trattare.<br />
Come sei <strong>di</strong>ventato scrittore enogastronomico?<br />
Per <strong>di</strong>versi motivi. Il primo è<br />
che viaggiando molto ho sempre<br />
provato un forte interesse per la<br />
storia dell’arte, della letteratura,<br />
ma ho anche sempre amato visitare<br />
i posti dove mangiano gli autoctoni,<br />
perché lo considero un avvicinamento<br />
alla cultura locale. Nel<br />
vedere come una città funziona,<br />
partire dalla cucina è sempre mol-<br />
to fruttuoso. In questo vi è certo<br />
una curiosità, un minimo <strong>di</strong> voyeurismo,<br />
ma una trattoria in un Paese<br />
straniero spesso può essere<br />
un teatro interessantissimo. Prima<br />
ho iniziato a frequentare locali a<br />
Vienna; allora la vita costava molto<br />
poco e nella capitale austriaca la<br />
cucina era decisamente più ricca<br />
e variegata <strong>di</strong> Monaco, grazie al<br />
patrimonio culinario lasciato in<br />
ere<strong>di</strong>tà dalla monarchia asburgica.<br />
Poi alla fi ne degli anni Settanta ho<br />
scoperto l’Italia, ho imparato l’italiano<br />
a Perugia e viaggiando per il<br />
vostro Paese ho capito molto presto<br />
che mangiare bene è identità.<br />
Senza contare l’emozione <strong>di</strong> trovarsi<br />
<strong>di</strong> fronte all’enorme varietà <strong>di</strong><br />
piatti regionali, <strong>di</strong> gusti, sapori,<br />
aromi e abbinamenti presenti in<br />
Italia. Nello scoprire la cucina ita-<br />
In Germania il<br />
fascino della cucina<br />
italiana è secondo<br />
solo a quello per<br />
l’arte del Belpaese.<br />
In Germany, the<br />
appeal of Italian<br />
cuisine is second<br />
only to that for<br />
Italian art.<br />
liana, dove il nome della pasta<br />
cambia da paese a paese, posso<br />
anche tenere allenati i miei stu<strong>di</strong><br />
<strong>di</strong> fi lologia.<br />
Ti ricor<strong>di</strong> la prima trattoria italiana<br />
in cui hai pranzato?<br />
Quando stu<strong>di</strong>avo a Perugia<br />
avevo un’amica viennese che faceva<br />
la ragazza alla pari a Roma.<br />
Andavo ogni fi ne settimana a trovarla<br />
con la mia guida rossa per<br />
vedere tutte le chiese. Avevo pochissimi<br />
sol<strong>di</strong>, ma ricordo ancora<br />
adesso la trattoria “Mario” a Trastevere.<br />
L’anno scorso ci sono<br />
tornato dopo anni <strong>di</strong> assenza. Costa<br />
ancora poco, è specializzata in<br />
cibi tra<strong>di</strong>zionali come le lumache o<br />
la pajata... ci sono ancora gli stessi<br />
quadri <strong>di</strong> beoni irsuti che bevono<br />
dal fiasco <strong>di</strong> Chianti. Con tutta<br />
l’esperienza accumulata in trent’anni<br />
<strong>di</strong> scoperta delle regioni<br />
italiane, posso ancora raccomandarla:<br />
vicolo del Moro, se non mi<br />
sbaglio.<br />
Dopo Roma come hai proseguito<br />
nella tua scoperta culinaria della<br />
cucina italiana?<br />
Stu<strong>di</strong>ando a Perugia ho incontrato<br />
la cucina umbra. Era una<br />
sensazione spettacolare per un<br />
tedesco stu<strong>di</strong>are a Perugia a fi ne<br />
anni Settanta. A quell’epoca nelle<br />
mense universitarie tedesche si<br />
mangiava roba orrenda. Si arrivava<br />
al bancone, era pieno <strong>di</strong> manifesti<br />
politici, e sopra ti scodellavano un<br />
piatto <strong>di</strong> spaghetti scotti.<br />
A Perugia c’era una mensa<br />
universitaria dove potevo trovare<br />
insalata fresca, un bicchiere <strong>di</strong> vino,<br />
già in queste piccole cose si<br />
poteva notare una <strong>di</strong>fferenza enorme<br />
con la Germania. Senza contare<br />
che la cucina umbra, ancora<br />
oggi, è eccellente.<br />
Ricordo <strong>di</strong> aver frequentato<br />
tante sagre e feste dell’Unità. Durante<br />
il fi ne settimana, spiantato<br />
com’ero, riuscivo anche con pochi<br />
sol<strong>di</strong> a degustare ottime specialità<br />
del posto.<br />
Poi ho scoperto la Sicilia,<br />
grazie anche al mio interesse per<br />
l’antichità. Laggiù c’è una cucina,<br />
forse non tanto borghese, ma raffi<br />
natissima grazie alle sue primizie
agricole. Passeggiare per i mercati<br />
<strong>di</strong> Palermo e Siracusa? Fantastico!<br />
Senza contare Napoli.<br />
Una cosa che mi ha sempre<br />
impressionato è l’intelligenza culinaria<br />
anche degli italiani <strong>di</strong> basso<br />
ceto sociale. Da noi in Germania<br />
mangiare bene è quasi <strong>di</strong>ventato<br />
un fattore accademico: più eru<strong>di</strong>ti<br />
si è, meglio si mangia. In Italia invece<br />
confesso che sono stati gli<br />
autisti dei pullman a segnalarmi<br />
posti fantastici. Se lo fai con un<br />
loro collega tedesco, al massimo<br />
ti consiglia arrosto <strong>di</strong> maiale e<br />
cinque canederli.<br />
Mi ha sempre affascinato il<br />
legame tra storia e cucina. Parlando<br />
della Sicilia, avevo stu<strong>di</strong>ato bene<br />
la storia e la letteratura, le dominazioni<br />
spagnole, greche e così<br />
via, e trovare che tutte queste po-<br />
polazioni hanno lasciato ricette<br />
ancora vive e utilizzate per me è<br />
stata una scoperta meravigliosa.<br />
In Sicilia si può fare un viaggio<br />
gastronomico lungo duemila anni.<br />
Così ho cominciato a scrivere<br />
libri su questo argomento: il primo,<br />
appunto, sulla cucina siciliana,<br />
perché in quel tempo in Germania<br />
si parlava solo della cucina toscana,<br />
che è certo buonissima ma<br />
non così ricca dal punto <strong>di</strong> vista<br />
culinario come lo è la Sicilia. Dopo<br />
ho scritto un libro sulle trattorie<br />
della Toscana, uno sulle trattorie<br />
del Lago <strong>di</strong> Garda per i miei connazionali<br />
bavaresi, uno sulle Stuben<br />
dell’Alto A<strong>di</strong>ge. Quest’ultimo mi ha<br />
aiutato molto, perché solo scrivendo<br />
<strong>di</strong> Alto A<strong>di</strong>ge ho cominciato a<br />
muovermi anche nell’ambito tedesco<br />
della buona ristorazione.<br />
Anche gli stu<strong>di</strong><br />
classici tornano utili<br />
per decifrare ricette<br />
antiche.<br />
Even the classics<br />
come in handy to<br />
decipher old recipes.<br />
Ormai in Germania si assiste a un<br />
fl orilegio <strong>di</strong> trasmissioni culinarie<br />
e a un crescente interesse per il<br />
cibo locale, prova ne è che tu<br />
stesso hai pubblicato una storia<br />
culturale della cucina tedesca.<br />
Non è sempre stato così, tanto<br />
che ancora molti italiani non hanno<br />
consapevolezza del fermento<br />
culinario d’oltralpe. Quando e perché<br />
è cominciata questa riscoperta<br />
della cucina tedesca?<br />
Fino a qualche tempo fa si<br />
mangiava molto male in Germania.<br />
Per via <strong>di</strong> un certo carattere militaresco<br />
o militante, e anche per un<br />
motivo religioso legato al protestantesimo<br />
e al suo ethos <strong>di</strong> rinuncia:<br />
meglio pensare che mangiare<br />
bene.<br />
Un altro motivo era la società<br />
tedesca, molto ugualitaria, dove<br />
tutti, avvocati, politici, ricchi o poveri,<br />
mangiavano male e modestamente,<br />
insieme. Poi negli anni<br />
Settanta ci sono stati i primi ribelli,<br />
molto spesso viaggiatori che si<br />
sono chiesti come mai i comunisti<br />
francesi mangiano bene mentre<br />
noi tedeschi no a causa <strong>di</strong> motivi...<br />
ideologici?<br />
A quel tempo nacque l’amore<br />
tedesco verso la cucina me<strong>di</strong>terranea<br />
e negli anni Ottanta chi voleva<br />
mangiare bene andava in esilio in<br />
Toscana.<br />
Emblematica è la storia <strong>di</strong><br />
Slow Food Germania. I primi convivi<br />
non facevano altro che imitare<br />
l’Italia: si visitavano e frequentavano<br />
soltanto le trattorie italiane in<br />
Germania. Questo fi no agli anni<br />
Novanta. Poi a un certo momento<br />
è sopraggiunta la noia, perché ormai<br />
la Germania è strapiena <strong>di</strong> ristoranti<br />
italiani. E così la <strong>di</strong>menticatissima<br />
cucina tedesca ha ricominciato<br />
a fi orire e fare furore. Una<br />
riscoperta <strong>di</strong> qualcosa che è stato<br />
<strong>di</strong>menticato dai tempi della Prima<br />
Guerra mon<strong>di</strong>ale. Da cinque o sei<br />
anni si è sviluppata la moda <strong>di</strong> riscoprire<br />
vecchie erbe, antiche preparazioni<br />
e usanze.<br />
Detto questo la Germania ha<br />
ancora una società culinaria molto<br />
<strong>di</strong>visa. Una parte della popolazione<br />
coltiva un amore e un gusto<br />
speciali verso il cibo, l’altra si nutre<br />
<strong>di</strong> pizze surgelate.<br />
PERSONAGGI 59
I tuoi libri più recenti sono soprattutto<br />
una storia culturale: uno per<br />
la cucina italiana, uno per quella<br />
tedesca. Quando ti è venuta l’idea<br />
<strong>di</strong> questo approccio all’alimentazione?<br />
Ho iniziato a scrivere piccoli<br />
articoli sulla nascita della pizza a<br />
Napoli, ma l’idea vera e propria mi<br />
è venuta a Roma nel museo della<br />
pasta alimentare vicino alla fontana<br />
<strong>di</strong> Trevi. Sono entrato, ho visto<br />
una bellissima fotografi a <strong>di</strong> Sophia<br />
Loren che con erotica eleganza<br />
mangiava spaghetti, una fotografi a<br />
non molto conosciuta, e mi sono<br />
detto: devo scrivere un libro con<br />
questa fotografia. Prima volevo<br />
fare una cosa semplice, raccontare<br />
che i ravioli forse venivano dalla<br />
Liguria, il baccalà mantecato da<br />
Venezia e così via, sono andato da<br />
un e<strong>di</strong>tore e questi mi ha proposto<br />
<strong>di</strong> lavorare a un’opera più densa, e<br />
allora ne ho approfi ttato, anche<br />
perché in passato ho pubblicato<br />
libri <strong>di</strong> storia e d’arte e guide su<br />
molte regioni dell’Italia. Occupandomi<br />
<strong>di</strong> storia culinaria mi sono<br />
stati molto utili gli stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> letteratura<br />
antica. La satira, ad esempio,<br />
ha un profondo legame con il cibo,<br />
nel teatro antico il cuoco è un protagonista<br />
della comme<strong>di</strong>a, il vegetarianesimo<br />
è nato in Magna Grecia.<br />
E così nel libro sulla storia<br />
della cucina italiana ho trattato<br />
l’antichità, il cristianesimo, poi la<br />
60 PERSONAGGI<br />
rappresentazione dei banchetti rinascimentali,<br />
lo sfarzo barocco, la<br />
crisi dell’Ottocento e il successo<br />
mon<strong>di</strong>ale degli ultimi decenni.<br />
Mi piace anche molto poter<br />
raccontare a voce <strong>di</strong> tutto questo,<br />
e spesso tengo conferenze in Germania.<br />
Se qualche associazione<br />
italiana fosse interessata sarei<br />
contento <strong>di</strong> entrare in contatto,<br />
basta scrivermi a pietropietro@<br />
web.de.<br />
© Museo Nazionale Paste Alimentari, Roma<br />
La foto <strong>di</strong> Sophia<br />
Loren che ha ispirato<br />
Peter a scrivere un<br />
libro sulla cultura<br />
culinaria del<br />
Belpaese.<br />
The photo of Sophia<br />
Loren that inspired<br />
Peter to write a book<br />
on the culinary<br />
culture of Italy.<br />
La storia culturale<br />
della cucina italiana<br />
e quella della cucina<br />
tedesca, e<strong>di</strong>ti dalla<br />
Beck Verlag <strong>di</strong><br />
Monaco.<br />
The cultural histories<br />
of Italian and<br />
German cuisines,<br />
published by Beck<br />
Verlag, Munich.<br />
Sei “costretto” a mangiare tutto<br />
quello <strong>di</strong> cui racconti nei tuoi libri?<br />
Ogni critico gastronomico ha<br />
le sue tecniche, quella migliore è<br />
cenare in compagnia <strong>di</strong> una bella<br />
signora che ti permetta <strong>di</strong> assaggiare<br />
il doppio delle pietanze. A<br />
volte se sei proprio convinto della<br />
bontà <strong>di</strong> un luogo puoi anche parlare<br />
con l’oste e chiedergli un assaggio<br />
<strong>di</strong> vari piatti, altrimenti dovresti<br />
venire cinque volte per provare<br />
tutto il menù.<br />
Comunque in Italia è molto<br />
<strong>di</strong>ffi cile mangiare male, mentre in<br />
Germania mi capita <strong>di</strong> girare decine<br />
<strong>di</strong> locande prima <strong>di</strong> trova re<br />
quella dove davvero cucinano un<br />
buon stinco <strong>di</strong> maiale con canederlo.<br />
A tutto svantaggio della<br />
linea...<br />
Pensa ai lettori italiani che non<br />
conoscono alcunché della cucina<br />
tedesca: cosa <strong>di</strong>resti loro per<br />
convincerli a lanciarsi in esplorazioni<br />
gastronomiche oltre le Alpi?<br />
La prima cosa è che è molto<br />
<strong>di</strong>versa da quella italiana, ha delle<br />
tecniche e delle combinazioni <strong>di</strong>fferenti,<br />
e questo può incuriosirli.<br />
Una ricchezza della Germania sono<br />
le storiche osterie: basta arrivare<br />
in un qualsiasi paesino e si<br />
trova un antico ristorante con salette<br />
perlinate, insegne in ferro e<br />
un’atmosfera accogliente. Poi ci<br />
sono certe cose in cui la Germania<br />
è ancora campione, come la varietà<br />
delle sue salsicce. In Italia non<br />
si ha nessuna idea – a meno che<br />
non si abiti a Cortina d’Ampezzo<br />
– <strong>di</strong> cosa possa essere un würstel.<br />
Al massimo lo si liquida come<br />
qualcosa da mettere sulla pizza:<br />
una cosa orrenda.<br />
Ma come ogni paese italiano<br />
ha la sua pasta, ogni paese tedesco<br />
in realtà ha il suo würstel, da<br />
quello bianco <strong>di</strong> Monaco, a quello<br />
affumicato o con fegato del Nord<br />
e così via. Un’altra cosa affascinante<br />
della cucina tedesca è il<br />
nostro pane, da quello bianchissimo<br />
a quello integrale. Ci sono dei<br />
panifi ci che fanno ancora pani <strong>di</strong><br />
tre o quattro chili che sembrano<br />
<strong>di</strong>nosauri, ma sono opere d’arte.<br />
La Germania è famosa per la sua
selvaggina e naturalmente, per le<br />
sue birre. Ci sono regioni come la<br />
Franconia in cui ogni piccola osteria<br />
produce la sua propria birra, un<br />
fenomeno conosciuto <strong>di</strong> solito<br />
solamente dalle zone vinicole.<br />
Ancora da scoprire <strong>di</strong>rei sono certi<br />
sapori nor<strong>di</strong>ci come una buona<br />
senape, certi legumi, la preparazione<br />
del cavolo rosso, dei cetrioli,<br />
tutti alimenti un po’ esotici per gli<br />
italiani.<br />
Infi ne, una caratteristica amabile<br />
della cucina tedesca è la sua<br />
semplicità. Si può andare in un ristorante<br />
e or<strong>di</strong>nare anche solo<br />
una minestra e un bicchiere <strong>di</strong><br />
birra o <strong>di</strong> vino. Mangi bene, stai<br />
comodo e non paghi molto.<br />
La “Gemütlichkeit”, lo stare bene<br />
in un luogo, è una caratteristica<br />
tipica delle atmosfere culinarie<br />
tedesche. Come la spiegheresti<br />
ai lettori italiani?<br />
È un fenomeno senz’altro<br />
settentrionale. Signifi ca trascorrere<br />
ore in osteria, ma non giocando<br />
a carte o imprecando, bensì stando<br />
seduti senza fretta e al caldo<br />
<strong>di</strong> una stufa. Un tempo la gente<br />
quasi abitava in osteria. In Italia<br />
invece si va al ristorante, un cameriere<br />
elegante ti serve e poi te<br />
ne vai. In Germania c’è più il gusto<br />
del vivere comodo, che si rifl ette<br />
anche nei caffè. Mentre da voi <strong>di</strong><br />
solito il bar è un luogo dove bevi<br />
in pie<strong>di</strong> un caffè <strong>di</strong> fretta, in Germania<br />
hai poltrone vellutate, giornali,<br />
puoi passare ore a sfogliarli,<br />
sorseggiando bevande calde e<br />
gustando torte monumentali.<br />
Un’esperienza che i viaggiatori<br />
italiani in Germania <strong>di</strong>mostrano <strong>di</strong><br />
apprezzare.<br />
Molti italiani si stupiscono però<br />
dell’importanza che la birra riveste<br />
nella cultura del tuo Paese.<br />
Quali sono secondo te i motivi<br />
storici e psicologici <strong>di</strong> questo<br />
amore tedesco per la bevanda<br />
bionda?<br />
Sono motivi storici e religiosi:<br />
il cattolicesimo in Baviera ha sostenuto<br />
il costume della birra, e<br />
molti conventi la producevano,<br />
come tuttora succede per il monastero<br />
<strong>di</strong> Andechs. I protestanti,<br />
Per chi voglia<br />
scoprire i vini<br />
tedeschi Peter Peter<br />
consiglia <strong>di</strong> iniziare<br />
con il Riesling<br />
Renano.<br />
To <strong>di</strong>scover German<br />
wines, Peter Peter<br />
recommends starting<br />
with a Reisling from<br />
the Rhine.<br />
che erano più ricchi, potevano<br />
mangiare ogni giorno carne, mentre<br />
i cattolici, che spesso vivevano<br />
loro accanto, dovevano <strong>di</strong>giunare.<br />
Così per dare un conforto nutriente<br />
ai <strong>di</strong>giunatori si è creato il culto<br />
della birra, che esiste da circa 300<br />
anni. Storicamente, infatti, il vino<br />
tedesco, tranne il famoso Riesling<br />
del Reno, è un vino acido e non<br />
buono, a <strong>di</strong>fferenza della birra maltata<br />
dal colore dell’ambra, che è<br />
dolce e che sazia.<br />
E poi in fondo il tedesco non<br />
ama l’eleganza, ama la convivialità.<br />
Bere birra è una cosa popolare,<br />
in grado <strong>di</strong> trasmettere un ideale<br />
sociale <strong>di</strong> unità tra le classi, bere<br />
vino invece è un atteggiamento<br />
raffi nato, che implica più <strong>di</strong>stinzione.<br />
Non <strong>di</strong>mentichiamo infi ne il<br />
fascino della festa della birra <strong>di</strong><br />
Monaco. Questa festa fantastica,<br />
coi costumi popolari e un pubblico<br />
tanto locale quanto internazionale,<br />
è <strong>di</strong>ventata il simbolo culinario non<br />
solo della Germania, ma anche<br />
della gioia della vita.<br />
E poi, se mi permetti questa<br />
punta <strong>di</strong> campanilismo, la birra<br />
bavarese è semplicemente fantastica.<br />
Che cosa ne pensi dei nuovi birrifi<br />
ci italiani, che fanno birre sofi sticate<br />
in bottiglie da vino?<br />
Un fenomeno interessante.<br />
Da noi esiste la stessa cosa, ma<br />
questi birrifi ci non sono costosi,<br />
perché conta più l’interesse a vedere<br />
come si fa la birra che produrre<br />
una bevanda <strong>di</strong> lusso. Penso<br />
che il fenomeno in Italia nasca dal<br />
fatto che da circa vent’anni gli italiani<br />
viaggiano moltissimo e le loro<br />
mete preferite, se non vanno sul<br />
Mar Rosso, sono la Scozia, l’Irlanda<br />
e la Baviera, Paesi dove si beve<br />
molta birra. Farlo per un italiano<br />
signifi ca vacanze e rilassamento.<br />
Un fascino che si rifl ette nell’amore<br />
degli italiani per le birre nostrane<br />
in confezioni antiche, esotiche,<br />
piene <strong>di</strong> etichette e con forti percentuali<br />
d’alcol, un fenomeno che<br />
fa sorridere i tedeschi perché è<br />
solo ad uso e consumo dei turisti<br />
italiani.<br />
Anche la moda <strong>di</strong>lagante in<br />
Italia dei pub irlandesi contribuisce<br />
a <strong>di</strong>ffondere l’interesse verso la<br />
birra. E poi se sei giovane e non<br />
devi spendere sol<strong>di</strong> per la cena<br />
puoi anche permetterti una birra<br />
costosa.<br />
PERSONAGGI 61
Per contro ultimamente il vino sta<br />
prendendo sempre più piede in<br />
Germania, anche a <strong>di</strong>scapito della<br />
birra... è un bene o un male?<br />
Per le birrerie un male. La<br />
birra, come hanno detto i monaci<br />
della Controriforma, è nutrimento,<br />
il vino non tanto. Quando ero giovane<br />
la birra per gli operai tedeschi<br />
era considerata quasi un alimento,<br />
era normale bere birra già alle nove<br />
<strong>di</strong> mattina se ti svegli alle cinque.<br />
Ora non lo è più, anche per<br />
motivi <strong>di</strong>etetici. Un tempo invece<br />
bere molto era un’abitu<strong>di</strong>ne rispettata<br />
e considerata anche virile,<br />
segno <strong>di</strong> cultura e integrazione<br />
sociale. Ora è tutto cambiato, viviamo<br />
in un mondo d’igiene, dove<br />
anche sul mondo del lavoro occorre<br />
essere sempre presenti, una<br />
e-mail ti può raggiungere in ogni<br />
minuto. Piccole dosi <strong>di</strong> vino sono<br />
più adeguate. Senza contare che<br />
in Germania i sogni <strong>di</strong> una vacanza<br />
perfetta non sono quelli <strong>di</strong> bere<br />
una birra in Irlanda, ma <strong>di</strong> stare su<br />
una terrazza italiana, portoghese o<br />
spagnola <strong>di</strong> fronte al mare e sorseggiare<br />
un buon rosso.<br />
Quali vini consiglieresti a un palato<br />
italiano curioso <strong>di</strong> stappare<br />
qualche turacciolo tedesco?<br />
Se vai all’estero consiglio <strong>di</strong><br />
non cercare cose simili al sapore<br />
<strong>di</strong> casa. Quin<strong>di</strong> <strong>di</strong>rei <strong>di</strong> iniziare provando<br />
il vino bianco più famoso del<br />
mondo, ovvero il Riesling Renano,<br />
quello della vendemmia tar<strong>di</strong>va,<br />
non troppo secco, capace <strong>di</strong> una<br />
raffi nata asprezza unita a una dolcezza<br />
fl oreale. Continuando si potrebbero<br />
assaggiare ad esempio il<br />
Müller-Thurgau del Lago <strong>di</strong> Costanza,<br />
l’Erbacher Marcobrunn, il Sommeracher<br />
Katzenkopf e il Rivaner.<br />
Con il vino si accompagna bene il<br />
formaggio, peccato solo che in un<br />
Land come la Baviera, nonostante<br />
il suo carattere tuttora molto<br />
attento alla cultura conta<strong>di</strong>na,<br />
non esista una vera cultura <strong>di</strong><br />
questo alimento.<br />
Uhm... parlerei piuttosto <strong>di</strong><br />
industria conta<strong>di</strong>na. Comunque è<br />
vero, la situazione del formaggio in<br />
Germania è una trage<strong>di</strong>a. Il motivo<br />
va ricercato nella “superigiene” e<br />
62 PERSONAGGI<br />
Dopo anni <strong>di</strong> cucina<br />
italiana ora i<br />
tedeschi cominciano<br />
a riscoprire la loro<br />
cucina locale.<br />
After years of Italian<br />
cuisine, the Germans<br />
are now beginning<br />
to re<strong>di</strong>scover their<br />
local cuisine.<br />
nella razionalizzazione tipicamente<br />
tedesche. Negli anni Settanta si è<br />
vietato tutto il formaggio fatto da<br />
latte crudo, con la piccola eccezione<br />
dell’Algovia. Poi hanno rovinato<br />
i piccoli caseifi ci che fanno la ricchezza<br />
del formaggio, con il risultato<br />
<strong>di</strong> costituire una decina <strong>di</strong><br />
megalatterie che producono un<br />
prodotto standar<strong>di</strong>zzato. Inutile<br />
sprecare un buon vino con questi<br />
formaggi castrati.<br />
Oltre a ciò vi è anche da considerare<br />
il fatto che storicamente<br />
il conta<strong>di</strong>no bavarese è un conta<strong>di</strong>no<br />
ricco, che si poteva permettere<br />
<strong>di</strong> ammazzare la vacca mangiandone<br />
la carne anziché tenerla<br />
per farne formaggio. Per tutti questi<br />
motivi purtroppo la cultura del<br />
formaggio non è fortemente ra<strong>di</strong>cata<br />
in Germania. Ultimamente<br />
tuttavia stanno rispuntando dei<br />
piccoli caseifi ci. Insomma, <strong>di</strong>ventiamo<br />
un po’ più globali... anche<br />
nella riscoperta delle tipicità locali.
Come capo guida turistica sei<br />
spesso in Italia con viaggi a metà<br />
tra cucina e cultura. Che tipo<br />
<strong>di</strong> clienti intraprendono queste<br />
e scursioni nel nostro Paese?<br />
Da noi esiste il termine “Stu<strong>di</strong>enraise”,<br />
viaggio <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>, che<br />
non è l’escursione <strong>di</strong> una parrocchia<br />
o quella <strong>di</strong> una bocciofila,<br />
bensì un viaggio in cui si visitano<br />
chiese, musei e templi con spiegazioni<br />
culturali, qualcosa <strong>di</strong> semiaccademico<br />
senza <strong>di</strong>ventare troppo<br />
serio. Ma i viaggi che organizzo io<br />
sono tuttavia più specializzati, non<br />
porto il mio gruppo a Roma per<br />
mostrare loro i Musei Vaticani o<br />
San Pietro in Vincoli, tutte cose<br />
che ha già visto. Viaggio con gente<br />
che già conosce molto bene l’Italia<br />
e che ha frequentato già molti<br />
musei. Cerco <strong>di</strong> trasmettere un<br />
rapporto più intimo e profondo con<br />
il vostro Paese, alla ricerca <strong>di</strong> un<br />
contatto più <strong>di</strong>retto con la terra<br />
visitata. Ultimamente sono stato<br />
in Sicilia, e ho portato un mio gruppo<br />
dai pastori per mangiare nel<br />
loro rifugio la ricotta appena fatta.<br />
Tutte esperienze vivide ed estremamente<br />
interessanti per un tedesco.<br />
Insomma, cerco <strong>di</strong> combinare<br />
l’avventura del mangiare con lo<br />
sfondo storico e culturale. Lo faccio<br />
anche per altre nazioni in giro<br />
per il mondo, ma in questo l’Italia<br />
è il Paese ideale.<br />
Quali mete vanno per la maggiore?<br />
Il turismo culinario ha ridefi nito<br />
la pianta dell’Italia. Per esempio<br />
fi no a qualche anno fa nessuno<br />
viaggiava per motivi <strong>di</strong> stu<strong>di</strong> culturali<br />
in Piemonte, mentre ora basta<br />
menzionare tartufo e Barolo e i<br />
viaggiatori vi ci si fi ondano. Venezia<br />
invece non approfi tta ancora<br />
del turismo culinario, sebbene abbia<br />
anche ottime locande.<br />
Con il turismo culinario mi<br />
capita <strong>di</strong> andare in paesi sperduti<br />
della montagna calabrese, dove<br />
esiste tuttora una cucina arcaica,<br />
ma la meta più apprezzata è la<br />
Sicilia con i suoi prodotti biologici,<br />
l’Umbria e certe zone come il Friuli,<br />
con il suo eccellente vino bianco.<br />
Sono forse le destinazioni poco<br />
conosciute a giovarsi <strong>di</strong> più <strong>di</strong><br />
questo tipo <strong>di</strong> turismo. Un viaggio<br />
in Valtellina per far scoprire ai tedeschi<br />
lo Sfursat, la bresaola e i<br />
pizzoccheri ancora non l’ho organizzato,<br />
ma penso proprio che lo<br />
farò.<br />
Nonostante i tuoi viaggiatori, negli<br />
ultimi tempi si sente parlare <strong>di</strong><br />
un raffreddamento dei rapporti<br />
italo-tedeschi. Qual è la tua opinione?<br />
Secondo me, almeno da parte<br />
tedesca, il rapporto è stato così<br />
intenso che è <strong>di</strong>ffi cile aumentare<br />
questa affi nità. Però è vero, l’Italia<br />
è <strong>di</strong>ventata un po’ noiosa. Dovunque<br />
vai in Germania ti danno pizza<br />
e cappuccino. E poi questa Italia<br />
i<strong>di</strong>lliaca tanto amata dai tedeschi,<br />
dove i pescatori cantano “O sole<br />
mio” e le donne ballano la tarantella<br />
esiste ancora, ma solo in pochi<br />
nascon<strong>di</strong>gli. L’Italia è <strong>di</strong>ventata un<br />
Paese moderno, con una politica<br />
che molti da noi criticano aspramente,<br />
con dei brutti fenomeni<br />
come il rumore ovunque, la troppa<br />
musica dappertutto. Ormai conosciamo<br />
troppo bene l’Italia per<br />
coltivare ancora troppe illusioni.<br />
Peter mostra con<br />
orgoglio la targa del<br />
premio Enit per la<br />
migliore guida<br />
sull’Italia.<br />
Peter proudly shows<br />
the plaque awarded<br />
by Enit, the Italian<br />
Tourist Board, for the<br />
best guidebook<br />
on Italy.<br />
L’Italia per secoli è stata una<br />
fascinosa amante, adesso noi tedeschi<br />
scopriamo che è una tranquilla<br />
casalinga.<br />
Per contro la Germania va sempre<br />
più <strong>di</strong> moda tra i giovani italiani<br />
Per molto tempo il mio Paese<br />
è stato un libro chiuso con sette<br />
sigilli nei confronti degli italiani.<br />
Pochissimi conoscevano la Germania,<br />
tranne gli sfortunati che<br />
sono stati arrestati durante la<br />
guerra, o i professori <strong>di</strong> lingua tedesca<br />
e i Gastarbeiter.<br />
Negli ultimi tempi però sempre<br />
più italiani scoprono il romanticismo<br />
della Germania, pensiamo<br />
ai mercatini <strong>di</strong> Natale, che senza<br />
<strong>di</strong> loro potrebbero chiudere. E così<br />
scoprono anche il buon rapporto<br />
prezzo-qualità degli alberghi tedeschi<br />
e l’affi dabilità dei servizi <strong>di</strong> ristorazione,<br />
compresa una struttura<br />
<strong>di</strong> prezzi limpida e piuttosto affi<br />
dabile.<br />
Per i giovani, nello specifi co,<br />
una cosa molto importante è la<br />
vita notturna. Correggetemi se<br />
sbaglio, ma la mia impressione è<br />
che l’Italia non abbia vita notturna.<br />
Si va a cenare, poi c’è qualche<br />
mega <strong>di</strong>scoteca sull’autostrada,<br />
ma la normalità con cui a<br />
Berlino si va in un club è poco<br />
conosciuta. Da noi non importa<br />
spendere molti sol<strong>di</strong> per fare bella<br />
fi gura, è tutto un po’ più rilassato.<br />
È facile uscire in una città<br />
tedesca senza spendere un capitale,<br />
senza impegnarsi troppo<br />
con un fl irt, senza vestirsi troppo<br />
elegantemente: tutti motivi che<br />
per i giovani possono costituire<br />
un fattore d’interesse.<br />
Divertirsi a Berlino tutto sommato<br />
è più facile che a Roma.<br />
Goethe <strong>di</strong> esperienze bizzarre in<br />
Italia ne ha fatta più d’una. Nei<br />
tuoi viaggi nel nostro Paese quale<br />
aneddotto ti è rimasto particolarmente<br />
caro?<br />
Un vigile urbano in Umbria mi<br />
ha fatto una contravvenzione perché<br />
ho sorpassato con il semaforo<br />
rosso.<br />
Cosa c’è <strong>di</strong> strano?<br />
Ero a pie<strong>di</strong>!<br />
PERSONAGGI 63
Gianrico Tedeschi<br />
o della<br />
vitalità geniale<br />
GIANCARLO ZIZOLA<br />
Scrittore, vaticanista de Il sole-24 Ore<br />
Gianrico Tedeschi ne L’opera da tre sol<strong>di</strong> <strong>di</strong> Bertolt Brecht, regia <strong>di</strong><br />
Giorgio Strehler, stagione 1972/73 (cortesia “Piccolo Teatro <strong>di</strong> Milano”).<br />
Gianrico Tedeschi in The Threepenny Opera by Bertolt Brecht, <strong>di</strong>rected<br />
by Giorgio Strehler, 1972/73 season (courtesy of “Piccolo Teatro of Milan”).<br />
Gianrico Tedeschi or rather, ingenious vitality<br />
As an accomplished actor moves on in age, it is normal to praise<br />
what he was able to achieve. We can always expect something new<br />
from Gianrico Tedeschi, elderly yet still performing onstage. Because<br />
he is theatre and is ready to challenge himself with something that<br />
will unsettle consciousness. His career began when he fell in love with<br />
Ibsen’s “Ghosts”. Then, a solid cultural education and the war caused<br />
a miracle to take place. His magnificent personality as a normal<br />
person blossomed, enabling him to give extraor<strong>di</strong>nary<br />
interpretations. He says he possesses an effective recipe for<br />
happiness at 90 years of age: risking, trying and venturing into new<br />
activities; he does not want to be a teacher and intends to remain a<br />
pupil. And when he is tired, he flees to his house on Lake Orta to<br />
admire the “Monte Rosa” mountain from his garden.<br />
64 PERSONAGGI<br />
EDGARDA FERRI<br />
Scrittrice e giornalista<br />
Nel secondo atto dello<br />
spettacolo La compagnia<br />
degli uomini <strong>di</strong><br />
Edward Bond, andato<br />
in scena all’inizio dello scorso inverno<br />
al “Piccolo Teatro Grassi” <strong>di</strong><br />
Milano con la regia <strong>di</strong> Luca Ronconi,<br />
ci sono stati quin<strong>di</strong>ci minuti in<br />
cui il gesto, la voce, la parola, le<br />
scene, le luci, gli attori, gli spettatori,<br />
insomma, “il teatro”, <strong>di</strong>pendevano<br />
esclusivamente, spasmo<strong>di</strong>camente<br />
da Gianrico Tedeschi.<br />
Luigi Ciminaghi<br />
Fragile e feroce vecchietto impeccabilmente<br />
vestito <strong>di</strong> grigio, l’industriale<br />
Oldfi eld si liberava fi nalmente<br />
dell’atroce segreto del giorno in<br />
cui sua moglie fi ngeva <strong>di</strong> partorire<br />
un fi glio, in realtà abbandonato<br />
dalla madre sui gra<strong>di</strong>ni della loro<br />
casa e da loro adottato. Accasciato<br />
su una poltrona, le braccia abbandonate,<br />
il capo riverso, gli occhi<br />
svuotati dall’orrore, Tedeschi<br />
era l’immagine stessa <strong>di</strong> un dolore<br />
represso per tutta la vita, la <strong>di</strong>chiarazione<br />
<strong>di</strong> un fallimento totale, la<br />
nostalgia <strong>di</strong> un amore paterno<br />
calpestato e sconvolto dalla passione<br />
per il potere, il successo, il<br />
denaro. «Ho dato qualcosa da pensare<br />
a chi è venuto ad ascoltarmi?
Marcello Norberth<br />
– domanda alla fi ne, stremato e<br />
ansante, ma ancora vispo e vivace<br />
–. Che senso avrebbe, altrimenti,<br />
questo mio star sulle scene a<br />
novant’anni compiuti? (91 il 20<br />
aprile 2011). Alla mia età, potrei<br />
starmene benissimo nella mia casa<br />
sul lago d’Orta. Ho una famiglia<br />
che adoro, mia moglie, le mie fi -<br />
glie, i miei nipotini. Una marea <strong>di</strong><br />
ricor<strong>di</strong>. Un pubblico che non ha<br />
mai smesso <strong>di</strong> amarmi. Ma se c’è<br />
un testo capace <strong>di</strong> mettere in guar<strong>di</strong>a<br />
la coscienza, che la induce a<br />
rifl ettere, la scuote, la cambia, allora<br />
io sono pronto. Ho fatto anche<br />
molto ridere, nel mio passato. Ho<br />
persino cantato e ballato. Ma arrivato<br />
fi n qui, e incre<strong>di</strong>bilmente felice<br />
<strong>di</strong> vivere tanto a lungo, penso <strong>di</strong><br />
non avere altro compito oltre a<br />
quello <strong>di</strong> contribuire all’esame, alla<br />
rifl essione, alla me<strong>di</strong>tazione sul<br />
senso della vita».<br />
È molto elegante; lungo car<strong>di</strong>gan<br />
giallo senape, camicia <strong>di</strong> spesso<br />
cotone color antracite, pantaloni<br />
<strong>di</strong> velluto a coste marrone: un<br />
gentiluomo <strong>di</strong> campagna cui manca<br />
soltanto la pipa. È anche molto<br />
bello. Il volto gloriosamente segnato<br />
dagli anni, il naso forte, la pelle<br />
chiarissima, i capelli bianchi lunghi<br />
e spettinati: come un artista, un<br />
architetto, un pittore. Ha una voce<br />
calda, suadente, avvolgente; e uno<br />
sguardo vivace, arguto, curioso,<br />
soprattutto attento, come oramai<br />
raramente succede in una società<br />
che parla, che parla, e non ascolta<br />
mai. E per fi nire, è fantasticamente<br />
educato: senza piaggerie, me-<br />
Un cast tutto<br />
maschile per<br />
La compagnia degli<br />
uomini <strong>di</strong> Edward<br />
Bond, regia <strong>di</strong> Luca<br />
Ronconi. In questo<br />
dramma Tedeschi<br />
veste i panni <strong>di</strong> un<br />
grande finanziere<br />
(cortesia “Piccolo<br />
Teatro <strong>di</strong> Milano”).<br />
An all-male cast for<br />
In the company of<br />
men by Edward<br />
Bond, <strong>di</strong>rected by<br />
Luca Ronconi. In this<br />
drama, Tedeschi<br />
plays the role of an<br />
important financier<br />
(courtesy “Piccolo<br />
Teatro of Milan”).<br />
Marcello Norberth<br />
lensaggini, complimenti superfl ui.<br />
Un’educazione solida, <strong>di</strong> fondo,<br />
non raccattata lungo la strada,<br />
basata sul rispetto della persona,<br />
sulla misura <strong>di</strong> sé, sulla moderata<br />
ironia, la gestualità leggera: in un<br />
mondo <strong>di</strong> tronfi e tromboni, una<br />
splen<strong>di</strong>da, esemplare persona<br />
normale.<br />
Novantun anni tutti da raccontare.<br />
«Dove c’entra, e molto,<br />
anche molta fortuna – ammette<br />
con un sorriso che ancora sa <strong>di</strong><br />
sorpresa –. Ho sempre pensato a<br />
tutto quello che è accaduto nella<br />
mia lunga vita guardando anche<br />
dalla sua opposta visuale. E se,<br />
per esempio, a nove anni non fossi<br />
rimasto folgorato dagli Spettri <strong>di</strong><br />
Ibsen, avrei tanto amato il teatro?<br />
Mio padre era un commesso <strong>di</strong><br />
negozio tipicamente e borghesemente<br />
milanese, che lavorava sodo<br />
per migliorare la posizione sociale<br />
dei fi gli mandandoli a scuola.<br />
Ero il più piccolo <strong>di</strong> quattro fratelli,<br />
lui sognava che <strong>di</strong>ventassi geometra,<br />
o ragioniere. Si era istruito da<br />
solo, amava leggere e andare a<br />
teatro. Ogni domenica pomeriggio<br />
ci faceva vestire tutti in or<strong>di</strong>ne e ci<br />
portava all’“Olimpia”, <strong>di</strong> fi anco al<br />
Castello Sforzesco. Mi sono mortalmente<br />
annoiato fi no a quando<br />
PERSONAGGI 65
non ho visto Ermete Zacconi interpretare<br />
quella tremenda trage<strong>di</strong>a<br />
che è Spettri. Una rivelazione. Da<br />
quel momento, ho incominciato ad<br />
andare a teatro da solo. Sgusciavo<br />
al mio posto, solitamente in loggione,<br />
e col fi ato sospeso mi preparavo<br />
a quel magico, incomparabile<br />
incanto che è la lenta e silenziosa<br />
apertura del sipario. Per molto<br />
tempo ho amato il teatro come<br />
spettatore. Capivo che attraverso<br />
la sua parola imparavo a vivere e<br />
<strong>di</strong>ventavo grande. Intanto stu<strong>di</strong>avo<br />
magistero, e per un paio d’anni ho<br />
insegnato: scuola “Schiaparelli”<br />
per periti industriali; e guarda il<br />
caso, esattamente dove adesso<br />
troneggia la gran mole rossa del<br />
“Piccolo Teatro Strehler”. Nel<br />
1940 è scoppiata la guerra. Nel<br />
1941 mi hanno mandato sulle<br />
montagne greche a scovare i partigiani<br />
ribelli. Iscritto alla facoltà <strong>di</strong><br />
Filosofi a all’Università Cattolica,<br />
avevo messo nello zaino tre libri:<br />
“la fi losofi a me<strong>di</strong>evale”, la “fi losofi<br />
a greca”, la “fi losofi a moderna”<br />
nella speranza <strong>di</strong> trovare il tempo<br />
per prepararmi a un esame».<br />
E la fortuna?<br />
«La fortuna si presenta in un<br />
modo bizzarro. Dopo l’armistizio<br />
dell’8 settembre 1943, i tedeschi<br />
ci catturarono a Volos. Dopo averci<br />
fatto passare per due lager, ci<br />
hanno chiuso defi nitivamente in<br />
66 PERSONAGGI<br />
L’attore ne Arlecchino<br />
servitore <strong>di</strong> due<br />
padroni <strong>di</strong> Carlo<br />
Goldoni, regia <strong>di</strong><br />
Giorgio Strehler,<br />
stagione 1972/73<br />
(cortesia “Piccolo<br />
Teatro <strong>di</strong> Milano”).<br />
The actor in<br />
Harlequin Servant of<br />
two masters by Carlo<br />
Goldoni, <strong>di</strong>rected by<br />
Giorgio Strehler,<br />
1972/73 season<br />
(courtesy “Piccolo<br />
Teatro of Milan”).<br />
quello <strong>di</strong> Sandbostel, in Germania.<br />
Avevo ventitré anni, l’uffi ciale più<br />
giovane del campo. I maggiori e i<br />
colonnelli che mi guardavano come<br />
se fossi un bambino. Divisi dai<br />
soldati, ci hanno messo davanti a<br />
una scelta: lavorare per loro scavando<br />
trincee o aggiustando le<br />
strade, o iscriverci alla Repubblica<br />
Sociale <strong>di</strong> Salò. Soltanto pochi dei<br />
nostri sono tornati in Italia come<br />
“repubblichini”. Quasi tutti abbiamo<br />
preferito non “collaborare” con<br />
i tedeschi; e come punizione, una<br />
baracca recintata col fi lo spinato,<br />
insulti e maltrattamenti, brodaglia<br />
e freddo, inattività forzata, paura e<br />
fame. Soprattutto fame».<br />
A questo punto, gli occhi <strong>di</strong><br />
Gianrico Tedeschi <strong>di</strong>ventano due<br />
piccoli, vivi, abbaglianti punti <strong>di</strong><br />
luce. I prigionieri non hanno niente<br />
altro da fare che rattoppare i loro<br />
vestiti e leggere i libri che si sono<br />
portati da casa. A qualcuno viene<br />
in mente <strong>di</strong> vuotare gli zaini e formare<br />
una biblioteca. I prigionieri<br />
sono me<strong>di</strong>ci, avvocati, insegnanti,<br />
pittori, musicisti, poeti, scrittori. La<br />
biblioteca si arricchisce delle voci<br />
più <strong>di</strong>sparate: me<strong>di</strong>cina, <strong>di</strong>ritto,<br />
scienza, letteratura, arte, fi losofi a.<br />
Un racconto bellissimo: la biblioteca<br />
nel lager. I prigionieri hanno<br />
tanto tempo. Quando hanno fi nito<br />
<strong>di</strong> leggere, non sanno più che cosa<br />
<strong>di</strong>rsi: si sono già detti tutto. Qual-<br />
Luigi Ciminaghi<br />
cuno propone <strong>di</strong> mettere in pie<strong>di</strong><br />
una compagnia teatrale. Fanno<br />
tutto da soli: il palcoscenico, le<br />
scene, i costumi. E fanno <strong>di</strong> tutto:<br />
prosa seria, varietà, farsa, comme<strong>di</strong>a,<br />
barzellette, satira contro i<br />
tedeschi. Quando se ne accorgono,<br />
i tedeschi incominciano a fare<br />
irruzioni or<strong>di</strong>nando <strong>di</strong> sospendere<br />
lo spettacolo e punendo i responsabili.<br />
Ma i responsabili hanno<br />
imparato l’antifona: mettono fuori<br />
dalla baracca uno dei loro, che<br />
lancia l’allarme quando li vede arrivare;<br />
e il programma cambia <strong>di</strong><br />
colpo. Una volta, mettono in scena<br />
Enrico IV <strong>di</strong> Pirandello. Ruolo <strong>di</strong>ffi -<br />
cile, in bilico fra la pazzia e la ragione.<br />
Gianrico Tedeschi si offre:<br />
ama il teatro <strong>di</strong> Pirandello più <strong>di</strong><br />
ogni altra cosa, e solo per poche<br />
sere ha provato l’emozione <strong>di</strong> stare<br />
sulla scena. Aveva do<strong>di</strong>ci anni.<br />
Recitava nella sala parrocchiale<br />
sotto casa, in via Re<strong>di</strong>. Sulla strada,<br />
i ragazzini gridavano: «Gent,<br />
gent, vegnì a vedè el teater». Gente,<br />
gente, venite a vedere il teatro.<br />
Dopo Enrico IV, il piccolo uffi ciale<br />
prigioniero interpreta anche L’uomo<br />
dal fi ore in bocca. Poi, torna a<br />
Spettri <strong>di</strong> Ibsen, il suo primo gran<strong>di</strong>ssimo<br />
amore. Poi, comme<strong>di</strong>e<br />
scritte sul momento dal compagno<br />
<strong>di</strong> prigionia Giovannino Guareschi.<br />
Nella baracca del lager trasformata<br />
in un palcoscenico, la sua formidabile<br />
vena grottesca, il suo misurato<br />
ma profon<strong>di</strong>ssimo senso del<br />
tragico, la sua irresistibile arguzia<br />
lombarda inchiodano gli spettatori<br />
che, seduti per terra e avvolti <strong>di</strong><br />
stracci, <strong>di</strong>menticano per un paio<br />
d’ore la fame. Il poeta Clemente<br />
Rebora, che lo segue con attenzione,<br />
alla fi ne gli <strong>di</strong>ce: «Fossi in te,<br />
una volta tornato, proverei a fare<br />
l’attore. La “stoffa” ce l’hai».<br />
Infatti. Una carriera strepitosa.<br />
Successi in ogni genere e categoria<br />
dello spettacolo. Irresistibile<br />
sul palcoscenico, al cinema, in<br />
televisione, nella pubblicità. Irresistibile<br />
pedante in My fair Lady<br />
nella parte del professor Higgins<br />
che insegna a parlare decentemente<br />
all’impertinente fi oraia. Problematicamente<br />
sottile ne La rigenerazione<br />
<strong>di</strong> Svevo. Beffardo ne Il<br />
maggiore Barbara <strong>di</strong> Shaw. Memo
abile nel fi lm <strong>di</strong> Salce Il federale,<br />
nei panni del poeta fascista creduto<br />
morto eroicamente al fronte, e<br />
invece nascosto in soffi tta. Impareggiabile<br />
nella comme<strong>di</strong>a musicale<br />
Enrico ’61 <strong>di</strong> Garinei e Giovannini.<br />
Gran<strong>di</strong> registi teatrali: da Visconti,<br />
Strehler, Squarzina «a Luca<br />
Ronconi, mi mancava, e che ammiro<br />
tantissimo perché affronta e<br />
sperimenta tutto ciò che è nuovo<br />
e “<strong>di</strong>verso”. Quando mi ha offerto<br />
la parte <strong>di</strong> protagonista ne La compagnia<br />
degli uomini gli ho risposto:<br />
eccomi, fai <strong>di</strong> me quello che vuoi»<br />
ridacchia, ilare e quieto. «Io sono<br />
un vecchio signore con delle care<br />
abitu<strong>di</strong>ni nella vita privata, ma con<br />
gli occhi rivolti al futuro e la curiosità<br />
intellettuale per quello che è<br />
nuovo, non sperimentato, non già<br />
scontato. Del resto, alla mia età,<br />
cercare <strong>di</strong> accontentare il gusto<br />
del pubblico solo per poter stare<br />
ancora sul palcoscenico, sarebbe<br />
come non aver dato un senso alla<br />
propria vita. E io so come fare per<br />
vivere bene a novant’anni passati:<br />
non devo andare per strade sulle<br />
quali ho già camminato, ma rischiare,<br />
provare, avventurarmi per<br />
quelle nuove. Questo signifi ca non<br />
aggrapparsi nostalgicamente al<br />
passato, ma progettare il futuro<br />
come se la vita dovesse durare<br />
ancora a lungo. Non devo fare il<br />
maestro, ma continuare a fare<br />
l’allievo».<br />
Quarant’anni fa si era promesso:<br />
«Quando sarò vecchio reciterò<br />
I <strong>di</strong>aloghi <strong>di</strong> Platone». Scuote<br />
la testa, ma non perde il sorriso:<br />
«Promessa mancata per ragioni <strong>di</strong><br />
carattere pratico, perché solo i<br />
Teatri Stabili possono garantire la<br />
messa in scena <strong>di</strong> un testo fi losofi<br />
co per un pubblico <strong>di</strong> gusti e palato<br />
fi ni. Nella mia lunga carriera,<br />
però, quasi sempre ho lavorato in<br />
compagnie <strong>di</strong> giro, dove si cambia<br />
piazza quasi ogni sera e non si fa<br />
in tempo a prepararsi il pubblico<br />
giusto per offrirgli qualcosa che io<br />
chiamo “un cibo per l’anima”. Ma<br />
oggi, questo sarebbe il momento.<br />
E io sono pronto». Allarga un poco<br />
le braccia, alza le spalle: «Altrimenti,<br />
l’alternativa è il riposo. Che comunque<br />
mi manca. Ho sempre<br />
lavorato tantissimo. Anche in estate.<br />
Anzi, soprattutto d’estate nei<br />
gran<strong>di</strong> meravigliosi teatri all’aperto<br />
Gianrico Tedeschi<br />
con la moglie<br />
Marianella Laszlo e<br />
Walter Mramor in<br />
un’immagine <strong>di</strong><br />
scena de Le ultime<br />
lune <strong>di</strong> Furio Bordon.<br />
Lo spettacolo – una<br />
produzione <strong>di</strong> a.<br />
ArtistiAssociati <strong>di</strong><br />
Gorizia – ha girato<br />
per <strong>di</strong>versi anni<br />
toccando moltissime<br />
piazze italiane.<br />
Gianrico Tedeschi<br />
with his wife<br />
Marianella Laszlo<br />
and Walter Mramor<br />
in a stage shot from<br />
Le ultime lune by<br />
Furio Bordon. The<br />
performance<br />
– produced by<br />
a.ArtistiAssociati<br />
of Gorizia – was on<br />
tour for several years<br />
and was staged in<br />
very many squares<br />
thoughout Italy.<br />
<strong>di</strong> Taormina, Ostia, Siracusa. Da<br />
qualche anno lavoro solo se mi fa<br />
piacere, godendomi finalmente<br />
lunghi e beati momenti <strong>di</strong> ozio<br />
nella mia casa sul lago d’Orta insieme<br />
a mia moglie, al mio camino,<br />
ai miei cani. Sono stato un<br />
grande camminatore, amo la montagna<br />
e fi nché ho potuto l’ho attraversata<br />
palmo a palmo. Adesso mi<br />
accontento <strong>di</strong> ammirare il Rosa dal<br />
giar<strong>di</strong>no <strong>di</strong> casa mia, <strong>di</strong> passeggiare<br />
nei prati e <strong>di</strong> bere un buon bicchiere<br />
<strong>di</strong> vino con Marianella, la<br />
mia moglie meravigliosa». Marianella<br />
Laszlo è una signora molto<br />
più giovane <strong>di</strong> lui, molto bella e dai<br />
mo<strong>di</strong> squisiti. Un’attrice brillante e<br />
<strong>di</strong> lunga carriera che da qualche<br />
anno ha rinunciato al teatro per<br />
non lasciare il marito nemmeno un<br />
momento. Lo segue come un’ombra<br />
fi no a quando non entra in<br />
scena, lo <strong>di</strong>fende dalle fatiche, gli<br />
compera i libri da leggere, lo aspetta<br />
in camerino. Amorosamente e<br />
<strong>di</strong>scretamente. «Oggi – sussurra<br />
Gianrico Tedeschi – Marianella è la<br />
mia vita». E solo qui, per un attimo,<br />
la commozione gli fa tremare la<br />
voce.<br />
a.ArtistiAssociati <strong>di</strong> Gorizia<br />
PERSONAGGI 67
Nel secondo centenario della nascita<br />
Franz e il suo doppio:<br />
i gemelli Liszt<br />
MELANIA G. MAZZUCCO<br />
Scrittrice<br />
Alti, snelli, la pelle trasparente,<br />
gli occhi chiari,<br />
lunghi capelli bion<strong>di</strong>,<br />
incarnazione ideale<br />
del la bellezza romantica, Franz<br />
Liszt e Marie d’Agoult sembravano<br />
gemelli a tutti coloro che li conobbero<br />
nei loro anni <strong>di</strong> pellegrinaggio,<br />
per parafrasare il titolo delle composizioni<br />
musicali che lui scrisse in<br />
quel periodo. La defi nizione impropria<br />
li lusingava: si sentivano complementari,<br />
speculari e in<strong>di</strong>spensabili<br />
l’uno all’altra. In effetti, non<br />
solo non erano gemelli, ma fi no al<br />
giorno in cui si incontrarono, in un<br />
salotto <strong>di</strong> Parigi, non avrebbero<br />
potuto essere più <strong>di</strong>versi.<br />
Una sera <strong>di</strong> <strong>di</strong>cembre del<br />
1832 la marchesa du Vayer <strong>di</strong>ede<br />
un ricevimento. Marie, che si proclamava<br />
stanca del bel mondo,<br />
non voleva andarci. L’attrazione<br />
era il giovane pianista che incantava<br />
le platee d’Europa: salutato agli<br />
esor<strong>di</strong> come “il nuovo Mozart”, era<br />
ormai considerato il Paganini del<br />
pianoforte per la sua tecnica pro<strong>di</strong>giosa<br />
– alcuni <strong>di</strong>cevano demoniaca.<br />
Era l’immagine stessa del musicista<br />
romantico. All’ultimo minuto,<br />
Marie cambiò idea e si presentò<br />
al ricevimento, al braccio dello<br />
scrittore Eugène Sue. Liszt si esibì,<br />
e fu esibito come un “cane sapiente”<br />
da salotto (così, crudamente,<br />
lui stesso si defi niva). I<br />
nobili lo applau<strong>di</strong>vano, ma lo consideravano<br />
un <strong>di</strong>amante grezzo,<br />
stravagante e malvestito, e sorri-<br />
68 PERSONAGGI<br />
devano della sua conversazione<br />
astrusa e delle sue pretese fi losofi<br />
che. Cinque o sei uomini follemente<br />
innamorati della contessa<br />
la corteggiarono tutta la sera, e lei,<br />
pur tenendoli a bada, li incoraggiò<br />
perché era, secondo una testimone,<br />
una “feroce civetta”. Ma benché<br />
fl irtasse con gli altri, rimase<br />
colpita da Liszt, «la persona più<br />
straor<strong>di</strong>naria che avessi mai visto»<br />
– come scrisse poi. «Alto, eccessivamente<br />
magro, il volto pallido,<br />
gran<strong>di</strong> occhi ver<strong>di</strong>, una fi sionomia<br />
sofferente e vigorosa, l’aria <strong>di</strong>stratta,<br />
inquieta, come un fantasma<br />
che aspettasse il rintocco dell’ora<br />
in cui doveva tornare tra le ombre».<br />
Ma anche Liszt notò lei. Gli parve<br />
bellissima, come una Lorelei, slanciata,<br />
portamento aristocratico,<br />
affascinante, mo<strong>di</strong> e toilette <strong>di</strong><br />
raffi nata eleganza, la testa orgogliosa<br />
coperta da una cascata <strong>di</strong><br />
capelli bion<strong>di</strong> che le ricadevano<br />
sulle spalle come una doccia<br />
d’oro, un profi lo da dea greca, che<br />
contrastava in modo curioso con<br />
la sognante malinconia impressa<br />
sul suo volto. Alla fi ne del ricevimento,<br />
Marie d’Agoult uscì dalla<br />
porta principale, e Franz Liszt, incassato<br />
il suo onorario, dalla porta<br />
della servitù. Così imponevano le<br />
abitu<strong>di</strong>ni e i pregiu<strong>di</strong>zi dell’epoca,<br />
l’abisso sociale che separava una<br />
contessa e un musicista.<br />
Quella sera, Franz Liszt aveva<br />
ventun anni. Era nato nel 1811<br />
a Rai<strong>di</strong>ng, citta<strong>di</strong>na dell’Impero<br />
Austroungarico. È noto come il più<br />
famoso musicista ungherese, ma<br />
il padre era <strong>di</strong> origine tedesca e la<br />
madre austriaca, e Rai<strong>di</strong>ng oggi si<br />
Ritratto giovanile <strong>di</strong><br />
Franz Liszt, opera <strong>di</strong><br />
Jean Auguste<br />
Dominique Ingres.<br />
Questi, <strong>di</strong>rettore<br />
dell’Accademia <strong>di</strong><br />
Francia, aiutò il<br />
compositore a<br />
inserirsi nell’ambiente<br />
romano.<br />
A youthful portrait of<br />
Franz Liszt, by Jean<br />
Auguste Dominique<br />
Ingres. The latter,<br />
<strong>di</strong>rector of the<br />
Academy of France,<br />
helped the composer<br />
settle into Roman<br />
circles.<br />
trova in Austria. Adam Liszt era<br />
amministratore al servizio dei principi<br />
Esterházy, ma avrebbe voluto<br />
essere musicista ed era un buon<br />
<strong>di</strong>lettante: insegnò al fi glio a suonare<br />
il piano fi n dai sei anni e poiché<br />
il bambino, nonostante la salute<br />
cagionevole, era straor<strong>di</strong>nariamente<br />
dotato, vide la possibilità <strong>di</strong><br />
fare <strong>di</strong> lui l’artista che non aveva<br />
potuto essere. Lo sottopose a un<br />
duro addestramento e già a nove<br />
anni lo fece esibire in pubblico. Gli<br />
procurò una borsa <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o per<br />
perfezionarsi a Vienna, con Carl<br />
Czerny e Antonio Salieri. Il bambino<br />
pro<strong>di</strong>gio aveva interrotto la carriera<br />
concertistica per approfon<strong>di</strong>re<br />
la sua cultura musicale, e a<br />
Franz and his double; the Liszt twins<br />
All artists lead tormented and unique lives, and this was<br />
particularly true of artists in the Romantic period. F. Liszt is no<br />
exception, with his cursed liaison with Marie d’Augolt. He was a<br />
successful concerto performer and she was a countess: two<br />
<strong>di</strong>fferent social backgrounds, but they had a single vocation to be<br />
martyrs of their sentiments. She left her husband and children<br />
because she believed that she could become the muse of a genius<br />
of music. He was apparently overwhelmed by emotions but was<br />
actually far more concrete in his calculations for life. Together they<br />
lived an intense phase of wandering and genuine love. Then the<br />
vanity of the acclaimed musician who loved being courted and<br />
adulated antagonized her once and for all. A separation which was<br />
more or less consensual put an end to the relationship of the<br />
“prisoners of love” which had seemed practically perfect.
Parigi era arrivato a do<strong>di</strong>ci anni per<br />
stu<strong>di</strong>are al conservatorio. L’accesso<br />
gli fu negato perché straniero,<br />
ma si de<strong>di</strong>cò a stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> poesia, fi -<br />
losofi a e sociologia, approfondendo<br />
nel frattempo le ricerche sui<br />
timbri pianistici (il fabbricante<br />
Erard gli mise a <strong>di</strong>sposizione un<br />
pianoforte speciale da lui inventato,<br />
che garantiva la rapida ripetizione<br />
<strong>di</strong> una singola nota). In breve<br />
tempo <strong>di</strong>venne una celebrità e gli<br />
aristocratici <strong>di</strong> Parigi lo assunsero<br />
come maestro <strong>di</strong> piano per le loro<br />
fi glie. La morte del padre quando<br />
aveva se<strong>di</strong>ci anni e la sfortunata<br />
passione per la fi glia <strong>di</strong> un conte<br />
della corte <strong>di</strong> Carlo X, Caroline<br />
Saint-Cricq, <strong>di</strong> cui si innamorò, ricambiato,<br />
ma che il padre costrinse<br />
a sposare un altro, lo segnarono.<br />
Cercando <strong>di</strong> fronteggiare le<br />
sue insicurezze, aveva in<strong>di</strong>viduato<br />
un padre spirituale nell’abate socialista<br />
Lamennais, e una sorta <strong>di</strong><br />
madre vicaria nell’amante Adèle<br />
de la Prunarède, quin<strong>di</strong>ci anni più<br />
grande <strong>di</strong> lui. In quel <strong>di</strong>cembre del<br />
1832 era un concertista apprezzato,<br />
ma come compositore era solo<br />
una promessa e aveva lavorato<br />
quasi esclusivamente a parafrasi,<br />
trascrizioni per piano o pezzi <strong>di</strong><br />
bravura strumentali alla sua carriera<br />
<strong>di</strong> virtuoso.<br />
Ritratto <strong>di</strong> Marie<br />
d’Agoult, opera <strong>di</strong><br />
Théodore<br />
Chassériau.<br />
Portrait of Marie<br />
d’Agoult, by<br />
Théodore Chassériau.<br />
Da sinistra:<br />
Johann Hummel<br />
e Alfred de Vigny.<br />
Il primo fu un valido<br />
insegnante <strong>di</strong> musica<br />
per Marie d’Agoult;<br />
il secondo, poeta, ne<br />
fu invaghito, ma il<br />
<strong>di</strong>vario sociale gli<br />
impe<strong>di</strong>va <strong>di</strong> coltivare<br />
il suo amore per la<br />
nobildonna.<br />
From the left: Johann<br />
Hummel and Alfred<br />
de Vigny.<br />
The former was an<br />
excellent music<br />
teacher for Marie<br />
d’Agoult;<br />
The latter, a poet,<br />
was in love with her,<br />
but the social<br />
<strong>di</strong>fference prevented<br />
him from cultivating<br />
his love for the<br />
noblewoman.<br />
In quel <strong>di</strong>cembre 1832, Marie<br />
Catherine Adelaide de Flavigny<br />
contessa d’Agoult aveva invece<br />
ventisette anni e una vita intera<br />
<strong>di</strong>etro le spalle. Era nata a Francoforte<br />
nel <strong>di</strong>cembre del 1805: a<br />
mezzanotte, raccontò sempre (anche<br />
se non era vero), perché si riteneva<br />
che “i bambini della mezzanotte”<br />
fossero speciali, <strong>di</strong>versi.<br />
Anche lei era fi glia <strong>di</strong> due mon<strong>di</strong>,<br />
aveva due patrie e molte lingue<br />
(con Liszt avrebbe corrisposto in<br />
inglese e in francese, riservando il<br />
tedesco per le frasi più tenere). I<br />
de Flavigny erano nobili fin dal<br />
Me<strong>di</strong>oevo e avevano dato alla<br />
Francia cortigiani, orientalisti, militari:<br />
due <strong>di</strong> loro erano stati ghigliottinati<br />
durante la Rivoluzione. Il padre<br />
Alexandre, paggio della contessa<br />
<strong>di</strong> Provenza, fedele alla famiglia<br />
reale era andato in esilio in Germania:<br />
a Francoforte aveva sposato<br />
Marie Bethmann, fi glia <strong>di</strong> ricchissimi<br />
banchieri <strong>di</strong> origine olandese,<br />
da cui aveva avuto due fi gli, Maurice<br />
e Marie. Nel 1809 i Flavigny<br />
erano tornati in Francia: d’estate<br />
vivevano in un castello a Mortier,<br />
vicino a Tours, dove Alexandre de<br />
Flavigny passava il tempo cacciando<br />
e intrattenendo i membri delle<br />
famiglie ultrarealiste vicine alla<br />
cerchia del conte d’Artois, d’inverno<br />
vivevano a Parigi. Fino al 1818,<br />
mentre Liszt bambino stu<strong>di</strong>ava<br />
pianoforte in una oscura citta<strong>di</strong>na<br />
dell’Impero, Marie stu<strong>di</strong>ava storia,<br />
geografi a e mitologia e leggeva<br />
avidamente i classici della letteratura<br />
col padre, nel castello <strong>di</strong> Mortier.<br />
Imparava la danza, il porta-<br />
mento, e le regole della società.<br />
Ma anche lei prendeva lezioni <strong>di</strong><br />
piano, e anche lei ebbe buoni maestri<br />
(più tar<strong>di</strong> fu Johann Hummel a<br />
darle lezioni avanzate <strong>di</strong> musica).<br />
Come Liszt, anche Marie perse<br />
presto il padre: e a tre<strong>di</strong>ci anni<br />
dovette trasferirsi in Germania con<br />
la madre. Se tornò a Parigi fu solo<br />
perché lì una Flavigny aveva migliori<br />
prospettive matrimoniali. La madre<br />
la spedì un anno al convento<br />
delle suore del Sacro Cuore, e lì la<br />
ragazza, già confusa fra il cattolicesimo<br />
del padre e l’austero luteranesimo<br />
della nonna materna,<br />
cominciò a <strong>di</strong>staccarsi dalla religione.<br />
A <strong>di</strong>ciassette anni aveva già<br />
debuttato con successo in società,<br />
ed era pronta per il matrimonio.<br />
La dote consistente e la prospettiva<br />
<strong>di</strong> ere<strong>di</strong>tare alla morte della<br />
madre più <strong>di</strong> un milione <strong>di</strong> franchi<br />
facevano <strong>di</strong> lei uno dei migliori<br />
partiti sul mercato parigino. L’amore<br />
era fuori causa e gli innamorati<br />
senza troppi mezzi si defi larono: il<br />
poeta Alfred de Vigny, invaghito <strong>di</strong><br />
lei, non poteva permettersela.<br />
Il fratello e la madre le presentarono<br />
conti, ammiragli, marchesi.<br />
Marie non sembrava interessata.<br />
Coltivava il sogno neanche<br />
troppo segreto <strong>di</strong> farsi un nome<br />
come musicista e scrittrice. Da<br />
bambina, durante una visita ai<br />
parenti, aveva incontrato Goethe.<br />
Il vecchio maestro le aveva dato<br />
un buffetto sulla testa: e lei considerava<br />
quel gesto una bene<strong>di</strong>zione.<br />
Il 16 maggio 1827, nella chiesa<br />
dell’Assumption – presente<br />
tutta la nobiltà parigina – sposò<br />
PERSONAGGI 69
Charles Louis Constance, conte<br />
d’Agoult. Gli portava in dote<br />
260.000 franchi (circa un milione<br />
duecentomila euro). Vent’anni più<br />
anziano <strong>di</strong> lei, basso, con le gambe<br />
arcuate, clau<strong>di</strong>cante dopo una<br />
ferita in guerra, il monarchico d’Agoult,<br />
già colonnello <strong>di</strong> cavalleria,<br />
era primo scu<strong>di</strong>ero della duchessa<br />
d’Angoulême: una specie <strong>di</strong> domestico<br />
del re Luigi XVIII, cui bastava<br />
bofonchiare “d’ag, d’ag”, perché<br />
d’Agoult gli porgesse la tabacchiera.<br />
Sposandolo, Marie <strong>di</strong>veniva<br />
dama <strong>di</strong> corte della delfi na. Per lui,<br />
fu un matrimonio d’amore. Per lei,<br />
un dovere. Andò a vivere sul Quai<br />
Malaquais, all’angolo con rue de<br />
Beaune, frequentò le serate <strong>di</strong><br />
corte, rispettando la rigida e vacua<br />
etichetta, ricamando nel cerchio<br />
delle dame <strong>di</strong> compagnia sedute<br />
intorno alla delfi na, mentre dall’altra<br />
parte della sala il re giocava a<br />
scacchi, aprendo bocca solo dopo<br />
che la duchessa aveva pronunciato<br />
la sua non memorabile battuta<br />
e solo per <strong>di</strong>re a sua volta banalità.<br />
Intanto, aprì il suo primo salon,<br />
imparò a intrattenere gli ospiti e a<br />
lusingare il loro amor proprio: per<br />
cinque anni fu ammirata in società<br />
per il suo fascino, l’eleganza, l’abilità<br />
musicale e un’insolita capacità<br />
<strong>di</strong> scrivere. Il suo salon non era<br />
importante, perché privo <strong>di</strong> ospiti<br />
davvero celebri, ma era aperto ai<br />
musicisti: vi erano passati Malibran<br />
e Rossini, mentre Marie stessa<br />
cantava e suonava il piano.<br />
Però d’Agoult era un estraneo, e<br />
per giunta le sue aspirazioni politiche<br />
e mondane erano state <strong>di</strong>strutte<br />
dalla Rivoluzione <strong>di</strong> luglio,<br />
nel 1830, che aveva segnato la<br />
fi ne dei Borboni. Con la dote della<br />
moglie, d’Agoult acquistò un piccolo<br />
castello a Croissy nella Brie, e<br />
andò precocemente in pensione.<br />
Marie leggeva romanzi romantici,<br />
inquieta, infelice, frustrata nelle<br />
sue ambizioni artistiche, corrosa<br />
dalla malinconia e in attesa che<br />
qualcosa le incen<strong>di</strong>asse il cuore.<br />
Un amico l’avrebbe descritta come<br />
una spolverata <strong>di</strong> neve su un lago<br />
<strong>di</strong> lava: un vulcano dormiente,<br />
pronto a esplodere.<br />
Il giorno dopo il ricevimento,<br />
la sagace marchesa du Vayer fece<br />
70 PERSONAGGI<br />
Un giovane e<br />
affascinante Franz<br />
Liszt. Con lui il<br />
pianoforte assurge<br />
alla sua vera<br />
<strong>di</strong>mensione: egli ne<br />
comprende infatti<br />
tutte le risorse e ne<br />
sfrutta le<br />
potenzialità.<br />
A young and<br />
fascinating Franz<br />
Liszt. With him the<br />
piano rose to its real<br />
<strong>di</strong>mension: he<br />
understood all its<br />
resources and made<br />
the most of all its<br />
potential.<br />
visita alla contessa d’Agoult, lodò<br />
il genio del suo giovane ospite e le<br />
suggerì <strong>di</strong> invitarlo nel suo salon.<br />
Marie scrisse due volte a Liszt una<br />
lettera d’invito, ma lui, orgogliosamente,<br />
si fece pregare e solo la<br />
terza volta si presentò. Il musicista<br />
e la contessa parlarono <strong>di</strong> Bibbia,<br />
<strong>di</strong> Shakespeare, <strong>di</strong> Goethe, Chateaubriand,<br />
Hugo, Sant’Agostino e<br />
<strong>di</strong> altri libri che avevano letto – o<br />
che fi ngevano <strong>di</strong> avere letto (giacché<br />
Liszt, che a causa della sua<br />
infanzia randagia aveva il complesso<br />
<strong>di</strong> una cultura <strong>di</strong>sorganica e<br />
frammentaria, voleva mostrarsi<br />
all’altezza della colta signora). Lo<br />
straniero parlò <strong>di</strong> cristianesimo<br />
sociale all’aristocratica reazionaria,<br />
e la convertì alla religione<br />
dell’umanità. Nel giro <strong>di</strong> poche<br />
settimane <strong>di</strong>vennero inseparabili e<br />
nella primavera del 1833 Liszt<br />
andò a farle visita nella tenuta <strong>di</strong><br />
Croissy. Lì vide per la prima volta<br />
le figlie <strong>di</strong> lei (Louise, nata nel<br />
1828, e Claire, nata nel 1830).<br />
Liszt detestava i bambini e avrebbe<br />
detestato anche i propri, relegandoli<br />
ai margini della sua vita,<br />
affi nché lo <strong>di</strong>sturbassero il meno<br />
possibile. Deluso, al ritorno a Parigi<br />
le rinfacciò i suoi doveri <strong>di</strong> madre<br />
e proprietaria terriera, chiedendole<br />
se le avrebbero lasciato tempo per<br />
qualcos’altro. Per qualche tempo,<br />
si scrissero lettere appassionate e<br />
amare, lamentando le proprie sofferenze.<br />
Si scambiarono però parole<br />
impegnative. Lei lo considerava<br />
un essere <strong>di</strong>vino, lui la padrona<br />
del suo destino.<br />
Nel 1834 la relazione si infi<br />
ammò, fra lirismo e rinunce, desiderio<br />
e rassegnazione, slanci mistici<br />
ed erotici, poiché a un certo<br />
punto <strong>di</strong>vennero amanti. Si incontravano<br />
nell’appartamento <strong>di</strong> Liszt<br />
in rue de la Sor<strong>di</strong>ère: un “buco per<br />
topi”. La clandestinità un po’ sor-<br />
Olycom
<strong>di</strong>da, il senso <strong>di</strong> colpa, la vergogna,<br />
mandarono in pezzi l’altezzosa<br />
contessa d’Agoult. Era tentata <strong>di</strong><br />
interrompere la relazione. Ma Liszt<br />
era il primo amore della sua vita:<br />
aveva sciolto la neve e non riuscì<br />
a privarsene. L’altalena emotiva<br />
<strong>di</strong>venne sempre più vertiginosa:<br />
un giorno si proponevano <strong>di</strong> separarsi<br />
per de<strong>di</strong>carsi alla vita religiosa<br />
(Liszt aveva sempre sognato <strong>di</strong><br />
farsi prete), il giorno dopo fantasticavano<br />
<strong>di</strong> fuggire insieme. Il loro<br />
legame però <strong>di</strong>ventava sempre più<br />
simbiotico. Liszt pretese che gli<br />
giurasse che non avrebbe potuto<br />
vivere senza <strong>di</strong> lui; quanto a lui,<br />
promise che non l’avrebbe mai lasciata.<br />
Lo scandalo non lo spaventava,<br />
e forse lo lusingava perfi no:<br />
poter vantare la conquista <strong>di</strong> un’aristocratica<br />
ricchissima e infl uente<br />
avrebbe accresciuto la sua fama.<br />
Avrebbe nobilitato la sua origine,<br />
sancendo il trionfo della musica<br />
sul sangue, dell’ideale sulla materia,<br />
del romanticismo sulla legge.<br />
Anche lei sognava <strong>di</strong> <strong>di</strong>mostrare al<br />
mondo che un artista e un’aristocratica<br />
possono essere uguali (eccetto<br />
nel genio, posseduto da<br />
quello solo), e che un amore libero<br />
può essere più forte, più fedele e<br />
più serio <strong>di</strong> un matrimonio. Ma<br />
sapeva anche troppo bene <strong>di</strong> avere<br />
tutto da perdere. Se fosse andata<br />
pubblicamente a vivere con<br />
un musicista avrebbe perso la reputazione,<br />
le fi glie, la posizione in<br />
società, il castello, ogni prospettiva<br />
<strong>di</strong> farsi un nome. Liszt, che in<br />
politica e in etica era allora molto<br />
ra<strong>di</strong>cale e molto rivoluzionario, le<br />
<strong>di</strong>sse che il problema era solo fra<br />
la sua coscienza e Dio. Non potendo<br />
parlare con gli amici, che ancora<br />
ignoravano la loro relazione,<br />
Marie andò a chiedere consiglio a<br />
una chiromante, la famigerata Madame<br />
Lenormand. Fu ricevuta in<br />
Marie d’Agoult<br />
(1805-76), meglio<br />
conosciuta come<br />
contessa d’Agoult, in<br />
un <strong>di</strong>pinto <strong>di</strong> Henri<br />
Lehman. Dopo il<br />
fallimento dell’unione<br />
con Liszt, si <strong>di</strong>ede<br />
alla letteratura,<br />
assumendo lo<br />
pseudonimo maschile<br />
<strong>di</strong> Daniel Stern.<br />
Marie d’Agoult<br />
(1805-76), better<br />
known as the<br />
countess d’Agoult, in<br />
a painting by Henri<br />
Lehman. After the<br />
end of her<br />
relationship with<br />
Liszt, she devoted<br />
herself to literature,<br />
taking on the male<br />
nom de plume of<br />
Daniel Stern.<br />
una stanza scura e soffocante. La<br />
tua vita cambierà completamente,<br />
le pre<strong>di</strong>sse la chiromante. Amerai<br />
un uomo che farà sensazione nel<br />
mondo.<br />
A <strong>di</strong>cembre, la piccola Louise<br />
d’Agoult si ammalò <strong>di</strong> meningite e<br />
in pochi giorni morì. La cameriera<br />
avvertì Liszt che Marie, sopraffatta<br />
dal rimorso, era scivolata sull’orlo<br />
della follia, delirava, piangeva,<br />
rifi utava <strong>di</strong> mangiare e <strong>di</strong> parlare,<br />
minacciava il suici<strong>di</strong>o. Però non<br />
poteva smettere <strong>di</strong> pensare a lui.<br />
Quando si riprese, Marie mise<br />
l’altra fi glia Claire in collegio: non<br />
voleva più vederla, la sua esistenza<br />
le ricordava la pre<strong>di</strong>letta morta.<br />
Ricominciò a frequentare la casa<br />
<strong>di</strong> Liszt, e lui si rese conto che era<br />
ormai pronta. Ricominciarono a<br />
parlare <strong>di</strong> fuggire insieme. Siamo<br />
giovani, coraggiosi, sinceri e orgogliosi.<br />
Dobbiamo avere gran<strong>di</strong> peccati<br />
o gran<strong>di</strong> virtù. Dobbiamo confessare<br />
in faccia al cielo la santità<br />
o la fatalità del nostro amore, le<br />
<strong>di</strong>sse (o Marie amava credere che<br />
le avesse detto). Di certo il giovane<br />
le <strong>di</strong>sse che, comunque, la scelta<br />
doveva essere sua. Una scelta<br />
consapevole, e libera.<br />
Non fu esattamente così,<br />
perché Marie rimase incinta. A<br />
Parigi la loro relazione era ormai<br />
nota, non solo perché durante gli<br />
incontri amorosi a rue de la Sor<strong>di</strong>ère<br />
la carrozza dei d’Agoult la aspettava<br />
al portone, ma soprattutto<br />
perché i due erano stati protagonisti<br />
<strong>di</strong> episo<strong>di</strong> clamorosi, come<br />
quando Liszt si fece aprire da un<br />
amico la cattedrale <strong>di</strong> Notre-Dame<br />
e suonò l’organo per un solo ascoltatore,<br />
Marie, vestita da uomo,<br />
che lo aveva seguito. Nonostante<br />
ciò, se le apparenze fossero state<br />
salvate, lo scandalo avrebbe ancora<br />
potuto essere evitato. Liszt era<br />
forse anche pronto a lasciare che<br />
il conte d’Agoult riconoscesse formalmente<br />
il bambino, e temeva la<br />
reazione della potente famiglia <strong>di</strong><br />
lei. Mandò Lamennais a sondare<br />
le sue vere intenzioni, e l’abate<br />
cercò <strong>di</strong> convincerla a rinunciare<br />
alla passione e a purifi care il suo<br />
amore per Liszt. Ma per lei, ormai,<br />
era troppo tar<strong>di</strong>. Scrisse una lettera<br />
d’ad<strong>di</strong>o al marito, non nascon-<br />
PERSONAGGI 71
dendo le sue colpe e chiedendogli<br />
solo silenzio. Poi, alla fi ne <strong>di</strong> maggio<br />
del 1835, partì per la Svizzera<br />
(dove la madre, ignara <strong>di</strong> tutto, era<br />
in vacanza), e il giorno dopo Liszt<br />
la raggiunse.<br />
Quando Marie informò la madre<br />
della sua fuga, madame de<br />
Flavigny svenne. Poi tentò <strong>di</strong> convincerla<br />
a seguirla a Francoforte,<br />
prima che la notizia trapelasse.<br />
Sarebbe potuta restare in Germania<br />
fi no alla nascita del bambino,<br />
e poi tornare a Parigi: nulla era<br />
ancora irreparabile. Marie le rispose<br />
che si sentiva chiamata a<br />
un compito nobile e <strong>di</strong>vino, come<br />
una missione: sostenere, sviluppare,<br />
ispirare il genio del suo<br />
compagno. A questo voleva de<strong>di</strong>care<br />
la sua vita.<br />
Il 1° giugno i due amanti lasciarono<br />
Basilea e per cinque settimane<br />
vagabondarono sui monti<br />
della Svizzera: ritenevano che la<br />
natura gran<strong>di</strong>osa elevasse l’animo<br />
<strong>di</strong>staccandolo dalle bassezze quoti<strong>di</strong>ane.<br />
Fantasticavano <strong>di</strong> mettere<br />
dello spazio fra loro e le loro vite<br />
precedenti, <strong>di</strong> moltiplicare le esperienze<br />
e crearsi un passato comune,<br />
<strong>di</strong> purifi care il loro legame e<br />
votarsi a una esistenza monastica<br />
che avrebbe preservato il loro<br />
amore. Durante una tempesta che<br />
li colse mentre attraversavano un<br />
lago, si <strong>di</strong>ssero che morire insieme<br />
sarebbe stato glorioso.<br />
Ma quando ri<strong>di</strong>scesero dalle<br />
montagne, Marie si rese conto<br />
che poteva sostenere la sua passione<br />
colpevole davanti alla natura,<br />
e perfi no a vedervi un martirio<br />
voluto da Dio, ma davanti al mondo<br />
era più <strong>di</strong>ffi cile. La famiglia le<br />
aveva voltato le spalle e la buona<br />
società svizzera la escluse. Era<br />
una donna perduta, e nessuno<br />
voleva frequentarla. Nelle loro chimere,<br />
Liszt avrebbe dovuto ritirarsi,<br />
vivere appartato, e de<strong>di</strong>carsi<br />
allo stu<strong>di</strong>o e alla composizione<br />
delle gran<strong>di</strong> opere musicali che<br />
tutti si attendevano da lui. Ma<br />
Liszt era inseguito dal suo successo,<br />
sollecitato a suonare il pianoforte<br />
nei salotti e nelle sale da<br />
concerto. I gemelli avevano bisogno<br />
<strong>di</strong> denaro, e lui prima cominciò<br />
ad accettare allievi, poi si ab-<br />
72 PERSONAGGI<br />
bandonò senza troppi rimpianti<br />
alla vita mondana. Una sera <strong>di</strong><br />
settembre Marie, ormai vistosamente<br />
incinta, lo accompagnò nel<br />
salone del principe Belgiojoso.<br />
Rimase in <strong>di</strong>sparte, emarginata.<br />
Liszt fu acclamato. Lei annotò a<br />
matita sul programma <strong>di</strong> sala:<br />
«avversione per il virtuoso… depravazione<br />
<strong>di</strong> un essere che suona<br />
per denaro». E più tar<strong>di</strong>, nelle<br />
sue Memorie, scrisse che quell’uomo<br />
«era Franz e non era Franz. Era<br />
come una persona che rappresentava<br />
lui in scena con molta abilità<br />
ma che tuttavia non aveva nulla in<br />
comune con lui ed era solo vana<br />
apparenza. Il suo modo <strong>di</strong> suonare<br />
mi turbava; il suo virtuosismo,<br />
pro<strong>di</strong>gioso, impressionante, incomparabile,<br />
mi dava una inesprimibile<br />
angoscia». Eppure quell’esibizione<br />
trionfale per lui e inquietante<br />
per lei fu come un presagio<br />
della loro vita futura, che sarebbe<br />
stata lacerata e poi <strong>di</strong>strutta da<br />
quel dualismo. Marie scopriva che<br />
il vero gemello <strong>di</strong> Franz non era lei,<br />
ma lui stesso. C’erano due Liszt:<br />
il pianista e il compositore. E lei<br />
sognava il secondo, ma era fuggita<br />
col primo, e a quello aveva<br />
consegnato la sua vita.<br />
Il 18 <strong>di</strong>cembre 1835 nacque<br />
Blan<strong>di</strong>ne. Fu registrata come fi glia<br />
naturale <strong>di</strong> “François Liszt, professore<br />
<strong>di</strong> musica” e <strong>di</strong> “Catherine-<br />
Adelaide Meran”: Marie d’Agoult<br />
non poteva fi gurare come madre<br />
Un ispirato Franz<br />
Liszt, ritratto da<br />
Wilhelm von<br />
Kaulbach. L’artista fu<br />
un grande<br />
catalizzatore <strong>di</strong><br />
masse e spettacolare<br />
in ogni sua<br />
manifestazione.<br />
An inspired Franz<br />
Liszt, portrayed by<br />
Wilhelm von<br />
Kaulbach. The artist<br />
attracted the masses<br />
and was spectacular<br />
at every event where<br />
he appeared.<br />
della bambina, che altrimenti per<br />
legge sarebbe appartenuta al marito.<br />
Ma così Blan<strong>di</strong>ne apparteneva<br />
a Liszt, e a lui solo. Liszt donò alla<br />
madre nascosta un anello con inciso<br />
il motto: In alta solitu<strong>di</strong>ne.<br />
Doveva essere un programma <strong>di</strong><br />
vita per entrambi. Ma il prezzo da<br />
pagare per quella solitu<strong>di</strong>ne per lui<br />
si rivelò insostenibile. Durante il<br />
suo “esilio” dal pubblico, il pianista<br />
Sigismund Thalberg, virtuoso non<br />
meno <strong>di</strong> lui e perfi no <strong>di</strong> un anno più<br />
giovane, si guadagnò una solida<br />
reputazione in Francia, e Liszt non<br />
poteva permettergli <strong>di</strong> soppiantarlo.<br />
Doveva anzi sfi dare il rivale, e<br />
se possibile trionfare pubblicamente<br />
su <strong>di</strong> lui. All’inizio della primavera<br />
partì per suonare nel Sud<br />
della Francia (dove l’altro aveva<br />
appena suonato), e poi tornò a<br />
Parigi. Diede un concerto nel salotto<br />
della principessa Belgiojoso:<br />
l’italiana, bella, esotica, intellettuale<br />
e carbonara, offrì a Liszt la sua<br />
infl uenza, il suo prestigio, la sua<br />
amicizia. A Marie, che aveva affi dato<br />
la neonata a una balia ed era<br />
rimasta sola a Ginevra, spaesata<br />
come una carpa sul prato e depressa<br />
dalla prolungata (e imprevista)<br />
assenza <strong>di</strong> Liszt, giunse qualche<br />
pettegolezzo su una loro liaison.<br />
Il 6 giugno si strappò dal letto<br />
in cui ormai vegetava, incapace <strong>di</strong><br />
trovare un motivo per alzarsi, e<br />
andò ad aspettare la carrozza che<br />
doveva riportarlo in<strong>di</strong>etro: ma Liszt<br />
non c’era.<br />
Tornò dalla “gemella” solo<br />
alla fi ne del mese. La rabbia e il<br />
risentimento <strong>di</strong> Marie scomparvero<br />
<strong>di</strong> fronte alla prospettiva <strong>di</strong> essere<br />
<strong>di</strong> nuovo, per sempre, la musa<br />
del genio. Ma siccome il <strong>di</strong>vorzio<br />
non esisteva e, come scrisse<br />
crudamente, i mariti muoiono solo<br />
nei romanzi, mentre d’Agoult godeva<br />
ottima salute (sarebbe morto a<br />
ottantacinque anni, poco prima <strong>di</strong><br />
lei), dovevano trovarsi un posto in<br />
cui vivere. Poiché la Svizzera calvinista<br />
e perbenista emarginava due<br />
amanti irregolari, scelsero l’Italia.<br />
L’Italia, oppressa, <strong>di</strong>visa, ricca <strong>di</strong><br />
arte e <strong>di</strong> dolore, appariva allora<br />
agli europei romantici come un<br />
miraggio <strong>di</strong> bellezza, cultura e libertà<br />
spirituale.
Fototeca Gilar<strong>di</strong><br />
Il viaggio, tuttavia, fu rimandato,<br />
e i due gemelli tornarono a<br />
Parigi. Qui Liszt elaborò le impressioni<br />
del viaggio svizzero, componendo<br />
i primi capolavori dell’Album<br />
d’un Voyageur e le fantasie romantiche<br />
su melo<strong>di</strong>e popolari. Diede<br />
anche un applau<strong>di</strong>to concerto con<br />
l’amico Berlioz. Marie si de<strong>di</strong>cò<br />
alla sua missione, <strong>di</strong>ffondendo la<br />
fama del compagno attraverso la<br />
pubblicazione <strong>di</strong> una serie <strong>di</strong> lettere,<br />
scritte da lei stessa sulla base<br />
<strong>di</strong> appunti abbozzati da lui. Le lettere<br />
– la Lettre à un poète voyageur,<br />
poi seguita da un<strong>di</strong>ci Lettres<br />
d’un bachelier ès musique – apparvero<br />
su Le Monde e sulla Revue et<br />
Gazette Musicale sotto il nome <strong>di</strong><br />
Liszt e suscitarono vasta risonanza.<br />
«Insieme – commentò scherzosamente<br />
Liszt – siamo un grande<br />
scrittore». In quelle lettere, che<br />
Marie continuò a scrivere fi no al<br />
1841, metteva le sue doti <strong>di</strong> scrittrice<br />
e le sue parole al servizio del<br />
genio e delle idee <strong>di</strong> lui, piegandole<br />
ai suoi desideri e alle sue aspirazioni.<br />
Cronache <strong>di</strong> viaggio e manifesti<br />
teorici sulla musica e sull’arte,<br />
possono essere lette anche<br />
come lettere d’amore. Marie si<br />
identifi cava col suo gemello e con<br />
la sua arte. Scriveva per lui e <strong>di</strong>ventava<br />
lui: in quelle pagine, il loro<br />
sogno <strong>di</strong> comunione assoluta era<br />
perfetto.<br />
Nell’estate del 1837 i gemelli<br />
raggiunsero fi nalmente l’Italia<br />
attraverso la strada del Sempione.<br />
Si fermarono qualche tempo a<br />
Milano, dove Liszt fu accolto da<br />
gran<strong>di</strong> onori, dall’aperta stima <strong>di</strong><br />
Rossini e dall’effi cienza organizzativa<br />
<strong>di</strong> Ricor<strong>di</strong>, che gli fece assaporare<br />
l’ospitalità italiana. Madame<br />
d’Agoult però trovò deludente la<br />
musica italiana e scadente il pubblico<br />
che apprezzava solo Donizetti.<br />
Nel primo concerto <strong>di</strong> Liszt alla<br />
Scala, uno spettatore – stufo dei<br />
suoi esperimenti – interruppe<br />
l’esecuzione del Prelu<strong>di</strong>o gridando:<br />
«Vengo a teatro per <strong>di</strong>vertirmi e<br />
non per stu<strong>di</strong>are!». Tuttavia Liszt<br />
fece furore, e conquistò l’attenzione<br />
dei giornali, che lodavano la<br />
sua bellezza e il suo fascino. Poi si<br />
ritirarono nella romantica Bellagio,<br />
sul lago <strong>di</strong> Como. Solo con un<br />
pianoforte, qualche libro e una<br />
donna che stu<strong>di</strong>ava Dante, Liszt<br />
visse una stagione <strong>di</strong> grazia, e alla<br />
madre scrisse: «Io abito nella regione<br />
più bella del mondo e sono<br />
l’uomo più felice della terra». Il 4<br />
<strong>di</strong>cembre nacque la loro seconda<br />
fi glia, Cosima. Ancora una volta,<br />
Marie non fi gurava come madre<br />
della piccola. Ma le spie austriache<br />
informarono l’ambasciata e la<br />
notizia giunse in Francia, suscitando<br />
l’irritazione del conte d’Agoult e<br />
dei Flavigny per la prole illegittima<br />
che la fuggitiva Marie andava seminando<br />
in tutta Europa. In gennaio,<br />
Liszt riprese a dare concerti<br />
a Milano dove, dopo aver sistemato<br />
Cosima da una balia, Marie poté<br />
raggiungerlo. I milanesi si mostra-<br />
Incisione<br />
ottocentesca del<br />
Teatro alla Scala <strong>di</strong><br />
Milano, una delle<br />
tante città italiane<br />
meta dell’incessante<br />
peregrinare artistico<br />
della coppia. Nel<br />
primo suo concerto<br />
alla Scala, Liszt fece<br />
furore, conquistando<br />
l’attenzione dei<br />
giornali.<br />
A 19th century<br />
engraving of the<br />
La Scala Theatre in<br />
Milan, one of the<br />
many Italian cities<br />
where the couple<br />
stayed on their<br />
endless artistic<br />
wanderings. At his<br />
first concert at La<br />
Scala, Liszt was a<br />
sensation,<br />
conquering the<br />
attention of the<br />
press.<br />
rono <strong>di</strong> vedute libere e aperte, e<br />
furono accoglienti con la coppia: a<br />
Milano, come nel resto d’Italia, la<br />
presenza dell’amante al fi anco del<br />
musicista fu accettata. Ma Liszt e<br />
Marie d’Agoult non ricambiarono<br />
l’indulgenza degli italiani, criticandone<br />
il basso livello intellettuale e<br />
i gusti estetici. La loro sprezzante<br />
Lettera sulla decadenza della musica<br />
italiana suscitò in<strong>di</strong>gnazione e<br />
sdegno.<br />
Poi i gemelli si rimisero in<br />
viaggio e percorsero <strong>di</strong>ligentemente<br />
la Penisola visitando i luoghi più<br />
celebri, segnalati dalle guide turistiche:<br />
Brescia, Verona, Vicenza,<br />
Padova. Giunsero a Venezia nel<br />
marzo 1838. Madame d’Agoult,<br />
sempre più esigente, o sempre più<br />
esaurita, trovò angusta la Fenice,<br />
detestabile Donizetti, spensierata,<br />
stracciona, ignorante e volgare<br />
l’aristocrazia locale. I vapori che<br />
salivano dall’acqua e l’aria pesante<br />
la soffocavano. Venezia puzzava<br />
come se avesse le coliche. Da<br />
parte sua, Liszt smaniava confusamente<br />
<strong>di</strong> tornare a Parigi, dare un<br />
concerto e poi ritirarsi in Germania.<br />
L’alluvione del Danubio in aprile<br />
gli <strong>di</strong>ede la possibilità <strong>di</strong> allontanarsi<br />
da una compagnia che cominciava<br />
a <strong>di</strong>ventare opprimente.<br />
Doveva dare due concerti per aiutare<br />
le vittime ungheresi della catastrofe.<br />
Rimase assente per mesi.<br />
A Vienna riscosse un successo<br />
fenomenale. Non avendo più voglia<br />
<strong>di</strong> tornare a Venezia, le propose<br />
<strong>di</strong> raggiungerlo. Lei non lo fece.<br />
Forse perché era malata, forse<br />
perché sapeva che a Vienna la<br />
aspettava l’altro – il gemello oscuro<br />
del suo Franz, quello che non<br />
amava: il concertista, il virtuoso,<br />
l’esecutore vanitoso e venale, il<br />
seduttore che si nutriva dell’amore<br />
del pubblico. Lei ancora sperava <strong>di</strong><br />
riuscire a tenerlo lontano dalle<br />
metropoli, recluso a comporre in<br />
qualche campagna, suonando solo<br />
occasionalmente per far conoscere<br />
la sua musica. Anche Liszt<br />
voleva affermarsi come compositore,<br />
però nel suo tour viennese fu<br />
accolto ovunque da applausi selvaggi<br />
e scoprì che – a parte il piacere<br />
che ricavava dall’adulazione<br />
del pubblico – dare concerti poteva<br />
PERSONAGGI 73
portargli enormi somme <strong>di</strong> denaro.<br />
Inoltre adorava essere corteggiato<br />
dalle donne, che si gettavano su <strong>di</strong><br />
lui, letteralmente. Non rimase insensibile.<br />
La tradì. Le propose <strong>di</strong><br />
instaurare un rapporto un po’ più<br />
libero. Poiché la rispettava ancora,<br />
le suggerì <strong>di</strong> pareggiare i conti e <strong>di</strong><br />
trovarsi un amante, il conte Emilio<br />
Malazzoni che devotamente la<br />
scortava per Venezia.<br />
Alla fi ne <strong>di</strong> maggio, Liszt tornò<br />
a Venezia. Agghindato come un<br />
aristocratico, convinto <strong>di</strong> essere<br />
nobile anche lui grazie a misteriose<br />
ricerche sull’albero genealogico<br />
dei Liszt fatte da ammiratori compiacenti.<br />
Marie accolse malissimo<br />
il fe<strong>di</strong>frago e lo accusò <strong>di</strong> essere<br />
un “Don Giovanni parvenu”, ferendo<br />
indelebilmente il suo amor proprio.<br />
A quel tempo, scrivevano un<br />
<strong>di</strong>ario comune. Sotto la riga in cui<br />
lei annotava che Franz le aveva<br />
promesso <strong>di</strong> non tra<strong>di</strong>rla mai più,<br />
lui scrisse «tu ricor<strong>di</strong> le mie parole,<br />
ma quelle che mi hai detto tu sembrano<br />
non aver lasciato traccia<br />
nella tua mente. Ma io non le ho<br />
<strong>di</strong>menticate». Tuttavia, non si lasciarono.<br />
Liszt ammise che i tre<br />
anni che aveva passato con lei<br />
avevano fatto <strong>di</strong> lui un uomo, Marie<br />
ormai lo accettava come suo<br />
angelo e suo demone, accettava<br />
<strong>di</strong> amarlo e o<strong>di</strong>arlo, e in fi n dei<br />
conti, voleva «andare dove tu vai,<br />
respirare l’aria che respiri, parlare<br />
le tue parole, vivere la tua vita,<br />
morire la tua morte». «Abbiamo il<br />
cattivo gusto <strong>di</strong> trovarci sempre<br />
più affascinanti, incomparabili –<br />
scrisse Marie a George Sand – e<br />
quando proviamo a lasciarci, <strong>di</strong>ventiamo<br />
tristi. Comincio a credere<br />
che siamo condannati ad amarci,<br />
eternamente».<br />
George Sand annotò <strong>di</strong>vertita<br />
quell’espressione, e la riferì al suo<br />
amico Balzac. Sand e la d’Agoult<br />
si erano frequentate a Parigi, dove<br />
i “galeotti dell’amore” avevano<br />
vissuto per qualche tempo in attesa<br />
<strong>di</strong> partire per l’Italia. Per volontà<br />
<strong>di</strong> Liszt, le due donne avevano <strong>di</strong>viso<br />
un salon e la vita bohèmienne<br />
degli artisti: ribelli al loro mondo,<br />
sembravano simili e destinate a<br />
capirsi. In realtà, Marie era gelosa<br />
del successo dell’altra, del suo<br />
74 PERSONAGGI<br />
talento e anche della sua libertà.<br />
Inoltre, tutti i loro amici ritenevano<br />
che Sand e Liszt fossero amanti.<br />
Nel gennaio del 1837 Marie aveva<br />
accettato l’invito della scrittrice e<br />
si era trasferita nella sua casa <strong>di</strong><br />
Nohant. In pochi mesi, l’amicizia<br />
era <strong>di</strong>venuta tenerezza, quasi un<br />
amore, ma altrettanto rapidamente<br />
si era mutata in in<strong>di</strong>fferenza, e<br />
poi in reciproco <strong>di</strong>sprezzo. Marie<br />
criticò la promiscuità sessuale<br />
della scrittrice, Sand ri<strong>di</strong>colizzò le<br />
pose dell’aristocratica, fi n troppo<br />
consapevole della nobiltà delle<br />
sue origini e del “sacrifi cio” che<br />
aveva fatto fuggendo col musicista.<br />
L’amico Balzac raccolse la sua<br />
<strong>di</strong>sistima e si affrettò a tracciare<br />
un feroce ritratto della nobile perduta<br />
nel romanzo Béatrix - I galeotti<br />
dell’amore: apparso nel 1839,<br />
contribuì non poco a macchiare la<br />
già <strong>di</strong>sastrosa fama della contessa<br />
d’Agoult. Liszt, cui il romanzo<br />
era piaciuto, tentò <strong>di</strong> minimizzare il<br />
danno e invitò Marie a ricucire i<br />
rapporti con l’infl uente scrittrice.<br />
Ma, nonostante i ripetuti tentativi,<br />
più o meno sinceri, <strong>di</strong> Marie, Sand<br />
non le concesse mai più né amicizia<br />
né stima né perdono.<br />
I gemelli (ormai per tutti piuttosto<br />
galeotti dell’amore, incatenati<br />
allo stesso remo e condannati a<br />
vogare insieme per non naufragare)<br />
proseguirono il viaggio. Lugano,<br />
Genova, <strong>di</strong> nuovo Milano (dove<br />
però, anche a causa delle polemiche<br />
suscitate dalla Lettera, il concerto<br />
<strong>di</strong> benefi cenza <strong>di</strong> Liszt nel<br />
ridotto della Scala fu un fi asco, e<br />
lui scrisse che avrebbe preferito<br />
La scrittrice francese<br />
George Sand<br />
(1804-76), al secolo<br />
Amantine Aurore<br />
Lucile Dupin, in un<br />
ritratto <strong>di</strong> Auguste<br />
Charpentier. Sand e<br />
la d’Agoult si erano<br />
frequentate a Parigi:<br />
sembravano simili e<br />
destinate a capirsi.<br />
The French author<br />
George Sand<br />
(1804-76), whose real<br />
name was Amantine<br />
Aurore Lucile Dupin,<br />
in a portrait by<br />
Auguste Charpentier.<br />
Sand and d’Agoult<br />
had known each<br />
other in Paris: they<br />
seemed similar and<br />
destined to<br />
understand one<br />
another.<br />
trascorrere quin<strong>di</strong>ci giorni in prigione<br />
piuttosto che vivere in quella<br />
città), Piacenza, Parma, Bologna,<br />
Ravenna. All’inizio del 1839 si<br />
stabilirono a Firenze. Liszt, sempre<br />
più pigro e svogliato, pensava solo<br />
a guadagnare sol<strong>di</strong> e vestirsi alla<br />
moda, mentre Marie d’Agoult si<br />
consolava frequentando pittori e<br />
scultori e soprattutto affezionandosi<br />
a Blan<strong>di</strong>ne, detta Moscerino,<br />
che li aveva raggiunti. Per nove<br />
mesi, la bimba, che aveva ormai<br />
tre anni ed era un angioletto roseo<br />
e ricciuto, visse coi genitori. Nessuno<br />
degli altri fi gli <strong>di</strong> Liszt e Marie<br />
ebbe lo stesso privilegio. Quando<br />
era ispirato, la sera Liszt le suonava<br />
le Scene infantili, e la piccola<br />
mostrava <strong>di</strong> apprezzare. Dopo un<br />
rapido passaggio a Pisa (che però<br />
anni dopo generò un frutto importante,<br />
la Totentanz ispirata dalla<br />
visita al Camposanto), arrivarono a<br />
Roma. Si stabilirono vicino a Trinità<br />
dei Monti. Il pittore Ingres, <strong>di</strong>rettore<br />
dell’Accademia <strong>di</strong> Francia e personalità<br />
centrale della cultura europea,<br />
li aiutò a inserirsi nell’ambiente<br />
romano e organizzò un<br />
concerto a Villa Me<strong>di</strong>ci: Liszt eseguì<br />
sonate e trii <strong>di</strong> Beethoven. E si<br />
abbandonò al piacere della mondanità,<br />
tra feste alle ambasciate e<br />
ricevimenti nei salotti. L’umore <strong>di</strong><br />
Marie doveva essere alterato, se<br />
trovò talmente detestabile la Roma<br />
cattolica da proporre <strong>di</strong> raderla<br />
al suolo, deportare la popolazione<br />
a Ostia e trasformare la città in un<br />
parco per turisti, lasciandovi solo<br />
alberghi tra le rovine della Roma<br />
antica. Il loro terzo fi glio, Daniel<br />
Henri, nacque il 9 maggio 1839.<br />
Sul suo certifi cato <strong>di</strong> nascita c’è<br />
scritto: “madre sconosciuta”. Anche<br />
Liszt non era troppo interessato<br />
alla sua esistenza: avvisò<br />
un’amica che «non è cambiato<br />
niente, c’è solo un romano in più».<br />
Lo sfortunato bimbo nato al tramonto<br />
<strong>di</strong> un amore fu affi dato appena<br />
un mese dopo la nascita a<br />
un amico della coppia e poi a una<br />
balia, a Palestrina. Marie non lo<br />
rivide fi no alla sua adolescenza.<br />
Il soggiorno italiano stava per<br />
concludersi. Dopo un estremo i<strong>di</strong>llio<br />
<strong>di</strong> due settimane nella solitu<strong>di</strong>ne<br />
della tenuta del Gombo a San
Rossore, fra bagni <strong>di</strong> mare e pranzi<br />
sotto i pini, Liszt accompagnò<br />
Marie e Blan<strong>di</strong>ne a Livorno, quin<strong>di</strong><br />
partì da solo per un nuovo viaggio<br />
nel nord Italia, <strong>di</strong>retto a Trieste,<br />
Lubiana, Vienna. Ancora non lo<br />
sapeva, ma stava per iniziare il<br />
terzo atto della sua vita: negli otto<br />
anni successivi sarebbe <strong>di</strong>ventato<br />
il concertista più acclamato e pagato<br />
d’Europa. Marie non voleva<br />
tornare in Francia: sognava ancora<br />
<strong>di</strong> stabilirsi in Italia, <strong>di</strong> costruirsi<br />
uno chalet nella foresta del Gombo<br />
e vivervi con Franz nella solitu<strong>di</strong>ne<br />
della natura e della musica.<br />
Temeva Parigi. Non apparteneva<br />
più ad alcun ambiente. Non aveva<br />
religione né famiglia né casa (sarebbe<br />
andata ospite dalla madre <strong>di</strong><br />
Liszt). Un carattere incapace <strong>di</strong><br />
compromessi. Un futuro incerto.<br />
Quando la nave che la portava a<br />
Genova (dove avrebbe preso con<br />
sé Cosima) fu colpita dalla tempesta,<br />
si augurò <strong>di</strong> sparire tra le onde.<br />
La separazione non doveva<br />
essere defi nitiva. E non lo fu, perché<br />
i gemelli si lasciarono davvero<br />
solo cinque anni dopo. Ma <strong>di</strong> fatto,<br />
avevano cessato <strong>di</strong> essere inseparabili<br />
compagni e avrebbero vissuto<br />
insieme solo pochi mesi, d’estate.<br />
Per lei, la separazione fu una<br />
<strong>di</strong>sfatta, e la fi ne del suo sogno <strong>di</strong><br />
essergli musa, guida e compagna.<br />
Per lui, fu un buon compromesso,<br />
che lo lasciava libero <strong>di</strong> dare concerti,<br />
suonare, guadagnare denaro<br />
per sé e per i fi gli, scrivere, e continuare<br />
ad amarla, ma con meno<br />
doveri. Tirarono avanti fra brevi<br />
i<strong>di</strong>lli e tra<strong>di</strong>menti clamorosi e assai<br />
pubblicizzati (fra l’altro con Lola<br />
Montes e Camille Pleyel), ripicche,<br />
ritorni <strong>di</strong> passione, gelosie, rancori,<br />
litigi feroci. «Sono felice <strong>di</strong> essere<br />
la tua amante, ma non una<br />
delle tue amanti» – gli scrisse Marie.<br />
E alla fi ne, nell’aprile del 1844,<br />
quando si rese conto <strong>di</strong> essere<br />
«una Beatrice senza Dante», lo lasciò.<br />
Lasciò il grande amore per<br />
cui aveva abbandonato tutto, ma<br />
non tornò dal marito, che l’avrebbe<br />
ripresa, né dai fi gli: a una vita in<strong>di</strong>pendente<br />
– tutta da inventare.<br />
Quando i gemelli si scoprirono<br />
<strong>di</strong>versi, opposti, inconciliabili, si<br />
Blan<strong>di</strong>ne, Cosima e Daniel soffrirono molto<br />
dei forti contrasti sorti tra i loro genitori <strong>di</strong>visi.<br />
A destra: Cosima, secondogenita <strong>di</strong> Franz<br />
Liszt, fu la seconda moglie <strong>di</strong> Richard Wagner<br />
al quale si de<strong>di</strong>cò con assoluta fedeltà.<br />
Blan<strong>di</strong>ne, Cosima and Daniel suffered greatly<br />
from the strong <strong>di</strong>sagreements between their<br />
separated parents. On the right: Cosima,<br />
Franz Liszt’s second child, was the second<br />
wife of Richard Wagner to whom she devoted<br />
herself with absolute fidelity.<br />
Fototeca Gilar<strong>di</strong><br />
All’inizio del 1839<br />
Franz e Marie si<br />
stabilirono a Firenze.<br />
In early 1839 Franz<br />
and Marie settled<br />
down in Florence.<br />
o<strong>di</strong>arono. Quella che doveva essere<br />
una comunione <strong>di</strong> anime e corpi,<br />
una fusione <strong>di</strong> genio e talento,<br />
<strong>di</strong> musica e parole, si tramutò in<br />
una banale storia <strong>di</strong> <strong>di</strong>samore.<br />
Quando la passione si spense,<br />
iniziò una sor<strong>di</strong>da, meschina guerra<br />
in cui entrambi <strong>di</strong>edero il peggio<br />
<strong>di</strong> sé. Incapace <strong>di</strong> accettare l’idea<br />
<strong>di</strong> avere <strong>di</strong>strutto la propria vita per<br />
un’illusione, Marie gli rinfacciò <strong>di</strong><br />
aver <strong>di</strong>strutto il loro sogno «non<br />
per una grande opera, per dovere,<br />
per patriottismo, ma per i successi<br />
dei salotti, la gloria della pubblicità,<br />
gli inviti delle principesse». Per<br />
ven<strong>di</strong>carsi scrisse un brutto romanzo<br />
a chiave, Nélida (1846), e<br />
de<strong>di</strong>cò il resto della sua vita a<br />
cercare <strong>di</strong> <strong>di</strong>ventare qualcuno –<br />
poiché, se non era stata la Musa<br />
del Genio, voleva essere non il<br />
Genio (ammetteva <strong>di</strong> esserne priva)<br />
ma almeno una celebrità. Franz<br />
le tolse i fi gli (su cui legalmente la<br />
madre ignota non aveva alcun <strong>di</strong>ritto),<br />
le impedì <strong>di</strong> vederli per anni,<br />
e perfi no <strong>di</strong> scrivergli. Glieli mise<br />
contro. Raccontò a Blan<strong>di</strong>ne, Cosima<br />
e Daniel che la madre li aveva<br />
abbandonati e che non voleva<br />
spendere un soldo per loro. La<br />
rinnegò <strong>di</strong>pingendola alla sua nuo-<br />
PERSONAGGI 75
va compagna, la principessa<br />
Caroline von Sayn-<br />
Wittgenstein, e ai suoi<br />
amici come una donna<br />
arida, ambiziosa, futile, il<br />
cui unico talento era la<br />
capacità <strong>di</strong> scegliere i vestiti.<br />
Fece scrivere alla<br />
principessa una sua falsa<br />
biografi a dettandole<br />
un capitolo su Marie d’Agoult<br />
talmente <strong>di</strong>ffamatorio<br />
e menzognero da<br />
macchiare la propria<br />
stessa immagine e gettare<br />
più <strong>di</strong> un’ombra sul<br />
suo carattere.<br />
Così, i due che avevano<br />
sognato <strong>di</strong> realizzarsi<br />
nell’amore, <strong>di</strong>vennero se<br />
stessi solo dopo l’ad<strong>di</strong>o. Neanche<br />
tre anni dopo, Liszt abbandonò<br />
davvero l’attività <strong>di</strong> concertista,<br />
<strong>di</strong>venne il compositore che Marie<br />
aveva sognato invano, e scrisse la<br />
Sonate, la sinfonia Faust, i do<strong>di</strong>ci<br />
poemi sinfonici per orchestra (fra<br />
cui i Préludes, Hamlet e Prometheus),<br />
le Rapso<strong>di</strong>e Ungheresi, la<br />
Via crucis e i capolavori sperimentali<br />
e innovativi per cui ancora lo<br />
celebriamo. Marie d’Agoult – sebbene<br />
mai libera del tutto dalla<br />
“grande ombra” <strong>di</strong> lui – riuscì faticosamente<br />
a rifarsi un’immagine e<br />
una vita, <strong>di</strong>venne una influente<br />
salonnière e, sotto il nome maschile<br />
<strong>di</strong> Daniel Stern, un giornalista <strong>di</strong><br />
politica e costume e un rispettabile<br />
scrittore <strong>di</strong> storia (la sua vivace<br />
e rigorosa Storia della rivoluzione<br />
del ’48 è ancora oggi fonte eccellente).<br />
Per quin<strong>di</strong>ci anni si de<strong>di</strong>carono<br />
entrambi a costruire se stessi.<br />
Nel maggio del 1861 Liszt – che<br />
dal 1847 viveva a Weimar, dove<br />
era <strong>di</strong>rettore della cappella <strong>di</strong> corte<br />
– tornò a Parigi per assistere alla<br />
prima del Tannhauser <strong>di</strong> Wagner.<br />
Marie lo invitò ad andare a trovarla,<br />
e Liszt – solo dopo aver ricevuto un<br />
invito scritto, come la prima volta<br />
– consentì a farle visita nel suo<br />
appartamento, all’Hotel Montaigne.<br />
Marie gli porse la mano,<br />
scioccata non tanto <strong>di</strong> trovarlo invecchiato,<br />
benché ancora bello, <strong>di</strong><br />
constatare che i suoi occhi avevano<br />
perso il loro fuoco o che il suo<br />
76 PERSONAGGI<br />
Il celeberrimo<br />
pianista e<br />
compositore<br />
ungherese negli<br />
ultimi anni della sua<br />
vita prese la tonsura<br />
e scrisse solo<br />
musica sacra.<br />
The very famous<br />
Hungarian pianist<br />
and composer took<br />
the tonsure in the<br />
last years of his life<br />
and wrote only<br />
sacred music.<br />
volto sembrava triste,<br />
quanto dalla sua nuova<br />
immagine, severa e serena.<br />
Liszt rimase sulla <strong>di</strong>fensiva,<br />
imbarazzato,<br />
sentenzioso, pungente.<br />
Non parlarono <strong>di</strong> Blan<strong>di</strong>ne<br />
e Cosima (Daniel era già<br />
morto <strong>di</strong> tubercolosi). Lui,<br />
che pure stava per recarsi<br />
a Roma, rimase stupito<br />
dalla passione <strong>di</strong> lei per<br />
l’Italia. Forse perché in<br />
Italia aveva vissuto liberamente<br />
il suo amore, e<br />
aveva potuto stargli accanto<br />
senza vergogna,<br />
Marie d’Agoult aveva <strong>di</strong>menticato<br />
i duri giu<strong>di</strong>zi<br />
degli anni del suo pellegrinaggio.<br />
Aveva appoggiato i patrioti<br />
del Risorgimento, Mazzini e la causa<br />
dell’Unità d’Italia. Avrebbe scritto<br />
<strong>di</strong> aver avuto cinque passioni<br />
nella vita: «Dio, Liszt, la Repubblica,<br />
la maternità e l’Italia. Solo la<br />
passione per l’Italia non mi ha delusa».<br />
Pochi giorni dopo, Liszt tornò<br />
per un pranzo con gli amici della<br />
contessa. La prese sottobraccio,<br />
per condurla a tavola. Lei ne fu<br />
emozionata. Era ancora l’unica<br />
persona al mondo che riuscisse a<br />
turbarla. Fu un pranzo triste e dolce.<br />
Alla fi ne, commentò lei, le gran<strong>di</strong><br />
cose della vita si riducono a ben<br />
poco: le gran<strong>di</strong> passioni, i gran<strong>di</strong><br />
dolori, le laceranti ambizioni si riducono<br />
a un pollo alla portoghese<br />
mangiato in compagnia <strong>di</strong> persone<br />
completamente estranee alla lunga<br />
vita trascorsa insieme. Pochi<br />
giorni dopo, Liszt andò a prendere<br />
congedo. Salutandolo, Marie lo<br />
baciò in fronte. «Dio ti bene<strong>di</strong>ca» le<br />
<strong>di</strong>sse lui, quasi salmo<strong>di</strong>ando, «Non<br />
augurarmi il male». Lei non riuscì a<br />
rispondergli e scoppiò in lacrime.<br />
Ma erano destinati a incontrarsi<br />
un’ultima volta, nel 1866.<br />
Liszt aveva preso la tonsura e gli<br />
or<strong>di</strong>ni minori. Indossava una tonaca<br />
nera. Parlarono dei fi gli vivi e<br />
morti, civilmente. Non fu però un<br />
incontro crepuscolare. Quando<br />
Marie gli annunciò <strong>di</strong> aver iniziato<br />
a scrivere le sue memorie, lui si<br />
allarmò, temendo (in parte giustamente)<br />
nuove vendette e nuove<br />
rese <strong>di</strong> conti. La avvisò ironico che<br />
Fototeca Gilar<strong>di</strong><br />
non ne sarebbe stata capace,<br />
perché avrebbe potuto scrivere<br />
solo pose e bugie. Lei stentava ad<br />
accettare l’idea che lui avesse<br />
preso i voti e che il seduttore mondano<br />
che aveva o<strong>di</strong>ato era morto:<br />
l’uomo che le stava davanti parlava<br />
come un prete e scriveva solo<br />
musica sacra. Erano, comunque,<br />
due estranei. «Che cosa hai fatto<br />
<strong>di</strong> questi ventotto anni?» scrisse<br />
qualche tempo dopo. «E cosa ho<br />
fatto io? Lui è l’abate Liszt e io<br />
sono Daniel Stern! E quale <strong>di</strong>sperazione,<br />
quali morti, quali lacrime,<br />
quale lutto ci separano!».<br />
Marie de Flavigny contessa<br />
d’Agoult morì il 5 marzo 1876.<br />
Così la salutò l’abate Liszt scrivendo<br />
alla principessa Sayn-Wittgenstein:<br />
«Senza ipocrisia, non potrei<br />
piangere per lei dopo la sua morte<br />
più che durante la sua vita. Madame<br />
d’Agoult possedeva a un alto<br />
grado un gusto, e perfi no una passione,<br />
per il falso – eccetto certi<br />
momenti <strong>di</strong> estasi che dopo non<br />
sopportava le venissero ricordati».<br />
Ma più civilmente, al genero Émile<br />
Ollivier, marito della defunta Blan<strong>di</strong>ne,<br />
scrisse: «La memoria che<br />
serbo <strong>di</strong> Madame d’Agoult è un<br />
doloroso segreto che confi do a<br />
Dio, pregando che possa dare<br />
pace e luce all’anima della madre<br />
dei miei tre fi gli».<br />
Le sopravvisse <strong>di</strong> <strong>di</strong>eci anni,<br />
venerato dagli allievi <strong>di</strong> Weimar e<br />
Budapest e dalle autorità dell’Impero,<br />
che lo nominarono consigliere<br />
reale, festeggiato e omaggiato<br />
ovunque – e però anche <strong>di</strong>scusso<br />
da chi lo riteneva un compositore<br />
<strong>di</strong>scontinuo e talvolta convenzionale,<br />
e contestato da chi, come<br />
Brahms, giu<strong>di</strong>cava certa sua musica<br />
pronta per la spazzatura. La<br />
loro fi glia Cosima, che aveva lasciato<br />
il marito Hans von Bülow<br />
per essere compagna del musicista<br />
Wagner, sua musa e ispiratrice,<br />
sua gemella d’anima e corpo,<br />
suo tutto, aveva realizzato il sogno<br />
giovanile dei genitori. Eppure Liszt<br />
non le perdonò quella scelta e<br />
Cosima aveva interrotto i rapporti<br />
con entrambi. Seppe della morte<br />
della madre dai giornali: la sorellastra<br />
Claire d’Agoult non aveva il<br />
suo in<strong>di</strong>rizzo.
Con la “Carta <strong>di</strong> Saint Vincent” dell’ottobre 2010 la si vuole arginare<br />
La me<strong>di</strong>cina <strong>di</strong>fensiva<br />
danneggia il paziente<br />
e la fi nanza pubblica<br />
NOTIZIARIO<br />
Giustizia<br />
La me<strong>di</strong>cina <strong>di</strong>fensiva incide per il 10,5% sulla spesa del SSN.<br />
Defensive me<strong>di</strong>cine accounts for 10.5% of the Italian National<br />
Healthcare expen<strong>di</strong>ture.<br />
Defensive me<strong>di</strong>cine damages the patient<br />
and public resources<br />
It is now a major practice to have recourse to a judge to define<br />
any <strong>di</strong>rect responsibility of a doctor in healthcare that has not<br />
been successful. This means that the doctor has to provide<br />
evidence, with defensive me<strong>di</strong>cine, that the tragic event cannot be<br />
connected with his professional activity. It has a “positive”<br />
character when the doctor prescribes tests and me<strong>di</strong>cine that are<br />
not strictly in<strong>di</strong>spensable, for the sole aim of showing that he <strong>di</strong>d<br />
everything possible; or “negative” when the doctor, in order not to<br />
run any risks, avoids doing any <strong>di</strong>fficult operations.<br />
The climate of chargeability that the doctor perceives costs the<br />
public administration euro 10 billion a year.<br />
An effective solution is a “black box” in the operating theatre,<br />
which records the various phases of the operation and provides<br />
definite proof in the case of <strong>di</strong>spute.<br />
ALFONSO MARRA<br />
Presidente Emerito<br />
delle Corti <strong>di</strong> Appello <strong>di</strong> Milano e <strong>di</strong> Brescia<br />
incremento del contenzioso,<br />
che si è registrato in<br />
questi ultimi anni a carico<br />
dei me<strong>di</strong>ci, è in buona parte<br />
dovuto alla concezione che oggi<br />
si dà all’errore nella prestazione<br />
sanitaria. Esso, infatti, è ritenuto<br />
un problema sociale perché viene<br />
considerato, appunto, socialmen-<br />
te inaccettabile in ragione dei pro-<br />
gressi della scienza me<strong>di</strong>ca. A<br />
questa nuova qualifi cazione dell’errore<br />
ha non poco contribuito la<br />
giurisprudenza della Cassazione la<br />
quale ha fatto rientrare la prestazione<br />
professionale fra le obbligazioni<br />
<strong>di</strong> risultato (negli anni scorsi<br />
l’aveva defi nita “<strong>di</strong> mezzi”) e consequenzialmente<br />
la responsabilità<br />
in quella “paraoggettiva” (e cioè<br />
responsabilità senza colpa). La<br />
Corte ha, altresì, elaborato regole<br />
ben precise alle quali i giu<strong>di</strong>ci debbono<br />
attenersi nel giu<strong>di</strong>care questo<br />
tipo <strong>di</strong> controversie. Ed esse<br />
stabiliscono che i me<strong>di</strong>ci per non<br />
rispondere dei danni lamentati dal<br />
paziente, ove l’intervento non sortisca<br />
l’effetto desiderato o abbia<br />
comportato un aggravamento dello<br />
stato <strong>di</strong> salute, debbono provare<br />
Fotolia L’<br />
<strong>di</strong> aver operato correttamente e<br />
che quanto lamentato non sia dovuto<br />
alla loro prestazione professionale.<br />
È stata, così introdotta<br />
un vera e propria inversione<br />
dell’onere della prova che comporta<br />
l’obbligo a carico del me<strong>di</strong>co<br />
<strong>di</strong> fornire ad<strong>di</strong>rittura una prova<br />
negativa e cioè che l’evento “non”<br />
è collegato alla sua attività professionale.<br />
Prova, questa, estremamente<br />
complessa e <strong>di</strong>ffi cile.<br />
Ecco perché, dopo questi principi<br />
introdotti dalla Cassazione, che<br />
assumono oggi il valore <strong>di</strong> una<br />
vera e propria norma giuri<strong>di</strong>ca (la<br />
stessa Cassazione parla <strong>di</strong> “giurisprudenza<br />
normativa”), si è <strong>di</strong>ffusa<br />
fra i me<strong>di</strong>ci la pratica della<br />
me<strong>di</strong>cina <strong>di</strong>fensiva che ha preso<br />
il posto <strong>di</strong> quella paternalistica.<br />
Essa può essere “positiva” quando<br />
i me<strong>di</strong>ci prescrivono test, procedure<br />
o farmaci non strettamente<br />
necessari al solo fi ne <strong>di</strong> ridurre<br />
la loro esposizione in un giu<strong>di</strong>zio<br />
<strong>di</strong> responsabilità, o anche “negativa”<br />
quando per il medesimo<br />
motivo evitano <strong>di</strong> effettuare interventi<br />
molto rischiosi.<br />
Il fenomeno, però, non è solo<br />
italiano. Di recente autorevoli organi<br />
della nostra stampa nazionale<br />
hanno dato notizia <strong>di</strong> un rapporto<br />
pubblicato dalla rivista Archives of<br />
Internal Me<strong>di</strong>cine secondo il quale<br />
negli Usa il 90 per cento dei me<strong>di</strong>ci<br />
ricorre alla me<strong>di</strong>cina <strong>di</strong>fensiva<br />
per tenersi al riparo da eventuali<br />
GIUSTIZIA 77
78 GIUSTIZIA<br />
azioni giu<strong>di</strong>ziarie dei pazienti. La<br />
medesima situazione si sta verifi -<br />
cando in Italia. E <strong>di</strong>fatti, secondo<br />
un recentissimo stu<strong>di</strong>o dell’Università<br />
Milano-Bicocca, nove me<strong>di</strong>ci<br />
su <strong>di</strong>eci ricorrono alla stessa pratica<br />
dei loro colleghi statunitensi.<br />
Il che – secondo quanto <strong>di</strong>chiarato<br />
dal Ministro della Salute – fi nisce<br />
per gravare sulla fi nanza pubblica<br />
del nostro Paese con un costo <strong>di</strong><br />
ben 10 miliar<strong>di</strong> <strong>di</strong> euro l’anno (Corriere<br />
della Sera del 12 <strong>di</strong>cembre<br />
2010 pagg. 54 e 55). E più precisamente<br />
la me<strong>di</strong>cina <strong>di</strong>fensiva incide<br />
per il 10,5% sulla spesa del<br />
SSN. Più alta è, poi, la percentuale<br />
relativa al settore privato dove<br />
l’incidenza è del 14% (Sole 24 Ore,<br />
Sanità n. 45 del 6 <strong>di</strong>cembre 2010<br />
pag. 11). Ma non sono solo questi<br />
gli effetti negativi della me<strong>di</strong>cina<br />
<strong>di</strong>fensiva. Ce ne sono altri <strong>di</strong> natura<br />
non certo minore che incidono<br />
sulla salute dei citta<strong>di</strong>ni. Essi sono<br />
dovuti agli effetti collaterali<br />
degli esami clinici inutili, alcuni <strong>di</strong><br />
essi, peraltro molto invasivi, nonché<br />
dei tanti farmaci prescritti ed<br />
assunti senza una effettiva necessità<br />
clinica.<br />
D’altronde, il timore dei nostri<br />
me<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> fi nire innanzi al giu<strong>di</strong>ce<br />
penale e civile spiega, e in un certo<br />
senso anche giustifi ca, le ragioni<br />
che li inducono a svolgere la<br />
professione con determinate cautele<br />
alle quali non avevano mai<br />
fatto ricorso negli anni ad<strong>di</strong>etro<br />
quando i pazienti riponevano nel<br />
loro operato la massima fi ducia<br />
accettando anche l’errore. E tale<br />
timore, in verità, appare tutt’altro<br />
che infondato se si pensa che, in<br />
questi ultimi tempi, ogni anno nel<br />
nostro Paese sono ben 15 mila i<br />
me<strong>di</strong>ci che vengono portati in giu<strong>di</strong>zio<br />
dai loro pazienti. Il che ha<br />
comportato anche un considerevole<br />
aumento dei costi <strong>di</strong> esercizio<br />
dell’attività professionale per l’elevatissima<br />
lievitazione dei premi<br />
delle polizze <strong>di</strong> assicurazione. Secondo<br />
uno stu<strong>di</strong>o dell’ANIA, dal<br />
1994 al 2007 il numero degli incidenti<br />
segnalati per eventi avversi<br />
connessi alle prestazioni professionali<br />
è passato da 9.500 a<br />
30.000 all’anno con un incremento<br />
del 200 per cento.<br />
Il risk management<br />
per prevenire l’errore<br />
Alla nuova fi gura professionale<br />
del “manager del rischio” con la<br />
qualifi ca <strong>di</strong> <strong>di</strong>rigente, introdotta <strong>di</strong><br />
recente nella struttura sanitaria<br />
pubblica, è affi dato l’importante<br />
compito <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduazione degli errori<br />
nelle prestazioni me<strong>di</strong>co-chirurgiche<br />
e delle loro cause nonché<br />
<strong>di</strong> tutti gli altri fattori che hanno<br />
determinato e determinano eventi<br />
avversi a carico dei pazienti.<br />
Oggi tale delicato ruolo, che<br />
ha la chiara fi nalità <strong>di</strong> tutelare in<br />
modo più incisivo la salute <strong>di</strong> questi<br />
ultimi, non viene <strong>di</strong> certo agevolato<br />
dai sanitari autori degli errori<br />
in quanto, salvo rare eccezioni,<br />
ben pochi li ammettono e li segnalano.<br />
La conseguenza <strong>di</strong> tutto ciò<br />
è il ripetersi degli stessi che <strong>di</strong><br />
certo sarebbero stati scongiurati<br />
se per tempo segnalati alla <strong>di</strong>rezione<br />
della struttura che avrebbe potuto<br />
pre<strong>di</strong>sporre le misure più idonee<br />
per combatterli.<br />
L’errore si può evitare e prevenire<br />
solo quando lo si conosce<br />
molto bene. Per raggiungere un<br />
tale risultato, secondo autorevoli<br />
stu<strong>di</strong>osi, bisognerebbe far ricorso<br />
ad una pratica in uso nel settore<br />
aeronautico per migliorare la sicurezza<br />
dei voli ed evitare incidenti.<br />
Essa è basata sull’obbligo, a carico<br />
dei piloti della comunicazione,<br />
non solo degli errori da loro commessi<br />
ma anche delle situazioni <strong>di</strong><br />
rischio <strong>di</strong> volta in volta accertate e<br />
che potenzialmente avrebbero potuto<br />
determinare un incidente (cosiddette<br />
“near miss”).<br />
A tal proposito va ricordato<br />
che, proprio per la mancata segnalazione<br />
<strong>di</strong> una situazione del genere,<br />
ebbe qualche anno fa a verifi -<br />
carsi l’incidente all’aeroporto <strong>di</strong><br />
Milano-Linate con 140 morti. Un<br />
aereo <strong>di</strong> linea in fase <strong>di</strong> decollo si<br />
scontrò sulla pista con un piccolo<br />
aereo in manovra che proprio in<br />
quell’istante stava attraversando<br />
la pista <strong>di</strong> decollo. Il pilota del<br />
piccolo velivolo, per il mancato<br />
funzionamento del radar <strong>di</strong> terra<br />
(che era guasto da qualche mese),<br />
non aveva avuto la segnalazione<br />
del <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> entrare nella pista<br />
impegnata dall’aereo <strong>di</strong> linea. Il<br />
<strong>di</strong>sastro sarebbe stato <strong>di</strong> certo<br />
evitato se i piloti, che in precedenza<br />
avevano effettuato la medesima<br />
e pericolosa manovra con il<br />
radar <strong>di</strong> terra non funzionante<br />
avessero comunicato la situazione<br />
<strong>di</strong> rischio alle competenti autorità.<br />
Ciò avrebbe indotto gli organi competenti<br />
a porre imme<strong>di</strong>ato rime<strong>di</strong>o,<br />
attivandosi a far riparare l’apparecchiatura.<br />
Un tipo <strong>di</strong> misure analoghe<br />
basate sulla comunicazione ed informazione<br />
dovrebbero essere<br />
adottate nelle strutture sanitarie<br />
pubbliche e private per prevenire<br />
gli incidenti in corsia.<br />
Il primo passo è quello della<br />
promozione della cultura della prevenzione,<br />
che si attua attraverso il<br />
monitoraggio e la comunicazione<br />
degli errori, che coinvolga tutti coloro<br />
che operano nel mondo della<br />
sanità, ivi compresi i pazienti.<br />
Un’altra strada in parallelo è<br />
quella, già seguita con successo<br />
in molte strutture sanitarie, della<br />
check list e del rtuf. La prima si<br />
sostanzia in una elencazione minuziosa<br />
della situazione del paziente<br />
non solo anamnestica, ma<br />
comprensiva <strong>di</strong> ogni informazione<br />
attinente al suo stato fi sico ed<br />
alla patologia che ha determinato<br />
il ricorso alla cure ospedaliere. Il<br />
secondo, che è l’acronimo <strong>di</strong> registro<br />
unico del farmaco contiene,<br />
raccoglie tutte le informazioni sui<br />
farmaci prescritti ed assunti dal<br />
paziente.<br />
C’è, infi ne, una terza strada,<br />
che in futuro avrà <strong>di</strong> certo un considerevole<br />
sviluppo, già percorsa<br />
con successo nel centro trapianti<br />
dell’ospedale Le Molinette <strong>di</strong> Torino.<br />
Si tratta dell’utilizzo in sala<br />
operatoria della cosiddetta “scatola<br />
nera”. Si è fatto, cioè, ricorso ad<br />
un sistema <strong>di</strong> sicurezza proprio<br />
degli aerei per ricercare la cause<br />
degli incidenti. Colla scatola nera<br />
in sala operatoria vengono microfi<br />
lmati – ovviamente con il consenso<br />
dei pazienti – tutti gli interventi<br />
chirurgici. In tal modo si registra<br />
tutto ciò che ivi si verifi ca. Il che<br />
sortisce non solo l’effetto <strong>di</strong> prevenire<br />
nuovi incidenti ma anche <strong>di</strong><br />
facilitare la soluzione <strong>di</strong> eventuali<br />
controversie tra me<strong>di</strong>ci e pazienti.
La “Carta <strong>di</strong> Saint Vincent”<br />
La sua intestazione è: “Documento<br />
<strong>di</strong> consenso su errore e<br />
responsabilità nelle organizzazioni<br />
sanitarie complesse”. È stata<br />
messa a punto nella omonima località<br />
valdostana lo scorso 20 ottobre<br />
2010 per arginare la me<strong>di</strong>cina<br />
<strong>di</strong>fensiva. L’errore viene defi nito<br />
come «un evento da cui apprendere<br />
per evitare che si ripeta». La<br />
Carta precisa che è stato proprio<br />
l’eccessivo accanimento dei pazienti<br />
nel trascinare in giu<strong>di</strong>zio i<br />
me<strong>di</strong>ci ad incrementare la me<strong>di</strong>cina<br />
<strong>di</strong>fensiva. Ed il mancato arresto<br />
del fenomeno accompagnato dall’adozione<br />
da parte dei me<strong>di</strong>ci <strong>di</strong><br />
comportamenti inappropriati <strong>di</strong> tipo,<br />
appunto, <strong>di</strong>fensivo non solo<br />
ostacola la costruzione delle procedure<br />
utili ad intercettare gli errori<br />
prima che essi accadano ma<br />
comporta anche il serio rischio <strong>di</strong><br />
frenare il progresso scientifi co della<br />
me<strong>di</strong>cina.<br />
Contiene, quin<strong>di</strong>, l’invito ai<br />
pazienti a superare “la cultura<br />
della colpa” ad ogni costo del me<strong>di</strong>co<br />
nei casi in cui la prestazione<br />
non <strong>di</strong>a il risultato sperato in ragione<br />
<strong>di</strong> un presunto errore. E ciò in<br />
quanto il rischio <strong>di</strong> sbagliare è intrinseco<br />
nell’attività me<strong>di</strong>co-chirurgica.<br />
La Carta, poi, fa preciso obbligo<br />
ai me<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> dare la massima<br />
trasparenza al loro operato professionale<br />
attraverso la comunicazione<br />
al paziente degli eventuali errori<br />
commessi nel corso della prestazione<br />
professionale fornendo<br />
un’adeguata spiegazione sulle<br />
cause che li hanno determinati. E<br />
ciò per consolidare il rapporto <strong>di</strong><br />
fi ducia con il paziente. Auspica,<br />
altresì, lo sviluppo <strong>di</strong> nuovi sistemi<br />
della gestione del rischio clinico<br />
Fotolia<br />
L’incremento del<br />
contenzioso, che si è<br />
registrato in questi<br />
ultimi anni a carico<br />
dei me<strong>di</strong>ci, è in<br />
buona parte dovuto<br />
alla concezione che<br />
oggi si dà all’errore<br />
nella prestazione<br />
sanitaria.<br />
The increase in legal<br />
<strong>di</strong>sputes in recent<br />
years is the<br />
responsibility of<br />
physicians, and is<br />
largely due to the<br />
conception that<br />
nowadays is given to<br />
errors in healthcare.<br />
con un intervento normativo che<br />
ri<strong>di</strong>segni criteri più elastici e meno<br />
punitivi nell’attribuzione delle responsabilità<br />
penali e civili in sintonia<br />
con lo sviluppo della scienza e<br />
delle frontiere della me<strong>di</strong>cina del<br />
nuovo millennio, nonché dei compiti<br />
sempre più complessi e <strong>di</strong>ffi cili<br />
che essa assegna ai me<strong>di</strong>ci. Si<br />
pensi alle terapie con le cellule<br />
staminali e con i fattori <strong>di</strong> crescita<br />
nonché ai farmaci biologici. In un<br />
futuro non molto lontano non sarà<br />
più l’organo ad essere curato ma<br />
il genoma. E <strong>di</strong>fatti per sconfi ggere<br />
alcune gravi patologie che affl iggono<br />
l’uomo la soluzione si troverà<br />
nel DNA. Si passerà, quin<strong>di</strong>, dalla<br />
cura dell’organo a quella delle cellule,<br />
dalle cellule al nucleo cellulare<br />
e da questo al cromosoma e dal<br />
cromosoma al genoma.<br />
In defi nitiva nella “Carta <strong>di</strong><br />
Saint Vincent” i me<strong>di</strong>ci riba<strong>di</strong>scono<br />
che essi, così come hanno<br />
fatto per il passato, vogliono prendersi<br />
cura dei pazienti, ma desiderano<br />
che tale impegno deontologico<br />
venga dai medesimi ricambiato<br />
colla massima fi ducia nella<br />
loro capacità professionale. La<br />
loro <strong>di</strong>sponibilità al <strong>di</strong>alogo, la risposta<br />
alle domande, la voglia <strong>di</strong><br />
combattere i propri errori deve<br />
rappresentare per i pazienti la<br />
migliore garanzia della correttezza<br />
del loro operare.<br />
Indubbiamente i tempi sono<br />
maturi anche per una ridefi nizione<br />
del concetto <strong>di</strong> responsabilità me<strong>di</strong>ca<br />
proprio in ragione del tipo <strong>di</strong><br />
prestazione che i sanitari del nuovo<br />
millennio saranno chiamati ad<br />
effettuare. Se, infatti oggi un chirurgo<br />
in venti anni <strong>di</strong> attività ha<br />
ottanta probabilità su cento <strong>di</strong> ricevere<br />
un avviso <strong>di</strong> garanzia, in futuro,<br />
se non cambia la vigente normativa,<br />
queste probabilità passeranno<br />
al cento per cento.<br />
L’attuazione dei principi in<strong>di</strong>cati<br />
nella “Carta <strong>di</strong> Saint Vincent”<br />
nel facilitare la ricerca <strong>di</strong> nuovi<br />
percorsi terapeutici potrà ricreare<br />
il rapporto <strong>di</strong> fi ducia fra me<strong>di</strong>co e<br />
paziente con il superamento della<br />
me<strong>di</strong>cina <strong>di</strong>fensiva.<br />
E <strong>di</strong> ciò ne trarrà un grande<br />
ed incalcolabile benefi cio la salute<br />
<strong>di</strong> tutti noi.<br />
GIUSTIZIA 79
La Costituzione Italiana<br />
Conoscerla<br />
per amarla<br />
FRANCESCO SAVERIO CERRACCHIO<br />
Presidente Vicario e <strong>di</strong> Sezione<br />
del Tribunale <strong>di</strong> <strong>Sondrio</strong><br />
The Italian Constitution.<br />
To know it is to love it<br />
Not only are the choices we make often unproductive. Sometimes<br />
we destroy even our greatest achievements. A recently approved<br />
law had introduced the teaching of “Citizenship and the<br />
Constitution”, but we quickly decided against it and filed that<br />
fundamental issue away in a historical curricular <strong>di</strong>scussion.<br />
It seems that the Charter proclaiming our basic values, born out of<br />
the Risorgimento and which balances political power with great<br />
patience, is to be used accor<strong>di</strong>ng to one’s personal convenience.<br />
The tense relations existing between the magistracy and the<br />
political system are a perfect example. Our Constitution, an old<br />
yet healthy old lady, should be abided by for the good of all.<br />
80 GIUSTIZIA<br />
Non si può amare la Costituzione<br />
se non la si<br />
conosce. Non si può<br />
apprezzarla, ma neppure<br />
giu<strong>di</strong>carla, se non si conoscono<br />
i principi e i valori in essa<br />
contenuti.<br />
La conoscenza è, infatti, un<br />
presupposto in<strong>di</strong>spensabile per<br />
esprimere qualsiasi giu<strong>di</strong>zio, positivo<br />
o negativo, favorevole o critico.<br />
Un giu<strong>di</strong>zio dato senza un’adeguata<br />
conoscenza del fatto o della<br />
questione in esame non può<br />
costituire una corretta valutazione,<br />
giusta o sbagliata che sia, e<br />
può dar luogo soltanto a possibili<br />
pregiu<strong>di</strong>zi.<br />
Ebbene, sembra logico e doveroso,<br />
alla luce <strong>di</strong> quanto sopra<br />
detto, ritenere che la nostra Costi-<br />
tuzione, la cui importanza non può<br />
essere <strong>di</strong>sconosciuta, essendo la<br />
legge fondamentale dello Stato<br />
Italiano, sia insegnata nelle scuole<br />
come materia autonoma. Ed infatti,<br />
sia pure tar<strong>di</strong>vamente, la legge<br />
n. 169 del 2008 ha istituito l’insegnamento<br />
<strong>di</strong> “Citta<strong>di</strong>nanza e Costituzione”<br />
come <strong>di</strong>sciplina autonoma<br />
con l’obiettivo appunto <strong>di</strong> insegnare<br />
i valori della convivenza civile<br />
e il rispetto della legalità nelle<br />
scuole <strong>di</strong> ogni or<strong>di</strong>ne e grado.<br />
Obiettivo questo <strong>di</strong> grande rilievo e<br />
signifi cato etico-sociale nell’attuale<br />
periodo storico caratterizzato da<br />
una larga e <strong>di</strong>ffusa illegalità a tutti<br />
i livelli e da un generale indebolimento<br />
del senso civico.<br />
Ma le buone intenzioni hanno<br />
avuto breve durata in quanto nell’ottobre<br />
dell’anno scorso inspiegabilmente<br />
il Ministero dell’Istruzione<br />
con la circolare n. 86 ha <strong>di</strong>sposto<br />
che “Citta<strong>di</strong>nanza e Costituzione”<br />
non doveva più considerarsi una<br />
materia autonoma, ma che essa<br />
doveva rientrare nell’ambito storico-geografi<br />
co o storico-sociale e<br />
non aveva <strong>di</strong>ritto ad una autonoma<br />
valutazione.<br />
Così la Costituzione ha perso<br />
la rilevanza che giustamente le era<br />
stata riconosciuta ed è ritornata<br />
ad essere considerata una materia<br />
secondaria come è sempre<br />
stata fi n dai tempi in cui era compresa<br />
nell’insegnamento <strong>di</strong> “storia<br />
ed educazione civica”. Peccato,<br />
perché ben altra considerazione<br />
meriterebbero i suoi principi ed i<br />
suoi valori che costituiscono il patrimonio<br />
ideale della nostra storia<br />
e della nostra identità nazionale.<br />
In occasione del 150° anniversario<br />
dell’Unità d’Italia è doveroso<br />
ricordare la nostra Costituzione,<br />
che è, come si è detto, la<br />
Carta fondamentale dello Stato<br />
Italiano.<br />
Essa ha ormai più <strong>di</strong> sessant’anni<br />
essendo stata promul-<br />
gata dal Capo provvisorio dello<br />
Stato, Enrico De Nicola, il 27 <strong>di</strong>cembre<br />
1947, ed è la più anti ca Costituzione<br />
scritta europea, e sclusa<br />
quella inglese che è orale. Essa<br />
costituisce la Carta dei principi e<br />
dei valori che sono alla base del<br />
patto <strong>di</strong> convivenza civile e dell’or<strong>di</strong>namento<br />
repubblicano e democratico<br />
del popolo e dello Stato<br />
Italiano.<br />
Il grande giurista e padre della<br />
Costituzione, Piero Calamandrei,<br />
nel <strong>di</strong>scorso ai giovani tenuto<br />
alla Società Umanitaria a Milano il<br />
26 gennaio 1956, <strong>di</strong>sse: «Se voi<br />
volete andare in pellegrinaggio nel<br />
luogo dove è nata la nostra Costituzione,<br />
andate nelle montagne<br />
dove caddero i partigiani, nelle<br />
carceri dove furono imprigionati,<br />
nei campi dove furono impiccati.<br />
Dovunque è morto un italiano per<br />
riscattare la libertà e la <strong>di</strong>gnità,<br />
andate lì, o giovani, col pensiero,<br />
perché lì è nata la nostra Costituzione».<br />
Storia, natura e caratteristiche<br />
della Costituzione<br />
Il quadro storico, politico ed<br />
economico era molto <strong>di</strong>verso da<br />
quello attuale quando si cominciò<br />
a costruire la nostra Costituzione.<br />
L’Italia stava uscendo dalla guerra<br />
e dalla <strong>di</strong>ttatura. Muoveva i primi<br />
passi verso la democrazia.<br />
L’Assemblea costituente si<br />
riunì per la prima volta il 25 giugno<br />
1946 a Palazzo Montecitorio. Il<br />
testo defi nitivo venne approvato il<br />
27 <strong>di</strong>cembre 1947 con il 90% dei<br />
voti ed entrò in vigore il 1° gennaio<br />
1948.<br />
Giuseppe Saragat nel <strong>di</strong>scorso<br />
inaugurale tenuto all’Assemblea<br />
costituente il giorno 26 giugno<br />
1946 <strong>di</strong>sse: «Fate che il volto<br />
<strong>di</strong> questa Repubblica sia un volto<br />
umano. Ricordatevi che la democrazia<br />
non è soltanto un rapporto<br />
tra maggioranza e minoranza, non
è soltanto un armonico equilibrio<br />
<strong>di</strong> poteri sotto il presi<strong>di</strong>o <strong>di</strong> quello<br />
sovrano della Nazione, ma è soprattutto<br />
un problema <strong>di</strong> rapporti<br />
fra uomo e uomo. Dove questi<br />
rapporti sono umani, la democrazia<br />
esiste, dove sono inumani,<br />
essa non è che la maschera <strong>di</strong> una<br />
nuova tirannide».<br />
La Costituzione non è una<br />
legge come le altre. Rappresenta<br />
il fondamento della nostra democrazia.<br />
È la Carta dei valori fondamentali,<br />
dei <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> tutti e delle<br />
regole per tutti. È il prodotto <strong>di</strong> un<br />
popolo che usciva sconfi tto dalla<br />
guerra e <strong>di</strong> una nazione che ha<br />
fatto propri i principi del costituzionalismo<br />
liberale e democratico. È<br />
il prodotto della convergenza <strong>di</strong><br />
forze e ideologie <strong>di</strong>verse nell’affermazione<br />
<strong>di</strong> valori e principi comuni.<br />
Conoscere la Costituzione<br />
signifi ca, innanzi tutto, ricordare il<br />
contesto storico, sociale e politico<br />
nel quale essa fu emanata.<br />
Dopo un <strong>di</strong>battito politico appassionato<br />
e <strong>di</strong> altissimo livello<br />
confl uirono nel testo della Costituzione<br />
tre gran<strong>di</strong> fi loni politici ideali,<br />
rappresentati dalle tre personalità<br />
che lo sottoscrissero: Enrico De<br />
Nicola, capo provvisorio dello Stato,<br />
Umberto Terracini, presidente<br />
dell’Assemblea costituente, Alcide<br />
De Gasperi, presidente del Consiglio.<br />
Essi <strong>di</strong>edero luogo ad un compromesso<br />
elevato, ad un grande<br />
patto costituente in cui esprimere<br />
Olycom<br />
Come asseriva il<br />
grande giurista e<br />
uomo politico Piero<br />
Calamandrei<br />
(1889-1956), la<br />
nostra è una<br />
Costituzione che<br />
viene dal<br />
Risorgimento e in<br />
essa vi sono le<br />
tracce delle nostre<br />
cultura e storia.<br />
As the great jurist<br />
and politician Piero<br />
Calamandrei<br />
(1889-1956) said,<br />
ours is a<br />
Constitution which<br />
comes from the<br />
Risorgimento and<br />
there are traces of<br />
our culture and<br />
history in it.<br />
La Costituzione<br />
Italiana è stata<br />
approvata il 27<br />
<strong>di</strong>cembre 1947.<br />
The Italian<br />
Constitution was<br />
approved on 27th<br />
December 1947.<br />
sia i principi naturali dell’uomo sia<br />
i valori della rinascita del Paese e<br />
della futura convivenza.<br />
Fu certamente questo il primo<br />
“miracolo italiano”: quello <strong>di</strong> un<br />
Paese sconfi tto e <strong>di</strong>viso, che seppe<br />
maturare e formulare un alto<br />
programma <strong>di</strong> democrazia, libertà,<br />
uguaglianza, solidarietà.<br />
Conoscere la Costituzione<br />
signifi ca, anche, capire che i principi<br />
ed i valori espressi sono il<br />
frutto della con<strong>di</strong>visione <strong>di</strong> un impegno<br />
comune a rispettarli e ad<br />
attuarli, nonostante le <strong>di</strong>versità<br />
politiche ed ideologiche.<br />
Essi sono e devono restare<br />
patrimonio <strong>di</strong> tutti, non <strong>di</strong> una<br />
maggioranza o <strong>di</strong> un’opposizione,<br />
e sono principi tuttora vali<strong>di</strong> ed<br />
attuali perché ra<strong>di</strong>cati nella coscienza<br />
e nella natura dell’uomo.<br />
Nella Costituzione repubblicana<br />
ci sono la nostra cultura e la<br />
nostra storia. È una Costituzione<br />
venuta dal Risorgimento, come<br />
<strong>di</strong>ceva Piero Calamandrei, il quale<br />
nel <strong>di</strong>scorso fatto ai giovani nel<br />
ventennale della Costituzione appunto<br />
affermava: «Quando io leggo<br />
nell’art. 2 (l’adempimento dei<br />
doveri inderogabili <strong>di</strong> solidarietà,<br />
politica, economica e sociale) o<br />
quando leggo nell’art. 11 (l’Italia<br />
ripu<strong>di</strong>a la guerra come strumento<br />
<strong>di</strong> offesa alla libertà <strong>di</strong> altri popoli),<br />
“la patria italiana in mezzo alle<br />
altre patrie”, ma questo è Mazzini!<br />
O quando io leggo nell’art. 8 (tutte<br />
le confessioni religiose sono<br />
ugualmente libere davanti alla legge),<br />
ma questo è Cavour! O quando<br />
io leggo nell’art. 5 (la Repubblica,<br />
una ed in<strong>di</strong>visibile, riconosce e<br />
promuove le autonomie locali), ma<br />
questo è Cattaneo! O quando<br />
nell’art. 52 io leggo, a proposito<br />
delle forze armate (l’or<strong>di</strong>namento<br />
delle forze armate si informa allo<br />
spirito democratico della Repubblica),<br />
e questo è Garibal<strong>di</strong>! O<br />
quando leggo all’art. 27 (non è<br />
ammessa la pena <strong>di</strong> morte), ma<br />
questo è Beccaria! Dietro ogni<br />
articolo <strong>di</strong> questa Costituzione o<br />
giovani, voi dovete vedere giovani<br />
come voi, caduti combattendo,<br />
fucilati, impiccati, torturati, morti<br />
<strong>di</strong> fame nei campi <strong>di</strong> concentramento,<br />
morti in Russia, morti in<br />
Africa, morti per le strade <strong>di</strong> Milano,<br />
per le strade <strong>di</strong> Firenze, che<br />
hanno dato la vita perché la libertà<br />
e la giustizia potessero essere<br />
scritte su questa Carta. Questo è<br />
un testamento, un testamento <strong>di</strong><br />
centomila morti».<br />
Questo passo del <strong>di</strong>scorso<br />
del Calamandrei è una lettura obbligata<br />
per conoscere la nostra Costituzione<br />
e per collegarla al 150°<br />
anniversario dell’Unità d’Italia.<br />
GIUSTIZIA 81<br />
Fototeca Gilar<strong>di</strong>
Stato <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto,<br />
<strong>di</strong>visione ed equilibrio dei poteri<br />
La contrapposizione fra i partiti<br />
e l’incertezza sul futuro rendevano<br />
inevitabile il ricorso ad una<br />
impostazione garantista, che prevedeva<br />
la <strong>di</strong>visione e l’equilibrio fra<br />
i poteri per evitare il rischio <strong>di</strong> un<br />
nuovo autoritarismo. Non <strong>di</strong>mentichiamo<br />
che uscivamo da un lungo<br />
periodo <strong>di</strong> <strong>di</strong>ttatura.<br />
Fu pertanto applicato il principio<br />
della separazione dei poteri<br />
(legislativo, esecutivo, giu<strong>di</strong>ziario)<br />
teorizzato dal barone <strong>di</strong> Montesquieu.<br />
Nella sua opera Lo spirito<br />
delle leggi il Montesquieu affermò<br />
il principio «che il potere arresti il<br />
potere», intendendo appunto <strong>di</strong>re<br />
che i poteri fossero affi dati a mani<br />
<strong>di</strong>verse e non alle stesse persone<br />
o istituzioni, per evitare sconfi namenti<br />
e degenerazioni.<br />
Saggiamente, dunque, i nostri<br />
Padri costituenti costruirono uno<br />
Stato <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto, basato sulla <strong>di</strong>visione<br />
dei poteri, in cui però nessun<br />
potere è assoluto, neppure quello<br />
del popolo, che è sovrano ma la<br />
sovranità la esercita «nelle forme e<br />
nei limiti della Costituzione» (art. 1).<br />
Non è assoluto il potere legislativo<br />
costituito dalle due Camere<br />
che esercitano la funzione<br />
legislativa.<br />
Le leggi, infatti, sono soggette<br />
al controllo preventivo <strong>di</strong> costituzionalità<br />
del presidente della Repubblica,<br />
che prima <strong>di</strong> promulgarle<br />
può chiedere alle Camere una<br />
nuova deliberazione (art. 74) e al<br />
controllo eventuale e successivo<br />
della Corte Costituzionale, che, se<br />
investita, può annullarle anche<br />
parzialmente (art. 134).<br />
Non è assoluto, inoltre, il potere<br />
esecutivo.<br />
Il Governo, composto dal presidente<br />
del Consiglio e dai ministri,<br />
deve avere la fiducia delle due<br />
Camere, che possono accordarla<br />
o revocarla (art. 94). Il presidente<br />
della Repubblica nomina il presidente<br />
del Consiglio e, su proposta<br />
<strong>di</strong> questo, i ministri. Gli atti del<br />
Governo sono soggetti al controllo<br />
preventivo <strong>di</strong> legittimità della Corte<br />
dei Conti e anche a quello successivo<br />
sulla gestione del bilancio<br />
dello Stato (art. 100).<br />
82 GIUSTIZIA<br />
La Pubblica Amministrazione<br />
deve seguire criteri <strong>di</strong> buon andamento<br />
e <strong>di</strong> imparzialità ità (art. 97).<br />
Contro gli atti della P.A. è<br />
sempre ammessa<br />
la tutela giuris<strong>di</strong>zionale<br />
(art. 113).<br />
Non è assoluto,<br />
infine, il potere<br />
giu<strong>di</strong>ziario.<br />
I giu<strong>di</strong>ci sono o<br />
soggetti soltanto alla a<br />
legge (art. 101). La a<br />
magistratura costituiuisce un or<strong>di</strong>ne autononomo e in<strong>di</strong>pendente da<br />
ogni altro potere (art. art.<br />
104). I magistrati sono ono<br />
governati dal Consiglio iglio<br />
Superiore della Magistrastratura, al quale spettano no le<br />
assunzioni, le assegnazioni azioni<br />
ed i trasferimenti, le promozioni<br />
ed i provve<strong>di</strong>menti enti<strong>di</strong><strong>di</strong>sciplinari (art. 105). Il C.S.M.<br />
è presieduto dal presidente sidente<br />
della Repubblica ed è compo<br />
sto per due terzi da componenti<br />
eletti da tutti i magistrati or<strong>di</strong>nari<br />
e per un terzo dal Parlamento (art.<br />
104). Il ministro della Giustizia ha<br />
facoltà <strong>di</strong> promuovere l’azione <strong>di</strong>sciplinare<br />
(art. 107). A lui spettano<br />
l’organizzazione e il funzionamento<br />
dei servizi relativi alla giustizia (art.<br />
110). Il pubblico ministero ha l’obbligo<br />
<strong>di</strong> esercitare l’azione penale<br />
(art. 112). I magistrati sono inamovibili.<br />
Non possono essere <strong>di</strong>spensati<br />
o sospesi dal servizio né destinati<br />
ad altre se<strong>di</strong> o funzioni se<br />
non con il loro consenso o in seguito<br />
a decisione del C.S.M. con le<br />
garanzie <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa stabilite dall’or<strong>di</strong>namento<br />
giu<strong>di</strong>ziario (art. 107).<br />
Va evidenziato che l’in<strong>di</strong>pendenza<br />
della magistratura è uno dei<br />
principi fondamentali della Costituzione<br />
sancito a tutela dell’uguale e<br />
imparziale applicazione della legge<br />
nei confronti <strong>di</strong> tutti i citta<strong>di</strong>ni.<br />
Solo magistrati in<strong>di</strong>pendenti, infatti,<br />
possono garantire l’imparzialità<br />
e l’uguaglianza dei citta<strong>di</strong>ni davanti<br />
alla legge.<br />
Tale in<strong>di</strong>pendenza, dunque,<br />
non costituisce un privilegio o una<br />
prerogativa a tutela dei magistrati<br />
o <strong>di</strong> una corporazione, bensì una<br />
garanzia per i citta<strong>di</strong>ni posta a<br />
La nostra banca, nel<br />
1978, in occasione<br />
della “Giornata<br />
Mon<strong>di</strong>ale del<br />
Risparmio” ha<br />
donato a tutti gli<br />
studenti valtellinesi<br />
una copia della<br />
Costituzione Italiana:<br />
Carta dei valori<br />
fondamentali, dei<br />
<strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> tutti e delle<br />
regole per tutti.<br />
Our bank, in 1978,<br />
on the “World Day<br />
of Saving” gave all<br />
pupils in the<br />
Valtellina a copy<br />
of the Italian<br />
Constitution:<br />
a Charter<br />
of fundamental<br />
values, rights for all<br />
and rules for all.<br />
salvaguar<strong>di</strong>a <strong>di</strong> valori costituzionalmente<br />
protetti come l’imparzia-<br />
lità della funzione giu<strong>di</strong>ziaria e<br />
l’uguaglianza l’uguaglia dei citta<strong>di</strong>ni da-<br />
vanti alla<br />
legge.<br />
Naturalmente Na<br />
l’in<strong>di</strong>pen-<br />
denza non n è assoluta perché<br />
si è voluto vo evitare il rischio<br />
che la<br />
magistratura potesse<br />
costituire costitu un corpo separato<br />
dello Stato. La separazione<br />
dagli altri poteri non è net-<br />
ta e totale, in quanto sono<br />
previsti prev nella stessa Costituzione<br />
tuzi un bilanciamento<br />
e uun<br />
equilibrio sia con il<br />
potere po legislativo, che<br />
deve de emanare le leggi<br />
alle a quali i giu<strong>di</strong>ci sono<br />
esclusivamente e<br />
soggetti<br />
g e che deve regolamentare<br />
m l’esercizio<br />
della funzione giuris<strong>di</strong>zionale<br />
e organizzare<br />
gli uffi ci giu<strong>di</strong>ziari, sia<br />
con il potere pot esecutivo, al qua-<br />
le spetta aattraverso<br />
il ministro<br />
della Giustizia la sorveglianza sugli<br />
uffi ci giu<strong>di</strong>ziari con la facoltà <strong>di</strong><br />
promuovere ispezioni e <strong>di</strong> esercitare<br />
l’azione <strong>di</strong>sciplinare nei confronti<br />
dei magistrati.<br />
Ma il raccordo più signifi cativo<br />
tra potere giu<strong>di</strong>ziario e potere<br />
politico è stato previsto nella composizione<br />
del C.S.M. con la presenza<br />
<strong>di</strong> un terzo dei componenti<br />
designati dal Parlamento tra i quali<br />
deve anche essere scelto il vice<br />
presidente.<br />
Rapporti<br />
tra magistratura e politica<br />
I rapporti tra magistratura e<br />
politica in Italia non sono mai<br />
stati i<strong>di</strong>lliaci, ma negli ultimi tempi<br />
essi sono <strong>di</strong>ventati più tesi e confl<br />
ittuali.<br />
Venuta meno l’immunità parlamentare,<br />
abolita nel 1993, l’azione<br />
penale, che è obbligatoria, è<br />
stata esercitata liberamente e<br />
cioè senza alcun fi ltro preventivo,<br />
come una volta, nei confronti dei<br />
politici, anche <strong>di</strong> primo piano. Naturalmente,<br />
sono seguite inevitabili<br />
strumentalizzazioni politiche e<br />
rilevanti conseguenze sul sistema<br />
politico. Può essere anche accaduto<br />
qualche eccesso, errore o
sconfi namento e le critiche in proposito<br />
sono sempre legittime, ma<br />
le reazioni a volte sono state esagerate<br />
o scomposte tanto da tradursi,<br />
in alcuni casi, nella denigrazione<br />
o ad<strong>di</strong>rittura nella delegittimazione<br />
<strong>di</strong> singoli magistrati o uffi ci<br />
giu<strong>di</strong>ziari o dell’intera magistra tura.<br />
I rapporti tra magistratura e<br />
politica sono correttamente regolati<br />
dalla Costituzione che ha previsto<br />
per i singoli poteri funzioni e<br />
ruoli <strong>di</strong>versi e separati, inserendoli<br />
in un sistema equilibrato che ne<br />
regola l’or<strong>di</strong>nato funzionamento e<br />
ne evita possibili sconfi namenti o<br />
degenerazioni.<br />
Più volte il presidente della<br />
Repubblica, supremo garante della<br />
Costituzione, è giustamente intervenuto<br />
per invitare i magistrati<br />
a rispettare le prerogative dei parlamentari<br />
e i politici a rispettare<br />
l’attività della magistratura. Recentemente<br />
il presidente Napolitano,<br />
in occasione della celebrazione<br />
della “Giornata dell’Informazione”<br />
è tornato ad invitare magistrati<br />
e politici al rispetto reciproco e<br />
a sollecitare l’equilibrio tra chi «è<br />
costituzionalmente deputato ad<br />
esercitare il controllo <strong>di</strong> legalità<br />
ed ha l’obbligo <strong>di</strong> esercitare l’azione<br />
penale», cioè i magistrati, e<br />
chi svolge funzioni <strong>di</strong> rappresentanza<br />
<strong>di</strong> governo nel quadro istituzionale<br />
e secondo le regole<br />
della Costituzione. Riguardo alla<br />
giuris<strong>di</strong>zione, ha aggiunto il presidente,<br />
vanno ricercate soluzioni e<br />
scelte organiche con<strong>di</strong>vise «capaci<br />
<strong>di</strong> risolvere alla ra<strong>di</strong>ce il problema<br />
della giustizia».<br />
Ma il faro non può che essere<br />
la Costituzione, ove sono già contenuti,<br />
secondo il capo dello Stato,<br />
i principi generali, le norme e le<br />
procedure con le quali si possano<br />
far valere sia le ragioni della legalità<br />
sia le garanzie del giusto processo.<br />
Il problema dei rapporti tra<br />
politica e magistratura va, dunque,<br />
risolto osservando rigorosamente<br />
i limiti delle rispettive competenze<br />
senza invasioni <strong>di</strong> campo o interferenze<br />
e strumentalizzazioni.<br />
Va infi ne rilevato che l’ineffi -<br />
cienza del sistema giustizia non<br />
<strong>di</strong>pende dall’assetto or<strong>di</strong>namenta-<br />
Angiolino Alfano,<br />
Ministro della<br />
Giustizia, e Michele<br />
Vietti, vicepresidente<br />
del Consiglio<br />
Superiore della<br />
Magistratura.<br />
Angiolino Alfano,<br />
Minister of Justice<br />
and Michele Vietti,<br />
Deputy President<br />
of the Higher Council<br />
of the Ju<strong>di</strong>ciary.<br />
le e dall’equilibrio dei poteri delineato<br />
dalla Costituzione, che costituisce<br />
anzi un punto <strong>di</strong> riferimento<br />
nel mondo. Pertanto, le annunciate<br />
riforme costituzionali della giustizia<br />
(<strong>di</strong>versa composizione del<br />
C.S.M., ruolo e poteri del P.M. e del<br />
ministro della Giustizia) non risolverebbero<br />
i problemi della giustizia<br />
e mo<strong>di</strong>fi cherebbero negativamente<br />
proprio quel delicato equilibrio<br />
tra i poteri <strong>di</strong>segnati dalla Carta<br />
Costituzionale.<br />
Modernità e attualità<br />
della Costituzione<br />
La Costituzione non è un testo<br />
superato. A <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> tanti<br />
anni si può <strong>di</strong>re che è una Carta<br />
ancora viva, moderna ed attuale. I<br />
suoi principi, già recepiti nella Dichiarazione<br />
universale dei <strong>di</strong>ritti<br />
dell’uomo proclamata dall’Assemblea<br />
delle Nazioni Unite nel <strong>di</strong>cembre<br />
del 1948, sono stati recentemente<br />
riconosciuti anche dall’Unione<br />
europea con il trattato <strong>di</strong> Lisbona<br />
entrato in vigore il 1°<br />
<strong>di</strong>cembre 2009.<br />
Il senatore Andreotti ha defi -<br />
nito la nostra Costituzione «un<br />
mobile antico <strong>di</strong> grande valore» ed<br />
ha aggiunto che se tutti i tentativi<br />
<strong>di</strong> cambiarla sono falliti vuol <strong>di</strong>re<br />
che «quel mobile antico ha più valore<br />
<strong>di</strong> uno nuovo».<br />
Essa è ad<strong>di</strong>rittura una Costituzione<br />
profetica laddove nell’art.<br />
Olycom<br />
11 contempla la possibilità <strong>di</strong> rinunciare<br />
parzialmente alla sovranità<br />
a parità <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zioni con gli altri<br />
Stati per assicurare la pace e la<br />
giustizia fra le Nazioni. Questo<br />
principio, che è stato giustamente<br />
defi nito una fi nestra sull’Europa,<br />
ha reso possibile il nostro ingresso<br />
nell’Unione europea.<br />
Eppure, è <strong>di</strong>ffusa l’opinione<br />
che la Costituzione sia comunque<br />
superata e vada sostituita. Si invoca<br />
la necessità <strong>di</strong> semplifi care e <strong>di</strong><br />
rendere più stabili i Governi e più<br />
veloci i processi decisionali (la cosiddetta<br />
governabilità).<br />
Non si intende toccare i principi<br />
e i <strong>di</strong>ritti fondamentali sanciti<br />
nella prima parte della Costituzione,<br />
bensì si vuole mo<strong>di</strong>fi care profondamente<br />
la seconda parte,<br />
quella de<strong>di</strong>cata all’Or<strong>di</strong>namento<br />
della Repubblica, assegnando<br />
alle Regioni maggiore autonomia,<br />
aumentando i poteri del capo del<br />
Governo, mo<strong>di</strong>fi cando l’organizzazione<br />
parlamentare, riducendo il<br />
numero dei deputati e dei senatori<br />
e introducendo il Senato federale.<br />
Tali mo<strong>di</strong>fi che, se ritenute<br />
necessarie, potranno essere introdotte<br />
a con<strong>di</strong>zione però che non<br />
stravolgano l’impianto costituzionale,<br />
tuttora valido, e che raccolgano<br />
una larga convergenza <strong>di</strong> consensi<br />
in Parlamento, perché è evidente<br />
che una riforma costituzionale<br />
richiede un’ampia con<strong>di</strong>visione<br />
politica e non può essere approvata<br />
da un’esigua maggioranza. Ci si<br />
augura anche che eventuali riforme<br />
vengano fatte secondo lo spirito<br />
e la coesione con cui la Costituzione<br />
fu approvata, affi nché la<br />
stessa continui ad essere percepita<br />
come la legge fondamentale <strong>di</strong><br />
tutti e non <strong>di</strong> una sola parte.<br />
Giustamente il capo dello<br />
Stato, Giorgio Napolitano, in occasione<br />
dell’inaugurazione al Quirinale<br />
delle celebrazioni per il 60° anniversario<br />
della Costituzione ha<br />
paragonato la nostra Costituzione<br />
ad una «signora in buona salute e<br />
tuttavia con qualche ruga, qualche<br />
inevitabile segno dell’età, che si<br />
possono eliminare, lasciando però<br />
intatto e ben riconoscibile il suo<br />
volto».<br />
GIUSTIZIA 83
Valchiavenna. Cascata presso l’Alpe Campo, in Val Garzelli (foto Mauro Lanfranchi)
86 INCONTRI BPS<br />
Fede e scienza<br />
La mia non è e non può essere una presentazione dell’illustre<br />
ospite, in quanto è un ospite che si presenta da sé, essendo<br />
universalmente conosciuto.<br />
Detto questo, saluto le autorità, le religiose, i religiosi<br />
presenti e tutti Voi signore e signori, dando il benvenuto.<br />
Un affettuoso e caloroso saluto, in uno con la riconoscenza,<br />
è per il conferen ziere Si gnor Car<strong>di</strong>nale Gianfranco Ravasi,<br />
innalzato alla porpora da poco più <strong>di</strong> un mese (20 novembre)<br />
con una suggestiva cerimonia, alla quale ho presen ziato insieme<br />
con il <strong>di</strong>rettore generale Pedranzini.<br />
Mi unisco alla letizia della comunità dei credenti, formulando<br />
al nuovo Prin cipe della Chiesa – nominato dal Santo<br />
Padre, <strong>di</strong> cui è collabo ra tore, con la prerogativa <strong>di</strong> far parte del<br />
Collegio car<strong>di</strong>nalizio che ha il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> elezione dei nuovi papi<br />
– fervi<strong>di</strong>ssimi auguri <strong>di</strong> ogni bene.<br />
Ringrazio Maria Teresa e Anna Maria, sorelle del conferenziere,<br />
per la gra <strong>di</strong>ta presenza.<br />
La conferenza <strong>di</strong> questa sera è la nona che il rinomato<br />
biblista Gianfranco tiene in questa sala. La sua voce è quella (mi<br />
sia consentita l’e spressione) del car <strong>di</strong>nale dalla bocca d’oro,<br />
novello “crisostomo”, voce che acquista portata sempre più vasta<br />
e risonanza più larga. Come tutti i gran<strong>di</strong> personaggi, suscita<br />
intorno a sé ammirazione ed entusiasmo per i doni della sua<br />
eloquenza.<br />
Tema dell’incontro è “Fede e scienza”. Un binomio che ne<br />
richiama un altro: uomo e religione. Voglio ricordare due libri in<br />
argomento, scritti re cente mente da Sua Eminenza – e<strong>di</strong>zione<br />
Mondadori: l’uno “500 curiosità della Fede”; l’altro “150 risposte<br />
ai perché <strong>di</strong> chi crede e <strong>di</strong> chi non crede”. Mi permetto inoltre<br />
<strong>di</strong> citare un’antologia a cura <strong>di</strong> Umberto Casale, che sta spopolando,<br />
intitolata “Fede e scienza. Un <strong>di</strong>alogo necessario” e che<br />
riunisce alcuni dei più importanti testi scritti da Joseph Ratzinger,<br />
prima come car<strong>di</strong>nale e poi da pontefi ce.<br />
Non poche sono le massime sul binomio ricordato. Mi<br />
permetto <strong>di</strong> ricor darne due. Einstein: «La scienza senza la<br />
religione è zoppa; la reli gione senza la scienza è cieca». Trilussa:<br />
«Credo in Dio onnipotente ma... ci hai quarche dubbio? Tiettelo<br />
per te. La Fede è bella senza li chissà, senza li come e senza li<br />
perché».<br />
Grazie!<br />
Piero Melazzini<br />
Presidente della <strong>Banca</strong> <strong>Popolare</strong> <strong>di</strong> <strong>Sondrio</strong><br />
SALA “FABIO BESTA” DELLA BANCA POPOLARE DI SONDRIO<br />
SONDRIO, MERCOLEDÌ 22 DICEMBRE 2010<br />
Foto Sgual<strong>di</strong>no
CARD. GIANFRANCO RAVASI<br />
Presidente del Pontifi cio Consiglio<br />
della Cultura e delle Pontifi cie<br />
Commissioni per i Beni Culturali<br />
della Chiesa e <strong>di</strong> Archeologia Sacra<br />
La rifl essione che ora proponiamo<br />
suppone, da un<br />
lato, un orizzonte immenso<br />
<strong>di</strong>ffi cilmente esauribile<br />
all’interno <strong>di</strong> un saggio e ancor<br />
più <strong>di</strong> un intervento sintetico; d’altro<br />
lato, costringe a inerpicarsi su<br />
sentieri d’altura, considerando la<br />
complessità dei meto<strong>di</strong> e dei temi<br />
che sono coinvolti. Cercheremo,<br />
allora, <strong>di</strong> attestarci solo sul piano<br />
<strong>di</strong> un <strong>di</strong>scorso generale riguardante<br />
i rapporti tra fede e scienza così<br />
come si sono confi gurati e si confi<br />
gurano. Presenteremo semplicemente<br />
in modo sommario i percorsi<br />
principali seguiti dalle due <strong>di</strong>scipline,<br />
scienza e teologia, nel loro<br />
confrontarsi, spesso sospettoso e<br />
fi n <strong>di</strong>alettico per non <strong>di</strong>re antitetico.<br />
Il “caso Galileo” rimane – nonostante<br />
tutte le puntualizzazioni<br />
e le precisazioni storiografi che –<br />
una sorta <strong>di</strong> vessillo sempre sventolato<br />
e il tribunale della storia è<br />
ancora aperto non tanto per un<br />
giu<strong>di</strong>zio sul passato, quanto piuttosto<br />
come monito minaccioso e<br />
mai archiviato per il presente e il<br />
futuro dei rapporti tra scienza e<br />
teologia. Sostanzialmente possiamo<br />
<strong>di</strong>re che queste relazioni hanno<br />
visto l’affermarsi <strong>di</strong> una triplice<br />
tipologia (spesso in contemporanea<br />
a livello storico): l’alternativa<br />
polemica, il parallelo <strong>di</strong>staccato, il<br />
<strong>di</strong>alogo sorvegliato.<br />
Il risultato auspicabile dovrebbe<br />
essere quello fatto balenare<br />
nella celebre battuta <strong>di</strong> Albert Einstein<br />
nel suo scritto autobiografi co<br />
Out of My Later Years (1950): «La<br />
scienza senza la religione è zoppa,<br />
la religione senza la scienza è cieca».<br />
Un pensiero echeggiato nel<br />
<strong>di</strong>scorso <strong>di</strong> Giovanni Paolo II in occasione<br />
del centenario della nascita<br />
(1879-1979) dello stesso Einstein.<br />
Il Papa, infatti, citando la<br />
Gau<strong>di</strong>um et Spes (n. 7), ricordava:<br />
«Anche la vita religiosa è sotto<br />
l’infl usso delle nuove situazioni…<br />
un più acuto senso critico la purifi -<br />
ca da ogni concezione magica del<br />
mondo e dalle sopravvivenze superstiziose».<br />
Ancor più sintetico ed<br />
esplicito il famoso scienziato Max<br />
Planck nel suo saggio sulla Conoscenza<br />
del mondo fi sico (e<strong>di</strong>zioni<br />
1906, 1947) affermava che «scienza<br />
e religione non sono in contrasto,<br />
ma hanno bisogno una dell’altra<br />
per completarsi nella mente <strong>di</strong><br />
un uomo che pensa seriamente».<br />
Da un lato, è, allora, necessario<br />
che lo scienziato lasci cadere<br />
quell’orgogliosa autosufficienza<br />
che lo spinge a relegare la fi losofi a<br />
e la teologia nel deposito dei relitti<br />
<strong>di</strong> un paleolitico intellettuale e<br />
quell’hybris che lo illude <strong>di</strong> <strong>di</strong>chiarare<br />
la capacità onnicomprensiva<br />
della scienza nel conoscere, circoscrivendo<br />
ed esaurendo la totalità<br />
dell’essere e dell’esistere, del senso<br />
e dei valori. Ma, d’altro lato, si<br />
deve vincere anche la tentazione<br />
del teologo desideroso <strong>di</strong> perimetrare<br />
i campi della ricerca scientifi -<br />
ca e <strong>di</strong> fi nalizzarne o piegarne i risultati<br />
apologeticamente a sostegno<br />
delle sue tesi. Come scriveva<br />
il fi losofo tedesco Friedrich Schel-<br />
ling a proposito del rapporto tra<br />
storia e fede, potremmo riba<strong>di</strong>re la<br />
necessità che scienziato e teologo<br />
«custo<strong>di</strong>scano castamente la loro<br />
frontiera», rimanendo aderenti ai<br />
loro specifici canoni <strong>di</strong> ricerca,<br />
pronti però anche a rispettare e a<br />
tenere in considerazione i meto<strong>di</strong><br />
e i risultati degli altri approcci alla<br />
realtà in esame.<br />
È, dunque, importante proporre<br />
innanzitutto una sorta <strong>di</strong><br />
“coesistenza pacifi ca” tra scienza<br />
e fede, lasciando alle spalle quello<br />
scontro che ha un vertice (o una<br />
sorgente) nel positivismo del fi losofo<br />
francese Auguste Comte, negatore<br />
della «legittimità <strong>di</strong> ogni interrogazione<br />
al <strong>di</strong> là della fi sica».<br />
Faith and science<br />
The confrontation between science and faith and their presumed<br />
irreconcilability is ancient: Galileo was a sacrificial victim.<br />
The solution for breaking through the sterile pretence for priority<br />
today is a peaceful coexistence between the two fields. Accor<strong>di</strong>ng<br />
to Einstein, science without religion was lame, and religion without<br />
science was blind. Planck believed they both counterbalance each<br />
other. Wittenstein was more categorical and apparently devoted to<br />
extreme positivism: that is, we must keep quiet on that which<br />
cannot be said. Less extreme, Nietzsche held that science and<br />
faith were neither friends nor enemies: they occupy <strong>di</strong>fferent<br />
spheres. Even John Paul II in a letter dated 1988 urged that they<br />
should be considered <strong>di</strong>stinct yet not separate.<br />
Foto Sgual<strong>di</strong>no<br />
Il folto pubblico<br />
presente in sala<br />
“Fabio Besta” ha<br />
seguito con sommi<br />
attenzione e<br />
interesse la dotta<br />
esposizione del<br />
signor Car<strong>di</strong>nale<br />
Gianfranco Ravasi.<br />
The large au<strong>di</strong>ence<br />
in the “Fabio Besta”<br />
room followed the<br />
learned lesson by<br />
Car<strong>di</strong>nal Gianfranco<br />
Ravasi with great<br />
attention.<br />
NOTIZIARIO<br />
Incontri BPS<br />
INCONTRI BPS 87
Immagine allegorica<br />
che rappresenta il<br />
rapporto dell’Uomo<br />
con il Cosmo.<br />
Incisione xilografica<br />
<strong>di</strong> anonimo del XVI<br />
secolo.<br />
An allegorical image<br />
representing the<br />
relationship of<br />
Man with the<br />
Cosmos. Xylograph,<br />
anonymous, 16th<br />
century.<br />
A destra: la Fede,<br />
porta meri<strong>di</strong>onale<br />
del Battistero <strong>di</strong> San<br />
Giovanni e Gionitus<br />
(l’astronomia),<br />
Campanile <strong>di</strong> Giotto,<br />
a Firenze.<br />
Entrambe le formelle<br />
sono opera <strong>di</strong><br />
Andrea Pisano<br />
(1290-1348).<br />
On the right: Faith,<br />
the southern door<br />
of the Baptistery<br />
of St. John and<br />
Jonitus (Astronomy),<br />
Giotto’s bell tower,<br />
in Florence.<br />
Both tiles by Andrea<br />
Pisano (1290-1348).<br />
88 INCONTRI BPS<br />
Un impulso ulteriore a questa <strong>di</strong>scrasia<br />
ra<strong>di</strong>cale è riconoscibile nel<br />
neopositivismo del Novecento. Il<br />
Tractatus logico-philosophicus <strong>di</strong><br />
Ludwig Wittgenstein (1921) <strong>di</strong>chiarava<br />
come prive <strong>di</strong> senso le proposizioni<br />
della metafi sica, dell’etica e<br />
dell’estetica, perché esse non sono<br />
immagine <strong>di</strong> nessun fatto del<br />
mondo. I neopositivisti del cosiddetto<br />
“Circolo <strong>di</strong> Vienna” (Schlick,<br />
Neurath, Carnap e così via) andarono<br />
oltre e interpretarono in senso<br />
svalutativo ra<strong>di</strong>cale l’affermazione<br />
<strong>di</strong> Wittgenstein riguardo ai<br />
<strong>di</strong>scorsi non scientifi ci. In realtà,<br />
per il fi losofo viennese – che non<br />
era certo un agnostico – si tratta<br />
solo <strong>di</strong> un’“ineffabilità” insita in<br />
quelle proposizioni, per cui «su ciò<br />
<strong>di</strong> cui non si può parlare, si deve<br />
tacere», e non certo <strong>di</strong> una loro<br />
assur<strong>di</strong>tà. Anche se sopravvivono<br />
ancora ben vigorosi epigoni delle<br />
tesi del “Circolo”, come Dawkins e<br />
altri <strong>di</strong>fensori <strong>di</strong> uno scientismo a<br />
oltranza, tale impostazione viene<br />
ormai considerata come marginale<br />
e semplifi catoria.<br />
Infatti ci si muove sempre <strong>di</strong><br />
più secondo un reciproco e coerente<br />
rispetto tra i due campi: la<br />
scienza si de<strong>di</strong>ca ai fatti, ai dati,<br />
alla “scena”, al “come”; la metafi -<br />
sica e la religione si consacrano ai<br />
valori, ai signifi cati ultimi, al “fondamento”,<br />
al “perché”, secondo<br />
specifici protocolli <strong>di</strong> ricerca. È<br />
quella che lo scienziato statunitense<br />
Stephen J. Gould, morto nel<br />
2002, ha sistematizzato nella formula<br />
dei Non-Overlapping-Magisteria<br />
(NOMA), ossia della non-sovrapponibilità<br />
dei percorsi della<br />
conoscenza fi losofi co-teologica e<br />
della conoscenza empirico-scientifi<br />
ca. Essi incarnano due livelli metodologici,<br />
epistemologici, linguistici<br />
che, appartenendo a piani<br />
<strong>di</strong>fferenti, non possono intersecarsi,<br />
sono tra loro incommensurabili,<br />
risultano reciprocamente intradu-<br />
Fototeca Gilar<strong>di</strong><br />
cibili e si rivelano in tal modo non<br />
confl ittuali. Come scriveva già nel<br />
1878 Nietzsche in Umano, troppo<br />
umano: «Fra religione e scienza<br />
non esistono né parentele né amicizia<br />
ma neppure inimicizia: vivono<br />
in sfere <strong>di</strong>verse».<br />
Riconosciuta la positività <strong>di</strong><br />
tale impostazione, che rigetta facili<br />
concor<strong>di</strong>smi sincretistici e assegna<br />
pari <strong>di</strong>gnità ai <strong>di</strong>versi tracciati<br />
<strong>di</strong> analisi della realtà, bisogna però<br />
opporre una riserva che è ben<br />
evidente già a partire dalla stessa<br />
esperienza storica. Entrambe,<br />
scienza e teologia (o filosofia),<br />
hanno in comune l’oggetto della<br />
loro investigazione (l’uomo, l’essere,<br />
il cosmo) e – come ha osservato<br />
acutamente Michał Heller, Premio<br />
Templeton 2009, nel suo bel<br />
saggio Nuova fi sica e nuova teologia<br />
– «esistono alcuni tipi <strong>di</strong> asserzioni<br />
che si lasciano trasferire dal<br />
campo delle scienze sperimentali<br />
a quello fi losofi co e viceversa senza<br />
confondere i livelli», anzi, con<br />
esiti fecon<strong>di</strong> (si pensi al contributo<br />
che la filosofia ha offerto alla<br />
scienza riguardo alle categorie<br />
“tempo” e “spazio”). Inoltre, continua<br />
lo stu<strong>di</strong>oso polacco, «la <strong>di</strong>-<br />
Photo Oilime
Photo Oilime<br />
stinzione dei livelli non dovrebbe<br />
legittimare l’esclusione aprioristica<br />
della possibilità <strong>di</strong> qualsiasi<br />
sintesi». È così che ha preso vigore,<br />
accanto alla sempre valida (a<br />
livello <strong>di</strong> metodo) “teoria dei due<br />
livelli”, una sussi<strong>di</strong>aria “teoria del<br />
<strong>di</strong>alogo” propugnata da Józef Tischner<br />
che fa leva sul fatto che<br />
ogni uomo è dotato <strong>di</strong> una coscienza<br />
unifi cante e, quin<strong>di</strong>, ogni ricerca<br />
sulla vita umana e sul rapporto<br />
con l’universo esige una pluralità<br />
armonica <strong>di</strong> itinerari e <strong>di</strong> esiti che<br />
si intrecciano tra loro nell’unicità<br />
della persona. Non è sod<strong>di</strong>sfacente,<br />
allora, per una più compiuta risposta,<br />
<strong>di</strong>ssociare ra<strong>di</strong>calmente i<br />
contributi scientifi ci da quelli fi losofi<br />
ci e viceversa, pena una per<strong>di</strong>ta<br />
della vera “concretezza” della realtà<br />
e dell’autenticità della stessa<br />
conoscenza umana che non è<br />
mono<strong>di</strong>ca, cioè solo razionale e<br />
formale, ma anche simbolico-affettiva<br />
(le pascaliane “ragioni del<br />
cuore”).<br />
Questa “teoria del <strong>di</strong>alogo” –<br />
che, per altro, faceva parte dell’ere<strong>di</strong>tà<br />
dell’umanesimo classico – è<br />
fatta balenare anche nella Lettera<br />
che Giovanni Paolo II aveva in<strong>di</strong>riz-<br />
zato nel 1988 al <strong>di</strong>rettore della<br />
Specola Vaticana: «Il <strong>di</strong>alogo [tra<br />
scienza e fede] deve continuare e<br />
progre<strong>di</strong>re in profon<strong>di</strong>tà e in ampiezza.<br />
In questo processo dobbiamo<br />
superare ogni tendenza regressiva<br />
che porti verso forme <strong>di</strong> riduzionismo<br />
unilaterale, <strong>di</strong> paura e <strong>di</strong><br />
autoisolamento. Ciò che è assolutamente<br />
importante è che ciascuna<br />
<strong>di</strong>sciplina continui ad arricchire,<br />
nutrire e provocare l’altra ad esse-<br />
Al termine<br />
dell’incontro, il<br />
cavalier Melazzini,<br />
presidente della<br />
banca, si congratula<br />
con Sua Eminenza<br />
Reveren<strong>di</strong>ssima.<br />
Alla sinistra, il<br />
vice<strong>di</strong>rettore<br />
generale vicario della<br />
Bps, Giovanni Ruffini.<br />
At the end of the<br />
meeting,<br />
Mr. Melazzini,<br />
Chairman of the<br />
Bank, congratulated<br />
His Very Reverend<br />
Eminence.<br />
On the left, the<br />
Vicar Deputy General<br />
Manager of Bps,<br />
Giovanni Ruffini.<br />
Il testo della<br />
conferenza è stato<br />
rivisto dal Relatore.<br />
re più pienamente ciò che deve<br />
essere e contribuire alla nostra visione<br />
<strong>di</strong> ciò che siamo e <strong>di</strong> dove<br />
stiamo andando». Distinzione ma<br />
non separatezza, dunque, tra<br />
scienza e fede. Il “fenomeno” a cui<br />
si de<strong>di</strong>ca la scienza, ossia la “scena”<br />
come sopra si <strong>di</strong>ceva, non è<br />
in<strong>di</strong>pendente dal “fondamento” e,<br />
quin<strong>di</strong>, esperienza e “trascendenza”<br />
sono <strong>di</strong>stinte nei livelli ma non<br />
isolate e incomunicabili.<br />
A questo punto, se vogliamo<br />
attestarci solo sul versante che ci<br />
è proprio, quello teologico, possiamo<br />
con<strong>di</strong>videre quanto scriveva<br />
nel 1982 sulla rivista Scripta<br />
Theologica José Luis Illanes: «La<br />
teologia può attuare il suo contributo<br />
solo se si mantiene in contatto<br />
con le altre scienze. Essa ha<br />
bisogno <strong>di</strong> essere ascoltata ma ha<br />
altrettanto bisogno <strong>di</strong> ascoltare gli<br />
altri saperi. Il teologo, come lo<br />
scienziato, deve essere umile, e in<br />
misura ancor maggiore: non solo<br />
perché ciò che sa lo riceve dalla<br />
parola <strong>di</strong> Dio, affi data alla Chiesa,<br />
<strong>di</strong> fronte a cui deve mantenersi in<br />
atteggiamento <strong>di</strong> devoto ascolto,<br />
ma anche perché riconosce che la<br />
scienza teologica non lo autorizza<br />
a prescindere da altri saperi». Siamo<br />
in presenza <strong>di</strong> due profi li dello<br />
stesso volto: cancellato uno, il viso<br />
si sfi gura. Per <strong>di</strong>rla con una battuta<br />
folgorante dei Pensieri <strong>di</strong> Pascal:<br />
«Due eccessi: escludere la ragione,<br />
non ammettere che la ragione»<br />
(n. 253, ed. Brunschvicg).<br />
Foto Sgual<strong>di</strong>no<br />
INCONTRI BPS 89
90 INCONTRI BPS<br />
Quale futuro<br />
per l’economia in Europa<br />
Autorità, signore e signori buona sera.<br />
SALA “FABIO BESTA” DELLA BANCA POPOLARE DI SONDRIO<br />
SONDRIO, VENERDÌ 28 GENNAIO 2011<br />
Sono particolarmente lieto <strong>di</strong> dare il benvenuto al professor<br />
Guido Tabellini, magnifi co ret tore della prestigiosa Università<br />
Commerciale Luigi Bocconi <strong>di</strong> Milano, al quale rin novo viva<br />
gratitu<strong>di</strong>ne per il privilegio nell’aver accolto l’invito a tenere una<br />
con ferenza quassù.<br />
Nel ciclo ormai lungo delle nostre conferenze, abbiamo<br />
avuto in questa sala numerose personalità <strong>di</strong> cultura, e tra <strong>di</strong><br />
esse – essendo la <strong>Popolare</strong> <strong>di</strong> Son drio vicina alle università, <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>verse delle quali è tesoriera, compresa la Bocconi – vi sono<br />
stati alti esponenti universitari. Cito – dei conferenzieri venuti<br />
in passato – l’attuale presidente della Bocconi professor Mario<br />
Monti, il quale fu in questa sala il 24 giugno 1988, quand’era<br />
<strong>di</strong>rettore dell’Istituto <strong>di</strong> Economia Politica dell’ateneo. Parlò sul<br />
tema “L’integrazione fi nanziaria europea e l’Italia”. Aggiungo<br />
le personalità legate agli atenei che sono state qui re centemente<br />
e che sono i professori Cesare Mirabelli, Lorenzo Ornaghi, Giulio<br />
Ballio, Alberto Quadrio Curzio, Giovanni Puglisi, Marcello<br />
Fontanesi.<br />
Questa sera ascolteremo il professor Guido Tabellini, rettore<br />
della Bocconi, <strong>di</strong> cui, come testé detto, siamo da anni – con<br />
sod<strong>di</strong>sfazione, che confi do sia reci proca – la banca <strong>di</strong> riferimento.<br />
Presso la stessa operiamo con l’agenzia n. 11, da noi chiamata<br />
semplicemente “fi liale della Bocconi”. All’ateneo, che ha una<br />
fornitis sima biblioteca, siamo altresì collegati attraverso la nostra<br />
Biblioteca Luigi Cre daro. Sempre in riferimento ai nostri aspetti<br />
culturali, sia pure modesti, non posso non ricordare che il 31<br />
ottobre 2002 siamo stati ospitati dalla Bocconi per la presentazione<br />
a Milano del nostro li bro, curato da Gavino Manca,<br />
Vilfredo Pareto (1848-1923). L’Uomo e lo Scienziato, corposa<br />
opera ispirata al Fondo pare tiano da noi acquisito a un’asta<br />
<strong>di</strong> Christie’s sul calare del 1996. Tra gli autori della pubblicazione<br />
vi sono il compianto Giuseppe Pontiggia, Gianfranco<br />
Ravasi, Marco Vi tale.<br />
L’Università Commerciale Luigi Bocconi, fondata nel<br />
1902, è specializ zata nell’insegnamento delle scienze economiche,<br />
giuri<strong>di</strong>che e manageriali e gli stu denti iscritti sono circa<br />
do<strong>di</strong>cimila.<br />
È noto come molti giovani della provincia <strong>di</strong> <strong>Sondrio</strong>, che<br />
intendono intra prendere stu<strong>di</strong> universitari a in<strong>di</strong>rizzo economico,<br />
pre<strong>di</strong>ligano la Boc coni, la cui reputazione è ottima e consolidata:<br />
un’eccellente uni versità che pre para alla vita, al lavoro. Tra i tanti<br />
studenti <strong>di</strong> que sta provincia che l’hanno fre quentata, non pochi<br />
lavorano presso <strong>di</strong> noi. Il nostro <strong>di</strong>rettore generale è uno <strong>di</strong> quelli.<br />
Il tema dell’incontro “Quale futuro per l’economia in Europa”<br />
è attua le e <strong>di</strong> grande interesse, soprattutto oggi che viviamo<br />
in un clima <strong>di</strong> grave incertezza eco nomica, avvolti da una<br />
crisi internazionale e nazionale senza precedenti, che ha sconquassato<br />
ovunque le Borse, quin<strong>di</strong> le fi nanze e, <strong>di</strong> conseguenza,<br />
l’economia, il lavoro. Speriamo che abbia a tornare il sereno sui<br />
mercati e la situazione possa normalizzarsi presto.<br />
Il professor Guido Tabellini, classe 1956, economista <strong>di</strong><br />
fama internazio nale, si è laureato in economia nel 1980 a Torino.<br />
Nell’84 ha conseguito il dottorato presso la UCLA negli<br />
Stati Uniti, dove ha lavorato come assistente per qualche anno.<br />
Rientrato in Italia, ha esercitato la do cenza presso le università<br />
<strong>di</strong> Cagliari e <strong>di</strong> Brescia.<br />
È poi approdato all’Università Commerciale Luigi Bocconi<br />
come profes sore <strong>di</strong> Economia politica, materia che insegna tuttora.<br />
Eletto rettore della stessa uni versità nel maggio 2008, è<br />
stato confermato nel prestigioso in carico nel novembre 2010.<br />
Fa parte <strong>di</strong> <strong>di</strong>versi centri <strong>di</strong> ricerca nazionali e internazionali<br />
e <strong>di</strong> comitati scientifi ci ed e<strong>di</strong>toriali. È autore <strong>di</strong> numerose<br />
pubblica zioni scientifi che <strong>di</strong> macroeconomia e politica macroeconomica,<br />
economia internazionale e pubblica.<br />
Il professor Tabellini è una fi rma prestigiosa de Il Sole 24<br />
Ore. Ricordo suoi articoli riferiti all’etica e all’economia, dove con<br />
saggezza l’autore illustra che l’e conomia e l’etica non sono mon<strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>stinti e separati. Sempre <strong>di</strong> etica e mercato egli ha trattato nel<br />
volume <strong>di</strong> Salvini, Zingales e Carrubba, dal titolo Il buono dell’economia:<br />
etica e mercato oltre i luoghi comuni.<br />
(Rivolgendosi al conferenziere) E ora assolvo al mio<br />
com pito <strong>di</strong> con segnarLe la medaglia della nostra banca, a ri cordo<br />
<strong>di</strong> questa importante conferenza.<br />
Piero Melazzini<br />
Presidente della <strong>Banca</strong> <strong>Popolare</strong> <strong>di</strong> <strong>Sondrio</strong>
GUIDO TABELLINI<br />
Magnifi co Rettore della Università<br />
Commerciale “Luigi Bocconi” <strong>di</strong> Milano<br />
In questa esposizione tratterò<br />
lo scenario economico internazionale,<br />
i problemi dell’Europa<br />
e, brevemente, la situazione<br />
dell’Italia.<br />
Gli scenari economici mon<strong>di</strong>ali<br />
sono in un momento <strong>di</strong> ripresa:<br />
la crescita mon<strong>di</strong>ale quest’anno<br />
sarà infatti attorno al 4% secondo<br />
stime <strong>di</strong> consenso. Sarà però<br />
una ripresa a due velocità, che<br />
vedrà crescere i Paesi emergenti<br />
rapidamente e oltre il loro trend<br />
consueto (probabilmente con una<br />
me<strong>di</strong>a attorno al 6-6,3%, con punte<br />
superiori all’8% per alcuni, in<br />
particolare Cina e Paesi asiatici). I<br />
Paesi avanzati tenderanno invece<br />
a crescere sotto il loro trend potenziale.<br />
Le stime <strong>di</strong> consenso in<strong>di</strong>cano<br />
per gli Stati Uniti una crescita<br />
del 2,50-3%, per l’Europa e il Giappone<br />
dell’1,5%, ma solo dell’1%<br />
per l’Italia che farà da cenerentola.<br />
Vorrei qui fare due osservazioni<br />
generali. La prima riguarda<br />
una caratteristica delle economie<br />
avanzate che non deve sorprendere,<br />
in confronto alle epoche storiche<br />
più lontane. Sappiamo che<br />
l’Europa e gli Stati Uniti hanno<br />
commesso l’errore <strong>di</strong> accumulare<br />
debiti in eccesso e la crisi fi nanziaria<br />
degli anni passati ne è stata la<br />
conseguenza. L’esperienza storica<br />
mostra che questi debiti in eccesso<br />
sfociano in crisi fi nanziarie seguite<br />
da perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> crescita particolarmente<br />
lenta, non imme<strong>di</strong>ati, ma<br />
lunghi fi no a sette-otto anni, o ad<strong>di</strong>rittura<br />
<strong>di</strong>eci secondo alcuni economisti.<br />
Le economie avanzate<br />
fronteggiano un periodo <strong>di</strong> crescita<br />
più bassa del solito dovendo smaltire<br />
i debiti accumulati.<br />
In secondo luogo, la rapida<br />
crescita delle economie emergenti<br />
non è un fenomeno congiunturale<br />
ma epocale. Credo che questo<br />
secolo sarà ricordato come quello<br />
in cui le gran<strong>di</strong> economie asiatiche<br />
sono tornate a occupare la posizione<br />
mon<strong>di</strong>ale <strong>di</strong> qualche secolo fa.<br />
Quella a cui assistiamo è veramente<br />
una trasformazione storica fondamentale<br />
e continuerà probabilmente<br />
nei prossimi decenni. Ciò<br />
vuol <strong>di</strong>re, e lo constatiamo ogni<br />
giorno, che le opportunità economiche<br />
saranno sempre più spostate<br />
verso i Paesi asiatici. Il confronto<br />
fra la Germania e l’Italia è un<br />
esempio. La Germania ha un’economia<br />
che è riuscita ad approfi ttare<br />
delle opportunità dei mercati<br />
asiatici, essendo stata capace <strong>di</strong><br />
entrarvi e <strong>di</strong> vendere molto: l’economia<br />
europea in questo momento<br />
va bene perché è trainata dalle<br />
Il relatore durante la<br />
sua conferenza.<br />
Al tavolo dei lavori<br />
siedono anche il<br />
presidente della<br />
banca, cavalier Piero<br />
Melazzini (sulla<br />
destra) e il <strong>di</strong>rettore<br />
generale della stessa,<br />
dottor Mario Alberto<br />
Pedranzini.<br />
The speaker during<br />
his conference. The<br />
following are seated<br />
at the work table:<br />
chairman of the bank,<br />
Knight of Labour<br />
Piero Melazzini (on<br />
the right) and the<br />
bank’s general<br />
manager, Dr. Mario<br />
Alberto Pedranzini.<br />
What is the future for the European economy?<br />
After the heavy effects of the crisis, the world economy will grow<br />
this year. But emerging countries will boast very comforting rates<br />
of development. The advanced countries are fin<strong>di</strong>ng it hard to<br />
maintain their potential growth trends. They must, in fact,<br />
eliminate their accumulated debts. The economies of countries<br />
such as Germany are at an advantage, as they are ready to meet<br />
the growing consumer demand of the Chinese system.<br />
Furthermore, the Eurozone states cannot count on the monetary<br />
policy to act as a safety vavle in a fiscal crisis situation. However,<br />
the central banks of England and the United States help their<br />
governments. More specifically, it is <strong>di</strong>fficult for Italy to rise above<br />
because it has not grown adequately in the last decade and<br />
therefore remains a Cinderella story.<br />
ven<strong>di</strong>te tedesche in Cina e in Asia.<br />
L’Italia, invece, non è riuscita nel<br />
complesso ad approfi ttare <strong>di</strong> queste<br />
opportunità, ma anche nel<br />
nostro Paese la parte <strong>di</strong> economia<br />
che dà buoni risultati è quella che<br />
riesce ad approfi ttare dei mercati<br />
asiatici. Un trend destinato a continuare,<br />
poiché quello che stiamo<br />
vedendo in Cina è solo l’inizio. I<br />
consumi dell’economia cinese sono,<br />
infatti, ancora una piccola parte<br />
del red<strong>di</strong>to. L’economia cinese<br />
cresce spinta dagli investimenti,<br />
ma i consumi in Cina sono circa<br />
poco più <strong>di</strong> un terzo del red<strong>di</strong>to:<br />
una frazione che corrisponde alla<br />
metà del rapporto fra consumi e<br />
red<strong>di</strong>to delle economie avanzate.<br />
Progressivamente, col crescere<br />
dell’economia cinese, aumenterà<br />
anche la domanda dei consumi e<br />
i Paesi che riusciranno a sod<strong>di</strong>sfare<br />
l’aumento della domanda interna<br />
in Cina saranno avvantaggiati.<br />
Non dobbiamo farci però troppe<br />
illusioni, perché in Cina è anche in<br />
corso un massiccio investimento<br />
in capitale umano. La capacità<br />
della Cina, come <strong>di</strong> altri Paesi<br />
emergenti, <strong>di</strong> far fronte all’espansione<br />
del mercato interno con la<br />
propria produzione aumenterà altrettanto<br />
velocemente. Gli anni e i<br />
decenni che stanno avanti offriran-<br />
INCONTRI BPS 91<br />
Foto Sgual<strong>di</strong>no
no delle opportunità, che non saranno<br />
tuttavia facili da cogliere<br />
come ora, poiché la competizione<br />
<strong>di</strong> quella parte del mondo si sposterà<br />
su settori sempre più sofi sticati.<br />
Un’implicazione <strong>di</strong> questa trasformazione<br />
epocale è che probabilmente<br />
il futuro economico del<br />
nostro Paese, nel lungo periodo,<br />
<strong>di</strong>penderà dalla nostra capacità <strong>di</strong><br />
rendere più effi ciente e più produttivo<br />
non solo il settore manifatturiero,<br />
che già compete con il resto<br />
del mondo, ma anche quello dei<br />
servizi. Non è semplice, in quanto<br />
occorrono una regolamentazione e<br />
una politica economica intelligente<br />
e si tratta <strong>di</strong> un settore spesso<br />
legato all’amministrazione pubblica<br />
e a situazioni <strong>di</strong> monopolio<br />
naturale. Non basta fare affi damento,<br />
come in parte avviene nel<br />
settore manifatturiero, sulla capacità<br />
impren<strong>di</strong>toriale dei privati, ma<br />
occorre anche che la macchina<br />
dello Stato funzioni in maniera<br />
effi ciente.<br />
In queste previsioni <strong>di</strong> consenso<br />
ho esposto uno scenario<br />
centrale che, come sempre, si<br />
accompagna a grande incertezza.<br />
È importante – accennando all’aspetto<br />
congiunturale – elencare<br />
i rischi che si presentano verso<br />
l’alto o verso il basso. A questo<br />
proposito, bisogna premettere che<br />
complessivamente i rischi sono<br />
<strong>di</strong>minuiti rispetto a sei mesi o un<br />
anno fa, quando la situazione era<br />
molto più incerta. Nei Paesi avanzati,<br />
soprattutto negli Stati Uniti,<br />
c’era il timore <strong>di</strong> una defl azione e<br />
<strong>di</strong> una ricaduta nella recessione<br />
– pericolo evaporato e <strong>di</strong>venuto<br />
molto meno imminente. Al contrario<br />
<strong>di</strong>verrà più probabile il rischio <strong>di</strong><br />
infl azione, maggiormente però negli<br />
Stati emergenti che non in quelli<br />
avanzati.<br />
Con più precisione, possiamo<br />
pensare a rischi in positivo e<br />
rischi in negativo rispetto allo scenario<br />
centrale. In positivo vanno<br />
citati i dati attuali sull’andamento<br />
del settore industriale mon<strong>di</strong>ale<br />
che in<strong>di</strong>cano un’accelerazione recente<br />
dell’attività economica. Negli<br />
Stati Uniti, in particolare, il<br />
settore delle imprese è in buone<br />
92 INCONTRI BPS<br />
La sede del<br />
Parlamento europeo<br />
a Strasburgo.<br />
The seat of the<br />
European Parliament<br />
in Strasbourg.<br />
con<strong>di</strong>zioni. La crisi del debito che<br />
ha colpito quel Paese coinvolgeva<br />
le famiglie e le banche, mentre le<br />
imprese avevano dei bilanci sani<br />
e in questo momento sono pronte<br />
a investire maggiormente se la<br />
realtà economica lo giustifi casse.<br />
Il settore delle imprese potrebbe<br />
quin<strong>di</strong> essere fonte <strong>di</strong> sorprese<br />
favorevoli. Siamo in un momento<br />
<strong>di</strong> ripresa, <strong>di</strong> <strong>di</strong>sponibilità nei confronti<br />
del rischio. I mercati fi nanziari<br />
si stanno riprendendo, le<br />
Borse sono salite, i <strong>di</strong>fferenziali<br />
d’interesse fra attività più e meno<br />
rischiose si stanno restringendo e<br />
<strong>di</strong> conseguenza gli investitori si<br />
stanno orientando verso investimenti<br />
un po’ più rischiosi, aumentando<br />
le opportunità economiche.<br />
Soprattutto, con il risalire dei<br />
prezzi delle attività, si riducono i<br />
rischi <strong>di</strong> ricaduta e si arricchisce<br />
il portafogli delle famiglie e degli<br />
investitori. Un altro aspetto positivo<br />
è che la ripresa delle economie<br />
emergenti potrebbe essere<br />
ancora più veloce delle attese.<br />
Infi ne, va ricordato che la politica<br />
monetaria resterà molto espansiva<br />
nel corso del 2011, soprattutto<br />
negli Stati Uniti e in Inghilterra,<br />
garantendo un’ulteriore spinta<br />
all’economia mon<strong>di</strong>ale.<br />
Tuttavia, <strong>di</strong> fronte agli aspetti<br />
positivi, esiste anche una serie <strong>di</strong><br />
rischi verso il basso da non sottovalutare.<br />
Il primo e il più rilevante<br />
riguarda la crisi del debito sovrano<br />
nell’area euro, non ancora fi nita. Il<br />
secondo, parlando degli Stati Uniti,<br />
è l’elevato tasso <strong>di</strong> <strong>di</strong>soccupazione.<br />
Un’opinione comune, alla<br />
luce della citata trasformazione<br />
dell’economia mon<strong>di</strong>ale, è che la<br />
ripresa dell’economia americana<br />
sarà una jobless recovery: non<br />
creerà lavoro. Sfrutterà gli aumenti<br />
<strong>di</strong> produttività lasciando però<br />
elevato il tasso <strong>di</strong> <strong>di</strong>soccupazione,<br />
al momento attorno al 9%. In questo<br />
caso la ripresa sarebbe più<br />
lenta, ostacolando il risanamento<br />
dei bilanci delle famiglie. Un altro<br />
elemento <strong>di</strong> rischio nell’economia<br />
Usa è il settore immobiliare in cui<br />
esiste un pericolo <strong>di</strong> ricaduta, rendendo<br />
la ripresa più lontana. Terzo<br />
rischio per gli Stati Uniti è la politica<br />
fi scale, in particolare il <strong>di</strong>savanzo<br />
fi scale. Per uscire dalla crisi gli<br />
Stati Uniti hanno spinto molto sulla<br />
politica fi scale e hanno mantenuto<br />
il <strong>di</strong>savanzo fi scale attorno al<br />
9-10% del red<strong>di</strong>to nazionale, ma è<br />
preoccupante che non vi siano<br />
imminenti segni <strong>di</strong> riduzione. I repubblicani<br />
– che controllano la
Camera dei Rappresentanti – affermano<br />
<strong>di</strong> volere stringere i cordoni<br />
della spesa pubblica e imporre<br />
una politica <strong>di</strong> spesa più attenta,<br />
ma le elezioni presidenziali non<br />
sono lontane ed è quin<strong>di</strong> poco<br />
probabile che il <strong>di</strong>savanzo rientri in<br />
maniera signifi cativa prima <strong>di</strong> allora.<br />
Dovremo probabilmente aspettare<br />
il 2013 o il 2014 per trovare i<br />
segni <strong>di</strong> una maggiore austerità.<br />
La rilevante accumulazione <strong>di</strong> debito<br />
porta il rischio <strong>di</strong> tensioni sui<br />
tassi d’interesse o sul dollaro. Un<br />
rischio collegato riguarda gli Stati<br />
e le città americane. A causa della<br />
crisi, le amministrazioni locali si<br />
sono trovate in <strong>di</strong>ffi coltà per problemi<br />
<strong>di</strong> debito pubblico. Per quanto<br />
questo non sia comparabile a<br />
quello dell’Europa, in rapporto al<br />
Pil, la capacità delle amministrazioni<br />
locali <strong>di</strong> sostenerlo è minore,<br />
data la modesta base imponibile.<br />
Potrebbero dunque esservi tensioni<br />
anche su questo fronte.<br />
Un altro elemento <strong>di</strong> rischio<br />
da valutare nello scenario internazionale<br />
riguarda i Paesi emergenti,<br />
nei quali il livello generale dei prezzi<br />
potrebbe correre troppo e quin<strong>di</strong><br />
provocare inflazione. Questo rischio<br />
presenta due aspetti. Da un<br />
lato la politica monetaria nei Paesi<br />
emergenti dovrebbe <strong>di</strong>venire più<br />
restrittiva: c’è infatti la sensazione<br />
che in questi Paesi essa sia in ritardo<br />
rispetto all’esigenza <strong>di</strong> controllare<br />
l’infl azione. D’altro canto,<br />
l’infl azione è concentrata soprattutto<br />
nelle commo<strong>di</strong>ties, con conseguenti<br />
ripercussioni sui Paesi<br />
avanzati che peggiorerebbero le<br />
relazioni <strong>di</strong> scambio e imporrebbero<br />
maggiore attenzione all’infl azione<br />
dalle autorità monetarie locali.<br />
Questo problema riguarda soprattutto<br />
l’Europa: proprio in questi<br />
giorni la <strong>Banca</strong> Centrale Europea<br />
ha mostrato un atteggiamento<br />
deciso sul pericolo che la rapida<br />
crescita dell’infl azione esterna sia<br />
importata nell’area euro causando<br />
un aumento duraturo dell’infl azione<br />
in Europa. Il presidente Trichet<br />
ha <strong>di</strong>chiarato che intende compensare<br />
un eventuale aumento dell’infl<br />
azione importata riducendo l’infl<br />
azione interna. A mio giu<strong>di</strong>zio sarebbe<br />
un errore <strong>di</strong> valutazione<br />
Recentemente la BCE<br />
ha mostrato un<br />
atteggiamento deciso<br />
sul pericolo che la<br />
rapida crescita<br />
dell’inflazione<br />
esterna sia importata<br />
nell’area euro<br />
causando un<br />
aumento duraturo<br />
dell’inflazione in<br />
Europa.<br />
Recently the ECB has<br />
shown a determined<br />
attitude regar<strong>di</strong>ng<br />
the threat that<br />
the rapid growth<br />
of external inflation<br />
might be imported<br />
into the Euro zone<br />
causing a longlasting<br />
increase of<br />
inflation in Europe.<br />
adottare una politica monetaria<br />
più restrittiva in Europa in questo<br />
momento, anche se non possiamo<br />
escludere che ciò accada prima<br />
del dovuto, pensando alla situazione<br />
economica locale.<br />
Nella zona dell’euro, il rischio<br />
più grave è quello del debito sovrano,<br />
su cui vorrei fare alcune osservazioni.<br />
Bisogna in primo luogo ricordare<br />
l’importanza della fi ducia.<br />
Siamo abituati a considerarla solo<br />
quando pensiamo alle monete e ai<br />
tassi <strong>di</strong> cambio, ma la fi ducia è<br />
fondamentale anche in riferimento<br />
al debito pubblico, poiché, se viene<br />
meno, i tassi d’interesse sul<br />
debito pubblico salgono mettendo<br />
in <strong>di</strong>ffi coltà un debitore sovrano.<br />
Da cosa <strong>di</strong>pende la fi ducia? È<br />
un concetto evanescente e <strong>di</strong>ffi cile<br />
da defi nire, che sicuramente <strong>di</strong>pende<br />
dalla storia e dalla tra<strong>di</strong>zione.<br />
Vi sono Paesi emergenti in cui<br />
la fi ducia nei confronti del debito<br />
sovrano è tra<strong>di</strong>zionalmente bassa:<br />
questi Paesi non riescono solitamente<br />
ad accumulare un debito<br />
superiore al 50-60% del red<strong>di</strong>to<br />
nazionale. Le crisi <strong>di</strong> Argentina e<br />
Russia sono arrivate quando il loro<br />
debito sovrano toccava solamente<br />
il 50-60% del Pil. Alcuni economisti<br />
parlano <strong>di</strong> debt intolerance,<br />
d’intolleranza del debito dei Paesi<br />
che hanno per consuetu<strong>di</strong>ne scarsa<br />
fi ducia nei confronti del debito<br />
sovrano.<br />
I Paesi avanzati che possiedono<br />
invece la capacità <strong>di</strong> dare fi -<br />
ducia sul debito, riescono generalmente<br />
a indebitarsi nella loro valuta.<br />
L’Europa è in una situazione un<br />
po’ particolare. È vero che gli Stati<br />
dell’area euro s’indebitano nella<br />
stessa valuta, ma non possono<br />
contare sulla politica monetaria<br />
come valvola <strong>di</strong> sicurezza in situazione<br />
<strong>di</strong> crisi fi scale. Se pensiamo,<br />
infatti, all’Inghilterra e agli Stati<br />
Uniti, uno degli aspetti che dà loro<br />
fi ducia è che, in caso <strong>di</strong> necessità,<br />
esiste una banca centrale che può<br />
aiutare il governo, almeno entro<br />
certi limiti. Non è invece detto che<br />
esista questa caratteristica anche<br />
nei Paesi dell’area euro. Se infatti<br />
tutti i Paesi europei dovessero<br />
perdere la fi ducia, la <strong>Banca</strong> Centrale<br />
europea sarebbe pronta ad<br />
aiutarli. Ma se questa crisi <strong>di</strong> fi ducia<br />
tocca solo alcuni Paesi, la BCE<br />
– secondo le basi della nostra costituzione<br />
monetaria – non potrebbe<br />
intervenire se non creando confl<br />
itti politici. C’eravamo <strong>di</strong>menticati<br />
che l’area euro è <strong>di</strong>versa dagli<br />
Stati Uniti e dall’Inghilterra. C’è<br />
dunque il rischio <strong>di</strong> una grave per<strong>di</strong>ta<br />
<strong>di</strong> fi ducia in un contesto <strong>di</strong><br />
volatilità e <strong>di</strong> debiti così elevati:<br />
quello italiano arriverà al 120% del<br />
Pil e quello <strong>di</strong> altri Paesi oltre il<br />
100% del Pil. Forse non potremo<br />
permetterci tali livelli <strong>di</strong> debito poiché<br />
non abbiamo <strong>di</strong>etro una banca<br />
INCONTRI BPS 93<br />
Shutterstock
centrale che può svolgere il ruolo<br />
che svolgerebbe la Fed o la <strong>Banca</strong><br />
d’Inghilterra. Per dare un’idea della<br />
concretezza delle mie osservazioni,<br />
dal 2008 a oggi il bilancio della<br />
banca centrale americana è circa<br />
triplicato, dato che questa, per<br />
sostenere l’economia, ha prestato<br />
sol<strong>di</strong> alle banche, ma ha anche<br />
acquistato in maniera rilevante il<br />
debito statale. Nello stesso periodo<br />
il bilancio della <strong>Banca</strong> d’Inghilterra<br />
è aumentato <strong>di</strong> circa due<br />
volte e mezzo. Il bilancio della <strong>Banca</strong><br />
Centrale europea è anch’esso<br />
aumentato in maniera signifi cativa,<br />
ma non altrettanto e soprattutto<br />
non in riferimento al debito<br />
emesso dai Paesi europei: una<br />
<strong>di</strong>fferenza importante che deve<br />
renderci più cauti.<br />
In secondo luogo, la reazione<br />
dei Paesi dell’Unione europea allo<br />
scoppio della crisi sul debito sovrano<br />
in Grecia, e più recentemente<br />
in Irlanda, è stata <strong>di</strong>sor<strong>di</strong>nata, Non<br />
eravamo pronti. Ciò ha contribuito<br />
ad aggravare la crisi e ha fatto fare<br />
dei passi in<strong>di</strong>etro. Quando sono<br />
emersi i primi problemi in Grecia,<br />
probabilmente la risposta che<br />
avrebbe dato fi ducia sarebbe stata<br />
<strong>di</strong> affermare che una ristrutturazione<br />
sul debito sovrano <strong>di</strong> un Paese<br />
dell’area euro non deve accadere,<br />
è un evento impossibile. Per<br />
evitare l’azzardo morale che altrimenti<br />
ci sarebbe stato, si sarebbe<br />
dovuto costringere sin dall’inizio la<br />
Grecia ad adottare provve<strong>di</strong>menti<br />
molto restrittivi e offrirle un sostegno<br />
molto grande <strong>di</strong> liqui<strong>di</strong>tà, non<br />
solo con prestiti, com’è stato fatto,<br />
ma anche da parte della <strong>Banca</strong><br />
Centrale europea, come avrebbero<br />
fatto la <strong>Banca</strong> d’Inghilterra e la<br />
Fed. Invece la politica monetaria è<br />
stata esclusa. La risposta dei governi<br />
ha avuto delle incertezze,<br />
soprattutto nell’autunno del 2010,<br />
quando è emerso il problema<br />
dell’Irlanda. Queste misure hanno<br />
infatti minato la fi ducia perché gli<br />
stanziamenti dell’Unione europea<br />
ai Paesi in <strong>di</strong>ffi coltà sono stati<br />
concessi a interessi elevati, meno<br />
<strong>di</strong> quelli del mercato ma <strong>di</strong> molto<br />
superiori a quelli con cui gli altri<br />
Stati dell’Unione europea si stavano<br />
indebitando. Tanto più alto è il<br />
94 INCONTRI BPS<br />
La sede della SDA<br />
Bocconi School of<br />
Management in via<br />
Bocconi 8 a Milano.<br />
The seat of the SDA<br />
Bocconi School of<br />
Management in via<br />
Bocconi 8 in Milan.<br />
La nuova Aula<br />
Magna Bocconi,<br />
nell’e<strong>di</strong>ficio Grafton<br />
<strong>di</strong> via Roentgen 1<br />
a Milano.<br />
The new Bocconi<br />
Great Hall in the<br />
Grafton buil<strong>di</strong>ng<br />
in via Roentgen 1<br />
in Milan.<br />
tasso d’interesse, tanto più <strong>di</strong>ffi cilmente<br />
scomparirà il problema con<br />
il tempo. La politica monetaria non<br />
è stata d’aiuto in modo effi cace,<br />
ma a togliere fi ducia sono state<br />
soprattutto le <strong>di</strong>chiarazioni della<br />
Merkel, che ha sottolineato come,<br />
a fronte degli aiuti concessi alla<br />
Grecia e poi all’Irlanda, bisognasse<br />
congegnare per il futuro, dopo<br />
il 2013, un sistema per consentire<br />
anche ai cre<strong>di</strong>tori e non soltanto ai<br />
contribuenti <strong>di</strong> affrontare il costo <strong>di</strong><br />
questa accumulazione eccessiva<br />
<strong>di</strong> debiti. Ciò ha reso evidente che<br />
il nuovo debito che gli Stati europei<br />
avrebbero dovuto emettere dopo il<br />
2013 sarebbe stato particolarmente<br />
rischioso. Il rischio era aggravato<br />
dal fatto che i prestiti concessi<br />
all’Irlanda sarebbero stati<br />
sostituiti da un nuovo fondo permanente<br />
ancora in elaborazione e<br />
con l’affermazione esplicita che<br />
dopo il 2013 eventuali aiuti concessi<br />
ai Paesi in <strong>di</strong>ffi coltà sarebbero<br />
stati trattati in maniera preferenziale<br />
rispetto ad altri debiti<br />
emessi sul mercato degli Stati<br />
dell’area euro, rendendo ancora<br />
più rischioso il ricorso al mercato<br />
per i Paesi che si trovassero in<br />
Archivio Università Commerciale “L. Bocconi” Archivio Università Commerciale “L. Bocconi”
Archivio Università Commerciale “L. Bocconi” - Paolo Tonato<br />
<strong>di</strong>ffi coltà dopo il 2013. Questo insieme<br />
<strong>di</strong> fattori ha contribuito a<br />
togliere la fi ducia.<br />
Ci sono classi d’investitori in<br />
Asia e negli Stati Uniti che improvvisamente<br />
hanno visto il debito<br />
sovrano dell’area euro come una<br />
classe d’investimento molto più<br />
rischiosa <strong>di</strong> quanto immaginassero<br />
e che si sono allontanati da<br />
questi investimenti. Le <strong>di</strong>ffi coltà<br />
dei Paesi dell’area euro non sono<br />
dovute soltanto agli hedge funds<br />
che speculano, ma a investitori <strong>di</strong><br />
lungo periodo che hanno scoperto<br />
un mondo <strong>di</strong>verso da quello che si<br />
aspettavano. Ciò è importante<br />
perché cambiare l’atteggiamento<br />
degli investitori istituzionali è più<br />
<strong>di</strong>ffi cile che non riacquistare la fi -<br />
ducia <strong>di</strong> uno speculatore <strong>di</strong> breve<br />
periodo.<br />
Più recentemente, ci si è accorti<br />
<strong>di</strong> questi errori. I policy makers<br />
europei hanno capito che occorre<br />
adottare un atteggiamento<br />
<strong>di</strong>verso. La <strong>Banca</strong> Centrale europea<br />
ha cominciato ad acquistare il<br />
debito pubblico degli Stati in <strong>di</strong>ffi -<br />
coltà, sebbene in piccole quantità,<br />
con effetti positivi per tutti i Paesi.<br />
Quando la BCE acquista debito del<br />
Portogallo e della Grecia, si abbassano<br />
anche i tassi d’interesse<br />
della Spagna e dell’Italia perché<br />
<strong>di</strong>minuisce il rischio <strong>di</strong> contagio.<br />
In questi giorni è in <strong>di</strong>scussione<br />
l’ipotesi <strong>di</strong> ampliare le risorse<br />
che i Paesi europei mettono a <strong>di</strong>sposizione<br />
per aiutare gli Stati in<br />
<strong>di</strong>ffi coltà. Le risorse dovevano essere<br />
in teoria <strong>di</strong> 400 miliar<strong>di</strong>, in<br />
pratica sono <strong>di</strong> meno, per varie<br />
ragioni (solo 250 sono in realtà<br />
utilizzabili). Ci si è resi conto che<br />
ciò rende troppo scarse le risorse<br />
attualmente a <strong>di</strong>sposizione e quin<strong>di</strong><br />
si sta cercando <strong>di</strong> ampliarle. Si<br />
<strong>di</strong>scute <strong>di</strong> abbassare il tasso d’interesse<br />
dei prestiti per i Paesi in<br />
<strong>di</strong>ffi coltà, anche se non sappiamo<br />
ancora se ciò avverrà.<br />
Un altro aspetto utile è stato<br />
l’intervento <strong>di</strong> Cina e Giappone e <strong>di</strong><br />
altri fon<strong>di</strong> sovrani che, consapevoli<br />
che in questo momento l’Europa<br />
ha bisogno <strong>di</strong> aiuto e che una crisi<br />
più grave nell’area euro non avvantaggerebbe<br />
nessuno, sono <strong>di</strong>sposti<br />
a comprare euro o debito sovrano<br />
per aiutare i Paesi in <strong>di</strong>ffi coltà.<br />
Tutto ciò ha fatto rientrare la crisi<br />
dai suoi momenti peggiori consentendo<br />
ai Paesi in <strong>di</strong>ffi coltà <strong>di</strong> guadagnare<br />
tempo, facendo riprendere<br />
l’economia e circoscrivendo la<br />
crisi.<br />
La domanda <strong>di</strong>ffi cile alla quale<br />
nessuno sa rispondere è se il<br />
rientro dalle <strong>di</strong>ffi coltà dell’area euro<br />
sia il primo passo verso la risoluzione<br />
del problema o soltanto<br />
Il rettore<br />
dell’Università<br />
Bocconi, professor<br />
Guido Tabellini, tiene<br />
il <strong>di</strong>scorso <strong>di</strong><br />
inaugurazione<br />
dell’anno accademico.<br />
The rector of the<br />
Bocconi University,<br />
Professor Guido<br />
Tabellini, giving the<br />
inaugural speech of<br />
the academic year.<br />
una pausa prima <strong>di</strong> un ritorno a<br />
problemi rilevanti. La risposta è<br />
molto complessa, ma a mio avviso<br />
è <strong>di</strong>ffi cile pensare che siamo fuori<br />
dal guado. È probabile che i prossimi<br />
anni siano caratterizzati da<br />
una volatilità ondeggiante. Ci saranno<br />
ancora momenti <strong>di</strong> <strong>di</strong>ffi coltà.<br />
È possibile che questa fase <strong>di</strong><br />
rientro duri ancora a lungo, ma nei<br />
prossimi due o tre anni ci saranno<br />
altri perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> forte volatilità.<br />
Le ragioni sono molteplici. La<br />
prima è che le <strong>di</strong>ffi coltà non sono<br />
solo economiche, ma anche politiche:<br />
le interpretazioni della crisi<br />
dell’area euro sono spesso <strong>di</strong>vergenti.<br />
In Germania prevale l’opinione<br />
che la colpa sia della politica<br />
fi scale miope dei Paesi in <strong>di</strong>ffi coltà,<br />
il che è sicuramente vero in<br />
Grecia, dove i governi hanno sbagliato.<br />
È però meno vero in altri<br />
Paesi – come Spagna e Irlanda –<br />
in cui i problemi nascono più dal<br />
sistema bancario che non dalla<br />
politica fiscale. L’errore è stato<br />
quello <strong>di</strong> lasciare accumulare troppo<br />
debito nel sistema bancario.<br />
Ma questo errore è stato commesso<br />
anche dalla Germania, le cui<br />
banche hanno molto debito emesso<br />
da Grecia, Irlanda e Spagna. La<br />
visione tedesca si accompagna<br />
poi alla prescrizione politica <strong>di</strong> non<br />
aiutare i Paesi in <strong>di</strong>ffi coltà, non<br />
soltanto perché a spese dei contribuenti<br />
tedeschi, ma perché ciò<br />
incoraggerebbe altri eccessi <strong>di</strong><br />
politica fi scale. Nei Paesi che hanno<br />
bisogno <strong>di</strong> essere aiutati l’opinione<br />
prevalente è <strong>di</strong>versa: si vede<br />
l’atteggiamento intransigente della<br />
Germania come punitivo. Per dare<br />
un esempio concreto, una delle<br />
con<strong>di</strong>zioni poste dai Paesi europei<br />
all’Irlanda per aiutarla è che il patrimonio<br />
delle casse previdenziali<br />
irlandesi fosse utilizzato per ripagare<br />
il debito dello Stato irlandese.<br />
I benefi ciari <strong>di</strong> questi rimborsi sono<br />
spesso le banche tedesche<br />
che hanno prestato denaro all’Irlanda<br />
e che chiedono ora i sol<strong>di</strong><br />
delle casse previdenziali irlandesi<br />
per ripagare i debiti. È ovvio che<br />
ciò procuri preoccupazione in Irlanda,<br />
e infatti il nuovo governo irlandese<br />
potrebbe assumere un atteggiamento<br />
<strong>di</strong>verso. Quando ci sono<br />
INCONTRI BPS 95
dei confl itti <strong>di</strong> questo genere e<br />
percezioni così <strong>di</strong>verse all’interno<br />
dell’area euro, è possibile che le<br />
soluzioni adottate per uscire dalla<br />
crisi contengano elementi economicamente<br />
poco effi caci. Ci potrebbero<br />
quin<strong>di</strong> essere delle delusioni<br />
rispetto alle attese che in<br />
queste settimane si stanno formando.<br />
A suggerire che i problemi<br />
non siano fi niti vi è anche il fatto<br />
che alcuni Paesi non si trovano<br />
solo in una situazione <strong>di</strong> mancanza<br />
<strong>di</strong> fi ducia, ma anche d’insolvenza<br />
effettiva. Il debito della Grecia<br />
raggiungerà, nelle stime uffi ciali,<br />
circa il 160% del red<strong>di</strong>to nazionale.<br />
Riuscire a rimborsare questo debito<br />
con un’economia a crescita ridotta<br />
sarà molto <strong>di</strong>ffi cile. Se si<br />
aggiunge che questo debito è detenuto<br />
in gran parte fuori dalla<br />
Grecia, gli incentivi a non far fronte<br />
a questo debito sono molto forti.<br />
La situazione irlandese non è altrettanto<br />
<strong>di</strong>ffi cile: il debito pubblico<br />
è più basso, attorno al 100% del<br />
Pil. Però l’Irlanda ha un debito<br />
estero lordo elevatissimo, in rap-<br />
96 INCONTRI BPS<br />
Un qualificato e<br />
numeroso pubblico<br />
ha seguito con<br />
interesse la chiara<br />
esposizione del<br />
Magnifico Rettore<br />
dell’Università<br />
“L. Bocconi”.<br />
A large and<br />
competent au<strong>di</strong>ence<br />
listened carefully to<br />
the presentation of<br />
the rector of the<br />
Bocconi University.<br />
porto <strong>di</strong> 16 a 1 sul red<strong>di</strong>to nazionale.<br />
Anche in questo caso non si<br />
tratta solo <strong>di</strong> una crisi <strong>di</strong> fi ducia,<br />
ma dei fondamentali economici<br />
<strong>di</strong>ffi cili da sostenere. È vero che<br />
sono Paesi molto piccoli e le <strong>di</strong>ffi -<br />
coltà possono essere circoscritte,<br />
ma ci vuole del tempo per essere<br />
sicuri che una ristrutturazione del<br />
debito in Grecia non crei <strong>di</strong>ffi coltà<br />
altrove.<br />
La terza e ultima considerazione,<br />
a sostegno della tesi che<br />
questi problemi non scompariranno<br />
facilmente, è che in <strong>di</strong>versi<br />
Pae si – non in Italia per fortuna – il<br />
problema non consiste solo nella<br />
fi nanza pubblica, ma in una combinazione<br />
<strong>di</strong> <strong>di</strong>ffi coltà dello Stato<br />
sovrano e del sistema bancario.<br />
Ciò avviene in Spagna dove le<br />
banche sono esposte sul sistema<br />
immobiliare in maniera rilevante,<br />
non catastrofi ca, ma neppure trascurabile,<br />
essendovi stata una<br />
bolla in questo settore. Ciò accade<br />
anche in Paesi economicamente<br />
sani come il Belgio, le cui banche<br />
sono fortemente esposte verso i<br />
Paesi periferici dell’area euro, e <strong>di</strong><br />
conseguenza a rischio <strong>di</strong> contagio<br />
nel caso <strong>di</strong> una crisi in uno <strong>di</strong> questi<br />
Paesi. Infi ne, il 30-40% del debito<br />
dell’area euro è detenuto dal<br />
suo sistema bancario, quin<strong>di</strong> le<br />
<strong>di</strong>ffi coltà della Grecia <strong>di</strong> fare fronte<br />
ai suoi debiti avrebbero delle ripercussioni<br />
sullo stesso sistema bancario<br />
greco. Stesso <strong>di</strong>scorso vale<br />
per il Portogallo, che pure ha altri<br />
tipi <strong>di</strong> problemi. Da una situazione<br />
come questa, in cui sia lo Stato<br />
sovrano sia il sistema bancario<br />
possono avere <strong>di</strong>ffi coltà, non è<br />
quin<strong>di</strong> così facile uscire. La soluzione<br />
naturale sarebbe <strong>di</strong> ricapitalizzare<br />
le banche in <strong>di</strong>ffi coltà, ma<br />
anche qui ci sono questioni politicamente<br />
<strong>di</strong>fficili. Quest’aspetto<br />
importante potrebbe emergere nei<br />
prossimi mesi, quando dovranno<br />
essere rifatti gli stress test del sistema<br />
bancario: delle simulazioni<br />
per valutare quanto il capitale delle<br />
singole banche sia suffi ciente a<br />
sostenere eventuali tensioni. Nei<br />
Paesi maggiormente in <strong>di</strong>ffi coltà,<br />
in particolare in Spagna, potrebbero<br />
esserci forti esigenze <strong>di</strong> ricapitalizzazione.<br />
Foto Sgual<strong>di</strong>no
A fronte <strong>di</strong> queste preoccupazioni<br />
esistono tuttavia argomenti<br />
<strong>di</strong> segno opposto: innanzitutto<br />
il fortissimo impegno politico<br />
<strong>di</strong> tutti i Paesi, non solo europei,<br />
per aiutare l’area euro ad<br />
avere il ruolo che merita nel mondo.<br />
Come abbiamo visto, la Cina<br />
e il Giappone ne sono consapevoli.<br />
La posta politica in gioco è così<br />
alta che si farà <strong>di</strong> tutto per evitare<br />
<strong>di</strong>ffi coltà ad un Paese dell’area<br />
euro: sei mesi fa sarebbe stato<br />
inimmaginabile pensare agli aiuti<br />
che invece sono stati dati a Grecia<br />
e Irlanda.<br />
In secondo luogo, i Paesi in<br />
<strong>di</strong>ffi coltà sono piccoli. Di fronte ad<br />
un progetto politico così importante<br />
è <strong>di</strong>ffi cile immaginare che non<br />
si trovi il modo per venire fuori<br />
dalla crisi <strong>di</strong> Paesi <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni<br />
così ridotte, anche se oggi non si<br />
può capire la soluzione tecnica.<br />
Alla fi ne la Spagna ha delle banche<br />
che devono essere ricapitalizzate,<br />
ma non è un Paese insolvente<br />
come la Grecia, l’Irlanda e, forse,<br />
il Portogallo.<br />
In terzo luogo, il tempo aiuta<br />
a isolare i Paesi che sono davvero<br />
in <strong>di</strong>ffi coltà rispetto a quelli che<br />
possono venirne fuori da soli.<br />
Tutto ciò fa pensare che ci siano<br />
tante ragioni per essere più ottimisti.<br />
La mia lettura <strong>di</strong> queste considerazioni<br />
contrastanti è che, a<br />
seconda del momento, prevarrà la<br />
visione più negativa o quella più<br />
positiva. Dipende anche dalla situazione<br />
economica mon<strong>di</strong>ale: se<br />
l’economia cresce rapidamente,<br />
se le attività fi nanziarie si riprendono,<br />
se gli investitori sono più <strong>di</strong>sposti<br />
a sopportare il rischio, allora<br />
prevarrà la visione ottimistica. In<br />
altri momenti vi saranno fondate<br />
ragioni per la cautela e allora le<br />
<strong>di</strong>ffi coltà e i no<strong>di</strong> irrisolti potrebbero<br />
farsi <strong>di</strong> nuovo pressanti. Anche<br />
l’economia reale e gli investimenti<br />
reali risentiranno <strong>di</strong> questo clima<br />
<strong>di</strong> volatilità e <strong>di</strong> incertezza. I dati<br />
mostrano come la ripresa economica<br />
mon<strong>di</strong>ale abbia portato a un<br />
ritorno degli investimenti <strong>di</strong>retti<br />
dall’estero verso i Paesi <strong>di</strong> quasi<br />
tutto il mondo, ma non nell’area<br />
euro – nemmeno nei suoi Paesi<br />
Nel corso della<br />
conferenza il<br />
professor Tabellini ha<br />
pure sottolineato che<br />
non basta fare<br />
affidamento sulla<br />
capacità<br />
impren<strong>di</strong>toriale dei<br />
privati, ma occorre<br />
anche che la<br />
macchina dello Stato<br />
funzioni in maniera<br />
efficiente.<br />
During the<br />
conference, Professor<br />
Tabellini also<br />
emphasized that we<br />
cannot rely on the<br />
entrepreneurial<br />
abilities of the<br />
private sector alone,<br />
but that the<br />
Government must<br />
also function<br />
efficiently.<br />
più sani. L’ipotesi già delineata <strong>di</strong><br />
un lungo periodo <strong>di</strong> crescita sotto<br />
il potenziale in Europa è quin<strong>di</strong><br />
plausibile e, nonostante le buone<br />
notizie, stenteremo a rivedere dei<br />
tassi <strong>di</strong> crescita molto elevati.<br />
Vorrei infi ne trattare dell’Italia.<br />
La nostra nazione è in una situazione<br />
particolare. Se guar<strong>di</strong>amo<br />
ai fl ussi della fi nanza pubblica<br />
stiamo abbastanza bene. Il <strong>di</strong>savanzo<br />
del nostro Stato è cresciuto<br />
in maniera modesta durante la<br />
crisi, e questo è uno dei meriti del<br />
ministro dell’Economia; tuttavia lo<br />
stock <strong>di</strong> debito pubblico rimane<br />
molto alto, essendo ritornato vicino<br />
al 120 per cento del Pil. A<br />
fronte <strong>di</strong> questo debito vi sono i<br />
risparmi privati, quin<strong>di</strong> l’economia<br />
è sana, ma senza una ripresa<br />
della crescita il rapporto fra debito<br />
e red<strong>di</strong>to nazionale è destinato a<br />
rimanere alto esponendoci ai già<br />
accennati rischi <strong>di</strong> volatilità.<br />
In questa situazione è <strong>di</strong>ffi cile<br />
uscire in maniera netta dal guado<br />
senza un’accelerazione forte<br />
della crescita. Per riuscire ad abbattere<br />
il rapporto debito-Pil occor-<br />
Foto Sgual<strong>di</strong>no<br />
re far crescere il denominatore, il<br />
red<strong>di</strong>to. Come fare quin<strong>di</strong> a rilanciare<br />
la crescita? Il nostro Paese<br />
cresce poco da più <strong>di</strong> un decennio,<br />
quin<strong>di</strong> non è colpa <strong>di</strong> un governo o<br />
dell’altro. Ad<strong>di</strong>rittura negli ultimi<br />
<strong>di</strong>eci anni il red<strong>di</strong>to pro capite è<br />
<strong>di</strong>minuito: <strong>di</strong>eci anni fa eravamo<br />
più ricchi.<br />
Credo che, per far ripartire la<br />
crescita, ci siano no<strong>di</strong> strutturali<br />
da affrontare per l’economia italiana.<br />
Alcuni, come le relazioni industriali,<br />
li stiamo già affrontando.<br />
Più nel lungo periodo, è necessario<br />
un miglior funzionamento delle<br />
istituzioni scolastiche, della ricerca<br />
e delle infrastrutture, che ovviamente<br />
non darà un risultato imme<strong>di</strong>ato.<br />
Non è infatti pensabile che<br />
la crescita riparta subito solo perché<br />
investiamo in infrastrutture o<br />
in scuole.<br />
Nell’imme<strong>di</strong>ato probabilmente<br />
lo strumento più in<strong>di</strong>spensabile<br />
per fi nanziare la crescita è quello<br />
tributario: oggi il fi sco italiano è<br />
molto sbilanciato sui fattori produttivi<br />
e soprattutto sul lavoro. Bisognerebbe<br />
spostare una parte <strong>di</strong><br />
questo carico fi scale altrove, poiché<br />
non possiamo abbassarlo signifi<br />
cativamente in una situazione<br />
<strong>di</strong> fi nanza pubblica come quella<br />
attuale. Ma dove? Non c’è molto<br />
altro che i consumi. Diminuire<br />
l’Irap e aumentare l’Iva è come<br />
svalutare: alleggeriamo il prelievo<br />
su chi produce in Italia e facciamo<br />
salire il prelievo su chi domanda<br />
in Italia e all’estero. Anche la tassazione<br />
sulle ren<strong>di</strong>te fi nanziarie, in<br />
questo contesto, dovrebbe naturalmente<br />
aumentare. Combattere<br />
l’evasione fi scale è poi imperativo.<br />
Bisogna infi ne aiutare i nostri servizi<br />
a ripartire, anche se l’effetto si<br />
avrà nel me<strong>di</strong>o periodo e non<br />
nell’imme<strong>di</strong>ato. Occorre sfruttare<br />
le molte opportunità che ancora<br />
esistono nel settore dei servizi<br />
con liberalizzazioni e regolamentazioni<br />
meno punitive. Tutto ciò è<br />
urgente, proprio perché siamo in<br />
una situazione <strong>di</strong> incertezza e volatilità<br />
economica. È importante<br />
che anche la politica si mostri<br />
all’altezza delle sfi de particolarmente<br />
impegnative che abbiamo<br />
davanti a noi.<br />
INCONTRI BPS 97
Tibet TawoTadra
Testo <strong>di</strong> FAUSTO SASSI<br />
Regista e scrittore<br />
Foto <strong>di</strong> FAUSTO SASSI<br />
E CLAUDIO FRAPOLLI<br />
TIBET<br />
Le testimonianze della nascita<br />
del Tibet non sono molte, si sa<br />
però che inizialmente era popolato<br />
da pastori noma<strong>di</strong> provenienti<br />
dall’Asia centrale.<br />
La storia del Tibet, in tibetano<br />
“Bod”, che si pronuncia “pö”, inizia<br />
nel 617 d.C. Dopo secoli <strong>di</strong> autonomia<br />
arrivò a espandersi coprendo<br />
parti della Cina. Divenne stato vassallo<br />
dell’Impero mongolo; poi, nel<br />
1368 e fi no al 1644, della <strong>di</strong>nastia<br />
Ming, quin<strong>di</strong>, fi no al 1911, della<br />
<strong>di</strong>nastia Qing. Nello stesso anno<br />
<strong>di</strong>venne uno Stato in<strong>di</strong>pendente,<br />
ma ebbe anche fi ne l’Impero cinese<br />
che si trasformò in Repubblica<br />
<strong>di</strong> Cina. L’invasione del Tibet da<br />
parte della Repubblica <strong>Popolare</strong><br />
Cinese ebbe inizio nel 1949-50 e<br />
ora quasi la totalità del territorio<br />
tibetano è sotto la sua sovranità.<br />
Il Tibet ha un’estensione, più<br />
o meno, come l’intera Germania<br />
– sui 2 milioni <strong>di</strong> Km quadrati – con<br />
circa 6 milioni <strong>di</strong> abitanti. Un censimento<br />
esatto, in questo periodo,<br />
è <strong>di</strong>fficile stilarlo. Ha un clima<br />
estremamente rigido, è ventoso e<br />
i tre quinti dell’altopiano sono situati<br />
ad oltre 3.500 m <strong>di</strong> altitu<strong>di</strong>ne.<br />
Recentemente è stata inaugurata<br />
una ferrovia che unisce Pechino a<br />
Lhasa in 40 ore, ciò che unirà,<br />
secondo le autorità cinesi, la capitale<br />
con le regioni più sperdute del<br />
Paese. Non ho mai preso questo<br />
treno, anche perché l’idea <strong>di</strong> passare<br />
40 ore al freddo, almeno<br />
credo, in un treno, non mi ha ancora<br />
stuzzicato la curiosità.<br />
Una curiosità: fi no ad un recente<br />
passato, fra gli abitanti del<br />
Tibet, che erano profondamente<br />
legati al matriarcato, era <strong>di</strong>ffusa la<br />
“<strong>di</strong>andria”, vale a <strong>di</strong>re che era costume<br />
corrente che le donne sposassero<br />
due uomini, <strong>di</strong> solito fratelli<br />
o comunque parenti.<br />
NOTIZIARIO<br />
Attualità<br />
Il Tibet rimase per<br />
lungo tempo un<br />
“mito” geografico per<br />
la maggioranza del<br />
pubblico occidentale.<br />
Tibet remained a<br />
geographical “myth”<br />
for the majority of<br />
the western public.<br />
Tibet Tawo Tadra<br />
Sometimes even Earth’s less hospitable regions propose extraor<strong>di</strong>nary initiatives. A kid escapes<br />
from Tibet after the People’s Republic of China dominates his country. He stays at a “Pestalozzi<br />
Village” in Germany, a Swiss institution that operates internationally to help orphan and refugee<br />
teenagers. That lucky kid stu<strong>di</strong>es, becomes a doctor and thinks about proposing in his<br />
country a similar initiative to the one that helped him. And he can build shelter houses at 4,000<br />
metres, where in the winter the temperature is 30º below zero. A touching modern fairytale.<br />
ATTUALITÀ 99
Tawo è un cognome tibetano,<br />
Palden un nome, Palden Tawo un<br />
me<strong>di</strong>co gastroenterologo che esercita<br />
in Germania in un grande<br />
ospedale. Arrivò in Germania nel<br />
1963 con tanti altri bambini orfani<br />
e profughi, vittime dell’invasione<br />
del Tibet da parte della Repubblica<br />
<strong>Popolare</strong> Cinese. Venne accolto in<br />
un villaggio Pestalozzi.<br />
Qui vale forse aprire una breve<br />
parentesi sulla Fondazione Villaggi<br />
Pestalozzi. Si tratta <strong>di</strong> un’opera<br />
assistenziale svizzera con sfera<br />
d’azione internazionale. Aiuta bambini<br />
e adolescenti bisognosi <strong>di</strong> entrambi<br />
i sessi in<strong>di</strong>pendentemente<br />
dalla nazionalità, colore, religione o<br />
lingua. Se l’abbandono, la solitu<strong>di</strong>ne<br />
e l’in<strong>di</strong>genza sono l’inferno, per<br />
questi bambini il villaggio Pestalozzi<br />
rappresenta il para<strong>di</strong>so. Rinascono<br />
il sorriso, la voglia <strong>di</strong> vivere e la<br />
speranza. In questo senso i villaggi<br />
Pestalozzi sono stati, fi n dalla loro<br />
creazione, una goccia <strong>di</strong> felicità nel<br />
cuore <strong>di</strong> migliaia <strong>di</strong> bambini abbandonati.<br />
Villaggi Pestalozzi sono<br />
stati costruiti anche in Germania<br />
ed è lì che il nostro piccolo Palden<br />
arrivò nel ’63. Stu<strong>di</strong>ò e <strong>di</strong>venne<br />
me<strong>di</strong>co con un’idea fi ssa: quella <strong>di</strong><br />
fondare un villaggio tipo Pestalozzi<br />
per accogliere piccoli orfani nella<br />
sua terra, in Tibet, e fu così che<br />
con sua moglie, Chöni, infermiera,<br />
tibetana come lui e conosciuta<br />
nello stesso villaggio della sua infanzia,<br />
cominciò a cercare i fon<strong>di</strong><br />
necessari. Così, nel 1997, con<br />
l’aiuto <strong>di</strong> amici in Germania e in<br />
Svizzera creò il primo villaggio per<br />
orfani, il progetto Tadra a Dawu,<br />
nella provincia del Kham.<br />
100 ATTUALITÀ<br />
TAWO<br />
Il dottor Palden Tawo<br />
con la moglie Chöni<br />
e un collaboratore.<br />
In basso: Palden con<br />
alcuni ragazzi.<br />
Nella foto piccola:<br />
Palden ragazzo al<br />
villaggio Pestalozzi<br />
con Chöni che più<br />
tar<strong>di</strong> <strong>di</strong>verrà sua<br />
moglie.<br />
Doctor Palden Tawo<br />
with his wife Chöni<br />
and a collaborator.<br />
Below: Palden with<br />
some youths. In the<br />
small photo: Palden<br />
as a boy in the<br />
Pestalozzi village with<br />
Chöni who later<br />
became his wife.
TADRA<br />
Il progetto Tadra aveva preso<br />
forma. Se all’inizio erano tre case,<br />
oggi sono molte <strong>di</strong> più ed è stata<br />
anche creata, grazie a un lascito<br />
svizzero, una scuola <strong>di</strong> arti e mestieri<br />
dove si portano i ragazzi ad<br />
apprendere una professione per<br />
poi, all’età <strong>di</strong> 16 anni, licenziarli<br />
con un <strong>di</strong>ploma professionale.<br />
Pensate che una classe <strong>di</strong> liceo<br />
in Germania si tassò e ogni<br />
allievo portò quanto era nelle sue<br />
possibilità, organizzarono feste,<br />
avvenimenti atti a raccogliere fon<strong>di</strong><br />
e alla fi ne dell’anno scolastico<br />
raccolsero i sol<strong>di</strong> necessari alla<br />
costruzione <strong>di</strong> una casa che porta<br />
il nome <strong>di</strong> quella terza liceo. Un<br />
anno dopo gli stessi allievi organizzarono<br />
una gita in Tibet per vedere<br />
realizzata la loro opera.<br />
Personalmente ho assistito<br />
alla cerimonia <strong>di</strong> chiusura dell’anno<br />
con la consegna dei <strong>di</strong>plomi e i<br />
successivi “licenziamenti” dalla<br />
struttura. Non ho mai visto così<br />
tanti giovani piangere a <strong>di</strong>rotto. Si<br />
rompeva una magia. L’infanzia era<br />
fi nita, il mondo esterno li stava per<br />
assorbire. Entrati all’età <strong>di</strong> tre anni,<br />
curati, amati e protetti, <strong>di</strong> colpo il<br />
momento della serenità fi niva.<br />
Nel 2006 un secondo villaggio<br />
Tadra veniva aperto per accogliere<br />
altri orfani. Ogni casa accoglie<br />
15 bambini, una “haus ma-<br />
Il nuovo villaggioorfanotrofio<br />
<strong>di</strong> Golok<br />
a 4.200 metri<br />
d’altezza.<br />
The new orphanage<br />
village in Golok at<br />
4200 metres of<br />
altitude.<br />
der” l’importante fi gura materna,<br />
la madre della casa, e un insegnante<br />
a rappresentare la sicurezza<br />
della fi gura paterna. Il nuovo<br />
villaggio Tadra si trova molto più a<br />
nord <strong>di</strong> Tawo, nella provincia dell’Amdo-Golok<br />
a circa 4.200 metri<br />
d’altezza. Si pensi a una cosa:<br />
sopravvivere d’inverno a una temperatura<br />
<strong>di</strong> –20 o –30 gra<strong>di</strong>, com’è<br />
la temperatura invernale in queste<br />
regioni, per questi bambini abbandonati<br />
<strong>di</strong>venta una cosa quasi impossibile.<br />
Da parte del governo<br />
cinese non ci sono grosse <strong>di</strong>ffi coltà<br />
anche perché nella struttura<br />
vengono accolti anche orfani cinesi.<br />
Oltre alle materie convenzionali<br />
si insegna anche il tibetano, il cinese<br />
e l’inglese. Molti sono i giovani<br />
insegnanti volontari che trascorrono<br />
un anno nella struttura<br />
Tadra. Ho conosciuto una ragazza<br />
tedesca che stava facendo un<br />
anno <strong>di</strong> volontariato insegnando<br />
l’inglese. Questo è un concetto<br />
unico negli altipiani tibetani.<br />
Attualmente le due strutture<br />
ospitano circa 400 orfani e bambini<br />
<strong>di</strong> strada: bambini felici e sorridenti.<br />
La grande tristezza è che c’è<br />
una “lista d’attesa” <strong>di</strong> ben 350<br />
bambini.<br />
Questo bellissimo progetto si<br />
basa esclusivamente sul patrocinio<br />
<strong>di</strong> fon<strong>di</strong> privati e donazioni.<br />
Assistere per un anno un orfano<br />
con alloggio, vestiario, istruzione,<br />
costa 650 euro, vale a <strong>di</strong>re un<br />
euro e 70 centesimi al giorno. Costruire<br />
una casa per 15 bambini<br />
ne costa 30.000.<br />
www.tadra.ch<br />
Info: fausto.sassi@bluewin.ch<br />
ATTUALITÀ 101
I bambini riuniti al mattino<br />
Felici dentro una casa La cernita dei vestiti per i ragazzi<br />
102 ATTUALITÀ
Anche un solo biscotto può rendere felici<br />
Un pranzo all’aperto<br />
Sono stati <strong>di</strong>stribuiti vestiti e regali<br />
È tornato il sorriso<br />
ATTUALITÀ 103
Oggi questi ragazzi sono felici<br />
e sorridenti, ieri erano <strong>di</strong>sperati<br />
104 ATTUALITÀ<br />
Gli “inquilini”<strong>di</strong> una casa dell’orfanotrofio<br />
Un abbraccio <strong>di</strong> ringraziamento vale più <strong>di</strong> ogni altra cosa
L’entrata del villaggio <strong>di</strong> Dawo Tenzin Frapolli sommersa dai Kata, le sciarpe bianche beneaugurali<br />
La Scuola Arti e Mestieri donata dalla Fondazione ticinese Ambrosoli<br />
Una delle case del villaggio Lo sterco <strong>di</strong> yack steso a essiccare al sole. Verrà usato come combustibile<br />
ATTUALITÀ 105
Le danze per la festa del villaggio <strong>di</strong> Golok si tengono all’aperto<br />
La collina <strong>di</strong> Golok coperta <strong>di</strong> ban<strong>di</strong>ere-preghiera<br />
Un altro scorcio del villaggio-orfanotrofio <strong>di</strong> Golok<br />
Il villaggio-orfanotrofio <strong>di</strong> Golok
Riunione sul piazzale<br />
Mensa e sala multiuso<br />
La scuola <strong>di</strong> Golok<br />
Qui, a 4.200 metri, i capelli si lavano nel fiume E non solo i capelli<br />
ATTUALITÀ 107
Il villaggio-orfanotrofio <strong>di</strong> Golok<br />
L’entrata del villaggio-orfanotrofio <strong>di</strong> Golok<br />
Attività lu<strong>di</strong>che al villaggio-orfanotrofio <strong>di</strong> Golok Una nuova casa in fase <strong>di</strong> costruzione<br />
108 ATTUALITÀ
Pranzo all’aperto<br />
La scuola Il ritratto <strong>di</strong> Palden Tawo è già <strong>di</strong>ventato un’icona<br />
Tutti gli ospiti del villaggio <strong>di</strong> Golok
La nuova meccanica<br />
e la ricerca inter<strong>di</strong>sciplinare<br />
EDOARDO MAZZA<br />
Professore Or<strong>di</strong>nario <strong>di</strong> Meccanica,<br />
Politecnico Federale <strong>di</strong> Zurigo, ETH<br />
Direttore <strong>di</strong> Laboratorio, Istituto Federale<br />
della Ricerca sui Materiali, EMPA<br />
Politecnico Federale <strong>di</strong> Zurigo,<br />
semestre autunnale<br />
2010. Anche quest’anno<br />
mi trovo <strong>di</strong> fronte ad un’aula<br />
gremita da centinaia <strong>di</strong> studenti.<br />
Un nuovo record. Gli iscritti al corso<br />
<strong>di</strong> “Meccanica-1” sono più <strong>di</strong> ottocento.<br />
Il Politecnico non ha un au<strong>di</strong>torium<br />
in grado <strong>di</strong> riceverli tutti,<br />
abbiamo dovuto <strong>di</strong>videre il corso.<br />
“Ai miei tempi” (20 anni fa) a<br />
seguire le lezioni <strong>di</strong> ingegneria<br />
meccanica eravamo circa in 300.<br />
Allora le preferenze andavano piuttosto<br />
all’elettrotecnica o all’informatica.<br />
Il grande aumento nel nu-<br />
New mechanics and inter<strong>di</strong>sciplinary research<br />
Zurich Polytechnic is going through a moment of renewed interest<br />
in mechanical engineering. The fact is due to the modernization<br />
recorded in the classic <strong>di</strong>sciplines of the sector, now the<br />
protagonists in solving today’s problems: energy, the environment,<br />
transport and me<strong>di</strong>cine. Experimental research is once again<br />
fundamental and special attention is reserved to an<br />
inter<strong>di</strong>sciplinary approach. The test bench for the new perspective<br />
is the optimization of thermo-electric power stations, with an<br />
analysis of the microstructure of materials and identification of the<br />
critical components. Attention is also focused on instrumentation<br />
and the use of robots in operating theatres, and even “tissue<br />
engineering” for car<strong>di</strong>ovascular applications.<br />
110 ATTUALITÀ<br />
Esperimenti<br />
termo-meccanici su<br />
acciaio 1% CrMoV.<br />
Thermo-mechanical<br />
experiments on 1%<br />
CrMoV steel.<br />
mero <strong>di</strong> studenti <strong>di</strong> ingegneria<br />
meccanica è avvenuto negli ultimi<br />
cinque anni, una sorta <strong>di</strong> revival <strong>di</strong><br />
una facoltà tra<strong>di</strong>zionale. Che cosa<br />
si attendono dal loro futuro professionale<br />
i ragazzi che ho davanti?<br />
Quali speranze ripongono in questa<br />
formazione?<br />
Il nostro <strong>di</strong>partimento (ingegneria<br />
meccanica e tecnologie <strong>di</strong><br />
processo) ha visto negli ultimi anni<br />
un forte aumento <strong>di</strong> tutti gli in<strong>di</strong>catori<br />
della performance accademica,<br />
non solo negli iscritti ai corsi:<br />
sono cresciuti in modo rilevante il<br />
numero <strong>di</strong> ricercatori, il volume <strong>di</strong><br />
progetti in collaborazione con l’industria,<br />
il numero <strong>di</strong> pubblicazioni<br />
scientifi che nelle riviste internazionali<br />
più importanti e selettive.<br />
Credo che questo sviluppo<br />
sia legato al processo <strong>di</strong> modernizzazione<br />
delle <strong>di</strong>scipline classiche<br />
dell’ingegneria meccanica, che sono<br />
<strong>di</strong>ventate protagoniste essenziali<br />
nella ricerca <strong>di</strong> soluzioni ai<br />
gran<strong>di</strong> e ai nuovi problemi dell’umanità<br />
(energia, risorse ambientali,<br />
trasporti, me<strong>di</strong>cina, ecc.) e che,<br />
soprattutto, si orientano a promuovere<br />
innovazione e a creare<br />
vantaggi competitivi per permettere<br />
alla nostra società <strong>di</strong> fronteggiare<br />
la concorrenza delle economie<br />
emergenti. E proprio <strong>di</strong> questa sfi -<br />
da possono <strong>di</strong>ventare protagonisti<br />
i giovani ingegneri.<br />
Parlo agli studenti della ricerca,<br />
per motivarli ad affrontare le<br />
<strong>di</strong>ffi coltà del corso. Mi chiedono<br />
secondo quali criteri si scelgano i<br />
temi dei nostri progetti <strong>di</strong> ricerca.<br />
È sempre <strong>di</strong>ffi cile, ed è parte primaria<br />
del ricercare, l’in<strong>di</strong>viduazione<br />
dell’obiettivo. La scelta è legata<br />
a quello che lo stu<strong>di</strong>oso ritiene<br />
praticabile per le sue competenze,<br />
<strong>di</strong>rimendo tra le innumerevoli necessità<br />
della società (una scelta<br />
cui non è estranea una sorta <strong>di</strong><br />
“vocazione”). Spiego loro anche<br />
che non sempre il ricercatore raggiunge<br />
l’obiettivo e talvolta neppure<br />
in<strong>di</strong>vidua la corretta <strong>di</strong>rezione,<br />
ma sempre il suo lavoro, perseguito<br />
con onestà, rigore e passione,<br />
farà compiere un passo più o meno<br />
lungo verso il risultato: chi poi<br />
lo raggiunge avrà fruito dei traguar<strong>di</strong>,<br />
ancorché parziali, <strong>di</strong> chi lo ha<br />
preceduto sul campo <strong>di</strong> quella ricerca.<br />
EMPA Dübendorf
La meccanica e l’ingegnere<br />
La meccanica è la parte della<br />
fi sica che stu<strong>di</strong>a il rapporto tra<br />
forze e movimenti o deformazioni<br />
della materia. Uno dei compiti<br />
fondamentali dell’ingegnere sta<br />
proprio nel caratterizzare il rapporto<br />
tra carichi e deformazioni nelle<br />
strutture, che siano queste la parte<br />
<strong>di</strong> un e<strong>di</strong>fi cio, i componenti <strong>di</strong><br />
una macchina o <strong>di</strong> uno strumento<br />
chirurgico <strong>di</strong> precisione. La cosiddetta<br />
“procedura <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensionamento”<br />
tratta le domande fondamentali<br />
riguardo all’integrità <strong>di</strong> un<br />
componente soggetto a determinati<br />
carichi <strong>di</strong> esercizio e alla compatibilità<br />
delle deformazioni conseguenti<br />
a questi carichi con l’assolvimento<br />
della sua funzione. Le<br />
risposte a queste domande passano<br />
attraverso la soluzione <strong>di</strong> un<br />
problema matematico, il “problema<br />
fondamentale della meccanica<br />
del continuo”, defi nito da una serie<br />
<strong>di</strong> equazioni <strong>di</strong>fferenziali e dalle rispettive<br />
con<strong>di</strong>zioni al contorno.<br />
La formulazione “semplice”<br />
del problema fondamentale, in<br />
termini <strong>di</strong> piccole deformazioni e<br />
comportamento linearmente elastico<br />
del materiale, rappresenta<br />
ancora oggi la base per l’analisi<br />
strutturale. Il lavoro <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong><br />
ingegneri e matematici ha infatti<br />
permesso <strong>di</strong> sviluppare, per questo<br />
caso semplice, soluzioni analitiche<br />
per elementi strutturali (per<br />
esempio travature, lastre, gusci) o<br />
per componenti <strong>di</strong> macchine (per<br />
esempio fl ange, recipienti in pressione,<br />
rotori). La ricerca teorica ha<br />
portato anche alla proposizione<br />
“non lineare” del problema fondamentale<br />
(quin<strong>di</strong> per gran<strong>di</strong> deformazioni)<br />
e alla defi nizione <strong>di</strong> criteri<br />
per la formulazione dei cosiddetti<br />
“modelli costitutivi” (le equazioni<br />
che legano stato <strong>di</strong> sforzo e <strong>di</strong><br />
deformazione) per il comportamento<br />
non lineare dei materiali<br />
(plasticità, viscoelasticità non<br />
linea re, iperelasticità). Lo sviluppo<br />
<strong>di</strong> queste teorie ha inizialmente<br />
rappresentato un certo <strong>di</strong>stacco<br />
dalle esigenze applicative dell’ingegnere,<br />
poiché la soluzione del<br />
problema non lineare era possibile<br />
solo per alcuni problemi <strong>di</strong> carattere<br />
“accademico”. Dalla se-<br />
L’analisi<br />
metallografica<br />
successiva ai test<br />
ciclici rileva <strong>di</strong>versi<br />
meccanismi <strong>di</strong><br />
deterioramento.<br />
A metallographic<br />
analysis following<br />
cyclical tests reveals<br />
various deterioration<br />
mechanisms.<br />
conda metà del secolo scorso<br />
tuttavia, grazie allo sviluppo del<br />
calcolo numerico e all’avvento del<br />
computer, si è verifi cata una vera<br />
e propria “rivoluzione” nel campo<br />
del calcolo strutturale che ha portato<br />
oggi a strumenti <strong>di</strong> lavoro<br />
completamente nuovi per l’ingegnere<br />
e ha dato ulteriori impulsi<br />
alla ricerca. Si tratta del metodo<br />
degli elementi fi niti.<br />
Nuovi orizzonti per la meccanica<br />
Non sarebbe opportuno descrivere<br />
in questa sede questo<br />
metodo <strong>di</strong> calcolo, solo voglio affermare<br />
che la rivoluzione consi-<br />
ste nel fatto che il problema matematico<br />
fondamentale, se adeguatamente<br />
formulato, <strong>di</strong>viene risolubile<br />
per ogni confi gurazione<br />
geometrica, anche per gran<strong>di</strong> deformazioni,<br />
e per ogni tipo <strong>di</strong> modello<br />
costitutivo.<br />
Le implicazioni <strong>di</strong> questa nuova<br />
meto<strong>di</strong>ca sono entusiasmanti:<br />
il modello può fortemente avvicinarsi<br />
alla realtà fi sica e rappresentarla<br />
nella sua complessità. Problemi<br />
prima preclusi ad un approccio<br />
<strong>di</strong> analisi deterministica sono<br />
ora accessibili. I coeffi cienti <strong>di</strong> sicurezza<br />
(generati dalle incertezze<br />
dei precedenti modelli meno accu-<br />
Rappresentazione esemplificativa dell’evoluzione della microstruttura e della sua relazione con<br />
le proprietà meccaniche del materiale.<br />
Illustrative representation of the evolution of the microstructure and its relation to the material’s<br />
mechanical properties.<br />
ATTUALITÀ 111<br />
EMPA Dübendorf<br />
EMPA Dübendorf
ati) possono essere ridotti a vantaggio<br />
<strong>di</strong> soluzioni più effi cienti e<br />
meno costose anche se altrettanto<br />
affi dabili. Inoltre il proce<strong>di</strong>mento<br />
<strong>di</strong> analisi quantitativa del rapporto<br />
causale tra forze e deformazioni<br />
può oggi essere applicato a sistemi<br />
molto complessi, come ad<br />
esempio, nella biomeccanica, agli<br />
organi del corpo umano.<br />
Per questa nuova meccanica<br />
la ricerca sperimentale torna ad<br />
avere rilevanza primaria. La formulazione<br />
delle equazioni che descrivono<br />
il comportamento meccanico<br />
dei materiali richiede particolari<br />
esperimenti e nuovi meto<strong>di</strong> <strong>di</strong><br />
analisi delle osservazioni strumentali.<br />
La defi nizione dei modelli<br />
costitutivi necessita inoltre <strong>di</strong> una<br />
più approfon<strong>di</strong>ta comprensione<br />
dei fenomeni rilevanti della fi sica<br />
dei materiali e quin<strong>di</strong> l’applicazione<br />
dei più moderni meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> visualizzazione<br />
ed analisi della loro<br />
microstruttura.<br />
La ricerca <strong>di</strong>viene dunque<br />
inerentemente inter<strong>di</strong>sciplinare, e<br />
per questo vera scienza. Forse<br />
proprio in questa novità <strong>di</strong> approccio<br />
va colto l’aspetto più interessante:<br />
l’interconnessione tra le<br />
problematiche in ambiti <strong>di</strong> ricerca<br />
<strong>di</strong>versi, a volte apparentemente<br />
lontani, è molto <strong>di</strong>ffusa se non<br />
generalizzata, così che vanno cadendo<br />
gli steccati <strong>di</strong> incomunicabilità<br />
tra le <strong>di</strong>scipline e crescono invece<br />
occasioni <strong>di</strong> sinergia. Lasciato<br />
il senso <strong>di</strong> possesso unilaterale<br />
della propria specialità, si sta realizzando<br />
una reale circolarità del<br />
sapere, spesso prima solo teorizzata,<br />
che avviene anche grazie al<br />
nostro mondo globalizzato e alla<br />
grande facilità <strong>di</strong> comunicazione.<br />
Per quel che riguarda la meccanica,<br />
le nuove possibilità <strong>di</strong> indagine<br />
dei fenomeni relativi al movimento<br />
e alle deformazioni dei corpi<br />
rendono la ricerca, oggi ancor <strong>di</strong><br />
più, protagonista dello sviluppo<br />
scientifi co e tecnologico negli ambiti<br />
rilevanti per il progresso della<br />
società. Ad illustrazione <strong>di</strong> quanto<br />
sopra propongo tre esempi tratti<br />
dai progetti in corso nel mio laboratorio<br />
<strong>di</strong> ricerca a Zurigo (con<br />
qualche dettaglio tecnico per i<br />
lettori interessati).<br />
112 ATTUALITÀ<br />
Sopra: esperimenti per analizzare le proprietà meccaniche delle<br />
membrane amnios corion. Sotto: applicazione intraoperativa della<br />
tecnica “aspiration device” per misurare la risposta meccanica del<br />
tessuto epatico in-vivo.<br />
Above: experiments for analysing the mechanical properties of the<br />
membranes of the amnion and the chorion. Below: intra-operation<br />
application of the “aspiration device” technique to measure the hepatic<br />
tissue’s mechanical response in-vivo.<br />
Esperimenti per la<br />
caratterizzazione dei<br />
mesh me<strong>di</strong>ci usati<br />
per supportare il<br />
tessuto connettivo.<br />
Experiments for<br />
characterization of<br />
me<strong>di</strong>cal meshes used<br />
to support<br />
connecting tissue.<br />
Centrali termoelettriche<br />
più effi cienti<br />
e quin<strong>di</strong> meno inquinanti<br />
Nelle centrali termoelettriche<br />
(centrali a gas, a vapore, a ciclo<br />
combinato, nucleari, a solare termo<strong>di</strong>namico)<br />
viene prodotto più<br />
ETH Zürich/Universitätsspital Zürich<br />
ETH Zürich/Universitätsspital Zürich<br />
dell’80% dell’energia elettrica, in<br />
Europa e nel mondo. È ovvio dunque<br />
che gli sforzi della comunità<br />
scientifi ca si concentrino, oltre che<br />
sullo sviluppo <strong>di</strong> fonti alternative e<br />
rinnovabili, sull’ottimizzazione <strong>di</strong><br />
queste centrali. Anche un piccolo<br />
aumento del ren<strong>di</strong>mento delle<br />
macchine termiche porta alla <strong>di</strong>minuzione<br />
del consumo e delle emissioni<br />
per l’intera vita <strong>di</strong> esercizio<br />
della macchina, e quin<strong>di</strong> a rilevanti<br />
miglioramenti in termini <strong>di</strong> impatto<br />
ambientale e <strong>di</strong> utilizzo delle risorse<br />
energetiche.<br />
Nel nostro laboratorio cerchiamo<br />
nuove soluzioni guardando<br />
alla microstruttura dei materiali<br />
metallici utilizzati per i componenti<br />
ad alta temperatura nelle turbine<br />
a gas o a vapore. È nella microstruttura<br />
che si manifestano i fenomeni<br />
che la modellizzazione<br />
meccanica intende descrivere e<br />
che caratterizzano la risposta alle<br />
sollecitazioni termo-meccaniche:<br />
si tratta della deformazione viscoplastica<br />
e del progressivo deterioramento<br />
che può culminare con il<br />
ce<strong>di</strong>mento del componente meccanico.<br />
La modalità <strong>di</strong> esercizio delle<br />
macchine termiche è limitata da<br />
criteri intesi a preservarne l’integrità.<br />
Parametri come la temperatura<br />
massima del ciclo termo<strong>di</strong>namico<br />
o la durata della fase transiente in<br />
una ripartenza a freddo sono dettati<br />
da questi criteri e incidono<br />
ETH Zürich
fortemente sull’efficienza, sulle<br />
emissioni, sulla sostenibilità ambientale<br />
ed economica dell’impianto.<br />
La ricerca propone soluzioni per<br />
ottimizzare l’esercizio delle macchine<br />
termiche, ad esempio sviluppando<br />
nuove leghe più resistenti<br />
alle sollecitazioni. Le nuove possibilità<br />
dell’analisi del problema meccanico<br />
contribuiscono in modo<br />
importante a questa sfi da sviluppando<br />
nuove procedure <strong>di</strong> calcolo<br />
che permettono <strong>di</strong> sfruttare al meglio<br />
sia i componenti già in esercizio,<br />
sia le potenzialità dei nuovi<br />
materiali. Per ottenere questo è<br />
necessario determinare modelli<br />
del comportamento meccanico dei<br />
materiali più accurati e affi dabili.<br />
La formulazione <strong>di</strong> questi modelli<br />
costitutivi non può basarsi<br />
sulle informazioni generate attraverso<br />
i test convenzionali per la<br />
caratterizzazione dei materiali. Infatti,<br />
mentre i cosiddetti test <strong>di</strong><br />
fatica convenzionali sono realizzati<br />
a temperatura costante, applicando<br />
uno stato <strong>di</strong> sforzo uni-assiale<br />
e una velocità <strong>di</strong> deformazione<br />
elevata, le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> carico reali<br />
dei componenti meccanici sono<br />
caratterizzate da sollecitazione<br />
multi-assiale a basse velocità <strong>di</strong><br />
deformazione e sono soggette a<br />
temperature variabili.<br />
Nel nostro laboratorio realizziamo<br />
esperimenti che intendono<br />
colmare queste <strong>di</strong>fferenze. In collaborazione<br />
con le maggiori industrie<br />
produttrici <strong>di</strong> turbomacchine<br />
abbiamo identifi cato i componenti<br />
critici per i quali ricreare in laboratorio<br />
con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> carico e <strong>di</strong> risposta<br />
meccanica rappresentativa<br />
delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> esercizio. Abbiamo<br />
sviluppato nuove procedure<br />
sperimentali con sistemi <strong>di</strong> controllo<br />
sincronizzato della deformazione<br />
ciclica e <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> temperatura<br />
nei provini. Le fi gure illustrano<br />
esempi <strong>di</strong> esperimenti <strong>di</strong><br />
fatica termo-meccanica con provini<br />
d’acciaio contenenti un effetto<br />
intaglio e con blocchi progettati<br />
per un’esposizione ciclica a gra<strong>di</strong>enti<br />
termici.<br />
L’analisi metallografi ca successiva<br />
ad ogni esperimento ci<br />
permette, in collaborazione con<br />
colleghi esperti <strong>di</strong> metallurgia, <strong>di</strong><br />
Modello numerico<br />
del volto ricavato da<br />
immagini <strong>di</strong><br />
risonanza magnetica.<br />
(a) (e) mostrano i<br />
<strong>di</strong>versi muscoli considerati,<br />
(f) il modello<br />
completo.<br />
Numerical model of<br />
the face made from<br />
magnetic resonance<br />
images. (a) (e) show<br />
the <strong>di</strong>fferent muscles<br />
considered, (f) the<br />
completed model.<br />
(a)<br />
Orbicularis<br />
Oris<br />
Man<strong>di</strong>bular<br />
ligaments<br />
Zygomaticus<br />
Major<br />
Buccinator<br />
Depressor<br />
Anguli Oris<br />
Levator<br />
Anguli Oris<br />
Zygomatic<br />
ligaments<br />
Masseteric<br />
ligaments<br />
Platysma-auricolar<br />
ligaments<br />
Buccal-maxillary<br />
ligaments<br />
identifi care i meccanismi <strong>di</strong> deterioramento<br />
responsabili del ce<strong>di</strong>mento<br />
del provino. Esempi <strong>di</strong> usura<br />
prevalentemente a fatica (con<br />
cricche transgranulari) e <strong>di</strong> ce<strong>di</strong>mento<br />
dovuto a deterioramento<br />
dominato da “creep” (con pori intergranulari)<br />
sono visibili nelle illustrazioni.<br />
I nuovi esperimenti ci permettono<br />
<strong>di</strong> defi nire equazioni costitutive<br />
per descrivere il comportamento<br />
visco-plastico del materiale e la<br />
sua evoluzione nel corso della<br />
storia <strong>di</strong> carico. Questi modelli introducono<br />
variabili rappresentative<br />
dello stato della microstruttura e<br />
le corrispondenti equazioni evolutive<br />
per descrivere l’incru<strong>di</strong>mento o<br />
l’addolcimento ciclico. Le equazioni<br />
sono inserite in algoritmi <strong>di</strong> cal-<br />
(b)<br />
(c) (d)<br />
(e) (f)<br />
Mentalis<br />
Depressor<br />
Labii<br />
Zygomaticus<br />
Minor<br />
Levator Labii<br />
Levator Labii<br />
Alaeque Nasi<br />
Masseter<br />
colo che ne permettono l’utilizzo<br />
nelle simulazioni con il metodo<br />
degli elementi fi niti. La capacità <strong>di</strong><br />
questi modelli <strong>di</strong> descrivere la risposta<br />
meccanica e la sua progressione<br />
durante la vita della<br />
turbina <strong>di</strong>pende dal legame tra il<br />
modello matematico adottato e i<br />
fenomeni fi sici che si sviluppano<br />
nella microstruttura del materiale.<br />
La formulazione <strong>di</strong> modelli basati<br />
su processi fi sici è oggi facilitata<br />
dalle nuove possibilità <strong>di</strong> indagine<br />
microscopica (microscopia elettronica,<br />
meto<strong>di</strong> <strong>di</strong>ffrattometrici) e della<br />
analisi quantitativa delle immagini<br />
ottenute. Noi seguiamo questa<br />
strada in un progetto <strong>di</strong> collaborazione<br />
inter<strong>di</strong>sciplinare con<br />
scienziati dei materiali e con i fi sici<br />
del Paul Scherrer Institute.<br />
ATTUALITÀ 113<br />
ETH Zürich
I successi ottenuti nel defi nire<br />
procedure <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensionamento<br />
che assicurino l’affidabilità dei<br />
componenti ma senza eccessivi<br />
coeffi cienti <strong>di</strong> sicurezza ci incoraggiano<br />
ad estendere questo approccio<br />
ad altri campi. In collaborazione<br />
con le aziende svizzere del<br />
settore stiamo iniziando a lavorare<br />
su un progetto nel quale si vogliono<br />
identifi care nuovi limiti <strong>di</strong> esercizio<br />
delle linee elettriche ad alta<br />
tensione. I vantaggi legati ad una<br />
gestione più fl essibile dei limiti <strong>di</strong><br />
temperatura, e quin<strong>di</strong> <strong>di</strong> capacità<br />
<strong>di</strong> trasmissione, sono notevoli.<br />
“Progettazione”<br />
dell’intervento chirurgico<br />
L’applicazione dei meto<strong>di</strong><br />
dell’ingegneria alla chirurgia si è<br />
intensifi cata negli ultimi anni. Basti<br />
pensare allo sviluppo della strumentazione<br />
e all’utilizzo del robot<br />
in sala operatoria, alle tecnologie<br />
per gli interventi <strong>di</strong> microchirurgia<br />
o minimally invasive, o ai sistemi<br />
computerizzati <strong>di</strong> navigazione intra-operativa.<br />
Lo sviluppo <strong>di</strong> alcune <strong>di</strong> queste<br />
tecnologie richiede la conoscenza<br />
del comportamento meccanico<br />
dei tessuti del corpo umano.<br />
Nel mio laboratorio svilup piamo<br />
nuovi meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> ca ratterizzazione e<br />
modellizzazione dei tessuti per<br />
applicazioni (i) in <strong>di</strong>agnostica (per<br />
esempio misurazione intraoperativa<br />
della consistenza del tessuto<br />
epatico; in<strong>di</strong>viduazione delle<br />
membrane fetali a rischio <strong>di</strong> rottura<br />
durante la amniocentesi), (ii)<br />
nello sviluppo <strong>di</strong> materiali per<br />
protesi e impianti (esempio i<br />
mesh me<strong>di</strong>ci utilizzati per supportare<br />
il tessuto connettivo in caso<br />
<strong>di</strong> ernia o prolasso; le protesi ot-<br />
114 ATTUALITÀ<br />
Esempi <strong>di</strong><br />
esperimenti utilizzati<br />
per la validazione<br />
del modello<br />
numerico del volto.<br />
Examples of<br />
experiments used to<br />
validate a numerical<br />
model of the face.<br />
tenute tramite tissue engineering<br />
per applicazioni car<strong>di</strong>o-vascolari),<br />
(iii) e nella simulazione e pianifi -<br />
cazione dell’intervento chirurgico.<br />
Quest’ultimo campo applicativo<br />
nasce dal tentativo <strong>di</strong> tradurre<br />
in campo me<strong>di</strong>co alcuni aspetti<br />
dell’approccio deterministico al <strong>di</strong>mensionamento:<br />
conosciuti forma,<br />
con<strong>di</strong>zioni al contorno e caratteristiche<br />
meccaniche dei “materiali”<br />
coinvolti si calcola lo stato <strong>di</strong><br />
deformazione e <strong>di</strong> sforzo che si<br />
viene a creare con la procedura<br />
chirurgica. Un importante esempio<br />
in questo senso è quello della<br />
chirurgia ricostruttiva ed estetica<br />
del volto.<br />
Abbiamo sviluppato un modello<br />
numerico dettagliato del volto<br />
<strong>di</strong> un dottorando del mio gruppo<br />
<strong>di</strong> ricerca. Attraverso l’analisi <strong>di</strong><br />
immagini a risonanza magnetica<br />
ad alta risoluzione abbiamo ricostruito<br />
i singoli muscoli, le ossa, le<br />
cartilagini, la pelle, il cosiddetto<br />
SMAS (superfi cial muscolar aponeurotic<br />
system), il tessuto a<strong>di</strong>poso,<br />
la mucosa del cavo orale. In<br />
stretta collaborazione con me<strong>di</strong>ci<br />
anatomisti abbiamo così creato un<br />
modello che rappresenta tutti questi<br />
elementi e le corrispondenti<br />
interazioni.<br />
Per la defi nizione del comportamento<br />
meccanico dei singoli<br />
tessuti ci siamo serviti <strong>di</strong> nuovi<br />
meto<strong>di</strong> sperimentali applicati <strong>di</strong>rettamente<br />
al viso oggetto della modellizzazione.<br />
Questi esperimenti<br />
utilizzano sia sollecitazioni locali<br />
(con il cosiddetto “aspiration device”)<br />
sia procedure <strong>di</strong> analisi delle<br />
deformazioni globali del volto. Abbiamo<br />
stu<strong>di</strong>ato la risposta a carichi<br />
fi siologici (per esempio gravità)<br />
e artifi ciali (per esempio pressione<br />
nel cavo orale) attraverso misurazioni<br />
olografi che, con telecamere<br />
3D, e meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> imaging con risonanza<br />
magnetica. Il confronto con<br />
i risultati delle corrispondenti simulazioni<br />
ha permesso <strong>di</strong> validare<br />
il modello numerico.<br />
La collaborazione con specialisti<br />
<strong>di</strong> chirurgia estetica e ricostruttiva<br />
e con gli ingegneri della<br />
Ethicon (azienda leader nel campo<br />
dei materiali per la chirurgia) si<br />
incentra sull’applicazione del nostro<br />
modello per sviluppare nuove<br />
procedure <strong>di</strong> lifting minimally invasive,<br />
sull’analisi dell’effetto della<br />
gravità sull’invecchiamento del<br />
volto, sullo stu<strong>di</strong>o del riposizionamento<br />
e delle mo<strong>di</strong>fi che della cinematica<br />
della man<strong>di</strong>bola sull’apparenza<br />
e le deformazioni dei<br />
tessuti del viso.<br />
Materiali “smart”<br />
per macchine “soft”<br />
I materiali compositi (tipicamente<br />
costituiti da una matrice<br />
polimerica e da fi bre <strong>di</strong> vetro o<br />
carbonio) hanno costituito un grande<br />
progresso per l’ingegneria delle<br />
strutture. Con questa tecnologia è<br />
possibile creare il materiale più<br />
adatto per la struttura da sviluppare,<br />
con enorme vantaggio in termini<br />
<strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione della capacità <strong>di</strong><br />
resistenza e quin<strong>di</strong> <strong>di</strong> peso della<br />
struttura. Non a caso questi materiali<br />
trovano sempre maggiore applicazione<br />
nel campo aeronautico<br />
e automotive.<br />
La nuova frontiera nello sviluppo<br />
<strong>di</strong> sistemi <strong>di</strong> materiali è rappresentata<br />
dai cosiddetti “smart<br />
materials”: si tratta <strong>di</strong> materiali in<br />
grado <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fi care forma e proprietà<br />
meccaniche se soggetti a<br />
un campo elettrico, magnetico o <strong>di</strong><br />
ETH Zürich
ETH Zürich<br />
temperatura. In collaborazione con<br />
esperti <strong>di</strong> polimeri ci occupiamo<br />
dei cosiddetti elastomeri <strong>di</strong>elettrici,<br />
una tipologia <strong>di</strong> polimeri elettroattivi.<br />
Si tratta <strong>di</strong> un sistema composto<br />
da una membrana elastomerica<br />
sulla quale sono applicati<br />
elettro<strong>di</strong> cedevoli. L’applicazione <strong>di</strong><br />
una tensione elettrica genera forze<br />
elettrostatiche che deformano notevolmente<br />
l’elastomero. Con questo<br />
sistema realizziamo elongazioni<br />
nell’or<strong>di</strong>ne del 30% delle <strong>di</strong>men-<br />
sioni <strong>di</strong> partenza. Sono dunque<br />
attuatori con notevoli capacità <strong>di</strong><br />
allungamento attivo e deformazione<br />
passiva (non a caso vengono<br />
chiamati “artifi cial muscles”). Potenziali<br />
applicazioni sono nei sistemi<br />
ottici e acustici adattivi, nei <strong>di</strong>spositivi<br />
per estrarre energia dal<br />
movimento (per esempio delle onde<br />
marine), nell’ampio campo biome<strong>di</strong>co<br />
e nella robotica.<br />
La realizzazione <strong>di</strong> questi attuatori<br />
richiede procedure <strong>di</strong> calcolo<br />
per valutare in anticipo le prestazioni<br />
delle <strong>di</strong>verse possibili confi gurazioni.<br />
Nel nostro laboratorio ci<br />
occupiamo dello sviluppo <strong>di</strong> questi<br />
modelli <strong>di</strong> calcolo. In particolare<br />
stu<strong>di</strong>amo il comportamento iperelastico-viscoelastico<br />
degli elastomeri<br />
e l’accoppiamento elettro-<br />
meccanico negli attuatori. I nostri<br />
esperimenti forniscono informazioni<br />
sul comportamento in con<strong>di</strong>zioni<br />
<strong>di</strong> sforzo uni-assiale ed equi-biassiale<br />
delle membrane elastomeriche.<br />
La simulazione della risposta<br />
elettromeccanica richiede inoltre<br />
la misurazione delle proprietà fi siche<br />
(coefficienti <strong>di</strong> permettività<br />
elettrica e <strong>di</strong> elettrostrizione) e la<br />
loro <strong>di</strong>pendenza dallo stato <strong>di</strong> deformazione<br />
dell’elastomero. La verifi<br />
ca dell’affi dabilità dei modelli<br />
avviene attraverso il confronto tra<br />
i risultati <strong>di</strong> esperimenti con attuatori<br />
reali e le corrispondenti simulazioni<br />
con il metodo degli elementi<br />
fi niti.<br />
Oltre a rappresentare un affascinante<br />
campo <strong>di</strong> ricerca, i sistemi<br />
<strong>di</strong> materiali “smart” e le<br />
EMPA Dübendorf<br />
Esempi <strong>di</strong><br />
simulazione <strong>di</strong><br />
deformazioni<br />
fisiologiche del volto.<br />
Examples of<br />
simulating physical<br />
deformations of<br />
the face.<br />
Al centro: esempi<br />
<strong>di</strong> sistemi<br />
<strong>di</strong> attuatori che<br />
utilizzano elastomeri<br />
<strong>di</strong>elettrici. A sinistra:<br />
sistema seriale <strong>di</strong><br />
elementi “agonistantagonist”.<br />
A destra: attuatore<br />
“spring-roll”.<br />
Centre: examples of<br />
actuator systems<br />
that use <strong>di</strong>electric<br />
elastomers. On the<br />
left: serial system of<br />
“agonist-antagonist”<br />
elements. Right:<br />
“spring-roll” actuator.<br />
Sistema<br />
sperimentale e stu<strong>di</strong><br />
numerici per la<br />
caratterizzazione del<br />
comportamento<br />
biassiale degli<br />
elastomeri.<br />
Experimental system<br />
and numerical<br />
stu<strong>di</strong>es for<br />
characterizing the<br />
biaxial behaviour<br />
of elastomers.<br />
strutture deformabili e adattive<br />
offrono maggiori gra<strong>di</strong> <strong>di</strong> libertà<br />
per lo sviluppo <strong>di</strong> nuovi prodotti o<br />
per l’ottimizzazione <strong>di</strong> prodotti esistenti.<br />
Registriamo una crescente<br />
attenzione delle industrie verso<br />
queste tecnologie e per il potenziale<br />
<strong>di</strong> innovazione che da esse<br />
deriva. Intorno a queste nostre<br />
attività <strong>di</strong> ricerca sono anche nate<br />
negli ultimi anni due aziende<br />
“spin-off”: la Optotune AG (www.<br />
optotune.com) e la Compliant Concept<br />
GmbH (www.compliantconcept.com).<br />
Considerazioni conclusive<br />
La ricerca inter<strong>di</strong>sciplinare<br />
non solo offre maggiori potenzialità<br />
<strong>di</strong> progresso: essa rappresenta<br />
anche un grande arricchimento<br />
per gli stu<strong>di</strong>osi, che trovano in altri<br />
“luoghi <strong>di</strong> analisi” nuove possibilità<br />
<strong>di</strong> sviluppo o <strong>di</strong> utile impiego del<br />
proprio sapere. In questo senso è<br />
fondamentale non solo il rifi uto <strong>di</strong><br />
un senso <strong>di</strong> “onnipotenza” ad excludendum,<br />
ma anche la volontà <strong>di</strong><br />
uscire dagli steccati, superando le<br />
<strong>di</strong>visioni tra le <strong>di</strong>scipline.<br />
La positività <strong>di</strong> questo atteggiamento<br />
vale non solo per le <strong>di</strong>scipline<br />
scientifi che, ma anche per<br />
altri ambiti, come l’arte, la fi losofi<br />
a, la religione. Penso che l’ingegnere<br />
sia ricercatore dell’utile per<br />
il progresso della nostra società,<br />
ma che partecipi anche alla ricerca<br />
del “vero” in natura, e in questo<br />
senso sia compagno <strong>di</strong> strada non<br />
solo dei fi sici, dei chimici, dei matematici,<br />
dei biologi, ma anche dei<br />
fi losofi e dei teologi. E anche per<br />
la ricerca del “vero” il <strong>di</strong>alogo che<br />
unisce le <strong>di</strong>scipline si rivela stimolante<br />
per i protagonisti e, spesso,<br />
profi cuo per l’umanità.<br />
ATTUALITÀ 115<br />
ETH Zürich
Gli assilli <strong>di</strong> un inviato speciale<br />
Travelling with Brunhilda and Rosamund<br />
The world is no longer a place for heroic and pioneering<br />
journalism where a correspondent was also a photographer who<br />
was anxious to capture a fleeting moment that would never return<br />
with his trusty reflex cameras. Nor was there any possibility of<br />
making sure that one shot, amongst the hundreds he had taken,<br />
would be worthy of a magazine page. Other times,<br />
other temperaments, other partners in adventure. For example,<br />
a pilot that might have taken you soaring over a mountain top in<br />
search of an exclusive photograph, who years later you find in one<br />
of those newspaper to which he himself had contributed,<br />
the victim of a fatal accident. As always, life and death are always<br />
an amazing adventure.<br />
116 ELZEVIRI<br />
In viaggio<br />
Con la stessa sgranata<br />
stupefazione che m’irretiva<br />
quando mio padre – io<br />
bambino – ingigantiva sul<br />
biancore dei muri <strong>di</strong> cucina le coloratissime<br />
fi gure a lastra della lanterna<br />
magica <strong>di</strong> famiglia, vedo<br />
adesso <strong>di</strong>latarsi dentro il bocca-<br />
GIORGIO TORELLI<br />
con Brunilde e Rosamunda<br />
Chiamavo così le due supreme macchine<br />
fotografi che tedesche che mi hanno<br />
accompagnato lungo il profi larsi<br />
del mondo. Allora, ogni immagine<br />
era a rischio perché <strong>di</strong>ventava impossibile<br />
averne imme<strong>di</strong>ato riscontro, magari al 72°<br />
parallelo in Groenlan<strong>di</strong>a, quasi a Capo Horn<br />
nella Terra del Fuoco, nella pampa,<br />
tra i Masai o sul Rio delle Amazzoni.<br />
Custo<strong>di</strong>vo i rullini impressionati come un<br />
bottino <strong>di</strong> caccia grossa al bello e al vero.<br />
E adesso non smetto <strong>di</strong> stupirmi al vedere<br />
foto comparire in silenzio sul computer,<br />
trasmesse col telefonino in tempo reale,<br />
da vicino o da lontanissimo, come se un<br />
miracolo appartenesse all’ovvietà.<br />
NOTIZIARIO<br />
Elzeviri<br />
scena del computer le fotografi e<br />
che gli amici hanno appena ripreso<br />
e spe<strong>di</strong>scono in prima visione, da<br />
vicino o da lontanissimo. Tutto<br />
avviene con morbida naturalezza<br />
come se un clamoroso evento fi orisse<br />
dall’ovvietà e non dovesse –<br />
sempre – convocare le piccole<br />
estasi della meraviglia.<br />
Le immagini sono perfette e<br />
scorrono in punta <strong>di</strong> scarpette fi n<br />
quando il computer, a un tattile<br />
sollecito dello sgonfi etto chiamato<br />
mouse, rintana le foto e le tien<br />
pronte per ogni successiva esibizione.<br />
È fatta: l’arte spicciola della<br />
fotografi a <strong>di</strong>gitale (camere-piuma<br />
con tutto prepensato) ha ormai<br />
prevalso sull’arte pensosa <strong>di</strong> quello<br />
che fu l’esercizio vocazionale del<br />
testimoniare – a scatti – il circostante<br />
col rigore monastico del<br />
bianco e nero o con l’eccitazione<br />
dei colori.<br />
Noi <strong>di</strong> allora (non molto poco<br />
fa); noi delle pellicole da sviluppare<br />
dentro claustrali laboratori dalle<br />
penombre rosse e in bagnarole<br />
d’aci<strong>di</strong> rivelatori; noi dei negativi<br />
appesi ad asciugarsi (un prudente<br />
bucatino <strong>di</strong> celluloide) e poi sbirciati<br />
controluce uno a uno così da<br />
selezionare la stampa su carta dei<br />
soggetti e prospettarsi gl’ingran<strong>di</strong>menti<br />
del caso; noi siamo <strong>di</strong>ventati<br />
pittoreschi padri pellegrini dell’obiettivo,<br />
quelli – per <strong>di</strong>re – che<br />
navigavano ancora a vela, affrontando<br />
ansiose e calibrate procedure<br />
<strong>di</strong> rotta per arrivare al dunque<br />
delle fotografi e fi nalmente pronte,<br />
squadrate, e a progressiva, lenta<br />
degustazione.<br />
Nel mio far giornalismo per<br />
decenni fi n dove il mondo si restringe,<br />
ne ho attraversate tante <strong>di</strong><br />
ansie fotografi che prenatali («Saranno<br />
venute tutte le foto del rulli-
Sopra, a sinistra: Isole Figi.<br />
Giorgio Torelli racconta la storia<br />
<strong>di</strong> Ratu Tevita Mara, capo<br />
dell’isoletta <strong>di</strong> Serúa. Ratu e la<br />
moglie sono amabili nipoti <strong>di</strong><br />
cannibali.<br />
A destra: reportage dal Kerala:<br />
incontro con l’italiana Lauretta<br />
Farina che vive tra i pescatori <strong>di</strong><br />
Marianad per mutarne le sorti.<br />
A fianco: Egedesminde,<br />
Groenlan<strong>di</strong>a, estate. Giorgio<br />
Torelli al sole <strong>di</strong> mezzanotte.<br />
Above, left: the Fiji Isles. Giorgio<br />
Torelli tells the story of Ratu<br />
Tevita Mara, chief of the island<br />
of Serúa. Ratu and his wife are<br />
the friendly grandchildren of<br />
cannibals. On the right:<br />
reportage from Kerala: a<br />
meeting with the Italian Lauretta<br />
Farina who lives with the<br />
fishermen of Marianad to<br />
change their fate. Alongside:<br />
Egedesminde, Greenland,<br />
summer. Giorgio Torelli in the<br />
midnight sun.<br />
ELZEVIRI 117
118 ELZEVIRI<br />
Giamaica, reportage<br />
sulla hospital ship<br />
“Hope”, arrivata in<br />
porto a Kingston per<br />
aggiornare me<strong>di</strong>ci<br />
locali e praticare<br />
interventi chirurgici<br />
decisivi.<br />
Jamaica, reportage<br />
on the hospital ship<br />
“Hope”, which docked<br />
in Kingston to<br />
update local doctors<br />
and perform decisive<br />
operations.<br />
Argentina, Torelli va<br />
a vivere coi gauchos<br />
della Pampa per<br />
raccontarne i giorni<br />
e le avventure.<br />
A fianco:<br />
il giornalista con gli<br />
incuriositi eschimesi<br />
della Baia <strong>di</strong> Baffin.<br />
Argentina, Torelli<br />
goes to live with the<br />
gauchos of the<br />
Pampa to relate their<br />
days and adventures.<br />
Alongside:<br />
the journalist with<br />
the curious Eskimos<br />
of Baffin Bay.<br />
no? Le immagini risulteranno nitide?<br />
Saranno a fuoco? Avrò interpretato<br />
bene la così esigente apertura<br />
dell’obiettivo? Avrò calcolato a<br />
modo i giusti tempi d’esposizione<br />
in eventuale contrasto intimo con<br />
l’esposimetro ben temperato?»).<br />
Volavo in luoghi estremi dove<br />
non avrei potuto e, se possibile,<br />
mai osato, far sviluppare come<br />
test <strong>di</strong> conforto almeno uno dei<br />
tanti rullini impressionati e così<br />
cavarne un sospiro <strong>di</strong> sollievo professionale.<br />
Partivo sempre con le<br />
armi fotografi che <strong>di</strong> cui mi dotavo:<br />
due Leica, raffi nate creature dell’ingegno<br />
ottico tedesco; talora portavo<br />
anche la madre nobile della fotografi<br />
a, la Rolleifl ex 4 per 4; e poi<br />
teleobiettivi, fi ltri, esposimetro da<br />
tenere al collo come una bussola<br />
<strong>di</strong> pronto impiego per far cabotaggio<br />
nella luce. Possedevo una borsa<br />
inglese da caccia stipata, invece<br />
che <strong>di</strong> cartucce, <strong>di</strong> rullini a <strong>di</strong>versa<br />
sensibilità. Altri pacchi <strong>di</strong> rullini<br />
li tenevo, <strong>di</strong> scorta e al riparo,<br />
dentro la valigia da pilota americano<br />
con cui m’inoltravo. I settimanali<br />
a grande <strong>di</strong>ffusione per cui lavoravo<br />
da inviato speciale mi chiedevano<br />
anzitutto <strong>di</strong> “vedere con la<br />
penna” le cose e le persone. Ma,<br />
essendosi confermata la possibilità<br />
<strong>di</strong> illustrare io stesso i miei reportages<br />
senza che un fotografo<br />
dello staff redazionale dovesse<br />
farmi da compagno e moltiplicare<br />
la spe<strong>di</strong>zione (a me, poi, piaceva<br />
viaggiare da solo e parlare con me<br />
stesso <strong>di</strong> quel che scoprivo), avevo<br />
un solo mandato (la frase è <strong>di</strong><br />
Montanelli): «Tornare col carniere<br />
pieno <strong>di</strong> belle storie».<br />
Accadeva dunque che il mio<br />
impegno sui luoghi del bersaglio <strong>di</strong><br />
lavoro, raddoppiasse: testo e foto<br />
in armonia sponsale.<br />
Mi preme anche <strong>di</strong>re che non<br />
ho mai rappresentato guerre o rivoluzioni,<br />
ma sempre fi sionomie <strong>di</strong><br />
luoghi attraverso i ritratti <strong>di</strong> personaggi<br />
in<strong>di</strong>viduati col sesto senso e<br />
delibati con calma e sincero desiderio<br />
<strong>di</strong> <strong>di</strong>alogo e <strong>di</strong> intreccio. Tutto<br />
quel che volevo raccontare andava<br />
scovato con passione, <strong>di</strong>sciplina,<br />
luci<strong>di</strong>tà d’intenti e piccole perizie<br />
tecniche perché la pariglia delle<br />
Leica, un bel momento entrate in
scena, mi secondassero con amichevole<br />
docilità: pronte, instancabili,<br />
rigorose, belle e altere. Il resto<br />
toccava a me: impiegare a modo<br />
Rosamunda e Brunilde (così le<br />
avevo battezzate) per esserne corrisposto<br />
a dovere.<br />
Supponiamo che io partissi<br />
da Milano con duecento rullini in<br />
bianco e nero e altrettanti a colori.<br />
La malizia tecnica per riportare<br />
veramente a casa fotografi e in<strong>di</strong>spensabili<br />
era questa: «Fai molti<br />
scatti per uno stesso soggetto,<br />
qualche scatto con l’esposizione<br />
che ti sembra indovinata e altri<br />
scatti <strong>di</strong> supporto, sottoesposti o<br />
sovraesposti. Nel mazzetto degli<br />
aggiustamenti, fi orirà l’immagine<br />
che esigi».<br />
I fotografi professionali – vecchie<br />
volpi con l’occhio aduso ai<br />
mirini – riba<strong>di</strong>vano la praticità del<br />
concetto, che – <strong>di</strong> converso – sul<br />
campo, si rivelava banale e perfi no<br />
supponente. Le fotografi e – continuavo<br />
a pensare – devono carpire<br />
l’attimo principe perché ogni frazione<br />
<strong>di</strong> tempo <strong>di</strong>verge da quella<br />
precedente. Come d’incanto, il<br />
soggetto si sbilancia magari <strong>di</strong><br />
pochissimo, la situazione si corrompe,<br />
l’insieme non trasmette<br />
più il richiamo per cui volevi, assolutamente<br />
volevi, la foto <strong>di</strong> quel<br />
preciso, tassativo e irrinunciabile<br />
momento.<br />
Così, andavo alla ventura seguendo<br />
l’istinto. E continuavo a<br />
fotografare <strong>di</strong> getto e per imme<strong>di</strong>atezza,<br />
senza le preoccupazioni del<br />
fare e rifare. In una parola: azzardavo,<br />
sperando che Brunilde e<br />
Rosamunda si confermassero così<br />
virtuose da supplire ogni mia<br />
<strong>di</strong>sinvoltura.<br />
La sera, dovunque fossi, nelle<br />
tante camere d’albergo dove<br />
ponevo quartiere, pulivo con rigore<br />
le due Leica rientrate dal lavoro. E<br />
lo facevo con la stessa cura che<br />
dovevo riservare al fucile in dotazione<br />
(un ottimo Enfi eld britannico,<br />
reduce dalla guerra in Italia) quando<br />
vestivo i panni della recluta <strong>di</strong><br />
Fanteria (1954-55) e la consegna<br />
per chi fosse colto con l’arma bistrattata<br />
era tassativa e urlata.<br />
Tutto in or<strong>di</strong>ne, mi <strong>di</strong>cevo, la<br />
sera e la notte in hotel, tutto a<br />
Un<strong>di</strong>ci metri <strong>di</strong> neve<br />
attorno all’ospizio<br />
del Gran San<br />
Bernardo, raggiunto<br />
col pilota delle vette<br />
Hermann Geiger.<br />
Il proposito: far<br />
Natale insieme ai<br />
monaci sciatori e<br />
con i loro cani da<br />
valanga.<br />
Eleven metres of<br />
snow around the<br />
hospice of the Gran<br />
San Bernardo,<br />
reached with the<br />
pilot of the summits<br />
Hermann Geiger.<br />
The aim: to spend<br />
Christmas with the<br />
skiing monks and<br />
avalanche rescue<br />
dogs.<br />
posto; ma fi ngevo, perché nel retropalco<br />
della mente, ancora e <strong>di</strong><br />
nuovo, si <strong>di</strong>segnava in bodoni l’interrogativo<br />
senza imme<strong>di</strong>ata risposta:<br />
e se le immagini non fossero<br />
state impresse nella pellicola, se<br />
– che so io e non potevo saperlo<br />
– le due Leica avessero subìto un<br />
inciampo interno, una ritenzione <strong>di</strong><br />
pellicola o una balbuzie meccanica?<br />
Bisognava soffrire e sperar<br />
bene, ri<strong>di</strong>rsi: vedrai che sarà tutta<br />
gloria.<br />
Faccio il caso <strong>di</strong> un viaggio<br />
perché il lettore intenda le mie<br />
rinnovate apprensioni e se ne faccia<br />
cortesemente partecipe. Ero<br />
alle isole Samoa occidentali, smeral<strong>di</strong><br />
a galla sull’immensità del<br />
Pacifi co. Dovevo raccontare con<br />
calma , da Apìa, il trasognato vivere<br />
degli isolani ignari e felici in<br />
bungalow spalancati ai sentori e<br />
alle brezze dell’oceano e con i<br />
frutti dell’albero del pane pendenti,<br />
rigonfi e carnosi, appena davanti<br />
alla cerchia dei pali <strong>di</strong> sostegno,<br />
tutti rampicati dal tinteggio fl uorescente<br />
della botanica tropicale.<br />
Mi aggiravo nell’eden <strong>di</strong> una<br />
piccola società <strong>di</strong>scinta, appartata,<br />
curiosa, culturalmente intatta,<br />
ospitale e feconda. Le sabbie delle<br />
riviere, <strong>di</strong> un rosa-corallo accecante,<br />
stor<strong>di</strong>vano la vista. Samoa è il<br />
luogo dove trovò estremo rifugio e<br />
pace lo scrittore Robert Louis Stevenson<br />
, il celebrato autore dell’Isola<br />
del tesoro. Costruì a Vailima, per<br />
se stesso e i suoi, una splen<strong>di</strong>da<br />
<strong>di</strong>mora vasta e ariosa, tutto legno<br />
isolano con voluti ce<strong>di</strong>menti all’aristocrazia<br />
del colore blu. I samoani<br />
lo chiamavano Robert Tusitala, che<br />
signifi ca: «Colui che racconta belle<br />
storie».<br />
A sua volta, Stevenson defi niva<br />
i samoani come «i più felici<br />
della Polinesia, semplici, allegri,<br />
amanti del piacere. I loro canti non<br />
hanno mai fi ne». Quando Tusitala<br />
morì, nel 1894, il suo volere fu<br />
onorato: esser portato da un corteo<br />
<strong>di</strong> duecento samoani fi n sul<br />
picco del monte Vaca, ripido, fangoso<br />
ed elevato 340 metri. E lassù<br />
dormire il sonno eterno dentro una<br />
tomba <strong>di</strong> pietra chiara, preciso sigillo<br />
nel verde unanime della vegetazione<br />
d’altura. Il viscido e ostile<br />
sentiero che i samoani percorsero<br />
con la bara <strong>di</strong> Stevenson, retta a<br />
più spalle, venne poi chiamato: «La<br />
strada dei cuori che amano».<br />
Bene, allora. Decisi che avrei<br />
fotografato ad ogni costo la tomba<br />
<strong>di</strong> Stevenson, ma come? Le piogge<br />
avevano <strong>di</strong>lavato il monte Vaca<br />
e il tracciato per appetire la vetta<br />
si svelava abbruttito da tre palmi<br />
ELZEVIRI 119
In alto, a sinistra: Umanaq, Groenlan<strong>di</strong>a, il<br />
villaggio con la montagna “a cuore <strong>di</strong> foca”.<br />
È estate, gli icebergs con un rombo si<br />
frantumano. La domenica, gli eschimesi<br />
vestono il costume nazionale.<br />
A destra: Kenya, riserva Masai oltre la Rift<br />
Valley. In missione col Piper Cherokee della<br />
dottoressa-pilota Anna Spoerry dei Flying<br />
Doctors. Ambulatorio all’aperto vicino a un<br />
termitaio abbandonato, 50 gra<strong>di</strong>.<br />
A fianco: Terra del Fuoco, Ushuaia, quasi<br />
Capo Horn. Il campanile più a sud della<br />
Terra tra selve, <strong>di</strong>ghe <strong>di</strong> castori e monti<br />
innevati.<br />
Above, on the left: Umanaq, Greenland, the<br />
village with the “seal heart” mountain.<br />
It’s summer and the icebergs break up with<br />
a rumble. On Sundays, the Eskimos put on<br />
their national dress.<br />
On the right: Kenya, a Masai reserve beyond<br />
the Rift Valley: in mission with the Piper<br />
Cherokee of the doctor and pilot Anna<br />
Spoerry of the Flying Doctors. An open-air<br />
surgery near an abandoned anthill,<br />
50 degrees.<br />
Alongside: Tierra del Fuego, Ushuaia, almost<br />
at Cape Horn: the southernmost bell tower<br />
in the world, amid forests, beavers’ dams<br />
and snow-topped mountains.
<strong>di</strong> limo succhioso. Non c’era che<br />
una soluzione: convincere il pilota<br />
dell’attempato DC3 presente sulla<br />
pista <strong>di</strong> Apìa, un bimotore <strong>di</strong><br />
fusoliera argentea, vecchio <strong>di</strong><br />
trent’anni ma impavido, il solo<br />
aeroplano che collegasse le isole<br />
circostanti con l’insegna ambiziosa<br />
Polynesian Airways, persuaderlo,<br />
coi dollari alla mano, a decollare<br />
per me e compiere, a più virate,<br />
ripetuti passaggi sopra la<br />
cima del Vaca.<br />
Il comandante era un canadese<br />
con la pipa tra i denti, capelli<br />
fulvi. Anche io avevo la pipa. Ci<br />
scambiammo il tabacco. Per una<br />
cifra ragionevole l’accordo fu sottoscritto.<br />
Decollammo con quel<br />
magnifi co rombo che i DC3, veterani<br />
<strong>di</strong> guerra, rilasciavano generosamente.<br />
Fatta quota, principiò il<br />
torneo, passare e ripassare sulla<br />
tomba <strong>di</strong> Tusitala, io <strong>di</strong> fi anco al<br />
pilota, il vetro del fi nestrino tirato,<br />
ancora io a sporgere la Leica e<br />
premere, premere, riuscendo appena<br />
ad inquadrare cima e tomba,<br />
rimaste subito in<strong>di</strong>etro per la velocità<br />
del DC3.<br />
Altro passaggio: «Più basso,<br />
più basso comandante!», gridavo.<br />
Il pilota faceva il massimo, ma la<br />
regola della sicurezza gl’imponeva<br />
<strong>di</strong> tenere la quota corretta. In fi ne<br />
atterrammo. Il pilota era <strong>di</strong>vertito,<br />
volle brindare al possibile risultato<br />
con una birra neozelandese. Il DC3<br />
era stato bravissimo. Chissà se io<br />
avevo fatto altrettanto bene la mia<br />
parte <strong>di</strong> mitragliere-fotografo. Il<br />
rullino restava al sicuro nel buio<br />
fondo della Leica – Rosamunda o<br />
Brunilde – con cui m’ero cimentato,<br />
il vento in faccia e i tremiti altisonanti<br />
dei motori indosso. Rovello,<br />
però. Il solito rovello: e se le<br />
fotografi e fossero sfuocate, mosse,<br />
alterate dalle cavalcate a fi or<br />
<strong>di</strong> monte e dagli sbalzi inevitabili<br />
del pur glorioso aeroplano? Di certo<br />
non avrei potuto far sviluppare<br />
in Samoa il rullino a colori. Ancora<br />
una volta, dovevo attendere il rimpatrio<br />
via Figi, Hawaii, California,<br />
New York, Londra, Milano, mezzo<br />
giro del mondo a farla breve.<br />
Consolazione: a Milano, affi -<br />
dati i molti rullini al tecnico e rimanendo<br />
appostato accanto alla<br />
porta del laboratorio come un<br />
padre che aspetti notizie <strong>di</strong> una<br />
nascita, contavo i minuti smisurati<br />
fi no alla voce liberatoria dal <strong>di</strong><br />
dentro: «Tutto okay!». L’impresa,<br />
così remota ormai, era andata a<br />
segno. Il settimanale per cui lavoravo,<br />
partivo e ripartivo, era servito<br />
– come s’usava <strong>di</strong>re – <strong>di</strong> barba<br />
e <strong>di</strong> parrucca.<br />
Le pagine a colori erano garantite.<br />
L’articolo – molte pagine<br />
– l’avevo già in canna e adesso<br />
non c’era che <strong>di</strong>sporsi davanti alla<br />
Olivetti e raccontare. Particolare:<br />
Oceano Pacifico,<br />
Isola <strong>di</strong> Samoa:<br />
la tomba dello<br />
scrittore Robert<br />
Louis Stevenson,<br />
fotografata da un<br />
DC3 in volo radente<br />
sul monte Vaca.<br />
The Pacific Ocean<br />
Island of Samoa:<br />
the tomb of the<br />
writer Robert Louis<br />
Stevenson,<br />
photographed from a<br />
hedgehopping DC3<br />
on Mount Vaca.<br />
un anno dopo ero a Roma per<br />
un’intervista e andavo <strong>di</strong> fretta<br />
verso l’aeroporto. A un semaforo<br />
comprai un giornale del pomeriggio<br />
da uno strillone. Tra i titoli ce<br />
n’era uno: «DC3 delle Polynesian<br />
Airways perde un’ala e s’inabissa<br />
nel Pacifi co».<br />
Era lui, il mio DC3 <strong>di</strong> Samoa,<br />
la nostra freccia sul monte Vaca, il<br />
pilota <strong>di</strong> cui mi tornava il sembiante<br />
scanzonato, quell’argentarsi della<br />
fusoliera all’antica. La commozione<br />
<strong>di</strong>lagò. Mi venne solo da<br />
pregare, poche parole, adagio.<br />
ELZEVIRI 121
Tortura per<br />
adolescenti<br />
LUCA GOLDONI<br />
Ritrovo su un vecchio taccuino queste note<br />
sul l’“apparecchio”. Stamattina sono uscito<br />
con lo scopo preciso <strong>di</strong> guardare la bocca<br />
e possibilmente i denti della gente pressappoco<br />
della mia età. Chi li aveva più fi tti, chi più<br />
ra<strong>di</strong>, forse non erano tutte chiostre smaglianti da<br />
réclame <strong>di</strong> dentifricio, ma comunque non ho scoperto<br />
nulla <strong>di</strong> sconvolgente. Eppure la mia generazione<br />
è cresciuta senza “apparecchio”, croce senza delizia<br />
dei nostri fi gli.<br />
Tutto comincia quel giorno in cui il bambino<br />
torna da scuola con un avviso che invita i genitori ad<br />
accompagnarlo all’istituto dei denti. Si crea subito<br />
uno stato d’allarme, il ragazzo non ha carie, spacca<br />
le noci con i denti, <strong>di</strong> cosa può trattarsi? Si va all’ambulatorio<br />
e dopo lunga attesa tra fi le <strong>di</strong> bambini che<br />
hanno avuto lo stesso invito, si è ricevuti dal professore,<br />
famoso mago dell’ortognatodonzia (vocabolo<br />
conturbante che ci ha fatto sfogliare il <strong>di</strong>zionario).<br />
Circondato da uno stuolo <strong>di</strong> assistenti, il maestro<br />
inizia la visita, apri, chiu<strong>di</strong>, e si rivolge ai <strong>di</strong>scepoli<br />
in gergo scientifi co. Quando la madre è sul<br />
punto <strong>di</strong> svenire, convinta che quel linguaggio grave<br />
ed indecifrabile riguar<strong>di</strong> un caso senza precedenti, il<br />
professore si decide a concludere la lezione e a rivolgersi<br />
con parole comprensibili agli interessati:<br />
l’arcata è stretta, la parte superiore sporge rispetto<br />
a quella inferiore, ci vuole l’apparecchio per tre anni.<br />
A casa si <strong>di</strong>scute, è meglio l’apparecchio, a<br />
costo <strong>di</strong> creare dei complessi, o lasciamo perdere?<br />
Nessuno <strong>di</strong> noi è <strong>di</strong>ventato un mostro anche se ab-<br />
Torture for teenagers<br />
When two sensitive parameters such as health and fashion appear<br />
together, there can be paradoxical and unforeseeable<br />
consequences. In<strong>di</strong>cative of this situation is the blessed or cursed<br />
“dental braces”. For some years now, this has been a source of<br />
torment for all parents who have the smile of their offspring at<br />
heart and one of joy for doctors specialized in orthognathodontics.<br />
The whole family is mobilized for the period of treatment, so that<br />
not even one minute of the precious applications is wasted.<br />
Sometimes the precautions veer on the paradoxical but, above all,<br />
for the unlucky “patient”, they can become a form of real torture.<br />
It’s true that you have to suffer to be beautiful, but in some cases<br />
the intervention can be exasperating.<br />
122 ELZEVIRI<br />
biamo qualche capsula. Ma è chiaro<br />
che si decide per l’apparecchio<br />
(se ci <strong>di</strong>cessero che nostro fi glio<br />
ha il mignolo leggermente curvo, lo<br />
faremmo ingessare subito fino<br />
all’omero).<br />
Così la nostra vita comincia<br />
ad essere con<strong>di</strong>zionata dall’apparecchio<br />
che ci segue ovunque,<br />
d’estate al mare, d’inverno in montagna;<br />
si torna in<strong>di</strong>etro, dopo cento<br />
chilometri d’autostrada, perché la<br />
madre s’è accorta con un urlo <strong>di</strong><br />
avere <strong>di</strong>menticato l’apparecchio.<br />
Bisogna litigare con le nonne che<br />
insorgono, “povero cocco è una<br />
tortura”; bisogna arrabbiarsi col<br />
bambino che, dopo un trimestre,<br />
pretende <strong>di</strong> avere già sistemato<br />
l’arcata superiore: “I denti sono<br />
tuoi, non miei, mettiti subito l’apparecchio”.<br />
Il bambino tenta <strong>di</strong><br />
eccepire. Cosa <strong>di</strong>ce?, chiede il<br />
marito alla moglie che, miracolo<br />
della maternità, riesce anche a<br />
decifrare il gorgoglio emesso dal<br />
fi glio con lo strumento in bocca.<br />
Questi apparecchi sono più o<br />
meno allucinanti, vanno dal più<br />
semplice – cioè il calco <strong>di</strong> plastica<br />
rosa che il bambino ha imparato<br />
ad applicarsi sotto il palato e a<br />
togliersi per immergerlo nel bicchiere<br />
sul como<strong>di</strong>no – all’archetto<br />
d’acciaio da applicare con gancetti<br />
ed elastici e qui ci vuole l’intervento<br />
della madre, polso fermo come<br />
quando s’infi la l’ago.<br />
Ogni due o tre giorni bisogna<br />
cambiare gli elastici, il padre ha<br />
Davide Marcolli<br />
scoperto una cartoleria dove vendono<br />
quelli della misura giusta,<br />
soltanto uno sprovveduto può illudersi<br />
che gli elastici raccolti via<br />
via in casa, e conservati nel vecchio<br />
samovar, vadano bene per le<br />
arcate.<br />
Il bambino va a letto con<br />
tutti i suoi tiranti, qualche volta <strong>di</strong><br />
notte ci sveglia, grida che gli è<br />
partito un elastico; accorriamo e,<br />
a vederlo con quel morso in bocca<br />
– gli mancano soltanto le briglie –<br />
ci assale un’ondata <strong>di</strong> tenerezza.<br />
Mi viene da sorridere alla tesi che<br />
le nuove generazioni siano ribelli<br />
e ribalde; abbiamo delle generazioni<br />
<strong>di</strong> martiri.<br />
Talvolta l’apparecchio si perde,<br />
la vita familiare si paralizza,<br />
tutti cominciano a cercarlo incolpandosi<br />
reciprocamente <strong>di</strong> negligenza;<br />
un giorno lo strumento salta<br />
fuori, incastrato nel cassettone<br />
del letto e resta (insolubile) il dubbio<br />
se c’è fi nito per caso o se ce<br />
l’ha sistemato il bambino con l’arcata<br />
superiore eccetera.<br />
Passano gli anni, ogni tanto<br />
viene lanciato un nuovo apparecchio<br />
e le madri si telefonano subito,<br />
se lo consigliano, se lo spiegano,<br />
basta avvitare un piccolo bullone.<br />
Al “complesso” ormai non ci<br />
pensa più nessuno. Se mai il complesso<br />
viene a quei poveri bambini<br />
che hanno le arcate banalmente<br />
regolari, non hanno bisogno <strong>di</strong><br />
nessun apparecchio e non sanno<br />
cos’è l’ortognatodonzia.
GAVINO MANCA<br />
La guerra è la cosa più facile<br />
del mondo, osserva Immanuel<br />
Kant; non così la<br />
pace, che è una conquista<br />
della ragione e quin<strong>di</strong> un atto <strong>di</strong><br />
volontà dell’uomo. Il pamphlet kantiano<br />
Per la pace perpetua non è<br />
tra le opere più note del grande<br />
fi losofo tedesco ma è molto utile<br />
per inquadrare compiutamente<br />
quel movimento <strong>di</strong> pensiero a favore<br />
della pace, fi orito nei secoli XVI,<br />
XVII, XVIII, che va sotto il nome <strong>di</strong><br />
irenismo; inoltre può aiutarci a cogliere<br />
il senso più profondo dei<br />
movimenti e dei progetti impegnati<br />
a evitare il ripetersi delle gran<strong>di</strong><br />
trage<strong>di</strong>e del passato.<br />
Se la pace autentica, “perpetua”,<br />
si può conseguire solo attraverso<br />
l’esercizio della ragione, allora<br />
è chiaro che la pace appartiene<br />
all’uomo solo in quanto egli saprà<br />
essere capace <strong>di</strong> un giu<strong>di</strong>zio autonomo<br />
al <strong>di</strong> fuori e al <strong>di</strong> sopra <strong>di</strong><br />
ogni con<strong>di</strong>zionamento. Da ciò appare<br />
evidente che il messaggio<br />
kantiano sfugge alla critica facile<br />
rivolta al mito <strong>di</strong> un mondo arca<strong>di</strong>co<br />
e i<strong>di</strong>llico, com’è quello descritto<br />
dagli antichi poeti e fi losofi – da<br />
Esiodo a Platone – che presuppone<br />
una trasformazione completa<br />
degli esseri umani, un capovolgimento<br />
totale della loro natura.<br />
Esso è invece saldamente ra<strong>di</strong>cato<br />
su una visione reale e “politica”<br />
della società, su una visione “storica”,<br />
che peraltro non gli impe<strong>di</strong>sce<br />
<strong>di</strong> assumere un atteggiamento<br />
costruttivo per la fi ducia nell’uomo,<br />
o meglio nel prevalere della<br />
ragione dell’uomo.<br />
La prova <strong>di</strong> questo realismo<br />
kantiano è fornita dalla premessa<br />
agli “articoli defi nitivi per una pace<br />
Immanuel Kant<br />
La pace della ragione<br />
perpetua tra gli Stati” dove si rivela<br />
che «lo stato <strong>di</strong> pace tra gli uomini<br />
non è certo uno stato <strong>di</strong> natura,<br />
quanto uno stato <strong>di</strong> guerra,<br />
nel senso che, sebbene non vi<br />
siano ostilità continuamente aperte,<br />
tuttavia c’è sempre una minaccia<br />
che esse vi siano. Bisogna<br />
dunque renderlo stabile...». E a<br />
questo fi ne tre sono le con<strong>di</strong>zioni<br />
fondamentali:<br />
1) la costituzione civile <strong>di</strong> ogni<br />
Stato deve essere repubblicana;<br />
2) il <strong>di</strong>ritto internazionale deve<br />
fondarsi su una federazione <strong>di</strong><br />
Stati liberi;<br />
3) il <strong>di</strong>ritto cosmopolitico deve<br />
essere limitato alle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong><br />
un’ospitalità universale.<br />
Quanto alla prima con<strong>di</strong>zione,<br />
bisogna far presente che Kant intende<br />
per “repubblicana” una costituzione<br />
basata sul principio della<br />
libertà dei membri <strong>di</strong> una società<br />
(come uomini), sul principio<br />
della <strong>di</strong>pendenza <strong>di</strong> tutti da un’unica<br />
legislazione comune (come<br />
sud<strong>di</strong>ti), sulla legge dell’eguaglianza<br />
(come citta<strong>di</strong>ni); quanto noi<br />
chiameremmo oggi più propriamente<br />
una costituzione democratica.<br />
Non è <strong>di</strong>ffi cile comprendere<br />
perché sia questa una con<strong>di</strong>zione<br />
fondamentale (la prima) per una<br />
pace perpetua: «Se (né in questa<br />
costituzione può essere altrimenti)<br />
si richiede il consenso dei citta<strong>di</strong>ni<br />
per decidere se la guerra debba o<br />
non debba essere fatta, niente <strong>di</strong><br />
più naturale dal pensare che, dovendo<br />
far ricadere su <strong>di</strong> sé tutte le<br />
calamità della guerra (combattere<br />
<strong>di</strong> persona, sostenere <strong>di</strong> propria<br />
tasca le spese della guerra, riparare<br />
le rovine che essa lascia <strong>di</strong>etro<br />
e, infi ne, per colmo <strong>di</strong> sventura,<br />
assumersi il carico <strong>di</strong> debiti mai<br />
estinti – a causa <strong>di</strong> sempre nuove<br />
guerre –, amareggiando così la<br />
stessa pace), essi ci penseranno<br />
sopra a lungo prima <strong>di</strong> iniziare un<br />
gioco così malvagio».<br />
Diverso <strong>di</strong>scorso vale naturalmente<br />
per quei regimi nei quali «il<br />
sud<strong>di</strong>to non è citta<strong>di</strong>no» e la forma<br />
<strong>di</strong> governo non è quella rappresen-<br />
Per Immanuel Kant<br />
(1724-1804), grande<br />
filosofo tedesco,<br />
la <strong>di</strong>ffusione della<br />
democrazia è la<br />
prima con<strong>di</strong>zione per<br />
la pace perpetua.<br />
For the great<br />
German philosopher<br />
Immanuel Kant<br />
(1724-1804),<br />
widespread<br />
democracy is the<br />
first con<strong>di</strong>tion for<br />
perpetual peace.<br />
Immanuel Kant. The peace of reason<br />
The Kantian idea of “perpetual peace” as an objective for civil<br />
society is not a casual invocation of an idyllic world. Reason must<br />
be applied in the very best way in order to achieve this<br />
undertaking. This political goal requires several inevitable<br />
elements: a republican form of state, a federation of free states,<br />
an international idea of universal hospitality. In this <strong>di</strong>rection,<br />
it would be very opportune that permanent armies <strong>di</strong>sappear, as<br />
they pose a continuous threat to peace. Furthermore, there can be<br />
no contrast between politics, the practical doctrine of law,<br />
and ethics, theoretic doctrine. Its message begins with the<br />
consideration that honesty is the best policy.<br />
ELZEVIRI 123
tativa; laddove «il sovrano non è<br />
membro dello Stato, ma ne è il<br />
proprietario». In tal caso, rileva<br />
Kant «la guerra è la cosa più facile<br />
del mondo ... perché chi la <strong>di</strong>chiara<br />
nulla perde dei suoi banchetti,<br />
delle sue cacce, castelli, ecc.».<br />
Quanto ciò sia – purtroppo – vero,<br />
la storia lo prova ampiamente.<br />
Se l’affermazione che la <strong>di</strong>ffusione<br />
della democrazia è la prima<br />
con<strong>di</strong>zione per la pace perpetua<br />
costituisce un fatto estremamente<br />
importante sul piano della dottrina<br />
politica, il secondo “articolo defi nitivo”<br />
– anch’esso determinante –<br />
presenta un signifi cato ed un’attualità<br />
del tutto particolari. Kant<br />
sostiene infatti che, per evitare la<br />
guerra, è altresì necessario che il<br />
<strong>di</strong>ritto internazionale si fon<strong>di</strong> su<br />
una federazione <strong>di</strong> Stati “liberi”,<br />
cioè democratici. Analogamente<br />
agli in<strong>di</strong>vidui che hanno superato<br />
lo stato <strong>di</strong> natura sottomettendosi<br />
ad una legge comune, così gli<br />
Stati, pur conservando la loro sovranità,<br />
dovrebbero costituire una<br />
federazione in cui risolvere, senza<br />
confl itto, i loro rapporti.<br />
124 ELZEVIRI<br />
«Per gli Stati che stanno in<br />
relazioni reciproche non vi è altra<br />
maniera razionale <strong>di</strong> uscire dallo<br />
stato <strong>di</strong> natura senza leggi, che<br />
comporta sempre guerre, se non<br />
rinunciando, come gli in<strong>di</strong>vidui singoli,<br />
alla loro selvaggia libertà (senza<br />
leggi), sottomettendosi a leggi<br />
pubbliche coattive e formando uno<br />
stato <strong>di</strong> popoli (civitas gentium) che<br />
si estenda sempre più, fi no ad<br />
abbracciare alla fi ne tutti i popoli<br />
della terra». E che si possa aspirare<br />
a giungere a questa civitas gentium<br />
lo fa pensare, rileva Kant,<br />
l’omaggio che ogni Stato (almeno<br />
a parole) rende al concetto <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto,<br />
che <strong>di</strong>mostra l’esistenza nell’uomo,<br />
«benché ancora latente..., <strong>di</strong><br />
una <strong>di</strong>sposizione morale più grande<br />
destinata a prendere un giorno<br />
il sopravvento sul principio del<br />
male che è in lui (cosa che egli non<br />
può negare), e a fargli sperare che<br />
ciò avvenga anche negli altri».<br />
Un’accentuazione profondamente<br />
umana traspare dalla terza<br />
con<strong>di</strong>zione fondamentale che Kant<br />
pone per la pace perpetua: il riconoscimento<br />
del <strong>di</strong>ritto cosmopoliti-<br />
La terribilità degli<br />
or<strong>di</strong>gni bellici<br />
moderni ha reso<br />
sempre più necessari<br />
progetti <strong>di</strong> <strong>di</strong>sarmo e<br />
<strong>di</strong> “non<br />
proliferazione”.<br />
Nella foto,<br />
l’esplosione della<br />
bomba atomica su<br />
Nagasaki del 9<br />
agosto 1945.<br />
The awfulness of<br />
modern war bombs<br />
has made projects of<br />
<strong>di</strong>sarmament and<br />
“non proliferation”<br />
increasingly<br />
necessary. In the<br />
photo, the explosion<br />
of the atomic bomb<br />
on Nagasaki on<br />
9th August 1945.<br />
co ad una ospitalità universale. E<br />
ciò sulla base del «possesso comune<br />
della superfi cie della terra<br />
sulla quale, essendo sferica, gli<br />
uomini non possono <strong>di</strong>sperdersi<br />
all’infi nito, ma alla fi ne debbono<br />
rassegnarsi a coesistere». Coesistenza<br />
che darà la forza agli uomini<br />
per vivere pacifi ci.<br />
Purtroppo la realtà era (ed è)<br />
<strong>di</strong>versa da quella auspicata dal<br />
grande fi losofo il quale, del resto,<br />
ben se ne rendeva conto; il commento<br />
alla proposizione enunciata<br />
condanna apertamente la politica<br />
<strong>di</strong> espansione imperialistica dei<br />
Paesi civili europei che, trovato il<br />
massimo sviluppo nell’Ottocento,<br />
doveva poi clamorosamente fallire.<br />
Ed altrettanto profetico doveva<br />
mostrarsi il rilievo che «in fatto <strong>di</strong><br />
associazione <strong>di</strong> popoli... si è progressivamente<br />
giunti ad un punto<br />
tale che la violazione del <strong>di</strong>ritto<br />
compiuta in una parte della terra<br />
viene risentita in tutte le parti...».<br />
Di quanto sia valida tale affermazione<br />
la storia della nostra epoca<br />
offre, purtroppo, una continua conferma.<br />
Questi i principi fondamentali<br />
cui Kant aggiunge (anzi premette)<br />
delle con<strong>di</strong>zioni “preliminari” tra le<br />
quali alcune presentano anch’esse<br />
una notevole attualità. Ad<br />
esempio quella che nessun trattato<br />
<strong>di</strong> pace può considerarsi tale se<br />
stipulato con la tacita riserva <strong>di</strong><br />
argomenti per una guerra futura; e<br />
l’altra che gli eserciti permanenti<br />
(miles perpetuus) devono col tempo<br />
scomparire, perché essi rappresentano<br />
una continua minaccia<br />
alla pace e sono incompatibili con<br />
la <strong>di</strong>gnità dell’uomo cui si ad<strong>di</strong>ce<br />
«l’esercizio alle armi volontario e<br />
perio<strong>di</strong>co» ma non il mercenarismo.<br />
Esigenza quest’ultima che<br />
ha trovato riconoscimento anche<br />
presso i “pratici” della politica,<br />
com’è provato dalla lunga serie <strong>di</strong><br />
progetti per il <strong>di</strong>sarmo o per lo<br />
meno la “non proliferazione”, resi<br />
sempre più necessari dalle terribilità<br />
degli or<strong>di</strong>gni bellici moderni.<br />
Ma forse il più signifi cativo <strong>di</strong><br />
questi “articoli preliminari” è quello<br />
che afferma che «nessuno Stato<br />
si deve immischiare con la forza<br />
nella costituzione e nel governo <strong>di</strong>
un altro»; non vi è giustifi cato dalla<br />
scusa <strong>di</strong> corruzione (scandalum<br />
acceptum), poiché «il cattivo comportamento<br />
<strong>di</strong> uno Stato serve<br />
piuttosto da ammonimento che da<br />
scandalo»; e nemmeno da <strong>di</strong>scor<strong>di</strong>e<br />
interne perché l’intervento sarebbe<br />
«una violazione dei <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong><br />
un popolo che non <strong>di</strong>pende da<br />
nessuno e che combatte contro<br />
un male interno... e renderebbe<br />
insicura l’autonomia degli altri».<br />
Si è accennato all’inizio al rigore<br />
razionale che domina l’esposizione<br />
kantiana e me<strong>di</strong>ante il quale<br />
è possibile cogliere – nella sua<br />
perfetta unitarietà – il modello logico<br />
sottoposto; la stessa matrice<br />
è alla base dell’affermazione, che<br />
costituisce forse il merito maggiore<br />
del grande filosofo tedesco,<br />
circa la necessaria identifi cazione<br />
(o meglio subor<strong>di</strong>nazione) della<br />
politica alla morale. È questa, come<br />
è facile intendere, un’appen<strong>di</strong>ce<br />
essenziale a tutto il <strong>di</strong>scorso,<br />
perché il verifi carsi <strong>di</strong> comportamenti<br />
come quelli auspicati è<br />
strettamente in funzione <strong>di</strong> un<br />
convinto impegno sul piano etico.<br />
L’argomentazione kantiana offre<br />
probabilmente uno degli esempi<br />
più raffi nati <strong>di</strong> logica (naturalmente<br />
inquadrata in un certo “sistema”<br />
fi losofi co): «La morale è già <strong>di</strong> per<br />
se stessa una pratica in senso<br />
oggettivo, come insieme <strong>di</strong> leggi<br />
che comandano incon<strong>di</strong>zionatamente<br />
e secondo le quali noi dobbiamo<br />
agire, ed è evidente l’assur<strong>di</strong>tà,<br />
dopo aver riconosciuto a questo<br />
concetto l’autorità che gli spetta,<br />
voler affermare che però non lo<br />
si può attuare... Con ciò non può<br />
esservi alcun contrasto tra la politica,<br />
quale dottrina pratica del <strong>di</strong>ritto,<br />
e la morale, quale dottrina<br />
teorica».<br />
Al contrario, vi deve essere<br />
identifi cazione, meglio subor<strong>di</strong>nazione:<br />
«Sebbene la massima:<br />
“L’onestà è la migliore politica”,<br />
contenga una teoria che la pratica<br />
purtroppo molto spesso smentisce,<br />
tuttavia la massima: “L’onestà<br />
è migliore <strong>di</strong> ogni politica”, è <strong>di</strong><br />
gran lunga superiore ad ogni obiezione,<br />
anzi è la con<strong>di</strong>zione in<strong>di</strong>spensabile<br />
<strong>di</strong> ogni politica». Siamo<br />
<strong>di</strong> fronte ad uno degli insegnamen-<br />
Photo Oilime<br />
La scultura pacifista<br />
Non violence dello<br />
svedese Carl<br />
Frederick, posta<br />
all’ingresso visitatori<br />
del “Palazzo <strong>di</strong><br />
vetro”, sede delle<br />
Nazioni Unite a New<br />
York.<br />
The pacifist sculpture<br />
Non-violence by<br />
Swe<strong>di</strong>sh artist Carl<br />
Frederick stands in<br />
the visitors’ entrance<br />
to the UN<br />
headquarters<br />
in New York.<br />
ti più alti che siano stati offerti, in<br />
nome della ragione, agli uomini;<br />
insegnamento spesso <strong>di</strong>satteso<br />
ma che il profondo travaglio che<br />
attraversa la nostra civiltà rende<br />
particolarmente attuale. È sempre<br />
più <strong>di</strong>ffusa e viva la convinzione<br />
che, in società che basano sul<br />
principio <strong>di</strong> eguaglianza ogni rapporto<br />
<strong>di</strong> convivenza, il comportamento<br />
della classe politica sia<br />
strettamente vincolato ai principi<br />
della morale sociale.<br />
Morale, politica, libertà: ecco<br />
il necessario anello <strong>di</strong> congiunzione<br />
che costituisce anche qui la<br />
chiave <strong>di</strong> volta del sistema: «È<br />
certo che se non esiste nessuna<br />
libertà e nessuna legge morale<br />
fondata su <strong>di</strong> essa, ma tutto ciò<br />
che accade o può accadere è puro<br />
meccanismo della natura, allora la<br />
politica è tutta la sapienza pratica<br />
e l’idea <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto è priva <strong>di</strong> senso.<br />
Ma se si riconosce in<strong>di</strong>spensabile<br />
collegare tale idea alla politica,<br />
elevandola anzi a sua con<strong>di</strong>zione<br />
limitatrice, allora si deve ammettere<br />
la conciliabilità delle due. Io<br />
posso immaginare un politico morale,<br />
cioè uno che intende i principi<br />
dell’arte politica in maniera tale<br />
che essi possano coesistere con<br />
la morale, ma non posso immaginare<br />
un moralista politico che si<br />
foggi la morale a seconda della<br />
convenienza dell’uomo <strong>di</strong> Stato».<br />
È su questa base, in conclusione,<br />
che si fonda tutto il <strong>di</strong>scorso<br />
per la pace perpetua, sulla questione<br />
se «nei problemi della ragion<br />
pratica si debba iniziare dal<br />
principio materiale, dallo scopo, o<br />
dal principio formale che <strong>di</strong>ce:<br />
opera in maniera tale che tu possa<br />
volere che la tua massima debba<br />
<strong>di</strong>ventare una legge universale». E<br />
per Kant non può esservi che una<br />
risposta. Egli <strong>di</strong>stingue così tra<br />
compito “tecnico” e compito “morale”<br />
che si <strong>di</strong>fferenziano l’uno<br />
dall’altro come “il cielo dalla terra”;<br />
e afferma che il secondo compito<br />
richiede la sapienza politica che<br />
«porta <strong>di</strong>rettamente allo scopo...<br />
pur senza <strong>di</strong>menticare la prudenza...<br />
che avverte <strong>di</strong> non voler giungere<br />
al traguardo affrettatamente<br />
e con la forza, ma <strong>di</strong> avvicinarsi <strong>di</strong><br />
continuo ad esso approfi ttando<br />
delle circostanze favorevoli». È il<br />
principio del gradualismo delle riforme,<br />
che non signifi ca però immobilismo!<br />
Cosa <strong>di</strong>re a oltre due secoli<br />
dal messaggio <strong>di</strong> Kant, dopo aver<br />
attraversato le esperienze tragiche<br />
della guerra totale? Che veramente<br />
la “pace perpetua” costituisce<br />
non già un’utopia, ma un’inderogabile<br />
esigenza per l’umanità. La<br />
storia ci narra l’avvilimento, il <strong>di</strong>sprezzo<br />
dell’uomo, la sua abiezione;<br />
noi storicamente siamo impegnati<br />
a negare questo <strong>di</strong>sprezzo, a<br />
non dare mai tregua e a non consentire<br />
mai la benché minima giustifi<br />
cazione alla violenza. Credere<br />
nell’uomo e nel suo dono più grande,<br />
la ragione; essa – <strong>di</strong>ce Kant –<br />
«ci illumina sempre abbastanza<br />
chiaramente su ciò che dobbiamo<br />
fare per restare nella linea del dovere<br />
(secondo le regole della saggezza),<br />
e con ciò ci in<strong>di</strong>ca anche la<br />
via verso il fi ne ultimo».
La lingua italiana si trasforma<br />
NOTIZIARIO<br />
Società<br />
e costume<br />
Solo lo spirito<br />
tirannico <strong>di</strong> certi<br />
grammatici<br />
pretende che si <strong>di</strong>ca<br />
“gli gnocchi” o “gli<br />
pneumatici”.<br />
Only the tyrannical<br />
spirit of certain<br />
pedants demands<br />
that we say “gli<br />
gnocchi” or<br />
“gli pneumatici”.<br />
The Italian language is transforming itself<br />
A language is naturally a living system, subject to changes which<br />
may also be consistent. Whilst in modern Italian journalism saying<br />
“gli” or “i” for the plural of the masculine definite article before a<br />
word beginning with “pn” arouses general in<strong>di</strong>fference, we can<br />
remember that Boccaccio, the father of Italian prose, was subject to<br />
harsh criticism because by calling one of his characters Philostratus<br />
he had mixed a Greek root with a Latin one. At times, it is caution<br />
induced by respect that creates particular euphemisms: Jesus is<br />
called the fruit of the breast, not of the womb, of the Virgin Mary.<br />
The Commission for the Defence of the Italian Language at the<br />
Ministry for Cultural Heritage still has a lot of work to do.<br />
126 SOCIETÀ E COSTUME<br />
Tra “puristi” e “anarchici”<br />
I.Nel corso della mia vita ho<br />
assistito a un mutamento<br />
della lingua italiana che richiederebbe<br />
ormai una correzione dei<br />
vocabolari: il verbo “iniziare” è in<strong>di</strong>cato<br />
nel Fanfani (metà dell’800)<br />
o nello Zingarelli (inizio del ’900)<br />
come “attivo”: tale, cioè, che richiede<br />
un complemento oggetto<br />
(ad esempio “iniziare un <strong>di</strong>scorso”;<br />
o “iniziare qualcuno alla massoneria”).<br />
Oggi, per contro, si <strong>di</strong>ce “iniziare<br />
a parlare” come se fosse un<br />
verbo neutro, che può avere o non<br />
avere un complemento oggetto<br />
(come “cominciare”). L’ultimo<br />
esempio <strong>di</strong> “iniziare” usato correttamente<br />
come verbo attivo l’ho<br />
trovato nella traduzione <strong>di</strong> Mister<br />
Mulliner, un romanzo umoristico <strong>di</strong><br />
P. G. Wodehouse ad opera <strong>di</strong> Alberto<br />
Tedeschi (Bietti 1933, pag.<br />
109): «Al tempo in cui il mio racconto<br />
si inizia». Oggi chiunque <strong>di</strong>rebbe<br />
“inizia”, senza l’oggetto.<br />
All’inizio lo scambio aveva<br />
ragioni <strong>di</strong> decoro: “cominciare a<br />
parlare” va bene per un infante,<br />
ma sembra riduttivo per un oratore;<br />
e allora si <strong>di</strong>ce “iniziò a parlare”.<br />
Poi, però, la forma aulica ha<br />
sostituito dappertutto la meno<br />
aulica, che va scomparendo. Si<br />
legge ad esempio, “inizia a piovere”,<br />
anche se la pioggia non ha<br />
nulla <strong>di</strong> solenne. L’uso ormai è<br />
così <strong>di</strong>ffuso che ai <strong>di</strong>zionari non<br />
rimane che sostituire “verbo neutro”<br />
a “verbo attivo”.<br />
L’uso è sempre decisivo? Su<br />
ciò si battono due scuole estremistiche,<br />
i puristi e gli anarchici. Questi<br />
osservano che la lingua non la<br />
fanno i grammatici, bensì i parlanti.<br />
Quelli ribattono che il parlante <strong>di</strong>ce<br />
qualcosa, e non si limita a emettere<br />
suoni inarticolati, solo grazie a<br />
una lingua comune, a cui non si<br />
comanda se non obbedendo. Occorre<br />
dunque un compromesso.<br />
Solo lo spirito tirannico <strong>di</strong><br />
certi grammatici pretende a volte<br />
che si <strong>di</strong>ca “gli pneumatici” o “gli<br />
gnocchi”, anziché “i”, contro l’uso<br />
anche <strong>di</strong> molti classici. È per contro<br />
certamente un errore, ma un<br />
errore tenue, scrivere “le superfi -<br />
ci” al plurale, perché la parola latina<br />
è della quinta declinazione,<br />
quin<strong>di</strong> dà “le superfi cie”. Esempio:<br />
Enrico D’Ovi<strong>di</strong>o, Le superfi cie <strong>di</strong><br />
secondo or<strong>di</strong>ne (1838), o Edgardo<br />
Ciani nelle Lezioni <strong>di</strong> geometria<br />
proiettiva (1883), dove, data la<br />
materia, il plurale ricorre continuamente.<br />
Però l’uso abusivo del plurale<br />
in i non può estendersi a tutto:<br />
<strong>di</strong>re “le speci” anziché “le specie”<br />
è ancor oggi errore da matita blu,<br />
non solo rossa.<br />
VITTORIO MATHIEU<br />
Accademico dei Lincei<br />
II. Il Boccaccio, padre della<br />
prosa italiana come Dante<br />
della poesia, fu rimproverato<br />
ancor vivente dai puristi per aver<br />
dato a un suo personaggio il nome<br />
<strong>di</strong> Filostrato, nel senso <strong>di</strong> “abbattuto<br />
da Amore”. La colpa era mescolare<br />
una ra<strong>di</strong>ce greca con una<br />
latina (philía con sternere). Il nome<br />
Filostrato è usato anche in greco,<br />
ma per signifi care un soggetto che<br />
ama l’esercito (stessa ra<strong>di</strong>ce in<br />
“stratega”). Se però dovessimo<br />
essere pignoli fi no a tal segno non<br />
dovremmo <strong>di</strong>re “automobile”, bensì<br />
“sesemobile” o “autokíneton”,<br />
come <strong>di</strong>cono i greci (con parola<br />
impiegata già da Platone per l’anima,<br />
che muove e si muove da sé).<br />
I greci sono più conservatori<br />
<strong>di</strong> noi. Il risultato è che un greco<br />
colto può leggere Omero con l’ausilio<br />
<strong>di</strong> qualche lessico, come noi<br />
leggiamo Dante. Così i greci hanno<br />
una parola adatta per supermarket:<br />
yperagorá. La cosa curiosa è<br />
che da noi qualcuno pensa <strong>di</strong> far<br />
l’elegantone <strong>di</strong>cendo “ipermercato”<br />
cadendo così nell’errore simmetrico<br />
a quello del Boccaccio.<br />
Dunque, compromessi. Io mi<br />
pavoneggio scrivendo “superfi cie”<br />
Fotolia
al plurale, ma mi astengo dal toscaneggiare<br />
scrivendo “superfice”,<br />
senza i al singolare; e mi accade<br />
<strong>di</strong> <strong>di</strong>re “la Venezuela” per ricordare<br />
che è una “piccola Venezia”,<br />
ma compiango i giornalisti<br />
che, terrorizzati da pseudofi lologi,<br />
scrivono “gli pneumatici”. E non è<br />
neppure un compromesso, bensì<br />
una locuzione esatta, <strong>di</strong>re “due<br />
euro” anziché “euri”, perché le<br />
parole <strong>di</strong>mezzate non si declinano.<br />
È corretto, infatti, <strong>di</strong>re “due auto”.<br />
E “bici” non sarà elegante, ma si<br />
capisce che sta per “bicicletta”.<br />
Noi abbiamo la fortuna <strong>di</strong><br />
avere una regione, la Toscana,<br />
che, pur storpiando tutto, fornisce<br />
una guida al parlar bene, cioè in<br />
modo appropriato. Anche se è<br />
<strong>di</strong>ffi cile capire nel toscano arcaico<br />
che “alle guagnele” signifi ca “alle<br />
Evangelia” non c’è dubbio che i<br />
toscani ci insegnano a parlar preciso:<br />
“caffè alto” signifi ca che la<br />
sua superfi cie è vicina al bordo<br />
della tazza, mentre “caffè lungo”<br />
non <strong>di</strong>ce niente.<br />
III. Lo slittamento <strong>di</strong> signifi<br />
cato è tipico per contro<br />
del francese. Il soutien-gorge<br />
(<strong>di</strong>ffusosi a partire dal 1900, quando<br />
entrò in uso quell’indumento)<br />
non sostiene affatto la gola. La<br />
genesi della locuzione tuttavia si<br />
capisce: gorge, come “gola” è an-<br />
Fotolia<br />
La parola “senologia”<br />
usata per in<strong>di</strong>care<br />
il reparto che<br />
si occupa delle<br />
mammelle<br />
è uno<br />
pseudoeufemismo<br />
delittuoso.<br />
The word “senology”<br />
used to in<strong>di</strong>cate the<br />
hospital ward that<br />
deals with breasts<br />
is a criminal<br />
pseudo-euphemism.<br />
Dire “due euro”<br />
anziche “euri”<br />
è locuzione esatta<br />
perché le parole<br />
<strong>di</strong>mezzate non<br />
si declinano.<br />
Saying “two euro”<br />
instead of “euri”<br />
is correct because<br />
shortened words are<br />
not declined.<br />
che la strettoia, le gouffre tra due<br />
prominenze quali le mammelle.<br />
Ma il francese fa molto peggio: è<br />
orrendo, ad esempio, <strong>di</strong>re che la<br />
cicoria è un “legume”, quasi si<br />
trattasse <strong>di</strong> fagioli o <strong>di</strong> ceci.<br />
D’altra parte l’organo femminile<br />
destinato all’allattamento è<br />
particolarmente soggetto in tutte<br />
le lingue a curiose trasposizioni:<br />
forse perché si trova poco elegante<br />
seguire Dante che alla fi ne del<br />
Duecento prevede che, tra breve,<br />
«sarà dal pergamo interdetto alle<br />
sfacciate donne fi orentine l’andar<br />
mostrando con le poppe il petto».<br />
Almeno nel parlare scientifi co<br />
non si dovrebbe <strong>di</strong>menticare mammella.<br />
Senonché il petto induce a<br />
volte in eufemismi perfi no quando<br />
è maschile: si può ricordare in<br />
piemontese lo “stomaco” nella locuzione<br />
scherzosa per lo sparato<br />
inamidato “stomaco <strong>di</strong> gesso” (stomi<br />
’d giss).<br />
Inammissibile però che il linguaggio<br />
me<strong>di</strong>co – che <strong>di</strong> solito si<br />
rifà al greco – cada, sia pur <strong>di</strong> rado,<br />
in locuzioni abominevoli. Mi accadde,<br />
mentre andavo a sottopormi a<br />
una ra<strong>di</strong>ografi a, <strong>di</strong> leggere sulla<br />
porta <strong>di</strong> uno stu<strong>di</strong>o vicino a quello<br />
a cui ero destinato io la parola<br />
“senologia”. Giuro che non capii <strong>di</strong><br />
che cosa si trattasse e me lo feci<br />
spiegare: il ra<strong>di</strong>ologo che lavorava<br />
in quella stanza, mi fu detto, si<br />
occupa dei “seni”.<br />
Qui lo pseudoeufemismo<br />
adottato è delittuoso. Il passaggio<br />
del latino sinus a signifi care una<br />
convessità anziché una cavità è<br />
molto meno giustifi cabile che gorge.<br />
Sein comincia in francese<br />
(1150: le date sono dell’anno in<br />
cui per la prima volta l’uso è documentato)<br />
a in<strong>di</strong>care lo spazio tra la<br />
veste e il petto. Poi si sposta a<br />
in<strong>di</strong>care ciascuna mammella<br />
(1786), mentre “tetta” viene dal<br />
germanico (tedesco Zitze). L’inversione<br />
probabilmente si spiega con<br />
uno spostamento dalla veste alla<br />
parte del corpo occultata. In origine,<br />
ad esempio, il tedesco Schosz<br />
era il bordo inferiore della gonna: il<br />
grembo, che poi passa alla parte<br />
del corpo corrispondente, tanto<br />
che noi <strong>di</strong>ciamo ancora «in grembo<br />
a Giove», o «nel seno <strong>di</strong> Abramo»<br />
(Luca XVI, 22), come Omero <strong>di</strong>ceva<br />
«en goúna<strong>di</strong> degli dèi». Poi Schosz<br />
<strong>di</strong>viene sinonimo <strong>di</strong> Busen (ancora<br />
in Goethe, Meister VIII, 9) che poteva<br />
in<strong>di</strong>care anche il petto o Brust<br />
maschile. L’eufemismo francese<br />
poitrine (dal latino pectorina o corazza)<br />
si <strong>di</strong>ffonde per contro molto<br />
tar<strong>di</strong>vamente (1835).<br />
L’indeterminazione della parte<br />
del corpo ricoperta favorisce il<br />
rovesciamento. Nel caso del mare,<br />
“seno” conserva il suo signifi cato<br />
giusto: si parla <strong>di</strong> “insenatura” ad<br />
esempio per Paraggi, non per il<br />
promontorio <strong>di</strong> Portofi no. Una cautela<br />
eufemistica induce per contro<br />
a <strong>di</strong>re il Messia «frutto del seno<br />
della Vergine», per non <strong>di</strong>re dell’utero;<br />
ma si potrebbe meglio rime<strong>di</strong>are<br />
con “grembo” o “ventre”.<br />
Presso il Ministero dei Beni<br />
culturali c’è un’apposita commissione<br />
per la <strong>di</strong>fesa dell’italiano. E<br />
affi anca la benemerita Dante Alighieri.<br />
Occorrerebbe dotarla del<br />
potere <strong>di</strong> irrogare pene detentive<br />
(non usandosi più, purtroppo, la<br />
gogna) per chi mette in circolazione<br />
mostri come “senologia”.<br />
Photo Oilime<br />
SOCIETÀ E COSTUME 127
Cos’è la buona me<strong>di</strong>cina?<br />
NOTIZIARIO<br />
Salute<br />
“Se dovessi <strong>di</strong>re<br />
cos’è una buona<br />
squadra <strong>di</strong> calcio<br />
non avrei dubbi,<br />
la risposta sarebbe:<br />
Inter”.<br />
“If I had to say what<br />
a good football team<br />
is, I wouldn’t have<br />
any doubts,<br />
the answer<br />
would be: Inter”.<br />
What is good me<strong>di</strong>cine?<br />
Good me<strong>di</strong>cine is something that is beneficial to the health<br />
of the ill. But this objective is not easily defined. It is fundamental<br />
to decide what is the best way to respect the pain of those<br />
suffering from illness. Respect, <strong>di</strong>alogue and comfort were the<br />
simple tools used by the family physician. Today, those tools have<br />
been replaced by protocols, tests and statistics that raise many<br />
doubts as to what is truly better, when working in <strong>di</strong>fficult<br />
con<strong>di</strong>tions. In order to be a good me<strong>di</strong>cine, the ill person must<br />
always feel that someone is at his side, to help him fight his<br />
battles, without automatically imposing what the deontological<br />
procedure <strong>di</strong>ctates. You can look down on a person only<br />
when you are helping him to get up.<br />
128 SALUTE<br />
ALESSANDRO BERTOLINI<br />
Direttore Oncologia Me<strong>di</strong>ca<br />
Azienda Ospedaliera Valtellina e Valchiavenna<br />
www.alessandrobertolini.it<br />
La tentazione che più mi<br />
assale <strong>di</strong> questi tempi<br />
sarebbe scrivere <strong>di</strong> questioni<br />
morali: moralità della<br />
politica, della comunicazione,<br />
della giustizia, della società e dello<br />
sport. Sarebbe una tentazione<br />
molto semplice da esau<strong>di</strong>re, basta<br />
un riassunto della semplice lettura<br />
dei giornali, tuttavia sarebbe tempo<br />
perso. Ormai vivo in una sorta<br />
<strong>di</strong> pessimismo cosmico e <strong>di</strong>ssertare<br />
<strong>di</strong> questioni che il tifo della politica<br />
interpreterebbe come pro o<br />
contro la realtà, bollandomi <strong>di</strong> positività<br />
o peggio <strong>di</strong> avversione a<br />
qualcosa o qualcuno, mi impone<br />
un’opportuna riservatezza.<br />
Viviamo un’epoca decadente,<br />
siamo tutti d’accordo credo, dove la<br />
coscienza della società segue l’in<strong>di</strong>rizzo<br />
del variabile e il singolo non<br />
è da meno. Impera la non cultura,<br />
la cultura omologata al minimo comune<br />
denominatore dal messaggio<br />
me<strong>di</strong>atico, stu<strong>di</strong>ato per produrre<br />
ricchezza con la pubblicità.<br />
Io ritengo che questo modo <strong>di</strong><br />
governare la vita sia <strong>di</strong>retta conse-<br />
guenza della nostra “coscienza<br />
elastica”. Si approva e si <strong>di</strong>sserta,<br />
anche pontificando, quanto dovrebbe<br />
essere sottomesso al giu<strong>di</strong>zio<br />
<strong>di</strong> un valore assoluto, fatto<br />
salvo che è insita in ciascuno <strong>di</strong><br />
noi la capacità <strong>di</strong> essere tolleranti<br />
e permissivi per prima cosa con<br />
noi stessi, ogni qual volta ci troviamo<br />
a infrangere le regole che l’etica<br />
ci imporrebbe <strong>di</strong> osservare.<br />
Un esempio che non offende<br />
nessuno e non scatena il tifo della<br />
politica? Non si può sorpassare se<br />
lungo la via qualche stra<strong>di</strong>no ha<br />
<strong>di</strong>pinto sull’asfalto la striscia continua,<br />
questa non è una regola <strong>di</strong><br />
destra o <strong>di</strong> sinistra, non si deve e<br />
basta. È motivo <strong>di</strong> bocciatura<br />
all’esame <strong>di</strong> guida e <strong>di</strong> grossa<br />
multa con penalizzazione sulla<br />
patente.<br />
Ebbene, quanti tra noi non<br />
l’hanno davvero mai fatto? Una<br />
coscienza elastica sa che il sorpasso<br />
in questione è cosa da non<br />
fare, ma proprio perché ragiona in<br />
modo duttile, giustifi ca il proprio<br />
sorpasso illegale ribaltando la responsabilità<br />
dell’infrazione su chi<br />
percorreva la stessa via con un’andatura<br />
non consona ai nostri appuntamenti.<br />
Pensate a qualsiasi<br />
altra cosa, nella società, nel vivere,<br />
nelle leggi e nella politica e<br />
vedrete quanto la nostra fragilità<br />
sia giorno dopo giorno sottomessa<br />
all’elasticità <strong>di</strong> una coscienza opportunista.<br />
Mi piacerebbe proseguire<br />
su questo modo <strong>di</strong> considerare<br />
il nostro approccio alle questioni<br />
dell’oggi, ma i tempi non<br />
sono maturi e il malinteso non<br />
gioverebbe a nessuno. È opportuno<br />
che ciascuno <strong>di</strong> noi rifl etta su<br />
quanto accade nel mondo, guardando<br />
i fatti non con gli occhi della<br />
nostra caducità o partigianeria,<br />
ma secondo le regole della morale<br />
e dell’etica, che dovrebbero avere<br />
sempre un valore assoluto e non<br />
elastico.<br />
A questo punto mi viene più<br />
semplice <strong>di</strong>ssertare <strong>di</strong> me<strong>di</strong>cina e<br />
lo spunto lo prenderei dal quesito<br />
su cosa sia la “buona me<strong>di</strong>cina”.<br />
Questo argomento non è poi così<br />
semplice da riferire, anzi esso<br />
stesso è pure delicato e parlare <strong>di</strong><br />
sport sarebbe molto più semplice.<br />
Per questo se dovessi <strong>di</strong>re<br />
cos’è una buona squadra <strong>di</strong> calcio<br />
non avrei dubbi, la risposta sarebbe:<br />
“Inter” e in occasione <strong>di</strong> un<br />
convegno nella Bergamasca, l’anno<br />
passato, dove mi era stata<br />
Olycom
chiesta una rifl essione sul tema<br />
“La buona me<strong>di</strong>cina”, l’ho <strong>di</strong>chiarato<br />
pubblicamente, facendo anche<br />
vedere l’immagine della mia squadra<br />
del cuore.<br />
All’opposto, se dovessi dare<br />
una risposta altrettanto imme<strong>di</strong>ata<br />
alla domanda su cosa sia la<br />
“buona me<strong>di</strong>cina” oggi, non avrei<br />
la stessa spavalderia. Questo succede<br />
perché io per primo non so<br />
cosa essa sia e non so neppure<br />
se sia dotato delle credenziali<br />
adatte per spiegarlo o se essa<br />
esista davvero, in questo periodo<br />
<strong>di</strong> esplosiva modernità scientifi ca.<br />
Oggi sono solo in grado <strong>di</strong><br />
elencare una serie <strong>di</strong> rifl essioni<br />
per tentare <strong>di</strong> avvicinare l’ideale<br />
della “buona me<strong>di</strong>cina”, anche se<br />
sono più consapevole <strong>di</strong> cosa essa<br />
non sia, piuttosto che certo <strong>di</strong><br />
ciò che essa dovrebbe essere.<br />
Per prima cosa penso, da<br />
me<strong>di</strong>co ospedaliero, inserito a pieno<br />
titolo nel sistema sanitario nazionale<br />
e parte <strong>di</strong> questo mondo,<br />
che la buona me<strong>di</strong>cina dovrebbe<br />
coincidere con quello che facciamo<br />
noi tutti durante le giornate <strong>di</strong> lavoro.<br />
Se così fosse il <strong>di</strong>scorso sarebbe<br />
chiuso: buona me<strong>di</strong>cina è quella<br />
fatta negli ospedali e negli stu<strong>di</strong><br />
dei me<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> me<strong>di</strong>cina generale.<br />
Tuttavia questa risposta non<br />
mi accontenta, perché ciascuno<br />
<strong>di</strong> noi lavora usando le proprie<br />
conoscenze, le proprie capacità<br />
professionali e le risorse che ha<br />
a <strong>di</strong>sposizione. Non tutti siamo<br />
omologati allo stesso livello nella<br />
professione.<br />
La malasanità, tanto cara alla<br />
stampa, non è mai esempio <strong>di</strong><br />
buona me<strong>di</strong>cina e quando viene<br />
A sinistra, un punto<br />
<strong>di</strong> vista e, a destra, il<br />
“mio” punto <strong>di</strong> vista.<br />
On the left, one<br />
point of view and,<br />
on the right, “my”<br />
point of view.<br />
Due esempi <strong>di</strong> “buona<br />
me<strong>di</strong>cina”: lo sciroppo<br />
che mi somministrava<br />
mia madre, “buono”<br />
solo perché era lei a<br />
darmelo, e la borsa<br />
del buon me<strong>di</strong>co <strong>di</strong><br />
famiglia.<br />
Two examples of<br />
“good me<strong>di</strong>cine”: the<br />
syrup my mother used<br />
to give me, “good”<br />
only because she<br />
gave it to me, and<br />
the good GP’s bag.<br />
denunciata dai me<strong>di</strong>a provo sempre<br />
un senso <strong>di</strong> profonda amarezza<br />
e dolore, che va oltre il mio<br />
senso civico e interessa il mio<br />
essere me<strong>di</strong>co.<br />
Facendo anche altro nella vita,<br />
mi considero un intellettuale<br />
che cerca <strong>di</strong> osservare i fatti del<br />
mondo nel modo meno elastico<br />
possibile, vorrei raccontare un mio<br />
punto <strong>di</strong> vista, che non <strong>di</strong>scende<br />
solo dalla professione che svolgo<br />
e che non deve avere un valore<br />
assoluto, ma potrebbe rappresentare<br />
il mio modo d’intendere l’argomento,<br />
che deve prescindere dalle<br />
risorse a <strong>di</strong>sposizione e dalle conoscenze.<br />
Ovvio che facendo l’oncologo<br />
me<strong>di</strong>co quando mi riferisco alla<br />
buona me<strong>di</strong>cina nelle spiegazioni<br />
intendo esclusivamente la buona<br />
me<strong>di</strong>cina oncologica, cioè quella<br />
Fotolia<br />
Fotolia<br />
attività specialistica me<strong>di</strong>ca de<strong>di</strong>cata<br />
alla cura dei malati <strong>di</strong> cancro.<br />
Lungi da me offrire spiegazioni che<br />
non <strong>di</strong>scendano da una mia <strong>di</strong>retta<br />
responsabilità professionale e lo<br />
<strong>di</strong>chiaro perché non vorrei essere<br />
frainteso. Quello che vale per l’oncologia<br />
me<strong>di</strong>ca potrebbe non valere<br />
per la buona ortope<strong>di</strong>a o la<br />
buona car<strong>di</strong>ologia e ritengo non si<br />
debba fare confusione nei punti <strong>di</strong><br />
vista o nelle generalizzazioni.<br />
«Per essere buona la me<strong>di</strong>cina<br />
– <strong>di</strong>ce Sandro Spinsanti, docente<br />
<strong>di</strong> bioetica ed esperto <strong>di</strong> me<strong>di</strong>cal<br />
humanities – deve procurare un<br />
benefi cio alla salute <strong>di</strong> chi è malato.<br />
È una con<strong>di</strong>zione che si misura con<br />
gli standard della scienza. Ma non<br />
basta».<br />
La nostra è una professione<br />
che cammina lungo un fi lo in equilibrio<br />
precario, in modo non <strong>di</strong>ssimile<br />
da chi faccia il funambolo. Ci<br />
sono fatti, conoscenze, miti e<br />
idee, che con<strong>di</strong>zionano il nostro<br />
modo <strong>di</strong> porci nei confronti della<br />
professione e dei pazienti.<br />
Se penso alla buona me<strong>di</strong>cina<br />
mi viene in mente quella che mi<br />
dava mia mamma da piccolo, lo<br />
sciroppo per la tosse, il lassativo<br />
o l’antibiotico, che erano buoni<br />
perché me li dava lei, anche se<br />
avevano un gusto orrendo. In questo<br />
caso il sostantivo me<strong>di</strong>cina<br />
assume due signifi cati <strong>di</strong>fferenti,<br />
da un lato è un prodotto dell’industria<br />
farmaceutica, dall’altro <strong>di</strong>viene<br />
una professione.<br />
Ho nostalgia <strong>di</strong> quei ricor<strong>di</strong>, <strong>di</strong><br />
quando lei mi <strong>di</strong>ceva: «Pren<strong>di</strong> la<br />
me<strong>di</strong>cina, è buona e ti farà bene»,<br />
ma ho anche rimpianti per il nostro<br />
caro me<strong>di</strong>co <strong>di</strong> famiglia, dottor<br />
SALUTE 129
Il dottor Gannon <strong>di</strong> Me<strong>di</strong>cal Center, il dottor<br />
Tersilli de Il me<strong>di</strong>co della mutua e Patch Adams,<br />
tre storie incentrate sulla figura dei me<strong>di</strong>ci e<br />
sulla sanità in generale.<br />
Dr. Gannon of “Me<strong>di</strong>cal Center”, Dr. Tersilli of<br />
Il me<strong>di</strong>co della mutua and Patch Adams, three<br />
stories built up around the figure of doctors<br />
and health in general.<br />
Romei, scomparso da anni, che<br />
era pure padre <strong>di</strong> un mio compagno<br />
d’università. Egli, quando veniva<br />
a casa nostra per curarci, mostrava<br />
una de<strong>di</strong>zione che negli<br />
anni <strong>di</strong> professione ho ritrovato a<br />
fatica. L’unica sua stranezza era<br />
che chiamava mia sorella Mariarosa,<br />
sviato dalla pubblicità del lievito<br />
che porta il mio cognome, che<br />
aveva un cartone animato e una<br />
canzonetta <strong>di</strong> una certa Mariarosa<br />
come testimonial. Noi in famiglia<br />
tutte le volte tentavamo <strong>di</strong> correggerlo,<br />
ma lui imperterrito aveva<br />
quel nome nella memoria e non<br />
rinunciava al Mariarosa. Alla fi ne<br />
desistemmo.<br />
I ricor<strong>di</strong> della mia infanzia<br />
passano attraverso fi ction in bianco<br />
e nero, che spopolavano a quei<br />
tempi: dottor Welby e dottor Gannon<br />
<strong>di</strong> Me<strong>di</strong>cal Center. In questi<br />
telefi lm degli anni Sessanta i me<strong>di</strong>ci<br />
erano perfetti, ben vestiti, facevano<br />
<strong>di</strong>agnosi azzeccate, salvavano<br />
vite o scoprivano magagne,<br />
che parevano esercizi <strong>di</strong> buona<br />
me<strong>di</strong>cina applicata alla giallistica.<br />
Il mondo degli ospedali era bello,<br />
accattivante, non erotico ed in<br />
ogni modo avvincente. Non esclu-<br />
Mash: in un ospedale<br />
militare da campo,<br />
tre ufficiali me<strong>di</strong>ci,<br />
pur prestando la loro<br />
opera <strong>di</strong> chirurghi<br />
con bravura e<br />
de<strong>di</strong>zione, sono<br />
insofferenti alla<br />
<strong>di</strong>sciplina.<br />
Mash: in a military<br />
field hospital, three<br />
me<strong>di</strong>cal officers,<br />
whilst exercising as<br />
surgeons with skill<br />
and de<strong>di</strong>cation, are<br />
intolerant of the<br />
<strong>di</strong>scipline.<br />
do che la pletora me<strong>di</strong>ca della mia<br />
generazione abbia subìto il fascino<br />
del mondo della televisione per la<br />
scelta universitaria. Non è un<br />
esempio <strong>di</strong> sana vocazione, quanto<br />
piuttosto il plagio per un ambiente<br />
<strong>di</strong> successo dove la me<strong>di</strong>cina<br />
investigativa dei telefi lm non ha<br />
mai avuto nulla a che fare con la<br />
realtà <strong>di</strong> tutti i giorni.<br />
Gli esempi del passato arrivano<br />
alla saga <strong>di</strong> Mash, storie<br />
immaginarie e ironiche <strong>di</strong> un ospedale<br />
da campo in zona <strong>di</strong> guerra,<br />
durante il confl itto in Corea, dove<br />
un certo eros si dava da fare per<br />
creare vocazioni nei futuri studenti<br />
universitari. La capo infermiera<br />
aveva un soprannome molto invitante:<br />
labbra <strong>di</strong> fuoco e molti cedettero<br />
a quel mito più che al testo<br />
<strong>di</strong> Anatomia Umana.<br />
In Italia nello stesso periodo<br />
usciva il più genuino Me<strong>di</strong>co della<br />
mutua <strong>di</strong> Alberto Sor<strong>di</strong>, che mostrava<br />
le contrad<strong>di</strong>zioni insite in<br />
una professione che al cinema<br />
perdeva il fascino e la de<strong>di</strong>zione<br />
che toccavo con mano ammirando<br />
il caro dottor Romei.<br />
Io iniziai l’università nel 1978,<br />
oltre trent’anni fa e per questo<br />
motivo dovrei sentirmi vecchio.<br />
Quello fu un anno memorabile e a<br />
ripensarlo nei fatti salienti esso è<br />
ormai consegnato alla storia. La<br />
storia è quella <strong>di</strong> Giulio Cesare o<br />
Napoleone e il pensare che ho<br />
iniziato l’università in un anno che<br />
è storia, questo colloca la mia vita<br />
professionale in qualcosa che parte<br />
da lontano, che sa d’antico.<br />
Nel 1978 ci furono tre papi,<br />
l’elezione a presidente della Repubblica<br />
<strong>di</strong> Sandro Pertini, il delitto<br />
Moro e l’attacco terroristico alla<br />
Repubblica nata dalla Resistenza.<br />
In quell’anno l’Italia arrivò pure<br />
quarta ai mon<strong>di</strong>ali <strong>di</strong> calcio argentini,<br />
i primi che vi<strong>di</strong> a colori e che<br />
ricordo con forte tensione sportiva.<br />
Si svolgevano in un Paese<br />
preda <strong>di</strong> una feroce <strong>di</strong>ttatura militare<br />
e ricordare tutte queste cose,<br />
un po’ in bianco e nero e un po’ a<br />
colori, dà il senso della lontananza<br />
dall’oggi.<br />
Il giro nei reparti era ancora<br />
caratterizzato dal primario pontefi -<br />
ce, attorniato da uno stuolo <strong>di</strong> ca-
mici bianchi dalle <strong>di</strong>fferenti attitu<strong>di</strong>ni<br />
e competenze. Era un mondo<br />
baronale, che ho intravisto all’università<br />
ma che oggi è stato del<br />
tutto spazzato dalla <strong>di</strong>fferente educazione<br />
<strong>di</strong> quanti sono cresciuti al<br />
mito <strong>di</strong> Mash. Capita che certi insegnamenti<br />
nella vita, mutuati dalla<br />
celluloide, servano per decidere<br />
cosa non si dovrà mai fare da<br />
gran<strong>di</strong>, piuttosto che per sapere<br />
cosa fare davvero.<br />
Il passato vissuto o visto al<br />
cinema non aiuta nell’arrivare a<br />
capire cosa possa essere la buona<br />
me<strong>di</strong>cina e neppure i tempi<br />
nostri sono d’aiuto. Oggi siamo<br />
plagiati da un illusorio bonario,<br />
dove un ospedale fasullo è interpretato<br />
in modo <strong>di</strong>ssacratorio dal<br />
mondo <strong>di</strong> celluloide con la storia<br />
controcorrente <strong>di</strong> Patch Adams, dal<br />
Me<strong>di</strong>co in famiglia dell’istrione Lino<br />
Banfi , oppure ancora da ER o da<br />
un certo Dottor House, un pazzo<br />
vestito neppure troppo bene da<br />
me<strong>di</strong>co. Sono tanti stravolgimenti<br />
della vita ospedaliera <strong>di</strong> tutti i giorni,<br />
che mi auguro non trainino altri<br />
giovani a una professione che in<br />
quella maniera non è davvero mai<br />
esistita.<br />
Rifuggendo da queste nuove<br />
storie televisive io sono più che<br />
certo che questo mondo alle volte<br />
buonista e più spesso falsamente<br />
scientifi co, non ha nulla a che fare<br />
con la buona me<strong>di</strong>cina.<br />
Tutto quanto raccontato fi nora<br />
ci aiuta a capire cosa non sia la<br />
buona me<strong>di</strong>cina e in questo senso<br />
c’è ad<strong>di</strong>rittura dell’altro.<br />
Nel mondo d’oggi, come sosteneva<br />
mia nonna, a pensar male<br />
non si sbaglia mai e, dopo l’irreale<br />
raccontato nei fi lm, il nostro cammino<br />
prosegue lungo una realtà<br />
funambolica.<br />
Se uno fabbricasse carrarmati,<br />
per vendere il proprio prodotto,<br />
avrebbe due sole possibilità:<br />
sperare in una guerra o provocarla<br />
egli stesso.<br />
Per questo domando, chi ci<br />
ha guadagnato dal gettare panico<br />
sociale per un virus, l’H1N1, che<br />
non ha fatto tutto lo sfacelo previsto?<br />
È buona me<strong>di</strong>cina quella <strong>di</strong><br />
investire sol<strong>di</strong> in un vaccino che<br />
poi non è stato neppure usato,<br />
perché la virosi si è <strong>di</strong>mostrata<br />
tutt’altro che virulenta, ma solo il<br />
frutto <strong>di</strong> una speculazione me<strong>di</strong>atica?<br />
Quanti carrarmati sono stati<br />
venduti <strong>di</strong>etro il mito illusorio <strong>di</strong> un<br />
virus fasullo?<br />
A pensar male come la nonna,<br />
mi viene da <strong>di</strong>re che qualcuno<br />
ha fomentato ad arte il panico<br />
sulla virosi per commerciare vaccini<br />
inutili. Non è buona me<strong>di</strong>cina<br />
questa, è solo il mondo degli affari,<br />
né più né meno che vendere<br />
pignatte in televisione, perché i<br />
vaccini sono stati acquistati sotto<br />
la pressione involontaria del piazzista<br />
del telegiornale.<br />
Gli spunti critici all’insegna <strong>di</strong><br />
cosa non sia la buona me<strong>di</strong>cina<br />
proseguono. Mettere i me<strong>di</strong>ci alla<br />
berlina su internet, <strong>di</strong>chiarando<br />
pubblicamente i loro stipen<strong>di</strong>, serve<br />
a migliorare le prestazioni del<br />
servizio sanitario nazionale? No <strong>di</strong><br />
certo.<br />
Mettere su un sito <strong>di</strong> un’istituzione<br />
un banner pubblicitario<br />
Ciò che si vede al<br />
cinema o in<br />
televisione non<br />
sempre aiuta<br />
nell’arrivare a capire<br />
cosa possa essere la<br />
“buona me<strong>di</strong>cina”.<br />
What we see at the<br />
cinema or on<br />
television is not<br />
always of help in<br />
being able to<br />
understand what<br />
“good me<strong>di</strong>cine” is.<br />
che recita “because they saved my<br />
life”, chi incanta? Non è buona<br />
me<strong>di</strong>cina il mercifi care la propria<br />
opera con motti che promettono il<br />
nulla e danno ben poco.<br />
Gli slogan <strong>di</strong> questo tipo cosa<br />
lasciano nei pazienti? L’illusione<br />
che in quel luogo siano in grado <strong>di</strong><br />
salvare la loro sorte, ma anche<br />
quando chi scriveva che la libertà<br />
sarebbe arrivata dal lavoro, scriveva<br />
inganni e prometteva menzogne<br />
e sappiamo tutti com’è andata<br />
a fi nire.<br />
Alla fi ne la nostra coscienza<br />
elastica approva motti fasulli,<br />
perché l’interesse non è esercitare<br />
l’arte me<strong>di</strong>ca ma promuovere<br />
affari.<br />
Il caro dottor Romei era un<br />
gran me<strong>di</strong>co, faceva della me<strong>di</strong>cina<br />
<strong>di</strong> famiglia un’arte e non aveva<br />
cartelli posticci che denunciavano<br />
la sua capacità scientifi ca o il suo<br />
red<strong>di</strong>to.<br />
«Un me<strong>di</strong>co, <strong>di</strong>versamente da<br />
un politico o da un attore, viene<br />
giu<strong>di</strong>cato soltanto dal suo paziente<br />
e dai suoi più prossimi colleghi, cioè<br />
a porte chiuse, da uomo a uomo».<br />
Questo è forse un in<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> buona<br />
me<strong>di</strong>cina, secondo Kundera. Io<br />
pure, nella vita intellettuale, ho<br />
scritto cosa ritengo signifi chi fare<br />
bene il me<strong>di</strong>co (Il Novecento d’Annetta).<br />
– Che ne pensi del professore?<br />
Chiese mentre erano nell’attesa<br />
del tram.<br />
– Devo <strong>di</strong>rti che mi ha impressionato,<br />
non aveva quel tono punitivo<br />
e saccente che hanno gli altri<br />
dottori. Parlava in modo comprensibile…<br />
– Ha dato la stessa impressione<br />
anche a me.<br />
– Era come se volesse de<strong>di</strong>carmi<br />
il suo tempo a capire e spie-<br />
SALUTE 131
gare quello che secondo lui mi sta<br />
accadendo. Non si è limitato a visitarmi,<br />
come farebbe un meccanico<br />
con un’automobile.<br />
– Con il suo aiuto e la sua sapienza<br />
torneremo a vivere. È senza<br />
dubbio un brav’uomo.<br />
Come <strong>di</strong>ce Sandro Spinsanti<br />
«fare me<strong>di</strong>cina in epoca <strong>di</strong> modernità<br />
è <strong>di</strong>verso» e credo possa <strong>di</strong>pendere<br />
dalla coscienza elastica che<br />
pervade la società.<br />
Innanzitutto nella me<strong>di</strong>cina<br />
moderna adottiamo il modello delle<br />
scelte con<strong>di</strong>vise, cercando <strong>di</strong><br />
defi nire il programma terapeutico<br />
col malato, spiegando in modo<br />
semplice e comprensivo a chi ne<br />
ha bisogno il perché <strong>di</strong> un percorso<br />
<strong>di</strong> cura. L’accettazione della proposta<br />
è siglata uffi cialmente con il<br />
consenso informato, che dovrebbe<br />
essere una garanzia per il paziente<br />
per una maggiore partecipazione<br />
alle decisioni che lo riguardano.<br />
Non so se esso serva per fare una<br />
buona me<strong>di</strong>cina o una me<strong>di</strong>cina<br />
sicura, comunque è un atto formale<br />
siglato da due persone, il me<strong>di</strong>co<br />
e il paziente. Oggi il nostro sapere<br />
passa attraverso una cono-<br />
132 SALUTE<br />
Paola Cusin<br />
Il fenomeno del<br />
“primario-pontefice” è<br />
stato debellato dalla<br />
<strong>di</strong>fferente educazione<br />
<strong>di</strong> quanti sono<br />
cresciuti al mito <strong>di</strong><br />
Mash.<br />
Al centro: la nostra<br />
coscienza elastica è<br />
vittima <strong>di</strong> informazioni<br />
me<strong>di</strong>atiche che<br />
andrebbero filtrate.<br />
In basso: aver<br />
fomentato ad arte il<br />
panico sull’H1N1 non<br />
è certo “buona<br />
me<strong>di</strong>cina”.<br />
The phenomenon of<br />
the “pope-head of<br />
hospital department”<br />
has been era<strong>di</strong>cated<br />
by the <strong>di</strong>fferent<br />
education of those<br />
who grew up in the<br />
myth of Mash.<br />
In the centre: our<br />
elastic conscience is<br />
the victim of me<strong>di</strong>a<br />
information which<br />
should be filtered.<br />
Below: having<br />
deliberately created<br />
panic over H1N1 was<br />
certainly not “good<br />
me<strong>di</strong>cine”.<br />
scenza della biologia molecolare<br />
che sta sempre più arricchendosi<br />
<strong>di</strong> informazioni e <strong>di</strong>viene sempre<br />
più <strong>di</strong>ffi cile e incomprensibile. Catene<br />
metaboliche spiegate con<br />
dovizie <strong>di</strong> particolari cui si deve<br />
dare fi ducia cieca, perché quelli<br />
che vedevano il dottor Gannon alla<br />
televisione non le avevano nel loro<br />
piano <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>, anche se oggi si<br />
trovano a usare molti farmaci che<br />
interferiscono con queste vie metaboliche<br />
cellulari.<br />
Siamo vittime anche del crescere<br />
delle informazioni me<strong>di</strong>atiche,<br />
che fanno da cassa <strong>di</strong> risonanza<br />
a notizie su presunti successi<br />
me<strong>di</strong>ci e che andrebbero fi ltrate<br />
per non ingenerare false attese.<br />
I nostri successi terapeutici<br />
in campo oncologico riguardano<br />
soprattutto un allungamento della<br />
vita del malato, a costi non sempre<br />
sostenibili. Avere una sopravvivenza<br />
nella malattia metastatica<br />
che passa da sei mesi a quasi tre<br />
anni nella me<strong>di</strong>a dei malati affetti<br />
da tumore metastatico del grosso<br />
intestino appaga la nostra professionalità<br />
ma non può accontentare<br />
i pazienti e non dobbiamo considerare<br />
questi successi come<br />
vera buona me<strong>di</strong>cina.<br />
Fare buona me<strong>di</strong>cina vuol<br />
<strong>di</strong>re tener conto delle caratteristiche<br />
cliniche del malato, seguendo<br />
linee guida internazionali, non fomentate<br />
da campagne me<strong>di</strong>atiche<br />
che portino ad acquistare<br />
vaccini inutili, anche se certe stranezze<br />
del passato le dobbiamo<br />
ancora scontare. Abbiamo dato<br />
per anni chemioterapia ai pazienti<br />
affetti dal cancro della prostata,<br />
perché un questionario <strong>di</strong> qualità<br />
<strong>di</strong> vita compilato da loro stessi<br />
dava cre<strong>di</strong>bilità a una cura solo in<br />
termini <strong>di</strong> benessere clinico, pur<br />
senza <strong>di</strong>mostrare mai un vantaggio<br />
nella loro sopravvivenza (Tannock,<br />
1996). Oggi per fortuna la<br />
situazione è mutata e i nuovi<br />
chemioterapici hanno un impatto<br />
concreto sull’allungamento della<br />
sopravvivenza dei malati trattati.<br />
La verità è che negli ultimi<br />
cinquant’anni, lo ha scritto nel<br />
2009 un e<strong>di</strong>toriale del The New<br />
York Times, abbiamo fatto una<br />
serie <strong>di</strong> errori fondamentali nel<br />
combattere la guerra al cancro,<br />
perché non sempre è stata fatta<br />
ricerca con l’intento <strong>di</strong> far avanzare<br />
la scienza ma solo per inseguire<br />
interessi <strong>di</strong> parte in un normale<br />
mondo a coscienza elastica. Negli<br />
ultimi cinquant’anni la mortalità<br />
per ragioni car<strong>di</strong>ache è <strong>di</strong>minuita<br />
del 64%, mentre per cause oncologiche<br />
solo del 5%. È dato noto<br />
che solo uno su cinque trials arriva<br />
a pubblicazione con dati che<br />
in<strong>di</strong>chino un reale benefi cio per i<br />
futuri pazienti.<br />
Riflettere su queste cose,<br />
mentre si esercita la professione,<br />
è come vivere in un incubo permanente<br />
ed è <strong>di</strong>fficile scegliere il<br />
meglio con il paziente e fare buona<br />
me<strong>di</strong>cina. «Guai a sognare: il momento<br />
<strong>di</strong> coscienza che accompagna<br />
il risveglio è la sofferenza più<br />
acuta. Ma non ci capita sovente (Se<br />
questo è un uomo, Primo Levi) e
non sono lunghi sogni: noi non siamo<br />
che bestie stanche».<br />
Oggi sono sicuro che la buona<br />
me<strong>di</strong>cina non si può fare da<br />
soli ma è un atto complesso <strong>di</strong><br />
sistema, dove tutti hanno una<br />
parte attiva nella fi liera della cura,<br />
perché «curare il tumore – Clau<strong>di</strong>o<br />
Magris – è come uccidere una vita<br />
che ci assale».<br />
Curare non è solo un esercizio<br />
<strong>di</strong> conoscenze farmacologiche ma<br />
passa attraverso la comprensione,<br />
il <strong>di</strong>alogo e l’informazione. «Fatti non<br />
foste a viver come bruti, ma per seguir<br />
virtute e canoscenza».<br />
La comunicazione al paziente<br />
è importante nell’esercizio <strong>di</strong> una<br />
buona me<strong>di</strong>cina, perché «una <strong>di</strong>agnosi<br />
<strong>di</strong> cancro è come un 11 settembre».<br />
I pazienti vogliono vivere<br />
con <strong>di</strong>gnità, cioè nel modo migliore<br />
e noi da tecnici del sapere me<strong>di</strong>co<br />
questo desiderio lo chiamiamo<br />
qualità <strong>di</strong> vita. «L’oncologia me<strong>di</strong>ca<br />
– Rosy Bin<strong>di</strong>, 1998 – è un’arma<br />
strategica in<strong>di</strong>spensabile nella lotta<br />
contro i tumori, non già perché<br />
guarisce sempre, ma perché sempre<br />
si prende cura del malato».<br />
L’oncologo in fondo ha questa<br />
doppia missione, cerca <strong>di</strong> far<br />
vivere più a lungo possibile i malati<br />
nel rispetto della loro qualità <strong>di</strong><br />
vita e quest’idea <strong>di</strong> lavoro può<br />
essere un tassello <strong>di</strong> un più ampio<br />
progetto incasellato dall’acronimo<br />
“buona me<strong>di</strong>cina”. Noi stessi<br />
«...dobbiamo smettere <strong>di</strong> dare ad<br />
un bisogno sempre e solo una risposta<br />
chemioterapica...» ma dobbiamo<br />
pensare alto, essere con il<br />
paziente, considerare le sue vere<br />
esigenze e staccarci dalle mille<br />
tentazioni elastiche dei nostri tempi.<br />
Mi chiedo spesso “che farei se<br />
fossi io dall’altra parte?”. Non lo<br />
so, ma le poche volte che sono<br />
stato paziente ho delegato ogni<br />
decisione al collega che mi curava,<br />
che in quel momento ritenevo<br />
essere in grado <strong>di</strong> proporre il meglio<br />
per me.<br />
Oggi facciamo largo uso del<br />
sostantivo “umanizzazione”, come<br />
concetto e come termine più che<br />
come atto pratico, nell’illusione<br />
che umanizzare un percorso <strong>di</strong><br />
cura sia suffi ciente per <strong>di</strong>re che<br />
stiamo facendo buona me<strong>di</strong>cina.<br />
In questo modello terapeutico, che<br />
con<strong>di</strong>vido, è importante «...non ri-<br />
Curare non è solo<br />
un esercizio <strong>di</strong><br />
conoscenze<br />
farmacologiche, così<br />
come la salute non è<br />
solo benessere fisico.<br />
Healing is not only<br />
an exercise of<br />
pharmacological<br />
knowledge, just as<br />
health is not only<br />
physical well-being.<br />
Per il paziente una<br />
<strong>di</strong>agnosi <strong>di</strong> cancro<br />
è come un 11<br />
settembre.<br />
For the patient,<br />
a <strong>di</strong>agnosis of<br />
cancer is like a 9/11.<br />
durre le humanities alle amenities...»,<br />
perché queste non servono<br />
al malato ma al me<strong>di</strong>co.<br />
Il malato desidera solo vivere<br />
e avere un rapporto <strong>di</strong> privilegio col<br />
proprio curante e noi facciamo<br />
buona me<strong>di</strong>cina quando siamo in<br />
grado <strong>di</strong> essere con i malati.<br />
Alla fi ne <strong>di</strong> questo lungo <strong>di</strong>scorso<br />
credo sia inevitabile tornare<br />
al mio me<strong>di</strong>co <strong>di</strong> famiglia d’un<br />
tempo, il caro dottor Romei, perché<br />
la buona me<strong>di</strong>cina oncologica<br />
la si fa quando si è in grado <strong>di</strong><br />
dare all’arte me<strong>di</strong>ca quanto dava<br />
lui ai suoi pazienti <strong>di</strong> sapere, attenzioni<br />
e stima. Ripensando al suo<br />
modo <strong>di</strong> operare e alle volte in cui<br />
sono stato oltre la barricata, ritrovo<br />
a pieno questa frase <strong>di</strong> Sandro<br />
Spinsanti: «Ho un sogno, che nelle<br />
decisioni me<strong>di</strong>che ogni persona<br />
possa proiettare la sua ombra».<br />
Da tutte queste riflessioni<br />
<strong>di</strong>scende la mia proposta <strong>di</strong> Decalogo<br />
della buona me<strong>di</strong>cina. Esso,<br />
se non riguarda la stessa al cento<br />
per cento, perlomeno si avvicina:<br />
1) <strong>di</strong>sponibilità totale al paziente<br />
(ascoltare, visitare, <strong>di</strong>alogare,<br />
esserci, capire, consolare);<br />
2) offrire cure che derivino da<br />
solide conoscenze scientifi che e<br />
attuali;<br />
3) grande capacità <strong>di</strong> comunicazione;<br />
4) con<strong>di</strong>videre le scelte terapeutiche<br />
con il paziente;<br />
5) pensare sempre alla persona<br />
e non solo alla sua malattia;<br />
6) in<strong>di</strong>rizzare con umiltà il paziente<br />
dove possa essere meglio<br />
curato;<br />
7) superare i “livelli essenziali <strong>di</strong><br />
assistenza” con progetti <strong>di</strong> umanizzazione;<br />
8) con<strong>di</strong>videre programmi <strong>di</strong> ricerca<br />
clinica con il paziente;<br />
9) interrompere le cure, senza<br />
fare accanimento, nell’interesse<br />
del paziente e non della struttura<br />
dove si lavora;<br />
10) non usare la me<strong>di</strong>cina <strong>di</strong>fensiva.<br />
«Ho imparato che un uomo ha<br />
il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> guardare dall’alto in basso<br />
un altro essere umano, solo<br />
quando lo aiuta a sollevarsi» (Gabriel<br />
Garcia Marquez).<br />
SALUTE 133
Il senso del non senso<br />
REMO BRACCHI<br />
Or<strong>di</strong>nario <strong>di</strong> Glottologia presso<br />
l’Institutum altioris latinitatis Università<br />
Pontifi cia Salesiana in Roma<br />
Divinità dell’aria e dei<br />
campi, degli ammassi<br />
rocciosi e dei fi umi, erano<br />
considerati in anni<br />
lontani, forse troppo, dai nostri, gli<br />
animali, specialmente i più gran<strong>di</strong><br />
e feroci, talora in carne e ossa,<br />
annidati nelle foreste e improvvisamente<br />
protagonisti <strong>di</strong> incursioni<br />
cruente, altre volte fantastici, ma<br />
non per questo temuti <strong>di</strong> meno.<br />
Piccole bestie e insetti erano fatti<br />
prigionieri dalle mani dei bimbi per<br />
essere inviati come interme<strong>di</strong>ari<br />
tra il regno dei beati e quello dei<br />
mortali, e venivano sospinti con<br />
formule cantilenate a mettersi in<br />
cammino o a prendere il volo per<br />
portare a termine la loro ambasciata.<br />
Una serie <strong>di</strong> fi lastrocche<br />
risulta rivelatrice della segreta missione<br />
un tempo a loro riservata. La<br />
struttura eucologica dei ritmi delle<br />
nenie, ancora leggibile nel frammento,<br />
riconduce a un sottofondo<br />
culturale assai arcaico, concludendosi<br />
in genere con la promessa <strong>di</strong><br />
un dono sacrifi cale (un granello <strong>di</strong><br />
frumento, pane, latte, cacio, vino,<br />
una monetina) o, in caso <strong>di</strong> rifi uto,<br />
con la minaccia <strong>di</strong> una sanzione<br />
estrema, spesso della decapitazione<br />
o della condanna al fuoco.<br />
In Brianza si invita la lucciola<br />
a calare in volo sulla mano, pro-<br />
Coccinella<br />
(Montagna)<br />
Polidòru, gùla in cél,<br />
ca l te sc’péccia san Michél;<br />
san Michél nu sa vegnì:<br />
gùla, gùla da per tì.<br />
134 PROVINCIA IERI E OGGI<br />
The sense of non-sense<br />
Nonsense rhymes are a synthesis of archaic wisdom.<br />
Animals, considered to have remarkable abilities, often appear<br />
in these simple songs. They are chosen accor<strong>di</strong>ng to particular<br />
characteristics, which seemed to be the seal of <strong>di</strong>vinity on their<br />
body, or some unusual behaviour which was interpreted as<br />
responses. For example, in Samolaco, in Valchiavenna, the ladybird<br />
is considered a <strong>di</strong>vinatory animal: the <strong>di</strong>rection it takes is the one<br />
that leads to a sweetheart. In ad<strong>di</strong>tion, the very etymology of<br />
“ filastrocca” (nonsense rhyme, nursery rhyme) refers to the activity<br />
of spinning or weaving, which are typically feminine:<br />
this shows, with the reference to the ancient Goddess-Mothers,<br />
the intervention of the supernatural in human life. In mythology,<br />
the three Fates would spin and weave human existences,<br />
then cutting them like thread.<br />
Maggiolino<br />
(Nembro BG)<br />
Balóres chi gùla,<br />
al ta ciàma la tò murùs´ a,<br />
al ta ciàma ol tò Michél.<br />
Gùla, gùla fi n al cél.<br />
Formicaleone<br />
(Sondalo)<br />
Mónega, mónega del terén,<br />
l’é serén, serenénto:<br />
fam troàr li mìa càura<br />
e li mìa féda in un momént.<br />
Fotolia<br />
mettendole come ricompensa latte<br />
e vino o una custo<strong>di</strong>a accogliente<br />
e sicura nel proprio nido, dove<br />
sarà protetta come la pupilla dell’occhio:<br />
lüsirö vegn de bas, / te<br />
daroo un cügià de latt, / te daroo<br />
un cügià de vin, / te metaroo in del<br />
mè ninìn. L’invito a posarsi è rimasto<br />
fi ssato per sempre in mariposa,<br />
“Maria, posati”, la denominazione<br />
spagnola più nota della farfalla.<br />
Uno dei sinonimi trentini che<br />
ne riverbera l’eco in territorio italiano<br />
è ba´satèra “bacia terra”. In<br />
aragonese paniquesa è un curioso<br />
composto che qualifi ca la “donnola”.<br />
Non è <strong>di</strong>ffi cile scorgere, al <strong>di</strong><br />
sotto della sequenza, i due segmenti<br />
compositivi, pane e cacio, i<br />
due doni degli antichi campagnoli<br />
offerti alla bestiola, temuta per la<br />
sua crudeltà e per la sua astuzia,<br />
allo scopo <strong>di</strong> ingraziarsela, in modo<br />
che passasse a randa del pollaio,<br />
senza insinuarvisi a fare strage.<br />
Una variazione sul medesimo<br />
tema, rintracciata nei Bassi Pirenei,<br />
è panlet, ossia pane e latte.<br />
La semplice tabella sinottica<br />
qui sotto riportata ci aiuta a collocare<br />
a fronte alcuni elementi comuni,<br />
per ricavarne i nessi dall’insieme.<br />
La scelta degli animali chiamati<br />
in gioco si rivela fatta sulla<br />
base <strong>di</strong> qualche loro caratteristica<br />
emergente, capace <strong>di</strong> attirare l’attenzione,<br />
ingenuamente intesa dai<br />
nostri lontani avi come il sigillo <strong>di</strong><br />
una <strong>di</strong>vinità sul loro corpo (la signa-<br />
Formicaleone<br />
(Poggiridenti)<br />
Trìpa, trìpa,<br />
cinch curtèi a la tu vìta:<br />
ün de scià, ün de là.<br />
Sòlta fò dä lä tu cà.<br />
Formica rossa<br />
(Montagna)<br />
Vén, vén,<br />
maiapàn,<br />
che te dò<br />
n tuchèl de pan.
tio rerum), o in considerazione <strong>di</strong><br />
qualche comportamento insolito<br />
che poteva essere interpretato<br />
come un responso. Entrano in<br />
questa categoria la lepre, la lince,<br />
la donnola, l’ermellino, la lontra, gli<br />
uccelli notturni, il cuculo, i rettili in<br />
genere, la farfalla, la cavalletta, la<br />
mantide religiosa, il cervo volante,<br />
la cetonia, il maggiolino, l’elaterio,<br />
la lucciola, la coccinella, l’onisco, il<br />
formicaleone, la forbicina e numerose<br />
altre specie.<br />
Il chiamare in causa una bestia,<br />
quasi fosse in grado <strong>di</strong> comprendere<br />
il linguaggio umano, rientrava<br />
pienamente in quell’arcaico<br />
quadro nel quale i confi ni fra i tre<br />
regni della natura non conoscevano<br />
ancora barriere inequivocabilmente<br />
incompatibili fra loro. Perciò<br />
dagli animali ci si attendevano reazioni<br />
simili a quelle manifestate<br />
dagli uomini, <strong>di</strong> simpatia o <strong>di</strong> ostilità,<br />
ed era necessario trattare con<br />
loro secondo co<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> comportamento<br />
improntati a grande rispetto.<br />
In modo ancora suffi cientemente<br />
<strong>di</strong>afano le fi lastrocche, quando<br />
non ci siano pervenute del tutto<br />
frammentarie, rappresentano<br />
spezzoni consistenti <strong>di</strong> antiche<br />
preghiere, inserite un tempo come<br />
sezioni irrinunciabili <strong>di</strong> rituali che<br />
noi dobbiamo limitarci a presupporre,<br />
dal momento che nessuno<br />
<strong>di</strong> essi ha avuto l’avventura <strong>di</strong><br />
giungere fi no a noi in questa veste<br />
sacrale e nel suo contesto liturgico.<br />
Per la Valtellina e la Valchiavenna,<br />
come per ogni altro angolo del<br />
villaggio globale, se ne potrebbero<br />
citare <strong>di</strong>versi esemplari, a commento<br />
dei motivi che hanno determinato<br />
l’assegnazione a tassonomie<br />
funzionali per noi assolutamente<br />
enigmatiche <strong>di</strong> numerosi<br />
animaletti che furono capaci <strong>di</strong><br />
suscitare l’interesse dell’uomo primitivo<br />
per qualche loro caratteristica,<br />
ma qui ci troviamo costretti dal<br />
tema scelto ad attenerci a quelli<br />
soltanto a carico dei quali traspaia<br />
qualche venatura <strong>di</strong> sgomento o <strong>di</strong><br />
timore reverenziale come sintomo<br />
<strong>di</strong> tabuizzazione.<br />
A Montagna il nome con il<br />
quale si è voluto designare la “coccinella”<br />
è pulidòru. Dal confronto<br />
con altre denominazioni confi na-<br />
L’invito a posarsi è<br />
rimasto fissato per<br />
sempre in mariposa,<br />
“Maria, posati”, la<br />
denominazione<br />
spagnola più nota<br />
della farfalla.<br />
The invitation to<br />
“touch down”<br />
(“posarsi”) has<br />
remained forever in<br />
mariposa, “Maria,<br />
posati”, the best<br />
known Spanish word<br />
for the butterfly.<br />
Nella pagina a<br />
fianco: in Brianza si<br />
invita la lucciola a<br />
calare in volo sulla<br />
mano con la<br />
promessa <strong>di</strong> latte<br />
e vino.<br />
On the facing page:<br />
in Brianza the firefly<br />
is invited to land<br />
on the hand with<br />
the promise of milk<br />
and wine.<br />
NOTIZIARIO<br />
Provincia<br />
ieri e oggi<br />
Il chiamare in causa<br />
una bestiola<br />
rientrava in<br />
quell’arcaico quadro<br />
nel quale i confini<br />
fra i tre regni della<br />
natura non<br />
conoscevano ancora<br />
barriere<br />
inequivocabilmente<br />
incompatibili fra loro.<br />
Calling into question<br />
an animal was fully<br />
part of that archaic<br />
picture where the<br />
borders between the<br />
three kingdoms of<br />
nature <strong>di</strong>d not yet<br />
have those<br />
unequivocally<br />
incompatible barriers<br />
between them.<br />
rie, si è indotti a spiegarlo come<br />
un composto dall’appellativo comune<br />
pula “pollastra”, ripreso<br />
dall’animale domestico, ma a<br />
buon conto ritoccato col ricorso<br />
alla terminazione affettiva in -i (si<br />
veda per esempio il trepallino barbi-róca<br />
“<strong>di</strong>avolo”, composto col<br />
parentelare bàrba “zio”, defi nito <strong>di</strong><br />
famiglia, per <strong>di</strong>fendersi dallo spirito<br />
del male), e dalla qualifica<br />
“d’oro”, che polarizza intorno a sé<br />
tutto ciò che <strong>di</strong> positivo si può immaginare.<br />
L’insetto è invitato a<br />
prendere il volo da una fi lastrocca<br />
ripetuta in coro dai fanciulli: Polidòru,<br />
gùla in cél, / ca l te sc’péccia<br />
san Michél; / san Michél nu sa vegnì:<br />
/ gùla, gùla da per tì, “coccinella,<br />
vola in cielo, che ti aspetta san<br />
Michele; san Michele non sa venire:<br />
vola, vola solitaria”. A pochi<br />
chilometri <strong>di</strong> <strong>di</strong>stanza, a Ponte, si<br />
riecheggia in modo simile: Pòla,<br />
pòla, gùla n cél, / che l te ciàma san<br />
Michél, / san Michél l’è andàc’ a<br />
Pavìa, / pòla, pòla, gùla vìa.<br />
Come sinonimo a Mazzo è<br />
tramandata la variante puàza, nella<br />
quale si riconosce una rimessa<br />
in campo, a causa <strong>di</strong> intersezioni<br />
fonetiche e <strong>di</strong> tangenzialità spesso<br />
misteriose nelle conoscenze entomologiche,<br />
del tipo puàza “maggiolino”,<br />
che si incontra altrove.<br />
Dal punto <strong>di</strong> vista strutturale, ci<br />
troviamo <strong>di</strong> fronte a una formazione<br />
suffissata, rispetto a pó(i)a<br />
“coccinella” attestata a Teglio nella<br />
sua forma semplice, a Castionetto<br />
póla, con l’attesa vocale tonica<br />
stretta, a Chiuro pùla “coccinella”,<br />
a Premana polalìin dol Segnóor<br />
“coccinella”, “pulcino del<br />
Signore”, con la quale i bambini<br />
giocavano, lasciandosela correre<br />
Fotolia<br />
Fotolia<br />
sulle mani e giocare a rimpiattino<br />
tra le <strong>di</strong>ta. A Grosotto incontriamo<br />
la variante pòna, forse per il riecheggiamento<br />
<strong>di</strong> un antico nesso<br />
con Madòna. La bestiola è qui<br />
chiamata sulla palma per essere<br />
inviata verso il regno dell’azzurro:<br />
Pòna, pòna, van in cél, / che l te<br />
ciàma san Michél. / San Michél l’é<br />
´sgià nàc’ lè: / pòna, pòna, van a<br />
chè, “San Michele se n’è già andato<br />
via: coccinella, torna a casa”.<br />
Nel villaggio che ha dato il nome<br />
alla Valtellina, la cantilena recitata<br />
per inviare l’insetto come messaggero<br />
dei mortali a coloro che abitano<br />
sopra le tempeste non si <strong>di</strong>scosta<br />
<strong>di</strong> molto dal copione: Puàza,<br />
puàza, van al cél, / che l te ciàma<br />
san Michél. / San Michél al völ<br />
mìga vegnì. / Puàza, puàza, van de<br />
per tì! La variante loverina è pòla e<br />
la fi lastrocca per invitarla a volare<br />
oltre la cortina delle nuvole suona:<br />
Pòla, pòla, va n del cél, / che l ta<br />
mànda san Michél; / san Michél l’è<br />
già partì, / pòla, pòla, van par tì.<br />
Quasi identica quella <strong>di</strong> Tresivio:<br />
Pòla, pòla, göla in cél, / che l te<br />
ciàma san Michél; / san Michél nu<br />
m sa vegnì, / göla, göla da per ti.<br />
Con attribuzione più specifi ca<br />
alla sfera sacrale, ad Albosaggia la<br />
“coccinella” è definita galinèla,<br />
galìna del Signór, a Campo pégura<br />
de la Madòna, “pecorella della<br />
Madonna”, a Tàrtano fràa, “frate”,<br />
nel <strong>di</strong>aletto <strong>di</strong> Surselva bàu Niességner,<br />
bàu Nossadùnna “coccinella”,<br />
in senso letterale “insetto del<br />
Signore, della Madonna”, nel gen.<br />
induvinellu, “indovinello”, probabilmente<br />
nel senso agentivo <strong>di</strong> “piccolo<br />
indovino, piccolo mago” o<br />
anche in quello risultativo <strong>di</strong> “pronostico”.<br />
Un frammento <strong>di</strong> filastrocca<br />
riverbera la propria striatu-<br />
PROVINCIA IERI E OGGI 135
a anche nelle singolari denominazioni<br />
tabarchine dell’insetto: a Calasetta<br />
minindé, in modo più <strong>di</strong>a fano<br />
a Carloforte duminindé, da Domine<br />
Deus, invocazione alla <strong>di</strong>vinità. A<br />
Lanzada si è ricorsi alla personifi -<br />
cazione, assegnando al piccolo<br />
coleottero il nome <strong>di</strong> caterìne, forse<br />
come spezzone iniziale superstite<br />
<strong>di</strong> un’antica cantilena, intesa<br />
a evocare il piccolo messaggero<br />
delle altezze. In alcuni <strong>di</strong>aletti settentrionali<br />
l’insetto appare infatti<br />
con il signifi cativo designante <strong>di</strong><br />
marìa vola.<br />
A Samòlaco, all’imboccatura<br />
della Valchiavenna, anche il maggiolino<br />
era considerato una bestiola<br />
<strong>di</strong>vinatoria. I ragazzi legavano<br />
alle loro zampette un fi lo e sollecitavano<br />
il rumoroso coleottero a librarsi<br />
nell’aria. La <strong>di</strong>rezione che il<br />
messaggero avrebbe presa sarebbe<br />
stata interpretata come in<strong>di</strong>cazione<br />
del percorso da seguire per<br />
muoversi alla ricerca della futura<br />
fi danzata. Il nome assegnatogli <strong>di</strong><br />
fi lamùur è probabilmente da decifrare<br />
come un composto imperativale,<br />
l’inizio del comando <strong>di</strong> partire,<br />
srotolando il fi lo magico: “Fila<br />
(il perfetto) amore!”. Una conferma<br />
in<strong>di</strong>retta ci è fornita da una cantilena<br />
bergamasca (raccolta a Nembro,<br />
dove la Valseriana sfocia al<br />
piano): Balóres chi gùla, / al ta<br />
ciàma la tò murù´sa, / al ta ciàma<br />
ol tò Michél. / Gùla, gùla fi n al cél,<br />
“maggiolino che vola, ti chiama la<br />
tua fi danzata, ti chiama il tuo Michele.<br />
Vola, vola fino al cielo”.<br />
L’arcangelo san Michele, così ricorrente<br />
nelle fi lastrocche, era raffi gurato<br />
nelle chiese della valle con<br />
una bilancia in mano, intento a<br />
pesare le anime. Egli stesso, come<br />
psicopompo, le avrebbe poi<br />
guidate verso le <strong>di</strong>more eterne.<br />
Il Garbini ha raccolto a Chiavenna<br />
fi lamór a nell’accezione <strong>di</strong><br />
“mantide religiosa”, concetto ricorrente<br />
nella defi nizione dell’ortottero<br />
in varie località e spiegato dalla<br />
nenia che ripetono i ragazzi siciliani:<br />
Filannera, chi fa tò mamma: fi la<br />
o tessi?, arguendo poi se fili o<br />
tessa dalla maniera in cui la bestiola,<br />
tenuta in mano, muove le<br />
zampe anteriori per <strong>di</strong>vincolarsi e<br />
<strong>di</strong>fendersi. Dall’invito a “cercare<br />
136 PROVINCIA IERI E OGGI<br />
l’amore”, volando dalla palma verso<br />
la <strong>di</strong>rezione che l’insetto indovino<br />
soltanto conosce, <strong>di</strong>pende assai<br />
probabilmente anche l’abr. cëcamóre,<br />
“coccinella”, “cerca amore”.<br />
Lo confermano le strofette<br />
popolari propagginatesi nei giochi<br />
dei ragazzi, quando sollecitano<br />
l’insetto catturato a prendere il<br />
largo sul fi lo della brezza che scorre<br />
loro incontro: Catarënèlla, catarënèlla,<br />
/ vann’a truvà l’amóra<br />
bèllë, / ggìrë dë llà, ggìrë dë nguà:<br />
/ va vvëdé addónna sta, “Caterinella,<br />
Caterinella, va’ a scoprire l’amore<br />
bello, gira <strong>di</strong> là, gira <strong>di</strong> qua, va’<br />
a vedere dove sta”; Ciavëlarèllë<br />
[composto probabilmente con “uccello”<br />
e “volare”, “volarello”] vólë,<br />
vólë, / sàccëm’asddìcë addó sc’tà<br />
l’amóre: / o da cquà o da llà, /<br />
sàccëm’ad<strong>di</strong>cë addónna sc’ta, “Uccello<br />
volarello, vola, vola, sappimi<br />
<strong>di</strong>re dove sta l’amore: o <strong>di</strong> qua o <strong>di</strong><br />
là, sappimi <strong>di</strong>re dove sta”.<br />
A Mazzo, per spingere il coleottero<br />
a levarsi in alto, si ripete<br />
la fi lastrocca: Puàza, puàza, van al<br />
cél, / che l te ciàma san Michél. /<br />
San Michél al völ mìga vegnì: /<br />
puàza, puàza, van (de) per tì, riecheggiando<br />
una formula applicata<br />
anche ad altri ambasciatori delle<br />
soglie <strong>di</strong> ametista. Il tipo puàza<br />
Fotolia<br />
Anche il maggiolino<br />
era considerato una<br />
bestiola <strong>di</strong>vinatoria,<br />
fatta prigioniera<br />
dalle mani dei bimbi<br />
per essere inviata<br />
come interme<strong>di</strong>aria<br />
tra il regno dei beati<br />
e quello dei mortali.<br />
The ladybird was<br />
also considered a<br />
<strong>di</strong>vinatory animal,<br />
captured in the<br />
hands of children<br />
to be sent as an<br />
interme<strong>di</strong>ary between<br />
the kingdom of the<br />
blessed and that<br />
of mortals.<br />
“maggiolino”, <strong>di</strong>ffuso pure a Lovero,<br />
rappresenta molto probabilmente<br />
un compromesso tra pùla<br />
“pollastra” e cugàza, ossia “codaccia”,<br />
attributo scorrente dal <strong>di</strong>spluvio<br />
demonizzato. A Novate Mezzola<br />
si segnala infatti pòla come nome<br />
del “maggiolino”, con la vocale<br />
tonica larga, presumibilmente per<br />
esigenze <strong>di</strong> rima più perfetta nell’inserzione<br />
in qualche fi lastrocca,<br />
mentre altrove, come si è visto<br />
sopra, lo stesso appellativo si<br />
presenta come designazione della<br />
“coccinella”.<br />
Un composto imperativale<br />
del tutto trasparente compare in<br />
saltamartìn, la denominazione della<br />
“cavalletta” più <strong>di</strong>ffusa in entrambi<br />
i bacini imbriferi dell’Adda e<br />
della Mera e vastamente traboccante<br />
nelle aree contermini: borm.,<br />
piatt. saltamartìn “cavalletta, locusta”,<br />
gros. saltamartìn “cavalletta”<br />
e “trottola”, Valle Olona saltamartén<br />
“locusta, mantide, grillo”, vares.<br />
saltemartìn, saltemartìtt “cavalletta”,<br />
mil. saltamartìn, saltamàrt,<br />
pav. saltamartei “cavalletta,<br />
locusta”, bresc. saltamartì<br />
“locusta, cavalletta”, tic. saltamartìn,<br />
saltamartégn, saltamartìgn, saltemartìn,<br />
sautramartìn, soltamartìn<br />
“saltamartino, cavalletta e altri insetti<br />
affi ni; formicaleone”, per traslato<br />
“ragazzo, in<strong>di</strong>viduo piccolo,<br />
magro, agile, irrequieto, volubile;<br />
persona che cambia spesso lavoro,<br />
che manca <strong>di</strong> parola, che parla<br />
in modo sconclusionato, saltando<br />
<strong>di</strong> palo in frasca; tipo <strong>di</strong> giocattolo<br />
per bambini; mazzeranga, pestello<br />
usato per comprimere e rassodare<br />
il selciato”, trent. (Roncone) saltamartìn<br />
“cavalletta, locusta, Locusta<br />
viri<strong>di</strong>ssima e congeneri”, ver.<br />
saltamartìn “cavalletta; gambalunga,<br />
saltabecca; larva dello stiantino”,<br />
regg. Seltamartèin “cavalletta,<br />
locusta”, valenz. saltamartí.<br />
A <strong>di</strong>fferenza degli insetti alati,<br />
la cavalletta si muove al suolo per<br />
lo più balzando. L’invito a partire le<br />
viene perciò rivolto adattandosi<br />
alle sue preferenze. Talora il secondo<br />
segmento compositivo muta,<br />
in considerazione del luogo <strong>di</strong><br />
partenza, o sotto l’infl usso <strong>di</strong> altre<br />
suggestioni, mentre il comando<br />
rimane identico, sia che venga
espresso col medesimo verbo, sia<br />
che venga affi dato a un suo sinonimo:<br />
tic. saltafén, saltefén “cavalletta”,<br />
“salta fieno”, friul. saltapayusk<br />
“salta pagliuzze”, Cabbio,<br />
Muggio saltabósch “cavalletta, locusta”;<br />
béarn. saltaprat, astur. saltapraos,<br />
spagn. saltamatos, saltamontes;<br />
abr. jundamartìnë “cavalletta”<br />
(dal lat. *iǔncta - re “saltare a<br />
pie<strong>di</strong> giunti”); it. saltacavalla “cavalletta”,<br />
con ritorno alla metafora<br />
dell’equino, folign. saltamula, appenn.<br />
bol. saltabécco “cavalletta”<br />
per sostituzione dell’animale preso<br />
come paragone, fr. mer. saltabuk;<br />
Mergoscia saltabèca “specie<br />
<strong>di</strong> cavalletta”, reinterpretato come<br />
“salta (e) becca”, it. saltabecca;<br />
Gandria saltamartèla “cavalletta”,<br />
forse “salta e martella”; Assisi,<br />
Amelia salta picchio, march., tic.<br />
(Bruzella) saltamósch “cavalletta”;<br />
umbro saltalippo, probabilmente<br />
composto in seconda sede coll’ipocoristico<br />
del personale “Filippo”,<br />
ancon. salippo, perug. cont. saléppico<br />
“cavalletta”, Terni saltazìppuro<br />
(DEI 5,3323); picc. grãper sotö<br />
“cavalletta”, “nonno saltatore”,<br />
con risvolto parentelare.<br />
Lo stesso composto è trasmesso<br />
per osmosi ad altri insetti<br />
salterini, in primo luogo al metallico<br />
“elaterio”. Ne troviamo testimonianza<br />
nel sondal. saltamartìn, con<br />
la variante agionimica sanmartìn<br />
“elaterio”, nel chiav. (Gordona) solatamartìn<br />
“elaterio”, nello zold.<br />
sautamartìn, nel friul. saltemartin<br />
“coleottero”, nel guastall. saltamartìn<br />
“elaterio”, nel sen. e tosc.<br />
saltamartino “elaterio”. A Monte<br />
sopra Morignone è apostrofato<br />
come sanmartìn, mentre a Tola,<br />
poco sotto, nella valle, porta il<br />
nome <strong>di</strong> santacaterìna, l’inizio<br />
dell’invocazione, con la quale lo si<br />
inviava verso il solito varco tra i<br />
nembi, ripetendo cadenzatamente<br />
a più riprese: santacaterìna, ´sg’gòla<br />
in cél, / che l te c(h)iàma san<br />
Michél. Tanto la personalizzazione,<br />
quanto il ricorso all’agionimo sono<br />
sintomi <strong>di</strong> una considerazione <strong>di</strong><br />
privilegio riservata all’insetto, consultato<br />
pure per conoscere dal suo<br />
balzo, quando è rovesciato, un responso<br />
su un interrogativo dai due<br />
esiti, come si fa quando si sfoglia<br />
Fotolia<br />
insetti alati, la<br />
cavalletta, come la<br />
mantide, si muove al<br />
suolo per lo più<br />
balzando. L’invito a<br />
partire le viene<br />
perciò rivolto<br />
adattandosi alle sue<br />
preferenze.<br />
Unlike winged<br />
insects, the<br />
grasshopper, like the<br />
praying mantis,<br />
moves on the ground<br />
mainly by jumping.<br />
Inviting it to leave is<br />
therefore made by<br />
adapting to its<br />
preferences.<br />
Fotolia A <strong>di</strong>fferenza degli<br />
una margherita. A Sonogno il piccolo<br />
coleottero è chiamato chessì,<br />
perché i fanciulli, giocando, mettevano<br />
alla prova le sue capacità <strong>di</strong>vinatorie<br />
(cf. palerm. anniminagghia<br />
“elaterio”, voce che vale anche “indovinello”,<br />
dal lat. tardo *in<strong>di</strong>vīna -<br />
re “leggere nel pensiero degli<br />
dei”, perché i ragazzi traevano<br />
pronostici dai movimenti della bestiola<br />
sul ritorno dei padri dalla<br />
pesca), osservando le affermazioni<br />
del capo, interpretate come una<br />
sua risposta <strong>di</strong> conferma: che sì.<br />
Gli si deve probabilmente affi ancare<br />
anche il verz. cìco <strong>di</strong> sì “specie<br />
<strong>di</strong> coleottero”, “insetto del sì”.<br />
Nel gergo dei magnani <strong>di</strong> Lanzada<br />
soltomartìn è la “pulce”, a<br />
Revine saltamartìn il “martin pescatore”.<br />
Ricorrendo alle due componenti<br />
rovesciate nella loro successione,<br />
si è plasmato a Bianzone,<br />
oltre Tirano, il nome del “formicaleone”,<br />
martin-scé´sa, da interpretarsi,<br />
in modo parallelo, come un<br />
invito alla bestiola personifi cata:<br />
“Martino, arretra”. Il segmento<br />
verbale è desunto dal lat. cěssa - re<br />
“ritirarsi”. Dopo aver scavata la<br />
propria buca, ammonticchiando<br />
su un lato il cumulo dei granelli in<br />
bilico, pronti a franare al più piccolo<br />
urto come il contenuto <strong>di</strong> una<br />
clessidra, l’insetto si ritira in fondo<br />
alla fossa in attesa della preda. La<br />
forma imperativale appare come<br />
una sollecitazione ad acquattarsi<br />
nel suo nascon<strong>di</strong>glio per non lasciarsi<br />
scoprire dall’eventuale vittima,<br />
mandando a vuoto l’insi<strong>di</strong>a.<br />
L’animaletto viene così blan<strong>di</strong>to<br />
col porsi dalla sua parte, per accon<strong>di</strong>scendenza<br />
empatica. I piccoli<br />
bianzonaschi infi lavano uno stecchino<br />
nella buca dell’insetto, ripetendo<br />
a intervalli cadenzati:<br />
martinscé´sa, scé´sa indré “ritirati,<br />
retroce<strong>di</strong>”. Alle bestiole sparute<br />
che si rintanano nella terra erano<br />
commissionate ambascerie in<strong>di</strong>rizzate<br />
alle <strong>di</strong>vinità ctonie, delegandole<br />
quali interme<strong>di</strong>arie verso il regno<br />
dei morti. L’invito a retrocedere<br />
poteva costituire un mandato <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>scesa verso il gorgo delle ombre.<br />
A Poggiridenti per defi nire la<br />
“larva del formicaleone” è stato<br />
segnalato l’appellativo trìpa. Per<br />
farla uscire dalla tana, anche qui<br />
si riteneva che fosse necessario<br />
ricorrere a una fi lastrocca <strong>di</strong> velata<br />
minaccia (l’amputazione del capo),<br />
ritmicamente scan<strong>di</strong>ta, quasi certamente<br />
sopravvissuta come momento<br />
culminante <strong>di</strong> un antico<br />
formulario magico: Trìpa, trìpa, /<br />
cinch curtèi a la tu vìta: / ün de scià,<br />
ün de là. / Sòlta fò dä lä tu cà.<br />
Forse anche in questo caso bisogna<br />
presupporre alla base dell’etimologia<br />
una motivazione analoga,<br />
partendo dal verbo germ. *trippo - n<br />
“saltare”, che ha lasciato numerosi<br />
continuatori nell’Italia settentrionale<br />
e altrove. Nella parlata <strong>di</strong> Samòlaco<br />
trépa è il “segno tracciato<br />
nell’erba strisciando il piede, prima<br />
<strong>di</strong> iniziare lo sfalcio, al fi ne <strong>di</strong> evidenziare<br />
il limite <strong>di</strong> proprietà per<br />
prevenire involontari sconfi namenti”.<br />
L’alone magico che si addensa<br />
intorno all’insetto è comprovato<br />
anche dalla personalizzazione rilevata<br />
dal ricorso al nome proprio<br />
caterinèta con il quale esso è conosciuto<br />
a Grosio, caterinéta a<br />
Grosotto, caterìn(n)a o anche caterinnadelavàl<br />
a Montagna, “Caterina<br />
della valle”, incipit decapitato <strong>di</strong><br />
una <strong>di</strong>ffusa cantilena, e da quello<br />
più generico <strong>di</strong> mónega “formicaleone”<br />
con cui lo si defi nisce a Sóndalo.<br />
Qui è sfuggita all’oblio una<br />
sequenza che si cantillava, per<br />
farsi in<strong>di</strong>care dal piccolo indovino<br />
la <strong>di</strong>rezione verso la quale ci si<br />
sarebbe dovuti muovere alla ricerca<br />
delle bestie smarrite al pascolo:<br />
Mónega, mónega del terén, / l’é<br />
serén, serenénto: / fam troàr li mìa<br />
càura e li mìa féda in un momént,<br />
“monaca, monachella del terreno,<br />
è sereno, sereno limpido. Fammi<br />
trovare in un attimo le mie capre e<br />
le mie pecore” (Dario Cossi). Assai<br />
più inquietante si rivela la raffi gurazione<br />
presupposta dal pav.<br />
PROVINCIA IERI E OGGI 137
<strong>di</strong>àvol <strong>di</strong> formìgh “formicaleone,<br />
larva del Myrmeleon formicarius”<br />
(Gambini 81).<br />
Il composto imperativale<br />
gros. pe´sasàs per identifi care la<br />
“larva della friganea, Phryganea<br />
rhombica” rappresenta probabilmente<br />
una voce <strong>di</strong> importazione,<br />
me<strong>di</strong>ata dal linguaggio dei pescatori,<br />
che la usavano come esca. La<br />
motivazione del nome si ritrova nel<br />
rivestimento intessuto <strong>di</strong> piccoli<br />
frammenti <strong>di</strong> pietra, saldati tra loro<br />
a forma <strong>di</strong> astuccio protettivo, entro<br />
il quale si rintana. La struttura<br />
della voce sembra riecheggiare, al<br />
suo inizio, l’incipit <strong>di</strong> una fi lastrocca,<br />
in<strong>di</strong>rizzata alla bestiola per invitarla<br />
a misurare il proprio carico.<br />
Il termine autoctono dovrebbe invece<br />
essere rappresentato dal<br />
gros. ga´sòtul “portasassi”, dato il<br />
suo riaffi oramento quasi identico<br />
a Villa <strong>di</strong> Chiavenna nella variante<br />
ca´sòtul “involucro sabbioso del<br />
portasassi” che, tanto per la sua<br />
oscillazione fonetica, quanto per la<br />
puntualizzazione semantica, invita<br />
a in<strong>di</strong>rizzare senza eccessive esitazioni<br />
l’indagine etimologica verso<br />
il lat. casa “capanna, abitazione,<br />
rifugio”.<br />
Forse anche nel tipo “trottapiano”<br />
si rifrange un originario comando<br />
rimasto privo <strong>di</strong> altre in<strong>di</strong>cazioni,<br />
rivolto a uno dei parassiti<br />
dell’uomo, ritenuti più fasti<strong>di</strong>osi e<br />
più umilianti: livign. trotaplàn generalmente<br />
al plurale “pidocchi”,<br />
borm. trotapiàn. L’imposizione a<br />
muoversi lentamente potrebbe<br />
rappresentare, in questo caso,<br />
uno scongiuro, la richiesta cioè <strong>di</strong><br />
rimanere lontano, <strong>di</strong> tenersi alla<br />
larga. Il risvolto demoniaco si riscopre<br />
attraverso l’evoluzione semantica<br />
affi orante nel trep. trotaplàn<br />
“spauracchio evocato per spaventare<br />
i bambini”.<br />
Al contrario, nel composto<br />
montagn. maiapàn, mangiapàn,<br />
imbastito per defi nire la “grossa<br />
formica rossa che ni<strong>di</strong>fi ca nel tronco<br />
dei castagni”, potrebbe profi larsi<br />
la cristallizzazione dell’invito a<br />
presentarsi per ricevere il dono in<br />
vista <strong>di</strong> una commissione ad essa<br />
affi data, da far giungere nel regno<br />
silenzioso del sottoterra. Anche<br />
per questa bestiola viene infatti<br />
138 PROVINCIA IERI E OGGI<br />
ripetuta una cantilena,<br />
intesa a chiamarla vicino<br />
per pre<strong>di</strong>sporla all’invio:<br />
Vén, vén, maiapàn, /<br />
che te dò n tuchèl de<br />
pan, “vieni, vieni, mangiapane,<br />
che ti darò un tozzo <strong>di</strong> pane”. Con<br />
il latte e il vino, l’impasto <strong>di</strong> frumento<br />
compare tra i più <strong>di</strong>ffusi<br />
doni sacrifi cali messi in serbo per<br />
le <strong>di</strong>vinità dei campi o per i loro<br />
messaggeri. Potrebbe rivelarsi<br />
analoga la combinazione dei due<br />
segmenti che formano il composto<br />
tresiv. pizaséghel “luì”, “becca<br />
segale”.<br />
Nella variante furbe´sìna della<br />
Val Gerola (IT 27,54) sembra <strong>di</strong><br />
cogliere, al <strong>di</strong> là della normale<br />
evoluzione della vocale pretonica,<br />
un’allusione larvata a furba. A<br />
Montagna vi fa eco furbe´séta e le<br />
si canta una fi lastrocca simile a<br />
quella che circola altrove per l’arrotino,<br />
invitandola ad affi lare le<br />
sue forbici: ´Zin, ´zéta, / furbe´séta, /<br />
cinch quatrìn, fàla mulà: / ün de<br />
préda e ün de sas / e l galét l’é a<br />
remulàz, “il galletto è (a pascersi)<br />
<strong>di</strong> foglie <strong>di</strong> ravanello”. In alta Valcamonica<br />
il ritocco fonetico investe<br />
la concezione stessa dell’insetto,<br />
presentandosi ad<strong>di</strong>rittura nella<br />
forma fùria “forfecchia”. Si dovrà<br />
tener presente tuttavia che qui il<br />
verbo furà signifi ca “pungere, bucare”<br />
(Goldaniga 1,409-410).<br />
Una constatazione conturbante<br />
si affaccia con evidenza<br />
a chi, mentre li va collezionando,<br />
ponga attenzione agli ingre<strong>di</strong>enti<br />
delle fi lastrocche. La citazione<br />
della morte è ricorrente in<br />
più <strong>di</strong> una <strong>di</strong> queste cantilene, che<br />
pure a prima vista si <strong>di</strong>rebbero<br />
giocose. È probabile che la conce-<br />
Dopo aver scavata la<br />
propria buca,<br />
ammonticchiando su<br />
<strong>di</strong> un lato il cumulo<br />
dei granelli in bilico,<br />
il formicaleone si<br />
ritira in fondo alla<br />
fossa in attesa della<br />
preda.<br />
After having dug its<br />
hole, piling up on<br />
one side the grains<br />
in precarious<br />
balance, the antlion<br />
withdraws to the<br />
bottom of the trench<br />
waiting for its prey.<br />
Anche per la “grossa<br />
formica rossa” viene<br />
ripetuta una<br />
cantilena.<br />
A lullaby is also<br />
sung for the<br />
“ fat red ant”.<br />
Fotolia<br />
zione dei piccoli protagonisti come<br />
messaggeri tra gli uomini e le <strong>di</strong>vinità<br />
della natura li ritenesse anche<br />
in grado <strong>di</strong> varcare liberamente la<br />
soglia che <strong>di</strong>vide noi dal regno dei<br />
trapassati per raccogliere dalla<br />
loro bocca una conferma <strong>di</strong> quella<br />
sopravvivenza della quale godono<br />
presso Dio e per portare loro la<br />
testimonianza del ricordo da parte<br />
<strong>di</strong> chi, durante il cammino verso il<br />
defi nitivo congiungimento con loro,<br />
continua a nutrirsi <strong>di</strong> pane.<br />
«A nessuno può sfuggire che<br />
tra fi la, fi latura e fi lastrocca c’è un<br />
[tema] a testimoniare la loro affi nità<br />
profonda. Non si fi lava soltanto<br />
la lana, ma si fi lavano anche i<br />
pensieri, le idee, le storie, oppure<br />
le rime, le fi lastrocche, le ninne<br />
nanne. Se la fi la deriva dall’attività<br />
<strong>di</strong> fi latura delle donne durante la<br />
veglia, può darsi che la fi lastrocca<br />
<strong>di</strong>scenda, linguisticamente, proprio<br />
dall’operazione iterata <strong>di</strong> queste<br />
api operose che si affaccendavano<br />
con gesti rapi<strong>di</strong> e millenari<br />
intorno al lavoro dei fusi (canapa,<br />
lino, lana) ma, contestualmente,<br />
percorrevano anche gli itinerari<br />
della comunicazione. Il fuso torna<br />
spesso… Le tre antiche Parche (o<br />
quattro, a seconda dei riaffi oramenti)<br />
mantengono signifi cativamente<br />
una presenza costante e<br />
millenaria nelle fi lastrocche. Ormai<br />
sono state trasformate dal lavorìo<br />
culturale della stratifi cazione in fi -<br />
gure meno suggestive, dalle qualità<br />
meramente umane o animali,<br />
ma noi sappiamo che questo<br />
“spostamento” non ne ha avvilito<br />
il senso profondo. Il bulino culturale,<br />
in particolare quello religioso,<br />
non le ha annientate anche se le<br />
ha indotte ad assumere vesti meno<br />
sgargianti, o a ripiegare sull’analogia<br />
animale. Così Clotho,<br />
Lachesis e Athropos hanno vestito<br />
i panni delle fi latrici impegnate,<br />
delle pulzelle che fi lano, avvolgono<br />
matasse, tagliano (o impastano) o<br />
delle civette [o scimmiette] arroccate<br />
sul comò. La loro matrice è<br />
comunque persistente e trasparente.<br />
Le donne della fi la costituiscono<br />
anch’esse una <strong>di</strong>nastia<br />
ulteriore <strong>di</strong> Parche. Anch’esse<br />
fi lano, avvolgono, recidono. Anche<br />
loro hanno potere <strong>di</strong> vita e <strong>di</strong> mor
te, inconsapevolmente, nelle formule<br />
che fi lano sommessamente<br />
da generazioni. Il senso <strong>di</strong> quelle<br />
rime era oscuro, incomprensibile,<br />
ma sicuramente quei suoni accordati<br />
da compositori arcaici suscitavano<br />
brivi<strong>di</strong> <strong>di</strong> suggestione e <strong>di</strong><br />
piacere» (Lavaroni, 28; cf. inoltre<br />
48, n. 37, 59, 60-61, 112-113).<br />
«Nelle fi lastrocche compaiono<br />
anche le <strong>di</strong>vinità lunari che sono<br />
notoriamente tre: le Moire greche,<br />
le Parche latine o le Norne<br />
nor<strong>di</strong>che. Esse vengono identifi cate<br />
come le dee del destino, del<br />
fato superiore e ineluttabile. Sono<br />
rappresentate come delle fi latrici<br />
che misurano a loro piacimento la<br />
vita degli uomini e in<strong>di</strong>cano gli<br />
sta<strong>di</strong> temporali <strong>di</strong> ogni <strong>di</strong>venire:<br />
nascita-vita-morte, passato-presente-futuro.<br />
Sono tre sorelle, una<br />
delle quali presiede alla nascita,<br />
l’altra al matrimonio avvolgendo il<br />
fi lo [ecco il perché del cappello da<br />
sposa e dell’invocazione per avere<br />
un bel bambino], la terza alla morte,<br />
tagliandolo: [friul.] Din-don, / tre<br />
pulgetis sul balcòn: / une’a file,<br />
une’a daspe, / une’a fas pipin <strong>di</strong><br />
paste [“<strong>di</strong>n don, tre pulzelle sul<br />
balcone: una fi la, una avvolge, una<br />
fa pupazzi <strong>di</strong> pasta”]. Le tre pulgetis<br />
(Moire, Parche, Norne) sono<br />
comunque collegate all’archetipo<br />
del Femminile e al mistero della<br />
fi latura e della tessitura che viene<br />
esperito come proiezione della<br />
Grande Madre che tesse la vita e<br />
fi la la matassa del fato. È questa<br />
la ragione per cui l’azione del fi larefuso<br />
è un attributo <strong>di</strong> tutte le dee<br />
Madri, delle dee lunari e delle dee<br />
che tessono il destino anche nel<br />
loro aspetto terribile; fi gura, questa,<br />
che può essere assimilata a<br />
quella del ragno. Il signifi cato del<br />
tessere – al pari <strong>di</strong> tutto ciò che è<br />
archetipo – comprende un aspetto<br />
positivo e uno negativo. L’arte del<br />
tessere è un’azione tipicamente<br />
femminile e rappresenta un atto<br />
creativo che si manifesta come un<br />
intervento del sovrannaturale nella<br />
vita dell’uomo e che si richiama a<br />
un <strong>di</strong>segno superiore a cui egli<br />
deve adeguarsi. “Tessere non signifi<br />
ca soltanto predestinare (sul<br />
piano antropologico) e riunire insieme<br />
realtà <strong>di</strong>verse (sul piano sote-<br />
riologico), ma anche creare, far<br />
uscire dalla propria sostanza, come<br />
fa il ragno costruendo da sé la<br />
propria tela” (Eliade, Storia, 188).<br />
Quest’immagine evoca, da un lato,<br />
quella negativa <strong>di</strong> Aracne, <strong>di</strong> colei<br />
che imprigiona le persone nelle<br />
maglie della sua rete, dall’altro<br />
quella <strong>di</strong> Penelope, la tessitrice<br />
ciclica che <strong>di</strong> notte <strong>di</strong>sfa il suo lavoro<br />
per rinviare eternamente la<br />
scadenza… Fuor <strong>di</strong> metafora, la<br />
tessitura è un lavoro <strong>di</strong> creazione,<br />
una sorta <strong>di</strong> parto. Il fi lo è ciò che<br />
unisce i <strong>di</strong>versi momenti della vita<br />
e li riconduce al loro principio. Il<br />
taglio del fi lo pertanto corrisponde<br />
alla rottura del cordone ombelicale<br />
del nascituro e il <strong>di</strong>stacco della<br />
madre. Inoltre, l’incrocio dei fi li è il<br />
simbolo dell’unione sessuale e<br />
l’incrocio dei sessi è la modalità<br />
fondamentale con cui l’archetipo<br />
del femminile “tesse” la vita. Ma<br />
non bisogna <strong>di</strong>menticare che la<br />
tessitura rinvia anche all’immagine<br />
della “vestitrice”, <strong>di</strong> colei che veste<br />
gli uomini confezionando i loro indumenti.<br />
Del tessuto l’or<strong>di</strong>to, formato<br />
dai fi li tessuti sul telaio, rappresenta<br />
l’elemento immutabile e<br />
principale, mentre i fi li della trama<br />
che passano tra quella dell’or<strong>di</strong>to<br />
in virtù del movimento della navetta,<br />
rappresentano l’elemento variabile<br />
e contingente. L’inserzione<br />
Alinari<br />
Francesco Salviati:<br />
Le tre Parche.<br />
Firenze, Palazzo Pitti.<br />
Le tre <strong>di</strong>vinità<br />
romane del Destino,<br />
erano preposte alla<br />
nascita, al<br />
matrimonio e alla<br />
morte.<br />
Francesco Salviati:<br />
The three Fates.<br />
Florence, Palazzo<br />
Pitti. The three<br />
Roman <strong>di</strong>vinities of<br />
Fate were responsible<br />
for birth, marriage<br />
and death.<br />
tra questi due fi li forma una croce<br />
<strong>di</strong> cui la linea verticale rinvia al<br />
principio attivo, maschile, e la linea<br />
orizzontale a quello femminile.<br />
La fi latrice è padrona del movimento<br />
circolare e dei ritmi come<br />
la dea Selene è signora della luna<br />
e delle sue fasi. La luna che muore<br />
e ritorna allude alle potenze<br />
femminili che governano il destino<br />
in un ambiente concettuale che<br />
ruota intorno all’idea della rinascita.<br />
Il movimento circolare del fuso<br />
è generato da quello alternativo e<br />
ritmico prodotto da un archetto o<br />
dal pedale del fi latoio. La circolarità<br />
è sempre simbolo <strong>di</strong> totalità<br />
temporale e del ricominciamento.<br />
Nella fi lastrocca ve<strong>di</strong>amo che una<br />
delle tre pulgetis… fa pupazzi <strong>di</strong><br />
pasta, insomma impasta, azione<br />
anche questa che rientra nel carattere<br />
trasformatore dell’archetipo<br />
del femminile per cui <strong>di</strong>venta “signora<br />
della trasformazione”. Inoltre<br />
il riferimento al marito, al matrimonio<br />
inteso come integrazione,<br />
come coniunctio, è sempre presente<br />
quando, nella versione cattolica,<br />
si prega san Martino forse<br />
perché il cavaliere, come narra la<br />
leggenda, frazionando il suo mantello<br />
per proteggere il men<strong>di</strong>cante,<br />
appare come colui che porta con<br />
sé una possibilità <strong>di</strong> rinascita. Il<br />
mantello, infatti, oltre a essere<br />
emblema della regalità, è simbolo<br />
della metamorfosi che l’uomo deve<br />
affrontare, nonché delle <strong>di</strong>verse<br />
personalità che l’uomo può assumere»<br />
(Lavaroni, 148-149).<br />
Ciò che senz’altro si può <strong>di</strong>re<br />
è che l’imbricazione tra fi lastrocca<br />
e morte non è né spora<strong>di</strong>ca né<br />
casuale. Ce lo ricorda una cantilena<br />
bormina, richiamata alla memoria<br />
dal rintocco delle campane a<br />
morto. Din dòn, campàna marón, /<br />
campàna <strong>di</strong> fra; / l’é mòrt un A, /<br />
un A de Pavìa; / l’é mòrt Lucìa, /<br />
Lucìa de Milàn; / l’é mòrt un can, /<br />
un can rabiós; / l’é mòrt un tós, /<br />
un tós debén: / l’é mòrt sul fén,<br />
“Din don, campana marrone, campana<br />
dei frati; è morta una A, una<br />
A <strong>di</strong> Pavia; è morta Lucia, Lucia <strong>di</strong><br />
Milano; è morto un cane, un cane<br />
rabbioso; è morto un fanciullo, un<br />
fanciullo per bene: è morto sul<br />
fi eno” (Marcello Canclini).<br />
PROVINCIA IERI E OGGI 139
ITINERARI<br />
Il giro della<br />
Valle Poschiavina<br />
Testi e foto <strong>di</strong><br />
LUISA ANGELICI<br />
E ANTONIO BOSCACCI<br />
La prima parte <strong>di</strong> questo<br />
giro, la salita al Passo<br />
<strong>di</strong> Campagneda, è un<br />
itinerario ricco <strong>di</strong><br />
curiosità e sorprese, come<br />
quelle che riservano i numerosi<br />
laghi <strong>di</strong> Campagneda, ognuno<br />
<strong>di</strong>verso dagli altri per forma,<br />
<strong>di</strong>mensione e colore.<br />
140 PROVINCIA IERI E OGGI<br />
Località <strong>di</strong> partenza:<br />
parcheggio <strong>di</strong> Campo Moro<br />
(2.000 m)<br />
Dislivello:<br />
600 m<br />
Tempo <strong>di</strong> salita:<br />
ore 5-6<br />
Si risale la Val Malenco e,<br />
passando per Lanzada, si<br />
raggiunge prima la località<br />
Franscia e infi ne il parcheggio<br />
<strong>di</strong> Campo Moro (2.000 m),<br />
posto poco a monte del lago<br />
artifi ciale che porta lo stesso<br />
nome. Qualche metro sopra il<br />
parcheggio si trova il rifugio<br />
Giuseppe “Popi” Miotti<br />
Zoia. Passando al suo fi anco,<br />
si percorre l’antica mulattiera<br />
che collegava l’alpeggio <strong>di</strong><br />
Campo Moro (ora sepolto dalle<br />
acque della <strong>di</strong>ga) con quello <strong>di</strong><br />
Campagneda.<br />
La mulattiera sale<br />
“girovagando” tra gran<strong>di</strong><br />
blocchi e rocce levigate, alcune<br />
delle quali sono state<br />
trasformate in palestre per<br />
l’arrampicata. Dopo un breve<br />
tratto pianeggiante, si scende<br />
alle baite dell’alpeggio <strong>di</strong><br />
Campagneda (2.145 m).<br />
Seguendo le in<strong>di</strong>cazioni, si<br />
sale tra i pascoli e ci si trova<br />
sulla sinistra <strong>di</strong> un grande<br />
piano paludoso sede <strong>di</strong> un<br />
antico lago, ora scomparso,<br />
ma che un tempo era il più<br />
grande tra quelli <strong>di</strong><br />
Campagneda.<br />
Passando sulla destra (o sulla<br />
sinistra) della conca che<br />
racchiude il primo vero lago <strong>di</strong><br />
questa area, si arriva alla base<br />
del complesso pen<strong>di</strong>o che<br />
porta al Passo omonimo. Qui<br />
si incontrano le in<strong>di</strong>cazioni<br />
dell’Alta Via della Valmalenco<br />
(sulla destra il sentiero<br />
attraversa i pen<strong>di</strong>i del Pizzo<br />
Scalino verso il Rifugio Cristina<br />
a Prabello).<br />
Risalita una corta vallecola, si<br />
incontra sulla sinistra il<br />
secondo lago <strong>di</strong> Campagneda.<br />
Poco sopra, dopo aver<br />
superato un breve tratto ripido,<br />
si passa accanto al terzo lago
e infi ne si costeggia la sponda<br />
sinistra del quarto lago, il più<br />
piccolo tra quelli incontrati.<br />
Di fronte, verso ovest,<br />
appaiono inconfon<strong>di</strong>bili i<br />
ghiacciai e le creste del Monte<br />
Disgrazia.<br />
Dopo pochi minuti <strong>di</strong> salita, il<br />
sentiero passa vicino al quinto<br />
lago e, poco sopra, voltandosi,<br />
si può ammirare anche il sesto<br />
lago <strong>di</strong> Campagneda, che si<br />
stende, lungo e stretto, a<br />
destra del quinto.<br />
Superato un piccolo salto con<br />
l’aiuto <strong>di</strong> alcuni gra<strong>di</strong>ni <strong>di</strong><br />
ferro, il sentiero si infi la sul<br />
fondo <strong>di</strong> due vallecole e arriva<br />
al Passo <strong>di</strong> Campagneda<br />
(2.601 m, ore 2,30).<br />
È qui che da qualche anno<br />
transitano i numerosi atleti<br />
della bella gara <strong>di</strong> corsa in<br />
montagna che congiunge<br />
Lanzada a Poschiavo.<br />
Discesa. Si scende in<br />
<strong>di</strong>rezione <strong>di</strong> alcuni laghetti e,<br />
superato il torrente che<br />
raccoglie le acque del<br />
ghiacciaio dello Scalino, ci<br />
s’imbatte nel confi ne tra l’Italia<br />
e la Svizzera (2.517 m, cartelli<br />
con le in<strong>di</strong>cazioni sulla destra<br />
per la Quadrada e Poschiavo e,<br />
sulla sinistra, per la Valle<br />
Poschiavina e la <strong>di</strong>ga <strong>di</strong> Alpe<br />
Gera, oltre che per il Passo <strong>di</strong><br />
Ur). Costeggiato un piccolo<br />
lago, il sentiero lascia il vasto<br />
e movimentato Passo <strong>di</strong><br />
Canciano (2.498 m) e si infi la<br />
(attenzione) tra le rocce<br />
levigate dall’azione del<br />
ghiacciaio dello Scalino che un<br />
tempo occupava anche l’intera<br />
Valle Poschiavina.<br />
Lasciata la deviazione per il<br />
Passo <strong>di</strong> Ur sulla destra e<br />
raggiunto il fondovalle, lo si<br />
percorre in tutta la sua<br />
lunghezza (ora accostandosi,<br />
ora allontanandosi dal<br />
torrente, ma rimanendo<br />
sempre alla sua destra), fi no<br />
alle baite dell’Alpe Poschiavina.<br />
Da qui si scende lungo una<br />
stra<strong>di</strong>cciola alla <strong>di</strong>ga <strong>di</strong> Alpe<br />
Gera e si ritorna facilmente al<br />
parcheggio <strong>di</strong> Campo Moro.<br />
(La <strong>di</strong>scesa qui descritta è<br />
assolutamente sconsigliabile<br />
in caso <strong>di</strong> nebbia, non<br />
infrequente in questi luoghi).<br />
A tour<br />
of Valle Poschiavina<br />
The destination is the Campoagneda<br />
Pass, going up Val Malenco, and after<br />
Lanzada and Franscia stopping at<br />
the Campo Moro car park. After the<br />
Zoia refuge and the Campagneda<br />
mountain grazing ground, follow the<br />
in<strong>di</strong>cations for the Alta Via of the<br />
Valmalenco. After this, you reach<br />
the second, third and fourth lake;<br />
you are facing Mount Disgrazia and<br />
imme<strong>di</strong>ately after that you reach the<br />
Pass. Special care must be taken in<br />
the descent, especially if there is mist.<br />
Dida, <strong>di</strong>da, <strong>di</strong>da,<br />
<strong>di</strong>da, <strong>di</strong>da, <strong>di</strong>da,<br />
<strong>di</strong>da, <strong>di</strong>da, <strong>di</strong>da,<br />
<strong>di</strong>da, <strong>di</strong>da, <strong>di</strong>da,<br />
<strong>di</strong>da.<br />
Dida, <strong>di</strong>da, <strong>di</strong>da,<br />
<strong>di</strong>da, <strong>di</strong>da, <strong>di</strong>da,<br />
<strong>di</strong>da, <strong>di</strong>da, <strong>di</strong>da,<br />
<strong>di</strong>da, <strong>di</strong>da, <strong>di</strong>da,<br />
<strong>di</strong>da.<br />
PROVINCIA IERI E OGGI 141
Antica colonia romana, ha attraversato<br />
la storia, da libero comune a membro<br />
della Lega Lombarda, dal dominio delle<br />
nobili casate milanesi sino ad assumere<br />
la <strong>di</strong>gnità <strong>di</strong> ducato insieme a Parma.<br />
Oggi, Piacenza è una città ricca <strong>di</strong><br />
industrie, <strong>di</strong> attività agricole, <strong>di</strong> una<br />
intensa vita culturale e <strong>di</strong> un’atmosfera<br />
particolare e davvero gradevole.<br />
Piacenza, alongside the Po<br />
Piacenza deserves to be visited leisurely. It is the only way to<br />
<strong>di</strong>scover the city’s authentic and ancient soul. Its extensive history<br />
features many players: Hannibal, Odoacer’s Goths, Barbarossa,<br />
Frederick I Barbarossa, Charles of Anjou, the Viscontis, the Sforzas<br />
and Pope Paul III Farnese. These <strong>di</strong>verse experiences have indeed<br />
painted the historic centre’s “puzzle” with history. The Duomo<br />
dates back to 1233; the Gotico or Comunale Palace (Town Hall) is<br />
dated 1281; the Farnese Palace was built at the end of the 16th<br />
century. But the great Po River played the lea<strong>di</strong>ng role in the life of<br />
this region. There is agriculture with vineyards, orchards and<br />
vegetable gardens on the banks of the Po. Yet behind the façade<br />
of this unique yet normal city lies a mystery, of course: The “Liver<br />
of Piacenza”, an archaeological fin<strong>di</strong>ng of Etruscan origin a few<br />
kilometres from the main town.<br />
142 PAESAGGI SENZA TEMPO<br />
PIACENZA<br />
a fi anco del Po<br />
GIGLIOLA MAGRINI<br />
Piacenza è una città particolare,<br />
che pretende d’essere<br />
scoperta e non “vista<br />
per caso”. Infatti, l’Autostrada<br />
del Sole, che corre a<br />
breve <strong>di</strong>stanza, nega alla massa <strong>di</strong><br />
turisti <strong>di</strong> poterla attraversare, <strong>di</strong><br />
doverla attraversare per proseguire<br />
il viaggio. Ma forse è meglio<br />
così: andarla a conoscere senza<br />
fretta e secondo il nostro consueto<br />
suggerimento; l’auto parcheggiata<br />
in periferia e poi, passo dopo<br />
passo, sino in centro, evitando<br />
magari le vie importanti, dai bei<br />
negozi, per svicolare in certe strade<br />
dove gli antichi palazzi sembrano<br />
invitare al silenzio.<br />
Ma torniamo alla periferia <strong>di</strong><br />
Piacenza per documentarci un po’<br />
meglio sulla sua storia, sul suo<br />
passato. Anzi, ripren<strong>di</strong>amo dal Po,<br />
percorrendo il bel ponte che sovrasta<br />
il fi ume e spalanca una porta<br />
ideale sulla città.<br />
Fotolia<br />
Un po’ <strong>di</strong> storia<br />
L’antica origine <strong>di</strong> Piacenza è<br />
chiaramente documentata dalla<br />
sua struttura urbana a “scacchiera”,<br />
tipica della città romana. Anche<br />
il suo nome ne è la prova: infatti<br />
Piacenza è la traduzione letterale<br />
<strong>di</strong> Placentia, i cui primi segni<br />
risalgono ad epoca preistorica, cui<br />
seguì la presenza dei Liguri, degli<br />
Etruschi e dei Galli Boi. Nel 218<br />
a.C. Placentia <strong>di</strong>venta colonia romana,<br />
assumendo appunto questo<br />
nome; nello stesso anno le<br />
sue truppe oppongono fi era resistenza<br />
all’esercito <strong>di</strong> Annibale sulle<br />
sponde del fi ume Trebbia. Del<br />
resto, l’anno precedente, ossia nel<br />
219 a.C., i soldati della futura Placentia<br />
avevano già misurato le<br />
proprie forze contro gli uomini <strong>di</strong><br />
Asdrubale, scontro che si ripeterà,<br />
ancor più cruento nel 207 a.C.<br />
Qualche anno <strong>di</strong> tregua e poi,<br />
nel 200 a.C., cala sulla piccola<br />
città la furia devastatrice delle orde<br />
<strong>di</strong> Amilcare, che devastarono e<br />
saccheggiarono ogni cosa.
Mauro Lanfranchi<br />
Poi la storia assunse una<br />
piega <strong>di</strong>versa, grazie alla nascita<br />
<strong>di</strong> una strada, ancor oggi importantissima:<br />
la via Emilia. Era il<br />
187 a.C. quando Piacenza venne<br />
collegata a Rimini. Nel 90 a.C.<br />
Placentia ottenne la citta<strong>di</strong>nanza<br />
romana e Augusto la iscrisse<br />
all’VIII Regione.<br />
Sembrava che la sorte della<br />
città si fosse in<strong>di</strong>rizzata verso un<br />
defi nitivo destino <strong>di</strong> pace e <strong>di</strong> in<strong>di</strong>pendenza<br />
e, invece, con la caduta<br />
dell’Impero Romano, Piacenza fu<br />
occupata da Odoacre, dai Goti e<br />
poi dai Longobar<strong>di</strong> che la eressero<br />
a capoluogo <strong>di</strong> “ducato”.<br />
Dopo il Governo vescovile,<br />
durato dal 997 al 1120, la città,<br />
con libera decisione, aderì alla<br />
Lega Lombarda contro Federico<br />
Barbarossa che, nel 1161, le impose<br />
un podestà imperiale.<br />
Fu proprio nella cattedrale<br />
piacentina <strong>di</strong> Sant’Antonino, che<br />
furono fi rmati i preliminari della<br />
Pace <strong>di</strong> Costanza, nel 1183.<br />
Una pace che non collimò<br />
con quanto sarebbe avvenuto<br />
nell’antica Placentia coinvolta in<br />
una serie <strong>di</strong> contrasti con Parma,<br />
Cremona e Pavia, tanto che nel<br />
1254 Oberto Pallavicino, signore<br />
lombardo <strong>di</strong> fede ghibellina, pretese<br />
il comando sulla città, impose<br />
un governo <strong>di</strong> assoluto rigore e <strong>di</strong><br />
buon assetto urbanistico.<br />
Mauro Lanfranchi<br />
NOTIZIARIO<br />
Paesaggi<br />
senza<br />
tempo<br />
A sinistra: il duomo<br />
<strong>di</strong> Piacenza e un<br />
particolare del suo<br />
portale.<br />
A destra: la<br />
cattedrale <strong>di</strong><br />
Sant’Antonino.<br />
In basso: la chiesa <strong>di</strong><br />
San Sisto inquadrata<br />
da una suggestiva<br />
angolazione.<br />
Left: the Piacenza<br />
duomo and its portal<br />
in detail.<br />
Right: the<br />
Sant’Antonino<br />
cathedral.<br />
Below: the San Sisto<br />
church photographed<br />
from an interesting<br />
angle.<br />
PAESAGGI SENZA TEMPO 143<br />
Mauro Lanfranchi
Sei secoli <strong>di</strong> alterne vicende<br />
Come spesso succede per le<br />
città <strong>di</strong> me<strong>di</strong>a <strong>di</strong>mensione poste<br />
lungo le più importanti <strong>di</strong>rettrici<br />
viarie, e magari a due passi da un<br />
grande fi ume, anche per Piacenza<br />
fu così. Dal XIII al XIX secolo essa<br />
attraversò un periodo che defi nire<br />
intenso, sotto il profi lo storico, è<br />
puramente riduttivo. Per non <strong>di</strong>lungarci<br />
eccessivamente descriveremo<br />
questa serie <strong>di</strong> eventi con lo<br />
scarno stile della cronaca, a partire<br />
dalla fine del 1200, quando<br />
Piacenza venne occupata da Carlo<br />
d’Angiò (1271), da Alberto I Scotti<br />
(1290), per passare nel 1317 sotto<br />
il dominio <strong>di</strong> Matteo Visconti.<br />
Passarono soltanto cinque<br />
anni e risuonarono richiami <strong>di</strong><br />
trombe e rulli <strong>di</strong> tamburi per annunciare<br />
l’arrivo delle truppe <strong>di</strong> Galeazzo<br />
Visconti e Obizzo Lan<strong>di</strong> che la<br />
cedettero quasi subito al legato<br />
pontifi cio Bertrando del Poggetto.<br />
Nel 1335 una rivolta popolare<br />
cacciò da Piacenza i Guelfi (sostenitori<br />
del Papato) e l’anno dopo<br />
la città passò ad Azzone Visconti.<br />
Ma non era certamente fi nita: dopo<br />
i brevi domini <strong>di</strong> Ottobono Terzi<br />
(1404-06) e <strong>di</strong> Facino Cane (1406-<br />
12) tornarono i Visconti. Una breve<br />
parentesi repubblicana nel 1447,<br />
anche grazie alla me<strong>di</strong>azione <strong>di</strong><br />
Venezia, quin<strong>di</strong> furono gli Sforza a<br />
impadronirsi del governo <strong>di</strong> Piacenza,<br />
che passò poi a Luigi XII <strong>di</strong><br />
Francia dal 1499 al 1512. Un intervallo<br />
molto breve, tanto che nel<br />
1512 la città fi nì allo Stato Pontifi -<br />
cio, dapprima in via transitoria, ma<br />
dal 1521 defi nitivamente.<br />
Senonché, nel 1545, Papa<br />
Paolo III Farnese decise <strong>di</strong> donare<br />
Piacenza e Parma al fi glio Pier Luigi,<br />
fondando il Ducato <strong>di</strong> Parma e<br />
Piacenza.<br />
Con quest’ultima annotazione,<br />
un po’ singolare, siamo arrivati<br />
all’epoca <strong>di</strong> Napoleone, quando<br />
Piacenza venne insignita del grado<br />
<strong>di</strong> “Dipartimento del Taro”. Il 15<br />
aprile 1860 venne inclusa nel Regno<br />
d’Italia.<br />
Un’impronta me<strong>di</strong>evale<br />
Sorvolando Piacenza non si<br />
può non restare stupiti dalla sua<br />
planimetria. È come guardare una<br />
144 PAESAGGI SENZA TEMPO<br />
Il Palazzo Gotico o<br />
Comunale, esempio<br />
<strong>di</strong> architettura<br />
me<strong>di</strong>evale, sobria ed<br />
elegante.<br />
The Gotico or<br />
Comunale Palace<br />
(Town Hall), an<br />
example of me<strong>di</strong>eval<br />
architecture, austere<br />
and elegant.<br />
<strong>di</strong>stesa <strong>di</strong> vecchi mattoni incisi da<br />
una rete <strong>di</strong> stra<strong>di</strong>ne che si affi ancano<br />
come un puzzle. Del resto, la<br />
storia <strong>di</strong> questa simpatica città è<br />
la più autorevole conferma a tale<br />
impressione: la breve durata <strong>di</strong><br />
ogni signoria ha impe<strong>di</strong>to che si<br />
attuassero successivi programmi<br />
<strong>di</strong> sistemazione urbana. La “pianta”<br />
me<strong>di</strong>evale ha così conservato<br />
la sua struttura e la città si è sviluppata<br />
e ha mutato volto soprattutto<br />
attorno al nucleo centrale.<br />
Questo non toglie che la parte più<br />
antica <strong>di</strong> Piacenza non possieda<br />
monumenti degni <strong>di</strong> nota, come il<br />
Duomo, pregevole esempio <strong>di</strong> stile<br />
romanico lombardo risalente al<br />
1233, dalla caratteristica facciata<br />
“a capanna”, spartita orizzontalmente<br />
da lesene e aperta nella<br />
parte inferiore da tre portali ornati<br />
da pronao, ossia da un atrio a colonne<br />
che precede la cella del<br />
tempio. L’interno, a tre navate,<br />
conserva affreschi (dal XIV al XVII<br />
secolo) fi rmati da L. Carracci, da C.<br />
Procaccini, da P. F. Morazzone e<br />
dal Guercino. Il campanile risale al<br />
1333.<br />
Mauro Lanfranchi
Altrettanto interessante l’antica<br />
cattedrale, oggi chiamata<br />
chiesa <strong>di</strong> Sant’Antonino, fondata<br />
nel IV secolo, ricostruita nell’XI<br />
secolo e trasformata nel XIII secolo.<br />
Nel 1350 alla chiesa fu aggiunto<br />
un atrio in stile gotico, chiamato<br />
“il Para<strong>di</strong>so”, progettato da Pietro<br />
Vago.<br />
È giusto ricordare anche la<br />
chiesa <strong>di</strong> San Savino e quella gotica<br />
<strong>di</strong> San Francesco, iniziata nel<br />
1278.<br />
Il maggior e<strong>di</strong>fi cio me<strong>di</strong>evale<br />
<strong>di</strong> Piacenza è il “Palazzo Gotico” o<br />
comunale, datato 1281, coronato<br />
da merli ghibellini e aperto inferiormente<br />
da un portico e cinque archi<br />
acuti.<br />
Nel Cinquecento, Piacenza<br />
ha conosciuto un particolare risveglio<br />
architettonico e ne rimane testimonianza<br />
con la chiesa <strong>di</strong> Santa<br />
Maria della Campagna, del 1528,<br />
su progetto <strong>di</strong> A. Tramello, affrescata<br />
nella cupola dal Pordenone<br />
e dal Solero. Sempre al Tramello<br />
si deve la ricostruzione della chiesa<br />
<strong>di</strong> San Sisto, fondata nell’874;<br />
a proposito <strong>di</strong> questa chiesa, si<br />
ricorda che la Madonna del suo<br />
altar maggiore, <strong>di</strong>pinta da Raffaello,<br />
oggi si trova a Dresda.<br />
Di notevole bellezza e valore<br />
anche il Palazzo Farnese (1588-<br />
93) forse eseguito su <strong>di</strong>segno <strong>di</strong> F.<br />
Paciotti e a cui lavorò anche il Vignola.<br />
Per restare nel centro, nel<br />
cuore dell’antica Placentia non<br />
possiamo trascurare la piazza dei<br />
Cavalli dove sono ambientate le<br />
due statue equestri <strong>di</strong> Alessandro<br />
e Ranuccio Farnese, opera <strong>di</strong> F.<br />
Mochi (1580-1654). Di notevole<br />
rilievo anche il Palazzo del Governatore<br />
(1781) e il Teatro Comunale,<br />
entrambi del piacentino L.<br />
Tromba. Vi è poi il Museo Civico,<br />
dove sono conservati <strong>di</strong>pinti del<br />
Botticelli, del Pordenone e del<br />
Campi, stupen<strong>di</strong> arazzi e resti archeologici<br />
importanti. Fra questi<br />
ultimi reperti è famoso il Fegato <strong>di</strong><br />
Piacenza, che descriviamo a parte.<br />
Conclu<strong>di</strong>amo questa rassegna<br />
delle maggiori “bellezze” piacentine<br />
con la Galleria Alberoni<br />
dove si ammirano opere <strong>di</strong> Antonello<br />
da Messina, Guido Reni,<br />
Palazzo Farnese,<br />
tipica <strong>di</strong>mora <strong>di</strong> una<br />
grande famiglia<br />
nobiliare.<br />
The Farnese Palace,<br />
a typical residence<br />
of a grand noble<br />
family.<br />
La chiesa <strong>di</strong><br />
San Francesco, dal<br />
profilo insolito<br />
sottolineato dai tre<br />
piccoli campanili.<br />
The San Francesco<br />
church, with its<br />
unusual profile<br />
embellished by three<br />
small bell-towers.<br />
PAESAGGI SENZA TEMPO 145<br />
Mauro Lanfranchi<br />
Mauro Lanfranchi
DALL’ARCHEOLOGIA ALLA STORIA<br />
Nel Museo Civico <strong>di</strong> Piacenza è visibile un reperto che gli archeologi<br />
conoscono come il Fegato <strong>di</strong> Piacenza. È un oggetto davvero singolare,<br />
<strong>di</strong> origine etrusca, in bronzo, rinvenuto a Gossolengo, un centro<br />
che <strong>di</strong>sta nove chilometri dal capoluogo. Si tratta <strong>di</strong> un modellino <strong>di</strong> un<br />
fegato <strong>di</strong> pecora che, con ogni probabilità, serviva agli aruspici, incaricati<br />
<strong>di</strong> formulare <strong>di</strong>vinazioni attraverso l’osservazione <strong>di</strong> particolari<br />
organi degli animali. Il Fegato <strong>di</strong> Piacenza è sud<strong>di</strong>viso in se<strong>di</strong>ci caselle,<br />
in ciascuna delle quali è inciso il nome <strong>di</strong> una <strong>di</strong>vinità etrusca. Inutile<br />
<strong>di</strong>re che a questo modellino si attribuisce notevole valore, anche perché<br />
testimone <strong>di</strong> un periodo storico <strong>di</strong> grande interesse.<br />
A proposito <strong>di</strong> storia, la città <strong>di</strong> cui ci stiamo occupando viene ricordata<br />
anche per il Concilio <strong>di</strong> Piacenza, convocato da papa Urba no II<br />
(1-7 marzo 1095) con lo scopo <strong>di</strong> prendere severi provve<strong>di</strong>menti in<br />
materia <strong>di</strong> eresia, simonia (peccato <strong>di</strong> chi intende commerciare i beni<br />
spirituali) e anche per ottenere maggiore <strong>di</strong>sciplina nel quadro della<br />
Riforma ecclesiastica e della lotta per le investiture. Al Concilio partecipavano<br />
i messi dell’imperatore bizantino Alessio I Comneno, venuti in<br />
Occidente per cercare aiuti contro i Turchi, sottolineando le sofferenze<br />
patite dai cristiani nei Paesi occupati dai musulmani. I <strong>di</strong>scorsi <strong>di</strong> questi<br />
messaggeri destarono grande preoccupazione nel Papa e nei vescovi<br />
circa la sicurezza dell’intera cristianità. Questa preoccupazione e l’implicito<br />
dovere <strong>di</strong> soccorrere i cristiani così minacciati, sono stati la<br />
premessa del movimento da cui prese origine la Prima Crociata, che<br />
Papa Urbano II pre<strong>di</strong>cò nel novembre 1095 durante il Concilio <strong>di</strong> Clermont.<br />
146 PAESAGGI SENZA TEMPO<br />
Mauro Lanfranchi<br />
La lunga teoria dei<br />
portici e le vie del<br />
centro raccontano<br />
le quieta atmosfera<br />
della Piacenza più<br />
antica.<br />
The long procession<br />
of porticos and the<br />
centre’s streets evoke<br />
the quiet atmosphere<br />
of an older Piacenza.<br />
Poussin e molti altri, mentre i <strong>di</strong>pinti<br />
italiani dell’Ottocento e del<br />
Novecento sono esposti nella Galleria<br />
Ricci-Od<strong>di</strong>.<br />
Fra industria e agricoltura<br />
Abbiamo cercato <strong>di</strong> ricordare<br />
il valore architettonico della Piacenza<br />
<strong>di</strong> ieri, giusto per rendere più<br />
intenso il fascino <strong>di</strong>screto e gentile<br />
delle sue vie, dove il tempo ha lasciato<br />
lame <strong>di</strong> luce e profi li d’ombra,<br />
dove si è trasformato in uno<br />
scrigno <strong>di</strong> ricor<strong>di</strong>. Ma Piacenza è<br />
anche qualcosa <strong>di</strong> <strong>di</strong>verso, è anche<br />
espressione <strong>di</strong> attività impren<strong>di</strong>toriali<br />
e artigianali molto apprezzate.<br />
È anche una città dove si rispetta<br />
al massimo l’ambiente; la<br />
pianura, intorno, non è soltanto<br />
sinonimo <strong>di</strong> “paesaggio”, bensì il<br />
risultato <strong>di</strong> un’agricoltura all’avanguar<strong>di</strong>a<br />
pur senza <strong>di</strong>menticare la<br />
nobile tra<strong>di</strong>zione del “lavoro dei<br />
campi”.<br />
Cominciamo col precisare<br />
che la provincia <strong>di</strong> Piacenza comprende<br />
48 comuni, su una superfi<br />
cie <strong>di</strong> 2.589 kmq, con una popolazione<br />
<strong>di</strong> 282.000 abitanti circa.<br />
Con quest’ultimo dato che può<br />
subire qualche variazione. La sigla<br />
automobilistica <strong>di</strong> Piacenza è PC.<br />
A parte queste precisazioni, puramente<br />
statistico-geografi che, possiamo<br />
commentare l’ambiente che<br />
circonda Piacenza, pianeggiante,<br />
<strong>di</strong> natura alluvionale, con una corona<br />
<strong>di</strong> colline verso Nord, con una<br />
zona centrale che si può defi nire<br />
montuosa per la presenza dell’Ap-
Mauro Lanfranchi<br />
pennino Ligure con la vetta del<br />
monte Lesina che raggiunge 1.724<br />
metri.<br />
Il clima è tipicamente continentale<br />
con piogge intense in autunno<br />
e in primavera; molti i corsi<br />
d’acqua a carattere torrentizio, ma<br />
è il Po il grande interprete della<br />
“vita” <strong>di</strong> questo territorio.<br />
L’agricoltura è senz’altro l’attività-base<br />
<strong>di</strong> questa zona, dove si<br />
alternano tratti “a vigneto” a coltu-<br />
re prative, frutteti e ortaggi; vasta<br />
la coltivazione <strong>di</strong> barbabietole da<br />
zucchero, senza scordare la zootecnia<br />
e la produzione casearia.<br />
La vicinanza con Milano e la<br />
non eccessiva <strong>di</strong>stanza da Bologna<br />
fanno sì che le industrie piacentine<br />
rappresentino – quasi – un<br />
bacino <strong>di</strong> riserva per le due gran<strong>di</strong><br />
città, con reciproco vantaggio. L’Autostrada<br />
del Sole è come un grande<br />
nastro che guida tutta questa<br />
Il Palazzo del<br />
Governatore e il<br />
Teatro comunale,<br />
dalle linee classiche<br />
e severe, completano<br />
il volto <strong>di</strong> Piacenza<br />
antica e moderna<br />
insieme.<br />
The Governor’s<br />
Palace and the<br />
Municipal Theatre<br />
with its classical and<br />
severe lines, bespeak<br />
the union of ancient<br />
and modern<br />
Piacenza.<br />
attività, rappresentata da vari settori:<br />
abbigliamento, materiali da<br />
costruzione, meccanica, chimica,<br />
petrolchimica, conserve alimentari.<br />
Ci sarebbero poi da ricordare<br />
le molte e svariate “eccellenze” <strong>di</strong><br />
tipo artigianale, senza per questo<br />
<strong>di</strong>menticare la vita artistica che fa<br />
da corona alla realtà della moderna<br />
Piacenza, non <strong>di</strong>mentica delle<br />
vicende e della storia dell’antica<br />
Placentia.<br />
<strong>Banca</strong> <strong>Popolare</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>Sondrio</strong><br />
A PIACENZA<br />
SUCCURSALE<br />
Via Palmerio 11<br />
Tel. 0523 32.01.79<br />
Fax 0523 31.80.50<br />
AGENZIA N. 1<br />
Via Colombo 18<br />
Tel. 0523 61.66.01<br />
Fax 0523 61.71.63<br />
PAESAGGI SENZA TEMPO 147<br />
Fotolia<br />
Mauro Lanfranchi
Primavera al Piano <strong>di</strong> Spagna. Sullo sfondo campeggia la mole del Sasso Manduino (foto Roberto Bogialli)
150 REPORTAGE<br />
Impressioni <strong>di</strong><br />
un viaggio in Corsica<br />
Testo e foto <strong>di</strong><br />
ROBERTO RUOZI<br />
Professore emerito presso l’Università “L. Bocconi” in Milano<br />
Caro Lettore,<br />
un viaggio in Corsica è<br />
un’esperienza molto interessante;<br />
lo testimoniano<br />
non solo quanto ho potuto<br />
vedere e gustare la scorsa estate<br />
recandomi nell’isola, ma anche e<br />
soprattutto gli scritti dei numerosissimi<br />
personaggi che l’hanno visitata<br />
nel corso dei millenni. Michel<br />
Vergé-Franceschi ne ha fatto<br />
un’antologia i cui capitoli fondamentali<br />
riguardano i viaggiatori<br />
dell’antichità, quelli dell’Ottocento<br />
e quelli più vicini a noi. I loro ricor<strong>di</strong><br />
sono <strong>di</strong>versi e concernono innanzittutto<br />
i contatti con le persone<br />
e l’incontro con la natura, che<br />
in Corsica è straor<strong>di</strong>nariamente<br />
ricca. L’isola offre al visitatore un<br />
mare purissimo dai colori strabilianti,<br />
che si mescolano con quelli<br />
delle rocce là dove si infrangono le<br />
onde e con quelli delle spiagge<br />
sulle quali esse vanno a placarsi.<br />
Ci sono poi i colori delle montagne<br />
impervie, sempre verdeggianti e<br />
cariche <strong>di</strong> alberi e <strong>di</strong> una tipicissima<br />
macchia, la quale rappresenta<br />
la quintessenza e l’esaltazione<br />
della vegetazione me<strong>di</strong>terranea. I<br />
colori colpiscono i sensi in modo<br />
violento. Dominano l’azzurro, o<br />
meglio gli azzurri, i ver<strong>di</strong>, i rossi e i<br />
gialli, cioè praticamente tutti i colori,<br />
che cambiano nel corso della<br />
giornata e della stagione a seconda<br />
della luce del sole e della luna<br />
e del fi ltro delle nubi. Ai colori della<br />
natura si sommano quelli <strong>di</strong>pinti<br />
dall’uomo, che nella natura ha inserito<br />
armonicamente le sue opere,<br />
senza fare violenza né al paesaggio<br />
né all’ambiente, rispettando<br />
la mano dell’Invisibile al cui<br />
volere, consciamente o meno, si è<br />
inchinato.<br />
In quella natura e in quei colori<br />
è nato, è vissuto e vive tuttora<br />
il popolo corso, nei riguar<strong>di</strong> del<br />
quale Seneca, che fu esiliato<br />
sull’isola nei primi decenni dell’era<br />
cristiana, si espresse molto duramente<br />
affermando che la sua prima<br />
legge era la vendetta, la seconda<br />
la rapina, la terza la menzogna<br />
e la quarta la negazione degli
dei. Certo Seneca doveva avere il<br />
dente avvelenato contro il luogo<br />
poco ospitale nel quale era stato<br />
confi nato, ma è certo che i corsi<br />
dovevano essere già allora un popolo<br />
duro, tanto è vero che i romani<br />
non si avventurarono mai oltre<br />
la costa, dove peraltro fondarono<br />
importanti città.<br />
Aléria è una <strong>di</strong> queste e arrivò<br />
ad ospitare oltre 20.000 abitanti.<br />
Oggi le sue rovine sono modeste<br />
anche se il sito in cui si trovano è<br />
molto suggestivo e profondamente<br />
romantico. I resti dell’antico foro<br />
riposano all’ombra <strong>di</strong> alberi ver<strong>di</strong>ssimi.<br />
La stragrande maggioranza<br />
della vecchia città deve tuttavia<br />
essere ancora scavata e scoperta<br />
ed è possibile che possa offrire<br />
sorprese <strong>di</strong> grande rilievo.<br />
Unico neo della visita alla<br />
città romana è stato l’incre<strong>di</strong>bile<br />
orario <strong>di</strong> apertura del sito e l’insipienza<br />
dei guar<strong>di</strong>ani che ne hanno<br />
voluto un’applicazione rigi<strong>di</strong>ssima<br />
assolutamente incoerente con le<br />
tra<strong>di</strong>zionali leggi dell’ospitalità.<br />
Càpita! Dato tuttavia che non tutti<br />
i mali vengono per nuocere, aspettando<br />
<strong>di</strong> entrare per vedere le rovine<br />
ho passato un po’ <strong>di</strong> tempo<br />
ammirando vecchie case nelle<br />
quali il tempo sembra non passare<br />
mai. Poi mi sono fermato in una<br />
specie <strong>di</strong> bar dove un burbero oste<br />
mi ha servito un ottimo panino<br />
contenente un saporito prosciutto<br />
corso. Lì ho fatto conoscenza con<br />
un gruppetto <strong>di</strong> agricoltori simpaticissimi<br />
che mi hanno raccontato le<br />
loro avventure. Uno <strong>di</strong> essi, originario<br />
<strong>di</strong> Montpellier, era fi nito in Algeria<br />
da dove era dovuto rientrare<br />
per i noti motivi politici connessi<br />
Una baia nei pressi<br />
<strong>di</strong> Calvi e, nella<br />
pagina a fianco, una<br />
tipica torre genovese<br />
a guar<strong>di</strong>a del mare.<br />
The bay near Calvi<br />
and on the facing<br />
page, a typical<br />
Genoese sea<br />
watchtower.<br />
NOTIZIARIO<br />
Reportage<br />
Le rovine romane<br />
<strong>di</strong> Aléria.<br />
Roman ruins in<br />
Aléria.<br />
Impressions of a trip to Corsica<br />
The nature and the character of Corsica’s inhabitants are typical.<br />
Seneca, who was here in exile, could not stand the people here:<br />
revengeful, thieving and liars. In ad<strong>di</strong>tion, although today it is<br />
considerably weaker, the pride in an independent spirit dates back<br />
a long time. Pasquale Poli, the leader of the claim for independence<br />
in the 18th century is a recognized hero. The other great figure<br />
from this land is naturally Napoleon, who was more inclined<br />
towards Corsica being annexed to France. Many lea<strong>di</strong>ng figures of<br />
European culture have spent time here, with <strong>di</strong>fferent experiences:<br />
Flaubert, Hugo, Balzac and Daudet. The splen<strong>di</strong>dly rugged coastline<br />
of Capo Corso has many watchtowers built by the Genoese to look<br />
out for pirates and Saracens.<br />
con la crisi franco-algerina e si era<br />
rifugiato in Corsica, dove era stato<br />
ben accolto e aveva ricominciato<br />
una nuova vita <strong>di</strong> cui sembrava<br />
molto sod<strong>di</strong>sfatto. Abbiamo con<strong>di</strong>viso<br />
un buon pastis che qui non<br />
manca mai. La Corsica ha svolto<br />
una funzione importante nel rimpatrio<br />
dei cosiddetti pieds noirs, che<br />
hanno modernizzato l’agricoltura<br />
dell’isola e hanno posto le basi per<br />
i successi che essa sta oggi ottenendo.<br />
La Corsica ebbe una funzione<br />
importantissima anche nella storia<br />
della Legione straniera, che qui<br />
installò alcune delle sue basi più<br />
importanti. Ora queste sono state<br />
fortemente ri<strong>di</strong>mensionate, ma alla<br />
periferia <strong>di</strong> Calvi è ancora <strong>di</strong><br />
stanza il 2° Reggimento paracadutisti,<br />
che si è coperto <strong>di</strong> gloria in<br />
tante occasioni. Passeggiando per<br />
la città è normale incontrare i legionari<br />
con i loro chepì bianchi, che<br />
tanti ricor<strong>di</strong> sollevano in coloro<br />
che, come il sottoscritto, sono rimasti<br />
fedeli alla storia e hanno<br />
sempre considerato i caduti per la<br />
patria – che nella Legione assume<br />
connotati del tutto particolari – degli<br />
eroi sfortunati <strong>di</strong> cui è doveroso<br />
serbare memoria.<br />
A Bonifacio i vecchi quartieri<br />
della Legione sono invece in via <strong>di</strong><br />
smantellamento e lasceranno spazio<br />
a nuove costruzioni che si spera<br />
non offenderanno un ambiente<br />
così bello come quello attuale.<br />
Mi rendo conto che sto <strong>di</strong>vagando<br />
ed è opportuno che riprenda<br />
il <strong>di</strong>scorso su Aléria, la quale,<br />
dopo secoli <strong>di</strong> oblio, è tornata d’attualità<br />
nel 1975 quando un gruppo<br />
<strong>di</strong> in<strong>di</strong>pendentisti si impadronì <strong>di</strong><br />
un’azienda vinicola <strong>di</strong> proprietà <strong>di</strong><br />
REPORTAGE 151
coloni francesi da poco rimpatriati<br />
dall’Algeria, vi si asserragliò e ingaggiò<br />
una vera e propria battaglia<br />
contro le forze dell’or<strong>di</strong>ne repubblicane<br />
provocando morti e feriti.<br />
L’episo<strong>di</strong>o è dettagliatamente descritto<br />
da Jean-Paul Delors e Stéphane<br />
Muracciole nel bel libro intitolato<br />
Corse. La poudrière, rappresenta<br />
il momento più tragico della<br />
lotta degli in<strong>di</strong>pendentisti, che negli<br />
ultimi decenni si sono fortunatamente<br />
trasformati in autonomisti<br />
e hanno abbandonato la violenza<br />
scegliendo l’arma del <strong>di</strong>alogo e<br />
dell’iniziativa politica. Sopravvivono<br />
alcuni irriducibili, come si può<br />
constatare guardando i muri su cui<br />
stampano i loro slogan, ma non<br />
incutono più paura.<br />
Il destino della Corsica, dal<br />
punto <strong>di</strong> vista dell’in<strong>di</strong>pendenza e<br />
dell’autonomia è peraltro infelice.<br />
Che si tratti <strong>di</strong> un popolo con caratteristiche<br />
particolari anche se<br />
non sempre omogenee è indubbio.<br />
Che esso abbia lottato per<br />
secoli al fi ne <strong>di</strong> ottenere la sospirata<br />
in<strong>di</strong>pendenza contro tutti i<br />
poteri ai quali è stato sottomesso<br />
è altrettanto indubbio. Che i risul-<br />
152 REPORTAGE<br />
Una scritta<br />
autonomista.<br />
Autonomist<br />
writing.<br />
Il vecchio porto<br />
<strong>di</strong> Bastia<br />
visto dalla nave.<br />
The old port<br />
of Bastia seen from<br />
a ship.<br />
tati attesi siano stati modestissimi<br />
e che ormai il <strong>di</strong>scorso sia chiuso<br />
nei princìpi e aperto solo per qualche<br />
aspetto pratico seppure importante,<br />
come l’autonomia amministrativa<br />
e la questione dell’insegnamento<br />
della lingua corsa, è la<br />
pura verità. È comunque comprensibile<br />
ed anzi auspicabile che i<br />
corsi facciano <strong>di</strong> tutto per valorizzare<br />
le loro tra<strong>di</strong>zioni e i punti fermi<br />
della loro civiltà. In questo senso<br />
qualche risultato è già stato acquisito.<br />
Posso portare l’esempio della<br />
musica e del canto, che ha fatto<br />
rinascere numerosi gruppi e complessi<br />
polifonici tra<strong>di</strong>zionali, come<br />
il “Meri<strong>di</strong>anu in giro”, che ho ascoltato<br />
mentre si esibiva nella piazza<br />
del mercato <strong>di</strong> Bastia affollata <strong>di</strong><br />
gente interessata e plaudente, ma<br />
purtroppo composta in gran parte<br />
da persone non giovanissime. La<br />
musica e i canti corsi ricordano il<br />
fado e le canzoni <strong>di</strong> Ornella Vanoni<br />
e <strong>di</strong> Fabrizio De André. Tristezza <strong>di</strong><br />
fondo, ricor<strong>di</strong> lontani, musica dolce<br />
che fa me<strong>di</strong>tare.<br />
Sull’in<strong>di</strong>pendenza della Corsica<br />
i gran<strong>di</strong> personaggi che hanno<br />
illustrato l’isola non sono sempre<br />
stati d’accordo. I più importanti fra<br />
essi, Pasquale Paoli e Napoleone<br />
Bonaparte, hanno ad esempio affrontato<br />
il problema in modo <strong>di</strong>verso.<br />
Il primo <strong>di</strong> essi fu pala<strong>di</strong>no<br />
dell’autonomia, che sotto la sua<br />
guida si esaltò in un breve periodo<br />
<strong>di</strong> in<strong>di</strong>pendenza nel XVIII secolo. Il<br />
secondo fu invece deciso fautore<br />
dell’unione della Corsica alla Francia<br />
e si adoperò a fondo per il<br />
raggiungimento del suo obiettivo.<br />
In Corsica tutto parla <strong>di</strong> Pasquale<br />
Paoli, <strong>di</strong> cui si conserva<br />
anche la casa natale in Castagniccia,<br />
ver<strong>di</strong>ssimo borgo inserito in<br />
lussureggianti castagneti i cui frut
ti furono per secoli la fonte fondamentale<br />
<strong>di</strong> sostentamento dei pastori<br />
corsi. Oggi Castagniccia è<br />
<strong>di</strong>ventata famosa anche per l’acqua<br />
minerale che vi sgorga e che<br />
è veramente eccellente sia nella<br />
versione naturale sia in quella<br />
frizzante. Il ricordo <strong>di</strong> Paoli è vivo<br />
anche a Corte, che fu capitale<br />
dello Stato corso nel periodo<br />
dell’in<strong>di</strong>pendenza e che conserva<br />
ancora l’austero palazzo dove aveva<br />
sede il governo dell’epoca.<br />
Corte è una bella citta<strong>di</strong>na,<br />
rianimata dall’università recentemente<br />
costituita e frequentata da<br />
una massa <strong>di</strong> studenti il cui numero<br />
supera quello della popolazione<br />
residente. Situata al centro dell’isola,<br />
in un ambito tipicamente montano<br />
incontaminato, è profondamente<br />
cambiata nel corso degli<br />
ultimi anni, ma è rimasta abbarbicata<br />
su uno sperone roccioso sormontato<br />
da una minacciosa rocca<br />
risalente al XV secolo. Corte è<br />
forse la città che meglio <strong>di</strong> ogni<br />
altra rappresenta le tra<strong>di</strong>zioni (anche<br />
gastronomiche) e l’animo corso.<br />
Non è un caso che mi sia stata<br />
servita proprio qui un’eccellente<br />
scaloppa <strong>di</strong> cinghiale con funghi e<br />
castagne annaffi ata da un aspro<br />
vino delle ver<strong>di</strong> e impervie valli locali.<br />
Quanto invece all’animo del<br />
popolo corso, esso è tipico delle<br />
genti dell’interno che hanno vissuto<br />
isolate per millenni, che hanno<br />
sempre combattuto per essere<br />
quello che sono e che sono fatalmente<br />
<strong>di</strong>ventate dure. Non per<br />
nulla sul bianco vessillo corso è<br />
raffi gurata la testa <strong>di</strong> un capo pira-<br />
ta moro che in una battaglia con<br />
le popolazioni locali fu sconfi tto e<br />
decapitato. La sua testa mozzata<br />
<strong>di</strong>pinta sul vessillo è sempre stata<br />
un chiaro monito a tutti coloro che<br />
non conoscevano i corsi e che si<br />
illudevano <strong>di</strong> poterli vincere e sottomettere<br />
facilmente.<br />
Di Napoleone Bonaparte è<br />
invece piena <strong>di</strong> ricor<strong>di</strong> Ajaccio,<br />
moderna capitale della Corsica. La<br />
casa natale dell’imperatore dei<br />
francesi è stata trasformata in<br />
museo, che in verità avrebbe potuto<br />
essere meglio attrezzato e gestito<br />
se si fosse voluto onorare degnamente<br />
il grande corso. Non vi<br />
sono altre sue fondamentali testimonianze<br />
sull’isola, dalla quale del<br />
resto egli partì giovanissimo per<br />
andare a frequentare una scuola<br />
militare in Francia. Ritornò in Corsica<br />
a varie riprese sempre per perio<strong>di</strong><br />
piuttosto brevi e dal l’isola<br />
fuggì precipitosamente con tutta la<br />
famiglia quando entrò in confl itto<br />
con Paoli e fu inseguito dai seguaci<br />
<strong>di</strong> quest’ultimo. A Calvi una targa<br />
ricorda la casa dove, nella fuga,<br />
egli sostò ospite del suo padrino.<br />
Successivamente la presenza <strong>di</strong><br />
Napoleone in Corsica si limitò ad<br />
una fuggevole sosta nel ritorno<br />
dalla spe<strong>di</strong>zione d’Egitto, <strong>di</strong> cui non<br />
resta alcuna traccia concreta. Statue<br />
dell’imperatore dominano comunque<br />
le principali piazze delle<br />
maggiori città dell’isola.<br />
In Corsica sono giunto con un<br />
traghetto partito dal porto <strong>di</strong> Genova.<br />
Il viaggio è stato piacevolissimo,<br />
allietato da un gran sole e da<br />
una brezza sottile. Giusto un’espe-<br />
Una vecchia<br />
cartolina <strong>di</strong> Corte<br />
risalente agli anni<br />
Trenta del secolo<br />
scorso e, a destra, il<br />
palazzo del governo<br />
<strong>di</strong> Pasquale Paoli<br />
nello stesso centro.<br />
An old postcard<br />
depicting Corte<br />
dating back to the<br />
1930s and right, the<br />
Pasquale Paoli<br />
government buil<strong>di</strong>ng<br />
in the same centre.<br />
rienza contraria a quella quasi<br />
drammatica descritta in un famoso<br />
racconto <strong>di</strong> Gustave Flaubert,<br />
passeggero infelice <strong>di</strong> una piccola<br />
imbarcazione che da Tolone raggiunse<br />
Bastia attraversando una<br />
sconvolgente tempesta che tormentò<br />
non poco il grande romanziere<br />
francese. Il suo soggiorno<br />
sull’isola fu invece piacevole e curioso.<br />
Incontrò un mondo a lui<br />
sconosciuto, con regole e costumi<br />
originalissimi, in un’atmosfera <strong>di</strong><br />
grande accoglienza. L’ospitalità<br />
corsa è stata proverbiale nei secoli.<br />
Oggi tutto è cambiato, ma il<br />
sorriso della gente e il loro calore<br />
non mancano quasi mai e tutti<br />
fanno del loro meglio per accoglierti.<br />
Flaubert non fu l’unico grande<br />
scrittore dell’Ottocento che ha<br />
soggiornato nell’isola. Di questa<br />
ha lasciato tracce in<strong>di</strong>menticabili<br />
anche Prosper Mérimée, i cui scritti<br />
fecero conoscere all’Europa un<br />
mondo che era sempre stato chiuso<br />
su se stesso e che era ignoto<br />
ai più. Così ha fatto anche Alphonse<br />
Daudet, che ci parla del suo<br />
soggiorno nei pressi del faro<br />
dell’isola Sanguinaria vicino ad<br />
Ajaccio. Pure Victor Hugo e Honoré<br />
de Balzac soggiornarono qui. Il<br />
primo abitò con il padre in gioventù<br />
(1803-05) nella piazza Santa Maria<br />
<strong>di</strong> Bastia e il secondo fu ospite<br />
veloce, nel 1838, in via Corbuccia<br />
nella stessa città. Il giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong><br />
questi scrittori sull’isola è vario.<br />
Alcuni se ne sono veramente innamorati<br />
e ne parlano in modo entusiasta.<br />
Balzac scrisse invece in<br />
proposito frasi feroci.<br />
REPORTAGE 153
Ma ritorniamo a Bastia per<br />
ricordare che, vista dalla nave,<br />
appare tranquilla, mollemente<br />
adagiata sulle pen<strong>di</strong>ci delle colline<br />
che si innalzano dal mare verso<br />
l’interno. La cittadella domina la<br />
parte vecchia della città e l’antico<br />
porto oggi è <strong>di</strong>ventato rifugio <strong>di</strong><br />
piccoli natanti. Attorno al porto si<br />
trovano numerosi ristoranti in cui<br />
si possono gustare eccellenti vini<br />
corsi (bianchi, rosati e rossi) insie-<br />
La rocca <strong>di</strong> Corte;<br />
in basso, la casa<br />
<strong>di</strong> Napoleone<br />
ad Ajaccio.<br />
The Corte fort;<br />
below, Napoleon’s<br />
house in Ajaccio.<br />
me con delicati piatti <strong>di</strong> pesce che<br />
comprendono le aragoste, che qui<br />
si pescano facilmente, ma anche i<br />
più tra<strong>di</strong>zionali pesci me<strong>di</strong>terranei<br />
che popolano le acque corse come<br />
quelle <strong>di</strong> tutte le altre località<br />
del vecchio Mare Nostrum. Quanto<br />
alla produzione vinicola corsa, colgo<br />
l’occasione per ricordare che si<br />
tratta <strong>di</strong> un’attività antica, per la<br />
quale l’isola fu famosa in Europa<br />
già nel Me<strong>di</strong>oevo quando i suoi<br />
vini cominciarono ad essere esportati<br />
nel continente soprattutto per<br />
il benefi cio dei raffi nati palati italiani<br />
e francesi. Le vigne sono del<br />
resto parte integrante del paesaggio<br />
corso e sono <strong>di</strong>sseminate un<br />
po’ dappertutto. Sono molto belle<br />
soprattutto quelle <strong>di</strong>gradanti verso<br />
il mare.<br />
Ma ritorniamo a Bastia dove,<br />
al tramonto, la cattedrale <strong>di</strong> San<br />
Giovanni Battista, patrono della<br />
città, assume toni dorati e dà al<br />
porto uno sfondo molto suggestivo.<br />
Una bella visione del porto si<br />
ha anche dalla cittadella, in cui è<br />
stato recentemente aperto un piccolo<br />
museo: vi si trova una curiosa<br />
statua lignea <strong>di</strong> sant’Erasmo, protettore<br />
dei marinai, raffi gurato infatti<br />
a cavallo <strong>di</strong> una nave.<br />
A Bastia non c’è molto altro<br />
da vedere. È comunque interessante<br />
il vecchio negozio stile liber-<br />
ty della prestigiosa casa vinicola<br />
Mattei, il cui proprietario inventò il<br />
Cap Corse, aperitivo simile al nostro<br />
vermout, che ebbe in passato<br />
un grande successo e che è attualmente<br />
in fase <strong>di</strong> rilancio. Le<br />
bevande alcoliche, che comprendono<br />
anche la produzione <strong>di</strong> eccellenti<br />
grappe, fra le quali spiccano<br />
quelle <strong>di</strong> mirto e quelle <strong>di</strong> castagne,<br />
sono uno dei punti forti della<br />
produzione agroalimentare corsa.<br />
Vi si produce anche il whisky, introdotto<br />
nell’isola negli anni Novanta<br />
del secolo scorso. Si tratta<br />
<strong>di</strong> una produzione limitata, ma <strong>di</strong><br />
qualità, che si basa sull’ottima<br />
acqua locale e su orzo francese.<br />
L’invecchiamento avviene in botti<br />
<strong>di</strong> rovere che danno morbidezza e<br />
aromaticità al <strong>di</strong>stillato. Non so<br />
quanto successo potrà avere il<br />
whisky corso sul mercato mon<strong>di</strong>ale,<br />
ma è certamente buono e la<br />
sua qualità può ancora migliorare<br />
anche per il previsto utilizzo <strong>di</strong><br />
cereali autoctoni.<br />
Da Bastia si parte per un giro<br />
<strong>di</strong> eccezionale interesse panoramico,<br />
quello del Capo Corso, cioè<br />
della parte più settentrionale<br />
dell’isola, che va a formare il cosiddetto<br />
“<strong>di</strong>to” proteso verso le coste<br />
della nostra riviera. Una tortuosissima<br />
strada, non sempre in perfette<br />
con<strong>di</strong>zioni e poco adatta al traffi<br />
co o<strong>di</strong>erno, consente <strong>di</strong> fare l’intero<br />
giro della penisola, offrendo<br />
visioni da sogno. Qui trovano grande<br />
sod<strong>di</strong>sfazione i motociclisti e gli<br />
amanti della bicicletta, i quali sono<br />
numerosissimi, così come sono<br />
numerosissimi anche i giovani<br />
che, muniti <strong>di</strong> buone scarpe, <strong>di</strong> un<br />
sacco a pelo e <strong>di</strong> uno zaino pieno<br />
<strong>di</strong> chissà che cosa, girano la Corsica<br />
in lungo e in largo assaporandola<br />
meglio degli automobilisti<br />
frettolosi, fra i quali purtroppo devo<br />
mettermi anch’io. Il Capo non è<br />
molto popolato e le sue coste sono<br />
separate da rilievi montuosi<br />
selvaggi che emanano una straor<strong>di</strong>naria<br />
sensazione <strong>di</strong> pace. Tali<br />
coste sono ricche <strong>di</strong> torri d’avvistamento<br />
facenti parte <strong>di</strong> un complesso<br />
ed effi ciente sistema <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa<br />
costruito dai genovesi nei <strong>di</strong>versi<br />
secoli in cui combatterono i corsari<br />
e i saraceni che cercavano in
Bastia: la cattedrale<br />
<strong>di</strong> San Giovanni<br />
Battista, la statua<br />
<strong>di</strong> Napoleone<br />
e il vecchio porto.<br />
Bastia: the cathedral<br />
of Saint John the<br />
Baptist, the statue<br />
of Napoleon and the<br />
old port.<br />
ogni modo <strong>di</strong> saccheggiare i villaggi<br />
dell’isola. La natura è intatta. I<br />
colori e i profumi intensi. Incontri<br />
poca gente anche perché la popolazione<br />
corsa, qui e nel resto<br />
dell’isola, o si è inurbata nelle<br />
gran<strong>di</strong> città o rimane confi nata nei<br />
villaggi persi nel verde, isolati gli<br />
uni dagli altri, dove la vita ha se-<br />
REPORTAGE 155
gnato per secoli gli stessi ritmi a<br />
<strong>di</strong>spetto <strong>di</strong> tutto quello che è accaduto<br />
nel mondo. Dopo la salita<br />
verso nord, si ammira l’isola della<br />
Giralda, che sembra <strong>di</strong>alogare con<br />
Capraia sdraiata ad oriente, e si<br />
scende sul lato occidentale del<br />
capo per fare una sosta al simpatico<br />
villaggio <strong>di</strong> Saint Florent, tipico<br />
antico borgo marinaro che conserva<br />
intatto il suo stile originario.<br />
Nella parte alta del borgo vi è una<br />
grande piazza sul cui sfondo spicca<br />
una cittadella <strong>di</strong> forma circolare<br />
con due gran<strong>di</strong> torrioni concentrici,<br />
fondata dai genovesi nel XV secolo.<br />
Dalle mura della cittadella si<br />
domina il borgo marinaro adagiato<br />
sulle acque azzurre del golfo.<br />
Alla periferia <strong>di</strong> Saint Florent<br />
si può visitare un eccezionale monumento<br />
romanico giunto miracolosamente<br />
intatto fi no ai nostri<br />
giorni, almeno nelle sue strutture<br />
esterne. Elegante e austera allo<br />
stesso tempo, la cattedrale del<br />
Nebbio ha origini romanico-pisane<br />
e presenta quel colore giallo dorato<br />
della pietra calcarea <strong>di</strong> queste<br />
parti, messa ancor più in risalto<br />
dalla luce del sole nel luogo solitario<br />
in cui è stata costruita.<br />
Ancora più isolato è un altro<br />
monumento, forse il più bello e il<br />
più appassionante dell’isola. Alludo<br />
alla chiesa <strong>di</strong> San Michele <strong>di</strong><br />
Murato, località che si raggiunge<br />
facendo una piccola deviazione<br />
sulla strada del ritorno verso Bastia.<br />
È una piccola chiesa me<strong>di</strong>evale<br />
bicolore come quelle pisane alla<br />
cui architettura è sicuramente ispirata.<br />
Ha bellissime fi nestre goti-<br />
156 REPORTAGE<br />
che, uno slanciato campanile quadrato<br />
che domina l’ingresso, dove<br />
appaiono alcune sculture tipiche<br />
dell’epoca effigianti personaggi<br />
sulla cui identità esistono ancora<br />
molti dubbi. Al momento della mia<br />
visita sul vasto prato verde che la<br />
circonda vagava qualche asino e<br />
pascolavano alcune pecore.<br />
Accanto a San Michele, all’ombra<br />
<strong>di</strong> un grande albero, c’è<br />
una fontana da cui sgorga un’acqua<br />
freschissima. La Corsica è<br />
ricca <strong>di</strong> fontane <strong>di</strong> questo genere<br />
che incontri un po’ dappertutto e<br />
che ristorano i viaggiatori, specie<br />
nelle calde giornate estive.<br />
La cittadella<br />
<strong>di</strong> Saint Florent e,<br />
sotto, la cattedrale<br />
del Nebbio.<br />
The Saint Florent<br />
citadel and below,<br />
the Nebbio cathedral.<br />
Da Bastia a Calvi le strade<br />
non sono molto <strong>di</strong>verse da quelle<br />
del Capo Corso. Si attraversano<br />
ambienti insieme marini e montani,<br />
fra i quali il cosiddetto deserto<br />
delle Agriates, chiamato deserto<br />
non per la sua natura geologica ma<br />
perché, per lunga e ignota tra<strong>di</strong>zione,<br />
non è mai stato abitato dall’uomo.<br />
Ci devono invece essere molti<br />
animali visto che vi ho incontrato<br />
numerosi gruppi <strong>di</strong> cacciatori che<br />
lasciavano le loro automobili per<br />
avventurarsi nella macchia.<br />
A proposito <strong>di</strong> animali, si vedono<br />
tanti falchi, che dall’alto del<br />
cielo volano scrutando terra e mare<br />
per precipitarsi sulle prede malaugurate<br />
che non hanno la minima<br />
possibilità <strong>di</strong> <strong>di</strong>fendersi. Due<br />
bellissimi falchi giravano anche su<br />
San Michele <strong>di</strong> Murato accentuando<br />
il ricordo del Me<strong>di</strong>oevo in cui<br />
forse sarebbero stati utilizzati dai<br />
signori locali per un tipo <strong>di</strong> caccia<br />
indubbiamente più intrigante <strong>di</strong><br />
quella <strong>di</strong> oggi.<br />
Calvi è un vasto borgo in riva<br />
al mare, con un grande porto e<br />
una importante cittadella che lo<br />
sovrasta. La sera c’è grande animazione<br />
e le mille luci del lungomare<br />
si specchiano nell’acqua insieme<br />
con i riflessi della luna.<br />
Calvi è profondamente mutata nel<br />
corso degli anni e ha de<strong>di</strong>cato un<br />
monumento a Cristoforo Colombo<br />
che la tra<strong>di</strong>zione locale vuole sia<br />
nato qui. Sui natali del grande navigatore<br />
esistono del resto le storie<br />
più incre<strong>di</strong>bili e questa non è<br />
molto più strana delle altre.<br />
Da Calvi si riparte verso Ajaccio.<br />
Il viaggio è ancora bellissimo.<br />
Le strade sono sempre più o meno<br />
uguali, ma il paesaggio muta in<br />
continuazione e i colori sono forse<br />
ancora più vivi che nel resto<br />
dell’isola. Si sale e si scende sempre<br />
fra mare e montagna. Si superano<br />
vari colli come quelli della<br />
Palmarella, della Lava e della Croce.<br />
Si ammira il golfo della Girolata<br />
con sponde rocciose color rosso<br />
vivo, lo stesso colore che domina<br />
i calanchi <strong>di</strong> Piana, che vengono<br />
subito dopo. I calanchi sono scoscese<br />
rocce granitiche forgiate<br />
nelle forme più strane, quasi sempre<br />
in verticale, dall’opera millena
ia del vento e del mare. Alcune <strong>di</strong><br />
esse ricordano immagini misteriose,<br />
come quelle che si intravedono<br />
quando si guardano le rocce o<br />
le nubi e si interpretano le loro<br />
forme secondo ciò che passa per<br />
la mente. Si vedono così cose che<br />
non esistono affatto e che soprattutto<br />
gli altri non vedono per nulla.<br />
La vista dei calanchi è comunque<br />
un vero e proprio spettacolo, non<br />
sempre gustabile appieno per la<br />
troppa gente che vi si trova. È<br />
forse l’unico posto in cui ho incon-<br />
Veduta d’insieme<br />
e un dettaglio<br />
architettonico<br />
della chiesa <strong>di</strong> San<br />
Michele <strong>di</strong> Murato.<br />
An overall view and<br />
architectural detail of<br />
the church of Saint<br />
Michel in Murato.<br />
Calvi<br />
si presentava così<br />
nei primi decenni<br />
del Novecento.<br />
Calvi as it once<br />
appeared in the first<br />
decades of the<br />
1900s.<br />
trato folle <strong>di</strong> persone trasportate<br />
da giganteschi autobus che non<br />
sono certo il veicolo più adatto a<br />
queste strade nelle quali sostano<br />
con <strong>di</strong>ffi coltà creando ingorghi fasti<strong>di</strong>osissimi.<br />
Ajaccio è anch’essa una città<br />
marinara caratterizzata dalla solita<br />
cittadella e offre al visitatore,<br />
oltre alla casa dell’imperatore e<br />
alla chiesa in cui egli fu battezzato,<br />
un e<strong>di</strong>fi cio imperiale ideato da<br />
Napoleone III come cappella funeraria<br />
per la famiglia Bonaparte. È<br />
da tempo chiuso per restauri e<br />
quin<strong>di</strong> non visitabile. È invece visitabile<br />
e vale la visita il Museo<br />
Fesch, voluto dal car<strong>di</strong>nale zio <strong>di</strong><br />
Napoleone che fu uno straor<strong>di</strong>nario<br />
collezionista soprattutto <strong>di</strong><br />
opere italiane. Vi fi gurano, fra gli<br />
altri, <strong>di</strong>pinti <strong>di</strong> Giovanni Bellini,<br />
Cosmé Tura, Jacopo del Sellaio,<br />
Sandro Botticelli, Pietro da Cortona<br />
e Tiziano. Di quest’ultimo il<br />
museo ospitava una mostra temporanea<br />
che esibiva un certo numero<br />
<strong>di</strong> interessanti ritratti.<br />
Nella città ho potuto gustare<br />
l’essenza della cucina corsa, basata<br />
fondamentalmente su carne <strong>di</strong><br />
maiale e <strong>di</strong> agnello e su formaggi<br />
<strong>di</strong> latte bovino, caprino e ovino. Il<br />
maiale è assai <strong>di</strong>ffuso nell’interno<br />
dell’isola, dove ancora oggi vive<br />
allo stato libero nutrendosi <strong>di</strong><br />
ghiande, castagne e bacche aromatiche.<br />
La sua carne è trasformata<br />
in insaccati <strong>di</strong> pregio, come<br />
il prosciutto, dolce e secco nel<br />
contempo, la lonza con stagionatura<br />
minima <strong>di</strong> tre mesi, la coppa<br />
più o meno uguale alla nostra e<br />
numerose varietà <strong>di</strong> salsicce speziate<br />
con erbe della macchia.<br />
Quanto ai formaggi, a parte il famoso<br />
brocciu, che dovrebbe essere<br />
prodotto solo in determinate<br />
stagioni e che invece viene servito<br />
sempre non si sa bene come, vi<br />
sono dei buoni pecorini anche <strong>di</strong><br />
tipo dolce.<br />
Da Ajaccio inizia la <strong>di</strong>scesa<br />
verso Bonifacio, gioiello fortifi cato<br />
dal quale si vedono le coste della<br />
Sardegna. Possiede un romanticissimo<br />
cimitero dei pescatori dal<br />
quale si può ammirare una straor<strong>di</strong>naria<br />
vista del mare sottostante.<br />
Bonifacio è molto affollata e conti-<br />
REPORTAGE 157
nuamente percorsa da un fasti<strong>di</strong>osissimo<br />
trenino carico <strong>di</strong> turisti che<br />
<strong>di</strong>venta per il pedone una vera<br />
ossessione.<br />
Il panorama che si vede nel<br />
trasferimento è meno entusiasmante<br />
rispetto a quello incontra-<br />
158 REPORTAGE<br />
Calvi: la cittadella<br />
fortificata<br />
e il monumento a<br />
Cristoforo Colombo.<br />
Calvi: a fortified<br />
citadel and a<br />
monument to<br />
Christopher<br />
Columbus.<br />
to fi no ad Ajaccio, ma comunque<br />
sempre bello. Ho fatto due fermate.<br />
La prima per vedere da vicino il<br />
villaggio <strong>di</strong> Sollacaro, tipico borgo<br />
corso isolato immerso nel verde,<br />
in cui è stato ambientato il fantastico<br />
romanzo I fratelli corsi <strong>di</strong> Alexandre<br />
Dumas, una delle più interessanti<br />
e appassionanti narrazioni<br />
<strong>di</strong> vita corsa. Esso offre un’immagine<br />
indelebile <strong>di</strong> quello che<br />
doveva essere l’isola nell’Ottocento,<br />
così come è stata ritratta anche<br />
da Prosper Mérimée nel racconto<br />
Mateo Falcone e nella novella<br />
Colomba.<br />
Quanto tempo è passato e<br />
come è cambiata la Corsica, che<br />
oggi si presenta (almeno ad un<br />
osservatore esterno come il sottoscritto)<br />
in veste assai meno ispirata<br />
alla sua tra<strong>di</strong>zione e in via <strong>di</strong><br />
omogeneizzazione spinta con altri<br />
popoli e altre genti nonostante i<br />
molti e reiterati tentativi <strong>di</strong> conser-<br />
vare l’identità storica. È comunque<br />
strano che per conoscere la<br />
Corsica occorra in ogni caso ricorrere<br />
ad autori francesi. La letteratura<br />
dell’isola infatti è piuttosto<br />
avara e mancano i gran<strong>di</strong> scrittori.<br />
Gli autori corsi non hanno del resto<br />
mai raggiunto una vera au<strong>di</strong>ence<br />
internazionale. È tuttavia vero<br />
che, sapendo leggere attentamente<br />
i loro scritti, come quelli <strong>di</strong> Anna<br />
Maria Corbara (Je saurai vivre<br />
sans toi) e <strong>di</strong> Marie Susini (Je<br />
m’appelle Anna Livia), lasciano intendere<br />
assai bene l’essenza<br />
dell’animo corso e il modo <strong>di</strong> sentire<br />
e <strong>di</strong> pensare della gente<br />
dell’isola.<br />
La seconda fermata del mio<br />
percorso ha avuto luogo vicino a<br />
Sollacaro ed è stata de<strong>di</strong>cata alla<br />
visita dello straor<strong>di</strong>nario complesso<br />
archeologico preistorico <strong>di</strong> Filitosa,<br />
il più ricco dell’isola. Qui le<br />
scoperte degli stu<strong>di</strong>osi stanno ri-
portando alla luce molti siti che<br />
testimoniano le <strong>di</strong>ffuse antichissime<br />
origini della civiltà corsa. Quello<br />
<strong>di</strong> Filitosa è un parco archeologico<br />
molto grande, costellato <strong>di</strong><br />
stele su alcune delle quali sono<br />
scolpiti visi umani. Vi sono vari allineamenti<br />
<strong>di</strong> tali stele e anche<br />
qualche altare complesso perfettamente<br />
integrato nella natura circostante.<br />
Luogo pieno <strong>di</strong> fascino e<br />
<strong>di</strong> mistero, interpretabile con <strong>di</strong>ffi -<br />
coltà anche per gli stu<strong>di</strong>osi, Filitosa<br />
accompagna il visitatore con un<br />
eccellente impianto au<strong>di</strong>o situato<br />
lungo tutto l’itinerario consigliato.<br />
Una dolcissima musica minimalista<br />
è <strong>di</strong>ffusa nel percorso in modo<br />
<strong>di</strong>screto e rende il luogo ancora più<br />
affascinante.<br />
Dopo aver fatto sosta a Bonifacio<br />
il viaggio è proseguito per<br />
Corte e fi nalmente per Bastia, da<br />
dove il solito traghetto veloce, ancora<br />
con un mare calmissimo e un<br />
cielo assolato, mi ha riportato a<br />
Genova e quin<strong>di</strong> a casa.<br />
Quello che ho raccontato è<br />
ciò che ho visto, non ha certo la<br />
pretesa <strong>di</strong> offrire un’immagine<br />
completa <strong>di</strong> quest’isola, la cui visita<br />
richiederebbe un tempo assai<br />
più ampio <strong>di</strong> quello <strong>di</strong> cui <strong>di</strong>sponevo<br />
io. Due cose soprattutto non ho<br />
ammirato con la necessaria tranquillità:<br />
le spiagge <strong>di</strong>sseminate<br />
praticamente lungo tutta la costa,<br />
che ho visto solo fuggevolmente, e<br />
le montagne dell’interno, dove esistono<br />
eccellenti percorsi per gli<br />
Sopra: roccia<br />
a forma <strong>di</strong> testa<br />
<strong>di</strong> cane nei calanchi<br />
<strong>di</strong> Piana e uno dei<br />
gran<strong>di</strong> altari <strong>di</strong><br />
Filitosa. Sotto: la<br />
baia e il cimitero dei<br />
pescatori a Bonifacio.<br />
Above: a rock<br />
resembling a dog’s<br />
head in the Piana<br />
calanques and one of<br />
Filitosa’s great altars.<br />
Below: the bay and<br />
the fishermen’s<br />
cemetery in Bonifacio.<br />
amanti del trekking, che portano<br />
fi n oltre i 2.500 metri <strong>di</strong> altezza fra<br />
boschi, rocce ed acque che pare<br />
siano <strong>di</strong> sogno. Il rimpianto per<br />
quanto non sono riuscito a vedere<br />
può tuttavia essere lo stimolo per<br />
riprendere il traghetto, magari con<br />
attrezzature e amici <strong>di</strong>versi, per<br />
scoprire altre meraviglie.<br />
Nell’attesa <strong>di</strong> ritornare e descrivere<br />
un nuovo viaggio in Corsica,<br />
ti ringrazio della solita attenzione<br />
e ti abbraccio con vivissima<br />
cor<strong>di</strong>alità.<br />
Il tuo Roberto Ruozi<br />
REPORTAGE 159
Allevare correttamente<br />
una tartarughina acquatica<br />
PIERO M. BIANCHI<br />
Me<strong>di</strong>co veterinario<br />
I RETTILI “DA COMPAGNIA” IN ITALIA<br />
Nel gruppo degli animali cosiddetti da compagnia<br />
o d’affezione che vivono nelle case degli italiani<br />
sono compresi anche i rettili (inclusi nella categoria<br />
degli “animali da terrario”), che assommano – secondo<br />
quanto in<strong>di</strong>cano le ultime stime demografi che<br />
(soggetti uffi cialmente denunciati) – a 1.000.000/<br />
1.500.000 in<strong>di</strong>vidui. A questo proposito, vale la pena<br />
<strong>di</strong> sottolineare come, secondo fonti uffi ciose, le tartarughe<br />
non denunciate siano in Italia ad<strong>di</strong>rittura sei<br />
milioni <strong>di</strong> esemplari.<br />
I rettili più allevati nel nostro Paese sono le<br />
iguane, i camaleonti e i gechi (tutti appartenenti<br />
all’or<strong>di</strong>ne zoologico degli Squamati, sottor<strong>di</strong>ne dei<br />
Sauri), taluni serpenti (or<strong>di</strong>ne degli Squamati, sottor<strong>di</strong>ne<br />
degli Ofi <strong>di</strong>) e – soprattutto – numerose specie<br />
<strong>di</strong> tartarughe terrestri e acquatiche.<br />
I rettili sono vertebrati eterotermi (più comunemente<br />
detti “a sangue freddo”) che, attualmente<br />
presenti in tutte le regioni temperate e tropicali del<br />
pianeta su cui viviamo, si sono, dal punto <strong>di</strong> vista<br />
evolutivo, sviluppati sul fi nire del Paleozoico (cioè<br />
alcune centinaia <strong>di</strong> milioni <strong>di</strong> anni orsono) a partire<br />
da un gruppo <strong>di</strong> anfi bi primor<strong>di</strong>ali.<br />
La scelta <strong>di</strong> un rettile come animale d’appartamento<br />
implica senza dubbio non solo l’allestimento<br />
dell’habitat ideale (generalmente ricostruibile nell’ambito<br />
<strong>di</strong> strutture note come terrari oppure – nel<br />
caso delle tartarughine acquatiche – acquaterrari o<br />
Correctly raising a turtle<br />
Accor<strong>di</strong>ng to statistics, there are well over a million terrarium<br />
animals, inclu<strong>di</strong>ng as pets, in Italy. There is a particular preference<br />
for tortoises or turtles, but it is very important to know how to<br />
prepare an ideal habitat for them: this is the only way to ensure<br />
that they can enjoy a life of up to a couple of decades in the best<br />
con<strong>di</strong>tions. It must not be forgotten that turtles are so intelligent<br />
that they can recognise the person looking after them.<br />
Their <strong>di</strong>et is mainly vegetarian, although perio<strong>di</strong>cally they should<br />
be given some proteins: perhaps in the form of live prey,<br />
to stimulate the animals’ hunting instinct.<br />
160 GLI AMICI DELL’UOMO<br />
Massimo Tognolini<br />
NOTIZIARIO<br />
Gli amici<br />
dell’uomo<br />
Le tartarughine del<br />
genere Trachemys si<br />
adattano molto bene<br />
alla vita all’aperto<br />
anche alle nostre<br />
latitu<strong>di</strong>ni.<br />
Trachemys turtles<br />
adapt very well to<br />
outdoor life in our<br />
latitudes.<br />
terracquari), ma anche l’acquisizione <strong>di</strong> tutta una<br />
serie <strong>di</strong> conoscenze sul loro allevamento domestico,<br />
inclusi gli aspetti anatomici, fi siologici, etologici, alimentari,<br />
riproduttivi e così via.<br />
Si tratta, infatti, <strong>di</strong> specie per certi versi alquanto<br />
delicate, che risentono in maniera determinante<br />
degli errori gestionali dovuti all’inesperienza o all’improvvisazione.<br />
Ciò vale a maggior ragione per le tartarughine<br />
acquatiche, troppo spesso vendute frettolosamente<br />
a ignari acquirenti, cui viene fatto credere che per<br />
mantenerle a lungo in buona salute sia più che suffi<br />
ciente alloggiarle in una vaschetta <strong>di</strong> plastica (magari<br />
con tanto <strong>di</strong> palma fi nta posizionata nel centro)<br />
parzialmente riempita <strong>di</strong> acqua del rubinetto e somministrare<br />
loro esclusivamente gamberetti essiccati<br />
o congelati.<br />
Per questo motivo non è mai eccessivo o fuori<br />
luogo ricordare ancora una volta che ospitare in casa<br />
un animale (soprattutto nel caso <strong>di</strong> un rettile) non<br />
costituisce una scelta da affrontare a cuor leggero,<br />
in quanto implica sempre e comunque dei doveri e<br />
delle responsabilità nei suoi confronti.
ZOOLOGIA DELLE TARTARUGHE:<br />
UN SOLO NOME PER TANTE SPECIE<br />
Il termine “tartaruga” comprende in realtà circa<br />
250 <strong>di</strong>fferenti specie zoologiche, tutte appartenenti<br />
alla classe dei rettili e all’or<strong>di</strong>ne dei Testu<strong>di</strong>nes.<br />
Quest’ultimo è a sua volta sud<strong>di</strong>viso in due<br />
sottor<strong>di</strong>ni: i Cripto<strong>di</strong>ri (animali che ritirano la testa nel<br />
guscio con un movimento telescopico del collo) e i<br />
Pleuro<strong>di</strong>ri (animali che ritirano la testa nel guscio<br />
piegando il collo lateralmente).<br />
Al primo sottor<strong>di</strong>ne, poi, appartengono quattro<br />
superfamiglie: i Testu<strong>di</strong>noi<strong>di</strong> (<strong>di</strong> cui fanno parte le<br />
famiglie degli Emy<strong>di</strong><strong>di</strong> – che comprende da sola circa<br />
la metà delle specie totali –, dei Testu<strong>di</strong>ni<strong>di</strong> – che<br />
raggruppa la maggior parte delle tartarughe terrestri<br />
– e dei Betaguri<strong>di</strong>), i Tryonicoi<strong>di</strong> (<strong>di</strong> cui fanno parte le<br />
famiglie d’acqua dolce dei Carettocheli<strong>di</strong> e dei Tryonichi<strong>di</strong><br />
o “tartarughe dal guscio molle”), i Chelonioi<strong>di</strong><br />
(<strong>di</strong> cui fanno parte le due famiglie <strong>di</strong> tartarughe marine<br />
dei Cheloni<strong>di</strong> e dei Dermocheli<strong>di</strong>) e dei Kinosternoi<strong>di</strong><br />
(<strong>di</strong> cui fanno parte le famiglie dei Dermatemy<strong>di</strong><strong>di</strong><br />
e dei Kinosterni<strong>di</strong> o “tartarughe del fango”).<br />
Al secondo sottor<strong>di</strong>ne, invece, appartengono<br />
tre famiglie <strong>di</strong> tartarughe d’acqua dolce: i Pelomedusi<strong>di</strong>,<br />
i Cheli<strong>di</strong> e i Podocnemi<strong>di</strong><strong>di</strong>.<br />
Esiste, inoltre, la famiglia dei Chelydri<strong>di</strong> o “tartarughe<br />
azzannatrici”, che viene considerata a sé<br />
stante.<br />
I risultati delle ricerche intraprese da paleontologi<br />
e zoologi hanno messo in evidenza come le<br />
tartarughe rappresentino forme <strong>di</strong> vita molto antiche,<br />
al punto da essere ormai universalmente ritenuto<br />
che si tratti dei vertebrati esistenti sulla Terra da più<br />
tempo: lo <strong>di</strong>mostra anche il fatto che i primi fossili<br />
identifi cati risalgono al Triassico,<br />
cioè a circa duecento milioni <strong>di</strong> anni<br />
orsono. Presumibilmente, quin<strong>di</strong>, le<br />
tartarughe vivevano già prima<br />
dell’avvento dei <strong>di</strong>nosauri e nonostante<br />
tutto sono riuscite, dopo<br />
avere superato intere ere geologiche,<br />
ad arrivare a noi senza evidenti<br />
cambiamenti fi siologici e morfologici.<br />
Molte specie <strong>di</strong> tartarughe sono<br />
oggi considerate a rischio <strong>di</strong><br />
estinzione: la Convenzione <strong>di</strong> Washington<br />
(ambito internazionale) e la<br />
Paleontologi e<br />
zoologi hanno<br />
evidenziato come le<br />
tartarughe<br />
rappresentino forme<br />
<strong>di</strong> vita molto antiche.<br />
Palaeontologists and<br />
zoologists have<br />
emphasized how<br />
turtles represent very<br />
ancient life forms.<br />
La vista <strong>di</strong> questi<br />
animali è<br />
particolarmente<br />
acuta, mentre le<br />
orecchie mancano<br />
sia <strong>di</strong> pa<strong>di</strong>glione<br />
auricolare sia <strong>di</strong><br />
condotto u<strong>di</strong>tivo<br />
esterno e la bocca,<br />
priva <strong>di</strong> denti, è<br />
foggiata a becco<br />
d’uccello.<br />
The animal’s sight is<br />
particularly keen,<br />
while the ears lack<br />
both pinna as well<br />
as ear canal. The<br />
mouth is toothless<br />
yet shaped like a<br />
bird’s beak.<br />
Convenzione <strong>di</strong> Berna (ambito europeo) si occupano<br />
della tutela <strong>di</strong> molte delle famiglie precedentemente<br />
citate, tant’è vero che la detenzione <strong>di</strong> numerose<br />
specie, così come la nascita dei nuovi esemplari,<br />
vanno notifi cate al Corpo Forestale dello Stato.<br />
Tra le specie acquatiche comunemente allevate<br />
in appartamento, le più <strong>di</strong>ffuse in Italia sono quelle<br />
che fanno parte del genere Trachemys, originario<br />
delle regioni sud-orientali degli Stati Uniti d’America.<br />
CENNI DI ANATOMIA,<br />
FISIOLOGIA ED ETOLOGIA<br />
La tartarughina dalle orecchie rosse (Trachemys<br />
scripta elegans), la specie più rappresentativa del<br />
genere Trachemys, ha colorazione verde/gialla su cui<br />
spiccano due chiazze allungate <strong>di</strong> colore rosso tra<br />
occhi e collo. Nel nostro Paese è altresì comune la<br />
Trachemys scripta scripta, che è del tutto simile alla<br />
precedente, fatta salva la mancanza delle macchie<br />
rosse ai lati della testa. Questi animali, nel momento<br />
in cui vengono acquistati dai riven<strong>di</strong>tori, hanno<br />
approssimativamente la <strong>di</strong>mensione <strong>di</strong> una grossa<br />
moneta, ma nel corso della loro vita crescono progressivamente<br />
fi no a raggiungere i 30 cm <strong>di</strong> lunghezza<br />
e i 25 cm <strong>di</strong> <strong>di</strong>ametro.<br />
La morfologia, al pari <strong>di</strong> quella <strong>di</strong> tutte le tartarughe,<br />
è caratterizzata dalla presenza <strong>di</strong> un guscio<br />
coriaceo (in questo caso <strong>di</strong> colore verde/giallo) che<br />
racchiude gli organi interni e che all’occorrenza funge<br />
da riparo per testa, zampe e coda. La parte superiore<br />
della suddetta corazza, <strong>di</strong> forma più o meno<br />
bombata, viene chiamata carapace, mentre quella<br />
inferiore – appiattita – prende nome <strong>di</strong> piastrone.<br />
Tali elementi, saldati tra loro me<strong>di</strong>ante<br />
un ponte osseo laterale, sono in<br />
realtà appen<strong>di</strong>ci scheletriche esterne,<br />
collegate alle vertebre e alle coste.<br />
Lo strato più esterno della corazza<br />
è formato da singoli scu<strong>di</strong> (ciascuno<br />
dei quali ha un proprio nome, a<br />
seconda della sede anatomica in cui<br />
è localizzato) <strong>di</strong>sposti a mosaico,<br />
mentre la parte più interna è costituita<br />
da vere e proprie placche ossee.<br />
Nella testa spiccano gli occhi<br />
(da ricordare come la vista <strong>di</strong> questi<br />
Fotolia<br />
GLI AMICI DELL’UOMO 161<br />
Fotolia
Fotolia<br />
animali sia particolarmente acuta), le orecchie (che<br />
mancano sia <strong>di</strong> pa<strong>di</strong>glione auricolare che <strong>di</strong> condotto<br />
u<strong>di</strong>tivo esterno) e la bocca. Quest’ultima, priva <strong>di</strong><br />
denti, è foggiata a becco d’uccello (con margini alquanto<br />
taglienti) e si continua con esofago, stomaco<br />
e intestino, per confl uire infi ne nella cloaca, una<br />
struttura che accoglie le terminazioni degli apparati<br />
<strong>di</strong>gerente, escretore e riproduttore.<br />
La maturità sessuale viene raggiunta tra i sei e<br />
gli otto anni <strong>di</strong> vita. Le gona<strong>di</strong> (ovaie e testicoli) sono<br />
interne. Le femmine possono conservare gli spermatozoi<br />
nel proprio corpo per lunghi perio<strong>di</strong> e deporre<br />
uova fecondate anche a <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> anni. L’organo<br />
copulatore maschile è alloggiato nella cloaca e può<br />
talora palesarsi all’esterno (erezione) in<strong>di</strong>pendentemente<br />
dalla presenza <strong>di</strong> una femmina. La determinazione<br />
dei sessi non è semplice (specie nei giovani),<br />
in quanto i caratteri secondari non sempre sono<br />
evidenti. In linea <strong>di</strong> principio, tuttavia, i maschi hanno<br />
taglia corporea inferiore a quella delle femmine, ma<br />
possiedono unghie e coda più sviluppate, oltre a una<br />
più accentuata concavità del piastrone.<br />
Tutti i rettili, come già accennato all’inizio, sono<br />
animali eterotermi. Non sono, cioè, capaci <strong>di</strong> mantenere<br />
costante la propria temperatura interna e subiscono<br />
pertanto l’infl uenza delle variazioni climatiche<br />
ambientali. Ciò si ripercuote invariabilmente sul loro<br />
metabolismo e può con<strong>di</strong>zionare, nella stagione invernale,<br />
il ricorso a fenomeni <strong>di</strong> ibernazione e/o letargo.<br />
Le zampe sono provviste <strong>di</strong> unghie ben sviluppate<br />
e la coda, <strong>di</strong> piccole <strong>di</strong>mensioni, è <strong>di</strong> forma<br />
triangolare. Le tartarughine acquatiche, se correttamente<br />
allevate, possono vivere anche un paio <strong>di</strong><br />
decenni e più.<br />
Gli etologi non mancano <strong>di</strong> sottolineare come<br />
le tartarughe, insieme ai coccodrilli, siano i rettili più<br />
intelligenti: proprio per questo, spesso le tartarughine<br />
acquatiche d’appartamento sono in grado <strong>di</strong> riconoscere<br />
chi le accu<strong>di</strong>sce.<br />
Si tratta, inoltre, <strong>di</strong> animali dal carattere abbastanza<br />
“forte”. Pur se abituate a vivere in gruppo,<br />
infatti, è buona norma – al fi ne <strong>di</strong> evitare fenomeni<br />
162 GLI AMICI DELL’UOMO<br />
In natura le<br />
tartarughe e tutti gli<br />
altri rettili trovano<br />
facilmente un<br />
equilibrio<br />
nutrizionale.<br />
In nature, turtles<br />
and all other reptiles<br />
are able to find a<br />
nutritional balance<br />
easily.<br />
<strong>di</strong> aggressività e problemi <strong>di</strong> convivenza – ospitarle<br />
in un acquaterrario dalle <strong>di</strong>mensioni adeguate al<br />
numero <strong>di</strong> animali presenti.<br />
L’ALLOGGIO IDEALE<br />
L’aspetto forse più importante per allevare al<br />
meglio una tartarughina acquatica è la scelta <strong>di</strong> un<br />
habitat il più simile possibile a quello naturale, anche<br />
nel rispetto delle esigenze fi siologiche ed etologiche<br />
dell’animale.<br />
Questi rettili possono essere ospitati in un<br />
idoneo acquaterrario (altresì detto terracquario, collocabile<br />
in casa o all’aperto) oppure in un’area pre<strong>di</strong>sposta<br />
del proprio giar<strong>di</strong>no.<br />
Nel primo caso occorre acquistare una vasca<br />
per pesci con pareti trasparenti (ideale è il vetro,<br />
anche perché più facile da pulire) e <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni<br />
adeguate (in funzione del numero <strong>di</strong> tartarughine da<br />
alloggiarvi all’interno), da posizionare in un luogo<br />
accessibile ma al tempo stesso tranquillo, luminoso<br />
(preferibilmente dove arrivi la luce <strong>di</strong>retta del sole) e<br />
aerato, al riparo da fumi e vapori nocivi, lontano dagli<br />
elettrodomestici e non soggetto a sbalzi climatici.<br />
Sul fondo della vasca può essere auspicabile<br />
stratifi care del ghiaietto <strong>di</strong> fi ume a grana non troppo<br />
piccola (i singoli sassolini devono cioè avere una <strong>di</strong>mensione<br />
superiore a quella della bocca delle tartarughine)<br />
e delle pietre <strong>di</strong> più gran<strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni, il<br />
tutto <strong>di</strong>sposto magari seguendo un gusto estetico<br />
ornamentale. Nell’allestire il fondo è importante fare<br />
in modo che vi siano una zona asciutta e una zona<br />
riempita con acqua: la prima deve essere a sua<br />
volta caratterizzata sia dalla presenza <strong>di</strong> aree ombrose,<br />
fresche e riparate da quella <strong>di</strong> aree in cui gli<br />
animali possano restare fermi a riposare e/o prendere<br />
bagni <strong>di</strong> sole; nella seconda, più esposta alla<br />
luce e a una temperatura maggiore, è preferibile che<br />
l’acqua abbia profon<strong>di</strong>tà <strong>di</strong>fferenti.<br />
La struttura deve essere dotata <strong>di</strong> impianti <strong>di</strong> illuminazione<br />
(è fondamentale la presenza della luce<br />
solare <strong>di</strong>retta o <strong>di</strong> quella emanata da lampade a raggi<br />
UVA – necessari per una corretta visione e per regolarizzare<br />
l’attività riproduttiva – e UVB – in<strong>di</strong>spensabili<br />
per la sintesi della vitamina D e il conseguente corretto<br />
metabolismo del calcio), <strong>di</strong> riscaldamento (cavetti e<br />
tappetini riscaldanti o lampade in vetro-ceramica da<br />
collegare a un termostato e da far funzionare nel rispetto<br />
dei ritmi circa<strong>di</strong>ani stagionali naturali, tenendo<br />
conto che la temperatura ideale – da controllare me<strong>di</strong>ante<br />
un termometro – deve essere compresa tra 20<br />
e 30 gra<strong>di</strong> centigra<strong>di</strong>), <strong>di</strong> aerazione (per impe<strong>di</strong>re il ristagno<br />
<strong>di</strong> umi<strong>di</strong>tà) e <strong>di</strong> fi ltraggio (è consigliabile l’uso<br />
<strong>di</strong> fi ltri esterni meccanici da pulire una volta alla settimana,<br />
tenendo comunque presente che ogni sette<br />
giorni è bene sostituire un terzo dell’acqua totale).<br />
Nel caso in cui, invece, si opti per una soluzione<br />
outdoor (giar<strong>di</strong>no), è utile sapere che le tartarughine<br />
del genere Trachemys si adattano molto bene alla
vita all’aperto anche alle nostre latitu<strong>di</strong>ni. L’importante<br />
è fornire loro un ambiente <strong>di</strong> vaste <strong>di</strong>mensioni, al<br />
riparo da eventuali predatori, recintato e a prova <strong>di</strong><br />
fuga (non <strong>di</strong>mentichiamo che le tartarughine sono<br />
ottime scavatrici), dove sia ovviamente presente un<br />
corso d’acqua, un laghetto (anche artifi ciale) o uno<br />
stagno. La luce e il calore del sole, le mo<strong>di</strong>fi cazioni<br />
della temperatura ambientale, l’alternarsi del giorno<br />
e della notte e tutti gli eventi atmosferici naturali<br />
consentiranno alle bestiole <strong>di</strong> condurre un’esistenza<br />
del tutto simile a quella libera. Anche l’alimentazione,<br />
in questi casi, non costituisce un problema: i rettili,<br />
infatti, sapranno cavarsela egregiamente in maniera<br />
del tutto spontanea.<br />
Un breve accenno merita l’ibernazione, cioè<br />
quello stato <strong>di</strong> rallentamento delle funzioni vitali cui<br />
in natura le tartarughine sottostanno quando la temperatura<br />
ambientale si abbassa e cui è utile sottoporre<br />
tutti gli animali (siano essi ospitati in casa o<br />
fuori) mantenendo la temperatura tra 3 e 8 gra<strong>di</strong><br />
centigra<strong>di</strong> e fornendo loro un rifugio coibentato, contenente<br />
due <strong>di</strong>ta d’acqua.<br />
LE TARTARUGHINE ACQUATICHE<br />
SONO CARNIVORE?<br />
In natura le tartarughine acquatiche sono prevalentemente<br />
vegetariane (si nutrono infatti per lo<br />
più <strong>di</strong> alghe e piante acquatiche <strong>di</strong> vario genere), ma<br />
si cibano occasionalmente anche <strong>di</strong> piccoli pesci e<br />
altri animaletti d’acqua dolce, così come larve d’insetti.<br />
La loro <strong>di</strong>eta, pertanto, non deve essere esclusivamente<br />
proteica o carnivora, come invece molti<br />
negozianti suggeriscono ai loro clienti. La regola<br />
della varietà necessita <strong>di</strong> assoluto rispetto, perché<br />
ciò aiuta a mantenere un buono stato <strong>di</strong> salute e<br />
getta le basi per una lunga sopravvivenza.<br />
I mangimi preconfezionati<br />
per tartarughe acquatiche sono<br />
facilmente reperibili nei negozi<br />
specializzati, ma non devono<br />
essere somministrati in maniera<br />
esclusiva: l’ideale è che i prodotti<br />
liofi lizzati, essiccati e pellettati<br />
rappresentino non più <strong>di</strong> circa un<br />
quarto della razione totale.<br />
Massimo Tognolini<br />
Le tartarughine<br />
acquatiche, se<br />
correttamente<br />
allevate, possono<br />
vivere anche un paio<br />
<strong>di</strong> decenni e più.<br />
If raised properly,<br />
aquatic turtles can<br />
live two decades<br />
and more.<br />
Il termine “tartaruga”<br />
comprende in realtà<br />
circa 250 <strong>di</strong>fferenti<br />
specie zoologiche,<br />
tutte appartenenti<br />
alla classe dei Rettili<br />
e all’or<strong>di</strong>ne dei<br />
Testu<strong>di</strong>nati.<br />
The term “turtle”<br />
covers approximately<br />
250 <strong>di</strong>fferent<br />
zoological species,<br />
all belonging to the<br />
Reptile class and the<br />
Testu<strong>di</strong>nata order.<br />
I vegetali freschi (necessari soprattutto per il<br />
loro contenuto in fi bre, vitamine e fruttosio), sotto<br />
forma <strong>di</strong> verdura e frutta <strong>di</strong> stagione, sono molto<br />
importanti: la scelta può essere ampia e comprende<br />
ra<strong>di</strong>cchio, catalogna, scarola, rucola, zucchina, carota,<br />
mela, pera, uva, ciliegia, albicocca e così via.<br />
Anche le proteine sono utili e vanno fornite con<br />
regolarità (pur se non con continuità) sia sotto forma<br />
<strong>di</strong> prede vive (ciò serve anche a stimolare l’istinto<br />
venatorio e a favorire l’esercizio fi sico) che <strong>di</strong> ingre<strong>di</strong>enti<br />
a pezzettini: pesciolini, molluschi, crostacei,<br />
lombrichi, insetti adulti e larve sono tutti adatti allo<br />
scopo.<br />
Da non scordare che il cibo va sempre <strong>di</strong>spensato<br />
in acqua e che deve essere fornito in quantità<br />
consumabili nel giro <strong>di</strong> pochi minuti al massimo,<br />
poiché eventuali residui possono inquinare l’habitat.<br />
Tutti gli alimenti offerti, infi ne, devono avere<br />
<strong>di</strong>mensioni adeguate alla bocca dei piccoli rettili.<br />
LE PRINCIPALI MALATTIE<br />
DELLA TARTARUGHINA ACQUATICA<br />
Anche le tartarughine acquatiche, come tutti gli<br />
esseri viventi, possono, nel corso della loro esistenza,<br />
andare incontro a problemi patologici più o meno seri.<br />
La maggior parte <strong>di</strong> tali affezioni deriva da errori<br />
gestionali cui le bestiole sono sottoposte e ai<br />
quali spesso si somma l’aggravante <strong>di</strong> squilibri immunitari<br />
derivanti dalle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> stress conseguenti<br />
alle operazioni <strong>di</strong> cattura, trasporto e ven<strong>di</strong>ta.<br />
Una delle più comuni patologie delle tartarughine<br />
(e dei rettili in generale) è la cosiddetta MOM<br />
(Malattia Osseo Metabolica) o MBD (Metabolic Bone<br />
Disease), un’alterazione del metabolismo <strong>di</strong> calcio,<br />
fosforo e vitamina D che, provocata da una <strong>di</strong>eta<br />
inadeguata associata all’insuffi ciente esposizione<br />
alle ra<strong>di</strong>azioni solari, si ripercuote negativamente<br />
sulle ghiandole paratiroi<strong>di</strong>, sullo scheletro, sui reni e<br />
sul sistema nervoso.<br />
Sebbene qualche tempo fa si ritenesse che le<br />
tartarughine acquatiche potessero essere portatrici<br />
sane <strong>di</strong> Salmonelle (e come tali considerate un eventuale<br />
pericolo per la trasmissione della salmonellosi<br />
all’uomo), recenti stu<strong>di</strong> hanno smentito tale ipotesi.<br />
Anche le forme respiratorie si presentano nelle<br />
tartarughine acquatiche con relativa frequenza e si<br />
manifestano con scolo nasale e orale, associato a<br />
<strong>di</strong>ffi coltà <strong>di</strong> galleggiamento e scarso<br />
appetito.<br />
In ogni caso, se il rettile<br />
mostra segni <strong>di</strong> malattia (evento<br />
già <strong>di</strong> per se stesso pre<strong>di</strong>ttivo <strong>di</strong><br />
una problematica <strong>di</strong> non trascurabile<br />
importanza), è buona norma<br />
rivolgersi quanto prima a un me<strong>di</strong>co<br />
veterinario esperto nella cura<br />
degli animali cosiddetti “esotici”<br />
o “non convenzionali”.<br />
Massimo Tognolini<br />
GLI AMICI DELL’UOMO 163
Honoré II,<br />
premier Seigneur<br />
de Monaco<br />
à porter<br />
le titre de Prince<br />
RENÉ NOVELLA<br />
Consigliere privato <strong>di</strong> S. A. S. il Principe Alberto II <strong>di</strong> Monaco<br />
epuis le 8 janvier 1297, date à laquelle le<br />
guelfe Francesco Grimal<strong>di</strong>, <strong>di</strong>t Malizia,<br />
s’était emparé de la forteresse du Rocher,<br />
alors occupée par les gibelins, et après<br />
une courte interruption, douze membres de la dynastie<br />
des Grimal<strong>di</strong> de Monaco ont régné sur ce pays<br />
avec le titre de “Seigneur”, trois avec le titre de<br />
“Coseigneur” (dont un devenu “Seigneur” par la suite)<br />
et un avec le titre de “Seigneur Viager” (en l’occurrence<br />
Augustin Ier , ancien évêque de Grasse, qui a<br />
succédé à son frére Lucien, assassiné sur ordre de<br />
l’amiral Andrea Doria).<br />
En 1589, Hercule Ier D<br />
était devenu Seigneur de<br />
Monaco, après le décès de son frère Charles II. Il<br />
était l’époux de Maria Lan<strong>di</strong> <strong>di</strong> Val <strong>di</strong> Taro, comtesse<br />
de Compiano. A l’instigation du duc de Savoie, il fut<br />
assassiné le 21 novembre 1604, dans la rue du<br />
Milieu (aujourd’hui rue Comte Félix Gastal<strong>di</strong>), non loin<br />
de son château. Il laissait un enfant mineur, prénommé<br />
Honoré, qui fut placé sous la tutelle de son<br />
oncle maternel, le Prince Federico Lan<strong>di</strong> <strong>di</strong> Val <strong>di</strong><br />
Taro.<br />
Honoré II, the first Lord of Monaco<br />
to give himself the title of Prince<br />
At the end of the 1500s, Hercule I Grimal<strong>di</strong> became Lord of Monaco.<br />
But for a lord to demand the title of prince required resolution and<br />
determination: Honoré possessed all of these qualities. To grace his<br />
court, he transformed the old castle into a palace, filling it with<br />
prestigious furnishings and paintings by the great masters. Honoré II<br />
vowed to deliver himself from the Spanish protectorate, and ratified a<br />
pact of assistance in favour of the Principality of Monaco with<br />
Louis XIII, King of France. A splen<strong>di</strong>d period then began in which<br />
Honoré embellished his tiny state with new architectural works of the<br />
like of the Chapel of Mercy. This undertaking earned him the name<br />
“Louis XIV of the Principality”.<br />
164 OLTRE LA VALLE<br />
Ritratto del<br />
Principe Onorato II<br />
opera <strong>di</strong> Philippe<br />
de Champaigne<br />
(Collezioni del<br />
Palazzo dei<br />
Principi).<br />
Portrait of Prince<br />
Honoré II,<br />
a work by Philippe<br />
de Champaigne<br />
(Collections<br />
of the Princes’<br />
Palace).<br />
NOTIZIARIO<br />
Oltre<br />
la Valle<br />
Onorato II,<br />
primo Signore<br />
<strong>di</strong> Monaco<br />
a fregiarsi del<br />
titolo <strong>di</strong> Principe<br />
Dopo l’8 gennaio 1297, data in cui il guelfo<br />
Francesco Grimal<strong>di</strong>, detto Malizia, si era<br />
impadronito della fortezza della Rocca,<br />
allora in mano ai ghibellini, e dopo una<br />
breve interruzione, do<strong>di</strong>ci membri della <strong>di</strong>nastia dei<br />
Grimal<strong>di</strong> <strong>di</strong> Monaco hanno regnato su questo Paese<br />
con il titolo <strong>di</strong> “Signore”, tre con il titolo <strong>di</strong> “Cosignore”<br />
(<strong>di</strong> cui uno <strong>di</strong>venuto “Signore” in seguito) e uno con il<br />
titolo <strong>di</strong> “Signore a vita” (è il caso <strong>di</strong> Agostino I, già<br />
vescovo <strong>di</strong> Grasse, che succedette al fratello Luciano,<br />
assassinato per or<strong>di</strong>ne dell’ammiraglio Andrea Doria).<br />
© Photo Archives du Palais Princier de Monaco - G. Luci
Nel 1589 Ercole I era <strong>di</strong>venuto Signore <strong>di</strong> Monaco,<br />
dopo il decesso del fratello Carlo II. Egli era lo<br />
sposo <strong>di</strong> Maria Lan<strong>di</strong> <strong>di</strong> Val <strong>di</strong> Taro, contessa <strong>di</strong> Compiano.<br />
Su istigazione del duca <strong>di</strong> Savoia fu assassinato<br />
il 21 novembre 1604 in rue du Milieu (oggi rue<br />
Comte Félix Gastal<strong>di</strong>), non lontano dal suo castello.<br />
Lasciò un fi glio in età minore, <strong>di</strong> nome Onorato, che<br />
fu messo sotto la tutela dello zio materno, il Principe<br />
Federico Lan<strong>di</strong> <strong>di</strong> Val <strong>di</strong> Taro.<br />
Come Etienne le Gubernant, tutore <strong>di</strong> Onorato I,<br />
e contro le aspettative dei Monegaschi, Federico<br />
governò <strong>di</strong> buona intesa con gli Spagnoli che, dopo il<br />
1525, data della fi rma del trattato <strong>di</strong> Burgos, perfezionato<br />
a Tordesillas, esercitavano il loro protettorato<br />
su Monaco.<br />
Federico <strong>di</strong> Val <strong>di</strong> Taro fece dare un’eccellente<br />
educazione al suo pupillo. In lui inculcò il gusto delle<br />
arti e delle lettere e soprattutto il senso della “grandeur”,<br />
tanto è vero che, allorché Onorato fu in con<strong>di</strong>zioni<br />
<strong>di</strong> esercitare pienamente il potere, decise <strong>di</strong> rinunciare<br />
al titolo <strong>di</strong> “Signore” e prendere quello <strong>di</strong><br />
“Principe” che parecchie corti d’Europa non tardarono<br />
a riconoscergli.<br />
Egli allora trasformò il suo vecchio castello in un<br />
vero e proprio Palazzo, dove raccolse mobili pregiati,<br />
ricche tappezzerie, soprammobili, libri preziosi, opere<br />
d’arte, pitture e sculture. Possedeva più <strong>di</strong> settecento<br />
quadri <strong>di</strong> maestri che rivaleggiavano con i più<br />
gran<strong>di</strong> musei d’Europa. Tutti questi tesori sfortunatamente<br />
furono oggetto <strong>di</strong> un saccheggio all’epoca<br />
della Rivoluzione francese che ebbe, a Monaco, l’effetto<br />
nefasto risaputo, e il Palazzo venne allora trasformato<br />
in rifugio per men<strong>di</strong>canti, successivamente<br />
in prigione. Dopo la sua salita al trono dei Grimal<strong>di</strong>,<br />
la principale preoccupazione <strong>di</strong> Onorato II fu quella <strong>di</strong><br />
sottrarsi al protettorato spagnolo, che era lungi dall’aver<br />
rispettato gli impegni promessi.<br />
Per questo fece intraprendere delle trattative<br />
segrete con il Car<strong>di</strong>nal Richelieu ma, impaziente <strong>di</strong><br />
venirne a capo, decise <strong>di</strong> non aspettare l’aiuto della<br />
Francia per sbarazzarsi della guarnigione spagnola.<br />
Riunì in un’ala del Palazzo un consistente gruppo <strong>di</strong><br />
Mentonesi, che fece passare, agli occhi dell’occupante,<br />
come prigionieri politici, i quali, ad un segnale<br />
convenuto, attaccarono <strong>di</strong> sorpresa gli Spagnoli.<br />
Questi capitolarono dopo un breve scontro, il 17 novembre<br />
1641.<br />
Due mesi prima, esattamente il 14 settembre,<br />
l’accordo fi rmato a Péronne dal re <strong>di</strong> Francia Luigi XIII,<br />
A sinistra: uno<br />
scudo con l’effigie<br />
<strong>di</strong> Onorato II<br />
(Collezioni del<br />
Palazzo dei<br />
Principi).<br />
Sotto: ritratto <strong>di</strong><br />
Ercole, marchese<br />
<strong>di</strong> Campagna, a<br />
cavallo (Collezioni<br />
del Palazzo dei<br />
Principi).<br />
Left: a shield<br />
with the image<br />
of Honoré II<br />
(Collections of the<br />
Princes’ Palace).<br />
Below: portrait<br />
of Hercule,<br />
marquis of<br />
Campagna, on<br />
horseback<br />
(Collections of the<br />
Princes’ Palace).<br />
Comme Etienne le Gubernant, tuteur d’Honoré I er ,<br />
et contre l’attente des Monégasques, Federico gouverna<br />
en bonne entente avec les Espagnols, qui,<br />
depuis 1525, date de la signature du traité de Burgos,<br />
amendé à Tordesillas, exerçaient leur protectorat<br />
sur Monaco.<br />
Federico <strong>di</strong> Val <strong>di</strong> Taro fi t donner à son pupille<br />
une excellente éducation. Il lui inculqua le goût des<br />
arts et des lettres et surtout le sens de la grandeur,<br />
si bien que, lorsqu’Honoré fut en état d’exercer pleinement<br />
le pouvoir, il décida de renoncer au titre de<br />
“Seigneur” et prit celui de “Prince” que ne tardèrent<br />
pas à lui reconnaître plusieurs Cours d’Europe.<br />
Il transforma alors son vieux château en véritable<br />
Palais, où il réunit meubles de prix, riches tapisseries,<br />
bibelots, livres précieux, oeuvres d’art, peintures<br />
et sculptures. Il possédait plus de sept cents<br />
tableaux de maîtres, de quoi rivaliser avec les plus<br />
grands musées d’Europe. Tous ces trésors furent<br />
malheureusement l’objet d’un pillage, à l’époque de<br />
la Révolution française qui eut, à Monaco, le rôle<br />
néfaste que l’on sait, le Palais ayant été alors transformé<br />
en dépôt de men<strong>di</strong>cité, puis en prison.<br />
© Photo Archives du Palais Princier de Monaco - G. Luci<br />
OLTRE LA VALLE 165
Dès son accession au trône des Grimal<strong>di</strong>, Honoré<br />
II eut pour principal souci de se soustraire au<br />
protectorat espagnol, qui était loin d’avoir respecté<br />
les engagements promis. Pour cela, il fit entreprendre<br />
des négociations secrètes avec le Car<strong>di</strong>nal<br />
Richelieu, mais, impatient d’aboutir, il décida de ne<br />
pas attendre le secours de la France pour se débarrasser<br />
de la garnison espagnole. Il réunit dans une<br />
pièce du Palais un groupe important de Mentonnais,<br />
qu’il fi t passer, aux yeux de l’occupant pour des prisonniers<br />
politiques, qui, à un signal donné, attaquèrent<br />
les Espagnols par surprise. Ceux-ci capitulèrent<br />
après un court combat, le 17 novembre 1641.<br />
Deux mois plus tôt, très exactement le 14 septembre,<br />
le traité signé à Péronne par le roi de France<br />
Louis XIII, avait été ratifi é, après avoir reçu l’approbation<br />
d’Honoré II.<br />
Aux termes de ce traité,<br />
– le roi accordait sa protection à Monaco «à la<br />
prière du Prince», dont il reconnaissait les droits<br />
souverains;<br />
– une garnison française de cinq cents<br />
hommes serait établie sur le Rocher aux frais de la<br />
France, et dont les offi ciers seraient nommés par<br />
le roi, mais la garnison serait placée sous les<br />
ordres du Prince, auquel les offi ciers prêteraient<br />
serment;<br />
– la garnison ne devrait s’immiscer dans aucune<br />
affaire intérieure de la Principauté;<br />
– le Prince serait compris dans tous les traités<br />
de paix signés par le roi;<br />
– en compensation des fi efs qui lui seraient<br />
confi squés par l’Espagne, le Prince recevrait une<br />
rente annuelle de 75.000 livres garantie par des<br />
fi efs français dont l’un serait érigé en duché-pairie,<br />
un autre en marquisat pour son fi ls et un troisième<br />
en comté.<br />
C’est en application de ce dernier paragraphe<br />
que le Prince reçut le duché-pairie de Valentinois; le<br />
comté de Carladez et, en faveur du Prince Héré<strong>di</strong>taire,<br />
le marquisat des Baux et la seigneurie de Saint-<br />
Rémy, en Provence.<br />
Honoré II fréquenta la Cour, où il comptait de<br />
nombreux amis. Il obtint du roi Louis XIII que celui-ci<br />
fût le parrain de son petit-fi ls, Louis. Mais Louis XIII<br />
mourut peu de temps après et avec l’accord du Car<strong>di</strong>nal<br />
Mazarin, Premier Ministre du royaume de<br />
France, ce fut Louis, le futur Louis XIV, alors à peine<br />
166 OLTRE LA VALLE<br />
Un’altra moneta<br />
<strong>di</strong> Onorato II<br />
(Collezioni del<br />
Palazzo dei<br />
Principi).<br />
Another coin<br />
bearing the image<br />
of Honoré II<br />
(Collections of the<br />
Princes’ Palace).<br />
Lo stemma dei<br />
Grimal<strong>di</strong><br />
campeggia sul<br />
Palazzo dei<br />
Principi.<br />
The Grimal<strong>di</strong> coat<br />
of arms in relief<br />
on the Princes’<br />
Palace.<br />
era stato ratifi cato, dopo aver ricevuto l’approvazione<br />
<strong>di</strong> Onorato II.<br />
Nelle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> questo trattato:<br />
– il re accordava la sua protezione a Monaco «su<br />
richiesta del Principe», al quale riconosceva i <strong>di</strong>ritti sovrani;<br />
– una guarnigione francese <strong>di</strong> cinquecento uomini<br />
verrà inse<strong>di</strong>ata sulla Rocca a spese della Francia, e<br />
i cui uffi ciali verranno nominati dal re, ma la guarnigione<br />
sarà agli or<strong>di</strong>ni del Principe, al quale gli uffi ciali<br />
presteranno giuramento;<br />
– la guarnigione non dovrà intromettersi in alcun<br />
affare interno del Principato;<br />
– il Principe sarà inserito in tutti i trattati <strong>di</strong> pace<br />
fi rmati dal re;<br />
– in compenso dei feu<strong>di</strong> che gli verranno confi -<br />
scati dalla Spagna, il Principe otterrà una ren<strong>di</strong>ta annua<br />
<strong>di</strong> 75.000 libbre, garanzia per dei feu<strong>di</strong> francesi<br />
dei quali uno verrà eretto in pari-ducato, un altro in<br />
marchesato per suo fi glio ed un terzo in contea.<br />
Fu in applicazione <strong>di</strong> quest’ultimo paragrafo che<br />
il Principe ricevette il pari-ducato <strong>di</strong> Valentinese; la<br />
contea <strong>di</strong> Carladez e, a favore del Principe Ere<strong>di</strong>tario,<br />
il marchesato <strong>di</strong> Les Baux e la signoria <strong>di</strong> Saint-Rémy,<br />
in Provenza.<br />
Onorato II frequentò la Corte, nella quale contava<br />
molti amici. Egli ottenne da re Luigi XIII che facesse<br />
da padrino al nipote Luigi. Ma Luigi XIII morì poco<br />
tempo dopo e, d’accordo con il Car<strong>di</strong>nale Mazarino,<br />
Primo Ministro del regno <strong>di</strong> Francia, fu Luigi, il futuro<br />
Luigi XIV, all’epoca <strong>di</strong> soli cinque anni <strong>di</strong> età, a fare<br />
Photo Oilime
da padrino al nostro futuro<br />
Luigi I <strong>di</strong> Monaco.<br />
Più tar<strong>di</strong>, grazie alle<br />
sue relazioni a Corte, Onorato<br />
II attirerà sempre più<br />
numerosi membri della<br />
nobiltà francese ed europea<br />
alle brillanti feste che<br />
organizzerà nel suo Palazzo,<br />
trasformato dai fratelli<br />
Giacomo e Tadeo Cantone,<br />
1 “mastri muratori” venuti<br />
apposta da Genova.<br />
Si deve specialmente a<br />
costoro la costruzione<br />
dell’attuale Cappella palatina,<br />
il rifacimento della<br />
grande cisterna sotto il<br />
Cortile d’onore e il pa<strong>di</strong>glione<br />
dei bagni, fortemente<br />
danneggiato durante la<br />
Rivoluzione francese e<br />
successivamente <strong>di</strong>strutto.<br />
Sono loro che hanno<br />
costruito anche la Cappella<br />
della Misericor<strong>di</strong>a, sede<br />
dell’Arciconfraternita dei<br />
Penitenti.<br />
Per contrassegnare<br />
la propria sovranità, Onorato<br />
II aveva creato, dal<br />
1640, una zecca ove si<br />
fabbricavano tra gli altri dei “Talari”, monete d’argento<br />
imitanti il “Tallero” e sulle quali fi gura lo scudo inquartato<br />
dei Grimal<strong>di</strong> e dei Lan<strong>di</strong>. Dopo il trattato <strong>di</strong><br />
Péronne, venne autorizzato dal regno <strong>di</strong> Francia a<br />
coniare monete, ammesse a circolare sul territorio<br />
francese, a con<strong>di</strong>zione che avessero lo stesso peso,<br />
titolo e modulo delle monete francesi, e così è stato<br />
fi no alla nascita dell’euro.<br />
Durante il soggiorno a Parigi, il 2 agosto 1651,<br />
Onorato II ebbe il dolore <strong>di</strong> perdere il fi glio Ercole,<br />
marchese <strong>di</strong> Les Baux, marito <strong>di</strong> Aurelia Spinola,<br />
morto accidentalmente, esercitandosi al tiro, durante<br />
una festa campestre, in un giar<strong>di</strong>no <strong>di</strong> Carnolès. Sarà<br />
dunque suo nipote Luigi a succedergli.<br />
Ma prima <strong>di</strong> lasciare questa terra, Onorato II<br />
ebbe ancora la gioia <strong>di</strong> vedere il matrimonio <strong>di</strong> Luigi<br />
con Carlotta Caterina de Gramont, fi glia del celebre<br />
Maresciallo de Gramont e, un anno più tar<strong>di</strong>, <strong>di</strong> conoscere<br />
il suo pronipote, Antonio, il futuro Antonio I.<br />
Onorato II morì qualche tempo dopo, il 10 gennaio<br />
1662.<br />
Lo storico <strong>di</strong> Monaco Gustave Saige ha scritto<br />
che «Onorato II è stato il Luigi XIV del Principato».<br />
1) Attraverso la nonna materna, Dévote Cantone, l’autore<br />
<strong>di</strong> questo artipMaria Guarnera, nata a Monaco il 10 agosto<br />
1626.<br />
Ritratto del<br />
Principe Luigi I, <strong>di</strong><br />
François de Troy<br />
(Collezioni del<br />
Palazzo dei<br />
Principi).<br />
Portrait of Prince<br />
Louis I, by<br />
François de Troy<br />
(Collections of the<br />
Princes’ Palace).<br />
âgé de cinq ans, qui fut le<br />
parrain de notre futur<br />
Louis Ier de Monaco. Plus<br />
tard, grâce à ses relations<br />
à la Cour, Honoré II attirera<br />
de plus en plus de<br />
membres de la noblesse<br />
française et européenne<br />
aux fêtes brillantes qu’il<br />
organisera à Monaco, dans<br />
son Palais, transformé par<br />
les frères Giacomo et<br />
Tadeo Cantone, 1 “mastri<br />
muratori”, venus de Gênes<br />
pour l’occasion. On doit<br />
notamment à ceux-ci la<br />
construction de l’actuelle<br />
Chapelle palatine, la réfection<br />
de la grande citerne<br />
sous la Cour d’honneur et<br />
le pavillon des bains, fortement<br />
endommagé pendant<br />
la Révolution française<br />
et détruit par la suite.<br />
Ce sont eux qui ont<br />
construit aussi la Chapelle<br />
de la Miséricorde, siège de<br />
l’Archiconfrérie des Pénitents.<br />
Pour marquer sa<br />
souveraineté, Honoré II<br />
avait créé, dès 1640, un<br />
atelier monétaire où l’on fabriquait, entre autres des<br />
“Talari”, pièces d’argent imitant le “Thaler” et sur<br />
lesquelles fi gure l’écu écartelé des Grimal<strong>di</strong> et des<br />
Lan<strong>di</strong>. Après le traité de Péronne, il fut autorisé par<br />
le royaume de France, à frapper des pièces, admises<br />
à circuler sur le territoire français, à con<strong>di</strong>tion d’avoir<br />
le même poids, titre et module que les monnaies<br />
françaises, ce qui demeurait le cas, avant la naissance<br />
de l’euro.<br />
Alors qu’il se trouvait à Paris, le 2 août 1651,<br />
Honoré II eut la douleur de perdre son fi ls Hercule,<br />
marquis des Baux, époux d’Aurelia Spinola, mort<br />
accidentellement, en s’exerçant au tir, lors d’une fête<br />
champêtre, dans un jar<strong>di</strong>n de Carnolès. Ce sera donc<br />
son petit-fi ls, Louis, qui lui succédera.<br />
Mais, avant de quitter notre monde, Honoré II eut<br />
encore la joie de voir le mariage de Louis avec Charlotte-Catherine<br />
de Gramont, fi lle du célèbre Maréchal<br />
de Gramont et, un an plus tard, de connaître son arrière-petit-fi<br />
ls, Antoine, le futur Antoine Ier . Honoré II<br />
décéda quelque temps après, le 10 janvier 1662.<br />
L’historien de Monaco, Gustave Saige a écrit<br />
qu’«Honoré II a été le Louis XIV de la Principauté».<br />
© Photo Archives du Palais Princier de Monaco - G. Luci<br />
1) Par sa grand-mère maternelle, Dévote Cantone, l’auteur<br />
de ces lignes est un descendant <strong>di</strong>rect de Tadeo, qui avait<br />
épousé en 1643, Anna-Maria Guarnera, née à Monaco le 10<br />
août 1626.<br />
OLTRE LA VALLE 167
Da un mondo conta<strong>di</strong>no al turismo in Riviera<br />
168 OLTRE LA VALLE<br />
Portofi no, Santa Margherita<br />
Ligure, Rapallo. Nomi<br />
noti <strong>di</strong> località del circondario<br />
<strong>di</strong> Chiavari che richiamano<br />
alla mente immagini <strong>di</strong><br />
mare, <strong>di</strong> vacanze, <strong>di</strong> turismo, legando<br />
in<strong>di</strong>ssolubilmente questo<br />
tratto della riviera ligure all’idea <strong>di</strong><br />
una certa <strong>di</strong>mensione del tempo<br />
libero, che alimenta (ed è sostenuta)<br />
un insieme <strong>di</strong> attività economiche,<br />
una varietà <strong>di</strong> iniziative impren<strong>di</strong>toriali<br />
che rendono una signifi<br />
cativa porzione della Liguria<br />
vivace e ricca, oltre che dal paesaggio<br />
e dalla natura suggestivi e<br />
affascinanti. Ciò è il risultato <strong>di</strong> un<br />
processo che, avviatosi dopo l’Unità<br />
d’Italia, ha trasformato e pla-<br />
smato l’economia e la società del<br />
Chiavarese, arretrate all’inizio<br />
dell’Ottocento e <strong>di</strong>venute alla vigilia<br />
della Prima Guerra mon<strong>di</strong>ale<br />
ben più prospere e <strong>di</strong>namiche.<br />
Prima dell’Unità:<br />
un’economia preindustriale<br />
L’agricoltura. Alla metà dell’Ottocento<br />
il circondario <strong>di</strong> Chiavari versa in<br />
una con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> arretratezza.<br />
La grande maggioranza della<br />
popolazione vive in aree poco<br />
o nulla urbanizzate e l’agricoltura<br />
è l’attività economica centrale.<br />
Un’agricoltura povera, praticata<br />
da conta<strong>di</strong>ni piegati dalla fatica<br />
sulle “fasce”, sostenute da muri<br />
a secco costruiti alternando fi le<br />
MARCO DORIA<br />
Docente <strong>di</strong> Storia economica<br />
presso p l’Università <strong>di</strong> Genova<br />
Le trasformazioni<br />
economiche e sociali del Chiavarese<br />
dall’Unità d’Italia al 1914<br />
Matteo Vinzoni,<br />
Chiavari, 1773.<br />
Archvio Sagep, Genova<br />
<strong>di</strong> pietre e <strong>di</strong> zolle erbose. In questo<br />
paesaggio, come si scrive su<br />
Il Politecnico nel 1860, «il conta<strong>di</strong>no<br />
(…) si strenua in erculei lavori,<br />
ed è cosa che fa stupore e<br />
ad un tempo stringe miseramente<br />
il cuore vederlo ad ogni acquazzone<br />
andarsene appiè della<br />
collina e con ceste apportar pazientemente<br />
sui denudati fi anchi<br />
il terreno che l’acqua rapiva». Gli<br />
strumenti dei conta<strong>di</strong>ni (i «più<br />
<strong>di</strong>ffusi… anzi quasi i soli adoperati»)<br />
sono la zappa, il piccone, la<br />
falce oltre agli attrezzi necessari<br />
per rimuovere e spaccare le pietre;<br />
non si usa l’aratro né è possibile<br />
avvalersi della ruota; i trasporti<br />
si effettuano a dorso d’uo-<br />
The economical and social<br />
transformations in the Chiavari<br />
region from the Unification<br />
of Italy to 1914<br />
Before the Unification of Italy, a “heroic”<br />
agricultural economy prevailed made possible<br />
by enormous sacrifices and primor<strong>di</strong>al<br />
instruments. During pauses from working the<br />
land, the loom was always a prominent<br />
feature: silk, satin and damask fabrics. A<br />
single form of industry: extracting slate, but<br />
the “chiapparolo <strong>di</strong>sease” (silicosis) mowed<br />
down its victims ruthlessly. Indeed the major<br />
lines of communication were the driving force<br />
behind progress. No longer just the coast<br />
road and a mule track, but the Genoa-<br />
Chiavari railroad line. The local economic<br />
system shifted into a <strong>di</strong>fferent gear. Workers<br />
migrated to the Po Valley, to the Maremma<br />
area and to Sar<strong>di</strong>nia. In the early 1900s they<br />
returned with their fortunes to invest in new<br />
activities, giving rise to tourism, the<br />
“ foreigner industry”.
mo: così viaggiano il letame, in<br />
ceste <strong>di</strong> vimini facili da rovesciare,<br />
e le patate, il mais, le castagne,<br />
alimenti fondamentali delle popolazioni<br />
rurali.<br />
Si producono cereali, patate,<br />
legumi, castagne, ortaggi, vino,<br />
olio, frutta. Questi ultimi sono più<br />
tipici dell’agricoltura costiera, più<br />
prospera <strong>di</strong> quella miserrima dell’interno<br />
e oggetto verso la metà<br />
del l’Ottocento <strong>di</strong> investimenti che<br />
favoriscono la <strong>di</strong>ffusione degli uliveti<br />
nei terreni prossimi al mare. La<br />
proprietà fon<strong>di</strong>aria è assai polverizzata<br />
(a fi ne Ottocento due ettari <strong>di</strong><br />
terreno coltivato in me<strong>di</strong>a) e rari<br />
sono i tentativi <strong>di</strong> migliorare produzione<br />
e produttività.<br />
L’attività manifatturiera ed estrattiva.<br />
Nel settore manifatturiero domina<br />
l’industria tessile, praticata a<br />
domicilio nelle campagne. In uno<br />
stu<strong>di</strong>o del 1846 si afferma che<br />
«specialmente ne’ comuni <strong>di</strong> Chiavari,<br />
<strong>di</strong> Fontanabuona, <strong>di</strong> Rapallo,<br />
non vi è casa <strong>di</strong> popolo che non<br />
abbia un telaio»; la tessitura, cui è<br />
a<strong>di</strong>bita una manodopera prevalentemente<br />
femminile, si svolge nelle<br />
«ore superfl ue alle cure agricole,<br />
con gran vantaggio dell’igiene e<br />
1882 - Immagine<br />
dell’attività<br />
cantieristica: un<br />
brigantino goletta<br />
(a sinistra) e una<br />
goletta gabbiola<br />
poco prima del varo.<br />
1882 - Image of the<br />
shipbuil<strong>di</strong>ng activity:<br />
a brigantine<br />
schooner<br />
(on the left) and a<br />
topsail schooner just<br />
before the launch.<br />
della morale, evitando i mali cui<br />
soggiacciono [madri e sorelle] nelle<br />
fabbriche».<br />
Praticata è ancora la lavorazione<br />
della seta. Già nel XV secolo<br />
si erano trasferiti nel Chiavarese<br />
da Genova numerosi aspiranti appren<strong>di</strong>sti,<br />
desiderosi <strong>di</strong> emanciparsi<br />
dal controllo della corporazione<br />
citta<strong>di</strong>na. Sul fi nire del Settecento<br />
sono rinomati i velluti <strong>di</strong> Zoagli e i<br />
rasi e i damaschi della Fontanabuona.<br />
Anche questa attività col<br />
tempo <strong>di</strong>viene appannaggio delle<br />
donne. Il ciclo della seta è completo:<br />
si coltiva il gelso, anche se la<br />
seta greggia localmente prodotta<br />
è abbondantemente integrata con<br />
quella messa a <strong>di</strong>sposizione dai<br />
mercanti, sono attive le fi lande<br />
(una trentina nel 1818, tra Rapallo,<br />
Chiavari e Sestri Levante, con<br />
circa 400 addetti).<br />
Nel circondario si producono<br />
inoltre se<strong>di</strong>e, una lavorazione che<br />
interessa mezzo migliaio <strong>di</strong> artigiani,<br />
e naviglio in legno <strong>di</strong> limitato<br />
tonnellaggio, costruito sugli arenili<br />
<strong>di</strong> Chiavari e Lavagna.<br />
Un ruolo particolare ha l’industria<br />
estrattiva dell’ardesia –<br />
Cogorno ne è il centro principale<br />
– i cui prodotti sono lastre da<br />
Archivio Storico del Banco <strong>di</strong> Chiavari<br />
tetto e da pavimento, ripiani per<br />
mobili <strong>di</strong> lusso e vasche per liqui<strong>di</strong>.<br />
Nel 1834 in 70 cave attive lavorano<br />
400 cavatori, organizzati<br />
in piccole compagnie, salariati da<br />
uno <strong>di</strong> loro o più frequentemente<br />
associati. Essi, armati <strong>di</strong> picconi,<br />
leve in ferro, scalpelli e dotati <strong>di</strong><br />
lumi ad olio, <strong>di</strong>staccano i blocchi<br />
dai quali si ricavano le lastre. Il<br />
lavoro è pesante e, come scrive<br />
un osservatore nel 1809, «coloro<br />
che travagliano sotterra… son<br />
vecchi passati che abbiano li 40<br />
o al più i 50 anni». Miete vittime il<br />
«male del chiapparolo» che solo<br />
alla fi ne dell’Ottocento sarà più<br />
correttamente defi nito silicosi. Le<br />
lastre, trasportate a Lavagna,<br />
sono rifi nite da scalpellini o caricate<br />
su piccoli bastimenti che attendono<br />
in rada. La commercializzazione<br />
del prodotto è saldamente<br />
nelle mani dei mercanti <strong>di</strong> Lavagna<br />
e <strong>di</strong> Genova.<br />
Le con<strong>di</strong>zioni sociali del circondario.<br />
Povere sono le abitazioni dei conta<strong>di</strong>ni<br />
e la loro alimentazione, scarsa<br />
<strong>di</strong> proteine animali e grassi, a<br />
base <strong>di</strong> castagne e polenta. Egualmente<br />
misero è il pasto dei cavatori<br />
d’ardesia che consumano un<br />
po’ <strong>di</strong> minestra <strong>di</strong> verdura accompagnata<br />
da focaccia <strong>di</strong> mais.<br />
Le epidemie sono ricorrenti.<br />
Nel 1829 si tratta del vaiolo, poi<br />
debellato dall’uso del vaccino. Più<br />
duratura è la presenza del colera<br />
che colpisce nel triennio 1835-37<br />
e nel 1854, con centinaia <strong>di</strong> vittime.<br />
Alta è la mortalità infantile e<br />
bassa la speranza <strong>di</strong> vita alla nascita,<br />
inferiore ai 40 anni agli inizi<br />
degli anni Ottanta.<br />
Si riduce solo verso la fi ne<br />
del secolo il fenomeno dell’abbandono<br />
dei neonati alla Ruota o davanti<br />
alle chiese. Gli infanti così<br />
raccolti vengono inviati all’ospedale<br />
<strong>di</strong> Chiavari; se sopravvivono sono<br />
in genere affi dati a balia alle<br />
donne conta<strong>di</strong>ne, che ricevono<br />
una somma in denaro dall’amministrazione<br />
sino al compimento del<br />
do<strong>di</strong>cesimo anno d’età del fanciullo<br />
e possono <strong>di</strong>sporre presto <strong>di</strong> un<br />
aiuto per il <strong>di</strong>sbrigo delle più umili<br />
mansioni, a cominciare dal controllo<br />
delle bestie.<br />
OLTRE LA VALLE 169
Lentamente migliorano i livelli<br />
d’istruzione. Nel 1848 quasi<br />
l’87% degli abitanti sono analfabeti,<br />
percentuale che declina grazie<br />
alla <strong>di</strong>ffusione dell’insegnamento<br />
elementare. I comuni destinano<br />
all’istruzione risorse consistenti<br />
dei loro peraltro contenuti bilanci<br />
ma, soprattutto nelle zone rurali,<br />
larga è l’inosservanza dell’obbligo<br />
scolastico e spesso insod<strong>di</strong>sfacente<br />
la con<strong>di</strong>zione dei locali a<strong>di</strong>biti<br />
a scuole.<br />
Diversa è la realtà delle citta<strong>di</strong>ne<br />
costiere. Sono qui attivi un<br />
ceto mercantile, che controlla i<br />
traffi ci da e per l’entroterra, una<br />
borghesia delle professioni attenta<br />
a quanto matura nel Paese e<br />
all’estero, così come – e si tratta<br />
del gruppo socio-economico più<br />
<strong>di</strong>namico – un nucleo <strong>di</strong> famiglie <strong>di</strong><br />
commercianti-armatori impegnati<br />
nei commerci <strong>di</strong> più ampio respiro,<br />
che posseggono, alla metà del<br />
secolo, velieri sulle 500 tonnellate<br />
che solcano gli oceani.<br />
I trasporti e i commerci. I commerci<br />
sono ostacolati dalle con<strong>di</strong>zioni<br />
delle vie <strong>di</strong> comunicazione. La sola<br />
“carrettiera” esistente nel circondario<br />
alla metà del secolo è la litoranea<br />
che collega Genova con la<br />
Toscana. Per l’entroterra si percorrono<br />
le “strade delle mule”, tra<strong>di</strong>zionali<br />
tracciati che partendo dalla<br />
costa si spingono verso la Pianura<br />
Padana. Importante è la navigazione<br />
<strong>di</strong> cabotaggio, più conveniente<br />
del trasporto su strada.<br />
Lungo queste linee <strong>di</strong> comunicazione<br />
arrivano derrate alimentari<br />
necessarie al consumo locale,<br />
materie prime per l’attività manifatturiera<br />
e manufatti, mentre si<br />
“esportano” specifi ci prodotti agricoli,<br />
artigianali e industriali.<br />
La rottura dei vecchi equilibri<br />
e il cambiamento<br />
Spinte endogene e sollecitazioni<br />
dall’esterno. Si propone <strong>di</strong> “migliorare<br />
l’agricoltura, le arti e il commercio”<br />
nel circondario la Società<br />
Economica, costituita a Chiavari<br />
nel 1791 per iniziativa <strong>di</strong> una cinquantina<br />
<strong>di</strong> liberi professionisti,<br />
alcuni proprietari, <strong>di</strong>versi ecclesiastici.<br />
Il sodalizio incentiva ad<br />
170 OLTRE LA VALLE<br />
esempio, sul fi nire del Settecento,<br />
la coltivazione della patata e sostiene<br />
le innovazioni nella manifattura,<br />
ma non riesce a incidere in<br />
profon<strong>di</strong>tà sulle pratiche e la mentalità<br />
dei soggetti economici. Resta<br />
refrattaria alle novità la proprietà<br />
terriera locale e pesa la<br />
“pigrizia” <strong>di</strong> un ambiente provinciale;<br />
soprattutto mancano le con<strong>di</strong>zioni<br />
strutturali idonee a favorire<br />
accumulazione <strong>di</strong> capitale e investimenti.<br />
Il fattore decisivo per il cambiamento<br />
è la costruzione <strong>di</strong> un<br />
moderno sistema <strong>di</strong> trasporti. Nel<br />
1868 entra in esercizio la linea<br />
ferroviaria Genova-Chiavari; nel<br />
1870 viene ultimato il tratto sino a<br />
Sestri Levante e nel 1874 il treno<br />
giunge sino alla Spezia: sono possibili<br />
nuovi collegamenti, non solo<br />
con Genova ma anche con la Pianura<br />
Padana, via Genova, e con la<br />
Toscana. Si riducono, grazie al<br />
treno, tempi e costi del trasporto:<br />
il tragitto <strong>di</strong> 36 chilometri da Chiavari<br />
a Genova viene percorso in<br />
1890 - Sulla spiaggia<br />
<strong>di</strong> Chiavari donne al<br />
lavoro, intente a<br />
imbarcare su <strong>di</strong> un<br />
leudo lastre <strong>di</strong><br />
ardesia provenienti<br />
dalle cave della<br />
Val Fontanabuona.<br />
Archivio Storico del Banco <strong>di</strong> Chiavari<br />
1890 - On the beach<br />
at Chiavari, women<br />
at work, busy<br />
loa<strong>di</strong>ng slabs of slate<br />
from the quarry of<br />
Val Fontanabuona on<br />
to a “leudo” (boat<br />
for coastal tra<strong>di</strong>ng).<br />
un’ora e venti minuti. Si articola e<br />
si irrobustisce inoltre la rete stradale.<br />
Inserito in un mondo che rapidamente<br />
cambia, anche il Chiavarese<br />
avvia la sua graduale trasformazione.<br />
Nel 1889-90, si contano<br />
8.740 addetti all’industria (6.901<br />
nel settore tessile), ancora largamente<br />
tra<strong>di</strong>zionale, includendo<br />
4.647 donne che, specie a Rapallo<br />
e Santa Margherita, fabbricano a<br />
domicilio pizzi e merletti <strong>di</strong> seta e<br />
cotone. È <strong>di</strong> fatto inesistente l’occupazione<br />
nei comparti tecnologicamente<br />
più avanzati. La lavorazione<br />
dei tessuti <strong>di</strong> seta conserva il<br />
suo spazio <strong>di</strong> nicchia: nel 90 sono<br />
circa 1.200 i telai casalinghi <strong>di</strong><br />
Zoagli soprattutto e poi <strong>di</strong> Chiavari,<br />
Lorsica e Rapallo. La cantieristica<br />
in legno, nel volgere <strong>di</strong> pochi anni,<br />
è letteralmente spazzata via dalla<br />
scena e la sua crisi precede <strong>di</strong><br />
poco l’irreversibile declino della<br />
marineria velica. Per quanto riguarda<br />
l’ardesia, infi ne, proprio a partire<br />
dagli anni Sessanta-Settanta<br />
inizia la decadenza delle cave <strong>di</strong><br />
Cogorno, a causa degli alti costi <strong>di</strong><br />
escavazione del materiale e della<br />
loro arretrata organizzazione.<br />
Si avvertono però anche segnali<br />
positivi. Nello stesso campo<br />
dell’ardesia, ad esempio, decolla<br />
l’attività estrattiva in Fontanabuona.<br />
Favorita dalla realizzazione<br />
della strada, un’impren<strong>di</strong>toria locale<br />
d’origine commerciale – nessuno<br />
tra i fondatori delle nuove <strong>di</strong>tte<br />
ha un passato da cavatore – avvia<br />
nel territorio dei comuni <strong>di</strong> Moconesi,<br />
Lorsica e Orero lo sfruttamento<br />
delle cave, collegate con<br />
teleferiche alla strada carrabile; il<br />
processo lavorativo, con l’introduzione<br />
<strong>di</strong> macchine mosse da motori<br />
elettrici, è almeno in parte<br />
“industriale”.<br />
Nella zona <strong>di</strong> Sestri Levante<br />
sono attive alcune miniere <strong>di</strong> rame<br />
gestite da una società inglese,<br />
mentre una <strong>di</strong>tta francese estrae<br />
manganese nei giacimenti della<br />
Val Graveglia. Capitali e impren<strong>di</strong>tori<br />
stranieri affi ancano gli operatori<br />
locali. Nel settore industriale la<br />
presenza <strong>di</strong> maggior rilievo è quella<br />
della Esercizio Bacini, specializzata<br />
in Genova nel lavoro delle ri-
parazioni navali, che a fi ne Ottocento<br />
costruisce un moderno cantiere<br />
navale a Riva Trigoso. Sono<br />
stati introdotti nel frattempo nuovi<br />
macchinari mossi da energia meccanica<br />
per la tessitura del lino e<br />
per la fi latura della seta, così come<br />
in alcuni oleifi ci e in fi lande cotoniere.<br />
La grande emigrazione. La prova<br />
più evidente dell’integrazione del<br />
Chiavarese in un sistema economico<br />
globale è rappresentata dal<br />
fenomeno migratorio, che interessa<br />
decine <strong>di</strong> migliaia <strong>di</strong> persone.<br />
Quella dell’emigrazione è storia<br />
antica per il circondario. Emigrazione<br />
stagionale, che si ripete regolare<br />
nel tempo, <strong>di</strong> uomini che si<br />
recano a lavorare nella Pianura<br />
Padana, nelle risaie, per la raccolta<br />
delle foglie del gelso e anche<br />
per essere impegnati nelle opere<br />
<strong>di</strong> irrigazione, o che raggiungono<br />
località più lontane, come la Maremma<br />
e la campagna romana; i<br />
montanari si recano a tagliare boschi<br />
e a lavorare per la produzione<br />
<strong>di</strong> carbone in Corsica, Sardegna e<br />
lungo l’arco appenninico. Il primo<br />
censimento generale del Regno<br />
d’Italia del 1861 ricorda questa<br />
emigrazione «<strong>di</strong> zappa, <strong>di</strong> falce e <strong>di</strong><br />
scure», destinata peraltro a ridursi<br />
progressivamente con la crescita<br />
e l’esplosione dell’emigrazione<br />
transoceanica.<br />
A partire dalla seconda metà<br />
degli anni Quaranta si assiste infatti<br />
a un cambiamento quantitativo<br />
e qualitativo dei fl ussi migratori.<br />
Le crisi agricole, il miraggio dell’oro<br />
californiano, l’istituzione nel 1854<br />
della ferma quinquennale per i coscritti<br />
nel Regno <strong>di</strong> Sardegna, rispetto<br />
alla quale altissima è la renitenza,<br />
incoraggiano le partenze.<br />
Emigrano soprattutto i conta<strong>di</strong>ni.<br />
Leone Carpi, autore negli anni<br />
Settanta dell’Ottocento <strong>di</strong> un approfon<strong>di</strong>to<br />
stu<strong>di</strong>o sul tema, riferendosi<br />
agli emigranti del Genovesato<br />
– e gli abitanti del Chiavarese ne<br />
sono <strong>di</strong> gran lunga la maggioranza<br />
– <strong>di</strong>ce che «essendo operosi e industriosi<br />
fanno più facilmente degli<br />
altri un poco <strong>di</strong> fortuna, ma per<br />
lo più anch’essi fi niscono male.<br />
Tutti i nostri consoli ci fanno rapporti<br />
[…] e tutti ripetono la stessa<br />
cosa […] che ci sono tanti affamati,<br />
tanti saltimbanchi, tanti giocolieri,<br />
tanti che suonano l’organetto».<br />
La miseria è la ragione prima<br />
della scelta <strong>di</strong> partire, cui la volon-<br />
Archivio Sagep, Genova<br />
Fine ´800 - L’imbarco<br />
nel porto <strong>di</strong> Genova.<br />
Il fenomeno interessa<br />
pesantemente il<br />
territorio <strong>di</strong> Chiavari.<br />
Una parte delle<br />
rimesse <strong>di</strong> emigrati<br />
originari del<br />
circondario confluirà<br />
nel Banco <strong>di</strong> Sconto.<br />
Late 19th century.<br />
Boar<strong>di</strong>ng in the port<br />
of Genoa.<br />
The phenomenon<br />
greatly affected the<br />
Chiavari area. Part of<br />
the remittances from<br />
emigrants from the<br />
region went into the<br />
Banco <strong>di</strong> Sconto.<br />
tà <strong>di</strong> evitare il servizio militare offre<br />
non <strong>di</strong> rado il pretesto. La meta è<br />
l’America. Gli abitanti delle fasce<br />
costiere e quelli dell’entroterra seguono<br />
percorsi migratori <strong>di</strong>versi: i<br />
primi, che animano i fl ussi iniziali<br />
dalla metà del secolo, si <strong>di</strong>rigono<br />
<strong>di</strong> preferenza nelle terre del Rio de<br />
la Plata; i secon<strong>di</strong> prendono più<br />
spesso la via degli Stati Uniti.<br />
L’emigrazione, necessaria<br />
valvola <strong>di</strong> sfogo per una altrimenti<br />
insostenibile pressione demografi -<br />
ca, frena la crescita della popolazione<br />
nell’ultimo trentennio del<br />
secolo; in talune aree dell’entroterra<br />
si registrano sal<strong>di</strong> demografi ci<br />
negativi e anche nei comuni costieri<br />
l’incremento della popolazione,<br />
almeno sino agli anni Ottanta,<br />
è praticamente nullo.<br />
Sono inoltre duraturi gli effetti<br />
del “ritorno a casa” <strong>di</strong> persone e<br />
capitali accumulati all’estero. Chi<br />
ritorna decide in genere <strong>di</strong> risiedere<br />
nelle citta<strong>di</strong>ne costiere, a Chiavari,<br />
Lavagna, Rapallo, e nella<br />
stessa Genova. I capitali accumulati<br />
all’estero sono investiti soprattutto<br />
nell’e<strong>di</strong>lizia o comunque nel<br />
mercato immobiliare. Si acquistano<br />
e<strong>di</strong>fi ci già esistenti, se ne costruiscono<br />
<strong>di</strong> nuovi: a Riva Trigoso<br />
sarà soprannominata “via Dollari”<br />
(“dollari” è la defi nizione <strong>di</strong> qualsivoglia<br />
somma <strong>di</strong> denaro <strong>di</strong> provenienza<br />
estera) una strada i cui<br />
e<strong>di</strong>fi ci sono tutti realizzati coi soli<br />
risparmi degli emigrati.<br />
Altri “dollari” sono investiti<br />
nell’agricoltura: si <strong>di</strong>ffonde un poco<br />
la vite, accanto alle colture <strong>di</strong><br />
cereali e ortaggi, a spese del bosco;<br />
sono più curati i castagneti;<br />
meno selvaggio <strong>di</strong>viene il paesaggio<br />
agrario. Protagonisti <strong>di</strong> queste<br />
micro-trasformazioni sono emigranti<br />
che, tornati in patria, <strong>di</strong>ventano<br />
agricoltori-possidenti capaci<br />
fi nalmente <strong>di</strong> vivere <strong>di</strong> ren<strong>di</strong>ta. Infi -<br />
ne, i “dollari” alimentano la crescita<br />
del sistema bancario locale.<br />
Il primo Novecento. Una realtà in<br />
movimento. Diverse sono le evoluzioni<br />
dell’entroterra e della fascia<br />
costiera. Il primo è teatro della<br />
crisi e della scomparsa delle vecchie<br />
esperienze manifatturiere,<br />
non rimpiazzate da signifi cative<br />
OLTRE LA VALLE 171
iniziative (il decollo del bacino<br />
dell’ardesia della Fontanabuona<br />
rappresenta un’eccezione), e <strong>di</strong>venta<br />
sempre più area da cui attingere<br />
forza lavoro. Migliore è la<br />
con<strong>di</strong>zione della costa: la possibilità<br />
<strong>di</strong> percorrere in un’ora e venti<br />
minuti <strong>di</strong> treno il percorso da Chiavari<br />
a Genova crea nuove relazioni<br />
tra il Tigullio e il capoluogo ligure<br />
che <strong>di</strong>viene un fortissimo polo<br />
d’attrazione per il Chiavarese.<br />
All’inizio del XX secolo si completa<br />
la trasformazione avviatasi<br />
nell’ultimo terzo dell’Ottocento.<br />
Il peso dell’agricoltura si riduce<br />
progressivamente anche se<br />
nella zona costiera, verso la fi ne<br />
Chiavari <strong>di</strong><br />
dell’Ottocento, si sviluppa la fl oricoltura<br />
e prendono campo nuove<br />
Banco del<br />
coltivazioni <strong>di</strong> ortaggi e frutta.<br />
Per quanto riguarda l’indu-<br />
Storico<br />
stria, nel settore dell’ardesia si<br />
effettuano ulteriori investimenti Archivio<br />
172 OLTRE LA VALLE<br />
LA CAPITALE DEL GOLFO DEL TIGULLIO: IL SUO VOLTO OGGI<br />
Massimo Mandelli
Archivio Storico del Banco <strong>di</strong> Chiavari<br />
Sono 27.000 (il 6% dei quali stranieri) gli abitanti <strong>di</strong><br />
Chiavari, terza città della provincia <strong>di</strong> Genova dopo<br />
il capoluogo e Rapallo per popolazione. Guardando<br />
ancora alla demografi a si rileva come l’età me<strong>di</strong>a degli<br />
abitanti sfi ori i 48 anni e i nuclei familiari siano oltre<br />
13.000. L’agglomerato urbano è situato alla destra del<br />
fi ume Entella che qui sfocia al termine della sua piana<br />
alluvionale, <strong>di</strong>videndo ad est la città dall’attigua Lavagna.<br />
Il centro storico chiavarese appare ben conservato<br />
e caratterizzato dalla presenza dei portici lungo il Caruggio<br />
Dritto – (via Martiri della Liberazione) – su cui sin<br />
dalla seconda metà del XIV secolo si affacciavano le <strong>di</strong>more<br />
delle borghesia citta<strong>di</strong>na. Non mancano <strong>di</strong>more che<br />
ricordano negli stili architettonici magioni sudamericane,<br />
e<strong>di</strong>fi cate da coloro che emigrati per lunghi anni in Paesi<br />
quali l’Argentina e quin<strong>di</strong> tornati a casa ne avevano assimilato<br />
il gusto. La pur consistente attività turistica, fondata<br />
sulle seconde case che rappresentano una parte<br />
cospicua del patrimonio abitativo del comune, non ha<br />
portato a stravolgimenti urbanistici, che hanno invece<br />
segnato negativamente il territorio <strong>di</strong> alcuni centri vicini.<br />
Sede dell’attività giu<strong>di</strong>ziaria nel Levante della provincia<br />
genovese e, dal 1892, della locale <strong>di</strong>ocesi, Chiavari<br />
si presenta oggi con un’economia solida e spiccatamente<br />
terziaria. Resistono ancora antiche attività quali<br />
la pesca e la rinomata fabbricazione delle famose se<strong>di</strong>e<br />
<strong>di</strong> Chiavari (le chiavarine) ideate da artigiani locali a<br />
inizio Ottocento riprendendo modelli francesi. La chiavarina,<br />
realizzata con legno <strong>di</strong> ciliegio e acero bianco e<br />
con la seduta in sottili fi li <strong>di</strong> salice intrecciati a spiga,<br />
non supera i sette etti <strong>di</strong> peso.<br />
Gravita su Chiavari l’entroterra retrostante la costa<br />
della citta<strong>di</strong>na, un’area compresa tra la me<strong>di</strong>a e bassa<br />
val Fontanabuona, la valle Sturla e la val Graveglia e<br />
storicamente legata al Capitanato <strong>di</strong> Chiavari, istituito<br />
nel XIII secolo dalla Repubblica <strong>di</strong> Genova nel Levante<br />
ligure. Sono poi stretti i legami con Genova, facilitati<br />
dalla presenza <strong>di</strong> un effi ciente sistema <strong>di</strong> collegamenti<br />
infrastrutturali.<br />
Primi anni ´30. Estate.<br />
Turismo a Chiavari:<br />
stabilimenti balneari<br />
e vele da <strong>di</strong>porto.<br />
Nella pagina a<br />
fianco: 1913.<br />
Chiavari vista dalle<br />
Grazie. Si riconosce<br />
in basso la<br />
deviazione a monte<br />
della ferrovia per<br />
Genova, appena<br />
realizzata.<br />
Early 1930s. Summer.<br />
Tourism in Chiavari:<br />
bathing<br />
establishments and<br />
pleasure craft.<br />
On the facing page:<br />
1913. Chiavari seen<br />
from Le Grazie.<br />
At the bottom the<br />
deviation upstream<br />
of the railway line for<br />
Genoa, recently built,<br />
can be recognized.<br />
nella Fontanabuona: si utilizza l’energia<br />
elettrica e si erigono a fondovalle<br />
moderni stabilimenti per la<br />
lavorazione del materiale estratto.<br />
Tanto le quantità estratte che il<br />
fatturato crescono considerevolmente<br />
in età giolittiana, anche<br />
grazie alle esportazioni <strong>di</strong> lastre in<br />
Francia, Inghilterra e Germania.<br />
Ardesia, sete e se<strong>di</strong>e: lavorazioni<br />
<strong>di</strong> nicchia che tengono e talvolta<br />
crescono. Nel complesso<br />
prevalgono le aziende <strong>di</strong> me<strong>di</strong>e e<br />
piccole <strong>di</strong>mensioni accanto alle<br />
quali si segnalano poche intraprese<br />
davvero industriali. Tra queste<br />
la Fabbrica Nazionale Tubi, nata<br />
nel 1905, con stabilimento a Sestri<br />
Levante, il citato cantiere navale<br />
<strong>di</strong> Riva Trigoso, il Cotonificio<br />
Entella, la cui fabbrica a Lavagna<br />
entra in esercizio nel 1908.<br />
Si assiste poi proprio in questi<br />
anni al sorgere <strong>di</strong> quella “indu-<br />
Massimo Mandelli<br />
Massimo Mandelli
stria del forestiero” che in un breve<br />
volgere <strong>di</strong> tempo assume una notevole<br />
importanza. Anche la riviera<br />
ligure <strong>di</strong> Levante viene scoperta<br />
dal turismo dopo che hanno già<br />
raggiunto una fama internazionale<br />
località del Ponente quali Sanremo<br />
e Bor<strong>di</strong>ghera: l’immagine e la realtà<br />
<strong>di</strong> un mondo più appartato e<br />
“genuino”, meno mondano delle<br />
non lontane Costa Azzurra e Liguria<br />
occidentale, fanno preferire il<br />
Levante a viaggiatori più sofi sticati<br />
e per certi aspetti più elitari. Anche<br />
in questa riviera cominciano a risiedere<br />
in modo più o meno stabile<br />
sia turisti stranieri sia emigrati<br />
ritornati arricchiti dalle Americhe.<br />
Seguendo il tracciato della linea<br />
ferroviaria da Genova alla Spezia,<br />
il Manual du voyageur <strong>di</strong> Karl Baedeker<br />
illustra i pregi <strong>di</strong> Portofi no,<br />
Santa Margherita Ligure, Rapallo e<br />
Sestri Levante. Il turismo <strong>di</strong>viene<br />
dunque sempre più “industria”<br />
che produce red<strong>di</strong>to.<br />
174 OLTRE LA VALLE<br />
<strong>Banca</strong> <strong>Popolare</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>Sondrio</strong><br />
AGENZIA<br />
<strong>di</strong><br />
CHIAVARI (GE)<br />
Piazza<br />
Nostra Signora dell’Orto<br />
angolo via Doria - 42/B<br />
Tel. 0185 18.78.300<br />
Fax 0185 59.95.25<br />
Massimo Mandelli<br />
In età giolittiana la Liguria fi -<br />
gura al primo posto tra le regioni<br />
d’Italia per ricchezza me<strong>di</strong>a per<br />
abitante, con un in<strong>di</strong>ce quasi doppio<br />
rispetto a quello me<strong>di</strong>o nazionale.<br />
Il dato regionale è certo infl<br />
uenzato dal peso <strong>di</strong> Genova, ma<br />
anche il circondario <strong>di</strong> Chiavari, col<br />
suo entroterra contribuisce a tale<br />
risultato.<br />
Sono stati fondamentali al<br />
riguardo i capitali provenienti<br />
dall’esterno – le rimesse degli<br />
emigranti e i denari che molti <strong>di</strong><br />
essi, tornando, portano con sé;<br />
gli investimenti effettuati da alcuni<br />
signifi cativi gruppi impren<strong>di</strong>toriali<br />
– che si sono affi ancati al risparmio<br />
locale nella promozione<br />
<strong>di</strong> iniziative interessanti, prevalentemente<br />
il settore terziario:<br />
tutto ciò ha impresso <strong>di</strong>namismo<br />
a un territorio ormai uscito da<br />
una con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> arretratezza e<br />
pienamente inserito in un mondo<br />
in movimento.<br />
Massimo Mandelli
Tutti all’appello<br />
NOTIZIARIO<br />
a 3.000 metri<br />
Momenti<br />
Pirovano<br />
per assistere alle lezioni... e non solo <strong>di</strong> sci<br />
FORMAZIONE AD ALTA QUOTA<br />
Inserito nella splen<strong>di</strong>da cornice del Parco Nazionale dello Stelvio, l’Hotel<br />
Quarto <strong>di</strong>venta la sede <strong>di</strong> workshop e percorsi formativi promossi in partnership<br />
dall’università IULM <strong>di</strong> Milano e Pirovano, la nota Università dello sci<br />
Turismo, marketing, comunicazione<br />
aziendale. E ancora, pubblicità, nuove tecnologie,<br />
lingue straniere. Questi gli ambiti <strong>di</strong> riferimento<br />
dei corsi <strong>di</strong> formazione proposti dall’Università<br />
IULM <strong>di</strong> Milano in partnership con Pirovano<br />
Stelvio (società controllata dal Gruppo<br />
<strong>Banca</strong> <strong>Popolare</strong> <strong>di</strong> <strong>Sondrio</strong> e nota ai molti come<br />
l’Università dello sci) sulla base <strong>di</strong> un Protocollo<br />
d’intesa firmato il 21 marzo scorso. Assolutamente<br />
incantevole lo scenario <strong>di</strong> riferimento: i<br />
corsi si terranno infatti presso l’Hotel Quarto,<br />
un’attrezzata struttura alberghiera <strong>di</strong> proprietà <strong>di</strong><br />
Pirovano e ubicata nel mezzo del Parco dello<br />
Stelvio, crocevia <strong>di</strong> lingue, culture e tra<strong>di</strong>zioni.<br />
«Offrire formazione <strong>di</strong> qualità in un contesto<br />
assolutamente straor<strong>di</strong>nario dal punto <strong>di</strong><br />
vista paesaggistico: questo l’obiettivo che, in<br />
sintonia con Pirovano, vogliamo centrare. Con<br />
la stipula <strong>di</strong> questo Protocollo il nostro Ateneo<br />
trova un nuovo partner con il quale con<strong>di</strong>videre,<br />
ad alta quota mi viene da aggiungere, importanti<br />
obiettivi formativi», sottolinea Giovanni Puglisi,<br />
rettore dell’Università IULM.<br />
Ampia e articolata l’offerta formativa: sono<br />
in via <strong>di</strong> definizione corsi <strong>di</strong> specializzazione<br />
della durata <strong>di</strong> 7 giorni (30 ore) o <strong>di</strong> 14 giorni (60<br />
ore) focalizzati sui temi della Comunicazione e<br />
della Pubblicità per il non profit, del Tourism<br />
Management e della comunicazione <strong>di</strong>gitale, ma<br />
anche workshop <strong>di</strong> 2 giorni (formula weekend –<br />
12 ore) centrati sulla gestione della reputazione<br />
online o sulle tecniche per l’ottimizzazione dei<br />
contenuti sui motori <strong>di</strong> ricerca. In programma,<br />
inoltre, percorsi formativi destinati a manager<br />
del settore turistico e della Pubblica Amministrazione<br />
e, in collaborazione con la Scuola Superio-<br />
re per me<strong>di</strong>atori linguistici Carlo Bo, corsi per<br />
l’insegnamento a livello professionale delle lingue<br />
straniere.<br />
«Questo accordo con l’Università IULM<br />
rafforza e amplia la missione d’insegnamento<br />
che da sempre ci prefiggiamo: da oltre 50 anni i<br />
nostri istruttori sono, infatti, impegnati a trasmettere<br />
ai propri allievi l’appren<strong>di</strong>mento della<br />
tecnica dello sci sapientemente unito ai principi<br />
morali ed educativi dello sport. Da oggi, qualificati<br />
corsi <strong>di</strong> lingue e comunicazione affiancheranno<br />
i nostri tra<strong>di</strong>zionali corsi <strong>di</strong> sci, in un ateneo<br />
esclusivo posto nel cuore del Parco Nazionale<br />
dello Stelvio e del Parco Svizzero», afferma<br />
Renato Sozzani, presidente <strong>di</strong> Pirovano Stelvio.<br />
Il rettore dell’Università IULM e il presidente <strong>di</strong> Pirovano<br />
Stelvio spa siglano il Protocollo d’Intesa.<br />
UNIVERSITÀ IULM, QUATTRO<br />
MODI PER DIRE FUTURO<br />
Quattro Facoltà, cinque corsi <strong>di</strong> Laurea<br />
triennale, quattro corsi <strong>di</strong> Laurea magistrale, numerosi<br />
Master. L’Università IULM è il polo <strong>di</strong><br />
eccellenza italiano per la formazione nei settori<br />
delle lingue, della comunicazione, del turismo e<br />
della valorizzazione dei beni culturali, ambiti<br />
professionali oggi molto ricettivi, oltreché particolarmente<br />
stimolanti. A tutti i suoi studenti<br />
l’Ateneo garantisce un imprinting culturale davvero<br />
completo e una solida preparazione, elementi<br />
fondamentali per inserirsi con successo<br />
nel mondo del lavoro e, cosa non meno importante,<br />
per realizzarsi nella vita come persona.<br />
Come? Proponendo percorsi <strong>di</strong>dattici innovativi,<br />
offrendo servizi all’avanguar<strong>di</strong>a, attivando contatti<br />
con il mondo del lavoro, incentivando le esperienze<br />
<strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o all’estero. Ma anche stimolando<br />
gli studenti a frequentare le lezioni, a partecipare<br />
attivamente alla vita universitaria e alle attività<br />
The IULM University rector and chairman of Pirovano<br />
Stelvio spa signing the Protocol agreement.<br />
MOMENTI PIROVANO 175<br />
Archivio IULM
La sede milanese dell’Università IULM si presenta<br />
come un complesso modernissimo e tecnologicamente<br />
avanzato.<br />
dell’Ateneo, offrendo loro adeguate strutture logistiche<br />
e garantendo un ottimale rapporto numerico<br />
studente-docente.<br />
Quattro Facoltà, si è detto, addentriamoci<br />
in ognuna <strong>di</strong> esse.<br />
Interpretariato, traduzione, stu<strong>di</strong> linguistici e culturali.<br />
Si rivolge a tutti coloro che hanno un forte<br />
interesse per lo stu<strong>di</strong>o delle lingue straniere e che<br />
puntano ad affermarsi nei campi della me<strong>di</strong>azione<br />
linguistica orale (<strong>di</strong>ventando ad esempio interpreti<br />
<strong>di</strong> conferenza) o scritta (affermandosi ad<br />
esempio come traduttori). Inglese, francese, tedesco<br />
e spagnolo, ma anche lingue e culture<br />
nor<strong>di</strong>che, russo cinese e arabo. Per lavorare<br />
ovunque nel mondo. A questa Facoltà fanno capo<br />
il corso <strong>di</strong> Laurea triennale in Interpretariato e<br />
comunicazione e il corso <strong>di</strong> Laurea magistrale in<br />
Traduzione specialistica e interpretariato <strong>di</strong> conferenza.<br />
Comunicazione, relazioni pubbliche e pubblicità.<br />
Gli studenti vengono coinvolti in un percorso<br />
formativo che ha l’obiettivo <strong>di</strong> fare <strong>di</strong> loro dei<br />
professionisti della comunicazione. Un’eccellente<br />
e approfon<strong>di</strong>ta preparazione teorica nelle aree <strong>di</strong><br />
riferimento è completata e integrata da attività<br />
pratiche in laboratorio che consentono allo studente<br />
<strong>di</strong> verificare sul campo ciò che va apprendendo.<br />
La Facoltà si articola in più corsi <strong>di</strong> Laurea,<br />
due triennali (in Comunicazione, me<strong>di</strong>a e<br />
pubblicità e in Relazioni pubbliche e comunicazione<br />
d’impresa) e due corsi <strong>di</strong> Laurea magistrale<br />
(in Marketing, consumi e comunicazione e in<br />
Televisione, cinema e new me<strong>di</strong>a).<br />
176 MOMENTI PIROVANO<br />
The Milanese branch of the IULM University is an<br />
extremely modern and technologically advanced<br />
complex.<br />
Turismo, eventi e territorio. Di una Facoltà come<br />
questa (e del suo omonimo corso <strong>di</strong> Laurea<br />
triennale) il sistema turistico italiano ha grande<br />
bisogno. I mercati connessi al turismo hanno<br />
infatti vissuto in questi ultimi anni profonde<br />
trasformazioni, crescendo e palesando potenziali<br />
occupazionali enormi. Occorrono però nuove<br />
figure professionali dai profili ben definiti in<br />
possesso <strong>di</strong> conoscenze (non solo linguistiche)<br />
adeguate. Gli studenti IULM sono chiamati ad<br />
acquisire i saperi e le tecniche per lavorare nella<br />
grande industria del turismo e per valorizzare al<br />
meglio le straor<strong>di</strong>narie bellezze del nostro Paese.<br />
Arti, mercati e patrimoni della cultura. I suoi due<br />
percorsi <strong>di</strong>dattici (il corso <strong>di</strong> Laurea triennale in<br />
Comunicazione nei mercati dell’arte e della<br />
cultura e il corso <strong>di</strong> Laurea magistrale in Arti,<br />
patrimoni e mercati, sviluppato in partnership<br />
con La Triennale <strong>di</strong> Milano) mirano a coniugare<br />
l’interesse per l’arte con due ambiti che caratterizzano<br />
l’intera Università ossia quello della comunicazione<br />
e quello gestionale. Rispetto alle<br />
lauree tra<strong>di</strong>zionali nel campo artistico e della<br />
conservazione dei beni culturali, questa Facoltà<br />
rappresenta un unicum nel quadro universitario<br />
italiano.<br />
UN CAMPUS ALL’AVANGUARDIA<br />
Sul modello dei campus americani, la sede<br />
milanese dell’Università IULM si presenta come<br />
un complesso modernissimo, tecnologicamente<br />
avanzato e dotato <strong>di</strong> strutture pensate per dare<br />
spazio allo stu<strong>di</strong>o, alla ricerca, ma anche ai momenti<br />
<strong>di</strong> aggregazione. Progettato da Roberto e<br />
Archivio IULM<br />
Lorenzo Guiducci e ultimato nel 1993, l’e<strong>di</strong>ficio<br />
principale <strong>di</strong> via Carlo Bo costituisce il nucleo<br />
centrale dell’Ateneo. Nel corso degli anni il campus<br />
si è allargato: sono nati un giar<strong>di</strong>no e cinque<br />
nuovi e<strong>di</strong>fici che ospitano aule, istituti <strong>di</strong> ricerca,<br />
la libreria universitaria, la mensa e la residenza<br />
studentesca. Un mosaico <strong>di</strong> spazi che si completerà<br />
con il progetto Knowledge Transfer Centre,<br />
una struttura post-moderna in via <strong>di</strong> realizzazione<br />
e pensata per favorire lo scambio e la contaminazione<br />
<strong>di</strong> culture e saperi con la città. Al suo interno<br />
sorgeranno, tra l’altro, la Torre <strong>di</strong> Cristallo<br />
(destinata a <strong>di</strong>ventare la sede degli archivi delle<br />
iniziative e delle attività IULM nel campo della<br />
moda, del cinema, della comunicazione) un Au<strong>di</strong>torium<br />
(luogo preposto a ospitare congressi e<br />
eventi culturali).<br />
Via Carlo Bo, 1<br />
20143 Milano<br />
Tel.+ 39 02 891411<br />
www.iulm.it<br />
At 3,000 metres altitude,<br />
all present for the lessons…<br />
and not just ski lessons<br />
A great season, with an “academic” flavour” is<br />
anticipated at the Pirovano.<br />
From 28th May, the Skiing University will have the<br />
great honour of hosting workshops and high-level<br />
training courses with the lecturers of the IULM<br />
(University Institute for Modern Languages) of<br />
Milan. This is thanks to an agreement signed<br />
between the Rector of the prestigious Milanese<br />
University, Giovanni Puglisi, and the Chairman of<br />
Pirovano Stelvio, Renato Sozzani. This excellent<br />
training at a high altitude is an extra something<br />
that is highly qualified and qualifying for clients.<br />
Alongside this important achievement, other<br />
interesting innovations are lined up. The road of<br />
the Stelvio is also to become... a gourmet<br />
chocolate, thanks to the inventiveness of Giovanni<br />
Pilatti, owner and superb pastry chef of the<br />
Valtellina confectionery company ChocoAlpi, whilst<br />
at the Quarto Hotel, sophisticated laser treatment<br />
will be available (for all the athletes) of the<br />
Piantedo Health Centre, <strong>di</strong>rected by Dr. Ezio<br />
Corbellini. There will also be the fantastic descents<br />
in fresh snow, in the Valle dei Vitelli and along the<br />
Madaccio, and the exhilarating adventure of the<br />
“Mapei day”, in mid-July. We look forward to seeing<br />
you on the Pass at 3000 metres above sea level!
IL GIGANTISSIMO<br />
SPEGNE LE PRIME 10 CANDELINE<br />
Grande festa <strong>di</strong> compleanno per il “Gigantissimo<br />
Pirovano”, gara <strong>di</strong> slalom gigante svoltasi<br />
sabato 12 marzo nello splen<strong>di</strong>do palcoscenico<br />
enga<strong>di</strong>nese. Dieci fulgide candeline, una per ogni<br />
e<strong>di</strong>zione, rilucevano idealmente sulla “torta”<br />
della manifestazione, entrata nell’albo degli appuntamenti<br />
sciistici più attesi non solo della<br />
stazione turistica <strong>di</strong> Celerina ma dell’intera Enga<strong>di</strong>na.<br />
Una gara che è anche un’occasione per ritrovarsi<br />
e che richiama, <strong>di</strong> anno in anno, un<br />
pubblico sempre più numeroso e appassionato.<br />
Nell’appuntamento del 2011, poi, si sono toccati<br />
numeri da record. Quasi 300 gli atleti presenti –<br />
tutti frementi e senza <strong>di</strong>stinzione d’età – al cancelletto<br />
<strong>di</strong> partenza per contendersi la vittoria<br />
sulle magnifiche piste della rinomata località<br />
sciistica.<br />
Il miglior tempo femminile l’ha fatto registrare<br />
Maria Laura Brancato con 26”52, mentre<br />
Nicolò Pedercini ha tagliato il traguardo con<br />
25”31.<br />
Alla premiazione, svoltasi nel primo pomeriggio,<br />
erano presenti quasi 400 persone, fra cui<br />
un’allegra compagine della BPS (SUISSE) composta<br />
dal <strong>di</strong>rettore generale Brunello Perucchi, da<br />
Roberto Crameri, responsabile dell’area enga<strong>di</strong>nese,<br />
e da Filippo Forcella, <strong>di</strong>rettore <strong>di</strong> Celerina.<br />
Il sole, purtroppo, si è fatto desiderare (il freddo,<br />
invece, si è fatto sentire, eccome), ma la cosa non<br />
ha certo rallentato o spento l’entusiasmo che l’ha<br />
fatta da padrone per l’intera giornata. La perfetta<br />
organizzazione messa in campo dalla Snow and<br />
Fun Enga<strong>di</strong>n School e dalla <strong>Banca</strong> <strong>Popolare</strong> <strong>di</strong><br />
<strong>Sondrio</strong> (SUISSE) SA – e da Pirovano Stelvio,<br />
naturalmente... – ha permesso, ancora una volta,<br />
l’ottima riuscita dell’evento. Allegra, ci si rivede a<br />
inizio 2012.<br />
IN NEVE FRESCA,<br />
INSEGUENDO LA LIBERTÀ<br />
All’apertura dei battenti dell’Università dello<br />
Sci (e della prestigiosissima Università IULM,<br />
con i suoi corsi d’eccellenza in alta quota, come<br />
descritto nell’ampio servizio alle pagine precedenti)<br />
seguirà, dall’1 al 5 giugno, la “White Fee-<br />
Archivio Pirovano<br />
Celerina, Enga<strong>di</strong>na. Tutti in posa per la<br />
X e<strong>di</strong>zione del “Gigantissimo Pirovano”.<br />
Nelle foto piccole: felicità dopo<br />
la <strong>di</strong>scesa... e grinta e determinazione<br />
mentre si “attacca” una porta.<br />
In basso: eleganti “firme” lungo i pen<strong>di</strong>i<br />
immacolati del Ghiacciaio del Madaccio.<br />
Celerina, Enga<strong>di</strong>na. Everyone in pose<br />
for the tenth e<strong>di</strong>tion of the<br />
“Gigantissimo Pirovano” (the Pirovano<br />
Super Giant). In the small photos:<br />
happiness after the downhill run…<br />
and guts and determination while<br />
“attacking” a gate. Below: elegant<br />
“signatures” along the immaculate<br />
slopes of the Madaccio Glacier.<br />
ling”. Un’avventura mozzafiato ed esilarante per<br />
gli amanti del freeride e del fuoripista. Tante<br />
emozioni da vivere a 360 gra<strong>di</strong>: lunghe <strong>di</strong>scese<br />
fuoripista alla scoperta dei pen<strong>di</strong>i immacolati<br />
della Valle dei Vitelli e del ghiacciaio del Madaccio,<br />
naturalmente “in sicurezza”, al seguito dei<br />
maestri Pirovano... sulla scia della libertà!<br />
Archivio Pirovano
Archivio Pirovano<br />
ROMBI IN ALTA QUOTA<br />
Domenica 3 luglio il Passo gran protagonista...<br />
I rombi dei boli<strong>di</strong> a due ruote – e i loro<br />
centauri – torneranno ad animare e a “colorare” i<br />
tornanti della Strada Imperiale dello Stelvio. Organizzato<br />
dal Moto Club Sondalo, dopo due anni<br />
<strong>di</strong> pausa e la parentesi 2010 “aperta” dal Moto<br />
Club Storico Alta Valtellina – che ha fatto registrare<br />
la bellezza <strong>di</strong> circa 2.000 iscritti –, la XXXV<br />
e<strong>di</strong>zione del “Motoraduno Stelvio International” è<br />
attesissimo appuntamento per migliaia <strong>di</strong> motociclisti<br />
provenienti da tutta Europa. Ai 3.000 metri<br />
del valico e all’Albergo Quarto, si accettano già<br />
scommesse, ci sarà un gran bel movimento.<br />
VII MAPEI DAY,<br />
AL VIA GLI ALLENAMENTI<br />
Il Mapei day, l’evento sportivo (ma non<br />
solo) “clou” della grande stagione Pirovano, andrà<br />
in onda, con la sua settima puntata, domenica<br />
17 luglio. La manifestazione è entrata ormai<br />
nel cuore <strong>di</strong> tutti gli sportivi valtellinesi (ma non<br />
solo <strong>di</strong> loro) e nella più viva tra<strong>di</strong>zione dello sport<br />
all’insegna dell’amicizia, del <strong>di</strong>vertimeno, della<br />
coralità. È per questo – e per tanti altri motivi –<br />
che l’irrinunciabile kermesse vede accrescere, <strong>di</strong><br />
anno in anno, il numero dei suoi aficionados. E<br />
molti fra questi, certamente, staranno già “scaldando<br />
i motori” (chi sulle bici, chi correndo, chi<br />
con gli ski-roll e chi praticando il nor<strong>di</strong>c walking)<br />
o programmando severi allenamenti per poter poi<br />
affrontare l’ambita performance che ha come<br />
palcoscenico i quasi 1.600 metri <strong>di</strong> <strong>di</strong>slivello che<br />
separano Bormio dal Passo, per un totale <strong>di</strong> oltre<br />
178 MOMENTI PIROVANO<br />
20 chilometri <strong>di</strong> percorrenza. È una prova per<br />
“duri”, nutrita e con<strong>di</strong>ta da forti motivazioni ...che<br />
il Mapei day fornisce sempre, e puntualmente. La<br />
bruciante ansia <strong>di</strong> ritrovarsi lassù, ai 2.760 metri<br />
In alto: il Passo in uno degli ultimi “Motoraduni”.<br />
Nelle altre foto: alcune immagini riferite al VI Mapei<br />
day, svoltosi l’11 luglio 2010.<br />
Top: the Pass in one of the last “Motorcycle rallies”.<br />
In the other photos: some images from the VIth Mapei<br />
Day, which took place on July 11, 2010.<br />
Mauro Lanfranchi<br />
della Cima Coppi, la generale atmosfera festosa<br />
che si respira a gran<strong>di</strong> polmoni, animano questa<br />
giornata così particolare che vede campioni,<br />
amatori, giovani e meno giovani, uomini e donne<br />
– e tutti con <strong>di</strong>fferenti preparazioni atletiche –<br />
frementi all’idea <strong>di</strong> raggiungere “il traguardo” per<br />
antonomasia, il valico, e <strong>di</strong> celebrarlo. Nell’e<strong>di</strong>zione<br />
del 2010 si è pedalato – anche se erano molti<br />
i partecipanti che hanno <strong>di</strong>sputato la mezza maratona<br />
– ricordando “Ballero” (al secolo Franco<br />
Ballerini, scomparso tragicamente nel febbraio<br />
2010), che sui tornanti della Grande Montagna si<br />
cimentava da grande campione quale in realtà<br />
era, provando sempre le emozioni della “prima<br />
volta” (scalare lo Stelvio è davvero qualcosa <strong>di</strong><br />
mitico). Nella manche del 2011 il pensiero correrà<br />
a uno dei registi del Mapei day, anzi, a uno dei<br />
suoi “papà” (insieme al patron Giorgio Squinzi e<br />
alla <strong>di</strong>namica Adriana Spazzoli, vera regina<br />
dell’evento): il dottor Aldo Sassi, “il professore”,<br />
<strong>di</strong>rettore generale del Centro Mapei Sport <strong>di</strong><br />
Castellanza, tecnico <strong>di</strong> ciclismo dal 1982 e allenatore<br />
<strong>di</strong> Basso e <strong>di</strong> Evans. L’amico Aldo, sempre<br />
presente, sempre pro<strong>di</strong>go <strong>di</strong> consigli, competente<br />
e rassicurante, purtroppo non è riuscito a ta-
A sinistra: Giovanni Pilatti e Renato Sozzani mostrano la squisita tavoletta “Pirovano”.<br />
A destra: il dr. Ezio Corbellini e il presidente <strong>di</strong> Pirovano Stelvio insieme<br />
per il “centro laser più alto d’Europa”.<br />
gliare il traguardo più arduo del suo percorso<br />
terreno. Se ne è andato nel <strong>di</strong>cembre del 2010,<br />
lasciando nel cuore <strong>di</strong> tutti coloro che hanno<br />
avuto la fortuna <strong>di</strong> conoscerlo un sentimento <strong>di</strong><br />
grande tristezza, temperato però dal bellissimo<br />
ricordo per quello che Aldo è stato e per quello<br />
che ha saputo fare, con gran<strong>di</strong> passione, forza,<br />
rigore e, soprattutto con tanta umiltà. Su quei<br />
tornanti che i “suoi” campioni hanno saputo affrontare<br />
negli anni con tanta grinta e con una<br />
conquistata – grazie ai suoi preziosi consigli e<br />
alla sua meticolosa “messa a punto” – nonchalance,<br />
Aldo sarà presente anche in questa settima<br />
e<strong>di</strong>zione. E spronerà tutti, verso la Cima Coppi.<br />
Grazie, Aldo, per i tuoi insegnamenti e per<br />
quello che hai saputo donare, con amicizia e<br />
professionalità, al folto popolo del Mapei day.<br />
Aldo Sassi a Bormio nel 2005, sul po<strong>di</strong>o del Mapei day<br />
con Adriana Spazzoli (a sinistra) e Anna Calcaterra.<br />
Doctor Aldo Sassi a Bormio in 2005, on the Mapei<br />
day po<strong>di</strong>um with Adriana Spazzoli (left) and Anna<br />
Calcaterra.<br />
Per chi volesse già mettersi in gioco, si<br />
rammenta <strong>di</strong> effettuare un click sui seguenti siti:<br />
www.winningtime.com - www.mapei.it<br />
www.popso.it - www.usbormiese.com<br />
Archivio Pirovano<br />
UNA STRADA SPECIALE IN UNA<br />
MONTAGNA DI... DOLCEZZA<br />
È proprio la Strada dello Stelvio, con i suoi<br />
ar<strong>di</strong>ti e perfetti tourniquets, quella che si snoda<br />
aggrappandosi alla cima della Montagna, sino a<br />
toccarne la sommità, per poi sfociare nel cielo...<br />
Una strada “del sapore e del gusto”, la si potrebbe<br />
definire, che campeggia nella tavoletta “Pirovano”,<br />
artistica quanto golosissima creazione<br />
che il gran Maestro cioccolataio “Gigi” Pilatti <strong>di</strong><br />
ChocoAlpi (So) ha realizzato, ispirandosi allo<br />
Stelvio e all’Università dello Sci.<br />
Il nastro d’asfalto si è così trasformato in<br />
una scia <strong>di</strong> prelibato cioccolato fondente, mentre<br />
la Grande Montagna che fa da sfondo è fatta <strong>di</strong><br />
cioccolato bianco; il cielo sopra, invece, ha il<br />
sapore e il colore del cioccolato al latte. Che<br />
squisitezza!<br />
Il presidente <strong>di</strong> Pirovano Stelvio, Renato<br />
“Tato” Sozzani, da buon gourmet e goloso quale<br />
è, con sorpresa ed entusiasmo ha accolto questa<br />
invitante e curiosa novità che contribuirà ad ampliare<br />
– allietando il palato... – la già ricca offerta<br />
gastronomica che Pirovano offre alla sua clientela.<br />
LASER, QUASI<br />
UN ANAGRAMMA DI RELAX<br />
Importante novità, sotto il profilo me<strong>di</strong>co e<br />
scientifico, all’interno dell’Albergo Quarto ove<br />
verrà creata una speciale area che ospiterà un<br />
innovativo “centro laser”. Che sarà, senza alcuna<br />
ombra <strong>di</strong> dubbio, il “centro laser più alto d’Europa”,<br />
seguito da uno specialista del settore: il<br />
dottor Ezio Corbellini del “Centro Salute” <strong>di</strong><br />
Piantedo (SO), che utilizza attrezzature marcate<br />
“ASALaser”.<br />
Con questa sorta <strong>di</strong> gemellaggio a tre, la<br />
laserterapia e la carbossiterapia, metodologie<br />
me<strong>di</strong>che all’avanguar<strong>di</strong>a, nella stagione estiva<br />
2011 saranno quin<strong>di</strong> al servizio <strong>di</strong> atleti e <strong>di</strong><br />
Left: Giovanni Pilatti and Renato Sozzani showing the exquisite “Pirovano” board.<br />
Right: Dr. Ezio Corbellini and the Pirovano chairman together for “Europe’s highest<br />
laser centre”.<br />
tutti coloro che desiderano vedere migliorate non<br />
solo le proprie con<strong>di</strong>zioni fisiche e atletiche, ma<br />
anche quelle mentali (chi non ricorda il famoso<br />
detto: mens sana in corpore sano?). La tecnologia<br />
laser e la pratica della carbossiterapia, i cui<br />
effetti benefici erano già noti ai tempi <strong>di</strong> Giulio<br />
Cesare, vanno così ad arricchire il ventaglio <strong>di</strong><br />
proposte “extra-sci” che l’Università Pirovano<br />
offre alla sua affezionata clientela. Clientela che<br />
ama lo sport ma che, attraverso nuovi stimoli,<br />
desidera rigenerarsi ad alta quota. In due parole:<br />
soggiorni all’insegna anche (e soprattutto) del<br />
relax.<br />
Positiva l’accoglienza da parte <strong>di</strong> Renato<br />
“Tato” Sozzani, presidente della Pirovano il quale<br />
ha affermato che «è molto importante per noi<br />
essere in grado <strong>di</strong> offrire a tutti gli sportivi che<br />
vengono quassù (siano essi sciatori, ciclisti,<br />
surfisti della neve, motociclisti, po<strong>di</strong>sti o amanti<br />
del trekking) l’opportunità <strong>di</strong> prendersi cura <strong>di</strong> sé,<br />
<strong>di</strong> coccolarsi quasi e <strong>di</strong> migliorare anche le proprie<br />
performance grazie all’utilizzo del laser [...]<br />
Pirovano è un centro <strong>di</strong> eccellenze e [...] questo<br />
accordo arrecherà importanti benefici nel campo<br />
me<strong>di</strong>co-sportivo».<br />
E ne siamo certi. Pirovano da sempre fa<br />
rima con benessere fisico e psichico, sin dalla sua<br />
nascita. Eravamo alla fine degli anni Quaranta del<br />
XX secolo.<br />
<strong>Sondrio</strong>, via Delle Prese 8<br />
Visitate il nostro sito: www.pirovano.it<br />
pirovano@popso.it - info@pirovano.it<br />
Per informazioni e prenotazioni<br />
Tel. +39 0342 210040 - 515450<br />
Fax +39 0342 514685<br />
http://webcam.popso.it
ADRIANO OLIVETTI<br />
Come <strong>di</strong> consuetu<strong>di</strong>ne,<br />
consuetu<strong>di</strong>ne<br />
si riporta uno stralcio della Relazione<br />
d’esercizio 2010 della controllata<br />
<strong>Banca</strong> <strong>Popolare</strong> <strong>di</strong> <strong>Sondrio</strong><br />
(SUISSE) SA <strong>di</strong> Lugano.<br />
In particolare, vengono trascritti<br />
i contributi relativi alla fi gura<br />
dell’illuminato industriale, ingegnere<br />
ed e<strong>di</strong>tore Adriano Olivetti, personalità<br />
<strong>di</strong> singolare rilievo nella storia italiana<br />
del secondo dopoguerra.<br />
Già pubblicati nella sezione del predetto<br />
fascicolo riservata alla cultura, i saggi<br />
proposti recano la fi rma <strong>di</strong> Carlo<br />
De Benedetti, Fabrizio Fazioli, Valerio<br />
Castronovo, Mauro Leo Baranzini,<br />
Davide Cadeddu e Laura Olivetti.<br />
Introduce la monografi a la prefazione<br />
del Presidente, cavaliere del lavoro<br />
Piero Melazzini.<br />
NOTIZIARIO<br />
Dalla “Suisse”<br />
180 DALLA “SUISSE”<br />
PREFAZIONE DEL PRESIDENTE PIERO MELAZZINI<br />
L’ispirazione dell’iniziativa culturale, che da quando esiste la BPS SUISSE<br />
è parte della Relazione <strong>di</strong> bilancio, la devo al grande critico e prosatore perugino<br />
Giu seppe Prezzolini. Ebbi la fortuna <strong>di</strong> conoscerlo a Lugano, città dove il<br />
perso naggio visse dal 1968 fi no al decesso, avvenuto nel 1982. Lo frequentai,<br />
affa scinato dal suo sapere, con cui manifestava la sua personalità curiosa e<br />
in quieta: uomo ricco <strong>di</strong> cultura e <strong>di</strong>vulgatore <strong>di</strong> idee.<br />
La monografi a che accompagna la Relazione dell’esercizio 2010 porta il<br />
nome illustre <strong>di</strong> un industriale italiano geniale, intellettuale e pure politico:<br />
Adriano Olivetti, ingegnere, fi glio <strong>di</strong> Ca millo, il fondatore della “Prima Fabbrica<br />
Italiana Macchine per Scrivere - Ing. C. Olivetti e C.” <strong>di</strong> Ivrea; così era<br />
scritto sull’inse gna quando, nell’ottobre 1908, fu costituita questa azienda.<br />
Adriano Olivetti, nato a Ivrea l’11 aprile 1901, si laureò in ingegneria<br />
chimica nel 1924 e due anni dopo entrò nell’impresa <strong>di</strong> famiglia dove, per<br />
volontà del padre, inizialmente svolse la mansione <strong>di</strong> operaio; ne <strong>di</strong>venne<br />
<strong>di</strong> rettore nel 1933 e presidente cinque anni dopo.<br />
Antifascista, e proprio per questa posizione politica ricercato dal regime,<br />
a guisa <strong>di</strong> <strong>di</strong>versi <strong>di</strong>ssidenti italiani si rifugiò in Svizzera e vi rimase<br />
fi no alla fi ne del secondo confl itto mon<strong>di</strong>ale. La Svizzera entrerà ancora a far<br />
parte della persona “Adriano Olivetti” quando questi, il 27 febbraio 1960, durante un<br />
viaggio in treno da Milano a Losanna, muore a Aigle, nel Canton Vaud.<br />
Nell’imme<strong>di</strong>ato periodo post-bellico, Adriano Olivetti, rientrato in pa tria, riprende<br />
le re<strong>di</strong>ni dell’azienda, che in poco tempo porta a essere fl ori da, e mette in pratica<br />
l’esperienza e i suoi convincimenti, in base ai quali occorre dar spazio alla ri cerca e<br />
alla sperimentazione, tenendo sempre conto dei <strong>di</strong> ritti della persona e della democrazia<br />
partecipativa, sia sul lavoro e sia al <strong>di</strong> fuori <strong>di</strong> esso. Un fa moso ingegnere, appartenuto<br />
a una équipe <strong>di</strong> ricerca tori promossa da Adriano Olivetti, realizzò, sia pure dopo<br />
la morte <strong>di</strong> quest’ul timo, la P101 – detta anche “Pe rottina” dal nome dell’inven tore<br />
Pier Giorgio Perotto –, prima macchina elet tronica program mabile, una specie <strong>di</strong> personal<br />
computer ante litteram, un vero e proprio gio iello tutto ita liano.<br />
Tra i prodotti <strong>di</strong> maggior successo dell’epoca in cui il personaggio in <strong>di</strong>scorso<br />
era al vertice della Olivetti, non si può non menzionare la “Lettera 22”, famosissima<br />
macchina per scrivere portatile, dalla quale Indro Monta nelli non si separò mai.<br />
Adriano Olivetti fu uomo <strong>di</strong> vasta cultura umanistica, politica e fi loso fi ca. Contribuì<br />
al <strong>di</strong>battito intellettuale con articoli, pubblicazioni e libri, che fanno <strong>di</strong> lui un<br />
impren<strong>di</strong>tore atipico.<br />
Fu contro il liberismo economico sfrenato e il socialismo soffocante <strong>di</strong> Stato,<br />
proponendo una terza via, volta alle esigenze materiali e morali.<br />
Merita <strong>di</strong> essere ricordato anche il suo impegno <strong>di</strong> e<strong>di</strong>tore.<br />
Ringrazio, per il suo auto revole contributo su Adriano Olivetti, il cavaliere del<br />
lavoro ingegner Carlo De Benedetti, che ha speso parte della sua vita operativa al<br />
vertice dell’azienda epore<strong>di</strong>ese. Lo ringrazio altresì per la se gnalazione del professor<br />
Valerio Castronovo, grande storico dell’economia. A questi va la mia viva gratitu<strong>di</strong>ne<br />
per il pezzo <strong>di</strong> valore approntato sul per sonaggio della monografi a. Sono poi riconoscente,<br />
per i loro interessanti saggi, ai profes sori Fabrizio Fazioli, Mauro Leo Baranzini,<br />
Davide Cadeddu e la dottoressa Laura Olivetti.<br />
Il pensiero torna al caro Prezzolini, in<strong>di</strong>menticato Maestro <strong>di</strong> vita, del quale conservo,<br />
sulla scrivania del mio uffi cio <strong>di</strong> <strong>Sondrio</strong> della <strong>Banca</strong> <strong>Popolare</strong>, una cartolina<br />
scrittami da Lugano il 3 febbraio 1982.
Un costruttore <strong>di</strong> futuro<br />
Associazione Archivio Storico Olivetti <strong>di</strong> Ivrea<br />
CARLO DE BENEDETTI<br />
Cavaliere del lavoro,<br />
presidente onorario <strong>di</strong> CIR Spa<br />
e presidente dell’E<strong>di</strong>toriale L’Espresso<br />
Non ho conosciuto Adriano Olivetti ma,<br />
quando nella primavera del 1978 ho assunto<br />
la posizione <strong>di</strong> azionista <strong>di</strong> riferimento, Vice<br />
Presidente e Amministratore Delegato <strong>di</strong> Olivetti,<br />
l’ho “respirato” nel mio uffi cio, nelle<br />
fabbriche e nei <strong>di</strong>rigenti che all’epoca lavoravano<br />
in Olivetti e lo avevano conosciuto.<br />
Adriano era una presenza, più che un ricordo<br />
o una nostalgia. Certamente ha vissuto<br />
in un’epoca felice che ha accompagnato la<br />
grande ripresa delle economie occidentali e<br />
giapponese negli anni ’60, producendo e promuovendo<br />
macchine da scrivere e macchine<br />
da calcolo elettromeccaniche praticamente<br />
senza concorrenza a causa della straor<strong>di</strong>naria<br />
capacità inventiva ed esecutiva che caratterizzava<br />
quelle produzioni in quegli anni ad<br />
Ivrea, godendo tra l’altro <strong>di</strong> margini impensabili<br />
ai tempi dell’elettronica: per dare un’idea,<br />
una “Divisumma” aveva un margine lordo vicino<br />
al 50%.<br />
La grande capacità <strong>di</strong> Adriano come industriale<br />
è stata quella <strong>di</strong> utilizzare questi enormi<br />
utili per espandersi nel mondo <strong>di</strong>ventando a<br />
quei tempi l’unica vera multinazionale italiana<br />
con fabbriche in Spagna, Messico, Brasile, Argentina<br />
e con organizzazioni <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta molto<br />
effi cienti, praticamente in ogni area della geografi<br />
a economica mon<strong>di</strong>ale <strong>di</strong> allora, dal Giappone<br />
agli Stati Uniti, da Singapore alla Malesia.<br />
Questo fu possibile per la grande, personale attenzione<br />
con cui Adriano Olivetti selezionava<br />
e sceglieva i suoi uomini. E così, oltre a creare<br />
l’unica vera multinazionale italiana, <strong>di</strong>sseminò<br />
cultura manageriale olivettiana in tante gran<strong>di</strong><br />
imprese italiane, dalla Fiat, all’Ifi , all’Alitalia e a<br />
tante altre.<br />
E poi aveva un elevato senso <strong>di</strong> utopia<br />
sociale, che lo portò a incoraggiare architetti<br />
italiani a costruire “spazi <strong>di</strong> vita” luminosi e<br />
gradevoli per i lavoratori Olivetti. Fu un grande<br />
“padrone”, ma anche eccezionale nella sua “solitu<strong>di</strong>ne”,<br />
nel suo gusto del bello e del grande.<br />
Giustamente ancora oggi lo si ricorda<br />
come tale.<br />
DALLA “SUISSE” 181
Adriano Olivetti<br />
e il “secolo breve”<br />
FABRIZIO FAZIOLI<br />
Laureato in scienze economiche e sociali<br />
all’Università <strong>di</strong> Neuchâtel, giornalista e autore<br />
Adriano Olivetti (1901-60).<br />
Adriano Olivetti and the “brief century”<br />
Hobsbawm defined the first half of the 20th century as the “brief century”<br />
for the intensity of the changes that took place, but also for the progress<br />
made in the world historical panorama. It was also the same period in which<br />
Adriano Olivetti launched his “utopia”. He began with political journalism,<br />
aimed at a federal concept inspired by Cattaneo. He considered American a<br />
model of organisational and productive efficiency, but not as a social system.<br />
He looked favourably on Carlo Rosselli’s liberal socialism, which sought to<br />
overcome utilitarian in<strong>di</strong>vidualism. To reach his objectives, he created the<br />
“Community Political Movement”, supported by a publishing activity that gave<br />
ample space to top level scholars: Jung, Piaget, Kierkegaard, Bergson,<br />
Bettelheim. A landmark work for transporting the idea of a business from<br />
the industrial to the post-industrial world.<br />
182 DALLA “SUISSE”<br />
Fondazione Adriano Olivetti <strong>di</strong> Roma<br />
Quando Adriano Olivetti nacque, nel 1901, l’Europa<br />
era in piena effervescenza, nel vivo <strong>di</strong> un euforico<br />
clima <strong>di</strong> belle époque, alimentato da costumi innovatori<br />
e da una spensierata fede nel progresso. Quando<br />
egli morì, nel 1960, l’Europa, pur ancora <strong>di</strong>visa da una cortina <strong>di</strong><br />
ferro, era sulla soglia della più folgorante crescita del benessere<br />
mai registrata dalla storia. Nel mezzo ci sono state due devastanti<br />
guerre mon<strong>di</strong>ali, una grande depressione economica e mettiamoci<br />
anche la rivoluzione sovietica, il nazismo in Germania e più<br />
<strong>di</strong> vent’anni <strong>di</strong> fascismo in Italia. Non si può certo <strong>di</strong>re che Adriano<br />
Olivetti abbia vissuto in un periodo particolarmente fortunato.<br />
Il grande storico Eric J. Hobsbawm defi nì questo intervallo violento<br />
e sconvolgente della storia dell’umanità, che va dalla Prima<br />
Guerra mon<strong>di</strong>ale alla caduta del muro <strong>di</strong> Berlino, “il secolo breve”.<br />
Un secolo <strong>di</strong> progresso scientifi co straor<strong>di</strong>nario e <strong>di</strong> guerre totali,<br />
<strong>di</strong> crisi economiche e <strong>di</strong> prosperità <strong>di</strong>seguale, <strong>di</strong> rivoluzioni nella<br />
società e nella cultura. Un secolo breve per l’accelerazione che<br />
gli eventi della storia e le trasformazioni nella vita degli uomini<br />
hanno assunto a un ritmo sempre più vorticoso. Adriano Olivetti,<br />
suo malgrado, fu dunque testimone e protagonista <strong>di</strong> questa<br />
travagliata epoca, breve come la sua vita, attraverso un itinerario<br />
intellettuale e impren<strong>di</strong>toriale del tutto singolare che si snoda<br />
lungo molteplici percorsi.<br />
Intellettuale, politico o impren<strong>di</strong>tore?<br />
Quando il padre Camillo Olivetti fondò la fabbrica a Ivrea era<br />
il 1908 e tutti erano ancora totalmente ignari dei tragici eventi<br />
che sarebbero seguiti. Era una piccola costruzione <strong>di</strong> mattoni<br />
rossi con pochi operai. Adriano aveva appena sette anni. Dalla<br />
ricostruzione biografi ca del giornalista storico Valerio Ochetto (già<br />
responsabile del servizio storia dei programmi della Rai) sappiamo<br />
che, dopo gli orrori della Grande Guerra, le tensioni sociali e<br />
politiche dell’epoca, nonché il clima <strong>di</strong> speranza e <strong>di</strong> riscatto,<br />
spinsero il giovane Adriano piuttosto verso l’impegno politico. Egli<br />
visse anche con un certo <strong>di</strong>stacco la sua esperienza universitaria,<br />
frequentando molto poco i corsi della sezione <strong>di</strong> chimica industriale<br />
al Politecnico <strong>di</strong> Torino. Né la successione nell’azienda del<br />
padre era già predestinata. Al contrario, dopo un’esperienza nel<br />
1914 come manovale nelle offi cine <strong>di</strong> Ivrea, lo stesso Adriano<br />
stabilì che non avrebbe mai partecipato attivamente ai destini<br />
della fabbrica. Si avvicinò invece ai circoli politici e intellettuali<br />
della Torino degli anni Venti. Con il padre cominciò a collaborare<br />
al settimanale L’Azione Riformista che Camillo aveva fondato nel<br />
1919. E poi ancora a un altro settimanale, Tempi Nuovi, pure<br />
fondato a Torino dal padre nel 1922. Gli anni del primo dopoguerra<br />
per Adriano non furono insomma soltanto gli anni dei sogni e<br />
delle letture; egli scriveva e pianifi cava un futuro che non vedeva<br />
però in fabbrica, ma nel giornalismo politico. Le sue proposte<br />
erano quelle un po’ acerbe della giovinezza ma colpivano <strong>di</strong>rettamente<br />
nel segno e anticipavano notevolmente i tempi. Egli si<br />
immaginava per esempio una forte autonomia per le Regioni<br />
italiane sul modello federalista. Un federalismo che si ispirava<br />
chiaramente al fi lone <strong>di</strong> Carlo Cattaneo, a sua volta attratto dal<br />
modello elvetico che aveva peraltro aiutato a costruire (visse in<br />
Svizzera dal 1848 fi no alla morte nel 1869). Non era in ogni caso<br />
un federalismo <strong>di</strong> stampo cattolico come si immaginava Vincenzo<br />
Gioberti, fondato sull’egemonia del Papato, e ancor meno un federalismo<br />
a deriva secessionista come è piuttosto riven<strong>di</strong>cato<br />
oggi in Italia. Anche per Adriano Olivetti, come per Carlo Cattaneo,<br />
doveva essere invece «una federazione <strong>di</strong> popoli, non uno Stato
Camillo Olivetti con le maestranze Olivetti. Camillo Olivetti with Olivetti workers.<br />
accentratore dove la libertà non potrebbe crescere, pur nel rispetto<br />
e nella forza dell’unione della Nazione». Un altro tema ricorrente<br />
era la burocrazia statale che doveva essere assolutamente<br />
“depoliticizzata” e affi data semmai a persone “valide e competenti”.<br />
Sono embrioni <strong>di</strong> pensiero che ritroveremo in età più matura<br />
nel progetto <strong>di</strong> riforma dello Stato che Adriano Olivetti affi nerà<br />
nel movimento politico e nelle e<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> Comunità.<br />
L’America, ma non come modello<br />
Nel frattempo il rifi uto <strong>di</strong> entrare nella fabbrica paterna a<br />
poco a poco si attenuò e la vena giornalistica <strong>di</strong> Adriano, come<br />
lui stesso ammetterà più tar<strong>di</strong>, si fece irta <strong>di</strong> ostacoli, a causa<br />
anche delle più marcate avversioni al fascismo. Da quel momento,<br />
all’impegno intellettuale e politico si aggiunse<br />
lo stu<strong>di</strong>o dell’organizzazione del lavoro<br />
e progressivamente anche la preoccupazione<br />
per la fabbrica. I due fi loni continueranno<br />
d’ora in poi in costante confronto, a volte appaiati<br />
e convergenti, altre in modo completamente<br />
autonomo, quando non ad<strong>di</strong>rittura <strong>di</strong>vergenti<br />
tra <strong>di</strong> loro. Bruno Caizzi, contemporaneo<br />
<strong>di</strong> Adriano e esule in Svizzera, fa notare<br />
come egli avvertì improvvisamente tutta la<br />
portata delle gran<strong>di</strong> possibilità che gli si sarebbero<br />
presentate attraverso l’impegno <strong>di</strong>retto<br />
nell’industria <strong>di</strong> famiglia, senza con questo<br />
dover abbandonare i suoi forti slanci ideali.<br />
Nel 1925 Adriano partì per gli Stati Uniti per<br />
stu<strong>di</strong>are i meto<strong>di</strong> organizzativi delle gran<strong>di</strong> industrie<br />
d’Oltreoceano. Il risultato dell’esperienza<br />
americana, come scrive Beniamino de’<br />
Liguori Carino in un lungo trattato de<strong>di</strong>cato<br />
alle maturazioni intellettuali <strong>di</strong> Adriano Olivetti,<br />
fu duplice:<br />
Ritratto <strong>di</strong> Adriano Olivetti nel 1927.<br />
Da una parte Adriano acquisisce gran<strong>di</strong>ssima <strong>di</strong>mestichezza<br />
con i meto<strong>di</strong> d’organizzazione del lavoro. Egli visita gli stabilimenti<br />
delle più importanti società statunitensi… L’altro aspetto è il giu<strong>di</strong>zio<br />
critico che il giovane Olivetti comincia a nutrire nei confronti<br />
della società americana in cui il consumo <strong>di</strong> massa e il sistema<br />
capitalista sono a uno sta<strong>di</strong>o <strong>di</strong> sviluppo che in Europa non è ancora<br />
possibile osservare. Non appare allora insensato ritenere che<br />
egli possa avere intuito e presagito le contrad<strong>di</strong>zioni dell’assetto<br />
sociale ed economico americano. In una lettera inviata ai familiari<br />
si legge che «qui il dollaro è veramente il <strong>di</strong>o e che in tutta la vita<br />
americana vi è uno strapotere del dollaro».<br />
Non v’è dubbio che al suo rientro il bagaglio intellettuale e<br />
<strong>di</strong> esperienze che egli portava con sé non era il frutto <strong>di</strong> un asservimento<br />
piatto e acritico al sogno americano,<br />
quanto piuttosto un insieme <strong>di</strong> ingre<strong>di</strong>enti<br />
tecnici, sociali e organizzativi che si tradussero<br />
in seguito in un progetto <strong>di</strong> società certamente<br />
<strong>di</strong>stante dal modello americano.<br />
Nel frattempo Adriano maturò la sua<br />
opposizione al fascismo e si assestò su posizioni<br />
molto vicine a quelle del socialismo<br />
liberale <strong>di</strong> Carlo Rosselli. Poco alla volta sviluppò<br />
una sua visione incentrata sul concetto<br />
<strong>di</strong> persona preso a prestito dal fi losofo<br />
francese Emmanuel Mounier. Secondo questa<br />
concezione era assolutamente necessario<br />
superare l’in<strong>di</strong>vidualismo utilitaristico. Il<br />
singolo avrebbe dovuto sviluppare le sue<br />
potenzialità all’interno <strong>di</strong> una rete <strong>di</strong> solidarietà<br />
rappresentata dalla comunità stessa in<br />
cui vive. Si fece dunque strada l’idea <strong>di</strong> comunità<br />
come unità politica, sociale ed economica<br />
che avrebbe dovuto fondarsi sulla<br />
partecipazione democratica dal basso, sen-<br />
Fondazione Adriano Olivetti <strong>di</strong> Roma<br />
DALLA “SUISSE” 183<br />
Fondazione Adriano Olivetti <strong>di</strong> Roma
za la forza impositiva e arbitraria dello Stato, che semmai<br />
avrebbe dovuto avere appunto un’impronta federalistica, nel<br />
rispetto delle particolarità territoriali.<br />
Prese allora corpo a poco a poco una visione che defi niremmo<br />
oggi “globale” della società, che si manifestò progressivamente<br />
a tutto campo nella fabbrica <strong>di</strong> famiglia, nell’ambiente<br />
urbano circostante, in un progetto e<strong>di</strong>toriale e persino in un <strong>di</strong>segno<br />
politico. Nel 1945, dopo un periodo trascorso precauzionalmente<br />
in Svizzera, Adriano Olivetti scrisse L’or<strong>di</strong>ne politico della<br />
Comunità, un manifesto in cui esprime le sue idee. Nel 1946<br />
fondò invece la rivista Comunità, a cui affi ancò imme<strong>di</strong>atamente<br />
dopo la casa e<strong>di</strong>trice “E<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> Comunità”, che si sarebbe <strong>di</strong>stinta<br />
per la pubblicazione in vari campi delle scienze umane <strong>di</strong><br />
autori non ancora conosciuti in Italia. E due anni dopo, nel 1948,<br />
creò un vero e proprio “Movimento politico <strong>di</strong> Comunità”.<br />
L’impegno e<strong>di</strong>toriale<br />
Difatti tutto ciò che interessava ad Adriano Olivetti sembrava<br />
non essere assolutamente conosciuto in Italia. Sul piano teorico,<br />
come rileva il sociologo Domenico De Masi, «egli leggeva e<br />
pubblicava la sociologia, la fi losofi a sociale, l’etica, l’estetica; sul<br />
piano pratico la produzione moderna, il riformismo, la partecipa-<br />
La prima lettera scritta da Camillo alla moglie con la macchina per scrivere.<br />
The first letter written by Camillo to his wife using a typewriter.<br />
184 DALLA “SUISSE”<br />
Fondazione Adriano Olivetti <strong>di</strong> Roma<br />
zione dei lavoratori, la pianifi cazione territoriale, l’architettura<br />
contemporanea, il design». Tutto insomma rompeva con la cultura<br />
vigente, aprendo nuove strade che da un lato <strong>di</strong>ffondevano<br />
visioni innovatrici, ma dall’altro apparivano sospette e <strong>di</strong>vergenti,<br />
a fronte <strong>di</strong> un panorama e<strong>di</strong>toriale che il Fascismo aveva separato<br />
per venti anni dal progresso.<br />
Non è facile rimettere il lettore <strong>di</strong> oggi nel clima culturale <strong>di</strong><br />
allora, né la critica <strong>di</strong> Adriano all’immobilismo culturale italiano si<br />
esauriva nella protesta, ma puntava decisamente al riformismo<br />
e al rigore dei valori scientifi ci da applicare <strong>di</strong>rettamente nella<br />
pratica. Dai cataloghi della Fondazione Olivetti si possono dedurre<br />
sterminati apporti alle E<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> Comunità <strong>di</strong> penne prestigiose,<br />
soprattutto straniere, nei più svariati campi delle scienze<br />
umane. Spiccano i nomi <strong>di</strong> Jung, Piaget, Kierkegaard, Bergson,<br />
Claudel, i sociologi della scuola francese quali Gurvitch, Bettelheim<br />
e Mounier, lo scrittore svizzero Ramuz, Denis de Rougemont<br />
con Vita e morte dell’Europa e una interminabile schiera <strong>di</strong> altri<br />
autori. Domenico De Masi cita i testi <strong>di</strong> Simone Weil sulla vita<br />
operaia, <strong>di</strong> Raymond Aron sul rapporto tra Occidente e Unione<br />
Sovietica, <strong>di</strong> Roethlisberger sulla coesione <strong>di</strong> gruppo nelle fabbriche,<br />
classici come Weber e Durkheim che «introducevano luminose<br />
visioni nella scialba palude e<strong>di</strong>toriale italiana». Forse nessun<br />
libro, nota ancora De Masi, tra tutti quelli pubblicati dalle E<strong>di</strong>zioni<br />
volute da Adriano Olivetti, è altrettanto para<strong>di</strong>gmatico quanto<br />
Gemeischaft und Gesellschaft del sociologo tedesco Fer<strong>di</strong>nand<br />
Tönnies. «Qui la Comunità calda, protettiva, sanguigna, confortante,<br />
ma anche lenta, bigotta sospettosa, oppressiva, tra<strong>di</strong>zionalista,<br />
era contrapposta alla società fredda, impersonale, alienante,<br />
ma anche <strong>di</strong>namica, tecnologica, pratica, innovativa». Le<br />
“E<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> Comunità” erano in fondo la sintesi quasi perfetta <strong>di</strong><br />
tutto questo a coronamento del sogno (o dell’utopia) <strong>di</strong> Adriano:<br />
quello <strong>di</strong> «conciliare comunità e società, rendendo <strong>di</strong>namica la<br />
vita quoti<strong>di</strong>ana e affettiva la vita operaia».<br />
Le peregrinazioni intellettuali <strong>di</strong> Adriano Olivetti erano quasi<br />
sempre dettate anche dalla necessità e dall’urgenza <strong>di</strong> trasferire<br />
le proprie idee e la passione sociale nel progetto industriale che<br />
stava costruendo, ma che teneva ben <strong>di</strong>stinto dal progetto <strong>di</strong><br />
Comunità, anche se ovviamente i due interagivano, spesso si<br />
intersecavano. La casa e<strong>di</strong>trice rappresentava un luogo <strong>di</strong> formazione<br />
intellettuale e professionale, come d’altra parte l’universo<br />
industriale <strong>di</strong> Ivrea. Entrambi erano punti <strong>di</strong> incontro e fucine<br />
d’idee, dove chi vi lavorava acquisiva un’esperienza che poteva<br />
poi liberamente far germogliare altrove, in altre affermazioni professionali.<br />
Alle “E<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> Comunità” si affi ancarono poi nuove case<br />
e<strong>di</strong>trici <strong>di</strong> carattere perlopiù saggistico, sempre sotto la spinta <strong>di</strong><br />
Adriano, che si collocavano spesso al <strong>di</strong> fuori dei due rigi<strong>di</strong> e<br />
tutto sommato limitati blocchi <strong>di</strong> pensiero sviluppatisi con la<br />
Guerra Fredda, nel tentativo anche <strong>di</strong> in<strong>di</strong>care una Terza Via <strong>di</strong><br />
fronte alle contrapposizioni intellettuali dell’epoca, con<strong>di</strong>zionate<br />
da una marcata <strong>di</strong>cotomia tra interclassismo cattolico e lotta <strong>di</strong><br />
classe comunista. L’impresa e<strong>di</strong>toriale <strong>di</strong> Adriano Olivetti ha insomma<br />
esercitato negli anni Cinquanta una spinta decisamente<br />
straor<strong>di</strong>naria a favore del rinnovamento culturale italiano e come<br />
de’ Liguori Carino accenna nel suo trattato, «le E<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> Comunità<br />
hanno garantito alle voci <strong>di</strong>ssonanti più vive e profonde del<br />
loro tempo uno spazio d’indagine e <strong>di</strong> <strong>di</strong>vulgazione libero e <strong>di</strong>namico,<br />
nel simultaneo tentativo <strong>di</strong> dotare la società civile e l’azione<br />
politica <strong>di</strong> una nuova coscienza del suo agire e <strong>di</strong> una nuova<br />
tecnica per la costruzione <strong>di</strong> una società or<strong>di</strong>nata secondo i
principi guida <strong>di</strong> cui Adriano Olivetti<br />
parla nel suo celebre saggio Città<br />
dell’uomo».<br />
Un uomo che ha fatto il Novecento<br />
Così come risulta <strong>di</strong>ffi cile riproporre<br />
il clima intellettuale nella complessità<br />
culturale dell’epoca, il pensiero<br />
<strong>di</strong> Adriano Olivetti non è imme<strong>di</strong>atamente<br />
confi gurabile o riducibile<br />
a qualche enunciazione <strong>di</strong> principio.<br />
Si tratta perlopiù <strong>di</strong> una <strong>di</strong>mensione<br />
civile, dove la cultura si frappone al<br />
semplice meccanicismo economico.<br />
Una cultura libera che voleva<br />
però anche veicolare una funzione<br />
economica e politica alla ricerca <strong>di</strong><br />
una società migliore. È indubbio che<br />
questo modo innovativo, a volte <strong>di</strong>rompente,<br />
<strong>di</strong> vedere le cose ha lasciato<br />
un segno indelebile in un<br />
Pae se che usciva particolarmente<br />
smarrito dagli effetti congiunti del<br />
regime e della guerra. È però <strong>di</strong>ffi cile<br />
capire con lo sguardo <strong>di</strong> oggi se<br />
la visione olivettiana <strong>di</strong> allora non<br />
sia stata in qualche modo anche un<br />
po’ visionaria, se non si sia insomma<br />
macchiata <strong>di</strong> qualche contrad<strong>di</strong>zione<br />
o <strong>di</strong> qualche scorciatoia intellettuale troppo sbrigativa. La<br />
morte prematura <strong>di</strong> Adriano Olivetti ha semmai lasciato che<br />
questi interrogativi si cristallizzassero un po’ acriticamente sotto<br />
forma <strong>di</strong> spinte ideali, spesso incomprese e che pertanto non<br />
hanno potuto realizzarsi nella loro pienezza e reggere alla prova<br />
del tempo.<br />
Sarebbe in ogni caso sbagliato credere che il <strong>di</strong>segno <strong>di</strong><br />
Adriano Olivetti si sia limitato al microcosmo <strong>di</strong> Ivrea e che da<br />
quel progetto <strong>di</strong> fabbrica sia partita anche qualche ambizione<br />
intellettuale o politica <strong>di</strong> troppo. Gli anni Cinquanta furono marcati<br />
da un forte interesse per il Mezzogiorno, ispirato questa<br />
volta dai libri <strong>di</strong> Carlo Levi e dall’impegno sociale <strong>di</strong> intellettuali<br />
come Danilo Dolci, che Adriano Olivetti con il suo pragmatismo<br />
tradusse in possenti iniziative: interventi straor<strong>di</strong>nari nella Riforma<br />
agraria, nella Cassa del Mezzogiorno, il progetto urbanistico<br />
<strong>di</strong> Matera, i nuovi stabilimenti Olivetti <strong>di</strong> Pozzuoli.<br />
Quando Adriano ere<strong>di</strong>tò l’impresa fondata dal padre, negli<br />
anni Quaranta, essa contava appena qualche centinaio <strong>di</strong> <strong>di</strong>pendenti.<br />
Quando morì improvvisamente nel 1960, su un treno <strong>di</strong>retto<br />
a Losanna, la Olivetti aveva superato i 45.000 <strong>di</strong>pendenti,<br />
27.000 dei quali all’estero. La sua grandezza era legata alla<br />
concezione dell’impresa:<br />
come sintesi <strong>di</strong> cultura internazionale, tecnologia all’avanguar<strong>di</strong>a,<br />
organizzazione effi ciente, cooperazione partecipante, il tutto al<br />
servizio della comunità. È legata alla concezione dell’uomo come<br />
sintesi <strong>di</strong> produttore, consumatore e citta<strong>di</strong>no. È legata alla concezione<br />
dello Stato come sistema integrato <strong>di</strong> molteplici comunità, …<br />
È legata alla concezione dell’estetica come valore aggiunto alla<br />
perfezione delle macchine… È legata alla concezione della cultura,<br />
intesa come sintesi <strong>di</strong> scienza e tecnica, umanità e arte (Adriano<br />
Olivetti e le E<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> Comunità 1946-1960).<br />
Veduta dello stabilimento Olivetti a Pozzuoli costruito nella prima parte degli anni ’50 su progetto <strong>di</strong> Luigi Cosenza.<br />
A view of the Olivetti plant in Pozzuoli built in the first part of the 1950s accor<strong>di</strong>ng to Luigi Cosenza’s design.<br />
Vorrei terminare con un ultimo giu<strong>di</strong>zio del sociologo Domenico<br />
De Masi, certamente forte, che abbraccia interamente il <strong>di</strong>segno<br />
culturale e sociale <strong>di</strong> Adriano, tanto da inserirlo in modo<br />
certamente meritato fra le persone che hanno determinato il<br />
Novecento:<br />
Lontano mille miglia dalla febbrile voracità dell’accumulazione,<br />
dall’ignorante avventurismo dell’azzardo… che tuttora contagiano<br />
tanti impren<strong>di</strong>tori, possiamo <strong>di</strong>re che Adriano Olivetti è riuscito<br />
a traghettare l’impresa e il management dal mondo industriale<br />
al mondo post-industriale. Così come, negli stessi anni,<br />
Freud e Jung hanno traghettato la psicologia tra<strong>di</strong>zionale verso la<br />
psicanalisi, Picasso ha traghettato la pittura <strong>di</strong> Piero della Francesca<br />
verso il cubismo, Einstein ha traghettato la fi sica <strong>di</strong> Newton<br />
verso la relatività, Stravinskij ha traghettato la musica romantica<br />
verso l’atonalità, Joyce ha traghettato il romanzo ottocentesco<br />
verso l’opera aperta.<br />
Riferimenti bibliografi ci<br />
Bruno CAIZZI, Camillo e Adriano Olivetti, Utet, Torino 1962.<br />
Domenico DE MASI, Prefazione a Adriano Olivetti e le E<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> Comunità,<br />
Quaderni della Fondazione Olivetti, Roma 2008.<br />
Beniamino DE’ LIGUORI CARINO, Adriano Olivetti e le E<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> Comunità<br />
(1946-1960), Quaderni della Fondazione Olivetti, Roma 2008.<br />
Valerio OCHETTO, Adriano Olivetti. Industriale e utopista, Cossavella E<strong>di</strong>tore,<br />
Ivrea 2000.<br />
Adriano OLIVETTI, Città dell’uomo, E<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> Comunità, Milano 1959.<br />
Robi RONZA, Tra<strong>di</strong>zione e attualità del pensiero federalista italiano, in Federalismo<br />
in cammino, Coscienza Svizzera e Armando Dadò, Locarno<br />
1995.<br />
Associazione Archivio Storico Olivetti <strong>di</strong> Ivrea<br />
DALLA “SUISSE” 185
Adriano Olivetti,<br />
ritratto <strong>di</strong><br />
un impren<strong>di</strong>tore<br />
illuminato<br />
VALERIO CASTRONOVO<br />
Presidente Centro Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> Roma;<br />
storico dell’economia e dell’industria italiana<br />
Fra le tante defi nizioni che si sono date <strong>di</strong> Adriano Olivetti,<br />
una mi sembra più appropriata e congeniale alla fi gura <strong>di</strong><br />
un impren<strong>di</strong>tore così atipico. Quella <strong>di</strong> “utopista positivo”<br />
cconiata<br />
a suo tempo da Ferruccio Parri, il leader della<br />
Resistenza e primo capo del governo dell’Italia democratica. Quel<br />
che contrassegnò l’opera <strong>di</strong> Adriano fu infatti un utopismo pragmatico.<br />
Sia perché egli svolse un’azione concreta volta ad abbinare<br />
cultura e industria; sia perché era animato dall’intento <strong>di</strong><br />
coniugare le regole economiche con la responsabilizzazione sociale<br />
dell’impresa. Quella che Adriano si proponeva <strong>di</strong> realizzare<br />
era una “fabbrica dal volto umano”: ossia, una comunità <strong>di</strong> lavoro<br />
al passo con le tecnologie più aggiornate, ma senza che il<br />
macchinismo avesse il sopravvento sul fattore umano; con i<br />
conti dell’azienda in attivo, ma senza che la logica del profi tto<br />
fosse l’unico metro <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zio e <strong>di</strong> condotta.<br />
D’altra parte, a orientare fi n dai primi anni della sua formazione<br />
il giovane Adriano (<strong>di</strong> madre valdese e <strong>di</strong> padre appartenente<br />
a una famiglia ebrea) verso l’obiettivo <strong>di</strong> conciliare umanesimo<br />
e industrialismo, era stato un duplice or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> suggestioni e <strong>di</strong><br />
esperienze. Da un lato, sul piano intellettuale, il personalismo<br />
cristiano <strong>di</strong> Maritain e <strong>di</strong> Mounier e gli ideali del riformismo socialista.<br />
Dall’altro, quale moderno impren<strong>di</strong>tore, la conoscenza <strong>di</strong>ret-<br />
Adriano Olivetti,<br />
portrait of an illuminated businessman<br />
He was a “positive utopian”, but in reality, his dream was firmly rooted in the<br />
industrial and territorial reality in which he asserted himself with intelligence and<br />
determination. The “ factory with a human face” was well integrated into the<br />
productive dynamism of the Canavese region, which responded at the end of the<br />
1950s to the extraor<strong>di</strong>nary increase in the demand for durable consumer goods,<br />
such as typewriters. His winning card was not only enthusiasm. He surrounded<br />
himself with technicians and engineers with keen professional skills; he was<br />
meticulous with regard to the interaction between practicality and aesthetics,<br />
relying on the contribution of ingenious architects. All of this gave him the<br />
possibility of realizing a business that united profit with social commitment, with<br />
the prospect of promoting a people-friendly work ethic on all levels.<br />
186 DALLA “SUISSE”<br />
Ritratto <strong>di</strong> Adriano Olivetti, 1959.<br />
ta, acquisita durante varie sue visite negli Stati Uniti, tanto dei<br />
risultati pratici quanto dei problemi sociali posti dagli sviluppi del<br />
taylorismo e del for<strong>di</strong>smo. Inoltre, in quegli stessi anni in cui egli<br />
fi gurava schedato nei rapporti della polizia fascista con l’etichetta<br />
<strong>di</strong> “sovversivo”, aveva cominciato a tracciare il progetto <strong>di</strong><br />
un’organizzazione statuale su basi federaliste. Una nuova compagine,<br />
nella quale le rappresentanze dell’industria, del lavoro e<br />
della cultura avrebbero dovuto <strong>di</strong>venire altrettante componenti<br />
costitutive <strong>di</strong> un or<strong>di</strong>namento istituzionale articolato sulla triade<br />
<strong>di</strong> comunità, regione e federazione.<br />
Questo <strong>di</strong>segno che Adriano mise poi a punto durante l’esilio<br />
in Svizzera, dove era riparato nell’ottobre 1943, dopo l’avvento<br />
della Repubblica <strong>di</strong> Salò, e che pubblicò ne L’or<strong>di</strong>ne politico<br />
delle comunità, era parso a molti osservatori, all’indomani della<br />
Liberazione, il frutto <strong>di</strong> congetture del tutto astratte. Non così<br />
l’aveva giu<strong>di</strong>cato Luigi Einau<strong>di</strong> che, pur <strong>di</strong>ssentendo da alcune<br />
argomentazioni dell’autore, con<strong>di</strong>videva tuttavia una prospettiva<br />
come quella olivettiana che mirava a una sorta <strong>di</strong> self government<br />
e s’ispirava ai principi del pluralismo politico: quegli stessi che il<br />
futuro presidente della Repubblica riteneva essenziali sia per<br />
evitare che si riproducessero le strutture verticistiche e burocratiche<br />
del vecchio Stato centralistico, sia per scongiurare il sopravvento<br />
sulla società civile <strong>di</strong> partiti ideologici <strong>di</strong> massa e dei loro<br />
apparati.<br />
Fondazione Adriano Olivetti <strong>di</strong> Roma
Adriano Olivetti era dunque giunto fi n dall’imme<strong>di</strong>ato dopoguerra<br />
ad auspicare, insieme alla realizzazione <strong>di</strong> una “comunità<br />
<strong>di</strong> fabbrica a misura d’uomo”, che fosse pure una fucina <strong>di</strong> evoluzione<br />
culturale e sociale, e non solo una macchina <strong>di</strong> produzione,<br />
anche l’avvento <strong>di</strong> un sistema democratico che avesse per<br />
suoi car<strong>di</strong>ni lo sviluppo delle autonomie locali e nuove forme <strong>di</strong><br />
rappresentanza e <strong>di</strong> autogoverno.<br />
Nella maturazione <strong>di</strong> questi suoi propositi ebbero parte rilevante<br />
non soltanto le sue matrici culturali e quell’intelligenza intuitiva<br />
e contagiosa, quasi profetica, che pur in seguito rimarrà<br />
uno dei suoi tratti <strong>di</strong>stintivi inconfon<strong>di</strong>bili. Importanti furono anche<br />
certe caratteristiche specifi che dell’impresa <strong>di</strong> cui era titolare e<br />
le connotazioni altrettanto peculiari dell’ambiente dove si trovava<br />
a operare. Tanto l’azienda ere<strong>di</strong>tata dal padre, che nell’imme<strong>di</strong>ato<br />
dopoguerra era poco più che uno stabilimento <strong>di</strong> me<strong>di</strong>e <strong>di</strong>mensioni,<br />
ancorché rinomato, quanto la sua piccola patria d’origine,<br />
una marca <strong>di</strong> confi ne come il Canavese, si prestavano infatti sia<br />
all’intento perseguito da Adriano <strong>di</strong> creare un’impresa che abbinasse<br />
a capacità progettuali innovative un sistema <strong>di</strong> relazioni<br />
industriali aperto alla partecipazione dei lavoratori; sia al suo<br />
obiettivo <strong>di</strong> dar vita a un esperimento <strong>di</strong> democrazia dal basso,<br />
ossia a quella che egli chiamava una “comunità concreta”, protagonista<br />
<strong>di</strong> nuove forme <strong>di</strong> organizzazione sociale a livello territoriale.<br />
Quanto abbiano contato questi due elementi, la confi gurazione<br />
intrinseca <strong>di</strong> un’azienda le cui possibilità <strong>di</strong> successo erano<br />
legate a una forte dose <strong>di</strong> creatività e <strong>di</strong> eccellenza tecnica, e la<br />
fi sionomia dell’Epore<strong>di</strong>ese ancora in gran parte piccolo-conta<strong>di</strong>na<br />
ed estranea a un urbanesimo spinto, lo si può riscontrare dalla<br />
tipologia e dalle <strong>di</strong>rettrici <strong>di</strong> marcia della Olivetti nel corso degli<br />
anni Cinquanta.<br />
Veduta aerea degli stabilimenti Olivetti <strong>di</strong> Ivrea, anni ’60.<br />
Aerial view of the Olivetti plants in Ivrea, 1960s.<br />
Associazione Archivio Storico Olivetti <strong>di</strong> Ivrea<br />
Camillo Olivetti e la sua famiglia. In alto a destra Adriano Olivetti.<br />
Camillo Olivetti and his family. Top right Adriano Olivetti.<br />
È pur vero che anche per l’impresa canavesana (non <strong>di</strong>versamente<br />
che per la Fiat e le altre aziende del settore meccanico),<br />
la leva fondamentale che innescò uno sviluppo della produzione<br />
senza precedenti e a costi decrescenti, fu la domanda sempre<br />
più ingente <strong>di</strong> nuovi beni <strong>di</strong> consumo durevoli. Tant’è che nel<br />
1958, rispetto all’inizio <strong>di</strong> quel decennio, il numero delle macchine<br />
da scrivere collocate sul mercato s’era moltiplicato per più <strong>di</strong><br />
quattro volte e mezzo, quello delle portatili <strong>di</strong> quasi nove e quello<br />
delle macchine contabili per più <strong>di</strong> sessantasei volte. E ciò non<br />
solo per la familiarizzazione degli italiani con i nuovi strumenti<br />
della scrittura e del calcolo meccanico, ma anche per l’allargamento<br />
degli sbocchi commerciali sui mercati esteri.<br />
Tuttavia se l’Olivetti conobbe un’ascesa travolgente, lo dovette<br />
per tanti versi a un insieme <strong>di</strong> retaggi e <strong>di</strong> fattori che avevano<br />
a che vedere tanto con la particolare strategia aziendale<br />
adottata da Adriano quanto con lo scenario economico e sociale<br />
del Canavese.<br />
Dalla sua fondazione nel 1908 per iniziativa <strong>di</strong> Camillo Olivetti,<br />
l’impresa canavesana non solo aveva conservato un sistema<br />
<strong>di</strong> gestione fortemente personalizzato (al punto che il fondatore<br />
e suo fi glio si occupavano anche della formazione dei capi<br />
operai). Essa era rimasta altresì fedele alla propria vocazione<br />
originaria, incentrata soprattutto sul perfezionamento dei proce<strong>di</strong>menti<br />
operativi, sulla ricerca e sulla sperimentazione, dall’attrezzaggio<br />
alle linee del prodotto. Si trattava in sostanza <strong>di</strong> un’impresa<br />
<strong>di</strong> tecnici e <strong>di</strong> ingegneri con robuste capacità professionali.<br />
Se nel campo della produzione determinate attitu<strong>di</strong>ni e capacità<br />
progettuali furono l’arma vincente dell’Olivetti, un design e<br />
una grafi ca particolarmente originale svolsero, a loro volta, un<br />
ruolo importante nel conferire alla Olivetti dei propri specifi ci<br />
tratti <strong>di</strong>stintivi e nell’assecondare, <strong>di</strong> conseguenza, le sue politiche<br />
promozionali. Di questo intreccio tra funzionalità ed estetica<br />
furono artefi ci alcuni geniali architetti (da Belgioioso a Perasutti,<br />
a Rogers, da Carlo Scarpa a Nizzoli, ad altri ancora). La loro opera<br />
contribuì anche all’allestimento <strong>di</strong> alcune se<strong>di</strong> dell’Olivetti, in<br />
Italia e all’estero, che rafforzarono l’immagine e il prestigio<br />
dell’azienda <strong>di</strong> Ivrea.<br />
Quanto al secondo elemento che concorse a fare dell’Olivetti<br />
un’azienda sui generis, con un timbro del tutto particolare,<br />
va detto che un territorio come il Canavese, ancora esente dall’af-<br />
DALLA “SUISSE” 187<br />
Fondazione Adriano Olivetti <strong>di</strong> Roma
fl usso <strong>di</strong> forti correnti immigratorie e da una proliferazione <strong>di</strong> attività<br />
industriali, ben si prestava a fare da modello per un <strong>di</strong>segno<br />
<strong>di</strong> programmazione che saldasse armonicamente l’espansione <strong>di</strong><br />
una grande impresa con l’economia agricola del contado, il capoluogo<br />
alle borgate dell’entroterra: ossia, alla convinzione <strong>di</strong> Adriano<br />
che si dovesse puntare sull’impianto <strong>di</strong> alcune aziende <strong>di</strong> lavorazione<br />
dei prodotti della terra nel circondario e nelle vallate<br />
prealpine, piuttosto che incentivare l’immigrazione <strong>di</strong> conta<strong>di</strong>ni e<br />
valligiani ad affollare, in cerca <strong>di</strong> lavoro, le aree urbane. Anche la<br />
fi gura dell’operaio allora prevalente negli stabilimenti della Olivetti,<br />
che non aveva interrotto del tutto i rapporti con la campagna<br />
intorno a Ivrea sia per la loro residenza nelle località d’origine sia<br />
in virtù del fatto che le loro famiglie possedevano per lo più dei<br />
piccoli fon<strong>di</strong>, offriva molti punti d’appoggio per una fi losofi a come<br />
quella del movimento <strong>di</strong> Comunità e del sindacato <strong>di</strong> “Autonomia<br />
aziendale”. Sia l’uno sia l’altro intendevano infatti affrancare la<br />
classe lavoratrice dalla servitù psicologica e dalle alienazioni del<br />
lavoro alla catena <strong>di</strong> montaggio e dall’anonimato della grande<br />
fabbrica.<br />
Dunque, da un lato, un’impresa contrassegnata da un’alta<br />
qualità e da un’eccellente concezione stilistica dei suoi prodotti;<br />
dall’altro, un comprensorio immune dai traumi del gigantismo<br />
industriale e da un’eccessiva congestione urbana. Furono queste<br />
le fondamenta su cui Adriano Olivetti fece assegnamento per<br />
realizzare un complesso industriale d’avanguar<strong>di</strong>a per la sua<br />
cultura d’impresa e le sue specifi che politiche sociali.<br />
A tal fi ne si rivelò comunque essenziale l’apporto delle idee<br />
e delle intuizioni del tutto personali <strong>di</strong> Adriano, che non avevano<br />
per riferimento né i retaggi del positivismo né i canoni dell’idealismo<br />
e del marxismo. Risultarono invece preziose per la sua formazione<br />
culturale le rifl essioni <strong>di</strong> pensatori e intellettuali come<br />
Schumpeter, Kelsen, Friedmann, Mounier, Simone Weil, Mumford.<br />
Esse erano infatti importanti non solo per comprendere<br />
meglio i problemi <strong>di</strong> fondo del capitalismo e del socialismo, ma<br />
anche per capire in pieno quale rilevanza<br />
avessero nella società contemporanea le<br />
conoscenze scientifi che, le trasformazioni<br />
del lavoro, il <strong>di</strong>ritto come tecnica <strong>di</strong> organizzazione<br />
sociale, l’urbanistica per la qualità<br />
della vita e i rapporti con l’ambiente.<br />
D’altra parte, Adriano Olivetti si avvalse,<br />
tanto nella conduzione della sua impresa<br />
quanto nelle relazioni culturali che fecero<br />
da collante ai suoi progetti, del contributo<br />
<strong>di</strong> un folto staff <strong>di</strong> intellettuali-manager<br />
e <strong>di</strong> consulenti provenienti dai più <strong>di</strong>versi<br />
campi delle scienze sociali e umane, ma<br />
accomunati da una visione che infrangeva<br />
il muro degli specialismi. Sociologi, economisti,<br />
psicologi, politologi, architetti e designer,<br />
ma anche scrittori e letterati. Non è<br />
qui il caso <strong>di</strong> citare dei nomi; basterà <strong>di</strong>re,<br />
per rendersi conto dei loro orientamenti,<br />
che essi, per lo più, appartenevano idealmente<br />
a quella che allora veniva defi nita<br />
come la “terza forza”, ossia una sinistra<br />
laica e <strong>di</strong> formazione neo illuminista, tendente<br />
a mutuare criteri e modelli d’azione<br />
dalla cultura progressista nord europea e<br />
americana.<br />
188 DALLA “SUISSE”<br />
Manifesto per la convocazione della Consulta del<br />
Consiglio <strong>di</strong> Gestione.<br />
The notice for summoning the Management<br />
Board Council.<br />
Adriano Olivetti accanto ad alcuni giovani operai nella fabbrica <strong>di</strong> Ivrea verso la<br />
fine degli anni Cinquanta (Publifoto).<br />
Adriano Olivetti next to several young workers in the Ivrea factory toward the end<br />
of the 1950s (Publifoto).<br />
Quella che Adriano realizzò nel corso degli anni Cinquanta<br />
fu, dunque, un’avventura impren<strong>di</strong>toriale pressoché unica, fuori<br />
dall’or<strong>di</strong>nario per quei tempi, e tale da costituire un modello mai<br />
più eguagliato in seguito. Un’impresa che, insieme a brillanti risultati<br />
economici, conseguì anche singolari obiettivi <strong>di</strong> carattere<br />
sociale; che dava modo ai suoi <strong>di</strong>rigenti <strong>di</strong> ampliare le loro visuali<br />
oltre l’orizzonte delle proprie particolari competenze e <strong>di</strong> fare<br />
cose nuove; che corrispondeva agli operai che vi lavoravano salari<br />
più elevati <strong>di</strong> un terzo rispetto a quelli vigenti nei contratti<br />
nazionali <strong>di</strong> categoria. Inoltre, Adriano aveva promosso un ventaglio<br />
<strong>di</strong> servizi sociali riconosciuti come altrettanti <strong>di</strong>ritti delle maestranze<br />
(case, asili, colonie, trasporti, scuole professionali e<br />
svariate forme <strong>di</strong> assistenza). Ma aveva anche <strong>di</strong>sposto che la<br />
biblioteca aziendale annoverasse opere delle più <strong>di</strong>verse tenden-<br />
Associazione Archivio Storico Olivetti <strong>di</strong> Ivrea<br />
ze, anche quelle più ra<strong>di</strong>cali ed eterodosse;<br />
e che alle conferenze che si tenevano ogni<br />
lunedì nei suoi centri culturali, per gli operai<br />
e gli impiegati, venissero invitati relatori <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>fferenti orientamenti – marxisti, liberali,<br />
cattolici. E questo in un Paese <strong>di</strong>viso a quel<br />
tempo da forti contrapposizioni politiche e<br />
ideologiche.<br />
Se queste e altre ancora furono le<br />
iniziative <strong>di</strong> carattere innovativo che Adriano<br />
Olivetti realizzò nell’ambito della sua<br />
fabbrica, in conformità ai suoi propositi <strong>di</strong><br />
natura sociale, ugualmente lungimiranti<br />
appaiono, ancor oggi, le sue concezioni in<br />
materia <strong>di</strong> politica del territorio. A questo<br />
riguardo aveva certamente appreso alcuni<br />
elementi <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zio dalla sua conoscenza<br />
<strong>di</strong>retta <strong>di</strong> una realtà come quella elvetica.<br />
Di fatto, Adriano muoveva dall’ideale <strong>di</strong> una<br />
federazione <strong>di</strong> piccole-me<strong>di</strong>e comunità<br />
territoriali, quali cellule primarie dell’organizzazione<br />
statuale, che consentissero sia<br />
un rapporto <strong>di</strong>retto fra eletti ed elettori sia<br />
lo sviluppo <strong>di</strong> particolari forme <strong>di</strong> autogoverno.<br />
In tal modo intendeva contrastare<br />
l’esautoramento della società civile da<br />
Associazione Archivio Storico Olivetti <strong>di</strong> Ivrea
parte <strong>di</strong> uno Stato burocratizzato e dalle<br />
oligarchie dei principali partiti.<br />
A questo suo progetto egli cercò <strong>di</strong><br />
dare consistenza concreta a Ivrea e in<br />
alcuni centri del Canavese amministrati<br />
dal Movimento <strong>di</strong> Comunità, da lui creato<br />
nel 1950. E contestualmente provvide<br />
sia a decentrare alcune aziende<br />
dell’indotto dell’Olivetti nelle località limitrofe<br />
sia a creare un Istituto (l’Irur) che<br />
aveva lo scopo <strong>di</strong> assecondare la formazione<br />
nelle campagne circostanti <strong>di</strong> piccole<br />
imprese e cooperative agricole<br />
tecnicamente attrezzate.<br />
Di fatto, il Piano regolatore del<br />
Canavese da lui promosso nel 1951,<br />
l’opera culturale ed educativa svolta dal<br />
Movimento <strong>di</strong> Comunità in vari piccoli<br />
centri e i programmi <strong>di</strong> investimento<br />
dell’Irur in impianti irrigui, rimboschimenti<br />
e infrastrutture, per uno “sviluppo integrato”<br />
fra agricoltura e industria, contribuirono<br />
a imprimere tratti del tutto<br />
peculiari all’ambiente e alla vita collettiva<br />
locale, nonché ad assicurare una <strong>di</strong>mensione<br />
socialmente accettabile agli<br />
impetuosi ritmi <strong>di</strong> sviluppo dell’Olivetti,<br />
assurta nel volgere <strong>di</strong> pochi anni ai fasti<br />
<strong>di</strong> una grande impresa.<br />
Quello <strong>di</strong> Adriano non fu tuttavia un<br />
itinerario scevro <strong>di</strong> remore e intralci, in<br />
quanto egli si scontrò, sul versante delle<br />
politiche sociali, sia con l’avversione e<br />
lo scetticismo <strong>di</strong> gran parte dell’establishment<br />
industriale, sia con la contrarietà<br />
dei principali sindacati che, per<br />
miopia o per pregiu<strong>di</strong>zi ideologici, consideravano<br />
l’in<strong>di</strong>rizzo inaugurato dalla Olivetti nei rapporti con le<br />
proprie maestranze una sorta più aggiornata <strong>di</strong> paternalismo<br />
padronale, se non come una vera e propria mistifi cazione.<br />
In realtà, Adriano non voleva essere defi nito, dai suoi estimatori,<br />
come un “patron” illuminato. Egli si sentiva e intendeva<br />
essere un “riformatore”. In effetti, le sue iniziative pratiche come<br />
le sue proiezioni avveniristiche avevano per denominatore comune<br />
un’ispirazione che traeva origine e fondamento da un progetto<br />
politico-culturale. Al punto che egli giunse a concepire l’idea<br />
<strong>di</strong> convertire un giorno la sua azienda in una fondazione sulla<br />
base <strong>di</strong> un nuovo assetto proprietario che rappresentasse le<br />
varie componenti del mondo della produzione, della cultura e del<br />
lavoro.<br />
Un personaggio, dunque, controcorrente sotto ogni aspetto,<br />
tanto da essere ad<strong>di</strong>tato <strong>di</strong> volta in volta come un temerario, un<br />
visionario, quando non come un uomo perso <strong>di</strong>etro il suo sogno<br />
<strong>di</strong> coniugare progresso industriale e democrazia economica, effi -<br />
cientismo tecnologico ed equità sociale.<br />
Eppure Adriano era riuscito a portare a compimento nel<br />
1959, un anno prima della sua prematura scomparsa, un’impresa<br />
come l’acquisizione della Underwood. Mai l’industria italiana<br />
era stata in grado <strong>di</strong> realizzare un’iniziativa così rilevante a livello<br />
internazionale, ossia la scalata a uno dei massimi “santuari”<br />
Sopra: cerimonia <strong>di</strong> inaugurazione del primo nucleo <strong>di</strong><br />
case per i <strong>di</strong>pendenti dello stabilimento Olivetti <strong>di</strong> Pozzuoli<br />
(Napoli) il 23 aprile 1955. Sotto: Roberto Olivetti nel<br />
maggio 1960 riceve a Firenze la laurea ad honorem<br />
assegnata dalla Facoltà <strong>di</strong> Scienze Politiche “C. Alfieri”<br />
alla memoria dell’ing. Adriano Olivetti, scomparso il 27<br />
febbraio <strong>di</strong> quello stesso anno (Foto Locchi-Firenze).<br />
Above: the inauguration ceremony of the first group of<br />
houses for employees of the Olivetti plant in Pozzuoli<br />
(Naples) on April 23, 1955. Below: Roberto Olivetti in May<br />
1960 as he receives an honorary degree in Florence from<br />
the “C. Alfieri” Political Science Faculty in memory of<br />
Engineer Adriano Olivetti, who passed away February 27<br />
of the same year (Photo Locchi Florence).<br />
Associazione Archivio Storico Olivetti <strong>di</strong> Ivrea Associazione Archivio Storico Olivetti <strong>di</strong> Ivrea<br />
dell’impren<strong>di</strong>toria americana, quello stesso<br />
che aveva tenuto a battesimo a fi ne<br />
Ottocento il prototipo della macchina da<br />
scrivere e monopolizzato, per tanti decenni,<br />
uno dei campi più esclusivi della meccanica<br />
<strong>di</strong> precisione con una produzione<br />
in serie dalle cadenze <strong>di</strong> centinaia <strong>di</strong> migliaia<br />
<strong>di</strong> pezzi l’anno. Qualcosa come la<br />
Singer fra le macchine da cucire o come<br />
la Ford fra le automobili, un traguardo che<br />
sia Camillo sia Adriano Olivetti (andati<br />
varie volte in pellegrinaggio a Hartford per<br />
guardare e imparare) non avevano nemmeno<br />
lontanamente immaginato <strong>di</strong> poter<br />
mettere in conto fra i loro più ar<strong>di</strong>ti piani<br />
per l’avvenire.<br />
Ma non si trattò dell’unica impresa<br />
che Adriano realizzò in quel tornante.<br />
L’altra fu quella <strong>di</strong> allineare la Olivetti agli<br />
stessi nastri <strong>di</strong> partenza della Ibm, e in<br />
anticipo sui giapponesi, in un settore<br />
strategico come quello dell’elettronica.<br />
Lui e il fi glio Roberto avevano infatti intuito<br />
in tutta la loro portata le potenzialità<br />
che sarebbero derivate col passaggio dei<br />
transistor ai circuiti integrati e ai semiconduttori.<br />
Tant’è che s’erano assicurati l’appoggio<br />
<strong>di</strong> Enrico Fermi e avevano dato vita<br />
a un’équipe <strong>di</strong> scienziati e specialisti, <strong>di</strong><br />
concerto con l’Università <strong>di</strong> Pisa, la cui<br />
opera s’era tradotta nella realizzazione<br />
nel 1959 dei primi gran<strong>di</strong> calcolatori<br />
“Elea”. Dopo la scomparsa <strong>di</strong> Adriano nel<br />
febbraio 1960, fu perciò un grave errore<br />
<strong>di</strong> fatto e <strong>di</strong> valutazione quello poi commesso<br />
da un gruppo d’intervento fi nanziario<br />
per il risanamento dell’Olivetti (ancor-<br />
ché fosse composto dai maggiori nomi dell’industria e della fi nanza<br />
italiana) che giu<strong>di</strong>cò i computer un sogno avveniristico, se non<br />
un giocattolo. Fu così che, qualche anno dopo, la Divisione elettronica<br />
dell’Olivetti venne purtroppo ceduta alla General Electric.<br />
Roberto Olivetti in visita alla Olivetti Underwood, a Toronto, in Canada, nel 1969.<br />
Roberto Olivetti during a visit to the Olivetti Underwood in Toronto, Canada in 1969.<br />
Associazione Archivio Storico Olivetti <strong>di</strong> Ivrea<br />
DALLA “SUISSE” 189
Adriano Olivetti:<br />
tra sogno e realtà<br />
MAURO LEO BARANZINI<br />
Professore or<strong>di</strong>nario, Università della Svizzera italiana;<br />
Membro Istituto Lombardo, Accademia Scienze e Lettere, Milano<br />
FABRIZIO FAZIOLI<br />
Laureato in scienze economiche e sociali<br />
all’Università <strong>di</strong> Neuchâtel, giornalista e autore<br />
Pubblicità Olivetti anni Settanta. Olivetti advertising from the 1970s<br />
Adriano Olivetti:<br />
between dream and reality<br />
In the spectrum of managerial theories of <strong>di</strong>fferent businesses, trends in the<br />
prospect of progress include: maximizing super-profits, maximizing sales and<br />
maximizing growth rates. The Olivetti experience was a breakthrough initiative<br />
in many senses. These uncommon entrepreneurial skills led the company to<br />
have 16,000 employees in 1960 in Italy alone. Abroad, international prestige<br />
was ensured by the takeover of Underwood, a leader in the field. Today,<br />
perhaps we should reconsider those illuminated choices, going beyond a<br />
“short-sighted” free market and the greed of Raiders with Fast Buck mentality.<br />
With regard to the recent financial crisis, it has nothing to do with a utopia but<br />
rather, a more open-minded view of the concept of development.<br />
190 DALLA “SUISSE”<br />
Serigio Libis<br />
La scienza economica e le teorie dell’impresa<br />
Gli stu<strong>di</strong>osi <strong>di</strong> economia arrancano sempre quando si tratta<br />
<strong>di</strong> offrire un quadro analitico dei comportamenti degli attori economici.<br />
Lo scozzese Adam Smith (1723-90) nella seconda metà<br />
del Settecento descriveva con attenzione i vantaggi della <strong>di</strong>visione<br />
del lavoro all’interno delle fabbriche, e la mano invisibile che guida<br />
gli impren<strong>di</strong>tori e che nel contempo fa l’interesse supremo sia<br />
degli stessi sia della società tutta intera. I marginalisti (dal 1870<br />
al 1936 circa) si sono occupati della combinazione dei fattori<br />
produttivi delle aziende così da minimizzare i costi o da massimizzare<br />
l’utile <strong>di</strong> breve periodo. Fu Alfred Marshall (1842-1924),<br />
dell’Università <strong>di</strong> Cambridge, che defi nì le con<strong>di</strong>zioni con le quali<br />
l’impresa in concorrenza perfetta massimizza il super-profi tto <strong>di</strong><br />
breve periodo. Tuttavia Marshall si limitò alle tecniche produttive,<br />
piuttosto che rivolgere la sua attenzione alle strategie aziendali.<br />
Poi la teoria dell’impresa registrò un’improvvisa accelerazione<br />
a partire dalla fi ne degli anni Venti del secolo scorso, sempre<br />
a Cambridge in Inghilterra. Dapprima con le sorprendenti analisi<br />
<strong>di</strong> Piero Sraffa (1898-1983), Richard Kahn (1905-89) e Joan<br />
Robinson (1903-83) che elaborarono i modelli dei mercati imperfetti,<br />
come monopolio, oligopolio e concorrenza monopolistica.<br />
Questi contributi sono stati importanti per meglio capire i meccanismi<br />
della micro-economia e delle varie forme <strong>di</strong> mercato. Ma<br />
bisognerà aspettare fi no al secondo dopoguerra per le moderne<br />
teorie manageriali dell’impresa.<br />
I <strong>di</strong>versi obiettivi dell’impresa<br />
Le strategie e gli obiettivi dell’impresa privata sono determinati:<br />
a) dalla sua proprietà giuri<strong>di</strong>ca (se posseduta <strong>di</strong>rettamente<br />
da una persona o attraverso una società); b) dal tipo <strong>di</strong> mercato<br />
sul quale opera (concorrenza perfetta, concorrenza monopolistica,<br />
monopolio, oligopolio); e c) dai rapporti <strong>di</strong> forza fra gruppi con<br />
interessi <strong>di</strong>fferenti (azionisti, <strong>di</strong>rigenti, sindacati e cre<strong>di</strong>tori). Va<br />
notato che l’organizzazione delle me<strong>di</strong>e e gran<strong>di</strong> aziende moderne<br />
<strong>di</strong>fferisce da quella dell’impresa classica <strong>di</strong> tipo familiare <strong>di</strong> un<br />
tempo, sia per <strong>di</strong>mensione, sia per organizzazione e quota <strong>di</strong><br />
mercato.<br />
La massimizzazione del super-profi tto<br />
Il super-profi tto <strong>di</strong> un’impresa è eguale alla <strong>di</strong>fferenza fra i<br />
suoi ricavi e i costi totali; si fa l’ipotesi della sua massimizzazione<br />
in base alle funzioni <strong>di</strong> costo (offerta) e <strong>di</strong> ricavo (domanda)<br />
dell’impresa. Tale ipotesi è basata:<br />
1) sulla convinzione che i super-profi tti possano essere contabilizzati<br />
in modo preciso. Questo richiede la conoscenza del valore<br />
dei ricavi totali e dei costi totali per un ampio intervallo <strong>di</strong><br />
produzione;<br />
2) sul concetto <strong>di</strong> impresa olistica, con un’unica e inscin<strong>di</strong>bile<br />
unità decisionale, che agisce con i medesimi criteri dell’impren<strong>di</strong>tore-padrone-<strong>di</strong>rigente<br />
<strong>di</strong> una volta.<br />
Il concetto <strong>di</strong> massimizzazione dei super-profi tti ha dominato<br />
l’analisi micro-economica dal 1870 al 1950 circa; in seguito<br />
vennero formulati nuovi modelli.<br />
La teoria <strong>di</strong> Baumol della massimizzazione<br />
delle ven<strong>di</strong>te (o dei ricavi totali)<br />
William Baumol ha proposto la prima teoria manageriale in<br />
alternativa alla massimizzazione del super-profi tto, e cioè quella<br />
della massimizzazione del ricavo dalle ven<strong>di</strong>te, con i seguenti argomenti:
1) la separazione della proprietà dell’azienda dall’effettiva<br />
conduzione, tipica dell’impresa moderna. Ciò dà ai <strong>di</strong>rettori-<strong>di</strong>rigenti<br />
un certo grado <strong>di</strong> libertà nel management dell’azienda, così<br />
da poter mirare alla massimizzazione delle ven<strong>di</strong>te, piuttosto che<br />
a quella del super-profi tto;<br />
2) sovente le retribuzioni dei manager, inclusi bonus e fringe<br />
benefi ts, sono più in relazione con il livello delle ven<strong>di</strong>te che con<br />
quello dei profi tti;<br />
3) gli istituti fi nanziari tendono a dare maggiore importanza al<br />
volume delle ven<strong>di</strong>te o dei ricavi totali in occasione <strong>di</strong> richieste <strong>di</strong><br />
fi nanziamento per nuovi investimenti;<br />
4) nel contesto <strong>di</strong> mercati non concorrenziali una maggior<br />
quota <strong>di</strong> mercato permette <strong>di</strong>: a) controllare e scoraggiare l’entrata<br />
<strong>di</strong> nuovi concorrenti; b) controllare l’operato dei concorrenti già<br />
esistenti, limitandone eventuali ambizioni espansive; c) esercitare<br />
un maggior potere sui prezzi; d) esercitare un certo controllo<br />
sui fornitori <strong>di</strong> materie prime; e) meglio controllare i canali <strong>di</strong>stributivi;<br />
5) la politica del personale risulta più facile quando le ven<strong>di</strong>te<br />
sono in espansione, in quanto ciò comporta una <strong>di</strong>minuzione del<br />
rapporto costi fi ssi/costi totali;<br />
6) rilevanti ven<strong>di</strong>te, crescenti nel tempo, danno prestigio ai<br />
<strong>di</strong>rettori-<strong>di</strong>rigenti, mentre rilevanti profi tti vanno soprattutto a<br />
vantaggio degli azionisti-comproprietari;<br />
7) la correlazione fra livello delle ven<strong>di</strong>te e retribuzioni dei<br />
manager è la risultante a) della necessità <strong>di</strong> offrire salari competitivi<br />
per assumere i quadri manageriali inferiori o me<strong>di</strong>; b)<br />
della struttura della gerarchia manageriale, più ridotta per le<br />
piccole aziende e più articolata per le gran<strong>di</strong>; c) del principio<br />
secondo il quale a responsabilità maggiori corrisponde una retribuzione<br />
superiore.<br />
Alcuni operai nella fabbrica Olivetti <strong>di</strong> Pozzuoli nel 1958.<br />
Several workers in the Olivetti factory in Pozzuoli in 1958.<br />
Adriano Olivetti tra la folla. Adriano Olivetti in a crowd.<br />
Riassumendo, per Baumol i manager mirano alla massimizzazione<br />
delle ven<strong>di</strong>te per accrescere il loro statuto associato con<br />
la conduzione <strong>di</strong> gran<strong>di</strong> aziende, e il proprio potere strettamente<br />
collegato ai fattori produttivi, quali il capitale umano, macchinario,<br />
tecnologia e capitale fi nanziario. Il potere è inoltre associato alla<br />
quota <strong>di</strong> mercato.<br />
Il modello <strong>di</strong> crescita dell’impresa manageriale<br />
<strong>di</strong> Robin Marris<br />
Per l’economista <strong>di</strong> Cambridge Robin Marris, l’impresa tende<br />
a massimizzare il “saggio <strong>di</strong> crescita equilibrata”, espresso<br />
dal saggio <strong>di</strong> crescita della domanda per i propri prodotti e del<br />
suo capitale sociale. Massimizzando congiuntamente il saggio <strong>di</strong><br />
crescita della domanda e del capitale sociale, i manager perseguono<br />
un duplice obiettivo: massimizzare la loro utilità (o sicurezza)<br />
e allo stesso tempo le aspettative dei proprietari-azionisti.<br />
Ricor<strong>di</strong>amo che i modelli manageriali<br />
si fondano su una netta separazione<br />
tra la proprietà e il controllo<br />
dell’impresa. La funzione <strong>di</strong> utilità<br />
dei manager ha come oggetto gli<br />
stipen<strong>di</strong>, il potere, la sicurezza del<br />
lavoro e il loro status sociale; gli<br />
azionisti-proprietari hanno una funzione<br />
<strong>di</strong> utilità che comprende anzitutto<br />
i profi tti e l’entità del capitale.<br />
Per Marris la classe manageriale<br />
non ambisce a massimizzare<br />
la <strong>di</strong>mensione assoluta dell’impresa,<br />
bensì il suo saggio <strong>di</strong> crescita.<br />
La Koutsoyiannis sottolinea che «i<br />
manager preferiscono essere promossi<br />
nell’ambito della medesima<br />
organizzazione in espansione, piuttosto<br />
che doversi spostare in una<br />
organizzazione più grande, dove<br />
l’ambiente potrebbe <strong>di</strong>mostrarsi<br />
ostile nei confronti del nuovo arrivato».<br />
I <strong>di</strong>rigenti punterebbero quin<strong>di</strong><br />
alla massimizzazione del saggio <strong>di</strong><br />
crescita dell’impresa piuttosto che<br />
alla sua <strong>di</strong>mensione.<br />
Cartier-Bresson - Associazione Archivio Storico Olivetti <strong>di</strong> Ivrea<br />
Fondazione Adriano Olivetti <strong>di</strong> Roma<br />
DALLA “SUISSE” 191
A sinistra: veduta dell’e<strong>di</strong>ficio destinato alla presidenza della fabbrica Olivetti <strong>di</strong><br />
Pozzuoli costruita nella prima parte degli anni ’50 su progetto <strong>di</strong> Luigi Cosenza.<br />
A destra: alcuni allievi del corso biennale <strong>di</strong> qualificazione per elettromeccanici<br />
durante un’esperienza <strong>di</strong> laboratorio.<br />
La tecnostruttura <strong>di</strong> John Kenneth Galbraith<br />
La teoria della tecnostruttura <strong>di</strong> John Kenneth Galbraith è<br />
basata sulla convinzione che le grosse imprese hanno la possibilità<br />
<strong>di</strong> creare la loro propria domanda, attraverso la pubblicità,<br />
la ricerca e lo sviluppo. Galbraith è convinto che la fi gura dell’impren<strong>di</strong>tore-proprietario<br />
stia scomparendo.<br />
Alla <strong>di</strong>rezione dell’impresa l’impren<strong>di</strong>tore è stato sostituito da<br />
un consiglio d’amministrazione, che è un organo collettivo, imperfettamente<br />
defi nito; nella grande società comprende il presidente<br />
del consiglio, il presidente della società, alcuni vicepresidenti con<br />
importanti responsabilità settoriali o relative al personale, i titolari<br />
<strong>di</strong> altre importanti posizioni <strong>di</strong>rigenti ed eventualmente i capi<strong>di</strong>visione<br />
ed i capireparto [...]. Questo gruppo è molto vasto: va dai più<br />
alti funzionari della società fi no a toccare, al limite, i <strong>di</strong>pendenti dal<br />
colletto bianco e blu la cui funzione consiste nell’uniformarsi alle<br />
<strong>di</strong>sposizioni o alla routine. Ne fanno parte tutti coloro che contribuiscono<br />
con cognizioni specialistiche, talento o esperienza alle decisioni<br />
<strong>di</strong> gruppo. Questo, non il consiglio d’amministrazione, è l’intelligenza<br />
<strong>di</strong>rettiva – il cervello – dell’impresa. Propongo <strong>di</strong> chiamare<br />
questa organizzazione tecnostruttura (JKG).<br />
L’impresa privata tra profi tto massimo e responsabilità sociale<br />
L’industria creata dagli Olivetti incorpora <strong>di</strong>versi degli elementi<br />
menzionati sopra, e rappresenta un apripista per <strong>di</strong>verse sue<br />
innovazioni. Notiamo che quando si parla <strong>di</strong> impresa con un forte<br />
senso <strong>di</strong> “responsabilità sociale”, si immagina una fi gura <strong>di</strong> impren<strong>di</strong>tore<br />
<strong>di</strong> terza o quarta generazione che parte con enormi mezzi<br />
fi nanziari, in<strong>di</strong>pendentemente dalle sue qualità impren<strong>di</strong>toriali. Invece,<br />
almeno nel caso <strong>di</strong> Camillo (padre) e <strong>di</strong> Adriano (fi glio) Olivetti<br />
si tratta anzitutto <strong>di</strong> persone con doti manageriali ed impren<strong>di</strong>toriali<br />
fuori dal comune. Ben <strong>di</strong>ce Bruno Caizzi (1962, p. 233):<br />
La fortuna della società <strong>di</strong> Ivrea fu che all’appuntamento col<br />
destino si presentasse un uomo della tempra <strong>di</strong> Adriano che non<br />
aveva bisogno <strong>di</strong> essere incoraggiato ad osare. Adriano sapeva<br />
fi utare le circostanze e come nessun altro era in grado <strong>di</strong> trarne<br />
partito. Il suo temperamento lo portava a prendere risolutamente<br />
l’iniziativa e ve lo portava la sua esperienza [...].<br />
Vi era dunque <strong>di</strong>etro tutto questo un <strong>di</strong>segno impren<strong>di</strong>toriale<br />
<strong>di</strong> risonanza mon<strong>di</strong>ale, che nel 1960, anno della prematura<br />
scomparsa <strong>di</strong> Adriano Olivetti, portò il numero dei <strong>di</strong>pendenti a<br />
16.000 in Italia, senza contare le migliaia all’estero, e la partecipazione<br />
al 69% dell’americana Underwood (che fu leader mon<strong>di</strong>ale<br />
per decenni). Il riconoscimento delle qualità manageriali <strong>di</strong><br />
Adriano Olivetti era anche internazionale.<br />
192 DALLA “SUISSE”<br />
Associazione Archivio Storico Olivetti <strong>di</strong> Ivrea<br />
Left: a view of the buil<strong>di</strong>ng designated for the presidency at the Olivetti plant in<br />
Pozzuoli built in the first part of the 1950s accor<strong>di</strong>ng to Luigi Cosenza’s design.<br />
Right: several students in the biennial qualification course for electromechanical<br />
fitters during a laboratory experience.<br />
La <strong>di</strong>tta <strong>di</strong> Ivrea era <strong>di</strong>ventata un solido e rispettato organismo.<br />
Gli esperti stranieri affermavano che la Olivetti era un’industria<br />
eccellente, con un capo pieno <strong>di</strong> idee geniali, ottimi tecnici e<br />
ottime maestranze, che offriva prodotti robusti ed eleganti, creava<br />
una pubblicità effi cace e aveva tra<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> correttissima moralità<br />
commerciale (Caizzi, 1962, p. 231).<br />
Adriano Olivetti era fortemente impegnato sul fronte della<br />
“responsabilità sociale”, rompendo con gli schemi della teoria<br />
tra<strong>di</strong>zionale dell’impresa:<br />
Le fabbriche, gli uffi ci amministrativi, e i centri <strong>di</strong> ricerca<br />
furono concepiti a misura d’uomo «perché questi trovasse nel suo<br />
or<strong>di</strong>nato posto <strong>di</strong> lavoro uno strumento <strong>di</strong> riscatto e non un congegno<br />
<strong>di</strong> sofferenza. Per questo abbiamo voluto le fi nestre basse<br />
e i cortili aperti, e gli alberi nel giar<strong>di</strong>no ad escludere defi nitivamente<br />
l’idea <strong>di</strong> una costrizione e <strong>di</strong> una chiusura ostile» (Caizzi,<br />
1962, p. 223).<br />
Sarebbe riduttivo asserire che questa preoccupazione <strong>di</strong><br />
Adriano Olivetti possa essere spiegata con questo suo ricordo<br />
personale:<br />
Nel lontano agosto 1914, avevo allora 13 anni, mio padre mi<br />
mandò a lavorare in fabbrica. Imparai così ben presto a conoscere<br />
e o<strong>di</strong>are il lavoro in serie; una tortura per lo spirito che stava imprigionato<br />
per delle ore che non fi nivano mai, nel nero e nel buio <strong>di</strong><br />
una vecchia offi cina. Per molti anni non rimisi piede nella fabbrica,<br />
ben deciso che nella vita non avrei atteso all’industria paterna.<br />
Passavo davanti al muro <strong>di</strong> mattoni rossi della fabrica, vergognandomi<br />
della mia libertà <strong>di</strong> studente, per simpatia e timore <strong>di</strong> quelli<br />
che ogni giorno, senza stancarsi, vi lavoravano (Adriano Olivetti,<br />
citato in Caizzi, 1962, p. 132).<br />
Adriano Olivetti sostituirà, per le proprie maestranze, la<br />
“vecchia fumosa offi cina” con un ambiente luminoso, rassicurante,<br />
riducendo la fatica e la durata del lavoro, assicurando ai collaboratori<br />
<strong>di</strong> ogni livello le migliori previdenze assistenziali e il<br />
migliore alloggio possibile. Poco prima <strong>di</strong> morire avrà a <strong>di</strong>re ai<br />
collaboratori:<br />
Ora che ho lavorato anch’io con voi tanti anni, non posso io<br />
stesso <strong>di</strong>menticare e accettare le <strong>di</strong>fferenze sociali che come una<br />
situazione da riscattare, una pesante responsabilità densa <strong>di</strong> doveri.<br />
Talvolta, quando sosto brevemente la sera e dai miei uffi ci<br />
vedo le fi nestre illuminate degli operai che fanno il doppio turno<br />
alle tornerie automatiche, mi vien voglia [...] <strong>di</strong> andare a porgere un<br />
saluto pieno <strong>di</strong> riconoscenza a quei lavoratori attaccati a quelle<br />
macchine che io conosco da tanti anni (Adriano Olivetti, citato in<br />
Caizzi, 1962, pp. 133-4).<br />
Associazione Archivio Storico Olivetti <strong>di</strong> Ivrea
La priorità dell’occupazione sul profi tto <strong>di</strong> breve periodo<br />
l’abbiamo trovata nella reazione <strong>di</strong> Adriano Olivetti alla mini-recessione<br />
del 1952, quando un rallentamento dell’economia mon<strong>di</strong>ale<br />
portò ad una forte contrazione delle ven<strong>di</strong>te <strong>di</strong> macchine per<br />
scrivere e <strong>di</strong> calcolatrici. Secondo la teoria economica <strong>di</strong> allora, i<br />
<strong>di</strong>rigenti della Olivetti avrebbero dovuto tagliare la produzione e<br />
mantenere i prezzi stabili per minimizzare le per<strong>di</strong>te. La reazione<br />
<strong>di</strong> Adriano Olivetti fu però <strong>di</strong>versa: lanciò subito una strategia <strong>di</strong><br />
espansione più <strong>di</strong>namica e più audace. In Italia in quell’anno furono<br />
assunti 700 nuovi ven<strong>di</strong>tori, fu ribassato il prezzo delle<br />
macchine, furono create numerose nuove fi liali. Questa politica<br />
ebbe pieno successo. Una reazione che in un certo senso anticipava<br />
le teorie manageriali dell’impresa, della massimizzazione<br />
della crescita <strong>di</strong> lungo periodo. Le maestranze hanno sovente ricompensato<br />
l’Olivetti per questa politica a loro favore. Basti ricordare<br />
che quando gli occupanti nazisti avevano più <strong>di</strong> una volta<br />
pensato <strong>di</strong> far saltare la fabbrica durante la Seconda Guerra<br />
mon<strong>di</strong>ale, gli operai trafugarono parte dei macchinari a casa loro,<br />
in attesa <strong>di</strong> tempi migliori. Macchinari che subito dopo l’armistizio<br />
tornarono in fabbrica, per la ripresa della produzione.<br />
Anche nella strategia <strong>di</strong> assunzione e <strong>di</strong> formazione delle<br />
maestranze Adriano Olivetti fu un precursore. Mentre nell’industria<br />
automobilistica fi no al 1970 circa dominava ancora la catena<br />
<strong>di</strong> montaggio alla quale lavoravano operai poco qualifi cati, con<br />
conseguente assenteismo e demotivazione, alla Olivetti già negli<br />
anni Cinquanta si assumevano il fi or fi ore dei tecnici sfornati dai<br />
politecnici, università ed istituti tecnici.<br />
La trasformazione strutturale della Società ha visto crescere<br />
[...] il numero degli ingegneri e dei tecnici rispetto agli impiegati<br />
generici, il numero degli operai qualifi cati rispetto ai semplici manovali.<br />
La fabbrica impiega sempre più laureati, <strong>di</strong>plomati e specialisti,<br />
chiede al Paese maestranze aventi una certa preparazione<br />
professionale, anche al basso della piramide sollecita una migliore<br />
educazione scolastica e se ne fa essa stessa promotrice (Caizzi,<br />
1962, p. 241).<br />
Anche qui Adriano Olivetti anticipa l’introduzione del “model-<br />
lo giapponese”, iniziata negli anni 1970,<br />
come superamento “della catena <strong>di</strong> montaggio”,<br />
<strong>di</strong> for<strong>di</strong>ana memoria. Qui è la<br />
squadra <strong>di</strong> specialisti che compone tutta<br />
la macchina, eliminando il lavoro ripetitivo,<br />
con l’ausilio <strong>di</strong> macchinari moderni e altamente<br />
effi cienti come i robot. E già negli<br />
anni Cinquanta l’Olivetti investiva la maggior<br />
parte dei propri profi tti in macchinari<br />
tecnologicamente avanzati e nella ricerca,<br />
reclutando i migliori fi sici e ricercatori. Il<br />
sempre maggiore investimento in capitale<br />
fi sico è alla base del modello giapponese,<br />
che è stato recentemente adottato e superato<br />
dal modello della Fiat italiana a Melfi ,<br />
con la stessa tecnica giapponese e l’approvvigionamento<br />
<strong>di</strong> parte delle componenti<br />
just-on-time e on-line da parte <strong>di</strong> <strong>di</strong>tte<br />
esterne.<br />
La fi losofi a <strong>di</strong> Adriano Olivetti, come<br />
vedremo sotto, carica com’è <strong>di</strong> valori etici<br />
e umani, si trova agli antipo<strong>di</strong> della mentalità<br />
<strong>di</strong> raider (predatori) che si è <strong>di</strong>ffusa a<br />
partire dagli ultimi due decenni del XX se-<br />
La palazzina che ospita le attività <strong>di</strong> ricerca e<br />
sperimentazione della Olivetti a Ivrea, costruita nel<br />
1954-55 su progetto <strong>di</strong> Eduardo Vittoria.<br />
The small buil<strong>di</strong>ng where research and experimenting<br />
was carried out by Olivetti in Ivrea, buil<strong>di</strong>ng in 1954-<br />
1955 accor<strong>di</strong>ng to Eduardo Vittoria’s design.<br />
colo. Fast buck, sol<strong>di</strong> in fretta, il motto degli speculatori, libero<br />
mercato, competitività a qualsiasi prezzo e poca etica sono <strong>di</strong>venute<br />
costanti in <strong>di</strong>versi settori della nostra economia. Il problema<br />
è che il libero mercato “vede corto”. Lo storico lombardo Raul<br />
Merzario, introducendo il volume <strong>di</strong> Stefania Bianchi Le terre dei<br />
Turconi, <strong>di</strong>scute della nozione <strong>di</strong> prezzo nel Settecento e nell’Ottocento<br />
nell’alta Lombar<strong>di</strong>a. Il prezzo è sì collegato a quello del<br />
grano e alle strategie impren<strong>di</strong>toriali dei proprietari terrieri, ma<br />
l’autrice «ci ha <strong>di</strong>mostrato, con dati alla mano, che il prezzo nei<br />
secoli dell’età moderna è determinato sì da fattori economici, ma<br />
ancora <strong>di</strong> più da valori sociali come i rapporti <strong>di</strong> forza tra le classi,<br />
la rilevanza dell’autoconsumo conta<strong>di</strong>no, i rapporti <strong>di</strong> parentela,<br />
amicizia, vicinato tra compratori e ven<strong>di</strong>tori ed altro ancora».<br />
Questi sono principi che hanno caratterizzato la nostra società<br />
prima del XX secolo. Con importanti eccezioni. Come quella della<br />
<strong>di</strong>nastia degli Olivetti, per la quale prima sta l’uomo e poi il fast<br />
buck.<br />
Lo spirito dell’epoca<br />
Vale la pena a questo punto <strong>di</strong> immergerci nell’ambiente<br />
sociale e storico in cui è cresciuto e ha operato il progetto <strong>di</strong><br />
Adriano Olivetti: un periodo unico e glorioso per i successi in<br />
generale dell’economia, per la conquista del benessere e per le<br />
aspettative democratiche della gente. Le riven<strong>di</strong>cazioni sociali per<br />
la verità erano già state abbozzate dopo la prima Grande Guerra,<br />
ma furono frenate dalla crisi degli anni Trenta e poi ancora dal<br />
secondo confl itto mon<strong>di</strong>ale. Riemersero e presero grande vigore<br />
solo negli anni Cinquanta, nella piena convinzione che il concorso<br />
al benessere fosse un <strong>di</strong>ritto e che anche il lavoro potesse partecipare<br />
degnamente al processo <strong>di</strong>stributivo della ricchezza<br />
prodotta. Si cullava pure l’illusione che alla democrazia politica<br />
del suffragio universale potesse fi nalmente succedere anche una<br />
effettiva democrazia economica, più compartecipe e attenta ai<br />
bisogni sociali della gente. Tutto insomma era in crescita e non<br />
solo all’Olivetti: la produzione, la produttività, l’occupazione, i<br />
salari, i prezzi, i consumi, i risparmi, gli investimenti, la spesa<br />
Associazione Archivio Storico Olivetti <strong>di</strong> Ivrea<br />
pubblica, in un clima generale e irripetibile<br />
<strong>di</strong> vero miracolo economico.<br />
Il profi lo fi losofi co <strong>di</strong> Adriano Olivetti<br />
si innesta perfettamente in questo vento<br />
portante e positivista dell’epoca, ma vi<br />
aggiunge una concezione del tutto originale,<br />
alimentata certamente dalla sua cultura<br />
e dalle sue frequentazioni <strong>di</strong> gioventù.<br />
Qualcuno l’ha chiamata utopia, altri visione,<br />
per <strong>di</strong>re in ogni caso <strong>di</strong> una spinta ben<br />
precisa verso un progetto d’azienda che è<br />
ben più <strong>di</strong> un risultato economico. Nella<br />
storia industriale torinese, pur in questo<br />
clima economico comune ed euforico, si<br />
venne insomma a creare una contrapposizione<br />
fra due modelli impren<strong>di</strong>toriali ben<br />
<strong>di</strong>stinti, quello degli Agnelli e quello degli<br />
Olivetti, che non mancarono del resto <strong>di</strong><br />
affrontarsi in schermaglie nemmeno troppo<br />
velate. Adriano Olivetti, considerato<br />
l’impren<strong>di</strong>tore rosso, non aderì per esempio<br />
alla Confi ndustria, manifestando così un<br />
suo <strong>di</strong>saccordo nei confronti della dottrina<br />
aziendale dell’epoca.<br />
DALLA “SUISSE” 193
A venticinque anni Adriano si era recato negli Stati Uniti<br />
dove restò inizialmente affascinato dal for<strong>di</strong>smo, tanto da convincere<br />
il padre a riorganizzare l’impresa <strong>di</strong> Ivrea in tutt’altro modo,<br />
ma cercò al tempo stesso <strong>di</strong> superare le tecniche puramente<br />
tayloristiche del lavoro, applicandole in modo meno degradante<br />
per il <strong>di</strong>pendente a una realtà <strong>di</strong> prossimità più coinvolgente.<br />
In Lessico famigliare Natalia Ginzburg fa frequenti riferimenti<br />
ad Adriano Olivetti, il quale aveva sposato la sorella Paola. In<br />
un ritratto caldo, quasi psicologico del personaggio lo descrive<br />
«affettuoso, goffo e timido. Amava mangiare dolci...». Traccia <strong>di</strong><br />
lui anche un bel ricordo quando aiutò il padre della stessa Ginzburg<br />
a fuggire dai tedeschi, oppure <strong>di</strong> quella volta che «era venuto<br />
da noi, quando scappammo da quella casa, a prendere Turati,<br />
il viso trafelato, spaventoso e felice <strong>di</strong> quando portava in salvo<br />
qualcuno». La sua formazione impren<strong>di</strong>toriale è stata un caso<br />
quasi unico in Italia. I genitori venivano da ambienti molto colti. Il<br />
padre Camillo, il fondatore della Olivetti, aveva insegnato a Stanford<br />
in California, era un ebreo non praticante e <strong>di</strong> idee socialiste.<br />
Un’infl uenza decisiva venne esercitata anche dalla madre, fi glia<br />
<strong>di</strong> un pastore valdese e apprezzato biblista. Una doppia matrice<br />
che si tradusse in famiglia in un rigore morale e in una spinta<br />
ideale a operare per il prossimo.<br />
L’utopia <strong>di</strong> Adriano<br />
Nel profi lo formativo e fi losofi co <strong>di</strong> Adriano Olivetti c’erano<br />
dunque cultura positivista e illuminista, l’industrialismo <strong>di</strong> stampo<br />
for<strong>di</strong>sta con sottofondo socialista e tanta America. Tutta roba del<br />
Novecento, anche se alla fi ne della Seconda Guerra mon<strong>di</strong>ale egli<br />
si scarta all’improvviso. Non bastano più per lui né il socialismo<br />
né il pensiero liberale. Inizia infatti a elaborare un suo concetto<br />
originale <strong>di</strong> azienda e <strong>di</strong> società che condensa nell’idea <strong>di</strong> Comunità:<br />
una miscela <strong>di</strong> utopia e <strong>di</strong> federalismo, <strong>di</strong> autonomie locali<br />
e <strong>di</strong> democrazia <strong>di</strong>retta (il soggiorno <strong>di</strong> Adriano Olivetti in Svizzera<br />
durante il periodo <strong>di</strong> guerra deve averlo infl uenzato in tutto questo).<br />
Questa idea <strong>di</strong> Comunità <strong>di</strong>venterà anche movimento politico<br />
e persino progetto e<strong>di</strong>toriale, con le E<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> Comunità appunto.<br />
E proprio nell’anno della sua morte, Adriano Olivetti darà<br />
alle stampe Città dell’uomo, un libro che raccoglie scritti e <strong>di</strong>scorsi<br />
sul suo Movimento, sul mondo della fabbrica, su urbanistica e<br />
territorio, sui problemi del Mezzogiorno, con un’idea <strong>di</strong> società<br />
integrata, compartecipe e responsabile. Il suo agire era tra l’altro<br />
coerente con il suo pensiero. La fabbrica <strong>di</strong> Ivrea era un tutt’uno<br />
con la città, in un rapporto quasi biunivoco con il territorio. A<br />
<strong>di</strong>fferenza però delle citta<strong>di</strong>ne operaie <strong>di</strong> Crespi d’Adda o delle<br />
acciaierie Falck a Sesto San Giovanni, non c’era più quel paternalismo<br />
<strong>di</strong> stampo ottocentesco che teneva stretto e in<strong>di</strong>ssolubile<br />
il legame con le famiglie operaie, alloggiate nelle case e<br />
nelle scuole della fabbrica. Dall’epoca delle macchine per scrivere<br />
d’inizio Novecento, passando per le macchine calcolatrici fi no<br />
al personal computer, le strutture e i servizi per le famiglie dei<br />
<strong>di</strong>pendenti costituivano alla Olivetti un autentico welfare modello<br />
impresa.<br />
A costruire la leggenda olivettiana contribuì certamente la<br />
presenza in fabbrica, del tutto inusuale, <strong>di</strong> uno stuolo d’intellettuali,<br />
stretti collaboratori <strong>di</strong> Adriano: urbanisti e designer, come<br />
Zevi o Sottsass, poeti come Giu<strong>di</strong>ci, scrittori come Volponi (immaginate<br />
oggi uno scrittore <strong>di</strong>rettore del personale <strong>di</strong> una fabbrica?),<br />
sociologi come Ferrarotti, letterati come Pampaloni. Luciano<br />
Gallino, sociologo del lavoro <strong>di</strong> grande fama, anche lui presente<br />
a Ivrea, è autore nel 2001 <strong>di</strong> una intervista ipotetica ad Adriano<br />
194 DALLA “SUISSE”<br />
Un allievo del Centro Formazione Meccanici, 1962.<br />
A student from the Mechanics Training Centre, 1962.<br />
Olivetti: «Io c’ero, fui parte della creazione del Movimento <strong>di</strong> Comunità<br />
sorto in seno alla Olivetti nel 1948. Amava la gente, ecco<br />
perché Adriano coniugò for<strong>di</strong>smo e socialismo». Nel 2005 Luciano<br />
Gallino pubblica L’impresa irresponsabile, pensando probabilmente<br />
per converso proprio a Olivetti:<br />
Si defi nisce irresponsabile un’impresa che al <strong>di</strong> là degli elementari<br />
obblighi <strong>di</strong> legge suppone <strong>di</strong> non dover rispondere ad alcuna<br />
autorità pubblica o privata, né all’opinione pubblica, in merito<br />
alle conseguenze in campo economico, sociale e ambientale delle<br />
sue attività [...]. Con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> lavoro, prezzi, trasporti, ambiente,<br />
tempo libero, alimentazione, organizzazione della famiglia, la possibilità<br />
stessa <strong>di</strong> progettarsi un’esistenza: piaccia o no <strong>di</strong>pendono<br />
tutte da decisioni che provengono, più che dal governo della nazione,<br />
dal governo delle imprese [...]. Purtroppo questa responsabilità sociale<br />
delle imprese è spesso del tutto subor<strong>di</strong>nata ad altre priorità.<br />
Nulla <strong>di</strong> tutto questo nel <strong>di</strong>segno responsabile e innovativo<br />
<strong>di</strong> Adriano Olivetti che nel 1955, in un <strong>di</strong>scorso ai lavoratori, si<br />
poneva alcune domande, rimaste ovviamente inevase, soprattutto<br />
agli occhi <strong>di</strong> chi guarda all’impresa <strong>di</strong> oggi:<br />
Può l’industria darsi dei fi ni? Si trovano questi semplicemente<br />
nell’in<strong>di</strong>ce dei profi tti? Non vi è al <strong>di</strong> là del ritmo apparente qualcosa<br />
<strong>di</strong> più affascinante, una destinazione, una vocazione anche<br />
nella vita <strong>di</strong> una fabbrica?<br />
Ecco invece cosa <strong>di</strong>ce il fi losofo Umberto Galimberti in<br />
un’intervista alla Televisione Svizzera nel febbraio del 2010:<br />
Oggi Olivetti non sopravviverebbe, come peraltro non è sopravvissuto.<br />
Perché se uno punta sull’uomo viene soppresso da<br />
quelli che puntano sul denaro. Olivetti ha fatto un sogno, un’utopia<br />
molto importante, ha costruito una cultura che aveva però l’uomo<br />
e la sua realizzazione come centro della produzione. L’invito era che<br />
l’industria guar<strong>di</strong> alla società. L’obiezione che farei io a Olivetti, non<br />
perché sono contrario a quella sua intenzione, ma semplicemente<br />
perché assisto a come funziona oggi la società. Essa funziona<br />
esattamente come gli apparati tecnici, all’interno dei quali gli uomini<br />
vengono inseriti come funzionari <strong>di</strong> apparato e non come soggetti<br />
che hanno desideri, aspirazioni e volontà. In questo sta l’utopia<br />
<strong>di</strong> Adriano Olivetti.<br />
Associazione Archivio Storico Olivetti <strong>di</strong> Ivrea
L’uomo al centro della fabbrica<br />
L’uomo, appunto. Non un pezzo <strong>di</strong> una macchina, da rendere<br />
sempre più docile e produttivo, connesso agli altri pezzi dell’ingranaggio,<br />
ma una persona da considerare come tale, coi suoi<br />
pensieri, i suoi problemi, le sue aspettative, i suoi sogni. Da<br />
mettere al lavoro, certo, ma non in una fabbrica-prigione, piuttosto<br />
in una fabbrica-comunità. Con risultati straor<strong>di</strong>nari e soluzioni<br />
tecnologiche in anticipo sui tempi. Sull’altro fronte, quello degli<br />
Agnelli, il sogno italiano si materializzava in un’auto tutta nuova<br />
e nel lavoro alla catena <strong>di</strong> montaggio. Duro, contestato, ma stabile.<br />
Poca conoscenza, molta fatica e soprattutto pensare poco,<br />
in perfetto stile for<strong>di</strong>sta.<br />
Esiste un bel libro, apparso nel 2005 a esperienza oramai<br />
defi nitivamente decaduta del sogno <strong>di</strong> Adriano, dal titolo rivelatore<br />
Uomini e lavoro alla Olivetti, curato da Francesco Novara con<br />
Renato Rozzi e Roberta Garruccio. Si tratta <strong>di</strong> una serie <strong>di</strong> testimonianze<br />
<strong>di</strong> personaggi <strong>di</strong> ogni categoria: operai, ingegneri, architetti,<br />
consulenti, tutti protagonisti del progetto Olivetti, del<br />
prima e dopo Adriano, con l’intento <strong>di</strong> fermare una memoria<br />
umana, <strong>di</strong> riscattarla dal silenzio e <strong>di</strong> contribuire in un certo qual<br />
modo ad alimentare quella che è oramai <strong>di</strong>ventata una vera e<br />
propria mitologia olivettiana. Una memoria sociale. Decine <strong>di</strong><br />
voci: vi si legge anche una critica pungente più o meno <strong>di</strong>retta ai<br />
successori <strong>di</strong> Adriano che a poco a poco hanno smantellato il suo<br />
gioiello industriale per ridurlo a sogno e utopia. Il che suona oggi<br />
perlomeno bizzarro, quando tutti si defi niscono ancora olivettiani<br />
senza esserlo, senza nulla con<strong>di</strong>videre dei valori che Adriano<br />
Olivetti ci ha trasmesso. Fra le molte voci, una sola, che spicca<br />
nell’introduzione al libro e che suona come un epitaffi o:<br />
Se in altre aziende il lavoratore si confondeva in una massa<br />
in<strong>di</strong>fferenziata, in Olivetti egli era una persona ben in<strong>di</strong>viduata e<br />
riconosciuta, con la sua storia e la sua vita lavorativa.<br />
Francesco Novara, oggi scomparso, è stato strettissimo<br />
collaboratore <strong>di</strong> Adriano e responsabile del Centro <strong>di</strong> psicologia<br />
industriale della Olivetti, dagli anni Cinquanta al 1992. Curatore<br />
Visita agli stabilimenti Olivetti <strong>di</strong> Ivrea del sociologo Lewis Mumford nel 1957.<br />
Sociologist Lewis Mumford during a visit to the Olivetti plants in Ivrea in 1957.<br />
Associazione Archivio Storico Olivetti <strong>di</strong> Ivrea<br />
del volume, de<strong>di</strong>ca all’azienda e al suo ideatore una sorta <strong>di</strong> Day<br />
After che conclude in questo modo:<br />
Agli impren<strong>di</strong>tori costruttori <strong>di</strong> futuro sono andati subentrando<br />
cacciatori <strong>di</strong> valori azionari, speculatori del mercato borsistico, arraffatori<br />
<strong>di</strong> monopoli, artefi ci <strong>di</strong> partecipazioni incrociate e <strong>di</strong> pirami<strong>di</strong><br />
societarie. A un mondo del lavoro umiliato, in una società lacerata<br />
e <strong>di</strong>sorientata, succube delle vicende aleatorie <strong>di</strong> un’economia fi nanziarizzata,<br />
si rivolge il coro <strong>di</strong> queste testimonianze. Esse ricordano<br />
il valore permanente delle ragioni <strong>di</strong> quel successo d’impresa: la<br />
responsabilità e capacità <strong>di</strong> costante innovazione, realistica e audace,<br />
razionale e immaginativa, votata all’eccellenza dei prodotti, alla<br />
qualità della vita lavorativa, all’elevazione della vita sociale.<br />
Si è forse sprecato qualche appellativo in questi cinquant’anni<br />
dalla morte <strong>di</strong> Adriano Olivetti? Impren<strong>di</strong>tore rosso,<br />
pioniere dell’innovazione, icona del capitalismo <strong>di</strong>verso, padrone<br />
illuminato e molti altri ancora? Sono defi nizioni che nemmeno lui<br />
avrebbe probabilmente gra<strong>di</strong>to, che richiamano senz’altro l’enfasi<br />
della <strong>di</strong>stanza del tempo, tipica <strong>di</strong> un personaggio scomparso nel<br />
vivo <strong>di</strong> un’attività intensa, a capo <strong>di</strong> un universo industriale <strong>di</strong><br />
decine <strong>di</strong> migliaia <strong>di</strong> <strong>di</strong>pendenti. Bisogna pure ammettere che non<br />
vi è stata probabilmente altra realtà storica industriale e insieme<br />
culturale, perlomeno in Italia, in grado <strong>di</strong> produrre tanta mitologia<br />
come Adriano e l’Olivetti. La sua fi gura riappare oggi, quasi per<br />
contrasto, in tutta la sua attualità, riaffermando i suoi valori profon<strong>di</strong><br />
in un panorama economico e produttivo più che mai controverso,<br />
non sempre decifrabile, spesso confuso e senza meta.<br />
Indro Montanelli, rispondendo a un lettore che gli chiedeva<br />
in cosa veramente consistesse la singolarità <strong>di</strong> Adriano Olivetti,<br />
scrive:<br />
[...] voleva inventare un modello del tutto nuovo d’impresa in<br />
cui capitale e lavoro fossero associati. Questo era l’ideale o il miraggio<br />
della famosa Comunità olivettiana, senza che il suo ispiratore<br />
si rendesse probabilmente conto <strong>di</strong> quanto esso urtasse gli<br />
interessi sia del padronato sia del sindacato, i quali vivono sulla<br />
contrapposizione dei loro interessi. [...] Olivetti era perfettamente<br />
conscio <strong>di</strong> questa contrapposizione, ma era convinto <strong>di</strong> superarla.<br />
E questa era la sua vera Utopia.<br />
Ma forse il ritratto che Adriano avrebbe apprezzato più <strong>di</strong><br />
ogni altro, un po’ nostalgico ed enigmatico, è tracciato ancora da<br />
Natalia Ginzburg in Lessico famigliare:<br />
Lo incontrai a Roma per la strada, un giorno durante l’occupazione<br />
tedesca. Era in pie<strong>di</strong>; andava solo, con il suo passo randagio;<br />
gli occhi perduti nei suoi sogni perenni, che li velavano <strong>di</strong><br />
nebbie azzurre. Era vestito come tutti gli altri, ma sembrava, nella<br />
folla, un men<strong>di</strong>cante; e sembrava, nel tempo stesso, anche un re.<br />
Un re in esilio, sembrava.<br />
Riferimenti bibliografi ci<br />
Mauro L. BARANZINI, Giandemetrio MARANGONI e Sergio ROSSI, Micro e Macro-<br />
Economia, Cedam, Padova 2001.<br />
Bruno CAIZZI, Gli Olivetti, UTET, Torino 1962.<br />
Luciano GALLINO, L’impresa responsabile. Un’intervista su Adriano Olivetti,<br />
Einau<strong>di</strong>, Torino 2001.<br />
Luciano GALLINO, L’impresa irresponsabile, Einau<strong>di</strong>, Torino 2005.<br />
Natalia GINZBURG, Lessico famigliare, Einau<strong>di</strong>, Torino 1963.<br />
Raul MERZARIO, Prefazione a Stefania BIANCHI, Le terre dei Turconi, Dadò,<br />
Locarno 1999.<br />
Francesco NOVARA, Renato ROZZI e Roberta GARRUCCIO (a cura <strong>di</strong>) Uomini e<br />
lavoro alla Olivetti, Mondadori, Milano 2005.<br />
Adriano OLIVETTI, Città dell’uomo, E<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> Comunità, Milano 1960.<br />
DALLA “SUISSE” 195
Comunità e Cantoni:<br />
alla ricerca <strong>di</strong> libertà politica<br />
DAVIDE CADEDDU<br />
Ricercatore <strong>di</strong> Storia delle dottrine politiche<br />
dell’Università degli Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> Milano;<br />
Consigliere della Société Européenne de Culture<br />
Da una tipografi a <strong>di</strong> Samedan, in Alta Enga<strong>di</strong>na, nel<br />
settembre del 1945 gli era giunta a Ivrea l’e<strong>di</strong>zione<br />
defi nitiva del suo libro L’or<strong>di</strong>ne politico delle Comunità,<br />
frutto <strong>di</strong> una lunga rifl essione, avviata in Italia nel 1942<br />
e conclusa durante l’esilio elvetico. Adriano Olivetti, uomo del<br />
<strong>di</strong>alogo, prima <strong>di</strong> pubblicare quest’opera – che avrebbe orientato<br />
idealmente tutta la sua attività successiva – aveva interloquito<br />
con un numero <strong>di</strong> persone davvero rilevante. Ne rimane traccia<br />
nelle memorie scritte, nella corrispondenza privata e nella documentazione<br />
che da poco tempo gli archivi <strong>di</strong> Stato italiani e<br />
stranieri lasciano libera alla consultazione. Attraverso lo stu<strong>di</strong>o,<br />
l’osservazione e il <strong>di</strong>alogo, in effetti, egli cercava <strong>di</strong> capire quali<br />
forme istituzionali avrebbero potuto garantire la libertà in uno<br />
Stato fondato su un sistema economico socialista. 1<br />
La Svizzera si rivelò luogo <strong>di</strong> incontri e fonte <strong>di</strong> ispirazione,<br />
ma già in passato si era mostrata terra amica. Negli anni Trenta,<br />
Olivetti aveva frequentato <strong>di</strong> tanto in tanto il salotto ginevrino<br />
dell’antifascista Guglielmo Ferrero e incontrato probabilmente<br />
anche Ignazio Silone a Zurigo. Se il primo gli permise <strong>di</strong> conoscere<br />
il fi losofo della politica Umberto Campagnolo, che ebbe un<br />
ruolo fondamentale nella nascita della biblioteca <strong>di</strong> fabbrica della<br />
Ing. C. Olivetti & C. e della olivettiana casa e<strong>di</strong>trice Nuove E<strong>di</strong>zioni<br />
Ivrea (antesignana delle più note E<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> Comunità), il secondo<br />
quasi certamente lo mise in contatto con i servizi segreti<br />
statunitensi nel gennaio del 1943.<br />
Furono mesi frenetici quelli tra l’autunno del ’42 e il feb braio<br />
del ’44, quando espatriò in Svizzera in compagnia della segretaria<br />
Wanda Soavi, entrambi inseguiti dall’Arma dei carabinieri e dal<br />
Servizio informazioni militari. Dopo essere stati detenuti qualche<br />
The Cantons Community:<br />
searching for political freedom<br />
Switzerland was also fundamental for Adriano Olivetti’s dream of a State where<br />
freedom was a concrete value. In this ally of a country, he developed a solid<br />
network of fruitful political relations and found a useful model in the Swiss<br />
system on which to base his “Community” project. He believed it should have<br />
been a rationalization of the Swiss Canton and its adaptation to the Italian<br />
tra<strong>di</strong>tion. The Federal Communities could become Regions and Regions would<br />
make up the Italian Federal State. Luigi Einau<strong>di</strong> also found this proposal<br />
interesting in developing his separatist thesis. Aside from the project, his<br />
constructive spirit led Olivetti to de<strong>di</strong>cate himself to <strong>di</strong>rect political action:<br />
In fact, he founded the Community Movement.<br />
196 DALLA “SUISSE”<br />
mese a Roma nel carcere <strong>di</strong> Regina Coeli ed essere usciti in<br />
modo rocambolesco, risultavano infatti ancora ricercati a causa<br />
del tentativo <strong>di</strong> costituire un trait d’union tra Alleati, antifascisti,<br />
forze armate, <strong>di</strong>plomazia vaticana e casa reale. Divenuto agente<br />
numero 660 dell’Offi ce of Strategic Services nel giugno del ’43<br />
grazie alle referenze soprattutto <strong>di</strong> Egi<strong>di</strong>o Reale, fu facile per<br />
Olivetti essere ascoltato anche dallo Special Operations Executive<br />
con il nome in co<strong>di</strong>ce Brown, ma, per quanto ritenuto una fonte<br />
preziosa e affi dabile, i progetti strategici degli Alleati non erano<br />
compatibili con le proposte che egli sosteneva una volta varcata<br />
la frontiera. 2 Più in generale, infatti, «tenendo conto sia dell’atteggiamento<br />
dominante inglese sia della mancanza <strong>di</strong> determinazione<br />
da parte italiana», occorre ricordare che «dalla metà del 1942<br />
alla caduta <strong>di</strong> Mussolini nel luglio del 1943 non vi fu alcuna possibilità<br />
concreta <strong>di</strong> arrivare a una pace separata tra le potenze<br />
alleate e l’Italia». 3<br />
Durante questi mesi, oltre a intensifi care la propria azione<br />
antifascista, Olivetti iniziò a elaborare un progetto <strong>di</strong> riforma istituzionale<br />
e sociale – il cui fuoco era l’ente politico territoriale locale<br />
denominato “Comunità” – che sottopose all’attenzione <strong>di</strong><br />
interlocutori italiani e stranieri. 4 Espatriato in Svizzera, passando<br />
per San Pietro, vicino a Stabio, dopo essere stato accolto presso<br />
l’Ospedale italiano <strong>di</strong> Lugano, soggiornò soprattutto a Champfèr,<br />
a pochi chilometri da St. Moritz, nell’albergo Chesa Guardalej,<br />
fi no al maggio del 1945. Questo <strong>di</strong>venne il luogo in cui le proprie<br />
idee, espresse nel Memorandum sullo Stato Federale delle Comunità<br />
in Italia già nel maggio del ’43, continuarono a maturare attraverso<br />
la rifl essione in<strong>di</strong>viduale e il confronto con l’opinione <strong>di</strong><br />
molti altri esuli antifascisti.<br />
A Champfèr le relazioni personali erano però abbastanza<br />
limitate. Grazie a vari permessi ottenuti dalle autorità elvetiche,<br />
Olivetti cercò quin<strong>di</strong> <strong>di</strong> recarsi a Zurigo, Lugano, Basilea, Berna,<br />
Losanna e soprattutto a Ginevra, allo scopo <strong>di</strong> incontrare amici<br />
o persone appena conosciute. Proprio a Ginevra rivide alcuni dei<br />
giovani collaboratori della sua casa e<strong>di</strong>trice: Luciano Foà, che<br />
avrebbe contribuito a creare negli anni Sessanta le e<strong>di</strong>zioni Adelphi,<br />
e Giorgio Fuà, che sarebbe <strong>di</strong>venuto uno dei più gran<strong>di</strong> economisti<br />
italiani della seconda metà del Novecento. L’esilio forzato<br />
gli permise <strong>di</strong> confrontare le proprie convinzioni – tra tanti altri –<br />
con i federalisti Ernesto Rossi, Egi<strong>di</strong>o Reale, Luigi Einau<strong>di</strong> e Altiero<br />
Spinelli, e con i socialisti Ignazio Silone, Guglielmo Usellini,<br />
Alessandro Levi, Edgardo Lami Starnuti e Ugo Guido Mondolfo:<br />
declinare istituzionalmente federalismo e socialismo era, in effetti,<br />
il suo scopo principale. 5<br />
L’idea <strong>di</strong> Comunità – una sorta <strong>di</strong> piccola Provincia – fu<br />
enucleata da Olivetti in Italia rifl ettendo sia sulla realtà del Canavese,<br />
sia su altre esperienze politiche straniere. Al centro della<br />
sua attenzione vi erano segnatamente gli Stati federali e quelli
Adriano Olivetti al suo tavolo da lavoro nel 1958.<br />
Adriano Olivetti at his work table in 1958.<br />
contrad<strong>di</strong>stinti da enti locali dotati <strong>di</strong> autonomia politica. Oltre agli<br />
Stati Uniti d’America e al Regno Unito, la Svizzera costituiva<br />
senz’altro uno dei principali motivi <strong>di</strong> rifl essione. A proposito<br />
della funzione che la Comunità avrebbe dovuto svolgere in Italia,<br />
egli scrisse che essa rappresentava una sorta<br />
<strong>di</strong> «razionalizzazione del Cantone svizzero» o,<br />
meglio, «il suo adattamento alla tra<strong>di</strong>zione italiana»:<br />
perfezionato, avrebbe potuto «affrontare<br />
i complessi compiti <strong>di</strong> una società moderna».<br />
Se, infatti, il Cantone svizzero aveva origini<br />
«esclusivamente storiche», che non tenevano<br />
conto «delle esigenze dell’economia e neppure<br />
<strong>di</strong> una logica <strong>di</strong>visione amministrativa», le Comunità<br />
da lui in<strong>di</strong>viduate erano concepite razionalmente,<br />
considerando sia gli aspetti storico-geografi<br />
ci, sia quelli economici e politici.<br />
In particolare, rappresentanza degli interessi e<br />
rappresentanza democratica venivano coniugate<br />
grazie alla coincidenza del <strong>di</strong>stretto economico<br />
con la circoscrizione amministrativa e<br />
con quella del collegio uninominale atto a<br />
eleggere il presidente della Comunità e, quin<strong>di</strong>,<br />
il futuro deputato in Parlamento. L’ente locale<br />
“Comunità” avrebbe dovuto avere «l’ampiezza<br />
me<strong>di</strong>a <strong>di</strong> un Cantone», coincidendo però so-<br />
Associazione Archivio Storico Olivetti <strong>di</strong> Ivrea<br />
Adriano Olivetti, nel periodo fascista considerato<br />
un “sovversivo” (tratto da Storia<br />
Illustrata A. Mondadori E<strong>di</strong>tore).<br />
Adriano Olivetti, considered a subversive<br />
during the Fascist period (taken from Storia<br />
Illustrata A. Mondadori E<strong>di</strong>tore).<br />
prattutto con unità italiane tra<strong>di</strong>zionali come la <strong>di</strong>ocesi, il collegio<br />
elettorale, la circoscrizione <strong>di</strong>strettuale o il circondario. 6 La vitalità<br />
e l’effi cienza dei Cantoni in Svizzera erano una garanzia per il<br />
futuro delle Comunità in Italia, che sarebbero state costituite su<br />
«analoghi principi amministrativi». 7 Le Comunità federate avrebbero<br />
dato origine alle Regioni, sulla base <strong>di</strong> identici criteri, improntati<br />
alla <strong>di</strong>mensione demografi ca, al dato storico-geografi co, alle<br />
risorse economiche presenti sul territorio e all’effi cienza amministrativa.<br />
Le Regioni federate avrebbero costituito, infi ne, lo Stato<br />
federale italiano. 8<br />
Contrario all’idea <strong>di</strong> piano – fosse politico o economico –,<br />
Luigi Einau<strong>di</strong> trovò nell’olivettiana Comunità lo strumento amministrativo<br />
più idoneo per risolvere molti dei problemi della politica<br />
italiana. Grazie al suo apporto critico, in un confronto franco e a<br />
tratti acceso, Olivetti stemperò alcune derive corporative del<br />
proprio progetto originario, anche se si trattava <strong>di</strong> un corporativismo<br />
<strong>di</strong>namico e intrinsecamente democratico. Entrambi erano<br />
persuasi, però, che l’orgoglio <strong>di</strong> appartenere a un corpo politico,<br />
in<strong>di</strong>viduato territorialmente o funzionalmente sulla base <strong>di</strong> caratteristiche<br />
precise, all’interno <strong>di</strong> un gruppo ristretto <strong>di</strong> persone,<br />
non avrebbe potuto che alimentare quel senso <strong>di</strong> responsabilità<br />
in<strong>di</strong>viduale ormai annacquato o annichilito dai partiti <strong>di</strong> massa e<br />
dai regimi totalitari. 9<br />
Nel novembre del ’44, il colloquio tra Einau<strong>di</strong> e Olivetti sembrò<br />
potersi intrecciare con le concrete vicende politiche dell’Italia<br />
del Nord. Contestualmente alla stesura della celeberrima Lettera<br />
aperta del Partito d’Azione a tutti i partiti aderenti al Comitato <strong>di</strong><br />
Liberazione Nazionale, Altiero Spinelli chiese a entrambi, da Milano,<br />
a nome dell’esecutivo Alta Italia del Partito d’Azione, un progetto<br />
per la ricostruzione dello Stato italiano in cui fosse sviluppata<br />
la tesi autonomista sostenuta da Einau<strong>di</strong> nell’articolo Via il<br />
prefetto!, che faceva cenno all’idea <strong>di</strong> ”Comunità”. Le due risposte<br />
rimasero però senza seguito, a causa dell’evolversi della situazione<br />
politica italiana, e solo nel dopoguerra, durante le riunioni<br />
della Commissione per la Costituzione, ritrovarono una felice per<br />
quanto inascoltata attualità. 10<br />
Completata la propria rifl essione, Adriano Olivetti aveva intenzione<br />
<strong>di</strong> pubblicare il Memorandum sullo Stato Federale delle<br />
Comunità sotto pseudonimo con le Nuove e<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> Capolago<br />
Associazione Archivio Storico Olivetti <strong>di</strong> Ivrea<br />
tra la fi ne del ’44 e i primi del ’45. Il connubio<br />
con la prestigiosa casa e<strong>di</strong>trice – nata nel ’36<br />
dall’iniziativa <strong>di</strong> Gina Ferrero Lombroso, Egi<strong>di</strong>o<br />
Reale e Ignazio Silone 11 – tuttavia svanì, per<br />
problemi <strong>di</strong> accordo e per le continue riformulazioni<br />
del contenuto dell’opera, che sarebbe<br />
stata stampata completamente a spese<br />
dell’autore. 12 Da quanto è possibile inferire<br />
dalla corrispondenza con Odoardo Masini,<br />
Gugliemo Usellini, Paola Carrara Lombroso e<br />
lo stesso Reale, sembra probabile che fossero<br />
sorti degli attriti tra Olivetti e i Ferrero, ai quali<br />
nel ’43 aveva promesso <strong>di</strong> rilevare l’attività<br />
della casa e<strong>di</strong>trice. 13 Forse anche per questo<br />
motivo, tra i primi libri a essere pubblicati dalle<br />
E<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> Comunità nel dopoguerra ci fu Potere<br />
<strong>di</strong> Guglielmo Ferrero, con un’introduzione <strong>di</strong><br />
Umberto Campagnolo.<br />
Quando la stampa del lavoro <strong>di</strong> Adriano<br />
Olivetti sembrava ormai prossima, Ernesto<br />
Rossi decise <strong>di</strong> esprimere all’autore tutte le ri-<br />
DALLA “SUISSE” 197
serve che esso gli suscitava. Oltre<br />
a restitui r gli le bozze del libro glossate<br />
a margine, gli scrisse due lettere<br />
che rimangono una testimonianza<br />
rara della lealtà e del rispetto<br />
intellettuale che si può nutrire per<br />
una persona. Con la consueta<br />
schiettezza, il polemico economista<br />
affermava, tra l’altro, che «il libro è<br />
ancora troppo faticoso da leggere»<br />
e «pochissimi saranno coloro che<br />
riusciranno a leggerlo, anche se<br />
molti <strong>di</strong>ranno che è “interessante”,<br />
senza averlo letto». Si prevedeva, in<br />
altri termini, ciò che i fatti successivi<br />
avrebbero confermato. Rossi, inoltre,<br />
intuì una questione che avrebbe<br />
contribuito alla taccia <strong>di</strong> utopismo<br />
spesso rivolta – dal dopoguerra fi no<br />
a oggi – al pensiero politico olivettiano:<br />
«Quello che lei scrive sulla morale<br />
cristiana che dovrebbe informare<br />
tutta l’attività degli organi amministrativi<br />
apparirà al comune lettore<br />
eccessivamente ingenuo». In effetti,<br />
«i motivi morali all’azione non cambiano,<br />
o cambiano ben poco, per il<br />
fatto che viene mutato l’or<strong>di</strong>namento politico amministrativo». E<br />
concludeva: «Affermare che senza un completo rivolgimento morale<br />
– per cui lo spirito <strong>di</strong> carità completi la giustizia sociale –<br />
l’organizzazione delle Comunità vivrebbe senza anima, signifi ca<br />
– secondo me – <strong>di</strong>minuire il valore delle sue proposte, perché<br />
molti penseranno che un tale rivolgimento non si verifi cherà». 14<br />
Ormai, però, non era possibile reimpostare il lavoro. Il Memorandum<br />
sullo Stato Federale delle Comunità era pronto per la pubblicazione<br />
defi nitiva con il titolo L’or<strong>di</strong>ne politico delle Comunità; costituiva,<br />
secondo l’autore, «un lavoro personale e non il Credo <strong>di</strong><br />
un partito». 15 Era la conclusione pregnante <strong>di</strong> un periodo trascorso<br />
in esilio proprio per motivi politici. 16<br />
Alle autorità fasciste, infatti, Olivetti risultava essere ”ariano”.<br />
L’appartenenza alla razza ebraica veniva invece singolarmente<br />
imputata dal regime a tutti gli altri membri della sua famiglia,<br />
a eccezione della sorella Elena e ovviamente della madre. 17 Per<br />
quanto possibile, si impegnò così al fi ne <strong>di</strong> far accogliere in Svizzera<br />
sia l’ex moglie Paola Levi con i fi gli, sia il fratello Massimo<br />
con la sua famiglia. Contattò anche per questa ragione, a partire<br />
dal marzo del ’44, 18 il Comitato svizzero <strong>di</strong> soccorso operaio <strong>di</strong><br />
Lugano, interloquendo in particolare con Fer<strong>di</strong>nando Santi e Guglielmo<br />
Canevascini. 19 Nel maggio del ’44, scrisse a Santi che<br />
tutta la propria famiglia, «in seguito a un annunciato peggioramento<br />
delle leggi razziali», poteva all’improvviso prendere la decisione<br />
<strong>di</strong> entrare in Svizzera: si trattava, in particolare, della<br />
sorella Elena, della moglie dell’appena espatriato Arrigo, e dei<br />
loro fi gli Vittorio, Luisa e Camillo. 20<br />
Da Champfèr, Olivetti riusciva a <strong>di</strong>rigere, almeno in parte, il<br />
movimento <strong>di</strong> resistenza antifascista attivo nella fabbrica <strong>di</strong> Ivrea<br />
e, in taluni casi, dava al Comitato svizzero <strong>di</strong> soccorso operaio<br />
assicurazioni sui sentimenti antifascisti <strong>di</strong> giovani che stavano<br />
per espatriare, al fi ne <strong>di</strong> facilitarne l’accoglienza. 21 Ricambiò le<br />
attenzioni che il Comitato aveva rivolto a lui e ai suoi familiari,<br />
198 DALLA “SUISSE”<br />
A. Olivetti,<br />
Città dell’uomo.<br />
1960.<br />
AA. VV.,<br />
Il Dio che è fallito.<br />
1950.<br />
A. Olivetti,<br />
Fini e fine della<br />
politica.<br />
1949.<br />
Schumpeter,<br />
Capitalismo,<br />
socialismo<br />
e democrazia.<br />
1955.<br />
L. Mumford,<br />
La con<strong>di</strong>zione<br />
dell’uomo.<br />
1957.<br />
Kierkegaard,<br />
Scuola <strong>di</strong><br />
cristianesimo.<br />
1960. Fondazione Adriano Olivetti <strong>di</strong> Roma<br />
inviando sol<strong>di</strong> allo scopo <strong>di</strong> fi nanziare l’aiuto che, intorno a settembre,<br />
esso stava portando ai bambini italiani delle terre da<br />
poco liberate, segnatamente della Val d’Ossola, acquistando<br />
generi alimentari e beni <strong>di</strong> prima necessità. 22 Il sentimento che<br />
animava i responsabili del Comitato svizzero <strong>di</strong> soccorso operaio,<br />
anche prima <strong>di</strong> questo impegno, può forse essere ben sintetizzato<br />
da quanto Fer<strong>di</strong>nando Santi scrisse a Olivetti nel luglio del ’44:<br />
«Volevo pregarla <strong>di</strong> non parlare <strong>di</strong> cortesie usate a Lei ed ai Suoi.<br />
In realtà quel poco che è stato fatto era più che doveroso per le<br />
sue note e tante benemerenze. Personalmente non ho poi meriti<br />
particolari: è il Comitato che si è occupato <strong>di</strong> Lei come <strong>di</strong> tanti<br />
altri assai meno meritevoli». 23<br />
Dato ormai alle stampe L’or<strong>di</strong>ne politico delle Comunità,<br />
Olivetti pensava fosse giunto il momento <strong>di</strong> de<strong>di</strong>carsi a un’azione<br />
politica «<strong>di</strong> natura <strong>di</strong>retta». Aveva confi dato perciò a Guglielmo<br />
Usellini che, «nelle circostanze politiche attuali, nell’imminenza<br />
della lotta», l’unica «conclusione logica e coerente» era chiedere<br />
<strong>di</strong> «partecipare al partito socialista, come il solo che, per l’orientamento<br />
spirituale dei suoi uomini migliori e per il suo atteggiamento<br />
pratico», collimava con le proprie aspirazioni: «un rinnovamento<br />
spirituale e organizzativo dei movimenti socialisti». 24 Un<br />
mese dopo aver aderito al Movimento federalista europeo tramite<br />
Ernesto Rossi, 25 sempre in Svizzera s’iscrisse dunque al Partito<br />
socialista italiano <strong>di</strong> unità proletaria, ma le proprie idee politiche,<br />
maturate durante il crogiolo della guerra, lo avrebbero<br />
presto indotto, una volta tornato in Italia, a fondare e <strong>di</strong>rigere un<br />
gruppo politico autonomo: il Movimento Comunità. 26<br />
L’organizzazione sociale esperita e osservata personalmente<br />
in Svizzera costituiva l’esemplifi cazione <strong>di</strong> molti degli ideali <strong>di</strong><br />
riforma che lo animavano e per i quali profuse il proprio impegno<br />
durante tutti gli anni Cinquanta. La conclusione improvvisa della<br />
sua esistenza rappresenta così, come nei racconti leggendari,<br />
qualcosa che può riassumere in sé il senso <strong>di</strong> tutta una storia.
Fondazione Adriano Olivetti <strong>di</strong> Roma<br />
Proteso sempre verso il futuro, attraverso il continuo movimento<br />
<strong>di</strong>alettico delle idee e la ricerca <strong>di</strong> esperienze para<strong>di</strong>gmatiche, 27<br />
Adriano Olivetti morì nel febbraio del 1960 su un treno in corsa<br />
verso Losanna, all’interno <strong>di</strong> quel territorio che, in anni <strong>di</strong>ffi cili,<br />
aveva garantito a lui, come a tanti altri gran<strong>di</strong> spiriti, <strong>di</strong> manifestare<br />
liberamente il pensiero.<br />
1) Si veda D. CADEDDU, Adriano Olivetti politico, E<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> Storia e<br />
Letteratura, Roma 2009.<br />
2) Sull’attività d’intelligence condotta da Olivetti, si consulti D. CA-<br />
DEDDU, Introduzione, in A. OLIVETTI, Stato Federale delle Comunità. La riforma<br />
politica e sociale negli scritti ine<strong>di</strong>ti (1942-1945), e<strong>di</strong>zione critica<br />
a cura <strong>di</strong> D. CADEDDU, Franco Angeli, Milano 2004; e M. BERETTINI, La<br />
Gran Bretagna e l’antifascismo italiano. Diplomazia clandestina, Intelligence,<br />
Operazioni speciali (1940-1943), prefazione <strong>di</strong> M. de Leonar<strong>di</strong>s,<br />
Le Lettere, Firenze 2010, pp. 122-129.<br />
3) E. AGA ROSSI, Una nazione allo sbando. L’armistizio italiano del<br />
settembre 1943 e le sue conseguenze, Il Mulino, Bologna 2003, pp.<br />
59-60.<br />
4) Si vedano in merito le considerazioni espresse in La riforma<br />
politica e sociale <strong>di</strong> Adriano Olivetti (1942-1945), a cura <strong>di</strong> D. CADEDDU,<br />
Fondazione Adriano Olivetti, Roma 2005.<br />
5) Sull’emigrazione antifascista, si veda A. GAROSCI, Storia dei fuorusciti,<br />
Laterza, Bari 1953; E. SIGNORI, La Svizzera e i fuorusciti italiani.<br />
Aspetti e problemi dell’emigrazione politica 1943-1945, prefazione <strong>di</strong> G.<br />
Spadolini, Franco Angeli, Milano 1983; R. BROGGINI, Terra d’asilo. I rifugiati<br />
italiani in Svizzera. 1943-1945, il Mulino, Bologna 1993; Id., La<br />
frontiera della speranza. Gli ebrei dall’Italia verso la Svizzera 1943-1945,<br />
Mondadori, Milano 1998.<br />
6) A. Olivetti, L’or<strong>di</strong>ne politico delle Comunità, V, 3, (c).<br />
7) Ibid., II, 1.<br />
8) Sulla fi losofi a politica <strong>di</strong> Olivetti, si consulti D. CADEDDU, Il valore<br />
della politica in Adriano Olivetti, Fondazione Adriano Olivetti, Roma<br />
2007.<br />
9) Cfr. D. CADEDDU, Del liberalismo <strong>di</strong> Luigi Einau<strong>di</strong>. Tre esercizi <strong>di</strong><br />
lettura, Cuem, Milano 2007, pp. 65-94.<br />
10) Cfr. ibidem.<br />
N. Ber<strong>di</strong>aev,<br />
Spirito e libertà.<br />
1947.<br />
Barsotti,<br />
La fuga immobile.<br />
1957.<br />
L. Beveridge,<br />
L’azione volontaria.<br />
1954.<br />
Kierkegaard,<br />
Timore e tremore.<br />
1948.<br />
S. Weil,<br />
La con<strong>di</strong>zione<br />
operaia.<br />
1952.<br />
E. Mounier,<br />
Rivoluzione<br />
personalista<br />
e comunitaria.<br />
1949.<br />
11) Si veda R. CASTAGNOLA ROSSINI,<br />
Incontri <strong>di</strong> spiriti liberi. Amicizie, relazioni<br />
professionali e iniziative e<strong>di</strong>toriali <strong>di</strong> Silone<br />
in Svizzera, Lacaita, Manduria-Bari-<br />
Roma 2004.<br />
12) Cfr. la copia della lettera <strong>di</strong> Olivetti<br />
a Odoardo Masini, Champfèr 13 <strong>di</strong>cembre<br />
1944, in Archivio del Centro<br />
inter<strong>di</strong>partimentale <strong>di</strong> ricerca e documentazione<br />
sulla storia del ’900, Università<br />
degli Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> Pavia, fondo Guglielmo<br />
Usellini, Fal. G, doc. 111<br />
(ulteriore copia in Archivio centrale dello<br />
Stato, Roma, fondo Egi<strong>di</strong>o Reale, b.<br />
4, fasc. «118 Adriano Olivetti»).<br />
13) Cfr. CASTAGNOLA ROSSINI, Incontri <strong>di</strong><br />
spiriti liberi, cit., p. 115, e la lettera <strong>di</strong><br />
Olivetti a Reale del 16 febbraio 1945,<br />
in Archivio centrale dello Stato, Roma,<br />
fondo Egi<strong>di</strong>o Reale, b. 4, fasc. «118<br />
Adriano Olivetti».<br />
14) Lettera <strong>di</strong> Rossi a Olivetti, 31<br />
marzo 1945, in Historical Archives of<br />
European Union, Firenze, fondo Ernesto<br />
Rossi, vol. 22, fasc. «Adriano Olivetti».<br />
15) Lettera <strong>di</strong> Olivetti a Rossi, 9 aprile<br />
1945, in Historical Archives of European<br />
Union, Firenze, fondo Ernesto<br />
Rossi, vol. 22, fasc. «Adriano Olivetti».<br />
16) Cfr. il «Questionario» della Divisione<br />
della polizia del Dipartimento fede-<br />
rale <strong>di</strong> giustizia e polizia, p. 11, nell’Archivio Federale Svizzero, Berna,<br />
E 4264 1985/196, vol. 1763, dossier «N 20629 Olivetti Adriano<br />
11.4.01 Italien».<br />
17) Cfr. V. OCHETTO, Adriano Olivetti, Mondadori, Milano 1985, p. 103.<br />
18) Cfr. la lettera <strong>di</strong> Olivetti a Santi del 12 marzo 1944, in D. CADED-<br />
DU, Adriano Olivetti e la Svizzera (gennaio 1943 – settembre 1945), in<br />
Spiriti liberi in Svizzera. La presenza <strong>di</strong> fuorusciti italiani nella Confederazione<br />
negli anni del fascismo e del nazismo (1922-1945). Atti del<br />
convegno internazionale <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>. Ascona, Centro Monte Verità. Milano,<br />
Università degli Stu<strong>di</strong>. 8-9 novembre 2004, a cura <strong>di</strong> R. CASTAGNOLA, F.<br />
PANZERA e M. SPIGA, Franco CESATI, Firenze 2006, p. 227.<br />
19) Per un quadro generale, si veda N. VALSANGIACOMO COMOLLI, Storia<br />
<strong>di</strong> un leader. Vita <strong>di</strong> Guglielmo Canevascini 1886-1965, Fondazione<br />
Pellegrini-Canevascini – Fondazione Miranda e Guglielmo Canevascini,<br />
s.l. [Lugano] 2001.<br />
20) Cfr. la lettera <strong>di</strong> Olivetti a Santi del 25 maggio 1944, in D. CADED-<br />
DU, Adriano Olivetti e la Svizzera, cit., pp. 231-232.<br />
21) Cfr. la lettera <strong>di</strong> Olivetti al Comitato svizzero <strong>di</strong> soccorso operaio<br />
del 22 aprile 1944, in D. CADEDDU, Adriano Olivetti e la Svizzera, cit., p.<br />
230.<br />
22) Cfr. le lettere a Olivetti del 26 settembre e del 13 ottobre [1944],<br />
e quella <strong>di</strong> Olivetti al Comitato svizzero <strong>di</strong> soccorso operaio del 4 ottobre<br />
1944, in D. CADEDDU, Adriano Olivetti e la Svizzera, cit., pp. 236-238.<br />
23) Lettera <strong>di</strong> Santi a Olivetti del 1° luglio 1944, in D. CADEDDU, Adriano<br />
Olivetti e la Svizzera, cit., p. 233.<br />
24) Lettera <strong>di</strong> Olivetti a Usellini del 23 marzo 1945, in Archivio del<br />
Centro inter<strong>di</strong>partimentale <strong>di</strong> ricerca e documentazione sulla storia del<br />
’900, Università degli Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> Pavia, fondo Guglielmo Usellini, Fal. B,<br />
fasc. 1, doc. 4.<br />
25) Cfr. la lettera <strong>di</strong> Olivetti a Rossi del 5 marzo 1945, in Historical<br />
Archives of the European Union, Firenze, fondo Ernesto Rossi, vol. 22,<br />
fasc. «Adriano Olivetti».<br />
26) Si veda in merito A. OLIVETTI, Fini e fi ne della politica. Democracy<br />
without political parties. Con un <strong>di</strong>scorso ine<strong>di</strong>to, introduzione e cura <strong>di</strong><br />
D. CADEDDU, Rubbettino, Soveria Mannelli 2009.<br />
27) Per un sintetico quadro biografi co, D. CADEDDU, «Humana civilitas».<br />
Profi lo intellettuale <strong>di</strong> Adriano Olivetti, in G. SAPELLI - D. CADEDDU, Adriano<br />
Olivetti. Lo Spirito nell’impresa, Il Margine, Trento 2007.<br />
DALLA “SUISSE” 199
La Fondazione Adriano Olivetti<br />
200 DALLA “SUISSE”<br />
Non solum in memoriam,<br />
sed in intentionem<br />
Adriano Olivetti con la figlia Laura nel 1955.<br />
Adriano Olivetti with his daughter Laura in 1955.<br />
Fondazione Adriano Olivetti <strong>di</strong> Roma<br />
LAURA OLIVETTI<br />
Presidente Fondazione Adriano Olivetti<br />
scomparsa <strong>di</strong> Adriano Olivetti all’inizio del<br />
1960 lasciò orfani non solo gli affetti, ma un’intera<br />
comunità e un progetto culturale, sociale e politico <strong>di</strong><br />
L’improvvisa<br />
gran<strong>di</strong>ssima complessità. All’indomani della sua morte,<br />
i familiari, gli amici e i suoi collaboratori più stretti decisero <strong>di</strong><br />
dare vita a uno strumento che potesse garantire continuità a<br />
quell’azione <strong>di</strong> riforma e, sebbene in forme <strong>di</strong>verse, portare nel<br />
futuro l’opera <strong>di</strong> Adriano Olivetti.<br />
Fu così costituita nel 1962 la “Fondazione Adriano Olivetti”,<br />
con l’obiettivo <strong>di</strong> custo<strong>di</strong>re e tutelare la memoria <strong>di</strong> Adriano Olivetti,<br />
<strong>di</strong> raccogliere e sviluppare l’impegno civile, sociale e politico<br />
che ha <strong>di</strong>stinto la sua opera e <strong>di</strong> promuovere e incoraggiare gli<br />
stu<strong>di</strong> <strong>di</strong>retti ad approfon<strong>di</strong>re la conoscenza delle con<strong>di</strong>zioni da cui<br />
<strong>di</strong>pende il progresso sociale, come i primi articoli del suo statuto<br />
impongono.<br />
Coerentemente a questo mandato, la Fondazione svolge<br />
attività <strong>di</strong> ricerca e promozione culturale e scientifi ca in quattro<br />
principali aree d’intervento: Istituzioni e società; Economia e società;<br />
Comunità e società; Arte, architettura e urbanistica.<br />
Sin dalla sua costituzione, la strada che la Fondazione percorre<br />
è <strong>di</strong>retta verso l’impiego <strong>di</strong> un patrimonio culturale complesso<br />
e <strong>di</strong> enorme valore civile e scientifi co come uno strumento<br />
creativo, e non solo commemorativo, per interpretare le sfi de<br />
della società contemporanea.<br />
Un’azione che la Fondazione porta avanti con il rigore e la<br />
passione riformatrice che hanno contrad<strong>di</strong>stinto l’esperienza olivettiana,<br />
e con lo sguardo rivolto alle sperimentazioni più vive e<br />
in<strong>di</strong>pendenti della cultura mon<strong>di</strong>ale.<br />
Abbiamo sempre preferito che fossero i momenti vivi<br />
dell’opera <strong>di</strong> Adriano Olivetti a costituire la suggestione per iniziative<br />
che celebrassero quell’esperienza riformulandone in contesti<br />
attuali i tratti più signifi cativi. Una scelta coerente con la natura<br />
riformatrice del progetto comunitario che ci obbliga, per vocazione<br />
Adriano Olivetti Foundation<br />
Adriano Olivetti’s intriguing idea of State <strong>di</strong>d not <strong>di</strong>e with him.<br />
Since 1962, the foundation bearing his name has aimed at protecting the<br />
memory and developing his social, political and civil commitment in the<br />
<strong>di</strong>rection he desired. This activity of cultural and scientific promotion offers<br />
<strong>di</strong>fferent areas of intervention: institutions, economy, art, architecture, city<br />
planning. The hands-on work includes organizing conventions, seminars,<br />
and exhibitions but also stimulating academic and scientific research which<br />
has an extensive archive at its <strong>di</strong>sposal in the two offices in Rome and Ivrea.
A sinistra: comizio <strong>di</strong> Adriano Olivetti al Teatro Adriano a Roma il 27 marzo 1958<br />
in vista delle elezioni politiche del maggio 1958. A destra: esterno della sede <strong>di</strong><br />
Ivrea della Fondazione Adriano Olivetti. In basso: Adriano Olivetti immerso nella<br />
lettura davanti alla ricca libreria nella sua casa <strong>di</strong> Ivrea a Villa Belliboschi.<br />
e per mandato statutario, a interpretare con de<strong>di</strong>zione e operosità<br />
la memoria <strong>di</strong> una storia ricca <strong>di</strong> cultura e, soprattutto, ricca<br />
<strong>di</strong> risorse e competenze per la società italiana attuale e non solo.<br />
In ragione <strong>di</strong> ciò, e all’interno degli ambiti d’intervento che connotano<br />
la sua azione, la Fondazione organizza e sostiene stu<strong>di</strong> e<br />
ricerche, incoraggia e coor<strong>di</strong>na convegni e seminari, cura e allestisce<br />
mostre, in collaborazione con altre istituzioni fi lantropiche<br />
o con enti pubblici e privati, in Italia e all’estero.<br />
Tra le prerogative principali che contrad<strong>di</strong>stinguono la Fondazione<br />
c’è anche la promozione <strong>di</strong> attività <strong>di</strong> ricerca accademica<br />
e scientifi ca, in particolare <strong>di</strong> quegli stu<strong>di</strong> che hanno per oggetto,<br />
come è ovvio, la vicenda impren<strong>di</strong>toriale, culturale e politica <strong>di</strong><br />
Adriano Olivetti. Tra la sede <strong>di</strong> Roma e quella <strong>di</strong> Ivrea, aperta nel<br />
2008 e ospitata nell’ultima casa <strong>di</strong> Adriano Olivetti, sono a <strong>di</strong>sposizione<br />
<strong>di</strong> ricercatori italiani e stranieri apparati documentari organizzati<br />
tra un grande archivio, cartaceo e multime<strong>di</strong>ale, e una<br />
ricca biblioteca <strong>di</strong> oltre 10.000 volumi, entrambi <strong>di</strong>chiarati <strong>di</strong> rilevante<br />
interesse storico dal Ministero per i Beni e le Attività culturali<br />
italiano. L’archivio, sud<strong>di</strong>viso in <strong>di</strong>versi fon<strong>di</strong>, raccoglie, tra le<br />
altre cose: la corrispondenza aziendale e privata <strong>di</strong> Camillo Olivetti,<br />
quella particolarmente ricca <strong>di</strong> Adriano e quella <strong>di</strong> altri<br />
membri della famiglia Olivetti; l’archivio del Movimento Comunità<br />
e delle E<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> Comunità, il movimento politico e la casa e<strong>di</strong>trice<br />
che Adriano Olivetti costituì tra il 1946 e il 1947; gli archivi<br />
personali <strong>di</strong> Ludovico Quaroni e Georges Friedrich Friedmann;<br />
infi ne l’archivio che testimonia i cinquant’anni <strong>di</strong> attività della<br />
stessa Fondazione. Nella sede <strong>di</strong> Roma sono ospitate: le biblioteche<br />
personali <strong>di</strong> Camillo e Adriano Olivetti, <strong>di</strong> grande rilevanza<br />
culturale tanto per la qualità delle pubblicazioni che per l’ampiezza<br />
<strong>di</strong> interessi scientifi ci e culturali che esprimono; la raccolta<br />
completa delle “E<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> Comunità” e della rivista “Comunità”;<br />
la collezione completa <strong>di</strong> tutte le pubblicazioni della Fondazione<br />
dal 1962 a oggi e dei Quaderni della Fondazione. La biblioteca<br />
della Fondazione raccoglie, inoltre, tutte le pubblicazioni e i lavo-<br />
Associazione Archivio Storico Olivetti <strong>di</strong> Ivrea<br />
Left: Adriano Olivetti’s rally at the Adriano Theatre in Rome on March 27, 1958<br />
prior to the political elections in May 1958. Right: outside the Ivrea premises of<br />
the Adriano Olivetti Foundation. Below: Adriano Olivetti engrossed in rea<strong>di</strong>ng in<br />
front of the vast library in his Ivrea house in Villa Belliboschi.<br />
ri accademici che hanno come oggetto la fi gura <strong>di</strong> Adriano Olivetti<br />
e la storia della Società Olivetti, costituendo, <strong>di</strong> fatto, un centro<br />
<strong>di</strong> documentazione unico.<br />
La Fondazione si avvale <strong>di</strong> un’attività e<strong>di</strong>toriale che si realizza<br />
attraverso le “E<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> Comunità”, con la tra<strong>di</strong>zionale serie<br />
dei Quaderni della Fondazione e in collaborazione con altre case<br />
e<strong>di</strong>trici. Dal 2008 è stato inoltre lanciato il progetto della Collana<br />
Intangibili, un impegno e<strong>di</strong>toriale <strong>di</strong> <strong>di</strong>ffusione prevalentemente<br />
<strong>di</strong>gitale.<br />
La Fondazione è tra i primi membri dell’European Foundation<br />
Center e durante i cinquanta anni della sua storia, che la<br />
rendono uno tra i più longevi istituti <strong>di</strong> questo tipo in Italia, ha<br />
promosso e collaborato a progetti e campagne <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o e <strong>di</strong> ricerca<br />
insieme con le principali Fondazioni europee e americane,<br />
nel solco <strong>di</strong> una tra<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> collaborazione e identità che ha<br />
fatto della vicenda <strong>di</strong> Adriano Olivetti un esempio <strong>di</strong> impegno<br />
autentico e rigoroso per la promozione della fi lantropia non solo<br />
in Italia ma anche all’estero.<br />
Associazione Archivio Storico Olivetti <strong>di</strong> Ivrea<br />
Fondazione Adriano Olivetti<br />
Via Giuseppe Zanardelli, 34<br />
00186 Roma<br />
Tel. +39.06.6834016<br />
www.fondazioneadrianolivetti.it<br />
Club Amici<br />
della Fondazione Adriano Olivetti<br />
info@fondazioneadrianolivetti.it<br />
DALLA “SUISSE” 201<br />
Fondazione Adriano Olivetti <strong>di</strong> Roma
29 <strong>di</strong>cembre 2010.<br />
Inaugurazione e<br />
bene<strong>di</strong>zione del<br />
pozzo <strong>di</strong> acqua<br />
potabile <strong>di</strong><br />
Sourgubilà, donato<br />
dalle banche<br />
Co.Ba.Po. e clienti.<br />
29th December 2010.<br />
Inauguration and<br />
blessing of the well<br />
for drinking water<br />
in Sourgubilà,<br />
donated by the<br />
Co.Ba.Po. banks and<br />
clients.<br />
NOTIZIARIO<br />
Cronache<br />
aziendali<br />
Water in Burkina<br />
In this part of the world, water is definitely the greatest asset;<br />
when a new well arrives in the area of Boussé, it is literally a gift<br />
from the heavens and solidarity. Many other evils threaten this<br />
frontier land: malaria, tuberculosis and AIDS. The members of the<br />
association APDPK do what they can, having to offer help an area<br />
with 60,000 inhabitants. Films are shown to raise awareness on<br />
sexually transmittable <strong>di</strong>seases. The other “evils” include the<br />
con<strong>di</strong>tion of the Burkinabé, the mole-like men who work in the<br />
goldmines: narrow shafts, up to 50 metres deep, without<br />
ventilation and which risk suddenly collapsing. But this does not<br />
dampen the enthusiasm that they show with singing and dancing<br />
during the celebration of the Mass.<br />
202 CRONACHE AZIENDALI<br />
Acqua del Burkina<br />
Testo e foto <strong>di</strong><br />
WAIDER VOLTA<br />
Vice<strong>di</strong>rettore Co.Ba.Po.<br />
Consorzio Banche Popolari<br />
Una mamma che non fa<br />
piangere troppo a lungo<br />
il proprio fi glio è una donna<br />
molto apprezzata nella<br />
tribù burkina dei “Peul”. L’avevo<br />
già percepito in un precedente<br />
viaggio ma non ci avevo fatto caso;<br />
ora che ho l’occasione <strong>di</strong> un viaggio<br />
<strong>di</strong>verso, noto che raramente i<br />
bambini burkina piangono, pur tra<br />
gran<strong>di</strong> <strong>di</strong>ffi coltà oggettive: malattie,<br />
fame, malnutrizione, mancanza<br />
<strong>di</strong> alcune cose in una pur semplice<br />
e povera vita quoti<strong>di</strong>ana.<br />
Incontro, nell’ambito <strong>di</strong> un<br />
piccolo progetto <strong>di</strong> cooperazione<br />
umanitaria, alcune situazioni <strong>di</strong>ffi -<br />
cili, altre invece che lasciano un<br />
po’ <strong>di</strong> speranza per un futuro migliore<br />
alla gente più povera. Un<br />
orfanotrofio che accoglie se<strong>di</strong>ci<br />
bambini da zero a quattro anni ci<br />
invita a fare un piccolo intervento;<br />
le con<strong>di</strong>zioni igieniche appaiono al<br />
limite. Alcuni piccoli “gattonano”<br />
tra sporco ambientale e “proprio”<br />
ma le educatrici sono ben curate.<br />
Al suono <strong>di</strong> una nostra fi sarmonica,<br />
come d’incanto i piccoli si risvegliano<br />
dalla atonicità nella quale li<br />
avevamo trovati. Stiamo con loro.<br />
Rientrando in jeep all’albergo<br />
mi riprendo un po’ pensando alla<br />
visita <strong>di</strong> ieri, all’anziano <strong>di</strong> molti<br />
villaggi, il saggio che <strong>di</strong>rime per<br />
migliaia <strong>di</strong> persone le questioni più<br />
ingarbugliate: matrimoni <strong>di</strong>ffi cili,<br />
bestiame malvenduto, situazioni<br />
educative contrastanti. Naaba Bulga,<br />
così si chiama il capo, mi ha<br />
voluto incontrare subito dopo aver<br />
inaugurato il pozzo <strong>di</strong> acqua potabile<br />
che i giovani clienti delle banche<br />
popolari CoBaPo hanno reso<br />
possibile inviando quote <strong>di</strong> loro risparmio.<br />
Il pozzo <strong>di</strong> Sourgubilà ora<br />
pompa fuori da molte decine <strong>di</strong><br />
metri sotto terra una fresca e limpida<br />
acqua che molti <strong>di</strong> noi bevono<br />
dalle mani “a coppa”.<br />
«Quella parte <strong>di</strong> territorio –<br />
<strong>di</strong>ce Naaba – ne aveva davvero<br />
bisogno e io vi ringrazio a nome<br />
della mia gente!». Detto fatto ed<br />
ecco che spunta un aiutante con<br />
una bella e giovane capra, dono <strong>di</strong><br />
gran pregio, quale ringraziamento!<br />
(la capra la aggiungerò, quale settimo<br />
ospite, al piccolo gregge dei<br />
monaci <strong>di</strong> Bissighin).<br />
Il due <strong>di</strong> gennaio lo passo con<br />
alcuni membri dell’associazione<br />
burkina APDPK che portano avanti<br />
i progetti <strong>di</strong> educazione sanitaria<br />
nella zona <strong>di</strong> Boussé a occidente<br />
<strong>di</strong> Uagà. Incontro gruppi <strong>di</strong> lavoro<br />
preparati sui tre gran<strong>di</strong> mali che<br />
affl iggono il Burkina: la malaria, la<br />
Tbc, l’Aids. Gli operatori burkina<br />
servono un territorio <strong>di</strong> 60.000<br />
persone su 84 villaggi, molti dei<br />
quali <strong>di</strong>ffi cili da raggiungere sia fi -<br />
sicamente sia culturalmente; in<br />
ogni villaggio cercano prima il contatto<br />
con i maggiori referenti, e<br />
una volta informati e formati questi,<br />
allora per imitazione ed “accettazione”<br />
è possibile allargare alla<br />
popolazione.
La sera siamo invitati in un<br />
villaggio rurale sparso a 15 km da<br />
Boussé ove vicino ad una casa <strong>di</strong><br />
agricoltori, <strong>di</strong> fango e paglia ma<br />
ampia, sono state portate in un<br />
largo spazio, sotto un albero <strong>di</strong><br />
karité, una ventina <strong>di</strong> panchine, un<br />
piccolo generatore <strong>di</strong> corrente, un<br />
proiettore e, trovati due alti bastoni,<br />
tra essi viene teso un telo bianco,<br />
dove verso le 19,30 tra il buio<br />
più pesto (qui il sole scende <strong>di</strong><br />
colpo), l’APDPK proietta due cortometraggi:<br />
l’uno su come cercare <strong>di</strong><br />
prevenire le malattie sessuali, l’altro<br />
su come portare assistenza<br />
emozionale e sociale ai malati <strong>di</strong><br />
Aids, altrimenti emarginati.<br />
Poi, sempre al buio, per noi<br />
squarciato dalla debole luce <strong>di</strong> una<br />
lampada a petrolio, la maggiore<br />
delle quattro fi glie del conta<strong>di</strong>no<br />
passa con un secchio d’acqua per<br />
le mani; quin<strong>di</strong> ci viene offerta su<br />
un piatto <strong>di</strong> lamiera battuta la cena<br />
con spaghetti e pezzetti <strong>di</strong> pollo e<br />
semi <strong>di</strong> arachi<strong>di</strong> e un po’ <strong>di</strong> brakina,<br />
una birra locale.<br />
Nelle miniere “<strong>di</strong> oro” <strong>di</strong> Kòva<br />
a 280 km a nord <strong>di</strong> Uagà al confi -<br />
ne con Mali e Niger, trecento “uomini<br />
talpa”, burkinabé, nigeriani e<br />
del Mali, scavano buchi sotto terra<br />
profon<strong>di</strong> fi no a 50 m e larghi 1 per<br />
1,50 m! Un tizio ha affi ttato il terreno,<br />
e a chiunque scava qui garantisce<br />
da mangiare ogni giorno<br />
e, se trovano oro, due terzi vanno<br />
a lui e un terzo agli operai. Lavorano<br />
ad ogni scavo in gruppi <strong>di</strong> cinque<br />
persone. Credo che nemmeno<br />
mille anni fa si facessero buchi<br />
in tal maniera e così pericolosi.<br />
Provano a ventilare il pozzo con<br />
vecchi sacchi <strong>di</strong> plastica nera cuciti<br />
come tubi. L’uomo che è giù<br />
Una veduta della<br />
struttura del pozzo<br />
la cui pompa a<br />
mano “In<strong>di</strong>a Mark II”<br />
pesca a circa 50<br />
metri sotto il suolo.<br />
A view of the<br />
structure of the well,<br />
with a “In<strong>di</strong>a Mark II”<br />
hand pump that<br />
draws water from<br />
about 50 metres<br />
below ground level.<br />
A sinistra: una<br />
famiglia locale posa<br />
davanti al pozzo.<br />
Anche la Bps ha<br />
contribuito alla sua<br />
costruzione.<br />
A destra: l’autore<br />
dell’articolo con don<br />
Joseph Sambieni,<br />
responsabile della<br />
Zona <strong>di</strong> S. Augustin<br />
de Bissighin.<br />
On the left: a local<br />
family poses in front<br />
of the well. The Bps<br />
also contributed to<br />
buil<strong>di</strong>ng it.<br />
On the right: the<br />
author of the article<br />
with Don Joseph<br />
Sambieni, responsible<br />
for the area of<br />
St. Augustin de<br />
Bissighin.<br />
scava, alla luce <strong>di</strong> una torcia legata<br />
alla tempia, e ogni tanto manda<br />
su due o tre sacchi <strong>di</strong> terriccio e<br />
roccia, agganciati ad una corda e<br />
carrucolati in superfi cie. Poi, sopra,<br />
un ragazzino seduto per terra,<br />
pesta in un mortaio tutto il materiale<br />
che, fi ne fi ne, sarà setacciato<br />
con l’acqua.<br />
Tra le buche passano due<br />
persone su una moto gialla. «Quelli<br />
– <strong>di</strong>ce una talpa – hanno trovato<br />
una buona vena alcuni mesi fa». Il<br />
resto è girone dantesco.<br />
È domenica tre gennaio e in<br />
Burkina viene celebrata la messa<br />
in moré alle sette e in francese<br />
alle nove: sono 120 minuti (o anche<br />
180) <strong>di</strong> energia pura e canti e<br />
ritmi e momenti <strong>di</strong> danza!<br />
La carica dei tamburi (unici<br />
strumenti della messa moré) e<br />
delle trombe è quasi coperta dai<br />
vari cori quando tutti assieme si<br />
fondono; poi la gente si prende per<br />
mano e si muove con lento ritmo<br />
con le braccia che a volte si alzano<br />
al cielo <strong>di</strong>ritte e altre in modo ondulatorio<br />
<strong>di</strong> lato. Per alcune volte<br />
sono costretto a deglutire per<br />
“chiudere” un po’ le orecchie, tanto<br />
è forte il timbro, bellissimo,<br />
delle voci <strong>di</strong>etro <strong>di</strong> me.<br />
Poi, non un fi ato quando, durante<br />
la pre<strong>di</strong>ca, il prete burkinabé<br />
chiede ai fedeli, duemila persone,<br />
se la loro vita è signifi cante, se la<br />
loro vita ha uno scopo! «Che senso<br />
gli state dando?». Resto colpito<br />
dalla <strong>di</strong>mensione <strong>di</strong> tale domanda,<br />
in pieno e arido Sahel. Buongiorno<br />
Africa!<br />
CRONACHE AZIENDALI 203
FATTI DI<br />
CASA NOSTRA<br />
APERTURE DI FILIALI<br />
Opening of branches<br />
AGENZIA DI CHIAVARI<br />
Il 3 <strong>di</strong>cembre 2010 ha preso avvio l’agenzia <strong>di</strong><br />
Chiavari, provincia <strong>di</strong> Genova, piazza Nostra Signora<br />
dell’Orto n. 42/B, angolo via Doria.<br />
È la seconda unità della banca in Liguria (l’altra è<br />
l’agenzia <strong>di</strong> Genova aperta tre anni or sono), regione che<br />
si affaccia sul mare ed è vicina alla Lombar<strong>di</strong>a, dov’è<br />
inse<strong>di</strong>ata la maggior parte delle nostre <strong>di</strong>pendenze.<br />
Chiavari conta quasi 28 mila abitanti e si trova nel<br />
cuore del Golfo del Tigullio, a poco più <strong>di</strong> quaranta chilometri<br />
<strong>di</strong> <strong>di</strong>stanza dal capoluogo regionale. È un importante<br />
centro balneare, ricco <strong>di</strong> storia, con uffi ci privati e<br />
pubblici, tra cui il tribunale, e con sede vescovile.<br />
Alle straor<strong>di</strong>narie bellezze naturali si aggiungono<br />
un rinomato porto turistico e, in numero copioso, chiese,<br />
monumenti e antichi palazzi <strong>di</strong> pregio.<br />
L’economia <strong>di</strong> Chiavari si basa sui commerci e soprattutto,<br />
data la posizione e la conformazione del territorio,<br />
sul turismo, per cui numerosi sono gli alberghi, le<br />
seconde case, i ristoranti, i negozi e le trattorie presenti.<br />
AGENZIA DI CIAMPINO<br />
Il 6 <strong>di</strong>cembre 2010 è stata la volta dell’agenzia <strong>di</strong><br />
Ciampino, con ubicazione nel centrale viale del Lavoro<br />
n. 56.<br />
La banca, con questa unità, è presente nella zona<br />
sud-est della capitale<br />
con quattro <strong>di</strong>pendenze<br />
(le altre<br />
sono Grottaferrata,<br />
Frascati e Genzano),<br />
il che <strong>di</strong>mostra<br />
il nostro crescente<br />
interesse non solo<br />
per Roma, ma anche<br />
per i centri a<br />
essa vicini.<br />
Ciampino è<br />
un centro del Lazio<br />
con 38.500 abitanti<br />
ed è situato<br />
nell’area metropolitana<br />
capitolina oltre<br />
il grande raccordo<br />
anulare, in<br />
204 CRONACHE AZIENDALI<br />
<strong>di</strong> ITALO SPINI<br />
con la collaborazione <strong>di</strong> MAURA POLONI<br />
<strong>di</strong>rezione dei Colli Romani. La citta<strong>di</strong>na è dotata <strong>di</strong> aeroporto,<br />
che dà lavoro e favorisce movimento <strong>di</strong> persone<br />
e <strong>di</strong> denaro, ed è servita da <strong>di</strong>verse linee ferroviarie e<br />
da un sistema viario sod<strong>di</strong>sfacente. Vi sono monumenti,<br />
palazzi e ville d’epoca, castelli, fortifi cazioni e numerosi<br />
resti archeologici, che attirano visitatori in gran<br />
numero.<br />
Imprese artigianali e commerciali, perlopiù <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni<br />
piccole e me<strong>di</strong>e, danno vita a un sistema <strong>di</strong><br />
produzione e commercio <strong>di</strong> buon livello.<br />
AGENZIA N. 1 DI SEREGNO<br />
E CONTESTUALE TRASFERIMENTO<br />
DELLA SUCCURSALE<br />
Con decorrenza 6 <strong>di</strong>cembre 2010 la succursale <strong>di</strong><br />
Seregno è stata trasferita da via Formenti n. 5 a via<br />
Cavour n. 84; e gli uffi ci lasciati liberi sono stati occupati<br />
dall’agenzia n. 1 <strong>di</strong> Seregno, aperta nello stesso<br />
giorno. Il rafforzamento, dopo 23 anni dal primo inse<strong>di</strong>amento,<br />
è stato voluto per meglio presi<strong>di</strong>are la piazza,<br />
una piazza notoriamente vivace e <strong>di</strong>namica.<br />
Seregno, 23 mila abitanti, vanta monumenti ed<br />
e<strong>di</strong>fi ci storici, come Villa Odescalchi, Palazzo Landriani<br />
Caponaghi, Torre Barbarossa, a cui si aggiungono <strong>di</strong>verse<br />
chiese <strong>di</strong> interesse artistico.<br />
Quanto alla viabilità, la citta<strong>di</strong>na è sfi orata dall’importante<br />
superstrada statale n. 36 Lecco-Milano e<br />
comprende uno snodo ferroviario con le tratte Milano-<br />
Como-Chiasso, Seregno-Carnate-Bergamo e Novara-<br />
Saronno-Seregno.
Ci troviamo<br />
nella parte meri<strong>di</strong>onale<br />
della laboriosa<br />
Brianza, centro per<br />
antonomasia del<br />
mobile, dell’artigianato,<br />
del lavoro, del<br />
progresso.<br />
AGENZIA<br />
DI ROVERETO<br />
Dicembre è<br />
notoriamente il mese<br />
<strong>di</strong> aperture. Il<br />
giorno 13 è stata la<br />
volta dell’agenzia <strong>di</strong><br />
Rovereto, ubicata<br />
in corso Antonio<br />
Rosmini n. 68, angolo via Fontana.<br />
Rovereto, oltre 37 mila abitanti, è un rinomato<br />
centro culturale del Trentino, che vanta un grande<br />
museo <strong>di</strong> arte contemporanea, denominato MART, e<br />
altri musei minori. Un’imponente campana, detta Campana<br />
dei Caduti o “Maria Dolens”, realizzata con la<br />
fusione del bronzo <strong>di</strong> cannoni usati nella Prima Guerra<br />
mon<strong>di</strong>ale, è presente sul Colle <strong>di</strong> Miravalle e i suoi<br />
cento rintocchi quoti<strong>di</strong>ani ricordano i Caduti <strong>di</strong> tutte le<br />
guerre, invitando alla pace. Vari monumenti, palazzi <strong>di</strong><br />
pregio, numerose chiese e santuari abbelliscono la<br />
citta<strong>di</strong>na. Il tutto contribuisce a richiamare turisti in<br />
gran numero.<br />
Di un certo rilievo sono le attività industriali, che<br />
ineriscono ai settori metalmeccanico, chimico, tessile,<br />
alimentare, elettronico e della lavorazione del legno. La<br />
viticoltura è praticata con sod<strong>di</strong>sfazione e l’artigianato<br />
e il commercio sono ben sviluppati.<br />
Rovereto è ricca <strong>di</strong> storia e, tra le tante personalità<br />
legate alla stessa, piace ricordare due patrioti,<br />
i cui nomi ricorrono spesso nella denominazione <strong>di</strong><br />
vie e piazze <strong>di</strong> città italiane: Damiano Chiesa e Fabio<br />
Filzi.<br />
AGENZIA DI CORTE FRANCA<br />
Il 27 <strong>di</strong>cembre ha aperto al pubblico l’agenzia <strong>di</strong><br />
Corte Franca, provincia <strong>di</strong> Brescia, via Sera<strong>di</strong>na n. 7.<br />
Il paese, fondato nel 1928 per fusione dei piccoli<br />
centri <strong>di</strong> Borgonato, Colombaro, Nigoline e Timoline,<br />
conta circa settemila abitanti ed è situato in collina, a<br />
sud del lago d’Iseo.<br />
Il territorio è ben conservato e alla coltura dei<br />
prati, che tra l’altro valorizzano il paesaggio già ridente<br />
<strong>di</strong> per sé, si affi anca quella <strong>di</strong> viti <strong>di</strong> pregio, dalle cui uve<br />
si producono vini, rinomati pure a livello internazionale.<br />
Teniamo presente che ci troviamo nella zona della Franciacorta,<br />
famosa per la vitivinicoltura.<br />
L’economia locale, oltre alla commercializzazione<br />
<strong>di</strong> vino, può contare su un turismo abbastanza sviluppato,<br />
su alcune attività industriali e sul terziario.<br />
AGENZIA DI LEGNANO<br />
L’apertura dell’agenzia <strong>di</strong> Legnano, provincia <strong>di</strong><br />
Milano, è avvenuta il 28 <strong>di</strong>cembre, con ubicazione nel<br />
centrale corso Garibal<strong>di</strong> n. 71.<br />
Siamo in un comune dell’Alto Milanese <strong>di</strong> 58 mila<br />
abitanti, a circa 20 chilometri dal capoluogo <strong>di</strong> provincia,<br />
attraversato dal fi ume Olona, tristemente noto per l’inquinamento.<br />
Il nome <strong>di</strong> “Legnano” ricorre, tra l’altro, nell’inno<br />
nazionale, quale elemento <strong>di</strong> unità e <strong>di</strong> forza. E questo,<br />
nel ricordo dell’omonima nota battaglia, combattuta<br />
eroicamente nel 1176 – e con successo – dai Comuni<br />
dell’Italia settentrionale, unitisi per la circostanza nella<br />
storica Lega Lombarda sotto il simbolo del “Carroccio”,<br />
contro l’imperatore Federico Barbarossa del Sacro Romano<br />
Impero.<br />
Diverse le e<strong>di</strong>fi cazioni <strong>di</strong> interesse: chiese, palazzi<br />
d’epoca, monumenti, a cui si aggiungono parchi<br />
naturali.<br />
L’impren<strong>di</strong>toria è ben sviluppata ed è appannaggio<br />
<strong>di</strong> molteplici piccole e me<strong>di</strong>e aziende. I servizi sono <strong>di</strong><br />
qualità e in continuo sviluppo.<br />
Un buon numero <strong>di</strong> legnanesi, non trovando occupazione<br />
in loco, è soggetto al cosiddetto pendolarismo<br />
quoti<strong>di</strong>ano, soprattutto verso la metropoli milanese.<br />
SUCCURSALE DI VERONA<br />
L’ultimo giorno del 2010 è stata avviata la succursale<br />
<strong>di</strong> Verona, corso Cavour n. 45, nostra seconda <strong>di</strong>pendenza<br />
veneta (la prima è Peschiera del Garda).<br />
Il Veneto è una laboriosissima regione contigua<br />
alla Lombar<strong>di</strong>a e pertanto, per la banca, è un territorio<br />
<strong>di</strong> naturale espansione, <strong>di</strong> sicuro interesse.<br />
Verona è situata allo sbocco della valle dell’A<strong>di</strong>ge<br />
e conta 270 mila abitanti. È nota in tutto il mondo per<br />
le fi ere e le manifestazioni culturali, a iniziare da quelle<br />
che si svolgono all’aperto nell’Arena, ma non solo. È una<br />
città d’arte con monumenti romani, me<strong>di</strong>evali, gotici e<br />
rinascimentali. Il centro storico è stato <strong>di</strong>chiarato<br />
CRONACHE AZIENDALI 205
dall’Unesco “Patrimonio mon<strong>di</strong>ale dell’umanità”. Il tutto<br />
richiama fl ussi turistici per circa tre milioni <strong>di</strong> persone<br />
ogni anno.<br />
Le vie <strong>di</strong> comunicazione abbracciano due gran<strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>rettrici: una, padana, trasversale – Torino-Milano-Venezia-Trieste<br />
– e l’altra, transalpina, longitu<strong>di</strong>nale – Roma-Bologna-Brennero-Monaco<br />
<strong>di</strong> Baviera. Merita <strong>di</strong> essere<br />
ricordato il prestigioso interporto, che è il più<br />
grande d’Italia.<br />
Flori<strong>di</strong>ssimo il commercio <strong>di</strong> prodotti vitivinicoli e<br />
agroalimentari in genere, anche verso l’estero.<br />
Molte le imprese industriali in vari settori: della<br />
carta, dell’e<strong>di</strong>toria, meccaniche, chimiche, alimentari,<br />
manifatturiere... Ben sviluppati i comparti dell’informatica<br />
e delle telecomunicazioni.<br />
FILIALE DI SAMEDAN<br />
DELLA CONTROLLATA BANCA POPOLARE<br />
DI SONDRIO (SUISSE) SA<br />
Il 21 febbraio 2011 la controllata svizzera ha aperto<br />
la fi liale <strong>di</strong> Samedan, Piazzet n. 21.<br />
Con questa unità la BPS (SUISSE), che è la banca<br />
svizzera <strong>di</strong> matrice italiana con la maggiore <strong>di</strong>ffusione<br />
territoriale, conta 23 <strong>di</strong>pendenze: 22 <strong>di</strong>slocate in 6<br />
Cantoni (Grigioni, Ticino, Basilea, Zurigo, Berna e San<br />
Gallo) e una nel Principato <strong>di</strong> Monaco.<br />
Samedan ha quasi tremila abitanti e si trova nel<br />
Cantone dei Grigioni, in Alta Enga<strong>di</strong>na, sulla sponda sinistra<br />
dell’Inn.<br />
Ci troviamo in una località rinomata per le bellezze<br />
naturali e conseguentemente per il buon fl usso turistico.<br />
Nell’economia locale rivestono un ruolo <strong>di</strong> rilievo i molteplici<br />
inse<strong>di</strong>amenti produttivi, costituiti da aziende <strong>di</strong><br />
piccola <strong>di</strong>mensione, soprattutto a carattere artigianale.<br />
Valorizzano Samedan la presenza <strong>di</strong> un aeroporto,<br />
che serve anche i paesi circonvicini, e una qualifi cata<br />
struttura ospedaliera <strong>di</strong> considerevoli <strong>di</strong>mensioni.<br />
206 CRONACHE AZIENDALI<br />
AGENZIA DI AOSTA<br />
L’ultimo giorno <strong>di</strong> febbraio 2011 è stata avviata<br />
l’agenzia <strong>di</strong> Aosta, con ubicazione nel centrale corso<br />
Battaglione Aosta n. 79.<br />
È il primo inse<strong>di</strong>amento della banca nella regione<br />
autonoma valdostana ed è stato scelto il capoluogo,<br />
essendo il centro più signifi cativo della regione.<br />
Aosta conta 35 mila abitanti, cui si aggiungono<br />
oltre 20 mila residenti nei comuni vicini, costituendo, il<br />
tutto, un unico agglomerato che comprende la metà<br />
della popolazione dell’intera Valle.<br />
Di Aosta numerose sono le testimonianze, giunte<br />
fi no a noi, degli antichi Romani transitati <strong>di</strong> lì durante la<br />
conquista e la dominazione delle Gallie, a iniziare dal<br />
nome ancor oggi talvolta usato <strong>di</strong> Augusta Praetoria<br />
Salassorum, e anche per dei tratti <strong>di</strong> strade <strong>di</strong> loro realizzazione,<br />
per dei monumenti dell’epoca ben conservati<br />
nel tempo e così via. Di queste vestigia parla pure<br />
Giosuè Carducci nell’autorevole ode patriottica Piemonte,<br />
con poche, appropriate parole: «...la vecchia Aosta <strong>di</strong><br />
cesaree mura ammantellata, che nel varco alpino eleva<br />
sopra i barbari manieri l’arco d’Augusto...».<br />
Nella città sono concentrate le attività amministrative<br />
regionali, il che, trovandoci in una regione a statuto<br />
speciale, riveste non poca importanza, tanto dal punto<br />
<strong>di</strong> vista economico quanto da quello politico. Do<strong>di</strong>cimila<br />
piccole e piccolissime imprese sono attive nell’artigianato,<br />
nell’agricoltura, nel commercio e nel turismo,<br />
settore quest’ultimo in costante crescita.<br />
È MORTO IL PROFESSOR<br />
TOMMASO PADOA SCHIOPPA<br />
Professor Tommaso Padoa Schioppa<br />
has passed away<br />
Il 18 <strong>di</strong>cembre 2010 è morto a Roma il professor<br />
Tommaso Padoa Schioppa, economista <strong>di</strong> fama, fervente<br />
europeista e uno dei padri della moneta unica.<br />
Nato nel luglio 1940 a Belluno, si era laureato presso
l’Università Luigi Bocconi <strong>di</strong> Milano in economia e<br />
commercio. Il suo curriculum vitae è vasto e coronato<br />
<strong>di</strong> successi <strong>di</strong> spessore.<br />
Tra i tanti incarichi ricoperti, vi sono quello dal<br />
’79 all’83 <strong>di</strong> <strong>di</strong>rettore generale per l’Economia e la<br />
Finanza dell’Unione Europea e quello imme<strong>di</strong>atamente<br />
successivo (dal 1984 al 1997) <strong>di</strong> vice <strong>di</strong>rettore<br />
generale della <strong>Banca</strong> d’Italia. Dal ’97 al ’98 era stato<br />
presidente della Consob e successivamente, fi no al<br />
2006, aveva fatto parte del Comitato Esecutivo della<br />
<strong>Banca</strong> Centrale Europea. Nel 2006 era <strong>di</strong>venuto ministro<br />
dell’Economia e delle Finanze come tecnico in<strong>di</strong>pendente<br />
e nel 2007 era stato nominato presidente<br />
del Comitato Monetario e Finanziario Internazionale<br />
del FMI (Fondo Monetario Internazionale). Il professor<br />
Tommaso Padoa Schioppa ha pure scritto vari libri <strong>di</strong><br />
economia.<br />
Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano,<br />
ricordando Padoa Schioppa, ha affermato che è stato<br />
«...un grande servitore dello Stato e dell’interesse<br />
pubblico. In tutte le alte funzioni dove è stato chiamato<br />
in Italia e in Europa ha lasciato l’impronta del suo<br />
eccezionale talento, della sua preziosa professionalità<br />
e della sua integrità». Sono espressioni che fotografano<br />
il rigore morale, la preparazione e le capacità non<br />
comuni del personaggio.<br />
Piace ricordare la sua attenzione e vicinanza a<br />
questa <strong>Popolare</strong>, concretatasi con la sua venuta nella<br />
nostra banca a <strong>Sondrio</strong> del 21 aprile 1995, quand’era<br />
vice <strong>di</strong>rettore generale della <strong>Banca</strong> Centrale. Egli, nella<br />
circostanza, aveva tenuto un’in<strong>di</strong>menticabile conferenza<br />
sul tema “Mercati fi nanziari tra pubblico e privato”.<br />
Il testo fu integralmente pubblicato sul nostro Notiziario<br />
<strong>di</strong> <strong>di</strong>cembre <strong>di</strong> quell’anno.<br />
Olycom<br />
Il professor<br />
Tommaso<br />
Padoa Schioppa<br />
Il car<strong>di</strong>nale<br />
Gianfranco Ravasi,<br />
pure a nome del<br />
Papa, consegna al<br />
signor Presidente,<br />
per il suo 80°<br />
compleanno, una<br />
medaglia particolare<br />
coniata dalla<br />
Santa Sede<br />
His Eminence, also<br />
in the name of the<br />
Pope, gave the<br />
Chairman, for his<br />
80th birthday, a<br />
special medal minted<br />
by the Holy See<br />
CONFERENZA<br />
DI SUA EMINENZA IL CARDINALE<br />
GIANFRANCO RAVASI<br />
Lecture by His Eminence Car<strong>di</strong>nal<br />
Gianfranco Ravasi<br />
Il ciclo delle nostre conferenze del 2010 si è chiuso<br />
con il car<strong>di</strong>nale Gianfranco Ravasi, il quale mercoledì<br />
22 <strong>di</strong>cembre ha intrattenuto un foltissimo pubblico<br />
nella nostra Sala Besta sul tema “Fede e scienza”. È<br />
stata la sua nona conferenza presso <strong>di</strong> noi, la prima<br />
nella sua eminente veste <strong>di</strong> porporato.<br />
Fede e scienza sono sentimenti e idee forti che si<br />
possono prestare a contrapposizioni e scontri tra credenti<br />
e non credenti.<br />
Al fi ne <strong>di</strong> facilitare il <strong>di</strong>alogo fra i <strong>di</strong>versi pensatori,<br />
per volere del Santo Padre, in Vaticano si è recentemente<br />
costituito Il Cortile dei Gentili, struttura appartenente<br />
al Pontifi cio Consiglio della Cultura. Trattasi <strong>di</strong> uno<br />
«...spazio <strong>di</strong> incontro e confronto attorno al tema della<br />
fede, quin<strong>di</strong> come possibilità <strong>di</strong> <strong>di</strong>alogo e reciproca conoscenza<br />
fra il mondo dei credenti e quello dei non<br />
credenti <strong>di</strong> oggi».<br />
In passato vi era una particolare rigi<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> pensiero,<br />
per cui, ad esempio, il cristiano interpretava i testi<br />
biblici in senso stretto, cioè non solo quale fonte <strong>di</strong> verità<br />
e <strong>di</strong> insegnamenti della religione, ma anche dal<br />
punto <strong>di</strong> vista scientifi co; ragione per la quale il geocentrismo<br />
(ma non solo) non poteva essere messo in <strong>di</strong>scussione.<br />
La posizione copernicana in contrapposizione<br />
con quella tolemaica non fu indolore: Galileo Galilei<br />
Foto Sgual<strong>di</strong>no<br />
CRONACHE AZIENDALI 207
è l’emblema della persecuzione, conseguente alla rigi<strong>di</strong>tà<br />
delle posizioni antitetiche e all’intolleranza.<br />
Anche oggi, sia pure sotto altre forme, ci può essere<br />
intolleranza e intransigenza fra scienziati e teologi.<br />
Ad esempio, si può verifi care il caso in cui lo scienziato<br />
pretende <strong>di</strong> essere il depositario della conoscenza e<br />
della verità. Vi è poi la teoria dei due livelli, dei due<br />
magisteri: quello scientifi co e quello teologico. Il primo<br />
fornisce dati, <strong>di</strong>mostrazioni, mette a punto le tecniche;<br />
il secondo offre valori, dà risposte alle problematiche<br />
dello spirito, al senso della vita, del creato, esalta il<br />
sentimento.<br />
La ricerca della verità, nata da quando esiste<br />
l’uomo, non ha scadenze, non ha fi ne. Gli uomini <strong>di</strong><br />
tutti i tempi hanno speso fi or <strong>di</strong> energie alla ricerca<br />
della verità, che è complessa e anche misteriosa. Lo<br />
scienziato autentico è <strong>di</strong>verso dal tecnico bieco ed è<br />
quello che, come i bambini, pone in continuazione domande.<br />
Analogamente è per il teologo vero. La vita è<br />
cercare, interrogarsi, osservare, scoprire. Scienziati e<br />
teologi devono collaborare, parlarsi, rifl ettere e rispettare<br />
le posizioni <strong>di</strong> ciascuno. È bene che teologi e scienziati<br />
si impongano dei limiti dettati dalla coscienza,<br />
operino in piena libertà e senza con<strong>di</strong>zionamenti, e, pur<br />
rimanendo sulle rispettive posizioni, non si pongano in<br />
confl itto fra <strong>di</strong> loro. La fede, la fi losofi a, la poesia danno<br />
un apporto, più o meno marcato, anche alla scienza; e<br />
viceversa. Nel confronto costruttivo si avvantaggiano la<br />
conoscenza, la verità.<br />
Al termine della straor<strong>di</strong>naria elocuzione, Sua Eminenza,<br />
pure a nome del Papa, ha donato al presidente<br />
cavaliere del lavoro Piero Melazzini, per il suo ottantesimo<br />
compleanno e in segno <strong>di</strong> ammirazione per il suo<br />
impegno anche nel settore culturale, una medaglia<br />
particolare, coniata dalla Santa Sede in occasione <strong>di</strong> un<br />
incontro nella Cappella Sistina fra il Sommo Pontefi ce<br />
e trecento artisti.<br />
208 CRONACHE AZIENDALI<br />
Un foltissimo<br />
pubblico segue con<br />
particolare<br />
attenzione la dotta<br />
conferenza del<br />
car<strong>di</strong>nale <strong>di</strong> recente<br />
nomina Gianfranco<br />
Ravasi<br />
A large au<strong>di</strong>ence<br />
follows very<br />
attentively the<br />
eru<strong>di</strong>te lecture by<br />
the recently<br />
appointed Car<strong>di</strong>nal,<br />
Gianfranco Ravasi<br />
Il dottor Giovanni<br />
Carlo Massera<br />
È MORTO IL DOTTOR<br />
GIOVANNI CARLO MASSERA<br />
Dr. Giovanni Carlo Massera has passed away<br />
Il 22 gennaio 2011, poco dopo mezzanotte, è<br />
improvvisamente venuto a mancare il dottor Giovanni<br />
Carlo Massera, maestro del lavoro, <strong>di</strong>pendente in quiescenza<br />
della banca.<br />
Nato il 27 novembre 1943, laureato in economia<br />
e commercio presso l’Università Commerciale Luigi<br />
Bocconi <strong>di</strong> Milano, era stato assunto in “<strong>Popolare</strong>” nel<br />
<strong>di</strong>cembre del 1970 e assegnato al Servizio cre<strong>di</strong>ti. Ha<br />
percorso i vari gra<strong>di</strong>ni della carriera fi no a <strong>di</strong>venire responsabile<br />
dello stesso Servizio e a ricoprire, dal gennaio<br />
1998 al 31 <strong>di</strong>cembre 2007, data <strong>di</strong> cessazione dal<br />
Foto Sgual<strong>di</strong>no
apporto <strong>di</strong> lavoro <strong>di</strong>pendente, la prestigiosa carica <strong>di</strong><br />
vice <strong>di</strong>rettore generale. Il dottor Massera ha dato il suo<br />
prezioso apporto all’azienda, in qualità <strong>di</strong> consulente,<br />
anche dopo il pensionamento e fi no al decesso. È venuto<br />
al lavoro per l’ultima volta il 20 gennaio.<br />
Persona riservata, preparata e scrupolosa, ha<br />
svolto le incombenze – e le sue erano delicate e <strong>di</strong> peso<br />
– sempre con correttezza e <strong>di</strong>ligenza.<br />
Era un uomo <strong>di</strong> stile, fi ne nel porsi, gentile con<br />
l’interlocutore, fosse questi collaboratore, cliente e no.<br />
Mai scontroso, mai una parola sopra le righe, mai infasti<strong>di</strong>to<br />
da situazioni, quand’anche spiacevoli, <strong>di</strong>ffi cili:<br />
una persona equilibrata, dabbene.<br />
Il dottor Massera ha lasciato negli stretti familiari<br />
e altri parenti, nel vertice aziendale, nei <strong>di</strong>pendenti della<br />
“<strong>Sondrio</strong>” – e altresì in tutti quelli che lo hanno conosciuto<br />
a vario titolo – un vuoto, uno smarrimento, un<br />
caro ricordo <strong>di</strong> bontà e serietà.<br />
CONFERENZA<br />
DEL PROFESSOR GUIDO TABELLINI<br />
Lecture by Professor Guido Tabellini<br />
Ha aperto il ciclo delle nostre conferenze del 2011<br />
il professor Guido Tabellini, magnifi co rettore dell’Università<br />
Commerciale Luigi Bocconi <strong>di</strong> Milano, alla presenza<br />
<strong>di</strong> un folto u<strong>di</strong>torio. Tema dell’incontro: “Quale futuro per<br />
l’economia in Europa”.<br />
La grave crisi in atto da qualche anno durerà ancora<br />
parecchio e la normalità arriverà non prima <strong>di</strong> otto<strong>di</strong>eci<br />
anni o più. Siamo comunque entrati in una fase <strong>di</strong><br />
ripresa, più marcata (circa il 4%) nei Paesi emergenti,<br />
Il professor<br />
Guido Tabellini<br />
cioè Cina, In<strong>di</strong>a e altri, a seguire gli Stati Uniti, gli Stati<br />
dell’area euro, tra cui, fanalino <strong>di</strong> coda, l’Italia con circa<br />
l’1%. Le nazioni con economie avanzate fanno più fatica<br />
delle altre a rimettersi in cammino, in quanto hanno<br />
sulle spalle debiti sovrani in eccesso.<br />
Le economie emergenti sono un fenomeno epocale,<br />
dovuto a repentina trasformazione storica e destinato<br />
a continuare per qualche decennio, magari (ma non<br />
è detto) con minori performance.<br />
La ripresa potrebbe essere più veloce del previsto.<br />
La Germania è riuscita ad agganciare le recenti opportunità<br />
<strong>di</strong> crescita; non altrettanto – sia pure con delle<br />
eccezioni riconducibili a talune regioni e a qualche impresa<br />
– l’Italia, gravata com’è da un debito sovrano<br />
CRONACHE AZIENDALI 209<br />
Foto Sgual<strong>di</strong>no<br />
Foto Sgual<strong>di</strong>no
elevatissimo, una vera e propria zavorra, i cui effetti<br />
negativi sono tuttavia mitigati dal risparmio elevato<br />
delle famiglie, fenomeno non riscontrabile altrove, molto<br />
salutare per l’economia nazionale e il sistema-Paese.<br />
Negli Usa il settore delle imprese è in buona forma,<br />
con bilanci sani, idonei per investire e accrescere<br />
il lavoro in un momento <strong>di</strong> ripresa, com’è l’attuale e <strong>di</strong><br />
cui si è fatto cenno, una ripresa che però lascerà il<br />
tasso <strong>di</strong> <strong>di</strong>soccupazione invariato. Le Borse tendono a<br />
salire e gli investitori ne sono attratti e sono invogliati a<br />
spostare l’attenzione verso impieghi con più opportunità,<br />
anche se maggiormente rischiosi.<br />
I rischi attuali, come la defl azione, sono <strong>di</strong>minuiti<br />
rispetto a un anno fa. Ci sarà, per contro, maggiore infl<br />
azione, soprattutto nei Paesi emergenti, che, se mantenuta<br />
entro limiti congrui, non sarà dannosa, perché<br />
faciliterà le esportazioni. Tra i rischi per l’area euro, il più<br />
rilevante e che fa perdere fi ducia, è riferito alla presenza<br />
del debito sovrano, la cui entità varia da nazione a nazione;<br />
e tra <strong>di</strong> esse, oltre all’Italia, bisogna ricordare il<br />
Belgio, la Spagna, ma ancor prima la Grecia e l’Irlanda,<br />
Paesi, questi ultimi due, che, a causa <strong>di</strong> una forte crisi<br />
interna, hanno avuto necessità <strong>di</strong> interventi comunitari<br />
sostanziosi. L’Europa non era preparata e ha tentennato<br />
nel prendere le opportune misure, con rischi per<br />
questa intempestività che avrebbero potuto portare<br />
danni incalcolabili a tutte le nazioni dell’area euro.<br />
Ora, con l’esperienza acquisita, si fa l’ipotesi <strong>di</strong><br />
irrobustire l’apposito Fondo, a <strong>di</strong>sposizione delle nazioni<br />
che si venissero a trovare in momentanea <strong>di</strong>ffi coltà. Si<br />
pensa altresì, per tali casi, <strong>di</strong> applicare tassi d’interesse<br />
particolarmente favorevoli.<br />
BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2010<br />
DELLA BANCA POPOLARE DI<br />
SONDRIO (SUISSE) SA<br />
Annual report 2010 of the <strong>Banca</strong> <strong>Popolare</strong> <strong>di</strong> <strong>Sondrio</strong><br />
(Suisse) SA<br />
Il 14 febbraio 2011 ha avuto luogo l’assemblea<br />
annuale della partecipata <strong>Banca</strong> <strong>Popolare</strong> <strong>di</strong><br />
<strong>Sondrio</strong> (SUISSE) SA, che ha approvato il<br />
bilancio dell’esercizio 2010, quin<strong>di</strong>cesimo<br />
dalla fondazione.<br />
210 CRONACHE AZIENDALI<br />
La controllata elvetica si è trovata a lavorare in un<br />
contesto nazionale particolare, con un franco forte e i<br />
conti in or<strong>di</strong>ne, e con una curva dei tassi d’interesse<br />
prossimi allo zero. La perdurante crisi internazionale,<br />
per effetto della globalizzazione, ha infl uito negativamente<br />
anche per la Svizzera, a riguardo del lavoro e<br />
dello sviluppo.<br />
L’utile netto è ammontato a CHF 4.700.780, in<br />
contrazione sull’anno prima del 51,02%, risultato che<br />
non è da ritenersi insod<strong>di</strong>sfacente, in relazione alle criticità<br />
internazionali economico-fi nanziarie, <strong>di</strong> cui si è<br />
fatto cenno, e al perdurare, nella Confederazione,<br />
dell’appiattimento dei tassi. L’utile è stato destinato,<br />
come nei precedenti esercizi, a riserva legale generale,<br />
per cui il patrimonio si è attestato a CHF 227 milioni.<br />
La raccolta <strong>di</strong>retta è ammontata a 2.130 milioni<br />
<strong>di</strong> franchi, più 0,41% sull’anno precedente. Quella complessiva<br />
da clientela ha segnato 4.777 milioni, con un<br />
calo del 5,35%. I cre<strong>di</strong>ti a clientela sono stati <strong>di</strong> CHF<br />
2.513 milioni, più 16,53%, dato importante che <strong>di</strong>mostra<br />
nei fatti la volontà della controllata <strong>di</strong> sostenere le<br />
economie locali.<br />
Il totale <strong>di</strong> bilancio si è assestato a 3.414 milioni<br />
<strong>di</strong> franchi svizzeri, più 18,83%.<br />
La parte culturale della Relazione dell’esercizio<br />
2010 è stata de<strong>di</strong>cata a uno straor<strong>di</strong>nario personaggio<br />
del secolo scorso, un industriale italiano <strong>di</strong> valore<br />
che amava la propria azienda e le persone che vi<br />
operavano, per le quali nutriva particolare attenzione,<br />
anche a scapito del profi tto. Era sostenitore<br />
della cultura e della ricerca, a cui de<strong>di</strong>cava spazio<br />
e denaro. Si tratta dell’ingegner Adriano Olivetti,<br />
fi glio <strong>di</strong> Camillo, fondatore dell’omonima azienda<br />
epore<strong>di</strong>ese, produttrice <strong>di</strong> macchine per scrivere<br />
e da calcolo.<br />
Adriano Olivetti, rifugiatosi in Svizzera<br />
durante il secondo confl itto mon<strong>di</strong>ale, al rientro<br />
in patria prende in mano le re<strong>di</strong>ni dell’azienda<br />
<strong>di</strong> famiglia e la porta a essere fl ori<strong>di</strong>ssima<br />
e famosa in tutto il mondo. Non si può<br />
non menzionare la realizzazione, avvenuta<br />
in quell’epoca, della celeberrima “Lettera<br />
22”, macchina per scrivere portatile <strong>di</strong> grande<br />
successo, <strong>di</strong>venuta il simbolo per antonomasia della<br />
Olivetti. Fu, tra l’altro, la “tastiera” del giornalista Indro<br />
Montanelli, dalla quale non si separò mai.
CONFERENZA<br />
DEL DOTTOR MICHELE FAZIOLI<br />
Lecture by Dr. Michele Fazioli<br />
La sera del 18 febbraio 2011 ha avuto luogo<br />
nella nostra Sala Besta a <strong>Sondrio</strong> la conferenza del<br />
dottor Michele Fazioli, giornalista della RSI – Ra<strong>di</strong>otelevisione<br />
Svizzera <strong>di</strong> lingua Italiana, sul tema “Informazione<br />
in controluce. Bellezze e insi<strong>di</strong>e della rivoluzione<br />
me<strong>di</strong>atica”.<br />
Negli ultimi tempi si è vissuta una rivoluzione<br />
dell’informazione che ha mutato l’uomo, le sue abitu<strong>di</strong>ni.<br />
Nell’antichità il mondo era semplice, non c’era<br />
nulla, le notizie si <strong>di</strong>ffondevano con il passaparola. Poi<br />
è arrivata l’epoca del cinema, degli aerei, della ra<strong>di</strong>o,<br />
della televisione, mezzi particolarmente veloci ed effi caci<br />
per <strong>di</strong>vulgare gli acca<strong>di</strong>menti. Ultimamente si sono<br />
aggiunti i telefoni cellulari e internet, che hanno ancor<br />
più velocizzato il tutto. In cent’anni è avvenuto ciò che<br />
non si è verifi cato in millenni: una rivoluzione me<strong>di</strong>atica<br />
straor<strong>di</strong>naria, che i nostri antenati mai avrebbero potuto<br />
immaginare.<br />
A titolo <strong>di</strong> esempio, nei tempi andati, quando<br />
capitava che morisse o fosse eletto un Papa, ci volevano<br />
giorni, mesi, affi nché se ne venisse a conoscenza.<br />
Oggi si è informati ovunque e subito, e, con altrettanta<br />
velocità, si può assistere a fatti lontani quel che<br />
si vuole, anche all’altro capo del mondo: senza essere<br />
in piazza San Pietro, si può assistere in <strong>di</strong>retta alla<br />
famosa fumata bianca, inequivocabile segnale della<br />
nomina <strong>di</strong> un nuovo Pontefi ce. Altro esempio. La scena<br />
dell’abbattimento delle Torri Gemelle newyorkesi<br />
dell’11 settembre 2001 fu ripresa da telefoni cellulari<br />
e le tragiche immagini si <strong>di</strong>ffusero nel mondo intero in<br />
pochissimi secon<strong>di</strong>.<br />
Tutto questo è positivo, anche se la velocizzazione<br />
porta all’assuefazione, con quanto <strong>di</strong> negativo conse-<br />
Il dottor Michele<br />
Fazioli, giornalista<br />
della<br />
Ra<strong>di</strong>otelevisione<br />
Svizzera <strong>di</strong> lingua<br />
italiana<br />
Dr. Michele Fazioli,<br />
journalist with the<br />
italian-language<br />
Swiss ra<strong>di</strong>o and<br />
television<br />
Il tema<br />
“Informazione in<br />
controluce. Bellezze<br />
e insi<strong>di</strong>e della<br />
rivoluzione<br />
me<strong>di</strong>atica” è stato<br />
particolarmente<br />
gra<strong>di</strong>to dal pubblico<br />
intervenuto<br />
The subject<br />
“Information between<br />
the lines. The beauty<br />
and dangers of the<br />
me<strong>di</strong>a revolution”<br />
was particularly<br />
appreciated by the<br />
au<strong>di</strong>ence<br />
gue, e – altra faccia della medaglia – fa sì che il giornale<br />
quoti<strong>di</strong>ano, un tempo mezzo principe per la <strong>di</strong>ffusione<br />
degli acca<strong>di</strong>menti, sia superato (vecchio) già in prima<br />
mattinata.<br />
Siamo in presenza <strong>di</strong> una concorrenza fors’anche<br />
esagerata da parte dei mezzi <strong>di</strong> comunicazione <strong>di</strong> massa.<br />
Per stare al passo con i tempi e vendere, è necessario<br />
essere veloci nell’acquisire le notizie e nel pubblicarle.<br />
Si sa che la fretta è nemica della ponderazione,<br />
della precisione, della completezza. Bisognerebbe invece<br />
pesare quanto si va a scrivere e non dare nulla per<br />
scontato, ma spiegare i fatti dall’inizio, evidenziandone<br />
le cause, l’evoluzione...<br />
Altra considerazione. La gente vuole il pettegolezzo,<br />
i processi in <strong>di</strong>retta TV, ama il<br />
macabro; e i giornalisti, consapevoli<br />
<strong>di</strong> questo, danno in pasto ai telespettatori,<br />
ai lettori, immagini raccapriccianti<br />
e descrizioni crude, che possono<br />
sconvolgere chi è sensibile, chi è<br />
debole. Ma, come si sente <strong>di</strong>re, non<br />
bisogna perdere telespettatori, il<br />
giornale va venduto in tante copie. E<br />
allora ci si <strong>di</strong>lunga sul male, sul trasgressivo,<br />
sui particolari scabrosi.<br />
Le notizie positive e quelle riguardanti<br />
il bene in genere, che notoriamente<br />
e per fortuna sovrasta <strong>di</strong> gran<br />
lunga il male, <strong>di</strong> solito non incrementano<br />
l’au<strong>di</strong>ence e non fanno piazzare<br />
più copie <strong>di</strong> giornali. Quin<strong>di</strong> se ne<br />
parla, quando lo si fa, con dei brevi<br />
cenni, con dei trafiletti collocati<br />
all’interno del giornale, in posizione<br />
defi lata. Che tutto ruoti attorno al<br />
<strong>di</strong>o denaro è moralmente inaccettabile,<br />
riprovevole.<br />
Foto Sgual<strong>di</strong>no<br />
CRONACHE AZIENDALI 211<br />
Foto Sgual<strong>di</strong>no
ASSEGNATO ALLA BANCA<br />
IL PRESTIGIOSO PREMIO<br />
“CREATORI DI VALORE”<br />
The prestigious “Creators of Value”<br />
prize awarded to the bank<br />
La banca è rimasta aggiu<strong>di</strong>cataria del premio<br />
“Creatori <strong>di</strong> Valore” come “Miglior <strong>Banca</strong> <strong>Popolare</strong>”,<br />
nell’ambito <strong>di</strong> “Milano Finanza Global Awards 2011”.<br />
È un’attestazione <strong>di</strong> rilievo, riservata alle aziende<br />
cre<strong>di</strong>tizie che abbiano realizzato, nell’anno <strong>di</strong> riferimento,<br />
le migliori performance patrimoniali e <strong>di</strong> effi cienza.<br />
Il soggetto da premiare viene selezionato con un<br />
criterio <strong>di</strong> valutazione MF Index, in<strong>di</strong>catore che – così si<br />
legge – «...coniuga <strong>di</strong>mensioni e risultati, con l’obiettivo<br />
<strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare gli istituti che hanno saputo abbinare allo<br />
sviluppo della massa amministrata la capacità <strong>di</strong> fare<br />
cassa e generare profi tti».<br />
Il prestigioso riconoscimento è la <strong>di</strong>mostrazione<br />
delle scelte oculate, operate dalla <strong>Popolare</strong> <strong>di</strong> <strong>Sondrio</strong><br />
anno dopo anno, per effetto delle quali siamo un’azienda<br />
solida e in espansione, e i soci sono in costante<br />
crescita. È pure la comprova che il modo <strong>di</strong> operare dei<br />
<strong>di</strong>pendenti, notoriamente improntato a professionalità,<br />
impegno ed entusiasmo, è effi cace e ripaga.<br />
UNITÀ D’ITALIA. INIZIATIVE<br />
ATTUATE DALLA BANCA<br />
Unity of Italy. The initiatives by the bank<br />
La banca, sensibile agli acca<strong>di</strong>menti<br />
che riguardano l’Italia,<br />
compresi quelli storici, per ricordare<br />
i 150 anni dell’Unità nazionale<br />
ha ritenuto <strong>di</strong> attuare due<br />
iniziative.<br />
La prima ha riguardato l’organizzazione,<br />
attraverso la propria biblioteca<br />
Luigi Credaro, <strong>di</strong> una mostra<br />
intitolata “Le monete e le<br />
medaglie raccontano l’Unità d’Italia”,<br />
con la collaborazione del Circolo<br />
Culturale Filatelico Numismatico<br />
Morbegnese.<br />
L’inaugurazione è avvenuta<br />
l’11 marzo 2011 a Son drio, Lungo<br />
Mallero Armando Diaz n. 18, nei<br />
locali della biblioteca stessa, con entrata libera, e le<br />
visite son potute avvenire dal martedì al sabato, fi no al<br />
30 marzo 2011, data <strong>di</strong> chiusura della mostra.<br />
L’esposizione ha riscosso notevole successo, sia<br />
per l’interesse suscitato dalle monete e dalle medaglie<br />
d’epoca, sia soprat tutto per lo spirito <strong>di</strong> “popolo” con il<br />
quale è stata attuata la manifestazione in un periodo <strong>di</strong><br />
fervore per le celebra zioni dei 150 anni dell’Unità nazionale.<br />
La seconda iniziativa ha riguardato la realizzazione<br />
<strong>di</strong> un elegante cofanetto, donato ai soci intervenuti<br />
in assemblea, contenente tre libri <strong>di</strong> autori della provin-<br />
212 CRONACHE AZIENDALI<br />
Sulla pubblicazione<br />
figura l’autorevole<br />
messaggio del<br />
presidente della<br />
Repubblica Giorgio<br />
Napolitano<br />
Olycom<br />
The authoritative<br />
message of Giorgio<br />
Napolitano, president<br />
of the Republic,<br />
appears on the<br />
publication<br />
Photo Oilime<br />
cia <strong>di</strong> <strong>Sondrio</strong>, libri incentrati sugli acca<strong>di</strong>menti dell’epoca<br />
risorgimentale in Valtellina. L’uno, Sommario delle<br />
vicende politiche della Valtellina dal marzo 1848 a tutto<br />
il 1859, è <strong>di</strong> Antonio Maffei, che fu arciprete <strong>di</strong> <strong>Sondrio</strong>,<br />
storico e intellettuale vissuto nel XIX secolo. L’altro volume,<br />
intitolato Osservazioni sulla con<strong>di</strong>zione presente<br />
della Valtellina, è stato scritto da Luigi Torelli (nato a<br />
Villa <strong>di</strong> Tirano nel 1810, morto a <strong>Sondrio</strong> nel 1887),<br />
patriota, politico, ministro e senatore del Regno. Il<br />
terzo libro è Il Risorgimento e la Valtellina, a cura <strong>di</strong><br />
Franco Monteforte, giornalista, storico e intellettuale<br />
contemporaneo. A completamento<br />
dell’opera, sono<br />
pubblicati un autorevole, significativo<br />
messaggio del<br />
presidente della Repubblica<br />
Giorgio Napolitano e un contributo<br />
del professor Arturo<br />
Colombo, saggista delle<br />
dottrine politiche.<br />
Con quanto attuato, la<br />
<strong>Banca</strong> <strong>Popolare</strong> <strong>di</strong> <strong>Sondrio</strong><br />
ha in teso onorare la Patria,<br />
esaltandone i vantaggi che<br />
lo stare sotto una medesima<br />
ban <strong>di</strong>era comporta nel<br />
cammino, talvolta tortuoso,<br />
della storia e nella <strong>di</strong>fesa<br />
della libertà.
ASSEMBLEA ORDINARIA.<br />
5.200 SOCI (FISICAMENTE PRESENTI<br />
3.300) IL 9 APRILE 2011 HANNO<br />
APPROVATO IL BILANCIO<br />
DELL’ESERCIZIO 2010 (140°)<br />
A LARGHISSIMA MAGGIORANZA<br />
General Shareholders Meeting<br />
5,200 shareholders (3,300 physically present)<br />
on April 9, 2011 approved the 2010 Financial<br />
Statement (the 140th) by a wide majority<br />
Qualche dato riferito all’esercizio 2010<br />
– Raccolta complessiva da clientela € 42.649 milioni,<br />
con un incremento del 10,24%<br />
– Raccolta <strong>di</strong>retta da clientela € 18.967 milioni, con<br />
un aumento dell’8,26%<br />
– Utile netto € 133,3 milioni, meno 30,08%<br />
– Dipendenze n. 290, più 12 rispetto al 2009<br />
Sabato 9 aprile 2011 si è svolta l’assemblea annuale<br />
della banca a Bormio, presso il centro polifunzionale<br />
Pentagono, con inizio dei lavori alle ore 10.30.<br />
È stata prescelta, come avviene da <strong>di</strong>versi anni, la<br />
citta<strong>di</strong>na <strong>di</strong> Bormio, sia perché ci si trova in un suggestivo<br />
centro montano <strong>di</strong> villeggiatura estiva e invernale<br />
particolarmente rinomato per gli sport della neve, ma<br />
non solo, sia perché la struttura del Pentagono si caratterizza<br />
per essere un ambiente accogliente e funzionale,<br />
molto adatto per adunanze con numerosi partecipanti.<br />
Il <strong>di</strong>sagio – soprattutto da parte dei provenienti da fuori<br />
della provincia <strong>di</strong> <strong>Sondrio</strong> –, dovuto al viaggio un po’<br />
I consiglieri<br />
della banca<br />
The bank’s members<br />
of the board<br />
lungo per il raggiungimento della località, è stato tra<br />
l’altro compensato dalla notevole riduzione dei tempi <strong>di</strong><br />
iscrizione ai lavori e dall’adeguata e or<strong>di</strong>nata sistemazione<br />
<strong>di</strong> tutti i soci in sala.<br />
È stato previsto – il che avviene da qualche anno<br />
a questa parte – un effi ciente servizio <strong>di</strong> pullman, risultato<br />
peraltro molto gra<strong>di</strong>to, tant’è che non pochi partecipanti<br />
ne hanno usufruito.<br />
Sono giunti in loco 3.300 soci – la maggior parte<br />
dei quali residenti in zone dove abbiamo sportelli e<br />
nella confi nante Confederazione svizzera –, che hanno<br />
complessivamente espresso, in proprio e per rappresentanza,<br />
5.200 voti.<br />
Alle 10.30 il presidente della banca ha aperto i<br />
lavori, invitando la platea ad alzarsi in pie<strong>di</strong> per la commemorazione<br />
dei soci e amici della banca venuti a<br />
mancare dopo l’assemblea dell’anno scorso. È una<br />
sezione, quella de<strong>di</strong>cata a chi non è più, che invita a<br />
CRONACHE AZIENDALI 213<br />
Paolo Rossi<br />
Paolo Rossi
ifl ettere e, in questo, vengono in soccorso intellettuali<br />
<strong>di</strong> ogni epoca, come per esempio William Shakespeare<br />
che nell’Amleto tra l’altro <strong>di</strong>ce: «Morire per dormire.<br />
Nient’altro. E con quel sonno poter calmare i dolorosi<br />
battiti del cuore, e le mille offese naturali <strong>di</strong> cui è erede<br />
la carne! Quest’è una conclusione da desiderarsi devotamente.<br />
Morire per dormire. Dormire, forse sognare».<br />
Il presidente ha proseguito nella lettura della corposa<br />
relazione, omettendo – con l’unanime consenso<br />
dei soci – taluni pezzi non essenziali, al fi ne <strong>di</strong> velocizzare<br />
il tutto e riservare maggiore spazio agli interventi<br />
fi nali.<br />
È stato sottolineato come il tanto e profi ttevole<br />
lavoro svolto nel 2010 abbia confermato la capacità<br />
della banca <strong>di</strong> avere ritorni sod<strong>di</strong>sfacenti, nonostante la<br />
crisi in atto da tempo a livello internazionale e, giocoforza,<br />
nazionale. Vi sono stati alcuni fattori che hanno<br />
però infl uito negativamente sul risultato dell’utile, a iniziare<br />
dalle minusvalenze dei CCT in portafoglio (in attesa<br />
che giungano a scadenza), in buona parte funzionali<br />
alle operazioni <strong>di</strong> pronti contro termine con la clientela;<br />
dallo sfavorevole andamento dei tassi <strong>di</strong> interesse, con<br />
il costo elevato della provvista per carenza <strong>di</strong> liqui<strong>di</strong>tà<br />
nel sistema; e da altri fattori collegati <strong>di</strong>rettamente o<br />
in<strong>di</strong>rettamente alla congiuntura in atto.<br />
Qualche cifra fotografa la situazione aziendale, riferita<br />
all’esercizio in esame.<br />
L’utile netto <strong>di</strong> esercizio è stato <strong>di</strong> € 133,3 milioni,<br />
meno 30,08% sull’anno prima (va considerato che quello<br />
dell’esercizio precedente fu un utile straor<strong>di</strong>nariamente<br />
elevato, eccezionale, anche per motivi contingenti e<br />
irripetibili), importo che ha consentito <strong>di</strong> sottoporre<br />
all’approvazione dei soci un <strong>di</strong>videndo unitario <strong>di</strong> 0,21<br />
euro.<br />
L’utile netto del bilancio consolidato è ammontato<br />
a 135,1 milioni, meno 32,78%.<br />
Il numero dei soci è aumentato nel 2010 <strong>di</strong> circa<br />
5.300 unità, portandosi a oltre 168.000 (nel primo<br />
scorcio del 2011 la compagine si è ulteriormente elevata).<br />
Il signifi cativo incremento è la <strong>di</strong>mostrazione della<br />
fi ducia accordata alla <strong>Popolare</strong> <strong>di</strong> <strong>Sondrio</strong>, nonostante<br />
la <strong>di</strong>saffezione del pubblico per le borse valori e, in ge-<br />
214 CRONACHE AZIENDALI<br />
Foto Sgual<strong>di</strong>no<br />
nerale, per l’investimento in titoli, causata dalla crisi fi -<br />
nanziaria che è <strong>di</strong>venuta un ritornello e non può non<br />
essere evocata nelle considerazioni. Oggi, ancor più che<br />
in passato, chi investe in titoli lo fa se la società a cui<br />
essi sottostanno dà garanzie in termini <strong>di</strong> soli<strong>di</strong>tà e <strong>di</strong><br />
buona conduzione. Evidentemente le numerose nuove<br />
sottoscrizioni <strong>di</strong> azioni BPS provano che la <strong>Popolare</strong> <strong>di</strong><br />
<strong>Sondrio</strong> rientra in questo para<strong>di</strong>gma e quin<strong>di</strong> rappresentano<br />
un giu<strong>di</strong>zio largamente positivo. La stima per la<br />
“<strong>Sondrio</strong>” è tra l’altro riscontrabile nell’aggiu<strong>di</strong>cazione<br />
alla stessa, da parte <strong>di</strong> MF - Milano Finanza, del prestigioso<br />
premio “Creatori <strong>di</strong> valore” come “Miglior <strong>Banca</strong><br />
<strong>Popolare</strong>” per le ottime performance patrimoniali riconosciute<br />
e per la massima effi cienza. L’apprezzamento è<br />
arrivato anche dal “World Payments - Report 2010”,<br />
dove si rammenta che la nostra istituzione ha saputo<br />
operare con particolare successo, ragione per la quale,<br />
nonostante le contenute <strong>di</strong>mensioni, è entrata a pieno<br />
titolo nel ristretto novero delle banche (perlopiù <strong>di</strong> caratura<br />
internazionale) <strong>di</strong> cui si avvale la Commissione<br />
Europea.<br />
La raccolta <strong>di</strong>retta da clientela ha segnato 18.967<br />
milioni, più 8,26%; quella in<strong>di</strong>retta da clientela si è posizionata<br />
a 23.072 milioni, più 11,76%; e l’assicurativa<br />
è stata <strong>di</strong> 610 milioni, più 16,39%. La raccolta complessiva<br />
da clientela è risultata quin<strong>di</strong> <strong>di</strong> 42.649 milioni,<br />
pari a un aumento percentuale del 10,24.<br />
I cre<strong>di</strong>ti verso clientela si sono attestati a 18.248<br />
milioni, corrispondenti a un incremento sull’anno precedente<br />
del 9,20%, e quelli <strong>di</strong> fi rma hanno sommato<br />
3.421 milioni, più 17,99%. Le attività fi nanziarie, rappresentate<br />
da titoli <strong>di</strong> proprietà e derivati, sono ammontate<br />
a 3.249 milioni, meno 3,13%. Le partecipazioni sono<br />
state <strong>di</strong> 349 milioni, più 138,30% rispetto all’esercizio<br />
2009.<br />
La buona salute della banca si è rivelata anche<br />
nell’espansione territoriale, con l’attivazione <strong>di</strong> ben 12<br />
nuove fi liali. Le località prescelte sono state: Riva del<br />
Garda, Cremona (agenzia n. 1), Erba, Brescia (agenzia<br />
n. 4), Darfo Boario Terme (agenzia n. 2), Chiavari, Seregno<br />
(agenzia n. 1), Ciampino, Rovereto, Corte Franca,<br />
Legnano e Verona. Come si può vedere, nelle aperture<br />
si è seguita la logica <strong>di</strong> rafforzamento delle località già<br />
presi<strong>di</strong>ate e <strong>di</strong> prosecuzione in quelle contigue.<br />
La partecipata più importante è la <strong>Banca</strong> <strong>Popolare</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>Sondrio</strong> (SUISSE) SA <strong>di</strong> Lugano, istituita nel maggio<br />
1995, che, nell’esercizio 2010, ha conseguito un utile<br />
netto <strong>di</strong> CHF 4.700.780, in contrazione sull’anno precedente<br />
del 51,02%. Il dato, a prima vista, si <strong>di</strong>rebbe negativo,<br />
ma, come già detto, così non è: una delle cause<br />
del forte calo è la curva dei tassi d’interesse elvetici<br />
prossimi allo zero. Le altre “poste” sono risultate buone,<br />
secondo le aspettative. Il totale <strong>di</strong> bilancio ha cifrato<br />
3.414 milioni <strong>di</strong> franchi svizzeri, con un incremento<br />
sull’esercizio 2009 pari al 18,83%.<br />
Giova ricordare, tra le partecipate, anche Factorit<br />
Spa, il cui controllo è stato assunto dalla banca il 29<br />
luglio 2010. Questa società ha una posizione <strong>di</strong> spicco<br />
nel mercato nazionale della cosiddetta “fattorizzazione”<br />
ed è uno strumento molto valido per il conseguimento
<strong>di</strong> sinergie. L’esercizio 2010 si è chiuso con un utile <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>eci milioni <strong>di</strong> euro.<br />
Letta la corposa relazione, che è stata seguita con<br />
generale attenzione dalla vasta platea, si è aperto un<br />
ampio <strong>di</strong>battito sul bilancio, sulle cifre, sulla situazione<br />
in genere. Sono state avanzate idee e proposte, sono<br />
stati posti <strong>di</strong>versi quesiti. Al tutto è stato risposto puntualmente<br />
ed esaurientemente.<br />
Giunti al momento delle votazioni, il bilancio è<br />
stato approvato a larghissima maggioranza.<br />
Foto Sgual<strong>di</strong>no<br />
Il presidente Piero<br />
Melazzini e il<br />
<strong>di</strong>rettore generale<br />
Mario Alberto<br />
Pedranzini<br />
The Chairman Piero<br />
Melazzini and<br />
General Manager<br />
Mario Alberto<br />
Pedranzini<br />
3.300 soci<br />
al “Pentagono”<br />
3,300 shareholders<br />
at the “Pentagono”<br />
Cariche sociali<br />
Sono risultati rieletti, per il triennio 2011-2013, i<br />
consiglieri in scadenza <strong>di</strong> mandato signori cavaliere del<br />
lavoro ragionier Piero Melazzini, cavaliere ragionier Gianluigi<br />
Bonisolo, dottor professor Miles Emilio Negri, dottor<br />
Lino Enrico Stoppani e dottor professor Paolo Biglioli.<br />
Al termine dell’assemblea, si è tenuto un Consiglio<br />
<strong>di</strong> amministrazione il quale, tra l’altro, ha confermato<br />
nella carica, per il triennio 2011-2013, il presidente e il<br />
vicepresidente in scadenza <strong>di</strong> mandato, cioè, rispettivamente,<br />
il cavaliere del lavoro ragionier Piero Melazzini e<br />
il dottor professor Miles Emilio Negri.<br />
Donato ai soci l’elegante cofanetto “Il Risorgimento e<br />
la Valtellina”<br />
È consuetu<strong>di</strong>ne della banca, al termine dei lavori<br />
assembleari, fare un presente a tutti i soci convenuti,<br />
in segno <strong>di</strong> riconoscenza per la vicinanza, l’attenzione e<br />
l’amicizia.<br />
Quest’anno il dono è consistito in un elegante cofanetto<br />
dal titolo “Il Risorgimento e la Valtellina”, includente<br />
tre libri che richiamano il periodo risorgimentale in<br />
provincia <strong>di</strong> <strong>Sondrio</strong>. L’opera è autorevolmente impreziosita<br />
da un elevato messaggio del presidente della Repubblica<br />
Giorgio Napolitano. Della singolare realizzazione<br />
si <strong>di</strong>ce più compiutamente in altro punto della presente<br />
rubrica, de<strong>di</strong>cato specifi camente alle iniziative della<br />
banca per ricordare i 150 anni dell’Unità nazionale.<br />
CRONACHE AZIENDALI 215<br />
Paolo Rossi
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE<br />
BANCA POPOLARE DI SONDRIO<br />
Società cooperativa per azioni - Fondata nel 1871<br />
Iscritta al Registro delle Imprese <strong>di</strong> <strong>Sondrio</strong> al n. 00053810149<br />
Iscritta all’Albo delle Banche al n. 842<br />
Iscritta all’Albo delle Società Cooperative al n. A160536<br />
Capogruppo del Gruppo bancario <strong>Banca</strong> <strong>Popolare</strong> <strong>di</strong> <strong>Sondrio</strong>,<br />
iscritto all’Albo dei Gruppi bancari al n. 5696.0<br />
Aderente al Fondo Interbancario <strong>di</strong> Tutela dei Depositi<br />
Co<strong>di</strong>ce Fiscale e Partita IVA: 00053810149<br />
Al 31 <strong>di</strong>cembre 2010 Capitale sociale: € 924.443.955<br />
Riserve: € 733.175.003<br />
DIREZIONE GENERALE E SEDE CENTRALE<br />
<strong>Sondrio</strong>, piazza Giuseppe Garibal<strong>di</strong> 16<br />
tel. 0342 528111 - fax 0342 528204<br />
www.popso.it - info@popso.it<br />
SERVIZI DISTACCATI<br />
ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI:<br />
Centro Servizi “F. Morani” - via Ranée 511/1<br />
Berbenno <strong>di</strong> Valtellina (So) - fraz. San Pietro<br />
INTERNAZIONALE: lungo Mallero Luigi Cadorna 24, <strong>Sondrio</strong><br />
COMMERCIALE, ENTI E TESORERIE, ECONOMATO, TECNICO,<br />
PREVENZIONE E SICUREZZA: corso Vittorio Veneto 7, <strong>Sondrio</strong><br />
SPORTELLI<br />
PROVINCIA DI SONDRIO<br />
ALBOSAGGIA via al Porto 11 tel. 0342 512178<br />
APRICA corso Roma 140 tel. 0342 746098<br />
ARDENNO via Libertà tel. 0342 660440<br />
BERBENNO DI VALTELLINA - fraz. San Pietro<br />
via Nazionale Ovest 84<br />
BORMIO via Roma 131<br />
tel. 0342 492115<br />
- ang. via don Evaristo Pecce<strong>di</strong> tel. 0342 910019<br />
BORMIO: Agenzia n. 1, Via Roma 64 tel. 0342 913071<br />
CAMPODOLCINO via Corti 67 tel. 0343 50544<br />
CEPINA VALDISOTTO via Roma 13/E<br />
CHIAVENNA<br />
tel. 0342 951103<br />
via Francesco e Giovanni Dolzino 67 tel. 0343 32202<br />
CHIESA IN VALMALENCO via Roma 138 tel. 0342 451141<br />
CHIURO via Stelvio 8 tel. 0342 483957<br />
COLORINA via Roma 84<br />
COSIO VALTELLINO - fraz Regoledo<br />
tel. 0342 598074<br />
via Roma 7 tel. 0342 638053<br />
DELEBIO piazza San Carpoforo 7/9 tel. 0342 696032<br />
DUBINO via Spluga 83 tel. 0342 687440<br />
GORDONA via Scogli 9 tel. 0343 42389<br />
GROSIO via Roma 67 tel. 0342 848063<br />
GROSOTTO via Statale 73<br />
ISOLACCIA VALDIDENTRO<br />
tel. 0342 887001<br />
via Nazionale 31 tel. 0342 921303<br />
LANZADA via Palù 388 tel. 0342 454021<br />
LIVIGNO via Sant’Antoni 135 tel. 0342 996192<br />
LIVIGNO: Agenzia n. 1, via Saroch 160 tel. 0342 997656<br />
MADESIMO via Giosuè Carducci 3 tel. 0343 56019<br />
MADONNA DI TIRANO piazza Basilica 55 tel. 0342 702552<br />
MAZZO DI VALTELLINA<br />
via Santo Stefano 18<br />
MONTAGNA IN VALTELLINA<br />
tel. 0342 860090<br />
via Stelvio 336 tel. 0342 210345<br />
MORBEGNO piazza Caduti per la Libertà 7 tel. 0342 613257<br />
MORBEGNO:<br />
Agenzia n. 1, via V Alpini 172 tel. 0342 615040<br />
NOVATE MEZZOLA via Roma 13 tel. 0343 63001<br />
PASSO DELLO STELVIO tel. 0342 904534<br />
PIANTEDO via Colico 43<br />
PONTE IN VALTELLINA<br />
tel. 0342 683140<br />
piazza della Vittoria 1 tel. 0342 482201<br />
SAMOLACO - fraz. Era, via Trivulzia 28<br />
SAN CASSIANO VALCHIAVENNA<br />
tel. 0343 38165<br />
via Spluga 108 tel. 0343 20252<br />
SAN NICOLÒ VALFURVA via San Nicolò 96 tel. 0342 946001<br />
SEMOGO VALDIDENTRO<br />
via Cima Piazzi 28 tel. 0342 921233<br />
SONDALO via Dr. Ausonio Zubiani 2<br />
SONDRIO<br />
tel. 0342 801150<br />
Sede, piazza Giuseppe Garibal<strong>di</strong> 16 tel. 0342 528111<br />
Agenzia n. 1, via Bernina 1 tel. 0342 210949<br />
Agenzia n. 2, via Tomaso Nani 32<br />
Agenzia n. 3,<br />
tel. 0342 210152<br />
Ingresso Ospedale Civile - via Stelvio 25 tel. 0342 216071<br />
Agenzia n. 4,<br />
piazzale Giovanni Bertacchi 57 tel. 0342 567256<br />
Agenzia n. 5, Galleria Campello 2 tel. 0342 212517<br />
Agenzia n. 6, via Giacinto Sertorelli 2 tel. 0342 510191<br />
TALAMONA via Don Giuseppe Cusini 83/A tel. 0342 670722<br />
TEGLIO piazza Santa Eufemia 2 tel. 0342 781301<br />
TIRANO piazza Cavour 20 tel. 0342 702533<br />
TRAONA via Valeriana 88/A tel. 0342 653171<br />
TRESENDA DI TEGLIO via Nazionale 57 tel. 0342 735300<br />
VILLA DI CHIAVENNA via Roma 38 tel. 0343 40490<br />
VILLA DI TIRANO traversa Foppa 25 tel. 0342 701145<br />
PROVINCIA DI BERGAMO<br />
ALBANO SANT’ALESSANDRO<br />
via Vittorio Emanuele II 6<br />
BERGAMO<br />
tel. 035 4521158<br />
Sede, via Broseta 64/B tel. 035 4370111<br />
Agenzia n. 1, via Vittore Ghislan<strong>di</strong> 4<br />
BONATE SOTTO via Vittorio Veneto<br />
tel. 035 234075<br />
- ang. via Antonio Locatelli tel. 035 995989<br />
CARVICO via Giuseppe Ver<strong>di</strong> 1<br />
CISANO BERGAMASCO<br />
tel. 035 790952<br />
via Giuseppe Mazzini 25 tel. 035 787615<br />
GAZZANIGA via IV Novembre 3 tel. 035 712034<br />
GRUMELLO DEL MONTE via Roma 133 tel. 035 833583<br />
OSIO SOTTO via Monte Grappa 12 tel. 035 881844<br />
ROMANO DI LOMBARDIA via Balilla 20 tel. 0363 903658<br />
SARNICO via Giuseppe Garibal<strong>di</strong> 1/C tel. 035 912638<br />
TREVIGLIO via Cesare Battisti 8/B<br />
PROVINCIA DI BOLZANO<br />
BOLZANO viale Amedeo Duca d’Aosta 88<br />
tel. 0363 309468<br />
Amedeo Duca D’Aosta Allee 88<br />
MERANO corso della Libertà 16<br />
tel. 0471 402400<br />
Freiheitsstrasse 16<br />
PROVINCIA DI BRESCIA<br />
tel. 0473 239895<br />
BERZO DEMO via Nazionale 14 tel. 0364 630328<br />
BIENNO via Giuseppe Fantoni 36 tel. 0364 300558<br />
BRENO piazza Generale Pietro Ronchi 4<br />
BRESCIA<br />
tel. 0364 320892<br />
Sede, via Benedetto Croce 22 tel. 030 29114111<br />
Agenzia n. 1, via Crocifissa <strong>di</strong> Rosa 59 tel. 030 3700976<br />
Agenzia n. 2, via Solferino 61 tel. 030 3775500<br />
Agenzia n. 3, viale Piave 61/A tel. 030 364779<br />
Agenzia n. 4, via Fratelli Ugoni 2 tel. 030 2807178<br />
COCCAGLIO via Adelchi Negri 12 tel. 030 7703857<br />
COLLEBEATO via San Francesco d’Assisi 12 tel. 030 2511988<br />
CORTE FRANCA via Sera<strong>di</strong>na 7<br />
DARFO BOARIO TERME<br />
tel. 030 9884307<br />
Agenzia n. 1, corso Italia 10/12 tel. 0364 536315<br />
Agenzia n. 2, piazza Patrioti 2<br />
DESENZANO DEL GARDA<br />
tel. 0364 799810<br />
via Guglielmo Marconi 1/A tel. 030 9158556<br />
EDOLO piazza Martiri della Libertà 16<br />
GARDONE VAL TROMPIA<br />
tel. 0364 770088<br />
via Giacomo Matteotti 300 tel. 030 8913039<br />
ISEO via Roma 12/E<br />
LONATO DEL GARDA<br />
tel. 030 980585<br />
corso Giuseppe Garibal<strong>di</strong> 59<br />
LUMEZZANE - fraz. Sant’Apollonio<br />
tel. 030 9131040<br />
via Massimo D’Azeglio 108 tel. 030 8925236<br />
MANERBIO via Dante Alighieri 8<br />
MONTICHIARI via Mantova<br />
tel. 030 9381117<br />
- ang. via 3 Innocenti 74 tel. 030 9650703<br />
ORZINUOVI piazza Giuseppe Garibal<strong>di</strong> 19 tel. 030 9941518<br />
OSPITALETTO via Brescia 107/109 tel. 030 643205<br />
PALAZZOLO SULL’OGLIO via Brescia 23 tel. 030 7400777<br />
PISOGNE via Trento 1 tel. 0364 880290<br />
PONTE DI LEGNO piazzale Europa 8 tel. 0364 900714<br />
SALE MARASINO via Roma 33/35 tel. 030 9820868<br />
SALÒ viale Alcide De Gasperi 13<br />
TOSCOLANO MADERNO<br />
tel. 0365 522974<br />
piazza San Marco 51<br />
PROVINCIA DI COMO<br />
tel. 0365 548426<br />
APPIANO GENTILE piazza della Libertà 9 tel. 031 934571<br />
AROSIO piazza Montello 1 tel. 031 763730<br />
BELLAGIO via Valassina 58 tel. 031 952177<br />
BREGNANO via Giuseppe Mazzini 22/A tel. 031 774163<br />
BULGAROGRASSO via Pietro Ferloni 2 tel. 031 891834<br />
CAMPIONE D’ITALIA piazza Roma 1/G tel. 0041 91 6401020<br />
CANTÙ via Milano 47 tel. 031 3517049<br />
CANZO via Alessandro Verza 39<br />
CARIMATE - fraz. Montesolaro<br />
tel. 031 681252<br />
piazza Lorenzo Spallino tel. 031 726061<br />
CARLAZZO via Regina 125<br />
COMO<br />
tel. 0344 74996/89<br />
Sede, viale Innocenzo XI 71 tel. 031 2769111<br />
Agenzia n. 1, via Giorgio Giulini 12<br />
Agenzia n. 2,<br />
tel. 031 260211<br />
via Statale per Lecco 70 - fraz. Lora<br />
Agenzia n. 3,<br />
tel. 031 555061<br />
via Asiago 25 - fraz. Tavernola<br />
Agenzia n. 4,<br />
tel. 031 513930<br />
c/o ACSM - via Vittorio Emanuele II 93 tel. 031 242542<br />
DOMASO via Statale Regina 77 tel. 0344 85170<br />
DONGO piazza Virgilio Matteri 14 tel. 0344 81206<br />
ERBA via Alessandro Volta 3<br />
FINO MORNASCO via Giuseppe Garibal<strong>di</strong><br />
tel. 031 4472070<br />
- ang. piazza Odescalchi 5 tel. 031 880795<br />
GARZENO via Roma 32 tel. 0344 88646<br />
GERA LARIO via Statale Regina 14 tel. 0344 84380<br />
GRAVEDONA via Dante Alighieri 20 tel. 0344 499000<br />
GUANZATE via Giuseppe Garibal<strong>di</strong> 1 tel. 031 3529036<br />
LURAGO D’ERBA via Roma 58 tel. 031 698367<br />
MENAGGIO<br />
via Annetta e Celestino Lusar<strong>di</strong> 62 tel. 0344 34128<br />
MERONE via San Girolamo Emiliani 5/C tel. 031 650817<br />
MONTORFANO via Brianza 6/B tel. 031 200859<br />
SALA COMACINA via Statale 14/A tel. 0344 57056<br />
SAN FEDELE INTELVI via Provinciale 79 tel. 031 831944<br />
SAN SIRO<br />
loc. Santa Maria - via Statale Regina tel. 0344 50425<br />
VILLA GUARDIA<br />
via Varesina - ang. via Monte Rosa tel. 031 483200<br />
PROVINCIA DI CREMONA<br />
CREMA via Giuseppe Mazzini 109 tel. 0373 80882<br />
CREMONA<br />
Sede, via Dante Alighieri 149/A tel. 0372 416030<br />
Agenzia n. 1, piazza Antonio Stra<strong>di</strong>vari 9 tel. 0372 1809100<br />
PANDINO via Umberto I 1/3 tel. 0373 91016<br />
RIVOLTA D’ADDA via Cesare Battisti 8 tel. 0363 370661<br />
PROVINCIA DI GENOVA<br />
CHIAVARI<br />
piazza Nostra Signora dell’Orto 42/B<br />
- ang. via Doria tel. 0185 1878300<br />
GENOVA via XXV Aprile 7 tel. 010 5535127<br />
PROVINCIA DI LECCO<br />
ABBADIA LARIANA via Nazionale 140/A tel. 0341 701402<br />
BOSISIO PARINI via San Gaetano 4 tel. 031 866865<br />
CALOLZIOCORTE corso Europa 71/A tel. 0341 643184<br />
CASATENOVO via Roma 23 tel. 039 9207454<br />
COLICO via Nazionale - ang. via Sacco tel. 0341 941260<br />
DERVIO via Don Ambrogio Invernizzi 2 tel. 0341 804447<br />
LECCO<br />
Sede, corso Martiri della Liberazione 65 tel. 0341 471111<br />
Agenzia n. 1, viale Filippo Turati 59 tel. 0341 361919<br />
Agenzia n. 2, piazza XX Settembre 11 tel. 0341 282520<br />
Agenzia n. 3,<br />
corso Emanuele Filiberto 104 tel. 0341 422748<br />
Agenzia n. 4, viale Montegrappa 18 tel. 0341 495608<br />
LOMAGNA via Milano 24 tel. 039 9278080<br />
MANDELLO DEL LARIO<br />
piazza Sacro Cuore 8 tel. 0341 732878<br />
MERATE via Don Cesare Cazzaniga 5 tel. 039 5983013<br />
NIBIONNO - fraz. Cibrone,via Montello 1 tel. 031 692045<br />
OGGIONO via Papa Giovanni XXIII 45 tel. 0341 263061<br />
PESCATE via Roma 98/E tel. 0341 283964<br />
PRIMALUNA via Provinciale 66 tel. 0341 981151<br />
VALMADRERA via San Rocco 31/33 tel. 0341 582972<br />
VARENNA via Corrado Venini 53 tel. 0341 815239<br />
PROVINCIA DI LODI<br />
CODOGNO via Giuseppe Ver<strong>di</strong> 18/C tel. 0377 436381<br />
LODI via Francesco Gabba 5 tel. 0371 421436<br />
PROVINCIA DI MANTOVA<br />
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE<br />
piazza Ugo Dallò 25 tel. 0376 672306<br />
MANTOVA<br />
Sede, corso Vittorio Emanuele II 154 tel. 0376 326095<br />
Agenzia n. 1, piazza Broletto 7 tel. 0376 288139<br />
SUZZARA piazza Giuseppe Garibal<strong>di</strong> 4 tel. 0376 508465<br />
VIADANA piazza Giacomo Matteotti 4/A tel. 0375 780877<br />
PROVINCIA DI MILANO<br />
BUCCINASCO via Aldo Moro 9 tel. 02 45716239<br />
CINISELLO BALSAMO<br />
via Giuseppe Garibal<strong>di</strong> 86 tel. 02 66047602<br />
LEGNANO corso Giuseppe Garibal<strong>di</strong> 71 tel. 0331 470255<br />
MILANO<br />
Sede, via Santa Maria Fulcorina 1 tel. 02 85541<br />
Agenzia n. 1, Porpora,<br />
via Nicola Antonio Porpora 104 tel. 02 70630941<br />
Agenzia n. 2, Barona, viale Faenza 22 tel. 02 8911115<br />
Agenzia n. 3, a2a, corso <strong>di</strong> Porta Vittoria 4 tel. 02 76005333<br />
Agenzia n. 4, Regione Lombar<strong>di</strong>a,<br />
via Torquato Taramelli 20 tel. 02 603238<br />
Agenzia n. 5, Bovisa, via degli Imbriani 54 tel. 02 39311498<br />
Agenzia n. 6, Corvetto,<br />
via Marco d’Agrate 11 tel. 02 55212294<br />
Agenzia n. 7, Caneva,<br />
via Monte Cenisio 50 tel. 02 33606260<br />
Agenzia n. 8, Quarto Oggiaro,<br />
via Michele Lessona - ang. via Trilussa 2 tel. 02 39001760<br />
Agenzia n. 9, c/o A.L.E.R.,<br />
viale Romagna 24 tel. 02 70128148<br />
Agenzia n. 10, Solari, via Andrea Solari 15 tel. 02 89404235<br />
Agenzia n. 11, Università Bocconi,<br />
via Fer<strong>di</strong>nando Bocconi 8 tel. 02 58301984<br />
Agenzia n. 12, Baggio,<br />
via delle Forze Armate 260 tel. 02 48915910<br />
Agenzia n. 13, Repubblica,<br />
viale Monte Santo 8 tel. 02 29003075<br />
Agenzia n. 14, Palazzo <strong>di</strong> Giustizia,<br />
via Cesare Battisti 1 tel. 02 76390159
Agenzia n. 15, Murat,<br />
via Gioacchino Murat 76 tel. 02 6682823<br />
Agenzia n. 16, Ortomercato,<br />
via Cesare Lombroso 54 tel. 02 5453131<br />
Agenzia n. 17, Pirelli/Bicocca,<br />
viale Sarca 226 - stabile n. 143 tel. 02 6438400<br />
Agenzia n. 18, Fiera, viale Ezio Belisario 1 tel. 02 43995155<br />
Agenzia n. 19, Giambellino,<br />
via Giambellino 39 tel. 02 428047<br />
Agenzia n. 20, Sempione,<br />
via Antonio Canova 39 tel. 02 33614132<br />
Agenzia n. 21, Politecnico,<br />
via Edoardo Bonar<strong>di</strong> 4 tel. 02 23993307<br />
Agenzia n. 22, Santa Sofia,<br />
via Santa Sofia 12 tel. 02 58307969<br />
Agenzia n. 23, Certosa, viale Certosa 62 tel. 02 3925445<br />
Agenzia n. 24, Piave, viale Piave 1 tel. 02 76028194<br />
Agenzia n. 25, Zara, viale Zara 13 tel. 02 66823609<br />
Agenzia n. 26, Lo<strong>di</strong>,<br />
corso Lo<strong>di</strong> - ang. via S. Gerolamo Emiliani 1 tel. 02 55019186<br />
Agenzia n. 27, Don Gnocchi,<br />
via Alfonso Capecelatro 66 tel. 02 48714408<br />
Agenzia n. 28, Corsica,<br />
via privata Sanremo - ang. viale Corsica 81 tel. 02 70006638<br />
Agenzia n. 29, Bicocca,<br />
piazza della Trivulziana 6 - e<strong>di</strong>ficio 6 tel. 02 66107314<br />
Agenzia n. 30, De Angeli,<br />
piazza Ernesto De Angeli 9 tel. 02 48029994<br />
Agenzia n. 31, Isola, via Carlo Farini 47 tel. 02 66809662<br />
PERO via Mario Greppi 13 tel. 02 33912478<br />
SEGRATE via Rodolfo Moran<strong>di</strong> 25 tel. 02 26921747<br />
SESTO SAN GIOVANNI Agenzia n. 1,<br />
piazza Martiri <strong>di</strong> via Fani 93 tel. 02 24417034<br />
SESTO SAN GIOVANNI Agenzia n. 2,<br />
piazza della Resistenza 52 tel. 02 24839443<br />
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA<br />
ALBIATE via Trento 35 tel. 0362 930277<br />
BERNAREGGIO<br />
via Michelangelo Buonarroti 6 tel. 039 6093934<br />
BOVISIO MASCIAGO<br />
via Guglielmo Marconi 7/A tel. 0362 559006<br />
CARATE BRIANZA via Francesco Cusani 10 tel. 0362 901072<br />
DESIO via Portichetto - ang. via Pio XI tel. 0362 301573<br />
GIUSSANO via Cavour 19 tel. 0362 852171<br />
LISSONE via Trieste 33 tel. 039 2456568<br />
MEDA via Yuri Gagarin<br />
- ang. corso della Resistenza tel. 0362 347832<br />
MONZA<br />
Sede, via Galileo Galilei 1 tel. 039 28285111<br />
Agenzia n. 1,<br />
via Alessandro Manzoni 33/A tel. 039 3902553<br />
NOVA MILANESE via Antonio Locatelli tel. 0362 451559<br />
SEREGNO<br />
Sede, via Cavour 84 tel. 0362 26521<br />
Agenzia n. 1, via Cesare Formenti 5 tel. 0362 26521<br />
SEVESO via San Martino 22 tel. 0362 640129<br />
VAREDO corso Vittorio Emanuele II 53 tel. 0362 544035<br />
VILLASANTA - fraz. San Fiorano<br />
via Amatore Antonio Sciesa 7/9 tel. 039 2051581<br />
VIMERCATE piazza Papa Giovanni Paolo II 9 tel. 039 6084991<br />
PROVINCIA DI NOVARA<br />
ARONA via Antonio Gramsci 19 tel. 0322 231958<br />
NOVARA via Andrea Costa 7 tel. 0321 442113<br />
PROVINCIA DI PARMA<br />
PARMA viale Mentana 91/A tel. 0521 386695<br />
PROVINCIA DI PAVIA<br />
BRONI via Giuseppe Mazzini 1 tel. 0385 250654<br />
CASTEGGIO piazza Cavour 4 tel. 0383 892968<br />
MORTARA via Roma 23 tel. 0384 295744<br />
PAVIA<br />
Sede, piazzale Ponte Coperto Ticino 11 tel. 0382 301759<br />
Agenzia n. 1, corso Strada Nuova 75 tel. 0382 539815<br />
VIGEVANO piazza IV Novembre 8 tel. 0381 692684<br />
VOGHERA via Emilia 70 tel. 0383 369046<br />
PROVINCIA DI PIACENZA<br />
PIACENZA<br />
Sede, via Raimondo Palmerio 11 tel. 0523 320179<br />
Agenzia n. 1, via Cristoforo Colombo 18 tel. 0523 616601<br />
PROVINCIA DI ROMA<br />
CIAMPINO viale del Lavoro 56 tel. 06 7919035<br />
FRASCATI via Benedetto Cairoli 1 tel. 06 9417071<br />
GENZANO DI ROMA<br />
via Giacomo Matteotti 14 tel. 06 93953195<br />
GROTTAFERRATA via XXV Luglio tel. 06 9412168<br />
ROMA<br />
Sede, Eur, viale Cesare Pavese 336 tel. 06 5099731<br />
Agenzia n. 1, Monte Sacro,<br />
viale Val Padana 2 tel. 06 8863213<br />
Agenzia n. 2, Ponte Marconi,<br />
via Silvestro Gherar<strong>di</strong> 45 tel. 06 5573685<br />
Agenzia n. 3, Prati Trionfale,<br />
via Trionfale 22 tel. 06 39742382<br />
Agenzia n. 4, Bravetta,<br />
piazza Biagio Pace 1 tel. 06 66165408<br />
Agenzia n. 5, Portonaccio,<br />
piazza S. Maria Consolatrice 16/B tel. 06 4394001<br />
Agenzia n. 6, Appio Latino,<br />
via Cesare Baronio 12 tel. 06 78347500<br />
Agenzia n. 7, Aurelio,<br />
viale <strong>di</strong> Valle Aurelia 59 tel. 06 39749875<br />
Agenzia n. 8, Africano Vescovio,<br />
viale Somalia 255 tel. 06 86207268<br />
Agenzia n. 9, Casal Palocco,<br />
piazzale Filippo il Macedone 70/75 tel. 06 50930508<br />
Agenzia n. 10, Laurentina,<br />
via Laurentina 617/619 tel. 06 5921466<br />
Agenzia n. 11, Esquilino,<br />
via Carlo Alberto 6/A tel. 06 444801<br />
Agenzia n. 12, Boccea,<br />
circonvallazione Cornelia 295 tel. 06 66017239<br />
Agenzia n. 13, Tuscolano,<br />
via Foligno 51/A tel. 06 70305677<br />
Agenzia n. 14, Garbatella,<br />
largo delle Sette Chiese 6 tel. 06 5136727<br />
Agenzia n. 15, Farnesina,<br />
via della Farnesina 154 tel. 06 36301544<br />
Agenzia n. 16, Nomentana/Monte Sacro Alto,<br />
via Nomentana 925/A tel. 06 8277629<br />
Agenzia n. 17, San Lorenzo,<br />
piazza dei Sanniti 10/11 tel. 06 4465490<br />
Agenzia n. 18, Infernetto,<br />
via Ermanno Wolf Ferrari 348 tel. 06 50918143<br />
Agenzia n. 19, Nuovo Salario,<br />
piazza Filattiera 24 tel. 06 88643496<br />
Agenzia n. 20, Tuscolano/Appio Clau<strong>di</strong>o,<br />
via Caio Canuleio 29 tel. 06 71077105<br />
Agenzia n. 21, Piazza Bologna,<br />
via Famiano Nar<strong>di</strong>ni 25 tel. 06 86202734<br />
Agenzia n. 22, c/o World Food Programme - Sportello Interno -,<br />
via Cesare Giulio Viola 31 tel. 06 65192014<br />
Agenzia n. 23, Lido <strong>di</strong> Ostia,<br />
via Carlo Del Greco 1 tel. 06 56368510<br />
Agenzia n. 24, San Giovanni/Colosseo,<br />
via <strong>di</strong> S. Giovanni in Laterano 51/A tel. 06 70495943<br />
Agenzia n. 25, Parioli,<br />
viale dei Parioli 39/B tel. 06 8088899<br />
Agenzia n. 26, Tritone,<br />
via del Tritone 207 tel. 06 69797092<br />
Agenzia n. 27, Prati, piazza Cavour 7 tel. 06 6878020<br />
Agenzia n. 28, Casilino,<br />
piazza della Marranella 9 tel. 06 24400032<br />
Agenzia n. 29, c/o FAO - Sportello Interno -,<br />
viale delle Terme <strong>di</strong> Caracalla 1 tel. 06 5741006<br />
Agenzia n. 30, c/o IFAD - Sportello Interno -,<br />
via Paolo Di Dono 44 tel. 06 51530238<br />
Agenzia n. 31, c/o Campus Bio-Me<strong>di</strong>co <strong>di</strong> Roma - Policlinico,<br />
via Alvaro Del Portillo 200 tel. 06 5061954<br />
Agenzia n. 32, Monteverde Vecchio,<br />
via Anton Giulio Barrili 50/H tel. 06 58303646<br />
PROVINCIA DI TORINO<br />
TORINO via XX Settembre 5 tel. 011 5178754<br />
PROVINCIA DI TRENTO<br />
CLES piazza Navarrino 5 tel. 0463 420301<br />
RIVA DEL GARDA viale Dante Alighieri 11 tel. 0464 567425<br />
ROVERETO corso Antonio Rosmini 68<br />
- ang. via Fontana tel. 0464 900000<br />
TRENTO piazza <strong>di</strong> Centa 14 tel. 0461 421645<br />
PROVINCIA DI VARESE<br />
AEROPORTO DI MALPENSA 2000<br />
Terminal 1 - FERNO tel. 02 58580083<br />
BISUSCHIO via Giuseppe Mazzini 80 tel. 0332 474991<br />
BUSTO ARSIZIO piazza Trento e Trieste 10 tel. 0331 632394<br />
CARNAGO via Guglielmo Marconi 2 tel. 0331 993137<br />
CASTELLANZA corso Giacomo Matteotti 2 tel. 0331 502934<br />
GALLARATE via Torino 15 tel. 0331 784793<br />
GAVIRATE via Guglielmo Marconi 13/A tel. 0332 732429<br />
LAVENA PONTE TRESA<br />
via Luigi Colombo 19 tel. 0332 523378<br />
LUINO via XXV Aprile 31 tel. 0332 511963<br />
MARCHIROLO<br />
via Cavalier Emilio Busetti 7/A tel. 0332 997395<br />
SOLBIATE OLONA via Vittorio Veneto 5 tel. 0331 376736<br />
SOMMA LOMBARDO via Milano 13 tel. 0331 254973<br />
<strong>Banca</strong> <strong>Popolare</strong> <strong>di</strong> <strong>Sondrio</strong><br />
VARESE<br />
Sede, viale Belforte 151 tel. 0332 336022<br />
Agenzia n. 1, piazza Monte Grappa 6 tel. 0332 242103<br />
Agenzia n. 2,<br />
via San Giusto - ang. via Malta tel. 0332 238149<br />
PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA<br />
CANNOBIO viale Vittorio Veneto 2/bis tel. 0323 739787<br />
GRAVELLONA TOCE<br />
corso Guglielmo Marconi 95 tel. 0323 840673<br />
VERBANIA - Intra<br />
piazza Daniele Ranzoni 27 tel. 0323 408064<br />
VERBANIA - Pallanza<br />
largo Vittorio Tonolli 34 tel. 0323 502198<br />
PROVINCIA DI VERONA<br />
PESCHIERA DEL GARDA via Venezia 40/A tel. 045 7552711<br />
VERONA corso Cavour 45 tel. 045 8036436<br />
REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA<br />
AOSTA corso Battaglione Aosta 79 tel. 0165 065150<br />
SPORTELLO TEMPORANEO<br />
NUOVO POLO FIERISTICO - Corso Italia Est<br />
Strada Statale del Sempione 38 - Rho/Pero tel. 02 4812910/815<br />
SPORTELLO MOBILE Autobanca<br />
UFFICI DI RAPPRESENTANZA ALL’ESTERO<br />
HONG KONG* - SHANGHAI* (*in comune con altri partner bancari)<br />
DESK ALL’ESTERO<br />
ABU DHABI - ATENE - BRUXELLES - BUENOS AIRES - CASABLAN-<br />
CA - CHICAGO - CHISINAU - CITTÀ DEL MESSICO - IL CAIRO<br />
- ISTANBUL - LIMA - LIONE - LISBONA - MONTEVIDEO - MON-<br />
TREAL - MOSCA - MUMBAI - PARIGI - SAN PAOLO - SEOUL<br />
- SHANGHAI - TEL AVIV - TOKYO - TUNISI - VARSAVIA - VIENNA<br />
(presso partner <strong>di</strong>versi)<br />
BANCA POPOLARE DI SONDRIO (SUISSE) SA<br />
CONFEDERAZIONE ELVETICA<br />
www.bps-suisse.ch - contact@bps-suisse.ch<br />
SEDE SOCIALE E DIREZIONE GENERALE:<br />
LUGANO, via Giacomo Luvini 2a tel. 0041 58 8553000<br />
fax 0041 58 8553015<br />
SEDE OPERATIVA<br />
LUGANO via Maggio 1 tel. 0041 58 8553100<br />
SUCCURSALI E AGENZIE<br />
LUGANO via Giacomo Luvini 2a tel. 0041 58 8553200<br />
LUGANO Cassarate, piazza E. Bossi 2 tel. 0041 58 8553250<br />
LUGANO Para<strong>di</strong>so,<br />
Riva Para<strong>di</strong>so 2 - Palazzo Mantegazza tel. 0041 58 8554500<br />
BASILEA Greifengasse 18 tel. 0041 58 8553900<br />
BASILEA Münsterberg 2 tel. 0041 58 8554400<br />
BELLINZONA viale Stazione 26 tel. 0041 58 8553500<br />
BERNA 7 Casinoplatz 2 tel. 0041 58 8554450<br />
BIASCA piazza Centrale 1 tel. 0041 58 8554250<br />
CASTASEGNA località Farzett tel. 0041 58 8553750<br />
CELERINA via Maistra 104 tel. 0041 58 8553700<br />
CHIASSO piazza In<strong>di</strong>pendenza 2 tel. 0041 58 8554000<br />
COIRA Bahnhofstrasse 9 tel. 0041 58 8553850<br />
DAVOS DORF Promenade 154 tel. 0041 58 8554350<br />
LOCARNO piazza Muraccio tel. 0041 58 8553550<br />
MENDRISIO piazzetta Borella 1 tel. 0041 58 8554200<br />
PONTRESINA via Maistra 184 tel. 0041 58 8554300<br />
POSCHIAVO strada San Bartolomeo tel. 0041 58 8553650<br />
SAMEDAN Plazzet 21 tel. 0041 58 8554550<br />
SAN GALLO Schmiedgasse 2<br />
- Haus zum Rosenstock tel. 0041 58 8553800<br />
ST. MORITZ via dal Bagn 9 tel. 0041 58 8553600<br />
ZURIGO Uraniastrasse 14 tel. 0041 58 8553950<br />
Principato <strong>di</strong> Monaco<br />
MONACO 3 rue Princesse Florestine tel. 00377 99996464<br />
FACTORIT SPA - Gestione Cre<strong>di</strong>ti Commerciali delle Imprese<br />
Filiali a Milano, Torino, Padova, Bologna, Roma e Napoli, oltre a 250<br />
corrispondenti esteri presenti in 65 paesi.<br />
Milano, via Cino del Duca 12 - tel. 02 58150.1 - fax 02 58150.205<br />
www.factorit.it - info@factorit.it<br />
PIROVANO STELVIO SPA - L’università dello sci<br />
Albergo Quarto - Passo dello Stelvio (m 2.760-3.450)<br />
<strong>Sondrio</strong>, via Delle Prese 8 - tel. 0342 210040 - fax 0342 514685<br />
www.pirovano.it - info@pirovano.it<br />
BIBLIOTECA LUIGI CREDARO<br />
<strong>Sondrio</strong>, lungo Mallero Armando Diaz, 18<br />
tel. 0342 562 270 - fax 0342 510 825<br />
www.popso.bibliotecacredaro.it - info@popso.bibliotecacredaro.it<br />
IL GRUPPO BANCARIO AL CENTRO DELLE ALPI<br />
<strong>Banca</strong> <strong>Popolare</strong> <strong>di</strong> <strong>Sondrio</strong> BPS (SUISSE) Factorit Pirovano Stelvio<br />
Dati aggiornati all’11 aprile 2011