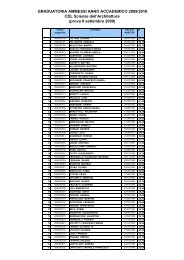CURRICULUM VITAE/STUDIORUM di Sandra Pucciarelli ...
CURRICULUM VITAE/STUDIORUM di Sandra Pucciarelli ...
CURRICULUM VITAE/STUDIORUM di Sandra Pucciarelli ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>CURRICULUM</strong> <strong>VITAE</strong>/<strong>STUDIORUM</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>Sandra</strong> <strong>Pucciarelli</strong><br />
Via Monte Vettore 1, Camerino (MC), 23 Ottobre 1969<br />
62022, Castelraimondo (MC) Citta<strong>di</strong>nanza italiana<br />
FORMAZIONE DI BASE<br />
Ricercatore a tempo determinato<br />
settore BIO/07 (Ecologia)<br />
Luglio 1988 Diploma <strong>di</strong> maturità classica. Liceo Classico Statale "A. Varano", Camerino<br />
(MC)<br />
FORMAZIONE SCIENTIFICA<br />
22 Luglio 1993 Laurea in Scienze Biologiche, con <strong>di</strong>scussione <strong>di</strong> una tesi sperimentale in<br />
Zoologia dal titolo: "Organizzazione ed espressione dei geni co<strong>di</strong>ficanti la<br />
β−tubulina in un organismo antartico, il ciliato Euplotes focar<strong>di</strong>i". Relatore:<br />
Prof.ssa Cristina Miceli, Dipartimento <strong>di</strong> Biologia Molecolare, Cellulare e<br />
Animale, Università <strong>di</strong> Camerino. Valutazione: 110/110 con lode.<br />
1993-1997 Dottorato <strong>di</strong> Ricerca in Biologia (IX ciclo) conclusosi con la <strong>di</strong>scussione <strong>di</strong> una<br />
tesi dal titolo: "Caratterizzazione <strong>di</strong> microtubuli e tubuline del ciliato antartico<br />
Euplotes focar<strong>di</strong>i", presso Università <strong>di</strong> Tor Vergata (Roma), l’8 Maggio 1998.<br />
Relatore: prof.ssa C. Miceli.<br />
Luglio-Dicembre<br />
1995<br />
28 marzo-10<br />
maggio 1997<br />
Novembre 1998-<br />
Giugno 2000<br />
Luglio 2000-<br />
Dicembre 2003<br />
Maggio 2004tutt’oggi<br />
CORSI E WORKSHOP<br />
13 Marzo-3<br />
Aprile 1994<br />
9-19 Settembre<br />
1996<br />
26-27 Marzo<br />
2002,<br />
1-7 Dicembre<br />
2002.<br />
Soggiorno per attività <strong>di</strong> perfezionamento all'estero presso il laboratorio del<br />
Prof Harry William Detrich III, Northeastern University, Boston-MA, USA.<br />
Spe<strong>di</strong>zione nella base americana Palmer Station, in Antartide, coor<strong>di</strong>nata dal<br />
Prof. H.W. Detrich III.<br />
Post-dottorato presso il laboratorio del Dr. Ronald Melki, Laboratoire<br />
d'Enzymologie et Biochimie Structurales, CNRS, Gif-Sur-Yvette, Francia.<br />
Assegnista per la collaborazione ad attività <strong>di</strong> ricerca presso il Dipartimento <strong>di</strong><br />
Biologia Molecolare, Cellulare e Animale, Università <strong>di</strong> Camerino.<br />
Ricercatore a tempo determinato, settore BIO/07 (Ecologia), presso il<br />
Dipartimento <strong>di</strong> Biologia Molecolare, Cellulare e Animale, Università <strong>di</strong><br />
Camerino.<br />
Soggiorno ERASMUS "Interest of current stu<strong>di</strong>es on protists for cellular and<br />
molecular biology, health and environment". Università "Blaise Pascal",<br />
Clermont Ferrand. Francia<br />
"EMBO practical course on Cytoskeleton Dynamics" Institute of Molecolar<br />
Biology, Austrian Academy of Sciences, Salisburgo, Austria.<br />
“Colture cellulari: meto<strong>di</strong>che <strong>di</strong> base ed applicazioni”. Milano<br />
I Workshop SCAR-EVOLANTIA Certosa <strong>di</strong> Pontignano (Si)<br />
1 <strong>di</strong> 18
18-21 Settembre<br />
2006<br />
Statistics for the design and analysis of research stu<strong>di</strong>es. Camerino (MC).<br />
Instructor Prof. Simon Cousens. Professore <strong>di</strong> Epidemiologia e Statistica<br />
Me<strong>di</strong>ca del London School of Hygiene and Tropical Me<strong>di</strong>cine<br />
2-6 Ottobre 2006 Statistical models and data analysis for experimental research. Camerino<br />
(MC). Instructor Prof. Lisandro Benedetti Cecchi. Professore Associato<br />
BIO/07- Ecologia, Dipartimento <strong>di</strong> Biologia, Università <strong>di</strong> Pisa<br />
SINOSSI DELLA RICERCA.<br />
La mia attività <strong>di</strong> ricerca si è svolta nell’ambito dell’ecologia molecolare. Le tematiche che ho<br />
sviluppato si possono schematizzare in tre linee principali:<br />
1- Evoluzione molecolare<br />
Fin dallo svolgimento della mia tesi <strong>di</strong> laurea mi sono interessata delle strategie evolutive e i<br />
meccanismi molecolari responsabili dell’adattamento al freddo degli organismi antartici.<br />
Il freddo è un fattore <strong>di</strong> “stress” per tutti gli organismi che rispondono con adattamenti<br />
fisiologici e molecolari per sopravvivere alle variate con<strong>di</strong>zioni climatiche. La risposta molecolare al<br />
freddo è la sintesi <strong>di</strong> proteine che legandosi alle strutture cellulari la cui funzione è inibita, ne<br />
ripristinano la normale attività. Quando lo stress è persistente, entrano in gioco dei meccanismi <strong>di</strong><br />
adattamento più ra<strong>di</strong>cali. Gli organismi che vivono in ambienti cronicamenti fred<strong>di</strong> hanno evoluto<br />
macromolecole capaci <strong>di</strong> funzionare in con<strong>di</strong>zioni estreme. Questa “evoluzione adattativa” si basa<br />
su mutazioni che aumentano la fitness <strong>di</strong> un organismo nel suo habitat ed hanno come bersaglio<br />
geni sotto forte pressione evolutiva in con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> stress e rendono il prodotto mutato più<br />
funzionale <strong>di</strong> quello originario in quelle determinate con<strong>di</strong>zioni ambientali.<br />
La mia attività <strong>di</strong> ricerca è stata inizialmente in<strong>di</strong>rizzata alla caratterizzazione dei meccanismi<br />
molecolari responsabili della polimerizzazione e stabilità al freddo dei microtubuli, analizzando la<br />
famiglia genica co<strong>di</strong>ficante l’α- e β-tubulina, il cui etero<strong>di</strong>mero costituisce l’unità base dei<br />
microtubuli. Più recentemente mi sono occupata della caratterizzazione dei meccanismi molecolari<br />
che permettono una efficiente sintesi proteica anche a basse temperature. Ho affrontato questo<br />
argomento analizzando i geni co<strong>di</strong>ficanti le proteine ribosomali P0 e P2. Per chiarire questi<br />
meccanismi <strong>di</strong> adattamento al freddo ho utilizzato come sistema <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o Euplotes focar<strong>di</strong>i, un<br />
ciliato endemico del continente antartico isolato dalle acque interstiziali della costa della baia <strong>di</strong><br />
Terra Nova, la cui temperatura è costantemente <strong>di</strong> –1,8 °C. Analisi fisiologiche, biochimiche e<br />
molecolari hanno <strong>di</strong>mostrato che questo organismo è strettamente psicrofilo: ha una temperatura<br />
ottimale <strong>di</strong> crescita intorno ai 2-4 °C, e non sopravvive a temperature oltre 10 °C; non risponde ai<br />
stress termici me<strong>di</strong>ante l’induzione della proteina “Heat Shock” HSP70, ed infine ha un co<strong>di</strong>ce<br />
genetico ricco <strong>di</strong> A e T, atto a favorire la separazione del doppio filamento <strong>di</strong> DNA durante la<br />
duplicazione o la trascrizione genica, in con<strong>di</strong>zioni energeticamente sfavorevoli.<br />
Ottimi organismi <strong>di</strong> confronto per avvalorare la correlazione tra l’adattamento al freddo e le<br />
sostituzioni aminoaci<strong>di</strong>che <strong>di</strong> E. focar<strong>di</strong>i sono cellule <strong>di</strong> Euplotes <strong>di</strong> un ceppo denominato MR13,<br />
prelevate nella regione nord orientale dell’Africa e poi allevate nei nostri laboratori a temperature<br />
intorno a 22°C. Queste cellule si presentano come una ‘sibling species’ <strong>di</strong> E. focar<strong>di</strong>i, con molti<br />
caratteri morfologici in comune, ma incapaci <strong>di</strong> sopravvivere a temperature inferiori ai 8-10 °C.<br />
2 <strong>di</strong> 18
Sulla base delle sequenze del DNA co<strong>di</strong>ficante l’RNA della subunità minore del ribosoma, il ceppo<br />
MR13 mostra una <strong>di</strong>stanza genetica da E. focar<strong>di</strong>i dell’or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> 60 milioni <strong>di</strong> anni sulla base <strong>di</strong><br />
dati analoghi riferiti ad altri ciliati. Le subunità ribosomali sono considerate un buon orologio<br />
molecolare per scan<strong>di</strong>re la <strong>di</strong>stanza evolutiva tra due organismi, in quanto il ribosoma è una<br />
molecola ubiquitaria e molto conservata durante l’evoluzione. Questi risultati lasciano ipotizzare<br />
che le E. focar<strong>di</strong>i ed il ceppo MR13 derivino da uno stesso progenitore, dal quale si sono<br />
<strong>di</strong>versificati dopo la separazione dell’Antartide dalla Gondwana ed il raffreddamento dell’oceano<br />
antartico. Nonostante la vicinanza evolutiva con E. focar<strong>di</strong>i, le sequenze proteiche <strong>di</strong> MR13<br />
mostrano una chiara e maggiore similarità <strong>di</strong> sequenza con quelle <strong>di</strong> altre specie <strong>di</strong> Euplotes non<br />
adattate al freddo. Questo lascia supporre che il tasso mutazionale delle proteine <strong>di</strong> MR13 sia lo<br />
stesso <strong>di</strong> quello delle altre specie <strong>di</strong> Euplotes, mentre quello delle tubuline <strong>di</strong> E. focar<strong>di</strong>i sia più<br />
elevato sotto la pressione selettiva dell’ambiente antartico. Questo stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> comparazione <strong>di</strong><br />
strategie evolutive tra E. focar<strong>di</strong>i ed MR13 è stato sviluppato con la collaborazione del prof.<br />
Fernando Dini e del Dr. Graziano Di Giuseppe dell’Università <strong>di</strong> Pisa ed è attualmente oggetto <strong>di</strong><br />
un manoscritto in preparazione.<br />
Un notevole contributo alla mia attività scientifica è derivato da perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> soggiorno all'estero<br />
presso il laboratorio del Prof H.William Detrich, della Northeastern University <strong>di</strong> Boston (USA), e<br />
presso il laboratorio del Dr. Ronald Melki, del CNRS <strong>di</strong> Gif-Sur-Yvette (Francia). Durante questi<br />
soggiorni, mi sono de<strong>di</strong>cata alla caratterizzazione dei meccanismi molecolari responsabili del<br />
fol<strong>di</strong>ng delle tubuline <strong>di</strong> E. focar<strong>di</strong>i alle basse temperature, dell’evoluzione <strong>di</strong> questo fenomeno, e<br />
della caratterizzazione molecolare e funzionale della ciaperonina citosolica, responsabile del<br />
fol<strong>di</strong>ng della tubulina e <strong>di</strong> altre proteine citoscheletriche, purificata dal pesce antartico Notothenia<br />
coriiceps.<br />
2- Filogenesi molecolare<br />
La filogenesi molecolare si basa sulla comparazione <strong>di</strong> sequenze <strong>di</strong> DNA e <strong>di</strong> aminoaci<strong>di</strong> <strong>di</strong><br />
organismi <strong>di</strong>versi e si fonda sul presupposto che esiste una <strong>di</strong>retta correlazione tra <strong>di</strong>fferenze<br />
geniche/aminoaci<strong>di</strong>che e <strong>di</strong>stanza filogenetica. L’uso <strong>di</strong> sequenze geniche co<strong>di</strong>ficanti le subunità<br />
ribosomali per risolvere le relazioni filogenetiche tra organismi ha confermato alcune idee<br />
tra<strong>di</strong>zionali basate sulla comparazione <strong>di</strong> caratteri morfologici, come il monofiletismo dei bilateri,<br />
ma ha rivoluzionato la classificazione basata sulla cavità celomatica: i protostomi sono sud<strong>di</strong>visi in<br />
Ec<strong>di</strong>sozoa, che comprende tra altri artropo<strong>di</strong> e nemato<strong>di</strong>, e in Lofotrocozoa, che comprende<br />
anelli<strong>di</strong>, molluschi e platelminti.<br />
Durante la mia attività <strong>di</strong> ricerca mi sono occupata <strong>di</strong> due argomenti molto <strong>di</strong>battuti. Il primo<br />
riguarda la storia evolutiva dei gastrotrichi e le relazioni filogenetiche del phylum Gastrotricha con<br />
gli altri metazoi bilateri. Il secondo argomento concerne il problema dell’origine filogenetica degli<br />
eucarioti. Ho affrontato questi argomenti effettuando delle analisi filogenetiche utilizzando <strong>di</strong>versi<br />
marker molecolari: l’ rDNA e marker alternativi come le proteine ribosomali e i geni omeotici.<br />
3- Biomonitoraggio ambientale.<br />
Il biomonitoraggio ambientale tramite utilizzo <strong>di</strong> organismi viventi è sicuramente una<br />
strategia alternativa e/o complementare al monitoraggio per via strumentale che permette una<br />
3 <strong>di</strong> 18
apida in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong> aree a rischio con bassi costi, tempi ridotti e una alta densità <strong>di</strong><br />
campionamento.<br />
Durante la mia attività <strong>di</strong> ricerca ho partecipato a due progetti <strong>di</strong> biomonitoraggio: il primo<br />
ha riguardato lo stato <strong>di</strong> contaminazione ambientale del Porto <strong>di</strong> Piombino ed ha implicato l’analisi<br />
<strong>di</strong> biomarker <strong>di</strong> espressione nei sipunculi<strong>di</strong>, utilizzati per la prima volta come organismi<br />
bioin<strong>di</strong>catori nei confronti <strong>di</strong> stress chimici e/o ambientali. I biomarker sono mo<strong>di</strong>ficazioni delle<br />
attività enzimatiche, alterazioni del DNA, o sintesi <strong>di</strong> proteine che proteggono la cellula dal danno<br />
indotto dalle sostanze xenobiotiche. Il secondo argomento ha riguardato un aspetto <strong>di</strong> una analisi<br />
qualitativa della bio<strong>di</strong>versità della comunità fitoplanctonica del Lago <strong>di</strong> Garda, ritenuta importante<br />
quale in<strong>di</strong>catrice <strong>di</strong> cambiamenti <strong>di</strong> stato dei corpi lacustri, utilizzando tecniche molecolari.<br />
Una trattazione più dettagliata dei tre temi sopra delineati è riportata qui <strong>di</strong> seguito.<br />
1a) I microtubuli e la famiglia genica co<strong>di</strong>ficante le tubuline in Euplotes focar<strong>di</strong>i.<br />
I microtubuli sono polimeri essenziali per la cellula eucariotica in quanto implicati nel<br />
mantenimento dell’architettura cellulare, nella costituzione del fuso mitotico, nel trasporto<br />
intracellulare <strong>di</strong> organuli e nel movimento ciliare. I sistemi microtubulari degli organismi che<br />
vivono in ambienti temperati mostrano <strong>di</strong>versi gra<strong>di</strong> <strong>di</strong> stabilità al freddo ed alcuni sistemi, a<br />
localizzazione citoplasmatica, tendono a depolimerizzare a temperature inferiori a 4°C. L’interesse<br />
a conoscere la struttura delle tubuline <strong>di</strong> E. focar<strong>di</strong>i è stato essenzialmente motivato dall’ipotesi<br />
che queste molecole, estremamente conservate nell’evoluzione, siano <strong>di</strong>rettamente coinvolte<br />
nell’adattamento della cellula a vivere a basse temperature. Questo organismo, come tutti quelli<br />
che sono permanentemente esposti al freddo, deve possedere tubuline caratterizzate da sostituzioni<br />
aminoaci<strong>di</strong>che che siano in grado <strong>di</strong> permettere meccanismi <strong>di</strong> polimerizzazione in con<strong>di</strong>zioni<br />
estreme. In primo luogo ho <strong>di</strong>mostrato che i microtubuli <strong>di</strong> E. focar<strong>di</strong>i mantengono, al freddo,<br />
regolari caratteristiche <strong>di</strong> <strong>di</strong>namica <strong>di</strong> polimerizzazione e depolimerizzazione. Queste<br />
caratteristiche sono apparse evidenti anche in assenza <strong>di</strong> proteine associate ai microtubuli,<br />
in<strong>di</strong>cando che gli stessi etero<strong>di</strong>meri <strong>di</strong> α− e β−tubulina, costituenti i protofilamenti dei microtubuli<br />
sono responsabili della stabilità al freddo, probabilmente per la presenza <strong>di</strong> peculiari residui<br />
aminoaci<strong>di</strong>ci e/o specifiche mo<strong>di</strong>ficazioni post-traduzionali.<br />
In secondo luogo ho analizzato me<strong>di</strong>ante clonaggio, le sequenze genomiche <strong>di</strong> α− e<br />
β−tubulina. In E. focar<strong>di</strong>i, l’α−tubulina è co<strong>di</strong>ficata da un solo gene e la β−tubulina da quattro geni<br />
paraloghi. Quest’ultima caratteristica sembra essere unica <strong>di</strong> E. focar<strong>di</strong>i. Negli organsmi<br />
unicellulari, l’α- e β-tubulina sono co<strong>di</strong>ficate da uno o due geni che producono un unico isotipo.<br />
Anche nel ceppo MR13, la β-tubulina è co<strong>di</strong>ficata da due geni i cui prodotti aminoaci<strong>di</strong>ci sono<br />
identici. Quin<strong>di</strong>, l’organizzazione della famiglia genica co<strong>di</strong>ficante la β-tubulina in E. focar<strong>di</strong>i<br />
potrebbe essere una conseguenza della colonizzazione dell’habitat antartico. L’analisi delle<br />
sequenze aminoaci<strong>di</strong>che predette da quelle nucleoti<strong>di</strong>che con gli ortologhi <strong>di</strong> specie <strong>di</strong> Euplotes non<br />
adattate al freddo, tra cui il ceppo MR13, ha rivelato che l’α−tubulina si è relativamente conservata<br />
durante l’evoluzione. Diversamente, la β−tubulina presenta numerose sostituzioni aminoaci<strong>di</strong>che,<br />
soprattutto in due dei quattro geni caratterizzati. La maggior parte delle sostituzioni aminoaci<strong>di</strong>che<br />
determinano un aumento nel numero <strong>di</strong> residui <strong>di</strong> alanina, serina, treonina e glicina. Analisi<br />
biochimiche <strong>di</strong> enzimi <strong>di</strong> organismi psicrofili associano l’abbondanza <strong>di</strong> questi residui ad un<br />
aumento della flessibilità molecolare che, in un ambiente energeticamente sfavorevole come quello<br />
antartico, permette <strong>di</strong> superare più facilmente la barriera cinetica dei cambiamenti<br />
conformazionali durante le reazioni enzimatiche.<br />
4 <strong>di</strong> 18
Per capire l’importanza funzionale e strutturale <strong>di</strong> queste sostituzioni aminoaci<strong>di</strong>che, ho<br />
iniziato una collaborazione con la Dr. Eva Nogales (Università della California, Berkeley, USA),<br />
nota per la risoluzione della struttura tri<strong>di</strong>mensionale del <strong>di</strong>mero <strong>di</strong> tubulina. Nell’ambito <strong>di</strong> questa<br />
collaborazione ho potuto constatare che le sostituzioni caratterizzate nella β−tubulina <strong>di</strong> E. focar<strong>di</strong>i<br />
sono in posizioni coor<strong>di</strong>nate della struttura tri<strong>di</strong>mensionale: anche se localizzate in posizioni<br />
<strong>di</strong>stanti della struttura primaria, esse interagiscono nell’ambito della struttura terziaria. Queste<br />
sostituzioni possono quin<strong>di</strong> generare una <strong>di</strong>versa flessibilità del <strong>di</strong>mero <strong>di</strong> tubulina. Inoltre, molte<br />
sostituzioni aminoaci<strong>di</strong>che delle tubuline <strong>di</strong> E. focar<strong>di</strong>i sono coinvolte proprio nelle più importanti<br />
interazioni idrofobiche che permettono l’assemblaggio della struttura microtubulare durante il<br />
processo <strong>di</strong> polimerizzazione, a livello delle interazioni sia longitu<strong>di</strong>nali intra− e inter<strong>di</strong>meriche, sia<br />
laterali tra protofilamenti. In generale, queste sostituzioni aminoaci<strong>di</strong>che aumentano il numero <strong>di</strong><br />
residui <strong>di</strong> natura idrofobica, come è stato osservato anche nelle tubuline <strong>di</strong> alghe psicrofile e <strong>di</strong><br />
pesci antartici (Nototenoidei). Questa osservazione ha fatto ipotizzare che specie antartiche anche<br />
evolutivamente <strong>di</strong>stanti abbiano seguito una strategia adattativa convergente per favorire la<br />
polimerizzazione dei microtubuli al freddo.<br />
Le analisi biochimiche dell’α− e β−tubulina <strong>di</strong> E. focar<strong>di</strong>i mi hanno permesso, inoltre, <strong>di</strong><br />
confrontare alcune mo<strong>di</strong>ficazioni post-traduzionali con quelle presenti in ciliati non antartici.<br />
Me<strong>di</strong>ante uso <strong>di</strong> anticorpi monoclonali anti-fosfoserina e anti-tubulina poliglutamilata ho potuto<br />
osservare che la β−tubulina è fosforilata e non poliglutamilata, come avviene in molti altri<br />
organismi. La fosforilazione potrebbe essere implicata nella stabilità al freddo dei microtubuli in<br />
quanto è una mo<strong>di</strong>ficazione post-traduzionale rara nelle tubuline, ed è stata evidenziata proprio<br />
nella frazione <strong>di</strong> microtubuli stabili al freddo <strong>di</strong> neuroni ed eritrociti <strong>di</strong> vertebrati.<br />
Ho rivolto il mio interesse anche alla caratterizzazione della γ−tubulina, che è la<br />
componente principale delle strutture subcellulari note come centri organizzatori dei microtubuli<br />
(MTOC). In organismi mesofili anche la nucleazione dei microtubuli è inibita dal freddo e le basi<br />
molecolari che caratterizzano questo processo a basse temperature non sono noti. In E. focar<strong>di</strong>i, la<br />
γ−tubulina è co<strong>di</strong>ficata da due geni paraloghi che presentano caratteristiche strutturali <strong>di</strong>vergenti<br />
rispetto agli ortologhi <strong>di</strong> altri organismi. La maggior parte delle sostituzioni aminoaci<strong>di</strong>che è<br />
localizzata nelle regioni coinvolte nella formazione <strong>di</strong> legami laterali e longitu<strong>di</strong>nali tra la<br />
γ−tubulina e il <strong>di</strong>mero <strong>di</strong> tubulina e/o altre proteine del MTOC durante la nucleazione dei<br />
microtubuli. In particolare, una sostituzione aumenta la natura idrofobica della regione nota come<br />
“M loop”, coinvolta nelle interazioni laterali tra i monomeri della γ−tubulina nella costituzione del<br />
MTOC. Esperimenti <strong>di</strong> mutagenesi in Aspergillus nidulans hanno messo in evidenza che una<br />
riduzione <strong>di</strong> idrofobicità nel ”M loop” aumenta la sensibilità al freddo dei microtubuli <strong>di</strong> questo<br />
organismo. Inoltre, nella γ−tubulina <strong>di</strong> E. focar<strong>di</strong>i si nota, rispetto ad altri organismi, un aumento<br />
nel numero <strong>di</strong> residui <strong>di</strong> asparagina, serina, treonina e glicina. Quin<strong>di</strong>, in E. focar<strong>di</strong>i i cambiamenti<br />
conformazionali intramolecolari della γ−tubulina che hanno luogo durante la nucleazione dei<br />
microtubuli potrebbero essere permessi proprio da quelle sostituzioni che aumentano la flessibilità<br />
della molecola.<br />
1b) Adattamento al freddo delle proteine ribosomali P0 e P2<br />
Negli organismi che vivono in ambienti temperati, la sintesi proteica è inibita dal freddo,<br />
mentre nei pesci antartici, l’attività del ribosoma è mantenuta efficiente anche alle temperature<br />
cronicamente basse del proprio habitat. Tuttavia, i meccanismi molecolari responsabili <strong>di</strong> una<br />
5 <strong>di</strong> 18
efficiente sintesi proteica negli organismi psicrofili non sono stati determinati. Ho affrontato<br />
questo argomento caratterizzando le proteine ribosomali del “gruppo P” in E. focar<strong>di</strong>i. Queste<br />
proteine sono chiamate P in quanto fosforilate da <strong>di</strong>verse chinasi quando esse sono associate al<br />
ribosoma, mentre sono defosforilate nel pool citoplasmatico. Nel ribosoma, le proteine P sono<br />
responsabili della formazione della protuberanza laterale nota come “ribosomal stalk”. P2<br />
costituisce un etero<strong>di</strong>mero con il paralogo P1, associato al ribosoma tramite l’interazione con P0. Il<br />
“ribosomal stalk” interviene nella sintesi proteica interagendo con i fattori <strong>di</strong> traduzione e<br />
promuovendo l’idrolisi del GTP che ne guida il processo. Nell’ambito <strong>di</strong> questo argomento ho svolto<br />
una confronto delle sequenze aminoaci<strong>di</strong>che <strong>di</strong> P0 e P2 <strong>di</strong> E. focar<strong>di</strong>i con quelle <strong>di</strong> altri organismi<br />
non adattati al freddo (tra cui MR13). Nella P0, le mutazioni hanno prodotto sostituzioni<br />
aminoaci<strong>di</strong>che che aumentano la flessibilità strutturale e potrebbero facilitare i cambiamenti<br />
conformazionali associati all’interazione con il centro GTPasico della subunità 60S ribosomale.<br />
Altre sostituzioni aumentano l’idrofobicità del dominio coinvolto nell’interazione con l’etro<strong>di</strong>mero<br />
P1/P2, la cui funzione potrebbe essere quella <strong>di</strong> stabilizzare il “ribosomal stalk” al freddo. Nella P2,<br />
sostituzioni aminoaci<strong>di</strong>che che aumentano la flessibilità molecolare sono state riscontrate solo a<br />
livello del dominio N-terminale, dove possono facilitare l’interazione con la P1 durante la<br />
formazione dell’etero<strong>di</strong>mero. Diversamente, nel dominio C-terminale della P2, che ha una stretta<br />
interazione con la P1, sono presenti sostituzioni aminoaci<strong>di</strong>che che riducono la flessibilità,<br />
aumentano l’idrofobicità, e sono interpretabili come stabilizzanti il complesso P1/P2 soggetto ad<br />
effetti <strong>di</strong>sgreganti causati dal freddo durante la sintesi proteica.<br />
Infine, sia in P0 che P2 ho osservato la presenza <strong>di</strong> un maggior numero <strong>di</strong> residui <strong>di</strong> serina e<br />
treonina. Queste sostituzioni, oltre ad aumentare la flessibilità strutturale delle proteine P,<br />
aumentano anche il numero <strong>di</strong> siti forforilabili, interpretabile come una strategia <strong>di</strong> adattamento al<br />
freddo per facilitare il turn-over tra le proteine P associate al ribosoma stalk e quelle nel pool<br />
citoplasmatico. Questo risultato conferma come la fosforilazione sia una mo<strong>di</strong>ficazine posttraduzionale<br />
alternativa e sia probabilmente favorita alle basse temperature in quanto rapidamente<br />
reversibile e quin<strong>di</strong> poco <strong>di</strong>spen<strong>di</strong>osa a livello energetico, una proprietà ideale per le necessità<br />
adattative <strong>di</strong> un organismo che vive alle basse temperature.<br />
1c) Fol<strong>di</strong>ng delle tubuline facilitato dalla ciaperonina (CCT) alle basse temperature<br />
Per “fol<strong>di</strong>ng” si intende il processo molecolare che porta all’acquisizione della struttura nativa<br />
<strong>di</strong> una proteina. La cellula utilizza una grande quantità <strong>di</strong> energia per sintetizzare le proteine.<br />
Questo investimento sarebbe inutile se il fol<strong>di</strong>ng e l’assemblaggio delle proteine non fosse<br />
produttivo. In vitro, anche in con<strong>di</strong>zioni ottimali, il fol<strong>di</strong>ng delle proteine è un processo inefficace.<br />
Questa inefficacia dà origine alla formazione <strong>di</strong> aggregati stabili ed inattivi da parte della proteina<br />
neo-sintetizzata che non ha ancora acquisito la propria struttura nativa. Malgrado l’informazione<br />
per il fol<strong>di</strong>ng risieda nella sequenza aminoaci<strong>di</strong>ca, alcune proteine richiedono l’assistenza <strong>di</strong><br />
complessi proteici chiamati ciaperonine per raggiungere la propria struttura nativa.<br />
La CCT (denominazione che sta per Cytosolic Chaperonin containing Tcp-1) è una<br />
ciaperonina citoplasmatica eucariotica che facilita principalmente il fol<strong>di</strong>ng <strong>di</strong> proteine<br />
citoscheletriche. E’ un complesso formato da 8-9 <strong>di</strong>stinte catene polipepti<strong>di</strong>che che assemblano a<br />
formare una struttura toroidale cava. L’interno della cavità accoglie la proteina in uno stato quasinativo<br />
e attraverso <strong>di</strong>versi cicli <strong>di</strong> legame e rilascio nel citoplasma, che implica cambiamenti<br />
conformazionali della CCT guidati dall’idrolisi dell’ATP, la proteina raggiunge lo stato nativo. Il<br />
fol<strong>di</strong>ng della β−tubulina e la costituzione del <strong>di</strong>mero α/β necessitano non solamente della CCT ma<br />
6 <strong>di</strong> 18
<strong>di</strong> altri cofattori. Il cofattore A e B stabilizzano rispettivamente la forma monomerica della β− e<br />
dell’α−tubulina prima dell’intervento dei cofattori C, D, E per la formazione del <strong>di</strong>mero.<br />
Per determinare eventuali cambiamenti strutturali e funzionali della CCT dovuti alla<br />
pressione evolutiva in un ambiente cronicamente freddo come l’Antartide, ho caratterizzato questo<br />
complesso proteico nel pesce antartico Notothenia coriiceps. A livello strutturale, la CCT <strong>di</strong> N.<br />
coriiceps (Nc CCT) ha una conformazione <strong>di</strong>versa rispetto quella purificata da coniglio, come<br />
risulta comparando i due coefficienti <strong>di</strong> se<strong>di</strong>mentazione. Inoltre, <strong>di</strong>versamente da tutte le altre<br />
ciaperonine citoplasmatiche caratterizzate finora, Nc CCT è in equilibrio con una forma composta<br />
da un solo anello anziché i due tipici della struttura toroidale. Questa forma alternativa potrebbe<br />
essere una conseguenza all’adattamento al freddo <strong>di</strong> N. coriiceps per facilitare i cambiamenti<br />
conformazionali che accompagnano l’attività della ciaperonina in un ambiente energeticamente<br />
sfavorevole. Anche le sequenze primarie <strong>di</strong> due subunità della Nc CCT, ovvero Nc β e θ, contengono<br />
numerose sostituzioni aminoaci<strong>di</strong>che che ne aumentano la flessibilità rispetto le sequenze<br />
ortologhe <strong>di</strong> pesci non adattati al freddo.<br />
A livello funzionale, Nc CCT forma un complesso molto stabile solo con la tubulina, mentre<br />
lega solo debolmente l’actina. Tuttavia, la tubulina non viene rilasciata dalla CCT come prodotto<br />
nativo, nemmeno in presenza del cofattore A. Infatti, me<strong>di</strong>ante reazioni <strong>di</strong> competizione, ho potuto<br />
<strong>di</strong>mostrate che le proteine bersaglio una volta legate alla Nc CCT rimangono intrappolate nella<br />
cavità toroidale. Quin<strong>di</strong>, Nc CCT ha subito durante l’evoluzione e sotto la pressione dell’ambiente<br />
antartico delle mo<strong>di</strong>ficazioni tali che la rendono morfologicamente <strong>di</strong>versa, più specifica per la<br />
tubulina e biologicamente attiva solo in presenza <strong>di</strong> un probabile cofattore, <strong>di</strong>verso dal cofattore A,<br />
che facilita il rilascio della proteina bersaglio dalla cavità toroidale della CCT e quin<strong>di</strong> il suo fol<strong>di</strong>ng.<br />
1d) Evoluzione del fol<strong>di</strong>ng delle tubuline<br />
Per determinare eventuali <strong>di</strong>fferenze nei meccanismi molecolari del fol<strong>di</strong>ng <strong>di</strong> tubuline<br />
<strong>di</strong>vergenti in E. focar<strong>di</strong>i, ho effettuato una analisi comparativa <strong>di</strong> questo processo utilizzando come<br />
proteine bersaglio due isotipi <strong>di</strong> β−tubulina <strong>di</strong> E. focar<strong>di</strong>i, uno molto conservato denominato β-T1,<br />
ed un altro più <strong>di</strong>vergente denominato β-T3, in confronto con l’isotipo β5 umano. Attraverso saggi<br />
<strong>di</strong> fol<strong>di</strong>ng in presenza o in assenza <strong>di</strong> CCT e del cofattore A (entrambi purificati da coniglio) ho<br />
<strong>di</strong>mostrato che l’isotipo <strong>di</strong> β−T1, più conservato, necessita dell’assistenza <strong>di</strong> questi macchinari<br />
molecolari per acquisire la propria struttura nativa, come d’altra parte l’isotipo umano, mentre<br />
l’isotipo più <strong>di</strong>vergente, β−T3, necessita della CCT e cofattori <strong>di</strong>versi dal cofattore A non ancora<br />
identificati, in quanto la reazione <strong>di</strong> fol<strong>di</strong>ng effettuata in presenza <strong>di</strong> CCT e cofattore A non genera<br />
un prodotto del fol<strong>di</strong>ng. Attraverso esperimenti <strong>di</strong> competizione sulla CCT purificata da coniglio tra<br />
le β−tubulina <strong>di</strong> E. focar<strong>di</strong>i e quella umana, ho mostrato che esse competono per lo stesso sito <strong>di</strong><br />
legame, ma la tubulina <strong>di</strong> E. focar<strong>di</strong>i si lega con minore affinità. Poiché le regioni della β−tubulina<br />
<strong>di</strong> E. focar<strong>di</strong>i coinvolte nel legame sulla CCT sono mo<strong>di</strong>ficate rispetto quelle della tubulina umana,<br />
è ipotizzabile che queste sostituzioni aminoaci<strong>di</strong>che siano la causa <strong>di</strong> una minore affinità <strong>di</strong> legame.<br />
Sulla base <strong>di</strong> questi risultati, ho potuto concludere che il fol<strong>di</strong>ng della tubulina è un processo<br />
conservato nell’evoluzione solo per isotipi che non presentato particolari mo<strong>di</strong>ficazioni<br />
aminoaci<strong>di</strong>che, mentre per isotipi <strong>di</strong>vergenti il processo del fol<strong>di</strong>ng può seguire vie alternative.<br />
Come ulteriori analisi comparativa ed evolutiva del processo del fol<strong>di</strong>ng mi sono chiesta se<br />
anche la FtsZ (proteina batterica coinvolta nella costituzione del setto <strong>di</strong> separazione durante la<br />
<strong>di</strong>visione cellulare che per l’analoga struttura tri<strong>di</strong>mensionale viene considerata l’antenato della<br />
7 <strong>di</strong> 18
tubulina) ha bisogno della CCT per il proprio fol<strong>di</strong>ng. Grazie a saggi <strong>di</strong> fol<strong>di</strong>ng in presenza o in<br />
assenza della CCT ho mostrato che FtsZ è una proteina capace <strong>di</strong> raggiungere la propria struttura<br />
nativa spontaneamente. Tuttavia, in presenza <strong>di</strong> CCT, la FtsZ forma un complesso stabile con esso.<br />
Attraverso esperimenti <strong>di</strong> competizione sulla CCT purificata da coniglio tra la FtsZ e la β−tubulina<br />
umana, ho mostrato che esse competono per lo stesso sito <strong>di</strong> legame. Inoltre, in presenza <strong>di</strong> CCT la<br />
FtsZ nativa è più stabile nel tempo, per cui presumo che una volta che la proteina abbia perso la<br />
propria struttura nativa si leghi nuovamente alla CCT per poterla riacquistare. Questo risultato è<br />
alquanto interessante perché mostra come la CCT non sia responsabile solamente del fol<strong>di</strong>ng delle<br />
proteine sintetizzate ex novo, ma anche <strong>di</strong> quello <strong>di</strong> proteine denaturate in conseguenza a shock<br />
termici o <strong>di</strong> altra natura, come altre proteine “heat-shock”.<br />
Il fatto che la tubulina batterica non necessita l’ausilio <strong>di</strong> ciaperonine per il raggiungimento<br />
del proprio stato nativo supporta l’ipotesi <strong>di</strong> una coevoluzione tra tubulina e CCT, cominciata con la<br />
nascita della cellula eucariotica.<br />
2a) Origine filogenetica dei primi eucarioti.<br />
Il problema dell’origine filogenetica degli eucarioti è un argomento ancora irrisolto molto<br />
<strong>di</strong>battuto. Attualmente, due modelli alternativi sono stati proposti: il modello <strong>di</strong> Sogin basato sulle<br />
sequenze geniche del rRNA 18S prevede una prima ra<strong>di</strong>azione <strong>di</strong> eucarioti “semplici” come<br />
Micetozoa e Euglenozoa dalla linea evolutiva che parte dagli Archebatteri, e una successiva grande<br />
ra<strong>di</strong>azione <strong>di</strong> eucarioti “complessi” che include animali, funghi, piante, alveolari (ciliati e<br />
apicomplessi) ed alcune alghe. Un modello più recente <strong>di</strong> Stechmann e Cavalier-Smith, prevede<br />
una grande ra<strong>di</strong>azione <strong>di</strong> supergruppi <strong>di</strong> eucarioti, in cui quello <strong>di</strong> animali e funghi è localizzato alla<br />
base dell’albero, che precede la ra<strong>di</strong>azione <strong>di</strong> supergruppi che includono i protisti e piante.<br />
Un mio contributo a questa problematica è rappresentato da una analisi filogenetica<br />
utilizzando come marker molecolari le sequenze delle proteine ribosomali P0 e P2. La scelta è<br />
caduta su queste sequenze in quanto P1 e P2 derivano molto probabilmente da un fenomeno <strong>di</strong><br />
duplicazione genica da un singolo gene ancestrale, e il fenomeno della duplicazione genica ha<br />
giocato un ruolo importante nella ra<strong>di</strong>azione degli eucarioti.<br />
Ho costruito due alberi filogenetici rispettivamente con le sequenze aminoaci<strong>di</strong>che P0 e P2 <strong>di</strong><br />
E. focar<strong>di</strong>i e gli ortologhi noti <strong>di</strong> altri eucarioti e <strong>di</strong> archebatteri. Entrambi gli alberi confermano il<br />
modello proposto da Sogin, per cui si riscontra una prima ra<strong>di</strong>azione dagli archebatteri <strong>di</strong><br />
Micetozoa e Euglenozoa, e una ra<strong>di</strong>azione successiva <strong>di</strong> Alveolari, animali e funghi. Questo<br />
risultato, oltre a dare un contributo al <strong>di</strong>battito sull’origine degli eucarioti, mostra anche che le<br />
proteine ribosomali possano essere considerate un valido marker filogenetico.<br />
2b) Relazioni filogenetiche interne al phylum Gastrotricha.<br />
In collaborazione con il gruppo <strong>di</strong> ricerca del prof. Paolo Tongiorgi dell’Università <strong>di</strong> Modena<br />
e della prof.ssa Maria Balsamo dell’Università <strong>di</strong> Urbino, mi sono occupata della problematica della<br />
filogenesi dei gastrotrichi. La storia evolutiva <strong>di</strong> questo gruppo <strong>di</strong> organismi è molto <strong>di</strong>battuta.<br />
Sulla base <strong>di</strong> caratteri morfologici, questo phylum era tra<strong>di</strong>zionalmente inserito tra gli<br />
“pseudocelomati”, con caratteristiche morfologiche simili ai rotiferi e nemato<strong>di</strong> (denominati<br />
aschelminti e anch’essi inseriti nel gruppo degli pseudocelomati), ma anche a turbellari e<br />
Gnatostomuli<strong>di</strong> (acelomati). Inoltre, i due or<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> gastrotrichi Chaetonotida e Macrodasyida<br />
presentano numerose <strong>di</strong>fferenze a livello morfologico ed ecologico che suggerivano una<br />
appartenenza a due <strong>di</strong>versi taxa. Per risolvere i rapporti filogenetici tra i due or<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> gastrotrichi e<br />
8 <strong>di</strong> 18
tra questi con altri invertebrati abbiamo costruito degli alberi filogenetici basati sulle sequenze<br />
geniche del rDNA 18S <strong>di</strong> <strong>di</strong>verse specie <strong>di</strong> gastrotrichi che hanno permesso, assieme all’analisi dei<br />
caratteri morfologici dei due or<strong>di</strong>ni Chaetonotida e Macrodasyida, <strong>di</strong> ottenere dei risultati alquanto<br />
innovativi, che sono qui riassunti: i- il phylum dei gastrotrichi costituisce un taxon monofiletico<br />
non <strong>di</strong>rettamente associato agli altri aschelminti; ii- contrariamente a quanto riportato<br />
precedentemente in letteratura, i Chaetonotida e non i Macrodasyida sono il gruppo più ancestrale<br />
all’interno del phylum; iii- la posizione dei gastrotrichi e rotiferi in due cla<strong>di</strong> separati nell’albero<br />
filogenetico fa supporre non solo una origine polifiletica degli aschelminti, ma anche che il termine<br />
“pseudocelomato” può essere ormai considerato privo <strong>di</strong> significato, come già suggerito da altre<br />
analisi filogenetiche basate su caratteri molecolari.<br />
2c) Relazioni filogenetiche del phylum Gastrotricha con gli altri metazoi bilateri: clonaggio <strong>di</strong> un<br />
gene omeotico Ubx-like <strong>di</strong> Paraturbanella teissieri.<br />
Negli ultimi anni, molte indagini <strong>di</strong> filogenesi molecolari hanno avuto come oggetto i geni<br />
Hox. Questi ultimi presenti in tutti i Metazoi, sono costituiti nei Bilateri da un complesso <strong>di</strong> geni<br />
omeotici (geni per lo sviluppo) associati in tre gruppi: anteriore, centrale e posteriore. Essi<br />
controllano la formazione dello schema corporeo dell’animale e <strong>di</strong> tutti i suoi elementi strutturali<br />
nel tempo e nello spazio. Si chiamano geni omeotici in quanto la per<strong>di</strong>ta completa della funzione <strong>di</strong><br />
uno qualsiasi <strong>di</strong> questi geni, causa la trasformazione dell’identità segmentale, con la conseguenza<br />
che la struttura corrispondente del corpo si genera, ma in posizione anomala. L’or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> questi<br />
geni corrisponde all’or<strong>di</strong>ne dei segmenti che essi influenzano: esiste cioè una colinearità tra<br />
l’or<strong>di</strong>ne dei geni lungo il cromosoma e la loro espressione lungo l’asse antero-posteriore del corpo.<br />
I geni Hox possono essere considerati un buon marker filogenetico in quanto l’analisi della loro<br />
sequenza e organizzazione sostiene quello che è uno dei risultati più <strong>di</strong>scussi ottenuto con le<br />
sequenze <strong>di</strong> RNA 18S, ovvero la sud<strong>di</strong>visione dei protostomi nei due cla<strong>di</strong> dei Lophotrocozoa e<br />
degli Ec<strong>di</strong>sozoa.<br />
In collaborazione con l’Università <strong>di</strong> Urbino, ho iniziato l’analisi dei geni Hox nei gastrotrichi<br />
per determinare le relazione del phylum Gastrotricha con gli altri protostomi. Come primo<br />
approccio per il clonaggio dei geni omeotici ho utilizzato la tecnica della PCR. Per la scelta degli<br />
oligonucleoti<strong>di</strong> da utilizzare come primers, ho effettuato una ricerca in banca dati <strong>di</strong> sequenze <strong>di</strong><br />
geni omeotici <strong>di</strong> specie filogeneticamente vicine ai gastrotrichi. Dall’allineamento delle<br />
corrispondenti sequenze proteiche ho notato la presenza <strong>di</strong> motivi aminoaci<strong>di</strong>ci conservati che<br />
fiancheggiano l’omeodominio nella maggior parte dei geni omeotici noti, le cui sequenze sono<br />
rispettivamente ELEKEF e WFQNRRM. Ho quin<strong>di</strong> costruito dei primers degenerati sulla base <strong>di</strong><br />
questi motivi per le reazioni <strong>di</strong> PCR. Delle tante strategie effettuate, ho ottenuto una sequenza<br />
omeotica solo da DNA <strong>di</strong> Paraturbanella teissieri. Effettuando una ricerca in banca dati con la<br />
sequenza parziale determinata, ho ottenuto degli allineamenti con il “Ultrabithorax gene product”<br />
<strong>di</strong> Drosophila melanogaster. Questo gene regola il numero delle ali e delle zampe nell’in<strong>di</strong>viduo<br />
adulto, ed è stato caratterizzato finora solo in artropo<strong>di</strong> ed onicofori. Il rinvenimento <strong>di</strong> un gene<br />
Ubx in gastrotrichi è il primo riportato, e mi ha permesso <strong>di</strong> costruire un albero filogenetico in cui i<br />
gastrotrichi sono legati agli Ec<strong>di</strong>sozoa da una netta relazione <strong>di</strong> “sister-group”, in accordo con<br />
alcune recenti analisi filogenetiche basate su dati morfologici. Questi interessanti risultati sono<br />
oggetto <strong>di</strong> un manoscritto in preparazione.<br />
9 <strong>di</strong> 18
3a) Biomonitoraggio delle aree portuali <strong>di</strong> Piombino me<strong>di</strong>ante utilizzo <strong>di</strong> biomarker molecolari.<br />
Nell’ambito <strong>di</strong> uno stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> monitoraggio ambientale in aree portuali, ho condotto un lavoro<br />
che si proponeva la messa a punto <strong>di</strong> metodologie basate sull’utilizzo dei sipunculi<strong>di</strong> come<br />
bioin<strong>di</strong>catori ambientali nuovi, da usare in sinergia o in alcuni casi in alternativa a classici<br />
organismi “sentinella”. Il tipo <strong>di</strong> alimentazione dei sipunculi<strong>di</strong> li rende particolarmente interessanti<br />
come organismi bioin<strong>di</strong>catori alternativi in quanto sono “deposit feeders” e non “filters feeders”<br />
come i mitili, quin<strong>di</strong> filtrano se<strong>di</strong>menti e non materiale particolato in sospensione e notoriamente i<br />
se<strong>di</strong>menti sabbiosi contengono un accumulo <strong>di</strong> contaminati. Inoltre, questi organismi adottano un<br />
sistema <strong>di</strong> filtrazione non selettivo per cui, non essendo in grado <strong>di</strong> <strong>di</strong>scernere particelle dannose<br />
da quelle utili per la sopravvivenza, inglobano anche <strong>di</strong>screte quantità <strong>di</strong> sostanze inorganiche tra<br />
cui metalli pesanti (Pb, Hg, Co, ecc.) peraltro dannosi per il loro metabolismo. In questo progetto<br />
ho focalizzato l’attenzione sull'indagine dell’espressione <strong>di</strong> una famiglia <strong>di</strong> “stress proteins”, le Hsp<br />
70, poiché indotte da un largo spettro <strong>di</strong> agenti e con<strong>di</strong>zioni stressanti tra cui anche i metalli<br />
pesanti. Le Hsp 70 sequestrano le proteine in uno stato non ripiegato (unfolded) impedendo la<br />
forma <strong>di</strong> aggregati, nocivi per la cellula, e permettendo il loro corretto ripiegamento fino al<br />
raggiungimento dello stato nativo. Le variazioni <strong>di</strong> questi ultimi a livello biochimico e/o fisiologico<br />
possono rappresentare uno strumento <strong>di</strong> <strong>di</strong>agnosi precoce <strong>di</strong> perturbazioni e <strong>di</strong> contaminazioni<br />
ambientali.<br />
Campioni <strong>di</strong> sipunculi<strong>di</strong> sono stati prelevati nelle aree portuali <strong>di</strong> Piombino, <strong>di</strong> Portoferraio<br />
(Isola d’Elba), ed in corrispondenza del pontile “Solmine” presso Follonica (GR). Il porto <strong>di</strong><br />
Piombino è a<strong>di</strong>bito al carico e scarico merci (carbone e minerale ferroso) ed è soggetto allo scarico<br />
<strong>di</strong> acque reflue provenienti dallo stabilimento della Magona, invaso da depositi <strong>di</strong> carbone e<br />
minerali ferrosi, e dagli scarichi a mare delle acciaierie Lucchini. Il pontile della Solmine a<br />
Follonica è stato scelto per la presenza <strong>di</strong> scarichi industriali <strong>di</strong>versi da quelli <strong>di</strong> Piombino e per<br />
verificare se le popolazioni <strong>di</strong> Sipunculi<strong>di</strong> soggette ad altri tipi <strong>di</strong> stress ambientali siano<br />
geneticamente vicine a quelle degli altri siti. Il porto <strong>di</strong> Portoferraio è a<strong>di</strong>bito esclusivamente al<br />
transito dei traghetti che consentono i collegamenti con Piombino.<br />
In primo luogo ho verificato che nelle aree prese in considerazione fosse presente una popolazione<br />
omogenea <strong>di</strong> sipunculi<strong>di</strong>. Attraverso il sequenziamento del gene co<strong>di</strong>ficante la subunità ribosomale<br />
18S, ho potuto verificare che i campioni presi in esame appartenevano tutti alla specie<br />
Phascolosoma granulatum.<br />
Quin<strong>di</strong>, attraverso analisi <strong>di</strong> Western blot <strong>di</strong> estratti cellulari <strong>di</strong> sipunculi<strong>di</strong>, utilizzando<br />
anticorpi commerciali anti-Hsp 70 ho potuto verificare che in tutti i campioni è presente un livello<br />
base <strong>di</strong> Hsp70 rappresentato da una banda <strong>di</strong> peso molecolare <strong>di</strong> circa 70 kDa. Questo risultato era<br />
preve<strong>di</strong>bile considerando che l’Hsp 70 viene comunque espressa in forma basale in quanto<br />
essenziale per mantenere le proteine nello stato nativo anche in assenza <strong>di</strong> stress. Invece, nei<br />
campioni prelevati dalle aree portuali <strong>di</strong> Piombino, soggette a scarichi industriali, sono presenti<br />
bande supplementari <strong>di</strong> peso molecolare superiore (denominate Hsp 79) imputabili a isoforme <strong>di</strong><br />
Hsp 70 inducibili da specifici stress. Infatti, anche in altri sistemi isoforme <strong>di</strong> Hsp 70 inducibili<br />
hanno pesi molecolari maggiori. Questa seconda forma potrebbe essere attivata nella sua<br />
trascrizione e quin<strong>di</strong> traduzione soltanto in presenza <strong>di</strong> uno stress eccessivo e/o specifico, come<br />
quello presente nelle aree portuali <strong>di</strong> Piombino soggette a scarichi industriali. Quin<strong>di</strong>, I sipunculi<strong>di</strong><br />
possono essere utilizzati come organismi “sentinella” per ottenere informazioni della qualità<br />
dell’ambiente, in quanto la quantità <strong>di</strong> Hsp 70 espressa appare correlabile con le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong><br />
inquinamento nei siti <strong>di</strong> prelievo.<br />
10 <strong>di</strong> 18
3b) Biomonitoraggio del Lago <strong>di</strong> Garda: determinazione della specie <strong>di</strong> protozoo ciliato, e<br />
relativa alga simbionte, infestaste le acque nell’agosto 2004.<br />
Il monitoraggio della qualità delle acque superficiali rappresenta uno dei principali strumenti<br />
<strong>di</strong> conoscenza circa lo stato <strong>di</strong> salute della "risorsa acqua" e un momento <strong>di</strong> verifica degli effetti<br />
delle politiche ambientali attivate in questo settore.<br />
L’interesse per il biomonitoraggio del lago <strong>di</strong> Garda è nato in conseguenza ad un fenomeno <strong>di</strong><br />
fioritura anomalo che si è verificato nell’estate 2004 e terminato nel mese <strong>di</strong> ottobre, che ha<br />
colorato il lago <strong>di</strong> nero. Questi episo<strong>di</strong> hanno indotto l’APPA (Agenzia Provinciale per la Protezione<br />
dell’Ambiente) della provincia <strong>di</strong> Trento a de<strong>di</strong>care particolare attenzione alla raccolta qualitativa<br />
dei dati sulla composizione della comunità fitoplanctonica del Lago <strong>di</strong> Garda, ritenuta importante<br />
quale in<strong>di</strong>catrice <strong>di</strong> cambiamenti <strong>di</strong> stato dei corpi lacustri.<br />
Il mio contributo all’attività dell’APPA si è concretizzati nell’identificazione dell’organismo<br />
responsabile del fenomeno della “macchia nera” nel Lago <strong>di</strong> Garda. Analisi morfologiche in vivo e<br />
su cellule fissate hanno inequivocabilmente rivelato le caratteristiche <strong>di</strong>agnostiche <strong>di</strong> Stentor<br />
amethystinus: 1) <strong>di</strong>mensioni tra i 250 e i 400 µm; 2) citostoma e citofaringe a forma <strong>di</strong> “imbuto”;<br />
3) capacità <strong>di</strong> ancorarsi al substrato; 4) possesso <strong>di</strong> granuli <strong>di</strong> pigmento, che nel caso in oggetto<br />
conferiscono una colorazione marrone scuro o nera; 5) notevole capacità <strong>di</strong> contrazione; 6)<br />
presenza nel citoplasma <strong>di</strong> alghe ver<strong>di</strong> simbionti, probabilmente appartenenti al genere Chlorella;<br />
7) macronucleo <strong>di</strong> forma sferica. Le chiavi <strong>di</strong>cotomiche usate per l’identificazione sono quelle<br />
riportate nella guida <strong>di</strong> Foissner et al., (1999) “Identification and Ecology of Limnetic Plankton<br />
Ciliates” Bayerisches Landesamt für Wasserwirtschaft. In coesistenza con S. amethystinus sono<br />
stati anche osservati in<strong>di</strong>vidui identificati come appartenenti ad un’altra specie <strong>di</strong> Stentor, S.<br />
polymorphous (5-10% degli in<strong>di</strong>vidui totali).<br />
L’esame molecolare è stato condotto me<strong>di</strong>ante analisi genica della sequenza co<strong>di</strong>ficante la<br />
subunità 18S del ribosoma. Ho effettuato due strategie <strong>di</strong> PCR, ognuna con combinazioni <strong>di</strong> due<br />
primer rispettivamente specifici <strong>di</strong> Stentor e Chlorella, corrispondenti a regioni conservate del<br />
gene co<strong>di</strong>ficante il 18S rRNA, rilevate me<strong>di</strong>ante allineamento <strong>di</strong> tutte le sequenze <strong>di</strong> organismi del<br />
genere Stentor e Chlorella <strong>di</strong>sponibili in banca dati. La ricerca in banca dati delle sequenze<br />
ottenute ha evidenziato che la specie <strong>di</strong> Stentor del Lago <strong>di</strong> Garda non appartiene ad alcuna <strong>di</strong><br />
quelle la cui sequenza del 18S rRNA è stata analizzata e depositata in banche dati geniche, cioè S.<br />
coeruleus, S. polymorphous, e S. roeseli, confermando che si tratta <strong>di</strong> S. amethystinus. Quin<strong>di</strong>, la<br />
sequenza da me otteunuta è la prima caratterizzazione della sequenza genica del 18S rDNA <strong>di</strong><br />
Stentor amethystinus. Il grado <strong>di</strong> similarità della suddetta sequenza genica e la costruzione <strong>di</strong> un<br />
albero filogenetico evidenzia che Stentor amethystinus è strettamente correlato filogeneticamnete<br />
con S. coeruleus, S. polymorphous, e S. roeseli, anche se la linea evolutiva <strong>di</strong> Stentor amethystinus<br />
si è separata precocemente da quelle degli altri Stentor Lo S. amethystinus non era mai stato<br />
rilevato in precedenza nel Lago <strong>di</strong> Garda, e <strong>di</strong> conseguenza anche suoi fenomeni <strong>di</strong> fioritura, quin<strong>di</strong><br />
si ipotizza che questo protozoo sia stato introdotto <strong>di</strong> recente da attività antropiche.<br />
L’alga endosimbionte si identifica come una specie <strong>di</strong> Chlorella non ancora caratterizzata a<br />
livello molecolare ed in più ha la stessa percentuale <strong>di</strong> identità (99%) con quattro <strong>di</strong>verse alghe:<br />
Micractinium pusillum, Chlorella vulgaris, Chlorella sorokiniana, ed un’altra specie <strong>di</strong> Chlorella<br />
non identificata. L’albero filogenetico che deriva dall’analisi della sequenza ribosomale determinata<br />
pone la Chlorella endosimbionte in un clade poco <strong>di</strong>vergente da quello che include Micractinium<br />
pusillum, Chlorella vulgaris, e Chlorella sorokiniana. La Chlorella endosimbionte potrebbe essere<br />
11 <strong>di</strong> 18
esponsabile della veloce fioritura <strong>di</strong> Stentor. Infatti, è interessante far notare come Micractinium<br />
pusillum sia stato identificato come causa <strong>di</strong> fenomeni <strong>di</strong> fioritura <strong>di</strong> un lago in Arabia Sau<strong>di</strong>ta (Al-<br />
Homaidan & Arif, 1998, Journal of Arid Environments, 38: 15–25). Comunque, la simbiosi<br />
potrebbe non essere obbligatoria, e la Chlorella endosimbionte potrebbe essere anche presente a<br />
vita libera nella comunità fitoplanctonica del Lago <strong>di</strong> Garda.<br />
In relazione alla improvvisa e poco compresa fioritura <strong>di</strong> Stentor, questo fenomeno non si è<br />
più verificato negli anni successivi e lo S. amethystinus non è stato più ritrovato nella comunità<br />
fitoplanctonica del Lago <strong>di</strong> Garda, suggerendo che esso sia stato introdotto da attività antropiche e,<br />
dopo il fenomeno della fioritura, non abbia trovato le ottimali con<strong>di</strong>zioni ecologiche per la propria<br />
sopravvivenza.<br />
12 <strong>di</strong> 18
PUBBLICAZIONI:<br />
Le pubblicazioni in<strong>di</strong>cate dal numero seguito da una A corrispondono ad “abstract”.<br />
Linea <strong>di</strong> ricerca n°1<br />
1) Marziale F., <strong>Pucciarelli</strong> S., Ballarini P., Melki R, and Miceli C. “Microtubule nucleation in<br />
the cold: characterization of γ−tubulin from the Antarctic ciliate Euplotes focar<strong>di</strong>i”. Cell Motil.<br />
Cytoskel. Submitted<br />
2) Joachimiak E., <strong>Pucciarelli</strong> S., Ballarini P., Kaczanowska J., Miceli (2007) C. Cell-cycle<br />
dependent expression of γ-tubulin in the amicronuclear ciliate Tetrahymena pyriformis.<br />
Protist. 158(1):39-50<br />
3) <strong>Pucciarelli</strong> S., Parker S., Detrich H.W. and Melki R. (2006) Cytoplasmic chaperonin<br />
containing tcp-1 (CCT) from the Antarctic fish Notothenia coriiceps: functional and structural<br />
properties. Extremophiles. 10(6):537-49<br />
4) <strong>Pucciarelli</strong> S., Marziale F., Di Giuseppe G., Barchetta S., Miceli C.(2005) Ribosomal coldadaptation:<br />
characterization of the aci<strong>di</strong>c ribosomal P0 and P2 proteins from the Antarctic<br />
ciliate Euplotes focar<strong>di</strong>i. Gene. 360: 103-11<br />
5) <strong>Pucciarelli</strong> S., Marziale F., Ballarini P., Miceli C. (2005) Microtubule cold-stability in the<br />
Antarctic ciliate Euplotes focar<strong>di</strong>i. Polarnet Technical Report. Procee<strong>di</strong>ngs of the Fifth PNRA<br />
Meeting on Antarctic Biology 29-30 April 2004, Messina, pp 34-38<br />
6) [A] <strong>Pucciarelli</strong> S., Di Giuseppe G., Dini F., Luporini P., Miceli C. (2003) “Euplotes focar<strong>di</strong>i,<br />
an Antarctic psychrophilic ciliate of presumed Gondwanan origin?”. J. Euk. Microbiol. 50:133<br />
7) <strong>Pucciarelli</strong> S., Miceli C., Melki R. (2002) Heterologous expression and fol<strong>di</strong>ng analysis of the<br />
Antarctic ciliate Euplotes focar<strong>di</strong>i β-tubulin. Eur J Biochem. 269(24):6271-7.<br />
8) <strong>Pucciarelli</strong> S., Miceli C. (2002) Microtubule cold adaptation: characterization of α−tubulin<br />
from the Antarctic ciliate Euplotes focar<strong>di</strong>i. Extremophiles. 6(5):385-9.<br />
9) [A] <strong>Pucciarelli</strong> S., Ballarini P., Miceli C. (2002) Adaptive evolution of alpha- and betatubulins<br />
in the Antarctic ciliate Euplotes focar<strong>di</strong>i. J. Euk. Microbiol. 49:53<br />
10) [A] <strong>Pucciarelli</strong> S., Ballarini P., Melki R., and Miceli C. (2001) Heterologous expression and<br />
fol<strong>di</strong>ng analysis of the Antarctic ciliate Euplotes focar<strong>di</strong>i β-tubulin. J. Euk. Microbiol. 48:92<br />
11) Miceli C., <strong>Pucciarelli</strong> S., Ballarini P., Luporini P. (2000) Cold-stable microtubules of the<br />
Antarctic ciliate ciliate Euplotes focar<strong>di</strong>i. In Antarctic Ecosystem. (eds Davison W., Howard-<br />
Williams C., Broady P.) Christchurch: Canterbury University Press. 154-7<br />
12) <strong>Pucciarelli</strong> S. (1998) Caratterizzazione <strong>di</strong> microtubuli e tubuline del ciliato antartico<br />
Euplotes focar<strong>di</strong>i. Tesi <strong>di</strong> dottorato.<br />
13) <strong>Pucciarelli</strong> S., Ballarini P., Miceli C. (1997) Cold-adapted microtubules: characterization of<br />
tubulin posttranslational mo<strong>di</strong>fications in the Antarctic ciliate Euplotes focar<strong>di</strong>i. Cell Motil.<br />
Cytoskel. 38:329-40.<br />
14) [A] <strong>Pucciarelli</strong> S., Ballarini P., Miceli C. (1997) Characterization of α- and β-tubulin in the<br />
Antarctic ciliate Euplotes focar<strong>di</strong>i. J. Euk. Microbiol. 44:40<br />
15) <strong>Pucciarelli</strong> S., Ballarini P., Miceli C., Luporini P. (1996). Posttranslational tubulin<br />
mo<strong>di</strong>fications of the Antarctic ciliate Euplotes focar<strong>di</strong>i. Procee<strong>di</strong>ng of the third meeting on<br />
Antarctic Biology, Santa Margherita Ligure, pp 311-315.<br />
16) Miceli C., <strong>Pucciarelli</strong> S., Ballarini P., Valbonesi A., Luporini P. (1996) The β−tubulin gene<br />
family of the Antarctic ciliate Euplotes focar<strong>di</strong>i: determination of the complete sequence of<br />
13 <strong>di</strong> 18
β−T1 gene. In Battaglia B. and Walton J. (eds) "Antarctic Communities". London: Cambridge<br />
University Press, pp. 300-306.<br />
17) Miceli C., <strong>Pucciarelli</strong> S., Di Giuseppe G. (1995) Characterization of the β−tubulin gene family<br />
in the Antarctic ciliate Euplotes focar<strong>di</strong>i. Procee<strong>di</strong>ngs of the II European Congress of<br />
Protistology and VIII European Conference on Ciliate Biology, Clermond-Ferrand, pp 71-75.<br />
18) [A] <strong>Pucciarelli</strong> S., Miceli C. (1995) "Structural characterization and expression of the βtubulin<br />
gene family in the cold-poikilotherm ciliate Euplotes focar<strong>di</strong>i." J. Euk. Microb. 42:<br />
24A.<br />
Presentazioni a congressi:<br />
1- XXVI Congresso della Società Italiana <strong>di</strong> Protozoologia. Macerata 30 giugno e 1 luglio 2007<br />
Different tubulin fol<strong>di</strong>ng mechanisms in the Antarctic ciliate Euplotes focar<strong>di</strong>i Marziale F.,<br />
<strong>Pucciarelli</strong> S., Melki R. and Miceli C. (Comunicazione)<br />
2- XXVI Congresso della Società Italiana <strong>di</strong> Protozoologia. Macerata 30 giugno e 1 luglio 2007<br />
Nucleazione dei microtubuli al freddo: stu<strong>di</strong>o della funzione degli isotopi <strong>di</strong> gamma-tubulina<br />
del ciliato antartico Euplotes focar<strong>di</strong>i. <strong>Pucciarelli</strong> S., Marziale F., Ballarini P. e Miceli C.<br />
(Comunicazione)<br />
3- FASEB Summer Reserarch Conference, “Il Ciocco” Lucca (Italia), 3-8 Agosto 2005 Marziale F.,<br />
<strong>Pucciarelli</strong> S., Ballarini P., Miceli C. “The γ−tubulin of the Antarctic ciliate Euplotes focar<strong>di</strong>i”.<br />
(comunicazione)<br />
4- EMBO-FEBS WORKSHOP on Biology of Molecular Chaperones, 28 maggio-2 giugno 2005,<br />
Zakopane, Polonia, <strong>Pucciarelli</strong> S., Parker S., Detrich H.W. and Melki R. “Cytoplasmic<br />
chaperonin containing tcp-1 (CCT) from the Antarctic fish Notothenia coriiceps: functional and<br />
structural properties” (poster)<br />
5- SCAR international Biology Symposium, 25-29 Luglio 2005, Curitiba, Brasile. <strong>Pucciarelli</strong> S.,<br />
Parker S., Melki R. and Detrich H.W. “Cytoplasmic chaperonin containing tcp-1 (CCT) from the<br />
Antarctic fish Notothenia coriiceps: functional and structural properties” (comunicazione).<br />
6- 24° Congresso della Società Italiana <strong>di</strong> Protozoologia. Rapallo (GE), 1-2 Ottobre 2004.<br />
<strong>Pucciarelli</strong> S. and Miceli C.“Approach to statistical methods for detecting molecular coldadaptation”<br />
(Comunicazione)<br />
7- 4th European Congress of Protistology and 10th European Conference on Ciliate Biology. San<br />
Benedetto del Tronto (AP) August 31-September 5, 2003 <strong>Pucciarelli</strong> S., Marziale F., Ballarini<br />
P., Miceli C. “The γ−tubulin of the Antarctic ciliate Euplotes focar<strong>di</strong>i”. (poster)<br />
8- III Convegno Nazionale delle Scienze del Mare, CONISMA, Bari 27-29 Novembre 2002.<br />
<strong>Pucciarelli</strong> S., Ballarini P., Miceli C.”Meccanismi molecolari responsabili dell’adattamento<br />
dell’ α− e β−tubulina nel ciliato antartico Euplotes focar<strong>di</strong>i a con<strong>di</strong>zioni climatiche estreme”.<br />
(comunicazione)<br />
9- 23° Congresso della Società Italiana <strong>di</strong> Protozoologia. Porto Conte, Alghero (SS), 4-5 Ottobre<br />
2002. <strong>Pucciarelli</strong> S., Di Giuseppe G., Dini F., Luporini P., Miceli C.. “Euplotes focar<strong>di</strong>i, an<br />
Antarctic psychrophilic ciliate of presumed Gondwanan origin”. (comunicazione)<br />
10- 63° Congresso Nazionale Unione Zoologica Italiana, Rende (CS) 22-26 Settembre 2002.<br />
<strong>Pucciarelli</strong> S., Di Giuseppe G., Dini F., Luporini P., Miceli C.. “Euplotes focar<strong>di</strong>i, an Antarctic<br />
psychrophilic ciliate of presumed Gondwanan origin”. (poster)<br />
14 <strong>di</strong> 18
11- XXII Congresso della Società Italiana <strong>di</strong> Protozoologia (SIP) La Spezia, 20-21 Settembre 2001.<br />
<strong>Pucciarelli</strong> S., Ballarini P., Miceli C "Adaptive evolution of α− and β−tubulins of the Antarctic<br />
ciliate Euplotes focar<strong>di</strong>i." (Poster)<br />
12- XI International Congress of Protozoology (ICOP). Salisburgo, 15-19 Luglio 2001. <strong>Pucciarelli</strong><br />
S., Ballarini P., Miceli C "Adaptive evolution of α− and β−tubulins of the Antarctic ciliate<br />
Euplotes focar<strong>di</strong>i." (Poster)<br />
13- FASEB Summer Reserarch Conference, Vermont (USA), 28 Luglio-2 Agosto 2001. Miceli C., La<br />
Terza A., <strong>Pucciarelli</strong> S., Barchetta S. Molecular evolution: adaptation, <strong>di</strong>saptation and gene<br />
plasticity as response to thermal stress in Euplotes and Tetrahymena (Comunicazione)<br />
14- XXI Convegno della Società Italiana <strong>di</strong> Protozoologia (SIP). Casalmaggiore (CR) 9-10<br />
Novembre 2000. <strong>Pucciarelli</strong> S., Melki R, Miceli C. "Espressione eterologa e fol<strong>di</strong>ng<br />
dell'isotipo β−T1 <strong>di</strong> tubulina del ciliato antartico Euplotes focar<strong>di</strong>i” (comunicazione)<br />
15- ABCD-AGI-SIBBM-SIMGBM. Montesilvano Lido (PE) 1-4 ottobre 1998 <strong>Pucciarelli</strong> S.,<br />
Ballarini P., Miceli C. Caratterizzazione dei microtubuli del ciliato antartico Euplotes focar<strong>di</strong>i.<br />
(poster)<br />
16- 13th European Cytoskeleton Forum, Strasbourg, France, August 22-26 1998. <strong>Pucciarelli</strong> S.,<br />
Ballarini P., Miceli C. “Distribution of the β−tubulin isotypes in the cold-adapted microtubules<br />
of the Antarctic protozoa ciliate Euplotes focar<strong>di</strong>i.” (poster)<br />
17- 58° Congresso nazionale Unione Zoologia Italiana, Cattolica 24-28 Settembre 1997<br />
<strong>Pucciarelli</strong> S., Ballarini P., Miceli C. Mo<strong>di</strong>ficazioni strutturali e funzionali della tubulina nel<br />
protozoo ciliato antartico Euplotes focar<strong>di</strong>i. (poster)<br />
18- 10th European Cytoskeleton Forum, Stockholm Univer., Stockholm, Sweden, May 27-31 1995<br />
<strong>Pucciarelli</strong> S., Miceli C. Tubulin posttranslational mo<strong>di</strong>fication in the Antarctic ciliate<br />
Euplotes focar<strong>di</strong>i. (comunicazione)<br />
19- 9th European Cytoskeleton Forum, Dundee, Scotland, September 7-12 1994 <strong>Pucciarelli</strong> S.,<br />
Miceli C. Structural characterization and expression of the β−tubulin gene family in the coldpoikilotherm<br />
ciliate Euplotes focar<strong>di</strong>i. (poster)<br />
Linea <strong>di</strong> ricerca n°2<br />
1- Wirz A, <strong>Pucciarelli</strong> S, Miceli C, Tongiorgi P, Balsamo M. (1999). Novelty in phylogeny of<br />
gastrotricha: evidence from 18S rRNA gene. Mol Phylogenet Evol. 13:314-8.<br />
2- Wirz A., Fregni E., <strong>Pucciarelli</strong> S., Miceli C., Balsamo M. (1998) Pylum Gastrotricha: a new<br />
phylogenetic perspective from molecular analysis. Atti 1° Colloquio Nazionale <strong>di</strong> Sistematica<br />
Clasti<strong>di</strong>stica, Verona, Vol. 1: 63-65<br />
Presentazioni a Congressi<br />
1- 59° Congresso U.Z.I., San Benedetto del Tronto (Italy), 20-24 settembre, 60° Wirz A., Fregni<br />
E., <strong>Pucciarelli</strong> S., Miceli C., Balsamo M. (1998) Posizione della famiglia Xenotrichulidae<br />
nella filogenesi del phylum Gastrotricha. (Comunicazione)<br />
2- 58° Congresso nazionale Unione Zoologia Italiana, Cattolica 24-28 Settembre, pag. 59° Wirz<br />
A., <strong>Pucciarelli</strong> S., Miceli C., Tongiorgi P. (1997) Rapporti filogenetici del phylum<br />
Gastrotricha sulla base dell'analisi molecolare del gene 18S rRNA. (Comunicazione)<br />
3- 57° Congresso nazionale Unione Zoologia Italiana, San Benedetto del Tronto 22-26 Settembre,<br />
Wirz A., <strong>Pucciarelli</strong> S., Miceli C., Balsamo M, Tongiorgi P. (1996) Stu<strong>di</strong>o dei geni co<strong>di</strong>ficanti<br />
15 <strong>di</strong> 18
gli RNA ribosomali 18S e 16S ai fini <strong>di</strong> un’analisi tassonomica e filogenetica del phylum<br />
Gastrotricha. (Comunicazione)<br />
Linea <strong>di</strong> ricerca n°3:<br />
1- <strong>Pucciarelli</strong> S., Buonanno F., Defrancesco F., Miceli C. Biomonitoring of Garda lake: specie<br />
determination of a blooming Stentor during Summer 2004. Manoscritto in preparazione.<br />
2- Be<strong>di</strong>ni R., <strong>Pucciarelli</strong> S., Gatta R., Nannelli A., Miceli C. (2004). HSP70 gene expression in<br />
sipunculids: a new biomarker for monitoring marine deposits Chemistry and Ecology, Vol. 20<br />
(Supplement 1), pp. S345–S352).<br />
Presentazioni a Congressi<br />
1- III Convegno Nazionale delle Scienze del Mare, CONISMA, Bari 27-29 Novembre 2002. Be<strong>di</strong>ni<br />
R., Gatta R., <strong>Pucciarelli</strong> S., Miceli C. “I sipunculi<strong>di</strong> come nuovi bioin<strong>di</strong>catori nel monitoraggio<br />
<strong>di</strong> se<strong>di</strong>menti marini” (poster).<br />
2- Convegno “Stu<strong>di</strong>o preliminare sulla situazione ambientale <strong>di</strong> aree interessate da scarichi<br />
industriali della costa toscana”. Piombino (Li), 15 Novembre 2002. <strong>Pucciarelli</strong> S. “I<br />
sipunculi<strong>di</strong> come bioin<strong>di</strong>catori nel monitoraggio ambientale del porto <strong>di</strong> Piombino”<br />
(Comunicazione)<br />
PROGETTI DI RICERCA:<br />
La mia attività <strong>di</strong> ricerca è stata ed è inserita nei seguenti progetti:<br />
- progetto <strong>di</strong> ricerca MIUR <strong>di</strong> interesse nazionale (2007) in “Analisi comparativa delle sequenze<br />
genomiche, del fol<strong>di</strong>ng e dell'adattamento molecolare <strong>di</strong> membri della superfamiglia delle<br />
tubuline”. Coor<strong>di</strong>natore nazionale prof. C. Miceli.<br />
- ENEA: Programma Nazionale <strong>di</strong> ricerca in “Genomica e Proteomica del ciliato antartico Euplotes<br />
focar<strong>di</strong>i” (2004-2006), coor<strong>di</strong>nato dalla prof.ssa C. Miceli.<br />
- ENEA: Programma Nazionale <strong>di</strong> ricerca in Antartide, coor<strong>di</strong>nato dal prof Pierangelo Luporini, dal<br />
1995 a tutt’oggi;<br />
- progetto <strong>di</strong> ricerca MIUR <strong>di</strong> interesse nazionale (2000-2003 e 2002-2004) in "Evoluzione<br />
molecolare e marcatori <strong>di</strong> filogenesi e <strong>di</strong> adattamento". Coor<strong>di</strong>natore nazionale prof. C. Miceli.<br />
- progetto <strong>di</strong> ricerca finalizzato del CNR in Biotecnologie ambientali (unità operativa coor<strong>di</strong>nata<br />
dalla prof.ssa Miceli);<br />
- progetto Giovani Ricercatori Anno 2002, dal titolo: " Espressione eterologa della tubulina del<br />
ciliato antartico Euplotes focar<strong>di</strong>i nella linea cellulare umana HepG2 per conferire ai microtubuli<br />
endogeni resistenza a basse temperature”.<br />
- progetto Giovani Ricercatori Anno 2001, dal titolo: “Analisi <strong>di</strong> fol<strong>di</strong>ng e proprietà nucleative della<br />
β-tubulina del ciliato Euplotes”.<br />
REVIEWER PER LE SEGUENTI RIVISTE INTERNAZIONALI:<br />
Antarctic Science<br />
Polar Biology<br />
16 <strong>di</strong> 18
ATTIVITÀ DIDATTICA<br />
Carichi<br />
1- “Biologia dell’ambiente marino”, settore BIO/07, 5 CFU, corso <strong>di</strong> laurea in Biologia (sede <strong>di</strong><br />
San Benedetto)<br />
2- “Laboratori <strong>di</strong>dattici naturalistici”, settore BIO/07, 2 CFU , corso <strong>di</strong> Laurea in Scienze per la<br />
natura e per l’ambiente<br />
3-“Ecologia e Biologia Marina II”, settore BIO/07, 2 CFU, corso <strong>di</strong> laurea in “Biologia della<br />
nutrizione” (sede <strong>di</strong> San Benedetto)<br />
4-“Meto<strong>di</strong> <strong>di</strong>agnostici per la rilevazione ambientale <strong>di</strong> eucarioti”, settore BIO/07, 3 CFU, corso<br />
<strong>di</strong> laurea specialistica in “Scienze biomolecolari e biofunzionali”<br />
5-“Evoluzione e bio<strong>di</strong>versità”, settore BIO/07, 4 CFU , corso <strong>di</strong> laurea specialistica in<br />
“Bioinformatica”<br />
6-“Biomonitoraggio e bioin<strong>di</strong>catori”, settore BIO/07, 3 CFU, corso <strong>di</strong> laurea specialistica in<br />
“Chimica e Metodologie Chimiche Avanzate ”<br />
nell’anno accademico 2002/2003<br />
“Esperienze Didattiche <strong>di</strong> Biologia” presso la Scuola <strong>di</strong> Specializzazione all’Insegnamento<br />
Secondario<br />
lezioni integrative<br />
1-“Biologia Cellulare e Biotecnologie cellulari” nel corso <strong>di</strong> Laurea in Biotecnologie.<br />
2-“Biologia Cellulare” e <strong>di</strong> “Laboratorio <strong>di</strong> esperienze <strong>di</strong>dattiche in Biologia”.<br />
3-Laboratorio <strong>di</strong> “Didattica Ambientale” del corso <strong>di</strong> Laura in Scienze della Formazione<br />
primaria presso la Facoltà interuniversitaria <strong>di</strong> Scienze della formazione, Università degli stu<strong>di</strong><br />
<strong>di</strong> Macerata.<br />
Relatore <strong>di</strong> tesi <strong>di</strong> Laurea:<br />
1- “Clonaggio <strong>di</strong> un gene omeotico in Paraturbanella teissieri (Gastroticha) e sue implicazioni<br />
per le relazioni filogenetiche del phylum” Corso <strong>di</strong> Laura specialistica in Biologia Cellulare e<br />
Molecolare della Facoltà <strong>di</strong> Scienze Matematiche Fisiche e Naturali dell’Università degli stu<strong>di</strong> <strong>di</strong><br />
Urbino “Carlo Bo”, Laureando: Cerri M. Ottobre 2006<br />
2- “Caratterizzazione della γ−tubulina e adattamento a basse temperature del ciliato antartico<br />
Euplotes focar<strong>di</strong>i”, Corso <strong>di</strong> Laurea in Scienze Naturali, Università <strong>di</strong> Camerino. Laureanda:<br />
Marziale F. Luglio 2003<br />
3- “I Sipunculi<strong>di</strong> come bioin<strong>di</strong>catori nel monitoraggio ambientale del porto <strong>di</strong> Piombino e zone<br />
limitrofe”, Corso <strong>di</strong> Laurea in Scienze Naturali, laureando: Gatta R. Aprile 2002<br />
4- “Caratterizzazione della proteina acida ribosomale della famiglia P2 in Euplotes”, Corso <strong>di</strong><br />
Laurea in Scienze Biologiche, laureanda Trovellesi M. Aprile 2002<br />
5- “Espressione in batteri e analisi in vitro del “fol<strong>di</strong>ng” della β−tubulina del ciliato antartico<br />
Euplotes focar<strong>di</strong>i”, Corso <strong>di</strong> Laurea in Scienze Biologiche, laureanda: Melonaro B. Aprile 2002<br />
6- “Caratterizzazione dei geni per la β-tubulina nel ceppo <strong>di</strong> Euplotes MR13 e relazione<br />
filogenetica con ceppi antartici <strong>di</strong> Euplotes focar<strong>di</strong>i”, Corso <strong>di</strong> laurea in Scienze Naturali,<br />
laureanda: Zaccari S. Aprile 2001<br />
17 <strong>di</strong> 18
7- “La Chaperonine Cytoplasmique (CCT) du poisson antarctique Notothenia coriiceps :<br />
détermination des propriétés structurelles et fonctionnelles”. Laboratoire d’Enzymologie et<br />
Biochimie Structurales, CNRS, Gif-Sur-Yvette, Francia. Laureando. Allard A. 2000.<br />
8- “Adattamento alle basse temperature <strong>di</strong> cilati antartici: caratterizzazione dell’α-tubulina in<br />
Euplotes focar<strong>di</strong>i”. Corso <strong>di</strong> laurea in Scienze Naturali, laureanda: Campanelli L. Aprile 1998<br />
CONOSCENZE TECNICHE<br />
Biologia molecolare purificazione <strong>di</strong> DNA e RNA. Clonaggio e sequenziamento <strong>di</strong> DNA. Sintesi<br />
<strong>di</strong> cDNA. PCR e Real Time-PCR. Southern e Northern blot. Espressione<br />
eterologa <strong>di</strong> proteine in batteri. Tecniche <strong>di</strong> trasformazione e transfezione.<br />
Biochimica Tecniche cromatografiche per la purificazione <strong>di</strong> proteine (scambio ionico,<br />
affinità, esclusione molecolare, ecc.). HPLC. SDS-PAGE e PAGE in<br />
con<strong>di</strong>zioni native. IEF e elettroforesi bi<strong>di</strong>mensionale. Western Blot.<br />
Ultracentrifugazione analitica.<br />
Analisi ecologiche Programmi per analisi statistiche <strong>di</strong> modelli ecologici: STATA e R<br />
Colture cellulari. Generazione e mantenimento.<br />
CONOSCENZE INFORMATICHE E BIOINFORMATICHE<br />
Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint); Photoshop; programmi per l’analisi <strong>di</strong> sequenze <strong>di</strong><br />
DNA e proteine (BLAST, DNASTAR, CLUSTAL), analisi filogenetiche (PAML) e costruzione <strong>di</strong><br />
alberi filogenetici (TREECON).<br />
LINGUE<br />
Inglese Buon livello <strong>di</strong> comprensione ed espressione orale e scritta (livello PET-with merit).<br />
Francese Ottimo livello <strong>di</strong> comprensione ed espressione orale e scritta<br />
18 <strong>di</strong> 18


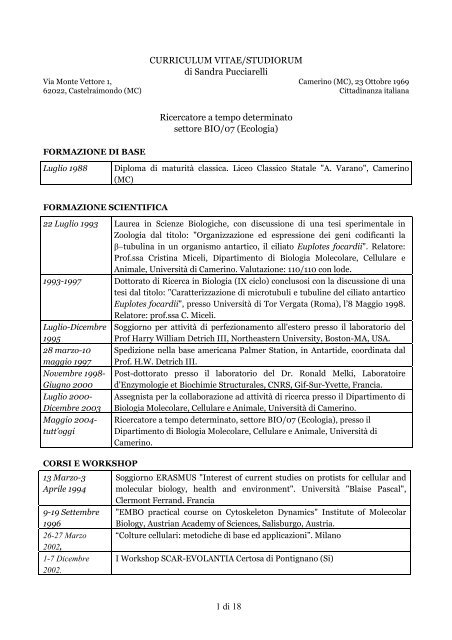
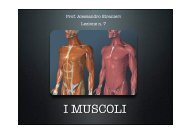





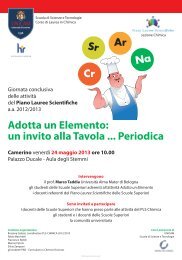


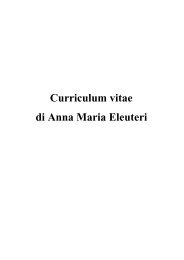

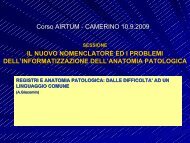
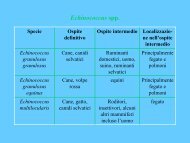
![PROGRAMMA [pdf] - Università degli Studi di Camerino](https://img.yumpu.com/15881781/1/184x260/programma-pdf-universita-degli-studi-di-camerino.jpg?quality=85)