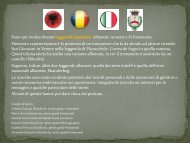Studio e ricerca sul monumento.pdf - Io sono,noi siamo ... la nostra ...
Studio e ricerca sul monumento.pdf - Io sono,noi siamo ... la nostra ...
Studio e ricerca sul monumento.pdf - Io sono,noi siamo ... la nostra ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
PROGETTO CENTOSCUOLE<br />
“IO SONO, NOI SIAMO…LA NOSTRA CITTA’”<br />
a.s 2011/2012
Le attività di STUDIO E RICERCA SUL MONUMENTO <strong>sono</strong> state svolte nel modo seguente:<br />
1) La FASE DELLE ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE AI LABORATORI (C1, C2, C4):<br />
La LETTURA ATTIVA: (C1, ricerche e approfondimenti curricu<strong>la</strong>ri in c<strong>la</strong>sse)<br />
Il SOPRALLUOGHI (C2, con sopralluogo a San Giovanni in Venere)<br />
La LETTURA CONSAPEVOLE DELL’INDAGINE CONOSCITIVA (C4, con costruzione di percorsi currico<strong>la</strong>ri di studio e approfondimento)<br />
2) La FASE DEI LABORATORI DIDATTICI IN AULA E IN SITU, CONDIVISI (D3), con le seguenti attività didattiche:<br />
Visita guidata : centro storico e chiesa di S. Maria Maggiore di Lanciano , a cura del<strong>la</strong> prof.ssa Elena La Morgia del Liceo Artistico<br />
Laboratorio con il MusAA, presso l’Abbazia, con gli esperti dell’Associazione MusAA<br />
Laboratorio condiviso fra gli alunni del Liceo Artistico e quelli del<strong>la</strong> S. Sec. 1°grado, presso il Liceo Artistico<br />
Visita guidata: Abbazia di San Clemente a Casauria (a cura del<strong>la</strong> prof.ssa M. D. Veronesi) e Abbazia di San Liberatore a Majel<strong>la</strong> (a cura del<strong>la</strong><br />
prof.ssa E. La Morgia) – i materiali didattici di supporto prodotti nell’ipertesto <strong>sono</strong> stati predisposti dal<strong>la</strong> prof.ssa E. La Morgia<br />
- I MATERIALI DI RICERCA E STUDIO INSERITI NELL’IPERTESTO SONO STATI PRODOTTI DURANTE LE ATTIVITA’ DEL LABORATORIO DIDATTICO<br />
CURRICULARE SVOLTE NEL CORSO DI STORIA DELL’ARTE DALLA CLASSE 4^C DEL LICEO ARTISTICO;<br />
- LE ALUNNE DELLA 4^C HANNO ANCHE SVOLTO IL RUOLO DI TUTOR NEL LABORATORIO CONDIVISO FRA LE DUE SCUOLE, CHE HA UTILIZZATO I<br />
MATERIALI PRODOTTI DA LORO STESSE NELLA FASE DELLA LETTURA CONSAPEVOLE DELL’INDAGINE CONOSCITIVA;<br />
- LA REALIZZAZIONE DELL’IPERTESTO E’ STATA COORDINATA DALLE DOCENTI DEL LICEO ARTISTICO CHE HANNO GUIDATO GLI ALUNNI NEL<br />
LABORATORIO CONDIVISO FRA LE DUE SCUOLE, LE PROF.SSE ELENA LA MORGIA E M.ANGELA SALVATORE, CON LA COLLABORAZIONE CONTINUA<br />
DEL TECNICO DELL’AULA MULTIUMEDIALE, SIG. MARIANO GIANGIORDANO.
L’edificio nel suo<br />
insieme<br />
OSSERVAZIONE<br />
Le absidi<br />
Linea del<br />
tempo<br />
Le Facciate<br />
Il Campanile<br />
Che cos'è<br />
un’abbazia e<br />
le abbazie<br />
cistercense<br />
I Portali<br />
Cripta e<br />
Decorazioni<br />
Visita a<br />
S. Maria<br />
Maggiore<br />
Lanciano<br />
Interventi di<br />
Restauro<br />
Materiali didattici<br />
<strong>sul</strong>le abbazie di<br />
San Clemente e<br />
San Liberatore<br />
Con nota su Montecassino<br />
Interno<br />
Chiostro<br />
Laboratorio<br />
LEZIONE POMERIDIANA<br />
Scuo<strong>la</strong> Secondaria Con 1° grado, il<br />
Fossacesia<br />
MusAA<br />
Progetto “<strong>Io</strong> <strong>sono</strong>, <strong>noi</strong> <strong>siamo</strong>…<strong>la</strong> <strong>nostra</strong> città”<br />
D3 – Vivere il Monumento<br />
Laboratorio didattico di <strong>Studio</strong> e Ricerca <strong>sul</strong> Monumento<br />
Abbazia di San Giovanni in Venere<br />
Fossacesia, 28 febbraio 2012<br />
Pao<strong>la</strong> Ardizzo<strong>la</strong><br />
Storico dell’architettura<br />
Gabriele d’Oltremare<br />
Land drafter & designer
PROGETTO CENTOSCUOLE “IO SONO, NOI SIAMO…LA NOSTRA CITTA’”<br />
IL SOPRALLUOGO - “GIRANDO INTORNO ALL’ABBAZIA…” : <strong>la</strong> grande mole<br />
ATTIVITA’ DIDATTICA DI OSSERVAZIONE<br />
L’EDIFICIO ESTERNO - LA CHIESA<br />
Scheda di osservazione sopralluogo 28 ottobre – prof.ssa Elena <strong>la</strong> Morgia, Liceo Artistico<br />
1. LA PERCEZIONE D’INSIEME<br />
Agli occhi del visitatore che arriva <strong>sul</strong> pianoro su cui sorge, l’abbazia si presenta con <strong>la</strong><br />
mole solitaria, massiccia e compatta dell’edificio del<strong>la</strong> chiesa, grandioso ed imponente allo<br />
sguardo. Dal<strong>la</strong> posizione trasversale, acquista risalto il severo aspetto del<strong>la</strong> nuda muratura<br />
che caratterizza <strong>la</strong> facciata <strong>la</strong>terale esterna: essa si staglia contro il cielo, appena interrotta<br />
dalle bucature delle piccole finestre in alto e del portale <strong>la</strong>terale.<br />
La facciata monumentale appare di scorcio, infatti occorre raggiunger<strong>la</strong> salendo <strong>la</strong> scalinata<br />
a sinistra dell’edificio.<br />
2. L’EDIFICIO NELLO SPAZIO<br />
L’ ubicazione (nel territorio):<br />
l’edificio si trova all’esterno dell’abitato, all’estremità di un promontorio, a ridosso di<br />
un’insenatura detta “Golfo di Venere”, al termine di un lungo viale alberato, su un pianoro che<br />
si affaccia <strong>sul</strong> mare Adriatico.<br />
<strong>la</strong> posizione (collocazione nello spazio):<br />
L’abbazia 1 si distende trasversalmente rispetto all’asse del<strong>la</strong> strada, che collega il pianoro su<br />
cui sorge l’abbazia all’abitato di Fossacesia, denominata “Viale di S. Giovanni in Venere”.<br />
l’ orientamento 2 :<br />
L’edificio ed il convento annesso <strong>sono</strong> orientati secondo l’asse E-O, cioè l’asse anche<br />
simbolico che governava lo sviluppo del cantiere medievale, dal<strong>la</strong> zona absidale<br />
(generalmente <strong>la</strong> prima ad essere costruita) al<strong>la</strong> facciata (<strong>la</strong> cui costruzione infatti, anche in<br />
questo caso, come spesso in situazioni analoghe, risale ad un’epoca successiva a quel<strong>la</strong> delle<br />
absidi)<br />
3. LE FACCIATE E I PORTALI<br />
<strong>la</strong> facciata <strong>la</strong>terale (esposta a sud) è quel<strong>la</strong> che si offre allo sguardo di chi giunge <strong>sul</strong><br />
pianoro, su di essa si apre un piccolo portale in pietra 3 , decorato da rilievi stilizzati<br />
<strong>la</strong>teralmente e con i resti di due figure scolpite nel<strong>la</strong> lunetta superiore;<br />
di scorcio invece si presenta <strong>la</strong> facciata maggiore o monumentale (a ovest), dal<strong>la</strong> forma a<br />
salienti 4 e realizzata in muratura, sebbene in modo diverso a seconda dei diversi livelli,<br />
evidentemente corrispondenti ad altrettanti interventi di rifacimento e ristrutturazione; essa è<br />
1 ABBAZIA. Etimologia del termine - L'abbazia (detta anche abazia o badia a seconda se diretta da un abate o una badessa), è un<br />
partico<strong>la</strong>re tipo di monastero, il cui nome deriva dal tardo <strong>la</strong>tino abbatīa, e con il quale non si indica solo un tipo di edificio ma anche<br />
l'insediamento che si sviluppava intorno ad esso.<br />
2 Sull’ ORIENTAMENTO delle chiese cristiane: nel documento più antico, le Costituzioni apostoliche (scritte da un orientale), si<br />
prescrive l'orientamento ad est, in omaggio al<strong>la</strong> rego<strong>la</strong> di pregare col viso rivolto ad oriente, <strong>la</strong> cui origine risale a tradizioni giudaiche<br />
(come molti altri aspetti del<strong>la</strong> prassi e dell'organizzazione cristiana). Molte chiese paleocristiane tuttavia sembrano non rispondere ad<br />
alcuna rego<strong>la</strong> precisa, ma piuttosto ad esigenze di topografia locale. A volte l'orientamento è determinato da fattori partico<strong>la</strong>ri, come ad<br />
esempio <strong>la</strong> presenza del<strong>la</strong> tomba di un martire. Comunque, dall'VIII secolo l'orientamento ad est si afferma in modo decisivo e,<br />
dopo il Mille, diventa norma costante per le chiese di tutto il mondo cristiano fino agli anni Sessanta del Novecento.<br />
3 Si tratta di uno dei due PORTALI LATRALI o MINORI (l’altro è <strong>sul</strong><strong>la</strong> facciata interna, che si affaccia <strong>sul</strong> chiostro del monastero)<br />
attribuiti al maestro Alessandro e realizzati all’inizio del sec. XIII (l’altro portale reca incisa <strong>la</strong> data 1204 ), in occasione dell’ultima<br />
sistemazione dell’abbazia, voluta dall’abate Oderisio, che morì nel 1204.<br />
4 La facciata a salienti è quel<strong>la</strong> che rende leggibili già dall’esterno le diverse altezze delle navate interne. Tuttavia, il numero dei<br />
salienti può anche non corrispondere al<strong>la</strong> suddivisione interna delle navate, che invece pos<strong>sono</strong> essere ricoperte da un un'unica falda<br />
inclinata: è il caso ad esempio del Duomo di Pisa.
sviluppata prevalentemente in <strong>la</strong>rghezza, anche se al centro riceve un modesto s<strong>la</strong>ncio verso<br />
l’alto sottolineato dal<strong>la</strong> picco<strong>la</strong> bifora centrale, in asse con il portale.<br />
Caratteristiche di questo portale, detto “del<strong>la</strong> Luna”, appaiono essere:<br />
<strong>la</strong> decorazione a rilievi in pietra bianca, sia più interna (realizzata sui piedritti<br />
dell’archivolto interno) che esterna (realizzata come su due leséne a <strong>la</strong>to delle colonnine<br />
d’angolo poste a fianco dei piedritti dell’archivolto esterno)<br />
La cornice in muratura bicroma, che prolunga il portale in alto, <strong>sul</strong><strong>la</strong> muraglia, secondo<br />
un disegno caratterizzato da un arco trilobato al centro e due prolungamenti cuspidati delle<br />
lesene decorate inferiori.<br />
4. IL CAMPANILE<br />
Si presenta come una tozza torre campanaria a ve<strong>la</strong> 5 , con tre luci (per far posto a tre campane),<br />
addossata al corpo dell’edifico all’altezza del transetto, immediatamente a ridosso dell’angolo<br />
svoltato il quale ci si trova a ridosso del<strong>la</strong> parte absidale.<br />
5. LE ABSIDI<br />
Sono tre, semicilindriche. Quel<strong>la</strong> centrale è più <strong>la</strong>rga, sporgente e alta delle altre due.<br />
Sono realizzate in muratura e distinte in due ordini 6 , separati da una fascia marcapiano<br />
decorata con semplici losanghe intrecciate, evidentemente corrispondenti ai due livelli del<strong>la</strong><br />
cripta (sottostante) e del presbiterio (soprastante).<br />
L’ ordine inferiore delle absidi è decorato da arcatelle cieche, di cui leggermente ogivali<br />
quelle dell’abside sinistra e a pieno sesto le altre.<br />
Tra le arcatelle e <strong>la</strong> fascia marcapiano a losanghe, <strong>sul</strong>l’abside centrale e quel<strong>la</strong> di destra,<br />
<strong>sono</strong> dei tondi stel<strong>la</strong>ti di ispirazione is<strong>la</strong>mica.<br />
La muratura, in entrambi gli ordini, presenta conci di pietra calcarea ma apparecchi<br />
diversi 7 , più irrego<strong>la</strong>re quello dell’ordine inferiore, più rego<strong>la</strong>re quello superiore;<br />
Solo <strong>sul</strong>l’abside centrale <strong>sono</strong> collocate in verticale, due finestre, esattamente al centro e<br />
in asse: si tratta di due monofore con cornice esterna trilobata.<br />
5 L' assenza di una cassa di risonanza e <strong>la</strong> semplice struttura facevano sì che non si potessero alloggiare in questo tipo di campanile<br />
grandi campane, né che il suono potesse giungere a grande distanza, per questo erano per lo più diffusi nel medioevo romanico e<br />
gotico presso le chiese minori o quelle che non volevano ostentare ricchezza (in part. francescane). Qui, pos<strong>siamo</strong> considerarlo<br />
il ri<strong>sul</strong>tato di un intervento non concluso secondo <strong>la</strong> previsione (vista <strong>la</strong> pianta quadrata del<strong>la</strong> torre stessa),comunque idoneo al<strong>la</strong> vita<br />
c<strong>la</strong>ustrale del monastero, dove il suono delle campane soprattutto serviva a scandire i tempi del<strong>la</strong> giornata dei monaci.<br />
6 I due ordini in cui è suddivisa <strong>la</strong> muratura corrispondono ai due livelli del<strong>la</strong> chiesa interna (presbiterio e cripta).<br />
7 Con il termine “apparecchio” (apparecchio murario) s’intende il modo di “porre in opera” i diversi elementi di una muratura.
San Giovanni in Venere<br />
La facciata<br />
descrizione<br />
La facciata si presenta con un profilo a salienti<br />
appena ascendenti, concluso da un timpano con<br />
sottostante cornice a go<strong>la</strong> dritta, aggettante su<br />
di una successione di archetti semicirco<strong>la</strong>ri e<br />
poligonali.<br />
Come in molti edifici cistercensi, un’ altra<br />
cornice a go<strong>la</strong> dritta taglia orizzontalmente<br />
tutta <strong>la</strong> facciata, attraversando il portale<br />
all’altezza del<strong>la</strong> linea d’imposta del<strong>la</strong> lunetta del<br />
portale.<br />
Il portale inoltre si prolunga verso l’alto al<br />
disopra del<strong>la</strong> cornice a go<strong>la</strong> dritta, con un<br />
profilo trilobato e pinnacoli <strong>la</strong>terali.<br />
Due finestre monofore polilobate si aprono ai<br />
<strong>la</strong>ti del portale, mentre più in alto, sotto il<br />
timpano centrale, è collocata una bifora<br />
decorata con archetti trilobi, che illumina <strong>la</strong><br />
navata principale.
Facciata a capanna<br />
Che cos’è una FACCIATA<br />
La facciata è <strong>la</strong> parte frontale più importante di un edificio, in cui si apre<br />
l’ingresso principale.<br />
Per le chiese, si definisce:<br />
• a capanna, <strong>la</strong> facciata costituita da due spioventi, che segue <strong>la</strong> forma del<strong>la</strong><br />
navata maggiore;<br />
• a salienti, quel<strong>la</strong> che palesa le diverse altezze delle navate;<br />
• a terminazione rettilinea, tipica di molte chiese abruzzesi, che non<br />
corrisponde alle diverse altezze delle navate e viene anche detta a<br />
coronamento orizzontale.<br />
Facciata a terminazione<br />
orizzontale<br />
Facciata a salienti
Esempi di facciate Medioevali<br />
Duomo di Pisa,1064-1092<br />
La cattedrale medievale di Pisa è un capo<strong>la</strong>voro<br />
assoluto del Romanico, in partico<strong>la</strong>re del romanico<br />
pisano. Essa rappresenta <strong>la</strong> testimonianza tangibile del<br />
prestigio e del<strong>la</strong> ricchezza raggiunti dal<strong>la</strong> Repubblica<br />
marinara di Pisa nel momento del suo apogeo.<br />
• La facciata di marmo grigio e bianco, decorata con<br />
inserti di marmo colorato, fu edificata da<br />
mastro Rainaldo.<br />
• Essa è caratterizzata da quattro ordini di loggette<br />
divise da cornici con tarsie marmoree, dietro i quali<br />
si aprono monofore, bifore e trifore.<br />
• Esse si trovano al di sopra di una fascia<br />
basamentale con arcate cieche che incorniciano i tre<br />
portali d’ingresso.<br />
a salienti<br />
Basilica di San Miniato al Monte, Firenze, XI sec.<br />
La facciata di San Miniato è uno dei capo<strong>la</strong>vori dell'architettura<br />
romanica fiorentina.<br />
Iniziata nell'XI secolo, è divisa in due fasce principali separate<br />
da una cornice marcapiano:<br />
• quel<strong>la</strong> inferiore , caratterizzata da cinque archi ciechi, a tutto<br />
sesto ,sorretti da colonne in serpentino verde con basi<br />
e capitelli corinzi in marmo bianco;<br />
• quel<strong>la</strong> superiore, corrispondente ai due frontali dei salienti<br />
<strong>la</strong>terali , decorati con tarsie bìcrome, che formano un reticolo<br />
geometrico, a somiglianza dell'opus reticu<strong>la</strong>tum romano;<br />
• Nel<strong>la</strong> parte superiore, al centro, le stesse tarsie bìcrome<br />
simu<strong>la</strong>no un pronao tetrastilo , al centro del quale è presente<br />
una finestra incorniciata da due colonne. Questa è<br />
sottostante ad un mosaico con Cristo fra <strong>la</strong> Vergine e san<br />
Miniato, composto nel 1260.
Esempi di facciate medievali a capanna<br />
La basilica di San Michele Maggiore, capo<strong>la</strong>voro dello stile<br />
romanico lombardo, è una chiesa di Pavia risalente ai secoli XI<br />
e XII.<br />
La facciata presenta un lineare profilo a capanna, impreziosito<br />
lungo gli spioventi da una loggetta di ventidue arcatelle. I<br />
contrafforti <strong>sono</strong> costituiti da pi<strong>la</strong>stri a fascio che scandiscono<br />
verticalmente <strong>la</strong> superficie.<br />
Sul<strong>la</strong> facciata si aprono cinque piccole bifore, tre monofore e<br />
una croce compresa tra due occhi di bue. Tale disposizione è una<br />
ricostruzione ottocentesca: fino a quel periodo, era presente<br />
infatti un grosso finestrone circo<strong>la</strong>re, certamente non originale,<br />
eliminato appunto per riportare <strong>la</strong> facciata al<strong>la</strong> configurazione<br />
originaria. Vi <strong>sono</strong> fasce orizzontali scolpite a bassorilievo,<br />
raffiguranti intrecci di esseri umani, animali e creature<br />
mostruose.<br />
Chiesa di San Francesco Assisi 1228-1253<br />
L'opera, incompiuta, prevedeva nel<strong>la</strong> parte bassa del<strong>la</strong><br />
facciata una tripartizione con archi inquadrati da<br />
semicolonne con capitello composito, mentre nel<strong>la</strong> parte<br />
superiore era previsto un specie difrontone con arco al<br />
centro affiancato da paraste. Punto focale era il portale<br />
centrale, con timpano triango<strong>la</strong>re al centro di un fornice<br />
riccamente ornato da <strong>la</strong>stre marmoree policrome di spoglio,<br />
provenienti probabilmente da Ravenna, che richiamano,<br />
nel<strong>la</strong> stessa accurata scelta cromatica delle pietre, l'opus<br />
sectile del<strong>la</strong> Roma imperiale. La mancanza dell'arco<br />
superiore permette di vedere, ancora oggi, un pezzo del<strong>la</strong><br />
semplice facciata medievale a capanna di San Francesco.
In Abruzzo, <strong>la</strong> facciata<br />
a terminazione orizzontale<br />
Santa Maria di Collemaggio<br />
L’ Aqui<strong>la</strong>, fondata nel 1287 per volere di<br />
Pietro da Morrone, divenuto poi Papa Celestino V.<br />
La facciata di Santa Maria Maggiore, chiesa in stile<br />
borgognone situata a Lanciano (Ch), è ornata da un<br />
grandioso portale, opera del maestro <strong>la</strong>ncianese<br />
Francesco Petrini, al 1317.<br />
Sant’ Agostino, Lanciano.<br />
La chiesa è situata in Via dei Frentani, nel quartiere di Lanciano<br />
Vecchia.<br />
Risale al XIII secolo, con successivi interventi.<br />
Il portale è opera del Petrini, capostipite del<strong>la</strong> “Scuo<strong>la</strong><br />
<strong>la</strong>ncianese” di scultura, autore anche del portale di S. Maria<br />
Maggiore.<br />
Qui egli poté esprimersi senza condizionamenti, come invece<br />
accade nell’altro edificio a causa dei contrafforti che scandiscono<br />
<strong>la</strong> facciata.
I RILIEVI DELL’ABBAZIA DI SAN GIOVANNI IN VENERE:<br />
I tre portali<br />
Portale del chiostro<br />
Portale del<strong>la</strong> luna<br />
Portale <strong>la</strong>terale
Il portale del<strong>la</strong> luna<br />
Il portale, detto del<strong>la</strong> Luna, è<br />
fiancheggiato da due alti fregi scolpiti.<br />
Questi, <strong>sono</strong> riferibili agli anni del<br />
cantiere di Oderisio e consistono in due<br />
grandi ante marmoree affiancate alle<br />
colonne.<br />
Al loro interno, su quattro registri<br />
sovrapposti, interval<strong>la</strong>ti nel mezzo da un<br />
motivo decorativo, <strong>sono</strong> narrate l’infanzia<br />
e <strong>la</strong> prima maturità di Giovanni Battista
LE DIVERSE PARTI CHE COMPONGONO<br />
LA DECORAZIONE A RILIEVO DEL PORTALE DELLA LUNA<br />
• A sinistra, partendo dall’alto si vedono due<br />
pavoni che bevono in un’anfora, Giovanni e i<br />
Farisei, l’Annuncio al<strong>la</strong> Vergine, <strong>la</strong> Visitazione e,<br />
in ultimo, due animali a<strong>la</strong>ti.<br />
• A destra, si osserva un fregio decorativo e<br />
successivamente l’Imposizione del nome e <strong>la</strong><br />
Circoncisione del Battista, L’Annuncio dell’Angelo<br />
a Zaccaria sotto una cornice di arcatelle a tutto<br />
sesto con quattro rosoncini di tradizione<br />
Abruzzese. In basso è raffigurato Daniele nel<strong>la</strong><br />
fossa dei leoni e in alto il Profeta Abacuc<br />
trasportato per i capelli da un angelo.<br />
Siamo di fronte al primo esempio di scultura<br />
narrativa in Abruzzo, è evidente <strong>la</strong> re<strong>la</strong>zione con<br />
l’ambiente padano, che nel XII secolo aveva<br />
qualificato tale genere di decoro.<br />
• Affiancate a ciascuno dei grandi fregi , sui<br />
<strong>la</strong>ti del portale, <strong>sono</strong> inserite due eleganti<br />
colonne con capitelli decorati con foglie e con<br />
sovrastanti abachi di gusto gotico.
LA LUNETTA DEL PORTALE DELLA LUNA<br />
Re<strong>la</strong>tiva al periodo dell’abate Rainaldo è <strong>la</strong> lunetta . Dopo quel<strong>la</strong> di San clemente a Casauria, questa<br />
è <strong>la</strong> seconda lunetta figurata presente in ambiente abruzzese nel<strong>la</strong> quale vi è una<br />
rappresentazione narrativa tipica dei grandi portali medievali.<br />
La lunetta è divisa in due parti da una cornice orizzontale , presenta nel<strong>la</strong> parte superiore <strong>la</strong> statua di<br />
Cristo in trono tra <strong>la</strong> Vergine e San Giovanni, scolpite in alto rilievo, e in quel<strong>la</strong> inferiore i resti di<br />
una composizione che prevedeva San Romano, San Benedetto all’interno di una nicchia, e San<br />
Rainaldo.<br />
Le sculture del<strong>la</strong> lunetta, furono prese ad esempio dagli altri cantieri che si <strong>sono</strong> succeduti per il<br />
carattere innovativo da esse espresso.
Decorazione del Portale <strong>la</strong>terale<br />
il Portale Laterale (o “delle donne”).<br />
Realizzato nel Duecento, esso propone una<br />
struttura simile al Portale del<strong>la</strong> Luna, con una<br />
lunetta delimitata da un architrave e da un<br />
archivolto, in questo caso a triplice rientranza<br />
e più sobrio.<br />
La decorazione del portale, collocato <strong>sul</strong> <strong>la</strong>to<br />
sud-ovest, venne affidata ad uno scultore<br />
locale, che si ripropose di raggiungere gli<br />
effetti dell’artista che aveva realizzato <strong>la</strong><br />
lunetta del portale del<strong>la</strong> luna. Infatti, egli<br />
eseguì due rilievi rappresentanti una Madonna<br />
con Bambino ed un angelo.
Portale del chiostro<br />
Sul fianco sinistro del<strong>la</strong> chiesa si apre il portale<br />
che immette al chiostro, esso è una delle più<br />
antiche testimonianze del<strong>la</strong> basilica di San<br />
Giovanni in Venere, firmato e datato dal Maestro<br />
Alessandro nel 1204.<br />
Si tratta di un portale<br />
a doppio risalto (triplice nel<strong>la</strong> lunetta), decorato<br />
mediante l'utilizzo di frammenti di recupero.<br />
Il portale è decorato da due lesene:<br />
• A sinistra, semicerchi e cerchi nastriformi si<br />
combinano con diagonali incrociate e includono<br />
fiori ruotanti a 5 petali;a destra, intrecci<br />
nastriformi multipli a stuoia<br />
Tutti questi rilievi <strong>sono</strong> riferibili al repertorio<br />
alto Medioevale di varie regioni d’Italia.
I RILIEVI DEL PORTALE DELLA LUNA DI SAN GIOVANNI<br />
IN VENERE COME…….QUELLI DI SAN ZENO A VERONA<br />
Verona, San Zeno,<br />
La creazione di Adamo,<br />
XII sec.<br />
Ai <strong>la</strong>ti del protiro, in San Zeno a Verona, come in San Giovanni in Venere, il portale è<br />
affiancato da due ante figurate, con una ricca decorazione p<strong>la</strong>stica.<br />
Suddivisa in 18 bassorilievi risalenti al XII secolo, <strong>la</strong> decorazione va letta dal basso verso<br />
l’alto. A sinistra, i rilievi del maestro Guglielmo e a destra quelli del maestro Nicolò, narrano<br />
soggetti sacri tratti dal Nuovo e Antico Testamento e profani, con al centro Teodorico il<br />
Grande. In uno dei rilievi, è presentato il duello fra Teodorico ed Odoacre, e in un altro<br />
Teodorico all'inseguimento del cervo, che rappresenta il demonio del<strong>la</strong> Leggenda di<br />
Teodorico.
L’interno del<strong>la</strong> chiesa abbaziale<br />
• All’interno, <strong>la</strong> chiesa abbaziale di<br />
San Giovanni in Venere si<br />
presenta con un impianto<br />
p<strong>la</strong>nimetrico a sviluppo<br />
longitudinale riferibile al modello<br />
del<strong>la</strong> Chiesa madre benedettina di<br />
Cassino.<br />
• Anche in San Giovanni, infatti, lo<br />
spazio del<strong>la</strong> chiesa è suddiviso in<br />
tre navate, con una successione<br />
di archi su pi<strong>la</strong>stri ed assenza di<br />
transetto sporgente.<br />
• Qui però gli archi <strong>sono</strong> da una<br />
parte ogivali ed i pi<strong>la</strong>stri tutti<br />
cruciformi.<br />
• Nelle volte a crociera costolonata<br />
del presbiterio è invece ravvisabile<br />
il riferimento all’architettura<br />
borgognona cistercense.
Lo spazio del<strong>la</strong> chiesa, con l’indicazione di tutti gli elementi strutturali
Pi<strong>la</strong>stri e capitelli<br />
I pi<strong>la</strong>stri, che hanno il compito di suddividere le<br />
navate, <strong>sono</strong> tutti cruciformi, diversamente<br />
dal<strong>la</strong> prevalente impostazione abruzzese<br />
benedettina, che utilizzava pi<strong>la</strong>stri a sezione<br />
rettango<strong>la</strong>re, come in San Liberatore a<br />
Majel<strong>la</strong>.<br />
Per quanto riguarda le decorazioni dei re<strong>la</strong>tivi<br />
capitelli, esse <strong>sono</strong> diverse sia per le<br />
soluzioni di ornato sia per quelle di raccordo<br />
al pi<strong>la</strong>stro.<br />
In una parte dei capitelli si rintracciano elementi<br />
di raccordo tra <strong>la</strong> loro forma quadrata e <strong>la</strong><br />
sottostante sezione cruciforme dei pi<strong>la</strong>stri,<br />
nei restanti invece non ci <strong>sono</strong> soluzioni di<br />
collegamento.<br />
Da notare,<strong>la</strong> presenza di archi a tutto sesto<br />
nel<strong>la</strong> navata destra e di archi a sesto acuto<br />
in quel<strong>la</strong> di sinistra; questi ultimi <strong>sono</strong><br />
composti di arco e contro arco concentrici,<br />
soluzione diffusasi in Abruzzo intorno<br />
all'ultimo quarto del XII secolo, con <strong>la</strong><br />
realizzazione di San Clemente a Casauria.
La Copertura del<strong>la</strong> navata è oggi a<br />
capriate lignee, invece quel<strong>la</strong> del<br />
presbiterio presenta volte a crociera<br />
ogivale costolonata, di chiara matrice<br />
borgognona.<br />
Da punto di vista simbolico, <strong>la</strong> presenza<br />
di tali volte <strong>sul</strong> presbiterio, che è lo<br />
spazio riservato alle celebrazioni,<br />
accresce <strong>la</strong> sua sacralità.<br />
Invece, dal punto di vista costruttivo e<br />
del<strong>la</strong> storia dell’architettura, le volte a<br />
crociera costolonate di matrice<br />
borgognona mostrano come nel<strong>la</strong><br />
<strong>nostra</strong> regione e proprio qui in San<br />
Giovanni in Venere, verso <strong>la</strong> fine del<br />
secolo XIII si stesse attuando il<br />
passaggio dal sistema strutturale<br />
romanico a quello gotico.<br />
Coperture e Volte<br />
Vista del<strong>la</strong> navata centrale dal<br />
presbiterio
Sviluppo p<strong>la</strong>nimetrico longitudinale nel<strong>la</strong> chiesa cristiana, a partire dallo schema<br />
basilicale: dal<strong>la</strong> basilica paleocristiana al<strong>la</strong> chiesa abbaziale cistercense<br />
LA BASILICA PALEOCRISTIANA LA CHIESA ABBAZIALE<br />
1) Pianta del<strong>la</strong> basilica<br />
paleocristiana di<br />
SANT’AMBROGIO a<br />
Mi<strong>la</strong>no. (IVsec.)<br />
2)Pianta del<strong>la</strong> basilica<br />
di S.Maria<br />
Maggiore.(V sec.)<br />
3)Pianta dell’abbazia<br />
cistercense di<br />
Royaumont. ( VIII<br />
sec.)
Caratteristiche dello spazio<br />
Spazio a sviluppo<br />
longitudinale<br />
architettonico<br />
Spazio a sviluppo<br />
centrale<br />
Utilizzata in Occidente, Utilizzata in Oriente,<br />
tipica dell’architettura tipica dell’architettura<br />
paleocristiana. bizantina.
Lo spazio architettonico del<strong>la</strong> basilica<br />
Navata<br />
centrale<br />
abside transetto<br />
presbiterio<br />
Navata<br />
<strong>la</strong>terale<br />
paleocristiana<br />
nartece<br />
quadriportico<br />
fonte<br />
Per <strong>la</strong> terminologia re<strong>la</strong>tiva al<strong>la</strong> basilica paleocristiana,<br />
vedi apposito glossario.
Glossario basilica paleocristiana<br />
Abside: Struttura architettonica a<br />
pianta semicirco<strong>la</strong>re,<br />
poligonale o quadrata, già esistente<br />
nell’architettura romana,<br />
generalmente situata all’estremità<br />
orientale del<strong>la</strong> chiesa cristiana, a<br />
conclusione del<strong>la</strong> navata centrale e<br />
– anche se non sempre - di quelle<br />
<strong>la</strong>terali, di una cappel<strong>la</strong> o del coro.<br />
Transetto: Navata trasversale che<br />
si interseca con il corpo principale<br />
(longitudinale) del<strong>la</strong> chiesa , dando<br />
all’edificio una forma a croce . Il<br />
transetto può anche essere<br />
suddiviso in navate.<br />
Navata:In una chiesa, è lo spazio<br />
longitudinale compreso tra due file di<br />
colonne o pi<strong>la</strong>stri oppure tra una fi<strong>la</strong><br />
di colonne o di pi<strong>la</strong>stri e un muro<br />
perimetrale.<br />
Presbiterio:Negli edifici di culto e <strong>la</strong> parte<br />
intorno all’ altare riservata al clero,separata<br />
dai fedeli tramite recinzioni.<br />
Quadriportico:Cortile<br />
quadrato,porticato su quattro<br />
<strong>la</strong>ti,antistante <strong>la</strong> facciata del<strong>la</strong> basilica<br />
paleocristiana. E’ il luogo in cui si<br />
riunivano i catecumeni.<br />
Nartece: E’ un atrio porticato, dove,<br />
nell’antica liturgia cristiana stavano i<br />
caticumeni e i penitenti.<br />
Fonte: vasca in genere in pietra o<br />
marmo, di varie forme, che contiene<br />
l’acqua per <strong>la</strong> celebrazione del battesimo
SAN GIOVANNI IN VENERE - ABSIDI<br />
Opposte al<strong>la</strong> facciata principale, si trovano tre absidi,<br />
rivolte a Oriente verso il Golfo di Venere,divise in due livelli<br />
separati tra loro da una fascia decorativa.<br />
Presentano archi e bifore che rive<strong>la</strong>no un certo gusto<br />
arabeggiante. All'interno, le absidi <strong>sono</strong> decorate da<br />
affreschi del duecento.
Aspetti costruttivi<br />
Le tre absidi, delle quali quel<strong>la</strong> centrale è<br />
più <strong>la</strong>rga, sporgente ed alta delle altre<br />
due, <strong>sono</strong> le più monumentali fra quelle<br />
delle abbazie abruzzesi.<br />
Esse <strong>sono</strong> realizzate in muratura e<br />
distinte in due livelli, separate da una<br />
fascia marcapiano decorata con semplici<br />
losanghe intrecciate:<br />
• Al primo livello <strong>la</strong> muratura è mista e<br />
grosso<strong>la</strong>na, mentre al livello superiore è<br />
realizzata con pietre squadrate.<br />
• Una serie di feritoie si apre su tutte le<br />
absidi; in quelle <strong>la</strong>terali ve ne <strong>sono</strong><br />
sovrapposte due, in asse, una nel<strong>la</strong> parte<br />
bassa ed una al livello superiore;<br />
nell’abside di centro, ve ne <strong>sono</strong><br />
quattro, due nel<strong>la</strong> zona basamentale e<br />
due nel<strong>la</strong> parte superiore.
IN BASSO<br />
Aspetti decorativi<br />
La parte inferiore delle tre absidi è decorata da arcatelle<br />
cieche: quelle dell’abside sinistra <strong>sono</strong> ogivali (profilo ad<br />
arco acuto)e le altre a pieno sesto (profilo<br />
semicirco<strong>la</strong>re).<br />
Questa decorazione ad archi e bifore rive<strong>la</strong> un certo gusto<br />
definito normanno o arabeggiante (riconducibile alle<br />
absidi del Duomo di Monreale)<br />
La fascia a losanghe intrecciate è sormontata da una cornice<br />
posta al livello del pavimento del presbiterio.<br />
IN ALTO<br />
I cilindri absidali <strong>sono</strong> coronati da una cornice composta da<br />
una fascia ad archetti al di sopra di una sequenza di<br />
dentelli.<br />
È presente un’altra cornice in corrispondenza del<strong>la</strong> navata<br />
centrale, come accade di solito nelle costruzioni di stile<br />
borgognone.<br />
In oltre ci <strong>sono</strong> monofore a tutto sesto arricchiscono l’abside<br />
mediana, decorate con un arco trilobato in marmo<br />
bianco sorretto da due colonnine tortili con capitelli a<br />
foglie racchiudenti piccole figure umane.<br />
All’interno, le absidi <strong>sono</strong> decorate da affreschi<br />
che rappresentano un documento “assai significativo<br />
del passaggio tra Duecento e Trecento” del<strong>la</strong><br />
produzione pittorica in Abruzzo (M. Andaloro, I<br />
dipinti murali nel<strong>la</strong> cripta di San Giovanni in Venere<br />
presso Fossacesia
ORIGINE E DEFINIZIONE<br />
DI ABSIDE<br />
• Presente già negli edifici civili e<br />
pagani di Roma antica, l’abside<br />
trova il suo sviluppo nell’<br />
architettura cristiana, dove ha<br />
acquisito anche un significato<br />
simbolico.<br />
• Essa infatti, nel<strong>la</strong> chiesa<br />
cristiana, è situata all’ estremità<br />
orientale, a conclusione del<strong>la</strong><br />
navata centrale, che rappresenta<br />
il percorso di purificazione verso<br />
il presbiterio, luogo delle<br />
celebrazioni liturgiche, sede<br />
dell’altare, mensa eucaristica.<br />
• Essa è una costruzione<br />
costruzione a pianta<br />
semicirco<strong>la</strong>re, poligonale o di<br />
altra forma rettilinea<br />
• E’ coperta da una semicupo<strong>la</strong>, il<br />
catino absidale.<br />
CHE COSA SONO LE ABSIDI<br />
TIPOLOGIE DI ABSIDI<br />
• Abside<br />
rettango<strong>la</strong>re<br />
• Abside circo<strong>la</strong>re<br />
• Abside poligonale
Absidi di altre Abbazie Abruzzesi<br />
San Clemente a Casauria è una chiesa<br />
abbaziale che si trova nel comune di<br />
Castiglione a Casauria in provincia di<br />
Pescara.<br />
In essa è presente un’unica abside semicirco<strong>la</strong>re,<br />
con una finestra centrale<br />
squadrata, <strong>la</strong> cui forma è stata modificata<br />
nei restauri.<br />
Il cilindro absidale è scandito da una serie di<br />
colonnine e da una sequenza di archetti su<br />
peducci figurati, che corona l’abside.<br />
La chiesa di S. Liberatore a Majel<strong>la</strong> sorge<br />
all’interno di un suggestivo scenario naturale<br />
immersa tra i boschi che contornano<br />
l’abitato di Serramonacesca.<br />
La chiesa presenta tre absidi semicirco<strong>la</strong>ri.<br />
L’ abside centrale è più alta rispetto alle altre due<br />
ed è decorata da archetti pensili e tre<br />
monofore.<br />
Le absidi <strong>la</strong>terali, più piccole rispetto a quel<strong>la</strong><br />
centrale, presentano un’unica monofora.
STORIA DELLE ABSIDI<br />
L'uso delle absidi nacque nell'architettura romana dal<strong>la</strong> tarda età repubblicana,si<br />
trova nelle basiliche civili d'epoca romana ed anche nelle celle degli edifici temp<strong>la</strong>ri.<br />
In seguito, in epoca tardo-imperiale, si diffuse <strong>la</strong> posizione preminente <strong>sul</strong> <strong>la</strong>to minore,<br />
dove di solito veniva collocata <strong>la</strong> statua o il trono dell'imperatore, che così acquisiva<br />
una valenza ultraterrena e sacrale.<br />
L'architettura delle absidi restò essenzialmente semplice fino all'epoca romanica,<br />
questi elementi, peraltro già presenti in alcune architetture più antiche, si diffusero<br />
nelle basiliche di pellegrinaggio (o santuari), per permettere ai pellegrini di girare<br />
attorno all'altare maggiore dove si trovavano le reliquie del santo, e di pregare nelle<br />
cappelle <strong>la</strong>terali.<br />
Furono presenti durante il medioevo e in epoca gotica, dove, come le pareti delle<br />
chiese, vennero traforate per <strong>la</strong>sciare spazio alle vetrate.<br />
Nel Rinascimento si diffuse un'alternativa all'abside nelle cappelle, <strong>la</strong> scarsel<strong>la</strong>, di<br />
base quadrata o rettango<strong>la</strong>re.
IL CAMPANILE di San Giovanni in Venere<br />
• Si presenta come una tozza torre campanaria a ve<strong>la</strong>, a pianta quadrango<strong>la</strong>re.<br />
• La parte terminale del campanile viene ricondotta al 1344 , cosi come quel<strong>la</strong> del prospetto<br />
principale.<br />
• Ai <strong>la</strong>ti del<strong>la</strong> chiesa si addossano, all’ altezza del presbiterio, due corpi di fabbrica.<br />
• Le due strutture pos<strong>sono</strong> essere inserite nelle edificazioni difensive realizzate da Oderisio I<br />
tra il 1061 e il 1076.<br />
• Quel<strong>la</strong> a sud si presenta oggi come una torre campanaria in comunicazione con <strong>la</strong> cripta e<br />
con <strong>la</strong> chiesa superiore.<br />
• Dallo spessore murario si può presumere che essa dovesse assumere <strong>la</strong> configurazione di<br />
una vera e propria torre.<br />
Campanile di San Giovanni in Venere
CHE COS’E’ IL CAMPANILE<br />
DEFINIZIONE E TIPOLOGIE<br />
Il campanile è una<br />
struttura architettonica che ospita una o<br />
più campane, a diverse tipologie,:;<br />
• più di frequente a torre, in genere<br />
attigua ad una chiesa o ad<br />
un pa<strong>la</strong>zzo pubblico (torre civica).<br />
• o anche a ve<strong>la</strong>, cioè consistente in<br />
un semplice muro elevato sopra <strong>la</strong><br />
copertura del<strong>la</strong> chiesa.<br />
• Una chiesa può anche avere più di<br />
un campanile.<br />
Torre pendente -Pisa<br />
Chiesa di S. Clemente a<br />
Casauria<br />
Torre del<br />
Pa<strong>la</strong>zzo Pubblico<br />
Siena
CAMPANILE A VELA<br />
• La tipologia, detta campanile a ve<strong>la</strong>, è diffusa per lo<br />
più in chiese di modesta dimensione o importanza, o<br />
in casi in cui si voglia evitare l’ ostentazione, come<br />
nelle chiese francescane.<br />
• Essa prevede una struttura costituita da un muro<br />
semplice, elevato sopra <strong>la</strong> copertura del<strong>la</strong> chiesa,<br />
forato da un'apertura nel<strong>la</strong> quale <strong>sono</strong> ospitate le<br />
campane, che vengono mosse da una fune collocata<br />
all'interno del<strong>la</strong> chiesa.<br />
• L'assenza di cassa di risonanza e <strong>la</strong> struttura semplice<br />
fanno sì che non sia possibile alloggiare in questo tipo<br />
di campanile grandi campane, né che il suono giunga<br />
a grande distanza.
CAMPANILE A TORRE<br />
• Il campanile a torre può avere diverse forme, <strong>la</strong> più frequente è quel<strong>la</strong> del<strong>la</strong><br />
pianta quadrata, come nel Campanile di Giotto a Firenze, ma molte chiese del<br />
passato <strong>sono</strong> affiancate da torri campanarie circo<strong>la</strong>ri o anche poligonali, come<br />
quello di San Pietro a Perugia.
ESEMPI DI CAMPANILI A PIANTA QUADRATA in regione<br />
Abbazia di San Liberatore A Maiel<strong>la</strong><br />
Abruzzo, Serramonacesca<br />
Stile romanico (1077).<br />
È uno dei più antichi monasteri dell'Abruzzo.<br />
Il campanile ha struttura divisa in piani da<br />
cornici orizzontali in <strong>la</strong>terizio. Tali cornici <strong>sono</strong><br />
costituite da fi<strong>la</strong>ri di mattoni sempre più<br />
aggettanti e da dentelli a sega.<br />
In ogni dado sovrapposto <strong>sono</strong> impiegate, per<br />
alleggerire <strong>la</strong> struttura muraria, bifore e trifore<br />
accoppiate.<br />
La decorazione è completata da cornici di<br />
scarso aggetto, che con andamento rettilineo<br />
coronano gli archi delle finestre e proseguono<br />
<strong>sul</strong>le quattro facciate, e scodelle policrome<br />
concave probabilmente provenienti da paesi<br />
orientali.<br />
Autori: Nilde – Liceo; Paolo, Everardo – I.C. Foss<br />
S. Maria Maggiore, Lanciano – stile<br />
borgognone (sec. XII e XIII)<br />
Il campanile si innalza al centro del prospetto<br />
posteriore, corrispondente al<strong>la</strong> fabbrica più antica,<br />
quel<strong>la</strong> del sec. XII.<br />
Esso è caratterizzato da tre livelli sovrapposti;<br />
a dividere i tre livelli vi <strong>sono</strong> archetti pensili ed una<br />
cornice in pietra;<br />
ogni livello è artico<strong>la</strong>to da specchiature decorate da<br />
archetti pensili in mattoni, al centro delle quali ci<br />
<strong>sono</strong> delle aperture, trifore con colonnine e archetti<br />
monolitici in pietra e monofore che ospitano le<br />
campane al livello più alto.<br />
La parte basamentale del campanile è realizzata in<br />
pietra e mattoni, mentre quel<strong>la</strong> superiore interamente<br />
in mattoni, rendendo quindi ben distinguibili le due<br />
parti.
Cos’è?<br />
La cripta cristiana è<br />
una camera ricavata<br />
di solito al di sotto<br />
del pavimento di<br />
una chiesa,<br />
contenente le tombe o<br />
le reliquie di santi o<br />
alte cariche del clero.<br />
Quando?<br />
Nasce all'inizio<br />
dell'era cristiana in<br />
Nord Africa e in<br />
Algeria, nel periodo<br />
Bizantino si sviluppa<br />
in Oriente; dopo il<br />
periodo romanico ,<br />
l’uso fu<br />
progressivamente<br />
abbandonato e le<br />
reliquie conservate in<br />
area presbiteriale.<br />
Dov’è?<br />
La cripta si trova<br />
generalmente sotto<br />
l'abside, ma anche<br />
sotto il transetto, o<br />
sotto le cappelle<br />
<strong>la</strong>terali o sotto le<br />
navate.<br />
E oggi…?<br />
Oggi le antiche cripte<br />
vengono utilizzate<br />
per il culto dei santi<br />
le cui reliquie o<br />
spoglie <strong>sono</strong> in esse<br />
conservate, o<br />
semplicemente <strong>sono</strong><br />
diventate luoghi per<br />
<strong>la</strong> celebrazione dei<br />
riti sacri in momenti<br />
partico<strong>la</strong>ri e<br />
ricorrenze cristiane.<br />
A San Giovanni in Venere:<br />
<strong>la</strong> cripta si trova sotto l’area presbiteriale<br />
dell’abbazia ed è artico<strong>la</strong>ta in due navate<br />
trasversali e cinque longitudinali, con tre absidi di cui quel<strong>la</strong><br />
centrale è notevolmente più ampia delle due <strong>la</strong>terali<br />
databile intono al secolo XI.<br />
E’ coperta da campate con crociere a sesto diverso, per<br />
garantire <strong>la</strong> stessa altezza su tutto l’ambiente, che<br />
scaricano il peso su colonne con capitelli diversi,<br />
(testimonianza dell’uso di materiale di spoglio).<br />
All’interno delle absidi si trovano quattro affreschi.<br />
Elementi scultorei <strong>sono</strong> individuabili solo nel<strong>la</strong> vasta<br />
tipologia dei capitelli.
L’iconografia<br />
L’ iconografia è un ramo del<strong>la</strong> storia dell’arte che si occupa del<strong>la</strong> descrizione,<br />
c<strong>la</strong>ssificazione e interpretazione di quanto raffigurato nelle opere d’arte.<br />
In genere analizza personaggi e avvenimenti di carattere religioso.<br />
Nel Medioevo l’arte è vista come una scienza, e gli artisti seguono precise regole nel produrre le opere.<br />
Ogni forma è involucro di un messaggio, e il popolo è in grado di riconoscere chiaramente i personaggi ritratti grazie<br />
agli attributi che presentano.<br />
• La Madonna in trono<br />
Esempi di analisi iconografica<br />
Maria è, insieme a Cristo, <strong>la</strong> figura del Vangelo più frequentemente rappresentata,<br />
nel<strong>la</strong> simbologia è identificata con <strong>la</strong> Chiesa, sposa di Cristo. Nel Duecento e<br />
Trecento si sviluppano vari modi di rappresentare <strong>la</strong> Madonna, fra cui quello del<strong>la</strong><br />
Maestà, in cui el<strong>la</strong> appare in trono con Gesù Bambino <strong>sul</strong>le ginocchia circondata<br />
da angeli e Santi, che assume valenze anche politiche in rapporto al potere delle<br />
diverse città a ordinamento comunale, come Siena con Duccio e Simone Martini<br />
o Firenze con Cimabue. Il baldacchino sopra Maria simboleggia Gerusalemme.<br />
• Cristo in mandor<strong>la</strong><br />
La raffigurazione di Gesù racchiuso in una forma che ricorda quel<strong>la</strong> di una mandor<strong>la</strong><br />
ha una doppia valenza simbolica: alludendo al frutto, e al seme in generale, diventa un<br />
naturale attributo per Colui che è Via,Verità e Vita; come intersezione di due cerchi<br />
essa rappresenta <strong>la</strong> comunicazione fra due mondi, due dimensioni diverse, ovvero il<br />
piano materiale e quello spirituale, che solo Gesù può unire.
La tecnica pittorica: l’affresco<br />
L'affresco è una pittura eseguita <strong>sul</strong>l’ intonaco ancora frescodi una parete.<br />
La tecnica pittorica consiste nel dipingere con pigmenti minerali, stemperati in acqua, su intonaco fresco;<br />
quando nell'intonaco si completa il processo di carbonatazione, il colore ne sarà inglobato,<br />
diventando molto resistente all'acqua e al tempo.<br />
I tre elementi principali <strong>sono</strong>:<br />
- il supporto, di pietra o di mattoni, che deve essere secco e senza dislivelli, altrimenti verrà<br />
uniformato spalmandovi un composto aggiuntivo;<br />
- l'intonaco, è l'elemento più importante, è un impasto di sabbia di fiume, polvere di marmo, calce ed acqua;<br />
- il colore, che viene steso <strong>sul</strong>l'intonaco ancora umido e deve appartenere al<strong>la</strong> categoria degli ossidi,<br />
poiché non deve interagire con <strong>la</strong> reazione di carbonatazione del<strong>la</strong> calce.<br />
Jacopo Lucalzi, Damiano Rocchi, Mary Serraiocco, Miguel Verì, Federica Virtù, C<strong>la</strong>udia Vizzarri
Il panorama nazionale<br />
La pittura medievale si sviluppa dalle forme dell'arte tardoantica, continuando<strong>la</strong>.<br />
L’arte bizantina (330-1453) è sia aspetto dell'arte medievale che asse portante: le sue forme furono quelle diffuse universalmente,<br />
anche se con accezioni regionali diverse di volta in volta.<br />
Le immagini delle chiese diventano biblia pauperum, <strong>la</strong> bibbia dei poveri, cioè comprensibili agli analfabeti.<br />
Opere esemp<strong>la</strong>ri <strong>sono</strong> le croci dipinte e le pale d'altare di Coppo di Marcovaldo, Giunta Pisano, Cimabue:<br />
A seguito di uno sviluppo teologico e filosofico che sottolinea <strong>la</strong> differenza fra oriente e occidente,<br />
<strong>la</strong> rinascenza c<strong>la</strong>ssica del<strong>la</strong> scuo<strong>la</strong> romana e fiorentina (Pietro Cavallini, Jacopo Torriti, Giotto di Bondone)<br />
prende una piega definitiva e compie un passo decisivo verso forme più naturalistiche,<br />
esempio <strong>sono</strong> <strong>la</strong> cappel<strong>la</strong> del Sancta Sanctorum del<strong>la</strong> Sca<strong>la</strong> Santa di Roma, ma soprattutto il ciclo di Assisi.<br />
Con il Gotico, inaugurato in Italia dalle scuole fiorentina e senese, avviene <strong>la</strong> fase terminale del<strong>la</strong> pittura medievale verso forme<br />
sempre più naturalistiche, filosofiche e sempre meno teologiche, fino al Rinascimento.
L’ Abbazia di S. Giovanni in Venere<br />
si trova a Fossacesia, in posizione<br />
panoramica <strong>sul</strong><strong>la</strong> collina che<br />
domina <strong>la</strong> costa.<br />
La chiesa presenta <strong>la</strong> struttura<br />
c<strong>la</strong>ssica delle basiliche di stile<br />
cistercense, con 3 navate separate<br />
da archi ogivali e soffitto a capriate.<br />
L’ABBAZIA<br />
La facciata principale presenta il Portale<br />
del<strong>la</strong> Luna in marmo decorato con<br />
altorilievi.<br />
Al di sotto dell’ altare maggiore si trova<br />
<strong>la</strong> cripta con colonne di epoca romana.<br />
All’ interno, le absidi <strong>sono</strong> decorate<br />
da affreschi del Duecento.
Che cos’è l’abbazia cistercense<br />
L’ architettura cistercense è un architettura tipica<br />
dell’ ordine monastico dei cistercensi, fondato nel<br />
1098 in Francia, da un gruppo di monaci<br />
benedettini, che fanno propri i principi stabiliti da<br />
Bernardo Di Chiaravalle, benedettino che,<br />
rifacendosi al<strong>la</strong> rego<strong>la</strong> originaria di San Benedetto,<br />
impose nuovamente rigore e severità per le<br />
architetture del suo ordine, basati <strong>sul</strong> rifiuto di<br />
ogni decorazione dipinta o scolpita e delle vetrate<br />
variopinte.<br />
Le abbazie che così nacquero e si diffusero in<br />
Europa, dovevano rispecchiare <strong>la</strong> sobria serenità<br />
del<strong>la</strong> rego<strong>la</strong> benedettina sia nel<strong>la</strong> struttura degli<br />
edifici e sia nel<strong>la</strong> loro ubicazione, preferibilmente<br />
in luoghi iso<strong>la</strong>ti.<br />
L’abbazia cistercense è un complesso<br />
di edifici in cui viveva una comunità<br />
cristiana di monaci, monache o canonici<br />
rego<strong>la</strong>ri, governata da un abate o da<br />
una badessa.<br />
Gli spazi più importanti erano <strong>la</strong> chiesa<br />
abbaziale, il chiostro, <strong>la</strong> sa<strong>la</strong> capito<strong>la</strong>re,<br />
il refettorio, lo scrittorio, <strong>la</strong> biblioteca, <strong>la</strong><br />
foresteria e le stanze dell’ abate.<br />
Abbazia di Fossanova Abbazia di Valvisciolo
ABBAZIA DI MONTECASSINO, chiesa<br />
madre dell’Ordine Benedettino<br />
L’ abbazia benedettina di Montecassino fu fondata nel 529 da<br />
S. Benedetto da Norcia.<br />
Per tutto il medioevo fu un importante centro culturale per le<br />
sue biblioteche, gli archivi, le scuole scrittorie e miniaturistiche<br />
che trascrissero e conservarono molte opere dell’ antichità.<br />
Lo sviluppo architettonico dell’ Abbazia si artico<strong>la</strong> su piani<br />
sfalsati, con una grande scalinata dove al<strong>la</strong> fine c’è <strong>la</strong> chiesa<br />
ricca di marmi, policromi e di affreschi .<br />
Il cuore di questa Abbazia è l’ altare maggiore, dove <strong>sono</strong><br />
conservate le reliquie di S. Benedetto e quelle del<strong>la</strong> sorel<strong>la</strong><br />
Sco<strong>la</strong>stica, ritrovate nel 1950.<br />
Per quanto riguarda <strong>la</strong> facciata del<strong>la</strong> chiesa, ci <strong>sono</strong> 3 porte che<br />
portano all’ interno del<strong>la</strong> basilica.<br />
All’ interno ci <strong>sono</strong> 3 navate, <strong>la</strong> navata centrale presenta una<br />
volta che nel ‘600 era affrescata con dipinti andati distrutti nel<br />
tempo. Alle navate <strong>la</strong>terali ci <strong>sono</strong> 4 cappelle. Al centro del<br />
presbiterio c’è l’ altare maggiore dove è posta l’ urna bronzea che<br />
conserva i resti dei 2 santi..
ABBAZIA DI FONTENAY, ispirata<br />
al<strong>la</strong> rego<strong>la</strong> del<strong>la</strong> riforma cistercense<br />
L'Abbazia di Fontenay è<br />
un'abbazia cistercense che si trova<br />
in Francia. L'edificio venne fondato nel 1118.<br />
Essa ha una pianta a croce <strong>la</strong>tina, costituita<br />
da una navata centrale lunga 66 metri e <strong>la</strong>rga<br />
8 e due navate <strong>la</strong>terali e da un transetto lungo<br />
19 metri. Il chiostro è lungo 36 metri e <strong>la</strong>rgo<br />
38. La sa<strong>la</strong> capito<strong>la</strong>re ha un soffitto a volta,<br />
con grossi costoloni. Il grande dormitorio ha<br />
un soffitto costruito in legno di castagno..
ABBAZIA CISTERCENSE DI FOSSANOVA<br />
modello di chiesa gotica in Italia<br />
L'abbazia di Fossanova è situata nei pressi di Priverno, in provincia di Latina.<br />
La facciata è semplice, con un portale strombato. Il portale è poi costituito da un arco a sesto<br />
acuto nel<strong>la</strong> cui lunetta è ripreso il motivo del rosone, mentre nel<strong>la</strong> parte inferiore, un<br />
mosaico cosmatesco sostituisce un'iscrizione dedicata a Federico Barbarossa. Al di sopra<br />
del portale riccamente decorato, <strong>la</strong> facciata è adornata da un grande rosone..<br />
L'oculus ottagonale al centro del frontone è un rifacimento di uno originario che doveva<br />
essere simile a quello dell'abside. La possanza del<strong>la</strong> facciata è accentuata dall'esposizione<br />
dei potenti contrafforti.
ABBAZIA DI CHIARAVALLE – esempio cistercense<br />
in Lombardia<br />
D’alto valore artistico <strong>sono</strong> il chiostro<br />
duecentesco, di cui rimangono il <strong>la</strong>to<br />
settentrionale e due campate orientali,e<br />
<strong>la</strong> Sa<strong>la</strong> capito<strong>la</strong>re con finestroni in cotto<br />
rinascimentali inscritti in quelli romanici<br />
e il Refettorio.<br />
L’Abbazia fu fondata nel 1135<br />
da S. Bernardo, abate di<br />
C<strong>la</strong>irvaux, che dette il nome al<strong>la</strong><br />
zona, prima chiamata<br />
Rovegnano. Al complesso si<br />
accede da una porta realizzata<br />
in una robusta torre<br />
cinquecentesca, <strong>sul</strong> cui fianco<br />
sorge il piccolo oratorio<br />
dedicato a S. Bernardo . La<br />
chiesa ha un impianto a croce<br />
<strong>la</strong>tina, con le tre navate divise<br />
da pi<strong>la</strong>stri cilindrici.
ABBAZIA DI SAN CLEMENTE a CASAURIA, in Abruzzo<br />
Quest’ Abbazia fu fatta erigere dall’ imperatore<br />
Ludovico II, a seguito delle modifiche dell’abate<br />
Leonate quest’ Abbazia divenne un importante centro<br />
di riferimento politico ed economico. La facciata è<br />
preceduta da un portico con colonne a capitelli, sotto<br />
ad esso si aprono 3 portali, di cui il centrale è il più<br />
grande. La lunetta e l’architrave di quest’ ultima <strong>sono</strong><br />
scolpite con immagini del<strong>la</strong> vita di S. Clemente e delle<br />
vicende storiche dell’ Abbazia. La porta in bronzo è<br />
costituita da 72 formelle con varie raffigurazioni<br />
bibliche.<br />
L’ interno è composto da 3 navate con un abside<br />
semicirco<strong>la</strong>re. L’ altare maggiore è costituito da un<br />
sarcofago paleocristiano, sormontato da un ciborio.<br />
La cripta (ambiente destinato a tomba dei<br />
santi e al<strong>la</strong> custodia di sacre reliquie) è<br />
scandita da nove navatelle longitudinali per<br />
due trasversali con le campate che hanno<br />
volta a crociera. Per <strong>la</strong> sua costruzione è<br />
stato utilizzato materiale di spoglio<br />
proveniente da edifici romani.
Fin dai primi giorni del dopoguerra, su molti dei<br />
monumenti abruzzesi,<br />
come in S. Giovanni in Venere a<br />
Fossacesia, si procedette ai restauri<br />
veri e propri, i quali interventi<br />
riguardarono partico<strong>la</strong>rmente:<br />
il rifacimento delle coperture<br />
<strong>la</strong> sistemazione di parti e di arredi interni.<br />
le delicate opere di risarcimento e di<br />
integrazione delle apparecchiature<br />
murarie<br />
Tutte queste operazioni <strong>sono</strong> state compiute<br />
attraverso un’applicazione costante e<br />
diligente dei principi stabiliti al<strong>la</strong> fine dell’Ottocento<br />
in materia di Restauro dei Monumenti e<br />
successivamente approfonditi.<br />
Tali azioni – proprio perché ispirate ai principi<br />
del<strong>la</strong> Carta del Restauro – hanno avuto quindi il<br />
loro esito naturale nel<strong>la</strong> ricostruzione<br />
dell’organismo operata in modo da <strong>la</strong>sciare tracce<br />
chiare dei <strong>la</strong>vori compiuti, semplificando forme,<br />
distinguendo materiali, apponendo sigilli, per<br />
consentire <strong>la</strong> riconoscibilità degli interventi<br />
moderni rispetto a quelli originari.<br />
L’ARCHITETTURA di<br />
SAN GIOVANNI IN<br />
VENERE E GLI<br />
INTERVENTI DI<br />
RESTAURO
Il restauro è un processo di<br />
conservazione o recupero di un<br />
opera d’ arte deteriorata dal<br />
tempo, da agenti atmosferici, da<br />
incuria dell’ uomo o da<br />
manomissioni successive.<br />
CHE COS’E’ IL RESTAURO
LA CARTA DEL RESTAURO – DOCUMENTO FONDAMENTALE PER LA<br />
CORRETTEZZA DEGLI INTERVENTI<br />
Ricordiamo qui le indicazioni del<strong>la</strong> Carta<br />
del Restauro, integrate dalle “ Istruzioni<br />
“del 1938:<br />
esse non contraddicono gli indirizzi di base<br />
e le indicazioni operative contenute nei<br />
documenti precedenti al<strong>la</strong> guerra, infatti<br />
basta confrontare <strong>la</strong> vecchia “ Carta “ e le<br />
successive “ Istruzioni ”, con <strong>la</strong> Carta del<br />
1964 per rendersi conto che le proiezioni<br />
operative del documento non<br />
rappresentano un cambiamento di rotta<br />
rispetto a quelle precedenti, bensì un loro<br />
prudente adeguamento caratterizzato da<br />
specificazioni ed accentuazioni derivanti da<br />
presupposti culturali più aggiornati.<br />
Con questo quindi si intende affermare che<br />
i <strong>la</strong>vori di ricostruzione del dopoguerra.<br />
Marika Krebely, Andrea Di Stefano e Fabio Di Rado
Progetto “<strong>Io</strong> <strong>sono</strong>, <strong>noi</strong> <strong>siamo</strong>…<strong>la</strong> <strong>nostra</strong> città”<br />
D3 – Vivere il Monumento<br />
Laboratorio didattico di <strong>Studio</strong> e Ricerca <strong>sul</strong> Monumento<br />
Abbazia di San Giovanni in Venere<br />
Fossacesia, 28 febbraio 2012<br />
LEZIONE POMERIDIANA<br />
Scuo<strong>la</strong> Secondaria 1° grado,<br />
Fossacesia<br />
Pao<strong>la</strong> Ardizzo<strong>la</strong><br />
Storico dell’architettura<br />
Gabriele d’Oltremare<br />
Land drafter & designer
Equilibrio compositivo e<br />
umanità dell’abbazia<br />
medievale<br />
Note in merito
Un’abbazia conosciuta<br />
in epoca coeva<br />
La carta del Mare di Piri Reis
Piri Reis, Il libro del mare: Ancona e il Conero
Piri Reis, il libro del mare: Porto Recanati, Porto Civitanova,<br />
Santuario del<strong>la</strong> Madonna di Loreto
Piri Reis, Il libro del Mare: tratto di costa abruzzese fra Fossacesia e Francavil<strong>la</strong>
Abbazia e Cattedrale
Abbazia di Montecassino
Badia Morronese, Sulmona
Cattedrale di Santa Maria Maggiore<br />
Lanciano
La verità è nel simbolo
Labirinto del<strong>la</strong> Cattedrale di Chartres, Francia
L’anima del pellegrino cristiano viene guidata dal<strong>la</strong> Paro<strong>la</strong> di<br />
Dio<br />
(incisione 1622)
Cristo in Mandor<strong>la</strong><br />
La vesica piscis o mandor<strong>la</strong> è un simbolo di forma ogivale ottenuto da due<br />
cerchi dello stesso raggio, intersecantisi in modo tale che il centro di ogni<br />
cerchio si trova <strong>sul</strong><strong>la</strong> circonferenza dell'altro.<br />
Come intersezione di due cerchi essa rappresenta <strong>la</strong> comunicazione fra due<br />
mondi, due dimensioni diverse, ovvero il piano materiale e quello spirituale,<br />
l'umano e il divino. Gesù, il Verbo divino fattosi uomo, diventa il solo Mediatore<br />
fra le due realtà, il solo pontefice fra il terrestre e il celeste, e come tale viene<br />
rappresentato all'interno dell'intersezione
Ἰχϑύς<br />
Si definisce ichthýs il simbolo di un pesce stilizzato, formato da due curve che<br />
partono da uno stesso punto.<br />
Le comunità cristiane adottarono questo simbolo probabilmente per rievocare il<br />
brano evangelico in cui Gesù si rivolge a Simone dicendogli «μή φοβού ἀπὸ<br />
τοῦ νῦν ἀνθρώπους ἔσῃ ζωγρῶν»: Non temere; d'ora in poi sarai pescatore di<br />
uomini (Lc 5, 10).<br />
Come rive<strong>la</strong> Agostino d'Ippona ne La città di Dio, inoltre, il termine greco Ἰχϑύς<br />
è a sua volta l'acronimo delle parole<br />
Iesùs CHristòs THeù HYiòs Sotèr
L’àncora<br />
Simbolo del<strong>la</strong> speranza cristiana. In una Lettera di san Paolo agli<br />
Ebrei (6, 18-19) si legge che l’ancora a cui affidarsi è Cristo,<br />
poichè " in essa (<strong>la</strong> speranza) infatti <strong>noi</strong> abbiamo l‘àncora del<strong>la</strong><br />
<strong>nostra</strong> vita". Spesso l'ancora è unita o si sostituisce al<strong>la</strong> croce.
Pavone<br />
(bassorilievo di epoca Longobarda)<br />
Simbolo del<strong>la</strong> resurrezione e del<strong>la</strong> vita eterna. L’immagine è legata al fatto che<br />
le piume di questo animale cadono in autunno e rinascono in primavera.<br />
Secondo una leggenda, <strong>la</strong> carne del pavone non si decompone.
Il chi rho<br />
Il monogramma di Cristo o<br />
Chi Rho (o CHRISMON) è una<br />
combinazione di lettere dell’alfabeto greco,<br />
che formano una abbreviazione del nome<br />
di Gesù. Esso viene tradizionalmente usato<br />
come simbolo cristiano ed è uno dei<br />
principali cristogrammi.<br />
Il simbolo si compone di due grandi lettere<br />
sovrapposte, <strong>la</strong> 'X' e <strong>la</strong> 'P'. Corrispondono,<br />
rispettivamente, al<strong>la</strong> lettera greca 'χ' ('chi',<br />
che si legge kh, aspirata) e 'ρ' ('rho', che si<br />
legge r).<br />
Queste due lettere <strong>sono</strong> le iniziali del<strong>la</strong><br />
paro<strong>la</strong> 'Χριστός' (Khristòs), l'appel<strong>la</strong>tivo<br />
di Gesù, che in greco significa "unto" e<br />
traduce l'ebraico "messia".<br />
Ai <strong>la</strong>ti di queste due lettere, se ne trovano<br />
molto spesso altre due: una 'α' ed un 'ω',<br />
alfa ed omega, prima ed ultima lettera<br />
dell'alfabeto greco, usate come simbolo del<br />
principio e del<strong>la</strong> fine.
Asse del mondo o albero cosmico
Misura, costruzione e<br />
corporazione
Cristo come geo-metros, sommo Creatore
Lo gnomone,<br />
strumento misuratore per eccellenza in epoca antica
Applicazione dello gnomone nei disegni di Filippo<br />
Brunelleschi, uno dei più grandi architetti del ‘400 italiano
Simbolo del<strong>la</strong> massoneria<br />
(dall’Inglese masonry = opera muraria)
Simboli delle corporazioni<br />
edili medievali
I giovani mastri muratori e falegnami in Germania oggi.<br />
Come in epoca medievale hanno<br />
l’obbligo, solo per tre anni, di<br />
spostarsi di cantiere in cantiere<br />
senza mai tornare a casa.
Oggi anche lo donne <strong>sono</strong> ammesse a questa pratica dura ma affascinante,<br />
che offre molte possibilità di apprendimento e di contatti umani
Grazie per <strong>la</strong> vostra attenzione<br />
per contatti e approfondimenti<br />
Pao<strong>la</strong> Ardizzo<strong>la</strong><br />
presidente@musaa.it<br />
3479689410<br />
Gabriele d’Oltremare<br />
segretario@musaa.it<br />
334 1880627
PROGETTO CENTOSCUOLE – IO SONO, NOI SIAMO…LA NOSTRA CITTA’<br />
Lanciano storica e <strong>la</strong> Chiesa di Santa<br />
Maria Maggiore – visita guidata<br />
Laboratorio D3 – <strong>Studio</strong> e <strong>ricerca</strong> <strong>sul</strong><br />
<strong>monumento</strong><br />
Attività di contestualizzazione<br />
Visita guidata al centro storico di Lanciano
Perché <strong>la</strong> visita?<br />
• Gli alunni delle due scuole visitano il centro<br />
storico di Lanciano, per effettuare un’attività di<br />
contestualizzazione dell’Abbazia di San Giovanni<br />
in Venere:<br />
• stabiliscono analogie e differenze sia dal punto di<br />
vista architettonico che dal punto di vista<br />
urbanistico con <strong>la</strong> Chiesa di Santa Maria<br />
Maggiore, stilisticamente affine ma<br />
funzionalmente diversa, essendo una «chiesa di<br />
città».
L’abitato di Lanciano in re<strong>la</strong>zione al TERRITORIO<br />
Ri<strong>sul</strong>ta molto chiara <strong>la</strong> «forma»<br />
del<strong>la</strong> città, distinta nelle sue due<br />
parti :<br />
• <strong>la</strong> città storica, circoscritta in blu,<br />
che si sviluppa sui tre colli:<br />
Erminio, del<strong>la</strong> Selva e Petroso<br />
• La città moderna (1^ espansione<br />
sec. XX), circoscritta in rosso, che<br />
si sviluppa <strong>sul</strong><strong>la</strong> Piana del<strong>la</strong> Fiera,<br />
con un evidente impianto<br />
rego<strong>la</strong>re a griglie ortogonale.<br />
PLANIMETRIA TRATTA DALLA CARTA<br />
TERRITORIALE DELL’I.G.M. (Istituto<br />
Geografico Militare), sca<strong>la</strong> 1:25.000,<br />
1957
Il centro storico di<br />
Lanciano<br />
Itinerario di visita
Lanciano «emporio di frentani»<br />
• La visita conduce i ragazzi attraverso vicoli,<br />
strade e piazze del<strong>la</strong> città medievale, uno dei<br />
centri più importanti del territorio frentano,<br />
luogo di attrazione, fra gli altri, per mercanti<br />
(<strong>la</strong> città è nota sin dall’antichità per le sue<br />
fiere) e per religiosi (vi <strong>sono</strong> insediate sin dai<br />
secoli avanti il mille, diverse comunità di frati,<br />
in partico<strong>la</strong>re dal XIII sec., francescani ed<br />
agostiniani).
Lo sviluppo urbanistico<br />
• Le nove porte del<strong>la</strong> città medievale danno <strong>la</strong> misura del<strong>la</strong> sua vivacità e<br />
del<strong>la</strong> assidua frequentazione da parte degli abitanti del contado, di<br />
visitatori e mercanti, del<strong>la</strong> varietà del<strong>la</strong> vita artigianale e commerciale che<br />
entro le sue mura si svolgeva, anche del<strong>la</strong> ricchezza che numerose famiglie<br />
andavano accumu<strong>la</strong>ndo, in partico<strong>la</strong>re grazie al commercio.<br />
• Proprio lo sviluppo del<strong>la</strong> vita urbana, a partire dai tempi del dominio<br />
longobardo in poi, portò al progressivo ampliamento del territorio<br />
urbanizzato, fino al<strong>la</strong> sua definizione entro il XIII secolo, nei quattro<br />
quartieri di Lancianovecchia (il più antico), Civitanova(risale al sec. X),<br />
Sacca (rappresenta l’espansione del precedente) e Borgo (sec. XIII).<br />
• Un momento di partico<strong>la</strong>re importanza è quello del<strong>la</strong> dominazione di<br />
Federico II, che nel XIII secolo procede ad una definizione e<br />
monumentalizzazione dei quartieri Civitanova e Borgo, attraverso <strong>la</strong><br />
realizzazione di monumenti (ricostruzione di S. Maria Maggiore) o il<br />
completamento di edifici preesistenti (facciate e portali delle Chiese di S.<br />
Agostino e S. Lucia).
La CHIESA DI SANTA MARIA<br />
MAGGIORE A LANCIANO<br />
Interno, navatel<strong>la</strong>, con volta a semibotte<br />
sestiacuta (derivazione borgognona)<br />
Pianta del<strong>la</strong> chiesa, con l’indicazione delle<br />
fasi di ampliamento
Le volte a crociera con costoloni
Partico<strong>la</strong>ri delle volte a crociera<br />
La spazialità dell’ edificio monumentale è caratterizzata dal<strong>la</strong> suddivisione in tre navate di cui<br />
<strong>la</strong> maggiore è voltata a crociera e le due <strong>la</strong>terali <strong>sono</strong> invece coperte da volte a semi-botte<br />
dal profilo ogivale: l’una e le altre si riconoscono di diretta derivazione borgognona, non<br />
mediate cioè attraverso le architetture benedettine del<strong>la</strong> scuo<strong>la</strong> di S.Liberatore, che<br />
ritroviamo in gran parte delle chiese abruzzesi del trecento. In partico<strong>la</strong>re, <strong>la</strong> navatel<strong>la</strong> del<br />
<strong>la</strong>to nord, abbattuta nel 1540 per l’ampliamento dell’edíficio, è stata ripristinata, nel restauro<br />
di fine anni sessanta, mentre l’altra, che era stata ripartita in cappelle è stata con gli stessi<br />
<strong>la</strong>vori restituita al<strong>la</strong> sua funzione e spazialità originarie.
La volta «ad ombrello» costolonata, delimitata<br />
da un arco trionfale, <strong>sul</strong> presbiterio ottagonale<br />
Riflessioni <strong>sul</strong> valore simbolico del numero 8 e del<strong>la</strong> forma ottagonale e <strong>sul</strong><strong>la</strong><br />
forma ottagonale nell’architettura sacra, dai Battisteri a S. Maria del Fiore.
LA FACCIATA con il portale monumentale trecentesco di<br />
Francesco Petrini e quel<strong>la</strong> re<strong>la</strong>tiva all’ampliamento<br />
cinquecentesco
San Giovanni in Venere<br />
e e<br />
Santa Maria Maria Maggiore a<br />
Lanciano Lanciano<br />
Confronto tra una chiesa abbaziale<br />
suburbana e una chiesa cattedrale urbana<br />
Micolucci Valentina, Caporale Moreno, De Santis Antonio
San Giovanni in Venere<br />
chiesa “suburbana”<br />
Questa abbazia, come tutte le altre, ovunque si<br />
trovino, è nata come un luogo dedicato al<strong>la</strong><br />
preghiera, alle attività meditative e<br />
spirituali, esclusivamente riservato agli<br />
uomini di chiesa, per questo<br />
è situata in un’area extraurbana rispetto<br />
all’abitato di Fossacesia, cui resta collegata<br />
da un lungo viale.<br />
Essa comprende: <strong>la</strong> chiesa, aperta anche al<strong>la</strong><br />
popo<strong>la</strong>zione durante le funzioni; il chiostro,<br />
uno spazio aperto circondato da un porticato<br />
e con al centro aiuole fiorite e il pozzo; spazio<br />
importante soprattutto per i benedettini; il<br />
dormitorio, luogo comune di riposo; il<br />
refettorio, il luogo comune dedicato ai pasti; <strong>la</strong><br />
foresteria per gli ospiti.<br />
Probabilmente, in passato, c’erano anche, secondo<br />
il modello ovunque diffuso, <strong>la</strong> biblioteca,<br />
l’infermeria e <strong>la</strong> farmacia, queste ultime<br />
affidate ad un monaco-medico.<br />
Santa Maria Maggiore – chiesa “urbana”<br />
Edificata nel cuore storico del<strong>la</strong> città di Lanciano a<br />
partire dal sec. X, <strong>la</strong> chiesa ha assunto assumere le<br />
forme borgognone nel secolo XIII, durante il<br />
dominio di Federico II.<br />
Tali forme <strong>sono</strong> state riportate al<strong>la</strong> luce con un<br />
impegnativo restauro negli anni sessanta del<br />
novecento, in considerazione dell’importanza che<br />
rivestivano per <strong>la</strong> storia dell’architettura di tutta <strong>la</strong><br />
regione.<br />
Per le sue caratteristiche costruttive e morfologiche, <strong>la</strong><br />
Chiesa di S. Maria Maggiore può ritenersi<br />
espressione del<strong>la</strong> diretta volontà imperiale di<br />
<strong>la</strong>sciare nel<strong>la</strong> città una testimonianza di grande<br />
pregio e significatività in re<strong>la</strong>zione con <strong>la</strong> figura<br />
dell’imperatore stesso,<br />
Federico II, “homo novus”, che dona al<strong>la</strong> città un<br />
<strong>monumento</strong> dal chiaro valore simbolico di<br />
“luogo del<strong>la</strong> rinascita”, collegata al<strong>la</strong> forma<br />
ottagonale del presbiterio, di norma utilizzata nei<br />
battisteri, luogo del<strong>la</strong> “nascita” spirituale del<br />
cristiano.
La primitiva chiesa di Santa Maria Maggiore<br />
e <strong>la</strong> 1^ fase di espansione in Civitanuova<br />
Al<strong>la</strong> fine dell’XI secolo, nel<strong>la</strong> città<br />
di Lanciano viene acquistando<br />
grande importanza il ceto<br />
mercantile e tornavano ad<br />
essere organizzate le antiche<br />
fiere (nundinae romane); il<br />
quartiere di Civitanova, che<br />
ospita <strong>la</strong> chiesa di Santa Maria<br />
Maggiore, si stava costituendo<br />
<strong>sul</strong> Colle del<strong>la</strong> Selva, in seguito<br />
all’accrescimento demografico.<br />
mancava ancora però un<br />
edificio religioso, così si dà<br />
inizio al<strong>la</strong> costruzione del<strong>la</strong><br />
prima chiesa romanica<br />
dedicata al<strong>la</strong> vergine Maria.<br />
QUARTIERE CIVITANOVA
La chiesa di Santa Maria Maggiore:<br />
l’ edificio cistercense e lo sviluppo urbano<br />
CHIESA DI SANTA MARIA MAGGIORE<br />
Agli inizi del XIII secolo,<br />
prende avvio l’espansione<br />
del quartiere Sacca.<br />
In corrispondenza di questo<br />
fenomeno, collochiamo<br />
il cantiere<br />
federiciano-borgognone<br />
di tipo cistercense<br />
del<strong>la</strong> chiesa di Santa<br />
Maria Maggiore<br />
riedificata ed ampliata,<br />
per divenire polo<br />
aggregante del quartiere e<br />
cattedrale del<strong>la</strong> città.
Chiesa di<br />
SANTA MARIA<br />
MAGGIORE<br />
Lanciano
Il portale <strong>la</strong>terale del<strong>la</strong> Chiesa di S. Maria<br />
Maggiore<br />
Il portale <strong>la</strong>terale,<br />
risalente al<strong>la</strong> prima metà<br />
del XIII secolo, mostra un<br />
notevole interesse<br />
storico-artistico per i<br />
modi c<strong>la</strong>ssici del<strong>la</strong><br />
risoluzione stilistica<br />
riconducibile al<strong>la</strong><br />
Rinascenza di epoca<br />
federiciana, il che ci<br />
permette di stabilire<br />
analogie con il portale di<br />
Castel del Monte (noto<br />
pa<strong>la</strong>zzo extraurbano di<br />
forma ottagonale di<br />
Federico II in Puglia).<br />
Portale di CASTEL DEL MONTE<br />
Portale di S. MARIA MAGGIORE
Il portale monumentale<br />
PORTALE MONUMENTALE<br />
Nel 1317 il Petrini<br />
conclude il processo di<br />
riedificazione dando al<strong>la</strong><br />
chiesa il magnifico<br />
portale monumentale, un<br />
nuovo accesso più<br />
comodo a valle, verso <strong>la</strong><br />
città: <strong>la</strong> chiesa è intito<strong>la</strong>ta<br />
a S. Maria Assunta e<br />
prende a svolgere il ruolo<br />
di duomo del<strong>la</strong> città, che<br />
le competerà fino al 1389.
La torre campanaria<br />
Nel 1331, in re<strong>la</strong>zione al nuovo<br />
titolo del<strong>la</strong> chiesa, divenuta<br />
duomo del<strong>la</strong> città, viene<br />
modificato il campanile<br />
romanico che però non assume<br />
solo il ruolo di torre<br />
campanaria, ma quello di<br />
emergenza cittadina (utile,<br />
oltre che per ricordare le<br />
festività religiose e le<br />
celebrazioni liturgiche, anche<br />
per il richiamo dei cittadini in<br />
occasione di ca<strong>la</strong>mità naturali<br />
o altre emergenze).<br />
La torre verrà poi ristrutturata<br />
al<strong>la</strong> sommità nel 1714.<br />
TORRE CAMPANARIA
LAB. D3 – STUDIO E RICERCA SUL MONUMENTO<br />
ATTIVITA’ DI CONTESTUALIZZAZIONE – VIAGGIO D’ISTRUZIONE ALLE ABBAZIE DI SAN CLEMENTE A<br />
CASAURIA E SAN LIBERATORE A MAJELLA – 11 MAGGIO 2012<br />
SCHEDA DI LAVORO PER IL RILIEVO METRICO DI ELEMENTI ARCHITETTONICI E<br />
SPAZIALI DI SAN LIBERATORE A MAJELLA<br />
PREMESSA – OSSERVAZIONI E CONSIDERAZIONI SUGLI ASPETTI SPAZIALI E COSTRUTTIVI<br />
L’edifico di San Liberatore è contraddistinto da<br />
un impianto fortemente unitario, dovuto al<strong>la</strong><br />
nitida e precisa definizione stereometrica degli spazi, dove tutti gli elementi obbediscono ad<br />
una geometria essenziale: libera stesura delle superfici, nuda semplicità dei pi<strong>la</strong>stri, taglio vivo degli archi e<br />
degli spigoli.<br />
La grande nave, con le poderose arcate procede verso il fondale secondo una progressione prospettica che<br />
culmina nel<br />
Presbiterio, individuato dai pi<strong>la</strong>stri cruciformi<br />
Ricostruita all’inizio del sec. XI, <strong>sul</strong> preesistente monastero , esistente già nell’anno 856, <strong>la</strong> chiesa di San Liberatore<br />
è realizzata secondo una forma semplice, essenziale, contenuta, perfetta nel suo ritmo ampio, sicuro e concluso.<br />
Tale forma è determinata da due file di pi<strong>la</strong>stri a pianta rettango<strong>la</strong>re e dal rapporto proporzionale fra le tre<br />
dimensioni del<strong>la</strong> navata, che assicura re<strong>la</strong>zioni costanti e modu<strong>la</strong>ri fra di esse.<br />
Lo sviluppo spaziale-dimensionale del<strong>la</strong> chiesa è infatti governato da un impianto rego<strong>la</strong>re ortogonale, con una<br />
progressione uniforme, <strong>la</strong> cui unità di misura è il cùbito* romano.<br />
* CUBITO: Unità di misura usata nell'antichità, e pari a circa 44,4 cm, corrispondente al<strong>la</strong> misura di un avambraccio,<br />
inteso come DISTANZA DAL GOMITO ALLA PUNTA DEL DITO medio.<br />
Si può dunque dire che <strong>la</strong> misura del cubito fosse di circa mezzo metro.<br />
STORIA DEL CUBITO nel mondo antico<br />
Il cubito ebraico era di 44,45 cm,<br />
Il cubito egiziano era un po' più lungo (44,7 cm), ed era di due spanne o sei palmi.<br />
Il cubito lungo o reale era invece di sette palmi<br />
Il cubito romano era uguale al cubito ebraico
diversa nel carsattere dedilizio<br />
CHIESA DI SAN LIBERATORE - Le misure riportate <strong>sono</strong> in cùbiti romani<br />
CHIESA DI MONTECASSINO<br />
Rappresenta <strong>la</strong> “chiesa madre” dell’Ordine e dal suo Monastero dipendeva San Liberatore, infatti è l’Abate<br />
Desiderio di Montecassino che promuove <strong>la</strong> ricostruzione del<strong>la</strong> chiesa.<br />
Le due chiese si corrispondono nelle dimensioni, sempre espresse in cùbiti romani ma:<br />
<strong>la</strong> Chiesa di S. Liberatore mostra <strong>la</strong> sua originalità rispetto al<strong>la</strong> “chiesa madre” dell’Ordine, di cui NON RIPETE né il<br />
tipo né le forme: l’Abate Desiderio di Montecassino, infatti, vuole che sia grande e corrispondente nelle dimensioni a<br />
quel<strong>la</strong> cassinese, ma diversa nel carattere edilizio e nel<strong>la</strong> risoluzione architettonica perché destinata a sorgere in una<br />
regione diversa e in un ambiente sociale e culturale assai differente.<br />
Essa doveva rappresentare l’ordine rinnovato in una sede monastica centro di p reghiera, ma anche di <strong>la</strong>voro, cultura<br />
e vita civile, nel cuore di un territorio montuoso e solitario, di fronte al<strong>la</strong> montagna solenne e austera, considerata<br />
sede del<strong>la</strong> santità.<br />
La chiesa , per questo, sorge, nell’insieme, più semplice e maestosa, in quanto volutamente essenziale, con pi<strong>la</strong>stri al<br />
posto di colonne e possente nelle sue poderose strutture fortemente scandite. Da ciò deriva <strong>la</strong> rinuncia alle<br />
raffinatezze delle basiliche romano-cassinesi e <strong>la</strong> riduzione dell’ampio transetto a semplice presbiterio, il rifiuto delle<br />
arcate su colonne, del<strong>la</strong> decorazione musiva e scultorea, IL RIFIUTO DI QUALSISASI RIFERIMENTO ALLA TRADIZIONE<br />
Si può dunque dire che LA CHIESA DI SAN LIBERATORE PROPONE UN MODELLO ORIGINALE DI ARCHITETTURA<br />
ISPIRATA DA UN’IDEA CLASSICA DI GRANDIOSITA’ E SOLENNITA’<br />
COSI’ NASCE IL ROMANICO NELLA NOSTRA REGIONE: AUSTERO E GRANDIOSO.
APPROFONDIMENTO PER METTERE MEGLIO IN RELAZIONE LE ABBAZIE<br />
ABRUZZESI, E QUELLA DI SAN LIBERATORE IN PARTICOLARE, CON L’ABBAZIA<br />
“MADRE” DI MONTECASSINO<br />
ABBAZIA DI MONTECASSINO – BREVE STORIA (rie<strong>la</strong>borata da siti internet)<br />
Questo celeberrimo Monastero di rego<strong>la</strong> benedettina, venne fondato nel 529 da San<br />
Benedetto da Norcia in persona, nel luogo collinare in cui esisteva un'antica torre ed un<br />
tempio romano, dedicato ad Apollo.<br />
Nel corso dei secoli, l'Abbazia è stata più volte distrutta, riedificata, modificata, ma ha<br />
mantenuto per centinaia di anni un'importanza grandissima nel territorio dell'Italia centro<br />
meridionale, e non solo.<br />
La scuo<strong>la</strong> scrittoria di Montecassino fu una delle più importanti del Medioevo, e grazie<br />
all'opera dei suoi amanuensi, innumerevoli opere preziose <strong>sono</strong> giunte fino a <strong>noi</strong>. Gli<br />
archivi e le biblioteche di Montecassino <strong>sono</strong> leggendari: incunaboli, codici miniati,<br />
opere in <strong>la</strong>tino ed in volgare, testi di letteratura c<strong>la</strong>ssica, testi sacri, per <strong>la</strong><br />
grandissima parte miniati finemente dai monaci, costituivano un tesoro di valore<br />
incalco<strong>la</strong>bile.<br />
L'Abate più famoso, dopo San Benedetto naturalmente, fu Desiderio, poi Papa<br />
Vittore III, il quale nel XI secolo, ordinò <strong>la</strong> completa ricostruzione del complesso<br />
abbaziale e fece decorare, con pregevoli mosaici ed affreschi, <strong>la</strong> Chiesa.<br />
Molti dei materiali costruttivi venivano da Roma e l'Abate fece venire da Bisanzio i<br />
mosaicisti più esperti, per <strong>la</strong> realizzazione delle opere destinate al tempio del<br />
Monastero.<br />
Grandissima parte dell'iconografia pittorica dell'Ecclesia Monasterii Casinensis è andata<br />
perduta nelle successive ricostruzioni, ma sappiamo che includeva un ciclo dedicato al<br />
Vecchio ed uno al Nuovo Testamento.<br />
Al<strong>la</strong> metà del '300, Montecassino venne di nuovo ricostruita, in seguito ai danni<br />
ingentissimi riportati nei sismi che sconvolsero <strong>la</strong> zona all'epoca.<br />
Nel secolo XVII, Luca Giordano e Francesco Solimena le conferirono, con le<br />
modifiche da loro apportate, l'aspetto tipico del barocco napoletano, che è quello<br />
con il quale l'Abbazia è giunta fino a <strong>noi</strong>, o almeno ai nostri padri, nel 1944.<br />
Un maestoso edificio sacro che comunicava maestosità e magnificenza, forse non molto in<br />
linea con <strong>la</strong> semplicità predicata da San Benedetto, ma sicuramente aderente al<strong>la</strong><br />
posizione di preminenza nel<strong>la</strong> storia locale, che nei secoli il Monastero aveva assunto.<br />
Nel 1944 poi, durante <strong>la</strong> famosa Battaglia di Montecassino, il complesso monastico<br />
venne pesantemente bombardato da parte delle Forze Alleate, che lo credevano in<br />
mano ai Tedeschi. Fortunatamente, l'archivio ed i documenti bibliografici più famosi<br />
erano stati nel frattempo posti in salvo.<br />
La ricostruzione, iniziata nel Dopoguerra, ha mirato a riportare Montecassino alle<br />
forme con le quali ci era giunto prima dei danni inferti durante <strong>la</strong> guerra.<br />
.
LABORATORIO D3 – <strong>Studio</strong> e <strong>ricerca</strong> <strong>sul</strong> <strong>monumento</strong><br />
CONTESTUALIZZAZIONE - VISITA ALLE ABBAZIE – preparazione /DOCUMENTAZIONE GENERALE<br />
Abbazia di San Clemente a Casauria, XII secolo – informazioni generali<br />
L'abate benedettino Grimoaldo intraprese <strong>la</strong> ricostruzione del<strong>la</strong> chiesa che fu riconsacrata solennemente<br />
nel 1105. I <strong>la</strong>vori di ricostruzione terminarono so<strong>la</strong>mente nel<strong>la</strong> seconda metà del XII secolo sotto <strong>la</strong> conduzione<br />
dell'abate Leonate.<br />
Nel 1348 subì gravi danni a causa del terremoto. Si perdettero splendidi partico<strong>la</strong>ri architettonici. Nel restauro che si fece<br />
del<strong>la</strong> chiesa cento anni dopo il terremoto, molte parti non cadute vennero soppresse o mascherate da nuove costruzioni.<br />
La facciata è preceduta da un portico con colonne a capitelli; sotto ad esso si aprono tre portali, di cui il centrale è il<br />
maggiore per dimensioni. La lunetta e l'architrave di quest'ultima <strong>sono</strong> scolpite con immagini del<strong>la</strong> vita di San Clemente e<br />
delle vicende storiche dell'Abbazia.<br />
L'interno è composto da tre navate con abside semicirco<strong>la</strong>re, che conducono al pulpito. L'altare maggiore è costituito da<br />
un sarcofago paleocristiano, sormontato da un ciborio del XIV secolo.<br />
Nel<strong>la</strong> cripta due recinti absidali dividono le zone del<strong>la</strong> chiesa primativa da quel<strong>la</strong> ricostruita dai Benedettini nel XII<br />
secolo.<br />
L’Imperatore Ludovico II fa sorgere l’Abbazia nell’in<strong>sul</strong>a casauriense, vicino una chiesa dedicata a S. Quirico e lungo le<br />
sponde del fiume Pescara che sin dall’801 aveva diviso naturalmente i confini dei ducati longobardi di Spoleto e<br />
Benevento.<br />
L’Abbazia, situata nei pressi del<strong>la</strong> via C<strong>la</strong>udio – Valeria lungo uno dei percorsi dei tratturi che da l’Aqui<strong>la</strong> portavano a<br />
Foggia (ed è conosciuta l’importanza avuta dal<strong>la</strong> pastorizia nell’economia abruzzese), costituiva un passaggio obbligato<br />
per quanti, diretti nelle zone costiere dell’Adriatico, avevano rapporti di commercio con l’Oriente e per i viandanti diretti al<br />
Santo Sepolcro di Gerusalemme o al<strong>la</strong> spelonca dell’arcangelo Michele <strong>sul</strong> Gargano: il culto delle reliquie, ragione e<br />
meta dei pellegrinaggi, rappresentava infatti una delle caratteristiche del<strong>la</strong> religione cattolica del medioevo.<br />
Strategicamente importante, come l’Abbazia di S. Vincenzo al Volturno o quel<strong>la</strong> di Montecassino a cui l’imperatore offre<br />
<strong>la</strong> sua alta protezione considerandoli i posti più avanzati del dominio franco nell’Italia meridionale, rappresenta un<br />
caposaldo per azioni di offesa e difesa: l’aspetto religioso nel<strong>la</strong> fondazione non appare quindi disgiunto da quello politico<br />
– economico.<br />
L’abbazia, dotata inizialmente di dodici moggi di terreno appartenenti al<strong>la</strong> chiesa di Penne, l’anno successivo arriva a<br />
millenovecento fino a comprendere con Lupo, abate fino al 911, quasi tutta <strong>la</strong> regione estendendo le sue proprietà al<br />
mare Adriatico, al massiccio del<strong>la</strong> Maiel<strong>la</strong> e ai fiumi Pescara e Trigno.
L’abbazia di S. Clemente è stata una del<strong>la</strong> più potenti abbazie abruzzesi. Si hanno molte notizie <strong>sul</strong><strong>la</strong> sua storia grazie ad un famoso<br />
manoscritto, il Chronicon Casauriense, un libro che ripercorre le vicende dell’abbazia dalle origini al 1182.<br />
Essa fu costruita nel IX secolo per volontà dell’imperatore Ludovico II e fu terminata nelle forme che ancora oggi pos<strong>siamo</strong> ammirare<br />
molto più tardi, nel XIII secolo.<br />
La facciata è animata da un imponente portico. Nel<strong>la</strong> parte inferiore aprono tre arcate dal profilo a tutto sesto e a sesto acuto, nel<strong>la</strong><br />
parte superiore troviamo quattro bifore che illuminano il corrispondente oratorio dedicato a San Michele Arcangelo, al<strong>la</strong> Santa Croce e a<br />
S. Tommaso Beckett. Le aperture degli archi, fittamente decorati nei capitelli, <strong>sono</strong> interval<strong>la</strong>te da quattro semicolonne che sostengono<br />
le sculture raffiguranti i simboli degli Evangelisti. Oltrepassato il portico, coperto da volte a crociera, si pos<strong>sono</strong> ammirare il portale<br />
maggiore ed i portali <strong>la</strong>terali.<br />
Il portale maggiore offre una complessa decorazione scolpita: nel<strong>la</strong> lunetta troviamo al centro San Clemente, a sinistra i suoi discepoli<br />
S. Cornelio e S. Efebo, a destra Leonate che offre il modellino del<strong>la</strong> chiesa e negli angoli rosette e un'aqui<strong>la</strong> che afferra una lepre.<br />
Nell'architrave <strong>sono</strong> narrate le vicende del<strong>la</strong> fondazione del<strong>la</strong> chiesa. Lungo gli stipiti <strong>sono</strong> raffigurati quattro re, forse i carolingi Ugo,<br />
Lotario, Lamberto e Berengario, i quali avevano concesso diversi benefici all'abbazia. Nei capitelli <strong>sono</strong> raffigurati mostri che<br />
rappresentano il male del mondo.<br />
Il portale principale è reso ancora più prezioso dal<strong>la</strong> bel<strong>la</strong> porta bronzea che ancora lo chiude, un vero gioiello di arte medievale<br />
realizzato tra il 1182 ed il 1189. La porta ha un anima in legno ed è rivestita da formelle in bronzo in cui <strong>sono</strong> raffigurati quattro<br />
personaggi (due abati, S. Clemente e l’imperatore Ludovico) e i rilevi stilizzati dei castelli che simboleggiano una o più proprietà<br />
dell'abbazia.<br />
Nelle lunette a tutto sesto dei portali <strong>la</strong>terali <strong>sono</strong> scolpiti una Madonna con Bambino (destra) e S. Michele Arcangelo (sinistra).<br />
Nel corso del Duecento fu realizzata <strong>la</strong> decorazione esterna delle mura con archetti a tutto sesto o ad arco acuto, mensole ed esili<br />
colonnine.<br />
All'interno del<strong>la</strong> chiesa troviamo tre navate divise da arcate a sesto acuto e pi<strong>la</strong>stri a sezione rettango<strong>la</strong>re, cruciformi e<br />
polistili. Seguono il transetto e l’abside.<br />
Dalle navatelle, tramite due rampe di scale, si accede al<strong>la</strong> cripta, un vano rettango<strong>la</strong>re diviso da colonne e coperto da volte a crociera.<br />
La chiesa conserva anche un prezioso ed antico arredo liturgico costituito dall'ambone, dal ciborio e dal cero pasquale.<br />
Il bellissimo ambone risale al XII secolo ed è composto da quattro colonne che sostengono una cassa quadrango<strong>la</strong>re. I capitelli<br />
presentano una decorazione a foglie di palma, l'architrave è animato da un motivo a girale e nelle <strong>la</strong>stre, ripartite in riquadri da una<br />
cornice a palmette, emergono i grossi rosoni, elementi decorativi tipici dell’Abruzzo. I rilievi del lettorino raffigurano un'aqui<strong>la</strong> e un<br />
leone, simboli degli Evangelisti Giovanni e Marco, che con gli artigli e le zampe sorreggono ognuno un libro.<br />
Il ciborio è del<strong>la</strong> prima metà del Quattrocento ed è composto da quatto colonne, archi trilobi ed una terminazione piramidale. Al<strong>la</strong> base<br />
corre un’iscrizione che ricorda le preziose reliquie conservate nel<strong>la</strong> chiesa. Il ciborio presenta una decorazione a rilievo molto artico<strong>la</strong>ta<br />
soprattutto <strong>sul</strong><strong>la</strong> fronte principale, dove <strong>sono</strong> scolpiti i simboli degli Evangelisti (aqui<strong>la</strong> per Giovanni, leone per Marco, angelo per<br />
Matteo, bue per Luca), gli angeli e <strong>la</strong> Madonna con il Bambino, seguiti in basso dall’angelo del<strong>la</strong> annunciazione e dal<strong>la</strong> Madonna<br />
annunciata. Sul fianco destro troviamo due angeli che sorreggono uno scudo araldico; <strong>sul</strong> retro <strong>sono</strong> riproposte le storie del<strong>la</strong><br />
fondazione dell'abbazia ed infine, <strong>sul</strong>l'ultima facciata, abbiamo un rilievo che simboleggia il peccato carnale e quello spirituale.<br />
Come altare è utilizzato un sarcofago del V secolo, in cui <strong>sono</strong> figurati a sinistra S. Pietro tra le guardie, al centro Cristo tra S. Pietro e<br />
S. Paolo, a destra S. Pietro che rinnega Cristo (?).<br />
Troviamo infine il cande<strong>la</strong>bro utilizzato per il cero pasquale impreziosito da una<br />
terminazione ad edico<strong>la</strong> e da inserzioni a mosaico.<br />
A seguito del sisma del 6 aprile 2009, <strong>la</strong> chiesa ri<strong>sul</strong>ta va IN<br />
QUESTE CONDIZIONI….<br />
Oggi, per fortuna, l’edificio, completamente ripristinato, è<br />
tornato agibile e visitabile in tutte le sue parti.<br />
TESTO RICAVATO DAL SITO INTERNET DEL COMUNE DI CASAURIA, con modifiche apportate durante <strong>la</strong> raccolta delle informazioni e <strong>la</strong> confezione del<strong>la</strong> scheda.
LABORATORIO D3 – ATTIVITA’ DI CONTESTUALIZZAZIONE (STUDIO E RICERCA SUL MONUMENTO)<br />
SAN LIBERATORE A MAJELLA – breve documentazione in vista del<strong>la</strong> visita<br />
La fabbrica fu innalzata nell'anno 1007 per volere del monaco Teobaldo su una costruzione preesistente<br />
databile intorno al IX secolo. E proprio a Teobaldo, che ha radicalmente ristrutturato <strong>la</strong> chiesa e gli edifici<br />
del<strong>la</strong> comunità, si deve un Commemoratorium, cioè un inventario testamentario nel quale, prima come<br />
preposito di S. Liberatore, poi in qualità di abate di Montecassino (dal 1022), egli attesta il suo impegno<br />
edilizio per S. Liberatore, oltre che <strong>la</strong> dotazione liturgica e l’attività scrittoria da lui promosse in favore del<strong>la</strong><br />
chiesa monastica maiellese. Tra alterne vicende, in pratica dal IX sino al<strong>la</strong> fine del XVIII sec., S. Liberatore,<br />
che rimase sempre una prepositura dipendente dall’abbazia cassinese, costituisce appunto il polo intorno al<br />
quale gravita <strong>la</strong> presenza di Montecassino in Abruzzo, come testimonia proprio <strong>la</strong> documentazione re<strong>la</strong>tiva<br />
al monastero maiellese che comprende oltre 800 unità.<br />
L'abbazia si trova immersa in uno scenario di suggestivo valore naturalistico, si presenta con una<br />
facciata bianca equilibrata nei volumi e affiancata da un campanile a pianta quadrata sviluppato in
tre piani traforati da monofore, bifore e trifore. La facciata ha uno schema disegnato da rilievi<br />
verticali con un gusto lombardo.<br />
La ripartizione interna dell'impianto basilicale è a tre navate con sette arcate a tutto tondo che<br />
insistono su pi<strong>la</strong>tri triango<strong>la</strong>ri.<br />
Al presbiterio si accede attraverso tre archi di trionfo (manca quello centrale), che poggiano su<br />
piloni a forma di croce e terminanti con belle decorazioni a ovuli e dentelli; questo stesso tipo di<br />
decorazione divide in senso orizzontale le muraglie del<strong>la</strong> navata centrale sino a portarsi <strong>sul</strong>l'abside,<br />
terminando in tre ordini circo<strong>la</strong>ri.<br />
Il soffitto è a capriate lignee; nel<strong>la</strong> navata sinistra si scorgono gli originari accessi al chiostro e al<strong>la</strong><br />
residenza del monastero, rappresentate da due porte decorate; è possibile notare <strong>sul</strong>l'architrave del<strong>la</strong><br />
seconda porta il caratteristico motivo a fiori tipico del romanico abruzzese.<br />
Il pavimento del<strong>la</strong> navata centrale presenta una bel<strong>la</strong> e rara composizione geometrica policroma<br />
databile intorno al 1200, mentre gli affreschi che ornavano il catino dell'abside, un tempo uniti, oggi<br />
<strong>sono</strong> ammirabili separatamente dopo l'ultimo restauro; il primo, posizionato su pannelli è del XVI<br />
secolo e raffigura il monaco Teobaldo, fondatore dell'abbazia, il secondo, più antico (XII secolo,<br />
rimasto nel<strong>la</strong> sua posizione originaria presenta tracce di figure di santi.<br />
L'ambone si presenta a cassa di forma quadrata e presenta notevoli somiglianze con <strong>la</strong> pari struttura<br />
dell'Abbazia di San Clemente a Casauria e di San Pelino a Corfinio.