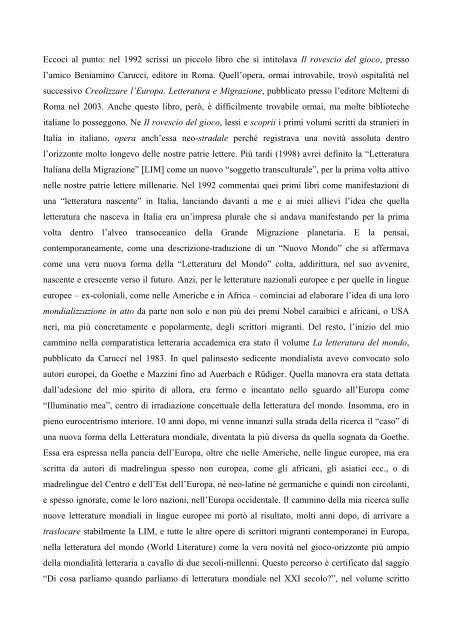Kuma&Transculturazione Armando Gnisci Nuova ... - Alias Network
Kuma&Transculturazione Armando Gnisci Nuova ... - Alias Network
Kuma&Transculturazione Armando Gnisci Nuova ... - Alias Network
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Eccoci al punto: nel 1992 scrissi un piccolo libro che si intitolava Il rovescio del gioco, presso<br />
l’amico Beniamino Carucci, editore in Roma. Quell’opera, ormai introvabile, trovò ospitalità nel<br />
successivo Creolizzare l’Europa. Letteratura e Migrazione, pubblicato presso l’editore Meltemi di<br />
Roma nel 2003. Anche questo libro, però, è difficilmente trovabile ormai, ma molte biblioteche<br />
italiane lo posseggono. Ne Il rovescio del gioco, lessi e scoprii i primi volumi scritti da stranieri in<br />
Italia in italiano, opera anch’essa neo-stradale perché registrava una novità assoluta dentro<br />
l’orizzonte molto longevo delle nostre patrie lettere. Più tardi (1998) avrei definito la “Letteratura<br />
Italiana della Migrazione” [LIM] come un nuovo “soggetto transculturale”, per la prima volta attivo<br />
nelle nostre patrie lettere millenarie. Nel 1992 commentai quei primi libri come manifestazioni di<br />
una “letteratura nascente” in Italia, lanciando davanti a me e ai miei allievi l’idea che quella<br />
letteratura che nasceva in Italia era un’impresa plurale che si andava manifestando per la prima<br />
volta dentro l’alveo transoceanico della Grande Migrazione planetaria. E la pensai,<br />
contemporaneamente, come una descrizione-traduzione di un “Nuovo Mondo” che si affermava<br />
come una vera nuova forma della “Letteratura del Mondo” colta, addirittura, nel suo avvenire,<br />
nascente e crescente verso il futuro. Anzi, per le letterature nazionali europee e per quelle in lingue<br />
europee – ex-coloniali, come nelle Americhe e in Africa – cominciai ad elaborare l’idea di una loro<br />
mondializzazione in atto da parte non solo e non più dei premi Nobel caraibici e africani, o USA<br />
neri, ma più concretamente e popolarmente, degli scrittori migranti. Del resto, l’inizio del mio<br />
cammino nella comparatistica letteraria accademica era stato il volume La letteratura del mondo,<br />
pubblicato da Carucci nel 1983. In quel palinsesto sedicente mondialista avevo convocato solo<br />
autori europei, da Goethe e Mazzini fino ad Auerbach e Rüdiger. Quella manovra era stata dettata<br />
dall’adesione del mio spirito di allora, era fermo e incantato nello sguardo all’Europa come<br />
“Illuminatio mea”, centro di irradiazione concettuale della letteratura del mondo. Insomma, ero in<br />
pieno eurocentrismo interiore. 10 anni dopo, mi venne innanzi sulla strada della ricerca il “caso” di<br />
una nuova forma della Letteratura mondiale, diventata la più diversa da quella sognata da Goethe.<br />
Essa era espressa nella pancia dell’Europa, oltre che nelle Americhe, nelle lingue europee, ma era<br />
scritta da autori di madrelingua spesso non europea, come gli africani, gli asiatici ecc., o di<br />
madrelingue del Centro e dell’Est dell’Europa, né neo-latine né germaniche e quindi non circolanti,<br />
e spesso ignorate, come le loro nazioni, nell’Europa occidentale. Il cammino della mia ricerca sulle<br />
nuove letterature mondiali in lingue europee mi portò al risultato, molti anni dopo, di arrivare a<br />
traslocare stabilmente la LIM, e tutte le altre opere di scrittori migranti contemporanei in Europa,<br />
nella letteratura del mondo (World Literature) come la vera novità nel gioco-orizzonte più ampio<br />
della mondialità letteraria a cavallo di due secoli-millenni. Questo percorso è certificato dal saggio<br />
“Di cosa parliamo quando parliamo di letteratura mondiale nel XXI secolo?”, nel volume scritto