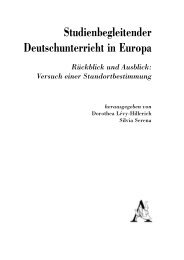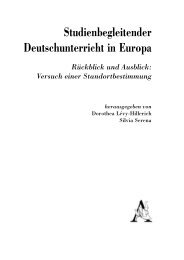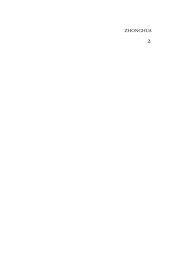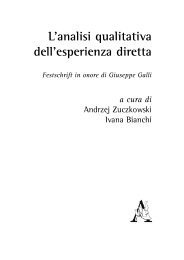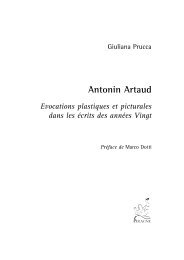Costanti e varianti del Tasso lirico - Aracne editrice
Costanti e varianti del Tasso lirico - Aracne editrice
Costanti e varianti del Tasso lirico - Aracne editrice
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Davide Colussi<br />
<strong>Costanti</strong> e <strong>varianti</strong><br />
<strong>del</strong> <strong>Tasso</strong> <strong>lirico</strong><br />
Il manoscritto Chigiano L VIII 302
Copyright © MMIX<br />
ARACNE <strong>editrice</strong> S.r.l.<br />
www.aracne<strong>editrice</strong>.it<br />
info@aracne<strong>editrice</strong>.it<br />
via Raffaele Garofalo, 133 a/b<br />
00173 Roma<br />
(06) 93781065<br />
ISBN 978–88–548–2817–9<br />
I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,<br />
di riproduzione e di adattamento anche parziale,<br />
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.<br />
Non sono assolutamente consentite le fotocopie<br />
senza il permesso scritto <strong>del</strong>l’Editore.<br />
I edizione: novembre 2009
INDICE<br />
PREMESSA 9<br />
INTRODUZIONE. DAI POSTILLATI AL CANZONIERE 11<br />
1. La tradizione <strong>del</strong>le «Rime» e il Chigiano 11<br />
2. Tecniche di costruzione <strong>del</strong> canzoniere 19<br />
2.1. Le assenze 19<br />
2.2. Tipi di connessioni intertestuali 21<br />
2.3. Connessioni attraverso le fonti 28<br />
I. FENOMENI FONOMORFOLOGICI<br />
31<br />
1. Premessa 31<br />
2. Fonologia 35<br />
2.1. Vocalismo 35<br />
2.1.1. Vocalismo tonico, 35; 2.1.2. Dittongamento, 37; 2.1.3.<br />
Vocalismo atono, 43<br />
2.2. Accidenti vocalici 48<br />
2.2.1. Aferesi, 48; 2.2.2. Prostesi, 50; 2.2.3. Sincope, 50;<br />
2.2.4. Epitesi, 51; 2.2.5. Apocope ed elisione, 51<br />
2.3. Consonantismo 71<br />
2.3.1. Scempie e geminate, 71; 2.3.2. Sorde e sonore, 74;<br />
2.3.3. Palatali, 75; 2.3.4. Velari, 77; 2.3.5. Sibilanti, 78; 2.3.6.<br />
Nessi latineggianti, 80<br />
3. Morfologia 81<br />
3.1. Articolo 81<br />
3.2. Nome 83<br />
3.2.1. Numero, 83; 3.2.2. Genere, 84; 3.2.3. Flessione, 85<br />
3.3. Aggettivo 86<br />
3.3.1. Dimostrativi, 86; 3.3.2. Possessivi, 87; 3.3.3. Numerali,<br />
87<br />
3.4. Pronome 88<br />
3.4.1. Personali, 88; 3.4.2. Altri pronomi, 89<br />
3.5. Verbo 90<br />
3.5.1. Indicativo presente, 90; 3.5.2. Imperfetto, 91; 3.5.3.<br />
Perfetto, 92; 3.5.4. Futuro, 94; 3.5.5. Congiuntivo presente,<br />
96; 3.5.6. Congiuntivo imperfetto, 97; 3.5.7. Condizionale,<br />
98; 3.5.8. Participio, 99<br />
3.6. Avverbi 100
6 INDICE<br />
II. FENOMENI SINTATTICI 103<br />
1. Morfosintassi 103<br />
1.1. Uso <strong>del</strong>l’articolo 103<br />
1.2. Uso <strong>del</strong>le preposizioni 109<br />
1.3. Uso <strong>del</strong>le congiunzioni 112<br />
1.4. Uso dei pronomi 114<br />
1.5. Uso degli aggettivi 117<br />
1.6. Uso dei verbi 118<br />
1.6.1. Reggenze verbali, 118; 1.6.2. Verbi riflessivi, 120;<br />
1.6.3. Concordanze, 122; 1.6.4. Forme nominali, 125<br />
2. Organizzazione <strong>del</strong> periodo 127<br />
2.1. Modi verbali 127<br />
2.2. Forme di subordinazione 132<br />
2.3. Paratassi e ipotassi 134<br />
III. LESSICO E FONTI<br />
153<br />
1. Lessico latineggiante assente nei «Fragmenta» 157<br />
1.1. Di diretta derivazione latina 157<br />
1.2. Latinismi danteschi 159<br />
1.3. Latinismi <strong>del</strong>la poesia umanistica 160<br />
1.4. Latinismi di Bembo e Della Casa 161<br />
1.5. Altri latinismi 161<br />
1.6. Formazione <strong>del</strong>le parole 163<br />
1.7. In diacronia 165<br />
2. Fonti 167<br />
2.1. Intrecci di fonti 167<br />
2.2. Altre fonti 169<br />
IV. RETORICA E SINTASSI<br />
171<br />
1. Dittologie 171<br />
1.1. In sincronia 171<br />
1.2. In diacronia 183<br />
2. Parallelismi e chiasmi 187<br />
2.1. Nel verso 187<br />
2.2. Oltre il verso 209<br />
2.3. In diacronia 215<br />
3. Ordine <strong>del</strong>le parole 216<br />
3.1. Inversioni<br />
3.1.1. Anteposizione <strong>del</strong> verbo, 219; 3.1.2. Posposizione <strong>del</strong><br />
verbo, 227; 3.1.3. Dislocazione <strong>del</strong> complemento, 240<br />
219<br />
3.2. Iperbati<br />
3.2.1. Nel sintagma, 246; 3.2.2. Tra sintagmi, 260; 3.2.3. Altri<br />
fenomeni di spostamento, 267; 3.2.4. Epifrasi, 286; 3.2.5.<br />
Iperbati combinati, 293<br />
246
INDICE 7<br />
V. METRICA E SINTASSI 301<br />
1. Enjambement 301<br />
1.1. Nel sirrema 306<br />
1.2. Tra sintagmi 314<br />
2. Varianti prosodiche 320<br />
CONCLUSIONI<br />
BIBLIOGRAFIA<br />
331<br />
341
CAPITOLO PRIMO<br />
FENOMENI FONOMORFOLOGICI<br />
1. PREMESSA<br />
In una lettera <strong>del</strong> 1575 a Scipione Gonzaga, stretto consulente<br />
nel processo di rielaborazione <strong>del</strong>la Gerusalemme liberata<br />
nonché materiale estensore, in una misura che è ancora da stimare,<br />
<strong>del</strong>la lezione <strong>del</strong> poema quale lo si legge nella seconda<br />
<strong>del</strong>le stampe Bonnà (1581) 1 e quindi nelle edizioni odierne,<br />
<strong>Tasso</strong> avverte:<br />
Prego Vostra Signoria a legger questi tre ultimi [scil. canti: Lib. XVIII-<br />
XX] come cosa imperfettissima. La prego anco a non mostrarli ad alcuno,<br />
se ben può leggerli a chi vuole; perché sarebbe gran vergogna la mia,<br />
che fossero visti così male scritti, con tante cancellature e con tanti errori<br />
di penna quanti vi debbono essere; e ho gran dubbio che Vostra Signoria<br />
stessa non saprà leggerli. Di lei non mi vergogno tanto, sapendo ch’ella,<br />
che mi stima sovra il mio merito, attribuisce alcuna sorte d’errori più tosto<br />
a fretta o a negligenza ch’ad ignoranza; ma gli altri, giudicandomi dalle<br />
mie scritture, mi potrebbono riputare un grande ignorante. Pur mi<br />
consola l’aver letto che Plotino, <strong>del</strong> quale nissun mai più dotto o eloquente<br />
uscì dalle scole platoniche, scriveva scorrettissimamente e non<br />
sapea alcuna regola d’ortografia 2.<br />
Su questa affermazione pare fondarsi uno dei più indistruttibili<br />
loci communes <strong>del</strong>la critica tassiana: già Leopardi annotava<br />
nello Zibaldone, traendone la notizia dai volumi Degli scrittori <strong>del</strong><br />
Trecento e de’ loro imitatori di Perticari, dove si allude proprio alla<br />
lettera in questione, la «stortissima e scorrettissima ortografia»<br />
<strong>del</strong> <strong>Tasso</strong>, «con errori tali che oggi non commetterebbe il più<br />
1 Cfr. POMA 1983.<br />
22 Lett. poet., pp. 222-23. E si veda in altra lettera al Gonzaga (ibid., p.<br />
151): «Se Vostra Signoria legge con tanto gusto i miei versi con quanto io<br />
vagheggio il suo carattere e la diligenza <strong>del</strong>l’ortografia, o me beato!».
32 CAPITOLO PRIMO<br />
imperito scrivano o fanciullo principiante» e dove «una stessa<br />
voce v’è scritta ora con una ora con altra ora con altra ortografia»<br />
3; gli editori moderni tassiani si sono poi richiamati spesso<br />
al passo citato 4, a giustificazione <strong>del</strong>le divergenze riscontrate tra<br />
gli usi scrittorii <strong>del</strong> poeta. Nulla di inesatto in tutto ciò, ma la<br />
facile connessione degli usi alternanti <strong>del</strong>la grammatica tassiana<br />
con gli squilibri psichici di cui per secoli si è nutrito il mito <strong>del</strong><br />
<strong>Tasso</strong> 5 tende forse per trasformare in incertezze quelle che sono<br />
semplicemente oscillazioni <strong>del</strong>la lingua di lunghissima durata<br />
6, che trovano fondamento d’altra parte, per quel che riguarda<br />
la tradizione poetica, nella grande ricchezza di doppioni fonologici<br />
e morfologici che è propria <strong>del</strong> Petrarca 7. Per parte<br />
sua, Devoto ha nei fatti negato l’esistenza di un problema linguistico<br />
in <strong>Tasso</strong>, se non contingente e circoscritto di volta in<br />
volta («Nessuna correzione appare ispirata a un criterio geografico:<br />
l’esigenza toscana non si impone né si rifiuta… Una esigenza<br />
negativa approssimativa, o ritmica o psicologica o ortografica,<br />
basta a determinare il mutamento, senza che si determinino<br />
contraccolpi nell’equilibrio <strong>del</strong> sistema linguistico» 8),<br />
ma la prospettiva <strong>del</strong>la sua disamina appare fortemente schiacciata<br />
verso l’ultima fase compositiva (le correzioni autografe al<br />
Torr. e le innovazioni <strong>del</strong>la Conq.), e semplifica inevitabilmente<br />
il quadro <strong>del</strong>le scelte linguistiche effettuate lungo l’intero arco<br />
3 Zibaldone, p. 2186.<br />
4 SOZZI 1954, pp. 159-60 (per il Torr.); RAIMONDI 1958, p. 196 (per i<br />
Dial.).<br />
5 Si veda ad es. RAIMONDI 1958, pp. 193-4, che individua negli autografi<br />
dei Dial. «alternanze ondulatorie, dirette, più che da un’opzione grammaticale<br />
o culturale, da un impulso psichico, da un turbamento emotivo il quale poi confina<br />
con l’indifferenza» (corsivi miei).<br />
6 Allo stesso modo, ha goduto di grande fortuna critica anche<br />
l’immagine, per molti versi complementare, di un Ariosto solerte correttore<br />
<strong>del</strong> poema a regola <strong>del</strong>le Prose bembesche, sulla scorta specialmente di MI-<br />
GLIORINI 1946. Ora quell’evoluzione viene indagata più a fondo e dunque<br />
sfumata da STELLA 1976 (e si veda pure TROVATO 1994, p. 131; già DEBE-<br />
NEDETTI 1928 aveva segnalato la natura contraddittoria di molte scelte ariostesche).<br />
7 Cfr. CONTINI 1951, p. 177: «le alternanze più proverbiali <strong>del</strong>la nostra<br />
lingua poetica».<br />
8 DEVOTO 1957, p. 172.
FENOMENI FONOMORFOLOGICI 33<br />
<strong>del</strong>l’opera <strong>del</strong> poeta. In particolare, è il versante che affonda le<br />
sue radici nella lingua di koinè settentrionale viva nei maggiori<br />
scrittori padani <strong>del</strong>l’inizio secolo – versante non imponente,<br />
tuttavia degno di essere descritto, anche perché sensibilmente<br />
ridimensionato nel tempo, con movimento congruente a quello<br />
di un Ariosto o di un Castiglione – ad essere sfuggito ad una<br />
analisi complessiva. Tra le ragioni <strong>del</strong>la lacuna sta il fatto che, a<br />
differenza di quanto accade per gli autori appena chiamati in<br />
causa, per certi versi scrittori unius libri, la storia interna <strong>del</strong>le<br />
singole opere <strong>del</strong> <strong>Tasso</strong> non reca impressi i segni di forti costanti<br />
correttorie. Non le <strong>varianti</strong> alla princeps introdotte nella<br />
seconda edizione <strong>del</strong> Rin. (1570) 9, che rimane l’opera più «varia»,<br />
«impetuosa» e «ingenua» 10 anche per profilo linguistico, né<br />
la lunga rielaborazione <strong>del</strong> Torr., che comincia all’indomani <strong>del</strong><br />
suo compimento (1586) e si fonda su preoccupazioni di riuscita<br />
poetica, non grammaticale 11; e neppure il gioco snervante di<br />
lezioni accolte e rifiutate <strong>del</strong>le maggiori stampe <strong>del</strong>la Lib. 12, tutte<br />
in varia misura contaminate e tutte indistintamente disapprovate<br />
da <strong>Tasso</strong> (ma gli studi di Poma illuminano sulla fase<br />
compositiva <strong>del</strong> poema, che risale al decennio precedente e ap-<br />
9 Si leggono ora nell’edizione critica di M. Sherberg: noto soltanto lito ><br />
lido VIII XLIV 4 (ma lito ad es. a X LXIII 5); equale > eguale I XLIV 8; rubbino ><br />
rubino IV XLI 6 e qualche sfrondamento, concentrato in ristrette zone <strong>del</strong><br />
poema, di epiteti bons à tout faire come aspro (II XLI 5, II XLIV 3, IV XXXIII 2)<br />
e alto (IV V 8, IV VI 1, IV IX 5, IV XXIX 1, IV LV 2, V XVI 6, IX LVII 2, IX<br />
LIX 5).<br />
10 È il giudizio che ne ebbe a dare Dionisotti, recensendo gli Studi sulla letteratura<br />
<strong>del</strong> Rinascimento di Mario Fubini: «un così meraviglioso coup d’essai…<br />
una tale festa, così varia, così impetuosa, così ingenua anche, ma sempre di<br />
una educata ingenuità, qual è quella che il <strong>Tasso</strong> diciottenne promuove e accende<br />
nella poesia italiana <strong>del</strong> secondo Cinquecento» (DIONISOTTI 1950, p.<br />
185).<br />
11 Si veda SOZZI 1954, pp. 173-202: «uniche tracce di correzione determinata<br />
dal senso grammaticale sono: tre correzioni ortografiche (lancie sostituito<br />
da lance; adversa corretto in aversa; norveggie ridotto alla corretta forma norvegie),<br />
e altrettante di natura sintattica: un che compl. ogg. risolto in il qual; un<br />
pronome personale aggiunto come soggetto di un’espressione assoluta; e la<br />
rettificazione di una dichiarativa prima esibita in forma contorta e anacolutica»<br />
(p. 180 n.).<br />
12 La cui collazione è stata compiuta da CARETTI 1957, pp. 640 e sgg.
34 CAPITOLO PRIMO<br />
pare intensissima, per quel che è dato vedere attraverso le Lett.<br />
poet., anche sotto l’aspetto linguistico 13). Del passaggio da Lib. a<br />
Conq. è stata studiata la vasta risistemazione narrativa, mentre<br />
in ombra sono rimasti i ritocchi linguistici 14. Si aggiunga che<br />
Raimondi non ha potuto ricavare dallo spoglio dei manoscritti<br />
dei Dial., che vanno dal 1579 al 1593, «un movimento di sviluppo<br />
lineare e organico», essendo la pagina tassiana «contraddistinta,<br />
quasi a un punto limite, dal gioco imprevisto e capriccioso<br />
degli umori, <strong>del</strong>le incertezze, dei pentimenti» 15.<br />
La situazione è in parte diversa per le Rime:<br />
Per i criteri d’ortografia è da osservare che le rime, offrendo duplicità di<br />
redazioni notevolmente distanti fra loro nel tempo e larga messe di autografi<br />
d’epoche diverse… ed edizioni curate ed emendate dal poeta stesso,<br />
possono permettere uno studio quanto mai preciso degli usi e <strong>del</strong>le forme<br />
linguistiche ed ortografiche <strong>del</strong> <strong>Tasso</strong> 16.<br />
E proprio Caretti ha insistito sulla possibilità che unicamente<br />
le Rime ci offrono di traguardare l’intero svolgimento<br />
<strong>del</strong>l’opera tassiana attraverso il travaglio <strong>del</strong>la loro rielaborazione<br />
ininterrotta, legandole così volta per volta alle opere<br />
maggiori 17.<br />
13 Per quel che <strong>del</strong>la riflessione linguistica veniva manifestato e discusso<br />
con i fidati Gonzaga e Scalabrino, cfr. Lett. poet., pp. 14, 25, 39-40, 48, 56, 81,<br />
87-88, 123, 194-95, 230-32, 282-3, 299-300, 312, 433, 446.<br />
14 Se ne vedono alcuni sparsi in DI BENEDETTO 1968; OLDCORN 1976<br />
analizza grafia e fonologia <strong>del</strong>l’autografo <strong>del</strong>la Conq. solo in prospettiva sincronica.<br />
15 RAIMONDI 1958, p. 193.<br />
16 CARETTI 1973, p. 111.<br />
17 «Lo studio <strong>del</strong>le rime giovanili, di quelle precisamente che stanno tra il<br />
Rinaldo e l’Aminta… offre infatti la possibilità di impostare con novità di accenti<br />
il problema critico <strong>del</strong>l’Aminta… perché proprio quel miracolo o ‘portento’…<br />
trova nelle rime intermedie, nel passaggio dai primi timidi sonetti<br />
agli azzardi coraggiosi dei madrigali, il suo antefatto poetico, la traccia <strong>del</strong>lo<br />
svolgersi e <strong>del</strong>lo svilupparsi <strong>del</strong>le giovanili istanze… le rime, invece, che si<br />
svolgono (quasi perpetuo ‘commentario’) tra la Liberata e la Conquistata, ci<br />
consegnano la vicenda amara e sofferente <strong>del</strong>le ultime invenzioni, <strong>del</strong>le illuminazioni<br />
estreme, e quindi – soprattutto dopo il 1588 – le violenze alla primitiva<br />
voce.» Il confronto tra Lib. e Conq. «dovrà essere tentato invece, d’ora<br />
in poi, attraverso una lettura aperta e consapevole (rispettosa, cioè, e filologicamente<br />
illuminata) dei testi estremi e <strong>del</strong>le opere intermedie, direi quasi <strong>del</strong>le
FENOMENI FONOMORFOLOGICI 35<br />
Da questo punto di vista il manoscritto Chigiano offre indicazioni<br />
<strong>del</strong> più alto interesse, poiché, con il suggello<br />
<strong>del</strong>l’autografia, illustra – una volta affiancato dai postillati Ts1 e<br />
Ts2, redatti sulle edd. Baldini e Vasalini degli anni ‘82-83 – la<br />
stagione di maggiore impegno rielaborativo <strong>del</strong>le rime tassiane,<br />
e sembra ragionevole attendersi che l’assemblaggio dei componimenti<br />
sparsi in canzoniere comporti uno sforzo anche nel<br />
senso <strong>del</strong>l’omogeneità linguistica, condotto – com’è immaginabile<br />
– al lume <strong>del</strong> mo<strong>del</strong>lo petrarchesco. Tale impegno non<br />
resterà lettera morta, ma verrà in gran parte devoluto all’unica<br />
stampa di rime amorose curata dall’autore, l’Osanna 1591.<br />
2. FONOLOGIA<br />
2.1. VOCALISMO<br />
2.1.1. Vocalismo tonico. In questo settore si segnalano pochissime<br />
voci, per lo più arcaismi, accetti solo in rima; le forme di<br />
marca settentrionale sono quasi tutte eliminate.<br />
a) -I-/-E-. Tra reo e rio, entrambi petrarcheschi, viene privilegiata<br />
la forma latineggiante, che è la più rara in Petrarca, ma<br />
già in Bembo prevalente fuori dalla rima: reo CLV 1, rea<br />
LXXXIX +7, CXVI 7 (e rei CXLVI +13); l’isolato rio CVII<br />
+12 si spiega con il recupero di un verso di Della Casa, «aspro<br />
costume in bella donna e rio» 3 12. Fuori dalla rima, una occorrenza<br />
di lece CXX 12 ed una di lice XVIII 7; il secondo è senza<br />
rivali in rima: XVIII +64, LII +11, CXVII +11, CXXIV +78,<br />
CLII +85. Oscillazione anche maggiore nella Lib. (13 lice contro<br />
11 lece), dove figurano la rima vece: lece XIV XIII 7-8 e quella<br />
vice: lice VII LXXXIV 7-8.<br />
forme e modi e variazioni – anche impercettibili (i minimi ‘scarti’) – <strong>del</strong>la<br />
irrequieta e mutabilissima poesia tassiana» (CARETTI 1973, pp. 15-16).
36 CAPITOLO PRIMO<br />
b) -O-/-U-. Scompaiono il tipo non anafonetico, raro fin<br />
dagli inizi in <strong>Tasso</strong>, longo, corretto in lungo CXXII 58 18 e quello<br />
comunque non toscano – ma che rimanda piuttosto ai rimatori<br />
napoletani di fine Quattrocento – occolto, forzato dalla rima,<br />
CXXII +82* (occulti, -a LXIX 38, CVII 4) 19. Viene respinto<br />
l’arcaismo sui CLII +23*, che coincide con la forma metafonetica<br />
settentr. 20 ed è d’altra parte estraneo alla tradizione lirica<br />
maggiore (è frequente invece ad es. nelle rime di Ariosto 21); resta,<br />
nella pointe di un madrigale, vui CXXXVII +9. Nella Lib. il<br />
tipo è impiegato spesso in rima: XIV XVIII 2-6 sui: lui: vui; nui<br />
II L +7; sui IV XLI +6, V LXXI +1, IX XXXVI +1 ecc.; vui XX<br />
LXXXV +6. Compare il latineggiante sepulta LXXV +10, ben<br />
18 Longo è presente nel Rin. (I XLIX 2, X LXXXII 5, XII XCI 1); in<br />
Disc.a.p. soggionge, in Disc.p.er. aggiongere, aggiontovi (cfr. POMA 1964, p. 319); nei<br />
Dial. due volte longo > lungo («è perfettamente consapevole <strong>del</strong>l’infrazione e la<br />
condanna come tale»: RAIMONDI 1958, p. 208); un congionto, non so se da addebitare<br />
alla stampatore, nella lettera dedicatoria <strong>del</strong>le Rime Marchetti (1593).<br />
Anche Bernardo <strong>Tasso</strong> soppianta longo in favore di lungo tra il primo e il secondo<br />
libro degli Amori (CHIODO 1995a, p. 428): la coincidente presa di posizione<br />
di Bernardo e Torquato rappresenta il cedimento in pieno Cinquecento<br />
al fiorentino letterario di tali forme residue non toscane, già avversate<br />
da Ariosto nel Furioso B (per gionco vd. MIGLIORINI 1946, p. 179; per giongere e<br />
longo nei Cinque Canti vd. SEGRE 1966, p. 173); in Castiglione: longo nel prologo<br />
alla Calandria <strong>del</strong> Bibbiena, soggionse e altro nel Cortegiano C, gionse nella redaz.<br />
definitiva (CIAN 1942, p. 27 e pp. 133, 139, 144 <strong>del</strong>l’appendice), ma si<br />
rarefanno col tempo nella grafia <strong>del</strong>l’autore (GHINASSI 1963, pp. 231-32).<br />
Salviati corregge conseglio in consiglio nella copia <strong>del</strong> Pastor fido inviatagli da<br />
Guarini (BATTAGLIN 1965, pp. 254 e 271).<br />
19 Anche la rima volto: occolto appartiene alla stagione <strong>del</strong> Rin.: cfr. IX<br />
XLIX 8. È uno degli «esiti semipopolari» più recidivi, anzi crescenti, nelle correzioni<br />
di Arcadia e rime sannazariane e nel Cariteo (FOLENA 1952, p. 29;<br />
MENGALDO 1962, p. 475; FENZI 1970, p. 17; per De Jennaro vd. CORTI<br />
1956, p. XCII).<br />
20 Cfr. ROHLFS 1966, § 74. Ricorre in Castiglione (per CIAN 1942, p. 73 è<br />
addirittura «la forma normale»), mentre «nui e vui, quasi scomparsi tra il 1509<br />
e il 1512 nell’epistolario, non si incontrano mai nel Cortegiano» (GHINASSI<br />
1967, pp. 182-83; cfr. l’appendice di CIAN 1942, pp. 111-14). È un caso, non<br />
isolato in <strong>Tasso</strong>, in cui lo scrupolo toscanizzante finisce per oscurare il pregio<br />
<strong>del</strong>l’arcaismo poetico, coincidente con la forma di koinè settentrionale.<br />
21 Specialmente nei Capitoli: nel primo nui ai vv. 73, 109 e 115; nel secondo<br />
sui al v. 110; nel quarto sui: nui ai vv. 7-9 ecc.
FENOMENI FONOMORFOLOGICI 37<br />
attestato nella tradizione (Dante, Boccaccio ecc.) 22, ma insepolte<br />
CXLVII 11 (anche in Lib. II LXXXVI 3-4 e Torr. 1210) e incolta<br />
LXIV 2 (inculta, -o, -i Lib. II XIV +8, Torr. 1070).<br />
c) -A-/-E-. Da segnalare solo cosperso CXLV +3, di forte tinta<br />
latineggiante, che discende da Par. XXVII 30, fonte <strong>del</strong>la<br />
quartina (in Petrarca figura cosperse ma anche cosparto).<br />
2.1.2. Dittongamento. Il quadro dei dittongamenti è fra i più<br />
frastagliati <strong>del</strong>l’uso tassiano; nondimeno si può qui misurare<br />
una più forte spinta verso i tipi monottongati, promossa in parte<br />
consistente nella revisione <strong>del</strong>le rime.<br />
a) -E-/-IE-. Le forme fero e fiero (senza distinzione <strong>del</strong> sost.<br />
femm., ma con lieve diffrazione semantica: connotata positivamente<br />
la forma ditt.) si equivalgono nel Rin. 23 e in seguito si<br />
alternano nelle preferenze di <strong>Tasso</strong>, peraltro sempre convivendo.<br />
La stampa B2 (1581) <strong>del</strong>la Lib., edita criticamente da Caretti<br />
in quanto apparentemente più fe<strong>del</strong>e agli usi tassiani 24, si stacca<br />
dalla precedente e dalla seguente per una chiara scelta <strong>del</strong> monottongo,<br />
mentre i frequenti passaggi in O al dittongo sembrano<br />
far parte di quella «pianificazione linguistica da parte<br />
<strong>del</strong>l’illustre editore» 25 che la rende inservibile ai nostri scopi;<br />
22 Cfr. BATTAGLIA 1938, p. CXVII: «comune latinismo»; lo si ritrova pure,<br />
con esito ibridato, nella prosa ‘bassa’ <strong>del</strong> Piovano Arlotto (sipulti: FOLENA<br />
1953, p. 364).<br />
23 Ad es. fero III XIII 5, III XIX 1, III XLII 5, IV XXVIII 1, IV XXXVIII 5,<br />
IV LV 1, IV LVIII 1 ecc.; fiero I XXXIX 8, II XVII 6, III I 4, IV XXXIV 5, VI<br />
XXI 2, VI XXXVI 5, VI XLII 3 ecc.<br />
24 In realtà, come ha dimostrato POMA 1983, frutto di varie contaminazioni<br />
editoriali (l’ultima è quella con il ‘vero’ cod. Gonzaga, Fr, studiato da<br />
CAPRA 1978b e POMA 1982) e portatrice di lezioni spesso regressive rispetto<br />
a B1.<br />
25 POMA 1983, p. 75; ma sulle lezioni di O è da vedere ora POMA 1996,<br />
spec. le pp. 524-25: «valgono anche nei confronti di Fr [= il codice autografo<br />
di Scipione Gonzaga dove egli veniva ricopiando il poema inviatogli a gruppi<br />
di canti da <strong>Tasso</strong>; reca concieri <strong>del</strong>lo stesso Gonzaga e ne riflette evidentemente<br />
l’ortografia] quasi tutti gli scarti sistematici (o molto frequenti) di O<br />
rispetto a B2» (nei primi due canti fer > fier I XXXVII 6; feramente > fieramente<br />
II VIII 6; fer > fier II XX 4 e XL 6).
38 CAPITOLO PRIMO<br />
ma l’ultimo <strong>Tasso</strong> propende semmai per il dittongo 26. In C la<br />
scelta di fero, fera è univoca, in ossequio all’uso di Petrarca, in<br />
cui il monottongo è numericamente prevalente (e si aggiungano<br />
gli interventi normalizzanti degli editori cinquecenteschi 27),<br />
e poi di Bembo e Della Casa: agg. XXIV 7, XL 37, XLIII 8,<br />
XLVII 3, LXXVII 14, CXVI 6, CXXII 4, CXXII 57, CXXV 7,<br />
CXXXII 9; sost. LXXXIX 7, CXVIII 10, CXXII 81, fiero passa<br />
a fero in LXXXVII 3 e scompare in CXLIV 8* 28. Si spiegano in<br />
questo modo anche preghi XXVI 4, XLVII 8, CLII 87; prieghi ><br />
preghi CLII 74 29 (Petrarca solo preghi) e leve XXXIV 11*,<br />
LXXXI 98, lieve > leve XXXI 4, LVI 13; solo lieve CLVI 3 30 (Petrarca<br />
autografo oscilla ma le edd. cinquecentesche propendono<br />
per il monottongo 31). Inoltre: chieggio > cheggio XVIII 91*,<br />
prima <strong>del</strong>l’ammodernamento in chiedo. Altre forme sono comuni<br />
al resto <strong>del</strong>la produzione poetica tassiana: sete XII 2, XIV<br />
8, XL 4 ecc.; siete > sete CXVII 4, mentre in prosa c’è oscilla-<br />
26 PETROCCHI 1951, p. 331 pone fero / fiero tra «le forme… oscillanti» tassiane<br />
che «restano tali» nel M. cr.; fiero prevale nel Torr. (64, 272, 281, 427,<br />
525, 530 ecc.) e nella Conq. (fer III XLIII 6 > fier IV XLVIII 6; feri IV IX 5 ><br />
fieri V XIX 5 e spesso).<br />
27 Nell’impossibilità di conoscere con esattezza quale edizione di Petrarca<br />
<strong>Tasso</strong> avesse fra mano a Sant’Anna, si sono collazionate in più punti le edd.<br />
MANUZIO, DOLCE, VELLUTELLO, RUSCELLI, CASTELVETRO (d’ora innanzi<br />
citate solo attraverso l’iniziale), secondo le stampe di cui si dà avviso in bibliografia.<br />
Si tenga presente tuttavia che ci è pervenuta una copia <strong>del</strong> Petrarca<br />
<strong>del</strong> Castelvetro con postille autografe <strong>del</strong> <strong>Tasso</strong>, edite da BALDASSARRI 1975,<br />
per più di una ragione probabilmente presente al poeta durante la stagione<br />
<strong>del</strong> Chigiano (l’editore vi ha potuto riconoscere, pp. 9-10, note utilizzate nel<br />
Messaggiero, <strong>del</strong>l’82-83 e ’87, nella Cavaletta e nell’Apologia, entrambe <strong>del</strong>l’85).<br />
Nel caso specifico, si osservi: fiero > fero RVF 69 4 (M, D, V, C), 256 7 (M,<br />
D, C); fiere sost. > fere 66 26 (M, D, C), 128 40 (tutte le edd.), 288 13 (V), 360<br />
47 (V, R).<br />
28 Ariosto invece distingue sempre meglio nel tempo fiero agg. da fera<br />
sost. (STELLA 1976, p. 50), ciò che viene ridotto a norma dal Ruscelli editore<br />
<strong>del</strong> Furioso (TROVATO 1991, p. 284).<br />
29 Nell’Am. prieghi 29 e 1174; nelle Rime 6 3; 285 2; 522 13 ecc.<br />
30 Appartenente a una <strong>del</strong>le ultime poesie <strong>del</strong>la raccolta, dove – come occorrerebbe<br />
notare spesso – più distratta è la revisione.<br />
31 Cfr. lieve > leve RVF 132 12 (D) e lievi > levi 198 4 (tutte le edd.). Leve<br />
prevale anche in Bembo e Casa. Notevole che nei Dial. sia esclusivo lieve: cfr.<br />
RAIMONDI 1958, p. 205.
FENOMENI FONOMORFOLOGICI 39<br />
zione; mèl XVIII 47, LXXXVIII 7 ecc.; acqueta XI 4, XVI 6 e<br />
queta CXXII 22 32; tepido LXXXI 53, CXLIX 5 e il vb. intepidire<br />
L 7, CXXVI 1, CLII 64.<br />
Sempre dittongati i vocaboli uscenti in -iero: pensier LXIX<br />
61, LXXI 1, LXXIV 2 ecc. 33; leggier CXXIV 58; messaggier, -i, -a<br />
XI 12, XL 30, XCIII 14, CXXIV 40; l’isolata lezione guerrera<br />
XLVII 2, rispetto a guerriero, -a LXXVIII 1, LXXXI 1,<br />
LXXXVI 3, CXI 3, CXXVIII 6, CXL 9, fa pensare ad una<br />
precisa memoria <strong>del</strong>l’incipit di RVF 21 («O più cru<strong>del</strong> d’ogni<br />
altra, e pur men cruda / a gli occhi miei che bella e men guerrera»<br />
amplifica e complica «Mille fiate, o dolce mia guerrera»; cfr. il<br />
sistema di rime: <strong>Tasso</strong> guerrera: fera: altera: spera; Petrarca guerrera:<br />
altera: spera: era) 34. Analogamente, la redditio «Si nieghi a me, pur<br />
ch’a ciascun si nieghi» (: spieghi) CXV 12 sviluppa RVF 70 5 (:<br />
pieghi) e ne conserva il dittongo (unico in Petrarca); inoltre nega<br />
> niega CXLVI 14. La correzione petra > pietra XL 33 è a scapito<br />
<strong>del</strong>la rima perfetta petra: spetra, propria di RVF 23 82-84 (ma<br />
già in Petrarca prevale la forma espansa) 35. Il rinsaldamento di<br />
un legame fonico è alla base di altiere nella dittologia altiere e liete<br />
CXVII +1, che si oppone all’usuale altero LXXXI 136, CLII 94<br />
ecc. 36 Dittongati anche vieta XI +1, che è <strong>del</strong>la tradizione; tiene<br />
CXXXVII +3; ritiene XI +2 ecc.: la rima perfetta condiziona<br />
32 Quieta predomina nei Dial. (RAIMONDI 1958, p. 205).<br />
33 È noto che la correzione <strong>del</strong>la forma petrarchesca penser in pensier viene<br />
teorizzata da Ruscelli (pensiero e leggiero «o accorciati o interi, si proferiscon e si<br />
scrivono sempre con i») e realizzata su tutta la linea, di contro alle aldine (che<br />
pure presentano qualche oscillazione: 72 44; 110 10; 123 7) e alla giolitina<br />
1554 <strong>del</strong> Dolce (cfr. TROVATO 1991, p. 280). Dolce di lì a poco si uniformerà<br />
a Ruscelli: nell’ed. 1557 figurano solo forme dittongate (e così in Vellutello).<br />
Più conservativo Castelvetro, dove i cedimenti coincidono con quelli <strong>del</strong>le<br />
aldine.<br />
34 Solo Ruscelli innova guerrera > guerriera RVF 21 1. La dipendenza <strong>del</strong><br />
monottongo dalla fonte trova conferma nel vocativo di Osanna 153 9, «bella<br />
Guerrera».<br />
35 Spesso inoltre nel Petrarca <strong>del</strong>le stampe cinquecentesche petra > pietra:<br />
RVF 214 17 (tutte le edd.); 23 82 (R); 50 78 (V, R); 51 7 e 135 16 (D, V, R).<br />
Oscillazione diacronica petra / pietra nel Furioso, vd. STELLA 1976, p. 51.<br />
36 Solita indifferenza a una norma nel Rin., oltre che nei Dial.
40 CAPITOLO PRIMO<br />
soltanto vène > mantène XL 15 (: vene) 37. L’innovazione, meramente<br />
grafica, di gielo per gelo XXXVII 1, L 7, LXXII 5, concorde<br />
con gielo IV 2, XXXIV 4, LXXXIII 7, appare anch’essa<br />
un tentativo – sia pur parziale (gelo rimane in LXIX 81,<br />
LXXVIII 6, CXVI 8, CXIX 5, CXXXIV 5, e in CXIV 14 attratto<br />
dal paretimologico gelosia) – di accostamento ad una scelta<br />
peculiare <strong>del</strong> Canzoniere 38.<br />
b) -O-/-UO-. La costanza <strong>del</strong>la forma monottongata in core,<br />
loco, foco – emblema <strong>del</strong>la tradizione lirica petrarchesca – è guadagnata<br />
solo in fase di revisione di C: cuore > core XLII 13; cuori<br />
> cori CXLVI 1; luogo > loco X 13; fuoco > foco V 8, LXXVIII 7,<br />
CLIII 7; ne è escluso solo fuoco CXLVIII 9. Il quadro nelle altre<br />
opere tassiane non è altrettanto lineare: il Rin. anche qui conferma<br />
la disinvoltura linguistica che gli è propria preferendo in<br />
genere luogo, cui affianca luoco 39; luogo è in maggioranza nell’Am.<br />
e insomma si registra un margine di oscillazione anche nelle<br />
opere coeve e tarde 40. <strong>Costanti</strong> sono pure novo IV 9, XVII 6,<br />
XXIV 12 ecc.; nuovi > novi LXXXV 14, mentre in prosa, debitamente,<br />
nuovo LXII arg.; rota LIII 12 e 14; voto LXXXVI 10;<br />
percote XXXI 1; le forme <strong>del</strong> vb. movere: move LXII 12, CXV 8*,<br />
CLII 31; muove > move CXLVI 5; muovi > movi XLII 3; movi<br />
CXXII 5*; mova CVII 10*; movon CLII 1*; il composto rimovo<br />
LXXII 12 e mover LXXXI 135; e <strong>del</strong> vb. morire: more XXXIX 8,<br />
XCIV 10; moro XC +8 (muoia CIX 8); ad esse si aggiunge cuoci<br />
37 Ruscelli, seguito solo da Vellutello, passa a viene, tiene ecc. anche in ri-<br />
ma. 38 Sempre gelo nella Lib. È una <strong>del</strong>le più puntuali reversioni grammaticali<br />
<strong>del</strong>le Rime Osanna e Marchetti. Anche nel Furioso C «le due forme si alternano…<br />
con prevalenza di gielo» (SEGRE 1976, p. 323). Le edd. cinquecentesche<br />
di Petrarca di Dolce e di Ruscelli però intaccano sovente il dittongo: RVF 11<br />
13 (D); 34 5 (D, R); 52 8 (R); 77 13 (D, R); 119 31 (D, V, R) ecc.<br />
39 DEBENEDETTI 1928, p. 420: «L’Ariosto nella prima edizione usava volentieri<br />
luoco, per lo più corretto loco in B. Nella terza si alternano meglio, secondo<br />
la convenienza dei suoni, loco e luogo: quest’ultima è certo la lezione<br />
definitiva». E vd. anche STELLA 1976, p. 53.<br />
40 Nelle liste di <strong>varianti</strong> tra stampe Bonnà e stampa Osanna di CARETTI<br />
1957, pp. 641-47 non si può intravvedere una tendenza omogenea : B1 luogo<br />
> B2 loco XVI LVI 6; B2 luogo > O loco XV XLVII 1; ma B1 luogo > B2 loco > O<br />
luogo XVII LXV 2. Tanto più sospettabile l’alternanza in una prosa aperta alle<br />
soluzioni <strong>del</strong>la poesia com’è quella dei Dial.: cfr. RAIMONDI 1958, pp. 206-7.
FENOMENI FONOMORFOLOGICI 41<br />
> coci CXXII 4: tutte forme autorizzate da Petrarca e progressivamente<br />
affermatesi come esclusive nella lingua poetica tassiana<br />
41. Nell’allestimento di C viene avviata, ma non ultimata<br />
(immutati può XVIII 5, LIII 4, LXXIII 5, CXXIV 61, CXLIII<br />
8; puoi XVIII +13 42), la correzione di può in pò 43, che è <strong>del</strong> Canzoniere:<br />
può > pò XIX 8, XLVII 8, CXXII 75 (e puon > ponno<br />
CLII 96*); pò LX 7; pòi CXXIV 39; pòte CXXXI +4; contrasta<br />
l’intervento pò > può CXXII 75, forse per differenziare il vb.<br />
dall’ avv. poi che compare due versi più sotto. Non si giunge<br />
però agli esiti molto spinti in senso latineggiante <strong>del</strong> canzoniere<br />
di Della Casa, che dovranno essere attribuiti alla mano <strong>del</strong> curatore<br />
postumo 44: prevale la forma dittongata in suol LXXXIII<br />
4; suoli XXXII 13 (con qualche dubbio: suoli > soli > suoli); suole<br />
IX 8, CXLIV 8, XVIII 61, anche quando esigenze di rima consiglierebbero<br />
il contrario: non solo suole: schole CXXIV 23; suole:<br />
parole LXXXI 44, ma anche suole: sole XCII 3 45, salvo poi, in<br />
XXIV 8 e LXIV 11, propendere per la rima equivoca sòle: sole.<br />
E così vale per vuole VIII 8, IX 1, CVI 5 – tranne vòl LXIX 39 e<br />
vuole > vòle XXXV 14, dove il monottongo è ricercato per perfezionare<br />
il bisticcio tra volere e volare, predisposto simmetrica-<br />
41 Nel Rin., senza rivali, vuoto II IV 6, V XXXVIII 5; ruota XII XLI 2 e LVI<br />
2; frequenti muova, -e I XXVIII 4, II XXVI 2, VI XI 7, VI XXVI 2, VI XLIII 8,<br />
VI XLVIII 7 ecc.; percuote V LXVI 5, VI XXXIII 1, VI LVII 8 ecc.; anche nuovo,<br />
-a I XXX 7; I L 6; I LIII 3: I LXXXI 8; II X 6; II XIII 7 ecc. Sempre muore<br />
nell’Am. 922, 1589, 1615, 1863 (ma è innovazione isolata <strong>del</strong>la Aldina 1590,<br />
su cui Sozzi fonda rischiosamente l’ed., presumendo in essa una volontà<br />
d’autore). Orazio Lombar<strong>del</strong>li nel Discorso intorno a’ contrasti che si fanno sopra la<br />
Gerusalemme liberata (1586) bollerà come lombardismi vuoto e vuotare (RUGGIE-<br />
RI 1945, p. 50).<br />
42 Qui conta di sicuro la rima puoi: tuoi, ma il contraddittorio raffronto di<br />
puote: note XLII 9-14 con note: pote CXXXI 1-4 testimonia ancora una volta <strong>del</strong><br />
ricorso, non costante in queste rime ma volta per volta motivato, alla rima<br />
perfetta.<br />
43 La Lib. abbina l’uso di può con quello, preferenziale, di pote, di più agevole<br />
sfruttamento in rima (ad es. II II 2, II LXVI 2, IV XXIII 2, IV LXXXV 5,<br />
V LIV 5); O, a volte concordando con B1 e seguendo dunque lo stesso diagramma<br />
di fero / fiero, sceglie spesso puote, anche in rima: cfr. CARETTI 1957,<br />
p. 648.<br />
44 Sulla questione CARRAI 1996.<br />
45 Si veda ad es. Della Casa: sòle: vòle: dòle 40 1-7; sòle: vòle 44 3-6.
42 CAPITOLO PRIMO<br />
mente a inizio e fine dei vv. 7-8 e 9-14 <strong>del</strong> sonetto: «volar vorrebbe…<br />
il voler ei sente»; «e voleria… e vole». Monottongata la 1 a<br />
pers. sing. con apocope vo’ C 4 (si badi che tra i lombardismi<br />
riprovati nella Lib. da Orazio Lombar<strong>del</strong>li compare anche<br />
vuo’ 46). Tra il tipo fuor, fuore e quello fora, -e, -i è preferito il secondo<br />
47: fore LXVII +4, XCIV +2, CXXXIV +2; fuore > fore<br />
LXXXII +1 (sempre in rime non dittongate) e fore > fora<br />
LXXXI 72; restano fuore CXLIV +2, attratto forse dalla rima<br />
con fiore e l’apocopato fuor VIII 10 e LXVI 10; cancellato dalla<br />
ripulitura un altro fuore CLIV 4*, come anche fori CXII 8*. Infine<br />
suono VIII 9, XXXI 11, LXXIV 11*, LXXXI 45; tuoni<br />
LXXVII 11; tuona CXXI 1; CXXIV 107; figliuol XXVIII 1; lacciuol<br />
LXXXII 13.<br />
La posizione nel complesso avanzata in fatto di monottongo<br />
accomuna il Chigiano alla seconda stampa Bonnà (B2) <strong>del</strong>la<br />
Lib. (ciò che doveva aver colto già Caretti: in comune la scelta<br />
senza eccezioni di foco, more, -a, -i, preghi e quella, con eccezioni<br />
nella Lib., di leve, fero, loco), ed alla stampa <strong>del</strong>le Rime curata da<br />
<strong>Tasso</strong> stesso nel 1591, con qualche attenuazione (nell’Osanna<br />
sole > suole anche nei due casi di rima equivoca prima rispettata<br />
33 8 e 159 11, corrispettivi di XXIV 8 e LXIV 11; pò > può 26<br />
8 = XIX 8 e 130 6 = XLVII 8; una volta move > muove 72 12 =<br />
LXII 12; vol > vuol 147 39 = LXIX 39; cor > cuor 21 13 = XI<br />
13 48 – però pietra > petra 29 8 = XX 8 e puote > pote [: note] 175<br />
14 = XLII 14 – quanto alle rime in comune; nelle restanti cuor<br />
156 12; intiero 156 39; prieghi 122 3; fiera 135 6 e poco altro). A<br />
questo gruppo si oppongono non solo opere più antiche (Rin.<br />
46 Cfr. RUGGIERI 1945, p. 50 ; vuo’ > vo’ è correzione ariostesca (SEGRE<br />
1966, p. 168 e SEGRE 1976, p. 321).<br />
47 «Leggesi Fuor e Fore e Fora e Fuori, le quali tutte sono <strong>del</strong> verso, ma la<br />
prima e l’ultima sono ancora <strong>del</strong>le prose» (BEMBO, Prose, p. 291).<br />
48 Nel postillato autografo <strong>del</strong>l’ed. Osanna Ber cuor ritorna a cor (è la correz.<br />
n. 14 in CARETTI 1973, p. 122): la forma dittongata sarà errore <strong>del</strong>lo<br />
stampatore? Anche nieghi 96 14 probabilmente corretto in neghi nell’altro<br />
post. Mi (correz. n. 40, ibid., p. 125; non c’è riscontro con C), ma niega 44 14;<br />
nieghi 146 12 = CXV 12. Si ricordi che le correzioni dei due postillati restano<br />
inoperanti nella rist. Marchetti. DE MALDÉ 1978b li giudica «residui di un<br />
lavoro correttorio di più vaste dimensioni, solo in parte coincidenti e più<br />
spesso divergenti,… prove di valore provvisorio» (p. 125).
FENOMENI FONOMORFOLOGICI 43<br />
specialmente, con molti dittongamenti singolari già visti, ed anche<br />
l’Am.: luogo, muore, lieve pressoché incontrastati) ma pure le<br />
successive (Torr.: prevalenti fiero, lieve, prieghi) 49.<br />
2.1.3. Vocalismo atono. Protoniche. a) -E-/-A-. Sono esclusivi<br />
maraviglia X 8, XXII 4, LXV 10, LXXXII 8 ecc. (e anche meraviglia<br />
> maraviglia CXXIV 7); maraviglioso LXXXIV 5. La forma<br />
49 Come è noto, Ariosto, con processo inverso rispetto a <strong>Tasso</strong>, incrementa<br />
tra Furioso B e C i dittongamenti (priego, tiepido, intiero, riviera, altiero, triema,<br />
nieve, ruota, scuola, truova, muora, pruova e persino giuova per amore di rima<br />
perfetta: cfr. DEBENEDETTI 1928, pp. 420-23 e MIGLIORINI 1946, pp. 181-<br />
82), in conformità all’uso <strong>del</strong> toscano letterario: ciò che avrebbe gradito Salviati,<br />
secondo il quale «sono andazzi, per dirlo con la voce <strong>del</strong> nostro presente<br />
Popolo, di vane immaginazioni, come fu anche quella <strong>del</strong> miglior secolo<br />
<strong>del</strong>la favella intorno all’uso, pur nel verso altresì, <strong>del</strong>le due sillabe uo ed ie,<br />
<strong>del</strong>le quali i cattivelli u ed i, senza alcuna lor colpa, dal detto verso, per una<br />
simile opinione, furono sbandeggiati, riempiendo per ciò il dir poetico di mille<br />
ambiguità e d’infinita confusione, mentre che sono per suono, sole per suole,<br />
vole per vuole, leve per lieve e mille altri si leggon di questa fatta che dopo la<br />
morte di Dante ebber principio per quel che si comprende»; le forme dittongate<br />
«nostrali sono, e natie, ed in niuna parte, né di dolcezza, né di bellezza,<br />
son vinte dalle primiere» (Avvertim., I, pp. 195-96 e 279). Guarini si vede infatti<br />
corretti, nel Pastor fido, dalla penna <strong>del</strong>l’Infarinato mori, nove, tremoto, possede,<br />
rineghi, tepido nei rispettivi esiti espansi (BATTAGLIN 1965, pp. 253-54 e<br />
271). Non mi è possibile concordare con ZACCARELLO 1991, che, osservando<br />
le <strong>varianti</strong> <strong>del</strong>le rime eteree nel tempo e distinguendo per comodità tre<br />
fasi di rielaborazione (in breve: I f. Eterei e stampe non autorizzate Manuzio,<br />
Baldini e Vasalini tra 1581 e 1589; II f. Chigiano e i due postillati apografi Ar<br />
e Brn; III f. edd. Osanna e Marchetti e i due postillati autografi Ber e Mi),<br />
registra solo nella III f. una «riduzione dei dittonghi, abbondanti nella II fase<br />
ed assicurati da C, ridotti già in Os.[anna] ed in ulteriore diminuzione nei postillati<br />
[seguono le due correzioni di cui si dà conto alla n. 40, nient’affatto<br />
probante la prima e assai poco la seconda, come si è visto]» (p. 575). Non mi<br />
pare che si possa misurare la propensione al dittongam. o al monottongam.<br />
in una qualsiasi opera tassiana per assaggi, considerato il margine di scarto,<br />
molto risicato, tra l’una e l’altra: quel che un’analisi a più vasto raggio esprime<br />
è: 1) la tendenza progressivamente crescente a scegliere il monottongo in<br />
molti dei casi inizialmente oscillanti; 2) l’attuazione di questa tendenza in<br />
modo più deciso al momento di assemblare il canzoniere, dunque dapprima<br />
in C e poi nelle Osanna e Marchetti; 3) il ripensamento su alcuni vocaboli,<br />
che tornano al dittongo (soprattutto tra Lib. e Conq.), ma al di fuori <strong>del</strong> genere<br />
<strong>lirico</strong>, su cui il peso <strong>del</strong>la tradizione è evidentemente decisivo.
44 CAPITOLO PRIMO<br />
<strong>del</strong> Chigiano sta con l’uso <strong>del</strong>le prose e <strong>del</strong> Rin. 50 e si oppone a<br />
meraviglia <strong>del</strong>le altre opere poetiche e <strong>del</strong>la tradizione lirica 51;<br />
nell’Osanna i componimenti che non provengono dal Chigiano<br />
presentano in maggioranza nuovamente l’esito in -e- (6 contro<br />
3 52) e confermano l’isolamento, sotto questo aspetto, <strong>del</strong> nostro<br />
testo. È uno dei casi di ‘irriducibilità’ <strong>del</strong>le scelte linguisti-<br />
50 Cfr. RAIMONDI 1958, p. 210; POMA 1964, p. 317; Rin. I LVI 6, I LXXXI<br />
3 e 4, III XII 2, III XXVIII 4 ecc.<br />
51 D’altronde si tratta di un doppione bipartito convenzionalmente tra<br />
verso e prosa nel Cinquecento (MIGLIORINI 1960, p. 416): «È da sapere che ’l<br />
Petrarca usò sempre meraviglia con la e nella prima sillaba, onde e’ disse: “qual<br />
meraviglia hebb’io, quando m’accorsi / de la trasfigurata mia persona ? /<br />
Ch’avanza tutte l’altre meraviglie”. E così meravigliare: “Ond’io meravigliando dissi:<br />
hor come / conosci me, ch’io te non riconosca?” Maraviglia allo ’ncontro,<br />
e maravigliare con l’a nella prima sillaba fu sempre usato dal Boccaccio e da gli<br />
altri prosatori» (DOLCE, Modi, c. 19r-v; e così anche SALVIATI, Avvertim., I, p.<br />
124). Discorda solo Ruscelli: «Maraviglia: i moderni scrittori poco avedutamente<br />
scrivendo <strong>del</strong>la lingua hanno introdotto alcune cose che non son <strong>del</strong>la<br />
lingua: et sì come essi hanno detto duono, intiero et simil’altre voci barbare,<br />
così parimente hanno fatto distintione da maraviglia a meraviglia. Io veramente<br />
confesso che il Bembo fu diligentis[simo] ricercator <strong>del</strong>le vere voci <strong>del</strong>la lingua<br />
Toscana, e nondimeno non ho mai veduto che habbia fatta cotal distintione,<br />
né i propi Toscani la fanno, ma sempre parlando e scrivendo dissero<br />
maraviglia… [seguono ess. <strong>del</strong> Villani e <strong>del</strong> Boccaccio] E se mi si dice il<br />
P[etrarca] usò meraviglia, rispondo che s’inganna chi lo dice, percioché ho veduto<br />
l’originale d’esso Petrarca mostratomi dalla fel[ice] me[moria] <strong>del</strong> Bembo<br />
ove è scritto per tutto maraviglia e non meraviglia, oltre ch’i poeti antichi<br />
usarono il medesimo, e tra loro M. Cino» (RUSCELLI, Il Petrarca, s.v.); con tutto<br />
ciò, nell’edizione ruscelliana accompagnata dal Vocabolario, di maraviglia<br />
non si conta nemmeno un caso, così come rare in genere sono nelle edizioni<br />
cinquecentesche le occorrenze di maraviglia (una in MANUZIO, Il Petrarcha; due<br />
in VELLUTELLO, Il Petrarca e due, ma una sola in comune, nella stampa precedente<br />
– Giolito 1547 – ; nessuna in DOLCE, Il Petrarca – ma una nella precedente<br />
Giolito 1554; e così via); anzi maraviglia è corretto in meraviglia nel<br />
Furioso ruscelliano <strong>del</strong> 1556 (TROVATO 1991, p. 284). Maraviglia si affermerà<br />
progressivamente tra Sei e Settecento come forma più antica e dunque specifica<br />
<strong>del</strong>la poesia, una volta diffusasi l’altra anche nella prosa (come prova una<br />
scorsa alle edizioni petrarchesche fino all’Ottocento: ad es. la ristampa Zatta,<br />
Venezia 1756 <strong>del</strong>l’ediz. di Castelvetro reca soltanto maraviglia; il TB conosce<br />
come forma petrarchesca maraviglia, che avrà ricavato dall’ed. padovana Comino<br />
1722 e da quelle ottocentesche); già in Marino il rapporto tra le due<br />
scritture non è più gerarchico (per la Sampogna cfr. DE MALDÉ 1983b, p. 159).<br />
52 Meraviglia in Osanna 68 3; 103 2 e 10; 133 7; 161 6; 170 1 / maraviglia<br />
117 68; maravigliosa, -o 103 63 e 170 32.
FENOMENI FONOMORFOLOGICI 45<br />
che tassiane ai soli mo<strong>del</strong>li canonici: qui Torquato segue l’uso<br />
di Bernardo che adopera sempre maraviglia (ad es. Amori II 7<br />
102; 12 61; 27 39; 37 44; III 11 13). L’esito -ar- è normale in<br />
boscarecci LXIII 12, già <strong>del</strong>l’Am. 53.<br />
b) -O-/-U-. Suavi > soavi XXXV 10 rispecchia una nota correzione<br />
ariostesca 54: lì un vasto movimento di revisione, qui il<br />
depennamento di un isolato superstite. Il latinismo troppo<br />
crudo cultura usato metaforicamente («seno maraviglioso, horto<br />
e cultura / d’Amore») è condotto alla forma toscana coltura<br />
LXXXIV 5 55. Normali focil XCI 5 e polisco CLII 7.<br />
c) -E-/-I-. Per quel che riguarda e protonica nei prefissi de- e<br />
re-, la soluzione toscana si è affermata ampiamente, non senza<br />
però alcuni precisi influssi <strong>del</strong>la tradizione letteraria, che hanno<br />
il pregio di assecondare le tendenze latineggianti e dialettali 56.<br />
Alcune scelte tassiane si spiegano con il circostanziato impiego<br />
<strong>del</strong>la forma quale è nella fonte petrarchesca: desviar XLI 7, raggiunto<br />
nella revisione, dipende direttamente dall’incipit di RVF<br />
169 («Pien d’un vago pensier da me desvia»; <strong>Tasso</strong>: «per desviar i<br />
miei pensier da l’orme») 57; dipinge > depinge CII 2, analogamente,<br />
va interpretato come adesione puntuale (dipinge IX 5) a Petrarca<br />
53 È parola tematica in Sannazaro: cfr. FOLENA 1952, p. 31.<br />
54 Il passaggio suave > soave si ha nella terza edizione, ma discretamente:<br />
«lascia qua e là suave, dove pare si esprima un intimo soddisfacimento più<br />
pieno e profondo» (DEBENEDETTI 1928, p. 417).<br />
55 E così coltori in Osanna 111 2.<br />
56 Una restrizione ulteriore rispetto a Petrarca (EWALD 1907, pp. 10-11)<br />
<strong>del</strong> tipo più antico è già testimoniata in Boccaccio («L’e nei prefissi e nelle<br />
protoniche è raramente mantenuta, ché il Boccaccio fa solo qualche sporadica<br />
concessione all’uso più conservativo»: BATTAGLIA 1938, pp. CXVII-<br />
CXVIII). Che nel Cinquecento fossero indistintamente sentite come non<br />
toscane le forme in e, lo provano l’esitazione di Guicciardini, che nei suoi<br />
appunti linguistici annotava «Deliberare, Delicato e simili, se per E o per I»<br />
(SPONGANO 1951, p. LXXXV) e, nella disputa linguistica sulla Lib., la difesa<br />
di <strong>Tasso</strong> da parte di Lombar<strong>del</strong>li, che osservava che molti dei latinismi di cui<br />
era accusato erano solo grafici, e tra essi includeva non solo destillare, defendere,<br />
devorare, nepote ma anche deposto, deserto, devoto, <strong>del</strong>icato: cfr. RUGGIERI 1945, p.<br />
48. La riduzione di e ad i è tra le correzioni <strong>del</strong> Cortegiano antecedenti alla revisione<br />
<strong>del</strong> Valerio (GHINASSI 1963, p. 238).<br />
57 Desvia > disvia RVF 169 1 e 206 21 solo in Ruscelli; d’altra parte disviando<br />
> de- RVF 331 51 (M, R, V).
46 CAPITOLO PRIMO<br />
(RVF 71 52 «Vedete in quanti color’ depigne / Amor» ma soprattutto<br />
RVF 155 9 «Quel dolce pianto mi depinse Amore»; <strong>Tasso</strong>:<br />
«Se l’imagine vostra in me / depinge Amore») 58. Così vale per<br />
repulse LXXI 5 (aspre repulse, a inizio di quartina e sintatticamente<br />
libero come il memorabile inizio di RVF 351, «Dolci durezze<br />
et placide repulse») 59, ma ripulse LXXXI 108, in contesto assai<br />
meno vago (è la prolissa disputa scolastica di Sdegno contro<br />
Amore di fronte alla Ragione); e vale, senza una fonte precisa,<br />
per riverenza > reverenza CLII 46, ma è tralasciato, venti versi<br />
più sotto, riverenza CLII 68 60. Non resistono le forme poetiche<br />
impregionato CXXXIII 5* e vertute CVII 6* 61, entrambi eliminati<br />
in revisione (impregionato in un primo tempo corretto in imprigionato)<br />
62. Nulla più di un relitto disio CXXIV 96* che si uniforma<br />
a desiosi, -o LXXXI 85, CXLV 8 63. L’oscillazione sicuro /<br />
securo viene ricondotta alla scelta petrarchesca: securo VIII 8; sicura<br />
> secura XXXI 8; quanto a sicuro > securo > sicuro CXXIV<br />
104, il ritorno alla forma di partenza si spiega facilmente con le<br />
modalità <strong>del</strong>la correzione: il secondo rifacimento <strong>del</strong> verso, apposto<br />
sopra quello iniziale rifiutato, viene attratto dalla lezione<br />
58 Depinge anche in Bembo (25 31); in B. <strong>Tasso</strong> depinta, -o Amori III 7 10;<br />
14 10. Ma si badi che il passaggio de- > di- è attuato da Ruscelli (e sulla sua<br />
scorta dalle successive Vellutello) in cinque casi su sette.<br />
59 È mantenuto senza eccezioni nelle edizioni cinquecentesche di Petrarca,<br />
dove è hapax sia il sost. sia l’agg., fortunatissimo in <strong>Tasso</strong>.<br />
60 Riverenza altrove è l’unica forma di <strong>Tasso</strong>: ad es. Rin. IV VI 4, VI II 8 e<br />
Lib. IV LXXXVII 4, V XXXVIII 8.<br />
61 Vertù e vertude solo nel Rin. II VIII 4 e VII LXVIII 6. Castiglione muta<br />
sua sponte vertù in virtù (GHINASSI 1963, p. 238). È larghissimo il processo<br />
normalizzante nelle stampe cinquecentesche di Petrarca: trascegliendo i primi<br />
sei casi di virtù e i primi quattro di virtute, si osserva: vertute > vi- RVF 37 93<br />
(M, R, V, C); 98 11; 146 1; 154 13 (tutte le edd.); vertù > vi- RVF 7 2; 28 66<br />
(D, R); 9 3; 12 3; 19 7; 29 54 (R, V).<br />
62 Salviati, disputando con <strong>Tasso</strong> nella Risp. Apol. sui «partigiani» <strong>del</strong> poeta,<br />
che, per ogni lombardismo trovato nell’Ariosto, «ne confessano cinquanta<br />
nel Goffredo», nota acremente a proposito di partigiano: «il qual [vocabolo] voi<br />
con la vostra natia pronunzia in partegiano avendo rivolto, ci fate parer goffissimo»<br />
(p. 121; cfr. Apol. pp. 476-77).<br />
63 Nel Rin. relativamente frequenti disio, disioso, disiato ecc. (II III 3, II<br />
XVIII 6, II XXIX 1, V LI 4 e 8 ecc.); disio è la forma infine prescelta da Ariosto<br />
nel Furioso (SEGRE 1976, p. 323).
FENOMENI FONOMORFOLOGICI 47<br />
di partenza, mentre la prima correzione resta ignorata a margine<br />
64.<br />
d) -E-/-O-. Per l’oscillaz. -o- / -e- in atonia <strong>del</strong>le voci <strong>del</strong> vb.<br />
dovere, il campionario <strong>del</strong> Chigiano si limita a devete LVI 7; devrei<br />
I 7 (forme petrarchesche) / dovrei LVIII +12, LXIX +17; dovrebbe<br />
XL 21. La Lib. sceglie sempre le forme in -o- (dovrebbe<br />
VIII LXX 4; dovete XII XVII 2, XIV LXXI 4 e LXXIX 4; dobbiam<br />
II LXXXV 6; dovria XIX LXXIV 3); al polo opposto si situa il<br />
Torr. – cui <strong>Tasso</strong> attese immediatamente dopo la stesura <strong>del</strong><br />
Chigiano – dove figurano in grande maggioranza voci in -e-,<br />
coerentemente alla propensione <strong>del</strong>la tragedia per forme latineggianti<br />
e nobilitanti (devrei 2702, devresti 2364, devreste 321, devrebbe<br />
1077, 3149, devete 331, devria 2211, devrian 1606 / dovrebbe<br />
133, dovuto 639, che viene criticato da Diomede Borghesi nella<br />
sua polemica linguistica contro il Torr. 65).<br />
e) -I-/-O-. Soltanto la forma dissimilata ritondetto CXLIV 2,<br />
non unica in <strong>Tasso</strong> (ritondo Rin. VII XIV 5; Lib. XI XXXV 5).<br />
f) -I-/-U-. La preferenza tra ribelle e rubello – tutti e due in<br />
Petrarca ma in rapporto di quattro a uno – cade sull’esemplare<br />
unico rubella (RVF 29 18 rubella di mercé) che sostanzia direttamente<br />
CXXII 34 («luna rubella / d’ogni pietà») e indirettamente<br />
XXV 14 e LXXXI 69; isolato ribelle LXXXII 10: il rapporto,<br />
rispetto a Petrarca, si è rovesciato, l’hapax è diventato forma<br />
comune, secondo prassi non solo tassiana ma <strong>del</strong> petrarchismo<br />
in genere, che sceglie fra i doppioni <strong>del</strong>la lingua <strong>del</strong>l’aretino le<br />
<strong>varianti</strong> più preziose, attraenti proprio per la loro rarità, e finisce<br />
per sfruttarle in misura anche maggiore <strong>del</strong>l’allotropo comune,<br />
con perdita <strong>del</strong>l’eventuale valore espressivo originario.<br />
Postoniche. Nei derivati dal lat. iuvenis, netta la scelta per la<br />
forma, che corrobora Petrarca 66 col latino, giovenil LXII 12; giovenetto<br />
XCVII 14, come dimostrano le correzioni giovinetto > gio-<br />
64 Sicuro prevale, al solito, nel Rin. (I XX 3, I LXVIII 3, III XXIX 8, IV<br />
XLVIII 5, V LI 1; V LXI 8 ecc.) e in molte <strong>del</strong>le Rime.<br />
65 MINESI 1980, p. 73 e sgg. Le forme latineggianti predominano in Bernardo<br />
<strong>Tasso</strong> (devevate Amori I 42 28; devrei I 54 12; devreste II 12 46 ecc.).<br />
66 Cfr. EWALD 1907, p. 11. Discorda dal resto degli editori esaminati<br />
Dolce, che in quattro casi su cinque innova: giovene > giovane RVF 30 1; 53 97;<br />
325 51; 359 49.
48 CAPITOLO PRIMO<br />
venetto LXXXI 88; giovinetti > giovenetti CXLIV 11; giovinetta ><br />
giovenetta CLI arg.; tralasciati giovinetta II 2 e, di seguito in due<br />
versi, giovanezza e giovanil LXIX 48-49, queste ultime adattate<br />
poi nell’Osanna: giovanil > giovenil e giovanezza > giovinezza 147<br />
48-49. Estraneo > estranio LIII 6 rappresenta il riaccostamento<br />
anche formale alla fonte petrarchesca (si noti la memoria fonica<br />
<strong>del</strong> verso: RVF 23 63 «mercé chiamando con estrania voce»;<br />
<strong>Tasso</strong>: «o di gemme che mandi estranio mare», e l’ambientazione<br />
acquatica: l’amate rive; il mare); si agisce di conserva a LXXXI<br />
72: estrane > estranie. Come nel caso di rubello / ribelle, estranio è<br />
hapax petrarchesco: altrove sempre strano e stranio; <strong>Tasso</strong> lo diffonde<br />
nella Lib. e già nel Rin., parimenti alla forma latineggiante<br />
qui corretta 67. Consueto debil XVIII 89, LXXVIII 1.<br />
2.2. ACCIDENTI VOCALICI<br />
2.2.1. Aferesi. Il processo correttorio, che riguarda per una<br />
parte consistente questioni di «concorsi» vocalici, di ammorbidimento<br />
<strong>del</strong> verso attraverso legatura ecc., comporta l’aumento<br />
<strong>del</strong> numero complessivo di aferesi in parole che cominciano<br />
con in-: infelice > ’nfelice XVIII 16; ingrato > ’ngrato XVIII 23; increbbe<br />
> ’ncrebbe XVIII 73; indarno > ’ndarno LXXI 1; accende ><br />
’ncende CVII 6 (con incremento di nobiltà lessicale), che si aggiungono<br />
a ’ntenerisce CVII 8; ’ntepidito CLII 64. Il fenomeno,<br />
che si registra mediamente in tutte le opere di <strong>Tasso</strong>, avrà dunque<br />
valore genericamente poetico, non senza radici dialettali<br />
settentrionali 68, ma il suo impiego non è casuale, anzi segue regolarmente<br />
una norma implicita: 1) aferesi con la cong. e: e<br />
’nchino LXXXV 8; e ’ncende CVII 6; e ’ntenerisce CVII 8; e ’ndarno<br />
CIX 6; e ’ntorno CXLVI 11; e ’ntepidito CLII 64 (ed e ’ndora<br />
XLVIII 4*), come confermano i luoghi in cui la cong. è introdotta<br />
in correzione: «crudo infelice» > «c. e ’nfelice» XVIII 16;<br />
«fuggitivo ingrato» > «f. e ’ngrato» XVIII 23; «… rime, indarno<br />
67 Lib. III IV 2 (estranio lido); VII XLVII 2, XVI XX 1, XVIII XI 6, XVIII<br />
XXV 5, XVIII LI 2, XX CIV 3; Torr. 1200, 1475, 1802. Viene progressivamente<br />
soppiantata così la forma mista estrano, unica presente nel Rin. II L 1 e<br />
LI 1, III I 2 e 3, III XV 2, III XXVI 3 ecc.<br />
68 «È in genere un tratto che distingue la parlata dialettale o venata di dialettalismo<br />
<strong>del</strong>la lingua colta»: MENGALDO 1963, p. 68.
FENOMENI FONOMORFOLOGICI 49<br />
spese» > «… e ’ndarno s.» LXXI 1; 2) aferesi evitata in tutti gli<br />
altri casi (in prevalenza si tratta di monosillabi atoni): con che:<br />
ch’infinito XII 8; ch’impressa XLI 1; ch’ingombro CXXII 56;<br />
ch’intanto CXXII 62, e di conseguenza ci si regola in correzione:<br />
che ’ntento > ch’intento XXIII 5; che ’ntorno > ch’intorno CLII 61; che<br />
’nvidia > ch’invidia CLV 1 (e scompare che ’ndegno LXXII 2*);<br />
pertanto la forma intera è ripristinata se vien meno la cong. e: e<br />
’nsieme > «mira insieme» X 14; e ’nvaghisce > «et invaghisce» > «anzi<br />
i.» CXXXVIII 8; altre occorrenze, tutte in osservanza <strong>del</strong>la<br />
norma suddetta: n’intende VIII 10; l’inaspra XVIII 56; «così è<br />
’ntricato» > «… intricato» XVIII 75 ecc. ecc. Unica deroga: le increbbe<br />
> le ’ncrebbe XVIII 73. Certo l’uso costante <strong>del</strong>l’aferesi solo<br />
con la congiunzione più elementare va posto in relazione<br />
con la larga revisione dei fatti di apocope ed elisione di cui si<br />
dirà più avanti, e in particolare ha in comune con quelli la scelta<br />
<strong>del</strong>la scrittura integrale <strong>del</strong> vocabolo, tranne che<br />
nell’eventualità in cui si produca la legatura minima tra i singoli<br />
componenti <strong>del</strong>la frase, in cui dunque la loro indipendenza sia<br />
meno compromessa dal punto di vista fonosintattico 69.<br />
Aferesi in parole comincianti con voc. seguita da s + cons.:<br />
sciugasti > asciugasti CXXII 59, con eliminazione, ancora una<br />
69 Salviati invece prescrive sempre l’aferesi con il, in, in-, im-, salvo se tonici<br />
(l’impio, l’Indo, l’inclito) o se seguiti da l, r, s (l’inlecito, l’inregolato,<br />
l’instigamento): si ha da scrivere lo ‘mperadore ecc. «non ostante che nelle stampe<br />
si sia nel verso introdotto abuso in contrario, senz’altro fondamento che<br />
<strong>del</strong>l’esserci fatti a credere, senza saper perché, che l’invidia, l’incarco, l’innanellato<br />
e sì fatti abbiano un non so chente più <strong>del</strong> peregrino e <strong>del</strong> vago» (Avvertim., I,<br />
p. 195). E infatti corregge in Guarini ch’inamora e s’ingiusto in che ’nnamora e se<br />
’ngiusto (BATTAGLIN 1965, p. 272). Segnalo qui in nota la singolare congruenza<br />
di alcune scelte tassiane in fatto di aferesi con la loro fonte petrarchesca:<br />
«e’ntepidito il foco» CLII 64 riporta a RVF 315 2 «e’ntepidir già sentia il foco»;<br />
«servo fuggitivo e ’ngrato» XVIII 23 (ottenuto in correz.) a RVF 360 109 «et<br />
tal merito à chi ’ngrato serve»; «quando, rivolto a me ch’intento e fiso» XXIII 5<br />
(anch’esso ottenuto in correz.) richiama RVF 17 8 «mentr’io son a mirarvi<br />
intento e fiso». Ma si tratterà di congruenza fortunosa (tranne forse nell’ultimo<br />
caso), dato che le edd. cinquecentesche di Petrarca negli incontri vocalici,<br />
come si vedrà anche per l’elisione, reintegravano o eliminavano le vocali a<br />
piacimento (ad es. MANUZIO, Il Petrarcha, DOLCE, Il Petrarca, RUSCELLI, Il<br />
Petrarca e VELLUTELLO, Il Petrarca presentano nei luoghi citt. sempre ’ntepidir<br />
ma anche ingrato).
50 CAPITOLO PRIMO<br />
volta, <strong>del</strong> tratto settentrionale. È tradizionale verno LVII 4,<br />
LXIX 79, CLIII 6, cui risponde fuori dal verso state XCVIII<br />
arg.<br />
2.2.2. Prostesi. Il gusto per l’intensificazione <strong>del</strong> corpo <strong>del</strong>la<br />
parola attraverso prefisso preposizionale (cfr. cap. III, § 1.6)<br />
influisce certamente sui casi, frequenti in <strong>Tasso</strong>, di prostesi davanti<br />
a s implicata 70. Tanto più notevole allora il fatto che <strong>Tasso</strong><br />
elimini durante la revisione tutti i nessi prostetici all’infuori<br />
di istesso, riconoscendo probabilmente nel fenomeno un eccesso<br />
arcaizzante (si ricordi che Bembo ne aveva supposto<br />
l’origine provenzale, muovendo a sdegno Castelvetro 71), non<br />
necessariamente distintivo (conto cinque casi nel Canzoniere,<br />
solo uno dei quali in sinalefe 72), e al limite connesso ad abitudini<br />
settentrionali: ispetra > spetra XL 32; isviar > desviar XLI 7;<br />
ischivo > schivo LIV 10; isbigottito > sbigottito LXXXI 108 73. Restano<br />
dunque solo una istessa face XVIII 32; l’istesso LXXXI 123;<br />
queste mani istesse CXLIII 12 (sempre in sinalefe o elisione, a<br />
conferma di quella ricerca eufonica che è tipica <strong>del</strong> Chigiano),<br />
dove l’i sarà visto anche come raccostamento al latino (iste). Latinismo<br />
tradizionale historie XXIII 14.<br />
2.2.3. Sincope. <strong>Tasso</strong> non conosce mai in poesia le forme<br />
piene corrispondenti a spirto II 4, XI 13, XVI 4 ecc.; opre XVI<br />
3, LXXXI 49, CII 3 ecc. (opera scompare da LXXII 11, figura<br />
in CIV arg.); merto XVIII 5, LXIX 22; carco: incarco CXXII 56-<br />
63; temprate XXIV 2; hedra CXXI 2: si è realizzata ormai «la<br />
tendenza storica… ad accogliere <strong>del</strong> lessico petrarchesco solo<br />
le voci più ‘poetiche’, scartando le <strong>varianti</strong> ritenute prosasti-<br />
70 Ad es. nella Lib. iscacciar II LXIV 6; ischietto VI XCI 5; isciagura VIII VIII<br />
3.<br />
71 Cfr. BEMBO, Prose, p. 103 e CASTELVETRO, Giunta, pp. 649-50.<br />
72 E cfr. ROHLFS 1966, § 187: «Dante fa uso <strong>del</strong>la i molto raramente, di<br />
regola allo scopo di ottenere il numero di sillabe necessario».<br />
73 Il provvedimento è rispettato nelle edd. Osanna e Marchetti, inclini invece<br />
talora a rivalutare lezioni respinte nel Chigiano: qui è il caso solo di isbigottito.
FENOMENI FONOMORFOLOGICI 51<br />
che» 74. È pur vero che <strong>Tasso</strong> è in grado talora di sfruttare la<br />
«più densa sonorità» 75 di tali forme per effetti stilistici: nelle<br />
quartine di CXXI, sonetto che contamina il Vivamus mea Lesbia<br />
catulliano con la Salmace <strong>del</strong>le Metamorfosi e il catalogo arboreo<br />
<strong>del</strong>le Georgiche, l’impellenza <strong>del</strong>la richiesta amorosa, che si esprime<br />
in amianci 1 e poi di nuovo in bacinsi 5, si ripercuote su<br />
hedra 2, distempri 6, spirto 8, oltre che su: «caro tronco abbraccia»<br />
2.<br />
2.2.4. Epitesi. Per le forme arcaizzanti <strong>del</strong> perfetto <strong>del</strong> tipo<br />
feo, poteo si rimanda a § 2.5.3. Va perduto anche Pane CXXII<br />
52* (esclusivo nell’Am.), sostituito dalla perifrasi «al Signor degli<br />
armenti e de’ pastori», che sfrutta l’altro emistichio di Am.<br />
180 «Pane fu padre, il gran Dio de’ pastori».<br />
2.2.5. Apocope ed elisione. Non sarà il caso di ricercare, a Cinquecento<br />
inoltrato, i troncamenti irregolari, fuori dai limiti<br />
<strong>del</strong>l’apocope tradizionale, che caratterizzano la prassi poetica<br />
quattrocentesca e che vengono ridimensionati dove con più<br />
forte coscienza poetica si impone il mo<strong>del</strong>lo petrarchesco (è<br />
notevole la presa di posizione di Sannazaro, con ampio intervento<br />
correttorio nell’Arcadia e nelle rime 76): dunque assenza di<br />
apocopi dei femm. in -a al sing. e al pl. (ancora presenti nella<br />
cerchia poetica medicea di fine Quattrocento: Poliziano paur[a];<br />
cur[e]; Lorenzo chiar[e] 77), ma in compenso largo sfruttamento<br />
dei troncamenti non consueti dei pl. in -i, già in Bembo e ancor<br />
più in Ariosto 78; così in <strong>Tasso</strong>, dove l’aperta cantabilità <strong>del</strong> ver-<br />
74 MENGALDO 1963, p. 69.<br />
75 GHINASSI 1957, p. 11.<br />
76 Cfr. FOLENA 1952, pp. 37-40 e MENGALDO 1962, pp. 471-72.<br />
77 GHINASSI 1957, pp. 11-4.<br />
78 Per l’apocope in Bembo, che «nelle Rime non si comporta in stretta osservanza<br />
con quanto prescrivono le Prose» (troncamenti al sing.: ad es. liquor,<br />
testimon, tuon, stranier, fral; al pl.: stagion’, pregion’, scrittor’, martir’ ecc.) e in Ariosto<br />
(al pl.: dilettevol’ suoni, lodevol’ prove, facil’ frodi, fier’ Circassi, adulazion’, angel’,<br />
giardin’ e molti altri) si veda MOLINARI 1990, pp. 55 e 73-77. La frequenza di<br />
troncamenti in Ariosto era avvertita anche dai contemporanei. Ruscelli, nelle<br />
Mutationi, et miglioramenti che M. Lodovico Ariosto havea fatti per mettere nell’ultima<br />
impressione <strong>del</strong> Furioso che accompagnano la sua ed. <strong>del</strong> Furioso, vedeva
52 CAPITOLO PRIMO<br />
so, l’insistita ricerca di scandite figure prosodiche,<br />
l’allacciamento di legami fonici all’interno <strong>del</strong> verso e tra versi<br />
in sequenza sono certo fenomeni connessi a un uso consistente<br />
<strong>del</strong>l’apocope 79.<br />
Anche su questo fronte il nostro testo si segnala per un generale<br />
processo di normalizzazione, che porta a smussare le<br />
punte di alcuni troncamenti eccezionali: vergin sacra > vergine sacra<br />
CXX 10; rai solar CXXII 43*; tal maraviglie > tal Maraviglia<br />
LXXXII 8 (in partenza tai maraviglie, per la diminuzione di queste<br />
forme palatalizzate cfr. § 1.3.3); anche il duro volavam > andò<br />
volando II 11 80. Permangono le seguenti apocopi anomale al<br />
plurale: divin pregi XXIII 11; bei rubin VI 10 (di trafila bembesca:<br />
Rime 71 2 «neve, or, perle, rubin, due stelle, un sole», che si riflette<br />
in «ma di coralli e d’or, di perle e d’ostri» LIV 9); «qual di<br />
Tantalo i pomi» CXLIV 12 (attenuato dall’iperbato); tra i proparossitoni:<br />
mirabil piaghe CXXIV 50 (mirabil è petrarchesco 81);<br />
nell’abbondanza di apocopi in l al pl. <strong>del</strong> tipo solazzevol balli un tratto dialettale,<br />
proprio <strong>del</strong> parlato: Ariosto usò «modi di dire… né sconvenevoli, né conosciuti<br />
universalmente per brutti… ma… communi… et usati universalmente<br />
da tutti nel parlar corrente, sì come sappiamo esser questo, <strong>del</strong> qual<br />
qui diciamo, cioè <strong>del</strong>l’usare accorciati <strong>del</strong>l’ultima vocale nel maggior numero i<br />
detti nomi che hanno la l semplice nell’ultima sillaba» (ibid., p. 46). Sotto questo<br />
aspetto, Della Casa è assai più parco di apocopi notevoli nel suo canzoniere<br />
(fol 40 8; sentier novi 26 6; sentier primi 47 102 e pochissimo altro).<br />
79 Difficile stabilire quanto la frequenza di troncamenti in <strong>Tasso</strong> sia influenzata<br />
dalle sue abitudini di parlante settentrionale; più agevole appurare la<br />
«collaborazione di consuetudini nordiche» (RAIMONDI 1958, p. 219) nella<br />
prosa, ma esempi come pensier leggiadri, maggior principi sono di matrice puramente<br />
ritmica.<br />
80 La scomparsa degli apocopati sdruccioli Nettar XVIII 47 e ocean<br />
LXXXIII 13* (sdrucciolo in teoria, in realtà piano per diastole) va messa in<br />
conto più a motivi prosodici che linguistici, come si vedrà al cap. V, § 2.<br />
81 Gli esigui casi petrarcheschi di troncamento di plurali sono stati variamente<br />
interpretati dai grammatici <strong>del</strong> Cinquecento: da un lato (Giraldi Coinzio<br />
– su cui cfr. ancora MOLINARI 1990, spec. le pp. 45-48 – e in parte Salviati)<br />
come autorizzazione ad un uso disinvolto, dall’altro come circoscritta eccezione<br />
che ne conferma l’irregolarità (Ruscelli e Dolce). In Petrarca due volte<br />
mirabil tempre RVF 119 43; 248 11; i vicin’ 48 10; perle oriental’ 199 5; tanti<br />
lacciuol’ 69 3; arbor’ 323 27; ma il luogo deputato al confronto con le abitudini<br />
ariostesche è Tr. Am. I 159 «e di lacciuoli innumerabil carco»: «Troncò spesso<br />
l’Ariosto la L non solo alle voci nel numero <strong>del</strong> meno ma anche <strong>del</strong> più, co-
FENOMENI FONOMORFOLOGICI 53<br />
nobil fiamme CXXVII 10 (inizialmente nobil fiamma, mutato per<br />
parallelismo); però nobil plurale viene estromesso due volte dal<br />
Chigiano: nobil voglie > alte voglie CLV 8; le nobil onde > ch’intorno<br />
inonda LIV 3 82. Con suffisso -iere, -iero: «suoi consiglier fe<strong>del</strong>i»<br />
CXXIV 50 e «i suoi guerrier» CXXXVIII 6; il primo estende al<br />
plurale l’apocope petrarchesca di RVF 360 35 («di ciò m’è stato<br />
consiglier sol esso»), il secondo trova conferma in Bembo,<br />
Rime 68 12 («gir devevi lontan dai guerrier tuoi»), ma converrà<br />
supporne la provenienza, in entrambi i casi, dal cospicuo gruppo<br />
di sostantivi apocopati plurali con identico suffisso utilizzati<br />
dall’epica tassiana e ariostesca: ad es. Lib. guerrier I XXI 1, VI<br />
XX 4, IX XL 4, IX LIII 2, IX LIX 2, IX XCII 1 ecc.; Aventurier<br />
V I 7, XX X 5; destrier IX XVII 7, XVII XXII 2, XVII XXIX 6,<br />
XVII XXXIV 7; cavalier IX XLIX 7, XI XXV 1, XV XI 3, XVII<br />
LVI 1 ecc.; scudier XII LXXIV 1; messaggier XVIII LXIV 2 83.<br />
me in quel verso: “havea infiniti et immortal trofei” [Furioso I V 4], “ne i molti<br />
assalti e ne i cru<strong>del</strong> conflitti” [Furioso XIV I 1], ove l’intera voce è immortali e<br />
cru<strong>del</strong>i. E anco il Petrarca, ove e’ disse: “e di lacciuoli innumerabil carco”»<br />
(DOLCE, Osservaz., pp. 31-33); «Non si mozza alcun nome nel numero de’ più<br />
il quale, mozzato, resti finito in l; tuttafiata l’uso, per compiacere al suono,<br />
rompe talor la regola in alcuni che escono in i… Il Petrarca disse: “e di lacciuoli<br />
innumerabil carco”, onde per aventura troppo rigorosi giudici son coloro<br />
che al moderno Poeta [scil. Ariosto] rimproverano i giovenil furori e<br />
gl’immortal trofei poiché in lungo e continuato poema eroico non gli concedono<br />
oggi l’uso di quelle cose che dall’antico nostro, in breve ed interrotta poesia,<br />
non fu schifata nel miglior tempo dal fior <strong>del</strong>la favella» (SALVIATI, Avvertim.,<br />
I, p. 215).<br />
82 Nel secondo caso conta l’estesa correzione (vd. qui avanti) di parole<br />
apocopate davanti a vocale (ma l’integrazione <strong>del</strong>la voc. è resa difficoltosa<br />
dalla posizione in decima sede; d’altra parte nobile ira in punta di verso a<br />
CXXII 6). Nella Lib. nobil acque XI LXX 3; instabil onde XV XV 7; nobil ire XX<br />
LIX 2.<br />
83 Per guerrier, destier, cavallier, nocchier ecc. nel Furioso si veda MOLINARI<br />
1990, pp. 73-77. Gran copia di troncamenti inconsueti <strong>del</strong>la Lib. al pl.: sost.:<br />
abitator IV III 1, XIII VII 4 e XV XXVII 3; rossor IV XXXVIII 5; vincitor VII<br />
CXVIII 6, XIX CXXXI 2 e XX CXLIV 4; onor VIII LXV 8; vapor IX XV 2; confin<br />
IX LVI 3, XIX CXXV 4 e XX CXXXIX 6; difensor XI XXIX 4; saracin XI<br />
XLVIII 8; furor XII LXXVIII 3; impression XIII LIII 4; prigion XIV LI 8; Faraon<br />
XVII IV 8; imagin XVII LVIII 5 e XCI 1; monton XVIII LXIV 8; pagan XVIII<br />
LXXXVI 2; campion XVIII XCIV 1 e XIX LXXIV 3; padiglion XIX VIII 2; traditor<br />
XIX CXXIX 5; liberator XX VI 6; cimier XX XXVIII 6; tesor XX CXLII 4;<br />
forse anche monil XVII XXXV 6; agg.: vicin I LXXXII 7; volubil XVIII XLV 2;