Untitled - Comune di Bastia Umbra
Untitled - Comune di Bastia Umbra
Untitled - Comune di Bastia Umbra
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
COMUNE DI BASTIA UMBRA<br />
C.E.U. srl Energy Project S.r.l.<br />
SISTEMA INTEGRATO GEOTERMICO-SOLARE<br />
CENTRALIZZATO<br />
Impianto fotovoltaico<br />
Impianto idroelettrico<br />
Impianto <strong>di</strong> teleriscaldamento<br />
Impianto <strong>di</strong> cogenerazione<br />
STUDIO DI PRE-FATTIBILITA’<br />
1
RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA E PRESTAZIONALE<br />
In<strong>di</strong>ce<br />
- IMPIANTO FOTOVOLTAICO<br />
- IMPIANTO IDROELETTRICO<br />
- IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO E COGENERAZIONE<br />
PREMESSA E CONSIDERAZIONI<br />
Il presente progetto ha lo scopo <strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzare il Piano Attuativo in oggetto verso filosofie<br />
particolarmente efficaci ed efficienti nel favorire il risparmio energetico e nel migliorare la<br />
sostenibilita' e la competitivita' del sistema energetico della città <strong>di</strong> <strong>Bastia</strong> <strong>Umbra</strong>.<br />
Si vuole proporre un’iniziativa innovativa e interessante dal punto <strong>di</strong> vista prima <strong>di</strong> tutto<br />
tecnologico, ma che, come illustreremo, <strong>di</strong> riflesso riguarda altre sfere, da quella ambientale a<br />
quella occupazionale.<br />
Con questa relazione si intende pertanto, definire solo alcuni aspetti principali e dare un cenno<br />
delle possibilità realizzative all’interno dell’area <strong>di</strong> intervento del PAIM, delle caratteristiche delle<br />
soluzioni impiantistiche e dei vantaggi conseguenti all’impiego <strong>di</strong> un sistema integrato<br />
centralizzato, costituito da impianto a pannelli fotovoltaici, impianto idroelettrico, impianto <strong>di</strong><br />
teleriscaldamento e <strong>di</strong> cogenerazione.<br />
1) IMPIANTO FOTOVOLTAICO<br />
CARATTERISTICHE GENERALI<br />
Un impianto fotovoltaico permette <strong>di</strong> trasformare <strong>di</strong>rettamente l’energia solare in energia<br />
elettrica in corrente continua grazie all’effetto fotovoltaico. Tale fenomeno si manifesta nei<br />
materiali detti “semiconduttori”, usati anche nella produzione <strong>di</strong> componenti elettronici, il più<br />
conosciuto dei quali è il silicio. Gli aspetti positivi della tecnologia fotovoltaica possono riassumersi<br />
in:<br />
• assenza <strong>di</strong> qualsiasi tipo d’emissione inquinante durante il funzionamento dell’impianto;<br />
• risparmio dei combustibili fossili;<br />
• estrema affidabilità poiché, nella maggior parte <strong>di</strong> casi, non esistono parti in movimento (vita<br />
utile, <strong>di</strong> norma, superiore a 20 anni);<br />
• costi <strong>di</strong> esercizio e manutenzione ridotti;<br />
• modularità del sistema (per aumentare la taglia basta aumentare il numero dei moduli).<br />
Le principali applicazioni dei sistemi fotovoltaici sono:<br />
1. impianti (con sistema d’accumulo) per utenze isolate dalla rete;<br />
2
2. impianti per utenze collegate alla rete <strong>di</strong> bassa tensione;<br />
3. centrali <strong>di</strong> produzione <strong>di</strong> energia elettrica, generalmente collegate alla rete in me<strong>di</strong>a tensione.<br />
La producibilità elettrica me<strong>di</strong>a annua <strong>di</strong> un impianto fotovoltaico può essere valutata attraverso<br />
un calcolo che tiene conto:<br />
‐ della ra<strong>di</strong>azione solare annuale del sito (determinabile ricorrendo a banche dati: UNI 10349,<br />
Atlante Solare Europeo, ENEA);<br />
‐ <strong>di</strong> un fattore <strong>di</strong> correzione calcolato sulla base dell’orientamento, dell’angolo d’inclinazione dei<br />
moduli fotovoltaici e <strong>di</strong> eventuali ombre temporanee;<br />
‐ delle prestazioni tecniche dei moduli fotovoltaici, dell’inverter e degli altri componenti<br />
dell’impianto;<br />
‐ delle con<strong>di</strong>zioni ambientali <strong>di</strong> riferimento del sito nelle quali devono operare i moduli<br />
fotovoltaici (ad esempio con l’aumento della temperatura <strong>di</strong> funzionamento <strong>di</strong>minuisce<br />
l’energia prodotta dall’impianto).<br />
Il DM 19/02/07 (nuovo Conto Energia) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23/02/2007, è<br />
subentrato ai precedenti DM del 28/07/2005 e del 6/02/2006 (primo Conto Energia) in materia <strong>di</strong><br />
incentivazione dell’energia fotovoltaica. Il decreto è <strong>di</strong>ventato operativo solo dopo la<br />
pubblicazione della delibera dell’AEGG n. 90/07, avvenuta il 13/04/07, che ha definito le con<strong>di</strong>zioni<br />
e le modalità per l’erogazione delle tariffe incentivanti.<br />
Per quanto stabilito dal DM del 19/02/07 gli impianti fotovoltaici entrati in esercizio a partire dal<br />
1° gennaio 2009 hanno <strong>di</strong>ritto a una tariffa incentivante articolata secondo i valori in<strong>di</strong>cati nella<br />
seguente tabella (€/kWh).<br />
3
Il DM 19/02/2007 definisce inoltre tre tipologie d’integrazione ai fini <strong>di</strong> una classificazione <strong>di</strong><br />
ciascun impianto fotovoltaico:<br />
1) impianto non integrato<br />
2) impianto parzialmente integrato<br />
3) impianto con integrazione architettonica<br />
1(non integrato) 2 (parzialmente integrato) 3 (integrato)<br />
Il comune <strong>di</strong> <strong>Bastia</strong> <strong>Umbra</strong> è caratterizzato da latitu<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> 43°04’17’’ N e longitu<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> 12°32’49’’<br />
E, ciò vuol <strong>di</strong>re che in questa località un impianto fotovoltaico in con<strong>di</strong>zioni ottimali produce in un<br />
anno in me<strong>di</strong>a 1250 kWh/kWp installato.<br />
La proposta progettuale ha per oggetto un impianto <strong>di</strong> produzione <strong>di</strong> energia elettrica a pannelli<br />
fotovoltaici da circa 1 MWatt da integrare su strutture <strong>di</strong> copertura, opportunamente progettate e<br />
<strong>di</strong>rezionate.<br />
La localizzazione <strong>di</strong> queste pensiline è stata ipotizzata all’interno delle aree destinate dal Piano<br />
Attuativo a parcheggi pubblici fuori terra, in particolare nella fascia lungo la ferrovia dove<br />
funzionano anche da barriere antirumore e dove sono collocate le principali aree tecniche per la<br />
produzione e successiva <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> energia alle varie sottostazioni.<br />
Le pensiline sono quin<strong>di</strong> poste a copertura dei parcheggi per le auto e il pannello fotovoltaico<br />
sostituisce il materiale da costruzione convenzionale <strong>di</strong>ventando componente attivo dell’involucro,<br />
allo scopo <strong>di</strong> combinare gli aspetti tecnici ed estetici della tecnologia con l’arredo urbano.<br />
4
Esempi:<br />
2) IMPIANTO IDROELETTRICO<br />
CARATTERISTICHE GENERALI<br />
Si tratta <strong>di</strong> un tipo <strong>di</strong> impianto che trasforma l’acqua, in questo caso <strong>di</strong> un fiume, in energia<br />
elettrica; nello specifico l’acqua viene convogliata in una condotta forzata fino ad arrivare alle<br />
turbine che ruotano grazie alla spinta dell'acqua stessa. Ognuna <strong>di</strong> esse è accoppiata a un<br />
alternatore che trasforma il movimento <strong>di</strong> rotazione in energia elettrica.<br />
La velocità impressa dall'acqua alle turbine viene generata attraverso una <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> quota,<br />
detta "salto", che si traduce in pressione idro<strong>di</strong>namica alla quota in cui sono posizionate le turbine.<br />
Di seguito vengono riportati in via preliminare i dati tecnici, delle producibilità <strong>di</strong> una centralina<br />
idroelettrica, la cui costruzione viene ipotizzata sul fiume Chiascio, secondo i quattro tracciati<br />
ipotizzati e riportati nel grafico allegato B.<br />
1) Prima ipotesi (A‐C‐D)<br />
‐ Opera presa a monte della briglia alla confluenza con il Tescio (A)<br />
‐ Dati tecnici<br />
‐ Condotta <strong>di</strong> adduzione interrata lunghezza 800 mt<br />
‐ Centrale a monte della briglia del ponte sulla strada Torgianese (C)<br />
‐ Canale <strong>di</strong> scarico (lunghezza 60 mt) sotto la briglia e rilascio a valle della briglia stessa (D)<br />
• salto me<strong>di</strong>o mt 8,80<br />
• portata massima derivabile mc/sec 4<br />
• portata me<strong>di</strong>a turbinatile mc/sec 2,6<br />
• potenza istallata KW 300<br />
• potenza me<strong>di</strong>a nominale KW 195<br />
• energia elettrica annua prodotta KWh 1.700.000<br />
5
2) Seconda ipotesi (A‐D)<br />
‐ Opera presa a monte della briglia alla confluenza con il Tescio (A)<br />
‐ Dati tecnici<br />
‐ Condotta <strong>di</strong> adduzione interrata lunghezza 860 mt<br />
‐ Centrale a valle della briglia del ponte sulla strada Torgianese (D)<br />
‐ Canale <strong>di</strong> scarico (lunghezza 20 mt) con rilascio a valle della briglia stessa (D)<br />
• salto me<strong>di</strong>o mt 8,80<br />
• portata massima derivabile mc/sec 4<br />
• portata me<strong>di</strong>a turbinatile mc/sec 2,6<br />
• potenza istallata KW 300<br />
• potenza me<strong>di</strong>a nominale KW 195<br />
• energia elettrica annua prodotta KWh 1.700.000<br />
3) Terza ipotesi (B‐C‐D)<br />
‐ Opera presa a monte della briglia sotto al ponte della ferrovia (B)<br />
‐ Dati tecnici<br />
‐ Condotta <strong>di</strong> adduzione interrata lunghezza 650 mt<br />
‐ Centrale a monte della briglia del ponte sulla strada Torgianese (C)<br />
‐ Canale <strong>di</strong> scarico (lunghezza 60 mt) sotto la briglia e rilascio a valle della briglia stessa (D)<br />
• salto me<strong>di</strong>o mt 5,30<br />
• portata massima derivabile mc/sec 4,3<br />
• portata me<strong>di</strong>a turbinatile mc/sec 2,9<br />
• potenza istallata KW 190<br />
• potenza me<strong>di</strong>a nominale KW 130<br />
• energia elettrica annua prodotta KWh 1.100.000<br />
4) Quarta ipotesi (B‐D)<br />
‐ Opera presa a monte della briglia sotto al ponte della ferrovia (B)<br />
‐ Dati tecnici<br />
‐ Condotta <strong>di</strong> adduzione interrata lunghezza 650 mt<br />
‐ Centrale a valle della briglia del ponte sulla strada Torgianese (D)<br />
‐ Canale <strong>di</strong> scarico (lunghezza 20 mt) con rilascio a valle della briglia stessa (D)<br />
• salto me<strong>di</strong>o mt 5,30<br />
• portata massima derivabile mc/sec 4,3<br />
6
• portata me<strong>di</strong>a turbinatile mc/sec 2,9<br />
• potenza istallata KW 190<br />
• potenza me<strong>di</strong>a nominale KW 130<br />
• energia elettrica annua prodotta KWh 1.100.000<br />
Tutti i dati <strong>di</strong> cui sopra devono intendersi <strong>di</strong> massima e pertanto suscettibili <strong>di</strong> variazioni fino +<br />
10%.<br />
Considerazioni generali<br />
a) soluzioni con l’opera <strong>di</strong> presa nel punto A<br />
- l’opera <strong>di</strong> presa viene a trovarsi in corrispondenza <strong>di</strong> un previsto viadotto della nuova<br />
viabilità, <strong>di</strong> cui non si sa ancora se i relativi pilastri possono o meno interferire.<br />
- la stessa condotta deve transitare nel previsto sottopasso della ferrovia comportando un<br />
<strong>di</strong>mensionamento <strong>di</strong>verso dello stesso, rispetto a quello già progettato<br />
- per quanto verificato dalle carte tecniche e sezioni <strong>di</strong>sponibili, la quota del pelo libero<br />
dell’acqua all’opera <strong>di</strong> presa, quasi sicuramente impe<strong>di</strong>rà la realizzazione <strong>di</strong> una condotta<br />
<strong>di</strong> adduzione interrata. (situazione da verificare con rilievi topografici dettagliati)<br />
- in corrispondenza dell’opera <strong>di</strong> presa si renderà necessario abbattere alcune piante <strong>di</strong> alto<br />
fusto<br />
b) soluzioni con la centrale nel punto C<br />
- il canale <strong>di</strong> scarico transiterebbe circa 3 mt sotto la briglia, determinando opere civili<br />
maggiori e autorizzazioni anche da parte della Provincia in quanto si andrebbe a operare<br />
vicinissimo alle fondazioni del ponte<br />
- occorrerà valutare le eventuali opere necessarie per non interferire con la condotta gas<br />
metano in transito in quella zona, le cui <strong>di</strong>mensioni, portate e profon<strong>di</strong>tà non sono al<br />
momento note<br />
c) le soluzioni con l’opera <strong>di</strong> presa nel punto B, consente <strong>di</strong> sfruttare circa 0.3 mc/sec in più<br />
delle altre soluzioni in quanto sfrutterebbe anche l’acqua in rilascio dal laghetto in<br />
costruzione subito a monte. Tale quantitativo infatti, andrebbe lasciato defluire nelle<br />
soluzioni con presa nel punto A.<br />
Delle soluzioni descritte riteniamo che la quarta, Tracciato B‐D, per questioni principalmente<br />
riguardanti l’ impatto ambientale, sia la più opportuna e consona alle esigenze del progetto e del<br />
luogo. Ci riserviamo comunque analisi altimetriche e tecniche più specifiche.<br />
7
3) IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO CON PRODUZIONE COMBINATA DI<br />
ENERGIA E COGENERAZIONE<br />
CARATTERISTICHE GENERALI<br />
Un sistema <strong>di</strong> teleriscaldamento consiste essenzialmente in una rete <strong>di</strong> trasporto del calore (che<br />
permette <strong>di</strong> servire contemporaneamente più e<strong>di</strong>fici) e in una centrale <strong>di</strong> produzione.<br />
Le <strong>di</strong>mensioni <strong>di</strong> un sistema <strong>di</strong> Teleriscaldamento possono essere molto variabili, si va dal piccolo<br />
quartiere ad una intera città.<br />
I sistemi <strong>di</strong> teleriscaldamento urbano rappresentano una importante opportunità <strong>di</strong> utilizzazione<br />
razionale dell’energia e un doveroso contributo al contenimento della spesa energetica, alla<br />
riduzione delle emissioni <strong>di</strong> gas ad effetto serra ad al controllo dell’inquinamento locale. Infatti i<br />
consumi complessivi <strong>di</strong> energia nei settori residenziali e terziario costituiscono una significativa<br />
quota del totale nazionale (circa il 28%).<br />
Una centrale <strong>di</strong> teleriscaldamento può utilizzare tecnologie cogenerative e/o fonti rinnovabili e lo<br />
scopo finale è un risparmio <strong>di</strong> fonti fossili d’energia.<br />
Infatti se si utilizza il metano in modo cogenerativo l’input primario è sempre una fonte fossile ma<br />
complessivamente la maggiore efficienza della cogenerazione porta ad utilizzarne un quantitativo<br />
minore. Infine se l’input della centrale <strong>di</strong> produzione è una fonte rinnovabile (come la geotermia,<br />
le biomasse) si ha totale sostituzione delle fonti fossili.<br />
La riduzione del consumo <strong>di</strong> fonti fossili d’energia è un obiettivo da perseguire per motivi ormai<br />
noti, ma che riteniamo opportuno sottolineare:<br />
• Maggiore sviluppo economico: la sostituzione <strong>di</strong> materia prima importata (le fonti fossili)<br />
con investimenti in tecnologie efficienti e fonti rinnovabili (che sono risorse territoriali)<br />
porta ad un maggiore sviluppo e quin<strong>di</strong> occupazione.<br />
• In<strong>di</strong>pendenza energetica: l’Italia è un paese che <strong>di</strong>pende fortemente dall’estero per gli<br />
approvvigionamenti energetici, il che espone il Paese a con<strong>di</strong>zionamenti politici ed a rischi<br />
economici.<br />
• Equa <strong>di</strong>stribuzione delle risorse tra paesi e tra generazioni: le fonti fossili <strong>di</strong> energia sono<br />
una risorsa limitata utilizzata fortemente dai paesi sviluppati dalla rivoluzione industriale in<br />
poi. Il principio <strong>di</strong> equità richiederebbe un minor consumo <strong>di</strong> queste risorse da parte dei<br />
paesi sviluppati a favore <strong>di</strong> paesi in via <strong>di</strong> sviluppo e delle generazioni future.<br />
Si è ritenuto necessario uno stu<strong>di</strong>o per verificare, me<strong>di</strong>ante un’analisi tecnico‐economica, la<br />
possibilità <strong>di</strong> realizzare un impianto per la produzione combinata <strong>di</strong> energia elettrica e calore a<br />
servizio <strong>di</strong> una rete <strong>di</strong> teleriscaldamento a servizio della città <strong>di</strong> <strong>Bastia</strong> <strong>Umbra</strong>; procedendo ad un<br />
<strong>di</strong>mensionamento <strong>di</strong> massima dell’impianto in base alle esigenze energetiche ed ai fabbisogni dei<br />
potenziali utenti della rete <strong>di</strong> teleriscaldamento (TLR).<br />
8
Lo stu<strong>di</strong>o è stato sviluppato attraverso le seguenti fasi:<br />
- in<strong>di</strong>viduazione dei fabbisogni energetici;<br />
- sistema <strong>di</strong> produzione <strong>di</strong> energia elettrica e/o calore;<br />
- il sistema <strong>di</strong> teleriscaldamento;<br />
- valutazione dell’energia producibile;<br />
- benefici energetico‐ambientali.<br />
Sulla base <strong>di</strong> valori parametrici è stato valutato il fabbisogno delle utenze interessate da una prima<br />
fase <strong>di</strong> teleriscaldamento e il valore totale <strong>di</strong> energia è stimato in circa 14 GWht/a.<br />
All’interno del Piano è stata prevista la produzione combinata <strong>di</strong> energia, cioè l’utilizzo <strong>di</strong> motori <strong>di</strong><br />
cogenerazione ad olio e metano e caldaie <strong>di</strong> integrazione e riserva funzionanti con combustibile<br />
gas naturale. In questo modo si ottengono vantaggi ormai ampiamente assodati che possono<br />
essere valutati in circa il 40‐50% <strong>di</strong> risparmio rispetto all’energia chimica necessaria se la<br />
produzione delle due energie fosse separata.<br />
La riduzione del consumo <strong>di</strong> fonti energetiche fossili comporta vantaggi ambientali. L’esatto<br />
ammontare <strong>di</strong> emissioni ambientalmente nocive che vengono evitate da un sistema <strong>di</strong><br />
Teleriscaldamento va calcolato caso per caso e varia in base a:<br />
• Input energetico utilizzato nella centrale <strong>di</strong> produzione (metano,olio, combustibile,<br />
carbone, biomassa)<br />
• Tecnologia impiantistica<br />
• Tecnologie <strong>di</strong> impianti termici sostituiti presso l’utenza (caldaie a gasolio e metano)<br />
• Sistema elettrico <strong>di</strong> riferimento (il mix <strong>di</strong> centrali nazionali)<br />
Gli inquinanti che vengono ridotti o eliminati sono:<br />
• CO2 anidride carbonica, è un gas che provoca l’effetto serra, quin<strong>di</strong> un danno globale, non<br />
provoca invece effetti dannosi sull’ambiente locale.<br />
• Ossi<strong>di</strong> <strong>di</strong> Zolfo, producono danni alla salute umana e all’ambiente attraverso le piogge<br />
acide, quin<strong>di</strong> danni locali, regionali e globali.<br />
• Ossi<strong>di</strong> <strong>di</strong> Azoto, valgono le stesse considerazioni fatte per gli ossi<strong>di</strong> <strong>di</strong> Zolfo. Va sottolineato<br />
come senza l’utilizzo <strong>di</strong> adeguate tecnologie <strong>di</strong> abbattimento le emissioni <strong>di</strong> NOX<br />
potrebbero aumentare a livello locale pur <strong>di</strong>minuendo complessivamente nel bilancio<br />
ambientale nazionale. Questo perché la cogenerazione implica un aumento locale del<br />
consumo <strong>di</strong> combustibile, sebbene con una aumentata efficienza.<br />
• Particolato, produce danni alla salute umana e all’ambiente urbano (smog, danni ai<br />
monumenti).<br />
Inoltre l’eliminazione delle caldaie <strong>di</strong>stribuite sostituiti con un’unica centrale permette l’adozione<br />
delle migliori tecnologie <strong>di</strong> abbattimento degli inquinanti.<br />
Le centrali cogenerative, dovendo essere localizzate vicino ai centri urbani, <strong>di</strong>minuiscono il<br />
fabbisogno <strong>di</strong> nuove linee elettriche <strong>di</strong> trasmissione ad alta tensione.<br />
9
È risaputa l’ostilità delle comunità locali al passaggio <strong>di</strong> nuove linee elettriche per problemi <strong>di</strong><br />
integrità del paesaggio e <strong>di</strong> prevenzione rispetto ai rischi dei campi elettromagnetici.<br />
Altro vantaggio <strong>di</strong> un sistema elettrico basato sulla cogenerazione è la <strong>di</strong>minuzione della cessione<br />
<strong>di</strong> calore all’ambiente che nelle centrali convenzionali produce il problema dell’inquinamento<br />
termico dei corpi idrici.<br />
Vantaggi<br />
Lo spegnimento delle caldaie <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficio e <strong>di</strong> appartamento porta all’eliminazione <strong>di</strong> una fonte <strong>di</strong><br />
rischi per la pubblica sicurezza come esplosioni <strong>di</strong> incen<strong>di</strong>.<br />
Altri effetti positivi nell’introduzione <strong>di</strong> un sistema <strong>di</strong> Teleriscaldamento attengono alla<br />
razionalizzazione <strong>di</strong> un settore quale quello dei consumi termici degli e<strong>di</strong>fici contrad<strong>di</strong>stinto da<br />
basse efficienze nell’utilizzo dell’energia.<br />
Inoltre il teleriscaldamento non presenta solo vantaggi collettivi ma porta anche a convenienze per<br />
i singoli utenti: le tariffe del servizio calore sono posizionate per offrire all’utenza un risparmio<br />
economico rispetto alle soluzioni tra<strong>di</strong>zionali.<br />
Ad essere offerto è un servizio finale e non combustibile che necessita <strong>di</strong> una ulteriore<br />
trasformazione tramite caldaie; infatti il servizio calore permette <strong>di</strong>:<br />
• Pagare a contatore il servizio e non il combustibile<br />
• Regolare la durata del riscaldamento secondo le proprie esigenze<br />
•<br />
I vantaggi del risparmio energetico visti precedentemente a livello Paese si riflettono anche livello<br />
utente. La minore <strong>di</strong>pendenza energetica indotta da questi sistemi significa anche minore volatilità<br />
delle tariffe.<br />
Detto ciò, il <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Bastia</strong> <strong>Umbra</strong> rientra nella zona climatica denominata “D” così come<br />
definita dal D.P.R. 26 agosto 1993 N° 412. L’esercizio degli impianti termici per sistemi <strong>di</strong><br />
teleriscaldamento come è noto è consentito senza alcuna limitazione. Nella tabella sotto riportata<br />
sono in<strong>di</strong>cati i parametri climatici <strong>di</strong> riferimento <strong>di</strong> <strong>Bastia</strong> <strong>Umbra</strong>.<br />
Nella fattispecie il “Volume totale effettivamente teleriscaldabile” è risultato <strong>di</strong> circa 588.000 m3,<br />
la potenza termica necessaria è stata stimata in circa 10,0 MWt con un fabbisogno energetico pari<br />
a circa 14,7 GWht/a.<br />
In relazione ai fabbisogni energetici stimati, all’andamento dei gra<strong>di</strong> giorno mensili e alla potenza<br />
termica massima <strong>di</strong> centrale tipici per questi fabbisogni si è ipotizzato un andamento della<br />
richiesta termica da parte degli utenti nelle 3600 ore dell’anno.<br />
La curva <strong>di</strong> durata cosi calcolata rappresenta a meno <strong>di</strong> una costante, l'energia necessaria.<br />
Parametri climatici progettuali <strong>di</strong> riferimento<br />
CARATTERISTICA U.M. BASTIA UMBRA<br />
ZONA [tipo] D<br />
GRADI GIORNO [GG°] [GG°] 1.994<br />
ALTITUDINE [m.s.l.m.] [m.s.l.m.] 200<br />
TEMPERATURA DI PROGETTO [°C] ‐2<br />
ABITANTI (al 31.12.2009) [N°] 21.600<br />
10
Nella pagina <strong>di</strong> seguito allegata è riportato l’andamento della potenza termica caratteristica <strong>di</strong><br />
questa tipologia <strong>di</strong> utenza.<br />
La rete <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione<br />
La rete <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione del calore prevista è essenzialmente costituita da un feeder principale<br />
(doppio tubo con controllo istantaneo delle per<strong>di</strong>te) da cui si staccano le alimentazioni dei singoli<br />
utenti; il <strong>di</strong>mensionamento fluido<strong>di</strong>namico delle reti <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione è effettuato per le con<strong>di</strong>zioni<br />
<strong>di</strong> esercizio invernali, per assicurare alla rete una capacità <strong>di</strong> trasporto <strong>di</strong> calore tale da sod<strong>di</strong>sfare<br />
il massimo carico termico ad essa allacciabile.<br />
Di seguito si allegano le seguenti tavole grafiche:<br />
- Schematizzazione rete teleriscaldamento;<br />
- Sezione tipo <strong>di</strong> posa delle tubazioni – <strong>di</strong>mensione dello scavo e prescrizioni <strong>di</strong> posa.<br />
In questa prima fase <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o si è ipotizzato che le strade potenzialmente interessate dalla posa<br />
della rete primaria <strong>di</strong> teleriscaldamento abbiano una lunghezza totale <strong>di</strong> circa 8.000 m.<br />
Per le sottocentrali d’utenza è prevista l’adozione <strong>di</strong> sistemi <strong>di</strong> cessione del calore a scambio<br />
in<strong>di</strong>retto, ossia con scambiatori <strong>di</strong> calore fra il circuito primario (rete <strong>di</strong> teleriscaldamento) e il<br />
circuito secondario (rete interna <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione ai corpi scaldanti).<br />
Il sistema in<strong>di</strong>retto, grazie alla suddetta separazione idraulica dei due circuiti nello scambiatore,<br />
consente un esercizio più sicuro dell’impianto <strong>di</strong> teleriscaldamento, e non pone problemi <strong>di</strong><br />
pressione nella rete <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione, nei riguar<strong>di</strong> dei corpi scaldanti, che restano quelli<br />
attualmente installati.<br />
11
Le centrali <strong>di</strong> scambio energetico installate presso l’utenza prevedono uno scambiatore uso<br />
riscaldamento e, per le utenze con produzione centralizzata dell’acqua calda sanitaria, un secondo<br />
scambiatore per tale servizio.<br />
In questa prima fase <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o sono state ipotizzate circa 85 sottocentrali <strong>di</strong> cui 25 <strong>di</strong> me<strong>di</strong>a e alta<br />
potenza.<br />
La modulazione/integrazione ai cogeneratori per la produzione dell’energia termica necessaria è<br />
prevista con l’utilizzo <strong>di</strong> più caldaie.<br />
Questo consente sempre il loro utilizzo, in con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> massima resa energetica e <strong>di</strong><br />
contenimento dei costi, in base all’effettivo carico richiesto dall’utente.<br />
Nella fattispecie è possibile prevedere una produzione <strong>di</strong> energia termica ed elettrica globale<br />
rispettivamente <strong>di</strong> circa 17,8GWht/a e 12,6GWhe/a.<br />
12
Il risparmio energetico<br />
Il risparmio energetico comporta conseguentemente una minore quantità <strong>di</strong> emissioni a parità <strong>di</strong><br />
energia prodotta.<br />
Vi è in più la possibilità <strong>di</strong> riqualificazione ambientale in virtù della tipologia <strong>di</strong> impianto proposto.<br />
Al fine <strong>di</strong> far emergere il costante impegno nel rispetto dell’ambiente si propone l'adozione <strong>di</strong> una<br />
politica secondo la norma UNI EN ISO 14064.<br />
La politica ambientale è ottenibile con un lavoro <strong>di</strong> Analisi Ambientale Iniziale del contesto fisico,<br />
delle attività gestite o controllate all’interno e degli eventuali agenti inquinanti o impattanti<br />
derivati anche dalle possibili situazioni <strong>di</strong> emergenza che si possono verificare all’interno<br />
dell’intero territorio.<br />
13
Tutto questo per organizzare un Sistema <strong>di</strong> Gestione Ambientale efficiente ed efficace per tendere<br />
al miglioramento continuo delle prestazioni ambientali (influenze e ricadute sull’ambiente esterno<br />
globale).<br />
CONCLUSIONI<br />
Da quanto esposto emerge che l’iniziativa oltre a risultare interessante ed innovativa dal punto <strong>di</strong><br />
vista tecnologico offre anche una serie <strong>di</strong> vantaggi non trascurabili come <strong>di</strong> seguito sinteticamente<br />
descritti.<br />
Innanzitutto con il teleriscaldamento si ha un impatto ambientale ridotto, in relazione alle minori<br />
emissioni inquinanti ed ai consumi, rispetto alla produzione separata delle due energie.<br />
Ancora, il teleriscaldamento ha la possibilità <strong>di</strong> essere ampliato a costi marginali contenuti con<br />
vantaggi ambientali ed economici che ne conseguono.<br />
Promuovendo tale iniziativa inoltre si otterrebbe un risparmio energetico, come auspicato anche<br />
dal PEN e la possibilità <strong>di</strong> promuovere avviando un sistema tecnologico <strong>di</strong> servizi a sicura<br />
certificazione ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14064 e il regolamento CEE 1836/93<br />
(EMAS).<br />
Infine si avrebbero risultati positivi anche dal punto <strong>di</strong> vista occupazionale con assunzione <strong>di</strong><br />
nuovo personale e l’indotto che tale iniziativa genera, e ciò a sicuro vantaggio <strong>di</strong> un favorevole<br />
accoglimento della stessa da parte della popolazione limitrofa.<br />
14


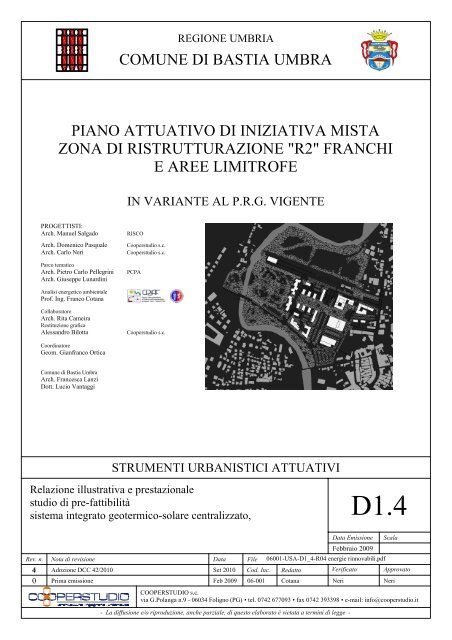
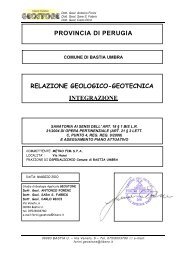

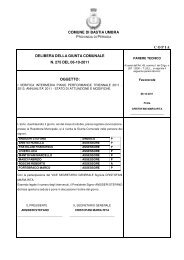
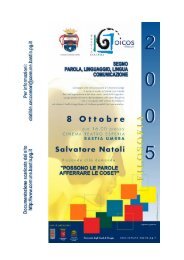
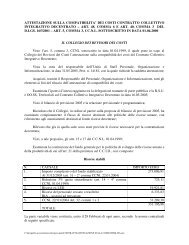
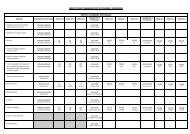
![[T] - Regolamento di Polizia Mortuaria - Comune di Bastia Umbra](https://img.yumpu.com/16054993/1/190x245/t-regolamento-di-polizia-mortuaria-comune-di-bastia-umbra.jpg?quality=85)



![NTA Aree C0 - [D]ettaglio - Comune di Bastia Umbra](https://img.yumpu.com/15419369/1/190x245/nta-aree-c0-dettaglio-comune-di-bastia-umbra.jpg?quality=85)


