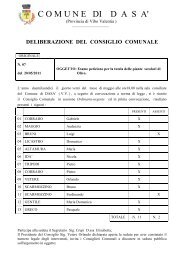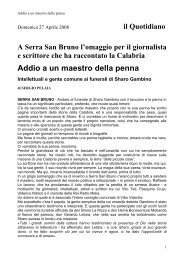i liberali pasquale calcaterra ed i suoi fratelli
i liberali pasquale calcaterra ed i suoi fratelli
i liberali pasquale calcaterra ed i suoi fratelli
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Testo integrale dell'intervento del prof. Francesco Romanò al convegno: "Alle origini del Risorgimento:<br />
Pasquale Calcaterra di Dasà".<br />
Biblioteca comunale Dasà, 27 febbraio 2011<br />
I LIBERALI PASQUALE CALCATERRA ED I SUOI FRATELLI<br />
Nella seconda metà del 1700 i Calcaterra erano la famiglia più potente e ricca di Dasà. Ad<br />
attestare tutto ciò senza ombra di dubbio è il Catasto Onciario (custodito all’Archivio di<br />
Stato di Napoli), che per Dasà porta la data del 1782. Sono ben 13 le pagine che elencano<br />
tutti i beni, soprattutto agrari, poss<strong>ed</strong>uti, oltre agli animali con varie mandrie. Nella prima<br />
pagina, interessantissimo, è lo stato della famiglia riferito naturalmente al 1782 o 1781 :<br />
“Don Domenico Calcaterra d’anni 53, Donna Felice... moglie d’anni 63, Don Vincenzo<br />
Calcaterra, figlio casato d’anni 32, M.a (magnifica) Anna Cavallaro, moglie d’anni 32; figli<br />
di Don Vincenzo: don Pasquale d’anni 10, don Nicola d’anni 7, don Domenico d’anni 4,<br />
donna Felice d’anni 2.”<br />
Donde era venuta tutta questa vasta possessione di proprietà agricole?<br />
Come era da immaginarsi la ricchezza dei Calcaterra era nata all’ombra del feudo di Arena.<br />
Dall’esame che ho fatto io di alcuni documenti dell’Archivio Caracciolo di Arena<br />
(custodito adesso dal Comune di Arena) risulta che Vincenzo Calcaterra era Erario e<br />
Cassiere Generale del marchese Caracciolo di Arena negli anni tra la fine del 1700 e gli<br />
inizi del 1800.<br />
Il terremoto del 1783 e l’istituzione della Cassa Sacra per la vendita delle terre<br />
ecclesiastiche segnarono un ulteriore balzo economico in avanti per i Calcaterra <strong>ed</strong> altre<br />
famiglie “borghesi” della zona. Qui il fondamentale studio del Placanica[1] ci illumina<br />
esaurientemente; infatti per quanto riguarda gli anni ottanta (1780) così scrive: “Si pensi al<br />
distretto di Arena, dove i fondi venduti furono stavolta moltissimi, 78, ma tutti abbastanza<br />
piccoli e in m<strong>ed</strong>ia inferiori a due tomolate di superficie ciascuno: ivi don Ferdinando<br />
d’Antona comprò 6 fondi di tom. 1 6 e mezzo per 461 ducati, la famiglia Calcaterra 6 fondi<br />
di tom. 30,75 per duc. 1.324,20, i massari Nicola e Vincenzo Galati 17 fondi di tom. 17 e<br />
meno per duc. 691,75 e, sempre in concorrenza tra di loro, ma una volta acquistando<br />
addirittura in società, i massari Bruno Galati e Domenico Calcaterra acquistarono un fondo<br />
ancor più pregiato; accanto ai Galati, ai d’Antona, ai Calcaterra, altre famiglie proseguirono<br />
negli acquisti (come i De Nardo, gli Englen, i Filardo, i Corrado), talora cercando di<br />
contrastare il passo ai principali compratori”. Ancora nello stesso libro, nell’elenco delle<br />
famiglie benestanti dello stato di Arena (di cui al certificato del 1799) c’erano: “famiglia<br />
Calcaterra (magnifico Domenico): Domenico, tom. 5,75, duc. 430,00; Vincenzo, tom.<br />
29,50, duc. 1.518,00;”[2] Più avanti Placanica, parlando delle vendite del decennio francese<br />
(1806- 1815), così si esprime: “Nella Calabria Ultra, alcune famiglie di compratori furono<br />
quelle stesse dei tempi della Cassa Sacra ( tanto per citare le più importanti, i Bisogni, i<br />
Calcaterra, i Carnovale, i Fazzari, i Gagliardi, i Lombardi, i Marzano, i Sarlo), ma molte<br />
altre furono del tutto nuove nell’acquistare beni ecclesiastici sequestrati…[3]<br />
E’ evidente che la potenza economica di queste famiglie baronali le porta anche ad<br />
impossessarsi del Comune <strong>ed</strong> esse vogliono il controllo dell’amministrazione pubblica.<br />
All’Archivio di Stato di Napoli nelle carte del Processo di Cassa Sacra. Inventario Blasco”<br />
vi si trovano: 1788: Arena: Istanza di D. Vincenzo Calcaterra, sindaco generale delle<br />
Università dello Stato di Arena per pagamento di spese fatte; 1789: Dasà: Istanza di D.<br />
Vincenzo Calcaterra, sindaco <strong>ed</strong> esattore per la revisione dei <strong>suoi</strong> conti del 1787 e 1788.<br />
Ora, riguardo il comportamento sociale dei Calcaterra e di questa nuova “borghesia” agraria<br />
1
calabrese, io non voglio ripetere le valutazioni da me fatte nello studio “ Il 1799 in Calabria<br />
<strong>ed</strong> i contadini”: da esso trarrò solo qualcosa per questo saggio; d’altronde sull’argomento<br />
sono esaustivi il libro testé citato di Placanica <strong>ed</strong> il classico studio del Cingari.[4]<br />
Quest’ultimo scrive: “Ma, benché avanzati sul terreno culturale, tanto i nobili che i borghesi<br />
erano estranei ai problemi dei ceti contadineschi, i quali, perciò, nutrivano verso i<br />
galantuomini avversione o, meglio, odio”[5] . Ancora Cingari ci dice che il fine principale<br />
di questa “borghesia” agraria, sorta dalla crisi della proprietà feudale era di riuscire a vivere<br />
more nobilium, magari acquistando un feudo con il relativo titolo”.[6] Il feudo no, ma il<br />
titolo nobiliare i Calcaterra si prodigarono ad acquisirlo veramente, diventando ad un certo<br />
punto baroni. Sia ben chiaro a tutti, l’ho già detto tante volte, allora i contadini vivevano<br />
nella miseria e nello squallore più neri e sul loro sfruttamento si erano create le fortune dei<br />
vari ceti dominanti tra cui pure i Calcaterra. Ora, con tutta questa fortuna e ricchezza,<br />
l’aspirazione di don Vincenzo Calcaterra era quella di fare il salto di qualità, ossia fare<br />
studiare i figli, eccetto quello o quelli che servivano alla conduzione della grande azienda<br />
familiare, e le donne. Una premessa: nelle famose “Biografie degli uomini illustri delle<br />
Calabrie” di Luigi Accattatis, pubblicate a Cosenza tra il 1869 e il 1877, ci sono le vite di<br />
Pasquale e Nicola Calcaterra di Dasà scritte da un Pasquale Calcaterra fu Francesco. Chi era<br />
costui?, si tratta di un dotto Calcaterra di Polistena, là dove un ramo dei Calcaterra di Dasà<br />
si era trasferito per via di matrimonio Infatti è lo stesso Pasquale Calcaterra che scrisse una<br />
“Monografia di Polistena”, pubblicata nel 1931 e citata nel libro di Lobstein. Questa<br />
“Monografia” è stata ristampata a dicembre 2006 <strong>ed</strong> io l’ho acquistata. Da essa ho appreso<br />
che questo Pasquale Calcaterra era nato a Polistena nel 1838 <strong>ed</strong> ivi è morto nel 1934. Era<br />
sacerdote e avvocato. Ancora è a Polistena che nel 1923 vengono pubblicate le “Memorie<br />
Istoriche Militari” del colonnello Antonino Calcaterra e si precisa nel risvolto del libro che<br />
la proprietà letteraria è della famiglia Calcaterra di Polistena. Le biografie quindi dei due<br />
Calcaterra dell’Accattatis sono scritte da un parente discendente della casa; tuttavia debbo<br />
dire che tante notizie sono oneste e precise (ne ho fatto i riscontri), anche se il tono è quasi<br />
sempre apologetico e al positivo. Questo biografo però ebbe il vantaggio di utilizzare i<br />
ricordi di prima mano della famiglia. Ad esse rimando per informazioni particolari su<br />
Pasquale e Nicola Calcaterra.<br />
A conferma di quanto da me scritto, proprio quando avevo concluso la prima stesura di<br />
questo mio saggio, sono comparse due brevi paginette, con mia soddisfazione, sulla rivista<br />
trimestrale “Calabria Letteraria” del numero Aprile-Maggio-Giugno 2003 scritte da<br />
Vincenzo Marvasi, nelle quali parla molto succintamente delle vite dei principali Calcaterra;<br />
il titolo dell’articolo mi sembra significativo: “Una famiglia di patrioti, i Calcaterra”. Il<br />
bello è che finisce così: “A conclusione di queste brevi note, mi sia concesso ringraziare<br />
sentitamente l’avv. Vincenzo Calcaterra di Polistena, per la squisita cortesia e disponibilità<br />
con la quale mi ha fornito preziose notizie sui <strong>suoi</strong> illustri maggiori.”. I <strong>suoi</strong> maggiori,<br />
guarda caso, erano tutti di Dasà.<br />
Comunque, tornando a noi, don Vincenzo Calcaterra manda a 18 anni il figlio Pasquale a<br />
studiare legge all’università di Napoli, dove, secondo il De Cristo, la madre aveva lo zio che<br />
era «illustre canonista della R. Università di Napoli». Ma intanto, quando nasce Pasquale?<br />
Nell’Accattatis si parla del 1770 a Dasà; invece Aliquò-Taverriti[7] e G. Valente[8] danno<br />
la data del 1773. Tuttavia il Valente nel suo ultimo, importante Dizionario in sei volumi<br />
(v<strong>ed</strong>i la citazione esatta nella biografia di Nicola Calcaterra) ci dà per la data di nascita di<br />
Pasquale Calcaterra, seguendo in ciò l’Accattatis, il 1770. Io penso che la data giusta sia il<br />
1770. Infatti nel Catasto Onciario, che porta la data per lo “stato” di Arena del 1782,<br />
2
(ammettendo che Dasà sia stato censito nel 1781 o che ancora il ragazzo non avesse<br />
compiuto gli anni), si dice che Pasquale avesse 10 anni, e più o meno ci siamo; ancora nel<br />
Registro dei morti del Comune di Dasà per l’anno 1830, in cui è certificata la morte di<br />
Pasquale Calcaterra, si scrive che è morto all’età di anni 60. Quindi per me è chiaro che egli<br />
sia nato nel 1770. E’ superfluo precisare che nel 1700 ancora non esistevano gli atti<br />
comunali di nascita, di morte ecc... istituiti dai governi napoleonici: per Dasà il primo<br />
registro è del 1809. Dai registri parrocchiali si potrebbe avere una ulteriore prova sulla vera<br />
data di nascita.<br />
La formazione di Pasquale Calcaterra avviene all’università di Napoli, che a quei tempi era,<br />
insieme a Milano, la capitale dell’Illuminismo italiano. La scuola giuridica napoletana<br />
raccoglieva il fior fiore dei riformatori e degli homines novi, a partire da Gaetano Filangieri,<br />
Mario Pagano, fino al calabrese Giuseppe Poerio, nato nel 1775 e più giovane di cinque<br />
anni del Nostro. E’ chiaro che questo clima e temperie di idee non poteva lasciare<br />
indifferente il giovane Pasquale, anzi ne segnò il destino. Io ritengo che Pasquale<br />
Calcaterra sia la figura più nobile, la personalità più forte e coerente, di una dirittura morale<br />
esemplare, che l’intera generazione dei Calcaterra abbia mai espresso. Il fatto di essere stato<br />
il primo, fu di esempio e modello per tutti i futuri discendenti. Verso il 1792-93 Pasquale si<br />
laurea e diventa un brillante avvocato: si affermerà gradatamente come uno dei più famosi<br />
giuristi del Regno di Napoli. Forse negli ultimi anni di università conobbe per la prima volta<br />
Giuseppe Poerio, che diverrà ancor più famoso e impegnato di lui. Veniamo ora alle date<br />
cruciali della sua biografia. Anzitutto l’entusiasmo e la trag<strong>ed</strong>ia del 1799. Sulla rivoluzione<br />
napoletana del 1799 esiste una vasta bibliografia; per la Calabria resta fondamentale il<br />
classico libro da me citato di Gaetano Cingari. Sull’argomento anch’io ho condotto ricerche<br />
approfondite per anni. Né io voglio ripetere ciò che ho scritto nel saggio “Il 1799 in<br />
Calabria <strong>ed</strong> i contadini”; da esso inserirò solo la seguente parte, rielaborata naturalmente.<br />
Scarsissime sono le fonti documentarie su ciò che è avvenuto in quel torbido e glorioso<br />
1799 in alcuni minuscoli borghi dell’interno di Monteleone (oggi Vibo Valentia). Quel che<br />
non si può dire è che essi siano rimasti estranei a quanto succ<strong>ed</strong>eva nel Regno e che tutto era<br />
fermo. Ci sono stati anche qui i movimenti, le lotte, le atrocità, certo in forme del tutto<br />
particolari. Ecco quanto sostiene Cingari: ”A questo episodio (scontri tra giacobini e<br />
sanf<strong>ed</strong>isti a S. Giovannello di Mileto) ne seguirono altri, specie ad opera delle popolazioni<br />
di Acquaro, Arena, Dasà, Soriano, Gerocarne, guidate dai parroci e da alcuni galantuomini,<br />
che (citaz. da A.<br />
Calcaterra: Memorie istoriche militari... p. 22)”.[9] La citazione del Cingari tuttavia merita<br />
una precisazione e cioè che il Calcaterra fa il suo discorso in generale parlando di <br />
e non lo riferisce in particolare ai paesi summenzionati, anche se io cr<strong>ed</strong>o che quanto detto<br />
può benissimo adattarsi pure ad essi. Ma più interessanti per il nostro discorso sono altri<br />
passi dell’opera del Calcaterra: “Tutt’i paesi erano sulle armi, in attesa del Cardinale; e il<br />
colore politico era pretesto a mutuo sfogo di privati rancori, <strong>ed</strong> i borbonici, massa caotica,<br />
anelava pr<strong>ed</strong>e e bottino. Un giorno, molti bravacci di Acquaro menavano tra funi il<br />
Canonico Pardea e il Sig. Cuccumarino ricco proprietario di Serrata, che diceano arrestati<br />
per ordine del Cardinale. Passando per Dasà assaltano la casa del venerando m<strong>ed</strong>ico<br />
Palmieri. Due nipoti di costui, uomini di armi, in quel momento si trovavano in casa<br />
Calcaterra. Affiancati da tre <strong>fratelli</strong> Calcaterra e dai servi di casa, accorrono in momento che<br />
il vecchio m<strong>ed</strong>ico veniva trascinato nelle prigioni di Arena. Si viene alle armi. Sopravviene<br />
da Soriano il barone Sabbatini, con seguito di armati; e quei di Acquaro sopraffatti, con<br />
qualche morto lasciarono in loro mani il vecchio m<strong>ed</strong>ico. Il Pardea e il Cuccumarino erano<br />
3
stati consegnati al Capitano delle milizie di Arena come giacobini e lasciarono la vita nelle<br />
prigioni di Nicotera. Questo è un episodio dei tanti che si ripetevano atroci per l’anarchia<br />
apportata dallo arrivo del Cardinale. La forza vinceva il diritto”.[10] Il seguente passo è<br />
ancora più significativo:” Quella massa si chiamò Truppa della Santa F<strong>ed</strong>e; ma era l’orda<br />
più trista di paesi e villaggi, anelante, senza alcuno scrupolo, pr<strong>ed</strong>a e saccheggio. Non<br />
restava nei paesi e nei villaggi tranquillo alcun proprietario. I preti dal Confessionale<br />
scompigliavano le coscienze; spesso <strong>fratelli</strong> contro <strong>fratelli</strong>, i figli contro il padre. Frequenti<br />
le denunzie anonime, frequenti gli assassini dei <strong>liberali</strong>. I graduati militari della famosa<br />
Truppa, tornando in paese, si atteggiavano a tiranni con libidine di vendetta e di<br />
arricchimento. Non mancava qualche tirannetto tra loro, come il Sig. C... incaricato di<br />
custodire nel convento di Soriano i cosi detti ostaggi Catanzaresi e Cotronesi; il quale<br />
attorniato da uomini feroci avea m<strong>ed</strong>itato l’esterminio di qualche famiglia. Il giorno di<br />
Carnevale una compagnia di austriaci e greco-albanesi, fucilieri camiciotti, comandati dal<br />
capitano Gregorio Trentacapilli da Pizzo, proc<strong>ed</strong>evano a parecchi arresti, e gli arrestati<br />
ristretti nel carcere di Casalnuovo dettero luogo alla compilazione di venti volumi di<br />
processo nella Certosa di Serra. L’avvocato Pasquale Calcaterra per parare la tempesta<br />
incombente sul suo capo e su quello dei <strong>suoi</strong>, corse a Napoli e dal primo ministro, Principe<br />
di Ascoli, ottenne ordine di arresto del nemico. Incaricato il Trentacapilli di eseguire tale<br />
arresto e tradurre l’arrestato in Napoli, s’imbarcano a Pizzo; ma sorta una tempesta fecero<br />
scalo a Palinuro. Ivi surse briga fra la gente del Trentacapilli e quegli abitanti. Si fecero<br />
fucilate. Trentacapilli ferito, i <strong>suoi</strong> sopraffatti e sbaragliati. L’arrestato fuggi e tornò in<br />
famiglia, ov’era stimolato di raccogliere i soliti <strong>suoi</strong> armigeri <strong>ed</strong> incrudelire contro le<br />
famiglie avversarie, e spegnere i testimoni che avevano deposto contro di lui nel processo<br />
compilato da Mugnos nella Certosa di Serra S. Bruno.”[11] Questi episodi sono squarci di<br />
luce su quello che è avvenuto nei nostri paesi in quel lontano 1799, anche se alcune notizie<br />
del Calcaterra vanno prese con le molle. I contadini, per le miserissime condizioni in cui<br />
vivevano, furono pure loro realisti e non fu difficile convincerli . Il marchese Caracciolo,<br />
signore del feudo, anche se viveva a Napoli, attraverso i <strong>suoi</strong> agenti non mancò di schierarsi<br />
contro i giacobini. Quello che avvenne in questi villaggi in sostanza, al di là delle eccezioni,<br />
fu qualcosa di più meschino e feroce: con la scusa della rivoluzione si scatenò una guerra tra<br />
i notabili della zona per il controllo del potere locale e per dare via libera alle vendette<br />
reciproche alimentate da vecchi rancori; ne accenna chiaramente A. Calcaterra nel brano da<br />
me citato: altro che giacobinismo e antigiacobinismo! Ne scrive anche con vivida<br />
rappresentazione L. Blanch: “Gli odi tra le famiglie nei comuni, che sorgevano dalle vive<br />
passioni inerenti alla natura dei popoli meridionali, e la monotona esistenza che è in quelle<br />
circoscritte riunioni, ricevettero una più energica impulsione dai politici avvenimenti, che ne<br />
ingrandirono le proporzioni, e produssero effetti terribili, che ricordano le descrizioni di<br />
Tucidide nelle civili discordie della guerra del Peloponneso, come le fazioni delle città<br />
italiane al M<strong>ed</strong>ioevo. Per questa causa, più che per opinioni positive, molti furono implicati<br />
in provincia nelle inquisizioni del ‘99, e al contrario in piccoli numeri quelle che<br />
prec<strong>ed</strong>ettero quest’epoca; ciò che comprova il nostro asserto, che furono più gli avvenimenti<br />
che le teorie, che compromisero questa classe (la borghesia), parteggiando per il nuovo<br />
ordine di cose”. [12]<br />
Quale fu l’atteggiamento dei Calcaterra durante il passaggio del cardinale Ruffo ce lo dice<br />
nella sua prefazione al più volte citato libro delle “Memorie di A. Calcaterra il prof.<br />
Vincenzo De Cristo: ”La famiglia Calcaterra, aveva aderito al novello partito della<br />
Repubblica allora sorgente; e per ciò, quando il cardinale Ruffo coi <strong>suoi</strong> agenti <strong>ed</strong> emissari<br />
4
aveva al suo passaggio i nomi delle persone qualificate per giacobini, tra le prime vide<br />
designata quella del Calcaterra. Lo auditore del Cardinale che conosceva il sig. Vincenzo<br />
Calcaterra, aveva a questi proposto per potersi salvare, di farsi presentare al cardinale<br />
dall’amico signor Conti, comandante della ferriera di Mongiana, insieme coi figli maggiori<br />
Pasquale, Nicola e Domenico, <strong>ed</strong> insieme con questi seguire il prelato nella riconquista del<br />
Regno. Non piacque al Calcaterra la proposta; ma seppe scusarsi <strong>ed</strong> abilmente fiancheggiare<br />
la posizione; <strong>ed</strong> ottenuta tolleranza <strong>ed</strong> indulgenza per la sua elevata posizione sociale, pensò<br />
di mandare i figli Pasquale e Nicola a studiare a Napoli sotto la protezione degli zii<br />
Cavallari, chiudere il tr<strong>ed</strong>icenne Antonino nel seminario di Mileto, <strong>ed</strong> egli, insieme<br />
coll’altro figlio Domenico rimanere ad attendere alla cultura dei <strong>suoi</strong> poderi <strong>ed</strong><br />
all’avanzamento della famiglia”. Ora da queste puntuali citazioni io mi son fatto un quadro<br />
pressoché veritiero, almeno dal mio punto di vista, di quel che è potuto succ<strong>ed</strong>ere,<br />
naturalmente sottoponendo le succitate fonti ad alcuni rilievi critici.Il colonnello Calcaterra<br />
parla di un di Dasà. Nel Catasto Onciario di Dasà, che però<br />
risale a prima del 1782, non ci sono Palmieri benestanti, ma solo ciabattini. Allora la notizia<br />
del m<strong>ed</strong>ico Palmieri dovrebbe essere falsa, <strong>ed</strong> invece cr<strong>ed</strong>o che sia vera. Si potrebbe pensare<br />
che nel Catasto Onciario di Dasà manchi qualche pagina, ma suppongo che la verità sia<br />
questa: donna Italia Palmieri ha detto a me personalmente che la sua famiglia è venuta a<br />
Dasà da fuori; probabilmente il periodo in cui sono arrivati potrebbe essere quello tra il<br />
1782 e il 1799, magari pensando che a Dasà più proficuamente si poteva esercitare la<br />
posizione di m<strong>ed</strong>ico. D’altronde lei stessa onestamente mi asseriva che i <strong>suoi</strong> antenati in<br />
origine erano “cirari” (lavoratori della cera). Nella seconda citazione del Calcaterra compare<br />
il nostro avvocato Pasquale Calcaterra (non dice che era suo fratello!). Attenzione però ai<br />
tempi. Si parla del giorno di Carnevale del 1799: il cardinale Ruffo era sbarcato in Calabria<br />
il 7 febbraio <strong>ed</strong> a fine marzo aveva già occupato le principali città calabresi. Allora<br />
l’avvocato in questa prima fase riesce a parare il colpo, correndo a Napoli, dove ancora era<br />
in vita la repubblica, fa arrestare il nemico di famiglia, questo “tirannetto” che chiama “ il<br />
sig. C… ; peccato che non dica il nome intero e non sappiamo chi e di quale paese fosse.<br />
Interessante è il fatto che dice che si imbarcano a Pizzo per andare a Napoli: era per la via di<br />
mare che si andava a Napoli e per quattro anni o più il nostro Pasquale l’aveva percorsa per<br />
laurearsi in legge. Comunque le “Memorie” del colonnello Calcaterra ritengo che siano<br />
oneste e veritiere, tuttavia egli ci dà la sua verità e spesso è reticente e non dice tutto. Inoltre<br />
quando parla del principe di Ascoli, al quale si sarebbe rivolto suo fratello Pasquale per<br />
salvare la sua famiglia dal tirannetto, è male informato: il principe di Ascoli era un ministro<br />
f<strong>ed</strong>ele ai Borboni (v<strong>ed</strong>i Colletta e G. Candeloro) e a carnevale del 1799 c’era già la<br />
repubblica a Napoli; e quindi Pasquale poteva pure conoscere l’Ascoli, ma si è dovuto<br />
rivolgere a qualche altro ministro della repubblica e non già all’Ascoli, che era certamente<br />
fuggito in Sicilia con il re.Dal passo del De Cristo si capisce chiaramente che la posizione<br />
della famiglia Calcaterra nel 1799 fu molto ambigua: la maturazione politica avvenne dopo<br />
e, come disse il Blanch, sulla base degli avvenimenti e non delle idee; l’avvenimento tragico<br />
per i Calcaterra fu l’arresto di Pasquale. Io cr<strong>ed</strong>o che il padre non si umiliò a correre dietro il<br />
cardinale probabilmente per l’intervento fermo del figlio Pasquale. Il De Cristo di svarioni<br />
ne scrive tanti: a parte che non parla del successivo arresto di Pasquale, afferma che egli fu<br />
mandato a Napoli a studiare dopo il 1799; è certo invece che all’epoca lui era già avvocato<br />
Pasquale Calcaterra nel 1799 fu l’innovatore della famiglia e rappresentò l’anello di svolta<br />
della sua storia successiva. Ciò avvenne anche suo malgrado perché la storia lo travolse<br />
(tutti vorremmo vivere con una relativa tranquillità senza cercare guai): la rivoluzione<br />
5
francese e l’epopea di Napoleone sconquassarono la vita dell’Europa e anche degli individui<br />
come il nostro Pasquale. Ma la sua famiglia nel 1799 ebbe atteggiamenti incoerenti (per loro<br />
veniva prima il portafoglio e poi le idee): essi sono i tipici rappresentanti di quel<br />
gattopardismo, non solo meridionale, che tanta storia ha avuto nelle vicende lontane e vicine<br />
d’Italia. D’altronde i Calcaterra sfruttavano i contadini nei loro latifondi con contratti agrari<br />
pesantissimi e quando qualche loro esponente si mise a capo del movimento riformatore, ciò<br />
fu visto con diffidenza anzi con odio dai contadini; e si badi bene la diffidenza e l’odio<br />
erano reciproci (il riformismo dei Calcaterra e di tanta parte della borghesia del Sud non<br />
prev<strong>ed</strong>eva nessun alleviamento imm<strong>ed</strong>iato della condizione di vita della massa contadina).<br />
Pertanto questa frattura sociale tra ceto rurale e borghesia meridionale nel 1700 sta alla base<br />
del fallimento della rivoluzione napoletana del 1799. Ma qual è il clima che porta alla<br />
prigionia di Pasquale? Da alcuni anni nel Regno di Napoli era rottura completa tra gli<br />
intellettuali e la corona: gli avvenimenti francesi fecero precipitare tutto. Quando<br />
nell’ottobre 1793 venne ghigliottinata Maria Antonietta, regina di Francia, l’avversione che<br />
Maria Carolina, regina di Napoli e sorella di Maria Antonietta, nutriva per i <strong>liberali</strong> si<br />
tramutò in odio. Quando poi addirittura nel gennaio 1799 la rivoluzione arrivò a Napoli<br />
sulle punte delle fucilerie francesi e dopo alcuni mesi di governo, a giugno crollò,<br />
soprattutto lei e l’ammiraglio Nelson scatenarono il Terrore, in senso contrario, verso i<br />
patrioti. Fu un vero e proprio massacro, dopo il quale infuriò in tutte le province del Regno<br />
la caccia alle streghe, il dalli, dalli al liberale. Alla fine il “ripurgo” voluto dalla regina<br />
Carolina fu completo, ma l’impressione e la riprovazione per tali eccessi fu enorme in tutta<br />
Europa. Qualche citazione a conferma di tutto ciò. Anzitutto il Cingari: “Il 1799 nel<br />
Mezzogiorno è l’anno della grande anarchia, della feroce guerra tra giacobini e sanf<strong>ed</strong>isti,<br />
tra patrioti e briganti. Nessun altro periodo posteriore, nemmeno il 1848, l’anno classico<br />
della rivoluzione, o il primo decennio unitario, quando esplose il grande brigantaggio,<br />
richiama, come il ‘99, una così spietata lacerazione del tessuto sociale, uno scontro tanto<br />
violento di idee, di passioni, di costumi, d’interessi”[13] Poi mi piace citare Ippolito Nievo:<br />
“Sorse una nuova Repubblica Partenopea; insigne per una singolare onestà, fortezza e<br />
sapienza dei capi, compassionevole per l’anarchia, per le passioni spietate e perverse che la<br />
dilaniarono, sventurata e mirabile per la tragica fine…. Non era quella una guerra tra<br />
uomini, ma uno sbranarsi tra fiere.”[14] Infine c’è un Compendio di Anonimo sul 1799<br />
scritto da un esule napoletano in Francia e rimasto per molti anni non pubblicato e sepolto<br />
nella Biblioteque Nationale de France a Parigi, che racconta che nei giorni della riconquista<br />
a Napoli i lazzaroni si abbandonarono nelle strade a scene di cannibalismo. Prima di<br />
continuare a parlare di Pasquale Calcaterra, è opportuno sottolineare una questione<br />
fondamentale per gli studiosi del 1799: i fondi archivistici riguardanti la rivoluzione<br />
napoletana sono estremamente carenti, Il punto a riguardo, quasi in maniera completa, lo fa<br />
il Cingari nella sua famosa opera. Per ciò che concerne il più importante, cioè l’Archivio di<br />
Stato di Napoli, così scrive: “ Distrutti nei primi anni dell’ ‘800 i preziosi processi istruiti<br />
dai Borboni contro i giacobini e distrutti altresì nel 1943, in conseguenza di un incendio, i<br />
cosiddetti “Notamenti dei rei di Stato”, cioè gli estratti dei processi istruiti nelle province<br />
dai “Visitatori politici”, mancano agli studiosi le fonti dirette più cospicue. Sì che non<br />
rimane che l’analisi dei documenti segnalati dal Moscati (storico), e cioè:<br />
1) Gli atti dei “Visitatori Economici”, che furono inviati nelle province per riordinarle<br />
economicamente e la cui azione si protrasse fino al 1804.<br />
2) Gli atti dell’ “Amministrazione dei rei di Stato”, che proc<strong>ed</strong>ette alla confisca e ai<br />
sequestri dei beni dei giacobini”.[15] C’è da precisare, a quanto scrive Nino Cortese nel suo<br />
6
commento al Saggio del Cuoco del 1926 a pag. 424, che gli atti dei processi furono distrutti<br />
dagli stessi Borboni; infatti dice: “ La reazione borbonica, dopo essersi servita dell’archivio<br />
della repubblica per istruire i processi contro i rei di Stato, bruciò e questi e quello”.In<br />
sostanza a Napoli fu istituita una Giunta di Stato (famigerata e terribile) per punire i<br />
repubblicani della capitale; ad essa furono associati i Visitatori per colpire quelli delle<br />
province.<br />
La persecuzione scatenata dai Visitatori nelle province fu ancora più feroce di quella di<br />
Napoli. Insomma sono andati distrutti gli atti dei processi sia della capitale che delle<br />
province. Importanti documenti si trovano pure nell’Archivio di Stato di Palermo, che io<br />
non ho consultato direttamente, ma attraverso l’opera di A.. Sansone. Il Cingari continua<br />
dicendo che gli atti dei “Visitatori economici” offrono ben poche indicazioni per lo studioso<br />
delle vicende calabresi; gli atti dell’ “Amministrazione dei beni dei rei di Stato” sono andati<br />
in parte distrutti nel citato incendio durante la seconda guerra mondiale: offrono però buone<br />
informazioni sulla Calabria <strong>ed</strong> io li ho consultati in parte. Il Cingari poi ci informa che: “ ci<br />
è stato possibile analizzare una copia importante, sebbene imperfetta, del prezioso<br />
relativo alle due Calabrie: si tratta di una copia trascritta nel<br />
1939 dall’originale che si conservava nell’archivio di Napoli e che abbiamo potuto ottenere<br />
per la <strong>liberali</strong>tà del dr. Filippo de Nobili di Catanzaro, cui va tutta la nostra riconoscenza”;<br />
aggiunge poi in nota che “ questo notamento è purtroppo lacunoso; non completo per la<br />
provincia di Calabria Ultra, è assai incompleto per la provincia di Calabria Citra”[16] Io non<br />
ho avuto il piacere di v<strong>ed</strong>ere almeno questa copia, che probabilmente sarà tra le carte del<br />
defunto storico Cingari o fra quelle del de Nobili. E non è che io sono stato fermo: mi sono<br />
recato ben due volte alla Biblioteca Comunale di Catanzaro, intitolata al de Nobili e dove<br />
sono custoditi tutti i <strong>suoi</strong> scritti e le sue carte, ma niente da fare: del famoso Notamento non<br />
c’è traccia. Ho telefonato ad una er<strong>ed</strong>e di Catanzaro di don Pippo de Nobili e mi ha detto<br />
che lei non ha niente e che tutte le sue carte si trovano alla Biblioteca Comunale. Ho poi<br />
telefonato alla v<strong>ed</strong>ova dello storico Gaetano Cingari e mi ha detto che suo marito è stato<br />
ospitato da de Nobili, ma ha preso solo degli appunti dal Notamento, cioè una specie di<br />
elenco dei patrioti della rivoluzione napoletana del 1799; l’originale però è rimasto al de<br />
Nobili. Comunque siano andate le cose, questo prezioso “Notamento” non si trova <strong>ed</strong> io mi<br />
auguro che o la copia del de Nobili o quella del Cingari vengano tirate fuori e pubblicate<br />
perchè questo documento è molto importante per gli studiosi. Ultima annotazione a<br />
riguardo: negli Atti del 2° Congresso Storico Calabrese tenuto nel 1960 e d<strong>ed</strong>icato alla<br />
Calabria nel Risorgimento, nel Catalogo della mostra documentaria allestita all’Archivio di<br />
Stato di Catanzaro c’era un pannello dove era scritto sotto: collezione De Nobili; in esso era<br />
esposto un documento con un’amnistia del 23 aprile 1800 concessa dal re Ferdinando IV per<br />
i reati di cospirazione commessi durante la Repubblica Partenopea. Vi sono indicati, divisi<br />
per provincia, i nomi dei principali cospiratori. All’epoca era ancora vivente il de Nobili e<br />
può darsi che si tratti dello stesso “Notamento” di cui stiamo discorrendo e che lui ha fornito<br />
in occasione del Congresso sul Risorgimento. Fatto è che questo documento oggi non si<br />
trova più e sembra si sia volatilizzato. In questo clima orribile di caccia alle streghe si arriva<br />
all’arresto, al processo e alla prigione per Pasquale Calcaterra. A parte la notizia di Aliquò-<br />
Taverriti che parla di esilio di Pasquale nel 1799 e che cr<strong>ed</strong>o si tratti di una delle tante<br />
imprecisioni che si trovano in questa opera, pur meritoria, ecco cosa si scrive nella più<br />
importante biografia dell’Accattatis a proposito di Pasquale Calcaterra: “ Nell’anno di<br />
sommo slancio liberale che fu il 1799, spirò dall’estrema Calabria l’aura del rinnovamento e<br />
cooperò colla sua parola potente a fare attecchire le nuove idee, alle quali veramente questi<br />
7
luoghi non presentavano terreno ben preparato. Con pochi altri eletti nel nuovo cammino<br />
portando una vita intemerata, sventavano il pregiudizio che facea de’ seguaci della<br />
rivoluzione altrettanti serpenti a sonaglio. Ciò gli valse, al ritorno del Borbone, l’esser tra’<br />
primi designato al sepolcro de’ vivi di Maretimo, donde ritrasse il germe della malattia che<br />
in seguito lo privò dell’udito. Al 1801 firmata la pace o meglio tregua concessa da<br />
Napoleone ai Borboni, aprendosegli la prigione, corse a rassicurare i <strong>suoi</strong>, e di lì a Napoli<br />
per sfuggire in quel centro popoloso le novelle persecuzioni, conducendo seco il fratello<br />
Nicola ventenne, che più tardi tanta potenza d’ingegno appalesava”.[17] L’altra importante<br />
testimonianza sulla prigionia di Pasquale è quella di Vittorio Visalli, che scrisse la sua<br />
pregevole opera qualche anno dopo di quella dell’Accattatis: “ A questi triarii della santa<br />
causa bisogna aggiungere Pasquale Salerno di Castrovillari, Antonio Verardi superstite di<br />
Vigliena, e tanti altri che gl’inviati della Giunta, col nome di Visitatori, andavano uccidendo<br />
per le province. Il sapiente giureconsulto Girolamo Arcovito di Reggio, capitano nella<br />
legione calabra, fu dannato a morte, e dovette alle preghiere e al denaro di suo fratello<br />
Antonio l’esser chiuso nella fortezza d’Ischia. E tra i condannati a Favignana ricorderemo il<br />
barone Giuseppe Poerio di Belcastro, Domenico Vanni di Rende, Gaetano Rodinò di<br />
Catanzaro, il magistrato Pasquale Calcaterra di Dasà, il marchese Domenico Grimaldi di<br />
Seminara (padre dell’eroico Francesco), il quale fu lasciato nelle carceri di Messina perchè<br />
malato di gotta. Guglielmo Pepe, giovinetto di s<strong>ed</strong>ici anni, che aveva combattuto al ponte<br />
della Maddalena, andò esule in Francia, intanto che Florestano, suo maggior fratello, colpito<br />
di palla al petto nell’assalto di Andria, languiva dentro la rocca di Barletta.”[18] Poco più<br />
sotto anche Visalli ci dà il clima orribile della persecuzione: “ Migliaia di persone, strappate<br />
al seno delle famiglie, gemevano in fondo alle squallide caverne di quei castelli borbonici<br />
ch’erano tanto inetti a proteggere il popolo contro gli stranieri quanto potenti ad opprimerlo;<br />
o erravano per selvatici luoghi, spiando l’occasione di affidarsi al mare in cerca di men<br />
desolati paesi. E tutti volgevano gli occhi verso la Francia”(pag. 48).Nella Introduzione si<br />
afferma: “ il Visalli, che da certosino indagatore visitò i paesi delle vittime, raccogliendo le<br />
testimonianze dei parenti e dei testimoni oculari superstiti, rovistò negli archivi privati e di<br />
Stato prendendo nota di istruttorie, sentenze, circolari, disposizioni d’autorità, senza<br />
omettere alcun particolare”. E’ probabile quindi che sia venuto pure a Dasà. Pertanto se noi<br />
non volessimo cr<strong>ed</strong>ere a ciò che scrive il biografo parente del Calcaterra nell’Accattatis, ci<br />
viene a conferma l’autorevole testimonianza del Visalli; nè è pensabile supporre che<br />
quest’ultimo abbia copiato dall’Accattatis perché tra l’altro questi dice che fu imprigionato a<br />
Marettimo, mentre Visalli parla di Favignana. Ora su quale sia stato il vero luogo di<br />
detenzione di Pasquale, in mancanza di altri documenti, è difficile stabilire.Io sarei portato a<br />
dare cr<strong>ed</strong>ito a Marettimo perché il parente discendente del Calcaterra era molto più<br />
informato del Visalli sul luogo di prigionia; d’altronde nelle varie notizie biografiche su<br />
Giuseppe Poerio, detenuto a Favignana, non viene mai fuori il nome del Calcaterra. Oppure<br />
può darsi che la sorte di Pasquale Calcaterra sia stata simile a quella di Guglielmo Pepe<br />
(v<strong>ed</strong>i Appendice), ossia che abbia passato il primo periodo della sua prigionia a Marettimo e<br />
il secondo a Favignana ( dove si viveva un po’ meglio). Comunque, a parte questo<br />
particolare importante, io cr<strong>ed</strong>o che Pasquale fu rinchiuso nelle carceri isolane; ma a quanti<br />
anni era stato condannato non si sa. Marettimo e Favignana sono le isole principali<br />
dell’arcipelago delle Egadi, appartenenti alla provincia di Trapani in Sicilia. C’erano a quei<br />
tempi alcune delle più orride prigioni dei Borbone. L’Accattatis parla di “sepolcro dè vivi”,<br />
dove appunto per l’umidità <strong>ed</strong> il fr<strong>ed</strong>do Pasquale prese la malattia che poi lo privò<br />
dell’udito. Per Favignana (Marettimo era ancora peggio) si dice della prigione come di “<br />
8
fosso scavato nel macigno, in cui si scendeva per una scala di centoventitre gradini”;[19] <strong>ed</strong><br />
il Croce scrive per Favignana: “ era questa una grotta, alla quale si scendeva dal castello per<br />
una lunga scala tagliata nel sasso, con fioca luce, priva di ogni raggio di sole, fr<strong>ed</strong>da e<br />
umidissima”.[20] Non dissimili furono le condizioni di prigionia del Calcaterra. Ecco una<br />
descrizione moderna di Marettimo: nel reportage per la rivista “Meridiani” Sicilia-Isole, del<br />
giugno 2000, Virman Cusenza scrive di Marettimo, che tra l’altro chiama “La montagna<br />
incantata”: “ . E’ Marettimo, la più lontana delle Egadi. I Greci la chiamarono<br />
così (), perchè appare ai naviganti come una possente, inaccessibile catt<strong>ed</strong>rale di<br />
granito. Per i <strong>suoi</strong> fondali da sogno, le sue scogliere selvagge e le sue grotte è una delle isole<br />
più belle del M<strong>ed</strong>iterraneo”. E più avanti aggiunge però:” Più giù, a strapiombo su Punta<br />
Troia, troneggia un forte borbonico che per decenni ospitò i sospiri di parecchi prigionieri<br />
politici. Gli unici che alla non hanno mai cr<strong>ed</strong>uto”. Su “il Giornale<br />
dell’8 agosto 2002, Giordano Bruno Guerri scrive a proposito di Marettimo:” Popoli duri<br />
che, come si usava prima degli aliscafi e degli elicotteri, v<strong>ed</strong>evano nelle isole appunto<br />
luoghi di isolamento, perfetti come avamposti e prigionie crudeli. Una delle più crudeli<br />
ch’io sappia ili quella che i Borboni, molli e feroci, inflissero a Guglielmo Pepe. C’è, sulla<br />
punta estrema dell’isola, un castello fatato e inespugnabile, dotato di una cisterna dell’acqua<br />
in caso d’ass<strong>ed</strong>io. Svuotata la cisterna, l’antro divenne la più tremenda delle prigioni, dove<br />
Pepe venne rinchiuso per anni, al buio, finché venne estratto verde e con la pelle attaccata<br />
alle ossa”. Orribile e bella questa descrizione della prigione-fortezza di Marettimo.<br />
Tornando a Pasquale Calcaterra, a parte le autorevolissime testimonianze citate, io sono<br />
andato in questi ultimi anni inutilmente alla ricerca di qualche documento di archivio che<br />
attestasse al 100% la sua prigionia: finora non ho trovato nulla. Il suo nome non compare nè<br />
nell’elenco dei condannati pubblicato nell’opera del Battaglini, nè in quella del<br />
Sansone.Quella di Mario Battaglini è un’ampia trattazione, fondamentale per la storia dei<br />
sei mesi di vita della repubblica di Napoli: M. Battaglini: Atti, leggi, proclami <strong>ed</strong> altre carte<br />
della repubblica napoletana (1798-1799), Soc. Ed. Meridionale, Salerno-Catanzaro, 1983,<br />
due volumi. In occasione del secondo centenario della rivoluzione napoletana del 1799 il<br />
Battaglini ha allestito una nuova <strong>ed</strong>izione della sua opera in collaborazione con Augusto<br />
Placanica. E’ un’<strong>ed</strong>izione riv<strong>ed</strong>uta, corretta e integrata, molto più corposa della prima: sono<br />
quattro volumi, pubblicata tra novembre 2000 e luglio 2001 da Di Mauro Editore, Cava de’<br />
Tirreni ( SA ).Quindi va precisato che il Battaglini ci fornisce tutta o quasi<br />
la documentazione esistente sulla vita della repubblica; la carenza di fonti archivistiche di<br />
cui si lamenta il Cingari pertanto riguarda il dopo: cioè dalla caduta della repubblica in poi.<br />
Tuttavia, per ciò che ci riguarda, il nome di Pasquale Calcaterra non compare nemmeno in<br />
questa nuova <strong>ed</strong>izione, perché poi documenti nuovi concernenti le condanne dei patrioti non<br />
ce ne sono. C’è tuttavia da precisare che la maggior parte della documentazione fornita dal<br />
Battaglini è tratta dal libro di A.. Sansone.[21] A sua volta il Sansone ha svolto un lavoro<br />
egregio, tratto dalle carte dell’Archivio di Stato di Palermo dove, si badi, si era trasferito il<br />
governo regio nel periodo della repubblica giacobina). Egli pubblica il “Registro dei<br />
condannati a pene diverse dai visitatori destinati nelle province del Regno di Napoli”; esso<br />
però riguarda il solo anno 1800, partendo da marzo, mi pare. Quindi se, come è probabile,<br />
Calcaterra è stato condannato prima non può risultare in questo elenco. Va tenuto comunque<br />
sempre presente che la documentazione principale, quella dell’Archivio di Stato di Napoli,<br />
come si è detto, è andata per lo più distrutta. Il Visitatore politico, che si occupava della<br />
Calabria e della Basilicata era il Marchese della Valva, il quale, risi<strong>ed</strong>endo prevalentemente<br />
in Basilicata, lasciò le varie trattazioni della Calabria ai Presidi di Catanzaro e Cosenza. Il<br />
9
Preside di Catanzaro era Antonio Winspeare, lo stesso che sp<strong>ed</strong>ì nel marzo 1801 il prezioso<br />
rapporto distrutto nel 1943 a causa dei bombardamenti della guerra su Napoli, ma copiato in<br />
parte nel 1939 da Filippo de Nobili. Ora, caduta la repubblica, tutte le protezioni per la<br />
famiglia Calcaterra crollano e si scatena anche per loro l’inferno. La famiglia di quel tale<br />
signorotto C... , che qualche mese prima era stato colpito dal nostro avvocato, si prese la sua<br />
vendetta. Probabilmente, insieme a costui, altri nemici si mossero con le denunce, le<br />
testimonianze finché non riuscirono ad incastrare Pasquale, leader e guida della famiglia<br />
Calcaterra. Secondo me Calcaterra fu processato e condannato dal Preside di Catanzaro o a<br />
limite, se è vero quello che scrive Antonino Calcaterra nelle “Memorie”, può darsi che si sia<br />
costituita una sottosezione di tribunale nella certosa di Serra S. Bruno, dove il nostro<br />
Pasquale può essere stato processato. Io penso che a settembre o ad ottobre 1799 (o al<br />
massimo prima di marzo del 1800) fu imbarcato con altri condannati verso le isole Egadi.<br />
Può darsi che si sia incontrato ancora una volta con Giuseppe Poerio; ma questi fu rinchiuso<br />
a Favignana e Pasquale invece a Marettimo. All’Archivio di Stato di Napoli ho consultato<br />
alcune buste della “ Amministrazione generale dei beni dei Rei di Stato” ; non è venuto<br />
fuori il nome di Pasquale Calcaterra di Dasà (mi auguro di essere più fortunato appresso<br />
);nella busta n.221contenente copia della Relazione della Suprema Giunta di Stato di<br />
Catanzaro,Calabria Ultra II, con vari ricorsi, dell’agosto 1800, si trova una denuncia che fa<br />
il sacerdote D. Michele Catania di Dinami con quel Governatore; non dice però il motivo<br />
della denuncia: forse per interc<strong>ed</strong>ere per qualche condannato?<br />
Tuttavia una cosa l’ho constatata con certezza: nella Mappa dei Rei di Stato, contro dei<br />
quali trovasi ordinata la confiscazione dei Beni dalla Suprema Giunta di Stato e dal Regio<br />
Visitatore Generale per la provincia di Catanzaro, ossia Calabria Ultra, non si trovano<br />
sequestrati beni della famiglia Calcaterra di Dasà. La famiglia era riuscita a limitare i danni<br />
al solo arresto di Pasquale. Ho trovato pure, sempre all’archivio di Napoli, un interessante<br />
elenco del Notamento delle Decisioni dei Rei di Stato condannati a decapitazione, forca,<br />
asportazione, esilio, concordia (sic, forse patteggiamento?)… <strong>ed</strong> altri escarcerati dalli 17<br />
agosto fino a 2 novembre 1799: non c’è però Pasquale Calcaterra. Questo elenco è scritto in<br />
maniera disordinata <strong>ed</strong> è confusionario: può darsi che il nome di Calcaterra sia sfuggito,<br />
oppure egli è stato condannato dopo il 2 novembre, oppure, meglio, se Calcaterra fu<br />
processato in Calabria, come par certo, non poteva esserci in questo elenco. Comunque da<br />
queste carte risulta una cosa: è impressionante e penoso il numero dei ricorsi: da quelle<br />
pagine rossicce, consumate dal tempo, promana prepotente il clima di terrore e di paura a<br />
cui fu sottoposto il Regno da parte dei Borboni alla caccia dei giacobini ,e le suppliche<br />
penose dei parenti per chi<strong>ed</strong>ere intercessione per i familiari condannati, i tentativi di<br />
corruzione con esborso di denaro per sconti di pena, la pesantezza delle delazioni ecc... Ho<br />
consultato inoltre dei documenti importanti sul 1799 (il Cingari non ha consultato questo<br />
fondo ), che si trovano a Napoli nell’Archivio Storico del Banco di Napoli, in via dei<br />
Tribunali, vicino al vecchio Palazzo di Giustizia. C’è ad es. una “Nota dei rei di stato<br />
obbligati a partire condannati a sequestri, confisca <strong>ed</strong> altro”. In questo lungo elenco in<br />
ordine alfabetico non ci sono i Calcaterra di Dasà. Ma se il nostro Pasquale è stato<br />
condannato in Calabria non poteva esserci in questo elenco. Più strano è che non parli della<br />
detenzione del fratello Pasquale, Antonino Calcaterra nelle sue “Memorie”. Intanto in<br />
questo suo libro di amnesie volute o meno Antonino ne ha parecchie. Comunque, a parte<br />
ciò, queste “Memorie” sono molto utili per una moltitudine di notizie altrimenti perdute: si<br />
noti bene che quando Antonino parla di sè stesso e dei <strong>fratelli</strong> lo fa sempre in terza persona.<br />
10
Ricordiamoci che egli scrive nel pieno periodo della Restaurazione borbonica e con tutti i<br />
problemi che la sua famiglia stava passando e doveva passare per colpa di quel regime,<br />
ritenne che non era il caso di cercarsi nuovi guai nel caso che le sue “Memorie” fossero<br />
finite nelle mani della polizia, facendo capire che alcuni membri della sua casa erano dei<br />
<strong>liberali</strong> e oppositori dei Borboni; d’altronde, a leggere bene il suo libro, le idee <strong>liberali</strong><br />
appaiono evidenti. Se è cosi, io ritengo, che egli volesse che quelle “ Memorie” rimanessero<br />
rigorosamente manoscritte; <strong>ed</strong> infatti furono pubblicate quasi un secolo dopo nel 1923. E’<br />
probabile pure che l’autore ritenesse disonorevole o dannoso rivelare che il fratello era stato<br />
in carcere per motivi politici o può darsi anche che queste “Memorie” Antonino le abbia<br />
scritte vivente ancora il fratello Pasquale, il quale forse era già stato colpito dalla grave<br />
malattia che lo porterà alla morte. Pertanto, per rispetto a Pasquale, non ha ritenuto di<br />
parlare della sua prigionia a Marettimo, oppure può averglielo chiesto lo stesso Pasquale di<br />
non ricordare quella tristissima esperienza della sua vita. Come sia andata la cosa è un<br />
mistero. Infine, a conferma della mattanza scatenata dai sanf<strong>ed</strong>isti già a partire dalla marcia<br />
trionfante che l’orda funesta intraprese lungo la Calabria, voglio riportare due lapidi che ho<br />
visto e fotografato io stesso: una si trova a Corigliano e l’altra a Nicotera ( chissà quanti altri<br />
episodi del genere sono successi in Calabria e non sono ricordati da nessuna lapide!).Quella<br />
di Corigliano è posta all’ingresso (sopra) del castello e recita così: “ Nel bicentenario della<br />
Repubblica Partenopea a perenne ricordo di Pietro Malena e Paolo Marrazzo qui fucilati il<br />
20 aprile 1799 martiri per amore di libertà e uguaglianza, a cura del Rotary Club Corigliano<br />
Rossano Sybaris, 8 maggio 1999”. La lapide di Nicotera ricorda l’eccidio del giovane<br />
avvocato Andrea Coppola e di Filippo Lùpari ad opera della furia popolare sanf<strong>ed</strong>ista. Il<br />
marmo di Nicotera è firmato pure dal Rotary Club. Entrambi gli episodi sono ben descritti<br />
nel classico libro del Cingari (Giacobini e Sanf<strong>ed</strong>isti…). Ma la storia proc<strong>ed</strong>eva rapida: si<br />
assiste alla fine del 1800 ad una ripresa della guerra in Italia tra Napoleone e l’Austria; a<br />
fianco di quest’ultima si schierò il re di Napoli, che però fu sconfitto dai francesi. Fu quindi<br />
firmata nel marzo 1801 una pace tra la Francia e il Regno di Napoli, tra le cui clausole<br />
c’erano pure la liberazione dei prigionieri politici e il riaccogliere gli esuli. Verso giugno di<br />
quell’anno Pasquale Calcaterra fu quindi liberato, dopo essersi fatto più o meno una ventina<br />
di mesi di prigione. Assieme a lui uscirono pure Giuseppe Poerio, valentissimo avvocato, e<br />
gli altri detenuti politici. Il Nostro venne a Dasà e, dopo essersi goduto per un breve periodo<br />
l’affetto della famiglia, si trasferì subito a Napoli, dove portò a studiare all’università il<br />
fratello Nicola. Egli voleva uscire dal clima pesante e meschino dei piccoli paesi e respirare<br />
l’aria della città. A Napoli Pasquale esercitò con successo la professione forense, legandosi<br />
sempre più di amicizia con Giuseppe Poerio, che seguì pure nella valentìa<br />
professionale,divenendo suo allievo. Nel 1806 iniziò il decennio di governo napoleonico nel<br />
Regno di Napoli <strong>ed</strong> il re Giuseppe Bonaparte chiamò a governare i vari distretti del Regno<br />
le personalità più illuminate e <strong>liberali</strong>, vicine ai <strong>suoi</strong> impegni riformatori. Pertanto il<br />
Calcaterra nel 1806, e non nel 1805 come vuole il biografo dell’Accattatis, perchè è<br />
impensabile che i Borboni dessero un tale incarico ad un liberale, fu nominato governatore a<br />
Castropignano (Campobasso) “ove più infieriva il malandrinaggio”.[22] Dopo più di un<br />
anno di governatorato, intorno al 1807, rientrò a Napoli per riprendere la carriera del Foro.<br />
Ed è in un famoso processo nel quale, contro ogni previsione, fece assolvere l’imputato, che<br />
egli si conquistò la fama di “ avvocato principe” (Accattatis) del Foro di Napoli. In buona<br />
sostanza un figlio del cav. Tortora, dopo aver esercitato la sua brutalità di p<strong>ed</strong>erasta sopra<br />
un giovanetto, per cancellare ogni testimonianza, lo fa uccidere, incolpando del delitto un<br />
suo domestico. Per il Tortora c’erano i più bei nomi degli avvocati di Napoli, tra cui il<br />
11
Lauria; il domestico fu difeso dal Calcaterra. Egli riuscì con la sua grande capacità oratoria<br />
e forza di persuasione, corroborata dalle prove, a far assolvere il domestico <strong>ed</strong> a condannare<br />
il Tortora. Si v<strong>ed</strong>a, per maggiori dettagli, la biografia dell’Accattatis. Il 1815 è l’anno della<br />
caduta definitiva di Napoleone, sconfitto a Waterloo; con lui si conclude anche il governo di<br />
Gioacchino Murat, cognato di Napoleone, e re di Napoli (sarà fucilato, come è noto, a Pizzo<br />
Calabro). Torna il governo borbonico e tra i <strong>liberali</strong>, alcuni vengono arrestati, altri sono<br />
costretti all’esilio. il Calcaterra prende la via dell’esilio a Firenze, “dove esercitò con fortuna<br />
la professione di avvocato”.[23] Però Aliquò sbaglia perchè attribuisce questo esilio<br />
all’anno 1820, mentre si tratta del 1815. Comunque, dopo due anni, nel 1817 Pasquale<br />
rientra dall’esilio e viene a vivere a Dasà. E’ in questi mesi di serenità familiare e di pace<br />
interiore che scrisse la sua opera giuridica “Riflessioni sul criterio morale “- Parte Prima -<br />
Analisi delle pruove; stampata a Messina nel 1819. Una copia di questo libro si trova nella<br />
Biblioteca Comunale “Filippo De Nobili”di Catanzaro. In questo volume io ho trovato un<br />
foglio manoscritto, di cui mi son fatto la fotocopia: mi ha emozionato pensare sia stato<br />
scritto dallo stesso Pasquale Calcaterra, ma non ne sono sicuro. Di sicuro si tratta di un<br />
elenco di libri ( forse con relativo prezzo o pag. ), tra cui è sottolineato Beccaria. Ancora di<br />
sicuro Pasquale aveva scritto nel corso di quegli anni la seconda parte del suo trattato, “ma i<br />
disastri di sua vita gli imp<strong>ed</strong>irono di pubblicarla”(Accattatis). Purtroppo questo manoscritto<br />
è andato disperso. L’argomento di questo libro a stampa è tutto giuridico: basta scorrere<br />
l’indice delle materie contenute. Una sintesi ce la da il biografo dell’Accattatis, anch’egli<br />
avvocato. Quel che mi preme di evidenziare è che l’intonazione dell’opera dall’inizio alla<br />
fine è ispirata a quel filone giuridico riformatore, tipico dell’illuminismo napoletano: v<strong>ed</strong>i<br />
ad es. l’ampia citazione di Mario Pagano.Nella breve nota biografica di Vincenzo Marvasi<br />
su “ Calabria Letteraria”, da me citata, a proposito di questo libro si scrive: “….. in cui<br />
auspicava la riforma della proc<strong>ed</strong>ura penale al fine di ” ( parole sue). Alla Biblioteca Nazionale di Napoli viene citato<br />
uno scritto di Pasquale Calcaterra dal titolo: “Il Regno delle Due Sicilie nel M<strong>ed</strong>io Evo”,<br />
che non è facile trovare; forse si trova in un’opera collettanea sul Regno delle Due Sicilie<br />
che c’è. L’ha scritta il nostro Pasquale Calcaterra o si tratta di un altro? Dopo alcuni mesi il<br />
tribunale di Reggio Calabria gli affidò la difesa dei briganti, i <strong>fratelli</strong> Monteleone, detti dal<br />
popolo Ronca. Ecco come si esprime l’Aliquò su questi ultimi anni di attività forense del<br />
Nostro: “Ritornato in Calabria nei Tribunali di Reggio e di Catanzaro fu primo per<br />
eloquenza e per capacità. Celebri le arringhe in difesa dei famosi briganti Bruno e Giuseppe<br />
Monteleone Ronca. Nel 1823 fu strenuo patrono di Francesco Monaco, Luigi, Pasquale e<br />
Giacinto Jessi, già <strong>suoi</strong> compagni di f<strong>ed</strong>e politica”. I famosi moti carbonari di Napoli del<br />
1820 mobilitarono le anime più generose del Regno verso quella riforma della Costituzione<br />
in senso moderno che si sperava poter finalmente attuare. Insieme al Muratori, al Romeo.<br />
Calcaterra di<strong>ed</strong>e il suo contributo di idee alla formazione della Costituzione, come attestano<br />
l’Accattatis e l’Aliquò-Taverriti. Più esposti di lui erano in questa fase rivoluzionaria gli<br />
amici calabresi: il generale Guglielmo Pepe e l’insigne avvocato Giuseppe Poerio. Ma ben<br />
presto gli entusiasmi di rinnovamento furono di nuovo delusi: la reazione austriacoborbonica<br />
stroncò tutto nel 1821 e l’illustre patriota vibonese Michele Morelli, che aveva<br />
capeggiato il moto, finì sulle forche di Napoli nel settembre 1822. in quella famigerata<br />
piazza Mercato, che aveva visti uccisi dai Borboni i principali eroi del 1799. Anche<br />
Calcaterra pagò per il suo impegno, ma questa volta in misura meno pesante: “Le peripezie<br />
di quella rivoluzione si chiusero pel Calcaterra con una composizione la più equa a sperarsi<br />
dalla polizia, di ritirarsi, cioè, dalla vita pubblica” (Accattatis). Ed egli si piegò inizialmente<br />
12
a questa condizione. Ma nel 1823 ebbe l’incarico di istruire a Catanzaro il processo contro<br />
l’uccisione di un Marincola, famiglia forte del luogo. In tale occasione “ebbe caro”<br />
(Accattatis ) fare parte del collegio di difesa dei tre patrioti catanzaresi condannati a morte.<br />
Ossia, trovandosi a Catanzaro per il processo Marincola, accettò di buon grado la difesa<br />
anche dei tre patrioti. A tale proposito tante sono le testimonianze. Ne cito tre autorevoli.<br />
Una è tratta dal pregevole volume collettaneo su Catanzaro.[24] Il saggio è quello di<br />
Antonio Carvello, che così scrive: “ E questi aneliti di libertà, queste idee nuove, che<br />
serpeggiavano anche a Catanzaro, mandavano sulla forca, il 24 marzo lun<strong>ed</strong>ì santo del 1823.<br />
due giovani catanzaresi di circa vent’anni. Luigi Pascali e Giacinto De Jessi, <strong>ed</strong> un altro<br />
giovane di Dipignano, Francesco Monaco, implicati nel moto del 1821. Fu vana, durante il<br />
processo, la battaglia che in loro difesa combatté il famoso avvocato Pasquale Calcaterra di<br />
Dasà, studioso di diritto e di etica e autore delle Riflessioni sul criterio morale”. L’autore<br />
cita come una delle sue fonti le Memorie di Guglielmo Pepe. Io ho consultato questa opera,<br />
ma non ho potuto riscontrare la notizia, forse perchè non ho letto da cima a fondo i due<br />
volumi <strong>ed</strong> inoltre, essendo delle vecchie <strong>ed</strong>izioni, non esiste un indice dei nomi. Sarebbe<br />
opportuna una <strong>ed</strong>izione critica delle Memorie del Pepe. L’altra attestazione è quella di<br />
Cesare Sinopoli nell’opera sulla Calabria scritta da tre autori, uno dei quali è il nostro<br />
compaesano di Arena, il generale Salvatore Pagano. Dice Sinopoli ad un certo punto:<br />
“Difendevano gli imputati l’avv. Nicola Marini- Serra, gigante del Foro Calabrese, l’avv.<br />
Pasquale Calcaterra, l’avv. Gaspare Arcuri. cognato di De lesse, insigne avvocato e maestro<br />
di Diritto Penale. L’avv. Giuseppe Manfr<strong>ed</strong>i, r<strong>ed</strong>uce della Grande Armata.....”.[25] La terza<br />
testimonianza è quella del Visalli: “Ed il 24 marzo 1823, lun<strong>ed</strong>ì santo, l’atterrita Catanzaro<br />
vide morire decapitato Francesco Monaco, vide morire su le forche Luigi Pascali e Giacinto<br />
Jessi, difesi invano dalla maschia eloquenza di Pasquale Calcaterra”.[26] Il biografo<br />
dell’Accattatis dice che, dopo tale difesa dei patrioti catanzaresi, risorse l’ira della polizia<br />
borbonica contro il Calcaterra. Ed allora io mi immagino come Pasquale e tutta la sua<br />
famiglia abbiano speso tutta la loro capacità <strong>ed</strong> influenza per dimostrare che egli non era<br />
venuto meno al suo impegno di ritirarsi dalla vita pubblica, ma aveva assolto, pressato, la<br />
sua professione di avvocato. Qualche amico si era mobilitato in suo favore, forse quel tale<br />
cardinale De Gregorio, a cui accenna l’Accattatis, ma non ne sono sicuro. Se<br />
l’interessamento ci fu, il cardinale poi come compenso lo chiamò a Roma e dopo a Palermo<br />
a difendergli delle sue cause, in tal caso, gratis; ma può darsi che il cardinale non si sia<br />
interessato al suo caso e lui gli difese le sue cause dietro compenso; ma è più probabile la<br />
prima ipotesi, stando all’Accattatis. Considerate i trapazzi fisici e psichici di questi viaggi e<br />
di questi processi, a cui dovette sottoporsi. Certo è che Calcaterra evitò guai grossi questa<br />
volta, ma ciò fu un ulteriore, duro colpo per la sua persona Infatti l’Accattatis ci informa che<br />
al Calcaterra “ nel 57° anno di sua vita si ecclissa la intelligenza, la memoria non gli<br />
soccorre, la sua giocondità tramutasi in malinconia”.[27] Io ne ho d<strong>ed</strong>otto che Calcaterra fu<br />
colpito dal morbo di Alzheimer. I dizionari m<strong>ed</strong>ici dicono che tale morbo prende dopo i 60<br />
anni, ma ci sono forme precoci e tale è il caso del nostro Pasquale. Fatto è che nel giro di tre<br />
anni egli “divenne un tronco” e morì. Sulla data di morte tutte le fonti sono concordi, a parte<br />
il giorno. Io mi limito a citare l’atto di morte conservato nel Comune di Dasà: “ nel giorno 7<br />
del mese di febbraio, anno mille ottocento trenta, alle ore 16 è morto nella casa del Padre<br />
Don Pasquale Calcaterra di anni 60, nato in Dasà, di professione Dr. di legge…. figlio di<br />
Don Vincenzo…. e di Donna Marianna Cavallaro….”. Era sindaco Saverio Corrado. Vi<br />
lascio immaginare le circostanze in cui si è svolto quel funerale, che avrebbe meritato ben<br />
altra solennità e partecipazione, visto il personaggio, ma che cr<strong>ed</strong>o fu celebrato piuttosto in<br />
13
sordina, dato il clima di piena Restaurazione in cui si viveva <strong>ed</strong> i rischi che un’esposizione<br />
troppo evidente delle sue vicende avrebbe comportato per la sua famiglia e per i presenti.<br />
Questa è solo una mia ipotesi, ma può darsi pure che il funerale fu celebrato in pompa<br />
magna. Fu seppellito “ nell’avello di sua famiglia”, ossia nello spazio ( non c’erano delle<br />
cappelle) riservato alle famiglie “nobili” della chiesa matrice di S. Nicola di Dasà. I<br />
cadaveri dei poveracci erano ammucchiati nella cripta comune sotto il pavimento della<br />
stessa chiesa. Purtroppo oggi non esistono tracce nè di queste tombe nè dell’architettura<br />
della chiesa, perchè con una sciagurata decisione del vescovo essa fu completamente<br />
demolita e ricostruita durante il periodo fascista, facendone il casermone che c’è adesso.<br />
Un’ultima postilla: come se la passava Pasquale Calcaterra a donne? Dall’atto di morte<br />
sembrerebbe che egli non fosse sposato, perciò si dice che è morto nella casa del padre. I<br />
biografi non parlano di donne particolari nella sua vita, ma cr<strong>ed</strong>o che non sia rimasto a<br />
digiuno, visto poi il personaggio.<br />
[1] A. Placanica: Alle origini dell’egemonia borghese in Calabria, Soc. Ed. Meridionale, 1979, Salerno-Catanzaro. ( La<br />
privatizzazione delle terre ecclesiastiche, 1784-1815 ).<br />
[2] A. Placanica: idem, pag. 125 .<br />
[3] A. Placanica: idem pp. 381-382.<br />
[4] G. Cingari: Giacobini e sanf<strong>ed</strong>isti in Calabria nel 1799, Casa del Libro Ed., R.C., 1978, reprint ( la prima <strong>ed</strong>izione è<br />
del 1957 ).<br />
[5] G. Cingari: idem, pag. 160.<br />
[6] G. Cingari: idem, pp. 19-20.<br />
[7] Aliquò-Taverriti: Gli Scrittori Calabresi, quattro volumi, R.C., 1955-58.<br />
[8] G. Valente: Dizionario dei luoghi della Calabria, due volumi, Frama Sud, Chiaravalle Centrale (CZ), 1973.<br />
[9] G. Cingari: op. cit., pag. 184.<br />
[10] A. Calcaterra: Memorie istoriche militari dal 1799 al 1822, Polistena, 1923, pp. 29-30.<br />
[11] A. Calcaterra: idem, pp. 31-33.<br />
[12] L. Blanch: in “ Scritti storici” ( brano preso da R. Villari: Il Sud nella storia d’Italia, Laterza, Bari, <strong>ed</strong>iz. 1978, pp.<br />
46-47).<br />
[13] G. Cingari: Brigantaggio – Proprietari e contadini nel Sud (1799-1900), Editori Meridionali Riuniti, R.C., 1977,<br />
pag. 37.<br />
[14] Ippolito Nievo: Confessioni di un italiano, capitolo XVII , Garzanti Edit.<br />
[15] G. Cingari: Giacobini…., cit. , pp. 8-9-10 .<br />
[16] G. Cingari: Giacobini…., cit.,( v<strong>ed</strong>i la citazione prec<strong>ed</strong>ente).<br />
[17] “Biografie degli Uomini illustri delle Calabrie” a cura di L. Accattatis, Cosenza, 1869-1877 ( Le biografie di<br />
Pasquale e Nicola Calcaterra sono state scritte dal loro discendente Pasquale Calcaterra fu Francesco, avvocato e<br />
sacerdote di Polistena).<br />
[18] V. Visalli: I Calabresi nel Risorgimento Italiano(1799-1862), Ed. Brenner, Cosenza, 1989;pp.47-48 ( Prima<br />
<strong>ed</strong>izione, Torino, 1893 ). Volume Primo.<br />
[19] Vita di Giuseppe Poerio, scritta dal figliuolo Carlo, in Commemorazione di giureconsulti napoletani, Na, 1882,pag.<br />
99.<br />
[20] B. Croce: Una famiglia di patrioti, Bari, Laterza, 1949, pag. 17.<br />
[21] Alfonso Sansone: Gli Avvenimenti del 1799, Palermo, 1901.<br />
[22] Accattatis: Biografie….. cit., vol. IV, pag. 27.<br />
[23] Aliquò-Taverriti: Scrittori…… cit.<br />
[24] Catanzaro ( Storia- Cultura- Economia ), Rubbettino Ed., Soveria Mannelli (CZ), 1994, pp. 157-158.<br />
[25] C. Sino poli- S. Pagano-A. Frangipane: La Calabria ( Storia-Geografia-Arte), Rubbettino Ed., 2004, pag. 167. La<br />
prima <strong>ed</strong>izione è stata presso Mauro, CZ, 1925.<br />
[26] V. Visalli: I Calabresi nel Risorgimento…. Cit., vol. Primo, pag. 279.<br />
[27] Accattatis: Biografie….. cit., vol. IV, pag. 31.<br />
Fonte e Copyright: www.associazionecultural<strong>ed</strong>asaese.it<br />
14