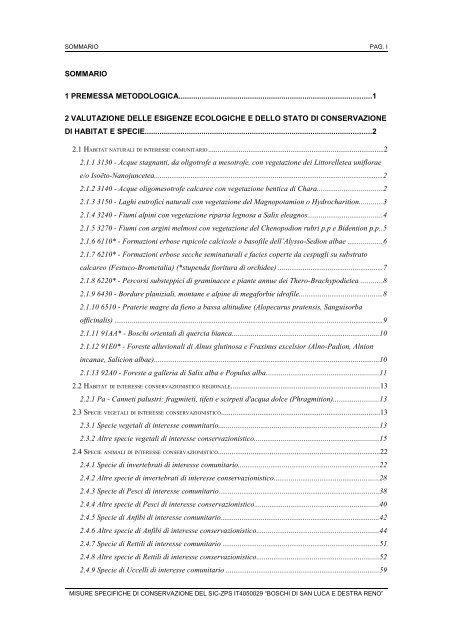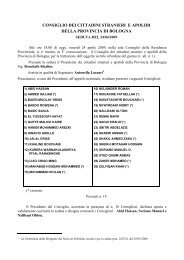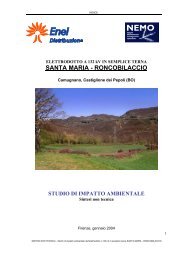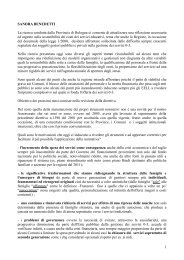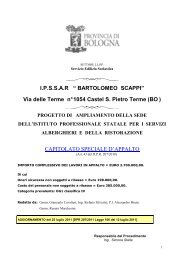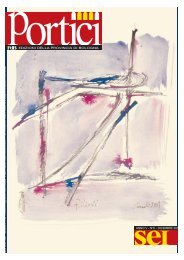MSC_San_Luca_consegna rer - Provincia di Bologna
MSC_San_Luca_consegna rer - Provincia di Bologna
MSC_San_Luca_consegna rer - Provincia di Bologna
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
SOMMARIO PAG. I<br />
SOMMARIO<br />
1 PREMESSA METODOLOGICA............................................................................................1<br />
2 VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE<br />
DI HABITAT E SPECIE............................................................................................................2<br />
2.1 HABITAT NATURALI DI INTERESSE COMUNITARIO............................................................................................2<br />
2.1.1 3130 - Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea uniflorae<br />
e/o Isoëto-Nanojuncetea........................................................................................................................2<br />
2.1.2 3140 - Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica <strong>di</strong> Chara..................................2<br />
2.1.3 3150 - Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition............3<br />
2.1.4 3240 - Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos.......................................4<br />
2.1.5 3270 - Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopo<strong>di</strong>on rubri p.p e Bidention p.p..5<br />
2.1.6 6110* - Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell’Alysso-Se<strong>di</strong>on albae ..................6<br />
2.1.7 6210* - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato<br />
calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura <strong>di</strong> orchidee) .......................................................7<br />
2.1.8 6220* - Percorsi substeppici <strong>di</strong> graminacee e piante annue dei Thero-Brachypo<strong>di</strong>etea ...........8<br />
2.1.9 6430 - Bordure planiziali, montane e alpine <strong>di</strong> megaforbie idrofile............................................8<br />
2.1.10 6510 - Praterie magre da fieno a bassa altitu<strong>di</strong>ne (Alopecurus pratensis, <strong>San</strong>guisorba<br />
officinalis) .............................................................................................................................................9<br />
2.1.11 91AA* - Boschi orientali <strong>di</strong> quercia bianca.............................................................................10<br />
2.1.12 91E0* - Foreste alluvionali <strong>di</strong> Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Pa<strong>di</strong>on, Alnion<br />
incanae, Salicion albae)......................................................................................................................10<br />
2.1.13 92A0 - Foreste a galleria <strong>di</strong> Salix alba e Populus alba...........................................................11<br />
2.2 HABITAT DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO REGIONALE..............................................................................13<br />
2.2.1 Pa - Canneti palustri: fragmiteti, tifeti e scirpeti d'acqua dolce (Phragmition)........................13<br />
2.3 SPECIE VEGETALI DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO...................................................................................13<br />
2.3.1 Specie vegetali <strong>di</strong> interesse comunitario....................................................................................13<br />
2.3.2 Altre specie vegetali <strong>di</strong> interesse conservazionistico.................................................................15<br />
2.4 SPECIE ANIMALI DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO.....................................................................................22<br />
2.4.1 Specie <strong>di</strong> invertebrati <strong>di</strong> interesse comunitario..........................................................................22<br />
2.4.2 Altre specie <strong>di</strong> invertebrati <strong>di</strong> interesse conservazionistico.......................................................28<br />
2.4.3 Specie <strong>di</strong> Pesci <strong>di</strong> interesse comunitario....................................................................................38<br />
2.4.4 Altre specie <strong>di</strong> Pesci <strong>di</strong> interesse conservazionistico.................................................................40<br />
2.4.5 Specie <strong>di</strong> Anfibi <strong>di</strong> interesse comunitario...................................................................................42<br />
2.4.6 Altre specie <strong>di</strong> Anfibi <strong>di</strong> interesse conservazionistico................................................................44<br />
2.4.7 Specie <strong>di</strong> Rettili <strong>di</strong> interesse comunitario ..................................................................................51<br />
2.4.8 Altre specie <strong>di</strong> Rettili <strong>di</strong> interesse conservazionistico................................................................52<br />
2.4.9 Specie <strong>di</strong> Uccelli <strong>di</strong> interesse comunitario ................................................................................59<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA RENO”
SOMMARIO PAG. II<br />
2.4.10 Specie <strong>di</strong> Mammiferi <strong>di</strong> interesse comunitario ........................................................................81<br />
2.5 SCELTA DEGLI INDICATORI UTILI PER LA VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE ED IL MONITORAGGIO DELLE<br />
ATTIVITÀ DI GESTIONE....................................................................................................................................91<br />
2.5.1 Generalità...................................................................................................................................91<br />
2.5.2 Habitat........................................................................................................................................92<br />
2.5.3 Specie vegetali <strong>di</strong> interesse conservazionistico .........................................................................96<br />
2.5.4 Fauna..........................................................................................................................................97<br />
2.5.5 Assetto idrobiologico................................................................................................................106<br />
2.6 PROGRAMMI DI MONITORAGGIO...............................................................................................................108<br />
2.6.1 Generalità.................................................................................................................................108<br />
2.6.2 Habitat......................................................................................................................................110<br />
2.6.3 Specie vegetali..........................................................................................................................116<br />
2.6.4 Fauna .......................................................................................................................................118<br />
3 DESCRIZIONE DELLE CRITICITÀ E DELLE CAUSE DI MINACCIA.............................158<br />
3.1 ALTERAZIONI DEL REGIME IDROLOGICO....................................................................................................158<br />
3.2 INQUINAMENTO ED EUTROFIZZAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI.................................................................159<br />
3.3 INVASIONE DI SPECIE VEGETALI ALLOCTONE..............................................................................................159<br />
3.3.1 Generalità.................................................................................................................................159<br />
3.3.2 Robinia (Robinia pseudoacacia)..............................................................................................163<br />
3.3.3 Falso indaco (Amorpha fruticosa)...........................................................................................163<br />
3.3.4 Acero americano (Acer negundo).............................................................................................163<br />
3.4 INVASIONE DI SPECIE ANIMALI ALLOCTONE................................................................................................164<br />
3.5 PROCESSI NATURALI..............................................................................................................................164<br />
3.6 ATTIVITÀ VENATORIA............................................................................................................................165<br />
3.6.1 Generalità.................................................................................................................................165<br />
3.6.2 Identificazione degli impatti.....................................................................................................166<br />
3.7 PESCA.................................................................................................................................................167<br />
3.8 USO DI ESCHE AVVELENATE PER IL CONTROLLO DI SPECIE INDESIDERATE........................................................168<br />
3.9 FRUIZIONE TURISTICO-RICREATIVA...........................................................................................................169<br />
3.10 BARRIERE ECOLOGICHE........................................................................................................................169<br />
3.10.1 Strade......................................................................................................................................169<br />
3.10.2 Linee elettriche.......................................................................................................................172<br />
3.10.3 Opere idrauliche.....................................................................................................................173<br />
3.10.4 Impianti per la produzione <strong>di</strong> energia da fonti rinnovabili....................................................174<br />
3.11 URBANIZZAZIONE...............................................................................................................................175<br />
3.12 ATTIVITÀ AGRICOLE INTENSIVE.............................................................................................................176<br />
3.13 GESTIONE FORESTALE..........................................................................................................................176<br />
3.13.1 Boschi ripariali.......................................................................................................................176<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA RENO”
SOMMARIO PAG. III<br />
3.13.2 Boschi collinari.......................................................................................................................177<br />
3.14 GESTIONE DELLE AREE DI FORAGGIAMENTO PER I CHIROTTERI...................................................................177<br />
3.15 DISTRUZIONE E PERTURBAZIONE DEI RIFUGI DEI CHIROTTERI......................................................................178<br />
3.15.1 Ambiente ipogeo.....................................................................................................................178<br />
3.15.2 Ambiente forestale..................................................................................................................179<br />
3.15.3 Rifugi per pipistrelli sinantropi..............................................................................................179<br />
4 DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE STRATEGIE GESTIONALI........................180<br />
4.1 OBIETTIVI GENERALI.............................................................................................................................180<br />
4.2 OBIETTIVI SPECIFICI..............................................................................................................................181<br />
4.2.1 Generalità.................................................................................................................................181<br />
4.2.2 Habitat......................................................................................................................................182<br />
4.2.3 Specie vegetali..........................................................................................................................188<br />
4.2.4 Specie animali...........................................................................................................................189<br />
5 MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE ................................................................191<br />
6 INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI NATURALI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO<br />
AGRARIO CON ALTA VALENZA ECOLOGICA.................................................................195<br />
7 NORME PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA (BOZZA)............................................196<br />
7.1 PREMESSA ..........................................................................................................................................196<br />
8 PROPOSTE DI MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE CHE PREVEDONO L'OBBLIGO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA .197<br />
8.1 PROPOSTE DI RESTRINGIMENTO DELLA TABELLA E.....................................................................................199<br />
8.2 OPERE DIRETTAMENTE CONNESSE ALLA GESTIONE DEL SITO DA NON SOTTOPORRE A VALUTAZIONE D’INCIDENZA<br />
(CFR. TABELLA E PUNTO 15).......................................................................................................................199<br />
BIBLIOGRAFIA...................................................................................................................200<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA RENO”
CAP. 1 – PREMESSA METODOLOGICA PAG. 1<br />
1 PREMESSA METODOLOGICA<br />
Le presenti Misure Specifiche <strong>di</strong> Conservazione sono state redatte sulla base dell’Allegato C<br />
"In<strong>di</strong>rizzi per la pre<strong>di</strong>sposizione delle Misure Specifiche <strong>di</strong> Conservazione dei Siti Natura<br />
2000 della Regione Emilia-Romagna" alla D.G.R. 28 <strong>di</strong>cembre 2009, n. 2253, tenendo conto<br />
anche <strong>di</strong> quanto previsto dal “Manuale per la gestione dei siti Natura 2000”, pubblicato dal<br />
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio.<br />
Nei paragrafi che seguono viene definito lo stato <strong>di</strong> conservazione degli habitat e delle<br />
specie <strong>di</strong> interesse comunitario obiettivo <strong>di</strong> conservazione, oltre a definire gli in<strong>di</strong>catori utili a<br />
monitorarne lo stato e l’efficacia delle misure <strong>di</strong> conservazione e delle azioni <strong>di</strong> gestione<br />
proposte. A questo elenco <strong>di</strong> specie si aggiungono anche le specie non incluse in Direttiva<br />
Habitat allegato II, ma comunque <strong>di</strong> interesse conservazionistico, basandosi sui medesimi<br />
principi ispiratori, mutuandoli ed adattandoli alla realtà territoriale del sito, e restituendo un<br />
giu<strong>di</strong>zio simile a quelli previsti a livello comunitario.<br />
Gli obiettivi e le strategie gestionali sono definiti sulla base dei risultati derivanti dal quadro<br />
conoscitivo.<br />
La necessità <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare apposite misure <strong>di</strong> conservazione è uno degli elementi <strong>di</strong><br />
maggiore importanza per la gestione dei siti della Rete Natura 2000. Le misure derivano da<br />
necessità <strong>di</strong> adempimento delle Dir. 92/43/CEE e 79/409/CEE. Le misure <strong>di</strong> conservazione<br />
sono finalizzate al mantenimento e all’eventuale ripristino in uno stato <strong>di</strong> conservazione<br />
sod<strong>di</strong>sfacente, degli habitat e delle specie <strong>di</strong> fauna e flora <strong>di</strong> interesse comunitario, tenendo<br />
conto delle esigenze <strong>di</strong> sviluppo economico, sociale e culturale, nonché delle particolarità <strong>di</strong><br />
ciascun sito.<br />
Le misure, oltre che ad essere definite in base alle specie e agli habitat effettivamente<br />
presenti nei siti e alle relative esigenze ecologiche, devono necessariamente essere<br />
integrate e coor<strong>di</strong>nate con la pianificazione e le regolamentazioni esistenti, considerando<br />
nelle maniere opportune le esigenze delle comunità locali e le forme <strong>di</strong> gestione<br />
tra<strong>di</strong>zionalmente adottate.<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 2<br />
2 VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI<br />
CONSERVAZIONE DI HABITAT E SPECIE<br />
2.1 Habitat naturali <strong>di</strong> interesse comunitario<br />
2.1.1 3130 - Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea<br />
uniflorae e/o Isoëto-Nanojuncetea<br />
2.1.1.1 Esigenze ecologiche<br />
Vegetazione costituita da comunità anfibie <strong>di</strong> piccola taglia, sia perenni, sia annuali pioniere,<br />
della fascia litorale <strong>di</strong> laghi e pozze con acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, su<br />
substrati poveri <strong>di</strong> nutrienti.<br />
2.1.1.2 Stato <strong>di</strong> conservazione<br />
Lo stato <strong>di</strong> conservazione dell’habitat risulta abbastanza buono, anche se l’unico<br />
popolamento è oggettivamente fragile a causa della sua limitata estensione.<br />
2.1.1.3 Tendenze <strong>di</strong>namiche naturali<br />
Le comunità vegetali <strong>di</strong> questo habitat sono relativamente stabili a meno che non vengano<br />
alterate le con<strong>di</strong>zioni naturali.<br />
2.1.1.4 Minacce<br />
• Gestione/uso della risorsa acqua (prosciugamento delle pozze; ridotto o assente apporto<br />
idrico nel periodo estivo).<br />
• Ridotte <strong>di</strong>mensioni dell’habitat.<br />
• Assenza <strong>di</strong> interventi per impe<strong>di</strong>re il progressivo interramento del corpo d’acqua.<br />
• Presenza <strong>di</strong> specie vegetali competitive.<br />
2.1.2 3140 - Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica <strong>di</strong> Chara<br />
2.1.2.1 Esigenze ecologiche<br />
Laghi, stagni e pozze <strong>di</strong> varie <strong>di</strong>mensioni e profon<strong>di</strong>tà con acque ricche <strong>di</strong> sostanze basiche<br />
<strong>di</strong>sciolte (pH spesso 6-7), o con colore blu-verdastro, molto limpide, <strong>di</strong> norma povere in<br />
nutrienti, ancora più ricche <strong>di</strong> sostanze basiche (con pH spesso >7.5)..<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 3<br />
2.1.2.2 Stato <strong>di</strong> conservazione<br />
Habitat localizzato e <strong>di</strong> superficie ridotta. Stato <strong>di</strong> conservazione generalmente buono, ma la<br />
cui stabilità è con<strong>di</strong>zionata dalla gestione degli apporti idrici.<br />
2.1.2.3 Tendenze <strong>di</strong>namiche naturali<br />
Questo habitat è caratterizzato da comunità notevolmente stabili anche per perio<strong>di</strong> me<strong>di</strong>o-<br />
lunghi. La <strong>di</strong>namica è spesso con<strong>di</strong>zionata dalla <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> nutrienti nelle acque (innesco<br />
<strong>di</strong> fenomeni <strong>di</strong> eutrofia, intorbidamento e affermazione <strong>di</strong> comunità <strong>di</strong> macrofite acquatiche e<br />
palustri e/o microalghe più tolleranti) o dall’invasione della vegetazione idrofitica/elofitica dai<br />
contesti ripari (processi <strong>di</strong> colmamento). La <strong>di</strong>namica non sembra invece con<strong>di</strong>zionata da<br />
perio<strong>di</strong> limitati <strong>di</strong> prosciugamento stagionale dei corpi idrici colonizzati.<br />
2.1.2.4 Minacce<br />
• Gestione/uso della risorsa acqua (prosciugamento delle pozze; ridotto o assente apporto<br />
idrico nel periodo estivo).<br />
• Assenza <strong>di</strong> interventi per impe<strong>di</strong>re il progressivo interramento del corpo d’acqua.<br />
• Presenza <strong>di</strong> specie vegetali competitive.<br />
2.1.3 3150 - Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition<br />
2.1.3.1 Esigenze ecologiche<br />
Le comunità <strong>di</strong> idrofite ra<strong>di</strong>canti e sommerse (Potamion pectinati) e quelle liberamente<br />
natanti (dei Lemnetalia minoris o Utricularietalia) afferenti a questo habitat colonizzano<br />
acque ferme <strong>di</strong> profon<strong>di</strong>tà generalmente modeste (2-3 m) a grado trofico elevato (ambiente<br />
eutrofico). In con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> apprezzabile naturalità negli specchi d’acqua è possibile<br />
osservare, dalla zona centrale proseguendo verso le sponde, la tipica serie delle comunità<br />
vegetali che si <strong>di</strong>spongono in funzione della profon<strong>di</strong>tà dell’acqua.<br />
2.1.3.2 Stato <strong>di</strong> conservazione<br />
Habitat localizzato e <strong>di</strong> superficie ridotta. Stato <strong>di</strong> conservazione generalmente buono, ma la<br />
cui stabilità è con<strong>di</strong>zionata dalla gestione degli apporti idrici.<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 4<br />
2.1.3.3 Tendenze <strong>di</strong>namiche naturali<br />
Le comunità vegetali <strong>di</strong> questo habitat sono relativamente stabili a meno che non vengano<br />
alterate le con<strong>di</strong>zioni naturali. Va in ogni caso evidenziato come il destino degli specchi<br />
d’acqua ferma è quello <strong>di</strong> essere colmato soprattutto per l’avanzamento della vegetazione<br />
palustre <strong>di</strong> gran<strong>di</strong> elofite ripariali (es. canneti), particolarmente veloce in ambiente eutrofico.<br />
In ambiente ipertrofico poi si possono verificare fenomeni <strong>di</strong> proliferazione algale che<br />
tendono a soffocare la vegetazione macrofitica.<br />
2.1.3.4 Minacce<br />
• Gestione/uso della risorsa acqua (prosciugamento delle pozze; ridotto o assente apporto<br />
idrico nel periodo estivo).<br />
• Dinamiche naturali <strong>di</strong> interramento dei laghetti.<br />
2.1.4 3240 - Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos<br />
2.1.4.1 Esigenze ecologiche<br />
L’habitat si sviluppa sui greti ghiaioso-sabbiosi <strong>di</strong> torrenti e fiumi (generalmente con regime<br />
torrentizio) e con sensibili variazioni del livello della falda nel corso dell'anno.<br />
Ecologicamente, queste comunità sono ben adattate alle rapide fluttuazioni dei livelli<br />
idrometrici della falda superficiale o sub-superficiale, capaci dunque <strong>di</strong> sopportare sia<br />
prolungate fasi <strong>di</strong> asfissia, a seguito del perdurare <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> sommersione<br />
(ipossia/anossia ra<strong>di</strong>cale), che fenomeni <strong>di</strong> ari<strong>di</strong>tà normalmente tardo-estiva tipica<br />
specialmente della porzione appenninica del reticolo idrografico del <strong>di</strong>stretto padano..<br />
2.1.4.2 Stato <strong>di</strong> conservazione<br />
Stato <strong>di</strong> conservazione generalmente buono, anche se la presenza <strong>di</strong> specie alloctone può<br />
essere considerata un in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> degrado. In particolare Amorpha fruticosa è ormai<br />
largamente <strong>di</strong>ffuso anche in situazioni prossimo-naturali. Presenze <strong>di</strong> specie nitrofile,<br />
sinantropiche e banali in<strong>di</strong>cano eutrofizzazione e scarsa qualità ambientale.<br />
2.1.4.3 Tendenze <strong>di</strong>namiche naturali<br />
Nei tratti fluviali ove il fondo è più stabile e le portate meno irregolari, si possono osservare<br />
contatti seriali con boschi ripari degli Habitat 92A0 o 91E0*. I rapporti <strong>di</strong>namici con gli sta<strong>di</strong><br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 5<br />
erbacei precedenti e con le eventuali evoluzioni verso formazioni arboree sono determinati<br />
soprattutto dalle caratteristiche del regime idrologico e dalla topografia.<br />
2.1.4.4 Minacce<br />
• Gestione/uso della risorsa acqua (captazioni idriche superficiali e <strong>di</strong> falda per usi agricoli<br />
e industriali; presenza <strong>di</strong> sbarramenti; regimazione fluviale).<br />
• Taglio incontrollato della vegetazione ripariale.<br />
• Presenza <strong>di</strong> specie invasive aliene (Amorpha fruticosa).<br />
• Inquinamento da reflui domestici urbani, industriali e agricoli.<br />
• Piene catastrofiche.<br />
2.1.5 3270 - Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopo<strong>di</strong>on rubri p.p e<br />
Bidention p.p.<br />
2.1.5.1 Esigenze ecologiche<br />
Le comunità vegetali annuali nitrofile pioniere afferenti a questo habitat si sviluppano sulle<br />
rive fangose, perio<strong>di</strong>camente inondate e ricche <strong>di</strong> nitrati dei fiumi <strong>di</strong> pianura e della fascia<br />
submontana, in ambienti aperti, su substrati sabbiosi, limosi o argillosi intercalati talvolta da<br />
uno scheletro ghiaioso. In primavera e fino all’inizio dell’estate questi ambienti, a lungo<br />
inondati, appaiono come rive melmose prive <strong>di</strong> vegetazione in quanto questa si sviluppa, se<br />
le con<strong>di</strong>zioni sono favorevoli, nel periodo tardo estivo – autunnale. La forte instabilità<br />
dell’ambiente è affrontata dalla vegetazione producendo, nel momento più favorevole, una<br />
grande quantità <strong>di</strong> semi che assicurano la conservazione del suo pool specifico.<br />
2.1.5.2 Stato <strong>di</strong> conservazione<br />
Habitat generalmente in buono stato <strong>di</strong> conservazione, per la ricchezza in specie tipiche.<br />
2.1.5.3 Tendenze <strong>di</strong>namiche naturali<br />
E’ una tipica comunità pioniera che si ripresenta costantemente nei momenti adatti del ciclo<br />
stagionale, favorita dalla grande produzione <strong>di</strong> semi. Data la loro natura effimera determinata<br />
dalle perio<strong>di</strong>che alluvioni, queste comunità sono soggette a profonde mo<strong>di</strong>ficazioni spaziali.<br />
Il permanere del controllo da parte dell’azione del fiume ne blocca lo sviluppo verso le<br />
vegetazioni <strong>di</strong> greto dominate da specie erbacee biennali e perenni.<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 6<br />
2.1.5.4 Minacce<br />
• Attività ricreative sul greto che generano compattamento e costipamento del suolo<br />
(transito con fuoristrada).<br />
• Gestione/uso della risorsa acqua (prosciugamento delle lanche e delle depressioni<br />
saltuariamente sommerse; eccessiva captazione per usi agricoli e industriali con<br />
progressivo abbassamento della falda; presenza <strong>di</strong> bacini idroelettrici che favoriscono<br />
processi erosivi; presenza <strong>di</strong> sbarramenti; ridotto o assente apporto idrico nel periodo<br />
estivo).<br />
• Alterazioni morfologiche conseguenti ad interventi <strong>di</strong> regimazione fluviale (rettificazioni,<br />
arginature, captazioni idriche).<br />
• Presenza <strong>di</strong> specie esotiche invasive (es. Bidens frondosa).<br />
• Piene catastrofiche.<br />
2.1.6 6110* - Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell’Alysso-Se<strong>di</strong>on albae<br />
2.1.6.1 Esigenze ecologiche<br />
Pratelli xerotermo fili su suoli sottili, rocciosi, dal piano mesome<strong>di</strong>terraneo a quello<br />
supratemperato inferiore, localmente fino all'orizzonte subalpino. Il substrato è generalmente<br />
calcareo, ma può interessare anche rocce ofiolitiche o vulcaniti.<br />
2.1.6.2 Stato <strong>di</strong> conservazione<br />
Lo stato <strong>di</strong> conservazione è <strong>di</strong>screto, in funzione della superficie ridotta e della pressione<br />
antropica esercitata.<br />
2.1.6.3 Tendenze <strong>di</strong>namiche naturali<br />
L' habitat è da considerare bloccato, o a <strong>di</strong>namica molto lenta, da aspetti edafici.<br />
2.1.6.4 Minacce<br />
• Localizzati episo<strong>di</strong> <strong>di</strong> erosione del suolo.<br />
• Calpestio eccessivo da attività escursionistica sia entro sentieri regolamentari (rete<br />
sentieristica CAI) che al <strong>di</strong> fuori dei tracciati .<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 7<br />
2.1.7 6210* - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su<br />
substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura <strong>di</strong> orchidee)<br />
2.1.7.1 Esigenze ecologiche<br />
L’habitat cresce su suoli neutro-basici o leggermente aci<strong>di</strong>, asciutti, generalmente ben<br />
drenati; si tratta in prevalenza <strong>di</strong> formazioni secondarie, mantenute da sfalcio e/o pascolo<br />
estensivi, ma possono includere anche aggruppamenti pionieri (primari o durevoli) su suoli<br />
acclivi o pietrosi.<br />
2.1.7.2 Stato <strong>di</strong> conservazione<br />
Lo stato <strong>di</strong> conservazione dell’habitat risulta in generale <strong>di</strong>screto: sono presenti praterie in<br />
buono stato <strong>di</strong> conservazione ad elevata ricchezza floristica, praterie con bassa<br />
colonizzazione arbustiva (copertura inferiore al 10%) e praterie a me<strong>di</strong>a colonizzazione <strong>di</strong><br />
arbusti, <strong>di</strong>fficilmente recuperabili.<br />
2.1.7.3 Tendenze <strong>di</strong>namiche naturali<br />
L’habitat risulta stabile fintanto che viene estensivamente pascolato; l’abbandono <strong>di</strong> tali<br />
pratiche, evidenziata dall’ingresso <strong>di</strong> specie arbustive, innesca processi <strong>di</strong>namici verso<br />
formazioni preforestali e poi forestali.<br />
2.1.7.4 Minacce<br />
• Localizzati episo<strong>di</strong> <strong>di</strong> erosione del suolo (idrica incanalata, attività franosa).<br />
• Transito <strong>di</strong> mezzi sulle superfici erbose.<br />
• Calpestio, raccolta <strong>di</strong> fiori da parte degli escursionisti.<br />
• Sconvolgimento del suolo operato dai cinghiali.<br />
• Conversione agronomica.<br />
• Abbandono totale del pascolamento o dello sfalcio, che potrebbe determinare una<br />
generalizzata ripresa delle <strong>di</strong>namiche successionali naturali, con conseguente riduzione<br />
<strong>di</strong> habitat.<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 8<br />
2.1.8 6220* - Percorsi substeppici <strong>di</strong> graminacee e piante annue dei Thero-<br />
Brachypo<strong>di</strong>etea<br />
2.1.8.1 Esigenze ecologiche<br />
Si tratta <strong>di</strong> praterie xerofile e <strong>di</strong>scontinue <strong>di</strong> piccola taglia a dominanza <strong>di</strong> graminacee, su<br />
substrati <strong>di</strong> varia natura, spesso calcarei e ricchi <strong>di</strong> basi, talora soggetti ad erosione.<br />
2.1.8.2 Stato <strong>di</strong> conservazione<br />
Lo stato <strong>di</strong> conservazione dell’habitat, risulta <strong>di</strong>screto, in ragione del buon grado <strong>di</strong><br />
conservazione della struttura (anche se i popolamenti sono soggetti a fenomeni <strong>di</strong> erosione<br />
attiva che possono <strong>di</strong>struggerli completamente), ma anche del me<strong>di</strong>o grado <strong>di</strong><br />
ruderalizzazione.<br />
2.1.8.3 Tendenze <strong>di</strong>namiche naturali<br />
Le comunità riferibili all’habitat possono essere invase da specie perenni arbustive legnose<br />
che tendono a soppiantare la vegetazione erbacea, dando luogo a successioni verso cenosi<br />
perenni più evolute, quando le con<strong>di</strong>zioni ambientali favoriscono i processi <strong>di</strong> sviluppo sia del<br />
suolo che della vegetazione.<br />
2.1.8.4 Minacce<br />
• Dinamismo naturale dell’habitat verso formazioni arbustive.<br />
• Fenomeni <strong>di</strong> erosione legati all’ambiente calanchivo.<br />
2.1.9 6430 - Bordure planiziali, montane e alpine <strong>di</strong> megaforbie idrofile<br />
2.1.9.1 Esigenze ecologiche<br />
Si tratta <strong>di</strong> comunità <strong>di</strong> alte erbe (megaforbie) igro-nitrofile <strong>di</strong> margini <strong>di</strong> boschi e <strong>di</strong> corsi<br />
d’acqua (inclusi i canali <strong>di</strong> irrigazione e margini <strong>di</strong> zone umide d’acqua dolce).<br />
2.1.9.2 Stato <strong>di</strong> conservazione<br />
Lo stato <strong>di</strong> conservazione dell’habitat risulta <strong>di</strong>screto, in ragione della superficie ridotta e<br />
della presenza <strong>di</strong> specie alloctone invasive (Solidago gigantea).<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 9<br />
2.1.9.3 Tendenze <strong>di</strong>namiche naturali<br />
Tali fitocenosi possono derivare dall’abbandono <strong>di</strong> prati umi<strong>di</strong> falciati, ma costituiscono più<br />
spesso comunità naturali <strong>di</strong> orlo boschivo o, alle quote più elevate, possono essere estranee<br />
alla <strong>di</strong>namica nemorale. Nel caso si sviluppino nell'ambito della potenzialità del bosco, si<br />
collegano a sta<strong>di</strong> <strong>di</strong>namici che conducono verso <strong>di</strong>fferenti formazioni forestali.<br />
2.1.9.4 Minacce<br />
• Interventi <strong>di</strong> pulizia idraulica.<br />
• Colonizzazione da parte <strong>di</strong> specie esotiche.<br />
2.1.10 6510 - Praterie magre da fieno a bassa altitu<strong>di</strong>ne (Alopecurus pratensis,<br />
<strong>San</strong>guisorba officinalis)<br />
2.1.10.1 Esigenze ecologiche<br />
Prati da mesici a pingui, regolarmente falciati e concimati in modo non intensivo,<br />
floristicamente ricchi, <strong>di</strong>stribuiti dalla pianura alla fascia montana inferiore.<br />
2.1.10.2 Stato <strong>di</strong> conservazione<br />
Lo stato <strong>di</strong> conservazione dell’habitat risulta <strong>di</strong>screto, in ragione dell’esiguità delle superfici<br />
occupate.<br />
2.1.10.3 Tendenze <strong>di</strong>namiche naturali<br />
In assenza <strong>di</strong> concimazione, pur assicurando regolari falciature, si svilupperebbero, secondo<br />
le caratteristiche dei <strong>di</strong>versi siti, altri tipi <strong>di</strong> prateria, soprattutto mesoxerofila (6210 con<br />
possibili facies a ginepro). Più raramente anche i molinieti (6410) favoriti dall'assenza <strong>di</strong><br />
drenaggi. Il brachipo<strong>di</strong>eto (a Brachypo<strong>di</strong>um rupestre) rappresenta uno sta<strong>di</strong>o <strong>di</strong> transizione<br />
prenemorale.<br />
2.1.10.4 Minacce<br />
• Fenomeni <strong>di</strong> degradazione del suolo per compattazione in aree umide, dovuti a<br />
calpestio.<br />
• Localizzati episo<strong>di</strong> <strong>di</strong> erosione del suolo (idrica incanalata).<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 10<br />
• Cessazione delle pratiche <strong>di</strong> sfalcio ed innesco delle <strong>di</strong>namiche <strong>di</strong> colonizzazione del<br />
bosco.<br />
• Trasformazione dei prati stabili in seminativi, frutteti, vigneti e altre colture specializzate.<br />
2.1.11 91AA* - Boschi orientali <strong>di</strong> quercia bianca<br />
2.1.11.1 Esigenze ecologiche<br />
Questi boschi me<strong>di</strong>terranei e subme<strong>di</strong>terranei, termofili e spesso in posizione edafo-xerofila<br />
sono tipici della penisola italiana ma con affinità con quelli balcanici, con <strong>di</strong>stribuzione<br />
prevalente nelle aree costiere, subcostiere e preappenniniche. Si rinvengono anche nelle<br />
conche infraappenniniche.<br />
2.1.11.2 Stato <strong>di</strong> conservazione<br />
Lo stato <strong>di</strong> conservazione dell’habitat risulta <strong>di</strong>screto, in ragione della ricchezza in specie<br />
tipiche e della struttura (cedui invecchiati e a regime).<br />
2.1.11.3 Tendenze <strong>di</strong>namiche naturali<br />
In rapporto <strong>di</strong>namico con i querceti si sviluppano per fenomeni <strong>di</strong> regressione cenosi<br />
arbustive dell’alleanza Cytision sessilifolii e praterie della classe Festuco-Brometea riferibili<br />
all’habitat 6210.<br />
2.1.11.4 Minacce<br />
• Frammentazione dell’habitat ed isolamento.<br />
• Struttura forestale sostanzialmente coetanea.<br />
• Degradazione della struttura con infiltrazione <strong>di</strong> robinia.<br />
2.1.12 91E0* - Foreste alluvionali <strong>di</strong> Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Pa<strong>di</strong>on,<br />
Alnion incanae, Salicion albae)<br />
2.1.12.1 Esigenze ecologiche<br />
L’habitat è presente lungo i corsi d’acqua sia nei tratti montani e collinari che planiziali o sulle<br />
rive dei bacini lacustri e in aree con ristagni idrici non necessariamente collegati alla<br />
<strong>di</strong>namica fluviale. Si sviluppano su suoli alluvionali spesso inondati o nei quali la falda idrica<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 11<br />
è superficiale, prevalentemente in macrobioclima temperato ma penetrano anche in quello<br />
me<strong>di</strong>terraneo dove l’umi<strong>di</strong>tà edafica lo consente. Si presentano, almeno nella porzione<br />
planiziale, come comunità usualmente lineari e <strong>di</strong>scontinue a predominanza <strong>di</strong> ontano<br />
bianco e/o ontano nero, con la partecipazione non trascurabile <strong>di</strong> salici e pioppi.<br />
2.1.12.2 Stato <strong>di</strong> conservazione<br />
Lo stato <strong>di</strong> conservazione dell’habitat risulta <strong>di</strong>screto, in ragione della struttura solo<br />
parzialmente degradata e dell’affermazione, nelle radure, <strong>di</strong> un fitto e continuo sottobosco <strong>di</strong><br />
falso indaco, oppure, nelle depressioni umide, <strong>di</strong> canneto, che rende impossibile la<br />
germinazione del seme delle specie arboree tipiche.<br />
2.1.12.3 Tendenze <strong>di</strong>namiche naturali<br />
I boschi ripariali sono formazioni azonali influenzati dal livello della falda e dai ciclici eventi <strong>di</strong><br />
piena e <strong>di</strong> magra. Nel caso in cui vi siano frequenti allagamenti con persistenza <strong>di</strong> acqua<br />
affiorante si ha una regressione verso comunità erbacee. Al contrario con frequenze ridotte<br />
<strong>di</strong> allagamenti si ha un’evoluzione verso cenosi mesofile più stabili.<br />
2.1.12.4 Minacce<br />
• Disturbo legato sia a fenomeni naturali (piene dei corsi d’acqua), sia a perio<strong>di</strong>ci tagli<br />
della vegetazione.<br />
• Non trascurabile presenza <strong>di</strong> esotiche invasive (es. robinia, falso indaco), che viene<br />
agevolata anche dai fattori <strong>di</strong>sturbo sopra elencati.<br />
• Presenza <strong>di</strong> attività agricole che determinano fenomeni <strong>di</strong> erosione.<br />
• Gestione/uso della risorsa acqua (realizzazione <strong>di</strong> drenaggi; eccessiva captazione idrica<br />
superficiale e <strong>di</strong> falda per usi agricoli con progressivo abbassamento della falda).<br />
• Inquinamento: eccesso <strong>di</strong> sostanze nutritive (in particolare nitrati) e/o tossiche con<br />
innesco <strong>di</strong> fenomeni <strong>di</strong> eutrofizzazione o intorbi<strong>di</strong>mento.<br />
2.1.13 92A0 - Foreste a galleria <strong>di</strong> Salix alba e Populus alba<br />
2.1.13.1 Esigenze ecologiche<br />
Boschi ripariali afferenti a questo habitat colonizzano gli ambiti ripari e creano un effetto<br />
galleria cingendo i corsi d’acqua in modo continuo lungo tutta la fascia riparia a stretto<br />
contatto con il corso d’acqua, in particolare lungo i rami secondari attivi durante le piene.<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 12<br />
Pre<strong>di</strong>lige i substrati sabbiosi mantenuti umi<strong>di</strong> da una falda freatica superficiale. I suoli sono<br />
giovanili, perché bloccati nella loro evoluzione dalle correnti <strong>di</strong> piena che asportano la parte<br />
superficiale. L’habitat è <strong>di</strong>ffuso sia nei contesti <strong>di</strong> pianura che nella fascia collinare.<br />
2.1.13.2 Stato <strong>di</strong> conservazione<br />
Vale quanto scritto per l’habitat 91E0, soprattutto per quanto riguarda i soprassuoli a<br />
prevalenza <strong>di</strong> Salix alba, a tratti in fasi <strong>di</strong> avanzata senescenza a causa dell’abbassamento<br />
della falda freatica connessa all’abbassamento dell’alveo inciso del Reno.<br />
2.1.13.3 Tendenze <strong>di</strong>namiche naturali<br />
I boschi ripariali sono formazioni azonali influenzati dal livello della falda e dai ciclici eventi <strong>di</strong><br />
piena e <strong>di</strong> magra. Nel caso in cui vi siano frequenti allagamenti con persistenza <strong>di</strong> acqua<br />
affiorante si ha una regressione verso comunità erbacee. Al contrario con frequenze ridotte<br />
<strong>di</strong> allagamenti si ha un’evoluzione verso cenosi mesofile più stabili. Le cenosi del 92A0 sono<br />
spesso associate, laddove si abbiano fenomeni <strong>di</strong> ristagno idrico per perio<strong>di</strong> più o prolungati<br />
a canneti a Phragmites australis subsp. australis, in cui possono essere presenti specie del<br />
Phragmition e del Nasturtio-Glycerion, e formazioni a gran<strong>di</strong> carici dell’alleanza<br />
Magnocaricion.<br />
2.1.13.4 Minacce<br />
• Disturbo legato sia a fenomeni naturali (piene dei corsi d’acqua), sia a perio<strong>di</strong>ci tagli<br />
della vegetazione.<br />
• Non trascurabile presenza <strong>di</strong> esotiche invasive (es. robinia, falso indaco), che viene<br />
agevolata anche dai fattori <strong>di</strong>sturbo sopra elencati.<br />
• Presenza <strong>di</strong> attività agricole che determinano fenomeni <strong>di</strong> erosione.<br />
• Gestione/uso della risorsa acqua (realizzazione <strong>di</strong> drenaggi; eccessiva captazione idrica<br />
superficiale e <strong>di</strong> falda per usi agricoli con progressivo abbassamento della falda).<br />
• Inquinamento: eccesso <strong>di</strong> sostanze nutritive (in particolare nitrati) e/o tossiche con<br />
innesco <strong>di</strong> fenomeni <strong>di</strong> eutrofizzazione o intorbi<strong>di</strong>mento.<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 13<br />
2.2 Habitat <strong>di</strong> interesse conservazionistico regionale<br />
2.2.1 Pa - Canneti palustri: fragmiteti, tifeti e scirpeti d'acqua dolce (Phragmition)<br />
2.2.1.1 Esigenze ecologiche<br />
Formazioni <strong>di</strong> elofite <strong>di</strong> grossa taglia che contribuiscono all'interramento <strong>di</strong> acque dolci<br />
stagnanti o a lento deflusso, da mesotrofiche ad eutrofìche.<br />
2.2.1.2 Stato <strong>di</strong> conservazione<br />
Habitat localizzato e <strong>di</strong> superficie ridotta. Stato <strong>di</strong> conservazione generalmente buono, ma la<br />
cui stabilità è con<strong>di</strong>zionata dalla gestione degli apporti idrici.<br />
2.2.1.3 Tendenze <strong>di</strong>namiche naturali<br />
In termini <strong>di</strong>namici, le comunità vegetali <strong>di</strong> questo habitat sono relativamente stabili a meno<br />
che non vengano alterate le con<strong>di</strong>zioni ambientali (es. fenomeni <strong>di</strong> eutrofizzazione o spinto<br />
interramento) e il regime idrico; nel complesso un’eccessiva sommersione può indurre la<br />
moria dei popolamenti stessi mentre la progressiva riduzione dell’igrofilia delle stazioni la<br />
loro sostituzione con formazioni meno igrofile (transizione verso cenosi terrestri quali saliceti<br />
arbustivi e, successivamente, boschi igrofili).<br />
2.2.1.4 Minacce<br />
• Eccessiva captazione idrica superficiale e <strong>di</strong> falda per usi agricoli e industriali con<br />
progressivo abbassamento della falda<br />
• Inquinamento falda acquifera ed eccessiva presenza <strong>di</strong> nutrienti dovuti ad attività<br />
agricole.<br />
• Ridotto o assente apporto idrico nel periodo estivo.<br />
• Presenza <strong>di</strong> specie invasive terrestri ed acquatiche.<br />
2.3 Specie vegetali <strong>di</strong> interesse conservazionistico<br />
2.3.1 Specie vegetali <strong>di</strong> interesse comunitario<br />
2.3.1.1 Orchide piramidale (Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.)<br />
2.3.1.1.1 Dati generali<br />
FORMA BIOLOGICA: G bulb<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 14<br />
TIPO COROLOGICO: Euri-Me<strong>di</strong>t.<br />
AMBIENTE DI CRESCITA: Prati magri, pascoli, incolti, sottoboschi, scarpate e bor<strong>di</strong> strada<br />
FASCIA ALTITUDINALE: 0-800 m<br />
CATEGORIA DI TUTELA E MOTIVO D’INTERESSE Specie protetta dalla Legge Regionale<br />
n. 2 del 24 gennaio 1977. Elencata nell'Allegato II della Direttiva 92/43, Specie target, cat<br />
IUCN – LC<br />
2.3.1.1.2 Stato <strong>di</strong> conservazione<br />
Buono, specie <strong>di</strong>ffusa in tutti i prati ari<strong>di</strong> del sito.<br />
2.3.1.1.3 Minacce<br />
• Distruzione dei bulbi da parte dei cinghiali<br />
2.3.1.2 Barbone adriatico (Himantoglossum adriaticum H. Baumann)<br />
2.3.1.2.1 Dati generali<br />
FORMA BIOLOGICA: G bulb<br />
TIPO COROLOGICO: Subme<strong>di</strong>terraneo centrale<br />
AMBIENTE DI CRESCITA: Spazi soleggiati e aperti come prati, pascoli, garighe, bor<strong>di</strong><br />
stradali, preferibilmente su substrato calcareo<br />
FASCIA ALTITUDINALE: 0-700 m<br />
CATEGORIA DI TUTELA E MOTIVO D’INTERESSE Specie protetta dalla Legge Regionale<br />
n. 2 del 24 gennaio 1977. Elencata nell'Allegato II della Direttiva 92/43, Specie target, cat<br />
IUCN – DD<br />
2.3.1.2.2 Stato <strong>di</strong> conservazione<br />
Da verificare.<br />
2.3.1.2.3 Minacce<br />
• Potenziali minacce legate a gestioni forestali non attente alla presenza della specie.<br />
• Distruzione dei bulbi da parte dei cinghiali<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 15<br />
2.3.2 Altre specie vegetali <strong>di</strong> interesse conservazionistico<br />
2.3.2.1 Pulmonaria dell'Appennino (Pulmonaria apennina Cristof. & Puppi)<br />
2.3.2.1.1 Dati generali<br />
FORMA BIOLOGICA: H scap<br />
TIPO COROLOGICO: Subend.<br />
AMBIENTE DI CRESCITA: Boschi <strong>di</strong> latifoglie (querceti mesofili collinari e castagneti)<br />
FASCIA ALTITUDINALE: 50-1600 (1800) m<br />
CATEGORIA DI TUTELA E MOTIVO D’INTERESSE Specie target, cat IUCN – LC<br />
2.3.2.1.2 Stato <strong>di</strong> conservazione<br />
Specie comune. Stato <strong>di</strong> conservazione generalmente buono.<br />
2.3.2.1.3 Minacce<br />
Nessuna.<br />
2.3.2.2 Bucaneve (Galanthus nivalis L.)<br />
2.3.2.2.1 Dati generali<br />
FORMA BIOLOGICA: G bulb<br />
TIPO COROLOGICO: Europ.-Caucas.<br />
AMBIENTE DI CRESCITA: Boschi umi<strong>di</strong>, vallecole umide e fresche<br />
FASCIA ALTITUDINALE: 100-1400 m<br />
CATEGORIA DI TUTELA E MOTIVO D’INTERESSE Specie protetta dalla Legge Regionale<br />
n. 2 del 24 gennaio 1977, cat IUCN - NT<br />
2.3.2.2.2 Stato <strong>di</strong> conservazione<br />
Specie rara. Stato <strong>di</strong> conservazione buono.<br />
2.3.2.2.3 Minacce<br />
• Raccolta dei bulbi per trapianti a fini ornamentali.<br />
• Interventi selvicolturali e pulizia del sottobosco.<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 16<br />
2.3.2.3 Crescione <strong>di</strong> Chiana (Rorippa amphibia (L.) Besser)<br />
2.3.2.3.1 Dati generali<br />
FORMA BIOLOGICA: H scap<br />
TIPO COROLOGICO: Eurosib.<br />
AMBIENTE DI CRESCITA: fanghi a perio<strong>di</strong>ca emersione<br />
FASCIA ALTITUDINALE: 0 – 800 m<br />
CATEGORIA DI TUTELA E MOTIVO D’INTERESSE cat IUCN - NT<br />
2.3.2.3.2 Stato <strong>di</strong> conservazione<br />
Specie rara e localizzata in una lanca del Reno. Stato <strong>di</strong> conservazione buono.<br />
2.3.2.3.3 Minacce<br />
• Interventi <strong>di</strong> gestione forestale ed idraulica.<br />
2.3.2.4 Giunco fiorito (Butomus umbellatus L.)<br />
2.3.2.4.1 Dati generali<br />
FORMA BIOLOGICA: I rad<br />
TIPO COROLOGICO: Euro-Asiat.<br />
AMBIENTE DI CRESCITA: ambiti litoranei <strong>di</strong> corpi idrici lentici<br />
FASCIA ALTITUDINALE: 0 – 1000 m<br />
CATEGORIA DI TUTELA E MOTIVO D’INTERESSE cat IUCN - VU/A1c<br />
2.3.2.4.2 Stato <strong>di</strong> conservazione<br />
Specie segnalata da Bonafede e Vignodelli (2009) con un solo esemplare in località Lido <strong>di</strong><br />
Casalecchio, probabilmente estinta.<br />
2.3.2.4.3 Minacce<br />
• Interventi <strong>di</strong> gestione idraulica.<br />
• Calpestio da fruizione turistico-ricreativa.<br />
• Raccolta a fini ornamentali.<br />
2.3.2.5 Lisca lacustre (Schoenoplectus lacustris (L.) Palla)<br />
2.3.2.5.1 Dati generali<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 17<br />
FORMA BIOLOGICA: He<br />
TIPO COROLOGICO: Subcosmop.<br />
AMBIENTE DI CRESCITA: ambiti litoranei <strong>di</strong> corpi idrici lentici<br />
FASCIA ALTITUDINALE: 0 – 1500 m<br />
CATEGORIA DI TUTELA E MOTIVO D’INTERESSE cat IUCN - NT<br />
2.3.2.5.2 Stato <strong>di</strong> conservazione<br />
Localizzata con piccole popolazioni presso la Chiusa e presso la sorgente sotto il Lido.<br />
2.3.2.5.3 Minacce<br />
• Gestione/uso della risorsa acqua (prosciugamento delle pozze; ridotto o assente apporto<br />
idrico nel periodo estivo).<br />
2.3.2.6 Millefoglio d'acqua comune (Myriophyllum spicatum L.)<br />
2.3.2.6.1 Dati generali<br />
FORMA BIOLOGICA: I rad<br />
TIPO COROLOGICO: Subcosmop.<br />
AMBIENTE DI CRESCITA: corsi d'acqua lotici, corpi idrici poco profon<strong>di</strong><br />
FASCIA ALTITUDINALE: 0 – 1500 m<br />
CATEGORIA DI TUTELA E MOTIVO D’INTERESSE cat IUCN - VU/A2<br />
2.3.2.6.2 Stato <strong>di</strong> conservazione<br />
Localizzata con una piccola popolazione nell’Oasi <strong>di</strong> <strong>San</strong> Gherardo, in buono stato <strong>di</strong><br />
conservazione.<br />
2.3.2.6.3 Minacce<br />
• Gestione/uso della risorsa acqua (prosciugamento delle pozze; ridotto o assente apporto<br />
idrico nel periodo estivo).<br />
• Dinamiche naturali <strong>di</strong> interramento dei laghetti.<br />
2.3.2.7 Lenticchia d’acqua comune (Lemna minor L.)<br />
2.3.2.7.1 Dati Generali<br />
FORMA BIOLOGICA: I nat<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 18<br />
TIPO COROLOGICO: Subcosmop.<br />
AMBIENTE DI CRESCITA: corpi idrici poco profon<strong>di</strong>, habitat 3150<br />
FASCIA ALTITUDINALE: 0 – 1600<br />
CATEGORIA DI TUTELA E MOTIVO D’INTERESSE: Lista Rossa idro-igrofila regionale, cat<br />
IUCN - VU<br />
2.3.2.7.2 Stato <strong>di</strong> conservazione<br />
Specie poco comune, presente solamente nello stagno a valle della sorgente del Lido. Stato<br />
<strong>di</strong> conservazione generalmente buono, ma la cui stabilità è con<strong>di</strong>zionata dalla gestione degli<br />
apporti idrici.<br />
2.3.2.7.3 Minacce<br />
• Gestione/uso della risorsa acqua (prosciugamento delle pozze; ridotto o assente apporto<br />
idrico nel periodo estivo).<br />
• Ridotte <strong>di</strong>mensioni dell’habitat.<br />
• Assenza <strong>di</strong> interventi per impe<strong>di</strong>re il progressivo interramento del corpo d’acqua.<br />
• Presenza <strong>di</strong> specie vegetali competitive.<br />
2.3.2.8 Giglio rosso (Lilium bulbiferum L. subsp. croceum (Chaix) Jan)<br />
2.3.2.8.1 Dati generali<br />
FORMA BIOLOGICA: G bulb<br />
TIPO COROLOGICO: Orof.S-Europ.<br />
AMBIENTE DI CRESCITA: Arbusteti, prati collinari<br />
FASCIA ALTITUDINALE: 0-2100 m<br />
CATEGORIA DI TUTELA E MOTIVO D’INTERESSE Specie protetta dalla Legge Regionale<br />
n. 2 del 24 gennaio 1977, specie target cat IUCN – NT.<br />
2.3.2.8.2 Stato <strong>di</strong> conservazione<br />
Specie in buono stato <strong>di</strong> conservazione.<br />
2.3.2.8.3 Minacce<br />
• Raccolta a fini ornamentali.<br />
• Distruzione dei bulbi da parte dei cinghiali<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 19<br />
2.3.2.9 Giglio martagone (Lilium martagon L.)<br />
2.3.2.9.1 Dati generali<br />
FORMA BIOLOGICA: G bulb<br />
TIPO COROLOGICO: Eurasiatico<br />
AMBIENTE DI CRESCITA: Boschi aperti, cedui, boscaglie, prati montani e radure, vallette<br />
umide e ombrose<br />
FASCIA ALTITUDINALE: 100-1900 m<br />
CATEGORIA DI TUTELA E MOTIVO D’INTERESSE Specie protetta dalla Legge Regionale<br />
n. 2 del 24 gennaio 1977, specie target cat IUCN – LC.<br />
2.3.2.9.2 Stato <strong>di</strong> conservazione<br />
Specie probabilmente estinta.<br />
2.3.2.9.3 Minacce<br />
• Raccolta a fini ornamentali.<br />
• Distruzione dei bulbi da parte dei cinghiali<br />
2.3.2.10 Pungitopo (Ruscus aculeatus L.)<br />
2.3.2.10.1 Dati generali<br />
FORMA BIOLOGICA: G bulb<br />
TIPO COROLOGICO: Eurasiatico<br />
AMBIENTE DI CRESCITA: Boschi aperti, cedui, boscaglie, prati montani e radure, vallette<br />
umide e ombrose<br />
FASCIA ALTITUDINALE: 100-1900 m<br />
CATEGORIA DI TUTELA E MOTIVO D’INTERESSE Specie protetta dalla Legge Regionale<br />
n. 2 del 24 gennaio 1977, specie target cat IUCN – LC.<br />
2.3.2.10.2 Stato <strong>di</strong> conservazione<br />
Specie abbastanza comune. Stato <strong>di</strong> conservazione generalmente buono.<br />
2.3.2.10.3 Minacce<br />
• Raccolta a fini ornamentali.<br />
• Distruzione dei bulbi da parte dei cinghiali<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 20<br />
2.3.2.11 Ofride dei fuchi (Ophrys fuciflora fuciflora (F.W. Schmidt) Moench)<br />
2.3.2.11.1 Dati generali<br />
FORMA BIOLOGICA: G bulb<br />
TIPO COROLOGICO: Eurime<strong>di</strong>terraneo<br />
AMBIENTE DI CRESCITA: Prati ari<strong>di</strong>, garighe, radure <strong>di</strong> querceti<br />
FASCIA ALTITUDINALE: 0-1000 m<br />
CATEGORIA DI TUTELA E MOTIVO D’INTERESSE Specie protetta dalla Legge Regionale<br />
n. 2 del 24 gennaio 1977, specie target cat IUCN – LC.<br />
2.3.2.11.2 Stato <strong>di</strong> conservazione<br />
Buono stato <strong>di</strong> conservazione delle popolazioni.<br />
2.3.2.11.3 Minacce<br />
Nessuna.<br />
2.3.2.12 Serapide lingua (Serapias lingua L.)<br />
2.3.2.12.1 Dati generali<br />
FORMA BIOLOGICA: G bulb<br />
TIPO COROLOGICO: Stenome<strong>di</strong>t.<br />
AMBIENTE DI CRESCITA: Prati e incolti umi<strong>di</strong>, calanchi<br />
FASCIA ALTITUDINALE: 0-600 m<br />
CATEGORIA DI TUTELA E MOTIVO D’INTERESSE Specie protetta dalla Legge Regionale<br />
n. 2 del 24 gennaio 1977, specie target cat IUCN – VU/B1a.<br />
2.3.2.12.2 Stato <strong>di</strong> conservazione<br />
Da verificare.<br />
2.3.2.12.3 Minacce<br />
Non sono noti fattori <strong>di</strong> minaccia<br />
2.3.2.13 Alaterno (Rhamnus alaternus L.)<br />
2.3.2.13.1 Dati generali<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 21<br />
FORMA BIOLOGICA: P caesp<br />
TIPO COROLOGICO: Stenome<strong>di</strong>t.<br />
AMBIENTE DI CRESCITA: margini <strong>di</strong> boschi termofili, rupi soleggiate, muri a secco<br />
FASCIA ALTITUDINALE: 0-500 m<br />
CATEGORIA DI TUTELA E MOTIVO D’INTERESSE Specie protetta dalla Legge Regionale<br />
n. 2 del 24 gennaio 1977, specie target, cat IUCN – VU/A1d<br />
2.3.2.13.2 Stato <strong>di</strong> conservazione<br />
Da verificare.<br />
2.3.2.13.3 Minacce<br />
Potenziale minaccia legata a gestioni forestali non attente alla presenza della specie.<br />
2.3.2.14 Tasso (Taxus baccata L.)<br />
2.3.2.14.1 Dati generali<br />
FORMA BIOLOGICA: P caesp<br />
TIPO COROLOGICO: Paleotemp.<br />
AMBIENTE DI CRESCITA: faggete e ambienti rupestri<br />
FASCIA ALTITUDINALE: 0-1500 m<br />
CATEGORIA DI TUTELA E MOTIVO D’INTERESSE Specie protetta dalla Legge Regionale<br />
n. 2 del 24 gennaio 1977, specie target, cat IUCN – LC<br />
2.3.2.14.2 Stato <strong>di</strong> conservazione<br />
Da verificare.<br />
2.3.2.14.3 Minacce<br />
Potenziale minaccia legata a gestioni forestali non attente alla presenza della specie.<br />
2.3.2.15 Mazzasorda (Typha latifolia L.)<br />
2.3.2.15.1 Dati Generali<br />
FORMA BIOLOGICA: G rhiz<br />
TIPO COROLOGICO: Cosmop.<br />
AMBIENTE DI CRESCITA: ambiti litoranei <strong>di</strong> corpi idrici lentici, habitat Pa<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 22<br />
FASCIA ALTITUDINALE: 0 – 2000<br />
CATEGORIA DI TUTELA E MOTIVO D’INTERESSE Lista Rossa idro-igrofila regionale, cat<br />
IUCN - LC<br />
2.3.2.15.2 Stato <strong>di</strong> conservazione<br />
Specie poco comune, presente solamente come bordura sulle sponde <strong>di</strong> un laghetto<br />
artificiale. Stato <strong>di</strong> conservazione generalmente buono, ma la cui stabilità è con<strong>di</strong>zionata<br />
dalla gestione degli apporti idrici.<br />
2.3.2.15.3 Minacce<br />
• Gestione/uso della risorsa acqua (prosciugamento delle pozze; ridotto o assente apporto<br />
idrico nel periodo estivo).<br />
• Ridotte <strong>di</strong>mensioni dell’habitat.<br />
• Assenza <strong>di</strong> interventi per impe<strong>di</strong>re il progressivo interramento del corpo d’acqua.<br />
2.4 Specie animali <strong>di</strong> interesse conservazionistico<br />
2.4.1 Specie <strong>di</strong> invertebrati <strong>di</strong> interesse comunitario<br />
Specie Callimorpha quadripunctaria (Poda, 1761)<br />
Sistematica Classe Insecta, Or<strong>di</strong>ne Lepidoptera, Famiglia Arctiidae<br />
Nome comune Falena dell’edera<br />
Livello <strong>di</strong> protezione Il taxon è riportato come specie prioritaria nell’Allegato II<br />
(specie <strong>di</strong> interesse comunitario che richiede la designazione<br />
<strong>di</strong> zone speciali <strong>di</strong> conservazione) della Direttiva Habitat<br />
92/43/CEE. Incluso tra le specie particolarmente protette in<br />
Emilia-Romagna ai sensi della Legge Regionale 15/2006<br />
“Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-<br />
Romagna”.<br />
Distribuzione Specie ad ampio areale <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione, è segnalata in tutta<br />
Europa, Asia minore, Russia, Caucaso, Siria e Iran.<br />
Habitat ed ecologia Il taxon pre<strong>di</strong>lige ambienti cal<strong>di</strong> e secchi, anche se mostra una<br />
certa propensione a frequentare i margini dei boschi e altri<br />
luoghi ombrosi. E’ specie monovoltina, con sfarfallamento degli<br />
adulti da luglio a settembre secondo la latitu<strong>di</strong>ne e la quota<br />
altimetrica. Le uova vengono deposte in folti gruppi <strong>di</strong> un solo<br />
strato sulla pagina inferiore delle foglie <strong>di</strong> svariate piante<br />
erbacee (ortiche, trifogli), arbustive (rovi) e arboree (salici,<br />
querce), in quanto le larve sono polifaghe. L’impupamento<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 23<br />
avviene generalmente nella bassa e rada vegetazione, e la<br />
crisalide è avvolta in una fine tela biancastra che forma una<br />
delicata reticella. Gli adulti visitano <strong>di</strong> preferenza le<br />
infiorescenze <strong>di</strong> Canapa acquatica (Eupatorium cannabinum).<br />
Distribuzione in Italia Distribuita in tutta Italia, dalla pianura alle zone montuose fino<br />
a circa 1500 m <strong>di</strong> altitu<strong>di</strong>ne.<br />
Stato <strong>di</strong> conservazione in Italia In generale, in Italia la specie non sembra essere<br />
Distribuzione e stato <strong>di</strong><br />
particolarmente minacciata, come succede invece in altre parti<br />
del suo areale. Il trend delle popolazioni è considerato stabile<br />
mentre il loro stato <strong>di</strong> conservazione è giu<strong>di</strong>cato “favorevole”<br />
dall’European Environmental Agency (2009).<br />
Segnalata nei <strong>di</strong>ntorni <strong>di</strong> Borgonuovo <strong>di</strong> Pontecchio. Non sono<br />
conservazione nel sito<br />
noti dati sul suo stato <strong>di</strong> conservazione all’interno del SIC.<br />
Fattori <strong>di</strong> minaccia E’ bene operare affinché venga limitato il rimboschimento<br />
(naturale o artificiale) <strong>di</strong> aree ove si alternino ampie praterie a<br />
vegetazione arbustiva con ra<strong>di</strong> alberelli. Anche i margini dei<br />
boschi, delle sterrate e dei sentieri (ecotoni), dove sono<br />
concentrate molto spesso piante erbacee con fiori ricchi <strong>di</strong><br />
nettare, vanno salvaguardati e non sottoposti a sfalci<br />
meccanici intensivi. Nel basso Appennino, dove la grande<br />
estensione <strong>di</strong> coltivi e aree urbanizzate ha frammentato gli<br />
ecosistemi, andrebbero creati dei corridoi ecologici per<br />
sopperire alla parcellizzazione sempre più significativa<br />
dell’habitat della specie.<br />
Specie Eriogaster catax (Linnaeus, 1758)<br />
Sistematica Classe Insecta, or<strong>di</strong>ne Lepidoptera, famiglia Lasiocampidae<br />
Nome comune Bombice del prugnolo<br />
Livello <strong>di</strong> protezione La specie è inclusa negli Allegati II e IV (specie <strong>di</strong> interesse<br />
comunitario che richiede la designazione <strong>di</strong> zone speciali <strong>di</strong><br />
conservazione e che necessita <strong>di</strong> una protezione rigorosa)<br />
della Direttiva Habitat 92/43/CEE. E’ riportata inoltre<br />
nell’Appen<strong>di</strong>ce II della Convenzione <strong>di</strong> Berna fra le specie<br />
strettamente protette. Inclusa tra le specie particolarmente<br />
protette della Legge Regionale 15/2006 “Disposizioni per la<br />
tutela della fauna minore in Emilia-Romagna”.<br />
Distribuzione La specie ha una gravitazione europea ed è <strong>di</strong>stribuita dalla<br />
Penisola iberica ai Balcani, con limite orientale costituito dalla<br />
foce del Danubio. Presente nella fascia compresa tra il 40° e il<br />
50° parallelo (Bertaccini et al., 1994).<br />
Habitat ed ecologia Distribuita dal piano basale fino a 1000 m circa, sembra<br />
pre<strong>di</strong>ligere i margini <strong>di</strong> aree boscate esposte a mezzogiorno.<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 24<br />
Specie monovoltina, con sfarfallamento tra la seconda metà <strong>di</strong><br />
ottobre e i primi <strong>di</strong> novembre. Gli adulti sono attivi nelle prime<br />
ore notturne; la femmina depone le uova in spirali molto strette<br />
sui rami delle piante ospiti, costituite principalmente dal<br />
prugnolo (Prunus spinosa) e più raramente dal biancospino<br />
(Crategus monogyna). La covata viene coperta da uno strato<br />
molto compatto <strong>di</strong> lanugine addominale che la femmina rilascia<br />
a scopo protettivo. In questo sta<strong>di</strong>o avviene infatti lo<br />
svernamento e, nella primavera successiva, la schiusa delle<br />
uova. Le larve ai primi sta<strong>di</strong> sono gregarie e vivono in un nido<br />
collettivo costituito da un ammasso sericeo da loro stesse<br />
secreto <strong>di</strong> colore bianco brillante. Una volta mature, esse<br />
<strong>di</strong>ventano solitarie e si spostano per completare lo sviluppo e<br />
ricercare un posto adatto per l’impupamento. La crisalide è<br />
avvolta in un bozzolo compatto e liscio al tatto, posto <strong>di</strong> solito<br />
sul substrato alla base della pianta ospite.<br />
Distribuzione in Italia Conosciuta per quasi tutte le regioni italiane ad eccezione <strong>di</strong><br />
Valle d’Aosta, Campania, Sicilia e Sardegna (Bertaccini et al.,<br />
1994). Nella nostra regione è <strong>di</strong>stribuita nel bolognese,<br />
modenese e soprattutto in Romagna, dove conta <strong>di</strong>verse<br />
stazioni concentrate in massima parte a quote collinari.<br />
Recentemente è stata rinvenuta anche nel parmense (Pizzetti,<br />
dati ine<strong>di</strong>ti).<br />
Stato <strong>di</strong> conservazione in Italia Il trend delle popolazioni italiane non è noto mentre il loro stato<br />
Distribuzione e stato <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong> conservazione è giu<strong>di</strong>cato “cattivo” nelle ecoregioni alpina e<br />
me<strong>di</strong>terranea mentre in quella continentale è riportato come<br />
“inadeguato”. (European Environmental Agency, 2009).<br />
Segnalata per il Monte Pradone. Non sono noti dati sul suo<br />
conservazione nel sito<br />
stato <strong>di</strong> conservazione all’interno del SIC.<br />
Fattori <strong>di</strong> minaccia Le cause in<strong>di</strong>viduate in letteratura sono legate a fattori<br />
antropici quali, ad esempio, la cura dei bor<strong>di</strong> forestali con<br />
l’eliminazione delle piante <strong>di</strong> prugnolo e l’uso <strong>di</strong> antiparassitari<br />
sugli alberi da frutto. In Europa centrale si è ipotizzato che la<br />
contrazione delle popolazioni <strong>di</strong> questa specie sia legata a<br />
mo<strong>di</strong>ficazioni <strong>di</strong> tipo climatico.<br />
Specie Cerambyx cerdo (Linnaeus, 1758)<br />
Sistematica Classe Insecta, Or<strong>di</strong>ne Coleoptera, Famiglia Cerambycidae<br />
Nome comune Cerambice della quercia, capricorno maggiore<br />
Livello <strong>di</strong> protezione Il taxon è inserito come specie prioritaria (specie <strong>di</strong> interesse<br />
comunitario che richiede la designazione <strong>di</strong> zone speciali <strong>di</strong><br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 25<br />
conservazione e che necessita <strong>di</strong> una protezione rigorosa)<br />
negli Allegati II e IV della Direttiva comunitaria Habitat<br />
92/43/CEE. E’ considerata specie minacciata e perciò<br />
segnalata come vulnerabile in Ruffo & Stoch (2005). Inoltre, il<br />
taxon è incluso nell’elenco delle specie particolarmente<br />
protette dell’Emilia-Romagna ai sensi della Legge Regionale<br />
15/2006 “Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-<br />
Romagna”.<br />
Distribuzione Ampio areale, comprendente Europa, Africa settentrionale,<br />
Asia minore, Caucaso e Iran.<br />
Habitat ed ecologia Vive in boschi maturi <strong>di</strong> quercia, ma frequenta anche parchi e<br />
filari <strong>di</strong> querce secolari o anche alberi isolati, purché vetusti,<br />
dalla pianura fino a 700-800 m <strong>di</strong> quota. La larva è xilofaga e<br />
vive nei tronchi <strong>di</strong> alberi vivi, generalmente <strong>di</strong> gran<strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>mensioni. Oltre alle querce, occasionalmente evolve su altre<br />
latifoglie arboree come castagno, carpino, salice, olmo e noce.<br />
La femmina depone le uova nelle screpolature della corteccia<br />
dell’albero ospite; le larve dapprima si nutrono della stessa<br />
corteccia e poi si approfondano nel legno, dove scavano<br />
gallerie ovali che possono raggiungere lo spessore <strong>di</strong> un<br />
pollice. Lo sviluppo larvale dura 3-5 anni. Le larve mature si<br />
impupano nel legno in autunno, e poco dopo sfarfallano gli<br />
adulti che però rimangono nella galleria per svernare,<br />
lasciando il proprio rifugio solo nel successivo mese <strong>di</strong> giugno.<br />
L’insetto adulto è in genere attivo dal crepuscolo a notte<br />
inoltrata e si ciba <strong>di</strong> frutta matura, linfa e foglie <strong>di</strong> quercia.<br />
Distribuzione in Italia Il taxon è <strong>di</strong>ffuso in tutta Italia ad eccezione della Valle d’Aosta.<br />
In Emilia-Romagna le segnalazioni della specie si fanno più<br />
rare nella porzione occidentale della regione. E’ specie molto<br />
vulnerabile e in forte rarefazione.<br />
Stato <strong>di</strong> conservazione in Italia Il trend delle popolazioni italiane é considerato stabile mentre il<br />
Distribuzione e stato <strong>di</strong><br />
loro stato <strong>di</strong> conservazione è giu<strong>di</strong>cato “favorevole”. (European<br />
Environmental Agency, 2009).<br />
Non sono noti dati precisi al riguardo.<br />
conservazione nel sito<br />
Fattori <strong>di</strong> minaccia Il cerambice della quercia è un insetto in<strong>di</strong>catore <strong>di</strong> boschi<br />
maturi, con presenza <strong>di</strong> piante secolari in buono stato <strong>di</strong> salute.<br />
I principali fattori <strong>di</strong> minaccia sono quin<strong>di</strong> legati alla <strong>di</strong>struzione<br />
dell’habitat boschivo in seguito a <strong>di</strong>sboscamento, ceduazione<br />
sconsiderata, incen<strong>di</strong>, abbattimento selettivo delle vecchie<br />
piante <strong>di</strong> quercia. Inoltre, in molte zone il taxon è attivamente<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 26<br />
combattuto perché considerato xilofago potenzialmente<br />
dannoso ai querceti.<br />
Specie <strong>Luca</strong>nus cervus (Linnaeus, 1758)<br />
Sistematica Classe Insecta, Or<strong>di</strong>ne Coleoptera, Famiglia <strong>Luca</strong>nidae<br />
Nome comune Cervo volante<br />
Livello <strong>di</strong> protezione Il taxon è inserito tra le specie <strong>di</strong> interesse comunitario che<br />
richiedono la designazione <strong>di</strong> zone speciali <strong>di</strong> conservazione<br />
(Allegato II della Direttiva Habitat 92/43/CEE). Incluso tra le<br />
specie particolarmente protette in Emilia-Romagna ai sensi<br />
della Legge Regionale 15/2006 “Disposizioni per la tutela della<br />
fauna minore in Emilia-Romagna”.<br />
Distribuzione Specie ad ampio areale <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione, è segnalata in tutta<br />
Europa, Asia Minore e Me<strong>di</strong>o Oriente.<br />
Habitat ed ecologia Vive nei boschi <strong>di</strong> latifoglie (querceti, castagneti, faggete),<br />
anche misti, dalla pianura fino a circa 1000 metri <strong>di</strong> altitu<strong>di</strong>ne.<br />
La larva, xilofaga, si sviluppa nel legno morto <strong>di</strong> ceppaie e <strong>di</strong><br />
alberi vetusti, con preferenza per le querce. Giunge a<br />
maturazione in 4-8 anni. In autunno la larva matura lascia il<br />
legno e si trasferisce al suolo; qui, impastando il terriccio con<br />
detriti <strong>di</strong> legno, costruisce una celletta ove poi si impuperà.<br />
All’inizio dell’estate sfarfallano gli adulti, i quali vivono poche<br />
settimane cibandosi <strong>di</strong> sostanze zuccherine (linfa e frutta<br />
matura). Essi si muovono in prevalenza al crepuscolo, con volo<br />
lento, goffo e rumoroso. I maschi utilizzano le lunghe e<br />
caratteristiche man<strong>di</strong>bole in veri e propri combattimenti per<br />
allontanare i rivali e conquistarsi la partner.<br />
Distribuzione in Italia In Italia il taxon è <strong>di</strong>stribuito dalle Alpi fino all’Umbria e alla<br />
Campania. In Emilia-Romagna la specie è <strong>di</strong>ffusa con una<br />
certa continuità nelle aree boschive a latifoglie dalla<br />
pedecollina alla me<strong>di</strong>a collina, mentre si fa rara nei boschi <strong>di</strong><br />
pianura e del litorale.<br />
Stato <strong>di</strong> conservazione in Italia E’ in fase <strong>di</strong> rarefazione nelle località <strong>di</strong> pianura e pedecollinari<br />
Distribuzione e stato <strong>di</strong><br />
dell’Italia settentrionale. Lo stato <strong>di</strong> conservazione delle<br />
popolazioni italiane è giu<strong>di</strong>cato “cattivo” dall’European<br />
Environmental Agency (2009).<br />
Non sono noti dati precisi al riguardo.<br />
conservazione nel sito<br />
Fattori <strong>di</strong> minaccia I principali fattori <strong>di</strong> minaccia risiedono nella <strong>di</strong>struzione<br />
dell’habitat boschivo causata da <strong>di</strong>sboscamenti <strong>di</strong>ssennati,<br />
urbanizzazione eccessiva, incen<strong>di</strong>, o da un uso poco accorto<br />
del bosco, con ceduazione eccessiva, abbattimenti selettivi<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 27<br />
delle piante più vetuste e rimozione del legno morto al suolo.<br />
Specie Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)<br />
Sistematica Subphylum Crustacea, Classe Malacostraca, Or<strong>di</strong>ne<br />
Decapoda, Famiglia Astacidae<br />
Nome comune Gambero <strong>di</strong> fiume<br />
Livello <strong>di</strong> protezione Il taxon è inserito tra le specie <strong>di</strong> interesse comunitario<br />
che richiedono la designazione <strong>di</strong> zone speciali <strong>di</strong><br />
conservazione (Allegato II della Direttiva Habitat<br />
92/43/CEE). Incluso tra le specie particolarmente protette<br />
in Emilia-Romagna ai sensi della Legge Regionale<br />
15/2006 “Disposizioni per la tutela della fauna minore in<br />
Emilia-Romagna”.<br />
Distribuzione Specie ad ampio areale <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione, è segnalata in<br />
tutta Spagna, Francia, Svizzera, Italia e gli stati della<br />
Penisola Balcanica affacciati sul Mar Adriatico. Sul<br />
versante nord-atlantico si trova in Irlanda e nelle isole del<br />
Regno Unito.<br />
Habitat ed ecologia Ama le acque limpide, correnti, fresche, ben ossigenate e<br />
<strong>di</strong> buona qualità, con fondo <strong>di</strong> roccia, ghiaia e sabbia.<br />
Generalmente in Italia si trova fino agli 800 m s.l.m. e<br />
talvolta fino a 1200 m quando le con<strong>di</strong>zioni termiche lo<br />
consentono. La maturità sessuale viene raggiunta la<br />
terza quarta estate <strong>di</strong> vita, l’accoppiamento avviene in<br />
autunno nei mesi <strong>di</strong> ottobre e novembre e generalmente<br />
quando la temperatura dell’acqua è intorno ai 10° C . Il<br />
maschio depone le spermatofore sotto l’addome della<br />
femmina e dopo circa una settimana vengono emesse le<br />
uova dalle papille genitali e fecondate dalle spermatofore.<br />
Per tutto l’inverno e la primavera queste vengono ben<br />
ossigenate e pulite da eventuali detriti. La schiusa delle<br />
uova avviene dopo 4-7 mesi.<br />
Distribuzione in Italia In Italia il taxon è <strong>di</strong>stribuito dalle Alpi fino alla Campania.<br />
In Lombar<strong>di</strong>a, Piemonte, Toscana e centro Italia è<br />
<strong>di</strong>stribuita con una certa continuità.<br />
Stato <strong>di</strong> conservazione in Italia La specie è considerata vulnerabile in base ai criteri dalla<br />
Distribuzione e stato <strong>di</strong><br />
conservazione nel sito<br />
IUCN list ed in molte zone non è più stata rintracciata.<br />
L’areale e le popolazioni stesse sono frammentati e ciò<br />
potrebbe portare ad un indebolimento genetico e ad una<br />
rapida estinzione sul nostro territorio.<br />
I dati a <strong>di</strong>sposizione sono insufficienti e si hanno pertanto<br />
scarse conoscenze al riguardo.<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 28<br />
Fattori <strong>di</strong> minaccia I principali fattori <strong>di</strong> minaccia risiedono nel frazionamento<br />
dell’areale a seguito della realizzazione <strong>di</strong> sbarramenti e<br />
interventi nei corsi d’acqua, nell’introduzione <strong>di</strong> specie<br />
alloctone che causano gravi danni (ad es. Procambarus<br />
clarkii), sia per la competizione delle risorse che per<br />
eventuale <strong>di</strong>ffusione <strong>di</strong> malattie, e nell’alterazione delle<br />
con<strong>di</strong>zioni ecologiche degli habitat.<br />
2.4.2 Altre specie <strong>di</strong> invertebrati <strong>di</strong> interesse conservazionistico<br />
Specie Retinella olivetorum (Gmelin, 1791)<br />
Sistematica Mollusca: Zonitidae<br />
Nome comune -<br />
Livello <strong>di</strong> protezione Considerata tra le specie target del PSR 2007-2013 in quanto<br />
endemita italiano. Anche la Regione Toscana ha inserito la<br />
specie nell’Allegato A alla LR 56/2000 quale “specie animale <strong>di</strong><br />
interesse regionale, la cui conservazione può richiedere la<br />
designazione <strong>di</strong> Siti <strong>di</strong> Interesse Regionale (S.I.R.). E’ una<br />
specie non classificata dall’“IUCN Red List of Threatened<br />
Species”.<br />
Distribuzione La specie è <strong>di</strong>stribuita esclusivamente in Italia.<br />
Habitat ed ecologia La specie frequenta aree collinari con boschi <strong>di</strong> latifoglie<br />
termofile e castagneti. Vive nella lettiera e tra i detriti vegetali<br />
(Cianfanelli, 2009).<br />
Distribuzione in Italia Specie a <strong>di</strong>ffusione appenninica estesa fino all’area prealpina;<br />
Stato <strong>di</strong> conservazione in Italia<br />
presente anche in Sicilia nord-occidentale (Cianfanelli, 2009)<br />
Non noto.<br />
Distribuzione e stato <strong>di</strong> La specie vive nelle aree boscate del sito. La popolazione pare<br />
conservazione nel sito<br />
abbondante.<br />
Fattori <strong>di</strong> minaccia La specie necessita del buono stato <strong>di</strong> conservazione degli<br />
habitat boscati.<br />
Specie Maculinea arion (Linnaeus, 1758)<br />
Sistematica Classe Insecta, or<strong>di</strong>ne Lepidoptera, famiglia Lycaenidae<br />
Nome comune Licena azzurra del timo<br />
Livello <strong>di</strong> protezione La specie è inclusa nell’Allegato IV (specie <strong>di</strong> interesse<br />
comunitario che richiedono una particolare protezione) della<br />
Direttiva Habitat 92/43/CEE. E’ inclusa anche nell’Appen<strong>di</strong>ce II<br />
della Convenzione <strong>di</strong> Berna (specie strettamente protetta).<br />
Valutata con la sigla NT (prossima ad essere minacciata)<br />
nell’ambito della categoria LR (specie a basso rischio) dalla<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 29<br />
IUCN. Valutata come in pericolo e ritenuta specie<br />
bioin<strong>di</strong>catrice nella Checklist della Fauna italiana (Balletto &<br />
Cassulo, 1995). Inclusa tra le specie particolarmente protette<br />
nella Legge Regionale 15/2006 “Disposizioni per la tutela della<br />
fauna minore in Emilia-Romagna”.<br />
Distribuzione La specie ha una gravitazione asiatico-europea ed è <strong>di</strong>ffusa<br />
dalla Spagna al Giappone; estinta in Inghilterra e assente dalle<br />
isole me<strong>di</strong>terranee ad eccezione della Corsica.<br />
Habitat ed ecologia Specie legata ad ambienti xerici sia prativi sia arbustivi, dal<br />
piano basale ai 2000 m circa, più comune nella fascia collinare<br />
e <strong>di</strong> me<strong>di</strong>a montagna compresa tra i 200 e i 900 m. Presenta<br />
una sola generazione annuale con sfarfallamento degli adulti in<br />
giugno-luglio. Le larve evolvono principalmente a spese <strong>di</strong><br />
Thymus serpillum ed Origanum vulgare (Villa et. al., 2009).<br />
Esse si nutrono degli organi interni del fiore e, dopo la terza ed<br />
ultima muta, si lasciano cadere al suolo. Qui avviene un<br />
passaggio comune a <strong>di</strong>verse specie <strong>di</strong> liceni<strong>di</strong>, ma che nel<br />
genere Maculinea assume una valenza fondamentale:<br />
l’adozione delle larve da parte delle formiche. I bruchi infatti<br />
secernono un liquido prodotto da una particolare ghiandola<br />
posta nella regione anale che attira le formiche del genere<br />
Myrmica, in particolare M. sabuleti. Queste riconoscono nella<br />
larva <strong>di</strong> M. arion quella <strong>di</strong> una consimile e provvedono a<br />
trasportarla nel formicaio. Qui il bruco completa il suo sviluppo<br />
nutrendosi <strong>di</strong> uova, larve e ninfe delle formiche. In un nido <strong>di</strong><br />
Myrmica può essere presente una sola larva <strong>di</strong> Licena azzurra<br />
del Timo la quale, per la sua sopravvivenza, necessita <strong>di</strong> un<br />
formicaio <strong>di</strong> una certa grandezza, composto da almeno 350<br />
operaie. Anche se queste particolari esigenze sono<br />
pienamente sod<strong>di</strong>sfatte, solo 1 larva su 5 <strong>di</strong> M. arion<br />
raggiungerà lo sta<strong>di</strong>o adulto (AA. VV., 2009).<br />
Distribuzione in Italia Presente in tutta Italia ad eccezione delle isole. Per quanto<br />
riguarda l’Emilia-Romagna è conosciuta per tutte le province<br />
ad eccezione <strong>di</strong> quelle <strong>di</strong> Rimini e Ferrara (Villa et. al., 2009)<br />
Stato <strong>di</strong> conservazione in Italia Il trend delle popolazioni italiane non è noto mentre il loro stato<br />
Distribuzione e stato <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong> conservazione è giu<strong>di</strong>cato “cattivo” dall’European<br />
Environmental Agency (2009).<br />
Non sono noti dati precisi al riguardo.<br />
conservazione nel sito<br />
Fattori <strong>di</strong> minaccia I fattori <strong>di</strong> minaccia riportati in letteratura sono riconducibili<br />
principalmente alla mutazione e all’intensificazione delle<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 30<br />
tecniche agricole: conversione degli incolti in seminativi e<br />
l’abbandono delle pratiche agro-pastorali tra<strong>di</strong>zionali come la<br />
raccolta del fieno o il pascolo non intensivo. Questo fa sì che<br />
in queste aree, una volta abbandonate, si instaurino con<strong>di</strong>zioni<br />
svantaggiose per le esigenze della Licena azzurra del Timo.<br />
La frammentazione degli habitat idonei è causa<br />
dell’isolamento delle popolazioni con conseguente aumento<br />
del loro grado <strong>di</strong> vulnerabilità. Un’altra minaccia è data dal<br />
rimboschimento: una pratica che provoca la chiusura degli<br />
ambienti <strong>di</strong> volo <strong>di</strong> Maculinea arion. Tutti questi fattori possono<br />
arrecare gravi danni alle popolazioni <strong>di</strong> questo interessante<br />
licenide, che molto spesso colonizza habitat alquanto ristretti.<br />
Specie Proserpinus proserpina (Pallas, 1772)<br />
Sistematica Classe Insecta, or<strong>di</strong>ne Lepidoptera, famiglia Sphingidae<br />
Nome comune Proserpina<br />
Livello <strong>di</strong> protezione La specie è inclusa nell’Allegato IV (specie <strong>di</strong> interesse<br />
comunitario che richiede una protezione rigorosa) della<br />
Direttiva Habitat 92/43/CEE E’ riportata anche nell’Appen<strong>di</strong>ce<br />
II della Convenzione <strong>di</strong> Berna (specie strettamente protetta).<br />
Inclusa tra le specie particolarmente protette nella Legge<br />
Regionale 15/2006 “Disposizioni per la tutela della fauna<br />
minore in Emilia-Romagna”.<br />
Distribuzione Il taxon è <strong>di</strong>stribuito dal Maghreb, attraverso tutta l’Europa<br />
centromeri<strong>di</strong>onale fino in Turkestan (Bertaccini et. al., 1994).<br />
Habitat ed ecologia Preferisce ambienti <strong>di</strong> <strong>di</strong>versa tipologia purché xerici e ben<br />
esposti, quali boschi ra<strong>di</strong>, margini forestali, greti <strong>di</strong> torrenti in<br />
secca e così via, dalla pianura ai 1200 m circa, più comune<br />
alle basse altitu<strong>di</strong>ni. Presenta una sola generazione annua con<br />
sfarfallamento degli adulti in maggio-giugno. Come molte altre<br />
specie <strong>di</strong> sfingi<strong>di</strong>, la Proserpina vola <strong>di</strong> preferenza al<br />
crepuscolo. Le uova vengono deposte singolarmente o a<br />
coppie sulla faccia inferiore delle foglie delle piante ospiti,<br />
costituite principalmente da specie appartenenti al genere<br />
Epilobium, ma anche Lythrum salicaria, Oenothera biennisi e<br />
O. stucchii.<br />
Distribuzione in Italia In Italia è <strong>di</strong>stribuita in modo frammentario in tutte le regioni<br />
comprese Sicilia ed Elba, manca in Sardegna.<br />
Stato <strong>di</strong> conservazione in Italia Il trend delle popolazioni italiane non è noto mentre il loro stato<br />
<strong>di</strong> conservazione è giu<strong>di</strong>cato “cattivo” dall’European<br />
Environmental Agency (2009).<br />
Distribuzione e stato <strong>di</strong> Dintorni <strong>di</strong> Paderno. Non sono noti dati precisi sul suo stato <strong>di</strong><br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 31<br />
conservazione nel sito conservazione all’interno del SIC.<br />
Fattori <strong>di</strong> minaccia Le cause in<strong>di</strong>viduate in letteratura sono legate al<br />
rimboschimento e, soprattutto nelle zone situate a bassa<br />
quota, alla trasformazione <strong>di</strong> incolti in seminativi o al loro<br />
inurbamento.<br />
Specie Hyles hippophaes (Esper, 1793)<br />
Sistematica Classe Insecta, or<strong>di</strong>ne Lepidoptera, famiglia Sphingidae<br />
Nome comune Sfinge dell’Olivella spinosa<br />
Livello <strong>di</strong> protezione La specie è inclusa nell’Allegato IV (specie <strong>di</strong> interesse<br />
comunitario che richiede una protezione rigorosa) della<br />
Direttiva Habitat 92/43/CEE. E’ riportata anche nell’Appen<strong>di</strong>ce<br />
II della Convenzione <strong>di</strong> Berna (specie strettamente protetta).<br />
Inclusa tra le specie particolarmente protette della Legge<br />
Regionale 15/2006 “Disposizioni per la tutela della fauna<br />
minore in Emilia-Romagna”.<br />
Distribuzione E’ una specie a gravitazione Centroasiatica-europea.<br />
Distribuita in modo frammentario dal sud della Spagna<br />
attraverso la Francia, l’Europa centro-meri<strong>di</strong>onale, l’Asia<br />
minore e quella centrale (Bertaccini et. al., 1994).<br />
Habitat ed ecologia Specie termofila strettamente legata all’olivella spinosa<br />
(Hippophae rhamnoides), un arbusto alto fino a 2 m<br />
appartenente alla famiglia delle Eleagnacee. Essa è quin<strong>di</strong><br />
presente solo nelle aree dove prospera la sua pianta nutrice,<br />
quali le rive e i greti dei torrenti, <strong>di</strong> solito a bassa altitu<strong>di</strong>ne.<br />
Questo sfingide compie due generazioni annue con<br />
sfarfallamento degli adulti in maggio-giugno e agosto-<br />
settembre. Le larve sono alquanto mimetiche, risultando <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>fficile osservazione all’interno del fogliame. Esse hanno infatti<br />
una colorazione verde con una striscia laterale bianca e la<br />
parte terminale, in corrispondenza del tipico cornetto delle<br />
sfingi, <strong>di</strong> un bel giallo-arancio, come le drupe dell’olivella.<br />
Distribuzione in Italia Conosciuta per alcune regioni dell’Italia settentrionale e<br />
centrale: Valle d’Aosta, Piemonte, Trentino, Alto A<strong>di</strong>ge, Friuli,<br />
Emilia-Romagna e Toscana (Parenzan & Porcelli, 2006). Nella<br />
nostra regione è alquanto localizzata ed è nota per poche<br />
località situate nel parmense, nel bolognese e in Romagna.<br />
Stato <strong>di</strong> conservazione in Italia Il trend delle popolazioni italiane non è noto mentre il loro stato<br />
<strong>di</strong> conservazione è giu<strong>di</strong>cato “cattivo” nell’ecoregione alpina e<br />
“sconosciuto” in quella continentale. (European Environmental<br />
Agency, 2009).<br />
Distribuzione e stato <strong>di</strong> Segnalata lungo il Reno nei <strong>di</strong>ntorni <strong>di</strong> Casalecchio. Non sono<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 32<br />
conservazione nel sito noti dati relativi al suo stato <strong>di</strong> conservazione all’interno del<br />
SIC.<br />
Fattori <strong>di</strong> minaccia I fattori <strong>di</strong> minaccia riportati in letteratura sono essenzialmente<br />
<strong>di</strong> natura antropica, come ad esempio la sistemazione idraulica<br />
dei corsi d’acqua, soprattutto delle rive, sulle quali cresce<br />
abbondante la sua pianta nutrice. Da non sottovalutare<br />
l’impatto che hanno, sull’habitat <strong>di</strong> questo sfingide, la<br />
captazione delle acque e le escavazioni <strong>di</strong> ghiaia dai greti: due<br />
attività che contribuiscono in modo significativo all’alterazione<br />
del corso dei fiumi. Per il suo inse<strong>di</strong>amento, infatti, l’olivella<br />
spinosa necessita <strong>di</strong> una buona stabilità del substrato.<br />
Specie Cicindela majalis Mandl, 1935<br />
Sistematica Classe Insecta, Or<strong>di</strong>ne Coleoptera, Famiglia Cicindelidae<br />
Nome comune Cicindela <strong>di</strong> maggio<br />
Livello <strong>di</strong> protezione Inclusa tra le specie particolarmente protette nella Legge<br />
Regionale n. 15/2006 “Disposizioni per la tutela della fauna<br />
minore in Emilia-Romagna”.<br />
Distribuzione Endemismo italico <strong>di</strong>stribuito in modo frammentario dalla riva<br />
destra del Po fino alla Calabria.<br />
Habitat ed ecologia Strettamente legata ai depositi e ai banchi sabbiosi ripariali <strong>di</strong><br />
torrenti e fiumi, in ambienti aperti e soleggiati, dalla pianura alla<br />
me<strong>di</strong>a collina. E’ una specie predatrice sia allo sta<strong>di</strong>o larvale<br />
che da adulta ed è situata al vertice della catena alimentare<br />
della comunità <strong>di</strong> macroinvertebrati dei greti fluviali. Gli adulti<br />
compaiono tra aprile e agosto e sono attivi nelle ore più calde<br />
della giornata, dove sono facilmente osservabili mentre<br />
cacciano attivamente altri artropo<strong>di</strong> spiccando brevi e rapi<strong>di</strong><br />
voli o rincorrendoli velocemente al suolo. Le larve cacciano<br />
all’agguato, appostandosi in un tunnel verticale scavato dove i<br />
depositi sabbiosi sono maggiormente compatti.<br />
Distribuzione in Italia Presente dall’Emilia-Romagna alla Calabria. La nostra regione<br />
costituisce il limite settentrionale dell’areale <strong>di</strong> questa specie,<br />
dove è nota per tutte le province, tranne quella <strong>di</strong> Ferrara.<br />
Stato <strong>di</strong> conservazione in Italia Specie fortemente minacciata in quanto molto esigente dal<br />
punto <strong>di</strong> vista ecologico. È estremamente sensibile ad ogni<br />
minima variazione ambientale e, per questo motivo, è da<br />
considerarsi come un valido bioin<strong>di</strong>catore. Un tempo era<br />
frequente in buona parte dell’areale italiano a sud del Po;<br />
attualmente è <strong>di</strong>venuta più rara e localizzata, inoltre risulta<br />
scomparsa da <strong>di</strong>verse stazioni storiche. Le popolazioni<br />
inse<strong>di</strong>ate lungo i corsi d’acqua emiliani sono numericamente<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 33<br />
Distribuzione e stato <strong>di</strong><br />
corpose e sembrano godere <strong>di</strong> un migliore stato <strong>di</strong> salute<br />
rispetto al quadro nazionale.<br />
Non sono noti dati precisi al riguardo.<br />
conservazione nel sito<br />
Fattori <strong>di</strong> minaccia La specie rischia l’estinzione da numerose località per la<br />
scomparsa degli ambienti idonei a causa delle manomissioni<br />
degli alvei fluviali, dovute in massima parte ai prelievi <strong>di</strong> ghiaia<br />
e sabbia. Di forte impatto sulle popolazioni è il <strong>di</strong>sturbo dovuto<br />
al turismo: passaggio con moto da cross, quad o fuoristrada<br />
lungo le rive dei fiumi e il notevole afflusso <strong>di</strong> bagnanti sui greti<br />
nel periodo estivo.<br />
Specie Stomis bucciarellii Pesarini, 1979<br />
Sistematica Classe Insecta, Or<strong>di</strong>ne Coleoptera, Famiglia Carabidae<br />
Nome comune Pterostico <strong>di</strong> Bucciarelli<br />
Livello <strong>di</strong> protezione Inclusa tra le specie particolarmente protette nella Legge<br />
Regionale 15/2006 “Disposizioni per la tutela della fauna<br />
minore in Emilia-Romagna”.<br />
Distribuzione Endemismo nord appenninico presente in Emilia-Romagna e<br />
in Lombar<strong>di</strong>a (Oltrepò pavese).<br />
Habitat ed ecologia Specie che frequenta principalmente gli ambienti calanchivi<br />
argillosi <strong>di</strong> bassa altitu<strong>di</strong>ne nei quali permangono con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong><br />
umi<strong>di</strong>tà per un certo periodo dell’anno. Ciclo biologico poco<br />
conosciuto. È specie strettamente igrofila, legata oltre che ai<br />
calanchi, anche a boschi e palu<strong>di</strong> con substrato argilloso. Vive<br />
infossato tra le crepe e le fessurazioni del substrato. È un<br />
predatore generalista sia da adulto che da larva, caccia<br />
invertebrati nel terreno ed ha attività notturna. Il periodo in cui<br />
è possibile ritrovare gli adulti va da inizio primavera<br />
all’autunno, con una probabile <strong>di</strong>apausa estiva nei mesi più<br />
cal<strong>di</strong>.<br />
Distribuzione in Italia Noto per lo più dell’Emilia-Romagna, dove è segnalato per i<br />
calanchi argillosi del basso Appennino limitatamente alle<br />
province <strong>di</strong> Piacenza, Parma, Modena, <strong>Bologna</strong> e Ravenna.<br />
Sono inoltre note due località nell’Oltrepò pavese.<br />
Stato <strong>di</strong> conservazione in Italia Specie endemica, rara e molto localizzata, in<strong>di</strong>catrice <strong>di</strong><br />
Distribuzione e stato <strong>di</strong><br />
ambienti non antropizzati a libera evoluzione, come sono<br />
appunto i calanchi.<br />
Non sono noti dati precisi al riguardo.<br />
conservazione nel sito<br />
Fattori <strong>di</strong> minaccia Le principali minacce derivano dal degrado degli ambienti<br />
idonei alla sua sopravvivenza, a causa della loro conversione<br />
in seminativi. Anche se le attività agricole non riguardano<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 34<br />
strettamente i calanchi, le coltivazioni intensive, che molto<br />
spesso li circondano, influiscono in modo alquanto negativo<br />
sulle comunità entomologiche presenti. Altre minacce sono<br />
date dall’utilizzo del piro<strong>di</strong>serbo, dall’esbosco o dalla<br />
ceduazione dei boschetti preappennici, dai rimboschimenti <strong>di</strong><br />
conifere e dall’azione <strong>di</strong> scavo operata dai cinghiali.<br />
Specie Elater ferrugineus Linnaeus, 1758<br />
Sistematica Classe Insecta, Or<strong>di</strong>ne Coleoptera, Famiglia Elateridae<br />
Nome comune Ferretto arancio<br />
Livello <strong>di</strong> protezione Inclusa tra le specie particolarmente protette nella Legge<br />
Regionale 15/2006 “Disposizioni per la tutela della fauna<br />
minore in Emilia-Romagna”.<br />
Distribuzione Specie a gravitazione europeo-me<strong>di</strong>terranea.<br />
Habitat ed ecologia Vive all’interno dei tronchi cavi e cariati <strong>di</strong> alberi vetusti in<br />
boschi <strong>di</strong> latifoglie e anche nei parchi citta<strong>di</strong>ni. Distribuito dalla<br />
pianura alla me<strong>di</strong>a montagna, con limite altitu<strong>di</strong>nale intorno agli<br />
800 m. Le larve vivono nel legno e sono predatrici degli sta<strong>di</strong><br />
preimmaginali <strong>di</strong> altri Coleotteri, soprattutto dei grossi Cetoni<strong>di</strong><br />
che si nutrono del legno marcescente. Gli adulti, attivi in<br />
giugno-agosto, volano al crepuscolo e sono attirati dalle<br />
sostanze zuccherine.<br />
Distribuzione in Italia Presente nelle regioni del nord e in Toscana, Marche, Lazio,<br />
Basilicata e Calabria. In Emilia-Romagna il Ferretto arancio è<br />
Stato <strong>di</strong> conservazione in Italia<br />
segnalato in tutte le province tranne quella <strong>di</strong> Modena.<br />
E’ specie vulnerabile e in rarefazione.<br />
Distribuzione e stato <strong>di</strong> Non sono noti dati precisi al riguardo.<br />
conservazione nel sito<br />
Fattori <strong>di</strong> minaccia Le principali minacce derivano dal taglio e rimozione dei vecchi<br />
alberi cariati presenti in alberature, parchi e boschi, nonché dei<br />
salici e dei pioppi capitozzati che si trovano nelle campagne<br />
lungo i filari delle viti.<br />
Specie Iolana iolas<br />
Sistematica Classe Insecta, or<strong>di</strong>ne Lepidoptera, famiglia Lycaenidae<br />
Nome comune Licena azzurra della Vescicaria<br />
Livello <strong>di</strong> protezione Considerata NT (near to threatened) nell’European red list<br />
(Van Swaay et al., 2010). E’ fra le specie <strong>di</strong> interesse<br />
conservazionistico poste sotto osservazione in Emilia-<br />
Romagna e per questo motivo è stata inclusa nel PSR 2007-<br />
2013.<br />
Distribuzione Presente in Marocco, Algeria, Spagna, Europa centro-<br />
meri<strong>di</strong>onale, Turchia e Iran (Tolman, 1997)<br />
Habitat ed ecologia Legata ad ambienti cal<strong>di</strong> e ricchi <strong>di</strong> arbusti dal piano basale<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 35<br />
fino ai 900 m circa. Una sola generazione annua con<br />
sfarfallamento degli adulti nel mese <strong>di</strong> giugno. Le femmine<br />
depongono le uova all’interno dei calici fiorali o sui baccelli<br />
della Vescicaria (Colutea arborescens), una leguminosa<br />
arbustiva tipica del bacino del Me<strong>di</strong>terraneo. Le larve si<br />
nutrono esclusivamente dei semi ancora ver<strong>di</strong> e la loro<br />
presenza sulla pianta ospite può essere in<strong>di</strong>viduata<br />
osservando i baccelli in trasparenza, rilevando così la<br />
presenza degli escrementi. I maschi hanno un volo vigoroso e<br />
rettilineo ed entrambi i sessi si fermano sovente a suggere<br />
nettare sui fiori della Vescicaria o a trarre sali minerali dal<br />
terreno umido.<br />
Distribuzione in Italia Presente in tutta Italia ad esclusione delle isole. In Emilia-<br />
Romagna è conosciuta per quasi tutte le province fatta<br />
eccezione per quelle <strong>di</strong> Reggio Emilia, Ferrara e Rimini (Villa<br />
Stato <strong>di</strong> conservazione in Italia<br />
et al., 2009).<br />
Non vi sono dati sullo stato <strong>di</strong> conservazione.<br />
Distribuzione e stato <strong>di</strong> Non sono noti dati precisi al riguardo.<br />
conservazione nel sito<br />
Fattori <strong>di</strong> minaccia Le cause riportate in letteratura sono legate principalmente<br />
alla conversione <strong>di</strong> aree incolte in seminativi e alla chiusura<br />
degli ambienti <strong>di</strong> volo dovuta all’espansione delle aree<br />
boscate. Visto i luoghi ari<strong>di</strong> in cui prospera la Vescicaria, non<br />
va sottovalutata l’azione nefasta degli incen<strong>di</strong>.<br />
Specie Hydrophilus piceus (Linnaeus, 1758)<br />
Sistematica Classe Insecta, Or<strong>di</strong>ne Coleoptera, Famiglia Hydrophilidae<br />
Nome comune Grande Idrofilo<br />
Livello <strong>di</strong> protezione E’ fra le specie <strong>di</strong> interesse conservazionistico poste sotto<br />
osservazione in Emilia-Romagna e per questo motivo è stata<br />
inclusa nel PSR 2007-2013.<br />
Distribuzione Elemento Asiatico-Europeo.<br />
Habitat ed ecologia Gran<strong>di</strong> stagni, palu<strong>di</strong> e fossati, con ricca vegetazione acquatica<br />
e detrito vegetale. Diffuso soprattutto in pianura, ma è stato<br />
rinvenuto anche a quote più elevate. Bioin<strong>di</strong>catore. Gli adulti<br />
sono tra i più gran<strong>di</strong> coleotteri acquatici paleartici. Buoni<br />
nuotatori, vivono sommersi portandosi appresso una bolla<br />
d’aria che conferisce un tipico aspetto “argentato” alla parte<br />
ventrale, quando l’insetto è in immersione, e che funge da<br />
branchia fisica per gli scambi gassosi sott’acqua. L’aria viene<br />
rinnovata perio<strong>di</strong>camente “bucando” il menisco della superficie<br />
con una antenna, dotata <strong>di</strong> una speciale pubescenza. Sono<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 36<br />
fitofagi e detritivori. Le larve deambulano sul fondo o tra la<br />
vegetazione sommersa e predano attivamente gasteropo<strong>di</strong><br />
d’acqua dolce, iniettando nel loro corpo i liqui<strong>di</strong> <strong>di</strong>gestivi,<br />
attraverso le forti man<strong>di</strong>bole canalicolate: un’operazione che<br />
viene svolta in emersione. Gli adulti sono attivi dalla primavera<br />
all’autunno e svernano in acqua. Le femmine depongono le<br />
uova in primavera, racchiuse in un particolare bozzolo <strong>di</strong> seta<br />
galleggiante e sormontato da un tubicino a mo’ <strong>di</strong> sifone. Le<br />
larve vanno incontro a tre mute e si impupano nel terreno<br />
umido, fuori dall’acqua. Gli adulti sfarfallano in primavera e si<br />
<strong>di</strong>sperdono in volo alla ricerca <strong>di</strong> altri ambienti da colonizzare.<br />
Distribuzione in Italia Specie nota in gran parte delle regioni italiane; più comune e<br />
<strong>di</strong>ffusa al centro-nord del nostro Paese. Manca in Sardegna e<br />
– pare – in Liguria, dove è presente l’affine H. pistaceus<br />
Laporte, 1840. In Emilia-Romagna è noto per <strong>di</strong>verse province<br />
anche se la maggior parte delle stazioni sono concentrate in<br />
Romagna e nel ferrarese.<br />
Stato <strong>di</strong> conservazione in Italia Una volta molto comune, attualmente è in drammatico declino<br />
Distribuzione e stato <strong>di</strong><br />
per l’alterazione o la <strong>di</strong>struzione degli ambienti palustri a cui è<br />
legato. Purtroppo a tutt’oggi scarseggiano stime effettive per<br />
quantificare la portata <strong>di</strong> questo trend negativo.<br />
Non sono noti dati precisi al riguardo.<br />
conservazione nel sito<br />
Fattori <strong>di</strong> minaccia Questa specie soffre del degrado e della <strong>di</strong>struzione degli<br />
ambienti palustri perpetrato, soprattutto in pianura, dall’azione<br />
dell’uomo. Agricoltura e allevamento intensivi sono infatti tra le<br />
principali cause <strong>di</strong> inquinamento delle aree umide. Da non<br />
sottovalutare il forte impatto ambientale causato<br />
dall’immissione <strong>di</strong> specie alloctone, come ad esempio il<br />
Gambero rosso della Louisiana, la cui voracità ha messo in<br />
crisi la fauna invertebratologica <strong>di</strong> interi biotopi. Anche gli<br />
stress idrici dovuti ai cambiamenti climatici in atto o<br />
all’eccessiva captazione delle acque per usi agricoli ed<br />
industriali, incidono negativamente sulle popolazioni <strong>di</strong> questo<br />
insetto.<br />
Specie Nebria psammodes (P.Rossi, 1792)<br />
Sistematica Classe Insecta, Or<strong>di</strong>ne Coleoptera, Famiglia Carabidae<br />
Nome comune Nebria delle sabbie.<br />
Livello <strong>di</strong> protezione E’ fra le specie <strong>di</strong> interesse conservazionistico poste sotto<br />
osservazione in Emilia-Romagna e per questo motivo è stata<br />
inclusa nel PSR 2007-2013.<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 37<br />
Distribuzione Specie sud-europea, con areale limitato alla Francia<br />
meri<strong>di</strong>onale, Italia continentale e Sicilia<br />
Habitat ed ecologia Elemento ripicolo, frequenta le rive sabbiose e ghiaiose <strong>di</strong><br />
torrenti e fiumi dal piano basale alla bassa montagna. Igrofilo;<br />
vive tra la ghiaia e la sabbia presso l’acqua, dove caccia<br />
attivamente piccoli invertebrati, che rappresentano la <strong>di</strong>eta sia<br />
dell’adulto che della larva.<br />
Distribuzione in Italia Segnalata in quasi tutte le regioni italiane<br />
Stato <strong>di</strong> conservazione in Italia Specie <strong>di</strong>ffusa e in passato piuttosto comune, attualmente<br />
Distribuzione e stato <strong>di</strong><br />
risulta in forte rarefazione in buona parte del suo areale.<br />
Segnalata nei <strong>di</strong>ntorni <strong>di</strong> Pontecchio. Non sono noti dati precisi<br />
conservazione nel sito<br />
al riguardo.<br />
Fattori <strong>di</strong> minaccia Le minacce principali provengono da tutte le attività umane che<br />
vanno ad alterare e degradare l’assetto originario <strong>di</strong> fiumi o<br />
torrenti <strong>di</strong> bassa e me<strong>di</strong>a quota. Fra queste la cementificazione<br />
delle sponde, l’escavazione <strong>di</strong> ghiaia e sabbia, l’eccessiva<br />
captazione delle acque per l’industria e l’agricoltura, il <strong>di</strong>sturbo<br />
dovuto al massiccio afflusso <strong>di</strong> bagnanti durante i mesi estivi e<br />
così via.<br />
Specie Anthypna abdominalis ssp. aemiliana (Ghi<strong>di</strong>ni, 1956)<br />
Sistematica Classe Insecta, Or<strong>di</strong>ne Coleoptera, Famiglia Glaphyridae.<br />
Nome comune<br />
Livello <strong>di</strong> protezione E’ fra le specie <strong>di</strong> interesse conservazionistico poste sotto<br />
osservazione in Emilia-Romagna e per questo motivo è stata<br />
inclusa nel PSR 2007-2013.<br />
Distribuzione Specie endemica dell’Italia settentrionale. Esistono tre<br />
sottospecie: A. a. abdominalis, presente a nord del Po; A. a.<br />
aemiliana, in Emilia-Romagna; A. a. binaghii della Liguria<br />
occidentale.<br />
Habitat ed ecologia Specie tipica delle golene e delle rive dei corsi d’acqua,<br />
soprattutto in aree planiziali. Frequenta i substrati sabbiosi con<br />
vegetazione erbacea rada, costituita soprattutto da<br />
graminacee. Gli adulti hanno un periodo <strong>di</strong> volo alquanto<br />
ristretto: essi appaiono per solo 10-15 giorni agli inizi <strong>di</strong> maggio<br />
e sono attivi dalla tarda mattinata alle prime ore del<br />
pomeriggio. I maschi volano radenti al suolo, a volte in gruppi<br />
numerosi, in cerca delle femmine. Queste ultime restano<br />
invece sempre a terra, sulla sabbia o all'interno <strong>di</strong> gallerie<br />
scavate da loro stesse. Frequentemente, la femmina<br />
deambulante al suolo si trova nascosta alla vista a causa del<br />
gran numero <strong>di</strong> maschi che la corteggiano. Le larve si<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 38<br />
sviluppano a spese <strong>di</strong> ra<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> graminacee. Diversamente dalla<br />
maggioranza dei Glafiri<strong>di</strong>, gli adulti non hanno abitu<strong>di</strong>ni<br />
floricole.<br />
Distribuzione in Italia La sottospecie aemiliana è presente in Emilia-Romagna tra<br />
l'Appennino e il fiume Po.<br />
Stato <strong>di</strong> conservazione in Italia Questa specie, visti il suo areale ristretto, la peculiarità degli<br />
Distribuzione e stato <strong>di</strong><br />
habitat in cui è infeudata e la sua eco-etologia, è da<br />
considerasi vulnerabile.<br />
Non sono noti dati precisi al riguardo.<br />
conservazione nel sito<br />
Fattori <strong>di</strong> minaccia La specie è minacciata delle manomissioni degli alvei fluviali,<br />
2.4.3 Specie <strong>di</strong> Pesci <strong>di</strong> interesse comunitario<br />
2.4.3.1 Barbo comune - Barbus plebejus (Bonaparte, 1839)<br />
Esigenze ecologiche<br />
dovute all’asportazione <strong>di</strong> sabbia, alla rettificazione e<br />
cementificazione delle sponde, nonché dal <strong>di</strong>sturbo creato dal<br />
passaggio <strong>di</strong> mezzi meccanici e turisti lungo le rive e le golene.<br />
Il barbo comune ha una <strong>di</strong>screta valenza ecologica in quanto occupa tratti <strong>di</strong>versificati dei<br />
corsi d’acqua, anche <strong>di</strong> piccole <strong>di</strong>mensioni, purché siano ben ossigenati. Pre<strong>di</strong>lige ad ogni<br />
modo acque correnti a quote me<strong>di</strong>o-alte dove l’acqua è limpida ed il fondo ghiaioso. Può<br />
uscire dal suo habitat ideale durante il periodo riproduttivo per motivi trofici ed in questo caso<br />
si trova a tollerare anche con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> acque più torbide e con velocità <strong>di</strong> corrente moderata.<br />
Stato <strong>di</strong> conservazione<br />
E’ considerato specie “a basso rischio” nella Lista Rossa nazionale ed è specie <strong>di</strong> interesse<br />
comunitario, inserita in Allegato II della Direttiva “Habitat” (92/43/CEE).<br />
Fattori <strong>di</strong> minaccia<br />
Il barbo è una specie in grado <strong>di</strong> tollerare modeste compromissioni della qualità delle acque;<br />
molto negative risultano per la specie le varie tipologie <strong>di</strong> manomissione ed interruzione degli<br />
alvei fluviali, così come l’inquinamento delle acque e gli eccessivi prelievi idrici.<br />
2.4.3.2 Cobite - Cobitis taenia (Canestrini, 1865)<br />
Esigenze ecologiche<br />
Il cobite è un pesce con una <strong>di</strong>screta valenza ecologica, anche se strettamente connessa ad<br />
acque dolci. Preferisce acque limpide ed aree dove la corrente è meno veloce e il fondo è<br />
sabbioso o fangoso, con una moderata presenza <strong>di</strong> macrofite in mezzo alle quali trova<br />
nutrimento e rifugio. Vive anche in acque <strong>di</strong> risorgiva e nella fascia litorale dei bacini lacustri,<br />
inoltre è in grado <strong>di</strong> tollerare basse concentrazioni <strong>di</strong> ossigeno.<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 39<br />
Stato <strong>di</strong> conservazione<br />
Il cobite comune è una specie d’interesse comunitario che ha subito un parziale decremento<br />
demografico a livello nazionale nel corso degli ultimi decenni ed è presente nell’Allegato II<br />
della Direttiva Habitat (92/43/CEE). La Lista rossa nazionale definisce invece questa specie<br />
come “a basso rischio”.<br />
Fattori <strong>di</strong> minaccia<br />
Questa specie è in grado <strong>di</strong> tollerare modeste compromissioni della qualità delle acque,<br />
come l’inquinamento prodotto dagli scarichi urbani, e risente particolarmente<br />
dell’inquinamento chimico. E’ minacciato dalle alterazioni strutturali dell’habitat come alcuni<br />
tipi <strong>di</strong> intervento sugli alvei (cementificazione, prelievi <strong>di</strong> sabbia etc). Il cobite viene inoltre<br />
utilizzato per la pesca sportiva come esca per i predatori.<br />
2.4.3.3 Lasca - Chondrostoma genei (Bonaparte, 1839)<br />
Esigenze ecologiche<br />
La Lasca vive nei tratti me<strong>di</strong>o-alti dei corsi d’acqua, dove c’è acqua limpida, spingendosi<br />
abbastanza in profon<strong>di</strong>tà nel rhitron, ove trova corrente rapida e fondo ghiaioso. Talvolta si<br />
rinviene anche in acque lacustri. È una specie abbastanza esigente per quanta riguarda il<br />
tenore <strong>di</strong> ossigeno <strong>di</strong>sciolto nelle acque; è <strong>di</strong> indole gregaria e forma branchi numerosi<br />
soprattutto durante il periodo <strong>di</strong> frega.<br />
Stato <strong>di</strong> conservazione<br />
E’ una specie endemica del <strong>di</strong>stretto padano-veneto. Considerata d’interesse comunitario è<br />
inserita in Allegato II della Direttiva “Habitat” (92/43/CEE) ed è inclusa nella Lista Rossa dei<br />
pesci d’acqua dolce in<strong>di</strong>geni in Italia nella categoria delle specie “vulnerabili”.<br />
Fattori <strong>di</strong> minaccia<br />
Quasi dappertutto le popolazioni <strong>di</strong> lasca sono in contrazione numerica per varie cause<br />
<strong>di</strong>pendenti da attività antropiche. E’ una specie a stretta valenza ecologica che risente<br />
negativamente del degrado degli ambienti fluviali ed in particolare della compromissione<br />
della qualità delle acque e delle alterazioni degli alvei e dei substrati. Anche <strong>di</strong>ghe ed altri<br />
sbarramenti fluviali sono particolarmente dannosi, impedendo in alcuni corsi d’acqua il<br />
raggiungimento delle aree <strong>di</strong> frega più idonee; infine, anche la pesca sportiva in alcune<br />
regioni può causare danni alla conservazione <strong>di</strong> questa specie. Tali motivi hanno condotto<br />
all’estinzione locale della lasca in alcune aree con una conseguente frammentazione<br />
dell’areale.<br />
2.4.3.4 Rovella - Rutilus rubilio (Bonaparte, 1837)<br />
Esigenze ecologiche<br />
La rovella è caratterizzata da una <strong>di</strong>screta valenza ecologica, pertanto è in grado <strong>di</strong><br />
occupare <strong>di</strong>versi tratti dei fiumi e dei corsi d’acqua <strong>di</strong> minori <strong>di</strong>mensioni. Sembra pre<strong>di</strong>ligere<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 40<br />
comunque le zone poco profonde e moderatamente correnti, con substrato sabbioso o<br />
ghiaioso e buona presenza <strong>di</strong> macrofite acquatiche.<br />
Stato <strong>di</strong> conservazione<br />
Nella Lista rossa dei pesci d’acqua dolce viene considerata nella categoria “a più basso<br />
rischio”, è inoltre citata nella Direttiva 92/43 CEE (all. II) ed elencata fra le specie protette<br />
dalla Convenzione <strong>di</strong> Berna (all. III).<br />
Fattori <strong>di</strong> minaccia<br />
La rovella, risente in maniera negativa delle alterazioni degli habitat provocate ad esempio<br />
dalle canalizzazioni ed altri interventi sugli alvei, come i prelievi <strong>di</strong> sabbia e ghiaia che<br />
riducono le aree idonee alla frega. In alcuni ambienti le popolazioni sono in forte contrazione<br />
numerica in seguito all’introduzione e all’acclimatazione <strong>di</strong> Ciprini<strong>di</strong> alloctoni, come il rutilo o<br />
gardon, aventi nicchia ecologica affine. La specie è inoltre oggetto <strong>di</strong> pesca sportiva,<br />
soprattutto da parte <strong>di</strong> principianti.<br />
2.4.3.5 Vairone - Leuciscus souffia (Bonaparte, 1837)<br />
Esigenze ecologiche<br />
Il vairone vive in acque correnti, limpide e ricche <strong>di</strong> ossigeno, con fondali ghiaiosi. E’<br />
presente nei tratti ritrali dei corsi d’acqua, nelle risorgive ed occasionalmente nei laghi<br />
oligotrofici. Necessita in particolare <strong>di</strong> una buona qualità dell’acqua.<br />
Stato <strong>di</strong> conservazione<br />
Nella Lista rossa dei pesci d’acqua dolce nazionale viene considerata una specie “a più<br />
basso rischio”. E’ riportato inoltre nella Direttiva 92/43 CEE tra le specie <strong>di</strong> interesse<br />
comunitario (all. II) e tra le specie protette dalla Convenzione <strong>di</strong> Berna.<br />
Fattori <strong>di</strong> minaccia<br />
E’ una specie minacciata dalle varie forme <strong>di</strong> inquinamento dei corpi idrici; inoltre, le<br />
alterazioni dell’habitat, come l’artificializzazione degli alvei fluviali ed i prelievi <strong>di</strong> ghiaia,<br />
risultano fortemente negative perché compromettono in modo irreversibile i substrati<br />
riproduttivi. Gli eccessivi prelievi idrici possono pertanto produrre danni consistenti.<br />
2.4.4 Altre specie <strong>di</strong> Pesci <strong>di</strong> interesse conservazionistico<br />
2.4.4.1 Cavedano - Leuciscus cephalus (Linneaus, 1758)<br />
Esigenze ecologiche<br />
Il cavedano è una specie ad ampia valenza ecologica, capace <strong>di</strong> vivere in una grande<br />
varietà <strong>di</strong> ambienti, come per esempio gli ambienti lacustri dove vive sia in acque<br />
oligotrofiche che eutrofiche. Pre<strong>di</strong>lige comunque acque limpide e fondali ghiaiosi presenti<br />
principalmente in bacini lacustri e nei tratti me<strong>di</strong>o-alti dei corsi d’acqua.<br />
Stato <strong>di</strong> conservazione<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 41<br />
E’ uno dei pochi pesci d’acqua dolce in<strong>di</strong>geni in Italia che è inserito in Lista rossa come<br />
specie “non a rischio” sia a livello nazionale, sia a livello regionale.<br />
Fattori <strong>di</strong> minaccia<br />
Le popolazioni sembrano non risentire particolarmente dal deterioramento generale della<br />
qualità delle acque dei fiumi italiani e dalla manomissione <strong>di</strong>ffusa degli alvei; si <strong>di</strong>mostra<br />
quin<strong>di</strong>, sotto questo aspetto, una specie estremamente opportunista. Comunque negative<br />
per la specie risultano le varie tipologie <strong>di</strong> manomissione ed interruzione degli alvei fluviali,<br />
così come l’inquinamento delle acque e gli eccessivi prelievi idrici.<br />
2.4.4.2 Gobione - Gobio gobio (Linneaus, 1758)<br />
Esigenze ecologiche<br />
Il gobione ha una <strong>di</strong>screta valenza ecologica che gli consente <strong>di</strong> vivere in <strong>di</strong>versi tipi <strong>di</strong><br />
ambienti: tratti me<strong>di</strong>o-alti, me<strong>di</strong> e me<strong>di</strong>o –bassi dei corsi d’acqua, dove pre<strong>di</strong>lige le acque<br />
con me<strong>di</strong>a velocità <strong>di</strong> corrente e modesta profon<strong>di</strong>tà; laghi con acque limpide e spiagge<br />
sabbiose; acque salmastre.<br />
Stato <strong>di</strong> conservazione<br />
Nella lista rossa dei pesci d’acqua dolce d’Italia viene considerato “a più basso rischio”. La<br />
popolazione è legata ad una buona qualità ambientale ed è quin<strong>di</strong> fondamentale garantire la<br />
naturalità degli alvei per la sua sopravvivenza.<br />
Fattori <strong>di</strong> minaccia<br />
Il gobione è in grado <strong>di</strong> tollerare lievi alterazioni della qualità delle acque; risente però molto<br />
<strong>di</strong> più delle variazioni morfologiche dell’alveo, delle canalizzazioni, degli interventi sugli alvei<br />
come prelievi <strong>di</strong> ghiaia e sabbia che possono causare la riduzione delle aree idonee alla<br />
frega. Ne consegue una rarefazione della specie.<br />
2.4.4.3 Ghiozzo comune - Padogobius martensii (Günther, 1861)<br />
Esigenze ecologiche<br />
Il ghiozzo comune è una specie a <strong>di</strong>screta valenza ecologica, che necessita però <strong>di</strong> acque<br />
limpide e ben ossigenate. Vive nel tratto me<strong>di</strong>o alto dei corsi d’acqua <strong>di</strong> piccola e me<strong>di</strong>a<br />
portata, in aree caratterizzate da moderata velocità della corrente e fondo ghiaioso o<br />
ciottoloso, elemento in<strong>di</strong>spensabile per le abitu<strong>di</strong>ni comportamentali e riproduttivi della<br />
specie.<br />
Stato <strong>di</strong> conservazione<br />
La specie è inserita in Lista rossa nazionale come specie “vulnerabile”. Padogobius<br />
martensii è inoltre inserito tra le specie protette nella Convenzione <strong>di</strong> Berna (all. III).<br />
Fattori <strong>di</strong> minaccia<br />
Il ghiozzo comune è una specie endemica del bacino padano-veneto, caratterizzata dalla<br />
scarsità delle sue popolazioni oltre che dal ridursi dell’areale <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione. Le maggiori<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 42<br />
cause <strong>di</strong> minaccia sono l’alterazione dell’habitat, l’artificializzazione dell’alveo, gli<br />
sbarramenti e l’inquinamento dei corsi d’acqua in cui vive.<br />
2.4.5 Specie <strong>di</strong> Anfibi <strong>di</strong> interesse comunitario<br />
Specie Salamandrina perspicillata (Savi, 1821)<br />
Sistematica Classe Amphibia, or<strong>di</strong>ne Urodela, famiglia Salamandridae<br />
Nome comune Salamandrina dagli occhiali<br />
Livello <strong>di</strong> protezione La specie è inclusa negli allegati II e IV della Direttiva<br />
92/43/CE, in appen<strong>di</strong>ce 2 della convenzione <strong>di</strong> Berna ed è<br />
tutelata dalla LR 15/06 RER.<br />
Categoria nella Lista Rossa Regionale: VU C2a1.<br />
Distribuzione Entità endemica dell'Italia appenninica centro-settentrionale.<br />
Habitat ed ecologia Pre<strong>di</strong>lige ambienti forestali quali querceti e faggete. Depone le<br />
uova prevalentemente in corsi d'acqua, canali e fossati.<br />
E' una specie spiccatamente terrestre, solo le femmine si<br />
recano in acqua per un breve periodo (per deporre le uova).<br />
L'attività terrestre è più consistente nelle ore serali; <strong>di</strong> giorno è<br />
attiva in giornate umide ed in luoghi particolarmente<br />
ombreggiati, o in suoli ricoperti <strong>di</strong> lettiera.<br />
Se minacciata assume una posizione del tronco in opistotono,<br />
con zampe a volte sollevate da terra e coda incurvata<br />
dorsalmente: una reazione <strong>di</strong>fensiva analoga all’unkenreflex<br />
tipico del genere Bombina.<br />
Le larve si nutrono prevalentemente <strong>di</strong> Artropo<strong>di</strong> acquatici. Gli<br />
adulti si cibano quasi esclusivamente <strong>di</strong> Oligocheta,<br />
Gasteropoda, Aracnida, Coleoptera.<br />
Le femmine possiedono una spermateca dove mantengono gli<br />
spermatozoi . La deposizione delle uova avviene in<br />
<strong>di</strong>pendenza delle con<strong>di</strong>zioni climatiche e <strong>di</strong> altitu<strong>di</strong>ne; <strong>di</strong><br />
solito,comunque, nei primi mesi primaverili. Le uova sono<br />
deposte in torrenti e ruscelli con portate non troppo eccessive<br />
e in tratti con debole corrente. Si riproduce anche in fontanili,<br />
pozze grotte allagate.<br />
Distribuzione in Italia Il limite nord-occidentale del suo areale è situato presso<br />
Bolzaneto (Genova); il limite meri<strong>di</strong>onale è definito da Lazio e<br />
Molise. Nell'Italia centrale è presente soprattutto in Toscana e<br />
Lazio.<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 43<br />
Distribuzione in Regione Distribuzione appenninica <strong>di</strong>scontinua: è presente nelle<br />
province <strong>di</strong> <strong>Bologna</strong>, Forlì - Cesena e <strong>di</strong> Piacenza.<br />
La popolazione presente nel sito è isolata.<br />
Stato <strong>di</strong> conservazione in Italia Specie piuttosto localizzata ma più <strong>di</strong>ffusa <strong>di</strong> quanto si<br />
ritenesse in passato. Presenta molte popolazioni isolate.<br />
Stato <strong>di</strong> conservazione in Regione In regione presenta un areale molto frammentato<br />
Distribuzione nel sito Presente con una popolazione in un tratto <strong>di</strong> Rio Cocco, il<br />
confronto tra i dati pregressi (che mostravano la presenza <strong>di</strong><br />
una popolazione priva <strong>di</strong> problemi) con quelli che saranno<br />
raccolti nella campagna <strong>di</strong> monitoraggio del 2012 potranno<br />
fornire il quadro della situazione.<br />
Fattori <strong>di</strong> minaccia Scomparsa o degrado dei siti riproduttivi.<br />
Prelievo illegale.<br />
Gestione non razionale delle aree boschive.<br />
Eccessiva “pulizia” del sottobosco.<br />
Eccessiva frequentazione antropica dei siti riproduttivi.<br />
Uso <strong>di</strong> prodotti chimici nelle aree coltivate.<br />
Specie Triturus carnifex (Laurenti, 1768)<br />
Sistematica Classe Amphibia, or<strong>di</strong>ne Urodela, famiglia Salamandridae<br />
Nome comune Tritone crestato italiano<br />
Livello <strong>di</strong> protezione La specie è inclusa negli allegati II e IV della Direttiva<br />
92/43/CE, in appen<strong>di</strong>ce 2 della convenzione <strong>di</strong> Berna ed è<br />
tutelata dalla LR 15/06 RER.<br />
Categoria nella Lista Rossa Regionale: LC.<br />
Distribuzione Presente nel sud dell'Europa: dalla Calabria fino alle Alpi<br />
austriache e Svizzera meri<strong>di</strong>onale; più a est dalla Repubblica<br />
Ceca meri<strong>di</strong>onale alla Grecia nord occidentale.<br />
Habitat ed ecologia La specie è presente in laghi, canali, fossati. Tra gli ambienti<br />
terrestri è prevalentemente presente in prati, pascoli, ambienti<br />
forestali e aree antropizzate.<br />
E' meno legato all'acqua degli altri tritoni; nel periodo<br />
riproduttivo frequenta corpi d'acqua fermi o con debole<br />
corrente e si mantiene nella parte centrale <strong>di</strong> essi.<br />
La <strong>di</strong>eta seguita è <strong>di</strong> tipo opportunista: invertebrati acquatici e<br />
terrestri, ma anche larve e uova <strong>di</strong> altri Anfibi.<br />
La riproduzione si svolge nei mesi primaverili o ad inizio estate.<br />
Come altri tritoni, il maschio effettua una "danza" <strong>di</strong><br />
corteggiamento con produzione <strong>di</strong> stimoli odorosi in<strong>di</strong>rizzati<br />
alla femmina. La “danza” si conclude con la deposizione <strong>di</strong> una<br />
spermatofora raccolta poi dalla femmina con le labbra cloacali.<br />
Le uova vengono deposte in<strong>di</strong>vidualmente o a piccoli gruppi,<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 44<br />
avviluppate tra le foglie <strong>di</strong> piante acquatiche adeguatamente<br />
ripiegate a scopo protettivo.<br />
Distribuzione in Italia In Italia il limite meri<strong>di</strong>onale è la Calabria centrale; a nord è<br />
assente in Liguria e Piemonte occidentali e in trentino Alto -<br />
A<strong>di</strong>ge.<br />
Occupa una fascia altitu<strong>di</strong>nale che va dal livello del mare fino<br />
quasi ai 2000 m (con preferenza per le basse e me<strong>di</strong>e quote).<br />
Distribuzione in Regione Ampiamente <strong>di</strong>stribuito su tutta la superficie regionale, con<br />
prevalenza nella fascia planiziale fino ai 200 m.<br />
Il territorio dell' Emilia - Romagna ricade tutto nel suo areale<br />
nazionale; per questo la specie risulta ben <strong>di</strong>ffusa e con una<br />
certa significatività a livello nazionale.<br />
Stato <strong>di</strong> conservazione in Italia È una specie comune anche se segnalati <strong>di</strong>versi casi <strong>di</strong><br />
estinzione locale è presente abbastanza frequentemente nei<br />
corpi d'acqua che non hanno subito degrado da<br />
antropizzazione e le cui acque sono <strong>di</strong> buona qualità.<br />
Stato <strong>di</strong> conservazione in Regione La specie è comune e presente abbastanza frequentemente<br />
nei corpi d'acqua che non hanno subito antropizzazione e le<br />
cui acque sono <strong>di</strong> buona qualità. Più rarefatta nei siti <strong>di</strong><br />
pianura, ove un tempo era più <strong>di</strong>ffusa, la popolazione si<br />
concentra in ambito collinare e basso montano.<br />
Distribuzione nel sito Non sono <strong>di</strong>sponibili dati quantitativi, ma la specie risulta ben<br />
<strong>di</strong>stribuita.<br />
Fattori <strong>di</strong> minaccia Scomparsa o degrado dei siti riproduttivi.<br />
Prelievo illegale.<br />
“Pulizia” <strong>di</strong> abbeveratoi e lavatoi.<br />
2.4.6 Altre specie <strong>di</strong> Anfibi <strong>di</strong> interesse conservazionistico<br />
Uso <strong>di</strong> prodotti chimici nelle aree coltivate.<br />
Specie Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758)<br />
Sistematica Classe Amphibia, or<strong>di</strong>ne Urodela, famiglia Salamandridae<br />
Nome comune Tritone punteggiato<br />
Livello <strong>di</strong> protezione La specie è inclusa in appen<strong>di</strong>ce 3 della convenzione <strong>di</strong> Berna<br />
ed è tutelata dalla LR 15/06 RER.<br />
Categoria nella Lista Rossa Regionale: LC.<br />
Distribuzione Entità <strong>di</strong>stribuita in Centro-Asia ed Europa.<br />
Habitat ed ecologia La specie frequenta una elevata varietà <strong>di</strong> ambienti anche<br />
parzialmente antropizzati. Pre<strong>di</strong>lige fossi, scoline, pozze<br />
piccole o <strong>di</strong> me<strong>di</strong>e <strong>di</strong>mensioni, abbeveratoi, cisterne e risaie. Si<br />
può trovare anche torrenti con flusso d'acqua ridotto. Come<br />
ambienti terrestri favorisce boschi igrofili, brughiere e pascoli <strong>di</strong><br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 45<br />
derivazione, ma frequenta anche giar<strong>di</strong>ni e aree suburbane. La<br />
presenza <strong>di</strong> vegetazione sommersa o ripariale è importante<br />
come rifugio o per la deposizione delle uova.<br />
La <strong>di</strong>eta è generalista: basata in particolare su Cladoceri,<br />
Ostraco<strong>di</strong>, Copepo<strong>di</strong>, e in misura minore su Lumbrici<strong>di</strong> e<br />
Gasteropo<strong>di</strong>.<br />
La riproduzione si svolge nei mesi tardo invernali o ad inizio<br />
della primavera. La deposizione è preceduta da un complesso<br />
rituale <strong>di</strong> corteggiamento, che consiste in prolungate danze da<br />
parte dei maschi con produzione <strong>di</strong> stimoli olfattivi in<strong>di</strong>rizzati<br />
alla femmina. Le “danze” si concludono con la deposizione <strong>di</strong><br />
una spermatofora che viene raccolta dalla femmina con le<br />
labbra cloacali.<br />
Le uova vengono deposte in<strong>di</strong>vidualmente o a piccoli gruppi,<br />
avviluppate tra le foglie <strong>di</strong> piante acquatiche adeguatamente<br />
ripiegate a scopo protettivo.<br />
Distribuzione in Italia In Italia è <strong>di</strong>ffusa dal Canton Ticino fino ad una fascia che<br />
congiunge Ancona a Napoli ove si sovrappone a Triturus<br />
italicus.<br />
Distribuzione in Regione Specie ad ampia <strong>di</strong>ffusione ,ma non omogenea, nel territorio<br />
regionale, prevalentemente nelle fasce planiziali e collinari (da<br />
0 a 400 m s.l.m.).<br />
Stato <strong>di</strong> conservazione in Italia È una specie comune con popolazione stabile, presente<br />
abbastanza frequentemente nei corpi d'acqua che non hanno<br />
subito degrado da antropizzazione e le cui acque sono <strong>di</strong><br />
buona qualità.<br />
Occupa una fascia altitu<strong>di</strong>nale che va dal livello del mare ai<br />
1700 m (prevalenza 0-400 m).<br />
Stato <strong>di</strong> conservazione in Regione La specie è comune e presente abbastanza frequentemente<br />
nei corpi d'acqua che non hanno subito antropizzazione e le<br />
cui acque sono <strong>di</strong> buona qualità.<br />
Distribuzione nel sito Non sono <strong>di</strong>sponibili dati quantitativi, ma la specie risulta ben<br />
<strong>di</strong>stribuita.<br />
Fattori <strong>di</strong> minaccia Scomparsa o degrado dei siti riproduttivi.<br />
Prelievo illegale.<br />
Invasione <strong>di</strong> specie alloctone.<br />
Uso <strong>di</strong> prodotti chimici nelle aree coltivate.<br />
“Pulizia” <strong>di</strong> abbeveratoi e lavatoi.<br />
Specie Bufo bufo (Linnaeus, 1758)<br />
Sistematica Classe Amphibia, or<strong>di</strong>ne Anura, famiglia Bufonidae<br />
Nome comune Rospo comune<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 46<br />
Livello <strong>di</strong> protezione La specie è inclusa in appen<strong>di</strong>ce 3 della convenzione <strong>di</strong> Berna<br />
ed è tutelata dalla LR 15/06 RER.<br />
Categoria nella Lista Rossa Regionale: LC.<br />
Distribuzione Specie a geonemia eurocentrasiatica-magrebina, <strong>di</strong>ffusa in<br />
tutta Europa (esclusa l'Irlanda).<br />
Habitat ed ecologia Specie prevalentemente notturna, terricola legata all'ambiente<br />
acquatico solo in periodo larvale e riproduttivo. L'attività<br />
annuale ha inizio tra febbraio e maggio, a seconda della quota<br />
e delle con<strong>di</strong>zioni meteorologiche. La pausa invernale è<br />
trascorsa in vari tipi <strong>di</strong> rifugi come tane, grotte, cantine, sotto<br />
materiale vegetale o grosse pietre.<br />
L’adulto è predatore, si nutre prevalentemente Invertebrati e<br />
piccoli Vertebrati, la larva si nutre prevalentemente <strong>di</strong> vegetali,<br />
detriti e materiale organico in decomposizione.<br />
Alla fine della stagione invernale ha luogo la migrazione<br />
riproduttiva, gli adulti si portano in prevalentemente in acque<br />
lentiche (laghi, pozze, palu<strong>di</strong>, vasche <strong>di</strong> cemento) ma anche in<br />
anse <strong>di</strong> fiumi e torrenti, ove ha luogo l'accoppiamento <strong>di</strong> tipo<br />
ascellare.<br />
La femmina depone le uova in lunghi cordoni gelatinosi, le<br />
uova schiudono dopo circa 2 settimane e lo sviluppo larvale<br />
dura dai 2 ai 3 mesi.<br />
Il Rospo comune presenta un'elevata fedeltà al sito<br />
riproduttivo.<br />
Distribuzione in Italia In Italia è presente quasi ovunque ad eccezione <strong>di</strong> Sardegna e<br />
isole minori.<br />
Occupa una fascia altitu<strong>di</strong>nale che va dal livello del mare ai<br />
2000 m (prevalenza 300-600 m).<br />
Distribuzione in Regione Ampiamente <strong>di</strong>stribuito in tutto il territorio regionale<br />
Stato <strong>di</strong> conservazione in Italia È una specie comune ma presenta una <strong>di</strong>minuzione<br />
generalizzata delle popolazioni italiane.<br />
Stato <strong>di</strong> conservazione in Regione In Regione si ravvisa una preoccupante rarefazione delle<br />
popolazioni, soprattutto in pianura, con situazioni localizzate<br />
maggiormente critiche.<br />
Distribuzione nel sito Non sono <strong>di</strong>sponibili dati quantitativi, ma la specie risulta ben<br />
<strong>di</strong>stribuita.<br />
Fattori <strong>di</strong> minaccia Scomparsa o degrado dei siti riproduttivi.<br />
Persecuzione.<br />
Uso <strong>di</strong> prodotti chimici nelle aree coltivate<br />
Collisione con autoveicoli durante le migrazioni riproduttive e<br />
durante la ricerca del cibo nelle serate piovose e calde.<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 47<br />
Specie Pseudepidalea viri<strong>di</strong>s (Laurenti, 1768)<br />
Sistematica Classe Amphibia, or<strong>di</strong>ne Anura, famiglia Bufonidae<br />
Nome comune Rospo smeral<strong>di</strong>no<br />
Livello <strong>di</strong> protezione La specie è inclusa in allegato IV della convenzione 92/43/CEE<br />
e in appen<strong>di</strong>ce 3 della convenzione <strong>di</strong> Berna ed è tutelata dalla<br />
LR 15/06 RER.<br />
Categoria nella Lista Rossa Regionale: LC.<br />
Distribuzione Specie <strong>di</strong>stribuita dal nord-est della Francia, attraverso tutta<br />
Europa fino al Kazakhstan.<br />
Habitat ed ecologia Specie planiziale e marginalmente planiziale presente in<br />
ambienti aperti, primari o <strong>di</strong> derivazione da formazioni forestali.<br />
Frequenta aree vallive, ambienti retrodunali, fiumi, canali,<br />
ambienti agricoli e aree urbanizzate. Ha una certa pre<strong>di</strong>lezione<br />
per substrati sabbiosi ed argillosi.<br />
Specie legata all'acqua in periodo larvale e riproduttivo è<br />
normalmente attiva durante le ore serali e notturne. Durante il<br />
giorno rimane nascosto in rifugi sotto pietre, tronchi,<br />
vegetazione.<br />
Specie pioniera, colonizza rapidamente le zone umide <strong>di</strong><br />
recente costruzione, anche in aree antropizzate (cantieri e<strong>di</strong>li),<br />
in ambienti più maturi sembra subire competizione con Bufo<br />
bufo con il quale non è quasi mai in con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> sintopia.<br />
Adulto: predatore <strong>di</strong> Invertebrati. Larva: detritivora e onnivora<br />
In periodo riproduttivo può essere attivo in acqua anche<br />
durante le ore <strong>di</strong>urne. Si riproduce durante il periodo<br />
primaverile fino all'inizio dell'estate utilizzando per la<br />
deposizione prevalentemente raccolte temporanee d'acqua <strong>di</strong><br />
piccole <strong>di</strong>mensioni, come grosse pozzanghere o piccole pozze,<br />
piccole vasche e altre strutture <strong>di</strong> origine antropica. Può<br />
deporre in raccolte d'acqua salmastra. L'accoppiamento è <strong>di</strong><br />
tipo ascellare, le uova sono deposte in lunghi cordoni<br />
gelatinosi. I girini nascono dopo un paio <strong>di</strong> settimane e<br />
completano lo sviluppo in estate dopo circa 2-3 mesi.<br />
Distribuzione in Italia Presente in tutte le regioni italiane tranne che in Val d’Aosta<br />
con <strong>di</strong>stribuzione altitu<strong>di</strong>nale tra 0 e 1300 m (prevalenza < 500<br />
m).<br />
Distribuzione in Regione Distribuito in tutto il settore padano del territorio regionale.<br />
Stato <strong>di</strong> conservazione in Italia Popolazione ben <strong>di</strong>stribuita negli ambienti planiziali, ma<br />
presenta a livello europeo e italiano una situazione più critica.<br />
Stato <strong>di</strong> conservazione in Regione Pur essendo ampiamente <strong>di</strong>ffusa in Regione si ravvisa una<br />
rarefazione delle popolazioni, con situazioni localizzate<br />
maggiormente critiche.<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 48<br />
Distribuzione nel sito Non sono <strong>di</strong>sponibili dati.<br />
Fattori <strong>di</strong> minaccia nel sito Scomparsa o degrado dei siti riproduttivi.<br />
Persecuzione.<br />
Uso <strong>di</strong> prodotti chimici nelle aree coltivate.<br />
Specie Pelophylax lessonae/klepton esculentus<br />
Sistematica Classe Amphibia, or<strong>di</strong>ne Anura, famiglia Ranidae<br />
Nome comune Rana verde<br />
Livello <strong>di</strong> protezione La specie è inclusa in allegato IV della Direttiva 92/43/CE, in<br />
appen<strong>di</strong>ce 2 della convenzione <strong>di</strong> Berna ed è tutelata dalla LR<br />
15/06 RER.<br />
Categoria nella Lista Rossa Regionale: LC.<br />
Distribuzione Europa centro-settentrionale, dalle coste atlantiche Francesi<br />
fino al Volga, a nord raggiunge la Gran Bretagna e l'estremo<br />
meri<strong>di</strong>onale della penisola scan<strong>di</strong>nava.<br />
Habitat ed ecologia Frequenta un’ampia varietà <strong>di</strong> corpi idrici sia naturali che<br />
artificiali come laghi, palu<strong>di</strong>, stagni, pozze temporanee, canali,<br />
raccolte d'acqua a lento corso lento il letto <strong>di</strong> torrenti, fossati e<br />
maceri.<br />
Attiva sia nelle ore <strong>di</strong>urne che in quelle notturne, conduce vita<br />
decisamente acquatica. Buon saltatore, passa gran parte delle<br />
ore <strong>di</strong>urne a termoregolarsi sulle sponde dei gli habitat<br />
acquatici. E' attiva dalla primavera a buona parte dell'autunno.<br />
L’adulto è predatore <strong>di</strong> invertebrati (prevalentemente insetti) e<br />
<strong>di</strong> piccoli vertebrati. La larva è onnivora.<br />
L’accoppiamento è ascellare e può durare anche per più <strong>di</strong> un<br />
giorno. Ha luogo in periodo primaverile-estivo.<br />
Le uova vengono deposte in ambienti ricchi <strong>di</strong> vegetazione, in<br />
ammassi gelatinosi rotondeggianti ancorati alla vegetazione.<br />
La schiusa avviene dopo 2-4 settimane e le larve<br />
metamorfosano dopo 3-4 mesi.<br />
L'accoppiamento può avvenire sia tra omospecifici (P.<br />
lessonae x P. lessonae) producendo solo in<strong>di</strong>vidui P. lessonae,<br />
sia tra eterospecifici (P. kl esculentus x P. lessonae)<br />
producendo solo in<strong>di</strong>vidui P. kl esculentus.<br />
Distribuzione in Italia In Italia è presente nella Pianura Padana a nord della linea<br />
immaginaria congiungente Genova a Rimini.<br />
Distribuzione altitu<strong>di</strong>nale per l'Italia: prevalentemente dal livello<br />
del mare fino a 800 m.<br />
Distribuzione in Regione Comune e ben <strong>di</strong>stribuita in tutto il territorio regionale dal<br />
livello del mare fino ai 1400 m (prevalenza
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 49<br />
Stato <strong>di</strong> conservazione in Regione La specie non sembra essere soggetta a livello Regionale a<br />
minacce imminenti, anche se negli ultimi decenni si è<br />
riscontrata una notevole e preoccupante rarefazione delle<br />
popolazioni specialmente nelle zone planiziali.<br />
Distribuzione nel sito Non sono <strong>di</strong>sponibili dati.<br />
Fattori <strong>di</strong> minaccia Scomparsa o degrado dei siti riproduttivi.<br />
Errata gestione della vegetazione ripariale.<br />
Prelievo illegale.<br />
Persecuzione.<br />
Uso <strong>di</strong> prodotti chimici nelle aree coltivate.<br />
Invasione <strong>di</strong> specie alloctone.<br />
Specie Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte, 1838<br />
Sistematica Classe Amphibia, or<strong>di</strong>ne Anura, famiglia Ranidae<br />
Nome comune Rana agile<br />
Livello <strong>di</strong> protezione La specie è inclusa in allegato IV della Direttiva 92/43/CE, in<br />
appen<strong>di</strong>ce 2 della convenzione <strong>di</strong> Berna ed è tutelata dalla LR<br />
15/06 RER.<br />
Categoria nella Lista Rossa Regionale: LC.<br />
Distribuzione Europa occidentale, centrale e meri<strong>di</strong>onale. Il limite occidentale<br />
della <strong>di</strong>stribuzione è rappresentato dalla Francia e dalla<br />
Spagna nord-orientale, quello settentrionale da Danimarca e<br />
Svezia meri<strong>di</strong>onale, a est si estende dalla penisola Balcanica<br />
alla Tracia turca fino all'Anatolia, a sud occupa Italia e<br />
Peloponneso.<br />
Habitat ed ecologia Frequenta prati, incolti, radure e boschi. Rara nelle aree<br />
antropizzate. I siti riproduttivi sono costituiti da acque lentiche<br />
naturali ed artificiali come stagni, raccolte d'acqua temporanee,<br />
piccoli invasi e pozze laterali dei torrenti.<br />
Specie ad attività prevalentemente notturna con abitu<strong>di</strong>ni<br />
prettamente terricole, legata all'ambiente acquatico solo in<br />
periodo larvale e riproduttivo. Ottima saltatrice.<br />
L'adulto si ciba in prevalenza <strong>di</strong> Artropo<strong>di</strong>.<br />
L'accoppiamento è ascellare ed avviene precocemente rispetto<br />
ad altri anuri avendo luogo già a febbraio-marzo. Le uova sono<br />
deposte in ammassi sferoidali ancorati alla vegetazione ma col<br />
tempo si <strong>di</strong>stendono sulla superficie dell'acqua assumendo<br />
forma <strong>di</strong>scoidale.<br />
Le larve nascono dopo 2-3 settimane e la vita larvale dura 2-3<br />
mesi.<br />
E' stata riscontrata un'elevata fedeltà al sito riproduttivo.<br />
Distribuzione in Italia In Italia è presente in tutta la penisola, è poco <strong>di</strong>ffusa lungo il<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 50<br />
me<strong>di</strong>o basso versante adriatico ed è assente da Sicilia e<br />
Sardegna.<br />
Distribuzione altitu<strong>di</strong>nale per l'Italia: dal livello del mare fino ai<br />
2000 m.<br />
Distribuzione in Regione Relativamente comune ma <strong>di</strong>stribuita in modo <strong>di</strong>scontinuo, è la<br />
più comune delle "rane rosse" italiane, presenta una certa<br />
maggior frequenza nel settore appenninico.<br />
Stato <strong>di</strong> conservazione in Italia È una specie comune, ma soffre a livello nazionale <strong>di</strong> per<strong>di</strong>ta<br />
do habitat.<br />
Stato <strong>di</strong> conservazione in Regione Pur essendo ampiamente <strong>di</strong>ffusa, la specie appare<br />
chiaramente soggetta ad un certo grado <strong>di</strong> rarefazione.<br />
Distribuzione nel sito Non sono <strong>di</strong>sponibili dati quantitativi, ma la specie sembra ben<br />
<strong>di</strong>stribuita.<br />
Fattori <strong>di</strong> minaccia Scomparsa o degrado dei siti riproduttivi.<br />
Errata gestione della vegetazione ripariale.<br />
Uso <strong>di</strong> prodotti chimici nelle aree coltivate.<br />
Invasione <strong>di</strong> specie alloctone e introduzioni <strong>di</strong> fauna ittica.<br />
Errata gestione delle aree boschive in special modo con<br />
eccessiva “pulizia” del sottobosco.<br />
Specie Rana italica Dubois, 1987<br />
Sistematica Classe Amphibia, or<strong>di</strong>ne Anura, famiglia Ranidae<br />
Nome comune Rana appenninica<br />
Livello <strong>di</strong> protezione La specie è inclusa in allegato IV della convenzione 92/43/CEE<br />
e in appen<strong>di</strong>ce 3 della convenzione <strong>di</strong> Berna ed è tutelata dalla<br />
LR 15/06 RER.<br />
Categoria nella Lista Rossa Regionale: LC.<br />
Distribuzione Endemita dell'Italia peninsulare.<br />
Habitat ed ecologia La specie frequenta esclusivamente torrenti e ruscelli che<br />
scorrono all'interno <strong>di</strong> aree boschive, prevalentemente<br />
boschi misti <strong>di</strong> latifoglie e faggete.<br />
Attiva durante il giorno in primavera ed autunno e durante le<br />
ore notturne in estate. Prettamente acquatica, ottima saltatrice<br />
e nuotatrice.<br />
Predatore <strong>di</strong> invertebrati acquatici e terrestri.<br />
Gli accoppiamenti sono <strong>di</strong> tipo ascellare, avvengono a fine<br />
inverno. La femmina depone le uova in masserelle ancorate<br />
alle rocce del fondo, pietre e tronchi sommersi in acque<br />
correnti. La schiusa avviene dopo 2-3 settimane e lo sviluppo<br />
larvale si completa in 2 mesi, ma può protrarsi, nei ruscelli<br />
montani, fino a 3 mesi.<br />
Distribuzione in Italia È <strong>di</strong>ffusa dalla Liguria centrale alla Calabria meri<strong>di</strong>onale,<br />
prevalentemente nella dorsale appenninica. Distribuzione<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 51<br />
altitu<strong>di</strong>nale: dal livello del mare fino ai 1400 m (prevalenza 200-<br />
600 m).<br />
Distribuzione in Regione Distribuita, in modo <strong>di</strong>scontinuo, in tutto il settore appenninico<br />
del territorio regionale tra i 130 e i 1700 m (prevalenza 400-600<br />
m).<br />
Stato <strong>di</strong> conservazione in Italia Pur presentando locali situazioni a rischio, non appare<br />
minacciata.<br />
Stato <strong>di</strong> conservazione in Regione La specie, ove presente, raggiunge densità elevate, ma<br />
l'areale presenta notevoli <strong>di</strong>scontinuità.<br />
Distribuzione nel sito Non sono <strong>di</strong>sponibili dati quantitativi.<br />
Fattori <strong>di</strong> minaccia Inquinamento dei corsi d’acqua minore.<br />
2.4.7 Specie <strong>di</strong> Rettili <strong>di</strong> interesse comunitario<br />
Gestione forestale non razionale.<br />
Eccessiva “pulizia” del sottobosco.<br />
Introduzione <strong>di</strong> ittiofauna.<br />
Specie Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)<br />
Sistematica Classe Reptilia, or<strong>di</strong>ne Testu<strong>di</strong>nes, famiglia Emy<strong>di</strong>dae<br />
Nome comune Testuggine palustre europea<br />
Livello <strong>di</strong> protezione La specie è inclusa in allegato II e IV della Direttiva 92/43/CE,<br />
in appen<strong>di</strong>ce 2 della convenzione <strong>di</strong> Berna ed è tutelata dalla<br />
LR 15/06 RER.<br />
Categoria nella Lista Rossa Regionale: VU A2ce<br />
Distribuzione Diffusa in tutto il bacino del Me<strong>di</strong>terraneo dal nord Africa<br />
all'Europa meri<strong>di</strong>onale e centrale fino a Danimarca e Polonia, a<br />
est si spinge attraverso l'Anatolia, le coste del Mar Caspio fino<br />
al Lago d'Aral.<br />
Habitat ed ecologia Specie stenoecia, frequenta esclusivamente ambienti umi<strong>di</strong>,<br />
prevalentemente planiziali, come stagni, pozze, palu<strong>di</strong>, maceri,<br />
casse <strong>di</strong> espansione, cave esaurite e canali <strong>di</strong> bonifica. Sia in<br />
ambiente aperto che in aree boscate.<br />
Legata agli ambienti acquatici, particolarmente attiva nelle ore<br />
crepuscolari e notturne passa le ore <strong>di</strong>urne a termoregolarsi su<br />
rive, tronchi, pietre o altro materiale emergente dall'acqua, è<br />
molto schiva e si immerge appena avverte un pericolo<br />
rimanendo immersa parecchi minuti. La pausa invernale (tra<br />
novembre e febbraio) avviene sia sotto terra in vicinanza dei<br />
corpi idrici che nel fondo fangoso degli stessi.<br />
Predatore <strong>di</strong> Invertebrati sia acquatici che terrestri e Vertebrati<br />
(specialmente piccoli Pesci e Anfibi), si nutre anche <strong>di</strong><br />
materiale vegetale.<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 52<br />
L'accoppiamento ha luogo in primavera, prevalentemente in<br />
acqua, la femmina tra fine primavera ed inizio estate depone<br />
un numero variabile <strong>di</strong> uova (solitamente
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 53<br />
e cataste <strong>di</strong> legna. Attiva da marzo a ottobre ha abitu<strong>di</strong>ni<br />
<strong>di</strong>urne con preferenza per le ore più fresche del giorno. Ha<br />
abitu<strong>di</strong>ni fossorie.<br />
Predatore <strong>di</strong> invertebrati (prevalentemente Anelli<strong>di</strong>, Molluschi e<br />
Artropo<strong>di</strong>) e occasionalmente <strong>di</strong> piccoli vertebrati (piccoli Rettili<br />
o Anfibi).<br />
Specie ovovivipara. Gli accoppiamenti avvengono in primavera<br />
e le femmine partoriscono prevalentemente in estate.<br />
Distribuzione in Italia In Italia è presente quasi ovunque.<br />
Occupa una fascia altitu<strong>di</strong>nale che va dal livello del mare ai<br />
2300 m. Segnalazioni in progressivo decremento con<br />
l'aumento <strong>di</strong> quota.<br />
Distribuzione in Regione Ampiamente <strong>di</strong>stribuito in tutto il territorio regionale tra il livello<br />
del mare e i 1750 m (prevalenza
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 54<br />
aggressivi nei confronti <strong>di</strong> altri maschi in periodo riproduttivo.<br />
Predatore: si nutre prevalentemente <strong>di</strong> Invertebrati ma anche<br />
<strong>di</strong> piccoli Vertebrati (piccoli Anfibi,Rettili e Mammiferi) e uova <strong>di</strong><br />
piccoli Uccelli, saltuariamente <strong>di</strong> bacche.<br />
Gli accoppiamenti avvengono in primavera e le uova deposte<br />
dopo poco più <strong>di</strong> un mese sotto cumuli <strong>di</strong> pietre, spaccature<br />
nella roccia, tra ra<strong>di</strong>ci o in piccole buche. La schiusa avviene<br />
dalla metà <strong>di</strong> agosto.<br />
Distribuzione in Italia In Italia peninsulare e Sicilia è presente quasi ovunque.<br />
Distribuzione altitu<strong>di</strong>nale: fino ai 2100 m (prevalenza < 600 m)<br />
Distribuzione in Regione Ampiamente <strong>di</strong>stribuito in tutto il territorio regionale tra il livello<br />
del mare e i 1400 m (prevalenza
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 55<br />
e buona arrampicatrice. I maschi sono territoriali in particolare<br />
in periodo riproduttivo quando ingaggiano anche<br />
combattimenti.<br />
Predatore: si nutre <strong>di</strong> Invertebrati, prevalentemente <strong>di</strong><br />
Artropo<strong>di</strong>.<br />
L'accoppiamento avviene prevalentemente in primavera ma<br />
può ripetersi fino a 3 volte. Le uova vengono deposte in buche,<br />
fessure <strong>di</strong> muri o rocce e sotto cumuli <strong>di</strong> detriti. La schiusa<br />
avviene in estate.<br />
Distribuzione in Italia In Italia è ampiamente <strong>di</strong>stribuita a nord e al centro, più<br />
rarefatta a sud dove presenta una <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong>scontinua, è<br />
assente da Sicilia, Sardegna e Puglia non garganica.<br />
Distribuzione altitu<strong>di</strong>nale per l'Italia: 0-2275 m<br />
Distribuzione in Regione Specie frequente e comune tra il livello del mare e i 1700 m.<br />
Stato <strong>di</strong> conservazione in Italia La specie non sembra essere in contrazione e non appare in<br />
uno stato conservazionistico sfavorevole.<br />
Stato <strong>di</strong> conservazione in Regione Appare in buono stato <strong>di</strong> conservazione.<br />
Distribuzione nel sito Non sono <strong>di</strong>sponibili dati quantitativi.<br />
Fattori <strong>di</strong> minaccia Utilizzo <strong>di</strong> prodotti chimici in agricoltura.<br />
Rimozione degli elementi naturali ed ecotonali degli agro<br />
ecosistemi.<br />
Collisione con autoveicoli durante la termoregolazione anche<br />
in strade a bassa percorrenza.<br />
Persecuzione.<br />
Specie Podarcis sicula (Rafinesque, 1810)<br />
Sistematica Classe Reptilia, or<strong>di</strong>ne Squamata, famiglia Lacertidae<br />
Nome comune Lucertola campestre<br />
Livello <strong>di</strong> protezione La specie è inclusa in allegato IV della <strong>di</strong>rettiva 92/43/CEE, in<br />
appen<strong>di</strong>ce 3 della convenzione <strong>di</strong> Berna ed è tutelata dalla LR<br />
15/06 RER.<br />
Categoria nella Lista Rossa Regionale: LC.<br />
Distribuzione Distribuita prevalentemente in Italia, isole comprese, è<br />
<strong>di</strong>stribuita anche in Slovenia e Croazia fino al Montenegro.<br />
Habitat ed ecologia Più termofila e xerofila della congenere, pre<strong>di</strong>lige prati ben<br />
drenati lungo i corsi d'acqua, margini <strong>di</strong> zone boscate,<br />
cespuglieti, arbusteti, habitat ruderali, aree urbane<br />
(specialmente parchi e giar<strong>di</strong>ni).<br />
Attiva dalla fine dell'inverno all'inizio dell'autunno, eliofila e<br />
<strong>di</strong>urna, agile e veloce. I maschi sono territoriali in particolare in<br />
periodo riproduttivo quando ingaggiano anche combattimenti.<br />
Predatore: si nutre <strong>di</strong> Invertebrati, prevalentemente <strong>di</strong><br />
Artropo<strong>di</strong>, in particolari con<strong>di</strong>zioni può integrare la <strong>di</strong>eta con<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 56<br />
parti vegetali.<br />
Si accoppia in periodo primaverile fino a due volte. Le uova<br />
vengono deposte in buche, fessure <strong>di</strong> muri o rocce e sotto<br />
cumuli <strong>di</strong> detriti. La schiusa avviene in estate.<br />
Distribuzione in Italia In Italia è ampiamente <strong>di</strong>stribuita.<br />
Distribuzione altitu<strong>di</strong>nale per l'Italia: 0-1000 m (segnalazioni a<br />
quote decisamente maggiori solo per la Sicilia)<br />
Distribuzione in Regione Distribuzione più frammentaria della congenere è <strong>di</strong>ffusa<br />
soprattutto lungo la costa e le aree planiziali e collinari.<br />
Fascia altitu<strong>di</strong>nale 0-1000 m (prevalenza
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 57<br />
ai bor<strong>di</strong> <strong>di</strong> strade e sentieri. Trascorre la latenza invernale in<br />
rifugi tra le ra<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> alberi, vecchie tane, spaccature del terreno<br />
e altre cavità, anche <strong>di</strong> notevoli <strong>di</strong>mensioni, dove talvolta<br />
possono svernare assieme anche parecchi in<strong>di</strong>vidui.<br />
Predatore <strong>di</strong> vertebrati, specialmente Sauri, micromammiferi,<br />
piccoli Uccelli (anche uova) e altri serpenti.<br />
I maschi ingaggiano combattimenti rituali per contendersi le<br />
femmine con le quali si accoppiano a primavera inoltrata. Le<br />
uova (5-15) vengono deposte all'inizio dell'estate<br />
prevalentemente in cavità, buche, spaccature delle rocce e<br />
cumuli <strong>di</strong> materiale vegetale o <strong>di</strong> detriti.<br />
Distribuzione in Italia Tutta Italia, sia peninsulare che insulare. Distribuzione<br />
altitu<strong>di</strong>nale per l'Italia: 0-1800 m<br />
Distribuzione in Regione Ampiamente <strong>di</strong>stribuito tra 0 e 1700 m.<br />
Stato <strong>di</strong> conservazione in Italia Specie piuttosto comune non presenta grossi problemi.<br />
Stato <strong>di</strong> conservazione in Regione La specie non sembra essere in contrazione, non appare in<br />
uno stato conservazionistico particolarmente sfavorevole.<br />
Distribuzione nel sito Non sono <strong>di</strong>sponibili dati quantitativi. La specie sembra<br />
comunque ben <strong>di</strong>stribuita.<br />
Fattori <strong>di</strong> minaccia Utilizzo <strong>di</strong> prodotti chimici in agricoltura.<br />
Collisione con autoveicoli durante la termoregolazione.<br />
Persecuzione.<br />
Specie Natrix natrix (Lacépède, 1789)<br />
Sistematica Classe Reptilia, or<strong>di</strong>ne Squamata, famiglia Colubridae<br />
Nome comune Natrice dal collare<br />
Livello <strong>di</strong> protezione La specie è inclusa in appen<strong>di</strong>ce 3 della convenzione <strong>di</strong> Berna<br />
ed è tutelata dalla LR 15/06 RER.<br />
Categoria nella Lista Rossa Regionale: LC.<br />
Distribuzione Specie ad ampia <strong>di</strong>ffusione, entità euro-centroasiatica-<br />
magrebina. È presente in quasi tutta Europa, fino al 67°<br />
parallelo nord. Si trova in Asia occidentale e Centrale e ad<br />
oriente sino al lago Baikal.<br />
Habitat ed ecologia Specie euriecia meno acquatica delle congeneri, da giovane<br />
preferisce ambienti umi<strong>di</strong> con acqua dolce o salmastra <strong>di</strong> ogni<br />
tipo, sia lentici che lotici, naturali e artificiali, gli esemplari<br />
maturi frequentano anche ambienti boschivi, prati, pascoli,<br />
zone rocciose e aree antropizzate.<br />
Attiva prevalentemente da marzo a ottobre è una specie<br />
soprattutto <strong>di</strong>urna, agile sia in ambiente terrestre che<br />
acquatico, in estate è più attiva nelle prime ore della giornata e<br />
al tramonto, in primavera e autunno è attiva nelle ore centrali<br />
della giornata. Se <strong>di</strong>sturbata può attuare tanatosi, emissioni <strong>di</strong><br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 58<br />
liquido nauseabondo dalla cloaca oppure imitare la Vipera<br />
nelle movenze e nella forma del capo.<br />
Predatore soprattutto <strong>di</strong> Anfibi e più raramente <strong>di</strong> Pesci,<br />
micromammiferi Sauri e ni<strong>di</strong>acei. I giovani si nutrono <strong>di</strong> piccoli<br />
Anfibi e loro larve, Invertebrati e piccoli Pesci.<br />
Gli accoppiamenti avvengono <strong>di</strong> norma a primavera inoltrata,<br />
talvolta in autunno (in tal caso le femmine svernano con le<br />
uova fecondate), più maschi compiono combattimenti<br />
ritualizzati e corteggiano contemporaneamente più femmine.<br />
La deposizione avviene in estate in ammassi <strong>di</strong> detriti vegetali<br />
e non, cavità, buchi, muretti a secco, la schiusa avviene a<br />
tarda estate.<br />
Distribuzione in Italia In Italia è ampiamente <strong>di</strong>ffusa, è rara e localizzata solo in<br />
Sardegna. Distribuzione altitu<strong>di</strong>nale per l'Italia: 0-2300 m (il<br />
numero <strong>di</strong> segnalazioni decresce all'aumentare della quota).<br />
Distribuzione in Regione Specie ampiamente <strong>di</strong>ffusa e ben <strong>di</strong>stribuita tra 0 e 1900 m<br />
(prevalenza
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 59<br />
è in grado <strong>di</strong> arrampicarsi con facilità su cespugli e alberi, dove<br />
lo si può osservare anche in termoregolazione. Teme sia il<br />
caldo eccessivo che il freddo. Non particolarmente timido può<br />
essere avvicinato notevolmente prima <strong>di</strong> darsi alla fuga. Lo<br />
svernamento avviene principalmente in cavità del terreno o <strong>di</strong><br />
muri.<br />
Predatore: prevalentemente micromammiferi, Sauri, Uccelli<br />
(prevalentemente uova e ni<strong>di</strong>acei). Le prede vengono uccise<br />
per costrizione.<br />
Gli accoppiamenti avvengono a tarda primavera, tra i maschi<br />
avvengono combattimenti ritualizzati. La deposizione delle<br />
uova avviene dopo 2-3 mesi in cumuli <strong>di</strong> detriti vegetali e non,<br />
cavità, e muretti a secco. La schiusa avviene a tarda estate.<br />
Distribuzione in Italia In Italia è presente in tutte le regioni. Distribuzione<br />
altitu<strong>di</strong>nale per l'Italia: 0-1600 m (prevalenza 300-900 m).<br />
Distribuzione in Regione Diffusa in tutto il territorio regionale con maggior frequenza nel<br />
settore appenninico, in pianura è rarefatta e confinata nelle<br />
zone che mantengono un certo grado <strong>di</strong> naturalità.<br />
Occupa la fascia tra 0 e 1300 m (soprattutto 200-600m).<br />
Stato <strong>di</strong> conservazione in Italia La specie presenta rarefazioni localizzate pur essendo comune<br />
in molte zone.<br />
Stato <strong>di</strong> conservazione in Regione Si evidenzia una notevole rarefazione della specie in aree<br />
planiziali che pongono la specie in uno stato<br />
conservazionistico non ottimale.<br />
Distribuzione nel sito Non sono <strong>di</strong>sponibili dati.<br />
Fattori <strong>di</strong> minaccia Utilizzo <strong>di</strong> prodotti chimici in agricoltura.<br />
2.4.9 Specie <strong>di</strong> Uccelli <strong>di</strong> interesse comunitario<br />
Rimozione <strong>di</strong> siepi e boschetti - eliminazione elementi naturali<br />
dell’agro-ecosistema e degli ecotoni<br />
Gestione non razionale delle aree boschive e loro riduzione.<br />
Eccessiva “pulizia” del sottobosco.<br />
Collisione con autoveicoli.<br />
2.4.9.1 Tarabusino, Ixobrychus minutus, (Linneus, 1766)<br />
Phylum: Chordata<br />
Classe: Aves<br />
Or<strong>di</strong>ne: Ciconiformes<br />
Famiglia: Ardeidae<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 60<br />
Convenzioni <strong>di</strong> tutela internazionali<br />
Convenzione <strong>di</strong> Berna. Ap. 2; Direttiva 409/79/CEE: Ap. 1; L. 157/1992: specie protetta; LR<br />
IUCN: NT; BirdLife: SPEC 3.<br />
Ecologia<br />
Specie solitaria e territoriale, prevalentemente crepuscolare ed elusiva. Volo potente, con<br />
battute rapide e a scatti. S alimenta prevalentemente <strong>di</strong> insetti acquatici, sia adulti sia larve<br />
oltre a Pesci, Anfibi e vegetali; possono aggiungersi Crostacei, Gasteropo<strong>di</strong>, piccoli Anfibi e<br />
Rettili oltre a uova <strong>di</strong> piccoli uccelli palustri. Ni<strong>di</strong>fica nei canneti, talvolta anche su rami bassi<br />
<strong>di</strong> arbusti o alberi appena sopra il livello dell’acqua; può utilizzare anche ni<strong>di</strong> artificiali. La<br />
deposizione avviene fra inizio maggio e giugno. Le uova, 4-6 schiudono dopo 17-18 giorni <strong>di</strong><br />
incubazione.<br />
Distribuzione generale<br />
Specie a <strong>di</strong>stribuzione paleartico-paleotropicale-australasiana. E’ presente come ni<strong>di</strong>ficante<br />
in tutta Europa esclusa Irlanda, Gran Bretagna, Scan<strong>di</strong>navia e Russia settentrionale. La<br />
popolazione europea è stimata <strong>di</strong> 60.000-120.000 coppie (BirdLife International 2004). I<br />
quartieri <strong>di</strong> svernamento sono ubicati in Africa a sud del Sahara e la specie è soggetta a<br />
fluttuazioni probabilmente a causa degli anni siccitosi nella fascia del Sahel. In Italia la<br />
specie è ni<strong>di</strong>ficante, presente in tutte le regioni, più <strong>di</strong>ffusa nella pianura Padano-Veneta e<br />
più scarsa e localizzata nel centro-sud. La consistenza della popolazione ni<strong>di</strong>ficante italiana<br />
è stata stimata in 1.300-2.300 coppie per il periodo 1995-2002 con trend della popolazione<br />
fluttuante<br />
Distribuzione locale<br />
Specie estiva ni<strong>di</strong>ficante, migratrice regolare e svernante irregolare. Presente in tutte le<br />
provincie dell’Emilia-Romagna come ni<strong>di</strong>ficante e migratore da metà marzo a metà ottobre.<br />
Censimenti della popolazione ni<strong>di</strong>ficante sono stati compiuti nella pianura bolognese nel<br />
1984 (57-87 coppie in 24 siti), nel 1994 (92-113 cp in 38 siti) nel 2003 (58-59 coppie)<br />
(Tinarelli 2004, Marchesi e Tinarelli 2007). Sulla base <strong>di</strong> censimenti in aree campione nel<br />
periodo 1994-1997 era stata avanzata una stima prudenziale <strong>di</strong> 150 coppie nelle provincie <strong>di</strong><br />
Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena, 100 coppie nel Bolognese e 250 coppie nel<br />
Ferrarese e in Romagna e quin<strong>di</strong> almeno 500 coppie complessivamente per l’Emilia-<br />
Romagna con tendenza alla <strong>di</strong>minuzione (Foschi e Tinarelli 1999). Tale stima è stata portata<br />
per il periodo 2001-2003 a 400-500 coppie con trend della popolazione in decremento<br />
(Tinarelli 2007). Mancano censimenti sulla maggior parte dell’areale regionale per<br />
aggiornare la stima della popolazione ni<strong>di</strong>ficante, la quale, sulla base <strong>di</strong> monitoraggi in varie<br />
zone (zone umide bolognesi e ferraresi – Tinarelli ined., settore ravennate del Parco del<br />
Delta del Po – Volponi 2009) risulterebbe però in <strong>di</strong>minuzione nell’ultimo decennio. E’ stata<br />
riportata la presenza occasionale <strong>di</strong> pochi in<strong>di</strong>vidui in periodo invernale nel Bolognese nei<br />
primi anni 2000.<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 61<br />
Minacce e stato <strong>di</strong> conservazione<br />
In Emilia-Romagna i principali fattori limitanti noti per la specie sono costituiti da interventi <strong>di</strong><br />
controllo (sfalcio, trinciatura, incen<strong>di</strong>o) dei canneti e della vegetazione ripariale durante il<br />
periodo riproduttivo, specialmente lungo i canali gestiti dai consorzi <strong>di</strong> bonifica, le improvvise<br />
e consistenti variazioni del livello dell’acqua che possono comportare la sommersione dei<br />
ni<strong>di</strong>, il degrado e la riduzione delle zone idonee per l’alimentazione, la presenza della Nutria<br />
il cui impatto negativo sul canneto avviene soprattutto nelle zone marginali dove il<br />
Tarabusino costruisce il nido, il <strong>di</strong>sturbo antropico nei siti <strong>di</strong> ni<strong>di</strong>ficazione (pescatori, turisti,<br />
escursionisti lungo i corsi d’acqua), la collisione con i cavi <strong>di</strong> linee elettriche a me<strong>di</strong>a e ad<br />
alta tensione. Lo stato <strong>di</strong> conservazione della popolazione regionale è complessivamente<br />
insod<strong>di</strong>sfacente.<br />
2.4.9.2 Nitticora, Nycticorax nycticorax, (Linneus, 1766)<br />
Phylum: Chordata Classe: Aves Or<strong>di</strong>ne: Ciconiformes Famiglia: Ardeidae<br />
Convenzioni <strong>di</strong> tutela internazionali<br />
Convenzione <strong>di</strong> Berna. Ap. 2; Direttiva 409/79/CEE: Ap. 1; L. 157/1992: specie protetta; LR<br />
IUCN: NT; BirdLife: SPEC 3.<br />
Ecologia<br />
Specie gregaria, prevalentemente crepuscolare e notturna. Vola con battute rapide e rigide,<br />
becco rivolto verso l’alto e zampe poco visibili. L’alimentazione include anfibi, pesci, rettili,<br />
insetti adulti e larve, crostacei, anelli<strong>di</strong> e micromammiferi. La <strong>di</strong>eta dei pulcini è identica a<br />
quella degli adulti. La Nitticora è attiva al crepuscolo e durante la notte, ma nella stagione<br />
riproduttiva caccia anche durante il giorno, sovrapponendo la propria nicchia trofica con<br />
quella della Garzetta nelle aree particolarmente ricche <strong>di</strong> prede ed entrando invece in forte<br />
competizione con essa là dove il numero <strong>di</strong> prede è più scarso. Le tecniche <strong>di</strong> caccia<br />
utilizzate sono “stan<strong>di</strong>ng”, per catturare rane e pesci e “walking”, preferita per cacciare prede<br />
lente e <strong>di</strong> piccole <strong>di</strong>mensioni come girini e Artropo<strong>di</strong>. Ni<strong>di</strong>fica in colonie sia plurispecifiche sia<br />
monospecifiche, in colonie costituite da pochi ni<strong>di</strong> e talvolta anche ni<strong>di</strong> isolati, su arbusti o<br />
alberi, localmente su vegetazione palustre. La migrazione post-riproduttiva avviene tra<br />
settembre ed inizio novembre. La migrazione pre-nuziale avviene tra marzo ed aprile.<br />
Risulta evidente un notevole erratismo estivo che interessa principalmente i giovani e<br />
concentra in aree particolarmente ricche <strong>di</strong> alimentazione alcune centinaia <strong>di</strong> esemplari. La<br />
deposizione avviene fra fine marzo e fine luglio. Le uova, 3-4 schiudono dopo 21-26 giorni <strong>di</strong><br />
incubazione.<br />
Distribuzione generale<br />
Specie a <strong>di</strong>stribuzione subcosmopolita, ampiamente <strong>di</strong>ffusa nell’Europa centrale e<br />
meri<strong>di</strong>onale. Per tutta l’Europa sono state stimate 63.000-87.000 coppie ni<strong>di</strong>ficanti<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 62<br />
concentrate principalmente in Italia, Russia e Ucraina (BirdLife International 2004). Le<br />
popolazioni europee svernano principalmente nell’Africa equatoriale e lungo il Nilo, quella<br />
italiana sverna nei Paesi del Golfo <strong>di</strong> Guinea. In Italia la specie è <strong>di</strong>ffusa ed abbondante<br />
soprattutto nella Pianura Padana, principalmente in Lombar<strong>di</strong>a e Piemonte mentre è più<br />
scarsa e localizzata nell'Italia peninsulare ed insulare. Nel 2001-2002 sono state censite<br />
13.244 coppie ni<strong>di</strong>ficanti in Italia (Fasola et al. 2005) e il trend della popolazione risulta<br />
fluttuante. La maggior parte della popolazione italiana è migratrice sebbene dagli anni '70<br />
alcuni gruppi svernino in Pianura Padana. Sulla base dei censimenti degli uccelli acquatici<br />
svernanti coor<strong>di</strong>nati dall’ISPRA (ex INFS) la consistenza della popolazione presente in<br />
gennaio in Italia è stata stimata <strong>di</strong> 300-500 in<strong>di</strong>vidui per il periodo 1991-2000 (Brichetti e<br />
Fracasso 2003).<br />
Distribuzione locale<br />
Specie estiva ni<strong>di</strong>ficante, migratrice regolare e parzialmente svernante. Per l’Emilia-<br />
Romagna sono state rilevate 2.858-2.923 coppie ni<strong>di</strong>ficanti nel 2001-2002 con un trend della<br />
popolazione in <strong>di</strong>minuzione (archiv. AsOER); quest’ultimo censimento ha permesso <strong>di</strong><br />
rilevare complessivamente 28 garzaie 1 nel Piacentino con 25 ni<strong>di</strong>, 5 nel Parmense con 856<br />
ni<strong>di</strong>, 2 nel Reggiano con 215 ni<strong>di</strong>, 4 nel Modenese con 110-140 ni<strong>di</strong>, 6 nel Bolognese con<br />
214 ni<strong>di</strong>, 8 nel Ferrarese con 1.218-1.238 ni<strong>di</strong>, 1 nel Ravennate con circa 200 ni<strong>di</strong> e 1 nel<br />
Riminese con 30-35 ni<strong>di</strong>. Per gli anni successivi sono <strong>di</strong>sponibili dati aggiornati solo per<br />
alcune garzaie del Bolognese, Ferrarese e Modenese (archiv. AsOER) e del Parco del Delta<br />
del Po (Volponi 2009). L’andamento della consistenza della popolazione nell'arco dell'anno è<br />
stato documentato nel 1992 per il territorio della provincia <strong>di</strong> <strong>Bologna</strong> (Boldreghini et al.<br />
1995) ed è rappresentativo dell’andamento annuale della popolazione regionale e mostra un<br />
picco delle presenze nella seconda metà <strong>di</strong> giugno e nella prima <strong>di</strong> luglio e il minimo nei<br />
mesi invernali. Nel periodo 1994-2009 la Nitticora ha svernato in Regione con un numero <strong>di</strong><br />
esemplari oscillante tra 8 (1995) e 122 (2007), con ampie fluttuazioni interannuali. La<br />
Nitticora risulta inoltre concentrata in pochi siti; per l’intero periodo sono noti solo 12 siti che<br />
hanno ospitato almeno l’1% della popolazione svernante in Regione: recentemente, poi, solo<br />
2 siti hanno ospitato fino ad oltre l’85 % degli esemplari svernanti (Val Campotto - FE e<br />
Vallette <strong>di</strong> Ostellato - FE). L’analisi dei dati per il periodo 2000-2009 in<strong>di</strong>ca un decremento<br />
pari all’8% annuo (I.C. 0-16%) statisticamente però non significativo. La specie rientra tra<br />
quelle per le quali i valori rilevati durante i censimenti invernali sono solitamente molto al <strong>di</strong><br />
sotto della consistenza reale a causa della presenza <strong>di</strong> in<strong>di</strong>vidui anche al <strong>di</strong> fuori delle zone<br />
umide censite (lungo i corsi d’acqua) e/o <strong>di</strong> <strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong> censimento (zone umide con densa<br />
copertura vegetale che impe<strong>di</strong>sce il censimento esaustivo degli in<strong>di</strong>vidui presenti, elusività<br />
degli in<strong>di</strong>vidui presenti).<br />
Minacce e stato <strong>di</strong> conservazione<br />
In Emilia-Romagna i principali fattori limitanti noti per la specie sono costituiti dal <strong>di</strong>sturbo<br />
antropico nei siti <strong>di</strong> ni<strong>di</strong>ficazione, dall’abbattimento illegale in alcune zone destinate<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 63<br />
soprattutto all’itticoltura, dal degrado e la riduzione delle zone idonee per l’alimentazione a<br />
causa della riduzione e scomparsa <strong>di</strong> piccoli pesci e anfibi e della semplificazione delle<br />
comunità vegetali determinata dall’eccessiva eutrofizzazione, dalla Nutria, da interventi <strong>di</strong><br />
controllo della vegetazione durante il periodo riproduttivo, dalla <strong>di</strong>struzione e la<br />
trasformazione dei siti <strong>di</strong> ni<strong>di</strong>ficazione e in particolare delle aree boscate presenti nelle<br />
golene dei fiumi per praticarvi la pioppicoltura intensiva, la collisione con i cavi <strong>di</strong> linee<br />
elettriche a me<strong>di</strong>a tensione, la morte per intrappolamento in reti <strong>di</strong> copertura <strong>di</strong> bacini per<br />
l’itticoltura intensiva. Lo stato <strong>di</strong> conservazione della popolazione regionale è<br />
complessivamente insod<strong>di</strong>sfacente.<br />
2.4.9.3 Garzetta, Egretta garzetta, (Linneus, 1766)<br />
Phylum: Chordata Classe: Aves Or<strong>di</strong>ne: Ciconiformes Famiglia: Ardeidae<br />
Convenzioni <strong>di</strong> tutela internazionali<br />
Convenzione <strong>di</strong> Berna. Ap. 2; Direttiva 409/79/CEE: Ap. 1; L. 157/1992: specie protetta; LR<br />
IUCN: NT; BirdLife: SPEC 3.<br />
Ecologia<br />
Specie gregaria, solitaria o in piccoli gruppi nel momento dell’alimentazione, o associata<br />
spesso ad altre congeneri. Al <strong>di</strong> fuori del periodo riproduttivo gli in<strong>di</strong>vidui presenti in un'area<br />
si radunano in dormitori generalmente situati su alberi o in canneti. L’alimentazione è in<br />
relazione al sito: nella Pianura Padana utilizza risaie e sponde fluviali mentre sulle coste<br />
dell’alto Adriatico vengono preferite le acque salmastre. La caccia è effettuata camminando<br />
nell’acqua bassa. Le specie catturate includono girini, adulti <strong>di</strong> Rana, larve <strong>di</strong> Odonati e <strong>di</strong><br />
altri Insetti, non <strong>di</strong>sdegna pesci e crostacei. I movimenti migratori verso quartieri <strong>di</strong><br />
svernamento più meri<strong>di</strong>onali avvengono a partire da agosto fino a ottobre mentre il ritorno<br />
verso Nord si registra tra febbraio e aprile. Nel periodo invernale vengono per lo più<br />
frequentati fiumi e canali d’acqua dolce, allevamenti <strong>di</strong> pesce e canali. Può ni<strong>di</strong>ficare sia in<br />
colonie monospecifiche, sia in colonie miste con altri Ardei<strong>di</strong>, specialmente con la Nitticora.<br />
Ni<strong>di</strong>fica su arbusti o alberi e vegetazione erbacea e palustre. La deposizione avviene fra<br />
aprile e metà agosto. Depone 3-5 che schiudono dopo 21-25 giorni <strong>di</strong> icubazione.<br />
Distribuzione generale<br />
Specie a <strong>di</strong>stribuzione paleartico-paleotropicale-australasiana, ampiamente, anche se<br />
<strong>di</strong>scontinuamente, <strong>di</strong>ffusa nell’Europa centro-meri<strong>di</strong>onale. La stima più recente per l’Europa<br />
in<strong>di</strong>ca 68.000-94.000 coppie ni<strong>di</strong>ficanti prevalentemente in Spagna, Italia, Francia,<br />
Azerbaijan e Russia (BirdLife International 2004). La popolazione europea sverna nei Paesi<br />
me<strong>di</strong>terranei e in Africa. In Italia è presente soprattutto nella pianura Padana e in particolare<br />
nella zona delle risaie tra Lombar<strong>di</strong>a e Piemonte dove colonie <strong>di</strong> centinaia <strong>di</strong> ni<strong>di</strong> sono<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 64<br />
<strong>di</strong>stanti tra loro 4-10 km. Diffusa ed abbondante anche nelle zone umide costiere dell'alto<br />
Adriatico e più localizzata nelle regioni centro-meri<strong>di</strong>onali e in Sardegna. Nel 2001-2002<br />
sono state censite 15.730 coppie ni<strong>di</strong>ficanti in Italia (Fasola et al. 2005) e il trend della<br />
popolazione risulta fluttuante. Sulla base dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti<br />
coor<strong>di</strong>nati dall’ISPRA (ex INFS) la consistenza della popolazione presente in gennaio in<br />
Italia è stata stimata <strong>di</strong> 5.000-9.000 in<strong>di</strong>vidui per il periodo 1991-2000 (Brichetti e Fracasso<br />
2003).<br />
Distribuzione locale<br />
Specie estiva ni<strong>di</strong>ficante, migratrice regolare e parzialmente svernante. Per l’Emilia-<br />
Romagna sono state stimate 2.200-2.300 coppie nel periodo 1994-1997 (Foschi e Tinarelli<br />
1999) e rilevate 1.908-1.935 coppie nel 2001-2002; il censimento effettuato nel 2001 ha<br />
permesso <strong>di</strong> rilevare complessivamente 24 garzaie: 1 nel Piacentino con 6 ni<strong>di</strong>, 3 nel<br />
Parmense con 121 ni<strong>di</strong>, 1 nel Reggiano con 2 ni<strong>di</strong>, 3 nel Modenese con 105-115 ni<strong>di</strong>, 5 nel<br />
Bolognese con 59-62 ni<strong>di</strong>, 9 nel Ferrarese con 1.107-1.117 ni<strong>di</strong>, 1 nel Ravennate con circa<br />
500 ni<strong>di</strong> e 1 nel Riminese con 8-12 ni<strong>di</strong>. Per gli anni successivi sono <strong>di</strong>sponibili dati<br />
aggiornati solo per alcune garzaie del Bolognese, Ferrarese e Modenese (archiv. AsOER) e<br />
del Parco del Delta del Po (Volponi 2009) da cui risultano marcate fluttuazioni a livello locale.<br />
In Regione le colonie vengono abbandonate imme<strong>di</strong>atamente dopo la ni<strong>di</strong>ficazione: la<br />
<strong>di</strong>spersione verso aree caratterizzate da maggiore <strong>di</strong>sponibilità alimentare, in particolare il<br />
comprensorio costiero tra Ravenna e la foce del Po <strong>di</strong> Volano, si registra già a giugno.<br />
Invece, i movimenti migratori verso quartieri <strong>di</strong> svernamento più meri<strong>di</strong>onali avvengono a<br />
partire da agosto fino a ottobre mentre il ritorno verso Nord si registra tra febbraio e aprile.<br />
La specie, durante l’inverno, frequenta svariate tipologie ambientali: pressoché tutte le<br />
categorie <strong>di</strong> Zone Umide, come definite dalla convenzione <strong>di</strong> Ramsar. La <strong>di</strong>stribuzione<br />
invernale interessa tutta la Regione. Il complesso <strong>di</strong> ecosistemi che caratterizza il territorio<br />
costiero emiliano-romagnolo, costituito da lagune, saline, palu<strong>di</strong> d’acqua dolce, valli da<br />
pesca, foci, ha ospitato porzioni comprese fra il 55 e il 70% del popolamento; dei 21 siti <strong>di</strong><br />
importanza regionale ben 17 appartengono a quest’area geografica, tra questi spiccano<br />
Pialassa della Baiona, Salina <strong>di</strong> Cervia e il comprensorio vallivo comacchiese, la somma dei<br />
siti che lo costituiscono registra presenze che contribuiscono per un 15-20% alla costituzione<br />
della popolazione svernante in Emilia-Romagna. Nelle pianure interne frequenta gli ambienti<br />
palustri relitti o recentemente ripristinati, i bacini per l’itticoltura; i bacini rinaturalizzati <strong>di</strong> ex<br />
cave e i corsi d’acqua, che talvolta ha risalito fino al cuore dell’Appennino. I dati raccolti con i<br />
censimenti IWC evidenziano sia un incremento della popolazione, sia un’espansione <strong>di</strong><br />
areale, infatti, tutti gli in<strong>di</strong>catori dei tre perio<strong>di</strong>, me<strong>di</strong>e, minimi, massimi, numero <strong>di</strong> siti<br />
occupati e percentuale <strong>di</strong> siti occupati rispetto ai censiti, sono in aumento. L’analisi stati per il<br />
decennio 2000-2009 in<strong>di</strong>ca un moderato incremento, pari al 5% annuo (I.C. 3-7%).<br />
Minacce e stato <strong>di</strong> conservazione<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 65<br />
In Emilia-Romagna i principali fattori limitanti noti per la specie sono dovuti al <strong>di</strong>sturbo<br />
antropico nei siti <strong>di</strong> ni<strong>di</strong>ficazione, agli abbattimenti illegali in alcune zone destinate soprattutto<br />
all’itticoltura, al degrado e la riduzione delle zone idonee per l’alimentazione a causa della<br />
riduzione/scomparsa <strong>di</strong> piccoli pesci e anfibi e della semplificazione delle comunità vegetali<br />
determinata dall’eccessiva eutrofizzazione, dalla Nutria, da interventi <strong>di</strong> controllo della<br />
vegetazione durante il periodo riproduttivo, alla <strong>di</strong>struzione e la trasformazione dei siti <strong>di</strong><br />
ni<strong>di</strong>ficazione e in particolare delle aree boscate presenti nelle golene dei fiumi per praticarvi<br />
la pioppicoltura intensiva, alla collisione con i cavi <strong>di</strong> linee elettriche a me<strong>di</strong>a tensione, alla<br />
morte per intrappolamento in reti <strong>di</strong> copertura <strong>di</strong> bacini per l’itticoltura intensiva, al <strong>di</strong>sturbo<br />
venatorio. Lo stato <strong>di</strong> conservazione della popolazione regionale è complessivamente sicuro.<br />
3.4.7.4 Aquila reale, Aquila crysaetos, (Linnaeus, 1758)<br />
Phylum: Chordata; Classe: Aves; Or<strong>di</strong>ne: Accipitriformes; Famiglia: Accipitridae<br />
Convenzioni internazionali<br />
Convenzione <strong>di</strong> Berna Ap. 3; Convenzione <strong>di</strong> Bonn Ap. 2; Direttiva 409/79/CEE: Ap. 1; L.<br />
157/1992: specie particolarmente protetta; L.R. della Toscana 56/2000; Allegato A; LR<br />
IUCN: Least Concern; LR N: vulnerabile; LR RT: rara; LR RER: me<strong>di</strong>a priorità <strong>di</strong><br />
conservazione.<br />
Ecologia<br />
Specie stanziale e ni<strong>di</strong>ficante in Italia, manifesta uno stretto legame col territorio<br />
d’appartenenza, dove, una volta inse<strong>di</strong>atasi, può costruire <strong>di</strong>versi ni<strong>di</strong> scegliendo anno per<br />
anno quello più adatto. Ni<strong>di</strong>fica in ambienti montani rocciosi con praterie e pascoli, più<br />
raramente ni<strong>di</strong>fica su albero. L’alimentazione è costituita prevalentemente da Uccelli e<br />
Mammiferi ma anche da Rettili ed occasionalmente Insetti e Pesci. Si nutre anche <strong>di</strong><br />
carogne. Sull’Appennino centrale i mammiferi costituiscono il 71% delle prede (86% della<br />
biomassa; la lepre è la specie più predata) e gli uccelli il 29% (14% della biomassa; Ragni et<br />
al. 1986). La deposizione avviene fra marzo e aprile, max. metà marzo-inizio aprile.<br />
Distribuzione<br />
Specie a <strong>di</strong>stribuzione oloartica. In Europa è presente dalla Scan<strong>di</strong>navia alla Sicilia e dalla<br />
Penisola Iberica al Caucaso. la popolazione europea è piccola ma risulta complessivamente<br />
stabile dal 1970, ni<strong>di</strong>ficano in<strong>di</strong>cativamente 8.400-11.000 coppie, (BirdLife International<br />
2004). In Italia l’areale riproduttivo comprende le Alpi, gli Appennini e le zone montuose <strong>di</strong><br />
Sardegna e Sicilia. Dopo un decremento demografico dal XIX secolo, dovuto alle<br />
persecuzioni, la popolazione ha mostrato negli ultimi decenni un leggero incremento con la<br />
rioccupazione <strong>di</strong> siti storici. La stima più recente della popolazione ni<strong>di</strong>ficante è <strong>di</strong> 486-547<br />
coppie, <strong>di</strong> cui 368-404 sulle Alpi, 62-73 nell’Appennino, 41-53 in Sardegna e 15-17 in Sicilia<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 66<br />
(Fasce e Fasce 2007). Non sono <strong>di</strong>sponibili dati significativi per stimare la consistenza della<br />
popolazione svernante in Italia.<br />
Distribuzione locale<br />
Specie sedentaria ni<strong>di</strong>ficante, migratrice e svernante irregolare. La popolazione riproduttiva<br />
regionale costituisce circa il 2% <strong>di</strong> quella nazionale. Almeno l’80% della popolazione<br />
regionale ni<strong>di</strong>ficante e almeno il 30% <strong>di</strong> quella svernante è all’interno <strong>di</strong> siti Natura 2000.<br />
Nell’Appennino Tosco- Emiliano sono conosciute 16-22 coppie ni<strong>di</strong>ficanti <strong>di</strong> cui 9 nei confini<br />
dell’Emilia-Romagna nel 2003. In Emilia-Romagna è essenzialmente sedentaria; si riproduce<br />
nella parte me<strong>di</strong>o-alta dell’Appennino ma è presente in tutta la fascia collinare e montana<br />
fino al limite della pianura. La popolazione è stabile o in leggero incremento e sono possibili<br />
altre 2-3 coppie (una in Romagna e 1-2 in Emilia) <strong>di</strong> cui non sono noti i siti <strong>di</strong> ni<strong>di</strong>ficazione<br />
(Bonora et al. 2007). Le coppie sono più concentrate nelle parte ovest della regione e più<br />
isolate nell’Appennino romagnolo. La specie rientra in un piano <strong>di</strong> monitoraggio delle specie<br />
rare e minacciate, iniziato anni fa. La coppia storica della Lama viene continuamente<br />
monitorata dal 1993 a oggi. Le segnalazioni sono numerose, tuttavia è accertata la presenza<br />
<strong>di</strong> una sola coppia ni<strong>di</strong>ficante nella Foresta della Lama, che si è riprodotta più o meno<br />
regolarmente dall’inizio degli anni ’90 del ‘900 (Ceccarelli et al. 2001 e 2005) anche se non si<br />
esclude la possibile presenza <strong>di</strong> una seconda coppia (Ceccarelli et al. 2005). Diversi sono gli<br />
avvistamenti <strong>di</strong> una coppia e <strong>di</strong> esemplari adulti nell’area del Falterona, nelle montagne <strong>di</strong><br />
Premilcuore-S.Benedetto e nell’area compresa fra M. Lavane e S.Benedetto, che potrebbero<br />
avvalorare questa tesi.<br />
Minacce e stato <strong>di</strong> conservazione<br />
Le minacce principali possono essere in<strong>di</strong>viduate nel <strong>di</strong>sturbo ai siti <strong>di</strong> ni<strong>di</strong>ficazione, nella<br />
persecuzione <strong>di</strong>retta ai ni<strong>di</strong> e nel bracconaggio, nella per<strong>di</strong>ta e/o riduzione degli ambienti <strong>di</strong><br />
caccia e alimentazione nella scarsa <strong>di</strong>sponibilità trofica, nella presenza <strong>di</strong> linee elettriche e<br />
nella lotta ai nocivi. Lo stato <strong>di</strong> conservazione della popolazione regionale è<br />
complessivamente sod<strong>di</strong>sfacente.<br />
2.4.9.4 Falco pecchiaiolo, Pernis apivorus, (Linnaeus, 1758)<br />
Phylum:Chordata, Classe: Aves; Or<strong>di</strong>ne: Accipitriformes; Famiglia: Accipitridae<br />
Convenzioni internazionali<br />
Convenzione <strong>di</strong> Berna: Ap. 3; Convenzione <strong>di</strong> Bonn: Ap. 2; Direttiva 409/79/CEE: Ap. I; L.<br />
157/1992: specie particolarmente protetta; L.R. della Toscana 56/2000: Allegato A; LR IUCN<br />
Red List: Least Concern; LR N: vulnerabile; LR degli Uccelli Ni<strong>di</strong>ficanti in Toscana (non<br />
minacciata).<br />
Ecologia<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 67<br />
Specie fortemente gregaria in migrazione ma solitaria nel periodo riproduttivo. Ha interazioni<br />
aggressive verso altri rapaci (es. Poiana) all'interno del territorio riproduttivo. Durante la<br />
caccia esplora il terreno e manovra con agilità a quote me<strong>di</strong>o-basse, sia in ambienti aperti<br />
che boscosi. Oltre che da posatoi poco elevati, può cercare le prede anche sul terreno dove<br />
si muove con destrezza. L’alimentazione è costituita prevalentemente da larve e pupe <strong>di</strong><br />
Imenotteri sociali, in particolare vespe, calabroni e bombi raccolti all'interno del nido che<br />
viene <strong>di</strong>strutto; le api rientrano raramente nella <strong>di</strong>eta. In perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> carenza <strong>di</strong> Imenotteri<br />
vengono cacciati altri Insetti ma anche Anfibi, Rettili ed Uccelli. Durante la riproduzione<br />
frequenta un’ampia gamma <strong>di</strong> ambienti forestali, comprendenti sia conifere sia caducifoglie,<br />
intercalati a spazi aperti, dal livello del mare a 1.200-1.300 m. s.l.m.. Durante la migrazione è<br />
osservabile in quasi tutte le tipologie ambientali, comprese le aree coltivate <strong>di</strong> pianura. La<br />
deposizione avviene fra metà maggio e giugno.<br />
Distribuzione<br />
Specie estiva ni<strong>di</strong>ficante e migratrice regolare in quasi tutta l’Europa, presente dalla<br />
Scan<strong>di</strong>navia alle regioni me<strong>di</strong>terranee. La stima più recente per l’Europa in<strong>di</strong>ca 110.000-<br />
160.000 con trend stabile (BirdLife International 2004). Trascorre l’inverno in Africa a sud del<br />
Sahara. In Italia è presente da aprile ad ottobre. La consistenza della popolazione ni<strong>di</strong>ficante<br />
italiana è stata stimata in 600-1.000 (Brichetti e Fracasso 2003). Ni<strong>di</strong>ficante <strong>di</strong>ffuso e<br />
comune nell’arco alpino e nell’Appennino settentrionale, più scarso e localizzato<br />
nell’Appennino centro meri<strong>di</strong>onale, raro e localizzato in Puglia, Calabria e Pianura Padana,<br />
assente in Sicilia e Sardegna. A livello europeo lo stato <strong>di</strong> conservazione è considerato<br />
sicuro (BirdLife International 2004).<br />
Distribuzione locale<br />
In Emilia-Romagna appare più <strong>di</strong>ffuso nei settori centrale ed occidentale dell’Appennino, con<br />
presenze fino a quote pedecollinari; più raro e localizzato nell’Appennino romagnolo<br />
(Ceccarelli et al. 2007). Per l’intero territorio regionale è stata prodotta una stima <strong>di</strong> 100-300<br />
coppie (Chiavetta 1992) che potrebbe essere aggiornata a 150-200 per il periodo 1995-2007<br />
(Tinarelli ined.). Stimate 20-30 coppie, per il periodo 1990-1999, nel SIC-ZPS Contrafforte<br />
Pliocenico. Lo stato <strong>di</strong> conservazione della popolazione regionale è complessivamente<br />
sicuro. Circa il 10% della popolazione regionale ni<strong>di</strong>ficante è concentrata in Aree Protette<br />
Regionali. Il 20-30% della popolazione regionale ni<strong>di</strong>ficante è all’interno <strong>di</strong> siti Natura 2000.<br />
Minacce e stato <strong>di</strong> conservazione<br />
Taglio in<strong>di</strong>scriminato e incen<strong>di</strong>o della vegetazione, uso <strong>di</strong> pestici<strong>di</strong> in agricoltura,<br />
inquinamento dei suoli, delle falde e dei corsi d'acqua, bracconaggio (inclusa la lotta ai<br />
cosiddetti "nocivi") con bocconi avvelenati e fucili, presenza <strong>di</strong> linee elettriche che causano<br />
elettrocuzioni (morte per fulminazione) e collisioni con gli uccelli.<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 68<br />
2.4.9.5 Nibbio bruno, Milvus migrans, (Boddaret, 1783)<br />
Phylum:Chordata Classe: Aves Or<strong>di</strong>ne: Accipitriformes Famiglia: Accipitridae<br />
Convenzioni internazionali<br />
Convenzione <strong>di</strong> Berna: Ap. 3; Convenzione <strong>di</strong> Bonn: Ap. 2; Direttiva 409/79/CEE: Ap. I; L.<br />
157/1992: specie particolarmente protetta; L.R. della Toscana 56/2000: Allegato A; LR<br />
IUCN: Least Concern; LR N: vulnerabile; LR RT: non minacciata; LR RER: alta priorità <strong>di</strong><br />
conservazione; BirdLife International: SPEC 3.<br />
Ecologia<br />
E' una specie molto sociale, ni<strong>di</strong>fica e si alimenta in modo gregario (colonie riproduttive o<br />
raggruppamenti presso concentrazioni <strong>di</strong> cibo o dormitori); migrazione solitaria o in piccoli<br />
gruppi. Volo agile, battito ampio ed elastico, ali leggermente arcuate in volteggio ed<br />
estremità delle remiganti <strong>di</strong>stanziate; planata con “mano” rivolta all’in<strong>di</strong>etro. Maestro del<br />
volteggio, sfrutta anche le più deboli correnti ascensionali. La specie è molto adattabile e<br />
opportunista soprattutto dal punto <strong>di</strong> vista trofico. L’alimentazione è costituita<br />
prevalentemente da prede vive (Anfibi, Pesci, Rettili, ni<strong>di</strong>acei <strong>di</strong> Uccelli, micromammiferi) ma<br />
sfrutta ampiamente la necrofagia, recuperando carogne nelle <strong>di</strong>scariche e lungo le strade.<br />
Dieta estremamente varia con marcate fluttuazioni locali e stagionali. I pesci rappresentano<br />
in molte zone una componente molto importante della <strong>di</strong>eta e la tendenza all'ittiofagia è nota<br />
in tutto l'areale. Specie ni<strong>di</strong>ficante in Italia. Ni<strong>di</strong>fica in ambienti planiziali o rupestri confinanti<br />
con zone erbose aperte. La deposizione avviene fra aprile e giugno, max. fine aprile-metà<br />
maggio. Solitamente depone dalle 2-3 uova, il periodo <strong>di</strong> incubazione è <strong>di</strong> 31-32 giorni.<br />
Distribuzione<br />
Specie a <strong>di</strong>stribuzione paleartico-paleotropicale- australasiana. In Europa è presente dal 65°<br />
parallelo alle regioni me<strong>di</strong>terranee. La stima più recente per l’Europa in<strong>di</strong>ca 64.000-100.000<br />
coppie ni<strong>di</strong>ficanti prevalentemente in Russia, Francia e Spagna (BirdLife International 2004).<br />
La popolazione europea trascorre l’inverno in Africa a sud del Sahara. L’areale riproduttivo<br />
italiano è frammentato in 4 <strong>di</strong>stinte aree: un’area prealpina e della pianura Padana, un’area<br />
tirrenica e dell’Appennino centrale, un’area dell’Appennino meri<strong>di</strong>onale e un’area in Sicilia.<br />
La consistenza della popolazione ni<strong>di</strong>ficante italiana è stata recentemente stimata in 847-<br />
1.138 coppie (Allavena et al. 2006) concentrate principalmente in Lombar<strong>di</strong>a, Trentino Alto<br />
A<strong>di</strong>ge, Basilicata e Lazio. Eccetto pochi in<strong>di</strong>vidui in Sicilia, la popolazione italiana è<br />
migratrice con areale <strong>di</strong> svernamento pressoché sconosciuto. Nell’Italia peninsulare lo<br />
svernamento è occasionale, con due casi nell’ex risaia <strong>di</strong> Bentivoglio (BO) e nella Bonifica<br />
del Mezzano (FE). La consistenza della popolazione presente in gennaio in Italia è stata<br />
stimata <strong>di</strong> 5-15 in<strong>di</strong>vidui per il periodo 1995-2002 (Brichetti e Fracasso 2003).<br />
Distribuzione locale<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 69<br />
Specie estiva ni<strong>di</strong>ficante, migratrice regolare e svernante irregolare. La specie è poco<br />
comune nella parte della pianura Padana a sud del Po. La presenza <strong>di</strong> in<strong>di</strong>vidui estivanti <strong>di</strong><br />
cui non si accerta l’attività riproduttiva è più consistente nelle province occidentali della<br />
Regione e in prossimità del Po per la maggior vicinanza alla popolazione ni<strong>di</strong>ficante<br />
presente in Lombar<strong>di</strong>a e Veneto. Per altre aree, tra cui la provincia <strong>di</strong> <strong>Bologna</strong>, il fenomeno è<br />
in regresso rispetto a uno-due decenni fa probabilmente in conseguenza della contrazione<br />
delle vicine popolazioni della pianura lombarda (Mason et al. 1999). Pochi in<strong>di</strong>vidui osservati<br />
lungo la costa adriatica nel corso <strong>di</strong> un campo <strong>di</strong> osservazione primaverile nel 2005 presso<br />
Volano (Premuda, in stampa) ed altri nelle valli a sud <strong>di</strong> Parma e <strong>di</strong> <strong>Bologna</strong> (Premuda et al.<br />
2006). Gli in<strong>di</strong>vidui in migrazione sono stimati da Chiavetta (1992) in alcune migliaia.<br />
Tuttavia finora non sono state evidenziate vie importanti per questo rapace in Emilia-<br />
Romagna.<br />
Minacce e stato <strong>di</strong> conservazione<br />
I fattori limitanti noti per la specie in Emilia-Romagna sono la <strong>di</strong>struzione degli habitat <strong>di</strong><br />
ni<strong>di</strong>ficazione (boschi ripariali e planiziali) e il <strong>di</strong>sturbo antropico durante la riproduzione,<br />
compreso l’abbattimento <strong>di</strong> pioppi coltivati durante il periodo riproduttivo (alcune coppie<br />
ni<strong>di</strong>ficano anche in pioppeti artificiali), la realizzazione <strong>di</strong> lavori idraulico-forestali e<br />
l’eliminazione della vegetazione naturale per realizzare pioppeti artificiali nelle aree golenali,<br />
il bracconaggio con bocconi avvelenati e fucili, la presenza <strong>di</strong> linee elettriche, specialmente<br />
quelle a me<strong>di</strong>a tensione, che causano elettrocuzioni e collisioni nelle quali periscono<br />
soprattutto giovani dell’anno ai loro primi voli, la realizzazione <strong>di</strong> centrali eoliche in aree <strong>di</strong><br />
alimentazione e transito. In bibliografia sono riportati come fattori limitanti per la specie:<br />
l’inquinamento da pestici<strong>di</strong> e metalli pesanti, la chiusura <strong>di</strong> <strong>di</strong>scariche urbane in cui si<br />
alimenta. Lo stato <strong>di</strong> conservazione della popolazione regionale è complessivamente<br />
insod<strong>di</strong>sfacente.<br />
2.4.9.6 Albanella minore, Circus pygargus, (Linnaeus, 1758)<br />
Phylum: Chordata Classe: Aves Or<strong>di</strong>ne: Accipitriformes Famiglia: Accipitridae<br />
Convenzioni internazionali<br />
Convenzione <strong>di</strong> Berna: Ap. 3; Convenzione <strong>di</strong> Bonn: Ap. 2; Direttiva 409/79/CEE: Ap. I; L.<br />
157/1992: specie particolarmente protetta; L.R. della Toscana 56/2000: Allegato A; LR<br />
IUCN: Least Concern; LR N: vulnerabile; LR RER: me<strong>di</strong>a priorità <strong>di</strong> conservazione.<br />
Ecologia<br />
Specie solitaria o gregaria in migrazione; a volte in gruppi più consistenti in dormitori comuni,<br />
anche con congeneri. Volo leggero ed aggraziato, volo <strong>di</strong> caccia tipico dei Circus (battute<br />
rapide alternate a brevi planate con ali a V) a bassa quota, a pochi metri dal terreno, ma<br />
molto elegante. Si posa sul terreno o su bassi posatoi (es. pali <strong>di</strong> recinzioni e cespugli<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 70<br />
secchi). Si alimenta continuativamente durante il giorno, cacciando a terra. L’alimentazione è<br />
costituita prevalentemente da piccoli mammiferi e piccoli uccelli e loro pulli, rettili, anfibi e<br />
invertebrati. Specie ni<strong>di</strong>ficante in Italia. Ni<strong>di</strong>fica in ambienti aperti, preferibilmente <strong>di</strong> collina.<br />
Ni<strong>di</strong>fica isolata o in piccoli gruppi, con densità varie e <strong>di</strong>stanza tra i ni<strong>di</strong> in genere superiore a<br />
100 m. La deposizione avviene tra fine aprile e inizio giugno. Le uova in genere 3-5<br />
schiudono dopo un periodo <strong>di</strong> incubazione <strong>di</strong> 28-29 giorni. I movimenti migratori avvengono<br />
tra fine marzo e metà aprile e tra metà agosto e ottobre con movimenti <strong>di</strong>spersivi a fine luglio<br />
e in agosto.<br />
Distribuzione<br />
Specie a <strong>di</strong>stribuzione euroturanica. L’areale riproduttivo europeo si estende dalla<br />
Danimarca e dal sud dell’Inghilterra al Me<strong>di</strong>terraneo e dal Portogallo alla Russia. La stima<br />
più recente della popolazione ni<strong>di</strong>ficante in Europa in<strong>di</strong>ca 35.000-65.000 coppie concentrate<br />
prevalentemente in Russia, Francia, Bielorussia, Polonia, Ucraina e Spagna (BirdLife<br />
International 2004). La popolazione europea sverna in Africa a sud del Sahara fino al<br />
Sudafrica. In Italia ni<strong>di</strong>fica nella pianura Padano-Veneta, nell’Italia centrale e in Sardegna; è<br />
assente nell’Italia meri<strong>di</strong>onale e in Sicilia. La consistenza della popolazione ni<strong>di</strong>ficante<br />
italiana è stata stimata in 260-380 coppie per il periodo 1995-2002 (Brichetti e Fracasso<br />
2003).<br />
Distribuzione locale<br />
Specie migratrice regolare e ni<strong>di</strong>ficante. In Emilia-Romagna può essere rilevata su tutto il<br />
territorio durante le migrazioni mentre ni<strong>di</strong>fica dal livello del mare a circa 500 m <strong>di</strong> altitu<strong>di</strong>ne<br />
in tutte le province, con popolazioni più consistenti nel Ferrarese (almeno 15-20 coppie per il<br />
periodo 2000-2006), Bolognese (20 coppie per il periodo 2003-2006) e Parmense (15-18<br />
coppie nel 1994-1995). Le stime per la Regione vanno da 70-140 (Chiavetta 1992) a 85-110<br />
(Gustin et al. 1997) a 70-140 (Marchesi e Tinarelli 2007) e, seppure in mancanza <strong>di</strong><br />
censimenti contemporanei in più province, quest’ultima può essere sostanzialmente<br />
confermata per il periodo 2001-2006; il trend della popolazione sembra stabile con<br />
fluttuazioni entro l’intervallo precedentemente definito. Il movimento migratorio interessa la<br />
Regione con importanti contingenti, ipotizzati in 2.000-3.000 in<strong>di</strong>vidui (Chiavetta 1992). La<br />
specie ha colonizzato per l’alimentazione e la riproduzione le varie tipologie <strong>di</strong> zone umide,<br />
prati umi<strong>di</strong> in particolare, e i complessi macchia radura realizzati e gestiti me<strong>di</strong>ante<br />
l’applicazione <strong>di</strong> misure agroambientali a partire dal 1995: 7 coppie nel 2002-2003 (5-10%<br />
della popolazione regionale).<br />
Minacce e stato <strong>di</strong> conservazione<br />
La specie è soggetta a numerosi fattori limitanti tra i quali i più rilevanti sono la <strong>di</strong>struzione<br />
dei ni<strong>di</strong> durante la trebbiatura <strong>di</strong> frumento e orzo e lo sfalcio dei prati (questo fattore è<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 71<br />
probabilmente il più importante), la scomparsa dei prati permanenti, l’abbandono e/o la<br />
trasformazione delle aree marginali coltivate a cereali in collina, l’uso <strong>di</strong> bioci<strong>di</strong> (rodentici<strong>di</strong> in<br />
particolare) in agricoltura che riducono il numero <strong>di</strong> prede <strong>di</strong>sponibili e che causano<br />
intossicazioni/avvelenamenti, il bracconaggio (inclusa la lotta ai “nocivi”) con bocconi<br />
avvelenati, la presenza <strong>di</strong> linee elettriche che causano elettrocuzioni e collisioni, il <strong>di</strong>sturbo<br />
antropico causato da curiosi durante la ni<strong>di</strong>ficazione, la realizzazione <strong>di</strong> centrali eoliche in<br />
aree <strong>di</strong> alimentazione, ni<strong>di</strong>ficazione e transito.<br />
2.4.9.7 Lanario, Falco biarmicus, (Temmink, 1825)<br />
Phylum: Chordata Classe: Aves Or<strong>di</strong>ne: Falconiformes Famiglia: Falconiidae<br />
Convenzioni internazionali<br />
Convenzione <strong>di</strong> Berna: Ap. 2; Convenzione <strong>di</strong> Bonn: Ap. 2; Direttiva 409/79/CEE: Ap. I; L.<br />
157/1992: specie particolarmente protetta; L.R. della Toscana 56/2000: Allegato A; LR<br />
IUCN: Least Concern; LR RER: estinto; BirdLife International: SPEC 3.<br />
Ecologia<br />
Specie generalmente solitaria o al massimo in piccoli gruppi familiari. Volo con battute<br />
potenti, rapide e poco ampie; in volteggio le ali sono piatte o leggermente abbassate con le<br />
punte rivolte verso l’alto. Caccia sia in volo esplorativo sia all’agguato. Nel primo caso<br />
velleggia ad altitu<strong>di</strong>ni elevate sfruttando veloci picchiate, nel secondo caso si posa su rocce<br />
dominanti (talvolta anche tralicci o alberi secchi). Ghermisce la preda sia in aria sia sul<br />
terreno. Talvolta caccia in coppia. La <strong>di</strong>eta <strong>di</strong>pende ampiamente dalla situazione locale in cui<br />
è presente il territorio <strong>di</strong> ni<strong>di</strong>ficazione. Pre<strong>di</strong>lige Uccelli <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni piccole e me<strong>di</strong>e,<br />
Micromammiferi e Chirotteri. Ni<strong>di</strong>fica su pareti rocciose in ambienti collinari stepposi oltre a<br />
zone aperte, aride o desertiche. Le coppie si inse<strong>di</strong>ano tra gennaio e marzo. La deposizione<br />
avviene fra fine gennaio e inizio aprile, max. fine febbraio-marzo. Le uova, 3-4 (2), sono <strong>di</strong><br />
color bianco con macchiettature evidenti rosso-marrone, giallastre o porpora. Periodo <strong>di</strong><br />
incubazione <strong>di</strong> 30-35 giorni.<br />
Distribuzione<br />
Specie a <strong>di</strong>stribuzione me<strong>di</strong>terraneo-afrotropicale. L’areale riproduttivo della specie è molto<br />
vasto e comprende l’Europa meri<strong>di</strong>onale, la Turchia, il Caucaso, l’Africa settentrionale e<br />
orientale e la Penisola Arabica. In Europa e nella Penisola Anatolica è presente la<br />
sottospecie feldeggii. La stima più recente della popolazione ni<strong>di</strong>ficante della sottospecie<br />
feldeggii è <strong>di</strong> 261-472 coppie concentrate prevalentemente in Turchia e Italia (Andreotti e<br />
Leonar<strong>di</strong> 2007). L’areale riproduttivo in Italia è <strong>di</strong>scontinuo e si estende dall’Appennino<br />
emiliano (provincia <strong>di</strong> <strong>Bologna</strong>) sino alla Sicilia meri<strong>di</strong>onale. E’ assente in Sardegna e circa<br />
metà della popolazione nazionale è concentrata in Sicilia. L’Italia ospita l’80% della<br />
popolazione europea che è stata stimata nel 2003-2004 <strong>di</strong> 140-172 (Andreotti e Leonar<strong>di</strong><br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 72<br />
2007). Non sono <strong>di</strong>sponibili dati significativi per stimare la consistenza della popolazione<br />
svernante in Italia.<br />
Distribuzione locale<br />
Specie sedentaria e ni<strong>di</strong>ficante, migratrice regolare e svernante irregolare. In Emilia-<br />
Romagna è presente tutto l’anno e i siti riproduttivi sono situati nella fascia collinare fino ad<br />
altitu<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> 1.000 m.. L’Appennino Bolognese rappresenta il limite settentrionale dell’areale<br />
<strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione in Europa e una delle aree italiane in cui la presenza della specie è da tempo<br />
nota e stu<strong>di</strong>ata (Bonora e Chiavetta 1975). Ad un primo periodo <strong>di</strong> circa 20 anni durante i<br />
quali poche coppie si sono riprodotte regolarmente in provincia <strong>di</strong> <strong>Bologna</strong>, per un breve<br />
periodo nel Modenese (Giannella e Rabacchi 1992) e una volta in Val Marecchia (Foschi e<br />
Gellini 1987), ha fatto seguito un periodo <strong>di</strong> circa un decennio in cui la specie era osservata<br />
saltuariamente presso falesie precedentemente occupate senza però prove <strong>di</strong> riproduzione;<br />
al termine degli anni ’90 una coppia si è inse<strong>di</strong>ata stabilmente su una parete<br />
precedentemente occupata, seguita successivamente da 1 o 2 altre coppie in altre aree del<br />
Bolognese (Martelli e Rigacci 2003). La consistenza accertata per il 2003 era <strong>di</strong> 3 coppie<br />
(Bonora et al. 2007) e per gli anni successivi può essere stimata <strong>di</strong> 3-4 (archiv. AsOER).<br />
Minacce e stato <strong>di</strong> conservazione<br />
Tra i fattori limitanti noti per la specie (Andreotti e Leonar<strong>di</strong> 2007, Bonora et al. 2007) si<br />
possono annoverare il <strong>di</strong>sturbo antropico al nido causato da arrampicatori, escursionisti,<br />
fotografi, cacciatori nei siti <strong>di</strong> ni<strong>di</strong>ficazione in marzo-aprile e durante il periodo <strong>di</strong><br />
inse<strong>di</strong>amento delle coppie in gennaio-febbraio, abbattimenti illegali (due immaturi trovati feriti<br />
dal 2000 nel Riminese e nella pianura bolognese), presenza <strong>di</strong> linee elettriche che causano<br />
elettrocuzioni (folgorazioni) e collisioni, realizzazione <strong>di</strong> centrali eoliche in aree <strong>di</strong><br />
alimentazione, ni<strong>di</strong>ficazione e transito (probabilmente una delle minacce più rilevanti per il<br />
futuro della specie), prelievo illegale <strong>di</strong> uova e/o pulcini dal nido, uso <strong>di</strong> pestici<strong>di</strong> in<br />
agricoltura, avvelenamento da piombo, probabilmente anche la cattura accidentale nelle<br />
trappole per corvi<strong>di</strong>, forse anche la competizione con il Falco pellegrino. Lo stato <strong>di</strong><br />
conservazione della popolazione regionale è complessivamente me<strong>di</strong>ocre a causa dei<br />
numerosi fattori <strong>di</strong> minaccia. La popolazione riproduttiva regionale costituisce il 2% <strong>di</strong> quella<br />
nazionale.<br />
2.4.9.8 Falco pellegrino, Falco peregrinus, (Tunstall, 1771)<br />
Phylum: Chordata; Classe: Aves; Or<strong>di</strong>ne: Falconiformes; Famiglia: Falconidae<br />
Convenzioni internazionali<br />
Convenzione <strong>di</strong> Berna Ap. 2; Convenzione <strong>di</strong> Bonn Ap. 2; Direttiva 409/79/CEE: Ap. 1; L.<br />
157/1992: specie particolarmente protetta; L.R. della Toscana 56/2000; Allegato A; LR<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 73<br />
IUCN: Least Concern; LR N: vulnerabile; LR RT: rara; LR RER: me<strong>di</strong>a priorità <strong>di</strong><br />
conservazione; BirdLife International: SPEC 3.<br />
Ecologia<br />
Specie generalmente solitaria o a volte in piccoli gruppi familiari, in migrazione può formare<br />
raggruppamenti <strong>di</strong> al massimo una decina d’in<strong>di</strong>vidui. Volo con battute potenti e molto rapide<br />
ma piuttosto rigide; in volteggio tiene le ali piatte o leggeremente sollevate a V. Caccia <strong>di</strong><br />
norma in volo esplorativo ghermendo le prede in aria dopo inseguimenti o picchiate. Per la<br />
caccia frequenta <strong>di</strong>versi ambienti, soprattutto quelli aperti per sfruttare al massimo le sue<br />
caratteristiche aeree. Talvolta ghermisce la preda anche sul terreno. Può fare<br />
eccezionalmente lo “spirito santo”. Talvolta caccia in coppia con adeguate strategie. Specie<br />
altamente specializzata nella cattura <strong>di</strong> Uccelli. L’alimentazione è costituita occasionalmente<br />
anche da Chirotteri e piccoli mammiferi. Specie ni<strong>di</strong>ficante in Italia. Specie tipicamente<br />
rupicola, utilizza per la ni<strong>di</strong>ficazione pareti rocciose naturali ma anche, sempre più spesso,<br />
e<strong>di</strong>fici in ambiente urbano; Ni<strong>di</strong>fica in ambienti rocciosi costieri, insulari ed interni. Nel Parco<br />
sfrutta come habitat per la riproduzione le pareti della marnoso-arenacea, a quote comprese<br />
tra i 400 e i 600 m <strong>di</strong> quota. La deposizione avviene fra metà febbraio e inizio aprile. Le<br />
uova, 3-4 schiudono doèo un periodo <strong>di</strong> incubazione <strong>di</strong> 29-32 giorni.<br />
Distribuzione<br />
E’ specie cosmopolita, <strong>di</strong>stribuita con varie sottospecie in gran parte del mondo. Presente<br />
ovunque in Europa, con popolazioni migratrici nelle regioni settentrionali e sedentarie in<br />
quelle centrali e meri<strong>di</strong>onali; nel continente sono valutate 12.000-25.000, coppie con trend <strong>di</strong><br />
moderato aumento, concentrate in Spagna, Turchia, Russia e Groenlan<strong>di</strong>a (BirdLife<br />
International 2004). In Italia il Pellegrino è sedentario, scarso e localizzato nell’arco alpino e<br />
negli Appennini, più <strong>di</strong>ffuso nelle due isole maggiori dove si trova quasi la metà della<br />
popolazione italiana, stimata per il periodo 2000-2001 in 826-1048 coppie (Brichetti e<br />
Fracasso 2003). Per l’Emilia-Romagna sono state accertate 45 coppie <strong>di</strong>stribuite in tutta la<br />
fascia collinare e montana, con espansione recente anche verso zone urbanizzate <strong>di</strong> pianura<br />
(Bonora et al. 2007).<br />
Distribuzione locale<br />
Specie sedentaria e ni<strong>di</strong>ficante, migratrice regolare e svernante. L’areale riproduttivo della<br />
specie comprende la fascia collinare e montana ed è in atto nell’ultimo decennio la tendenza<br />
ad espandersi in zone ad altitu<strong>di</strong>ni maggiori e soprattutto ad occupare aree antropizzate<br />
della pianura (2 coppie ni<strong>di</strong>ficanti a <strong>Bologna</strong>, una nel polo chimico <strong>di</strong> Ferrara, una su una<br />
ciminiera <strong>di</strong> una centrale elettrica a Piacenza, vari in<strong>di</strong>vidui, forse ni<strong>di</strong>ficanti, che frequentano<br />
il centro storico <strong>di</strong> Parma, Modena e Forlì). La consistenza della popolazione ni<strong>di</strong>ficante in<br />
Emilia- Romagna era stimata <strong>di</strong> 20-40 coppie nei primi anni ’90 (Chiavetta 1992); per il 2003<br />
sono state accertate 45 coppie e stimate 61 coppie con trend della popolazione in marcato<br />
incremento negli ultimi anni (Bonora et al. 2007). Pur non <strong>di</strong>sponendo <strong>di</strong> conteggi<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 74<br />
contemporanei su tutto il territorio regionale, si può confermare la tendenza all’incremento<br />
della popolazione ni<strong>di</strong>ficante anche per gli anni successivi. Nella provincia <strong>di</strong> <strong>Bologna</strong> ad<br />
esempio era presente una sola coppia ad inizio anni ’70; la popolazione è cresciuta poi<br />
assestandosi per lungo tempo a valori <strong>di</strong> circa 5 coppie. A metà anni ’90 erano presenti 7<br />
coppie con altre in via <strong>di</strong> inse<strong>di</strong>amento. Dal 1999 si è assistito al passaggio da 11 coppie alle<br />
19 del 2003 e alle 24 del 2007. Al <strong>di</strong> fuori del periodo riproduttivo è osservabile in tutto il<br />
territorio regionale e in particolare nelle zone umide e negli ambienti aperti ricchi <strong>di</strong> piccoli<br />
uccelli. La popolazione svernante è <strong>di</strong>fficile da stimare poiché è composta da in<strong>di</strong>vidui sia<br />
sedentari sia in transito. Anche il trend della popolazione svernante in Emilia-Romagna dagli<br />
anni ’90 è probabilmente in aumento.<br />
Minacce e stato <strong>di</strong> conservazione<br />
La specie è in espansione negli ultimi anni e sembra godere <strong>di</strong> buona salute. Le possibili<br />
minacce riguardano il <strong>di</strong>sturbo ai siti <strong>di</strong> ni<strong>di</strong>ficazione, elettrocuzione, avvelenamento<br />
secondario per ingestione <strong>di</strong> prede avvelenate, utilizzo <strong>di</strong> pestici<strong>di</strong>, abbattimenti illegali,<br />
cattura accidentale nelle trappole per corvi<strong>di</strong>, scomparsa dell’Habitat. Lo stato <strong>di</strong><br />
conservazione della popolazione regionale è complessivamente sod<strong>di</strong>sfacente ma la<br />
popolazione è limitata.<br />
2.4.9.9 Succiacapre, Caprimulgus europaeus, (Linnaeus, 1758)<br />
Phylum: Chordata Classe: Aves Or<strong>di</strong>ne: Caprimulgiformes Famiglia: Caprimulgidae<br />
Convenzioni internazionali<br />
Convenzione <strong>di</strong> Berna: Ap. 2; Direttiva 409/79/CEE: Ap. 1; L. 157/1992: specie protetta; L.R.<br />
della Toscana 56/2000: Allegato A; LR IUCN: Least Concern; LR N: a più basso rischio; LR<br />
RT: non minacciata; BirdLife International: SPEC 2.<br />
Ecologia<br />
Specie molto elusiva <strong>di</strong>fficile da rilevare se non attraverso l’ascolto del canto territoriale<br />
emesso dai maschi; è spesso confusa con rapaci notturni. Trascorre il giorno posato sul<br />
terreno nel sottobosco o su un ramo basso, restando immobile, a rischio <strong>di</strong> essere<br />
calpestato. L’alimentazione è costituita quasi esclusivamente da Insetti (Lepidotteri notturni,<br />
Coleotteri, Ditteri, Odonati ecc.). Specie crepuscolare e notturna <strong>di</strong> indole territoriale, può<br />
aggregarsi in gruppi <strong>di</strong> poche decine <strong>di</strong> in<strong>di</strong>vidui in migrazione o in siti <strong>di</strong> riposo <strong>di</strong>urni. Volo<br />
leggero ed agile, con frequenti cambi <strong>di</strong> <strong>di</strong>rezione e planate e fasi <strong>di</strong> “spirito santo”. Ni<strong>di</strong>fica<br />
su suoli o versanti cal<strong>di</strong> e secchi, anche con affioramenti rocciosi, ai margini <strong>di</strong> zone aperte.<br />
La deposizione avviene fra maggio e metà agosto, max. fine maggio-metà giugno.<br />
Distribuzione<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 75<br />
Specie politipica a <strong>di</strong>stribuzione eurocentroasiatico-me<strong>di</strong>terranea. L’areale <strong>di</strong> riproduzione<br />
comprende l’Europa, il Maghreb occidentale, il Me<strong>di</strong>o Oriente e parte dell’Asia fino alla Cina.<br />
La stima più recente della popolazione ni<strong>di</strong>ficante in Europa in<strong>di</strong>ca 470.000-1.000.000<br />
coppie (BirdLife International 2004). Sverna in Africa a sud del Sahara. La popolazione<br />
europea è grande ma soggetta ad un moderato declino dal 1970 (BirdLife International<br />
2004). In Italia la specie è <strong>di</strong>ffusa come ni<strong>di</strong>ficante in tutte le regioni ad eccezione delle<br />
vallate alpine più interne, <strong>di</strong> vaste zone della Pianura Padana, <strong>di</strong> parte della Puglia e <strong>di</strong> gran<br />
parte della Sicilia. La stima più recente della popolazione ni<strong>di</strong>ficante in Italia è <strong>di</strong> 10.000-<br />
30.000 coppie per il periodo 1995-2004 e trend della popolazione in decremento (Brichetti e<br />
Fracasso 2006). La presenza della specie come svernante in Italia è occasionale.<br />
Distribuzione locale<br />
Specie migratrice regolare e ni<strong>di</strong>ficante. Almeno il 50% della popolazione regionale<br />
ni<strong>di</strong>ficante è all’interno <strong>di</strong> siti Natura 2000. È presente da aprile a settembre e ni<strong>di</strong>fica in tutta<br />
l’area appenninica, dalle zone pedecollinari ad altitu<strong>di</strong>ni elevate, nelle conoi<strong>di</strong> dei corsi<br />
d’acqua appenninici e su alcune isole fluviali del Po dell’Emilia occidentale; ni<strong>di</strong>fica anche<br />
nelle formazioni boschive delle pinete costiere ma è assente nel resto della pianura centro-<br />
orientale. Considerando le informazioni riportate dagli atlanti provinciali e da censimenti<br />
effettuati in aree significative è possibile stimare una popolazione ni<strong>di</strong>ficante in Emilia-<br />
Romagna negli anni ’90 <strong>di</strong> 1.150-1.700 coppie. Il trend della popolazione è probabilmente in<br />
decremento ma mancano censimenti ripetuti su vaste aree. La specie almeno fino a pochi<br />
anni fa occupava ancora quasi molti dei siti dov’era conosciuta in passato (Tellini Florenzano<br />
et al. 2001) ed era in<strong>di</strong>cata, sia pure con il beneficio del dubbio, come stabile da Ceccarelli et<br />
al. (2001); le segnalazioni recenti relativamente numerose nel versante romagnolo<br />
sembrano in<strong>di</strong>care, almeno in questo settore, che la specie sia ancora ben <strong>di</strong>ffusa tuttavia.<br />
Stato <strong>di</strong> conservazione e minacce<br />
Lo stato <strong>di</strong> conservazione della popolazione regionale è complessivamente insod<strong>di</strong>sfacente<br />
poiché gli habitat utilizzati per l’alimentazione dalla specie sono in regresso. Le minacce<br />
principali vengono dalla <strong>di</strong>struzione e frammentazione degli habitat <strong>di</strong> riproduzione e<br />
alimentazione; riduzione dell’attività agricola e zootecnica tra<strong>di</strong>zionale con siepi e alberature;<br />
avvelenamento secondario ed utilizzo <strong>di</strong> pestici<strong>di</strong>.<br />
2.4.9.10 Martin pescatore, Alcedo atthis, (Linneus, 1758)<br />
Phylum: Chordata Classe: Aves Or<strong>di</strong>ne: Coraciiformes Famiglia: Alce<strong>di</strong>nidae<br />
Convenzioni internazionali<br />
Convenzione <strong>di</strong> Berna (Ap. 2); Direttiva 409/79/CEE: Appen<strong>di</strong>ce 1; L. 157/1992: specie<br />
protetta; L.R. della Toscana 56/2000: Allegato A; IUCN Red List: Least Concern; BirdLife:<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 76<br />
SPEC 3; Lista Rossa Animali d’Italia-Vertebrati (a più basso rischio); Lista Rossa degli<br />
Uccelli Ni<strong>di</strong>ficanti in Toscana (non minacciata).<br />
Ecologia<br />
Uccello <strong>di</strong> piccole <strong>di</strong>mensioni, dalla colorazione vivace inconfon<strong>di</strong>bile, con capo grosso, coda<br />
corta e becco a pugnale. Specie territoriale in ogni periodo dell’anno. I maschi adulti tendono<br />
a <strong>di</strong>fendere i territori riproduttivi della stagione precedente, mentre i territori invernali della<br />
femmina possono essere appena a<strong>di</strong>acenti o ad<strong>di</strong>rittura con<strong>di</strong>visi. Volo molto rapido, radente<br />
all’acqua, con battute veloci e regolari e traiettoria rettilinea. La specie è legata strettamente<br />
agli ambienti acquatici sulle cui sponde, in tratti anche piccoli, sabbiosi o argillose,<br />
preferibilmente privi <strong>di</strong> vegetazione, scava piccole gallerie ove ni<strong>di</strong>fica. Raramente utilizza<br />
cavità <strong>di</strong> altro tipo o si allontana dall’acqua. Si nutre principalmente <strong>di</strong> piccoli pesci d'acqua<br />
dolce e, in misura minore, <strong>di</strong> Insetti, pesci marini, crostacei, molluschi e anfibi (Massara &<br />
Bogliani 1994). Pre<strong>di</strong>lige acque a lento corso e poco profonde ove più facilmente cattura i<br />
piccoli pesci. La deposizione avviene fra fine marzo e agosto.<br />
Distribuzione<br />
Specie a <strong>di</strong>stribuzione paleartico-orientale. In Europa l’areale riproduttivo si estende dalla<br />
Penisola Iberica e dall’Irlanda agli Urali e dalla Scan<strong>di</strong>navia meri<strong>di</strong>onale alla regione<br />
me<strong>di</strong>terranea. La stima più recente della popolazione ni<strong>di</strong>ficante in Europa in<strong>di</strong>ca 79.000-<br />
160.000 coppie (BirdLife International 2004). Le popolazioni<br />
dell’Europa centro-settentrionale, meri<strong>di</strong>onale e balcanica sono sedentarie mentre quelle<br />
dell’Europa nord-orientale sono migratrici. La stima più recente della popolazione ni<strong>di</strong>ficante<br />
in Italia è <strong>di</strong> 6.000-16.000 coppie per il periodo 1995-2006 (Brichetti e Fracasso 2007) e<br />
trend della popolazione probabilmente stabile (BirdLife International 2004). E’ presente come<br />
ni<strong>di</strong>ficante in tutte le regioni con <strong>di</strong>stribuzione continua in quelle centro settentrionale e molto<br />
frammentata in quelle meri<strong>di</strong>onali e in Sardegna. Durante l’inverno alla popolazione<br />
sedentaria si aggiungono gli in<strong>di</strong>vidui migratori. La popolazione presente in inverno in Italia è<br />
stata stimata <strong>di</strong> oltre 30.000 in<strong>di</strong>vidui per il periodo 1995-2006 (Brichetti e Fracasso 2007).<br />
Distribuzione locale<br />
Specie sedentaria ni<strong>di</strong>ficante, migratrice regolare e svernante. E’ presente come ni<strong>di</strong>ficante<br />
in zone umide con acque sia stagnanti sia correnti, dalla costa fino a 800-900 metri, in tutte<br />
le province; tuttavia la maggior parte della popolazione è concentrata nelle zone umide <strong>di</strong><br />
pianura. Considerando le informazioni riportate dagli atlanti provinciali e da censimenti<br />
effettuati in aree significative è possibile stimare grossolanamente una popolazione<br />
ni<strong>di</strong>ficante in Emilia-Romagna negli anni ’90 <strong>di</strong> 1.045-1.730 coppie così ripartite (Piacenza<br />
120- 250 cp, Parma 85-90 cp, Reggio-Emilia 60-120 cp, Modena 60-100 cp, <strong>Bologna</strong> 200-<br />
280 cp, Ravenna 150-250 cp, Ferrara 300-500 cp, Forlì-Cesena 50-100 cp, Rimini 20-40<br />
cp). Il trend della specie è probabilmente stabile con fluttuazioni, anche marcate, in alcune<br />
province. Non vi sono informazioni sufficienti per stimare la popolazione svernante. Specie<br />
facilmente rilevabile e identificabile.<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 77<br />
Minacce e stato <strong>di</strong> conservazione<br />
Lo stato <strong>di</strong> conservazione della popolazione regionale è complessivamente insod<strong>di</strong>sfacente<br />
per il progressivo degrado degli habitat utilizzati. I fattori limitanti più significativi per la specie<br />
sono costituiti da scarsità <strong>di</strong> sponde subverticali in prossimità dei corsi d’acqua in cui<br />
scavare i ni<strong>di</strong> a galleria, eccessiva torbi<strong>di</strong>tà dell’acqua che impe<strong>di</strong>sce la caccia dei pesci,<br />
eccessivo inquinamento delle acque che limita la <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> prede, <strong>di</strong>sturbo antropico<br />
dovuto alla presenza <strong>di</strong> pescatori e bagnanti durante la stagione riproduttiva. Anche se<br />
registra locali decrementi la specie non sembra avere attualmente particolari problemi <strong>di</strong><br />
conservazione. Il Martin pescatore potrebbe essere soggetto “naturalmente” a fluttuazioni <strong>di</strong><br />
popolazione e possibili estinzioni locali.<br />
2.4.9.11 Tottavilla, Lullula arborea, (Linnaeus, 1758)<br />
Phylum: Chordata Classe: Aves Or<strong>di</strong>ne: Passeriformes Famiglia: Alau<strong>di</strong>dae<br />
Convenzioni internazionali<br />
Convenzione <strong>di</strong> Berna: Ap. 3; Direttiva 409/79/CEE: Ap. 1; L. 157/1992: specie protetta; L.R.<br />
della Toscana 56/2000: Allegato A; LR IUCN: Least Concern.<br />
Ecologia<br />
Rispetto ad altre specie <strong>di</strong> Alau<strong>di</strong>dae, la Tottavilla è d’indole meno gregaria: al <strong>di</strong> fuori della<br />
stagione riproduttiva forma gruppi costituiti al massimo da 15-20 soggetti. Nella stagione<br />
riproduttiva è solitaria e territoriale, ma può accadere che alcune coppie ni<strong>di</strong>fichino a breve<br />
<strong>di</strong>stanza le une dalle altre. Volo leggero e sfarfalleggiante con battute rapide seguite da fase<br />
con ali chiuse; andatura ondulata. I maschi effettuano il volo canoro. Nella stagione<br />
riproduttiva la Tottavilla si nutre principalmente <strong>di</strong> insetti <strong>di</strong> me<strong>di</strong>e <strong>di</strong>mensioni e <strong>di</strong> ragni,<br />
mentre nel resto dell’anno ingerisce soprattutto semi, foglie e gemme <strong>di</strong> specie appartenenti<br />
ai generi Betula e Corylus. I giovani vengono alimentati soprattutto con invertebrati <strong>di</strong> me<strong>di</strong>e<br />
<strong>di</strong>mensioni. Ni<strong>di</strong>fica in ambienti erbosi con boschetti e cespugli sparsi. La deposizione<br />
avviene fra metà marzo e inizio agosto.<br />
Distribuzione<br />
Specie politipica con <strong>di</strong>stribuzione europea. Circa i tre quarti dell’areale globale della<br />
Tottavilla sono compresi nei confini europei. La stima più recente della popolazione<br />
ni<strong>di</strong>ficante in Europa in<strong>di</strong>ca 1.300.000-3.300.000 coppie (BirdLife International 2004). In Italia<br />
l’areale riproduttivo comprende principalmente il crinale appenninico e le vallate a<strong>di</strong>acenti,<br />
gran parte delle aree <strong>di</strong> me<strong>di</strong>a collina delle regioni centrali e meri<strong>di</strong>onali e le due isole<br />
maggiori; è assente nella Pianura Padana e ha una <strong>di</strong>stribuzione frammentata e limitata<br />
nelle Alpi. La stima più recente della popolazione ni<strong>di</strong>ficante in Italia è <strong>di</strong> 20.000-40.000<br />
coppie per il periodo 1995-2006 (Brichetti e Fracasso 2007) e trend della popolazione<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 78<br />
probabilmente stabile (BirdLife International 2004). Non sono <strong>di</strong>sponibili dati significativi per<br />
stimare la consistenza della popolazione svernante in Italia.<br />
Distribuzione locale<br />
Specie sedentaria, migratrice, ni<strong>di</strong>ficante e svernante. La popolazione ni<strong>di</strong>ficante in Emilia-<br />
Romagna costituisce il 12-13% <strong>di</strong> quella nazionale. Almeno il 20% della popolazione<br />
regionale ni<strong>di</strong>ficante e il 10% <strong>di</strong> quella svernante è all’interno <strong>di</strong> siti Natura 2000. E’<br />
completamente assente come ni<strong>di</strong>ficante dalla pianura, mentre è comune nella fascia<br />
appenninica compresa tra 300 e 1.000 metri <strong>di</strong> altitu<strong>di</strong>ne. Considerando le informazioni<br />
riportate dagli atlanti provinciali e da censimenti effettuati in aree significative è possibile<br />
stimare una popolazione ni<strong>di</strong>ficante in Emilia- Romagna negli anni ’90 <strong>di</strong> 2.700-4.900 coppie<br />
<strong>di</strong> cui 600-650 nel Parmense, 400-1.000 nel Bolognese, 400-800 in ognuna delle altre<br />
province che includono vaste aree appenniniche (Piacenza, Reggio-Emilia, Modena, Forlì-<br />
Cesena) e 50-100 nel Ravennate. E’ assente come ni<strong>di</strong>ficante nel Riminese (Casini 2008).<br />
Un confronto tra le densità nei perio<strong>di</strong> 1995-1997 e 2004-2006 in Romagna in<strong>di</strong>ca una<br />
<strong>di</strong>minuzione (Ceccarelli e Gellini 2008); il trend complessivo della popolazione regionale è<br />
probabilmente in decremento.<br />
Minacce e stato <strong>di</strong> conservazione<br />
Possibili minacce sono rappresentate dalla riduzione e dalla scomparsa <strong>di</strong> pascoli e aree<br />
aperte dovuta all’evoluzione naturale del bosco, <strong>di</strong>struzione <strong>di</strong> siepi, filari alberati, boschetti<br />
ra<strong>di</strong> e sfalcio dei prati durante il periodo riproduttivo, abbandono e/o trasformazione delle<br />
aree piccole e marginali coltivate a cereali, uso <strong>di</strong> pestici<strong>di</strong> in agricoltura, abbattimenti<br />
involontari a causa della somiglianza e quin<strong>di</strong> della facile confusione con l’Allodola,<br />
predazione <strong>di</strong> uova e ni<strong>di</strong>acei da parte dei cinghiali, realizzazione <strong>di</strong> centrali eoliche in aree<br />
<strong>di</strong> alimentazione, ni<strong>di</strong>ficazione e transito. La Tottavilla presente uno stato <strong>di</strong> conservazione<br />
positivo, anche se l’attuale tendenza alla scomparsa degli ambienti aperti, anche <strong>di</strong> ridotte<br />
<strong>di</strong>mensioni, potrebbe costituire, in un prossimo futuro, una minaccia alla conservazione della<br />
specie.<br />
2.4.9.12 Averla piccola, Lanius collurio, (Linneus, 1758)<br />
Phylum: Chordata Classe: Aves Or<strong>di</strong>ne: Passeriformes Famiglia: Laniidae<br />
Convenzioni <strong>di</strong> tutela internazionali<br />
Convenzione <strong>di</strong> Berna. Ap. 2; Direttiva 409/79/CEE: Ap. 1; L. 157/1992: specie protetta;<br />
L.R. della Toscana 56/2000: Allegato A.<br />
Ecologia<br />
Specie territoriale. Volo <strong>di</strong>retto fra un posatoio e l’altro; caratteristica posa a terra ed<br />
imme<strong>di</strong>ato ritorno sul posatoio; andatura ondulata su lunghe <strong>di</strong>stanze. Caccia all’agguato da<br />
un posatoio dominante tuffandosi sia sul terreno o fra i rami dei cespugli; trasporta le prede o<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 79<br />
con il becco o con gli artigli e a volte le infila su rametti appuntiti o spine. Si nutre<br />
principalmente <strong>di</strong> insetti, soprattutto Coleotteri. Utilizza però anche altri invertebrati, piccoli<br />
mammiferi, uccelli e rettili. Ni<strong>di</strong>fica in luoghi aperti con arbusti sparsi, piccoli alberi e cespugli,<br />
in brughiere o pascoli. La deposizione avviene da inizio-metà maggio.<br />
Distribuzione generale<br />
Specie a <strong>di</strong>stribuzione euroasiatica. In Europa ni<strong>di</strong>fica in tutti i paesi ad esclusione <strong>di</strong> Islanda,<br />
Gran Bretagna, Irlanda, penisola Iberica meri<strong>di</strong>onale e Scan<strong>di</strong>navia settentrionale. La stima<br />
più recente della popolazione ni<strong>di</strong>ficante in Europa è <strong>di</strong> 6.300.000-13.000.000 coppie<br />
(BirdLife International 2004). I quartieri <strong>di</strong> svernamento sono nell’Africa meri<strong>di</strong>onale. L’areale<br />
riproduttivo italiano comprende tutte le regioni ad eccezione della penisola Salentina e della<br />
Sicilia dove è molto localizzata. La consistenza della popolazione ni<strong>di</strong>ficante italiana è stata<br />
recentemente stimata in 50.000-120.000 coppie nel 2003 con trend probabilmente in<br />
decremento (BirdLife International 2004). I movimenti migratori avvengono principalmente<br />
tra aprile e metà maggio e tra metà agosto e settembre.<br />
Distribuzione locale<br />
Specie estiva migratrice regolare e ni<strong>di</strong>ficante. La popolazione ni<strong>di</strong>ficante in Emilia-Romagna<br />
costituisce circa il 7% <strong>di</strong> quella nazionale. Ni<strong>di</strong>fica in tutte le province dal livello del mare fino<br />
a 1.500 m. s.l.m.; la rarefazione delle coppie ni<strong>di</strong>ficanti negli ultimi decenni è risultata più<br />
accentuata nelle zone <strong>di</strong> pianura. Sulla base delle informazioni fornite dagli Atlanti provinciali<br />
e <strong>di</strong> censimenti in aree significative è stata prodotta una stima <strong>di</strong> 3.000- 4.000 coppie per il<br />
periodo 1994-1997 (Tinarelli in Marchesi e Tinarelli 2007) <strong>di</strong> cui 500-550 nel Parmense<br />
(Ravasini 1995) e 300-400 nel Bolognese. La stima è stata aggiornata a 2.800-3.700 coppie<br />
per il periodo 2001-2003 (Tinarelli in Marchesi e Tinarelli 2007). Un confronto <strong>di</strong> rilievi<br />
effettuati nel 1995-1997 e nel 2004/2006 in Romagna in<strong>di</strong>ca una marcata <strong>di</strong>minuzione (-<br />
51%) della popolazione ni<strong>di</strong>ficante (Ceccarelli e Gellini 2008). L’averla piccola risulta <strong>di</strong>ffusa<br />
in particolare nelle aree agricole collinari e <strong>di</strong> me<strong>di</strong>a montagna; zone collinari del Casentino e<br />
dei pascoli e coltivi della Verna, hanno confermato la presenza <strong>di</strong> almeno 4 coppie (da<br />
recenti indagini specifiche compiute nel 2007).<br />
Minacce e stato <strong>di</strong> conservazione<br />
La specie è minacciata, da un lato, da una semplificazione dell’ecosistema agrario, e<br />
dall’altro, dalla scomparsa <strong>di</strong> ambienti aperti, soprattutto pascoli, a seguito dell’abbandono<br />
delle pratiche agricole e zootecniche. Il maggiore declino della specie è avvenuto negli anni<br />
‘60 e ‘70 in seguito all’eliminazione delle siepi e delle piantate in pianura e alla <strong>di</strong>ffusione<br />
dell’uso generalizzato <strong>di</strong> insettici<strong>di</strong> e geo<strong>di</strong>sinfestanti in agricoltura. L’averla piccola risulta in<br />
<strong>di</strong>minuzione in quasi tutto il suo areale, sia a livello europeo che nazionale; a livello locale,<br />
dopo un lungo periodo <strong>di</strong> <strong>di</strong>minuzione, sembra aver raggiunto una con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> stabilità, pur<br />
con notevoli fluttuazioni annuali.<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 80<br />
2.4.9.13 Ortolano, Emberiza hortulana, (Linneus, 1758)<br />
Phylum: Chordata Classe: Aves Or<strong>di</strong>ne: Passeriformes Famiglia: Emberizidae<br />
Convenzioni <strong>di</strong> tutela internazionali<br />
Convenzione <strong>di</strong> Berna: Ap. 2; Direttiva 409/79/CEE: Ap. I; L. 157/1992: specie protetta; L.R.<br />
della Toscana 56/2000: Allegato A; LR IUCN: Least Concern; BirdLife: SPEC 2; LR N: a più<br />
basso rischio; LR RT: altamente vulnerabile.<br />
Ecologia<br />
Specie solitaria o in piccoli gruppi in migrazione, che possono <strong>di</strong>ventare più numerosi in<br />
inverno. Volo debole con caratteristico movimento oscillatorio della coda e battute rapide. La<br />
<strong>di</strong>eta è composta da invertebrati e semi. Ai ni<strong>di</strong>acei vengono forniti soprattutto larve <strong>di</strong><br />
Lepidotteri defogliatori delle querce (Geometri<strong>di</strong>), Coleotteri (Scarabei<strong>di</strong>), Ortotteri e Ditteri. I<br />
semi sono estratti dalle pigne <strong>di</strong> peccio e dalle spighe <strong>di</strong> cereali. In inverno, nei quartieri <strong>di</strong><br />
svernamento, l'Ortolano si alimenta soprattutto nei campi arati o in coltivazioni <strong>di</strong> cereali.<br />
Ni<strong>di</strong>fica tra aprile e luglio in zone coltivate, terreni incolti con arbusti sparsi o vegetazione<br />
erbacea più alta, in vigneti, boschetti e margini <strong>di</strong> terreni boscosi. I movimenti migratori<br />
avvengono da marzo a maggio e da agosto a ottobre. La deposizione avviene fra inizio<br />
maggio e inizio giugno. Le uova, 4-5, si schiudono dopo un periodo <strong>di</strong> incubazione <strong>di</strong> 11-12<br />
giorni.<br />
Distribuzione<br />
Specie a <strong>di</strong>stribuzione euroasiatica. L’areale riproduttivo si estende dalla Penisola iberica<br />
all’Asia centrale e dalla Scan<strong>di</strong>navia alle coste dell’Algeria. In Europa ni<strong>di</strong>fica in tutti i Paesi<br />
ad eccezione <strong>di</strong> Gran Bretagna, Irlanda ed Islanda. Nell’Europa occidentale la <strong>di</strong>stribuzione<br />
è frammentata. La stima più recente della popolazione ni<strong>di</strong>ficante in Europa è <strong>di</strong> 5.200.000-<br />
16.000.000 coppie (BirdLife International 2004). E’ un migratore transahariano che sverna<br />
nella fascia del Sahel. In Italia è <strong>di</strong>stribuito in modo irregolare nelle regioni settentrionali e<br />
centrali fino alla Campania settentrionale ed al Molise; vi sono popolazioni isolate in<br />
Calabria. Manca in Sicilia e Sardegna. La stima più recente della popolazione ni<strong>di</strong>ficante in<br />
Italia è <strong>di</strong> 4.000-16.000 coppie nel 2003 con trend della popolazione probabilmente in<br />
decremento (BirdLife International 2004).<br />
Distribuzione locale<br />
Specie migratrice e ni<strong>di</strong>ficante regolare. Specie scarsa come ni<strong>di</strong>ficante, <strong>di</strong>ffusa soprattutto<br />
nella fascia collinare da Piacenza a Rimini e in modo <strong>di</strong>scontinuo anche in quella montana<br />
con ni<strong>di</strong>ficazioni fino a 1.200 metri <strong>di</strong> altitu<strong>di</strong>ne. E’ molto localizzato come ni<strong>di</strong>ficante in<br />
pianura nelle province <strong>di</strong> Parma, <strong>Bologna</strong> e Ferrara. La consistenza della popolazione<br />
ni<strong>di</strong>ficante in Emilia-Romagna è stata stimata <strong>di</strong> 500-770 coppie nel 1994-1997 e <strong>di</strong> 500-650<br />
nel 2001-2003 con trend della popolazione in decremento, in particolare in pianura (Tinarelli<br />
in Marchesi e Tinarelli 2007). Anche Ceccarelli e Gellini (2008) riportano un forte calo della<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 81<br />
popolazione ni<strong>di</strong>ficante in Romagna attraverso un confronto del numero <strong>di</strong> siti occupati nel<br />
1995-1997 e nel 2004-2006.<br />
Minacce e stato <strong>di</strong> conservazione<br />
L'introduzione e la <strong>di</strong>ffusione <strong>di</strong> moderne tecniche agricole sono la principale causa della<br />
crisi che ha subito la specie nelle campagne dell'Europa centro-occidentale. La riduzione dei<br />
filari <strong>di</strong> siepi un tempo utilizzati per la demarcazione dei campi, le monocolture intensive,<br />
l'espansione dei centri abitati ed il <strong>di</strong>sturbo arrecato dall'uomo hanno determinato la<br />
scomparsa della specie da molte zone dell'areale storico. In particolare in Emilia-Romagna i<br />
fattori limitanti per la specie sono costituiti da <strong>di</strong>struzione della vegetazione spontanea<br />
erbacea ed arbustiva ai margini dei coltivi durante il periodo riproduttivo, trasformazione e/o<br />
scomparsa dei prati-pascoli, abbandono e/o dalla trasformazione delle aree piccole e<br />
marginali coltivate a cereali, sfalci precoci, impiego massiccio <strong>di</strong> insettici<strong>di</strong> ed erbici<strong>di</strong> che<br />
costituiscono probabilmente il magiore fattore. limitante. Nell’800 e all’inizio del ‘900 la<br />
specie ha subito un declino in tutto il suo areale europeo causato dalla sistematica cattura<br />
per scopi alimentari. E’ verosimile che l’attuale <strong>di</strong>minuzione della popolazione sia giustificata<br />
anche da fattori limitanti quali la trasformazione degli ambienti <strong>di</strong> svernamento e l’uso<br />
massiccio <strong>di</strong> bioci<strong>di</strong> nei quartieri <strong>di</strong> svernamento in Africa la cui entità è però per il momento<br />
<strong>di</strong>fficilmente valutabile. Lo stato <strong>di</strong> conservazione della popolazione regionale è<br />
complessivamente insod<strong>di</strong>sfacente.<br />
2.4.10 Specie <strong>di</strong> Mammiferi <strong>di</strong> interesse comunitario<br />
2.4.10.1 Rhinolophus ferrumequinum<br />
2.4.10.1.1 Esigenze ecologiche<br />
Specie termofila che pre<strong>di</strong>lige aree aperte con un mosaico <strong>di</strong> arbusti, alberi sparsi e zone<br />
umide. La si ritrova dal livello del mare fino ai 2000 m <strong>di</strong> quota, mantenendosi<br />
preferenzialmente a quote non superiori agli 800 m. Specie sedentaria, che effettua brevi<br />
spostamenti dell’or<strong>di</strong>ne dei 15-60 km tra i rifugi invernali e quelli estivi. Pre<strong>di</strong>lige rifugi in<br />
cavità ipogee ed e<strong>di</strong>fici, raramente in cavità <strong>di</strong> alberi. Le colonie riproduttive, comprendenti in<br />
genere da alcune decine a 200 esemplari adulti, possono essere miste assieme a<br />
Rhinolophus euryale, Rhinolophus mehelyi, Miniopterus schreibersii, M. emarginatus. La<br />
nascita dei piccoli, in genere uno per femmina, avviene tra giugno e agosto. Le femmine<br />
raggiungono la maturità sessuale intorno ai 3-4 anni <strong>di</strong> età, mentre i maschi ai 2-3. La<br />
massima longevità finora registrata è <strong>di</strong> 30 anni.<br />
2.4.10.1.2 Presenza e status <strong>di</strong> conservazione nel SIC<br />
La specie è stata segnalata a livello regionale in tutte le province dell’Emilia Romagna, ed in<br />
particolare in 13 dei siti della Rete Natura 2000 della provincia <strong>di</strong> <strong>Bologna</strong>. Per quanto<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 82<br />
riguarda il SIC, la specie era già segnalata come presente ed è nuovamente stata contattata<br />
sia nell’agosto del 2011 tramite avvistamento <strong>di</strong>retto <strong>di</strong> due esemplari all’interno della cavità<br />
ipogea artificiale denominata “Ettore Muti” che nell’aprile del 2012 tramite avvistamento<br />
<strong>di</strong>retto <strong>di</strong> un esemplare nel cosiddetto “rifugio dei tedeschi”. In data 20/01/2012 un<br />
esemplare è stato nuovamente contattato presso il rifugio “Ettore Muti”, il sopralluogo è stato<br />
svolto dal dr. Massimo Bertozzi. Alcuni segni <strong>di</strong> presenza probabilmente attribuibili a questa<br />
specie sono stati ritrovati nell’aprile 2012 anche all’interno <strong>di</strong> in un e<strong>di</strong>ficio in previsione <strong>di</strong><br />
ristrutturazione nel complesso <strong>di</strong> “Ganzole”. La specie è stata contattata anche tramite<br />
indagine bio-acustica nell’agosto 2011. Lo status <strong>di</strong> conservazione della specie a livello<br />
nazionale è considerato “vulnerable” (GIRC 2007). Nonostante il monitoraggio pluriennale<br />
della zona del Parco Talon abbia riscontrato per più anni la presenza <strong>di</strong> alcuni in<strong>di</strong>vidui<br />
isolati all’interno <strong>di</strong> alcune cavità artificiali, è comunque impossibile definire la consistenza e<br />
la tendenza della popolazione all’interno del SIC quin<strong>di</strong> fornire una valutazione atten<strong>di</strong>bile<br />
del suo attuale status <strong>di</strong> conservazione.<br />
2.4.10.2 Rhinolophus hipposideros<br />
2.4.10.2.1 Esigenze ecologiche<br />
Specie termofila che pre<strong>di</strong>lige le aree boscate con chiarie e zone umide, fino ad una quota <strong>di</strong><br />
2000 m. Specie considerata sedentaria, in genere i rifugi estivi ed invernali non <strong>di</strong>stano più <strong>di</strong><br />
5-10 km tra loro. Questi si localizzano in e<strong>di</strong>fici, limitatamente alla buona stagione, e in cavità<br />
ipogee. Spesso con<strong>di</strong>vide il roost con colonie <strong>di</strong> altre specie, come R. ferrumequinum,<br />
Myotis myotis, M. emarginatus, senza però mescolarvisi. Le colonie riproduttive sono in<br />
genere formate da 10-100 in<strong>di</strong>vidui adulti, raramente si raggiungono consistenze maggiori. I<br />
piccoli, in genere uno per femmina, nascono a partire dalla seconda metà <strong>di</strong> giugno fino a<br />
luglio. La maturità sessuale viene raggiunta a 1-2 anni <strong>di</strong> età in entrambi i sessi. La longevità<br />
massima registrata è <strong>di</strong> 21 anni.<br />
2.4.10.2.2 Presenza e status <strong>di</strong> conservazione nel SIC<br />
La specie è stata segnalata a livello regionale in quasi tutte le province dell’Emilia Romagna,<br />
ed in particolare in 11 dei siti della Rete Natura 2000 della provincia <strong>di</strong> <strong>Bologna</strong>. Per quanto<br />
riguarda il SIC, la specie era già segnalata come presente ed è nuovamente stata contattata<br />
sia nell’agosto del 2011 tramite avvistamento <strong>di</strong>retto <strong>di</strong> due esemplari all’interno della cavità<br />
ipogea artificiale denominata “rifugio dei tedeschi” che nell’aprile del 2012 tramite<br />
avvistamento <strong>di</strong>retto <strong>di</strong> due esemplari nella stessa e uno nella cavità denominata “Ettore<br />
Muti”. In data 20/01/2012 tre esemplari sono stati nuovamente contattato presso il rifugio<br />
“Ettore Muti” e sei presso il “rifugio dei tedeschi”, il sopralluogo è stato svolto dal dr.<br />
Massimo Bertozzi. La specie è stata segnalata durante l’inverno 2011-2012 anche<br />
nell’acquedotto romano <strong>di</strong> Rio Conco (2 in<strong>di</strong>vidui, Grazioli comunicazione personale). Lo<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 83<br />
status <strong>di</strong> conservazione della specie a livello nazionale è considerato “endangered” (GIRC<br />
2007). Nonostante il monitoraggio pluriennale della zona del Parco Talon abbia riscontrato<br />
per più anni la presenza <strong>di</strong> alcuni in<strong>di</strong>vidui isolati all’interno <strong>di</strong> alcune cavità artificiali, è<br />
comunque impossibile definire la consistenza e la tendenza della popolazione all’interno del<br />
SIC quin<strong>di</strong> fornire una valutazione atten<strong>di</strong>bile del suo attuale status <strong>di</strong> conservazione.<br />
2.4.10.3 Eptesicus serotinus<br />
2.4.10.3.1 Esigenze ecologiche<br />
Specie primitivamente forestale che caccia abitualmente presso margini dei boschi e<br />
agroecosistemi con siepi ed altri elementi lineari, la si ritrova anche in ambiente urbano.<br />
Pre<strong>di</strong>lige zone <strong>di</strong> bassa e me<strong>di</strong>a altituti<strong>di</strong>ne ed è stata tuttavia segnalata anche a 1800 m <strong>di</strong><br />
quota. Con abitu<strong>di</strong>ni tendenzialmente sedentarie, utilizza come rifugi principalmente gli<br />
e<strong>di</strong>fici, dove utilizza fessure fra le travi ed interstizi vari. Più raramente utilizza le cavità degli<br />
alberi e bat box, mentre in inverno preferisce cavità ipogee. Le colonie riproduttive sono<br />
formate generalmente da 10-50 in<strong>di</strong>vidui adulti. I parti avvengono tra giugno e luglio,<br />
generalmente con un piccolo per femmina adulta, raramente due. Le femmine raggiungono<br />
la maturità sessuale a 1-2 anni <strong>di</strong> età. L’età massima registrata è <strong>di</strong> 21 anni.<br />
2.4.10.3.2 Presenza e status <strong>di</strong> conservazione nel SIC<br />
La specie è stata segnalata a livello regionale in tutte le province dell’Emilia Romagna, ed in<br />
particolare in 15 dei siti della Rete Natura 2000 della provincia <strong>di</strong> <strong>Bologna</strong> Per quanto<br />
riguarda il SIC, la specie era già segnalata come presente ed è nuovamente stata contattata<br />
sia nell’agosto 2011 che nell’aprile 2012 tramite indagine bio-acustica. Lo status <strong>di</strong><br />
conservazione della specie a livello nazionale è considerato “near threatened” (GIRC 2007).<br />
A causa della mancanza <strong>di</strong> informazioni pregresse sulla consistenza della popolazione<br />
all’interno del SIC è attualmente impossibile definirne le tendenze e quin<strong>di</strong> fornire una<br />
valutazione atten<strong>di</strong>bile del suo attuale status <strong>di</strong> conservazione.<br />
2.4.10.4 Hypsugo savii<br />
2.4.10.4.1 Esigenze ecologiche<br />
Specie euriecia che frequenta varie tipologie ambientali, tra cui le preferite sono<br />
rappresentate da margini forestali, aree umide e anche ambienti urbanizzati, dove spesso<br />
caccia intorno ai lampioni. La si ritrova fino ai 2000 m <strong>di</strong> quota e tende a rifugiarsi all’interno<br />
<strong>di</strong> spaccature e fessure, sia tra le rocce che nei pressi degli e<strong>di</strong>fici, ma anche in bat box.<br />
Raramente utilizza ambienti ipogei nel periodo invernale. Presenta probabilmente un<br />
comportamento sedentario, anche se è stato documentato uno spostamento <strong>di</strong> circa 250 km.<br />
All’interno delle colonie riproduttive <strong>di</strong> circa 5-70 in<strong>di</strong>vidui le femmine partoriscono nei mesi <strong>di</strong><br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 84<br />
giugno luglio due piccoli ciascuna, più raramente uno. La maturità sessuale è raggiunta dalle<br />
femmine già nel primo anno <strong>di</strong> vita.<br />
2.4.10.4.2 Presenza e status <strong>di</strong> conservazione nel SIC<br />
La specie è stata segnalata a livello regionale in tutte le province dell’Emilia Romagna, ed in<br />
particolare in 15 dei siti della Rete Natura 2000 della provincia <strong>di</strong> <strong>Bologna</strong>. Per quanto<br />
riguarda il SIC, la specie era già segnalata come presente ed è nuovamente stata contattata<br />
sia nell’agosto 2011 che nell’aprile 2012 tramite indagine bio-acustica e nell’aprile 2012<br />
tramite avvistamento <strong>di</strong>retto presso un e<strong>di</strong>cio abbandonato (complesso “Ganzole”) in<br />
previsione <strong>di</strong> ristrutturazione (2 in<strong>di</strong>vidui). Lo status <strong>di</strong> conservazione della specie a livello<br />
nazionale è considerato “least concern” (GIRC 2007). A causa della mancanza <strong>di</strong><br />
informazioni pregresse sulla consistenza della popolazione all’interno del SIC è attualmente<br />
impossibile definirne le tendenze e quin<strong>di</strong> fornire una valutazione atten<strong>di</strong>bile del suo attuale<br />
status <strong>di</strong> conservazione.<br />
2.4.10.5 Myotis blythii / myotis<br />
2.4.10.5.1 Esigenze ecologiche<br />
M. myotis caccia solitamente presso ambienti boscati con sottobosco rado, oppure in<br />
ambienti aperti non <strong>di</strong>stanti da boschi, mentre M. blythii pre<strong>di</strong>lige generalmente zone aperte<br />
con estesa copertura erbacea. Entrambe le specie si ritrovano dal livello del mare fino a<br />
circa 1000 m <strong>di</strong> quota, M. myotis può venir segnalato anche ad altitu<strong>di</strong>ni maggiori (2200 m è<br />
la quota massima riscontrata) in occasione dei movimenti migratori che vanno in genere dai<br />
50 ai 100 km <strong>di</strong> <strong>di</strong>stanza. M. blythii è considerata specie sedentaria. Entrambe le specie in<br />
estate si rifugiano in e<strong>di</strong>fici e cavità ipogee, mentre ibernano esclusivamente in ambiente<br />
ipogeo. Formano colonie riproduttive formate da poche decine fino a migliaia <strong>di</strong> esemplari,<br />
spesso in associazione con R. ferrumequinum, M. schreibersii, Myotis capaccinii. Le<br />
femmine partoriscono generalmente un solo piccolo tra i mesi <strong>di</strong> maggio e giugno. Sia i<br />
maschi che le femmine raggiungono la maturità sessuale poco dopo il primo anno <strong>di</strong> vita. La<br />
massima età registrata finora è <strong>di</strong> 22 anni per M. myotis e 30 per M. blythii.<br />
2.4.10.5.2 Presenza e status <strong>di</strong> conservazione nel SIC<br />
M. myotis è stata segnalata a livello regionale in quasi tutte le province dell’Emilia Romagna,<br />
ed in particolare in 7 dei siti della Rete Natura 2000 della provincia <strong>di</strong> <strong>Bologna</strong>, mentre M.<br />
blythii risulta presente solamente in 2 siti. Per quanto riguarda il SIC, è stata segnalata la<br />
presenza <strong>di</strong> M. myotis (ultima segnalazione certa: Ecosistema 2006-2007) tramite indagine<br />
bioacustica, riteniamo tuttavia che tale metodo non sia sufficiente per <strong>di</strong>scriminare con<br />
assoluta certezza queste specie gemelle. Per tale motivo si è deciso <strong>di</strong> adottare la <strong>di</strong>citura<br />
Myotis blythii / myotis piuttosto che segnalare una delle due specie. Nessuna delle due<br />
specie è stata contattata durante le indagini per l’aggiornamento del quadro conoscitivo. Lo<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 85<br />
status <strong>di</strong> conservazione <strong>di</strong> entrambe le specie a livello nazionale è considerato “vulnerable”<br />
(GIRC 2007). A causa della mancanza <strong>di</strong> informazioni pregresse sulla consistenza delle<br />
popolazioni all’interno del SIC è attualmente impossibile definirne le tendenze e quin<strong>di</strong><br />
fornire una valutazione atten<strong>di</strong>bile dell’attuale status <strong>di</strong> conservazione.<br />
2.4.10.6 Myotis daubentonii<br />
2.4.10.6.1 Esigenze ecologiche<br />
Specie fortemente legata a zone umide lentiche e lotiche caratterizzate da una sviluppata<br />
fascia <strong>di</strong> vegetazione ripariale e dalla vicinanza <strong>di</strong> aree boschive planiziali. E’ stata rilevata<br />
fino alla quota <strong>di</strong> 1800 m, ma più frequentemente la si trova dal livello del mare fino agli 800<br />
m. Gli spostamenti tra rifugi invernali ed estivi non superano <strong>di</strong> norma i 100 km. Durante la<br />
stagione estiva si rifugia principalmente nelle fessure dei ponti, ma anche in e<strong>di</strong>fici, bat box e<br />
cavità degli alberi. Sverna in situazioni <strong>di</strong> alta umi<strong>di</strong>tà sia in cavità ipogee che in costruzioni<br />
antropiche. Le colonie riproduttive sono generalmente formate da 20-50 femmine ed i parti,<br />
solitamente <strong>di</strong> un piccolo, avvengono tra giugno e luglio. I maschi raggiungono la maturità<br />
sessuale dopo poco più <strong>di</strong> un anno <strong>di</strong> vita, mentre le femmine dopo circa due. La longevità<br />
massima registrata è <strong>di</strong> 28 anni.<br />
2.4.10.6.2 Presenza e status <strong>di</strong> conservazione nel SIC<br />
La specie è stata segnalata a livello regionale in numerose province dell’Emilia Romagna, ed<br />
in particolare in 10 dei siti della Rete Natura 2000 della provincia <strong>di</strong> <strong>Bologna</strong>. Per quanto<br />
riguarda il SIC, la specie è segnalata come presente (ultima segnalazione certa: Ecosistema<br />
2006-2007), tuttavia questa non è stata contattata durante le indagini per l’aggiornamento<br />
del quadro conoscitivo. Lo status <strong>di</strong> conservazione della specie a livello nazionale è<br />
considerato “least concern” (GIRC 2007). A causa della mancanza <strong>di</strong> informazioni pregresse<br />
sulla consistenza della popolazione all’interno del SIC è attualmente impossibile definirne le<br />
tendenze e quin<strong>di</strong> fornire una valutazione atten<strong>di</strong>bile del suo attuale status <strong>di</strong> conservazione.<br />
2.4.10.7 Myotis emarginatus<br />
2.4.10.7.1 Esigenze ecologiche<br />
Specie termofila che frequenta zone collinari e <strong>di</strong> pianura anche abitate, purchè siano<br />
presenti giar<strong>di</strong>ni e corpi d’acqua. Pre<strong>di</strong>lige comunque formazioni forestali <strong>di</strong> latifoglie a quote<br />
me<strong>di</strong>o basse, pur ritrovandola fino a 1800 m <strong>di</strong> quota. Tendenzialmente sedentaria, il<br />
massimo spostamento registrato è <strong>di</strong> 160 km. I rifugi estivi si trovano principalmente nelle<br />
gran<strong>di</strong> cavità <strong>di</strong> manufatti ed e<strong>di</strong>fici, spesso in associazione con R. ferrumequinum, più<br />
raramente la si ritrova in bat box, nei cavi degli alberi o in cavità ipogee. Per lo svernamento<br />
utilizza esclusivamente cavità ipogee. Le colonie riproduttive sono formate da 20-200<br />
femmine adulte, anche se esistono casi con circa 1000 indvidui. La nascita <strong>di</strong> un solo piccolo<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 86<br />
per in<strong>di</strong>viduo, eccezionalmente due, avviene tra giugno e luglio. La maturità sessuale delle<br />
femmine è raggiunta al temine del primo anno <strong>di</strong> vita e la massima longevità registrata è <strong>di</strong><br />
18 anni.<br />
2.4.10.7.2 Presenza e status <strong>di</strong> conservazione nel SIC<br />
La specie è stata segnalata a livello regionale in tutte le province dell’Emilia Romagna, ed in<br />
particolare in 3 dei siti della Rete Natura 2000 della provincia <strong>di</strong> <strong>Bologna</strong>. Per quanto<br />
riguarda il SIC, la specie è segnalata come presente (ultima segnalazione certa: Bertozzi<br />
2010), tuttavia questa non è stata contattata durante le indagini per l’aggiornamento del<br />
quadro conoscitivo. Lo status <strong>di</strong> conservazione della specie a livello nazionale è considerato<br />
“vulnerable” (GIRC 2007). A causa della mancanza <strong>di</strong> informazioni pregresse sulla<br />
consistenza della popolazione all’interno del SIC è attualmente impossibile definirne le<br />
tendenze e quin<strong>di</strong> fornire una valutazione atten<strong>di</strong>bile del suo attuale status <strong>di</strong> conservazione.<br />
2.4.10.8 Myotis natte<strong>rer</strong>i<br />
2.4.10.8.1 Esigenze ecologiche<br />
Specie legata essenzialmente ad ambienti forestali con presenza <strong>di</strong> aree umide nelle<br />
vicinanze. Presente dal livello del mare fino a quote <strong>di</strong> oltre 2000 m. Considerata<br />
tendenzialmente sedentaria, è stato tuttavia registrato uno spostamento <strong>di</strong> 185 km. Utilizza<br />
soprattutto cavità arboree, ma anche bat box, ponti e altre fessure in manufatti come rifugio<br />
estivo, mentre trascorre l’inverno in ambienti ipogei con umi<strong>di</strong>tà relativamente alta. Le<br />
colonie riproduttive sono formate da 20-80 femmine, raramente <strong>di</strong> più, che partoriscono tra<br />
giugno e luglio un solo piccolo ciascuna, eccezionalmente due. Le femmine sono<br />
sessualmente mature già durante il primo anno <strong>di</strong> vita. La longevità massima finora<br />
registrata è <strong>di</strong> 20 anni.<br />
2.4.10.8.2 Presenza e status <strong>di</strong> conservazione nel SIC<br />
La specie è stata segnalata a livello regionale in numerose province dell’Emilia Romagna, ed<br />
in particolare in 4 dei siti della Rete Natura 2000 della provincia <strong>di</strong> <strong>Bologna</strong>. Per quanto<br />
riguarda il SIC, la specie è segnalata come presente (ultima segnalazione certa: Bertozzi<br />
2010), tuttavia questa non è stata contattata durante le indagini per l’aggiornamento del<br />
quadro conoscitivo. Lo status <strong>di</strong> conservazione della specie a livello nazionale è considerato<br />
“vulnerable” (GIRC 2007). A causa della mancanza <strong>di</strong> informazioni pregresse sulla<br />
consistenza della popolazione all’interno del SIC è attualmente impossibile definirne le<br />
tendenze e quin<strong>di</strong> fornire una valutazione atten<strong>di</strong>bile del suo attuale status <strong>di</strong> conservazione.<br />
2.4.10.9 Nyctalus leisleri<br />
2.4.10.9.1 Esigenze ecologiche<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 87<br />
Specie tipicamente boschiva legata sia nella stagione estiva che invernale ai rifugi nelle<br />
cavità degli alberi. Presenta comunque un certo grado <strong>di</strong> adattamento all’ambiente<br />
antropizzato e la si ritrova fino oltre i 2000 m <strong>di</strong> quota. Specie migratrice, lo spostamente<br />
maggiore conosciuto è <strong>di</strong> 1567 km. Come rifugio utilizza principalmente i cavi degli alberi,<br />
ma anche bat box e fessure negli e<strong>di</strong>fici. Le colonie riproduttive sono piccole, formate in<br />
genere da 20-50 in<strong>di</strong>vidui ed i parti, <strong>di</strong> uno o due piccoli per in<strong>di</strong>viduo, avvengono intorno al<br />
mese <strong>di</strong> giugno. Le femmine sono presumibilmente mature già al termine del primo anno <strong>di</strong><br />
vita. La longevità massima finora registrata è <strong>di</strong> 11 anni.<br />
2.4.10.9.2 Presenza e status <strong>di</strong> conservazione nel SIC<br />
La specie è stata segnalata a livello regionale in varie province dell’Emilia Romagna, ed in<br />
particolare in 7 dei siti della Rete Natura 2000 della provincia <strong>di</strong> <strong>Bologna</strong>. Per quanto<br />
riguarda il SIC, la specie era già segnalata come presente ed è nuovamente stata contattata<br />
nell’aprile 2012 tramite indagine bio-acustica. Lo status <strong>di</strong> conservazione della specie a<br />
livello nazionale è considerato “near threatened” (GIRC 2007). A causa della mancanza <strong>di</strong><br />
informazioni pregresse sulla consistenza della popolazione all’interno del SIC è attualmente<br />
impossibile definirne le tendenze e quin<strong>di</strong> fornire una valutazione atten<strong>di</strong>bile del suo attuale<br />
status <strong>di</strong> conservazione.<br />
2.4.10.10 Nyctalus noctula<br />
2.4.10.10.1Esigenze ecologiche<br />
Specie principalmente legata agli ambienti forestali, evidenzia tuttavia ampie tendenze alla<br />
frequentazione <strong>di</strong> ambienti antropizzati. Pre<strong>di</strong>lige aree <strong>di</strong> bassa e me<strong>di</strong>a altitu<strong>di</strong>ne (500-1000<br />
m), ma può raggiungere anche i 2000 m <strong>di</strong> quota durante gli spostamenti migratori. E’ infatti<br />
specie migratrice e lo spostamento più lungo registrato è <strong>di</strong> 2347 km. Sia in inverno che in<br />
estate utilizza come rifugio i cavi negli alberi, ma anche rifugi artificiali e all’occorrenza<br />
fessure in e<strong>di</strong>fici. Molto raramente la si può ritrovare in ambienti ipogei. Nele colonie<br />
riproduttive, generalmente <strong>di</strong> 20-50 in<strong>di</strong>vidui adulti, i parti avvengono in giugno-luglio. In<br />
genere ogni femmina partorisce due piccoli, raramente uno o tre. Le femmine raggiungono la<br />
maturità sessuale già alla fine del primo anno <strong>di</strong> vita. La longevità massima registrata è <strong>di</strong> 12<br />
anni.<br />
2.4.10.10.2Presenza e status <strong>di</strong> conservazione nel SIC<br />
La specie è stata segnalata a livello regionale in varie province dell’Emilia Romagna, ed in<br />
particolare in 14 dei siti della Rete Natura 2000 della provincia <strong>di</strong> <strong>Bologna</strong>. Per quanto<br />
riguarda il SIC, la specie è segnalata come presente (ultima segnalazione certa: Ecosistema<br />
2006-2007), tuttavia questa non è stata contattata durante le indagini per l’aggiornamento<br />
del quadro conoscitivo. Lo status <strong>di</strong> conservazione della specie a livello nazionale è<br />
considerato “vulnerable” (GIRC 2007). A causa della mancanza <strong>di</strong> informazioni pregresse<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 88<br />
sulla consistenza della popolazione all’interno del SIC è attualmente impossibile definirne le<br />
tendenze e quin<strong>di</strong> fornire una valutazione atten<strong>di</strong>bile del suo attuale status <strong>di</strong> conservazione.<br />
2.4.10.11 Pipistrellus kuhlii<br />
2.4.10.11.1Esigenze ecologiche<br />
Specie originariamente rupicola, risulta particolarmente legata agli ambienti urbanizzati dove<br />
si rifugia nelle fessure degli e<strong>di</strong>fici. La si ritrova dal livello del mare fino a quasi 2000 m <strong>di</strong><br />
quota, preferendo tuttavia aree al <strong>di</strong> sotto dei 700 m. Frequenta molteplici ambienti, ma<br />
pre<strong>di</strong>lige comunque le aree <strong>di</strong> pianura e bassa collina, cacciando lungo i corsi d’acqua<br />
oppure ai margini <strong>di</strong> siepi e alberature. Altri rifugi sono costituiti da bat box, fessure nelle<br />
rocce e raramente cavità degli alberi. Tendenzialmente sedentaria, i luoghi <strong>di</strong> rifugio estivi<br />
corrispondono spesso a quelli invernali. Le colonie riproduttive sono <strong>di</strong> piccole <strong>di</strong>mensioni,<br />
solitamente da poche decine fino a un centinaio <strong>di</strong> esemplari. Le femmine partoriscono<br />
generalmente due piccoli ciascuna, più raramente uno, tra giugno e luglio e sono<br />
sessualmente mature già nel primo anno <strong>di</strong> età. La longevità massima rilevata è <strong>di</strong> 8 anni.<br />
2.4.10.11.2Presenza e status <strong>di</strong> conservazione nel SIC<br />
La specie è stata segnalata a livello regionale in tutte le province dell’Emilia Romagna, ed in<br />
particolare in 19 dei siti della Rete Natura 2000 della provincia <strong>di</strong> <strong>Bologna</strong>. Per quanto<br />
riguarda il SIC, la specie era già segnalata come presente ed è nuovamente stata contattata<br />
sia nell’agosto 2011 che nell’aprile 2012 tramite indagine bio-acustica. Lo status <strong>di</strong><br />
conservazione della specie a livello nazionale è considerato “least concern” (GIRC 2007). A<br />
causa della mancanza <strong>di</strong> informazioni pregresse sulla consistenza della popolazione<br />
all’interno del SIC è attualmente impossibile definirne le tendenze e quin<strong>di</strong> fornire una<br />
valutazione atten<strong>di</strong>bile del suo attuale status <strong>di</strong> conservazione.<br />
2.4.10.12 Pipistrellus pipistrellus<br />
2.4.10.12.1Esigenze ecologiche<br />
Specie con spiccate tendenze antropofile, ma frequente anche in habitat forestali, la si<br />
ritrova dal livello del mare fino ai 2000 m <strong>di</strong> quota. Caccia generalmente lungo i margini dei<br />
boschi, siepi ed altri elementi lineari. Tendenzialmente stanziale, non compie in genere<br />
spostamenti superiori ai 50 km. Come rifugio, sia in estate che in inverno, utilizza le fessure<br />
presenti negli e<strong>di</strong>fici, ma anche bat box, cavità degli alberi e spaccature nelle rocce. Le<br />
colonie riproduttive sono composte da un numero <strong>di</strong> femmine che varia dalle poche decine<br />
alle centinaia <strong>di</strong> esemplari. Queste partoriscono tra i mesi <strong>di</strong> giugno e luglio e danno alla luce<br />
generalmente due piccoli ciascuna, più raramente uno. Le femmine raggiungono la maturità<br />
sessuale già ad un anno <strong>di</strong> età e la longevità massima nota è <strong>di</strong> 16 anni.<br />
2.4.10.12.2Presenza e status <strong>di</strong> conservazione nel SIC<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 89<br />
La specie è stata segnalata a livello regionale in tutte le province dell’Emilia Romagna, ed in<br />
particolare in 15 dei siti della Rete Natura 2000 della provincia <strong>di</strong> <strong>Bologna</strong>. Per quanto<br />
riguarda il SIC, la specie era già segnalata come presente ed è nuovamente stata contattata<br />
sia nell’agosto 2011 che nell’aprile 2012 tramite indagine bio-acustica. Lo status <strong>di</strong><br />
conservazione della specie a livello nazionale è considerato “least concern” (GIRC 2007). A<br />
causa della mancanza <strong>di</strong> informazioni pregresse sulla consistenza della popolazione<br />
all’interno del SIC è attualmente impossibile definirne le tendenze e quin<strong>di</strong> fornire una<br />
valutazione atten<strong>di</strong>bile del suo attuale status <strong>di</strong> conservazione.<br />
2.4.10.13 Plecotus auritus<br />
2.4.10.13.1Esigenze ecologiche<br />
Specie tipicamente legata ad ambienti forestali, i cui principali rifugi sono le cavità degli<br />
alberi. Può utilizzare anche bat box o fessure in rocce ed e<strong>di</strong>fici in estate, mentre in inverno<br />
la si può ritrovare anche in cavità ipogee. E’ stata segnalata dal livello del mare fino ad oltre<br />
2000 m <strong>di</strong> quota. Considerata sedentaria, lo spostamento massimo registrato è <strong>di</strong> poco<br />
superiore ai 90 km. La morfologia delle ali e le gran<strong>di</strong> orecchie le consentono un volo<br />
manovrato all’interno <strong>di</strong> ambienti chiusi. Le colonie riproduttive generalmente sono piccole<br />
(5-50 adulti) ed i parti avvengono tra giugno e luglio, con la nascita <strong>di</strong> un piccolo per ciascun<br />
in<strong>di</strong>viduo, raramente due. Le femmine raggiungono la maturità sessuale nel secondo anno <strong>di</strong><br />
vita. La longevità massima registrata è <strong>di</strong> 30 anni.<br />
2.4.10.13.2Presenza e status <strong>di</strong> conservazione nel SIC<br />
La specie è stata segnalata a livello regionale in quasi tutte le province dell’Emilia Romagna,<br />
ed in particolare in 4 dei siti della Rete Natura 2000 della provincia <strong>di</strong> <strong>Bologna</strong>. Per quanto<br />
riguarda il SIC, la specie è segnalata come presente (ultima segnalazione certa: Bertozzi<br />
2008), tuttavia questa non è stata contattata durante le indagini per l’aggiornamento del<br />
quadro conoscitivo. Lo status <strong>di</strong> conservazione della specie a livello nazionale è considerato<br />
“near threatened” (GIRC 2007). A causa della mancanza <strong>di</strong> informazioni pregresse sulla<br />
consistenza della popolazione all’interno del SIC è attualmente impossibile definirne le<br />
tendenze e quin<strong>di</strong> fornire una valutazione atten<strong>di</strong>bile del suo attuale status <strong>di</strong> conservazione.<br />
2.4.10.14 Tadarida teniotis<br />
2.4.10.14.1Esigenze ecologiche<br />
Specie tipicamente rupicola, la si ritrova dal livello del mare fino a oltre 2000 m <strong>di</strong> quota,<br />
raggiungendo le altitu<strong>di</strong>ni più elevate probabilmente nel corso degli spostamenti. Caccia a<br />
notevole <strong>di</strong>stanza dal suolo, talvolta a centinaia <strong>di</strong> metri d’altezza. Probabilmente sedentaria,<br />
risulta comunque una migratrice occasionale. Utilizza le fessure nelle pareti rocciose, falesie<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 90<br />
e scogliere come rifugi, ma anche gli interstizi <strong>di</strong> alti e<strong>di</strong>fici, dove pre<strong>di</strong>lige le fessure verticali.<br />
Colonie riproduttive generalmente <strong>di</strong> piccole <strong>di</strong>mensioni (5-50 in<strong>di</strong>vidui adulti), nonostante si<br />
abbiano notizie <strong>di</strong> alcune con oltre cento in<strong>di</strong>vidui adulti. I piccoli, solitamente uno per<br />
ciascun esemplare, nascono tra giugno e luglio. Le femmine risultano riproduttive già nel<br />
primo anno <strong>di</strong> vita e la longevità massima registrata supera i 10 anni.<br />
2.4.10.14.2Presenza e status <strong>di</strong> conservazione nel SIC<br />
La specie è stata segnalata a livello regionale in quasi tutte le province dell’Emilia Romagna,<br />
ed in particolare in 11 dei siti della Rete Natura 2000 della provincia <strong>di</strong> <strong>Bologna</strong>. Per quanto<br />
riguarda il SIC, la specie era già segnalata come presente ed è nuovamente stata contattata<br />
nell’aprile 2012 tramite indagine bio-acustica. Lo status <strong>di</strong> conservazione della specie a<br />
livello nazionale è considerato “least concern” (GIRC 2007). A causa della mancanza <strong>di</strong><br />
informazioni pregresse sulla consistenza della popolazione all’interno del SIC è attualmente<br />
impossibile definirne le tendenze e quin<strong>di</strong> fornire una valutazione atten<strong>di</strong>bile del suo attuale<br />
status <strong>di</strong> conservazione.<br />
2.4.10.15 Istrice, Hystrix cristata, (Linnaeus, 1758)<br />
Phylum; Chordata Classe: Mammalia; Or<strong>di</strong>ne: Rodentia; Famiglia: Hystricidae<br />
Convenzioni internazionali<br />
Convenzione <strong>di</strong> Berna: Ap. 2; Direttiva 43/92/CEE: Ap. 4; L. 157/1992: specie protetta; L.R.<br />
della Toscana 56/2000: non in<strong>di</strong>cato; LR IUCN: Least Concern; Liste Rosse: non in<strong>di</strong>cato.<br />
Ecologia<br />
Specie ad alta valenza ecologica, lo si rinviene comunemente in tutti gli ecosistemi agro-<br />
forestali. Molta importanza rivestono elementi lineari come siepi e fossi con ricca<br />
vegetazione sulle sponde che la specie utilizza ampiamente come corridoi per gli<br />
spostamenti. Dieta vegetariana generalista: piante spontanee o coltivate <strong>di</strong> cui consuma<br />
prevalentemente le parti ipogee, ma anche la corteccia, i frutti e i semi. Si rifugia in cavità<br />
naturali o in gallerie attivamente scavate e spesso con<strong>di</strong>vise con il Tasso. Attivo<br />
principalmente <strong>di</strong> notte. Monogama, il suo ciclo riproduttivo è basato sulla formazione <strong>di</strong><br />
coppie stabili. Uno o due parti all'anno, in momenti in<strong>di</strong>pendenti dalle stagioni, ma pare più<br />
frequenti in febbraio. Parti semplici o gemellari.<br />
Distribuzione<br />
La sua <strong>di</strong>stribuzione in Europa riguarda solo l'Italia, dove è presente non tanto per<br />
introduzioni ad opera dei Romani, quanto per la sopravvivenza <strong>di</strong> popolazioni <strong>di</strong> origine<br />
pleistocenica. In Africa è presente lungo la fascia costiera me<strong>di</strong>terranea con estensione fino<br />
al Senegal, Zaire e Tanzania. In Italia presenta una <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong>scontinua: Sicilia,<br />
Calabria, Gargano, Lazio, Abruzzo, Umbria, Marche, Toscana (anche Elba), Emilia<br />
Romagna, Veneto e Lombar<strong>di</strong>a meri<strong>di</strong>onale. In queste aree sembra ben <strong>di</strong>ffusa e comune.<br />
Distribuzione regionale<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 91<br />
Segnalata per tutte le provincie della regione, risulta più comune nei territori <strong>di</strong> RN e FC,<br />
dove frequenta le aree collinari ricche <strong>di</strong> vegetazione arborea e arbustiva. Meno comune<br />
nelle aree montane, in pianura si può spingere fino alla periferia delle aree antropizzate dove<br />
comunque è raro. In espansione negli ultimi anni. Scaravelli (2001) in<strong>di</strong>ca la presenza della<br />
specie “consistente e <strong>di</strong>stribuita in tutti gli ambiti dell'area protetta”. Le segnalazioni sono<br />
numerose in tutte le aree ad eccezione <strong>di</strong> quelle alle quote più alte.<br />
Minacce e stato <strong>di</strong> conservazione<br />
La specie è in progressivo aumento numerico in Emilia Romagna, a partire dalle prime<br />
segnalazioni degli anni 1950 fino all'attuale colonizzazione che si è estesa verso nord a<br />
Veneto e Lombar<strong>di</strong>a. Non si segnalano minacce puntuali e lo stato <strong>di</strong> conservazione appare<br />
favorevole. Specie <strong>di</strong> basso valore conservazionistico, in Emilia Romagna sembra essere in<br />
espansione progressiva. A livello nazionale si espande verso nord, mentre in alcune aree<br />
dell'Italia meri<strong>di</strong>onale sembra essere in regressione. Le minacce si riscontrano nella<br />
crescente antropizzazione e sottrazione <strong>di</strong> habitat (particolarmente elevata in aree <strong>di</strong><br />
pianura), banalizzazione delle campagne con per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> formazioni lineari e inquinamento. La<br />
specie è spesso vittima <strong>di</strong> investimento da parte <strong>di</strong> veicoli sulle strade.<br />
2.5 Scelta degli in<strong>di</strong>catori utili per la valutazione dello stato <strong>di</strong> conservazione ed il<br />
monitoraggio delle attività <strong>di</strong> gestione<br />
2.5.1 Generalità<br />
L’in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong> alcuni elementi in<strong>di</strong>catori è in<strong>di</strong>spensabile e funzionale alla costruzione <strong>di</strong><br />
un sistema <strong>di</strong> monitoraggio e controllo dello stato <strong>di</strong> conservazione dell’intero sito in<br />
relazione alle attività <strong>di</strong> gestione e al perseguimento degli obiettivi del Piano <strong>di</strong> gestione. Tali<br />
in<strong>di</strong>catori devono consentire il rilevamento e la valutazione delle variazioni ecologiche<br />
<strong>di</strong>venendo strumento importante per in<strong>di</strong>rizzare o modulare le azioni e gli interventi <strong>di</strong><br />
gestione.<br />
Il sistema <strong>di</strong> in<strong>di</strong>catori deve fare riferimento specifico alla <strong>di</strong>versa complessità e<br />
organizzazione del mosaico territoriale, agli assetti floristico, vegetazionale, forestale,<br />
faunistico e idrobiologico, oltre che ai fattori <strong>di</strong> <strong>di</strong>sturbo e alterazione ambientale. Il quadro<br />
informativo deve essere integrato da in<strong>di</strong>catori relativi al settore socioeconomico, che<br />
devono rispondere a una duplice valenza: quella <strong>di</strong>retta, <strong>di</strong> rilevazione e misura degli<br />
andamenti dei fenomeni socioeconomici, a livello della comunità locale del territorio in cui è<br />
ubicato il sito (tendenze demografiche, tassi <strong>di</strong> attività e <strong>di</strong>soccupazione, tassi <strong>di</strong> scolarità,<br />
flussi turistici), e quella in<strong>di</strong>retta, <strong>di</strong> segnalazione della presenza <strong>di</strong> fattori <strong>di</strong> pressione<br />
antropica sull'ambiente.<br />
Si tratta quin<strong>di</strong> <strong>di</strong> elementi, gli in<strong>di</strong>catori, che devono fornire risposte ad esigenze gestionali e<br />
al contempo rispondere a criteri <strong>di</strong> sintesi e semplicità <strong>di</strong> rilevamento e <strong>di</strong> lettura.<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 92<br />
Lo stato <strong>di</strong> conservazione per un habitat è da considerare sod<strong>di</strong>sfacente quando:<br />
• la sua area <strong>di</strong> ripartizione naturale e la superficie occupata è stabile o in estensione;<br />
• la struttura, le con<strong>di</strong>zioni e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento nel<br />
lungo periodo esistono e possono continuare ad esistere in un futuro preve<strong>di</strong>bile.<br />
Andranno monitorati con continuità nel tempo l’estensione complessiva dei <strong>di</strong>versi habitat<br />
con particolare riferimento a quelli prioritari e lo stato <strong>di</strong> conservazione delle specie tipiche<br />
e/o guida e dei fattori caratteristici o intrinseci (es. struttura verticale, densità ecc.).<br />
Lo stato <strong>di</strong> conservazione per una specie animale o vegetale è sod<strong>di</strong>sfacente quando:<br />
l’andamento della popolazione della specie in<strong>di</strong>ca che la stessa specie continua e può<br />
continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale presente negli habitat del sito;<br />
la presenza quantitativa ed areale <strong>di</strong> tale specie non è minacciata né rischia la riduzione o il<br />
declino in un futuro preve<strong>di</strong>bile.<br />
La scelta degli in<strong>di</strong>catori deve rispondere a determinati requisiti e criteri; devono cioè essere:<br />
• <strong>di</strong> riconosciuta significatività ecologica;<br />
• sensibili ai fini <strong>di</strong> un monitoraggio precoce dei cambiamenti;<br />
• <strong>di</strong> vasta applicabilità a scala nazionale;<br />
• <strong>di</strong> rilevamento relativamente semplice ed economico;<br />
• chiari e non generici;<br />
• ripetibili, in<strong>di</strong>pendentemente dal rilevatore;<br />
• confrontabili nel tempo, e quin<strong>di</strong> standar<strong>di</strong>zzati;<br />
• coerenti con le finalità istitutive del sito;<br />
• uno strumento concreto in mano all’Ente Gestore, con i quali esso sappia tenere sotto<br />
controllo l’evoluzione dei popolamenti e l’influenza su <strong>di</strong> essi degli interventi gestionali.<br />
In ragione degli stu<strong>di</strong> e ricerche condotti sul sito in tempi <strong>di</strong>versi, del risultato dei monitoraggi<br />
recentemente eseguiti e sulla base delle considerazioni sopradescritte sono stati definiti i<br />
seguenti in<strong>di</strong>catori.<br />
2.5.2 Habitat<br />
Il monitoraggio degli habitat e la loro gestione deve consentire l’acquisizione almeno delle<br />
seguenti informazioni:<br />
- superficie occupata dall’habitat e dai poligoni dell’habitat, e variazione nel tempo <strong>di</strong> tali<br />
parametri;<br />
- struttura dell’habitat necessaria al mantenimento a lungo termine, e preve<strong>di</strong>bilità della<br />
sua presenza in futuro (<strong>di</strong> particolare rilevanza per gli habitat forestali);<br />
- funzionalità e funzioni specifiche dell’habitat (stato fitosanitario e fisico-vegetativo,<br />
processi <strong>di</strong> rigenerazione e stato <strong>di</strong> vitalità delle specie tipiche, presenza <strong>di</strong> specie rare);<br />
- presenza <strong>di</strong> specie tipiche (quantità specie e copertura).<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 93<br />
L’analisi strutturale è particolarmente rilevante per gli habitat forestali; questi devono essere<br />
dotati <strong>di</strong> una <strong>di</strong>versità strutturale (verticale e orizzontale) sufficiente alla <strong>di</strong>versificazione della<br />
nicchia ecologica (spaziale e trofica) delle specie tipiche dell’habitat (vegetali e animali).<br />
È possibile riconoscere, nei <strong>di</strong>versi tipi <strong>di</strong> habitat forestali, una struttura nella <strong>di</strong>stribuzione<br />
orizzontale e verticale degli in<strong>di</strong>vidui che tende a crearsi per <strong>di</strong>namiche naturali, legate alle<br />
modalità e ai tempi d’inse<strong>di</strong>amento della rinnovazione naturale delle specie caratteristiche<br />
dell’habitat, e legate ai rapporti <strong>di</strong> competizione intraspecifici e interspecifici (Del Favero et<br />
al., 2000).<br />
NOME TARGET<br />
Dimensione<br />
della tessera<br />
più estesa<br />
dell’habitat<br />
Estensione<br />
dell’habitat<br />
Presenza <strong>di</strong><br />
specie esotiche<br />
nell’habitat<br />
3150<br />
Presenza <strong>di</strong><br />
captazioni<br />
idriche/drenagg<br />
i<br />
Presenza <strong>di</strong><br />
scarichi<br />
Presenza <strong>di</strong><br />
specie esotiche<br />
nell’habitat<br />
3240<br />
Presenza <strong>di</strong><br />
specie nitrofile<br />
nell’habitat<br />
3240<br />
UNITA' DI<br />
MISURA<br />
Tutti gli habitat Ettari e frazioni<br />
fino al m 2<br />
Tutti gli habitat Ettari e frazioni<br />
fino al m 2<br />
DEFINIZIONE FONTE<br />
Superficie<br />
territoriale,<br />
misurata in ettari e<br />
frazioni fino al m 2 ,<br />
della tessera <strong>di</strong><br />
maggiori<br />
<strong>di</strong>mensioni<br />
occupata<br />
dall’habitat<br />
Superficie<br />
territoriale,<br />
misurata in ettari e<br />
frazioni fino al m 2 ,<br />
occupata<br />
dall’habitat<br />
Habitat 3150 n. <strong>di</strong> specie target Presenza /<br />
assenza <strong>di</strong> specie<br />
esotiche<br />
Habitat 3240 Presenza/assenza<br />
(eventualmente<br />
portata delle<br />
captazioni)<br />
Verifica della<br />
presenza <strong>di</strong><br />
captazioni/drenaggi<br />
nei pressi<br />
dell'habitat<br />
Habitat 3240 Presenza/assenza Verifica della<br />
presenza <strong>di</strong><br />
scarichi nei pressi<br />
dell'habitat<br />
Habitat 3240 n. <strong>di</strong> specie target Presenza /<br />
assenza <strong>di</strong> specie<br />
esotiche: Amorpha<br />
fruticosa, Robinia<br />
pseudoacacia,<br />
Populus<br />
canadensis<br />
Habitat 3240 presenza/assenza<br />
(eventualmente<br />
anche In<strong>di</strong>ce <strong>di</strong><br />
copertura)<br />
Presenza /<br />
assenza <strong>di</strong> specie<br />
nitrofile (es.: Urtica<br />
<strong>di</strong>oica)<br />
Carta habitat e<br />
DB associato<br />
con superfici e<br />
successivi<br />
aggiornamenti<br />
Carta habitat e<br />
DB associato<br />
con superfici e<br />
successivi<br />
aggiornamenti<br />
Rilevamenti<br />
floristici /<br />
fitosociologici<br />
Osservazioni su<br />
campo, elenco<br />
captazioni<br />
autorizzate<br />
Osservazioni su<br />
campo, elenco<br />
scarichi<br />
autorizzati<br />
Rilevamenti<br />
floristici /<br />
fitosociologici<br />
Rilevamenti<br />
floristici /<br />
fitosociologici<br />
SOGLIA<br />
CRITICA<br />
Drastica<br />
riduzione della<br />
<strong>di</strong>mensione<br />
delle tessere<br />
occupate<br />
dall'habitat<br />
Riduzione<br />
eccessiva della<br />
copertura,<br />
inferiore ad 1/5<br />
della superficie<br />
attuale<br />
Devono<br />
prevalere le<br />
specie<br />
autoctone<br />
rispetto a quelle<br />
esotiche che<br />
non devono<br />
superare il 50<br />
% in termini <strong>di</strong><br />
copertura totale<br />
Riduzione <strong>di</strong><br />
bio<strong>di</strong>versità,<br />
estinzione <strong>di</strong><br />
specie.<br />
Riduzione <strong>di</strong><br />
bio<strong>di</strong>versità,<br />
estinzione <strong>di</strong><br />
specie.<br />
Devono<br />
prevalere le<br />
specie<br />
autoctone<br />
rispetto a quelle<br />
esotiche che<br />
non devono<br />
superare il 30<br />
%<br />
La copertura <strong>di</strong><br />
specie nitrofile<br />
non deve<br />
essere<br />
predominante<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”<br />
BIBLIOGRAFIA<br />
E NOTE<br />
Rossi & Parolo,<br />
2009<br />
DM 3 settembre<br />
2002<br />
DM 3 settembre<br />
2002<br />
L’elevata<br />
copertura<br />
percentuale <strong>di</strong><br />
specie nitrofile<br />
può essere<br />
in<strong>di</strong>ce della<br />
presenza <strong>di</strong>
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 94<br />
NOME TARGET<br />
Presenza <strong>di</strong><br />
specie esotiche<br />
nell’habitat<br />
3270<br />
Presenza <strong>di</strong><br />
specie<br />
caratteristiche<br />
dell'habitat<br />
6110<br />
Presenza <strong>di</strong><br />
specie<br />
caratteristiche<br />
dell'habitat<br />
6210<br />
Presenza <strong>di</strong><br />
specie <strong>di</strong><br />
orchidee<br />
nell’habitat<br />
6210<br />
Presenza <strong>di</strong><br />
specie<br />
caratteristiche<br />
dell'habitat<br />
6220<br />
Presenza <strong>di</strong><br />
specie esotiche<br />
nell’habitat<br />
6430<br />
UNITA' DI<br />
MISURA<br />
DEFINIZIONE FONTE<br />
Habitat 3270 n. <strong>di</strong> specie target Presenza /<br />
assenza <strong>di</strong> specie<br />
esotiche: Ambrosia<br />
artemisifolia<br />
Habitat 6110 Numero <strong>di</strong> specie<br />
e copertura 6/10<br />
m 2<br />
Habitat 6210 Numero <strong>di</strong> specie<br />
e copertura 50 m 2<br />
Habitat 6210 Numero <strong>di</strong> specie<br />
e copertura 50 m 2<br />
Habitat 6220 Numero <strong>di</strong> specie,<br />
e copertura 50 m 2<br />
Numero <strong>di</strong> specie e<br />
copertura, dell'<br />
Alysso-Se<strong>di</strong>on albi<br />
6/10 m 2<br />
Numero <strong>di</strong> specie e<br />
copertura del<br />
Festuco-<br />
Brometalia 50 m 2<br />
Numero <strong>di</strong> specie e<br />
copertura tra le<br />
Orchidaceae<br />
Numero <strong>di</strong> specie e<br />
copertura dei<br />
Thero-<br />
Brachypo<strong>di</strong>etea 50<br />
m 2<br />
Habitat 6430 n. <strong>di</strong> specie target Presenza /<br />
assenza <strong>di</strong> specie<br />
esotiche: Solidago<br />
gigantea,<br />
Helianthus<br />
tuberosum ecc.<br />
Rilevamenti<br />
floristici /<br />
fitosociologici<br />
Rilevamenti<br />
floristici e<br />
fitosociologici<br />
Rilevamenti<br />
floristici e<br />
fitosociologici<br />
Rilevamenti<br />
floristici e<br />
fitosociologici<br />
Rilevamenti<br />
floristici e<br />
fitosociologici<br />
Rilevamenti<br />
floristici /<br />
fitosociologici<br />
SOGLIA<br />
CRITICA<br />
Devono<br />
prevalere le<br />
specie<br />
autoctone<br />
rispetto a quelle<br />
esotiche che<br />
non devono<br />
superare il 50<br />
%<br />
Deve esserci<br />
prevalenza <strong>di</strong><br />
specie dell'<br />
Alysso-Se<strong>di</strong>on<br />
albi<br />
Deve esserci<br />
prevalenza <strong>di</strong><br />
specie del<br />
Festuco-<br />
Brometalia<br />
Deve essere<br />
sod<strong>di</strong>sfatto<br />
almeno uno dei<br />
seguenti criteri :<br />
(a) presenza <strong>di</strong><br />
un ricco<br />
contingente <strong>di</strong><br />
specie <strong>di</strong><br />
orchidee;<br />
(b) presenza <strong>di</strong><br />
un’importante<br />
popolazione <strong>di</strong><br />
almeno una<br />
specie <strong>di</strong><br />
orchidee<br />
ritenuta non<br />
molto comune a<br />
livello<br />
nazionale;<br />
(c) ) presenza<br />
<strong>di</strong> una o più<br />
specie <strong>di</strong><br />
orchidee<br />
ritenute rare,<br />
molto rare o <strong>di</strong><br />
eccezionale<br />
rarità a livello<br />
nazionale.<br />
Deve esserci<br />
presenza<br />
significativa <strong>di</strong><br />
specie<br />
Therodei<br />
Brachypo<strong>di</strong>etea<br />
Devono<br />
prevalere<br />
specie<br />
autoctone<br />
le<br />
rispetto a quelle<br />
esotiche che<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”<br />
BIBLIOGRAFIA<br />
E NOTE<br />
sostanze<br />
chimiche<br />
provenienti<br />
presumibilmente<br />
dalle attività<br />
colturali nei<br />
terrazzi<br />
a<strong>di</strong>acenti (DM 3<br />
settembre 2002)
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 95<br />
NOME TARGET<br />
Presenza <strong>di</strong><br />
specie<br />
caratteristiche<br />
dell'habitat<br />
6510<br />
Presenza <strong>di</strong><br />
specie<br />
caratteristiche<br />
dell'habitat<br />
91AA<br />
Presenza <strong>di</strong><br />
specie invasive<br />
nell’ habitat<br />
91AA<br />
Struttura<br />
verticale<br />
dell’habitat<br />
Superficie<br />
forestale gestita<br />
a ceduo<br />
Superficie<br />
forestale gestita<br />
a fustaia<br />
Presenza <strong>di</strong><br />
alberi morti in<br />
pie<strong>di</strong><br />
Presenza <strong>di</strong><br />
necromassa<br />
UNITA' DI<br />
MISURA<br />
Habitat 6510 Numero <strong>di</strong> specie,<br />
e copertura 50 m 2<br />
Habitat 91AA Numero in<strong>di</strong>vidui<br />
e copertura<br />
400/500 m 2<br />
Habitat 91AA Numero in<strong>di</strong>vidui<br />
e copertura<br />
400/500 m 2<br />
Habitat<br />
91AA/91E0/92A0<br />
Habitat<br />
91AA/91E0/92A0<br />
Habitat<br />
91AA/91E0/92A0<br />
Habitat<br />
91AA/91E0/92A0<br />
Habitat<br />
91AA/91E0/92A0<br />
Incen<strong>di</strong> Habitat<br />
91AA/91E0/92A0<br />
Presenza <strong>di</strong><br />
specie<br />
alloctone (es.<br />
Robinia<br />
pseudoacacia)<br />
Habitat<br />
91AA/91E0/92A0<br />
DEFINIZIONE FONTE<br />
Numero <strong>di</strong> specie e<br />
copertura degli<br />
Arrhenateretalia<br />
Numero in<strong>di</strong>vidui e<br />
copertura 400/500<br />
m2<br />
Numero in<strong>di</strong>vidui e<br />
copertura 400/500<br />
m 2<br />
Numero Numero <strong>di</strong> strati in<br />
cui è articolata la<br />
vegetazione<br />
Ettari e % Ettari e % <strong>di</strong><br />
superficie forestale<br />
gestita a ceduo<br />
Ettari e % Ettari e % <strong>di</strong><br />
superficie forestale<br />
gestita a fustaia da<br />
frutto<br />
Numero<br />
alberi/ettaro<br />
Numero alberi<br />
morti in pie<strong>di</strong> per<br />
ettaro<br />
m 3 /ettaro Metri cubi <strong>di</strong><br />
necromassa per<br />
ettaro<br />
Densità dei punti<br />
<strong>di</strong> innesco e<br />
superficie<br />
percorsa<br />
Localizzazione,<br />
superficie <strong>di</strong><br />
presenza (ha) e %<br />
<strong>di</strong> incidenza<br />
specie alloctone<br />
(numero e<br />
copertura);<br />
rinnovazione<br />
specie alloctone<br />
(n/ha)<br />
Verifica della<br />
Presenza/assenza<br />
dei punti <strong>di</strong> innesco<br />
e della tipologia <strong>di</strong><br />
incen<strong>di</strong>o (es: <strong>di</strong><br />
chioma, al suolo)<br />
Localizzazione,<br />
superficie <strong>di</strong><br />
presenza (ha) e %<br />
<strong>di</strong> incidenza specie<br />
alloctone (numero<br />
e copertura);<br />
rinnovazione<br />
specie alloctone<br />
(n/ha)<br />
Rilevamenti<br />
floristici e<br />
fitosociologici<br />
Rilevamenti<br />
floristici e<br />
fitosociologici<br />
Rilevamenti<br />
floristici e<br />
fitosociologici<br />
Rilevamenti<br />
floristici /<br />
fitosociologici<br />
Carta Forestale,<br />
Progetti e/o<br />
Pianificazione <strong>di</strong><br />
settore, rilievi<br />
forestali<br />
Carta Forestale,<br />
Progetti e/o<br />
Pianificazione <strong>di</strong><br />
settore,<br />
forestali<br />
rilievi<br />
Rilievi forestali<br />
Stime/rilevamenti<br />
forestali<br />
Osservazioni e<br />
misurazioni in<br />
campo<br />
Rilevamenti<br />
floristici /<br />
fitosociologici e/o<br />
forestali<br />
SOGLIA<br />
CRITICA<br />
non devono<br />
superare il 50<br />
%<br />
Deve esserci<br />
presenza<br />
significativa <strong>di</strong><br />
specie degli<br />
Arrhenateretali<br />
a<br />
Deve esserci<br />
prevalenza <strong>di</strong><br />
Quercus<br />
pubescens<br />
Non deve<br />
esserci<br />
prevalenza <strong>di</strong><br />
Ostrya<br />
carpinifolia<br />
Meno <strong>di</strong> 10<br />
m 3 /ettaro viene<br />
qui in<strong>di</strong>cata<br />
come una<br />
situazione non<br />
favorevole<br />
Oltre 40% viene<br />
considerata una<br />
situazione non<br />
favorevole<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”<br />
BIBLIOGRAFIA<br />
E NOTE<br />
Una <strong>di</strong>minuzione<br />
delle specie<br />
quercine a<br />
favore <strong>di</strong><br />
in<strong>di</strong>vidui della<br />
specie O.<br />
carpinifolia può<br />
portare a uno<br />
sbilanciamento<br />
della<br />
composizione<br />
dell’ habitat<br />
DM 3 settembre<br />
2002<br />
Mason &<br />
Cavalli, 2003
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 96<br />
NOME TARGET<br />
In<strong>di</strong>ce <strong>di</strong><br />
rinnovazione<br />
(IR)<br />
Presenza <strong>di</strong><br />
specie<br />
caratteristiche<br />
dell'habitat<br />
91E0 rispetto<br />
all’habitat 92A0<br />
Habitat<br />
91AA/91E0/92A0<br />
Habitat<br />
91E0/92A0<br />
UNITA' DI<br />
MISURA<br />
Numero <strong>di</strong><br />
semenzali<br />
affermati/ettaro <strong>di</strong><br />
specie forestali<br />
tipiche dell’habitat<br />
Numero in<strong>di</strong>vidui<br />
e copertura<br />
400/500 m 2<br />
DEFINIZIONE FONTE<br />
Numero <strong>di</strong><br />
semenzali<br />
affermati/ettaro<br />
specie forestali<br />
tipiche dell’habitat<br />
Numero in<strong>di</strong>vidui e<br />
copertura 400/500<br />
m 2<br />
Rilevamenti<br />
forestali<br />
Rilevamenti<br />
floristici e<br />
fitosociologici<br />
TABELLA 1 – SOGLIE CRITICHE PER GLI INDICATORI DEGLI HABITAT.<br />
2.5.3 Specie vegetali <strong>di</strong> interesse conservazionistico<br />
SOGLIA<br />
CRITICA<br />
Assenza <strong>di</strong><br />
semenzali<br />
affermati<br />
Nel sottobosco<br />
erbaceo<br />
dell’habitat<br />
91E0 deve<br />
esserci<br />
prevalenza <strong>di</strong><br />
megaforbie<br />
igrofile quali<br />
Filipendula<br />
ulmaria,<br />
Angelica<br />
sylvestris,<br />
Cardamine<br />
spp., Rumex<br />
sanguineus,<br />
Carex spp.,<br />
Cirsium<br />
oleraceum,<br />
oppure <strong>di</strong><br />
geofite quali<br />
Ranunculus<br />
ficaria,<br />
Anemone<br />
nemorosa, A.<br />
ranunculoides,<br />
Corydalis<br />
solida<br />
Il monitoraggio delle specie vegetali <strong>di</strong> interesse conservazionistico e la loro gestione deve<br />
consentire l’acquisizione almeno delle seguenti informazioni:<br />
- Stima della popolazione.<br />
- Numero e <strong>di</strong>stribuzione aree e siti <strong>di</strong> presenza.<br />
NOME TARGET UNITA’ DI DEFINIZIONE FONTE SOGLIA<br />
MISURA<br />
CRITICA<br />
Presenza <strong>di</strong> Potamogeton Numero Numero <strong>di</strong> database drastica<br />
specie rare natans, Typha<br />
stazioni con regionale riduzione delle<br />
<strong>di</strong> ambiente latifolia<br />
presenza delle (aggiornamento stazioni note,<br />
acquatico<br />
specie in<strong>di</strong>cate 2010) e drastica<br />
osservazioni sul riduzione della<br />
campo<br />
superficie<br />
occupata,<br />
estinzione<br />
Presenza <strong>di</strong> Himantoglossu Numero Numero <strong>di</strong> database drastica<br />
Orchidacea m adriaticum,<br />
stazioni con regionale riduzione delle<br />
e delle Orchis<br />
presenza delle (aggiornamento stazioni note,<br />
praterie coriophora<br />
specie in<strong>di</strong>cate 2010) e drastica<br />
aride Serapias lingua<br />
osservazioni sul riduzione della<br />
campo<br />
superficie<br />
occupata,<br />
estinzione<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”<br />
BIBLIOGRAFIA<br />
E NOTE<br />
BIBLIOGRAFIA E<br />
NOTE
Presenza <strong>di</strong><br />
specie rare<br />
<strong>di</strong> ambiente<br />
forestale<br />
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 97<br />
Galanthus<br />
nivalis,<br />
Pulmonaria<br />
apennina, Lilium<br />
martagon,<br />
Rhamnus<br />
alaternus,Taxus<br />
baccata<br />
2.5.4 Fauna<br />
Numero Numero <strong>di</strong><br />
stazioni con<br />
presenza delle<br />
specie in<strong>di</strong>cate<br />
database<br />
regionale<br />
(aggiornamento<br />
2010) e<br />
osservazioni sul<br />
campo<br />
drastica<br />
riduzione delle<br />
stazioni note,<br />
drastica<br />
riduzione della<br />
superficie<br />
occupata,<br />
estinzione<br />
TABELLA 2 – SOGLIE CRITICHE PER GLI INDICATORI DELLA FLORA DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO.<br />
Il monitoraggio delle specie animali <strong>di</strong> interesse conservazionistico e la loro gestione deve<br />
consentire l’acquisizione almeno delle seguenti informazioni:<br />
- Processi informativi <strong>di</strong> base.<br />
- Status delle zoocenosi.<br />
- Composizione <strong>di</strong> zoocenosi guida.<br />
- Presenza <strong>di</strong> specie animali alloctone.<br />
2.5.4.1 Invertebrati<br />
NOME TARGET UNITA’ DI DEFINIZIONE FONTE SOGLIA CRITICA BIBLIOGRAFIA<br />
MISURA<br />
E NOTE<br />
Presenza <strong>di</strong> Cicindela Numero Definizione Rilievo in Rilevamento <strong>di</strong> un Brandmayr P.,<br />
coleotteri legati ad majalis<br />
della<br />
campagna drastico calo degli Zetto T. &<br />
ambienti <strong>di</strong> greto. Anthypna<br />
<strong>di</strong>stribuzione<br />
adulti all’interno <strong>di</strong> Pizzolotto R.,<br />
abdominalis<br />
nel SIC delle<br />
un periodo <strong>di</strong> 2005<br />
aemiliana<br />
specie <strong>di</strong><br />
monitoragggio Zangheri, 1981<br />
(1336-2186)<br />
coleotteri<br />
protratto su almeno<br />
inse<strong>di</strong>ate in<br />
aree stabili <strong>di</strong><br />
tre anni.<br />
greto<br />
banchi<br />
con<br />
sabbiosi<br />
basso<br />
<strong>di</strong>sturbo<br />
antropico.<br />
e<br />
Presenza <strong>di</strong> Cerambyx Numero Stima della Rilievo in Rilevamento <strong>di</strong> un Mason et al.,<br />
Coleotteri<br />
cerdo<br />
consistenza campagna drastico calo degli 2002<br />
saproxilici<br />
Elater<br />
delle<br />
adulti all’interno <strong>di</strong> Ranius &<br />
ferrugineus<br />
popolazioni <strong>di</strong><br />
un periodo <strong>di</strong> Jansson, 2002<br />
<strong>Luca</strong>nus<br />
coleotteri<br />
monitoraggio Harvey et al.,<br />
cervus<br />
saproxilici<br />
protratto su almeno 2011<br />
(1738-<br />
presenti nel<br />
tre anni.<br />
2116- 2437)<br />
SIC.<br />
Presenza <strong>di</strong> Hydrophilus Numero Definizione Rilievo in Rilevamento <strong>di</strong> un Zangheri, 1981<br />
coleotteri<br />
piceus<br />
della<br />
campagna drastico calo degli<br />
acquatici legati ad (2416)<br />
<strong>di</strong>stribuzione<br />
adulti all’interno <strong>di</strong><br />
acque lentiche<br />
nel SIC <strong>di</strong><br />
un periodo <strong>di</strong><br />
Hydrophilus<br />
monitoragggio<br />
piceus, specie<br />
protratto su almeno<br />
legata a<br />
tre anni.<br />
stagni<br />
ricca<br />
con<br />
vegetazione<br />
ripariale.<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 98<br />
NOME TARGET UNITA’ DI<br />
MISURA<br />
Presenza <strong>di</strong><br />
Coleotteri carabi<strong>di</strong><br />
<strong>di</strong> interesse<br />
conservazionistico<br />
Presenza <strong>di</strong><br />
lepidotteri<br />
associati a<br />
vegetazione<br />
ripariale<br />
specializzata<br />
Presenza <strong>di</strong><br />
Austropotamobius<br />
pallipes<br />
Nebria<br />
psammode<br />
s Stomis<br />
bucciarellii<br />
(1489-1665)<br />
Hyles<br />
hippophaes<br />
(3871)<br />
Specie <strong>di</strong><br />
interesse<br />
comunitario<br />
(All. II e All.<br />
IV Direttiva<br />
Habitat)<br />
2.5.4.2 Ittiofauna<br />
DEFINIZIONE FONTE SOGLIA CRITICA BIBLIOGRAFIA<br />
E NOTE<br />
Numero Definizione<br />
della<br />
<strong>di</strong>stribuzione<br />
nel SIC <strong>di</strong><br />
Stomis<br />
bucciarellii,<br />
endemismo<br />
italico tipico<br />
dei calanchi <strong>di</strong><br />
buona qualità.<br />
Numero Definizione<br />
della<br />
<strong>di</strong>stribuzione<br />
nel SIC <strong>di</strong><br />
Hyles<br />
hippophaes,<br />
sfingide<br />
infeudato<br />
sull’Olivello<br />
spinoso.<br />
In<strong>di</strong>ci <strong>di</strong><br />
abbondanza<br />
NOME TARGET UNITA’ DI<br />
Austropotamo-<br />
bius pallipes<br />
Barbus plebejus<br />
Specie <strong>di</strong><br />
interesse<br />
comunitari<br />
o<br />
(All. II e All.<br />
IV Direttiva<br />
Habitat)<br />
L.R.<br />
15/2006<br />
Specie <strong>di</strong><br />
interesse<br />
comunitari<br />
o<br />
(All. II e All.<br />
V Direttiva<br />
Habitat)<br />
L.R.<br />
Classi <strong>di</strong><br />
abbondanza<br />
Rilievo in<br />
campagna<br />
Rilievo in<br />
campagna<br />
Censimenti<br />
macrobentonic<br />
i<br />
TABELLA 3 – SOGLIE CRITICHE PER GLI INDICATORI DELL’INVERTEBRATOFAUNA.<br />
MISURA<br />
In<strong>di</strong>ci <strong>di</strong><br />
abbondanz<br />
a<br />
Struttura <strong>di</strong><br />
popolazione<br />
In<strong>di</strong>ci <strong>di</strong><br />
abbondanz<br />
a<br />
Rilevamento <strong>di</strong> un<br />
drastico calo degli<br />
adulti all’interno <strong>di</strong><br />
un periodo <strong>di</strong><br />
monitoragggio<br />
protratto su almeno<br />
tre anni.<br />
Rilevamento <strong>di</strong> un<br />
drastico calo degli<br />
adulti all’interno <strong>di</strong><br />
un periodo <strong>di</strong><br />
monitoraggio<br />
protratto su almeno<br />
tre anni.<br />
Popolazioni<br />
rarefatte (nessuno o<br />
pochi esemplari)<br />
DEFINIZIONE FONTE SOGLIA<br />
Classi <strong>di</strong><br />
abbondanza<br />
Classi <strong>di</strong> età<br />
Classi <strong>di</strong><br />
abbondanza<br />
Censimenti<br />
macrobentonic<br />
i<br />
Censimenti<br />
CRITICA<br />
Popolazion<br />
i rarefatte<br />
(nessuno o<br />
pochi<br />
esemplari)<br />
Cobitis taenia<br />
15/2006<br />
Specie <strong>di</strong> Struttura <strong>di</strong> Classi <strong>di</strong> età Censimenti Popolazion Dati<br />
ittici<br />
Popolazion<br />
i rarefatte e<br />
non<br />
strutturate<br />
Brandmayr P.,<br />
Zetto T. &<br />
Pizzolotto R.,<br />
2005<br />
Zangheri, 1981<br />
Fry & Waring,<br />
2001<br />
Southwood,<br />
1978<br />
Dati<br />
Carta ittica<br />
Emilia-<br />
Romagna -<br />
Zona C;<br />
Ecosistema<br />
Scarl;<br />
Bioprogramm<br />
2011<br />
RIFERIMENTI<br />
BIBLIOGRAFICI<br />
Dati<br />
Carta ittica Emilia-<br />
Romagna - Zona<br />
C; Ecosistema<br />
Scarl;<br />
Bioprogramm<br />
2011<br />
Dati<br />
Carta ittica Emilia-<br />
Romagna - Zona<br />
C; Ecosistema<br />
Scarl;<br />
Bioprogramm<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”<br />
2011
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 99<br />
NOME TARGET UNITA’ DI<br />
Chondrostoma<br />
genei<br />
Rutilus rubilio<br />
Leuciscus<br />
souffia<br />
Leuciscus<br />
cephalus<br />
interesse<br />
comunitari<br />
o<br />
(All. II<br />
Direttiva<br />
Habitat)<br />
L.R.<br />
15/2006<br />
Specie <strong>di</strong><br />
interesse<br />
comunitari<br />
o<br />
(All. II<br />
Direttiva<br />
Habitat)<br />
L.R.<br />
15/2006<br />
Specie <strong>di</strong><br />
interesse<br />
comunitari<br />
o<br />
(All. II<br />
Direttiva<br />
Habitat)<br />
Specie <strong>di</strong><br />
interesse<br />
comunitari<br />
o<br />
(All. II<br />
Direttiva<br />
Habitat)<br />
L.R.<br />
15/2006<br />
L.R.<br />
15/2006<br />
Gobio gobio L.R.<br />
15/2006<br />
MISURA<br />
popolazione<br />
In<strong>di</strong>ci <strong>di</strong><br />
abbondanz<br />
a<br />
Struttura <strong>di</strong><br />
popolazione<br />
In<strong>di</strong>ci <strong>di</strong><br />
abbondanz<br />
a<br />
Struttura <strong>di</strong><br />
popolazione<br />
In<strong>di</strong>ci <strong>di</strong><br />
abbondanz<br />
a<br />
Struttura <strong>di</strong><br />
popolazione<br />
In<strong>di</strong>ci <strong>di</strong><br />
abbondanz<br />
a<br />
Struttura <strong>di</strong><br />
popolazione<br />
In<strong>di</strong>ci <strong>di</strong><br />
abbondanz<br />
a<br />
Struttura <strong>di</strong><br />
popolazione<br />
In<strong>di</strong>ci <strong>di</strong><br />
DEFINIZIONE FONTE SOGLIA<br />
Classi <strong>di</strong><br />
abbondanza<br />
Classi <strong>di</strong> età<br />
Classi <strong>di</strong><br />
abbondanza<br />
Classi <strong>di</strong> età<br />
Classi <strong>di</strong><br />
abbondanza<br />
Classi <strong>di</strong> età<br />
Classi <strong>di</strong><br />
abbondanza<br />
Classi <strong>di</strong> età<br />
Classi <strong>di</strong><br />
abbondanza<br />
Classi <strong>di</strong> età<br />
Classi <strong>di</strong><br />
ittici<br />
Censimenti<br />
ittici<br />
Censimenti<br />
ittici<br />
Censimenti<br />
ittici<br />
Censimenti<br />
ittici<br />
Censimenti<br />
ittici<br />
CRITICA<br />
i rarefatte e<br />
non<br />
strutturate<br />
Popolazion<br />
i rarefatte e<br />
non<br />
strutturate<br />
Popolazion<br />
i rarefatte e<br />
non<br />
strutturate<br />
Popolazion<br />
i rarefatte e<br />
non<br />
strutturate<br />
Popolazion<br />
i rarefatte e<br />
non<br />
strutturate<br />
Popolazion<br />
i rarefatte e<br />
non<br />
strutturate<br />
RIFERIMENTI<br />
BIBLIOGRAFICI<br />
Carta ittica Emilia-<br />
Romagna - Zona<br />
C; Ecosistema<br />
Scarl;<br />
Bioprogramm<br />
2011<br />
Dati<br />
Carta ittica Emilia-<br />
Romagna - Zona<br />
C; Ecosistema<br />
Scarl;<br />
Bioprogramm<br />
2011<br />
Dati<br />
Carta ittica Emilia-<br />
Romagna - Zona<br />
C; Ecosistema<br />
Scarl;<br />
Bioprogramm<br />
2011<br />
Dati<br />
Carta ittica Emilia-<br />
Romagna - Zona<br />
C; Ecosistema<br />
Scarl;<br />
Bioprogramm<br />
2011<br />
Dati<br />
Carta ittica Emilia-<br />
Romagna - Zona<br />
C; Ecosistema<br />
Scarl;<br />
Bioprogramm<br />
2011<br />
Dati<br />
Carta ittica Emilia-<br />
Romagna - Zona<br />
C; Ecosistema<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 100<br />
NOME TARGET UNITA’ DI<br />
Padogobius<br />
martensii<br />
L.R.<br />
15/2006<br />
MISURA<br />
abbondanz<br />
a<br />
Struttura <strong>di</strong><br />
popolazione<br />
In<strong>di</strong>ci <strong>di</strong><br />
abbondanz<br />
a<br />
DEFINIZIONE FONTE SOGLIA<br />
abbondanza<br />
Classi <strong>di</strong> età<br />
Classi <strong>di</strong><br />
abbondanza<br />
Censimenti<br />
ittici<br />
CRITICA<br />
Popolazion<br />
i rarefatte e<br />
non<br />
strutturate<br />
TABELLA 4 – SOGLIE CRITICHE PER GLI INDICATORI DELL’ITTIOFAUNA E DEL GAMBERO DI FIUME.<br />
NOME TARGET UNITA’ DI<br />
In<strong>di</strong>ce <strong>di</strong><br />
Moyle<br />
In<strong>di</strong>ce <strong>di</strong><br />
Moyle<br />
In<strong>di</strong>ce <strong>di</strong><br />
Moyle<br />
In<strong>di</strong>ce <strong>di</strong><br />
Moyle<br />
In<strong>di</strong>ce <strong>di</strong><br />
Moyle<br />
Austropota-<br />
mobius<br />
pallipes<br />
Barbus<br />
plebejus<br />
Cobitis<br />
taenia<br />
Chondrosto-<br />
ma genei<br />
Rutilus<br />
rubilio<br />
MISURA<br />
Classe <strong>di</strong><br />
abbondanza<br />
Classe <strong>di</strong><br />
abbondanza<br />
Classe <strong>di</strong><br />
abbondanza<br />
Classe <strong>di</strong><br />
abbondanza<br />
Classe <strong>di</strong><br />
abbondanza<br />
DEFINIZIONE FONTE SOGLIA<br />
Numero <strong>di</strong> in<strong>di</strong>vidui<br />
su 50 m lineari:<br />
0
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 101<br />
In<strong>di</strong>ce <strong>di</strong><br />
Moyle<br />
In<strong>di</strong>ce <strong>di</strong><br />
Moyle<br />
In<strong>di</strong>ce <strong>di</strong><br />
Moyle<br />
In<strong>di</strong>ce <strong>di</strong><br />
Moyle<br />
In<strong>di</strong>ce <strong>di</strong><br />
struttura <strong>di</strong><br />
popolazione<br />
In<strong>di</strong>ce <strong>di</strong><br />
struttura <strong>di</strong><br />
popolazione<br />
Leuciscus<br />
souffia<br />
Leuciscus<br />
cephalus<br />
Classe <strong>di</strong><br />
abbondanza<br />
Classe <strong>di</strong><br />
abbondanza<br />
Gobio gobio Classe <strong>di</strong><br />
Padogobius<br />
martensii<br />
Barbus<br />
plebejus<br />
Cobitis<br />
taenia<br />
abbondanza<br />
Classe <strong>di</strong><br />
abbondanza<br />
Livello <strong>di</strong><br />
struttura <strong>di</strong><br />
popolazione<br />
Livello <strong>di</strong><br />
struttura <strong>di</strong><br />
popolazione<br />
Numero <strong>di</strong> in<strong>di</strong>vidui<br />
su 50 m lineari:<br />
0
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 102<br />
In<strong>di</strong>ce <strong>di</strong><br />
struttura <strong>di</strong><br />
popolazione<br />
In<strong>di</strong>ce <strong>di</strong><br />
struttura <strong>di</strong><br />
popolazione<br />
In<strong>di</strong>ce <strong>di</strong><br />
struttura <strong>di</strong><br />
popolazione<br />
In<strong>di</strong>ce <strong>di</strong><br />
struttura <strong>di</strong><br />
popolazione<br />
In<strong>di</strong>ce <strong>di</strong><br />
struttura <strong>di</strong><br />
popolazione<br />
Chondrosto-<br />
ma genei<br />
Rutilus<br />
rubilio<br />
Leuciscus<br />
souffia<br />
Leuciscus<br />
cephalus<br />
Livello <strong>di</strong><br />
struttura <strong>di</strong><br />
popolazione<br />
Livello <strong>di</strong><br />
struttura <strong>di</strong><br />
popolazione<br />
Livello <strong>di</strong><br />
struttura <strong>di</strong><br />
popolazione<br />
Livello <strong>di</strong><br />
struttura <strong>di</strong><br />
popolazione<br />
Gobio gobio Livello <strong>di</strong><br />
struttura <strong>di</strong><br />
popolazione<br />
Distribuzione degli<br />
in<strong>di</strong>vidui all’interno<br />
delle classi <strong>di</strong> età<br />
Livello 1: Pop.<br />
strutturata<br />
Livello 2: Pop. non<br />
strutturata –<br />
assenza <strong>di</strong> adulti<br />
Livello 3: Pop. non<br />
strutturata –<br />
assenza <strong>di</strong> giovani<br />
Distribuzione degli<br />
in<strong>di</strong>vidui all’interno<br />
delle classi <strong>di</strong> età<br />
Livello 1: Pop.<br />
strutturata<br />
Livello 2: Pop. non<br />
strutturata –<br />
assenza <strong>di</strong> adulti<br />
Livello 3: Pop. non<br />
strutturata –<br />
assenza <strong>di</strong> giovani<br />
Distribuzione degli<br />
in<strong>di</strong>vidui all’interno<br />
delle classi <strong>di</strong> età<br />
Livello 1: Pop.<br />
strutturata<br />
Livello 2: Pop. non<br />
strutturata –<br />
assenza <strong>di</strong> adulti<br />
Livello 3: Pop. non<br />
strutturata –<br />
assenza <strong>di</strong> giovani<br />
Distribuzione degli<br />
in<strong>di</strong>vidui all’interno<br />
delle classi <strong>di</strong> età<br />
Livello 1: Pop.<br />
strutturata<br />
Livello 2: Pop. non<br />
strutturata –<br />
assenza <strong>di</strong> adulti<br />
Livello 3: Pop. non<br />
strutturata –<br />
assenza <strong>di</strong> giovani<br />
Distribuzione degli<br />
in<strong>di</strong>vidui all’interno<br />
delle classi <strong>di</strong> età<br />
Livello 1: Pop.<br />
strutturata<br />
Livello 2: Pop. non<br />
Monitoraggi<br />
a cadenza<br />
triennale<br />
Monitoraggi<br />
a cadenza<br />
triennale<br />
Monitoraggi<br />
a cadenza<br />
triennale<br />
Monitoraggi<br />
a cadenza<br />
triennale<br />
Monitoraggi<br />
a cadenza<br />
triennale<br />
Livello <strong>di</strong><br />
struttura 2<br />
e 3<br />
Livello <strong>di</strong><br />
struttura 2<br />
e 3<br />
Livello <strong>di</strong><br />
struttura 2<br />
e 3<br />
Livello <strong>di</strong><br />
struttura 2<br />
e 3<br />
Livello <strong>di</strong><br />
struttura 2<br />
e 3<br />
Turin et al., 1999<br />
Turin et al., 1999<br />
Turin et al., 1999<br />
Turin et al., 1999<br />
Turin et al., 1999<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 103<br />
In<strong>di</strong>ce <strong>di</strong><br />
struttura <strong>di</strong><br />
popolazione<br />
Padogobius<br />
martensii<br />
2.5.4.3 Erpetofauna<br />
Livello <strong>di</strong><br />
struttura <strong>di</strong><br />
popolazione<br />
strutturata –<br />
assenza <strong>di</strong> adulti<br />
Livello 3: Pop. non<br />
strutturata –<br />
assenza <strong>di</strong> giovani<br />
Distribuzione degli<br />
in<strong>di</strong>vidui all’interno<br />
delle classi <strong>di</strong> età<br />
Livello 1: Pop.<br />
strutturata<br />
Livello 2: Pop. non<br />
strutturata –<br />
assenza <strong>di</strong> adulti<br />
Livello 3: Pop. non<br />
strutturata –<br />
assenza <strong>di</strong> giovani<br />
Monitoraggi<br />
a cadenza<br />
triennale<br />
Livello <strong>di</strong><br />
struttura 2<br />
e 3<br />
Turin et al., 1999<br />
NOME TARGET UNITA’ DI DEFINIZIONE FONTE SOGLIA CRITICA BIBLIOGRAFIA<br />
MISURA<br />
E NOTE<br />
Status <strong>di</strong> Salamandrin Consistenza Numero <strong>di</strong> Monitoraggi Qualsiasi flessione in • Lanza B. et<br />
Salamandrina<br />
a della in<strong>di</strong>vidui in o biennale negativo della<br />
al. 2007<br />
perspicillata perspicillata popolazione riproduzione<br />
Occorre valutare<br />
anche lo status<br />
dei biotopi<br />
occupati<br />
consistenza delle<br />
popolazioni, qualsiasi<br />
contrazione della<br />
<strong>di</strong>stribuzione o<br />
peggioramento/riduzione<br />
dei biotopi occupati<br />
devono essere<br />
considerati come in<strong>di</strong>ci<br />
<strong>di</strong> rischio <strong>di</strong> estinzione<br />
locale delle specie.<br />
• Sindaco R. et<br />
al. 2006<br />
• Mazzotti S. et<br />
al. 1999<br />
• Database<br />
Regionale<br />
• CKMAP<br />
• Dall’Alpi A. e<br />
Sazzini M.<br />
2006<br />
Status <strong>di</strong> Triturus Triturus Distribuzione Presenza/assenza Monitoraggi Qualsiasi flessione in • Lanza B. et<br />
carnifex carnifex nel Sito <strong>di</strong> in<strong>di</strong>vidui e o triennale negativo della<br />
al. 2007<br />
(indagine<br />
qualitativa) e<br />
consistenza<br />
della<br />
popolazione<br />
in aree<br />
campione<br />
(indagine<br />
numero <strong>di</strong><br />
in<strong>di</strong>vidui in aree<br />
campione.<br />
Occorre valutare<br />
anche lo status<br />
dei biotopi<br />
occupati<br />
consistenza delle<br />
popolazioni nei siti<br />
campione, qualsiasi<br />
contrazione della<br />
<strong>di</strong>stribuzione o<br />
peggioramento/riduzione<br />
dei biotopi occupati<br />
devono essere<br />
• Sindaco R. et<br />
al. 2006<br />
• Mazzotti S. et<br />
al. 1999<br />
• Database<br />
Regionale<br />
• CKMAP<br />
quantitativa)<br />
considerati come<br />
in<strong>di</strong>catori <strong>di</strong> stress a<br />
carico delle popolazioni<br />
che possono portare a<br />
estinzioni locali o forte<br />
rarefazione<br />
Status degli Anfibi Anfibi Distribuzione Presenza/assenza Monitoraggi Qualsiasi flessione in • Lanza B. et<br />
<strong>di</strong> interesse non inclusi in nel Sito e <strong>di</strong> in<strong>di</strong>vidui o triennale negativo della ricchezza al. 2007<br />
conservazionistic<br />
o<br />
allegato II<br />
della Direttiva<br />
92/43/CE<br />
ricchezza<br />
specifica<br />
della<br />
comunità<br />
Occorre valutare<br />
anche lo status<br />
dei biotopi<br />
occupati in aree<br />
campione<br />
specifica delle comunità<br />
analizzate, contrazione<br />
della <strong>di</strong>stribuzione o<br />
peggioramento/riduzione<br />
dei biotopi occupati<br />
devono essere<br />
considerati come<br />
in<strong>di</strong>catori <strong>di</strong> stress a<br />
carico delle popolazioni<br />
• Sindaco R. et<br />
al. 2006<br />
• Mazzotti S. et<br />
al. 1999<br />
• Database<br />
Regionale<br />
• CKMap<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 104<br />
NOME TARGET UNITA’ DI<br />
MISURA<br />
Status dei Rettili<br />
<strong>di</strong> interesse<br />
conservazionistic<br />
o<br />
Status <strong>di</strong> Emys<br />
orbicularis<br />
Presenza <strong>di</strong><br />
Emy<strong>di</strong>dae<br />
alloctoni<br />
Collisione<br />
stradale<br />
Rettili<br />
non inclusi in<br />
allegato II<br />
della Direttiva<br />
92/43/CE<br />
Emys<br />
orbicularis<br />
Emy<strong>di</strong>dae<br />
alloctoni<br />
Distribuzione<br />
nel Sito<br />
e ricchezza<br />
specifica<br />
della<br />
comunità<br />
Distribuzione<br />
nel Sito<br />
(indagine<br />
qualitativa) e<br />
consistenza<br />
della<br />
popolazione<br />
nell’Oasi <strong>di</strong><br />
<strong>San</strong><br />
Gherardo<br />
(indagine<br />
quantitativa)<br />
Numero <strong>di</strong><br />
aree<br />
occupate<br />
Anfibi e Rettili Numero <strong>di</strong><br />
in<strong>di</strong>vidui<br />
2.5.4.4 Avifauna<br />
DEFINIZIONE FONTE SOGLIA CRITICA BIBLIOGRAFIA<br />
E NOTE<br />
che possono portare a<br />
estinzioni locali o forte<br />
rarefazione.<br />
Presenza/assenza<br />
<strong>di</strong> in<strong>di</strong>vidui<br />
Numero <strong>di</strong><br />
in<strong>di</strong>vidui<br />
Presenza <strong>di</strong><br />
in<strong>di</strong>vidui<br />
Presenza <strong>di</strong><br />
in<strong>di</strong>vidui<br />
schiacciati dai<br />
veicoli<br />
Monitoraggi<br />
o triennale<br />
Monitoraggi<br />
o triennale<br />
Monitoraggi<br />
o triennale<br />
Monitoraggi<br />
o triennale<br />
Qualsiasi flessione in<br />
negativo della ricchezza<br />
specifica delle comunità<br />
analizzate o contrazione<br />
della <strong>di</strong>stribuzione<br />
devono essere<br />
considerati come<br />
in<strong>di</strong>catori <strong>di</strong> stress a<br />
carico delle popolazioni<br />
che possono portare a<br />
estinzioni locali o forte<br />
rarefazione.<br />
TABELLA 5 – SOGLIE CRITICHE PER GLI INDICATORI DELL’ERPETOFAUNA.<br />
Qualsiasi flessione in<br />
negativo del numero <strong>di</strong><br />
in<strong>di</strong>vidui <strong>di</strong>stribuzione<br />
deve essere considerato<br />
come in<strong>di</strong>catore <strong>di</strong><br />
stress a carico della<br />
popolazione che<br />
possono portare a<br />
estinzione locale o forte<br />
rarefazione.<br />
• Corti C. et al.<br />
2011<br />
• Sindaco R. et<br />
al. 2006<br />
• Mazzotti S. et<br />
al. 1999<br />
• Database<br />
Regionale<br />
• CKMap<br />
• Database<br />
Regionale<br />
Comparsa <strong>di</strong> in<strong>di</strong>vidui • Corti C. et al.<br />
2011<br />
• Sindaco R. et<br />
al. 2006<br />
• Mazzotti S. et<br />
al. 1999<br />
• Database<br />
Regionale<br />
Collisioni concentrate<br />
(spazialmente e/o<br />
temporalmente)<br />
• CKMap<br />
NOME TARGET UNITA’ DI DEFINIZIONE FONTE SOGLIA CRITICA BIBLIOGRAFIA<br />
MISURA<br />
E NOTE<br />
Ornitofauna<br />
Complessità,<br />
Stazioni <strong>di</strong> Rilevamento <strong>di</strong> Blondel et al.<br />
forestale e <strong>di</strong><br />
equiripartizione e<br />
ascolto <strong>di</strong>minuzione dei 1970<br />
ambienti aperti<br />
<strong>di</strong>versità delle<br />
parametri descrittori<br />
comunità<br />
della comunità (H’,J’);<br />
Rilevamento <strong>di</strong> un<br />
drastico<br />
depauperamento<br />
delle popolazioni<br />
riproduttive all’interno<br />
<strong>di</strong> un periodo <strong>di</strong><br />
monitoraggio<br />
protratto su più anni<br />
(minimo tre)<br />
Presenza <strong>di</strong> Lullula Densità/numerosità La specie è Rilievo in Rilevamento <strong>di</strong> un Razzetti e<br />
Tottavilla arborea<br />
ritenuta una campagna drastico<br />
Rubolini, 2005<br />
buona specie<br />
depauperamento<br />
ombrello nei<br />
delle popolazioni<br />
contesti a<br />
riproduttive all’interno<br />
ecomosaico<br />
<strong>di</strong> un periodo <strong>di</strong><br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 105<br />
NOME TARGET UNITA’ DI<br />
MISURA<br />
Presenza <strong>di</strong><br />
Averla piccola<br />
Presenza <strong>di</strong><br />
Martin<br />
Pescatore<br />
Presenza <strong>di</strong><br />
Falco<br />
pellegrino<br />
Presenza <strong>di</strong><br />
Pecchiaiolo<br />
Lanius<br />
collurio<br />
Alcedo<br />
atthis<br />
Falco<br />
peregrinu<br />
s<br />
Pernis<br />
apivorus<br />
2.5.4.5 Teriofauna<br />
DEFINIZIONE FONTE SOGLIA CRITICA BIBLIOGRAFIA<br />
E NOTE<br />
presenti nel<br />
monitoraggio<br />
sito.<br />
protratto su più anni<br />
(minimo tre)<br />
Densità/numerosità La specie è Rilievo in Rilevamento <strong>di</strong> un<br />
ritenuta una campagna drastico<br />
buona specie<br />
depauperamento<br />
ombrello nei<br />
delle popolazioni<br />
contesti a<br />
riproduttive all’interno<br />
ecomosaico<br />
<strong>di</strong> un periodo <strong>di</strong><br />
presenti nel<br />
monitoraggio<br />
sito.<br />
protratto su più anni<br />
(minimo tre)<br />
Densità/numerosità Ittiofago, in<br />
Rilevamento <strong>di</strong> un<br />
popolazioni campagna drastico<br />
stabili in<strong>di</strong>cano<br />
depauperamento<br />
un buon livello<br />
delle popolazioni<br />
<strong>di</strong> qualità <strong>di</strong><br />
riproduttive all’interno<br />
acque e fauna<br />
<strong>di</strong> un periodo <strong>di</strong><br />
ittica<br />
monitoraggio<br />
Densità/numerosità Essendo ai in<br />
vertici della campagna<br />
piramide<br />
trofica la<br />
specie è<br />
Densità/numerosità<br />
ritenuto ottimo<br />
in<strong>di</strong>catore <strong>di</strong><br />
complessità<br />
ecologica<br />
Specie legate Rilievo in Rilevamento <strong>di</strong> un Brichetti P. &<br />
ai complessi campagna drastico<br />
Fracasso G.,<br />
forestali maturi<br />
depauperamento 2003<br />
o cedui<br />
delle popolazioni<br />
invecchiati.<br />
riproduttive all’interno<br />
<strong>di</strong> un periodo <strong>di</strong><br />
monitoraggiio<br />
protratto su più anni<br />
(minimo tre)<br />
NOME TARGET UNITA’ DI<br />
MISURA<br />
Presenza <strong>di</strong><br />
Moscar<strong>di</strong>no<br />
Muscar<strong>di</strong>nu<br />
s<br />
avellanarius<br />
TABELLA 6 – SOGLIE CRITICHE PER GLI INDICATORI DELL’AVIFAUNA.<br />
Densità/numerosità Definizione<br />
della<br />
<strong>di</strong>stribuzione<br />
nelle aree<br />
boscate ed<br />
arbustate del<br />
SIC<br />
considerando<br />
la specie una<br />
buona<br />
in<strong>di</strong>catrice<br />
della presenza<br />
<strong>di</strong> un buon<br />
strato<br />
arbustivo in<br />
generale e nei<br />
boschi in<br />
particolare.<br />
DEFINIZIONE FONTE SOGLIA<br />
CRITICA<br />
Rilievo in<br />
campagna<br />
Rilevamento <strong>di</strong><br />
un drastico<br />
depauperament<br />
o delle<br />
popolazioni<br />
riproduttive<br />
all’interno <strong>di</strong> un<br />
periodo <strong>di</strong><br />
monitoraggiio<br />
protratto su più<br />
anni (minimo tre)<br />
BIBLIOGRAFIA<br />
E NOTE<br />
Amori G.,<br />
Contoli L. &<br />
Nappi A., 2008<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 106<br />
NOME TARGET UNITA’ DI<br />
MISURA<br />
Presenza <strong>di</strong><br />
Istrice<br />
Presenza <strong>di</strong><br />
Chirotteri<br />
all’interno<br />
del SIC<br />
tramite<br />
indagine<br />
bioacustica<br />
Presenza <strong>di</strong><br />
Chirotteri<br />
all’interno<br />
del SIC<br />
tramite<br />
monitoraggi<br />
o dei rifugi<br />
Hystrix<br />
cristata<br />
Tutte le<br />
specie <strong>di</strong><br />
Chirotteri<br />
Tutte le<br />
specie <strong>di</strong><br />
Chirotteri<br />
2.5.5 Assetto idrobiologico<br />
DEFINIZIONE FONTE SOGLIA<br />
CRITICA<br />
Densità/numerosità Rilievo in<br />
campagna<br />
Numero <strong>di</strong> contatti Definizione<br />
delle specie<br />
presenti<br />
tramite<br />
indagine<br />
bioacustica;<br />
Numero Definizione<br />
della<br />
consistenza<br />
dei rifugi<br />
presenti e dei<br />
relativi trend <strong>di</strong><br />
utilizzo tramite<br />
rilievo <strong>di</strong>retto.<br />
Rilievo in<br />
campagna<br />
tramite<br />
batdetector<br />
Rilievo<br />
<strong>di</strong>retto ai<br />
rifugi<br />
TABELLA 7 – SOGLIE CRITICHE PER GLI INDICATORI DELLA TERIOFAUNA.<br />
Rilevamento <strong>di</strong><br />
un drastico<br />
depauperament<br />
o delle<br />
popolazioni<br />
riproduttive<br />
all’interno <strong>di</strong> un<br />
periodo <strong>di</strong><br />
monitoraggiio<br />
protratto su più<br />
anni (minimo tre)<br />
Rilevamento <strong>di</strong><br />
un drastico calo<br />
nel numero <strong>di</strong><br />
contatti e/o <strong>di</strong><br />
specie all’interno<br />
<strong>di</strong> un periodo <strong>di</strong><br />
monitoraggio<br />
protratto per più<br />
anni<br />
Rilevamento <strong>di</strong><br />
un drastico calo<br />
<strong>di</strong> esemplari nei<br />
rifugi all’interno<br />
<strong>di</strong> un periodo <strong>di</strong><br />
monitoraggiio<br />
protratto per più<br />
anni.<br />
BIBLIOGRAFIA<br />
E NOTE<br />
Agnelli P., A.<br />
Martinoli, E.<br />
Patriarca, D.<br />
Russo, D.<br />
Scaravelli and<br />
P. Genovesi<br />
(E<strong>di</strong>tors), 2006.<br />
Agnelli P., A.<br />
Martinoli, E.<br />
Patriarca, D.<br />
Russo, D.<br />
Scaravelli and<br />
P. Genovesi<br />
(E<strong>di</strong>tors), 2006.<br />
Gli aspetti relativi all’assetto idrobiologico trovano adeguata collocazione normativa nel<br />
D.Lgs. 152/06 e s.m., nonché nella Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del<br />
Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia <strong>di</strong><br />
acque.<br />
A titolo <strong>di</strong> riferimento si riporta parte dell’allegato 5 alla Direttiva 2000/60/CE, relativo agli<br />
elementi valutativi per la classificazione dello stato ecologico delle acque, nelle <strong>di</strong>verse<br />
tipologie <strong>di</strong> ambienti acquatici.<br />
Fiumi<br />
Elementi biologici<br />
• Composizione e abbondanza della flora acquatica<br />
• Composizione e abbondanza dei macroinvertebrati bentonici<br />
• Composizione, abbondanza e struttura <strong>di</strong> età della fauna ittica<br />
Elementi idromorfologici a sostegno degli elementi biologici<br />
• Regime idrologico<br />
• massa e <strong>di</strong>namica del flusso idrico<br />
• connessione con il corpo idrico sotterraneo<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 107<br />
• Continuità fluviale<br />
Con<strong>di</strong>zioni morfologiche<br />
• variazione della profon<strong>di</strong>tà e della larghezza del fiume<br />
• struttura e substrato dell'alveo<br />
• struttura della zona ripariale<br />
Elementi chimici e fisico-chimici a sostegno degli elementi biologici<br />
• Con<strong>di</strong>zioni termiche<br />
• Con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> ossigenazione<br />
• Salinità<br />
• Stato <strong>di</strong> aci<strong>di</strong>ficazione<br />
• Con<strong>di</strong>zioni dei nutrienti<br />
• Inquinanti specifici<br />
L’ambiente acquatico, l’alveo, le rive dei corpi idrici e il territorio circostante possono essere<br />
valutati me<strong>di</strong>ante l’impiego <strong>di</strong> In<strong>di</strong>ci Biotici e <strong>di</strong> Funzionalità, applicando in parte o tutti i<br />
seguenti meto<strong>di</strong>:<br />
- I.B.E. (In<strong>di</strong>ce Biotico Esteso) tramite il quale si identifica la classe <strong>di</strong> qualità biologica dei<br />
corsi d’acqua utilizzando le comunità dei macroinvertebrati bentonici (Ghetti, 1997,<br />
APAT, 2003: met. 9010);<br />
- In<strong>di</strong>ci Trofico-Funzionali relativi al ruolo trofico degli invertebrati bentonici che sono<br />
con<strong>di</strong>zionati dalla <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> cibo e, quin<strong>di</strong>, dalla tipologia dell’habitat acquatico<br />
(ÖNORM M., 1995)<br />
- I.F.F. (In<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> Funzionalità Fluviale) per l’identificazione ponderata dello stato<br />
complessivo dell’ambiente fluviale e della sua funzionalità, intesa come una sinergia <strong>di</strong><br />
fattori sia biotici sia abiotici presenti nell’ecosistema fluviale (APAT, 2007);<br />
- LIM (Livello <strong>di</strong> Inquinamento dei Macrodescrittori): è calcolato me<strong>di</strong>ante la procedura<br />
in<strong>di</strong>cata nel D. Lgs. 152/99 e s.m. per elaborare le concentrazioni <strong>di</strong> sei macrodescrittori<br />
chimici e <strong>di</strong> uno microbiologico ed è in<strong>di</strong>spensabile per la determinazione dello stato<br />
ecologico delle acque;<br />
- S.E.C.A. (Stato Ecologico dei Corsi d’Acqua): si ottiene incrociando il dato risultante<br />
dalle indagini sui macrodescrittori LIM con quello dell’IBE.<br />
- ISECI (In<strong>di</strong>ce dello Stato Ecologico delle Comunità Ittiche).<br />
La valutazione della qualità dei corpi idrici lacustri e della funzionalità perilacuale si può<br />
condurre attraverso l’applicazione dei seguenti In<strong>di</strong>ci:<br />
- I.F.P. (In<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> Funzionalità Perilaciuale) per l’identificazione ponderata dello stato<br />
complessivo dell’ambiente lacustre e della sua funzionalità, intesa come una sinergia <strong>di</strong><br />
fattori sia biotici sia abiotici presenti nell’ecosistema fluviale (ISPRA APPA, 2009);<br />
- LTLeco (livello trofico laghi per lo stato ecologico) che integra il fosforo totale, la<br />
trasparenza e l’ossigeno <strong>di</strong>sciolto. La somma dei punteggi ottenuti per i singoli parametri<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 108<br />
costituisce il punteggio da attribuire all’LTLeco , utile per l’assegnazione della classe <strong>di</strong><br />
qualità.<br />
2.6 Programmi <strong>di</strong> monitoraggio<br />
2.6.1 Generalità<br />
La valutazione dello stato <strong>di</strong> conservazione e il monitoraggio nel corso del tempo<br />
dell’evoluzione del medesimo giocano un ruolo chiave nel determinate la funzionalità del sito<br />
in relazione ai propri obiettivi <strong>di</strong> conservazione e al sistema della rete Natura 2000. Le azioni<br />
<strong>di</strong> monitoraggio e ricerca assumono quin<strong>di</strong> particolare rilevanza.<br />
Il piano <strong>di</strong> monitoraggio si prefigge una molteplicità <strong>di</strong> funzioni e scopi.<br />
- <strong>di</strong> aggiornare e completare il quadro conoscitivo con rilievo <strong>di</strong> dati perio<strong>di</strong>ci sulla<br />
<strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> habitat e specie, su ecologia e popolazioni, per le valutazioni dello stato<br />
<strong>di</strong> conservazione;<br />
- osservare e rilevare le <strong>di</strong>namiche relazionali tra gli habitat vegetazionali nonché le<br />
<strong>di</strong>namiche spaziali e temporali delle popolazioni;<br />
- controllare e verificare quanto rilevato ed interpretato alla redazione del presente Piano<br />
in merito ai fattori <strong>di</strong> pressione e alle minacce e all’intensità delle loro influenze su habitat<br />
e specie;<br />
- verificare l’efficacia delle misure previste.<br />
Il piano <strong>di</strong> monitoraggio in<strong>di</strong>vidua quin<strong>di</strong> un sistema <strong>di</strong> azioni che devono consentire una<br />
verifica della qualità delle misure <strong>di</strong> conservazione, la loro efficienza e la loro efficacia.<br />
In sintesi il monitoraggio ha un duplice compito:<br />
- fornire le informazioni necessarie per valutare gli effetti ambientali delle misure messe in<br />
campo, consentendo <strong>di</strong> verificare se esse sono effettivamente in grado <strong>di</strong> conseguire i<br />
traguar<strong>di</strong> prefissati;<br />
- permettere <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare tempestivamente le misure correttive che eventualmente<br />
dovessero rendersi necessarie.<br />
Il sistema <strong>di</strong> monitoraggio, inoltre, deve garantire attraverso l’in<strong>di</strong>viduazione degli in<strong>di</strong>catori la<br />
verifica degli effetti ambientali in relazione agli obiettivi prefissati delle <strong>di</strong>verse fasi <strong>di</strong><br />
attuazione al fine <strong>di</strong> consentire tempestivi adeguamenti delle misure stesse.<br />
Il sistema <strong>di</strong> monitoraggio che viene proposto ricalca modelli utilizzati in altri strumenti <strong>di</strong><br />
pianificazione e presenta una struttura articolata nello schema seguente:<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 109<br />
ANALISI:<br />
• Acquisizione dei dati<br />
• Elaborazione in<strong>di</strong>catori<br />
• Verifica del raggiungimento degli<br />
Obiettivi<br />
• In<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong> effetti indesiderati o <strong>di</strong><br />
eventuali cause <strong>di</strong> scostamento dalle<br />
previsioni<br />
• Misure correttive<br />
RELAZIONE DI<br />
MONITORAGGIO<br />
Eventuali consultazioni dei<br />
portatori <strong>di</strong> interesse<br />
NO<br />
Nuovo<br />
orientamento<br />
delle misure <strong>di</strong><br />
conservazione<br />
e/o delle azioni <strong>di</strong><br />
Piano?<br />
SI<br />
FIGURA 1 – SCHEMA DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO.<br />
Aggiornamento<br />
del Piano<br />
Nella fase <strong>di</strong> analisi verranno acquisiti i dati e le informazioni relative al contesto ambientale,<br />
verranno elaborati gli in<strong>di</strong>catori e verrà verificato il loro andamento in riferimento alla<br />
situazione iniziale descritta nella fase <strong>di</strong> analisi del contesto ambientale. Ogni Report alla<br />
sua prima e<strong>di</strong>zione potrebbe essere considerato come sperimentale da migliorare ed<br />
affinare nelle successive e<strong>di</strong>zioni.<br />
Sulla base <strong>di</strong> questa prima verifica, verrà analizzato il raggiungimento degli Obiettivi delle<br />
Misure <strong>di</strong> Conservazione, l’efficacia delle stesse e soprattutto saranno in<strong>di</strong>viduati gli<br />
eventuali scostamenti dalle previsioni o gli effetti indesiderati e non previsti. Verranno, infine,<br />
eventualmente approntate e proposte delle misure correttive.<br />
La relazione <strong>di</strong> monitoraggio riporterà quanto riscontrato nella fase <strong>di</strong> analisi. Le<br />
consultazioni potranno riguardare la <strong>di</strong>scussione <strong>di</strong> quanto riportato nella relazione <strong>di</strong><br />
monitoraggio con le autorità con competenze ambientali e/o portatori <strong>di</strong> interesse; durante<br />
tale <strong>di</strong>scussione verranno richiesti pa<strong>rer</strong>i ed integrazioni in merito alla situazione ed alle<br />
criticità evidenziate nella fase <strong>di</strong> analisi ed alle possibili misure <strong>di</strong> aggiustamento, fino ad un<br />
rior<strong>di</strong>no complessivo del Piano con conseguente aggiornamento.<br />
Il piano <strong>di</strong> monitoraggio proposto cerca <strong>di</strong> perseguire le esigenze sopra descritte<br />
concentrandosi sui seguenti aspetti:<br />
- Stato <strong>di</strong> conservazione <strong>di</strong> habitat e specie e delle tendenze in atto;<br />
- Fenomeni e attività che influenzano lo stato <strong>di</strong> protezione del sito (fattori <strong>di</strong> pressione);<br />
- Azioni attivate (aspetti quantitativi, qualitativi ed efficacia).<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 110<br />
2.6.2 Habitat<br />
2.6.2.1 Protocolli standar<strong>di</strong>zzati a livello locale, nazionale o internazionale <strong>di</strong><br />
riferimento<br />
- Acquisizione <strong>di</strong> informazioni territoriali me<strong>di</strong>ante interpretazione <strong>di</strong> immagini telerilevate o<br />
<strong>di</strong> fotografie aeree<br />
- Meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> raccolta dati in campo per l’elaborazione <strong>di</strong> in<strong>di</strong>catori <strong>di</strong> bio<strong>di</strong>versità. Metodo<br />
fitosociologico <strong>di</strong> Braun-Blanquet.<br />
- Meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> raccolta dati in campo per l’elaborazione <strong>di</strong> in<strong>di</strong>catori <strong>di</strong> bio<strong>di</strong>versità. Metodo<br />
del profilo <strong>di</strong> struttura.<br />
2.6.2.2 Frequenza e stagionalità<br />
Per quanto riguarda l’interpretazione delle immagini essa può essere condotta anche su dati<br />
d’archivio che sono limitati, nella loro <strong>di</strong>sponibilità, dalla risoluzione temporale.<br />
Nel caso del Metodo fitosociologico <strong>di</strong> Braun-Blanquet la raccolta dati non viene effettuata<br />
con una regolare frequenza temporale.<br />
Nel caso del Metodo del profilo <strong>di</strong> struttura il rilievo deve essere effettuato durante la<br />
stagione vegetativa.<br />
In ogni caso le indagini devono essere svolte ad intervalli <strong>di</strong> 3/5 anni.<br />
2.6.2.3 Criteri <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduazione e posizionamento delle stazioni <strong>di</strong> campionamento<br />
Nel caso del Metodo fitosociologico <strong>di</strong> Braun-Blanquet il rilievo deve interessare un’area che<br />
sia rappresentativa della composizione specifica me<strong>di</strong>a del popolamento campionato<br />
(popolamento elementare). L’area unitaria deve quin<strong>di</strong> contenere tutti gli elementi della flora.<br />
Ciascun rilievo deve essere georeferenziato tramite l’utilizzo <strong>di</strong> GPS. Le <strong>di</strong>mensioni possono<br />
variare da pochi metri quadrati a oltre 100.<br />
Nel caso del Metodo del profilo <strong>di</strong> struttura il rilievo deve interessare un’area che sia<br />
rappresentativa del popolamento da campionare. La superficie quin<strong>di</strong> varia da caso a caso,<br />
comunemente è caratterizzata da una forma rettangolare con <strong>di</strong>mensione <strong>di</strong> 10 x 100 metri.<br />
La localizzazione sul terreno sarà effettuata me<strong>di</strong>ante l’infissione <strong>di</strong> picchetti <strong>di</strong> legno,<br />
verniciati con minio, <strong>di</strong>sposti ai 4 vertici dell’area e ai due vertici dell’asse centrale<br />
longitu<strong>di</strong>nale (asse delle ascisse), in<strong>di</strong>viduato concretamente da una cordella metrica stesa<br />
sul terreno in <strong>di</strong>rezione sud-nord.<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 111<br />
2.6.2.4 Strumentazione per il campionamento<br />
Nel caso del Metodo fitosociologico <strong>di</strong> Braun-Blanquet non sono previste strumentazioni<br />
particolari, a parte il GPS.<br />
Il metodo del profilo <strong>di</strong> struttura, da utilizzare esclusivamente per gli habitat forestali, richiede<br />
l’utilizzo del GPS e dello squadro agrimensorio (con paline) per il posizionamento del rilievo,<br />
dell’ipsometro o del relascopio per la determinazione dell’altezze, del cavalletto<br />
dendrometrico per i <strong>di</strong>ametri e del nastro metrico per le coor<strong>di</strong>nate e per i raggi della chioma.<br />
2.6.2.5 Procedura <strong>di</strong> campionamento<br />
La metodologia <strong>di</strong> “acquisizione <strong>di</strong> informazioni territoriali me<strong>di</strong>ante interpretazione <strong>di</strong><br />
immagini telerilevate o <strong>di</strong> fotografie aeree” prevede <strong>di</strong> derivare informazioni sulla copertura<br />
della superficie terrestre, legata alle caratteristiche fisiche della stessa che ne influenzano il<br />
potere riflettente, attraverso l’analisi <strong>di</strong> immagini satellitari. Tale approccio impone la<br />
realizzazione <strong>di</strong> fasi successive e la necessità <strong>di</strong> integrare i dati satellitari con insostituibili<br />
controlli <strong>di</strong> verità a terra allo scopo <strong>di</strong> elaborare Cartografia relativa alla <strong>di</strong>stribuzione degli<br />
habitat naturali <strong>di</strong> un determinato territorio.<br />
2.6.2.5.1 Metodo fitosociologico <strong>di</strong> Braun-Blanquet<br />
Piano <strong>di</strong> rilevamento. Consiste nel pre<strong>di</strong>sporre sulla carta la collocazione approssimativa dei<br />
rilievi fitosociologici che dovranno essere eseguiti in campo. Il piano dovrà essere fatto in<br />
modo che tutti i <strong>di</strong>versi fototipi ricevano dei rilievi, in particolare infittendo la maglia <strong>di</strong><br />
campionamento nelle aree interessate da interventi <strong>di</strong> progetto.<br />
Rilievo della vegetazione. Consiste nell’esecuzione dei rilievi fitosociologici (secondo il<br />
metodo <strong>di</strong> Braun-Blanquet, 1964) che permetteranno il passaggio dall’interpretazione<br />
fisionomica a quella fitosociologica. Ciascun rilievo sarà georeferenziato tramite l’utilizzo <strong>di</strong><br />
GPS. Il rilievo si può sud<strong>di</strong>videre nelle seguenti fasi:<br />
1. delimitazione <strong>di</strong> un’area unitaria sufficiente a contenere tutti gli elementi della vegetazione<br />
stu<strong>di</strong>ata (popolamento elementare);<br />
2. inventario completo <strong>di</strong> tutte le specie presenti;<br />
3. stima a occhio della copertura <strong>di</strong> ciascuna specie rilevata.<br />
La stima della copertura si effettua basandosi su un scala convenzionale (Braun-Blanquet,<br />
mo<strong>di</strong>ficata da Pignatti in Cappelletti C. Trattato <strong>di</strong> Botanica, 1959):<br />
r - copertura trascurabile<br />
+ - copertura debole, sino all’1 %<br />
1 - copertura tra 1 e 20 %<br />
2 - copertura tra 21 e 40 %<br />
3 - copertura tra 41 e 60 %<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 112<br />
4 - copertura tra 61 e 80 %<br />
5 - copertura tra 81 e 100 %<br />
2.6.2.5.2 Metodo del profilo <strong>di</strong> struttura<br />
I caratteri censiti, tramite apposite schede <strong>di</strong> rilevamento, per ogni singolo in<strong>di</strong>viduo vivente<br />
presente all’interno del transect, <strong>di</strong> altezza superiore a 1,30 m e <strong>di</strong>ametro a 1,30 m da terra<br />
superiore a 2,5 cm, saranno i seguenti:<br />
- specie botanica;<br />
- coor<strong>di</strong>nate cartesiane <strong>di</strong> riferimento;<br />
- <strong>di</strong>ametro a 1,30 m da terra;<br />
- altezza totale;<br />
- altezza <strong>di</strong> inserzione della chioma verde;<br />
- altezza <strong>di</strong> inserzione della chioma morta;<br />
- altezza <strong>di</strong> massima larghezza della chioma<br />
- area <strong>di</strong> insidenza della chioma (4 raggi);<br />
- inclinazione dell’in<strong>di</strong>viduo (gra<strong>di</strong> e <strong>di</strong>rezione)<br />
- eventuali note sul portamento (fusto inclinato, ricurvo, biforcato ecc.) e sullo stato<br />
fitosanitario.<br />
Per altezza totale si intende la <strong>di</strong>stanza tra la base del fusto della pianta considerata e la<br />
cima viva più alta; l'altezza <strong>di</strong> inserzione della chioma verde si valuta prendendo in<br />
considerazione il ramo vivo più basso. L'area <strong>di</strong> insidenza della chioma corrisponde alla<br />
superficie occupata sul terreno dalla proiezione della chioma stessa e si valuta misurando 4<br />
raggi perpen<strong>di</strong>colari tra <strong>di</strong> loro, <strong>di</strong> cui due paralleli alla <strong>di</strong>rezione dell'asse centrale del<br />
transect e gli altri due ortogonali ad essa.<br />
Nel caso <strong>di</strong> ceppaie <strong>di</strong> origine agamica ogni singolo pollone sarà considerato come un<br />
in<strong>di</strong>viduo e sarà sottoposto a tutte le misurazioni; analogamente si procederà nel caso <strong>di</strong><br />
fusti biforcati sotto 1,30 m <strong>di</strong> altezza da terra.<br />
Gli esemplari arbustivi saranno considerati come macchie omogenee <strong>di</strong> cui si rileveranno<br />
altezza ed estensione.<br />
In riferimento all’importanza ecologica della necromassa, per ciascun esemplare arboreo<br />
morto in pie<strong>di</strong> e/o a terra si raccoglieranno i seguenti dati:<br />
- specie botanica (ove possibile);<br />
- coor<strong>di</strong>nate cartesiane <strong>di</strong> riferimento;<br />
- <strong>di</strong>ametro a 1,30 m da terra (ove possibile);<br />
- lunghezza (nel caso <strong>di</strong> legno morto a terra) o altezza totale;<br />
- <strong>di</strong>rezione <strong>di</strong> caduta rispetto al nord per gli esemplari con <strong>di</strong>ametro a 1,30 m superiore a 10<br />
cm.<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 113<br />
All’interno <strong>di</strong> ciascun transetto si possono rilevare altre informazioni secondo le finalità dello<br />
stu<strong>di</strong>o (es. presenza <strong>di</strong> danni, legno <strong>di</strong> in<strong>di</strong>vidui morti a terra, cavità in in<strong>di</strong>vidui arborei,<br />
roccia affiorante, ecc.).<br />
Lungo l’asse centrale del transetto sarà ricavato un ulteriore transetto per lo stu<strong>di</strong>o della<br />
rinnovazione, con larghezza <strong>di</strong> 2 m. All’interno <strong>di</strong> tale superficie la valutazione della<br />
rinnovazione sarà effettuata considerando la presenza, la <strong>di</strong>stribuzione, la localizzazione in<br />
relazione alla copertura del soprassuolo e lo stato vegetativo delle piantine o dei giovani<br />
semenzali affermati (da 20-30 cm a 1,30 m <strong>di</strong> altezza), originati per <strong>di</strong>sseminazione naturale<br />
o provenienti da semina o impianto artificiale. L’altezza totale <strong>di</strong> ciascuna piantine sarà<br />
misurata tramite rotella metrica.<br />
2.6.2.6 Analisi ed elaborazione dei dati<br />
2.6.2.6.1 Metodo fitosociologico <strong>di</strong> Braun-Blanquet<br />
L’analisi della vegetazione effettuata con il metodo fitosociologico produce tabelle <strong>di</strong> dati che<br />
riuniscono i rilievi effettuati sul campo, in ambiti appositamente scelti aventi struttura e<br />
composizione floristica omogenee, denominati “popolamenti elementari”. L’elaborazione<br />
numerica dei dati <strong>di</strong> campagna, ormai abitualmente impiegata per meglio interpretare e<br />
rappresentare la <strong>di</strong>versità della copertura vegetale dell’area in esame, richiede la<br />
trasformazione dei simboli usati nei rilievi fitosociologici in modo da poter <strong>di</strong>sporre<br />
unicamente <strong>di</strong> dati numerici. I valori <strong>di</strong> copertura tra<strong>di</strong>zionalmente attribuiti alle specie<br />
vegetali nel corso dei rilievi saranno quin<strong>di</strong> trasformati come segue, secondo una scala<br />
proposta dal botanico olandese van der Maarel nel 1979: r = 1; + = 2; 1 = 3; 2 = 5; 3 = 7; 4 =<br />
8; 5 = 9. La tabella fitosociologica <strong>di</strong>viene a questo punto una matrice le cui colonne (rilievi)<br />
rappresentano degli oggetti che possono essere confrontati fra loro sulla base dei valori<br />
assunti dalle variabili che li definiscono (specie). Fra i meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> elaborazione più usati in<br />
campo vegetazionale vi sono quelli che producono classificazioni gerarchiche. Questi meto<strong>di</strong><br />
(cluster analysis) fanno raggruppamenti <strong>di</strong> rilievi sulla base delle affinità riscontrate,<br />
avvicinando dapprima i rilievi che presentano fra loro maggiori somiglianze, e poi riunendoli<br />
in gruppi via via più numerosi ma legati a un livello <strong>di</strong> somiglianza sempre meno elevato,<br />
così da fornire, alla fine, un’immagine sintetica delle relazioni che intercorrono fra le varie<br />
tipologie vegetazionali. I meto<strong>di</strong> per calcolare le affinità sono <strong>di</strong>versi, e fanno uso per lo più <strong>di</strong><br />
funzioni geometriche, insiemistiche e basate su in<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> similarità. In questo caso i rilievi<br />
saranno confrontati con una procedura basata sulla <strong>di</strong>stanza euclidea previa<br />
normalizzazione dei dati (<strong>di</strong>stanza della corda, Lagonegro M., Feoli E., 1985). La<br />
rappresentazione grafica dei rapporti <strong>di</strong> somiglianza fa uso <strong>di</strong> dendrogrammi, nei quali<br />
l’altezza del legame rappresenta il livello <strong>di</strong> <strong>di</strong>stanza tra le singole entità e/o gruppi <strong>di</strong> entità.<br />
Dall’applicazione <strong>di</strong> tale metodo risulta una classificazione <strong>di</strong> tipo «gerarchico», in quanto<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 114<br />
vengono raggruppate progressivamente le classi che si ottengono in classi via via più ampie.<br />
Ai fini della descrizione si potranno in<strong>di</strong>viduare gruppi che possano avere un significato<br />
vegetazionale ed ecologico, e sarà possibile ipotizzare una relazione spaziale (e anche<br />
temporale) fra tali gruppi, determinata verosimilmente da uno o più fattori ambientali. Prima<br />
<strong>di</strong> sottoporre la tabella dei rilievi alla cluster analysis saranno temporaneamente eliminate le<br />
specie presenti spora<strong>di</strong>camente (solo una volta, con trascurabili valori <strong>di</strong> copertura), quelle<br />
non ancora sicuramente determinate, ed infine quelle <strong>di</strong> origine artificiale, piantate dall’uomo<br />
e quin<strong>di</strong> con un valore “<strong>di</strong>agnostico” sull'ecologia dei luoghi pressoché nullo; queste specie,<br />
tuttavia, vengono reinserite, alla fine dell’elaborazione, nella tabella ristrutturata, secondo la<br />
nuova collocazione dei rilievi stabilita dal dendrogramma. Un metodo particolarmente<br />
efficace per interpretare le relazioni fra gruppi <strong>di</strong> rilievi, questa volta non gerarchico, è quello<br />
che produce un or<strong>di</strong>namento dei dati. Tra i meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> classificazione (cluster analysis) e quelli<br />
<strong>di</strong> or<strong>di</strong>namento esiste una <strong>di</strong>fferenza concettuale rilevante: mentre i primi tendono ad<br />
esaltare le <strong>di</strong>fferenze presenti tra i <strong>di</strong>versi gruppi <strong>di</strong> rilievi per permetterne la separazione in<br />
modo più o meno netto, l’or<strong>di</strong>namento tende ad evidenziare la continuità <strong>di</strong> trasformazione<br />
tra i <strong>di</strong>versi gruppi (Blasi e Mazzoleni, 1995). Le meto<strong>di</strong>che <strong>di</strong> or<strong>di</strong>namento consentono <strong>di</strong><br />
rappresentare i dati in una determinata serie o sequenza or<strong>di</strong>nandoli per mezzo <strong>di</strong> assi, che<br />
sono in realtà delle nuove variabili derivate da combinazioni delle variabili originarie che<br />
hanno il <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> essere troppe per essere usate come tali, e la particolarità <strong>di</strong> essere<br />
sempre legate tra loro da un certo grado <strong>di</strong> correlazione. La complementarietà dei meto<strong>di</strong> <strong>di</strong><br />
classificazione e <strong>di</strong> or<strong>di</strong>namento è stata più volte <strong>di</strong>mostrata ed il loro uso congiunto viene<br />
consigliato da numerosi autori (Feoli, 1983; Goodall, 1986), che sottolineano come<br />
l’or<strong>di</strong>namento possa servire, in aggiunta alla cluster analysis, ad identificare delle tendenze<br />
nella variazione della copertura vegetale, interpretabili in termini <strong>di</strong> gra<strong>di</strong>enti <strong>di</strong> fattori<br />
ambientali. Nel caso che esista una tendenza dominante, i punti che rappresentano i singoli<br />
rilievi si <strong>di</strong>spongono nel grafico attorno ad una linea che può assumere forme <strong>di</strong>verse; in<br />
caso contrario essi sono sparsi in una nube <strong>di</strong> punti più o meno iso<strong>di</strong>ametrica.<br />
2.6.2.6.2 Metodo del profilo <strong>di</strong> struttura<br />
L’esecuzione del transetto permetterà <strong>di</strong> esaminare l’organizzazione spaziale in una sezione<br />
orizzontale, potendo così conoscere la <strong>di</strong>spersione degli organismi, ed in una sezione<br />
verticale, evidenziando la <strong>di</strong>stribuzione delle chiome e i rapporti <strong>di</strong> concorrenza intra ed<br />
interspecifici. Tali caratteristiche saranno messe in evidenza me<strong>di</strong>ante l’applicazione <strong>di</strong> uno<br />
specifico software (SVS - Stand Visualization System, dell’USDA Forest Service, Pacific<br />
Northwest Research Station) che consente la visualizzazione bi<strong>di</strong>mensionale della struttura<br />
orizzontale e verticale del soprassuolo.<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 115<br />
FIGURA 2 - ESEMPIO DI TRANSECT STRUTTURALE, PLANIMETRIA.<br />
FIGURA 3 - ESEMPIO DI TRANSECT STRUTTURALE, PROSPETTO.<br />
L’elaborazione dei dati raccolti nel transetto per lo stu<strong>di</strong>o della rinnovazione naturale<br />
permetterà <strong>di</strong> calcolare i seguenti in<strong>di</strong>ci:<br />
- altezza massima (Hmax);<br />
- altezza me<strong>di</strong>a (Hm);<br />
- altezza minima (Hmin);<br />
- n° piantine affermate;<br />
- n° novellame/m 2 ;<br />
- in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> rinnovazione (IR = Hm x n° novellame/m 2 ).<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 116<br />
2.6.3 Specie vegetali<br />
2.6.3.1 Protocolli standar<strong>di</strong>zzati a livello locale, nazionale o internazionale <strong>di</strong><br />
riferimento<br />
Il testo <strong>di</strong> riferimento per il rilevamento dello stato <strong>di</strong> conservazione delle specie vegetali è :<br />
Elzinga C.L., Salzer D.W., Willoughby J.W., Gibbs J.P., 2001 - Monitoring Plant and Animal<br />
populations. Blackwell Science.<br />
2.6.3.2 Frequenza e stagionalità<br />
Il periodo <strong>di</strong> rilevamento deve concentrarsi nella stagione vegetativa, febbraio-settembre<br />
inclusi.<br />
Il numero <strong>di</strong> rilevamenti <strong>di</strong>penderà dalle specie presenti, nonché dall’estensione del sito<br />
stesso, prevedendo non meno <strong>di</strong> 2/3 uscite per sito, ripartite in base alla fenologia delle<br />
specie target.<br />
Le indagini devono essere svolte ad intervalli <strong>di</strong> 3/5 anni.<br />
2.6.3.3 Criteri <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduazione e posizionamento delle stazioni <strong>di</strong> campionamento<br />
Principalmente la fase <strong>di</strong> campo vedrà il rilevamento <strong>di</strong> informazioni nei siti <strong>di</strong> presenza già<br />
noti (sulla base dei database già esistenti, dalla letteratura e da segnalazioni ine<strong>di</strong>te), ma<br />
prevedrà anche una <strong>di</strong>samina accurata del territorio soprattutto nelle aree che verranno <strong>di</strong><br />
volta in volta identificate come idonee da un punto <strong>di</strong> vista ecologico alla loro presenza.<br />
2.6.3.4 Strumentazione per il campionamento<br />
La raccolta dati avverrà avvalendosi <strong>di</strong> apposita scheda <strong>di</strong> rilevamento delle informazioni<br />
riportate nei paragrafi precedenti, della cartografia degli habitat aggiornata, <strong>di</strong> strumento<br />
GPS eventualmente dotato anche <strong>di</strong> palmare per potersi orientare meglio in campo. In taluni<br />
casi in cui si ritenesse necessario, si potrà effettuare la raccolta <strong>di</strong> materiale d’erbario e/o <strong>di</strong><br />
materiale fotografico ritraente le specie target.<br />
2.6.3.5 Procedura <strong>di</strong> campionamento<br />
Il programma <strong>di</strong> rilevamento proposto prevede un duplice livello d’indagine, <strong>di</strong>fferenziato in<br />
base allo status delle specie vegetali, riconosciuto a livello <strong>di</strong> <strong>di</strong>rettiva habitat o regionale,<br />
come segue:<br />
1) Specie vegetali degli allegati II e IV della Direttiva habitat e specie delle categorie CR<br />
ed EN della lista rossa regionale;<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 117<br />
2) Specie vegetali dell’allegato V della Direttiva habitat, specie delle altre categorie della<br />
lista rossa regionale, altre specie floristiche <strong>di</strong> interesse regionale.<br />
Questa <strong>di</strong>fferenziazione deriva dal fatto che per le specie più frequenti (caso del punto 2)<br />
non è necessario <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> informazioni così <strong>di</strong> dettaglio, che sarebbero molto time-<br />
consuming, in quanto la stessa categoria cui sono inserite <strong>di</strong>mostra già la loro appartenenza<br />
ad uno stato <strong>di</strong> conservazione sod<strong>di</strong>sfacente. Tuttavia, non si esclude che, in casi particolari<br />
giustificabili, specie del punto 2) possano essere trattate con la stessa metodologia <strong>di</strong> cui al<br />
punto 1) e viceversa.<br />
Per le specie vegetali afferenti al punto 1) si prevedono le seguenti azioni:<br />
- georeferenziazione delle popolazioni nel sito (puntiforme o areale a seconda delle<br />
<strong>di</strong>mensioni della popolazione stessa); per popolazione si deve intendere un aggregato <strong>di</strong><br />
in<strong>di</strong>vidui <strong>di</strong>stanti almeno 100 m lineari da un altro aggregato <strong>di</strong> in<strong>di</strong>vidui;<br />
- per ciascuna popolazione, conteggio del numero <strong>di</strong> in<strong>di</strong>vidui adulti (in fiore o in frutto) in<br />
caso <strong>di</strong> popolazioni con meno <strong>di</strong> 50 in<strong>di</strong>vidui adulti, oppure stima del n. <strong>di</strong> in<strong>di</strong>vidui ed<br />
attribuzione alle seguenti categorie:<br />
50-100 in<strong>di</strong>vidui adulti<br />
100-200 in<strong>di</strong>vidui adulti<br />
200-500 in<strong>di</strong>vidui adulti<br />
500-1000 in<strong>di</strong>vidui adulti<br />
> 1000 in<strong>di</strong>vidui adulti<br />
Al <strong>di</strong> sopra dei 100 in<strong>di</strong>vidui adulti le popolazioni possono essere considerate stabili da<br />
un punto <strong>di</strong> vista genetico, quin<strong>di</strong> il loro stato <strong>di</strong> conservazione può considerarsi, eccetto<br />
sempre casi specifici, sod<strong>di</strong>sfacente.<br />
Per le specie del punto 2) si prevede la verifica della presenza assenza e un’in<strong>di</strong>cazione <strong>di</strong><br />
abbondanza all’interno <strong>di</strong> ciascun habitat del sito, secondo il protocollo <strong>di</strong> rilevamento del<br />
progetto GLORIA (Global Observation Research Initiative in Alpine Environments, V<br />
Progetto Quadro Europeo), adattato alla più ampia realtà del sito, e circostanziata in base<br />
all’estensione dell’habitat in cui la specie cresce:<br />
- assente: dalle indagini <strong>di</strong> campo la specie non viene più riscontrata;<br />
- probabile: nonostante la specie non sia stata riscontrata è presumibile che sia presente<br />
in qualche habitat del sito;<br />
- molto rara: si sono osservati pochi in<strong>di</strong>vidui, che potevano sfuggire ad una ricerca non<br />
approfon<strong>di</strong>ta;<br />
- rara: pochi in<strong>di</strong>vidui <strong>di</strong>fficilmente non osservabili anche con un grado <strong>di</strong> indagine non<br />
approfon<strong>di</strong>to;<br />
- spora<strong>di</strong>ca: gruppi <strong>di</strong> pochi in<strong>di</strong>vidui presenti in vari settori del sito;<br />
- frequente: gli in<strong>di</strong>vidui sono ben <strong>di</strong>stribuiti nel sito e si osservano frequentemente, ma<br />
ancora con delle lacune <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione;<br />
- comune: in<strong>di</strong>vidui comunemente <strong>di</strong>stribuiti nel sito.<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 118<br />
Verranno inoltre raccolte informazioni puntuali inerenti le minacce localmente presenti<br />
insistenti sulle singole popolazioni e/o sulle specie vegetali target.<br />
2.6.3.6 Analisi ed elaborazione dei dati<br />
Per le specie vegetali afferenti al punto 1) la definizione dell’areale <strong>di</strong>stributivo e<br />
l’identificazione dei popolamenti deve condurre alla redazione <strong>di</strong> un cartografia specie-<br />
specifica.<br />
Per le specie vegetali afferenti al punto 2), la valutazione delle categorie <strong>di</strong> frequenza sarà<br />
quin<strong>di</strong> attribuita habitat per habitat. L’habitat sarà co<strong>di</strong>ficato secondo le categorie Corine<br />
Land Cover (fino al V° livello) e solo in una secon da fase sarà convertito, ove possibile, agli<br />
habitat Natura 2000. Questo perché l’elenco degli habitat Natura 2000 non contempla tutte<br />
le tipologie presenti in Emilia-Romagna (es. boschi meso-termofili <strong>di</strong> querce che ospitano<br />
specie <strong>di</strong> rilevante interesse, quali alcune Orchidaceae).<br />
Tutti i dati raccolti devono essere archiviati nel geodatabase della Regione Emilia Romagna<br />
2.6.4 Fauna<br />
2.6.4.1 Insetti<br />
2.6.4.1.1 Coleotteri Carabi<strong>di</strong><br />
Comprende il monitoraggio delle seguenti specie: Nebria psammodes (P. Rossi, 1792) e<br />
Stomis bucciarelli Pesarini, 1979.<br />
Metodo <strong>di</strong> monitoraggio della comunità qualitativo a vista e quantitativo con trappole a<br />
caduta (pifall-traps)<br />
Frequenza e stagionalità<br />
- Il monitoraggio con trappole a caduta deve essere eseguito nell’arco <strong>di</strong> un anno<br />
continuativamente da aprile a ottobre, con rinnovi mensili e ripetuto all’incirca ogni 5 anni<br />
per determinare eventuali variazioni nel popolamento;<br />
- Il monitoraggio a vista deve essere eseguito una volta al mese da aprile ad ottobre<br />
nell’arco <strong>di</strong> un anno e ripetuto all’incirca ogni 5 anni.<br />
Criteri <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduazione e posizionamento delle stazioni <strong>di</strong> campionamento<br />
- Il campionamento dovrà essere effettuato scegliendo un’area omogenea per<br />
caratteristiche ambientali. È necessario evitare i microambienti in quanto il punto in cui<br />
viene effettuato il campione deve essere rappresentativo dell’area;<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 119<br />
- Cattura con trappole a caduta collocate a terra, ad una certa <strong>di</strong>stanza dall’acqua e al<br />
sicuro dalle piene improvvise dei corsi d’acqua, riparate con coperture dagli agenti<br />
atmosferici e dai detriti;<br />
- Collocazione <strong>di</strong> 5-6 trappole per stazione a <strong>di</strong>stanza reciproca <strong>di</strong> 6-10 m;<br />
- Raccolta manuale a vista in alternativa o ad integrazione del trappolaggio, anche nei<br />
punti in cui non possono essere collocate le trappole (ad esempio lungo le rive dei corsi<br />
d’acqua e delle zone umide, sotto massi e pietre infossate, tra le chiome degli alberi,<br />
ecc.).<br />
Strumentazione per il campionamento<br />
- Trappole a caduta composte da barattoli <strong>di</strong> plastica da 250 cc (ogni trappola è composta<br />
da una coppia <strong>di</strong> barattoli, uno contenuto nell’altro, con quello superiore da sfilare per il<br />
prelievo e il rinnovo);<br />
- Zappetta e perforatore per scavo;<br />
- Liquido per il rinnovo (soluzione <strong>di</strong> aceto <strong>di</strong> vino sovrasatura <strong>di</strong> cloruro <strong>di</strong> so<strong>di</strong>o o con<br />
acido ascorbico);<br />
- Contenitori in plastica da 500 cc per la raccolta dei campioni delle trappole;<br />
- Etichette adesive da attaccare sui contenitori;<br />
- Imbuto con imboccatura larga (2-3 cm <strong>di</strong> <strong>di</strong>ametro) e piccolo colino (maglie 0,75 mm);<br />
- Torcia elettrica;<br />
- Macchina fotografica <strong>di</strong>gitale;<br />
- Pinzette, barattolo con sughero ed etere acetico, aspiratore ed ombrello entomologico<br />
per la cattura a vista;<br />
- Schede cartacee pre<strong>di</strong>sposte per la raccolta dei dati in campo;<br />
- Rilevatore GPS e cartografia della zona;<br />
- Binoculare stereoscopico fino 40x (in laboratorio);<br />
- Alcool 70° per conservare il materiale raccolto (in laboratorio);<br />
- Provette <strong>di</strong> vetro <strong>di</strong> varie misure (in laboratorio);<br />
- Vaschette <strong>di</strong> plastica bianca per smistare i materiali (in laboratorio);<br />
- Spilli entomologici, misure da 2 a 4, cartellini entomologici bianchi <strong>di</strong> varie misure e colla<br />
entomologica (in laboratorio);<br />
- Tavolette su cui preparare gli esemplari (in laboratorio);<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 120<br />
- Scatole entomologiche standard con vetro superiore (misure 6x26x39 cm) (in<br />
laboratorio).<br />
Procedura <strong>di</strong> campionamento<br />
- Collocazione delle trappole con schemi prefissati a transetto lineare o a quinconce;<br />
- Raccolta campioni delle trappole e rinnovo liquido ogni 3 settimane o mensile ed<br />
etichettatura dei barattoli con i dati del rinnovo;<br />
- Raccolta a vista con frequenza mensile con l’ausilio <strong>di</strong> pinzette, aspiratore, torcia<br />
elettrica <strong>di</strong> notte ed etichettatura dei barattoli con i dati <strong>di</strong> raccolta. Per tutte le specie si<br />
raccomanda <strong>di</strong> trattenere solo nei casi dubbi, previa autorizzazione e comunque meno<br />
esemplari possibili, non più <strong>di</strong> 1-2 per stazione. Per le specie <strong>di</strong> facile identificazione si<br />
raccomanda <strong>di</strong> non trattenere esemplari e <strong>di</strong> documentare con foto;<br />
- Rilevazione con GPS dei punti <strong>di</strong> collocazione delle trappole e <strong>di</strong> raccolta a vista;<br />
- Annotazione su schede dei dati del sito e altro: data, toponimo (compreso: nome<br />
regione, provincia, comune), altitu<strong>di</strong>ne, inclinazione, esposizione, coor<strong>di</strong>nate<br />
geografiche, descrizione ambiente, copertura arborea, cognome del raccoglitore ed<br />
iniziale del nome, fotografie scattate.<br />
2.6.4.1.2 Coleotteri acquatici<br />
Comprende il monitoraggio delle seguenti specie: Hydrophilus piceus (Linnaeus, 1758)<br />
Metodo <strong>di</strong> monitoraggio manuale della comunità a Coleotteri acquatici e Iru<strong>di</strong>nei qualitativo e<br />
quantitativo<br />
Frequenza e stagionalità<br />
Il monitoraggio degli adulti deve essere eseguito una volta ogni 15 giorni da marzo-aprile a<br />
novembre durante le belle giornate e nell’arco <strong>di</strong> un anno. Il monitoraggio dovrebbe essere<br />
ripetuto all’incirca ogni 5 anni per determinare eventuali variazioni nel popolamento.<br />
Criteri <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduazione e posizionamento delle stazioni <strong>di</strong> campionamento<br />
- Il campionamento dovrà essere effettuato scegliendo un’area omogenea per<br />
caratteristiche ambientali;<br />
- Scelta dei punti nelle zone umide e lungo i corsi d’acqua in cui campionare gli adulti.<br />
Strumentazione per il campionamento<br />
- Retino per insetti acquatici con <strong>di</strong>ametro <strong>di</strong> 25 cm o maggiore, maglie <strong>di</strong> 1 mm e con<br />
manico <strong>di</strong> circa 150 cm, riducibile secondo le esigenze;<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 121<br />
- Piccolo colino (maglie 0,75 mm);<br />
- Pinzette morbide e barattoli in plastica da 50 o 100 cc con trucioli <strong>di</strong> sughero ed etere<br />
acetico;<br />
- Vaschette <strong>di</strong> plastica bianca per smistare i materiali (in campo e in laboratorio);<br />
- Etichette adesive da attaccare sui contenitori;<br />
- Macchina fotografica <strong>di</strong>gitale;<br />
- Schede cartacee pre<strong>di</strong>sposte per la raccolta dei dati in campo;<br />
- Rilevatore GPS e cartografia della zona;<br />
- Alcool 70° per conservare il materiale raccolto (in campo e in laboratorio);<br />
- Binoculare stereoscopico fino 40x (in laboratorio);<br />
- Spilli entomologici, misure da 1 a 4, cartellini entomologici bianchi <strong>di</strong> varie misure e colla<br />
entomologica (in laboratorio);<br />
- Tavolette su cui preparare gli adulti (in laboratorio);<br />
- Provette <strong>di</strong> vetro <strong>di</strong> varie misure;<br />
- Scatole entomologiche standard con vetro superiore (misure 6x26x39 cm) (in<br />
laboratorio);<br />
- Stivali <strong>di</strong> gomma e altro equipaggiamento comune per chi frequenta gli ambienti<br />
acquatici.<br />
Procedura <strong>di</strong> campionamento<br />
- Campionamento in punti prestabiliti degli adulti con retino per insetti acquatici dalle<br />
sponde e se necessario da natanti, e anche con l’ausilio del colino, smistamento entro<br />
vaschetta, raccolta con pinze ed inserimento degli esemplari entro barattoli con trucioli <strong>di</strong><br />
sughero ed etere acetico;<br />
- Rilevazione con GPS dei punti <strong>di</strong> cattura;<br />
- Annotazione su schede dei dati del sito e altro: data, toponimo (compreso: nome<br />
regione, provincia, comune), altitu<strong>di</strong>ne, coor<strong>di</strong>nate geografiche, descrizione ambiente,<br />
copertura arborea, cognome del raccoglitore ed iniziale del nome, fotografie scattate;<br />
- Per tutte le specie si raccomanda <strong>di</strong> trattenere solo nei casi dubbi, previa autorizzazione<br />
e comunque meno esemplari possibili. Per le specie <strong>di</strong> facile identificazione si<br />
raccomanda <strong>di</strong> non trattenere esemplari e <strong>di</strong> documentare con foto.<br />
2.6.4.1.3 Coleotteri Cicindeli<strong>di</strong> e Coleotteri Glafiri<strong>di</strong> (Scaraboidei floricoli)<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 122<br />
Comprende rispettivamente il monitoraggio delle seguenti specie: Cicindela majalis Mandl,<br />
1935 e Anthypna (= Amphicoma) abdominalis aemiliana Ghi<strong>di</strong>ni, 1956.<br />
Metodo <strong>di</strong> monitoraggio della comunità qualitativo e quantitativo a vista degli adulti.<br />
Frequenza e stagionalità<br />
Il monitoraggio degli adulti deve essere eseguito una volta ogni 15 giorni da aprile a<br />
settembre con buone con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> tempo atmosferico e ripetuto all’incirca ogni 5 anni per<br />
determinare eventuali variazioni nel popolamento.<br />
Criteri <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduazione e posizionamento delle stazioni <strong>di</strong> campionamento<br />
- Il campionamento dovrà essere effettuato scegliendo un’area omogenea per<br />
caratteristiche ambientali lungo le dune marine, depressioni interdunali, spiagge, greti,<br />
rive e golene fluviali;<br />
- Scelta dei percorsi fissi e/o transetti nella stazione in cui effettuare il monitoraggio degli<br />
adulti.<br />
Strumentazione per il campionamento<br />
- Retino da farfalle con <strong>di</strong>ametro <strong>di</strong> 30-40 cm, con manico <strong>di</strong> 60-70 cm o più lungo e sacco<br />
<strong>di</strong> tulle profondo 70-80 cm;<br />
- Boccetti in plastica da 100 cc con segatura <strong>di</strong> sughero o altro materiale assorbente ed<br />
etere acetico;<br />
- Flacone con etere acetico;<br />
- Etichette adesive da attaccare sui contenitori;<br />
- Pinzette morbide;<br />
- Macchina fotografica <strong>di</strong>gitale;<br />
- Schede cartacee pre<strong>di</strong>sposte per la raccolta dei dati in campo;<br />
- Rilevatore GPS e cartografia della zona;<br />
- Binoculare stereoscopico fino 40x (in laboratorio);<br />
- Spilli entomologici, misure da 2 a 4, cartellini entomologici bianchi <strong>di</strong> varie misure e colla<br />
entomologica (in laboratorio);<br />
- Tavolette su cui preparare gli esemplari adulti (in laboratorio);<br />
- Scatole entomologiche standard con vetro superiore (misure 6x26x39 cm) (in<br />
laboratorio).<br />
Procedura <strong>di</strong> campionamento<br />
- Percorrenza dei tratti in precedenza in<strong>di</strong>viduati ogni 15 giorni con cattura degli adulti<br />
me<strong>di</strong>ante retino per farfalle, loro identificazione e successivo rilascio degli esemplari –<br />
saranno trattenuti e posti nel boccetto con etere acetico e con i dati <strong>di</strong> cattura solo gli<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 123<br />
esemplari <strong>di</strong> dubbia determinazione. Per tutte le specie si raccomanda <strong>di</strong> trattenere solo<br />
nei casi dubbi, previa autorizzazione e comunque meno esemplari possibili, non più <strong>di</strong> 1-<br />
2 per stazione. Per le specie <strong>di</strong> facile identificazione si raccomanda <strong>di</strong> non trattenere<br />
esemplari e <strong>di</strong> documentare con foto;<br />
- Rilevazione con GPS dei percorsi e punti <strong>di</strong> cattura;<br />
- Annotazione su schede dei dati del sito e altro: data, toponimo (compreso: nome<br />
Note<br />
regione, provincia, comune), altitu<strong>di</strong>ne, inclinazione, esposizione, coor<strong>di</strong>nate<br />
geografiche, descrizione ambiente, eventuale copertura arborea, cognome del<br />
raccoglitore ed iniziale del nome, fotografie scattate.<br />
Il monitoraggio può avere un carattere anche quantitativo ad esempio con cattura, marcatura<br />
e ricattura ogni 1-2 giorni degli esemplari adulti <strong>di</strong> una specie; tale proce<strong>di</strong>mento verrà<br />
ripetuto più volte nell’arco del periodo <strong>di</strong> attività della specie.<br />
2.6.4.1.4 Coleotteri saproxilici del legno morto<br />
Comprende il monitoraggio delle seguenti specie:<br />
Cerambyx cerdo (Linnaeus, 1758)<br />
<strong>Luca</strong>nus cervus (Linnaeus, 1758)<br />
Metodo <strong>di</strong> monitoraggio della popolazione qualitativo a vista e quantitativo con varie<br />
tipologie <strong>di</strong> trappole<br />
Frequenza e stagionalità<br />
Il monitoraggio con trappole deve essere eseguito da maggio a settembre nell’arco <strong>di</strong> un<br />
anno e dovrebbe essere ripetuto all’incirca ogni 5 anni per in<strong>di</strong>viduare possibili cambiamenti<br />
nel popolamento.<br />
Il monitoraggio a vista deve essere eseguito nell’arco <strong>di</strong> un anno una volta ogni 15 giorni da<br />
maggio a settembre e durante giornate con con<strong>di</strong>zioni meteo buone. Il monitoraggio<br />
dovrebbe essere ripetuto all’incirca ogni 5 anni per determinare eventuali variazioni nelle<br />
presenze. La raccolta del legname per l’allevamento va effettuata nel periodo invernale e<br />
all’inizio della primavera.<br />
Criteri <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduazione e posizionamento delle stazioni <strong>di</strong> campionamento<br />
- Il campionamento dovrà essere effettuato scegliendo un’area omogenea per<br />
caratteristiche e copertura del suolo. È necessario evitare i microambienti in quanto il<br />
punto in cui viene effettuato il campione deve essere rappresentativo dell’area;<br />
- Collocazione in totale <strong>di</strong> circa 5-6 trappole per stazione, <strong>di</strong> varia tipologia. Le trappole<br />
saranno ad intercettazione: trappole a finestra collocate ai tronchi degli alberi e pendenti<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 124<br />
dai rami e/o con nasse arboree <strong>di</strong>sposte tra gli alberi e/o con trappole aeree attrattive<br />
poste in alto pendenti dai rami;<br />
- Raccolta manuale o campionamento a vista degli adulti e allevamento da legname con<br />
segni <strong>di</strong> presenza larvale in alternativa o ad integrazione del trappolaggio.<br />
Strumentazione per il campionamento<br />
- Trappole a finestra (trunk window trap e window fligt trap) e/o trappole arboree attrattive<br />
(piège attractif aérien) e/o nasse arboree (<strong>di</strong> varia tipologia);<br />
- Barattoli da 500 cc e liqui<strong>di</strong> per il rinnovo (soluzione <strong>di</strong> alcool 70% e acido acetico 5%;<br />
miscela <strong>di</strong> birra, zucchero o melassa, sale);<br />
- Retino semiovale per la raccolta a vista sui tronchi e sotto le cortecce con l’ausilio <strong>di</strong> un<br />
coltello durante il campionamento manuale;<br />
- Ombrello entomologico con lato almeno <strong>di</strong> 50-70 cm e retino per farfalle per la cattura a<br />
vista;<br />
- Pinzette e barattolo con sughero ed etere acetico;<br />
- Imbuto con imbocattura larga (2-3 cm <strong>di</strong> <strong>di</strong>ametro) e piccolo colino (maglie 0,75 mm);<br />
- Etichette adesive da attaccare sui contenitori;<br />
- Schede cartacee pre<strong>di</strong>sposte per la raccolta dei dati in campo;<br />
- Macchina fotografica <strong>di</strong>gitale;<br />
- Rilevatore GPS e cartografia della zona;<br />
- Binoculare stereoscopico fino 40x (in laboratorio);<br />
- Vaschette <strong>di</strong> plastica per smistare i materiali (in laboratorio);<br />
- Alcool 70° per conservare il materiale raccolto (in laboratorio);<br />
- Spilli entomologici, misure da 2 a 4, cartellini entomologici bianchi <strong>di</strong> varie misure e colla<br />
entomologica (in laboratorio);<br />
- Scatole entomologiche standard con vetro superiore (misure 6x26x39 cm) (in<br />
laboratorio).<br />
Procedura <strong>di</strong> campionamento<br />
- Collocazione trappole con schemi prefissati a transetto lineare o a quinconce;<br />
- Controllo trappole ogni 15 giorni con rinnovo dei liqui<strong>di</strong> e dei contenitori <strong>di</strong> raccolta. Una<br />
volta verificata la presenza delle specie per le quali si effettua il campionamento,<br />
soprattutto nel caso <strong>di</strong> specie protette, è opportuno interrompere il trappolaggio.<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 125<br />
In<strong>di</strong>cativamente può essere ritenuto significativo il campionamento una volta catturati 5<br />
esemplari per specie <strong>di</strong> interesse per stazione; tale numero massimo <strong>di</strong> esemplari<br />
catturati giustifica la sospensione del trappolaggio. Per tutte le specie si raccomanda <strong>di</strong><br />
trattenere solo nei casi dubbi, previa autorizzazione e comunque meno esemplari<br />
possibili, non più <strong>di</strong> 1-2 per stazione. Per le specie <strong>di</strong> facile identificazione si raccomanda<br />
<strong>di</strong> non trattenere esemplari e <strong>di</strong> documentare con foto;<br />
- Raccolta a vista con cattura degli adulti, loro identificazione e successivo rilascio degli<br />
esemplari, ogni 15 giorni su tronchi a terra e in pie<strong>di</strong>, in ceppaie, cataste <strong>di</strong> legna, ove vi<br />
siano segni <strong>di</strong> presenza, sulle fronde e fiori con l’ausilio <strong>di</strong> pinzette, ombrello<br />
entomologico, retino per farfalle, retino per tronchi ed etichettatura dei barattoli con i dati<br />
<strong>di</strong> raccolta. Saranno trattenuti, e posti entro barattolo con etere acetico e con i dati <strong>di</strong><br />
cattura, solo gli esemplari <strong>di</strong> dubbia determinazione e comunque in numero molto ridotto<br />
e previa autorizzazione non più <strong>di</strong> 1-2 per stazione per le specie protette. Nel caso <strong>di</strong><br />
specie <strong>di</strong> facile identificazione, soprattutto se rare e/o protette, si raccomanda <strong>di</strong><br />
documentare con foto e il rilascio dopo l’identificazione;<br />
- Rilevazione con GPS dei punti <strong>di</strong> collocazione delle trappole e <strong>di</strong> raccolta a vista;<br />
- Annotazione su schede dei dati del sito e altro: data, toponimo (compreso: nome<br />
regione, provincia, comune), altitu<strong>di</strong>ne, inclinazione, esposizione, coor<strong>di</strong>nate<br />
geografiche, descrizione ambiente, copertura arborea, cognome del raccoglitore ed<br />
iniziale del nome, fotografie scattate;<br />
- Raccolta invernale e all’inizio della primavera <strong>di</strong> porzioni <strong>di</strong> legname e pezzi <strong>di</strong> rami e<br />
trasporto in laboratorio.<br />
2.6.4.1.5 Coleotteri saproxilici<br />
Comprende il monitoraggio delle seguenti specie: Elater ferrugineus (Linnaeus, 1758)<br />
Metodo <strong>di</strong> monitoraggio della popolazione qualitativo a vista e quantitativo con trappole<br />
I meto<strong>di</strong> più efficienti per monitorare la specie sono l’uso delle trappole a caduta “in vivo” per<br />
adulti entro le cavità degli alberi vivi, la ricerca <strong>di</strong>retta delle larve e l’in<strong>di</strong>viduazione dei resti<br />
degli adulti e degli escrementi delle larve tra la rosura nelle cavità. La raccolta manuale degli<br />
adulti è possibile ma poco efficiente siccome questi coleotteri lasciano raramente le cavità<br />
degli alberi. Occasionalmente possono essere in<strong>di</strong>viduati gli adulti entro le cavità, captando<br />
vicino alle cavità con l’olfatto la presenza del tipico odore della specie, ciò va eseguito nei<br />
cal<strong>di</strong> pomeriggi in giugno-luglio.<br />
Frequenza e stagionalità<br />
Il monitoraggio con trappole a caduta deve essere eseguito continuativamente da inizio<br />
giugno ad inizio agosto durante il periodo estivo <strong>di</strong> attività degli adulti, con visita delle<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 126<br />
trappole ogni 2 giorni. Il monitoraggio dovrebbe essere ripetuto all’incirca ogni 5 anni per<br />
in<strong>di</strong>viduare possibili cambiamenti nelle presenze.<br />
Il monitoraggio a vista entro le cavità degli alberi delle larve, dei resti degli adulti e degli<br />
escrementi delle larve (solo escrementi <strong>di</strong> Osmoderma) deve essere eseguito<br />
preferibilmente in autunno con una visita ad ogni albero cavo <strong>di</strong> un’area campione prescelta.<br />
In autunno le larve si mantengono più in alto tra i detriti e sono quin<strong>di</strong> più facili da rinvenire. Il<br />
monitoraggio dovrebbe essere ripetuto all’incirca ogni 5 anni per determinare eventuali<br />
variazioni nel popolamento.<br />
Criteri <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduazione e posizionamento delle stazioni <strong>di</strong> campionamento<br />
- Il campionamento dovrà essere effettuato scegliendo un’area con vecchi alberi vivi<br />
cariati, dotati <strong>di</strong> gran<strong>di</strong> cavità, sia ai margini e all’interno <strong>di</strong> boschi, foreste e gran<strong>di</strong> parchi<br />
sia lungo fiumi e altri corsi d’acqua e lungo filari <strong>di</strong> alberi idonei (salici, pioppi, querce,<br />
platani, ippocastani, tigli, castagni);<br />
- Collocazione <strong>di</strong> un numero variabile <strong>di</strong> trappole a caduta per stazione, una per albero<br />
cavo;<br />
- Ricerca manuale autunnale entro le cavità degli alberi delle larve, dei resti degli adulti e<br />
degli escrementi delle larve, una sola volta per albero, in alternativa o ad integrazione<br />
del trappolaggio.<br />
Strumentazione per il campionamento<br />
- Trappole a caduta “in vivo” (barattoli <strong>di</strong> plastica da 500 cc) da collocare dentro le cavità<br />
degli alberi (ogni trappola è composta da una coppia <strong>di</strong> barattoli, uno contenuto nell’altro,<br />
con quello superiore da sfilare per il prelievo e il rinnovo e quello sottostante contenente<br />
un po’ <strong>di</strong> liquido attrattivo);<br />
- Liquido attrattivo composto da una miscela <strong>di</strong> birra, frutta o succhi <strong>di</strong> frutta o melassa;<br />
- Retino semiovale per la raccolta e l’esame a vista della rosura e del detrito delle cavità<br />
dei tronchi con l’ausilio <strong>di</strong> una paletta da giar<strong>di</strong>naggio durante il campionamento<br />
manuale;<br />
- Pinzette morbide e piccoli barattoli o boccetti per la raccolta dei reperti;<br />
- Barattolo con sughero ed etere acetico;<br />
- Etichette adesive da attaccare sui contenitori;<br />
- Schede cartacee pre<strong>di</strong>sposte per la raccolta dei dati in campo;<br />
- Macchina fotografica <strong>di</strong>gitale;<br />
- Rilevatore GPS e cartografia della zona;<br />
- Binoculare stereoscopico fino 40x (in laboratorio);<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 127<br />
- Vaschette <strong>di</strong> plastica per smistare i materiali (in laboratorio);<br />
- Spilli entomologici, misure da 3 a 4, cartellini entomologici bianchi <strong>di</strong> varie misure e colla<br />
entomologica (in laboratorio);<br />
- Scatole entomologiche standard con vetro superiore (misure 6x26x39 cm) (in<br />
laboratorio).<br />
Procedura <strong>di</strong> campionamento<br />
- In<strong>di</strong>viduazione dei tronchi con cavità e scelta <strong>di</strong> quelli da monitorare;<br />
- Ricerca nel periodo autunnale <strong>di</strong> larve e segni <strong>di</strong> presenza (escrementi larvali <strong>di</strong><br />
Osmoderma, spoglie <strong>di</strong> exuvie e resti <strong>di</strong> elitre, pronoti, teste e altro degli esemplari<br />
adulti);<br />
- Collocazione ad inizio giugno delle trappole a caduta, una per cavità, posizionate con<br />
l’apertura perfettamente allo stesso livello della superficie dei detriti all’interno della<br />
cavità;<br />
- Visita ogni 2 giorni delle trappole con rinnovo del liquido e con prelievo degli adulti, loro<br />
identificazione e successivo rilascio (saranno trattenuti, e posti entro barattolo con etere<br />
acetico e con i dati <strong>di</strong> cattura, solo alcuni esemplari, quelli danneggiati o morti). Essendo<br />
le specie <strong>di</strong> facile identificazione si raccomanda <strong>di</strong> non trattenere esemplari e <strong>di</strong><br />
documentare solo con foto;<br />
- Rilevazione con GPS dei punti <strong>di</strong> collocazione delle trappole e <strong>di</strong> raccolta a vista <strong>di</strong> resti;<br />
- Annotazione su schede dei dati del sito e altro: data, toponimo (compreso: nome<br />
regione, provincia, comune), altitu<strong>di</strong>ne, inclinazione, esposizione, coor<strong>di</strong>nate<br />
geografiche, descrizione ambiente, copertura arborea, cognome del raccoglitore ed<br />
iniziale del nome, fotografie scattate.<br />
Il monitoraggio può essere svolto anche con cattura, marcatura, rilascio e ricattura degli<br />
adulti.<br />
2.6.4.1.6 Lepidotteri <strong>di</strong>urni<br />
Comprende il monitoraggio delle seguenti specie: Iolana iolas e Maculinea arion<br />
Metodo <strong>di</strong> monitoraggio qualitativo e quantitativo a vista delle farfalle adulte in attività<br />
secondo il “Butterfly Monitoring Scheme”<br />
Frequenza e stagionalità<br />
Il monitoraggio degli adulti deve essere eseguito una volta ogni 15 giorni da aprile a ottobre,<br />
con buone con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> tempo atmosferico, nelle ore calde e centrali della giornata. Il<br />
monitoraggio dovrebbe essere ripetuto all’incirca ogni 5 anni per determinare eventuali<br />
variazioni nel popolamento.<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 128<br />
Criteri <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduazione e posizionamento delle stazioni <strong>di</strong> campionamento<br />
- Il campionamento dovrà essere effettuato scegliendo un’area omogenea per<br />
caratteristiche ambientali. È necessario evitare i microambienti in quanto il punto in cui<br />
viene effettuato il campione deve essere rappresentativo dell’area;<br />
- Scelta dei percorsi fissi e transetti nella stazione in cui effettuare il monitoraggio delle<br />
farfalle <strong>di</strong> lunghezza variabile secondo l’ampiezza dell’area da indagare.<br />
Strumentazione per il campionamento<br />
- Retino da farfalle con <strong>di</strong>ametro <strong>di</strong> 30-40 cm, con manico <strong>di</strong> 60-70 cm e sacco profondo<br />
70-80 cm <strong>di</strong> rete (tulle) soffice per non danneggiare le delicate ali delle farfalle;<br />
- Bustine <strong>di</strong> cellophane o carta pergamino triangolari a bor<strong>di</strong> ripiegati, con possibilità <strong>di</strong><br />
scrivere sopra i dati <strong>di</strong> cattura e <strong>di</strong> formato vario, minimo da 5x7 cm a 12x17 cm, riposte<br />
dentro un contenitore rigido;<br />
- Pinzette morbide;<br />
- Macchina fotografica <strong>di</strong>gitale;<br />
- Schede cartacee pre<strong>di</strong>sposte per la raccolta dei dati in campo;<br />
- Rilevatore GPS e cartografia della zona;<br />
- Binoculare stereoscopico fino 40x (in laboratorio);<br />
- Spilli entomologici, misure da 1 a 4 (in laboratorio);<br />
- Sten<strong>di</strong>toi su cui preparare le farfalle (in laboratorio);<br />
- Strisce <strong>di</strong> carta pergamino con cui tenere stese le ali delle farfalle (in laboratorio);<br />
- Scatole entomologiche standard con vetro superiore (misure 6x26x39 cm) (in<br />
laboratorio).<br />
Procedura <strong>di</strong> campionamento<br />
- Percorrenza dei transetti e percorsi fissi in precedenza in<strong>di</strong>viduati ogni 15 giorni con<br />
censimento (annotando le specie ed il numero <strong>di</strong> esemplari riscontrati nel raggio <strong>di</strong> 15-20<br />
m) e/o cattura degli adulti me<strong>di</strong>ante il retino per farfalle, loro identificazione e successivo<br />
imme<strong>di</strong>ato rilascio degli esemplari nel caso <strong>di</strong> cattura. Al fine <strong>di</strong> preservare il più<br />
possibile la lepidotterofauna e <strong>di</strong> incidere il meno possibile sulle popolazioni presenti,<br />
saranno trattenuti e posti entro le bustine con i dati <strong>di</strong> cattura solo gli esemplari <strong>di</strong> dubbia<br />
determinazione. Tale attività richiederà autorizzazione specifica. Per tutte le specie si<br />
raccomanda <strong>di</strong> trattenere solo nei casi dubbi e comunque meno esemplari possibili, non<br />
più <strong>di</strong> 1-2 per stazione. Per le specie <strong>di</strong> facile identificazione si raccomanda <strong>di</strong> non<br />
trattenere esemplari e <strong>di</strong> documentare con foto;<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 129<br />
- Durante le uscite, per alcune specie <strong>di</strong> particolare interesse, saranno ricercati sulle<br />
piante, o nei pressi <strong>di</strong> queste, gli sta<strong>di</strong> preimmaginali (uova, bruchi e crisali<strong>di</strong>);<br />
- Rilevazione con GPS dei percorsi e punti <strong>di</strong> censimento;<br />
- Annotazione su schede dei dati del sito e altro: data, toponimo (compreso: nome<br />
regione, provincia, comune), altitu<strong>di</strong>ne, inclinazione, esposizione, coor<strong>di</strong>nate<br />
geografiche, descrizione ambiente, copertura arborea, cognome del raccoglitore ed<br />
iniziale del nome, eventuali piante nutrici dei bruchi, fotografie scattate.<br />
2.6.4.1.7 Lepidotteri notturni<br />
Comprende il monitoraggio delle seguenti specie: Eriogaster catax (Linnaeus, 1758),<br />
Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761), Hyles hippophaes, Proserpinus proserpina (Pallas,<br />
1772).<br />
Meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> monitoraggio qualitativo e quantitativo delle farfalle notturne in attività con caccia<br />
notturna al lume e/o con trappole luminose<br />
Frequenza e stagionalità<br />
Il monitoraggio deve essere eseguito una volta ogni 15 giorni da aprile a ottobre, nelle notti a<br />
partire già dall’imbrunire, <strong>di</strong> preferenza con novilunio, prive <strong>di</strong> vento e afose. Il monitoraggio<br />
dovrebbe essere ripetuto all’incirca ogni 5 anni per determinare eventuali variazioni nel<br />
popolamento.<br />
Criteri <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduazione e posizionamento delle stazioni <strong>di</strong> campionamento<br />
- Il campionamento dovrà essere effettuato scegliendo un’area omogenea per<br />
caratteristiche ambientali. È necessario evitare i microambienti in quanto la zona in cui<br />
viene effettuato il campione deve essere rappresentativo dell’area;<br />
- Le trappole luminose o il lume devono essere collocati in aree aperte, radure e<br />
comunque in zone in cui la luce artificiale possa essere visibile da ogni parte e anche da<br />
una certa <strong>di</strong>stanza. In ogni sito può essere sistemato un lume oppure 2-3 trappole<br />
luminose;<br />
- Scelta dei percorsi fissi e transetti nella stazione, <strong>di</strong> lunghezza variabile secondo<br />
l’ampiezza dell’area da indagare, in cui effettuare il monitoraggio <strong>di</strong>urno per rilevare la<br />
presenza <strong>di</strong> sta<strong>di</strong> preimmaginali e <strong>di</strong> eventuali adulti a riposo.<br />
Strumentazione per il campionamento<br />
- Grande telo bianco (<strong>di</strong> 1,5-2 m per lato) teso tra due sostegni, che agisce da <strong>di</strong>ffusore<br />
della luce, e lume (sorgente luminosa come una lampada a vapori <strong>di</strong> mercurio da 160 W<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 130<br />
o a luce miscelata da 250 W alimentata da un generatore portatile) collocato sul lato<br />
posteriore del telo a circa 1-1,5 m <strong>di</strong> altezza;<br />
- Trappole luminose (light-trap) costituite da un contenitore <strong>di</strong> plastica su cui è montato un<br />
imbuto che sostiene a sua volta due lamine <strong>di</strong> plexiglas trasparente poste a croce; tra le<br />
lamine è posizionata la lampada al neon a luce <strong>di</strong> Wood da 6, 8 o 12 W, alimentata da<br />
una piccola batteria da 12 volt; entro il contenitore sono posti nel fondo alcuni fogli <strong>di</strong><br />
carta assorbente e tra questi un piccolo vasetto con etere acetico;<br />
- Piccoli contenitori per uccidere le falene con dentro etere acetico;<br />
- Retino da farfalle con <strong>di</strong>ametro <strong>di</strong> 30-40 cm, con manico <strong>di</strong> 60-70 cm e sacco profondo<br />
70-80 cm <strong>di</strong> rete (tulle) soffice per non danneggiare le delicate ali delle farfalle;<br />
- Bustine <strong>di</strong> cellophane o carta pergamino triangolari a bor<strong>di</strong> ripiegati, con possibilità <strong>di</strong><br />
scrivere sopra i dati <strong>di</strong> cattura e <strong>di</strong> formato vario, minimo da 5x7 cm a 12x17 cm, riposte<br />
dentro un contenitore rigido;<br />
- Piccola siringa con ammoniaca;<br />
- Pinzette morbide e pinzette rigide;<br />
- Macchina fotografica <strong>di</strong>gitale;<br />
- Schede cartacee pre<strong>di</strong>sposte per la raccolta dei dati in campo;<br />
- Rilevatore GPS e cartografia della zona;<br />
- Binoculare stereoscopico fino 40x (in laboratorio);<br />
- Spilli entomologici, misure da 1 a 3 (in laboratorio);<br />
- Sten<strong>di</strong>toi su cui preparare le farfalle (in laboratorio);<br />
- Strisce <strong>di</strong> carta pergamino con cui tenere stese le ali delle farfalle (in laboratorio);<br />
- Scatole entomologiche standard con vetro superiore (misure 6x26x39 cm) (in<br />
laboratorio).<br />
Procedura <strong>di</strong> campionamento<br />
- Posizionamento ogni 15 giorni del telo e del lume e cattura delle falene che si<br />
appoggiano sul telo me<strong>di</strong>ante barattoli o retino per farfalle, loro identificazione e<br />
successivo rilascio o cattura con barattoli con etere acetico per trattenerle. Al fine <strong>di</strong><br />
preservare il più possibile la lepidotterofauna e <strong>di</strong> incidere il meno possibile sulle<br />
popolazioni presenti, saranno trattenuti e posti entro le bustine con i dati <strong>di</strong> cattura solo<br />
alcuni esemplari ed in particolare quelli <strong>di</strong> dubbia determinazione. Tale attività richiederà<br />
autorizzazione specifica. Per tutte le specie si raccomanda <strong>di</strong> trattenere solo nei casi<br />
dubbi e comunque meno esemplari possibili, non più <strong>di</strong> 1-2 per stazione. Per le specie <strong>di</strong><br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 131<br />
facile identificazione si raccomanda <strong>di</strong> non trattenere esemplari e <strong>di</strong> documentare con<br />
foto;<br />
- Gli esemplari <strong>di</strong> gran<strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni che si vogliono trattenere, vanno uccisi con una<br />
piccola iniezione <strong>di</strong> ammoniaca;<br />
- Posizionamento ogni 15 giorni <strong>di</strong> 2-3 trappole luminose per sito all’imbrunire, loro<br />
attivazione e successivo prelievo il mattino seguente. Le trappole possono essere<br />
lasciate in sito anche per più giorni consecutivi ma vanno rinnovate tutte le mattine. Il<br />
materiale raccolto va poi portato in laboratorio, dove va conservato in congelatore se<br />
non viene subito smistato. E’ opportuno interrompere o ridurre molto la frequenza dei<br />
campionamenti con questa metodologia, una volta verificata la presenza delle specie da<br />
monitorare e comunque non superare le 10 catture per stazione (o altri numeri da<br />
concordare);<br />
- Durante le uscite <strong>di</strong>urne, per alcune specie <strong>di</strong> particolare interesse, potranno essere<br />
ricercati sulle piante nutrici i bruchi;<br />
- Rilevazione con GPS dei percorsi e punti <strong>di</strong> censimento;<br />
- Annotazione su schede dei dati del sito e altro: data, toponimo (compreso: nome<br />
regione, provincia, comune), altitu<strong>di</strong>ne, inclinazione, esposizione, coor<strong>di</strong>nate<br />
geografiche, descrizione ambiente, copertura arborea, cognome del raccoglitore ed<br />
iniziale del nome, fotografie scattate.<br />
2.6.4.2 Crostacei Decapo<strong>di</strong><br />
Le modalità <strong>di</strong> indagine sulla presenza del gambero <strong>di</strong> fiume saranno le stesse utilizzate per<br />
i pesci e conseguentemente si rimanda a quanto descritto al paragrafo 1.6.4.3. Verrà inoltre<br />
condotta una ricerca <strong>di</strong>retta itinerante da parte <strong>di</strong> operatore esperto. L’uso <strong>di</strong> bertovelli (o<br />
simili) non verrà generalmente previsto per l’invasività verso gli anfibi. Tali trappole saranno<br />
usate solo se una porzione della nassa potrà stare al <strong>di</strong> sopra del pelo dell’acqua per<br />
permettere la respirazione alle specie che necessitano <strong>di</strong> aria; saranno raccolti dati anche<br />
in<strong>di</strong>retti (esuvie o resti). Il dato prodotto sarà <strong>di</strong> tipo semiquantitativo (in<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> consistenza,<br />
struttura).<br />
2.6.4.3 Pesci<br />
2.6.4.3.1 Metodologia <strong>di</strong> campionamento<br />
Ciascuno dei corpi idrici con presenza <strong>di</strong> specie ittiche <strong>di</strong> interesse conservazionistico sarà<br />
monitorato attraverso la realizzazione <strong>di</strong> censimenti ittici <strong>di</strong> tipo semiquantitativo con<br />
cadenza minima triennale. Il numero delle stazioni sarà definito in sede <strong>di</strong> <strong>consegna</strong><br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 132<br />
definitiva, in ogni caso non potrà essere inferiore ad una stazione ogni 10 Km <strong>di</strong> percorso<br />
lineare o inferiore per corsi d’acqua <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni ridotte.<br />
I campionamenti della fauna ittica dovranno essere eseguiti me<strong>di</strong>ante l’utilizzo <strong>di</strong> uno<br />
stor<strong>di</strong>tore elettrico <strong>di</strong> tipo fisso a corrente continua pulsata e/o ad impulsi (150-600 V;0.3-6 A,<br />
500-3500 W; 50 Kw). L’elettropesca è un metodo che consente la cattura <strong>di</strong> esemplari <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>versa taglia e appartenenti a <strong>di</strong>verse specie, per cui non risulta selettivo e consente una<br />
visione d’insieme sulla qualità e sulla quantità della popolazione ittica presente in un<br />
determinato tratto del corso d’acqua.<br />
Il passaggio della corrente lungo il corpo del pesce ne stimola la contrazione muscolare<br />
<strong>di</strong>fferenziata facendolo nuotare attivamente verso il catodo posizionandosi con la testa verso<br />
il polo positivo del campo. Quando la <strong>di</strong>stanza tra il polo positivo ed il pesce è limitata il<br />
pesce viene immobilizzato e raccolto dagli operatori utilizzando dei gua<strong>di</strong>ni. L’efficienza<br />
dell’elettropesca è massima nelle zone dove la profon<strong>di</strong>tà dell’acqua non supera i 2 m. Il<br />
campionamento interesserà un tratto <strong>di</strong> corso d’acqua con lunghezza variabile ed adeguata<br />
allo scopo; la scelta della lunghezza del tratto da controllare sarà eseguita <strong>di</strong> volta in volta in<br />
funzione della variabilità ambientale presente e delle caratteristiche fisiche del sito.<br />
La metodologia <strong>di</strong> indagine <strong>di</strong> tipo semi-quantitativo consentirà la definizione <strong>di</strong> un elenco<br />
delle specie presenti con l’espressione dei risultati in termini <strong>di</strong> in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> abbondanza (I.A.) al<br />
fine <strong>di</strong> definire anche una stima relativa delle abbondanze specifiche.<br />
Per l’attribuzione dell’in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> abbondanza specifica sarà utilizzato l’in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> abbondanza<br />
semiquantitativo (I.A.) secondo Moyle e Nichols (1973) che viene riportato in Tabella<br />
8Errore: sorgente del riferimento non trovata.<br />
INDICE DI<br />
ABBONDANZA<br />
TABELLA 8 - INDICE DI ABBONDANZA DI MOYLE & NICHOLS (1973).<br />
NUMERO DI INDIVIDUI RITROVATI IN 50 M<br />
LINEARI DI CORSO D’ACQUA<br />
GIUDIZIO<br />
1 1 - 2 Scarso<br />
2 3 - 10 Presente<br />
3 11 – 20 Frequente<br />
4 21 - 50 Abbondante<br />
5 > 50 Dominante<br />
Si procederà inoltre ad attribuire un in<strong>di</strong>ce riguardante la struttura delle popolazioni <strong>di</strong> ogni<br />
singola specie campionata per caratterizzare la struttura <strong>di</strong> popolazione secondo lo schema<br />
riportato nella tabella seguente (Turin et al., 1999).<br />
TABELLA 9 - INDICE DI STRUTTURA DI POPOLAZIONE (TURIN ET AL., 1999).<br />
INDICE DI STRUTTURA DI<br />
POPOLAZIONE<br />
LIVELLO DI STRUTTURA DELLA<br />
POPOLAZIONE<br />
1 popolazione strutturata<br />
2 popolazione non strutturata – dominanza <strong>di</strong> in<strong>di</strong>vidui giovani<br />
3 popolazione non strutturata – dominanza <strong>di</strong> in<strong>di</strong>vidui adulti<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 133<br />
2.6.4.3.1.1 In<strong>di</strong>ce dello Stato Ecologico delle Comunità Ittiche (ISECI)<br />
L’ISECI è un in<strong>di</strong>ce ancora nelle sue prime fasi <strong>di</strong> sperimentazione pertanto, come sostenuto<br />
dal suo stesso autore, necessita <strong>di</strong> essere migliorato sulla base dei dati che deriveranno<br />
dalle prime applicazioni pratiche. La sua applicazione viene pertanto proposta in questa<br />
sede come strumento <strong>di</strong> incremento delle conoscenze e <strong>di</strong> acquisizone <strong>di</strong> informazioni per la<br />
creazione <strong>di</strong> una banca dati nazionale. L’utilizzo pratico ai fini gestionali dei risultati ottenuti<br />
tramite l’applicazione dell’in<strong>di</strong>ce dovrà però essere preventivamente oggetto <strong>di</strong> verifica e<br />
taratura da effettuare con gli enti competenti.<br />
Struttura dell’in<strong>di</strong>ce ISECI<br />
La valutazione <strong>di</strong> una comunità ittica secondo l’ISECI (In<strong>di</strong>ce dello Stato Ecologico delle<br />
Comunità Ittiche) si basa su due criteri principali: la naturalità della comunità e la con<strong>di</strong>zione<br />
biologica delle popolazioni. A questi si aggiungono il <strong>di</strong>sturbo dovuto alla presenza <strong>di</strong> specie<br />
aliene, la presenza <strong>di</strong> specie endemiche e l’eventuale presenza <strong>di</strong> ibri<strong>di</strong>. Il calcolo dell’ISECI<br />
si basa quin<strong>di</strong> sulla somma <strong>di</strong> un punteggio determinato da 5 in<strong>di</strong>catori principali: presenza<br />
<strong>di</strong> specie in<strong>di</strong>gene, con<strong>di</strong>zione biologica delle popolazioni, presenza <strong>di</strong> ibri<strong>di</strong>, presenza <strong>di</strong><br />
specie aliene e presenza <strong>di</strong> specie endemiche. I primi due in<strong>di</strong>catori sono a loro volta<br />
articolati in in<strong>di</strong>catori <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne inferiore secondo lo schema presente in Figura 4.<br />
Le specie in<strong>di</strong>gene rappresentano il primo in<strong>di</strong>catore (f1) dell’ISECI. Lo scostamento dai<br />
valori <strong>di</strong> riferimento si ottiene dalla <strong>di</strong>fferenza tra il numero <strong>di</strong> specie osservato e quello<br />
atteso. L’in<strong>di</strong>catore si sud<strong>di</strong>vide in due in<strong>di</strong>catori inferiori, uno relativo alle specie in<strong>di</strong>gene <strong>di</strong><br />
importanza ecologica maggiore (f1,1), l’altro relativo alle altre specie in<strong>di</strong>gene (f1,2). Nel<br />
calcolo dei valori dell’in<strong>di</strong>ce, al primo viene attribuito un peso pari al 40%, al secondo viene<br />
attribuito un peso pari al 60%. Alle specie in<strong>di</strong>gene <strong>di</strong> importanza maggiore appartengono le<br />
famiglie dei Salmoni<strong>di</strong>, Esoci<strong>di</strong> e Perci<strong>di</strong>. Se alcune specie monitorate non fanno parte delle<br />
comunità in<strong>di</strong>gene <strong>di</strong> riferimento l’in<strong>di</strong>catore non viene calcolato.<br />
Al fine <strong>di</strong> valutare la presenza <strong>di</strong> specie in<strong>di</strong>gene <strong>di</strong> maggiore e minore importanza è quin<strong>di</strong><br />
necessario considerare: l’in<strong>di</strong>catore, le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> riferimento, la funzione valore associata.<br />
Presenza <strong>di</strong> specie in<strong>di</strong>gene <strong>di</strong> maggiore importanza ecologico-funzionale (f1,1)<br />
• In<strong>di</strong>catore f1,1: numero <strong>di</strong> specie in<strong>di</strong>gene presenti appartenenti alle famiglie <strong>di</strong><br />
Salmoni<strong>di</strong>, Esoci<strong>di</strong>, Perci<strong>di</strong> (Ni).<br />
• Con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> riferimento: numero <strong>di</strong> specie in<strong>di</strong>gene attese appartenenti a<br />
Salmoni<strong>di</strong>, Esoci<strong>di</strong>, Perci<strong>di</strong> (Ni, R).<br />
• Funzione valore associata: ipotizzo una funzione valore crescente.<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 134<br />
Presenza <strong>di</strong> altre specie in<strong>di</strong>gene (f1,2)<br />
• In<strong>di</strong>catore f1,2: numero <strong>di</strong> specie in<strong>di</strong>gene presenti che non appartengono alle<br />
famiglie <strong>di</strong> Salmoni<strong>di</strong>, Esoci<strong>di</strong>, Perci<strong>di</strong> (Ni).<br />
• Con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> riferimento: numero <strong>di</strong> specie in<strong>di</strong>gene attese non appartenenti a<br />
Salmoni<strong>di</strong>, Esoci<strong>di</strong>, Perci<strong>di</strong> (Ni, R).<br />
• Funzione valore associata: ipotizzo una funzione valore crescente.<br />
Le con<strong>di</strong>zioni biologiche della popolazione (f2) rappresentano il secondo in<strong>di</strong>catore. Per<br />
ciascuna delle specie in<strong>di</strong>gene per cui sono stati catturati un sufficiente numero <strong>di</strong> in<strong>di</strong>vidui<br />
viene calcolato l’in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> struttura <strong>di</strong> popolazione e la consistenza demografica. La struttura<br />
della popolazione è un in<strong>di</strong>catore <strong>di</strong> tipo qualitativo che può assumere i valori “ben<br />
strutturata”, “me<strong>di</strong>amente strutturata”, “destrutturata”. La definizione delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong><br />
riferimento e l’assegnazione <strong>di</strong> un giu<strong>di</strong>zio a questo in<strong>di</strong>catore devono fare riferimento alle<br />
conoscenze sulla biologia e sull’ecologia delle specie monitorate. Gli in<strong>di</strong>vidui raccolti nel<br />
campionamento si <strong>di</strong>stribuiscono quin<strong>di</strong> nelle varie classi d’età e, a partire dalle taglie <strong>di</strong><br />
lunghezza, viene definita la seguente funzione valore:<br />
• v 2,i,1 (“ben strutturata”) = 1;<br />
• v 2,i,1 (“me<strong>di</strong>amente strutturata”) = 0,5;<br />
• v 2,i,1 (“destrutturata”) = 0.<br />
La consistenza demografica è un in<strong>di</strong>catore <strong>di</strong> tipo qualitativo, che può assumere i valori<br />
“pari a quella attesa”, “interme<strong>di</strong>a”, “scarsa”. La valutazione dell’in<strong>di</strong>catore rispetto a queste<br />
categorie predefinite deve fare riferimento alle conoscenze sulla biologia ed ecologia delle<br />
specie. Funzione valore:<br />
• v 2,i,2 (“pari a quella attesa”) = 1;<br />
• v 2,i,2 (“interme<strong>di</strong>a”) = 0,5;<br />
• v 2,i,2 (“scarsa”) = 0.<br />
La presenza <strong>di</strong> ibri<strong>di</strong> (f3) è un ulteriore in<strong>di</strong>catore utilizzato per il calcolo dell’ISECI. Viene<br />
calcolato sia per specie in<strong>di</strong>gene che per specie alloctone appartenenti ai generi Salmo,<br />
Thymallus, Esox, Barbus e Rutilus; per le specie in<strong>di</strong>gene appartenenti a questi generi esiste<br />
la possibilità <strong>di</strong> ibridarsi con in<strong>di</strong>vidui alloctoni, immessi <strong>di</strong> solito tramite ripopolamenti a<br />
favore della pesca sportiva. L’in<strong>di</strong>catore assume il valore “SI” quando sono presenti specie<br />
ibridate, il valore “NO” quando la presenza <strong>di</strong> queste non viene rilevata.<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 135<br />
Il successivo in<strong>di</strong>catore si basa su liste <strong>di</strong> specie aliene a <strong>di</strong>verso livello <strong>di</strong> impatto sulla<br />
fauna ittica in<strong>di</strong>gena (f4). Le invasioni <strong>di</strong> specie aliene che hanno maggiormente successo<br />
sono quelle che avvengono in ambienti che risentono dell’attività umana. In molte aree del<br />
mondo è stato infatti rilevato che pesci d’acqua dolce introdotti abbondano particolarmente in<br />
habitat acquatici degradati. Le specie più facilmente introdotte sono infatti quelle aventi<br />
elevata tolleranza alle <strong>di</strong>verse con<strong>di</strong>zioni ambientali e ad alta capacità <strong>di</strong> adattamento ad alte<br />
concentrazioni <strong>di</strong> nutrienti nelle acque. Queste specie possono avere: un impatto <strong>di</strong>retto sui<br />
pesci del luogo, tramite predazione, competizione per le risorse, interferenza con la<br />
riproduzione e introduzione <strong>di</strong> parassiti e malattie; un impatto in<strong>di</strong>retto, alterando le<br />
con<strong>di</strong>zioni degli habitat e i processi ecosistemici. I pesci introdotti sono quin<strong>di</strong> sintomo e<br />
causa <strong>di</strong> declino per la salute del fiume e per l’integrità delle comunità ittiche native.<br />
Le specie aliene possono appartenere a tre <strong>di</strong>fferenti liste: alla LISTA 1, se considerate<br />
estremamente nocive; alla LISTA 2 se me<strong>di</strong>amente nocive; alla LISTA 3 se moderatamente<br />
nocive. L’in<strong>di</strong>catore può assumere sette <strong>di</strong>versi valori, in funzione della presenza <strong>di</strong> specie<br />
appartenenti alle tre liste e alla con<strong>di</strong>zione e consistenza della popolazione. Possono quin<strong>di</strong><br />
verificarsi le seguenti situazioni:<br />
• A: sono presenti specie della lista 1, almeno una delle quali con popolazione ben<br />
strutturata;<br />
• B: sono presenti specie della lista 1 ma con popolazione/i destrutturata/e;<br />
• C: sono presenti specie della lista 2, ma non della lista 1; il numero <strong>di</strong> specie aliene<br />
è superiore al 50% del totale della comunità campionata;<br />
• D: sono presenti specie della lista 2, ma non della lista 1; il numero delle specie<br />
aliene della lista è inferiore al 50% del totale delle specie della comunità<br />
campionata;<br />
• E: sono presenti specie della lista 3, ma non della lista 1 né della lista 2; il numero <strong>di</strong><br />
specie aliene della lista 3 è superiore al 50% del totale delle specie della comunità<br />
campionata;<br />
• F: sono presenti specie della lista 3, ma non della lista 1 né della lista 2; il numero <strong>di</strong><br />
specie aliene della lista 3 è inferiore al 50% della specie della comunità campionata;<br />
• G: assenza <strong>di</strong> specie aliene.<br />
La funzione valore associata alle varie classi è:<br />
• v4 (A) = 0;<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 136<br />
• v4 (B) = v4 (C) = 0,5;<br />
• v4 (D) = v4 (E) = 0,75;<br />
• v4 (F) = 0,85;<br />
• v4 (G) = 1.<br />
FIGURA 4 – STRUTTURA AD “ALBERO” DELL’ISECI: I VALORI DEGLI INDICATORI VERSO CUI PUNTANO LE FRECCE SONO CALCOLATI<br />
TRAMITE L’AGGREGAZIONE, PESATA ATTRAVERSO I PESI P DEI VALORI DI ORDINE INFERIORE; CIASCUNO RAPPORTATO ALLE CONDIZIONI DI<br />
RIFERIMENTO MEDIANTE UNA FUNZIONE F (ZERUNIAN ET AL., 2009).<br />
Ultimo in<strong>di</strong>catore considerato è la presenza <strong>di</strong> specie endemiche (f5) avente le seguenti<br />
caratteristiche:<br />
• In<strong>di</strong>catore f5: numero <strong>di</strong> specie endemiche presenti (Ne).<br />
• Con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> riferimento: numero <strong>di</strong> specie endemiche attese (Ne,R).<br />
• Funzione valore associata: lineare crescente (come per f1,1).<br />
Complessivamente, si ritiene che la presenza <strong>di</strong> specie in<strong>di</strong>gene e la con<strong>di</strong>zione biologica<br />
delle popolazioni siano <strong>di</strong> pari importanza e più importanti degli altri criteri; seguono la<br />
presenza <strong>di</strong> specie aliene, quin<strong>di</strong>, con pari importanza, la presenza <strong>di</strong> ibri<strong>di</strong> e la presenza <strong>di</strong><br />
specie endemiche.<br />
Con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> riferimento<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 137<br />
Secondo quanto previsto dalla normativa vigente (Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE)<br />
è in<strong>di</strong>spensabile per la classificazione dello stato ecologico dei fiumi, l’identificazione delle<br />
con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> riferimento. Le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> riferimento sono definite come le “con<strong>di</strong>zioni<br />
corrispondenti ad alcuna alterazione antropica, o alterazioni antropiche poco rilevanti”, ed<br />
equivalgono all’estremo superiore delle cinque classi previste per lo stato ecologico (stato<br />
elevato). Nello stato elevato “i valori degli elementi del corpo idrico superficiale devono<br />
rispecchiare quelli <strong>di</strong> norma associati a tale tipo inalterato e non devono evidenziare alcuna<br />
<strong>di</strong>storsione, o <strong>di</strong>storsioni poco rilevanti”.<br />
Il calcolo degli in<strong>di</strong>catori si basa sul confronto tra il valore misurato e il valore atteso nelle<br />
con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> riferimento.<br />
In accordo con le precedenti versioni dell’ISECI, le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> riferimento per gli Elementi<br />
<strong>di</strong> Qualità Biologica della fauna ittica sono:<br />
• tutte le specie in<strong>di</strong>gene attese, comprese quelle endemiche, sono presenti;<br />
• tutte le popolazioni in<strong>di</strong>gene si trovano nella migliore con<strong>di</strong>zione biologica, essendo<br />
ben strutturate in classi d’età, capaci <strong>di</strong> riprodursi naturalmente e con la corretta<br />
consistenza demografica;<br />
• nessuna popolazione in<strong>di</strong>gena risulta ibrida con taxa alloctoni;<br />
• non sono presenti specie aliene.<br />
Vengono poi definite le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> riferimento per ciascuno degli in<strong>di</strong>catori (Zerunian et al.,<br />
2009).<br />
Zonazione dei corsi d’acqua<br />
Secondo l’In<strong>di</strong>ce dello Stato Ecologico delle Comunità Ittiche la comunità ittica in<strong>di</strong>viduata va<br />
sempre confrontata con una comunità ittica attesa.<br />
Per ciascuna stazione <strong>di</strong> campionamento si in<strong>di</strong>vidua in via teorica la comunità ittica attesa,<br />
prendendo come comunità <strong>di</strong> riferimento quelle in<strong>di</strong>viduate da Zerunian et al. (2009) tenendo<br />
conto della <strong>di</strong>stribuzione della specie, <strong>di</strong> tutti i taxa presenti nelle acque interne italiane,<br />
dell’ecologia della specie, del periodo <strong>di</strong> campionamento (Tabella 10).<br />
Ogni zona ha determinate specie <strong>di</strong> riferimento e nell’ambito <strong>di</strong> queste sono in<strong>di</strong>cate anche<br />
le specie endemiche.<br />
TABELLA 10 - ZONE ZOOGEOGRAFICO-ECOLOGICHE FLUVIALI PRINCIPALI INDIVIDUABILI IN ITALIA (ZERUNIAN ET AL, 2009).<br />
ZONE ZOOGEOGRAFICO-<br />
ECOLOGICHE<br />
REGIONE PADANA<br />
REGIONI<br />
I ZONA DEI SALMONIDI<br />
II ZONA DEI CIPRINIDI A DEPOSIZIONE LITOFILA<br />
III ZONA DEI CIPRINIDI A DEPOSIZIONE FITOFILA<br />
REGIONE ITALICO-PENINSULARE<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 138<br />
ZONE ZOOGEOGRAFICO-<br />
ECOLOGICHE<br />
Applicazione dell’ISECI<br />
REGIONI<br />
IV ZONA DEI SALMONIDI<br />
V ZONA DEI CIPRINIDI A DEPOSIZIONE LITOFILA<br />
VI ZONA DEI CIPRINIDI A DEPOSIZIONE FITOFILA<br />
REGIONE DELLE ISOLE<br />
VII ZONA DEI SALMONIDI<br />
VIII ZONA DEI CIPRINIDI A DEPOSIZIONE LITOFILA<br />
IX ZONA DEI CIPRINIDI A DEPOSIZIONE FITOFILA<br />
Il valore dell’ISECI si calcola come somma pesata delle funzioni valore degli in<strong>di</strong>catori<br />
precedentemente descritti (Zerunian et al., 2009).<br />
Le funzioni valore degli in<strong>di</strong>catori descritti nei precedenti paragrafi sono le seguenti:<br />
1. Presenza <strong>di</strong> specie in<strong>di</strong>gene:<br />
2. Con<strong>di</strong>zione biologica della popolazione:<br />
3. Presenza <strong>di</strong> ibri<strong>di</strong>: f3= 0<br />
Assenza <strong>di</strong> ibri<strong>di</strong>: f3= 1<br />
4. Presenza <strong>di</strong> specie aliene:<br />
f4= 0 se sono presenti specie della lista 1, con almeno 1 sp. me<strong>di</strong>amente strutturata;<br />
f4= 0,5 se sono presenti specie della lista 1, con popolazione destrutturata;<br />
f4= 0,5 se sono presenti specie della lista 2, numero specie ≥ 50% del totale specie;<br />
f4= 0,75 se sono presenti specie della lista 2, numero specie < 50% del totale specie;<br />
f4= 0,75 se sono presenti specie della lista 3, numero specie ≥ 50% del totale specie;<br />
f4= 0,85 se sono presenti specie della lista 3, numero specie < 50% del totale specie;<br />
f4= 1 se non sono presenti specie aliene.<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 139<br />
5. Presenza <strong>di</strong> specie endemiche:<br />
Il valore <strong>di</strong> ISECI si ottiene quin<strong>di</strong> dalla seguente formula:<br />
ISECI = F = p1 * (p1,1* v1,1(f1,1) + p1,2 * v1,2(f1,2)) + p2 * ∑ n i=1(p2,i,1*v2,i,1(f2,i,1) + p2,i,2*v2,i,2(f2,i,2)) + p3*<br />
v3(f3) + p4 * v4 (f4) + p5 * v5 (f5)<br />
Infine, è possibile effettuare la conversione dei valori dell’ISECI in 5 classi corrispondenti a<br />
giu<strong>di</strong>zi sintetici che vanno da elevato (classe I) a cattivo (classe V) (Tabella 11).<br />
CLASSI<br />
TABELLA 11 - CLASSIFICAZIONE DELLO STATO DELLA FAUNA ITTICA SECONDO L’ISECI 2009<br />
VALORI<br />
DELL’ISECI<br />
(ZERUNIAN ET AL., 2009).<br />
GIUDIZIO SINTETICO SULLO<br />
STATO ECOLOGICO DELLE<br />
COMUNITÀ ITTICHE<br />
COLORE (PER LA<br />
RAPPRESENTAZIONE<br />
CARTOGRAFICA)<br />
I 0,8
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 140<br />
2.6.4.4.2 Frequenza e stagionalità<br />
Il monitoraggio delle comunità <strong>di</strong> Anfibi deve essere attuato nei perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> riproduzione.<br />
Essendo le specie in<strong>di</strong>cate prevalentemente a strategia monomodale esplosiva, in<br />
particolare i rospi le rane e le raganelle, i monitoraggi dovranno essere effettuati in periodo<br />
primaverile (febbraio-maggio), programmando monitoraggi anche nelle nottate piovose e<br />
nelle giornate piovose. I monitoraggi vanno compiuti settimanalmente nel caso si utilizzino i<br />
retini per catturare gli esemplari, quoti<strong>di</strong>anamente nel caso si utilizzi il metodo barriere e<br />
trappole a caduta.<br />
2.6.4.4.3 Criteri <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduazione e posizionamento delle stazioni <strong>di</strong> campionamento<br />
I siti saranno in<strong>di</strong>viduati attraverso le caratteristiche degli habitat selezionando quelli<br />
connotati da ambienti umi<strong>di</strong> <strong>di</strong> piccole <strong>di</strong>mensioni come laghetti, stagni, pozze, prati umi<strong>di</strong>,<br />
risorgive, ruscelli canali ecc. Dovrà essere in<strong>di</strong>viduata almeno un sito <strong>di</strong> campionamento<br />
significativo (area campione). Tale sito sarà determinato dalla particolare concentrazione <strong>di</strong><br />
specie <strong>di</strong> Anfibi nel periodo riproduttivo.<br />
2.6.4.4.4 Strumentazione per il campionamento<br />
• GPS<br />
• retini e gua<strong>di</strong>ni con manici telescopici e con maglie <strong>di</strong> 0,5 cm<br />
• microfoni e idrofoni<br />
• registratore au<strong>di</strong>o<br />
• barriere <strong>di</strong> Nylon o pannelli in PVC e polipropilene, dell’altezza <strong>di</strong> circa 60 cm, sorretti da<br />
paletti <strong>di</strong> legno e interrati al suolo<br />
• trappole a caduta costituite da coni in PVC <strong>di</strong> 36 cm <strong>di</strong> altezza e <strong>di</strong> 12 cm <strong>di</strong> <strong>di</strong>ametro<br />
massimo<br />
• trappole a caduta costituite da secchi in PVC <strong>di</strong> circa 30 cm <strong>di</strong> altezza e <strong>di</strong> 18-20 cm <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>ametro, con bordo interno rientrante per impe<strong>di</strong>re l’uscita degli animali catturati.<br />
• trappole galleggianti per tritoni<br />
• binocolo<br />
• fotocamera <strong>di</strong>gitale<br />
2.6.4.4.5 Procedura <strong>di</strong> campionamento<br />
METODOLOGIE<br />
Contatti <strong>di</strong>retti<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 141<br />
Si può procedere con la cattura <strong>di</strong>retta sia manualmente che con retino a seguito<br />
dell’avvistamento degli esemplari, oppure “alla cieca” operando con un numero <strong>di</strong> retinate<br />
standard per ogni sito <strong>di</strong> campionamento.<br />
In alcune aree i rilevamenti possono essere effettuati lungo un percorso a transetto<br />
seguendo elementi lineari dell’ecosistema (bor<strong>di</strong> stradali, bor<strong>di</strong> <strong>di</strong> fossi, campi e canali) Tale<br />
metodo prevede la scelta <strong>di</strong> percorsi lineari <strong>di</strong> lunghezza prestabilita contattando gli<br />
esemplari alla destra e alla sinistra del percorso.<br />
Ascolto dei canti riproduttivi sia esterni che subacquei, in entrambi i casi i canti possono<br />
essere registrati. I sopralluoghi vanno effettuati prevalentemente nelle ore notturne.<br />
Cattura me<strong>di</strong>ante trappole<br />
I campionamenti svolti me<strong>di</strong>ante i <strong>di</strong>spositivi con barriere e trappole a caduta (per i Tritoni è<br />
si usano trappole nasse galleggianti per tritoni) permettono <strong>di</strong> ricavare anche riguardanti<br />
l’abbondanza relativa, la ricchezza specifica, la struttura, la fenologia ed evidenziare l’uso<br />
dell’habitat delle comunità batracologiche, grazie a questo metodo è possibile rivelare la<br />
presenza <strong>di</strong> specie rare e molto elusive.<br />
Nel caso dei laghetti si opera con una recinzione completa con barriere. A contatto della<br />
barriera si collocano trappole a caduta, <strong>di</strong> cui circa la metà poste all’esterno le altre<br />
all’interno del recinto, a circa 5 m <strong>di</strong> <strong>di</strong>stanza le une dalle altre. Le trappole a caduta con<br />
bordo interno rientrante per impe<strong>di</strong>re l’uscita degli animali catturati sono in<strong>di</strong>spensabili per la<br />
cattura anche <strong>di</strong> Hyla interme<strong>di</strong>a che grazie a ventose <strong>di</strong>gitali fuoriesce facilmente dalle<br />
trappole costituite da semplici coni. Nel caso dei aree costituite da fossati e prati allagati la<br />
<strong>di</strong>sposizione delle trappole va effettuata con barriera semplice con sviluppo lineare <strong>di</strong><br />
lunghezza variabile. Al termine <strong>di</strong> ogni ciclo <strong>di</strong> campionamento le trappole a caduta sono<br />
chiuse me<strong>di</strong>ante interramento e vengono tolti alcuni pannelli della barriera per consentire la<br />
ripresa del flusso degli animali in entrata ed in uscita dai siti riproduttivi.<br />
Nei siti con i <strong>di</strong>spositivi a trappole a caduta con barriere, ogni mattina, e per tutta la durata<br />
del ciclo <strong>di</strong> campionamento, si verifica la presenza <strong>di</strong> animali all’interno delle trappole.<br />
In<strong>di</strong>vidui investiti<br />
Occorre eseguire, alla mattina, transetti campione lungo le strade e contare gli in<strong>di</strong>vidui<br />
investiti dalle auto.<br />
RACCOLTA DATI<br />
In apposite schede devono essere annotati le specie rilevate, il numero <strong>di</strong> in<strong>di</strong>vidui (se<br />
<strong>di</strong>sponibile) e, nel caso <strong>di</strong> rilievi all’ascolto: tempi <strong>di</strong> ascolto e il numero <strong>di</strong> maschi.<br />
In ciascun sito <strong>di</strong> rilevamento occorre registrare alcuni parametri ambientali quali:<br />
temperatura dell’aria, temperatura dell’acqua, pH e conduttività.<br />
RILASCIO DEGLI ANIMALI<br />
Alla fine delle operazioni descritte gli animali vengono imme<strong>di</strong>atamente rilasciati nel sito <strong>di</strong><br />
campionamento; nei laghetti recintati con barriere continue gli animali catturati nelle trappole<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 142<br />
esterne vengono rilasciati all’interno della pozza mentre gli animali trovati nelle trappole<br />
interne venivano rilasciati all’esterno del <strong>di</strong>spositivo.<br />
Occorre georeferenziare ogni punto <strong>di</strong> cattura (reticolo UTM, Longitu<strong>di</strong>ne e Latitu<strong>di</strong>ne).<br />
2.6.4.4.6 Procedura <strong>di</strong> analisi dei dati/campioni<br />
Tutti i dati raccolti attraverso schede cartacee utilizzate sul campo, dovranno essere riportati<br />
in archivi informatizzati strutturati in fogli elettronici (Excel, Access) che prevedano tutti i<br />
campi <strong>di</strong> acquisizione delle informazioni ottenute sugli esemplari intercettati. Dalle Banche<br />
Dati potranno poi essere elaborate sintesi per l’acquisizione <strong>di</strong> informazioni relative alle<br />
composizioni (struttura delle comunità, specie dominanti, frequenze relative ecc.) e alle<br />
<strong>di</strong>namiche (fenologia, consistenza delle popolazioni) delle comunità <strong>di</strong> Anfibi dei siti<br />
monitorati.<br />
2.6.4.4.7 Analisi ed elaborazione dei dati<br />
I dati ottenuti potranno essere elaborati me<strong>di</strong>ante in<strong>di</strong>ci statistici che possano identificare i<br />
seguenti in<strong>di</strong>catori relativi ai singoli siti <strong>di</strong> campionamento: ricchezza specifica, <strong>di</strong>versità <strong>di</strong><br />
Shannon, equiripartizione o Eveness.<br />
2.6.4.4.8 Modalità <strong>di</strong> georeferenziazione<br />
E’ necessario georeferenziare i siti <strong>di</strong> campionamento me<strong>di</strong>ante uso <strong>di</strong> GPS e vettorializzare<br />
le banche dati per un utilizzo in GIS. È opportuna la sovrapposizione dei dati relativi alle<br />
comunità <strong>di</strong> Anfibi a carte tematiche (reticolo idrografico, carta della vegetazione e dell’uso<br />
reale del suolo, ecc) e foto aeree.<br />
2.6.4.4.9 In<strong>di</strong>viduazione del tecnico incaricato<br />
Personale qualificato, laureato in Scienze Naturali o Biologiche, che presenti un curriculum<br />
attinente, <strong>di</strong> comprovata esperienza e che <strong>di</strong>mostri la professionalità adeguata nelle azioni <strong>di</strong><br />
monitoraggio. Tutte le operazioni che prevedono manipolazione e cattura <strong>di</strong> in<strong>di</strong>vidui devono<br />
essere <strong>di</strong>rette da personale in possesso dei permessi ministeriali<br />
2.6.4.4.10 Note<br />
Manipolazione degli in<strong>di</strong>vidui<br />
La manipolazione degli Anfibi deve avvenire sempre con le mani bagnate, immergendole nel<br />
corpo idrico dal quale vengono catturati, oppure, se catturati <strong>di</strong>stante da corpi idrici occorre<br />
bagnare le mani con acqua priva <strong>di</strong> contaminanti e a temperatura ambiente.<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 143<br />
Tutte le operazioni che prevedono manipolazione e cattura <strong>di</strong> in<strong>di</strong>vidui devono essere<br />
condotte seguendo protocolli volti alla loro tutela sanitaria, si faccia riferimento a tal<br />
proposito ai documenti della Commissione Conservazione della SHI e si adotti rigidamente<br />
“The Declining Amphibian Task Force Fieldwork Code of Practice” redatto dalla Declining<br />
Amphibian Task Force (DAPTF).<br />
2.6.4.5 Rettili (esclusa Emys orbicularis)<br />
2.6.4.5.1 Principali manuali <strong>di</strong> riferimento<br />
Elzinga C., Salzer DW., Willoghby JW., Gibbs JP., 2001. - Monitoring Plant and Animal<br />
Populations. Blackwell Science. Malden MA.<br />
Serra B., Bari A., Capocefalo S., Casotti M., Commodari D., De Marco P., Mammoliti Mochet<br />
A., Morra <strong>di</strong> Cella U., Raineri V., Sardella G., Scalzo G., Tolve E., Trèves C. (E<strong>di</strong>tors) -<br />
Meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> raccolta dati in campo per l’elaborazione <strong>di</strong> in<strong>di</strong>catori <strong>di</strong> bio<strong>di</strong>versità. APAT Agenzia<br />
per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici.<br />
Sutherland W. J. (E<strong>di</strong>tors), 2006 – Ecological Census Techniques. Cambridge University<br />
Press, Cambridge.<br />
2.6.4.5.2 Frequenza e stagionalità<br />
Si consiglia <strong>di</strong> effettuare alcuni cicli <strong>di</strong> monitoraggio durante il periodo <strong>di</strong> attività delle specie<br />
(aprile-settembre) concentrando i monitoraggi nel periodo primaverile e tardo-estivo.<br />
I monitoraggi vanno svolti <strong>di</strong> preferenza durante le ore nelle quali gli animali sono in<br />
termoregolazione: soprattutto nelle ore centrali della giornata, in genere tra le 10 e le 16, in<br />
primavera ed autunno, mentre in estate, a causa delle elevate temperature, possono essere<br />
reperiti all’aperto soprattutto nelle prime ore della giornata e, meno comunemente, nel tardo<br />
pomeriggio.<br />
2.6.4.5.3 Criteri <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduazione e posizionamento delle stazioni <strong>di</strong> campionamento<br />
Si devono in<strong>di</strong>viduare zone a carattere ambientale idonee alle <strong>di</strong>verse specie, avendo cura<br />
<strong>di</strong> monitorare i micro-habitat come i muretti a secco, le pietraie, le pareti rocciose fissurate, i<br />
casolari, i ruderi e i manufatti, le cataste <strong>di</strong> legna e vegetazione, i cespuglieti, ecc., nelle<br />
aree boscose occorre controllare a fondo le zone aperte ed in tutti gli ambienti occorre porre<br />
attenzione alle fasce ecotonali. Non vanno tralasciati i bor<strong>di</strong> delle strade. E’ necessario<br />
effettuare sopralluoghi estesi ai <strong>di</strong>versi siti <strong>di</strong> campionamento per localizzare le popolazioni<br />
da monitorare.<br />
2.6.4.5.4 Strumentazione per il campionamento<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 144<br />
• GPS<br />
• cappi <strong>di</strong> filo da pesca con relative canne telescopiche per la cattura a vista degli animali<br />
• barriere <strong>di</strong> nylon o pannelli in PVC e polipropilene, dell’altezza <strong>di</strong> circa 60 cm,<br />
• pannelli quadrangolari (circa 50x50 cm) <strong>di</strong> <strong>di</strong>verse materie plastiche (nylon, linoleum,<br />
polipropilene, PVC ecc.) e metalliche (lamiere <strong>di</strong> vario spessore)<br />
• guanti alti e robusti<br />
• bastoni con estremità a “Y” o a “L”<br />
• binocolo<br />
• fotocamera <strong>di</strong>gitale<br />
2.6.4.5.5 Procedura <strong>di</strong> campionamento<br />
METODOLOGIE<br />
Contatti <strong>di</strong>retti<br />
Viste le peculiari caratteristiche biologiche e comportamentali dei Rettili è necessario attuare<br />
<strong>di</strong>verse metodologie che comprendano per lo più strumenti <strong>di</strong> cattura a vista come cappi fatti<br />
con filo da pesca sostenuti a mano o da canne telescopiche. Per alcune specie<br />
particolarmente <strong>di</strong>ffidenti e veloci, così come per buona parte dei serpenti, si procede con la<br />
cattura manuale degli in<strong>di</strong>vidui.<br />
Per facilitare il reperimento degli animali è utile collocare a stretto contatto con il suolo<br />
<strong>di</strong>stribuiti nei siti <strong>di</strong> campionamento, i pannelli plastici e metallici che favoriscono la<br />
concentrazione <strong>di</strong> esemplari per il ricovero o la termoregolazione. I pannelli vanno lasciati in<br />
ambiente idoneo e controllati perio<strong>di</strong>camente sollevandoli e ricollocandoli nella stessa<br />
posizione. Analogamente bisogna procedere smuovendo massi, pietre, cataste <strong>di</strong> legna e <strong>di</strong><br />
vegetazione (avendo cura, al termine del controllo, <strong>di</strong> ricollocarli nella stessa posizione).<br />
Molte specie sono in grado <strong>di</strong> arrampicarsi (Lacerti<strong>di</strong> e alcuni Colubri<strong>di</strong>) occorre quin<strong>di</strong><br />
osservare bene muri e tronchi degli alberi.<br />
In alcuni siti i rilevamenti possono essere effettuati lungo un percorso a transetto, specie<br />
lungo le strade e le fasce cespugliate. Tale metodo prevede la scelta <strong>di</strong> percorsi lineari <strong>di</strong><br />
lunghezza prestabilita contattando gli esemplari alla destra e alla sinistra del percorso.<br />
In<strong>di</strong>vidui investiti<br />
Occorre eseguire, in tarda mattinata, transetti campione lungo le strade e contare gli<br />
in<strong>di</strong>vidui investiti dalle auto.<br />
RACCOLTA DATI<br />
In apposite schede devono essere annotati le specie rilevate e il numero <strong>di</strong> in<strong>di</strong>vidui (se<br />
<strong>di</strong>sponibile).<br />
Gli esemplari catturati (con cappi, manualmente o con trappole) vanno identificati, occorre<br />
determinarne il sesso e l’opportuna classe <strong>di</strong> età (giovane, subadulto e adulto.<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 145<br />
Le femmine adulte vanno palpate dolcemente sull’addome in modo tale da valutarne lo stato<br />
riproduttivo (gravide o meno) e l’eventuale numero <strong>di</strong> uova/piccoli in esse contenuti.<br />
RILASCIO DEGLI ANIMALI<br />
Tutti gli in<strong>di</strong>vidui, dopo la raccolta dei dati e la marcatura vanno imme<strong>di</strong>atamente rilasciati<br />
nel preciso sito <strong>di</strong> cattura (così da rispettarne la territorialità). Se si tratta <strong>di</strong> muretti e<br />
manufatti ogni singolo sito <strong>di</strong> presenza <strong>di</strong> in<strong>di</strong>vidui potrà essere contrassegnato con un<br />
simbolo effettuato con vernice spray.<br />
Occorre georeferenziare ogni punto <strong>di</strong> cattura (reticolo UTM, Longitu<strong>di</strong>ne e Latitu<strong>di</strong>ne).<br />
2.6.4.5.6 Procedura <strong>di</strong> analisi dei dati/campioni<br />
Tutti i dati raccolti attraverso schede cartacee utilizzate sul campo, dovranno essere riportati<br />
in archivi informatizzati strutturati in fogli elettronici (Excell, Access) che prevedano tutti i<br />
campi <strong>di</strong> acquisizione delle informazioni ottenute sugli esemplari intercettati. Dalle Banche<br />
Dati potranno poi essere elaborate sintesi per l’acquisizione <strong>di</strong> informazioni relative alla<br />
struttura, alla <strong>di</strong>namica, fenologia e consistenza delle popolazioni.<br />
2.6.4.5.7 Analisi ed elaborazione dei dati<br />
Per le esigenze degli in<strong>di</strong>catori in<strong>di</strong>viduali è sufficiente il calcolo della ricchezza specifica.<br />
2.6.4.5.8 Modalità <strong>di</strong> georeferenziazione<br />
E’ necessario georeferenziare i siti <strong>di</strong> avvistamento degli esemplari me<strong>di</strong>ante uso <strong>di</strong> GPS e<br />
vettorializzare le banche dati per una utilizzo in GIS. È opportuna la sovrapposizione dei dati<br />
relativi alle popolazioni monitorate a carte tematiche (reticolo idrografico, carta della<br />
vegetazione e dell’uso reale del suolo, ecc) e foto aeree.<br />
2.6.4.5.9 In<strong>di</strong>viduazione del tecnico incaricato<br />
Personale qualificato, laureato in Scienze Naturali o Biologiche, che presenti un curriculum<br />
attinente, <strong>di</strong> comprovata esperienza e che <strong>di</strong>mostri la professionalità adeguata nelle azioni <strong>di</strong><br />
monitoraggio. Tutte le operazioni che prevedono manipolazione e cattura <strong>di</strong> in<strong>di</strong>vidui devono<br />
essere <strong>di</strong>rette da personale in possesso dei permessi ministeriali<br />
2.6.4.5.10 Note<br />
Manipolazione degli in<strong>di</strong>vidui<br />
In ogni caso i serpenti vanno sollevati per la coda in modo tale da non danneggiare la<br />
delicata struttura del capo e del collo e, quin<strong>di</strong>, manipolati con tutta l’attenzione necessaria.<br />
Le lucertole invece vanno manipolate avendo cura <strong>di</strong> non provocarne l’autotomia della coda.<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 146<br />
La manipolazione <strong>di</strong> Vipera aspis va condotta con tutte le precauzioni possibili usando<br />
sempre guanti e bloccando gli in<strong>di</strong>vidui con bastoni appositi (facendo sempre attenzione a<br />
non danneggiare gli animali). Solo personale altamente specializzato può essere autorizzato<br />
a compiere tali manipolazioni. Si tenga presente che un occhio inesperto potrebbe<br />
confondere una giovane vipera con altri ofi<strong>di</strong> non velenosi.<br />
Tutte le operazioni che prevedono manipolazione e cattura <strong>di</strong> in<strong>di</strong>vidui devono essere<br />
condotte seguendo protocolli volti alla loro tutela sanitaria, si faccia riferimento a tal<br />
proposito ai documenti della Commissione Conservazione della SHI.<br />
2.6.4.6 Emys orbicularis Linnaeus, 1758<br />
2.6.4.6.1 Manuali <strong>di</strong> riferimento<br />
• Elzinga C., Salzer DW., Willoghby JW., Gibbs JP., 2001 - Monitoring Plant and Animal<br />
Populations. Blackwell Science. Malden MA.<br />
• Serra B., Bari A., Capocefalo S., Casotti M., Commodari D., De Marco P., Mammoliti<br />
Mochet A., Morra <strong>di</strong> Cella U., Raineri V., Sardella G., Scalzo G., Tolve E., Trèves C.<br />
(E<strong>di</strong>tors) - Meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> raccolta dati in campo per l’elaborazione <strong>di</strong> in<strong>di</strong>catori <strong>di</strong> bio<strong>di</strong>versità.<br />
APAT Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici.<br />
• Sutherland W. J. (E<strong>di</strong>tors), 2006 – Ecological Census Techniques. Cambridge University<br />
Press, Cambridge.<br />
• Stubbs, D., Hailey, A., Pulford, E., Tyler, W. (1984): Population ecology of european<br />
tortoises: review of field techniques. Amphibia-Reptilia 5: 57-68.<br />
2.6.4.6.2 Frequenza e stagionalità<br />
I cicli <strong>di</strong> monitoraggio vanno svolti durante il periodo <strong>di</strong> attività delle Testuggini (aprile-<br />
settembre), a partire dal periodo primaverile (aprile-maggio) e in periodo estivo.<br />
2.6.4.6.3 Strumentazione per il campionamento<br />
• GPS<br />
• binocolo<br />
• retino (gua<strong>di</strong>no)<br />
• trappole galleggianti a caduta (atolli) costituite da un quadrilatero <strong>di</strong> 1 m per 0.8 m<br />
formato da tubi in pvc nella cui parte inferiore occorre applicatre una rete da pesca a<br />
maglie <strong>di</strong> 1 cm 2 . appoggiata sopra la cornice galleggiante va posta una passerella <strong>di</strong><br />
compensato larga circa 25 cm con scivoli immersi nell’acqua per facilitare la risalita delle<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 147<br />
Testuggini l’altezza del telaio galleggiante (10 cm) non consente lo scavalcamento,<br />
mentre la rete impe<strong>di</strong>sce loro <strong>di</strong> fuggire sott’acqua.<br />
• nasse, che consistono in un cilindro <strong>di</strong> rete elettrosaldata con maglie <strong>di</strong> 1 cm 2 , lungo<br />
circa 120 cm con <strong>di</strong>ametro <strong>di</strong> 40 cm. alle estremità del cilindro sono fissate con del filo <strong>di</strong><br />
ferro due ellissi <strong>di</strong> rete piegate lungo l’asse minore con aperture lungo la piega con i<br />
bor<strong>di</strong> ripiegati all’interno della nassa in modo da impe<strong>di</strong>re la fuga dell’animale. sulla parte<br />
superiore del cilindro è presente uno sportello per posizionare l’esca (trancio <strong>di</strong> pesce) e<br />
prelevare gli animali catturati, all’interno è presente un filo <strong>di</strong> ferro utilizzato per fissare<br />
l’esca. per consentire il galleggiamento, sono fissate lateralmente al cilindro <strong>di</strong> rete 3 o 4<br />
corpi galleggianti (ad es. bottiglie <strong>di</strong> plastica vuote chiuse ermeticamente).<br />
• calibro<br />
• bilancia<br />
2.6.4.6.4 Procedura <strong>di</strong> campionamento<br />
METODOLOGIA<br />
Contatto <strong>di</strong>retto<br />
Può avvenire sia campionando i singoli siti o habitat conteggiando a occhio nudo o con<br />
binocolo gli in<strong>di</strong>vidui, che seguendo transetti <strong>di</strong> lunghezza prestabilita (linear transect<br />
censuses, LTC), i transetti sono costituiti da strade o sentieri che costeggiano i corpi<br />
d’acqua, le Testuggini contattate a destra e a sinistra sono conteggiate a occhio nudo o con<br />
binocolo.<br />
In entrambi i casi si può procedere catturando a mano o con retino gli esemplari contattati.<br />
Cattura me<strong>di</strong>ante trappole<br />
Si possono usare trappole ad atollo o nasse. Le trappole galleggianti a caduta (atolli) vanno<br />
collocate in zone centrali <strong>di</strong> laghi e stagni lontane da punti naturali <strong>di</strong> emersione e approdo<br />
delle Testuggini. Le passerelle degli atolli costituiscono punti <strong>di</strong> appoggio per l’attività <strong>di</strong><br />
basking dai quali la Testuggine in termoregolazione, quando si sente minacciata, si getta in<br />
acqua cadendo all’interno della trappola.<br />
Le nasse devono essere messe a <strong>di</strong>mora legandole tra <strong>di</strong> loro ad una <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> circa 2 m e<br />
fissate a due estremità per impe<strong>di</strong>re il movimento.<br />
Gli atolli e le nasse devono rimanere attivi per i perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> monitoraggio e vanno controllati<br />
quoti<strong>di</strong>anamente.<br />
Marcatura<br />
Il sistema <strong>di</strong> marcatura da usare è quello proposto da Stubbs che prevede l’incisione delle<br />
placche marginali del carapace. Ciascuna placca corrisponde ad un numero e dalla<br />
combinazione <strong>di</strong> più placche si ottengono i co<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> riconoscimentio.<br />
Gli in<strong>di</strong>vidui vanno sempre rilasciati nello stesso punto <strong>di</strong> ritrovamento.<br />
RACCOLTA DATI<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 148<br />
Occorre rilevare il tipo <strong>di</strong> attività osservato al momento del contatto dell’animale.<br />
Dopo la cattura gli in<strong>di</strong>vidui vengono pesati e misurati, se ne determina sesso ed età; le<br />
misure sono: la lunghezza e la larghezza lineare del carapace e del piastrone, l’altezza dello<br />
scudo, le larghezze delle placche del carapace e del piastrone, della testa e della coda.<br />
Per quanto riguarda i dati da raccogliere durante i linear transect censuses si veda “Analisi<br />
ed elaborazione dei dati”.<br />
Occorre georeferenziare ogni punto <strong>di</strong> cattura (reticolo UTM, Longitu<strong>di</strong>ne e Latitu<strong>di</strong>ne)..<br />
RILASCIO DEGLI ANIMALI<br />
Tutti gli in<strong>di</strong>vidui, dopo la raccolta dei dati e la marcatura vanno imme<strong>di</strong>atamente rilasciati nel<br />
preciso sito <strong>di</strong> cattura (così da rispettarne la territorialità).<br />
2.6.4.6.5 Procedura <strong>di</strong> analisi dei dati/campioni<br />
Tutti i dati raccolti attraverso schede cartacee utilizzate sul campo, dovranno essere riportati<br />
in archivi informatizzati strutturati in fogli elettronici (Excell, Access) che prevedano tutti i<br />
campi <strong>di</strong> acquisizione delle informazioni ottenute sugli esemplari intercettati. Dalle Banche<br />
Dati potranno poi essere elaborate sintesi per l’acquisizione <strong>di</strong> informazioni relative alla<br />
struttura, alla <strong>di</strong>namica, fenologia e consistenza delle popolazioni <strong>di</strong> Testuggine acquatica.<br />
2.6.4.6.6 Analisi ed elaborazione dei dati<br />
Me<strong>di</strong>ante il metodo <strong>di</strong> cattura marcatura e ricattura (CMR) si stima la densità, si analizza la<br />
biometria, l’eco-etologia, la demografia e la <strong>di</strong>namica <strong>di</strong> popolazione.<br />
Per lo stu<strong>di</strong>o demografico e <strong>di</strong> <strong>di</strong>namica <strong>di</strong> popolazione si applica il modello per popolazioni<br />
aperte (Comark-Jolly-Seber). La stima della densità della popolazione si effettua applicando<br />
l'in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> Jolly-Seber utilizzato per popolazioni aperte, si può anche utilizzare il metodo<br />
Shnabel impiegato per popolazioni chiuse.<br />
I dati raccolti sono analizzati me<strong>di</strong>ante l’utilizzo <strong>di</strong> software.<br />
Per la stima della popolazione ci si avvale del metodo delle osservazioni rilevate in transetti<br />
con censimenti su percorso lineare (linear transect censuses, LTC). Il metodo prevede <strong>di</strong><br />
tracciare uno o più percorsi all’interno dell’area interessata dallo stu<strong>di</strong>o, <strong>di</strong> percor<strong>rer</strong>e i<br />
transetti a velocità ridotta e costante in modo tale da poter osservare tutti gli animali presenti<br />
sul percorso, <strong>di</strong> calcolare le <strong>di</strong>stanze (R) in linea d’aria tra l’osservatore e gli animali e gli<br />
angoli (α e α’) formati dalle rette osservatore-Testuggini rispetto alla <strong>di</strong>rezione del percorso.<br />
La <strong>di</strong>stanza perpen<strong>di</strong>colare tra le singole osservazioni e la linea del percorso si calcola<br />
secondo l’espressione: x = R sen α. La densità della popolazione si effettua utilizzando<br />
l’equazione: D = n/2*L*X, dove: D = densità stimata per unità <strong>di</strong> area; n = numero totale <strong>di</strong><br />
osservazione; X = me<strong>di</strong>a delle <strong>di</strong>stanze perpen<strong>di</strong>colari; L = lunghezza totale del percorso<br />
lineare. Nell’applicazione <strong>di</strong> questa meto<strong>di</strong>ca <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o si assume che tutte le osservazioni<br />
degli animali siano effettuate in posizione perpen<strong>di</strong>colare al tracciato (α=90°). I limiti fiduciali<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 149<br />
entro i quali varia D (P=95%) sono D±1,96*S, dove S 2 (varianza teorica <strong>di</strong> D) = D 2 /n*2*(n-1)/<br />
(n-2) – n/ (D*A) e A è l’area totale occupata dalla popolazione.<br />
2.6.4.6.7 In<strong>di</strong>viduazione del tecnico incaricato<br />
Personale qualificato, laureato in Scienze Naturali o Biologiche, che presenti un curriculum<br />
attinente, <strong>di</strong> comprovata esperienza e che <strong>di</strong>mostri la professionalità adeguata nelle azioni <strong>di</strong><br />
monitoraggio. Tutte le operazioni che prevedono manipolazione e cattura <strong>di</strong> in<strong>di</strong>vidui devono<br />
essere <strong>di</strong>rette da personale in possesso dei permessi ministeriali<br />
2.6.4.6.8 Modalità <strong>di</strong> georeferenziazione<br />
E’ necessario georeferenziare i siti <strong>di</strong> avvistamento degli esemplari me<strong>di</strong>ante uso <strong>di</strong> GPS e<br />
vettorializzare le banche dati per una utilizzo in GIS. È opportuna la sovrapposizione dei dati<br />
relativi alle popolazioni monitorate a carte tematiche (reticolo idrografico, carta della<br />
vegetazione e dell’uso reale del suolo, ecc) e foto aeree.<br />
2.6.4.6.9 Note<br />
Manipolazione degli in<strong>di</strong>vidui<br />
Tutte le operazioni che prevedono manipolazione e cattura <strong>di</strong> in<strong>di</strong>vidui devono essere<br />
condotte seguendo protocolli volti alla loro tutela sanitaria, si faccia riferimento a tal<br />
proposito ai documenti della Commissione Conservazione della SHI.<br />
2.6.4.7 Uccelli<br />
Il popolamento ni<strong>di</strong>ficante sarà monitorato ad ogni stagione riproduttiva. Il metodo utilizzato<br />
per il rilevamento dell’avifauna sarà quello delle stazioni d’ascolto. (Blondel et al. 1970).<br />
Il metodo, consiste nel rilevare a vista o al canto tutti gli uccelli ni<strong>di</strong>ficanti in una data area,<br />
da stazioni <strong>di</strong> rilevamento <strong>di</strong>stribuite sul territorio, per un tempo complessivo <strong>di</strong> 10 minuti.<br />
I rilevamenti quantitativi saranno eseguiti per due volte in ogni stagione riproduttiva (per<br />
rilevare ni<strong>di</strong>ficanti precoci e tar<strong>di</strong>vi) e ripetuti negli anni.<br />
I rilevamenti saranno effettuati nel periodo 1 marzo – 30 giugno. La prima serie <strong>di</strong> rilevamenti<br />
sarà centrata attorno al 15 marzo; la seconda serie attorno al 30 aprile <strong>di</strong> ogni anno.<br />
I rilevamenti saranno effettuati all'alba e nelle prime ore del mattino (dalle 5 alle 10), quando<br />
massima è l'attività canora e nelle giornate con con<strong>di</strong>zioni atmosferiche favorevoli (prive <strong>di</strong><br />
vento e <strong>di</strong> precipitazioni atmosferiche).<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 150<br />
Per convenzione, e ai fini della quantificazione, alle osservazioni sarà attribuito un<br />
punteggio:<br />
1 punto = in<strong>di</strong>vidui in canto, attività riproduttiva, gruppo famigliare, coppia,<br />
0,5 punti = in<strong>di</strong>vidui osservati senza alcun in<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> attività riproduttiva.<br />
Al termine delle elaborazioni, si otterrà per ciascuna specie, una abbondanza relativa<br />
espressa in numero <strong>di</strong> coppie per punto <strong>di</strong> rilevamento.<br />
Al termine <strong>di</strong> ogni stagione riproduttiva si avranno, per ogni punto, una lista <strong>di</strong> specie col<br />
relativo valore <strong>di</strong> abbondanza: l'in<strong>di</strong>ce puntiforme <strong>di</strong> abbondanza (I.P.A.) per una particolare<br />
specie, per quella stazione e per quella stagione riproduttiva.<br />
Al termine del lavoro sul campo, oltre al valore IPA, si otterrà per ogni specie, un valore <strong>di</strong><br />
frequenza calcolato come percentuale delle unità <strong>di</strong> rilevamento in cui la specie è stata<br />
registrata. Le frequenze delle specie così ottenute, si possono comparare, in ambienti<br />
<strong>di</strong>versi, e in anni <strong>di</strong>versi con appropriati test statistici. Inoltre, in base al risultato <strong>di</strong> Blondel<br />
(1975), confermato su basi teoriche da Frelin (1982), è possibile, almeno a densità<br />
interme<strong>di</strong>e, considerare le frequenze come buoni in<strong>di</strong>catori <strong>di</strong> abbondanza, dal momento che<br />
esse sono altamente correlate al logaritmo delle abbondanze. Il presente risultato consente<br />
<strong>di</strong> calcolare, sulla base delle frequenze, i numerosi parametri ed in<strong>di</strong>ci che solitamente si<br />
utilizzano negli stu<strong>di</strong> sulla composizione e sulla struttura delle comunità ornitiche e che<br />
saranno <strong>di</strong> grande utilità nella <strong>di</strong>agnosi ecologico-ambientale del Sito Natura 2000 e per le<br />
valutazioni delle popolazioni delle singole specie componenti il popolamento.<br />
2.6.4.8 Mammiferi non Chirotteri<br />
2.6.4.8.1 Monitoraggio degli in<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> presenza su percorsi campione<br />
Per le specie Martes foina e Hystrix cristata viene proposto il metodo della ricerca <strong>di</strong> in<strong>di</strong>ci <strong>di</strong><br />
presenza su percorsi campione. Il rilevatore si muove lungo un transetto prefissato e conta e<br />
georeferenzia tutti i segni <strong>di</strong> presenza avvistati, (feci, impronte, pellets, avvistamenti <strong>di</strong>retti<br />
ecc.) compilando una apposita scheda <strong>di</strong> campo. I transetti devono essere in<strong>di</strong>viduati in<br />
modo il più possibile casuale; alternativamente, è possibile in<strong>di</strong>viduare i transetti in modo<br />
sistematico nell’area <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o, per coprire in maniera rappresentativa l’area stessa. Un unico<br />
transetto <strong>di</strong> lunghezza predefinita può essere sostituito da più transetti piccoli (sezioni <strong>di</strong><br />
transetto), la cui lunghezza complessiva sia uguale a quella del transetto iniziale. Nei<br />
transetti in<strong>di</strong>viduati nelle parcelle <strong>di</strong> monitoraggio potrà essere valutato se posizionare<br />
trappole per pelo e fototrappole (Multiple detection methods). Il metodo è <strong>di</strong> facile<br />
applicabilità e ripetibilità, inoltre più specie possono essere contattate contemporaneamente,<br />
massimizzando lo sforzo <strong>di</strong> campionamento, in previsione <strong>di</strong> una ripetizione costante nel<br />
tempo.<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 151<br />
Il transetto sarà posizionato nelle parcelle <strong>di</strong> monitoraggio in<strong>di</strong>viduate con il metodo descritto<br />
per la parte generale, si prevede <strong>di</strong> effettuare una campagna <strong>di</strong> rilevo (“one-season”) durante<br />
il periodo <strong>di</strong> maggior contattabilità delle specie, in<strong>di</strong>cativamente tra aprile e giugno , con due<br />
ripetizioni (k=2).<br />
2.6.4.8.2 Hair-tubes<br />
Per le specie Myoxis glis e Muscar<strong>di</strong>nus avellanarius viene proposto il monitoraggio tramite<br />
hair-tube, che possono essere impiegati per il monitoraggio <strong>di</strong> Sciuri<strong>di</strong>, Gliri<strong>di</strong> (ghiro,<br />
moscar<strong>di</strong>no) e il topolino delle risaie. Il monitoraggio con hair-tube rappresenta una tecnica<br />
spe<strong>di</strong>tiva che prevede la preparazione, il posizionamento e il controllo <strong>di</strong> tubi in PVC per la<br />
raccolta <strong>di</strong> campioni <strong>di</strong> pelo. Per il monitoraggio si utilizzeranno tubi della lunghezza <strong>di</strong> circa<br />
30 cm e del <strong>di</strong>ametro <strong>di</strong> 6-3 cm (per sciuri<strong>di</strong>/gliri<strong>di</strong> e per il topolino delle risaie). Alle due<br />
estremità del tubo verranno posizionate delle placche in gomma sulle quali si applica una<br />
striscia <strong>di</strong> biadesivo <strong>di</strong> 3 cm <strong>di</strong> larghezza e 5 cm <strong>di</strong> lunghezza, che ha la funzione <strong>di</strong><br />
trattenere i peli dell’animale quando questo entra nel tubo per cibarsi dell’esca posta al suo<br />
interno. Le trappole così preparate saranno collocate lungo transetti lineari, in<strong>di</strong>cativamente<br />
15 hair-tube, <strong>di</strong>stanziati fra i 50 m per quercino e i 25 m per moscar<strong>di</strong>no. Ogni hair-tube sarà<br />
fissato ai rami <strong>di</strong> vegetazione arbustiva per contattare quercino e moscar<strong>di</strong>no, con filo da<br />
giar<strong>di</strong>niere in anima metallica e innescato con semi <strong>di</strong> girasole e nocciole. Le coor<strong>di</strong>nate<br />
della posizione <strong>di</strong> ogni hair-tube verranno georeferenziate tramite l’utilizzo <strong>di</strong> un GPS. Il<br />
controllo perio<strong>di</strong>co delle placche adesive e l’analisi del pelo trattenuto dal nastro adesivo<br />
permetterà <strong>di</strong> determinare la specie che ha frequentato la trappola. Le 2 placche rimosse da<br />
ciascun hair-tube devono essere conservate unendole in modo da avere la parte recante i<br />
peli rivolta verso l’esterno; successivamente i campioni vengono protetti con apposite<br />
pellicole, inseriti in buste e conservati in luogo asciutto. Nel caso in cui non sia possibile<br />
determinare i peli rinvenuti sulle placche in base alle loro caratteristiche macro-morfologiche<br />
(lunghezza e colore del pelo, Teerink, 1991), si procede ad ulteriori analisi <strong>di</strong> laboratorio; in<br />
questo caso i peli vengono estratti dalle placche me<strong>di</strong>ante xilolo, <strong>di</strong>sidratati con lavaggio in<br />
acetone e, successivamente, inclusi in resina epossi<strong>di</strong>ca. I campioni così ottenuti possono<br />
essere sezionati al microtomo e osservati al microscopio ottico per la determinazione, sulla<br />
base <strong>di</strong> caratteri micromorfologici (forma della medulla e delle scaglie cuticolari, Teerink,<br />
1991).<br />
Il transetto sarà posizionato nelle parcelle <strong>di</strong> monitoraggio in<strong>di</strong>viduate con il metodo descritto<br />
per la parte generale, si prevede <strong>di</strong> effettuare una campagna <strong>di</strong> rilevo (“one-season”),<br />
durante il periodo <strong>di</strong> maggior contattabilità delle specie, in primavera da maggio a giugno ,<br />
con tre ripetizioni (k=3), controllando gli hair-tube a 15, 30, 45 giorni dall’innesco.<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 152<br />
2.6.4.8.3 Trappole a caduta<br />
Per le specie Crocidura leucodon, Sorex samniticus, Talpa caeca e Talpa europaea, si<br />
propone <strong>di</strong> effettuare catture me<strong>di</strong>ante pit-fall a vivo, costituite da contenitori con profon<strong>di</strong>tà<br />
<strong>di</strong> almeno 30 cm e <strong>di</strong>ametro <strong>di</strong> almeno 10 cm, che non prevede l’uccisione degli in<strong>di</strong>vidui<br />
catturati, offre la possibilità <strong>di</strong> effettuare catture multiple (all’interno della stessa trappola), ha<br />
un impatto sulla popolazione quasi nullo e, a fronte <strong>di</strong> un costo relativamente contenuto, ha<br />
una <strong>di</strong>screta efficienza <strong>di</strong> cattura. È peraltro necessario un maggiore sforzo in termini <strong>di</strong><br />
numero <strong>di</strong> controlli delle trappole, in quanto occorre effettuare controlli ravvicinati nel tempo<br />
(3-4 volte al giorno), per evitare il decesso degli animali. Inoltre ad una parziale impegno <strong>di</strong><br />
posizionamento iniziale, corrisponde un più facile controllo per le ripetizioni successive, in<br />
quanto le trappole possono, se opportunamente occultate e inattivate, essere lasciate in situ.<br />
Al momento della posa ciascuna trappola viene innescata, dopo averne riempito<br />
parzialmente l’interno con cotone idrofilo, in modo da creare un ambiente favorevole alla<br />
sopravvivenza dell’animale catturato. Per la marcatura temporanea si ricor<strong>rer</strong>à alla rasatura<br />
del pelo o colorazione<br />
Si propone <strong>di</strong> <strong>di</strong>sporre le trappole lungo transetto, in quanto , data la natura del dato da<br />
raccogliere e dei modelli utilizzati per l’analisi, non è necessario che lo schema <strong>di</strong><br />
trappolaggio sia riferibile ad una superficie, e richiede tempi <strong>di</strong> allestimento più brevi. Le<br />
trappole rimarranno innescate per 3 giorni <strong>di</strong> cattura, cui deve essere aggiunto il tempo<br />
necessario per il pre-baiting, per complessivi 4 giorni.<br />
Il transetto sarà posizionato nelle parcelle <strong>di</strong> monitoraggio in<strong>di</strong>viduate con il metodo descritto<br />
per la parte generale, si prevede <strong>di</strong> effettuare una campagna <strong>di</strong> rilevo (“one-season”),<br />
durante il periodo <strong>di</strong> maggior contattabilità delle specie a maggio e giugno per gli insettivori.<br />
2.6.4.9 Chirotteri<br />
2.6.4.9.1 Protocolli standar<strong>di</strong>zzati a livello locale, nazionale o internazionale <strong>di</strong> riferimento<br />
Agnelli P., A. Martinoli, E. Patriarca, D. Russo, D. Scaravelli and P. Genovesi (E<strong>di</strong>tors),<br />
2006. Guidelines for bat monitoring: methods for the study and conservation of bats in Italy.<br />
Quad. Cons. Natura, 19, Min. Ambiente – Ist. Naz. Fauna Selvatica, Rome and Ozzano<br />
dellEmilia (<strong>Bologna</strong>), Italy. Tipolitografia FG, Savigno sul Panaro, Modena, pp. 199.<br />
Agnelli P., Biscar<strong>di</strong> S., Don<strong>di</strong>ni G., Vergari S., 2001. “Progetto per il monitoraggio dello stato<br />
<strong>di</strong> conservazione <strong>di</strong> alcune specie <strong>di</strong> Chirotteri” pagg. 34-113. In: Lovari S. (a cura <strong>di</strong>);<br />
Progetto <strong>di</strong> monitoraggio dello stato <strong>di</strong> conservazione <strong>di</strong> alcuni Mammiferi particolarmente a<br />
rischio della fauna italiana. Relazione al Ministero dell’Ambiente, Servizio Conservazione<br />
della Natura – Roma; pp. 481.<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 153<br />
2.6.4.9.2 Frequenza e stagionalità<br />
È opportuno effettuare i monitoraggi in due <strong>di</strong>stinti perio<strong>di</strong> dell’anno: uno durante la buona<br />
stagione (in tarda primavera-inizio estate) e uno in tardo autunno-inverno. Nel caso specifico<br />
<strong>di</strong> monitoraggio dei rifugi, sono assolutamente da evitare frequenze <strong>di</strong> monitoraggio maggiori<br />
<strong>di</strong> due all’anno, per evitare eccessivo <strong>di</strong>sturbo e il rischio <strong>di</strong> abbandono dei rifugi stessi. In<br />
particolare, le colonie riproduttive vanno visitate entro maggio, cioè nel periodo <strong>di</strong> formazione<br />
delle nursery e prima della nascita dei piccoli, oppure dopo la metà <strong>di</strong> luglio quando i giovani<br />
sono ormai in grado <strong>di</strong> volare. I siti <strong>di</strong> svernamento invece vanno visitati a fine autunno per<br />
evitare agli animali un eccessivo <strong>di</strong>spen<strong>di</strong>o energetico nel caso che la visita gli induca ad un<br />
risveglio forzato.<br />
2.6.4.9.3 Criteri <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduazione e posizionamento delle stazioni <strong>di</strong> campionamento<br />
Le esigenze ecologiche dei pipistrelli variano parecchio durante il giorno e durante l’anno,<br />
mentre la grande varietà <strong>di</strong> specie si riflette in un ampia <strong>di</strong>versità <strong>di</strong> ambienti frequentati da<br />
questi animali. Per riuscire a rilevare tutte le specie presenti occorre allora adottare <strong>di</strong>verse<br />
tecniche <strong>di</strong> indagine. Per quanto riguarda il campionamento si possono in<strong>di</strong>viduare due<br />
<strong>di</strong>verse tipologie:<br />
1 - ai rifugi (come nursery e colonie <strong>di</strong> svernamento), per il monitoraggio <strong>di</strong>retto degli animali<br />
e la raccolta <strong>di</strong> serie storiche <strong>di</strong> dati, data la notevole fedeltà degli animali ai rifugi. Le<br />
nursery e le colonie <strong>di</strong> svernamento sono generalmente localizzate in siti <strong>di</strong>versi.<br />
Due sono le principali tipologie <strong>di</strong> rifugio da ricercare: costruzioni antropiche e cavità<br />
sotterranee. Tale ricerca deve essere condotta sul territorio del SIC dove siano presenti tali<br />
tipologie <strong>di</strong> rifugio. Un’ulteriore tipologia riguarda i rifugi in cavi degli alberi e deve essere<br />
condotta in aree boscate, preferibilmente caratterizzate dalla presenza <strong>di</strong> alberi maturi.<br />
2 – presso le aree <strong>di</strong> foraggiamento/abbeverata (lungo corsi d'acqua a scorrimento laminare<br />
o presso raccolte d'acqua come pozze, stagni ecc.) per consentire il monitoraggio anche per<br />
quelle specie per le quali non si conoscono siti coloniali. Campionando in ambienti <strong>di</strong>versi è<br />
possibile rilevare tutte le specie presenti (seppur con tempi e modalità <strong>di</strong>stinte).<br />
Per la localizzazione delle stazioni <strong>di</strong> campionamento notturno presso i siti <strong>di</strong> foraggiamento<br />
occorre tenere presente che la maggioranza delle specie si alimenta in un raggio massimo <strong>di</strong><br />
circa 5 km dal rifugio, quin<strong>di</strong> la programmazione <strong>di</strong> campionamenti mirati al rilevamento della<br />
chirotterofauna <strong>di</strong> un SIC deve prevedere una <strong>di</strong>stanza massima tra le stazioni <strong>di</strong> non più <strong>di</strong><br />
9 km.<br />
2.6.4.9.4 Strumentazione per il campionamento<br />
- I campionamenti ai rifugi in<strong>di</strong>viduati dovranno essere effettuati all’esterno del rifugio stesso<br />
me<strong>di</strong>ante registrazione con termocamera o con hand-camera sensibile ai bassi livelli <strong>di</strong><br />
luminosità, in modo da poter rilevare gli animali durante l'involo dal rifugio dopo il tramonto.<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 154<br />
Questa tecnica è applicabile nel caso in cui le specie che si intendono monitorare siano già<br />
state determinate a livello tassonomico e si intenda effettuare un conteggio delle stesse. Nel<br />
caso invece che le specie presso il rifugio non siano ancora state determinate, occor<strong>rer</strong>à<br />
procedere ad una rapida ispezione <strong>di</strong>urna nel rifugio per la determinazione <strong>di</strong>retta delle<br />
specie, oppure, nel caso <strong>di</strong> specie non determinabili a vista, con catture me<strong>di</strong>ante harp trap<br />
o reti mistnet posizionate all'uscita del roost al tramonto. Il ricorso a quest’ultima tecnica per<br />
le regolari operazioni <strong>di</strong> conteggio è assolutamente da evitare per l’eccessivo <strong>di</strong>sturbo e il<br />
concreto rischio <strong>di</strong> abbandono del rifugio da parte della colonia. Nel caso <strong>di</strong> rifugi occupati da<br />
uno o da pochi animali, è possibile utilizzare un retino a mano, all’interno del rifugio stesso.<br />
In genere risultano idonei i retini per Lepidotteri (meglio se dotati <strong>di</strong> manico telescopico) che<br />
evitano che l’animale si impigli; vanno assolutamente evitati i retini da pesca. Un chirottero<br />
così catturato va prontamente rimosso dal retino. Quando l’animale vi entra, l’attrezzo andrà<br />
subito ruotato <strong>di</strong> 90°, ponendo la superficie <strong>di</strong> cat tura in posizione verticale, così da chiudere<br />
l’apertura e imprigionare il chirottero. Dopo<strong>di</strong>ché è in genere conveniente poggiare il retino<br />
su un piano orizzontale, ad es. al suolo, e introdurre una mano nel sacco per estrarre<br />
l’animale. Il retino deve essere utilizzato per catturare esemplari statici e non chirotteri in<br />
volo, nonostante ciò sia tecnicamente possibile: infatti, se l’animale impatta contro le parti<br />
dure dell’attrezzo può ferirsi seriamente o morirne. Se nel rifugio sono presenti più <strong>di</strong> 5<br />
esemplari, il <strong>di</strong>sturbo originato dalla cattura <strong>di</strong> un esemplare ha un impatto eccessivo sulla<br />
colonia e deve essere evitato.<br />
Rilevare i rifugi delle specie fitofile (ad es. le specie del genere Nyctalus e Barbastella,<br />
M.bechsteinii e P.nathusii) è quanto mai improbabile, a causa della enorme <strong>di</strong>fficoltà<br />
nell’in<strong>di</strong>viduare le piccole cavità nascoste in alcuni alberi del bosco. Risulta allora utile<br />
installare dei rifugi artificiali (bat box) che una volta colonizzati da queste specie, sono<br />
facilmente ispezionabili. Esistono vari modelli <strong>di</strong> bat box, i più adatti e pratici per le aree<br />
boscate sono <strong>di</strong> due tipi: quelli a barilotto (i più <strong>di</strong>ffusi sono quelli prodotti dalla <strong>di</strong>tta<br />
Schwegler) e quelli a cassetta (come quelli ultimamente <strong>di</strong>stribuiti in Italia dalla nota catena<br />
<strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione COOP, per conto del Museo <strong>di</strong> Storia Naturale <strong>di</strong> Firenze). Buoni risultati si<br />
ottengono installando gruppi <strong>di</strong> una decina <strong>di</strong> bat box (<strong>di</strong>stanti tra loro 20-30 m) ogni 2 km<br />
circa in ambienti boscati. Se nel bosco ci sono alberi maturi, e quin<strong>di</strong> sono già presenti<br />
anche le specie che li frequentano, le probabilità <strong>di</strong> colonizzazione <strong>di</strong> questi rifugi artificiali<br />
ovviamente aumentano. Occorre considerare che a quote inferiori ai 900-1000 m le bat box<br />
a barilotto non sono in<strong>di</strong>cate perché spesso vengono occupate prima da cincie, ghiri,<br />
moscar<strong>di</strong>ni, calabroni o formiche. I tempi <strong>di</strong> colonizzazione dei rifugi artificiali per chirotteri<br />
sono quanto mai vari e vanno da pochi giorni a tre anni; passato questo più lungo periodo<br />
conviene spostare la bat box in un luogo più favorevole.<br />
- I campionamenti presso le aree <strong>di</strong> foraggiamento/abbeverata dovranno essere effettuati<br />
me<strong>di</strong>ante cattura con reti mistnet. Si tratta <strong>di</strong> reti <strong>di</strong> nylon o <strong>di</strong> terilene, dello spessore <strong>di</strong> 50 o<br />
70 denier (denier = massa in grammi <strong>di</strong> 9.000 m <strong>di</strong> fibra). La <strong>di</strong>mensione delle maglie<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 155<br />
(misurata tra due vertici opposti) è in genere <strong>di</strong> 32-38 mm. Si tenga presente che per la<br />
cattura e la manipolazione dei pipistrelli occorre sempre un permesso <strong>di</strong> cattura rilasciato<br />
dalla Regione o dalla <strong>Provincia</strong>, sentito il pa<strong>rer</strong>e dell'ISPRA e del Ministero Ambiente).<br />
Esistono reti <strong>di</strong> <strong>di</strong>versa lunghezza, si suggerisce <strong>di</strong> usare quelle <strong>di</strong> lunghezza 6, 9, 12 e 18 m<br />
a seconda delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> cattura. L’altezza è generalmente <strong>di</strong> 2-2,6 m. Quando un<br />
chirottero in volo si scontra con la rete, viene catturato in quanto cade all’interno <strong>di</strong> una delle<br />
tasche, aperta dall’impatto. La rete, allestita in campo per la cattura deve essere sostenuta<br />
da due pali (meglio se telescopici) posti verticalmente, ai quali viene assicurata attraverso<br />
alcuni anelli <strong>di</strong> cotone o nylon posti lungo i lati verticali. I pali possono essere retti da corde<br />
fissate al suolo con picchetti o assicurate a massi, alberi, ecc.<br />
Molto utilizzata in questi ultimi anni la tecnica della identificazione acustica dei chirotteri<br />
tramite rilevatore <strong>di</strong> ultrasuoni, il bat-detector. Si tenga presente però che questa tecnica <strong>di</strong><br />
monitoraggio pur essendo efficace in talune situazioni necessita <strong>di</strong> personale altamente<br />
specializzato, in particolare nelle fasi <strong>di</strong> analisi delle registrazioni, e che in molti casi non<br />
permette un riconoscimento certo a livello <strong>di</strong> specie. I bat-detector professionali sono solo<br />
quelli che utilizzano un sistema <strong>di</strong> trasformazione del segnale ultrasonico definito Time<br />
expansion perché permette l’analisi dettagliata del segnale senza <strong>di</strong>storsioni. Elaborazioni <strong>di</strong><br />
tipo Etero<strong>di</strong>nico o a Divisione <strong>di</strong> frequenza sono utilizzabili solo <strong>di</strong> complemento al Time<br />
expansion o per semplici scopi <strong>di</strong>vulgativi. Per ulteriori informazioni sull’uso del bat-detector<br />
si veda Agnelli et al., 2006.<br />
2.6.4.9.5 Procedura <strong>di</strong> campionamento<br />
• selezione dei siti <strong>di</strong> campionamento idonei (siti <strong>di</strong> rifugio e/o aree <strong>di</strong> foraggiamento e<br />
abbeverata). La scelta delle stazioni deve essere messa in relazione ad eventuali rifugi<br />
già conosciuti in zona e alla massima <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> spostamento delle specie<br />
presumibilmente presenti<br />
• scelta delle opportune tecniche <strong>di</strong> campionamento<br />
• attuazione dei monitoraggi e raccolta dei soli dati <strong>di</strong> maggiore importanza (la raccolta <strong>di</strong><br />
dati <strong>di</strong> maggior dettaglio comporterebbe la necessità <strong>di</strong> catturare gli esemplari con<br />
conseguente eccessivo <strong>di</strong>sturbo):<br />
o Data e ora del rilievo<br />
o Informazioni geografiche sulla stazione <strong>di</strong> rilevamento<br />
o Coor<strong>di</strong>nate GPS<br />
o Tipologia del rifugio/area foraggiamento<br />
o Specie rilevate e conteggio/stima del numero <strong>di</strong> in<strong>di</strong>vidui per specie<br />
o Eventuali fattori che minacciano il rifugio<br />
o Rilevatore<br />
o Ruolo biologico del rifugio (riproduttivo, <strong>di</strong> accoppiamento, <strong>di</strong> svernamento)<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 156<br />
o Metodo utilizzato per il censimento<br />
• analisi dei dati e stime quantitative (densità o abbondanza relativa)<br />
2.6.4.9.6 Procedura <strong>di</strong> analisi dei dati/campioni<br />
Archiviazione in un database <strong>di</strong> tutti i dati legati al sito <strong>di</strong> campionamento ed alle specie<br />
rilevate (come da punto precedente), ve<strong>di</strong> anche Agnelli et al., 2006.<br />
2.6.4.9.7 Analisi ed elaborazione dei dati<br />
L'analisi dei dati ottenuti è relativamente semplice in quanto si possono ottenere:<br />
1. semplici checklist, cioè elenchi <strong>di</strong> specie caratterizzanti una determinata area, con<br />
eventuale descrizione delle valenze conservazionistiche delle specie stesse, in relazione<br />
al loro status complessivo, all'inserimento in categorie <strong>di</strong> minaccia IUCN (Red List) o in<br />
allegati <strong>di</strong> <strong>di</strong>rettive comunitarie (“Direttiva Habitat”)<br />
2. stime quantitative relative all'abbondanza o densita <strong>di</strong> specie<br />
3. conteggi <strong>di</strong> in<strong>di</strong>vidui presso colonie<br />
4. variazioni, in perio<strong>di</strong> temporali me<strong>di</strong>o-lunghi, delle abbondanze o del numero <strong>di</strong> in<strong>di</strong>vidui<br />
presso le colonie<br />
2.6.4.9.8 Modalità <strong>di</strong> validazione dei dati da parte della <strong>Provincia</strong> <strong>di</strong> <strong>Bologna</strong><br />
Le <strong>Provincia</strong> <strong>di</strong> <strong>Bologna</strong> potrà avvalersi della collaborazione del Gruppo Italiano Ricerca<br />
Chirotteri (GIRC, www.pipistrelli.net), gruppo a carattere nazionale che già svolge mansioni<br />
<strong>di</strong> consulenza per il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sui temi<br />
legati al monitoraggio, alle ricerche e alla conservazione dei chirotteri in Italia.<br />
2.6.4.9.9 Modalità <strong>di</strong> georeferenziazione<br />
L’utilizzo <strong>di</strong> un GPS permette una precisa georeferenziazione dei rifugi e delle aree <strong>di</strong> rilievo,<br />
con la possibilità <strong>di</strong> riportare tali punti su mappe e foto aeree. Occorre standar<strong>di</strong>zzare la<br />
tipologia <strong>di</strong> sistema cartografico utilizzato, uniformandolo agli standard utilizzati dalla<br />
Regione Emilia Romagna.<br />
2.6.4.9.10 Note<br />
Tutte le specie <strong>di</strong> Chirotteri sono considerate minacciate <strong>di</strong> estinzione in modo più o meno<br />
grave e per questo sono particolarmente protette da leggi Nazionali e Comunitarie. Risulta<br />
quin<strong>di</strong> assolutamente necessario evitare azioni <strong>di</strong> <strong>di</strong>sturbo durante i rilievi, perché altrimenti il<br />
monitoraggio delle popolazioni <strong>di</strong> Chirotteri a scopo conservazionistico potrebbe produrre un<br />
effetto opposto a quello desiderato. Per questo motivo risulta <strong>di</strong> grande importanza affidare<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />
E SPECIE PAG. 157<br />
le attività <strong>di</strong> monitoraggio esclusivamente a specialisti con una formazione specifica e<br />
comprovata nel settore chirotterologico.<br />
È bene inoltre ricordare che proprio per motivi conservazionistici la cattura e la<br />
manipolazione <strong>di</strong> Chirotteri è subor<strong>di</strong>nata al rilascio <strong>di</strong> specifiche autorizzazioni da parte del<br />
Ministero Ambiente e che l’iter autorizzativo richiede anche alcuni mesi per il rilascio dei<br />
permessi.<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – DESCRIZIONE DELLE CRITICITÀ E DELLE CAUSE DI MINACCIA PAG. 158<br />
3 DESCRIZIONE DELLE CRITICITÀ E DELLE CAUSE DI MINACCIA<br />
3.1 Alterazioni del regime idrologico<br />
Le componenti del regime idrologico, fondamentali per la regolazione dei processi ecologici<br />
negli ecosistemi dei corsi d’acqua, sono cinque:<br />
1. la portata complessiva;<br />
2. la frequenza <strong>di</strong> una certa con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> deflusso;<br />
3. la durata <strong>di</strong> una certa con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> deflusso;<br />
4. il periodo dell’anno in cui una certa con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> deflusso si presenta;<br />
5. la rapi<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> variazione da una con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> deflusso ad un’altra.<br />
Le alterazioni alle cinque componenti sopra elencate, indotte dalle opere e da altre azioni<br />
antropiche, influiscono in senso negativo sui fattori che concorrono alla definizione dello<br />
stato <strong>di</strong> qualità dei corpi idrici:<br />
- per quanto riguarda lo stato <strong>di</strong> qualità chimico-fisica dell’acqua dei corpi idrici, nei perio<strong>di</strong><br />
<strong>di</strong> magra con bassi valori <strong>di</strong> portata complessiva, dovuti a scarse precipitazioni, ridotta<br />
capacità <strong>di</strong> infiltrazione, o a eccessivi prelievi, si riduce la capacità <strong>di</strong> <strong>di</strong>luire i carichi <strong>di</strong><br />
sostanze inquinanti e il grado <strong>di</strong> ossigenazione delle acque necessario, oltre che per la<br />
vita acquatica, anche per i processi metabolici <strong>di</strong> degradazione delle sostanze<br />
organiche;<br />
- per quanto riguarda lo stato delle comunità biotiche sia acquatiche sia ripariali, la<br />
regolazione artificiale dei deflussi altera gli spazi naturali a <strong>di</strong>sposizione per i loro <strong>di</strong>versi<br />
cicli vitali (habitat), generalmente con una conseguente riduzione del numero <strong>di</strong> specie<br />
(bio<strong>di</strong>versità). A questo si somma il blocco dei movimenti migratori della fauna ittica in<br />
corrispondenza delle opere prive delle strutture <strong>di</strong> mitigazione (es: sistemi per i passaggi<br />
dei pesci);<br />
- per quanto riguarda la <strong>di</strong>namica morfologica del corso d’acqua, questa viene alterata sia<br />
attraverso la mo<strong>di</strong>fica dei deflussi sia attraverso il blocco del naturale trasporto <strong>di</strong><br />
se<strong>di</strong>menti.<br />
L'eccessiva captazione e la scarsa sensibilità <strong>di</strong> alcuni proprietari dei terreni hanno<br />
determinato la scomparsa <strong>di</strong> piccole pozze e stagni adatti alla vita degli anfibi a causa<br />
dell’interramento e dell’introduzione <strong>di</strong> pesci.<br />
Le specie ittiche dei corsi d’acqua risentono dei seguenti fattori:<br />
• alterazioni degli alvei fluviali che riducono i substrati idonei alla deposizione dei gameti<br />
(Lasca, Vairone, Cobite, Barbo, Barbo canino);<br />
• eccessive captazioni idriche che riducono la portata dei corsi d’acqua in periodo estivo<br />
(Vairone, Barbo canino).<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – DESCRIZIONE DELLE CRITICITÀ E DELLE CAUSE DI MINACCIA PAG. 159<br />
3.2 Inquinamento ed eutrofizzazione delle acque superficiali<br />
In generale <strong>di</strong>versi tipi <strong>di</strong> sostanze inquinanti possono avere <strong>di</strong>versi impatti sulle acque<br />
superficiali:<br />
l’eutrofizzazione, con proliferazione <strong>di</strong> alghe, anche tossiche, e piante acquatiche, è<br />
causata da un eccesso <strong>di</strong> nutrienti (azoto e fosforo), prevalentemente derivante dalle<br />
attività agricole e dagli scarichi urbani non depurati o trattati in modo insufficiente;<br />
la riduzione della quantità <strong>di</strong> ossigeno <strong>di</strong>sciolto, necessario per la vita degli organismi<br />
acquatici, che comporta una riduzione della capacità autodepurativa degli ecosistemi<br />
acquatici, è causata da un eccesso <strong>di</strong> sostanze organiche biodegradabili, generalmente<br />
provenienti da scarichi urbani non depurati;<br />
l’eccessiva concentrazione <strong>di</strong> sostanze pericolose (metalli pesanti, inquinanti organici,<br />
fitofarmaci ecc… prevalentemente derivanti da attività industriali e agricole) nei tessuti <strong>di</strong><br />
organismi acquatici è causata dalla presenza, nell’acqua, <strong>di</strong> tali sostanze, non<br />
degradabili in composti non tossici e non smaltibili dagli organismi stessi, con pesanti<br />
danni alla loro salute e a quella dell’uomo;<br />
la torbi<strong>di</strong>tà e l’aumento della temperatura dell’acqua costituiscono esempi <strong>di</strong> alterazione<br />
delle caratteristiche fisiche dei corpi idrici che possono danneggiare le comunità<br />
acquatiche vegetali e animali, e che sono causate rispettivamente dalla presenza <strong>di</strong> un<br />
eccesso <strong>di</strong> se<strong>di</strong>menti o <strong>di</strong> sostanza organica in sospensione, e dallo scarico <strong>di</strong> acque <strong>di</strong><br />
trattamento o raffreddamento più calde <strong>di</strong> quelle del corpo idrico recettore.<br />
La popolazione isolata <strong>di</strong> Salamandrina dagli occhiali si riproduce in un ruscello esposto a<br />
rischi <strong>di</strong> inquinamento da scarichi fognari.<br />
L’utilizzo <strong>di</strong> sostanze inquinanti ha effetti negativi, sia <strong>di</strong>retti che in<strong>di</strong>retti, anche sulla<br />
chirotterofauna presente nel SIC. I pipistrelli possono infatti accumulare nei propri tessuti<br />
queste sostanze sia tramite il contatto <strong>di</strong>retto della pelle, che assumendole con l’acqua e gli<br />
insetti <strong>di</strong> cui si cibano. Queste sostanze nocive vengono generalmente accumulate<br />
all’interno <strong>di</strong> particolari cellule a<strong>di</strong>pose dove rimangono inattive finchè non vengono<br />
metabolizzate, spesso durante l’ibernazione. Un’eccessiva concentrazione degli inquinanti<br />
all’interno dell’organismo può portare alla morte dell’in<strong>di</strong>viduo, spesso lontana sia nel tempo<br />
che nello spazio rispetto all’assunzione delle sostanze.<br />
3.3 Invasione <strong>di</strong> specie vegetali alloctone<br />
3.3.1 Generalità<br />
Le specie vegetali esotiche invasive sono considerate unanimemente un elemento<br />
pregiu<strong>di</strong>zievole alla conservazione della bio<strong>di</strong>versità e dei naturali processi funzionali<br />
dell’ecosistema; tra gli effetti più negativi troviamo l’estinzione locale <strong>di</strong> specie autoctone<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – DESCRIZIONE DELLE CRITICITÀ E DELLE CAUSE DI MINACCIA PAG. 160<br />
vegetali e animali, l’alterazione delle caratteristiche fisico-chimiche dei suoli e la<br />
mo<strong>di</strong>ficazione del paesaggio tipico, a cui bisogna aggiungere ingenti danni economici alle<br />
attività produttive (ad esempio in agricoltura) e alle infrastrutture nonché alla salute, in<br />
particolare dell’uomo.<br />
Di seguito vengono ripresi alcuni estratti relativi al controllo delle specie vegetali invasive<br />
riportati nelle “Linee guida per la gestione della flora e della vegetazione delle aree protette<br />
nella Regione Lombar<strong>di</strong>a”.<br />
I taxa invadenti (o invasivi) sono piante naturalizzate, le quali producono propaguli spesso in<br />
elevato numero, permettendo, in termini reali o potenziali, l’espansione dei taxa su vaste<br />
aree.<br />
La capacità <strong>di</strong> invadere gli ambienti <strong>di</strong>viene inoltre proporzionale al numero <strong>di</strong> sorgenti <strong>di</strong><br />
propaguli (piante madri: sia introdotte, sia spontaneizzate). La proprietà <strong>di</strong> invadere<br />
l’ambiente è sostanzialmente in<strong>di</strong>pendente dalla capacità <strong>di</strong> impatto che il taxon ha<br />
sull’ambiente e sui danni che può causare.<br />
La capacità <strong>di</strong> invadere l’ambiente può essere valutata su una scala <strong>di</strong> tre livelli:<br />
• bassa: taxon con capacità <strong>di</strong> invadenza limitata, generalmente circoscritta alle vicinanze<br />
della pianta madre (perlopiù taxon naturalizzato in senso stretto);<br />
• me<strong>di</strong>a: taxon con capacità <strong>di</strong> invadenza contenuta, sia in relazione al tipo <strong>di</strong> riproduzione<br />
(es. prevalentemente vegetativa), <strong>di</strong>spersione (es. bassa capacità <strong>di</strong> vagazione dei<br />
propaguli) e autoecologia (es. necessità <strong>di</strong> eccezionali con<strong>di</strong>zioni ambientali per<br />
l’inse<strong>di</strong>amento delle plantule);<br />
• elevata: taxon che non mostra evidenti limiti nella capacità <strong>di</strong> invadere l’ambiente.<br />
L’impatto sull’ambiente in<strong>di</strong>vidua i danni reali o potenziali che provengono <strong>di</strong>rettamente (es.<br />
competizione con taxa autoctoni) o in<strong>di</strong>rettamente (es. mo<strong>di</strong>ficazione delle caratteristiche<br />
edafiche) dalla presenza <strong>di</strong> un taxon alloctono.<br />
Si possono <strong>di</strong>stinguere gli impatti ambientali nei seguenti comparti:<br />
bio<strong>di</strong>versità: alterazione della bio<strong>di</strong>versità autoctona (bio<strong>di</strong>versità β, α e sub-α);<br />
caratteristiche abiotiche dell’ecosistema: alterazioni dei fattori abiotici dell’ecosistema<br />
(suolo, acqua, microclima ecc.);<br />
paesaggio: alterazione nelle componenti autoctone (bio<strong>di</strong>versità γ);<br />
salute: il taxon rappresenta un rischio importante per la salute <strong>di</strong> uomini e/o animali;<br />
danni economici: il taxon provoca danni economici in uno o più settori (agricoltura,<br />
selvicoltura, infrastrutture ecc.).<br />
L’impatto ambientale <strong>di</strong> un taxon può essere stimato sul numero <strong>di</strong> comparti in cui può<br />
provocare danni. Per semplificazione, questa valutazione può essere ridotta a sole tre classi<br />
<strong>di</strong> impatto ambientale:<br />
basso: il taxon al più può produrre danni in un unico comparto;<br />
me<strong>di</strong>o: può produrre danni in due o tre comparti;<br />
alto: può produrre danni in quattro o cinque comparti.<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – DESCRIZIONE DELLE CRITICITÀ E DELLE CAUSE DI MINACCIA PAG. 161<br />
Un taxon deve essere considerato sempre ad alto impatto quando:<br />
• rappresenta un elevato rischio per la salute umana;<br />
• rappresenta una <strong>di</strong>retta, concreta e comprovata minaccia per la conservazione <strong>di</strong> taxa o<br />
habitat inclusi in elenchi <strong>di</strong> protezione (<strong>di</strong>rettiva 92/43/CEE, Liste Rosse ecc.) o <strong>di</strong><br />
particolare interesse naturalistico-scientifico (endemiti, relitti biogeografici o sistematici<br />
ecc.).<br />
La classificazione del livello <strong>di</strong> pericolosità ambientale <strong>di</strong> un taxon esotico avviene tramite<br />
una semplice combinazione tra i tre gra<strong>di</strong> <strong>di</strong> capacità <strong>di</strong> invadere l’ambiente e i tre livelli <strong>di</strong><br />
potenziale d’impatto ambientale. Si identificano pertanto nove possibili combinazioni, a loro<br />
volta raggruppate in tre classi secondo la figura seguente:<br />
FIGURA 5 – CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DI PERICOLOSITÀ. (FONTE: CENTRO FLORA AUTOCTONA, 2009)<br />
Le tre classi <strong>di</strong> piante possono così essere descritte:<br />
- tollerabile:<br />
taxa che mostrano un basso impatto ambientale; conseguentemente la loro<br />
presenza risulta in generale tollerabile nell’ambiente e quin<strong>di</strong> non viene prevista la loro<br />
inclusione nelle liste speciali;<br />
- lista grigia:<br />
sono rappresentati da taxa con un me<strong>di</strong>o impatto ambientale, oppure alto ma<br />
con bassa capacità <strong>di</strong> invadere l’ambiente. In generale si tratta <strong>di</strong> taxa dannosi per<br />
l’ambiente, la cui <strong>di</strong>ffusione deve essere perlomeno controllata e contrastata, ai fini <strong>di</strong><br />
evitarne una maggior espansione e quin<strong>di</strong> mitigarne l’influenza; la loro presenza è<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – DESCRIZIONE DELLE CRITICITÀ E DELLE CAUSE DI MINACCIA PAG. 162<br />
tollerabile unicamente in contesti ambientali particolari, in generale con una bassa<br />
bio<strong>di</strong>versità naturale (ambienti antropizzati, coltivi ecc.).<br />
- lista nera:<br />
sono rappresentati da taxa con un alto impatto ambientale abbinato ad una<br />
me<strong>di</strong>o-alta capacità <strong>di</strong> invadere l’ambiente. In generale si tratta <strong>di</strong> taxa alquanto dannosi<br />
per l’ambiente, la cui <strong>di</strong>ffusione deve essere contrastata e le singole popolazione <strong>di</strong><br />
norma era<strong>di</strong>cate (almeno nelle situazioni più nocive per il comparto ambientale<br />
interessato).<br />
TABELLA 12 – CLASSIFICAZIONE DELLE SPECIE VEGETALI ALLOCTONE. IL SIMBOLO + INDICA CHE LA SPECIE RAPPRESENTA UNA DIRETTA,<br />
CONCRETA E COMPROVATA MINACCIA PER LA CONSERVAZIONE DI TAXA O HABITAT INCLUSI IN ELENCHI DI PROTEZIONE (DIRETTIVA<br />
92/43/CEE, LISTE ROSSE ECC.) O DI PARTICOLARE INTERESSE NATURALISTICO-SCIENTIFICO (ENDEMITI, RELITTI BIOGEOGRAFICI O<br />
SISTEMATICI ECC.) OPPURE RAPPRESENTA UN ELEVATO RISCHIO PER LA SALUTE UMANA (FONTE: CENTRO FLORA AUTOCTONA, 2009).<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – DESCRIZIONE DELLE CRITICITÀ E DELLE CAUSE DI MINACCIA PAG. 163<br />
Le caratteristiche salienti dei tre gruppi <strong>di</strong> taxa alloctoni sono riassunti in Tabella 12.<br />
3.3.2 Robinia (Robinia pseudoacacia)<br />
Robinia pseudoacacia è una specie <strong>di</strong> origine nordamericana, introdotta in Europa agli inizi<br />
del 1600 ed attualmente naturalizzata in tutta Italia, dalla pianura alla bassa montagna, su<br />
terreni abbandonati, argini, scarpate e all’interno <strong>di</strong> siepi e boschi ripari. In questi ambienti la<br />
robinia può formare boschi puri o misti con altre latifoglie decidue.<br />
La robinia è una pianta a crescita rapida, capace <strong>di</strong> occupare ampie superfici grazie agli<br />
stoloni e all’emissione <strong>di</strong> polloni in caso <strong>di</strong> taglio. I popolamenti possono essere molto densi<br />
e soppiantare cespugli e alberi autoctoni.<br />
Il rapido sviluppo ed il temperamento eliofilo <strong>di</strong>mostrato dalla specie sono tali per cui i<br />
robinieti tendono a rimanere stabili solo se ceduati regolarmente. La comparsa <strong>di</strong> specie<br />
autoctone denota la tendenza evolutiva verso boschi misti.<br />
3.3.3 Falso indaco (Amorpha fruticosa)<br />
Amorpha fruticosa o falso indaco è una specie arbustiva nordamericana, ampiamente<br />
naturalizzata nella Pianura Padana, soprattutto lungo i fiumi e nelle zone golenali. Si tratta <strong>di</strong><br />
una specie caratterizzata da versatilità ecologica, anche se tendenzialmente igrofila, che si<br />
inse<strong>di</strong>a con preferenza in situazioni caratterizzate da <strong>di</strong>sturbo antropico (es. argini fluviali,<br />
terreni <strong>di</strong> riporto).<br />
Amorpha fruticosa tende a formare fitti arbusteti (“amorfeti”) alti non più <strong>di</strong> 2-3 m, in cui<br />
l’indaco è l’unica specie presente, mentre il corteggio erbaceo risulta assai variegato.<br />
In sintesi si sottolinea il carattere pioniero delle formazioni ad Amorpha fruticosa, che si<br />
affermano già nei primi sta<strong>di</strong> della seriazione interrante delle zone umide d’acqua dolce, con<br />
un impatto negativo sulle cenosi elofitiche. L’indaco riveste invece un ruolo positivo <strong>di</strong><br />
colonizzatore e miglioratore del terreno in situazioni a impronta ruderale, tipiche delle<br />
successioni secondarie in ambienti degradati.<br />
3.3.4 Acero americano (Acer negundo)<br />
Questo acero, originario della parte orientale dell’America settentrionale, fu importato in<br />
Europa nel secolo XVII. Presente qua e là, in forma arborea od arbustiva, soprattutto in<br />
ambienti ruderali, al margine <strong>di</strong> strade e corsi d'acqua. È una specie in forte e rapida<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – DESCRIZIONE DELLE CRITICITÀ E DELLE CAUSE DI MINACCIA PAG. 164<br />
espansione in luoghi abbandonati e lungo i fiumi, conoscendo una fase <strong>di</strong> forte esplosione<br />
demografica del tutto estranea a fenomeni <strong>di</strong> parassitismo e malattie <strong>di</strong> vario genere<br />
Tale albero presenta ritmi <strong>di</strong> crescita molto elevati, ed essendo dotato <strong>di</strong> una particolare<br />
resistenza ad eventi climatici estremi (sostanzialmente siccità e gelate), ai parassiti nostrani<br />
e ad un certo grado <strong>di</strong> eutrofizzazione dell' ambiente in cui vive, tende a <strong>di</strong>ffondersi<br />
rapidamente, anche grazie ad una abbondante <strong>di</strong>sseminazione e ad una notevole<br />
produzione <strong>di</strong> polloni basali che possono contribuire ulteriormente alla <strong>di</strong>ffusione della<br />
specie.<br />
3.4 Invasione <strong>di</strong> specie animali alloctone<br />
Un problema che non va sottovalutato è l’invasione <strong>di</strong> specie alloctone, quali il cinghiale, le<br />
testuggini esotiche, il gambero della Lousiana, la pseudorasbora ecc..<br />
Il cinghiale è in crescente aumento in tutto il territorio regionale e non si può trascurare<br />
l’impatto sugli habitat <strong>di</strong> interesse comunitario, con danni a carico delle cenosi vegetali, oltre<br />
che alla rinnovazione delle specie arboree legate agli habitat forestali.<br />
Altro problema è dato dalla conservazione della testuggine palustre europea, attualmente in<br />
forte competizione con le tartarughe esotiche immesse in natura dopo la cattività.<br />
Anche la conservazione del Gambero <strong>di</strong> fiume è fortemente minacciata dalla presenza ormai<br />
<strong>di</strong>ffusa del Gambero della Louisiana, maggiormente competitiva e vettore <strong>di</strong> parassiti.<br />
L’introduzione anche accidentale <strong>di</strong> specie ittiche aliene è da considerarsi estremamente<br />
negativa e pericolosa per le popolazioni in<strong>di</strong>gene e più in generale per l’intero ecosistema. I<br />
danni che possono essere causati dall’introduzione <strong>di</strong> una specie aliena sono:<br />
• danni a carico delle componenti fisiche, floristiche e vegetazionali;<br />
• alterazioni delle catene trofiche, quin<strong>di</strong> dei rapporti interspecifici tra i vari elementi della<br />
comunità animale, come un’eccessiva predazione esercitata a carico <strong>di</strong> specie in<strong>di</strong>gene o<br />
una competizione fra la specie aliena e le specie in<strong>di</strong>gene aventi simile nicchia ecologica;<br />
• <strong>di</strong>ffusione <strong>di</strong> agenti patogeni e <strong>di</strong> parassiti;<br />
• inquinamento genetico conseguente alla riproduzione con taxa in<strong>di</strong>geni sistematicamente<br />
affini.<br />
3.5 Processi naturali<br />
I processi biotici rilevanti in riferimento alla vegetazione sono rappresentati dai <strong>di</strong>namismi<br />
evolutivi che si generano nel contesto delle successioni seriali; si tratta <strong>di</strong> processi naturali<br />
che possono manifestarsi nelle <strong>di</strong>mensioni dello spazio e del tempo in forma anche<br />
apparentemente non preve<strong>di</strong>bile o anomala in relazione alle mo<strong>di</strong>ficazioni delle pressioni e<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – DESCRIZIONE DELLE CRITICITÀ E DELLE CAUSE DI MINACCIA PAG. 165<br />
degli usi antropici della risorsa naturale; tali <strong>di</strong>namiche sono correlate alla stabilità della<br />
cenosi vegetale in una data stazione ed alle interazioni tra cenosi limitrofe o compenetrate.<br />
I brometi sono habitat tipicamente secondari, il cui mantenimento è subor<strong>di</strong>nato alle attività<br />
<strong>di</strong> sfalcio o <strong>di</strong> pascolamento del bestiame, garantite dalla persistenza delle tra<strong>di</strong>zionali attività<br />
agro-pastorali (sfalcio e/o pascolamento). In assenza <strong>di</strong> tale sistema <strong>di</strong> gestione, i naturali<br />
processi <strong>di</strong>namici della vegetazione favoriscono l’inse<strong>di</strong>amento nelle praterie <strong>di</strong> specie <strong>di</strong> orlo<br />
ed arbustive e lo sviluppo <strong>di</strong> comunità riferibili rispettivamente alle classi Trifolio - Geranietea<br />
sanguinei e Rhamno - Prunetea spinosae; quest’ultima può talora essere rappresentata<br />
dalle “Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli” dell’Habitat 5130.<br />
Infine sono da prendere in considerazione i fenomeni <strong>di</strong> erosione fluviale, che possono<br />
sortire i seguenti effetti:<br />
• rimaneggiamento degli ambiti fluviali e conseguente ri<strong>di</strong>stribuzione degli habitat erbacei,<br />
in particolare degli habitat 3240 e 3270; le mo<strong>di</strong>fiche spaziali, legate al corso dei fiumi e<br />
degli eventi <strong>di</strong> piena, sono generalmente compensate e si creano nuovi spazi ecologici<br />
adatti;<br />
• erosione <strong>di</strong> sponda catastrofica con conseguente scomparsa <strong>di</strong> habitat (es. 3240, 91E0,<br />
92A0).<br />
3.6 Attività venatoria<br />
3.6.1 Generalità<br />
Nei siti della Rete Natura 2000 la caccia non è a priori vietata ma può altresì comportare un<br />
fattore negativo per gli animali selvatici: l’attività venatoria viene cioè considerata dal<br />
documento della UE “Guidance document on hunting under Council Directive 79/409/EEC<br />
on the conservation of wild birds” alla stregua <strong>di</strong> qualsiasi altra attività umana suscettibile <strong>di</strong><br />
impatto negativo sull’avifauna e sui suoi habitat. Come tale va attentamente gestita in<br />
maniera da renderla compatibile con gli obiettivi <strong>di</strong> conservazione del sito.<br />
Le azioni <strong>di</strong> <strong>di</strong>sturbo dell’attività venatoria sul sito, sempre tenendo conto degli obiettivi <strong>di</strong><br />
conservazione (art. 2 DPR 357/97), si possono raggruppare in due categorie:<br />
1. azioni <strong>di</strong> <strong>di</strong>sturbo <strong>di</strong>rette;<br />
2. azioni <strong>di</strong> <strong>di</strong>sturbo in<strong>di</strong>rette.<br />
Le prime derivano dalla possibilità <strong>di</strong> svolgere, all’interno del sito, la caccia vagante.<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – DESCRIZIONE DELLE CRITICITÀ E DELLE CAUSE DI MINACCIA PAG. 166<br />
3.6.2 Identificazione degli impatti<br />
3.6.2.1 Uccisione <strong>di</strong>retta <strong>di</strong> esemplari appartenenti a specie cacciabili<br />
Sicuramente oggi la caccia è uno dei fattori limitanti per molte specie migratorie, che ogni<br />
anno viaggiano dall'Africa al Nord Europa, e per le quali l'Italia rappresenta un'area <strong>di</strong> sosta.<br />
L’impatto <strong>di</strong>retto, che si manifesta con l’abbattimento <strong>di</strong> capi, è ovviamente più incisivo per le<br />
specie cacciabili previste dell’art. 18 della L. 157/92.<br />
La caccia all’Allodola vagante e da appostamento provoca abbattimenti accidentali <strong>di</strong><br />
Tottavilla dove questa specie è presente come ni<strong>di</strong>ficante, residente, migratore.<br />
Lo svolgimento della caccia vagante può determinare in zone vocate per la riproduzione <strong>di</strong><br />
rapaci rupicoli, quali Aquila reale, Pellegrino, Lanario, Gufo reale, un rilevante e frequente<br />
<strong>di</strong>sturbo in gennaio, proprio all’inizio del periodo <strong>di</strong> inse<strong>di</strong>amento delle coppie che può<br />
spingerle a <strong>di</strong>sertare i siti.<br />
3.6.2.2 Caccia al cinghiale<br />
La caccia e il controllo del Cinghiale in battuta o in braccata è un sistema <strong>di</strong> caccia molto<br />
invasivo che produce un forte <strong>di</strong>sturbo su tutti gli animali presenti nell’area interessata e che<br />
determina quin<strong>di</strong> un notevole <strong>di</strong>sturbo per specie <strong>di</strong> interesse conservazionistico e<br />
soprattutto un elevato rischio <strong>di</strong> abbattimenti accidentali <strong>di</strong> esemplari <strong>di</strong> Lupo.<br />
Le varie forme <strong>di</strong> caccia collettiva al Cinghiale in gennaio e le caccie <strong>di</strong> selezione agli<br />
Ungulati da strutture fisse nel periodo gennaio-luglio possono costituire un fattore <strong>di</strong><br />
incidenza negativa significativa (molto localizzato) per l’inse<strong>di</strong>amento e il successo<br />
riproduttivo <strong>di</strong> rapaci rupicoli.<br />
L’eccessiva densità <strong>di</strong> cinghiali causa danni ad habitat e specie <strong>di</strong> interesse comunitario a<br />
causa della predazione <strong>di</strong> Anfibi (Tritone crestato italiano, Ululone appenninico,<br />
Salamandrina dagli occhiali) e <strong>di</strong> Uccelli (Tottavilla, Calandro, Ortolano) che si riproducono a<br />
terra.<br />
3.6.2.3 Disturbo antropico ed inquinamento acustico<br />
Ovviamente l’attività venatoria induce altri tipi <strong>di</strong> impatti, oltre all’abbattimento <strong>di</strong> capi, a<br />
carico delle specie non cacciabili, nonché delle specie vegetali, quali quelli derivanti dal<br />
<strong>di</strong>sturbo provocato dal passaggio dei cacciatori, eventualmente accompagnati da cani da<br />
caccia, dall’inquinamento acustico dovuto allo sparo e, a carico della qualità dell’ecosistema<br />
(componente suolo in primis), a causa del possibile abbandono dei bossoli, composti da<br />
plastiche e metalli.<br />
I parametri caratterizzanti una situazione <strong>di</strong> <strong>di</strong>sturbo acustico sono essenzialmente<br />
riconducibili alla potenza <strong>di</strong> emissione delle sorgenti, alla <strong>di</strong>stanza tra queste ed i potenziali<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – DESCRIZIONE DELLE CRITICITÀ E DELLE CAUSE DI MINACCIA PAG. 167<br />
recettori, ai fattori <strong>di</strong> attenuazione del livello <strong>di</strong> pressione sonora presenti tra sorgente e<br />
recettore.<br />
Gli effetti <strong>di</strong> <strong>di</strong>sturbo dovuti all’azione <strong>di</strong> sparo e <strong>di</strong> passaggio, possono portare ad un<br />
allontanamento della fauna, con conseguente sottrazione <strong>di</strong> spazi utili all'inse<strong>di</strong>amento,<br />
alimentazione e riproduzione.<br />
Risulta evidente come il <strong>di</strong>sturbo arrecato dall’attività venatoria sia tale da ostacolare<br />
l’utilizzo dei biotopi da parte <strong>di</strong> molte specie ornitiche: nel caso degli Anati<strong>di</strong> è stato<br />
osservato che il <strong>di</strong>sturbo arrecato dalla caccia nei quartieri <strong>di</strong> svernamento può ostacolare la<br />
ricerca del cibo in una fase del ciclo biologico in cui l’accumulo <strong>di</strong> riserve energetiche<br />
rappresenta un elemento essenziale per incrementare il successo riproduttivo nel corso della<br />
primavera successiva.<br />
Esistono attualmente pochi stu<strong>di</strong> che consentano <strong>di</strong> confermare la tesi secondo cui gli uccelli<br />
hanno ampiamente e liberamente accesso a risorse alimentari per compensare gli squilibri.<br />
Gli uccelli cercheranno siti alternativi più tranquilli, che potrebbero non essere situati nelle<br />
vicinanze o nei quali potrebbero non essere <strong>di</strong>sponibili adeguate riserve alimentari. Inoltre, le<br />
varie categorie <strong>di</strong> uccelli presentano livelli <strong>di</strong>fferenti <strong>di</strong> sensibilità al <strong>di</strong>sturbo in funzione delle<br />
<strong>di</strong>verse caratteristiche biologiche e comportamentali e della <strong>di</strong>pendenza da <strong>di</strong>versi habitat.<br />
Ciononostante, anche se il comportamento alimentare può essere <strong>di</strong>sturbato, in generale<br />
non esistono stu<strong>di</strong> che consentano <strong>di</strong> stabilire se gli uccelli non sono in grado <strong>di</strong> alimentarsi<br />
efficacemente nel breve o nel lungo periodo, soprattutto in quanto l’apporto energetico della<br />
razione alimentare deve essere considerato sia a breve che a lungo termine.<br />
In assenza <strong>di</strong> stu<strong>di</strong> empirici, non è possibile comprendere pienamente le conseguenze <strong>di</strong><br />
uno squilibrio energetico sul successo riproduttivo e sulla sopravvivenza della specie.<br />
Ad ogni modo gli uccelli sono incapaci <strong>di</strong> compensazione se, oltre al <strong>di</strong>spen<strong>di</strong>o energetico<br />
derivante dal fattore <strong>di</strong> <strong>di</strong>sturbo, non hanno accesso a risorse alimentari per più giorni<br />
consecutivi (ad esempio in con<strong>di</strong>zioni climatiche sfavorevoli) o nel periodo <strong>di</strong> attività prima e<br />
durante la riproduzione.<br />
Infine non sono <strong>di</strong>sponibili informazioni e ricerche sistematiche sugli uccelli in migrazione<br />
che consentano <strong>di</strong> valutare meglio gli effetti dei fattori <strong>di</strong> <strong>di</strong>sturbo, quali la caccia, sulle<br />
popolazioni aviarie e sul loro stato <strong>di</strong> conservazione.<br />
3.7 Pesca<br />
I principali fattori <strong>di</strong> minaccia derivanti dall’attività alieutica sono riconducibili principalmente<br />
alle attività <strong>di</strong> semina, alla mancanza <strong>di</strong> misure <strong>di</strong> cattura minime adeguate e all’uso del<br />
pesciolino vivo come esca.<br />
L’immissione <strong>di</strong> salmoni<strong>di</strong> e ciprini<strong>di</strong> adulti a scopo alieutico può incidere negativamente<br />
sulla densità <strong>di</strong> popolazione <strong>di</strong> anfibi e pesci inseriti nella Direttiva Habitat. Essenzialmente<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – DESCRIZIONE DELLE CRITICITÀ E DELLE CAUSE DI MINACCIA PAG. 168<br />
gli in<strong>di</strong>vidui immessi possono potenzialmente predare le uova <strong>di</strong> anfibio e gli in<strong>di</strong>vidui non<br />
ancora metamorfosati; lo stesso vale anche per i pesci <strong>di</strong> piccola taglia come scazzone,<br />
lasca ecc.; i salmoni<strong>di</strong> immessi vanno inoltre ad occupare l’habitat <strong>di</strong> specie consimili come<br />
barbo, <strong>di</strong>sturbandone l’attività trofica o riproduttiva.<br />
Per quanto concerne le attività <strong>di</strong> ripopolamento esse possono rappresentare un notevole<br />
fattore <strong>di</strong> pressione, infatti l’immissione <strong>di</strong> materiale giovanile può essere veicolo <strong>di</strong><br />
immissione <strong>di</strong> forme aliene indesiderate o produrre effetti negativi sulle popolazioni<br />
autoctone autoriproducenti.<br />
Anche l’uso del pesciolino vivo come esca, permesso dal regolamento provinciale per la<br />
pesca, è uno dei principali veicoli <strong>di</strong> introduzione <strong>di</strong> fauna aliena nelle acque provinciali.<br />
La pesca nelle forme consentite, sia da terra che da acqua, non è <strong>di</strong> per sé negativa per gli<br />
Uccelli ma l’attività comporta molto spesso la permanenza del pescatore per lungo tempo in<br />
zone critiche, portando agli stessi problemi delle altre attività ricreative.<br />
Va inoltre considerato il danno alla vegetazione, e conseguentemente faunistico, derivante<br />
dal rilevante calpestio e, in molti casi, dal necessario taglio della vegetazione che ostacola<br />
l’attività <strong>di</strong> pesca dalla riva.<br />
Un impatto negativo della pesca, spesso sottostimato ma talora molto evidente, è il danno<br />
<strong>di</strong>retto derivante dall’abbandono <strong>di</strong> lenze nella zona umida, che spesso funzionano da<br />
trappola mortale o comunque invalidante per determinati gruppi <strong>di</strong> specie.<br />
3.8 Uso <strong>di</strong> esche avvelenate per il controllo <strong>di</strong> specie indesiderate<br />
La pratica criminale dell’uso <strong>di</strong> bocconi avvelenati rappresenta una situazione correlata alla<br />
gestione della fauna <strong>di</strong> grande rilevanza per i siti Natura 2000 e per numerose specie <strong>di</strong><br />
interesse comunitario a causa delle vaste aree su cui viene attuata, della sua frequenza,<br />
dell’impatto negativo molto significativo su specie rare e minacciate (Lupo e varie specie <strong>di</strong><br />
rapaci) e della <strong>di</strong>fficoltà, <strong>di</strong> fatto, <strong>di</strong> prevenirla e contenerla adeguatamente con gli attuali<br />
strumenti normativi e <strong>di</strong> vigilanza. Lo spargimento <strong>di</strong> bocconi avvelenati è attuato da ignoti<br />
che per varie ragioni, in ogni caso prive <strong>di</strong> fondamenti scientifici ed ecologici, ritengono<br />
eccessivo il numero <strong>di</strong> predatori (volpi, lupi, rapaci ecc.), cani, gatti, corvi<strong>di</strong> ed inadeguati i<br />
mezzi legali <strong>di</strong> controllo e <strong>di</strong> indennizzo <strong>di</strong> eventuali danni alle produzioni.<br />
Complessivamente l’uso illegale <strong>di</strong> bocconi avvelenati può essere definito come un fattore <strong>di</strong><br />
incidenza negativa altamente significativa per il Lupo e per vari rapaci (Aquila reale, Falco <strong>di</strong><br />
palude, Nibbio reale, Nibbio bruno, Aquila minore) <strong>di</strong> interesse comunitario presenti<br />
regolarmente nei siti Natura 2000 del Bolognese.<br />
Tra i possibili fattori <strong>di</strong> pressione correlati all’attività venatoria possono rientrare anche i<br />
fenomeni <strong>di</strong> bracconaggio.<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – DESCRIZIONE DELLE CRITICITÀ E DELLE CAUSE DI MINACCIA PAG. 169<br />
3.9 Fruizione turistico-ricreativa<br />
La fruizione turistico-ricreativa <strong>di</strong>retta nel sito può comportare forme <strong>di</strong> <strong>di</strong>sturbo ad habitat e<br />
specie <strong>di</strong> vario livello.<br />
Comportamenti come l’accesso incontrollato al sito con mezzi a motore sulle aree <strong>di</strong> greto<br />
fluviale, generano due tipi <strong>di</strong> <strong>di</strong>sturbo:<br />
- in<strong>di</strong>retto, con allontanamento degli animali presenti, possibile abbandono del nido,<br />
caduta dei piccoli dallo stesso, <strong>di</strong>sturbo e conseguente abbandono delle aree <strong>di</strong> “roost” e<br />
<strong>di</strong>spen<strong>di</strong>o energetico talvolta letale nel periodo critico <strong>di</strong> svernamento;<br />
- <strong>di</strong>retto, con <strong>di</strong>struzione <strong>di</strong> uova e pulcini <strong>di</strong> specie ni<strong>di</strong>ficanti a terra o sulla bassa<br />
vegetazione.<br />
Anche l’accesso incontrollato a pie<strong>di</strong> o con mezzi poco impattanti (bicicletta o cavallo) in<br />
aree sensibili e in particolare durante la riproduzione, potrebbe avere effetti negativi (es.<br />
Mountain-Bike sul sentiero dei Bregoli e down-hill nei boschi sotto <strong>San</strong> <strong>Luca</strong>). Tale tipologia<br />
<strong>di</strong> impatto è stata osservata <strong>di</strong> recente nel sito Natura 2000 “Bosco Fontana”: la colonia<br />
ni<strong>di</strong>ficante <strong>di</strong> nibbio bruno ha infatti spostato la sua localizzazione all’interno del bosco in<br />
funzione della lontananza dal percorso ciclabile Bosco Fontana – Marmirolo, che corre<br />
tangente al limite orientale del sito stesso (F. Mason, comunicazione verbale).<br />
Pertanto non sono da sottovalutare le conseguenze che la frequentazione antropica può<br />
avere sugli habitat forestali (es. al Parco Talon), ed in particolare:<br />
• calpestio e conseguente compattazione del terreno e <strong>di</strong>struzione della vegetazione<br />
erbacea;<br />
• danni al sottobosco per la raccolta <strong>di</strong> fiori e frutti;<br />
• danni al novellame <strong>di</strong> specie arboree;<br />
• <strong>di</strong>sturbo alla fauna nel periodo <strong>di</strong> riproduzione;<br />
• maggiore possibilità dell’insorgere <strong>di</strong> incen<strong>di</strong>;<br />
• abbandono <strong>di</strong> rifiuti che, a prescindere da considerazioni estetiche, costituiscono<br />
una fonte impropria <strong>di</strong> alimentazione per gli animali (Piussi, 1994).<br />
3.10 Barriere ecologiche<br />
3.10.1 Strade<br />
3.10.1.1 Inquinamento acustico dovuto al traffico veicolare<br />
Il traffico è una delle principali fonti <strong>di</strong> <strong>di</strong>sturbo per quanto concerne l'inquinamento acustico.<br />
Il rumore viene trasmesso dalla fonte, in questo caso il traffico veicolare, attraverso un<br />
mezzo (terreno e/o aria) ad un ricettore, che in questo caso può essere rappresentato dalla<br />
fauna presente.<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – DESCRIZIONE DELLE CRITICITÀ E DELLE CAUSE DI MINACCIA PAG. 170<br />
I parametri caratterizzanti una situazione <strong>di</strong> <strong>di</strong>sturbo sono essenzialmente riconducibili alla<br />
potenza acustica <strong>di</strong> emissione delle sorgenti, alla <strong>di</strong>stanza tra queste ed i potenziali recettori,<br />
ai fattori <strong>di</strong> attenuazione del livello <strong>di</strong> pressione sonora presenti tra sorgente e ricettore.<br />
Il livello acustico generato da un'infrastruttura stradale è determinato dalle emissioni dei<br />
veicoli circolanti, da volumi e composizione del traffico, dalla velocità dei veicoli, dalla<br />
pendenza della strada.<br />
Gli effetti <strong>di</strong> <strong>di</strong>sturbo dovuti all'aumento dei livelli sonori, della loro durata e frequenza,<br />
potrebbero portare ad un allontanamento della fauna dall'area, con conseguente sottrazione<br />
<strong>di</strong> spazi utili all'inse<strong>di</strong>amento e riproduzione.<br />
In termini generali i <strong>di</strong>versi fattori <strong>di</strong> interazione negativa variano con la <strong>di</strong>stanza dalla strada<br />
e con la <strong>di</strong>fferente natura degli ecosistemi laterali. In ambienti aperti come in genere sono<br />
quelli dell’area in oggetto l’effetto rumore lo si avverte in decremento fino ad una <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong><br />
circa 1.000 m. Ad esempio è stato osservato come la densità relativa <strong>di</strong> ni<strong>di</strong> <strong>di</strong> alcune specie<br />
<strong>di</strong> Uccelli, <strong>di</strong>minuisse in relazione all’aumento del rumore da traffico con una soglia intorno ai<br />
40 dB. Il rumore, oltre ad aumentare l’effetto barriera della struttura, provoca uno stato<br />
generale <strong>di</strong> stress nei confronti degli animali, poiché <strong>di</strong>sturba le normali fasi fenologiche<br />
(alimentazione, riposo, riproduzione ecc.) ed espone alla predazione, sfavorendo le specie<br />
più sensibili a vantaggio <strong>di</strong> quelle più adattabili e comuni.<br />
3.10.1.1.1 Inquinamento atmosferico dovuto al traffico veicolare<br />
Per quanto concerne il possibile incremento <strong>di</strong> agenti inquinanti dell’atmosfera, si avrebbe<br />
una ricaduta imme<strong>di</strong>ata sulla catena trofica a partire dai livelli più bassi, fino ad incidere ai<br />
vertici della piramide alimentare in cui si trovano i rapaci ed uccelli insettivori e carnivori.<br />
L’aumento <strong>di</strong> sostanze <strong>di</strong> sostanze inquinanti produce un impatto <strong>di</strong>retto sulla vegetazione<br />
tale da determinare danni a vari livelli, fra cui rallentamento dell’accrescimento, danni alla<br />
clorofilla con alterazione del ciclo della fotosintesi, necrosi tissutale, impoverimento del<br />
terreno a causa dell’aci<strong>di</strong>ficazione delle precipitazioni, alterazione del metabolismo cellulare;<br />
<strong>di</strong> conseguenza tanto la fauna invertebrata quanto quella vertebrata <strong>di</strong>pendente dalle piante<br />
per il sostentamento, subirebbero un impatto significativo che si rifletterebbe in via <strong>di</strong>retta<br />
sulle specie predatrici che <strong>di</strong> essa si nutrono. L’effetto dell’inquinamento dell’aria da polveri<br />
si recepisce fino a circa 200 m dalla strada.<br />
3.10.1.1.2 Rischio <strong>di</strong> incidenti dovuto al traffico veicolare<br />
L’immissione <strong>di</strong> rumori e sostanze nocive <strong>di</strong>sturba gli animali in maniera minore del traffico<br />
veicolare, il quale minaccia tutti gli in<strong>di</strong>vidui che tentano <strong>di</strong> attraversare la strada. L’effetto<br />
<strong>di</strong>pende dalla larghezza del corpo stradale, dalle modalità esecutive (trincea, rilevato ecc.),<br />
dall’eventuale rinver<strong>di</strong>mento dei margini e dal ricorso a misure speciali per la <strong>di</strong>fesa della<br />
selvaggina. Sono particolarmente minacciati gli animali caratterizzati da elevata mobilità e<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – DESCRIZIONE DELLE CRITICITÀ E DELLE CAUSE DI MINACCIA PAG. 171<br />
territorio <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni ridotte (es. passeriformi), vasto territorio (es. Ungulati), modeste<br />
potenzialità fisico-psicologiche (lenti nella locomozione, pesanti, deboli <strong>di</strong> u<strong>di</strong>to o <strong>di</strong> vista es.<br />
istrice), modeste capacità <strong>di</strong> adattamento e con comportamenti tipici svantaggiosi (es. attività<br />
notturna, ricerca del manto bituminoso relativamente caldo da parte <strong>di</strong> rettili ed anfibi ecc.).<br />
Le per<strong>di</strong>te per incidenti risultano particolarmente rilevanti nel caso in cui la strada tagli un<br />
percorso <strong>di</strong> migrazione stabilito geneticamente: sotto questo aspetto sono minacciate<br />
soprattutto le popolazioni <strong>di</strong> Anfibi.<br />
Si tratta <strong>di</strong> un aspetto tutt’altro che marginale, che può <strong>di</strong>ventare un vero e proprio fattore<br />
limitante per la <strong>di</strong>namica <strong>di</strong> popolazione delle specie più sensibili al problema, fino a<br />
determinare l’estinzione <strong>di</strong> sub-popolazioni <strong>di</strong> una metapopolazione.<br />
La presenza <strong>di</strong> una strada riduce notevolmente i normali spostamenti; tutte le popolazioni<br />
che dopo la realizzazione dell’infrastruttura rimangono separate dai propri siti riproduttivi, <strong>di</strong><br />
deposizione delle uova e <strong>di</strong> alimentazione saranno portate ad attraversare il tracciato <strong>di</strong><br />
nuova formazione per raggiungerli, con conseguente aumento della mortalità dovuta a<br />
investimento.<br />
I danni maggiori si verificano in genere nel periodo iniziale in seguito all’apertura della<br />
strada, per poi stabilizzarsi su valori “normali”. D’altra parte il traffico molto intenso può<br />
limitare il numero <strong>di</strong> incidenti, poiché gli animali vedono i veicoli e non tentano <strong>di</strong><br />
attraversare: sopra a 10.000 veicoli/giorno, <strong>di</strong>venta praticamente impossibile<br />
l’attraversamento (Muller e Berthoud, 1996). L’area <strong>di</strong>sturbata equivale ad almeno il doppio<br />
della larghezza della strada (quin<strong>di</strong> circa 60 m da entrambi i lati), la mortalità è bassa perché<br />
solo pochi animali si avvicinano, ma la barriera dal punto <strong>di</strong> vista biologico è completa.<br />
Gli investimenti <strong>di</strong> fauna selvatica rappresentano un fenomeno in costante crescita sia per<br />
l’incremento numerico delle popolazioni delle specie coinvolte che per lo sviluppo della rete<br />
stradale e l’aumento dei mezzi circolanti.<br />
Numerose sono le possibili conseguenze negative degli investimenti, basti ricordare i danni<br />
ai veicoli, il ferimento delle persone e la potenziale riduzione numerica delle popolazioni<br />
animali, in alcuni casi rappresentate da specie <strong>di</strong> particolare interesse conservazionistico<br />
(Romin e Bissonette, 1996; Sovada et al., 1998).<br />
3.10.1.1.3 Effetti positivi delle strade per la fauna<br />
Non bisogna comunque <strong>di</strong>menticare che le strade fungono da ambienti <strong>di</strong> attrazione per<br />
alcune specie animali, per i seguenti motivi (Dinetti, 2000):<br />
• lungo il tracciato e nelle aree <strong>di</strong> sosta in genere i rifiuti alimentari sono abbondanti ed<br />
allettano <strong>di</strong>verse specie <strong>di</strong> invertebrati, mammiferi ed uccelli;<br />
• alcune specie insettivore si alimentano talvolta sui vecioli in sosta, nutrendosi degli<br />
insetti che vi sono rimasti uccisi durante la marcia;<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – DESCRIZIONE DELLE CRITICITÀ E DELLE CAUSE DI MINACCIA PAG. 172<br />
• alcune specie agiscono da “spazzine”, nutrendosi dei resti <strong>di</strong> altri animali travolti dai<br />
veicoli;<br />
• la superficie della strada, a causa delle proprietà termiche (calore accumulato<br />
dall’asfalto), attira gli insetti che a loro volta vengono predati da alcuni vertebrati;<br />
• alcuni rapaci quali i nibbi, la poiana, il gheppio, il barbagianni, la civetta sono attirati a<br />
causa dell’elevata abbondanza <strong>di</strong> prede presente lungo i margini non sottoposti a<br />
gestione (es. scarpate con arbusti), della <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> un habitat per certi versi idoneo<br />
e <strong>di</strong> posatoi (es. recinzioni);<br />
• maggiore possibilità <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare le prede.<br />
3.10.2 Linee elettriche<br />
L’interferenza delle linee elettriche con gli spostamenti dell’avifauna è dovuta<br />
essenzialmente a due cause:<br />
• elettrocuzione, ovvero fulminazione per contatto <strong>di</strong> elementi conduttori (fenomeno legato<br />
quasi esclusivamente alle linee elettriche a me<strong>di</strong>a tensione, MT);<br />
• collisione in volo con i conduttori (fenomeno legato soprattutto a linee elettriche ad alta<br />
tensione, AT).<br />
L’elettrocuzione si può produrre qualora un uccello tocchi contemporaneamente, con due o<br />
più parti del corpo, specie se bagnate, due elementi elettrici che presentano fra loro una<br />
<strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> potenziale (es. due conduttori o un conduttore ed una struttura conducente <strong>di</strong><br />
una linea MT; Nelson, 1979b, 1980, in Penteriani, 1998). La massima probabilità che questo<br />
avvenga si ha quando l’animale si posa su un palo <strong>di</strong> sostegno o parte <strong>di</strong> esso, quando<br />
effettua movimenti delle ali o del corpo oppure quando tale contatto si verifica attraverso<br />
l’espulsione degli escrementi (che negli uccelli sono sotto forma liquida). Sui rapaci si è visto<br />
che 12 milliampère <strong>di</strong> corrente provocano convulsioni, mentre 17-20 milliampère causano la<br />
morte (Nelson, 1979a, in Penteriani, 1998). Con le linee ad alta tensione, vista la maggior<br />
<strong>di</strong>stanza tra i conduttori, non può verificarsi la folgorazione per contatto.<br />
Il problema della collisione interessa, invece, sia le linee a MT, sia quelle ad AT. Essa<br />
avviene generalmente lontano dalle strutture <strong>di</strong> sostegno qualora l’uccello non s’accorga<br />
della presenza dei cavi sospesi. Particolari conformazioni geografiche del paesaggio attorno<br />
all’elettrodotto possono accentuare questo problema.<br />
Le con<strong>di</strong>zioni atmosferiche influenzano in modo considerevole l’impatto sull’avifauna degli<br />
elettrodotti: si è visto che la <strong>di</strong>rezione del vento prevalente è un fattore molto importante,<br />
così come la sua intensità. Come è ovvio immaginare, la ridotta visibilità può accentuare il<br />
rischio <strong>di</strong> morte per collisione e, in minor misura, per folgorazione. Pioggia e neve, bagnando<br />
il piumaggio, possono aumentare il rischio <strong>di</strong> elettrocuzione specialmente se al riapparire del<br />
sole l’uccello spiega le ali per asciugarle.<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – DESCRIZIONE DELLE CRITICITÀ E DELLE CAUSE DI MINACCIA PAG. 173<br />
Nello specifico, l’area in esame è potenzialmente suscettibile <strong>di</strong> rischio “elettrico” per<br />
l’avifauna, soprattutto in ragione del fatto che il sito è attraversato da elettrodotti e linee<br />
elettriche a me<strong>di</strong>a tensione.<br />
3.10.3 Opere idrauliche<br />
La presenza <strong>di</strong> manufatti invalicabili come <strong>di</strong>ghe, chiuse, briglie e traverse realizzati a vari<br />
scopi, comportano un’interruzione della continuità del corso d’acqua, impedendo alla fauna<br />
ittica i movimenti migratori sia trofici che riproduttivi lungo l'asta fluviale.<br />
Tutte le specie ittiche, infatti, con mo<strong>di</strong> e tempi estremamente <strong>di</strong>fferenti, effettuano<br />
spostamenti lungo i corsi d’acqua per necessità <strong>di</strong> carattere trofico o riproduttivo, nell’ambito<br />
del bacino idrografico oppure muovendosi da o per l’ambiente marino (anguilla, cheppia,<br />
muggine, storione ecc.).<br />
Alla luce <strong>di</strong> questo appare evidente come la fauna ittica sia particolarmente interessata da<br />
un impatto significativo, che può alterare sensibilmente la composizione <strong>di</strong> una comunità<br />
ittica sia dal punto <strong>di</strong> vista qualitativo (tipo e numero <strong>di</strong> specie presenti rispetto alla<br />
vocazione naturale del tratto) che quantitativo (riduzioni <strong>di</strong> densità e biomassa ittica).<br />
FIGURA 6 - DETTAGLIO DELLA TRAVERSA IN COSTRUZIONE SUL F. RENO A PONTECCHIO MARCONI<br />
Tali sbarramenti sono stati osservati lungo il corso del Fiume Reno, e a tal proposito è stata<br />
rilevata la presenza <strong>di</strong> nuova opera in costruzione (ammodernamento <strong>di</strong> una traversa<br />
fluviale) che potrebbe avere incidenza particolarmente negativa sulla conservazione <strong>di</strong> molte<br />
specie ittiche presenti nel fiume Reno in quanto, ad una prima analisi, è sembrata priva <strong>di</strong><br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – DESCRIZIONE DELLE CRITICITÀ E DELLE CAUSE DI MINACCIA PAG. 174<br />
adeguato passaggio pesci. Si tratta della traversa localizzata a Pontecchio Marconi,<br />
all’incirca all’altezza del ponte sul Reno <strong>di</strong> via Chiù. Un’opera <strong>di</strong> tali <strong>di</strong>mensioni e<br />
caratteristiche, se non dotata <strong>di</strong> adeguato passaggio per pesci, rappresenta un elemento <strong>di</strong><br />
forte <strong>di</strong>sturbo e minaccia per la conservazione <strong>di</strong> molte delle specie reofile presenti nel corso<br />
d’acqua.<br />
Anche per quanto riguarda gli altri sbarramenti è stata osservata la mancanza <strong>di</strong> opportune<br />
scale <strong>di</strong> rimonta per il passaggio dei pesci.<br />
Altri fattori <strong>di</strong> minaccia potrebbero essere legati alla realizzazione <strong>di</strong> interventi <strong>di</strong><br />
sistemazione idraulica che comportino mo<strong>di</strong>fiche agli habitat fluviali o alterazioni del regime<br />
idrologico tali da mettere a rischio la sopravvivenza delle popolazioni ittiche presenti.<br />
3.10.4 Impianti per la produzione <strong>di</strong> energia da fonti rinnovabili<br />
Gli impianti per la produzione <strong>di</strong> energia che sfruttano fonti rinnovabili, quali il sole o il vento,<br />
comportano alcuni impatti che è opportuno valutare attentamente durante la fase decisionale<br />
che ne precede la realizzazione. In particolare, per i Chirotteri gli impianti eolici comportano<br />
una serie <strong>di</strong> gravi problematiche quali il rischio <strong>di</strong> collisione con le pale in funzione, la<br />
mo<strong>di</strong>fica dei percorsi migratori e l’abbandono <strong>di</strong> rifugi o territori <strong>di</strong> caccia. Viste le<br />
caratteristiche ecologiche <strong>di</strong> questi animali, tali impatti possono avere effetti negativi<br />
significativi anche ad una certa <strong>di</strong>stanza dalla zona <strong>di</strong> realizzazione dell’impianto. La<br />
vicinanza del SIC alla zona montuosa dell’Appennino, particolarmente interessata dalla<br />
realizzazione <strong>di</strong> queste opere, rende necessaria una particolare attenzione a questa<br />
potenziale criticità.<br />
Premesso che la realizzazione <strong>di</strong> impianti eolici è vietata all’interno delle ZPS ai sensi del<br />
DGR n.1224/08, gli impianti fotovoltaici a terra (parchi solari) in primo luogo possono agire<br />
negativamente in seguito a:<br />
1) sottrazione <strong>di</strong> territorio - habitat d’interesse conservazionistico oppure habitat riproduttivi<br />
o <strong>di</strong> alimentazione per specie d’interesse comunitario.<br />
Ulteriori impatti possono provenire da:<br />
2) strutture <strong>di</strong> servizio realizzate per il funzionamento dell’impianto stesso (p.e. cavi <strong>di</strong><br />
collegamento alla rete elettrica <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione), oppure<br />
3) sistema <strong>di</strong> recinzioni perimetrali che possono ridurre il movimento della fauna al suolo,<br />
oppure<br />
4) <strong>di</strong>spersione nel suolo <strong>di</strong> sostanze chimiche utilizzate per il lavaggio dei pannelli, oppure<br />
5) <strong>di</strong>sturbo causato da attività <strong>di</strong> gestione or<strong>di</strong>naria o straor<strong>di</strong>naria dell’impianto.<br />
Dati relativi ad altre forme d’impatto sulla fauna non sono <strong>di</strong>sponibili, ma meriterebbero stu<strong>di</strong><br />
specifici (p.e. valutazione dell’effetto specchio dei pannelli sull’avifauna migratrice).<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – DESCRIZIONE DELLE CRITICITÀ E DELLE CAUSE DI MINACCIA PAG. 175<br />
3.11 Urbanizzazione<br />
La presenza <strong>di</strong> piccoli centri urbani non è <strong>di</strong> per sé una minaccia per la chirotterofauna, anzi,<br />
alcune specie traggono beneficio dalla presenza <strong>di</strong> alcuni manufatti antropici, all’interno dei<br />
quali possono trovare rifugio. Esistono tuttavia alcune attività umane collegate alla presenza<br />
<strong>di</strong> centri abitati che sono potenzialmente dannose per i pipistrelli. La massiccia<br />
nebulizzazione <strong>di</strong> pestici<strong>di</strong>, specialmente nel periodo estivo, è uno <strong>di</strong> questi fattori, ma anche<br />
la presenza <strong>di</strong> una forte illuminazione dà luogo a fenomeni <strong>di</strong> inquinamento luminoso che<br />
possono <strong>di</strong>sturbare fortemente l’attività <strong>di</strong> questi animali. La rete stradale che collega i centri<br />
abitati è anch’essa una minaccia a causa dei potenziali impatti degli animali con i veicoli,<br />
anche se è ancora poco chiara l’entità <strong>di</strong> questa fonte <strong>di</strong> <strong>di</strong>sturbo. All’interno del SIC sono<br />
presenti alcune abitazioni e strade <strong>di</strong> comunicazione moderatamente illuminate che<br />
costituiscono delle modeste cause <strong>di</strong> minaccia per la conservazione dei chirotteri presenti.<br />
Uno dei problemi ancora irrisolti del sito e fonte <strong>di</strong> potenziale ulteriore inquinamento <strong>di</strong> falda<br />
e suolo è la presenza <strong>di</strong> alcune micro<strong>di</strong>scariche abusive, nonché la presenza <strong>di</strong> <strong>di</strong>ffuse<br />
baraccopoli in sinistra idraulica del Reno (Figura 7). Queste ultime interrompono <strong>di</strong> fatto la<br />
continuità del corridoio ecologico fluviale, frammentando gli habitat 91E0* e 92A0 in piccole<br />
tessere non più connesse tra loro.<br />
FIGURA 7 – DISCARICA ABUSIVA.<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – DESCRIZIONE DELLE CRITICITÀ E DELLE CAUSE DI MINACCIA PAG. 176<br />
3.12 Attività agricole intensive<br />
Il sistema agricolo del sito è essenzialmente caratterizzato da un ruolo decisamente<br />
dominante dei seminativi.<br />
L’impiego nelle pratiche agricole <strong>di</strong> concimi, sia <strong>di</strong> sintesi, sia naturali, <strong>di</strong> pestici<strong>di</strong> e<br />
fertilizzanti produce accumuli <strong>di</strong> queste sostanze nelle acque <strong>di</strong> falda con aumenti delle<br />
concentrazioni anche nelle acque <strong>di</strong> scorrimento fluviale; tali concentrazioni possono<br />
assumere valori elevati in corrispondenza <strong>di</strong> stagioni secche e perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> bassa portata<br />
fluviale.<br />
3.13 Gestione forestale<br />
3.13.1 Boschi ripariali<br />
Il bosco ripariale lungo il Reno è esposto a rischi <strong>di</strong> taglio e degrado per orti abusivi e<br />
gestione idraulica delle sponde.<br />
Il taglio della vegetazione riparia trova giustificazione prettamente sotto il profilo idraulico,<br />
quando viene effettuato in tratti <strong>di</strong> corsi d’acqua siti a monte <strong>di</strong> aree urbanizzate, con<br />
presenza <strong>di</strong> infrastrutture che potrebbero subire gravi danni od occludersi con conseguente<br />
potenziale pericolo per la pubblica incolumità. Non <strong>di</strong> meno la presenza <strong>di</strong> grossi accumuli <strong>di</strong><br />
materiale, associata alla presenza <strong>di</strong> vegetazione arborea al centro alveo, comporta<br />
deviazioni del flusso verso i versanti durante gli eventi <strong>di</strong> piena, con destabilizzazione degli<br />
stessi e con inizio <strong>di</strong> fenomeni erosivi <strong>di</strong> una certa rilevanza.<br />
Il taglio della vegetazione riparia arreca impatti molto pesanti all’ecosistema fluviale, sia per<br />
quanto riguarda la parte terrestre (riduzione o scomparsa <strong>di</strong> specie animali, interruzione dei<br />
corridoi ecologici), sia per quella acquatica. Questa viene ad essere negativamente alterata<br />
da una riduzione dell’input <strong>di</strong> sostanza organica al torrente, da un aumento della<br />
temperatura dell’acqua da un minor ombreggiamento della corrente, da una minor capacità<br />
assorbente della fascia tampone riparia, e da una ridotta immissione in alveo <strong>di</strong> detrito<br />
legnoso <strong>di</strong> gran<strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni. Il detrito legnoso assume infatti una valenza ecologica molto<br />
importante, poiché favorisce i fenomeni <strong>di</strong> erosione localizzata che portano alla formazione<br />
<strong>di</strong> pozze, determina lo stoccaggio <strong>di</strong> se<strong>di</strong>menti e materiale organico aumentando la capacità<br />
<strong>di</strong> ritenzione della sostanza organica, rilascia gradualmente esso stesso sostanza organica<br />
alla corrente, ed infine rappresenta un habitat ideale per varie specie animali (invertebrati,<br />
anfibi, uccelli).<br />
Inoltre anche l’inquinamento <strong>di</strong>ffuso con oli dovuto ad un marcato utilizzo della motosega<br />
può avere rilevanze non trascurabili (circa l’85% dell’olio impiegato per la lubrificazione viene<br />
<strong>di</strong>sperso a terra). Elevate risultano essere anche le emissioni sonore e <strong>di</strong> sostanze inquinanti<br />
derivanti dalla combustione del carburante.<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – DESCRIZIONE DELLE CRITICITÀ E DELLE CAUSE DI MINACCIA PAG. 177<br />
Le larve <strong>di</strong> Apatura ilia (Lepidoptera Nymphalidae) superano la stagione invernale appese ai<br />
rami esili <strong>di</strong> pioppi e salici, pertanto la loro potatura è inopportuna perché può comportare la<br />
per<strong>di</strong>ta delle larve.<br />
3.13.2 Boschi collinari<br />
I boschi presenti nell'area sono in gran parte giovani, hanno una struttura estremamente<br />
semplice, sono privi delle cavità arboree utili al ciclo biologico <strong>di</strong> numerosi uccelli, chirotteri,<br />
mammiferi arboricoli e insetti e sono gestiti spesso in modo sfavorevole alle suddette specie<br />
con tagli eccessivi, tagli in periodo riproduttivo e rimozione <strong>di</strong> alberi secchi e morti.<br />
L'utilizzazione del bosco come ceduo per la produzione <strong>di</strong> legna da ardere da catasta<br />
prevede un drastico taglio raso sulle ceppaie e il rilascio <strong>di</strong> poche matricine a coprire il<br />
terreno e a garantire un minimo <strong>di</strong> rinnovazione per seme. Così, generalmente a <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong><br />
12-15 anni, il bosco è soggetto a un drastico sconvolgimento dal punto <strong>di</strong> vista strutturale<br />
(azzeramento pressoché totale della biomassa aerea), energetico (con luce e calore che<br />
arrivano in grande quantità al suolo), ma naturalmente anche paesaggistico ed ecologico in<br />
senso generale. Sicuramente questa gestione non riflette un fenomeno ricorrente in natura.<br />
Piuttosto esprime una forma <strong>di</strong> intervento deciso da parte dell'uomo, propenso a trarne dei<br />
benefici, che è facilitato dall'enorme vitalità e dalla lunga e mite stagione vegetativa del<br />
bosco me<strong>di</strong>terraneo.<br />
A livello locale, <strong>di</strong> popolamento, dal punto <strong>di</strong> vista ecologico <strong>di</strong>venta quin<strong>di</strong> auspicabile<br />
riuscire a ridurre gli effetti negativi sulla bio<strong>di</strong>versità specifica, in particolar modo in termini <strong>di</strong><br />
composizione arborea: infatti a scadenza ravvicinata i tagli producono un forte impatto<br />
sull'ecosistema che ha come conseguenza imme<strong>di</strong>ata lo svantaggio competitivo delle specie<br />
mesofile e poco pollonifere nei confronti <strong>di</strong> quelle più rustiche e <strong>di</strong> più facile ricaccio.<br />
3.14 Gestione delle aree <strong>di</strong> foraggiamento per i Chirotteri<br />
Le <strong>di</strong>verse specie <strong>di</strong> Chirotteri si sono specializzate nel corso dell’evoluzione a rifugiarsi e<br />
alimentarsi in <strong>di</strong>verse tipologie ambientali. Ciò comporta che per la conservazione <strong>di</strong> una ben<br />
strutturata chirotterofauna è fondamentale che il territorio venga gestito in modo da<br />
consentire la presenza <strong>di</strong> un complesso mosaico ambientale, che comprenda cioè un<br />
sistema <strong>di</strong> habitat <strong>di</strong>versi e interconnessi. Questo lo si ritrova ad esempio nella tra<strong>di</strong>zionale<br />
gestione della campagna dal tipico paesaggio agro-silvo-pastorale, in cui si riconosce un<br />
mosaico <strong>di</strong> ambienti agricoli, boscati e prati/pascoli. Il progressivo abbandono delle<br />
campagne e il cambiamento del tipo <strong>di</strong> gestione agricola da estensiva e <strong>di</strong>versificata ad<br />
intensiva monoculturale, sono le principali minacce che affliggono la conservazione<br />
dell’ambiente agricolo. Per quanto riguarda il bosco occorre evitare meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> gestione che<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – DESCRIZIONE DELLE CRITICITÀ E DELLE CAUSE DI MINACCIA PAG. 178<br />
non siano sostenibili, quali ad esempio il ceduo con taglio raso, in quanto questi<br />
<strong>di</strong>minuiscono drasticamente la complessità e la funzionalità dell’ecosistema boschivo. Sono<br />
altrettanto importanti i prati/pascoli, spesso in <strong>di</strong>minuzione a causa del progressivo<br />
abbandono dell’attività pastorizia. Si corre in questo caso il rischio che la naturale evoluzione<br />
<strong>di</strong> questi ambienti a quote me<strong>di</strong>o/basse li sostituisca gradualmente prima con arbusteti e<br />
successivamente con boschi. L’interconnessione <strong>di</strong> questi ambienti deve essere infine<br />
garantita da una serie <strong>di</strong> formazioni lineari quali siepi, filari <strong>di</strong> alberi e formazioni riparie, in<br />
grado <strong>di</strong> stabilire una vera e propria connessione ecologica tra gli ambienti. Queste<br />
formazioni sono infatti importanti per i Chirotteri sia come serbatoio <strong>di</strong> insetti che come<br />
elementi <strong>di</strong> riferimento durante gli spostamenti.<br />
3.15 Distruzione e perturbazione dei rifugi dei Chirotteri<br />
Una delle più gravi minacce per la conservazione dei Chirotteri è senza dubbio il <strong>di</strong>sturbo<br />
presso i rifugi che questi animali utilizzano durante l’anno. A seconda delle esigenze e delle<br />
caratteristiche delle varie specie, i rifugi si possono ritrovare: in ambienti ipogei, quali grotte<br />
o miniere; in ambito forestale, nelle fessure presenti sugli alberi maturi; su infrastrutture<br />
realizzate dall’uomo, quali ad esempio anfratti nelle costruzioni oppure ampi spazi come<br />
soffitte e cantine; in ambiente rupicolo, nelle spaccature delle rocce.<br />
3.15.1 Ambiente ipogeo<br />
Le maggiori minacce che affliggono questi rifugi sono dovute alla frequentazione da parte<br />
dell’uomo, generalmente per attività speleologica, ma in alcuni casi, specialmente per<br />
piccole cavità, anche da parte <strong>di</strong> semplici escursionisti. La turisticizzazione <strong>di</strong> certe cavità<br />
può anch’essa comportare un grave pericolo, come anche la chiusura dell’ingresso delle<br />
grotte/miniere con meto<strong>di</strong> che non consentano il passaggio dei pipistrelli. All'interno del SIC<br />
presso il Parco Talon sono presenti 2 rifugi sotterranei risalenti alla Seconda Guerra<br />
Mon<strong>di</strong>ale al cui interno sono segnalate da tempo <strong>di</strong>verse specie <strong>di</strong> chirotteri troglofili. Le<br />
cavità sono già state oggetto <strong>di</strong> specifiche misure <strong>di</strong> conservazione come l’applicazione <strong>di</strong><br />
opportune griglie che permettono il passaggio dei pipistrelli e che impe<strong>di</strong>scono l’accesso alle<br />
persone. Per una <strong>di</strong> queste cavità è stata ipotizzata una parziale turisticizzazione da parte<br />
dell’amministrazione comunale <strong>di</strong> Casalecchio <strong>di</strong> Reno. Occorre regolamentare le visite<br />
turistiche in modo da non creare <strong>di</strong>sturbo alle popolazioni <strong>di</strong> Chirotteri presenti all’interno del<br />
rifugio.<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 2 – DESCRIZIONE DELLE CRITICITÀ E DELLE CAUSE DI MINACCIA PAG. 179<br />
3.15.2 Ambiente forestale<br />
I rifugi in ambito forestale sono costituiti principalmente dalle cavità che si formano sugli<br />
alberi <strong>di</strong> gran<strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni, siano esse dovute al grado <strong>di</strong> maturazione della pianta (cavità <strong>di</strong><br />
marcescenza, esfoliazione della corteccia) o dall’intervento <strong>di</strong> altri animali (ad esempio ni<strong>di</strong><br />
<strong>di</strong> picchio abbandonati). Alberi abbastanza maturi che presentino questo tipo <strong>di</strong> cavità sono<br />
assai rari, in quanto spesso la gestione del bosco non ne prevede la presenza, sia per una<br />
loro sostanziale improduttività che per il rischio <strong>di</strong> caduta, con successivo danno al resto<br />
degli in<strong>di</strong>vidui più giovani e dunque produttivi. Anche al <strong>di</strong> fuori dei contesti strettamente<br />
produttivi, alberi <strong>di</strong> gran<strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni che corrano il rischio <strong>di</strong> cadere sono spesso rimossi<br />
per questioni <strong>di</strong> sicurezza nei confronti degli utenti del bosco. Il SIC è contrad<strong>di</strong>stinto dalla<br />
presenza <strong>di</strong> una buona copertura boscosa, consentendo la presenza <strong>di</strong> specie, quali N.<br />
leisleri e N. noctula, profondamente legate all’ecosistema boschivo maturo. Risulta dunque<br />
necessario attuare politiche <strong>di</strong> gestione forestale sostenibile per la conservazione dei<br />
Chirotteri fitofili presenti.<br />
3.15.3 Rifugi per pipistrelli sinantropi<br />
Molte specie <strong>di</strong> pipistrelli si sono adattate a rifugiarsi nelle infrastrutture realizzate dall’uomo,<br />
vicariando in parte quelli che sono i loro rifugi originari. Questa nuova tipologia <strong>di</strong> rifugi è in<br />
grado <strong>di</strong> offrire un riparo sia a quelle specie che utilizzano le fessure che a quelle che<br />
necessitano <strong>di</strong> ampi spazi in cui riposare. Tra le situazioni più comuni si possono ritrovare<br />
pipistrelli in soffitte, cantine, interstizi dei muri, <strong>di</strong>etro le grondaie, sotto le tegole, ma anche al<br />
<strong>di</strong> sotto <strong>di</strong> ponti o in altri tipi <strong>di</strong> manufatti come ad esempio pali cavi in cemento. Gran parte<br />
<strong>di</strong> questi rifugi si ritrovano in contesti abbandonati, apparentemente tranquilli, che corrono<br />
tuttavia il rischio <strong>di</strong> venire <strong>di</strong>strutti a causa del crollo del manufatto. Altro pericolo per questi<br />
rifugi è la ristrutturazione o la manutenzione della struttura, in quanto in genere i lavori<br />
vengono condotti senza sapere della possibile presenza dei pipistrelli (ad esempio l’e<strong>di</strong>ficio<br />
nel complesso “Ganzole”, con due in<strong>di</strong>vidui <strong>di</strong> H. savii ed alcuni segni <strong>di</strong> presenze<br />
probabilmente attribuibili a R. ferrumequinum). La minaccia forse maggiore resta in ogni<br />
caso la <strong>di</strong>fficile convivenza che spesso si instaura con le persone che utilizzano il manufatto<br />
colonizzato dai pipistrelli. Infondate superstizioni e ingiustificate fobie accompagnano questo<br />
gruppo animale, rendendolo non particolarmente simpatico agli occhi dei più, ed è proprio<br />
per questo che spesso chi ha la fortuna <strong>di</strong> ospitare questi utilissimi animali tende comunque<br />
a scacciarli o peggio, ucciderli. Vista la presenza nel SIC <strong>di</strong> alcuni e<strong>di</strong>fici, principalmente in<br />
uso, è necessario porre particolare attenzione a questa minaccia, così da informare le<br />
persone e poter intervenire con semplici accorgimenti in caso <strong>di</strong> problematiche <strong>di</strong> questo<br />
tipo.<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 4 – DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE STRATEGIE GESTIONALI PAG. 180<br />
4 DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE STRATEGIE GESTIONALI<br />
4.1 Obiettivi generali<br />
Dal punto <strong>di</strong> vista generale lo scopo della pre<strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> misure conservative in un sito<br />
Natura 2000, secondo quando <strong>di</strong>sposto dalla Direttiva “Habitat” 92/43/CEE e dalla Direttiva<br />
“Uccelli” 79/409/CEE, è rappresentato dalla conservazione della stessa ragion d'essere del<br />
sito, e si sostanzia nel salvaguardare la struttura e la funzione degli habitat e/o garantire la<br />
persistenza a lungo termine delle specie alle quali ciascun sito è "de<strong>di</strong>cato" (cfr. artt. 6 e 7<br />
Direttiva 92/43/CEE).<br />
Il concetto <strong>di</strong> conservazione figura nel sesto “considerando” della premessa alla Direttiva<br />
“Habitat” 92/43/CEE che recita: «considerando che, per assicurare il ripristino o il<br />
mantenimento degli habitat naturali e delle specie <strong>di</strong> interesse comunitario in uno stato <strong>di</strong><br />
conservazione sod<strong>di</strong>sfacente, occorre designare zone speciali <strong>di</strong> conservazione per<br />
realizzare una rete ecologica europea coerente, secondo uno scadenzario definito»; e<br />
nell’ottavo “considerando”: «considerando che, in ciascuna zona designata, occorre attuare<br />
le misure necessarie in relazione agli obiettivi <strong>di</strong> conservazione previsti».<br />
All’articolo 1, lettera a), della <strong>di</strong>rettiva figura poi la definizione seguente: «a) conservazione:<br />
un complesso <strong>di</strong> misure necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat naturali e le<br />
popolazioni <strong>di</strong> specie <strong>di</strong> fauna e flora selvatiche in uno stato sod<strong>di</strong>sfacente ai sensi delle<br />
lettere e) ed i)».<br />
L’articolo 2, paragrafo 2 in particolare, specifica l’obiettivo delle misure da adottare a norma<br />
della <strong>di</strong>rettiva: «Le misure adottate (…) sono intese ad assicurare il mantenimento o il<br />
ripristino, in uno stato <strong>di</strong> conservazione sod<strong>di</strong>sfacente, degli habitat naturali e della specie <strong>di</strong><br />
fauna e flora selvatiche <strong>di</strong> interesse comunitario».<br />
Le misure <strong>di</strong> conservazione necessarie devono pertanto mirare a mantenere o ripristinare lo<br />
stato <strong>di</strong> conservazione sod<strong>di</strong>sfacente dei tipi <strong>di</strong> habitat naturali e delle specie <strong>di</strong> interesse<br />
comunitario.<br />
Lo stato <strong>di</strong> conservazione è definito all’articolo 1 della <strong>di</strong>rettiva:<br />
• per un habitat naturale, l’articolo 1, lettera e), specifica che è: “l’effetto della somma dei<br />
fattori che influiscono sull’habitat naturale in causa, nonché sulle specie tipiche che in<br />
esso si trovano, che possono alterare a lunga scadenza la sua ripartizione naturale, la<br />
sua struttura e le sue funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie tipiche (…)”;<br />
• per una specie, l’articolo 1, lettera i), specifica che è: “l’effetto della somma dei fattori<br />
che, influendo sulle specie in causa, possono alterare a lungo termine la ripartizione e<br />
l’importanza delle sue popolazioni (…)”.<br />
Lo stato <strong>di</strong> conservazione sod<strong>di</strong>sfacente è anche definito sempre all’articolo 1:<br />
• per un habitat naturale quando «la sua area <strong>di</strong> ripartizione naturale e le superfici che<br />
comprende sono stabili o in estensione; la struttura e le funzioni specifiche necessarie al<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 4 – DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE STRATEGIE GESTIONALI PAG. 181<br />
suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un<br />
futuro preve<strong>di</strong>bile; lo stato <strong>di</strong> conservazione delle specie tipiche è sod<strong>di</strong>sfacente»;<br />
• per una specie quando: «i dati relativi all’andamento delle popolazioni della specie in<br />
causa in<strong>di</strong>cano che tale specie continua e può continuare a lungo termine ad essere un<br />
elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene; l’area <strong>di</strong> ripartizione naturale <strong>di</strong> tale<br />
specie non è in declino né rischia <strong>di</strong> declinare in un futuro preve<strong>di</strong>bile; esiste e<br />
continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si<br />
mantengano a lungo termine».<br />
L’articolo 6, paragrafo 1, specifica che le misure <strong>di</strong> conservazione necessarie devono essere<br />
conformi «alle esigenze ecologiche dei tipi <strong>di</strong> habitat naturali <strong>di</strong> cui all’allegato I e delle<br />
specie <strong>di</strong> cui all’allegato II presenti nei siti». Nel concetto sono comprese tutte le esigenze<br />
dei fattori abiotici e biotici necessari per garantire lo stato <strong>di</strong> conservazione sod<strong>di</strong>sfacente dei<br />
tipi <strong>di</strong> habitat e delle specie, comprese le loro relazioni con l’ambiente (aria, acqua, suolo,<br />
vegetazione ecc.).<br />
In riferimento al sito in esame la definizione <strong>di</strong> obiettivi e misure <strong>di</strong> conservazione costituisce<br />
una sintesi complessa risultante da una analisi condotta in merito alla verifica della presenza<br />
<strong>di</strong> habitat e specie, al loro stato conservativo, alle minacce rilevate o potenziali.<br />
Gli obiettivi generali possono quin<strong>di</strong> essere sintetizzati in:<br />
• favorire, attraverso specifiche misure gestionali, il mantenimento o il ripristino, in uno<br />
stato <strong>di</strong> conservazione sod<strong>di</strong>sfacente, degli habitat e delle specie <strong>di</strong> interesse<br />
conservazionistico presenti nel sito;<br />
• promuovere la gestione razionale degli habitat presenti, assicurando al contempo la<br />
corretta fruizione del patrimonio naturale da parte dei citta<strong>di</strong>ni.<br />
4.2 Obiettivi specifici<br />
4.2.1 Generalità<br />
La tutela degli habitat e delle specie <strong>di</strong> importanza comunitaria è possibile contrastando le<br />
minacce gravanti sull’ecosistema, attraverso una serie <strong>di</strong> azioni organizzate nell’ambito dei<br />
seguenti obiettivi specifici:<br />
1) mantenere e migliorare il livello <strong>di</strong> bio<strong>di</strong>versità degli habitat e delle specie <strong>di</strong> interesse<br />
comunitario per i quali il sito è stato designato;<br />
2) mantenere e/o ripristinare gli equilibri biologici alla base dei processi naturali (ecologici<br />
ed evolutivi);<br />
3) ridurre le cause <strong>di</strong> declino delle specie rare o minacciate ed i fattori che possono<br />
causare la per<strong>di</strong>ta o la frammentazione degli habitat all’interno del sito e nelle zone<br />
a<strong>di</strong>acenti;<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 4 – DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE STRATEGIE GESTIONALI PAG. 182<br />
4) tenere sotto controllo ed eventualmente limitare le attività che incidono sull’integrità<br />
ecologica dell’ecosistema (es. organizzazione delle attività <strong>di</strong> fruizione <strong>di</strong>dattico-<br />
ricreativa secondo modalità compatibili con le esigenze <strong>di</strong> conservazione attiva degli<br />
habitat e delle specie);<br />
5) in<strong>di</strong>viduare e attivare i processi necessari per promuovere lo sviluppo <strong>di</strong> attività<br />
economiche compatibili con gli obiettivi <strong>di</strong> conservazione dell’area (es. regolamentazione<br />
delle attività produttive);<br />
6) promuovere l’attività <strong>di</strong> ricerca scientifica attraverso la definizione <strong>di</strong> campagne <strong>di</strong><br />
indagine mirate alla caratterizzazione <strong>di</strong> componenti specifiche del sistema;<br />
7) attivare meccanismi socio – politico - amministrativi in grado <strong>di</strong> garantire una gestione<br />
attiva ed omogenea del sito (es. gestione dei livelli e della qualità delle acque).<br />
4.2.2 Habitat<br />
4.2.2.1 Habitat del greto fluviale lungamente o perennemente allagati (3270 - Fiumi<br />
con argini melmosi con vegetazione del Chenopo<strong>di</strong>on rubri p.p e Bidention<br />
p.p.)<br />
La conservazione degli habitat <strong>di</strong> greto lungamente o perennemente allagati è strettamente<br />
connessa con una adeguata <strong>di</strong>sponibilità idrica fluviale durante tutto l’anno e dall’assenza <strong>di</strong><br />
eccessivi carichi inquinanti.<br />
È opportuno pertanto garantire il Deflusso Minimo Vitale e rispettare in tutto il sito i criteri <strong>di</strong><br />
qualità delle acque previsti dalla normativa vigente. Occor<strong>rer</strong>à inoltre monitorare il regime e<br />
la qualità delle acque per evitare un’eccessiva accelerazione dei processi <strong>di</strong> proliferazione<br />
algale con<strong>di</strong>zionati da un livello trofico troppo elevato.<br />
Gli ambienti fluviali, a causa della loro natura instabile, sono particolarmente soggetti ad<br />
essere occupati da specie alloctone invasive, soprattutto in pianura e nelle aree ad esse<br />
a<strong>di</strong>acenti. È pertanto opportuno eseguire un monitoraggio attento e continuo degli habitat<br />
per potere tempestivamente accertare situazioni critiche dovute all’espansione <strong>di</strong> specie<br />
indesiderate e prendere gli opportuni provve<strong>di</strong>menti per contenerle ed eventualmente<br />
era<strong>di</strong>carle.<br />
Nell'area <strong>di</strong> presenza dell'habitat 3270 la riduzione o l’eliminazione dei rischi <strong>di</strong> alterazione<br />
morfologica e funzionale è garantita dal rispetto del <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> esecuzione <strong>di</strong> interventi <strong>di</strong><br />
regimazione idraulica nel periodo riproduttivo <strong>di</strong> pesci e uccelli. Tali interventi sono ammessi<br />
solo ed esclusivamente nel caso <strong>di</strong> comprovati ed imprescin<strong>di</strong>bili motivi <strong>di</strong> sicurezza idraulica<br />
e in caso <strong>di</strong> eventi eccezionali (inondazioni e siccità). In tal caso è necessario, per quanto<br />
possibile, non alterare la morfologia del substrato che ospita l'habitat (banchi fangoso-<br />
limosi).<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 4 – DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE STRATEGIE GESTIONALI PAG. 183<br />
4.2.2.2 Invasi idrici d’acqua dolce lentica (3130 - Acque stagnanti, da oligotrofe a<br />
mesotrofe, con vegetazione dei Littorellete uniflorae e/o degli Isoëto-<br />
Nanojuncetea; 3140 - Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione<br />
bentica <strong>di</strong> Chara spp.; 3150 - Laghi eutrofici naturali con vegetazione del<br />
Magnopotamion o Hydrocharition)<br />
La conservazione degli habitat acquatici è strettamente connessa con la corretta gestione<br />
dei livelli idrici e della qualità delle acque per quanto in precedenza evidenziato. E’<br />
opportuno monitorare regime e qualità delle acque per evitare un’eccessiva accelerazione<br />
dei processi <strong>di</strong> proliferazione algale con<strong>di</strong>zionati da un livello trofico troppo elevato. E’ quin<strong>di</strong><br />
opportuno salvaguardare le vegetazioni elofitiche circostanti che separano il corpo acquatico<br />
dal contesto colturale esterno e per quanto possibile evitare l’immissione <strong>di</strong> acque che<br />
drenano superfici agrarie soggette a fertilizzazione.<br />
La vegetazione acquatica è soggetta ad essere danneggiata/<strong>di</strong>strutta dalle nutrie, che si<br />
cibano <strong>di</strong> <strong>di</strong>verse specie idrofitiche. Occorre pertanto controllare la popolazione della nutria<br />
attraverso la sua cattura.<br />
4.2.2.3 Formazioni legnose ripariali (3240 - Fiumi alpini con vegetazione riparia<br />
legnosa a Salix eleagnos, 91E0 - *Foreste alluvionali <strong>di</strong> Alnus glutinosa e<br />
Fraxinus excelsior (Alno-Pa<strong>di</strong>on, Alnion incanae, Salicion albae) e 92A0 -<br />
Foreste a galleria <strong>di</strong> Salix alba e Populus alba)<br />
Le formazioni legnose ripariali, oltre all'elevato valore naturalistico, svolgono un'importante<br />
funzione nella regimazione delle acque, nel consolidamento del greto - quin<strong>di</strong> <strong>di</strong> protezione<br />
<strong>di</strong>retta dall'erosione fluviale - e <strong>di</strong> fascia tampone per i prodotti ammendanti e anticrittogamici<br />
usati negli appezzamenti agricoli a<strong>di</strong>acenti alle aree fluviali. Per un buono stato <strong>di</strong><br />
conservazione è necessario favorire il contenimento delle specie vegetali alloctone.<br />
Occor<strong>rer</strong>à pertanto eseguire un monitoraggio attento e continuo degli habitat per potere<br />
tempestivamente accertare situazioni critiche dovute all’espansione <strong>di</strong> specie indesiderate<br />
(in particolare Robinia pseudoacacia) e prendere gli opportuni provve<strong>di</strong>menti per contenerle<br />
ed eventualmente era<strong>di</strong>carle. Il contenimento <strong>di</strong> Robinia pseudoacacia dovrà essere<br />
realizzato attraverso la cercinatura delle piante.<br />
Occor<strong>rer</strong>à prevedere la conservazione della necromassa attraverso la regolamentazione<br />
dell’asportazione del legno morto (tronchi e rami sia in pie<strong>di</strong> che a terra) da boschi, siepi e<br />
boschetti ripariali. I vecchi alberi morti, sia quelli ancora in pie<strong>di</strong>, sia quelli già schiantati e i<br />
grossi rami cariati costituiscono un importante luogo dove, in tempi e mo<strong>di</strong> <strong>di</strong>versi, vari<br />
vertebrati ricercano il cibo, ni<strong>di</strong>ficano o semplicemente si rifugiano. Ad esempio la maggior<br />
parte dei pici<strong>di</strong> sono importanti predatori <strong>di</strong> faune saproxiliche e la scarsa <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong><br />
tronchi morti o marcescenti è la causa principale della loro rarefazione o scomparsa da una<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 4 – DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE STRATEGIE GESTIONALI PAG. 184<br />
vasta porzione della Pianura Padana. Molto più nutrita è la schiera degli uccelli che sfruttano<br />
le cavità <strong>di</strong> tronchi e rami per costruirvi il nido. Ad esempio, la presenza <strong>di</strong> queste cavità è<br />
determinante per il successo riproduttivo <strong>di</strong> alcuni strigiformi, micromammiferi e chirotteri.<br />
I tronchi caduti al suolo e le cataste <strong>di</strong> rami costituiscono per insettivori e ro<strong>di</strong>tori terricoli<br />
un’importante nicchia trofica e una ricca <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> rifugi. Infatti l’accumulo sul terreno <strong>di</strong><br />
cortecce, rami marcescenti ed altri residui vegetali, ne favoriscono la presenza, poiché<br />
rappresentano luoghi in cui ricercare invertebrati <strong>di</strong> varie specie che costituiscono<br />
un’importante frazione della loro <strong>di</strong>eta. La presenza <strong>di</strong> quantità considerevoli <strong>di</strong> necromassa<br />
non è un fattore negativo nel bosco perché la sua decomposizione è realizzata in buona<br />
parte dall’attacco dell’entomofauna saproxilici. Gli insetti saproxilici non arrecano danni alle<br />
piante sane, il legno caduto a terra e i ceppi contribuiscono a <strong>di</strong>versificare l’ampio spettro <strong>di</strong><br />
microambienti <strong>di</strong> un bosco e gli alberi senescenti e il legno morto rappresentano<br />
un’importante riserva <strong>di</strong> bio<strong>di</strong>versità. Varie specie <strong>di</strong> Coleotteri saproxilici si trovano solo<br />
all’interno del legno a terra in decomposizione e marcescente o morto in pie<strong>di</strong>, ma la gran<br />
parte vive al suolo e trae beneficio in<strong>di</strong>retto dalla presenza <strong>di</strong> questo materiale organico<br />
attraverso un aumento, ben documentato, della <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> prede ed in particolare degli<br />
invertebrati saproxilofagi primari.<br />
Un altro importante obiettivo è la rigenerazione o più in generale la gestione attiva per i<br />
popolamenti invecchiati <strong>di</strong> salice bianco con morie e presenza <strong>di</strong> specie alloctone.<br />
4.2.2.4 Formazioni erbose aride e sassose (6110 - *Formazioni erbose rupicole<br />
calcicole o basofile dell’Alysso-Se<strong>di</strong>on albae; 6220 - *Percorsi substeppici <strong>di</strong><br />
graminacee e piante annue dei Thero-Brachypo<strong>di</strong>etea)<br />
Si tratta <strong>di</strong> habitat che non mostrano particolari tendenze evolutive, essendo in genere<br />
bloccati dalle estreme con<strong>di</strong>zioni edafiche in cui si sviluppano. La conservazione degli<br />
habitat rupestri <strong>di</strong>pende in primo luogo dalla regolamentazione della fruizione antropica e<br />
quin<strong>di</strong> dal contenimento dei fenomeni <strong>di</strong> calpestio e raccolta.<br />
Nonostante la loro stabilità, non si può però escludere che tali habitat possano evolvere<br />
verso la formazione <strong>di</strong> fitocenosi arbustive. Occorre pertanto sottoporre tali habitat a<br />
continuo e attento monitoraggio per in<strong>di</strong>viduare tempestivamente l’innesco <strong>di</strong> <strong>di</strong>namiche<br />
indesiderate o l’ingresso <strong>di</strong> specie esotiche. Ciò consentirà <strong>di</strong> prendere gli opportuni<br />
provve<strong>di</strong>menti per evitare l’alterazione o la scomparsa <strong>di</strong> questi ambienti.<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 4 – DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE STRATEGIE GESTIONALI PAG. 185<br />
4.2.2.5 Praterie aride (6210 - *Formazioni erbose secche seminaturali e facies<br />
coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*con<br />
stupenda fioritura <strong>di</strong> orchidee)<br />
Il principale obiettivo per questo habitat prioritario è evitare la sua alterazione o la sua<br />
scomparsa a causa dell’eccessiva crescita <strong>di</strong> vegetazione arbustiva che precede<br />
l’affermazione <strong>di</strong> fitocenosi forestali. Tale obiettivo potrà essere conseguito attraverso<br />
l’esecuzione <strong>di</strong> sfalci mirati ed eventualmente attraverso interventi <strong>di</strong> trinciatura <strong>di</strong> aree<br />
particolarmente invase da arbusti.<br />
Occorre inoltre limitare i danneggiamenti provocati da cinghiali e caprioli. Oltre al<br />
contenimento del numero dei cinghiali, in via sperimentale si potrà inoltre prevedere la<br />
protezione <strong>di</strong> alcune porzioni <strong>di</strong> prateria con la realizzazione <strong>di</strong> apposite recinzioni.<br />
4.2.2.6 Praterie umide (6430 - Bordure planiziali, montane e alpine <strong>di</strong> megaforbie<br />
idrofile)<br />
Lo stato <strong>di</strong> conservazione sod<strong>di</strong>sfacente dell’habitat <strong>di</strong>pende dal contenimento delle specie<br />
vegetali alloctone invasive.<br />
4.2.2.7 Prati stabili (6510 - Praterie magre da fieno a bassa altitu<strong>di</strong>ne (Alopecurus<br />
pratensis, <strong>San</strong>guisorba officinalis))<br />
Il mantenimento <strong>di</strong> uno stato <strong>di</strong> conservazione sod<strong>di</strong>sfacente dei prati stabili deve prevedere<br />
(attraverso il reperimento <strong>di</strong> incentivi economici) l’applicazione delle tra<strong>di</strong>zionali tecniche <strong>di</strong><br />
coltivazione, che consistono in sfalci regolari (almeno 2 all’anno), irrigazione e<br />
concimazione. Occor<strong>rer</strong>à inoltre regolamentare le tecniche <strong>di</strong> sfalcio del prato stabile,<br />
adottando soluzioni che assicurino la conservazione dell’elevata bio<strong>di</strong>versità che li<br />
caratterizza. In particolare occor<strong>rer</strong>à prevedere l’effettuazione <strong>di</strong> sfalci tar<strong>di</strong>vi, l’utilizzo <strong>di</strong><br />
barre d’involo e una procedura <strong>di</strong> intervento dal centro degli appezzamenti verso l’esterno<br />
con <strong>di</strong>rezione centrifuga, a velocità ridotta.<br />
Il reperimento <strong>di</strong> incentivi economici per chi mantiene la coltivazione del prato stabile sarà<br />
fondamentale per evitare la sua conversione in seminativi.<br />
4.2.2.8 Boschi collinari (91AA - *Boschi orientali <strong>di</strong> quercia bianca)<br />
Lo stato <strong>di</strong> conservazione <strong>di</strong> questo habitat è con<strong>di</strong>zionato dalla struttura forestale<br />
sostanzialmente coetanea, dalla presenza <strong>di</strong> necromassa in pie<strong>di</strong> e a terra e dalla presenza<br />
<strong>di</strong> specie alloctone invasive (robinia).<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 4 – DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE STRATEGIE GESTIONALI PAG. 186<br />
Per un buono stato conservativo è necessario favorire la <strong>di</strong>setaneizzazione dei soprassuoli,<br />
oltre che il contenimento delle specie vegetali alloctone ed il mantenimento <strong>di</strong> un’adeguata<br />
quantità <strong>di</strong> necromassa in pie<strong>di</strong> e a terra.<br />
Nelle superfici <strong>di</strong> proprietà pubblica: conversione progressiva al bosco <strong>di</strong>setaneo me<strong>di</strong>ante<br />
interventi <strong>di</strong> selvicoltura naturalistica a basso impatto. Si tratta <strong>di</strong> interventi <strong>di</strong>fficilmente<br />
realizzabili senza avere a <strong>di</strong>sposizione dati certi sulla struttura verticale e sulla <strong>di</strong>stribuzione<br />
orizzontale della specie dominante e <strong>di</strong> quelle accessorie. In generale, trattandosi <strong>di</strong> cedui<br />
invecchiati a struttura coetaneiforme, si potrebbe pensare ad una gestione orientata verso<br />
l’ottenimento <strong>di</strong> tipi strutturali <strong>di</strong>setanei, allo scopo <strong>di</strong> mantenere molte catene trofiche,<br />
passando attraverso l’applicazione <strong>di</strong> un metodo selvicolturale <strong>di</strong> conversione che preveda il<br />
rilascio <strong>di</strong> molte matricine e polloni <strong>di</strong> <strong>di</strong>verse età, su cui intervenire successivamente con<br />
tagli <strong>di</strong> curazione. Il principio è quello <strong>di</strong> ottenere strutture <strong>di</strong>setanee per piccoli gruppi o per<br />
piede d’albero attraverso il taglio <strong>di</strong>versificato sulle ceppaie, il rilascio <strong>di</strong> ceppaie intere o,<br />
viceversa, il taglio a raso <strong>di</strong> intere ceppaie ecc..<br />
In alternativa le in<strong>di</strong>cazioni gestionali sono orientate alla conversione all’alto fusto coetaneo.<br />
Nella pratica operativa il primo intervento <strong>di</strong> conversione si realizza eseguendo un<br />
<strong>di</strong>radamento che interessa prevalentemente le piante codominanti ma che agisce<br />
parzialmente anche sul piano dominato a carico dei polloni dominati, deperienti e malformati,<br />
nonché <strong>di</strong> quelli soprannumerari del piano dominante. Vengono rilasciati 1-2, al massimo 3,<br />
polloni per ceppaia scelti tra quelli a migliore conformazione, sviluppo e capacità <strong>di</strong><br />
affrancamento (piante sane con fusto <strong>di</strong>ritto e chioma regolarmente sviluppata). Le matricine<br />
e gli esemplari <strong>di</strong> grosse <strong>di</strong>mensioni sani o con caratteristiche <strong>di</strong> rilievo, come pure gli<br />
esemplari delle specie accessorie vengono sempre rilasciati, tranne nel caso in cui<br />
provochino un eccessivo aduggiamento. Nella fustaia transitoria così originata l’assetto<br />
strutturale verrà in seguito perfezionato con l’esecuzione <strong>di</strong> almeno 1 o 2 <strong>di</strong>radamenti<br />
perio<strong>di</strong>ci, a <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> 10-15 anni l’uno dall’altro, in modo tale da realizzare nel più breve<br />
tempo possibile un soprassuolo ad alto fusto coetaneiforme che verrà in seguito trattato a<br />
tagli successivi a piccoli gruppi (0,5-1 ha).<br />
Nelle superfici <strong>di</strong> proprietà privata: in linea generale i presupposti per la definizione delle<br />
forme <strong>di</strong> trattamento del ceduo <strong>di</strong> produzione, comunque a taglio raso con rilascio <strong>di</strong><br />
matricine, possono essere sinteticamente riassunti nei seguenti punti:<br />
• allungamento del turno fino a 30 anni;<br />
• attenta valutazione <strong>di</strong> forma, <strong>di</strong>mensioni e <strong>di</strong>stribuzione spazio-temporale delle tagliate<br />
ed in generale ceduazione su piccole superfici;<br />
• variabilità nella tecnica <strong>di</strong> rilascio delle matricine (eventuale matricinatura per gruppi,<br />
rilascio <strong>di</strong> intere ceppaie, sterzatura per alcune specie ecc.);<br />
• conservazione e ripristino della <strong>di</strong>versità specifica.<br />
L’allungamento del turno, oltre a non pregiu<strong>di</strong>care la vitalità delle ceppaie, comporta,<br />
ovviamente, anche un miglioramento della fertilità stazionale e del soprassuolo, e quin<strong>di</strong><br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 4 – DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE STRATEGIE GESTIONALI PAG. 187<br />
l’innesco <strong>di</strong> processi evolutivi, privilegiando le specie più esigenti come gli aceri e l’orniello.<br />
Per quanto riguarda il contenimento degli effetti <strong>di</strong> concorrenza sulla rinnovazione agamica<br />
da parte degli in<strong>di</strong>vidui rilasciati al taglio, risulta necessario considerare l'intensità <strong>di</strong><br />
matricinatura un fattore che può influenzare sensibilmente il mantenimento del governo<br />
ceduo in boschi a prevalenza <strong>di</strong> specie quercine decidue. Dal punto <strong>di</strong> vista operativo<br />
contestualmente al taglio <strong>di</strong> utilizzazione dovranno essere rilasciate 100 matricine per ettaro,<br />
preferibilmente con <strong>di</strong>stribuzione spaziale omogenea, costituite per il 30% da esemplari <strong>di</strong><br />
età doppia del turno. Le matricine saranno comunque soggetti vigorosi, affrancati o<br />
selezionati sulle ceppaie più piccole.<br />
In alcuni casi, allo scopo <strong>di</strong> ridurre alcuni effetti ecologici negativi della ceduazione, su<br />
superfici <strong>di</strong> <strong>di</strong>versa estensione in funzione della viabilità, delle caratteristiche vegetazionali e<br />
strutturali del popolamento e delle con<strong>di</strong>zioni geomorfologiche si può valutare la possibilità <strong>di</strong><br />
adottare una matricinatura "per gruppi". In pratica, nuclei <strong>di</strong> 20-25 piante (fra le quali anche<br />
qualche matricina) vengono lasciati a macchia <strong>di</strong> leopardo sulla superficie tagliata, al posto<br />
della omogenea ripartizione delle matricine. Dal punto <strong>di</strong> vista operativo la scelta dei gruppi<br />
<strong>di</strong> matricine deve basarsi sui seguenti criteri (Grohmann et al., 2002):<br />
• evitare <strong>di</strong> avere una <strong>di</strong>stanza tra i gruppi superiore ai 20 m, con un numero <strong>di</strong> gruppi pari<br />
a circa 5-6 per ettaro, con una copertura me<strong>di</strong>a del 10-15%, paragonabile a quella<br />
esercitata da circa 100 matricine ad ettaro uniformemente <strong>di</strong>stribuite;<br />
• valorizzare la presenza <strong>di</strong> in<strong>di</strong>vidui <strong>di</strong> specie pregiate;<br />
• utilizzare alberi stabili per delimitare i margini dei gruppi ed eventualmente rilasciare<br />
alcuni polloni dominati all’esterno degli alberi stabili del gruppo, allo scopo <strong>di</strong> limitarne<br />
l’espansione della chioma e ridurre l’effetto <strong>di</strong> isolamento improvviso causato dal taglio);<br />
• rilasciare una maggiore copertura in zone soggette a fenomeni erosivi;<br />
• evitare <strong>di</strong> intervenire in zone non percorribili o <strong>di</strong>fficilmente accessibili.<br />
Gli aspetti significativi che caratterizzano la matricinatura per gruppi rispetto alla<br />
matricinatura omogeneamente <strong>di</strong>stribuita si possono sintetizzare come segue:<br />
• non si alterano le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> stabilità delle piante interne e si limitano i danni da brusco<br />
isolamento;<br />
• aumentano notevolmente le fasce ecotonali, con la conservazione in queste zone della<br />
<strong>di</strong>versificazione strutturale del bosco, evitando il taglio delle piante dominate e dello<br />
strato arbustivo;<br />
• le ceppaie dovrebbero risentire meno dell’effetto aduggiante delle matricine;<br />
• in generale la matricinatura a gruppi è maggiormente impattante nel caso <strong>di</strong> aree ad uso<br />
del suolo esclusivamente forestale, ma questo effetto può essere attenuato <strong>di</strong>sponendo i<br />
gruppi ai margini delle zone maggiormente frequentate;<br />
• viene garantita una maggiore ricchezza floristica e faunistica, soprattutto nel caso <strong>di</strong><br />
gruppi con <strong>di</strong>mensioni superiori all’altezza dominante dei polloni;<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 4 – DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE STRATEGIE GESTIONALI PAG. 188<br />
• la produzione risulta più concentrata nello spazio e le operazioni <strong>di</strong> abbattimento ed<br />
esbosco meno <strong>di</strong>fficoltose;<br />
• l’effetto <strong>di</strong> protezione idrogeologica è maggiore localmente ma inferiore nel caso in cui i<br />
rischi idrogeologici siano uniformemente presenti sulla superficie posta al taglio.<br />
Nei tratti <strong>di</strong> ceduo privi <strong>di</strong> matricine o <strong>di</strong> allievi idonei (si hanno frequenti tratti con ceppaie<br />
con numerosi polloni filati e piegati non idonei) si procederà al rilascio <strong>di</strong> parti <strong>di</strong> ceppaie (o <strong>di</strong><br />
intere ceppaie), alleggerendo le ceppaie troppo dense e scegliendo alcuni (2-5) polloni<br />
meglio conformati (spesso sono quelli al centro della ceppaia) (matricinatura a “voliere”, cfr.<br />
Bernetti, 1995). In generale è comunque sempre in<strong>di</strong>cato favorire la mescolanza delle<br />
specie, anche risparmiando al taglio qualche pianta <strong>di</strong> specie accessorie per avvantaggiarla<br />
nella competizione con i polloni che riscoppieranno.<br />
4.2.2.9 Formazioni elofitiche (Pa - Fragmiteti, tifeti e scirpeti d'acqua dolce<br />
(Phragmition))<br />
Le fasce <strong>di</strong> vegetazione elofitica sono minacciate dalla presenza della nutria, specie animale<br />
alloctona che si nutre <strong>di</strong> germogli <strong>di</strong> specie acquatiche (elofite, ma anche rizofite),<br />
<strong>di</strong>struggendo interi habitat e negando a questi la possibilità <strong>di</strong> crearsi al margine <strong>di</strong> corpi<br />
idrici.<br />
Occorre inoltre sottoporre gli habitat <strong>di</strong> vegetazione elofitica a continuo e attento<br />
monitoraggio per in<strong>di</strong>viduare tempestivamente l’eventuale ingresso <strong>di</strong> specie esotiche. Ciò<br />
consentirà <strong>di</strong> prendere gli opportuni provve<strong>di</strong>menti per evitare l’alterazione o la scomparsa <strong>di</strong><br />
questi ambienti.<br />
4.2.3 Specie vegetali<br />
La conservazione delle specie vegetali <strong>di</strong> interesse conservazionistico sarà garantita<br />
attraverso:<br />
1 Divieto <strong>di</strong> raccolta <strong>di</strong> specie <strong>di</strong> interesse conservazionistico in tutto il SIC-ZPS;<br />
2 Regolamentazione del passaggio <strong>di</strong> escursionisti che in tutto il SIC-ZPS dovrà essere<br />
consentito solamente nell’ambito della rete sentieristica ufficiale;<br />
3 Contenimento/era<strong>di</strong>cazione <strong>di</strong> specie alloctone invasive;<br />
4 Recinzione <strong>di</strong> praterie ricche <strong>di</strong> orchidee riferibili all’habitat 6210* e <strong>di</strong> stazioni <strong>di</strong><br />
emergenze floristiche per proteggerle dalla fauna selvatica;<br />
5 Cattura <strong>di</strong> nutrie;<br />
6 Evitare l’eutrofizzazione e l’inquinamento delle acque con alterazione chimica delle<br />
stesse per la conservazione della presenza <strong>di</strong> idrofite ed elofite <strong>di</strong> interesse<br />
conservazionistico (Myriophyllum spicatum, Typha latifolia).<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 4 – DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE STRATEGIE GESTIONALI PAG. 189<br />
7 Mantenimento <strong>di</strong> prati e praterie, degli ecosistemi <strong>di</strong> transizione, delle zone <strong>di</strong> “margine”<br />
dei boschi e delle radure interne alle formazioni forestali per la conservazione <strong>di</strong> specie<br />
della famiglia delle Orchidaceae.<br />
8 Miglioramento della complessità strutturale delle formazioni forestali e mantenimento o<br />
perseguimento <strong>di</strong> buoni od elevati gra<strong>di</strong> <strong>di</strong> copertura e/o densità per la conservazione<br />
della presenza <strong>di</strong> Galanthus nivalis, Pulmonaria apennina, Lilium martagon, Taxus<br />
baccata.<br />
4.2.4 Specie animali<br />
La conservazione delle specie animali <strong>di</strong> interesse conservazionistico sarà garantita<br />
attraverso gli obiettivi e le strategie gestionali <strong>di</strong> seguito descritte per i <strong>di</strong>versi taxa.<br />
4.2.4.1 Invertebrati<br />
- Monitoraggio dell’entomofauna con particolare riguardo alle specie in<strong>di</strong>catrici e <strong>di</strong><br />
interesse conservazionistico.<br />
- Conservazione, nelle aree <strong>di</strong> greto stabili, delle formazioni vegetali riparie ad Olivello<br />
spinoso, pianta ospite <strong>di</strong> Hyles hippophaes, lepidottero sfingide ad abitu<strong>di</strong>ni crepuscolari.<br />
- Conservazione e incremento delle popolazioni <strong>di</strong> coleotteri cicindeli<strong>di</strong>, carabi<strong>di</strong> e glafiri<strong>di</strong><br />
legati agli ambienti <strong>di</strong> greto.<br />
- Conservazione e incremento delle popolazioni <strong>di</strong> insetti saproxilici inse<strong>di</strong>ate nelle aree<br />
boscate presenti nel SIC, tramite una gestione oculata della componente arborea.<br />
- Conservazione e incremento delle popolazioni <strong>di</strong> macroeteroceri <strong>di</strong> interesse<br />
conservazionistico tramite la gestione oculata della vegetazione ecotonale presente ai<br />
margini delle aree boscate.<br />
- Contenimento e/o era<strong>di</strong>cazione degli alloctoni, in particolar modo <strong>di</strong> Procambarus clarkii.<br />
4.2.4.2 Pesci<br />
- Monitoraggio quantitativo dell’ittiofauna del reticolo idrico.<br />
- Specifico programma <strong>di</strong> recupero delle specie più minacciate.<br />
- Contenimento e/o era<strong>di</strong>cazione degli alloctoni.<br />
4.2.4.3 Anfibi e Rettili<br />
• Conservazione e incremento dei microhabitat idonei alle specie <strong>di</strong> Rettili.<br />
• Stu<strong>di</strong>o approfon<strong>di</strong>to dell’erpetofauna del sito.<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 4 – DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE STRATEGIE GESTIONALI PAG. 190<br />
• Mappatura <strong>di</strong> dettaglio dei siti riproduttivi <strong>di</strong> Anfibi al fine <strong>di</strong> valutarne lo status locale in<br />
modo adeguato.<br />
• Conservazione e incremento dei siti riproduttivi <strong>di</strong> Anfibi.<br />
• Sensibilizzazione della popolazione locale rispetto alla tutela delle specie e dei loro<br />
habitat.<br />
• Programmi specifici per Salamandrina perspicillata.<br />
4.2.4.4 Uccelli<br />
• Monitoraggio dell’avifauna del sito.<br />
• Conservazione e incremento della popolazione <strong>di</strong> Accipitriformi me<strong>di</strong>ante riduzione<br />
dell’impatto causato dalle linee elettriche e controllo delle trappole per corvi<strong>di</strong>.<br />
• Conservazione e incremento della popolazione <strong>di</strong> Falconi<strong>di</strong>, in particolare Falco<br />
columbarius e Falco peregrinus, me<strong>di</strong>ante riduzione dell’impatto causato dalle linee<br />
elettriche, controllo delle trappole per corvi<strong>di</strong>, incentivazione dell’agricoltura biologica e<br />
riduzione dell’uso <strong>di</strong> fitofarmaci.<br />
• Controllo delle attività antropiche (escursionismo, fotografia naturalistica ecc.) che<br />
possono avere un impatto negativo sull’inse<strong>di</strong>amento e sul successo riproduttivo <strong>di</strong><br />
rapaci rupicoli.<br />
• Conservazione e incremento <strong>di</strong> specie fossorie (Alcedo atthis e Riparia riparia) me<strong>di</strong>ante<br />
controllo della fruizione in alveo e la sensibilizzazione dei fruitori dell’area,<br />
regolamentazione degli interventi <strong>di</strong> regimazione idraulica, rispetto del DMV e controllo<br />
degli scarichi inquinanti, realizzazione <strong>di</strong> pareti artificiali per la ni<strong>di</strong>ficazione.<br />
• Conservazione e incremento <strong>di</strong> Ardei<strong>di</strong> <strong>di</strong> canneto, coloniali e Phalacrocorax carbo<br />
me<strong>di</strong>ante riduzione dell’impatto causato dalle linee elettriche, regolamentazione della<br />
fruizione delle aree <strong>di</strong> ni<strong>di</strong>ficazione e foraggiamento, anche attraverso opera <strong>di</strong><br />
sensibilizzazione, rispetto del DMV e controllo degli scarichi inquinanti.<br />
• Conservazione e incremento <strong>di</strong> Passeriformi legati ad ambienti agricoli (Alauda arvensis,<br />
Emberiza calandra, Galerida cristata, Lullula arborea, Motacilla flava) me<strong>di</strong>ante<br />
incentivazione dell’agricoltura biologica e riduzione dell’uso <strong>di</strong> fitofarmaci, conservazione<br />
delle aree <strong>di</strong> riproduzione e alimentazione (prati stabili), interventi <strong>di</strong> controllo <strong>di</strong> Sus<br />
scrofa, il <strong>di</strong>vieto d’uso <strong>di</strong> barre falcianti per potatura <strong>di</strong> siepi; azioni <strong>di</strong> sensibilizzazione.<br />
4.2.4.5 Mammiferi<br />
1. Mantenimento ed incremento dell’attuale chirotterofauna presente nel sito, sia come<br />
numero <strong>di</strong> specie sia come consistenza delle popolazioni;<br />
2. Adottare le opportune misure <strong>di</strong> conservazione dei siti <strong>di</strong> rifugio in<strong>di</strong>viduati nel corso dello<br />
stu<strong>di</strong>o.<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />
RENO”
CAP. 5 – MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE PAG. 191<br />
5 MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE<br />
Le misure <strong>di</strong> conservazione, nonché i piani <strong>di</strong> gestione, dei siti della Rete Natura 2000, così<br />
come definiti dagli artt.4 e 6 del DPR n.357/97 e ss. mm. e ii., sono prioritariamente finalizzati<br />
ad evitare il degrado degli habitat naturali e la perturbazione delle specie animali e vegetali<br />
d'interesse comunitario presenti nei siti, nonché a promuovere il ripristino degli stessi habitat ed<br />
il miglioramento delle con<strong>di</strong>zioni ambientali più favorevoli alle popolazioni delle specie da<br />
tutelare, sulla presenza dei quali si è basata l’in<strong>di</strong>viduazione dei siti stessi. Le misure <strong>di</strong><br />
conservazione, nonché i piani <strong>di</strong> gestione, dei siti della Rete Natura 2000, devono, inoltre,<br />
garantire l'uso sostenibile delle risorse naturali presenti, tenendo conto della necessità <strong>di</strong><br />
instaurare un rapporto equilibrato tra le esigenze <strong>di</strong> conservazione dell’ambiente e quelle<br />
socioeconomiche.<br />
Le Misure Specifiche <strong>di</strong> Conservazione costituiscono quin<strong>di</strong> gli in<strong>di</strong>rizzi gestionali contenenti le<br />
norme regolamentari e le azioni da intraprendere per la salvaguar<strong>di</strong>a degli habitat e delle specie<br />
<strong>di</strong> interesse conservazionistico, attraverso la regolamentazione delle attività antropiche più<br />
impattanti (<strong>di</strong>vieti e vincoli) e la in<strong>di</strong>viduazione delle attività favorevoli alla conservazione degli<br />
habitat e delle specie da promuovere, con in<strong>di</strong>cazione delle risorse economiche necessarie al<br />
loro finanziamento (incentivi e indennizzi).<br />
Le Misure Specifiche <strong>di</strong> Conservazione sono costituite da misure regolamentari, amministrative<br />
e contrattuali e sono state elaborate per ciascun habitat e specie che costituiscono gli obiettivi <strong>di</strong><br />
conservazione del sito.<br />
Secondo la D.G.R. 1191/2007 (Allegato A) le misure <strong>di</strong> conservazione delle ZPS e dei SIC si<br />
articolano in:<br />
• misure generali <strong>di</strong> conservazione, valide per tutti i siti Natura 2000, la cui approvazione è <strong>di</strong><br />
competenza regionale;<br />
• misure specifiche <strong>di</strong> conservazione, articolate per ogni singolo sito Natura 2000, la cui<br />
approvazione compete alle Province o agli Enti <strong>di</strong> gestione delle aree naturali protette. Tali<br />
misure <strong>di</strong> conservazione, costituite da misure regolamentari, amministrative e contrattuali,<br />
possono, all'occorrenza, anche implicare l’adozione <strong>di</strong> piani <strong>di</strong> gestione, specifici o integrati ad<br />
altri piani <strong>di</strong> natura territoriale, urbanistica, paesaggistica, faunistico-venatoria ed ambientale.<br />
Nel presente capitolo vengono quin<strong>di</strong> presentate le misure specifiche <strong>di</strong> conservazione del<br />
sito, redatte sulla base delle linee guida regionali (“Allegato C” D.G.R. 2253/2009), che<br />
scaturiscono dal Quadro Conoscitivo raggiunto, rapportando le esigenze ecologiche con i fattori<br />
<strong>di</strong> minaccia, lo stato <strong>di</strong> conservazione e le eventuali forme <strong>di</strong> tutela già in essere.<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA RENO”
CAP. 5 – MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE PAG. 192<br />
Le Misure Specifiche <strong>di</strong> Conservazione (<strong>MSC</strong>) sono state quin<strong>di</strong> redatte in conformità con:<br />
1. il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 3 settembre 2002<br />
“Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000”;<br />
2. 2. il Manuale per la gestione dei siti natura 2000 redatto dal Ministero dell’Ambiente -<br />
Direzione per la Conservazione della Natura, prodotto nell’ambito del progetto LIFE<br />
denominato “Verifica della rete Natura 2000 in Italia e modelli <strong>di</strong> gestione” (LIFE 99<br />
NAT/IT/006279);<br />
3. 3. la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1191/07, allegato A “In<strong>di</strong>rizzi per la<br />
pre<strong>di</strong>sposizione dei Piani <strong>di</strong> gestione e delle Misure specifiche <strong>di</strong> conservazione e dei siti<br />
della Rete Natura 2000”;<br />
4. le misure <strong>di</strong> conservazione per le Zone speciali <strong>di</strong> conservazione (ZSC) <strong>di</strong> cui all’art. 2<br />
“Definizione delle misure <strong>di</strong> conservazione per le Zone speciali <strong>di</strong> conservazione (ZSC)” del<br />
DM 17.10.2007, n. 184 “Criteri minimi uniformi per la definizione <strong>di</strong> misure <strong>di</strong> conservazione<br />
relative a Zone speciali <strong>di</strong> conservazione (ZSC) e a Zone <strong>di</strong> protezione speciale (ZPS)”;<br />
5. le in<strong>di</strong>cazioni della delibera <strong>di</strong> Giunta regionale n. 1224 del 28.7.2008 “Recepimento DM n.<br />
184/07 “Criteri minimi uniformi per la definizione <strong>di</strong> misure <strong>di</strong> conservazione relative a Zone<br />
speciali <strong>di</strong> conservazione (ZSC) e a Zone <strong>di</strong> protezione speciale (ZPS). Misure <strong>di</strong><br />
conservazione gestione ZPS, ai sensi Dirett. 79/409/CEE, 92/43/CEE e DPR 357/97 e<br />
ss.mm. e DM del 17/10/07”.<br />
6. 5. la D.G.R 2253 del 28/12/2009 e relativi allegati (Allegato A, Allegato C e Allegato D),<br />
nonchè la successiva D.G.R. 185 del 14/02/2011;<br />
Le Misure Specifiche <strong>di</strong> Conservazione sono state raccolte in uno specifico documento, allegato<br />
alla presente Relazione, allo scopo <strong>di</strong> <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> uno strumento sintetico ed accessibile nelle<br />
informazioni, nonchè <strong>di</strong> facile consultazione.<br />
Per continuità con le Azioni del Piano <strong>di</strong> Gestione, anche alle Misure Specifiche <strong>di</strong><br />
Conservazione sono state attribuite le categorie in<strong>di</strong>viduate dal Decreto Ministeriale del 2002<br />
sopra richiamato:<br />
7. REGOLAMENTAZIONI (RE): azioni <strong>di</strong> gestione i cui effetti sullo stato <strong>di</strong> conservazione degli<br />
habitat e delle specie sono frutto <strong>di</strong> scelte programmatiche che suggeriscano/raccoman<strong>di</strong>no<br />
comportametni da adottare in determinate cirocstanze e luoghi;<br />
8. INTERVENTI ATTIVI (IA): interventi realizzabili da pubbliche amministrazioni o da privati,<br />
finalizzati a rimuovere/ridurre un fattore <strong>di</strong> <strong>di</strong>sturbo al fine <strong>di</strong> ottenere un recupero delle<br />
<strong>di</strong>namiche naturali (linee guida, programmi d’azione o interventi <strong>di</strong>retti);<br />
9. INCENTIVAZIONI (IN): incentivi a favore delle misure proposte che favoriscano il<br />
raggiungimento degli obiettivi <strong>di</strong> conservazione del sito;<br />
10. MONITORAGGIO o RICERCA (MR): hanno la finalità <strong>di</strong> misurare lo stato <strong>di</strong> conservzione <strong>di</strong><br />
habitat e specie e <strong>di</strong> verificare l'efficacia delle misure specifiche <strong>di</strong> conservazione o il<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA RENO”
CAP. 5 – MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE PAG. 193<br />
successo delle azioni proposte dal Piano <strong>di</strong> gestione; le Misure relative al monitoraggio si<br />
riferiscono anche ad azioni preliminari da intraprendere, volte a definire una misura<br />
specifica.<br />
Le azioni <strong>di</strong> monitoraggio degli habitat e delle specie <strong>di</strong> interesse comunitario sono riportate<br />
senza dettagliare le singole metodologie da applicare, in quanto in attesa dell’emanazione delle<br />
linee guida ministeriali e del Programma regionale <strong>di</strong> monitoraggio degli habitat e delle specie<br />
Natura 2000.<br />
11. PROGRAMMI DIDATTICI (PD): sono orientati alla <strong>di</strong>ffusione <strong>di</strong> conoscenze e modelli <strong>di</strong><br />
comportamento sostenibili, che mirano alla tutela dei valori del sito attraverso il<br />
coinvolgimento delle popolazioni locali (piani <strong>di</strong> <strong>di</strong>vulgazione, sensibilizzazione e formazione<br />
rivolti alle <strong>di</strong>verse categorie interessate, quali agricoltori, turisti, pescatori, ecc)<br />
Le misure specifiche si applicano su tutto il territorio del sito quando si rivolgono ad una ampia<br />
gamma <strong>di</strong> habitat e specie che interessano trasversalmente il sito stesso (misure trasversali).<br />
Con tali misure <strong>di</strong> conservazione trasversali si intende incentrare l’attività <strong>di</strong> tutela sulla base <strong>di</strong><br />
una gestione attiva messa in capo alle stesse attività economiche ed in particolare a quelle<br />
agrosilvopastorali e del turismo sostenibile (definibile anche come estensivo o “slow”). E’<br />
possibile, infatti, mantenere il mosaico ecologico, che è la forma <strong>di</strong> organizzazione territoriale<br />
che maggiormente garantisce la bio<strong>di</strong>versità, solo rafforzando la presenza <strong>di</strong> attività tra<strong>di</strong>zionali,<br />
opportunamente innovate, che mantengano gli habitat secondari che costituiscono quelli a<br />
maggior rischio <strong>di</strong> scomparsa. Altre attività invece sono da regolamentare garantendo il loro<br />
svolgimento nei tempi e nei mo<strong>di</strong> adeguati a garantire il raggiungimento degli obiettivi <strong>di</strong><br />
conservazione dei Siti.<br />
Le Misure sono state, quin<strong>di</strong>, organizzate per ambiti <strong>di</strong> attività da regolamentare e/o da<br />
promuovere per un uso sostenibile delle risorse del territorio, tenendo conto degli obiettivi <strong>di</strong><br />
conservazione del sito, come <strong>di</strong> seguito dettagliato:<br />
1. Tutela, monitoraggio e conservazione <strong>di</strong> habitat e specie<br />
2. Informazione, Formazione, Educazione, Divulgazione naturalistica<br />
3. Attività venatoria e gestione faunistica<br />
4. Pesca e gestione della fauna ittica<br />
5. Utilizzo dei boschi e gestione forestale<br />
6. Attività agricola e zootecnica<br />
7. Utilizzo delle acque lentiche, lotiche e sorgenti, interventi nei corsi d'acqua e alvei<br />
fluviali, infrastrutture idrauliche<br />
8. Attività <strong>di</strong> produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali, rifiuti, suolo<br />
9. Viabilità, e<strong>di</strong>lizia, interventi su fabbricati e altri manufatti<br />
10. Fruizione, attività turistico ricreative, culturali e sportive<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA RENO”
CAP. 5 – MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE PAG. 194<br />
Le Misure <strong>di</strong> conservazione specifiche, non già comprese nelle Misure trasversali, trovano<br />
applicazione in funzione della presenza degli habitat e/o delle specie in<strong>di</strong>cate. Per tutte le<br />
specie riportate è sottintesa la tutela del loro habitat, il quale è fortemente correlato alle<br />
esigenze ecologiche delle specie stesse, riportate in ciascuna scheda <strong>di</strong> misura.<br />
Le Misure Specifiche <strong>di</strong> Conservazione devono in<strong>di</strong>care regolamentazioni cogenti e attività<br />
concrete da realizzare e, pertanto, hanno carattere <strong>di</strong>:<br />
− Prescrizioni quando che pongono obblighi e/o <strong>di</strong>vieti, per alcuni dei quali sono previsti<br />
specifici indennizzi nelle superfici agricole e forestali (prescrizioni indennizzabili);<br />
− Direttive nel caso sia necessario in<strong>di</strong>rizzare una specifica attività da parte del soggetto<br />
competente<br />
− In<strong>di</strong>rizzi gestionali quando in<strong>di</strong>cano le attività da intraprendere (buone pratiche) per il<br />
raggiungimento degli obiettivi <strong>di</strong> conservazione del sito<br />
− Incentivi economici, che in<strong>di</strong>viduano le attività antropiche all'interno del sito favorevoli<br />
alla conservazione <strong>di</strong> habitat e specie, da promuovere me<strong>di</strong>ante un sistema <strong>di</strong><br />
meccanismi incentivanti<br />
Le Misure Specifiche <strong>di</strong> Conservazione costituiscono uno strumento <strong>di</strong>namico che tiene conto<br />
dell'aggiornamento delle conoscenze scientifiche; le stesse sono pertanto soggette a perio<strong>di</strong>ca<br />
revisione e conseguentemente prevedono l'adeguamento nel tempo del quadro conoscitivo e<br />
delle conseguenti strategie adottate per la gestione degli habitat e delle specie nel sito.<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA RENO”
CAP. 6 – INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI NATURALI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO AGRARIO CON<br />
ALTA VALENZA ECOLOGICA PAG. 195<br />
6 INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI NATURALI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO<br />
AGRARIO CON ALTA VALENZA ECOLOGICA<br />
All’interno del SIC sono presenti <strong>di</strong>versi appezzamenti <strong>di</strong> terreno destinati all’uso agricolo.<br />
Queste piccole particelle sono intervallate da aree boschive e prative <strong>di</strong> varie <strong>di</strong>mensioni, così<br />
da formare un variegato mosaico ambientale <strong>di</strong> tipo agro-silvo-pastorale. I margini dei vari<br />
appezzamenti sono spesso delimitati da siepi, alberature e altre formazioni lineari che ne<br />
garantiscono una buona interconnettività.<br />
Questi elementi lineari costituiscono delle fasce tampone e degli ecosistemi filtro, dove per<br />
fascia tampone si intende qualsiasi sistema vegetato (siepi, filari, boschetti, zone umide naturali<br />
e artificiali), interposto tra l’ambiente terrestre e acquatico, in grado <strong>di</strong> intercettare e ridurre<br />
l’apporto <strong>di</strong> sostanze inquinanti <strong>di</strong> origine antropica in ingresso nelle acque superficiali.<br />
La presenza delle siepi e dei filari consente <strong>di</strong> ridurre l’apporto <strong>di</strong> azoto ai corsi d’acqua<br />
attraverso processi <strong>di</strong>retti <strong>di</strong> assimilazione ra<strong>di</strong>cale, creando inoltre nel terreno ambienti idonei<br />
alla presenza <strong>di</strong> fauna microbica assimilatrice e <strong>di</strong> batteri denitrificanti.<br />
Tali formazioni svolgono inoltre altre ed importanti funzioni quali:<br />
- l’incremento della bio<strong>di</strong>versità dell’agroecosistema;<br />
- la funzione <strong>di</strong> corridoio ecologico <strong>di</strong> collegamento tra i vari sistemi naturali, importante per<br />
l’avifauna e per altre specie animali;<br />
- l’assorbimento <strong>di</strong> anidride carbonica e quin<strong>di</strong> la riduzione dei “gas serra” in atmosfera;<br />
- la funzione idrologico-idraulica a scala <strong>di</strong> bacino attraverso l’aumento dei tempi <strong>di</strong><br />
corrivazione, la riduzione dei fenomeni <strong>di</strong> erosione superficiale e la stabilizzazione delle<br />
sponde dei corsi d’acqua;<br />
- il miglioramento del paesaggio in ambito agricolo;<br />
- la <strong>di</strong>fferenziazione delle produzioni (legna da ardere, da opera e da biomassa, produzione<br />
<strong>di</strong> prodotti apistici e piccoli frutti) da rivendere (<strong>di</strong>versificazione delle fonti <strong>di</strong> red<strong>di</strong>to) o da<br />
utilizzare nelle piccole aziende (riduzione dei costi aziendali);<br />
- l’effetto frangivento che riduce i danni meccanici alle coltivazioni, l’evapotraspirazione e<br />
l’erosione <strong>di</strong> suolo nel caso <strong>di</strong> colture annuali che lasciano il terreno “nudo”.<br />
Questi elementi del paesaggio sono fondamentali per i Chirotteri che li utilizzano sia come guida<br />
per gli spostamenti che come luoghi <strong>di</strong> foraggiamento. La presenza <strong>di</strong> tali formazioni è<br />
sicuramente l’elemento <strong>di</strong> maggior pregio per la presenza e la conservazione <strong>di</strong> una ben<br />
<strong>di</strong>versificata chirotterofauna in ambiente rurale<br />
Per le motivazioni esposte appare in<strong>di</strong>spensabile mantenere tutte le siepi ed i filari esistenti nel<br />
territorio del SIC e la gestione dovrà rispettare quanto previsto dalle normative vigenti nonché<br />
dagli in<strong>di</strong>rizzi gestionali del SIC.<br />
Sono inoltre presenti laghetti <strong>di</strong> irrigazione e piccoli stagni, molto importanti come stepping<br />
stones nell’ambito <strong>di</strong> un più generale <strong>di</strong>segno <strong>di</strong> rete ecologica locale.<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA RENO”
CAP. 8 – PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA PAG. 196<br />
7 NORME PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA (BOZZA)<br />
7.1 Premessa<br />
Nell’ambito delle misure <strong>di</strong> conservazione obbligatorie per i Siti della Rete Natura 2000, la<br />
normativa <strong>di</strong> riferimento a livello comunitario, nazionale e regionale ha introdotto la procedura<br />
denominata "Valutazione d'Incidenza". Essa si applica sia nei confronti degli atti <strong>di</strong><br />
pianificazione e programmazione territoriale, sia nei confronti dei singoli progetti/interventi che<br />
possono avere effetti, anche in<strong>di</strong>retti, purché significativi, sui Siti <strong>di</strong> Interesse Comunitario e<br />
Regionale.<br />
Con Delibera <strong>di</strong> Giunta Regionale 2253/2009, relativa al finanziamento della elaborazione e<br />
redazione delle Misure Specifiche <strong>di</strong> Conservazione e dei piani <strong>di</strong> gestione dei siti natura 2000,<br />
la Regione Emilia Romagna ha richiesto che gli Enti <strong>di</strong> gestione provvedano all'applicazione<br />
della D.G.R. 1191/2007, relativamente alla possibilità <strong>di</strong> ampliare o restringere la Tabella E della<br />
suddetta <strong>di</strong>rettiva, contenente le tipologie <strong>di</strong> interventi / opere /piani che non sono soggetti alla<br />
Valutazione <strong>di</strong> Incidenza.<br />
I soggetti gestori dei siti Natura 2000 possono escludere, o mo<strong>di</strong>ficare in senso più restrittivo, le<br />
tipologie d'intervento in<strong>di</strong>cate nella Tabella E, attraverso le misure specifiche <strong>di</strong> conservazione o<br />
l’eventuale piano <strong>di</strong> gestione del singolo sito Natura 2000.<br />
La redazione delle Misure Specifiche <strong>di</strong> Conservazione può costituire anche un’utile occasione<br />
per l’in<strong>di</strong>viduazione delle categorie <strong>di</strong> piani/progetti, interni o esterni al sito, su cui utilizzare al<br />
meglio la procedura della Valutazione <strong>di</strong> incidenza.<br />
Sono state pertanto <strong>di</strong> seguito esaminate:<br />
• le tipologie <strong>di</strong> opere che possono risultare particolarmente critiche per la conservazione<br />
del sito e/o che devono essere sottoposte a valutazione d’incidenza anche se esterne al<br />
sito;<br />
• le tipologie <strong>di</strong> opere che devono essere sottoposte alla procedura <strong>di</strong> Valutazione <strong>di</strong><br />
Incidenza (esclusione dalla Tabella E)<br />
• le tipologie d'interventi vari, purchè il piano <strong>di</strong> gestione del sito Natura 2000 le in<strong>di</strong>chino<br />
tra quelle che non determinano inci<strong>di</strong>enze negative significative sul sito stesso (cfr. Tab.<br />
E punto 16 <strong>di</strong> cui alla deliberazione regionale n. 1191/07)<br />
• le tipologie <strong>di</strong> opere che si possono ritenere <strong>di</strong>rettamente connesse alla gestione del<br />
sito e quin<strong>di</strong> non soggette a Valutazione d’Incidenza (cfr. Tab. E punto 15 <strong>di</strong> cui alla<br />
deliberazione regionale n. 1191/07);<br />
Di seguito si riassumono le proposte <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fica delle norme in materia <strong>di</strong> Valutazione <strong>di</strong><br />
Incidenza per il sito, che costituiscono una bozza che dovrà essere visionata dal Gruppo <strong>di</strong><br />
Lavoro Intersettoriale della <strong>Provincia</strong> <strong>di</strong> Bolgona, e pertanto ancora suscettibile <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fiche nei<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA RENO”
CAP. 8 – PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA PAG. 197<br />
contenuti e nella redazione; il documento non comprende le norme vigenti in materia che non<br />
vengono mo<strong>di</strong>ficate e pertanto non è esaustivo del quadro normativo in materia <strong>di</strong> VINCA.<br />
All’approvazione <strong>di</strong> eventuali norme specifiche regionali o nazionali, queste prevalgono <strong>di</strong> volta<br />
in volta sui corrispondenti criteri specifici in<strong>di</strong>cati nelle presenti <strong>MSC</strong> solo se più restrittive o<br />
vincolanti.<br />
In deroga alle presenti <strong>MSC</strong>, qualora un piano o progetto debba essere realizzato per motivi<br />
imperativi <strong>di</strong> rilevante interesse pubblico connessi con la salute dell'uomo e la sicurezza<br />
pubblica e valutata la assenza <strong>di</strong> alternative, si applicano le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui al D.P.R. 357/97<br />
e s.m.i..<br />
8 Proposte <strong>di</strong> misure specifiche <strong>di</strong> conservazione che prevedono l'obbligo <strong>di</strong><br />
Valutazione <strong>di</strong> Incidenza<br />
Sono obbligatoriamente sottoposte a Valutazione <strong>di</strong> Incidenza le seguenti<br />
attività/interventi/opere/piani:<br />
1. nuove derivazioni <strong>di</strong> acque superficiali (incluse centrali idroelettriche e<br />
miniidroelettriche) anche se localizzate all'esterno del sito entro una <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> 1 km<br />
dal sito; per <strong>di</strong>stanze superiori al buffer in<strong>di</strong>cato non è comunque da escludersi a priori<br />
la possibilità <strong>di</strong> procedere alla Valutazione <strong>di</strong> Incidenza da parte dell'Ente competente,<br />
che ne valuterà la necessità come previsto dalla normativa vigente (DGR 1191/2007)<br />
2. attività organizzate legate alla fruizione tuirstica o agonistica che implicano l'uso <strong>di</strong><br />
mezzi autorizzati o afflusso ingente <strong>di</strong> persone (superiore a 100) - In alternativa alla<br />
Valutazione <strong>di</strong> Incidenza si può prevedere la seguente misura che tiene conto della<br />
DGR 1191/2007, paragrafi 5.2 e 5.3:<br />
“In caso <strong>di</strong> svolgimento <strong>di</strong> attività legate alla<br />
fruizione turistica o agonistica che implicano l'uso <strong>di</strong> mezzi motorizzati o un afflusso<br />
ingente <strong>di</strong> persone (superiore a 100) per le quali è richiesto il rilascio <strong>di</strong> specifica<br />
autorizzazione o altro atto <strong>di</strong> assenso, l'autorità competente, ai fini della verifica della<br />
compatibilità ambientale, deve, precedentemente al rilascio dell'atto dovuto, inviare<br />
all’Ente gestore del sito un'apposita comunicazione contenente la preventiva verifica<br />
della compatibilità ambientale dell'attività elaborata sulla base degli obiettivi <strong>di</strong> gestione<br />
e tutela del sito Natura 2000 interessato. La comunicazione dovrà essere effettuata con<br />
congruo anticipo al fine <strong>di</strong> consentire all'Ente <strong>di</strong> gestione del sito interessato <strong>di</strong> poter<br />
effettuare le proprie osservazioni.”<br />
3. realizzazione delle seguenti tipologie <strong>di</strong> piani, progetti e interventi, anche se localizzati<br />
al <strong>di</strong> fuori del sito per un'area buffer <strong>di</strong> 1 Km dal perimetro del sito; per <strong>di</strong>stanze<br />
superiori al buffer in<strong>di</strong>cato non è comunque da escludersi a priori la possibilità <strong>di</strong><br />
procedere alla Valutazione <strong>di</strong> Incidenza da parte dell'Ente competente, che ne valuterà<br />
la necessità come previsto dalla normativa vigente (DGR 1191/2007):<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA RENO”
CAP. 8 – PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA PAG. 198<br />
• costruzione <strong>di</strong> impianti <strong>di</strong> elettrodotti ad alta e me<strong>di</strong>a tensione fuori terra ; impianti che<br />
producono emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 commi 2-8 e dell’art. 272 del<br />
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;<br />
• costruzione <strong>di</strong> infrastrutture viarie;<br />
• concessione relativa a derivazione <strong>di</strong> acqua sotterranea ai sensi del R.R. 2/2006, da<br />
reperire me<strong>di</strong>ante la costruzione <strong>di</strong> pozzi,<br />
• concessione relativa a derivazione <strong>di</strong> acqua superficiale, scarichi puntuali in corpo idrico<br />
superficiale, non riconducibili ad opere temporanee <strong>di</strong> esercizio delle reti<br />
acquedottistiche, su suolo e strati superficiali del sottosuolo;<br />
• impianti fotovoltaici;<br />
• piani urbanistici attuativi con destinazione d’uso produttiva e/o residenziale e/o per<br />
servizi.<br />
4. impianti eolici (rimane da definire soglia <strong>di</strong>mensionale) da realizzare (dove tali opere<br />
sono consentite) e nella fascia perimetrale esterna <strong>di</strong> 5 Km intorno ai confini del sito,<br />
attenendosi, per i chirotteri, alle in<strong>di</strong>cazioni adottate dal Consiglio d’Europa con la<br />
risoluzione 5.6 “Wind Turbines and Bat Populations” del 2006 e, in particolare:<br />
- basandosi su indagini conoscitive, sia bibliografiche, sia sul campo, relative all’intero<br />
arco dell’anno, considerando un’area interessata dalle indagini del raggio <strong>di</strong> almeno 5<br />
km attorno alle centrali eoliche in progetto, al fine <strong>di</strong> conoscere gli aspetti quantitativi e<br />
qualitativi delle comunità ni<strong>di</strong>ficanti, svernanti e migratrici; - in<strong>di</strong>viduando e monitorando<br />
le rotte migratore degli uccelli e dei chirotteri e le aree <strong>di</strong> collegamento per le specie<br />
presenti nell’ambito regionale, oltre che con rilievi a vista, me<strong>di</strong>ante strumenti (es. radar,<br />
termocamere, ecc.) in grado <strong>di</strong> fornire le in<strong>di</strong>cazioni circa fenologia e caratteristiche del<br />
flusso migratorio (es. altezza e <strong>di</strong>rezione <strong>di</strong> volo, intensità, Ecc.). In caso <strong>di</strong> specie con<br />
<strong>di</strong>verso home range (maggiori <strong>di</strong> 5 Km), il buffer entro cui vale l'obbligo <strong>di</strong> effettuare la<br />
Valutazione <strong>di</strong> Incidenza, viene definito dall'ampiezza dell'home range stesso.<br />
5. impianti a biomassa (rimane da definire soglia <strong>di</strong>mensionale), anche quando questi<br />
siano localizzati in aree esterne al sito Natura 2000 per un’area buffer <strong>di</strong> 1 chilometro<br />
dal perimetro del sito stesso; è fatto obbligo <strong>di</strong> effettuare la valutazione <strong>di</strong> incidenza<br />
anche nel caso in cui i terreni <strong>di</strong> approvigionamento delle biomasse e <strong>di</strong> span<strong>di</strong>mento<br />
del <strong>di</strong>gestato prodotto rientrino nel buffer <strong>di</strong> 1 km; ; per <strong>di</strong>stanze superiori al buffer<br />
in<strong>di</strong>cato non è comunque esclusa a priori la possibilità <strong>di</strong> procedere alla Valutazione <strong>di</strong><br />
Incidenza da parte dell'Ente competente, che ne valuterà la necessità come previsto<br />
dalla normativa vigente (DGR 1191/2007)<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA RENO”
CAP. 8 – PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA PAG. 199<br />
8.1 Proposte <strong>di</strong> restringimento della Tabella E<br />
6. Per la tipologia <strong>di</strong> interventi previsti al punto 2 della Tabella E, è necessaria una<br />
valutazione ecologica limitata ai chirotteri, con sopralluogo nell’e<strong>di</strong>ficio per la verifica<br />
dell’esistenza <strong>di</strong> colonie <strong>di</strong> queste specie, utilizzando le “Linee guida per la<br />
conservazione dei chirotteri nelle costruzioni antropiche e la risoluzione degli aspetti<br />
conflittuali connessi” e<strong>di</strong>to nel 2008 a cura <strong>di</strong> GIRC, Ministero dell’Ambiente”<br />
7. Per la tipologia <strong>di</strong> interventi previsti al punto 5 della Tabella E, in caso <strong>di</strong> intervento su<br />
ponti è necessaria una valutazione limitata ai chirotteri, con sopralluogo della struttura<br />
per la verifica dell’esistenza <strong>di</strong> colonie <strong>di</strong> queste specie, utilizzando le “Linee guida per<br />
la conservazione dei chirotteri nelle costruzioni antropiche e la risoluzione degli aspetti<br />
conflittuali connessi” e<strong>di</strong>to nel 2008 a cura <strong>di</strong> GIRC, Ministero dell’Ambiente e della<br />
Tutela del Territorio e del Mare e Ministero per i Beni e le Attività Culturali e s.m.i.”.<br />
8. Per la tipologia <strong>di</strong> interventi previsti al punto 6, nelle more <strong>di</strong> attuazione della misura <strong>di</strong><br />
tutela integrale del Rio Cocco, è fatto obbligo <strong>di</strong> effettuare la Valutazione <strong>di</strong> Incidenza<br />
per interventi <strong>di</strong> utilizzazione del bosco anche quando riguar<strong>di</strong>no superfici inferiori ad 1<br />
ha entro una fascia <strong>di</strong> 100 m dal corso d'acqua<br />
9. Per la tipologia <strong>di</strong> interventi previsti al punto 10 è fatto obbligo <strong>di</strong> effettuare la<br />
Valutazione <strong>di</strong> Incidenza <strong>di</strong> opere ed interventi in alveo, anche quando trattasi <strong>di</strong><br />
manutenzione or<strong>di</strong>naria, nei corsi d'acqua in cui risulti presente il gambero <strong>di</strong> fiume<br />
(Austropotamobius pallipes)<br />
8.2 Opere <strong>di</strong>rettamente connesse alla gestione del sito da non sottoporre a<br />
Valutazione d’Incidenza (cfr. Tabella E punto 15)<br />
Come previsto dalla DGR 1191/2007 (Tabella E, punto 15) non sono sottoposti a Valutazione <strong>di</strong><br />
Incidenza i piani e/o gli interventi <strong>di</strong>rettamente connessi o necessari alla conservazione <strong>di</strong><br />
habitat e specie previsti dalle presenti Misure Specifiche <strong>di</strong> Conservazione che per definizione<br />
concorrono al raggiungimento degli obiettivi <strong>di</strong> conservazione da esse perseguiti, <strong>di</strong> seguito<br />
in<strong>di</strong>cati: da in<strong>di</strong>viduare tra le misure contenute nello specifico aAllegato.<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA RENO”
BIBLIOGRAFIA PAG. 200<br />
BIBLIOGRAFIA<br />
AA.VV. (2008) – Guida alla <strong>di</strong>sciplina della caccia nell’ambito della <strong>di</strong>rettiva 79/409/CEE sulla<br />
conservazione degli uccelli selvatici. Commissione Europea.<br />
AA. VV. (2002-2008) - Carte ittiche dell’Emilia Romagna zone A, B, C, D. A cura <strong>di</strong>: CREST –<br />
Centro Ricerche in Ecologia e Scienze del Territorio. Regione Emilia Romagna, Assessorato<br />
Attività Produttive, Sviluppo Economico e Piano Telematico. <strong>Bologna</strong>.<br />
Agnelli P., Martinoli A., Patriarca E., Russo D., Scaravelli D. e Genovesi P. (a cura <strong>di</strong>), 2004 –<br />
Linee guida per il monitoraggio dei Chirotteri: in<strong>di</strong>cazioni metodologiche per lo stu<strong>di</strong>o e la<br />
conservazione dei pipistrelli in Italia. Quad. Cons. Natura, 19, Min. Ambiente – Ist. Naz.<br />
Fauna Selvatica.<br />
Agnelli P., Russo D., Martinoli A. (a cura <strong>di</strong>), 2008 - Linee guida per la conservazione dei<br />
Chirotteri nelle costruzioni antropiche e la risoluzione degli aspetti conflittuali connessi.<br />
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero per i Beni e le<br />
Attività Culturali, Gruppo Italiano Ricerca Chirotteri e Università degli Stu<strong>di</strong> dell’Insubria.<br />
A.P.A.T. (2007) - I.F.F. 2007 In<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> Funzionalità Fluviale, Nuova versione del metodo<br />
revisionata. Manuale A.P.A:T./ 2007, Roma, pp. 336.<br />
APAT-IRSA CNR (2003) - Meto<strong>di</strong> analitici per le acque. In<strong>di</strong>ce biotico esteso (I.B.E.). Metodo<br />
9020: 1115-1136.<br />
Barbati A., Corona P., Garfì G., Marchetti M., Ronchieri I. (2002) – La gestione forestale nei<br />
SIC/ZPS della rete Natura 2000: chiavi <strong>di</strong> interpretazione e orientamenti per l’applicazione<br />
della <strong>di</strong>rettiva Habitat. Monti e Boschi, 2: 4-13.<br />
Benedetto L., Franco A., Marco A. B., Clau<strong>di</strong>a C. & Edoardo R., 2007 - Fauna d'Italia, vol. XLII,<br />
Amphibia, Calderini, <strong>Bologna</strong>, XI + 537 pp.<br />
Bertozzi M., 2008 - Progetto <strong>di</strong> tutela, monitoraggio e sensibilizzazione dell’opinione pubblica<br />
nei confronti della fauna minore all’interno del Parco della Chiusa.<br />
Bertozzi M., 2010 - Progetto <strong>di</strong> tutela, monitoraggio e sensibilizzazione dell’opinione pubblica<br />
nei confronti della fauna minore all’interno del Parco della Chiusa.<br />
Bion<strong>di</strong> E., Blasi C. (a cura <strong>di</strong>) (2009) – Manuale italiano <strong>di</strong> interpretazione degli habitat della<br />
Direttiva 92/43/CEE.<br />
Braioni G., Penna G. (1998) - I nuovi In<strong>di</strong>ci Ambientali sintetici <strong>di</strong> valutazione della qualità delle<br />
rive e delle aree riparie: Wild State index, Buffer Strip index, Environmental Landscape<br />
In<strong>di</strong>ces: il metodo. Bollettino C.I.S.B.A. 6.<br />
Cavalli R. & Mason F. (a cura <strong>di</strong>) (2003) – Tecniche <strong>di</strong> ripristino del legno morto per la<br />
conservazione delle faune saproxiliche. Il progetto LIFE Natura NAT/IT/99/6245 <strong>di</strong> “Bosco<br />
della Fontana” (Mantova, Italia). Gianluigi Arcari E<strong>di</strong>tore, Mantova.<br />
Cerabolini B., Villa M., Brusa G., Rossi G. (2009) – Linee guida per la gestione della flora e<br />
della vegetazione delle aree protette nella Regione Lombar<strong>di</strong>a. Centro Flora Autoctona.<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA RENO”
BIBLIOGRAFIA PAG. 201<br />
Corti C., Capula M., Luiselli L., Sindaco R. & Razzetti E., 2011 - Fauna d'Italia, vol. XLV,<br />
Reptilia, Calderini, <strong>Bologna</strong>, XII + 869 pp.<br />
Dall'Alpi A. & Sazzini M., 2006 - Status and conservation of two populations of Salamandrina<br />
perspicillata in the <strong>Bologna</strong> Province. In: SHI: Atti del VI Convegno (30 settembre 2006,<br />
Roma).<br />
Del Favero R. (a cura <strong>di</strong>) (2000) – Bio<strong>di</strong>versità ed in<strong>di</strong>catori nei tipi forestali del Veneto. Regione<br />
Veneto.<br />
Dinetti M. (2000) - Infrastrutture ecologiche. Manuale pratico per progettare e costruire le opere<br />
urbane ed extraurbane nel rispetto della conservazione e della bio<strong>di</strong>versità. Il Verde<br />
E<strong>di</strong>toriale, Milano.<br />
Douglas D.C., Ratti J.T., Black R.A., Alldredge J.R. (1992) - Avian Habitat Associations in<br />
Riparian Zones of Idaho's Centennial Mountains. Wilson Bulletin, 104:485-500.<br />
Ecosistema, 2007 - Relazione <strong>di</strong> accompagnamento agli elaborati prodotti nel 2006 e nel 2007<br />
per gli stu<strong>di</strong> sulla fauna <strong>di</strong> interesse comunitario nei siti rete Natura 2000 del territorio<br />
collinare e montano della provincia <strong>di</strong> <strong>Bologna</strong>.<br />
Frazer J.F.D., 1973 - Estimating butterfly numbers. Biological Conserv., 5 (4): 271-276.<br />
Fry R. & Waring P., 2001 - A Guide to moths traps and their use. The Amateur Entomologists’,<br />
24: 1-68.<br />
Garibol<strong>di</strong> A., Andreotti A. e Bogliani G. (2004) – La conservazione degli uccelli in Italia-Strategie<br />
ed azioni – Alberto Per<strong>di</strong>sa E<strong>di</strong>tore.<br />
Ghetti, P.F. (1997) - In<strong>di</strong>ce Biotico Esteso (I.B.E.). I macroinvertebrati nel controllo della qualità<br />
degli ambienti <strong>di</strong> acque corrente. <strong>Provincia</strong> Autonoma <strong>di</strong> Trento. pp. 222.<br />
Har<strong>di</strong>ng P.T., Asher F. & Yates T.J., 1995 - Butterfly monitoring 1 – recor<strong>di</strong>ng the changes. In:<br />
Pullin A.S. (ed.) Ecology and Conservation of Butterflies. pp. 3-22. Chapman & Hall, London.<br />
Harvey D., Hawes C.J., Gange A.C., Finch P., Chesmore D. & Farr I., 2011 - Development of<br />
non-invasive monitoring methods for larvae and adults of the stag beetle, <strong>Luca</strong>nus cervus.<br />
Insect Conservation and Diversity, 4: 4-14.<br />
Kaila L., 1993 - A new method for collecting quantitative samples of insects associated with<br />
decaying wood or wood fungi. Entomol. Fennica, 4: 21-23.<br />
Kowarik I. (1995) - On the role of alien species in urban flora and vegetation. In: Pysek, P.,<br />
Prach, K., Rejmànek, M. & Wade, P.M. (eds.): Plant invasions - general aspects and special<br />
problems, pp. 85-103. SPB Academic Publishing, Amsterdam.<br />
Mazzotti S., Caramori G. & Barbieri C., 1999 - Atlante degli Anfibi e Rettili dell'Emilia-Romagna<br />
(Aggiornamento 1993/1997). Quad. Staz. Ecol. Civ. St. nat. Ferrara, 12: 121 pp.<br />
Ministero per l’Ambiente e per la Tutela del Territorio (2000) - Manuale per la gestione dei siti<br />
Natura 2000.<br />
Mitchell-Jones A. J., Bihari Z., Masing M. & Rodrigues L., 2007 - Protecting and managing<br />
underground sites for bats. EUROBATS Publication Series No. 2 (English version).<br />
UNEP/EUROBATS Secretariat, Bonn, Germany.<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA RENO”
BIBLIOGRAFIA PAG. 202<br />
Moyle P.B., Nichols R.D. (1973) - Ecology of some native and introduced fishes of the Sierra<br />
Nevada foothills in central California. Copeia, 3: 478-490.<br />
Muller S., Berthoud G. (1996) - Fauna/traffic safety. Manual for civil engineers. Département<br />
Génie Civil, Ecole Polytechnic Féderale, Lausanne.<br />
Nelson M. W. (1979a) – Impact of Pacific Power and Light Company’s 500kV line construction<br />
on raptors. Unpubl. rep. Pacific Power and Light Company, Portland, Oregon.<br />
Nelson M. W. (1979b) – Power line progress report on eagle protection research. Unpubl. rep.<br />
Boise, Idaho.<br />
Nelson M. W. (1980) – Update on eagle protection practices. Unpubl. rep. Boise, Idaho.<br />
Nonnis Marzano F., Piccinini A., Palanti E. (2010) - Stato dell’ittiofauna delle acque interne della<br />
regione Emilia Romagna e strategie <strong>di</strong> gestione e conservazione – Relazione finale.<br />
Università degli Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> Parma – Dipartimento <strong>di</strong> Biologia Evolutiva e Funzionale, Parma.<br />
Parenzan P. & De Marzo L., 1981 - Una nuova trappola luminosa per la cattura <strong>di</strong> Lepidotteri ed<br />
altri insetti ad attività notturna. Informatore del Giovane Entomologo, suppl. Boll. Soc.<br />
entomol. ital., Genova, 99: 5-11.<br />
Penteriani V. (1998) – L’impatto delle linee elettriche sull’avifauna. WWF Toscana.<br />
Pignatti G., De Natale F., Gasparini P. & Paletto A., 2009 - Il legno morto nei boschi italiani<br />
secondo l'Inventario Forestale Nazionale. Forest@ 6: 365-375<br />
Pirovano A. R., Cocchi R. (2008) - Linee Guida per la mitigazione dell’impatto degli elettrodotti<br />
sull’avifauna. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.<br />
Piussi P. (1994) – Selvicoltura generale. Ed. UTET.<br />
Pollard E. & Yates, T.J., 1993 - Monitoring Butterflies for Ecology and Conservation. Chapman<br />
& Hall, London 274 pp.<br />
Romin, L.A., Bissonette J.A. (1996a) - Deer-vehicle collisions: nationwide status of state<br />
monitoring activities and mitigation efforts. Wildlife Society Bulletin 24.<br />
Romin, L.A., Bissonette J.A. (1996b) - Temporal and spatial <strong>di</strong>stribution of highway mortality of<br />
Mule deer in newly constructed roads at Jordanelle Resevoir, Utah. Great Basin Naturalist<br />
56: 1-11.<br />
Seber G.A.F., 1973 - The estimation of animal abundance. Griffin, London, XII+506 pp.<br />
Siitonen J., 1994 - Deacying wood and saproxylic Coleoptera in two old spruce forests: a<br />
comparison based on two sampling methods. Ann. Zool. Fennici, 31: 89-95.<br />
Southwood T.R.E., 1978 - Ecological Methods. 2nd e<strong>di</strong>tion. xxiv + 524 pp. Chapman & Hall,<br />
London.<br />
Sovada M.A., Roy C.C., Bright J.B., Gillis J.R. (1998) - Causes and rates of mortality of swift<br />
foxes in western Kansas. Journal of Wildlife Management 62:1300-1306.<br />
Turin P., Maio G., Zanetti M.,Bilò M.F., Rossi V., Salviati S. (1999) - Carta Ittica della <strong>Provincia</strong><br />
<strong>di</strong> Rovigo. Amministrazione <strong>Provincia</strong>le <strong>di</strong> Padova, pp. 400 + all.<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA RENO”
BIBLIOGRAFIA PAG. 203<br />
Zangheri P., 1981 - Il naturalista esploratore, raccoglitore, preparatore, imbalsamatore. Guida<br />
pratica elementare per la raccolta, preparazione, conservazione <strong>di</strong> tutti gli oggetti <strong>di</strong> Storia<br />
Naturale. Sesta e<strong>di</strong>zione riveduta. Hoepli E<strong>di</strong>tore, ristampa 2001, pp. 506.<br />
Zerunian S. (2004) - Pesci delle acque interne d’Italia. Quad. Cons. Natura, 20, Min. Ambiente –<br />
Ist. Naz. Fauna Selvatica.<br />
Zerunian S., Goltara A., Schipani I., Boz B. (2009) - Adeguamento dell’In<strong>di</strong>ce dello Stato<br />
Ecologico delle Comunità Ittiche alla Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE. Biologia<br />
Ambientale, 23 (2): 15-30, 2009.<br />
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA RENO”