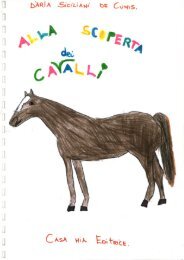“ Un terzo tentativo di analisi paleografica“ - Archivi di Famiglia
“ Un terzo tentativo di analisi paleografica“ - Archivi di Famiglia
“ Un terzo tentativo di analisi paleografica“ - Archivi di Famiglia
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
8.1 Premessa<br />
<strong>“</strong> <strong>Un</strong> <strong>terzo</strong> <strong>tentativo</strong> <strong>di</strong> <strong>analisi</strong> paleografica<strong>“</strong><br />
Ciò che segue è una parte tesi <strong>di</strong> laurea <strong>di</strong> Natascia Lucarini 1 , quella de<strong>di</strong>cata allo stu<strong>di</strong>o della<br />
grafia <strong>di</strong> Joan Antonio Cumis.<br />
Conclude la documentazione un articolo <strong>di</strong> Nicola Siciliani de Cumis, Lettera su lettera,<br />
pubblicato sulla rivista «La <strong>Famiglia</strong>», nel 2010 2 .<br />
1 Studentessa del Corso <strong>di</strong> Laurea in Scienze dell’Educazione e Formazione.<br />
Si è laureata nell’anno accademico 2008-2009 con una tesi dal titolo Il carattere nei caratteri. Prime note su grafologia e<br />
educazione.<br />
2 NICOLA SICILIANI DE CUMIS, Lettera su lettera, in «La <strong>Famiglia</strong>», aprile-giugno 2010, pp. 82-85.
Postilla<br />
Lettera su lettera<br />
A Natascia Lucarini<br />
Cara Natascia, volevo ritornare ancora una volta sul suo elaborato scritto per la laurea triennale,<br />
dal titolo Il carattere nei caratteri. Prime note su grafologia e educazione (<strong>Un</strong>iversità degli Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong><br />
Roma <strong>“</strong>La Sapienza”, Anno Accademico 2008-2009. Relatore: Nicola Siciliani de Cumis.<br />
Correlatore: Corrado Veneziano). In particolare, mi interessava <strong>di</strong>re <strong>di</strong> una delle appen<strong>di</strong>ci, la<br />
seconda, Analisi <strong>di</strong> una lettera venuta da lontano, in quanto si rifà proprio alla precedente puntata <strong>di</strong><br />
questa rubrica <strong>di</strong> Carte <strong>di</strong> <strong>Famiglia</strong>, dal titolo Da Catanzaro alle Ande (cfr. <strong>“</strong>La <strong>Famiglia</strong>”, 249, lugliosettembre<br />
2009, pp. 89-92). Ma per capire meglio <strong>di</strong> che si tratta, ricordo l’In<strong>di</strong>ce generale del suo<br />
lavoro. E dunque:<br />
Premessa ................................................................................................. IX<br />
Introduzione ........................................................................................... XI<br />
Parte prima ............................................................................................. 1<br />
Capitolo primo – La grafologia nell’educazione. ................................ 3<br />
1.1. La grafologia in età evolutiva. ......................................................... 3<br />
1.2. Altre applicazioni. ............................................................................ 6<br />
1.3. Il metodo morettiano. ...................................................................... 7<br />
Capitolo secondo – Dimensioni grafologiche e pedagogiche. ............. 9<br />
2.1. La formazione del grafologo. .......................................................... 9<br />
2.2. L’AGP. ............................................................................................ 14<br />
Capitolo <strong>terzo</strong> –Tra <strong>“</strong>grammatica” e <strong>di</strong>dattica elementare:<br />
segni grafici fondamentali. ................................................................... 21<br />
3.1. Come interpretare una lettera. ...................................................... 21<br />
3.2. Nozioni per una buona auto<strong>analisi</strong>. .............................................. 23<br />
Parte seconda ........................................................................................ 27<br />
Capitolo primo – <strong>Un</strong>a esemplificazione <strong>di</strong> Cattedra:<br />
come scriveva Antonio Labriola. . ........................................................ 29<br />
1.1. La vita <strong>di</strong> Labriola in pillole: spunti grafologici. .......................... 29<br />
1.2. Quello che già sappiamo, quello che cerchiamo. ........................ 31<br />
Capitolo secondo – Analisi grafologica. ............................................. 35<br />
2.1. Labriola <strong>di</strong>ciannovenne .................................................................. 35<br />
2.2. Labriola anni ’70. ............................................................................ 38<br />
2.3. Labriola anni ’80. ............................................................................ 41<br />
2.4. Labriola tra 1890 e 1900. ................................................................. 43<br />
2.5. Labriola e la malattia. ..................................................................... 46<br />
Capitolo <strong>terzo</strong> – Cattedre pedagogiche a confronto. .......................... 49<br />
3.1. Antonio Labriola. ........................................................................... 49<br />
3.2. Luigi Credaro. ................................................................................. 51<br />
3.3. Aldo Visalberghi. ........................................................................... 54<br />
3.4. Nicola Siciliani de Cumis. .............................................................. 57
Conclusioni. ........................................................................................... 61<br />
Appen<strong>di</strong>ce I. La grafologia nell’orientamento scolastico:<br />
attuazione <strong>di</strong> un progetto. ........................................................................ 63<br />
Appen<strong>di</strong>ce II. Analisi <strong>di</strong> una lettera venuta da lontano. ............................. 67<br />
Appen<strong>di</strong>ce III. Tariffario grafologico. ......................................................... 79<br />
Riferimenti biblio-sitografici. ................................................................... 81<br />
In<strong>di</strong>ce dei nomi. ....................................................................................... 85<br />
In<strong>di</strong>ce delle tematiche. . ............................................................................. 87<br />
Su questa base, ripropongo quin<strong>di</strong> qui <strong>di</strong> seguito una parte della suddetta Appen<strong>di</strong>ce II: e cioè<br />
l’essenziale, per proseguire la ricerca da me proposta sul numero su citato <strong>di</strong> <strong>“</strong>La <strong>Famiglia</strong>”; e, così<br />
facendo, per ringraziarla della consulenza grafologica offerta; e per invitarla a non perdere <strong>di</strong> vista<br />
le indagini su Joan Antonio Cumis, che proseguono a più livelli: e <strong>di</strong> cui, intanto, proprio la lettera<br />
oggetto della sua attenzione, è un risultato.<br />
Lei, Natascia, scrive infatti a proposito del mio testo <strong>di</strong> <strong>“</strong>La <strong>Famiglia</strong>” e del testo della lettera<br />
manoscritta, da Catanzaro, 21 marzo 1580, conservata presso l’<strong>Archivi</strong>o della Casa Generalizia<br />
della Compagnia <strong>di</strong> Roma (<strong>Archivi</strong>um Romanum Societatis Iesu/ARSI, Ital. 156. 1580. ff. 65-66; 70<br />
- Epistolae III – 4 – 288 - Cullio).<br />
Ecco il suo testo (in parte):<br />
[… ] Sul web le notizie riguardanti Cumis non sono molte e quanto esse possano essere<br />
atten<strong>di</strong>bili è ancora da capire. Vengono <strong>di</strong> seguito pubblicate due traduzioni <strong>di</strong> una stessa lettera:<br />
traduzioni, che hanno aspetti comuni, ma che si <strong>di</strong>fferenziano sotto alcuni aspetti. Joan Anton<br />
Cumis scrive questa lettera al Padre Clau<strong>di</strong>o Acquaviva, si definisce malato ma <strong>di</strong> cosa è ancora da<br />
comprendere con precisione. Questi ed altri quesiti sono al centro della storia <strong>di</strong> JAC che è ancora<br />
tutta o quasi tutta da scoprire.<br />
Analisi 3 paleografica del testo della epistola inviata dal gesuita coa<strong>di</strong>utore Joan Anton Cumis<br />
(Jac) da Catanzaro a Roma al generale della compagnia <strong>di</strong> Gesù Padre Clau<strong>di</strong>o Acquaviva il<br />
21.3.1580<br />
(A chi e dove è inviata l’Epistola viene ricavato solo in<strong>di</strong>rettamente dai toni usati, esprimenti una<br />
devozione particolare e dal tipo <strong>di</strong> permesso richiesto che poteva essere accordato solo dal Generale della<br />
Compagnia <strong>di</strong> Gesù, che al tempo era appunto il Padre Clau<strong>di</strong>o Acquaviva).<br />
La Epistola è composta da 17 righe:<br />
1. Catanzaro 21 marzo 1580 Jo. Anton Cumis 57<br />
2. Molto Rev.do in Dio Padre<br />
3. Pax Xsti (Saluto fra religiosi tratto da una frase <strong>di</strong> S. Paolo, adottata da S. Ignazio da Loyola)<br />
4. Io Giò. Ant. ° Cumis fratello coagiusore della Comp.a <strong>di</strong> Gesù proponendo humiltade<br />
5. fo intendere a S. R. garantiti (?) essendo tre<strong>di</strong>ci anni (*) che sto nella Comp.a<br />
3 Prima traduzione e annotazioni, a cura <strong>di</strong> Gianvincenzo Siciliani de Cumis. Consulenze del Padre Saveriano<br />
Mimmo Calarco e del prof. Franco Porsia (sulla base <strong>di</strong> una propria traduzione).
6. <strong>di</strong> Gesù, adesso (?) essendo incorso in una grave infermità de paralisi e per causa<br />
7. delli esercizi della Comp.a et essendo che mi risono cre<strong>di</strong>bile (?) per li esercizi<br />
8. mi La penso in Dio facendo intendere, et repareria in gran opere <strong>di</strong> Charità<br />
9. <strong>di</strong> concedermi che mi si riposi in casa <strong>di</strong> miei fratelli per quattro anni sana,<br />
10. che mi guarisca <strong>di</strong> detta infermità pigliando favori per servir meglio la Comp.a<br />
Interrigo <strong>di</strong> annotazione: ciò che patisco d’epilessia, cioè <strong>di</strong> pazzia (nel ‘500 le malattie neurologiche<br />
erano considerate un tutt’uno, e quin<strong>di</strong> confuse con quelle psichiatriche, il che spiega l’usa <strong>di</strong> quel doppio<br />
cioè).<br />
11. l’alma <strong>di</strong> dui miei fratelli, che sono in estrema necessità, et hanno bisogno<br />
12. grandemente del mio agiuso, pure se farà quello che or<strong>di</strong>nava S. R. (Sua Reverenza)<br />
13. et La preghiamo, come gra<strong>di</strong>tissimo da Dio (**). Non altro da Catanzaro.<br />
14. Adì 21 <strong>di</strong> Marzo delli ‘80<br />
15. D. S. R. P (Di Sua Reverenda Paternità)<br />
16. Suo in XSto ( Stesso saluto <strong>di</strong> S. Ignazio)<br />
17. Jo. Anton Cumis<br />
Annotazioni:<br />
(*) JAC entrò nella Compagnia <strong>di</strong> Gesù il 1567 come si evince dalla stessa presente Epistola.<br />
(**) Dal contesto della Epistola si evince che JAC chiede a Padre Acquaviva quella che si chiama<br />
tecnicamente una <strong>“</strong>eclaustrazione”, cioè un permesso temporaneo <strong>di</strong> abitare fuori dal Collegio Romano <strong>di</strong><br />
Catanzaro, presso cui evidentemente era ospitato <strong>di</strong> norma JAC, per circa quattro anni; e questo, non tanto<br />
per poter curarsi, quanto per essere <strong>di</strong> aiuto ai suoi fratelli che erano nel bisogno.<br />
L’<strong>analisi</strong> che segue 4 vuole essere uno tra i tanti esempi possibili <strong>di</strong> applicazione grafologica. Si è<br />
scelto <strong>di</strong> realizzarla proprio su questa lettera, poiché raccoglie in sé i seguenti fattori dominanti.<br />
1. Rappresenta il materiale iniziale <strong>di</strong> una ricerca appena avviata e che ha come suo oggetto la<br />
conoscenza <strong>di</strong> un autore del quale pochissimo o niente si conosce.<br />
2. La grafologia può essere uno strumento <strong>di</strong> aiuto per la comprensione della psicologia <strong>di</strong> Jo.<br />
Anton Cumis e per la ricostruzione del testo, dei contesti e delle indagini che vi sono<br />
correlate.<br />
3. Tale <strong>analisi</strong> ha inoltre una doppia valenza pedagogica:<br />
a. contribuire a ricostruire la formazione della personalità oggetto <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o;<br />
b. ottenere un risultato storiografico in via <strong>di</strong> ipotesi nuovo.<br />
Dal punto <strong>di</strong> vista <strong>di</strong> un completamento e sviluppo della ricerca vengono registrati nelle pagine<br />
seguenti i punti <strong>di</strong> arrivo.<br />
A prima vista la grafia risulta allungata, accurata, artificiale, confusa, <strong>di</strong>sor<strong>di</strong>nata, dritta; e<br />
mantiene il rigo. Nello specifico, allungata ossia sproporzionata, tra le ampiezze letterali e le loro<br />
<strong>di</strong>mensioni orizzontali e verticali in<strong>di</strong>ca narcisismo e mania <strong>di</strong> fare bella figura.<br />
La grafia stu<strong>di</strong>ata e artificiosa sostiene la tesi appena esposta in quanto le caratteristiche esposte<br />
si manifestano in scritture in cui il soggetto analizzato mostra una tendenza all’artificio,<br />
all’esibizionismo, un bisogno <strong>di</strong> fare buona figura. <strong>Un</strong>o scritto confuso in grafologia sta a in<strong>di</strong>care<br />
un pensiero in<strong>di</strong>stinto, impreve<strong>di</strong>bili cambiamenti <strong>di</strong> umore e smemoratezza che porta al<br />
<strong>di</strong>sor<strong>di</strong>ne ovvero alla mancanza <strong>di</strong> chiarezza e all’istintività.<br />
La scrittura avendo poca pendenza è definita dritta e in<strong>di</strong>ca senso del dovere, orgoglio,<br />
freddezza e scarsa presenza del sentimento.<br />
4 A cura <strong>di</strong> Natascia Lucarini. Sono state qui tolte le immagini dei manoscritti.
Va inoltre detto che lo scrivente che mantiene il rigo (come in questo caso) manifesta fermezza e<br />
rifiuto dei compromessi, oltre che temperamento molto volitivo e <strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong> adattamento.<br />
Ricapitolando, il soggetto qui analizzato è una persona estremamente egocentrica, esibizionista,<br />
con le idee poco chiare ma anche razionale e ligia al dovere.<br />
È possibile asserire che tra l’<strong>analisi</strong> grafologica e l’<strong>analisi</strong> paleografica si rilevano informazioni<br />
caratteriali che trovano congruenze con il contesto in cui è stata scritta la lettera.<br />
La necessità <strong>di</strong> fare una bella figura è giustificata dal destinatario della lettera e dal tipo <strong>di</strong><br />
permesso che viene chiesto. I repentini cambiamenti <strong>di</strong> umore e la fermezza possono essere<br />
giustificati dal suo <strong>di</strong>chiararsi pazzo. Il suo esserne cosciente attribuisce una specifica valenza alla<br />
sua malattia.<br />
Dunque, Natascia, l’Appen<strong>di</strong>ce II al suo elaborato <strong>di</strong> laurea, finisce qui. Se come mi ha<br />
preannunziato si iscriverà alla <strong>“</strong>magistrale”, potremo riprendere il <strong>di</strong>scorso. Mio fratello<br />
Gianvincenzo ed io stiamo portando avanti le ricerche su Joan Anton e <strong>di</strong>sponiamo <strong>di</strong> nuovi<br />
manoscritti anche epistolari. Ne riparleremo. E, alla luce dei nuovi testi, potremo ragionare ancora<br />
delle sue ipotesi grafologiche. Se può avere avuto ragione, o meno, sul carattere <strong>di</strong> questo Cumis,<br />
così come si evince dai caratteri della sua scrittura.<br />
<strong>Un</strong> caro saluto e auguri,<br />
Nicola Siciliani de Cumis<br />
Roma, 20 <strong>di</strong>cembre 2009