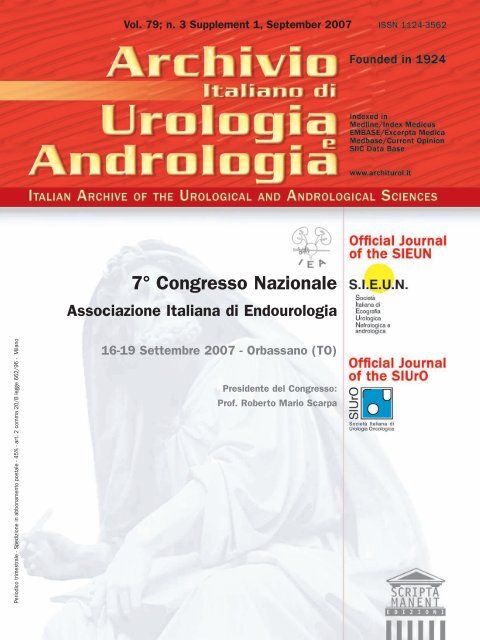7° Congresso Nazionale
7° Congresso Nazionale
7° Congresso Nazionale
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Periodico trimestrale - Spedizione in abbonamento postale - 45% - art. 2 comma 20/B legge 662/96 - Milano<br />
Vol. 79; n. 3 Supplement 1, September 2007<br />
<strong>7°</strong> <strong>Congresso</strong> <strong>Nazionale</strong><br />
Associazione Italiana di Endourologia<br />
16-19 Settembre 2007 - Orbassano (TO)<br />
Presidente del <strong>Congresso</strong>:<br />
Prof. Roberto Mario Scarpa
Urological and Andrological Sciences<br />
Founded in 1924 by: G. Nicolich, U. Gardini, G.B. Lasio<br />
Official Journal of the Editorial SIEUN - board Official Journal of the SIUrO<br />
Indexed in<br />
Medline/Index Medicus - EMBASE/Excerpta Medica - Medbase/Current Opinion - SIIC Data Base
<strong>7°</strong> <strong>Congresso</strong> <strong>Nazionale</strong> Associazione Italiana di Endourologia<br />
<strong>7°</strong> <strong>Congresso</strong> <strong>Nazionale</strong><br />
Associazione Italiana di Endourologia<br />
16-19 Settembre 2007 - Orbassano (TO)<br />
Presidente del <strong>Congresso</strong>: Prof. Roberto Mario Scarpa<br />
GIUNTA ESECUTIVA<br />
PRESIDENTE<br />
Roberto Mario Scarpa<br />
PAST PRESIDENT<br />
Giampaolo Bianchi<br />
VICE PRESIDENTE<br />
Massimino D’Armiento<br />
SEGRETARIO<br />
Emanuele Montanari<br />
TESORIERE<br />
Antonello De Lisa<br />
CONSIGLIERI<br />
Paolo Beltrami, Pietro Cortellini, Massimo Dal Bianco<br />
Antonello De Lisa, Emanuele Montanari, Domenico Prezioso<br />
COMITATO SCIENTIFICO<br />
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ENDOUROLOGIA<br />
Arcangelo Pagliarulo, Enrico Pisani, Guglielmo Breda, Sergio Caggiano<br />
Paolo Caione, Giovanni Caramia, Luca Cormio, Antonello De Lisa<br />
Salvatore Micali, Francesco Porpiglia, Alfredo Trippitelli,<br />
Andrea Tubaro, Gianpaolo Zanetti, Filiberto Zanotti<br />
COMITATO ORGANIZZATORE<br />
PRESIDENTE<br />
Roberto M. Scarpa<br />
SEGRETARI<br />
Francesco Porpiglia, Cesare Marco Scoffone<br />
COLLABORATORI<br />
Ivano Morra, Marco Cossu, Massimiliano Poggio, Cecilia Cracco<br />
Francesca Ragni, Alessandro Volpe, Michele Billia, Davide Vaccino<br />
Susanna Grande, Julien Renard, Rosaria Porcu<br />
Archivio Italiano di Urologia e Andrologia 2007; 79, 3, Supplemento 1<br />
I
II<br />
Informazioni Generali<br />
Segreteria Scientifica<br />
Roberto Mario Scarpa<br />
Azienda Ospedaliera S. Luigi<br />
Regione Gonzole 10<br />
10043 Orbassano (To)<br />
Tel. 011.9026556 Fax 011.9038654<br />
e.mail: romasca@tiscalinet.it<br />
Abstract e Videotapes<br />
Emanuele Montanari<br />
Clinica Urologia III<br />
Università degli Studi di Milano Polo San Paolo<br />
Via di Rudinì 8 - 20142 Milano<br />
Sede del <strong>Congresso</strong><br />
Università degli Studi di Torino<br />
Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche<br />
Azienda Sanitaria Ospedaliera S. Luigi<br />
Regione Gonzole 10<br />
10043 Orbassano (To)<br />
Segreteria IEA<br />
Associazione Italiana di Endourologia c/o EVCM<br />
Via Porrettana 76/2 – 40033 Casalecchio di Reno (Bo)<br />
Tel. +39 051 6194911 Fax +39 051 6194900<br />
E-mail: iea.segreteria@emiliaviaggi.it<br />
Web site: www.ieanet.it<br />
Segreteria Organizzativa<br />
E.V.C.M. s.r.l.<br />
Via Porrettana 76/2 – 40033 Casalecchio di Reno (Bo)<br />
Tel. +39 051 6194911 Fax +39 051 6194900<br />
E-mail: evcongressi@emiliaviaggi.it<br />
Web site: www.emiliaviaggi.it<br />
Sede della Chirurgia in Diretta, Minilabs, Workshop<br />
Università degli Studi di Torino<br />
Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche<br />
Azienda Sanitaria Ospedaliera S. Luigi<br />
Regione Gonzole 10<br />
10043 Orbassano (To)<br />
Iscrizioni dopo il 27 Luglio 2007<br />
Quota di Partecipazione NON SOC Euro 600,00 + IVA 20%<br />
Quota di Partecipazione SOCI IEA Euro 400,00 + IVA 20%<br />
Quota per Specializzandi Euro 150,00 + IVA 20%<br />
Quota per Infermieri Euro 30,00 + IVA 20%<br />
Quota per Studenti infermieri Nessuna quota<br />
La quota d’iscrizione comprende:<br />
Partecipazione ai Lavori Scientifici, Kit Congressuale, Attestato di Partecipazione,<br />
Lunch, Coffee Break.<br />
IL CORSO INFERMIERI è A NUMERO CHIUSO<br />
Espositori / Sponsor<br />
Verranno forniti su richiesta un massimo di nr. 3 badges gratuiti NON NOMINATIVI per Azienda.<br />
Archivio Italiano di Urologia e Andrologia 2007; 79, 3, Supplemento 1
16 Settembre 2007<br />
<strong>7°</strong> <strong>Congresso</strong> <strong>Nazionale</strong> Associazione Italiana di Endourologia<br />
<strong>7°</strong> <strong>Congresso</strong> <strong>Nazionale</strong><br />
Associazione Italiana di Endourologia<br />
16-19 Settembre 2007 - Orbassano (TO)<br />
Ore 15:00 SALUTO DELLE AUTORITÀ E INAUGURAZIONE DEL CONGRESSO<br />
Apertura dei lavori e introduzione da parte del Presidente del <strong>Congresso</strong><br />
Ore 15:30 Salvatore Rocca Rossetti: I trionfi della tecnologia nei miei ricordi<br />
Ore 16:00 Enzo Usai: La conservazione della vescica<br />
Ore 16:30-18:30 LETTURE in onore del Prof. S. ROCCA ROSSETTI e del Prof. E. USAI<br />
Introduzione. R.M. Scarpa<br />
Urodinamica: storia ed evoluzione in Italia. W. Artibani<br />
La chirurgia della calcolosi renale: dalla nefrectomia alla percutanea. G. Martorana<br />
La terapia chirurgica conservativa del tumore renale: dall’ipotesi alla pratica. M. Carini<br />
Le neovesciche con risparmio delle vescicole seminali:<br />
una chirurgia ricostruttiva e funzionale. P. Rigatti<br />
Nascita e sviluppo dell’endourologia in Italia. G. Bianchi<br />
La resezione endoscopica in Italia. V. Mirone<br />
Ore 19:00 Consegna dei riconoscimenti da parte del Presidente del <strong>Congresso</strong><br />
Archivio Italiano di Urologia e Andrologia 2007; 79, 3, Supplemento 1<br />
III
IV<br />
17 Settembre 2007<br />
AUDITORIUM<br />
Ore 8:30-9.00 LETTURA MAGISTRALE<br />
Le fasce pelviche, precisazioni anatomo chirurgiche e implicazioni funzionali. B. Frea<br />
Introduzione di S. Rocca Rossetti<br />
Ore 9:00-12:30 CHIRURGIA IN DIRETTA La chirurgia pelvica laparoscopica.<br />
(Programma indicativo – I programmi potranno subire delle variazioni, in base all’andamento degli interventi)<br />
Provoker: G. Carrieri, W. Artibani, A. Tizzani, U. Ferrando, M. Bellina<br />
Sala A Ernioplastica inguinale + TURP Bipolare (Gyrus). G. Breda<br />
Diverticulectomia vescicale. V. Pansadoro<br />
Sala B Prostatectomia radicale robotica. T. Piechaud<br />
Prostatectomia radicale robotica. W. Artibani<br />
Sala C Crioablazione di tumore renale. G. Guazzoni<br />
Ureteroscopia semirigida. J.R. Gautier<br />
Ureteroscopia flessibile. O. Traxer<br />
Sala D Prostatectomia radicale intrafasciale. F. Porpiglia<br />
Reimpianto uretero-vescicale in megauretere ostruttivo. F. Porpiglia<br />
Ore 12:30-13:30 TAVOLA ROTONDA La laparoscopia nella patologia pelvica.<br />
Moderatori: G. Bianchi, V. Mirone<br />
Analisi critica sui risultati funzionali. G. Breda<br />
Prospettive della laparoscopia nella chirurgia pelvica. G. Guazzoni<br />
Io scelgo ancora il cielo aperto. B. Frea<br />
Ore 13:30-14.30 Aule blu, verde, viola gialla, arancione, rossa.<br />
CORSI IEA Corso di Endoscopia delle basse Vie Urinarie su simulatori<br />
Ore 13:30-19.00 AUDITORIUM<br />
I resettori Mono e Bipolari. G. Breda 15’<br />
Tutor S. Micali, A. Celia<br />
La percutanea in posizione prona e supina<br />
Tecniche di puntura in posizione prona. E. Montanari<br />
Tecniche di puntura in posizione supina. C. Scoffone<br />
Tecniche endourologiche combinate. R.M. Scarpa<br />
Ureteroscopia flessibile<br />
Aggiornamento sullo strumentario e tecniche di accesso. L. Defidio<br />
Possibilità diagnostiche e terapeutiche. F. Cauda<br />
Ore 14:30-15:30 Prostatectomia radicale laparoscopica: standard o robotica?<br />
Moderatori: V. Di Santo, W. Artibani<br />
Faccia a faccia. F. Porpiglia, T. Piechaud<br />
Ore 16:00-16:30 SIMPOSIO KARL STORZ ENDOSCOPIA E COOK<br />
Lettura a tre voci: Le novità in Endourologia. J.R. Gautier. O. Traxer e R.M. Scarpa<br />
L’ureteroscopia rigida, l’ureteroscopia flessibile e la tecnica percutanea combinata<br />
Ore 16:30-17:30 TAVOLA ROTONDA: Malattia del giunto pielo ureterale e stenosi ureterale<br />
Moderatori: G. Morgia, M. Laudi<br />
Pieloplastica laparoscopica: è il Gold standard? G. Breda<br />
Trattamento endoscopico del giunto: ha ancora un ruolo? A. De Lisa<br />
Archivio Italiano di Urologia e Andrologia 2007; 79, 3, Supplemento 1
Ore 17:30-18:30 Golden video<br />
Trattamento endoscopico delle stenosi ureterali per via retrograda:<br />
vecchie e nuove incisioni. A. Pagliarulo<br />
Qual è il ruolo della chirurgia? G. Bianchi<br />
Moderatori: P. Pierini, M. Laudi<br />
<strong>7°</strong> <strong>Congresso</strong> <strong>Nazionale</strong> Associazione Italiana di Endourologia<br />
Ore 17:30 V1 - Nefrolitotrissia percutanea (PCNL) in età pediatrica: il Gold standard.<br />
A. Frattini, S. Ferretti, P. Salsi, F. Dinale, P. Granelli, P. Cortellini<br />
U.O. Urologia - Azienda Ospedaliera - Universitaria di Parma<br />
V2 - e-TURP: evoluzione tecnica della TURP.<br />
G. Breda, A. Celia, G. Zeccolini, S. El Dahshan<br />
Struttura Complessa di Urologia - Ospedale San Bassiano, Bassano del Grappa (VI)<br />
V3 - Correzione di cistocele centrale con tecnica trans-otturatoria.<br />
M. Simonazzi, S. Meli, F. Dinale, S. Fornia, P. Cortellini<br />
Unità Operativa di Urologia - Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma<br />
V4 - Trattamento endoscopico percutaneo di neoplasia uroteliale dell’alta via escretrice.<br />
B. Azizi, C. Vecchioli, A. Garritano, W. Giannubilo, V. Ferrara<br />
U.O. Urologia Ospedale Civile di Jesi (AN)<br />
V5 - Riallineamento di uretere retrocavale con pieloplastica laparoscopica.<br />
F. Porpiglia, J. Renard, M. Billia, S. Grande, M. Cossu, F. Ragni, M. Poggio, G. Biamino,<br />
M. Cussotto, I. Morra e R.M. Scarpa<br />
Università di Torino - Divisione Universitaria di Urologia<br />
Ospedale San Luigi (Torino)<br />
V6 - Rimozione di stent endoureterale calcifico in paziente con rene trapiantato mediante<br />
approccio endoscopic antero-retrogrado in posizione supina.<br />
C.M. Scoffone, M. Poggio, C. Cracco, R.M. Scarpa<br />
Clinica Urologica, Università di Torino, Ospedale San Luigi di Orbassano (Torino)<br />
Ore 18:30-19:00 Highlights della giornata<br />
18 Settembre 2007<br />
Moderatori: A. Volpe, C. Cracco<br />
Ore 8:00-9:00 Aule blu, verde, gialla, rossa, arancione<br />
Aula Blu Endourologia Alta Via escretrice 1<br />
Moderatori: G. Arena, A. Frattini<br />
Ore 8:00 C6 - Litotrissia ureterorenoscopica retrograda (RIRS) nel trattamento di calcoli renalidi dimensioni >2 cm.<br />
G. Giusti, A. Piccinelli, G. Taverna, A. Benetti, O. Maugeri, L. Pasini, S. Zandegiacomo de Zorzi,<br />
M. Corinti, P. Graziotti.<br />
U.O. di Urologia, Istituto Clinico Humanitas, IRCCS, Rozzano (Milano)<br />
C7 - Litotrissia percutanea: tubeless or not tubeless?<br />
G. Giusti, A. Piccinelli, G. Taverna, A. Benetti, O. Maugeri, L. Pasini, S. Zandegiacomo de Zorzi,<br />
M. Corinti, P. Graziotti<br />
U.O. di Urologia, Istituto Clinico Humanitas, IRCCS, Rozzano (Milano)<br />
C8 - La selezione del paziente con calcolosi reno ureterale. Valutazione personale<br />
dei fattori predittivi di successo.<br />
A. Saita, A. Bonaccorsi, M. Burrello, D. Aleo, B. Giammusso, G. Caldarella, M. Motta<br />
Clinica Urologica Università degli Studi Catania (OVE)<br />
C9 - Trattamento della litiasi con ESWL: valutazione retrospettiva su 584 pazienti.<br />
A. Saita, A. Bonaccorsi, F. Marchese, M. Falsaperla, S.V. Condorelli, M. Motta<br />
Clinica Urologica Università degli Studi Catania (OVE)<br />
Archivio Italiano di Urologia e Andrologia 2007; 79, 3, Supplemento 1<br />
V
VI<br />
C10 - Trattamento della calcolosi ureterale con ureteroscopio rigido: valutazione di 500 casi consecutivi.<br />
G. Deiana, L. Feroldi, L.P. Canclini, M. Nicolai, A. Lembo<br />
Unità Operativa di Urologia, Azienda Ospedaliera - Ospedali Riuniti di Bergamo<br />
C11 - PCNL in posizione di Valdivia-Uria mod. Galdakao nel trattamento della calcolosi renale:<br />
nostra esperienza.<br />
C.M. Scoffone, C.M. Cracco, M. Cossu, M. Poggio, S. Grande, M. Billia, R.M. Scarpa<br />
Clinica Urologica, Università di Torino, A.S.O. San Luigi di Orbassano (Torino)<br />
Aula Verde Endourologia Alta Via escrettrice 2<br />
Moderatori: A. De Zan, M. Medica<br />
Ore 8:00 C12 - Efficacia e sicurezza di una nuova sorgente di Holmium:yag laser<br />
nel trattamento endoscopico della calcolosi ureterale.<br />
L. Ruggera*, M. Zanin*, A. Aloisi*, P. Beltrami*, M. A. Cerruto*, W. Cecchetti**, F. Zattoni*<br />
*Divisione Clinicizzata di Urologia, Policlinico “G.B. Rossi”, Verona<br />
**Dipartimento Chimica Fisica, Università Cà Foscari, Venezia<br />
Aula Gialla Miscellanea 1<br />
C13 - Nefrolitiasi cistinica ricorrente: trattamento mediante ureterorenoscopia con strumento<br />
semi-rigido e/o flessibile e litotrissia con Holmium:yag laser.<br />
L. Ruggera*, M. Zanin*, L. Luciani**, F. Gigli*, P. Beltrami*, M. A. Cerruto*, F. Zattoni*<br />
*Divisione Clinicizzata di Urologia, Policlinico “G.B. Rossi”, Verona<br />
**Reparto di Urologia, Ospedale S. Chiara, Trento<br />
C14 - Ureterorenoscopia: studio prospettico dei possibili fattori prognostici.<br />
L. Ruggera, P. Beltrami, M. A. Cerruto, M. Zanin, A. Aloisi, F. Gigli, F. Zattoni<br />
Divisione Clinicizzata di Urologia, Policlinico “G.B. Rossi”, Verona<br />
C15 - Trattamento percutaneo di urotelioma della pelvi renale con elettrobisturi bipolare<br />
a radiofrequenza: evoluzione del trattamento endoscopico.<br />
M. Tura, O. Fenice, M. Parravicini, P. Baroni<br />
U.O. Urologia, Policlinico di Monza<br />
Moderatori: L. Cormio, F. Garofalo<br />
Ore 8:00 C16 - Trattamento del cistocele con tecnica tension free per via trans-otturatoria (PROLIFT A®).<br />
F. Blefari, C. Radicchia, P. A. Petroni<br />
U.O. Urologia ASL TR4 – Sede di Orvieto<br />
C17 - Nostra esperienza nel trattamento dell’incontinenza urinaria da sforzo maschile con PRO-ACT.<br />
G. Zeccolini, A. Celia, A. Caruso, G. Breda<br />
Struttura Complessa di Urologia - Ospedale San Bassiano, Bassano del Grappa (VI)<br />
C18 - Lo scollamento idraulico della fascia pelvica nella prostatectomia radicale nerve sparing:<br />
risultati istologici e funzionali.<br />
M. Mari, A. Ambu, S. Guercio, F. Mangione, M. Bellina<br />
U.O.C. Urologia, P.O. di Rivoli (TO)<br />
C19 - La litotrissia endcoscopia sovrapubica nel trattamento della calcolosi vescicale.<br />
A. Porreca, M. Preite, M. Frigo, V. Alfano, C. Tallarigo<br />
Polo Ospedaliero dell’Est Veronese, San Bonifacio (Verona)<br />
C20 - Pseudodiverticolo dell’uretere pelvico e possibilità di trattamento endourologico:<br />
case report e revisione della letteratura.<br />
M. Zanin, L. Ruggera, F. Gigli, P. Beltrami, M. A. Cerruto, D. Schiavone, F. Zattoni<br />
Divisione Clinicizzata di Urologia, Policlinico “G.B. Rossi”, Verona<br />
C21 - Cistoscopia flessibile con sistema endosheath slide-on, l’ottimizzazione<br />
dell’uso degli endoscopi flessibili.<br />
A. Porreca, M. Preite, M. Frigo, V. Alfano, C. Tallarigo<br />
Polo Ospedaliero dell’Est Veronese, San Bonifacio (Verona)<br />
Archivio Italiano di Urologia e Andrologia 2007; 79, 3, Supplemento 1
Aula Rossa Video Laparoscopia 1<br />
Moderatori: C. Martinengo, D. Minocci<br />
<strong>7°</strong> <strong>Congresso</strong> <strong>Nazionale</strong> Associazione Italiana di Endourologia<br />
Ore 8:00 V7 - Pieloplastica laparoscopica sinistra transmesenterica con accesso diretto alla giunzione<br />
pielo-ureterale.<br />
F. Porpiglia, M. Billia, J. Renard, I. Morra, M. Poggio, C. Scoffone, D. Vaccino, F. Ragni, R.M. Scarpa<br />
Università di Torino - Divisione Universitaria di Urologia - Ospedale San Luigi (Orbassano)<br />
V8 - Pieloplastica secondo Anderson Hynes laparoscopica assistita dal robot Da Vinci.<br />
G.M. Ludovico, G.D. Vestita, G. Cardo, G. Pagliarulo*, M. Erinnio, F.P. Maselli, E. Restini*<br />
Dipartimento delle Specialità Chirurgiche – Unità Operativa di Urologia Ospedale “S. Giacomo”<br />
Monopoli, Bari<br />
*Dipartimento di Chirurgia Generale Mininvasiva e Robotica “La Madonnina”, Bari<br />
V9 - Correzione laparoscopica di fistola vescico-vaginale. (video)<br />
F. Porpiglia, I. Morra, A. Volpe, M. Billia, R. M. Scarpa<br />
Divisione Universitaria di Urologia<br />
Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche, Ospedale San Luigi, Orbassano (TO)<br />
V10 - Adenomectomia prostatica laparoscopica extraperitoneale.<br />
A. Celia, G. Zeccolini, G. Breda<br />
Struttura Complessa di Urologia - Ospedale San Bassiano, Bassano del Grappa (VI)<br />
V11 - Riparazione laparoscopica extraperitoneale di ernia inguinale.<br />
A. Celia, G. Breda, G. Zeccolini<br />
Struttura Complessa di Urologia - Ospedale San Bassiano, Bassano del Grappa (VI)<br />
Aula Arancione Video Laparoscopia 2<br />
Moderatori E. Vestita, E. Barasolo<br />
Ore 8:00 V12 - Cistectomia parziale endo-laparoscopica per endometriosi vescicale.<br />
L. Carmignani, G. Aimi°, P. Vercellini°, M. Spinelli*, G. Bozzini*, R. Anceschi*, F. Rocco*, L. Fedele°<br />
UO Urologia IRCCS Policlinico San Donato M, *UO Urologia, °UO Ginecologia Ostetricia<br />
IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena MILANO<br />
V13 - Diverticulectomia vescicale laparoscopica extraperitoneale.<br />
A. Celia, G. Zeccolini, G. Breda<br />
Struttura Complessa di Urologia - Ospedale San Bassiano, Bassano del Grappa (VI)<br />
V14 - Prostatectomia laparoscopica extraperitoneale robot assistita:<br />
evoluzione dalla tecnica extrafasciale a quella intrafasciale.<br />
G.M. Ludovico, G.D. Vestita, G. Cardo, G. Pagliarulo*, M. Erinnio, F.P. Maselli, E. Restini*<br />
Dipartimento delle Specialità Chirurgiche – Unità Operativa di Urologia Ospedale “S. Giacomo”<br />
Monopoli – Bari<br />
*Dipartimento di Chirurgia Generale Mininvasiva e Robotica “La Madonnina” Bari<br />
V15 - L’utilizzo del sistema di coagulazione Gyrus in corso di prostatectomia radicale<br />
laparoscopica. (video)<br />
R. Tarabuzzi, F. Varvello, S. Zaramella, G. Marchioro, G. Maso, S. Ranzoni, C. Terrone<br />
Ospedale Maggiore della Carità, Novara<br />
V16 - Riparazione laparoscopica extraperitoneale di ernia inguinale.<br />
A. Celia, G. Breda, G. Zeccolini<br />
Struttura Complessa di Urologia - Ospedale San Bassiano, Bassano del Grappa (VI)<br />
Ore 9:00-12:30 AUDITORIUM<br />
Ore 9:00-12:30 CHIRURGIA IN DIRETTA Novità nel trattamento endoscopico della patologia delle alte<br />
e basse vie urinarie<br />
(Programma indicativo – i programmi potranno subire delle variazioni, in base all’andamento degli interventi)<br />
Archivio Italiano di Urologia e Andrologia 2007; 79, 3, Supplemento 1<br />
VII
VIII<br />
Provokers E. Usai, G. Morgia, F. Cauda, G. Fasolis, J.D. Valdivia<br />
Sala A HOLEP. I. Vavassori<br />
KTP. D. Melloni<br />
TULEP. S. Mattioli<br />
Sala B TURP Bipolare Karl Storz.<br />
TURB Bipolare Wolf.<br />
TURB Bipolare Olympus.<br />
TURP Bipolare Bowa.<br />
Sala C PCNL prona. E. Montanari<br />
Uteroscopia semirigida. L. Defidio<br />
Uteroscopia flessibile. A. De Lisa<br />
Sala D ECIRS in posizione supina. G. Ibarluçea, C. Scoffone<br />
ECIRS in posizione supina. C. Scoffone, R.M. Scarpa<br />
LETTURA Breve 15’: R.M. Scarpa lettura GSK<br />
(da tenersi in relazione all’andamento della Sala Operatoria):<br />
“Novità nella terapia medica dell’Iperplasia Prostatica Benigna”.<br />
LETTURA Breve 15’: R. Colombo lettura GE Healthcare<br />
(da tenersi in relazione all’andamento della sala operatoria)<br />
“L’uso dell’esaminolevulinato nella diagnostica e terapia dei tumori uroteliali della vescica”.<br />
Ore 12:30-13:30 TAVOLA ROTONDA Trattamento endoscopico della calcolosi: quali novità?<br />
Moderatori G. Valdivia, F. Rocco<br />
Ureterorenoscopia: rigida e flessibile. L. De Fidio<br />
Percutanea. G. Bianchi<br />
Percutanea in età infantile. A. Frattini<br />
ECIRS. R.M. Scarpa, C. Scoffone<br />
ESWL. A. Saita<br />
Ore 13:00-14:30 Aule blu, verde, viola, rossa, arancione, gialla<br />
CORSI IEA 1° CORSO di Laparoscopia di Base “I nodi in Laparoscopia” (Pelvic Trainer)<br />
Responsabile: C. Terrone, R. Tarabuzzi<br />
Introduzione e teoria del nodo in Laparoscopia. 10’ C. Terrone<br />
Teoria e tecnica degli strumenti. 10’ R. Tarabuzzi<br />
Esercitazione pratica. 40’<br />
Posti limitati secondo priorità d’iscrizione<br />
2° CORSO di Laparoscopia di Base<br />
“Principi anatomici e tecnica nella laparoscopia della loggia Renale”<br />
Responsabile: G.P. Bianchi<br />
Introduzione, via d’accesso della loggia renale. 15’ S. Micali<br />
Anatomia chirurgica della loggia renale. 15’ E. Montanari<br />
La nefrectomia semplice: principi di tecnica. 15’ G.P. Bianchi<br />
Domande e discussione. 15’<br />
3° CORSO di laparoscopia ricostruttiva: La pieloplastica laparoscopica<br />
Responsabile: G. Guazzoni<br />
Vie d’accesso: trans o retro? R. Tarabuzzi<br />
Tecniche di sutura in pieloplastica laparo. G. Guazzoni<br />
To stent or no to stent: how to stent? I. Morra<br />
Ore 14:30-19 AUDITORIUM<br />
Ore 14:30-16:00 Evoluzione del trattamento dell’adenoma prostatico: tecniche consolidate, novità e desaparecidos<br />
Moderatori: E. Usai, D. Prezioso<br />
Archivio Italiano di Urologia e Andrologia 2007; 79, 3, Supplemento 1
Quale TURP: mono o bipolare? C. Terrone<br />
HoLEP: perché dovremmo farla? I. Vavassori<br />
KTP: quale ruolo? A. Tubaro<br />
TUVAP: cosa ne è stato? A. Tizzani<br />
Adenomectomia laparoscopica: ha un futuro? F. Porpiglia<br />
L’adenomectomia chirurgica: un ruolo da ridefinire? D. Fontana<br />
Quale sarà lo standard? W. Artibani<br />
Ore 15:30-16:30 Golden communications<br />
Moderatori: D. Randone – C. Aragona<br />
<strong>7°</strong> <strong>Congresso</strong> <strong>Nazionale</strong> Associazione Italiana di Endourologia<br />
Ore 15:30 C1 - Confronto tra chirurgia retrograda intrarenale (RIRS) e litotrissia percutanea (PCNL)<br />
nel trattamento di calcoli renali di dimensioni comprese fra 1 e 2 cm.<br />
G. Giusti, A. Piccinelli, G. Taverna, A. Benetti, O. Maugeri, L. Pasini, S. Zandegiacomo de Zorzi,<br />
M. Corinti, P. Graziotti.<br />
U.O. di Urologia, Istituto Clinico Humanitas, IRCCS, Rozzano (Milano)<br />
C2 - Ureteroscopia semirigida e flessibile per calcolosi reno-ureterale: nostra esperienza.<br />
C.M. Scoffone, M. Poggio, C.M. Cracco, M. Cossu, S. Grande, M. Billia, F. Porpiglia, R.M. Scarpa<br />
Clinica Urologica, Università di Torino, Ospedale San Luigi di Orbassano (Torino)<br />
C3 - Valutazione di un nuovo polimero per prevenire la migrazione retrograda dei calcoli durante<br />
la litotrissia endoscopica con laser.<br />
G. Mirabile1 , C.K. Phillips2 , G.W. Hruby2 , A. Campagna1 , P. Bove1 , J. Landman2 1Cattedra di Urologia; Università di Tor Vergata; Roma<br />
2 Columbia Presbyterian Medical Center, New York, NY, U.S.A.<br />
C4 - Holmium Laser Enucleation of Prostate (HoLEP).<br />
F. Blefari, P. A. Petroni, C. Radicchia, I. Vavassori*<br />
U.O. Urologia ASL TR4 – Sede di Orvieto<br />
* Humanitas - Cliniche Gavazzeni – Bergamo<br />
C5 - Comparazione dell’accuratezza istologica tra biopsia pre e post criablazione renale:<br />
esperienza su modello animale e iniziale esperienza clinica.<br />
G. Mirabile1 , E.H. Lambert2 , G.W. Hruby2 , P. Bove1 , C.K. Phillips2 , A. Campagna1 , G. Vespasiani1 ,<br />
J. Landman2 1Cattedra di Urologia; Università di Tor Vergata; Roma<br />
2 Columbia Presbyterian Medical Center, New York, NY, U.S.A.<br />
Ore 16:30-17:00 LETTURA Laparoscopia ricostruttiva: a che punto siamo? V. Pansadoro<br />
Ore 17:00-18:00 DIBATTITO Tumore renale di piccole dimensioni: quali opzioni?<br />
Moderatori: P. Rigatti, S. Rocca Rossetti<br />
La biopsia delle masse renali: pro o contro. A. Volpe, G. Martorana 15’<br />
Chirugia nephron sparing: laparoscopica o chirurgica? F. Porpiglia, M. Carini 15’<br />
Terapia con sonda Crio o radiofrequenza? G. Guazzoni, A. Veltri 15’<br />
Ore 18:00-18:30 LETTURA Novità nella terapia medica dell’RCC.<br />
L. Dogliotti<br />
Ore 18:30-19:00 Highlights della giornata. S. Micali, P. Usai<br />
Ore 19:00 SEDUTA AMMINISTRATIVA<br />
CENA SOCIALE<br />
I ticket dovranno essere ritirati presso la Segreteria Congressuale.<br />
Archivio Italiano di Urologia e Andrologia 2007; 79, 3, Supplemento 1<br />
IX
X<br />
18 settembre 2007 - A.S.O.S. Luigi di Orbassano<br />
Corso Infermieri in collaborazione con A.I.UR.O.<br />
Ruolo degli infermieri nelle procedure laparoscopiche ed endoscopiche:<br />
organizzazione, gestione e assistenza.<br />
Ore 12:30 Registrazione partecipanti<br />
Ore 13:00 Saluto del Presidente I.E.A., Presidente IPASVI di Torino, Direttore del Servizio Infermieristico.<br />
Ore 13:30 Introduzione al Corso dei Moderatori della giornata:<br />
I SESSIONE<br />
D.D.S.I Corso di laurea in infermieristica S. Luigi Sara Campagna<br />
CP.S.E Sala Operatoria H. Cottolengo Debora Coda Zabetta<br />
Ore 14:00 L’infermiere in sala operatoria: Ruolo e responsabilità nella Laparoscopia.<br />
C.P.S.I S. Luigi B.O. Cristina Volterrani<br />
Ore 14:20 Laparoscopia urologica: job description della strumentista per migliorare la qualità dell'assistenza.<br />
C.P.S.I. Paola Striglia/Marta Arnau Canton B.O. S. Raffaele, Milano<br />
Ore 14:50 Perché la job description specifica dell'infermiere di urologia? Definizione del ruolo.<br />
0re 15:10 Discussione<br />
Ore 15:30 Coffee break<br />
II SESSIONE<br />
C.P.S.I. Simona Merli/Giulia Villa S. Raffaele di Milano<br />
Ore 16:00 L’infermiere in sala operatoria: ruolo e responsabilità nelle procedure endoscopiche.<br />
C.P.S.I. B.O. S. Luigi Cristian De Melas<br />
Ore 16:30 Il percorso diagnostico assistenziale del paziente da sottoporre a procedure endoscopiche:<br />
l’esperienza del S. Paolo<br />
C.P.S.I. S. Paolo Milano<br />
Ore16:50 Il percorso diagnostico assistenziale del paziente da sottoporre a procedure endoscopiche:<br />
l’esperienza del S. Luigi<br />
C.P.S.E. S. Maggi<br />
0re 17:10 Il percorso formativo dell’infermiere che lavora in Urologia: attualità e prospettive future.<br />
Ore 17:30 Discussione<br />
D.D.S.I Polo Universitario S. Luigi Patrizia Sampietro<br />
Ore 18:00 Conclusioni del presidente A.I.UR.O. Cinzia Sanseverino<br />
Ore 18:30 Termine lavori<br />
Archivio Italiano di Urologia e Andrologia 2007; 79, 3, Supplemento 1
19 settembre 2007<br />
Ore 8:00-9:00 Aule blu, verde, arancione, gialla, viola, rossa.<br />
Aula Blu Miscellanea 2<br />
Moderatori: M. Bellina, P. Germani<br />
<strong>7°</strong> <strong>Congresso</strong> <strong>Nazionale</strong> Associazione Italiana di Endourologia<br />
Ore 8:00 C22 - TURP GYRUS con intento radicale come modalità di trattamento del carcinoma prostatico<br />
dal mito alla realtà.<br />
Aula Verde Laparoscopia<br />
M. Tura, O. Fenice, M. Parravicini, P. Baroni<br />
U.O. Urologia, Policlinico di Monza<br />
C23 - I buchi neri in endourologia.<br />
L. Defidio, M. De Dominicis<br />
U.O.C. di Urologia, Ospedale Cristo Re, Roma<br />
C24 - Effetti del contenuto intraluminale sulla capacità coagulativa dei vasi ottenuta con l’utilizzo<br />
dell’Harmonic ACE®e del Ligasure V®.<br />
G. Mirabile1 , C.K. Phillips2 , G.W. Hruby2 , P. Bove1 , A. Campagna1 , D.S. Lehman2 , P. Wei Hong2 ,<br />
J. Landman2 1Cattedra di Urologia; Università di Tor Vergata; Roma<br />
2Columbia Presbyterian Medical Center, New York, NY, U.S.A<br />
C24 1 - Ruolo del phillantus niruri (Uriston) come terapia audiuvante alla litotrissia extracorporea<br />
per i calcoli renali.<br />
S. Micali, M. Grande, M.C. Sighinolfi, S. De Stefani, C. De Carne, F. Fidanza, G. Bianchi<br />
Cattedra di Urologia, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia<br />
C24 2 - Dornier Lithotripter S: la prima casistica con oltre 1000 trattamenti<br />
S. Micali, M. Grande, M.C. Sighinolfi, C. De Carne, F. Fidanza, S De Stefani, G. Bianchi<br />
Dipartimento di Urologia, Università di Modena e Reggio Emilia<br />
C24 3 - L’utilizzo dello stent metallico “Resonance TM ” nella patologia ostruttiva dell’uretere.<br />
D. Piccolotti, C. Aliberti*, S. Papa, F. Carparelli, E. Vece, G.R. Russo<br />
AUSL di Ferrara, U.O. di Urologia<br />
* AUSL di Ferrara, U.O. di Diagnostica per Immagini<br />
Moderatori: G. Fasolis, F. Cauda<br />
Ore 8:00 C25 - La crioterapia laparoscopica per il trattamento delle neoformazioni renali:<br />
esperienza preliminare.<br />
P. Bovea , G. Mirabilea , E. Finazzi Agròa , A. Campagnaa , R. Mianoa , F. Kimb , G. Vespasiania aCattedra di Urologia, Università di Roma “Tor Vergata”; Roma<br />
bDepartment Of Urology, Denver Health Hospital; University of Colorado - USA<br />
C26 - Effetto della pressione di argon sulle dimensioni e il grado di formazione della ice ball<br />
nelle procedure di crioablazione.<br />
G. Mirabile1 , P.C. Sprenkle2 , P. Bove1 , A. Campagna1 , A. Edelstein2 , P. Wai Hong2 , G.W. Hruby2 ,<br />
G. Vespasiani1 , J. Landman2 1Cattedra di Urologia; Università di Tor Vergata; Roma<br />
2Columbia Presbyterian Medical Center, New York, NY, U.S.A.<br />
C27 - EAU Guidelines 2002: “Laparoscopic hernia repair” procedura ad alto livello<br />
di raccomandazione (a).<br />
A. Celia, G. Breda, G. Zeccolini<br />
Struttura Complessa di Urologia - Ospedale San Bassiano, Bassano del Grappa (VI)<br />
C28 - Due modelli per la laparoscopia urologica: i nostri risultati dopo tre anni di attività.<br />
P. Bove, A. Campagna, E. Finazzi Agrò, R. Miano, G. Virgili, G. Vespasiani<br />
Cattedra di Urologia; Università di Roma “Tor Vergata” - Roma<br />
Archivio Italiano di Urologia e Andrologia 2007; 79, 3, Supplemento 1<br />
XI
XII<br />
Aula Rossa Video Calcolosi<br />
C29 - Studio prospettico sulla ureterolitotomia laparoscopica:<br />
approccio trans e retroperitoneale a confronto.<br />
P. Bovea , S. Micalib , G. Mirabilea , R. Mianoa , A. Campagnaa , E. Botteric, G. Bianchib , G. Vespasiania aCattedra di Urologia, Università di Roma “Tor Vergata”; Roma<br />
bCattedra di Urologia, Università di Modena e Reggio Emilia; Modena<br />
C30 - Nefrectomia parziale laparoscopica: nostra esperienza iniziale.<br />
L. Cosentino, P. Cozzupoli, O. Sicuro, G. Malara, L. Carbone, E. Sgro, D. Veneziano<br />
UOC di Urologia e Trapianti di Rene - Ospedale “B-M-M” Reggio Calabria<br />
C31 - Nefrectomia laparoscopica: efficacia e sicurezza di una tecnica min-invasiva.<br />
G. Porcu, G. Puggioni, P. Usai, A. De Lisa<br />
Università degli studi di Cagliari - Clinica Urologica - Ospedale SS Trinità – Cagliari<br />
Moderatori: L. Defidio, U. Ferrando<br />
Ore 8:00 V17 - Trattamento combinato di calcolosi renale complessa con accesso percutaneo<br />
in decubito supino, in paziente obeso.<br />
S. Guercio, A. Ambu, F. Mangione, M. Mari, F. Vacca, M. Bellina<br />
U.O.C. Urologia, P.O. di Rivoli (TO)<br />
V19 - Trattamento mediante approccio endoscopico combinato antero-retrogrado in posizione<br />
supina in paziente con neovescica affetto da calcolosi ureterale.<br />
C.M. Scoffone, M. Poggio, C. Cracco, R.M. Scarpa<br />
Clinica Urologica, Università di Torino, Ospedale San Luigi di Orbassano (Torino)<br />
V20 - Percutanea “Endovision”: quando l’accesso è davvero corretto.<br />
A. Frattini, S. Ferretti, P. Salsi, F. Dinale, M. Ciuffreda, P. Cortellini<br />
U.O. Urologia - Azienda Ospedaliero- Universitaria di Parma, Italy<br />
V21 - Approccio endoscopico combinato antero-retrogrado in posizione supina nella diagnostic<br />
di macroematuria in paziente con bricker.<br />
C.M. Scoffone, M. Poggio, C. Cracco, R.M. Scarpa<br />
Clinica Urologica, Università di Torino, Ospedale San Luigi di Orbassano (Torino)<br />
V22 - Nefrolitotrissia percutanea con plurimi accessi ecoguidati per calcolosi a stampo complessa.<br />
S. Micali, C. Di Pietro, S. De Stefani, F. Annino, C. De Carne, G. Bianchi<br />
Dipartimento di Urologia, Università di Modena e Reggio Emilia<br />
Aula Arancione Video Incontinenza - Laparoscopia<br />
Moderatori: G. Marino, R. Cevoli<br />
Ore 8:00 V23 - Impianto simultaneo di protesi peniena e sling bulbo-uretrale INVANCE attraverso<br />
un unico accesso peno-scrotale.<br />
I. Morra, F. Ragni, L. Rolle, A. Tamagnone, D. Fontana, R.M. Scarpa<br />
Divisione Universitaria di Urologia, Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche,<br />
Università di Torino, Azienda Ospedaliera S. Luigi, Orbassano<br />
V24 - Accesso peno-scrotale per il trattamento del deficit sfinteriale maschile<br />
mediante sling bulbo-uretrale INVANCE.<br />
I. Morra, F. Ragni, M. Poggio, C. Cracco, D. Vaccino, S. Grande, R.M.Scarpa<br />
Divisione Universitaria di Urologia, Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche,<br />
Università di Torino, Azienda Ospedaliera S. Luigi, Orbassano<br />
V25 - Correzione di prolasso vaginale totale recidivo per via vaginale mediante utilizzo<br />
dei dispositivi perigee e apogee.<br />
I. Morra, F. Ragni, M. Poggio, C. Cracco, D. Vaccino, S. Grande, R.M. Scarpa<br />
Divisione Universitaria di Urologia, Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche,<br />
Università di Torino, Azienda Ospedaliera S. Luigi, Orbassano<br />
Archivio Italiano di Urologia e Andrologia 2007; 79, 3, Supplemento 1
Ore 9:00-13:30 AUDITORIUM<br />
<strong>7°</strong> <strong>Congresso</strong> <strong>Nazionale</strong> Associazione Italiana di Endourologia<br />
V26 - Nuovo approccio chirurgico mini-invasivo nel trattamento del rettocele (Apogee System).<br />
S. Fornia, A. Salvaggio, M. Ciuffreda, F. Dinale, M. Simonazzi<br />
Unità Operativa di Urologia, Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma, Italy<br />
V27 - Esplorazione laparoscopica di una neoformazione retroperitoneale sospetta<br />
per recidiva di carcinoma a cellule renali.<br />
A. Campagna, P. Bove, E. Finazzi Agrò, A. Asimakopoulos, R. Miano, G. Vespasiani<br />
Cattedra di Urologia, Università di Roma “Tor Vergata”, Roma<br />
V28 - Nefroureterectomia laparoscopica destra con litotrissia di calcolosi ø 2 cm dell’uretere<br />
intramurale in doppio distretto completo. (video)<br />
R. Tarabuzzi, F. Varvello, G. Marchioro, G. Maso, S. Ranzoni, F. Sogni, C. Terrone<br />
Ospedale Maggiore della Carità, Novara<br />
Ore 9:00-12:30 CHIRUGIA IN DIRETTA Trattamento dell’incontinenza e PDD dei tumori vescicali.<br />
(Programma indicativo - I programmi potranno subire delle variazioni, in base all’andamento degli interventi)<br />
Provokers M. Bellina, G. Vespasiani, A. Tizzani, R. Carone<br />
Sala A Colposacropessia laparoscopica. T. Piechaud<br />
Plastica vaginale anteriore/posteriore. C. Vicentini<br />
Sala B Sfintere artificiale. R. Olianas, I. Morra<br />
TVT - TOT. I. Morra<br />
Sala C TURB con PDD (Olympus). R. Colombo<br />
TURB con PDD (Wolf).<br />
TURB con PDD (K. Storz).<br />
Ore 12:00-13:00 TAVOLA ROTONDA Novità nel trattamento dell’incontinenza urinaria.<br />
- Moderatori: A. Tizzani, G. Vespasiani<br />
Ruolo della laparoscopia. T. Piechaud<br />
TVT o TOT? I. Morra, E. Kocjancic<br />
L’incontinenza urinaria dopo la prostatectomia radicale:<br />
quale è la strategia chirurgica migliore? R. Olianas<br />
Ore 13:00-13:30 LETTURA Stato dell’arte dell’endourologia in Tunisia.<br />
Ore 13:30-14:30 Lunch<br />
Ben Rais Nawfel, Presidente Società Tunisina di Urologia<br />
Ore 14:30-16:00 HOT SPOTS: Le controversie del <strong>Congresso</strong><br />
L. Defidio, C. Terrone, D. Prezioso<br />
Ore 16:15 Chiusura dei lavori da parte del Presidente Prof. R.M. Scarpa<br />
Archivio Italiano di Urologia e Andrologia 2007; 79, 3, Supplemento 1<br />
XIII
<strong>7°</strong> <strong>Congresso</strong> <strong>Nazionale</strong><br />
Associazione Italiana di Endourologia<br />
16-19 Settembre 2007 - Orbassano (TO)<br />
L’Associazione Italiana di Endourologia ringrazia le seguenti Aziende che hanno contribuito<br />
in modo significativo alla realizzazione del <strong>7°</strong> <strong>Congresso</strong> <strong>Nazionale</strong> I.E.A<br />
GOLDEN SPONSOR<br />
AB MEDICA<br />
BOSTON SCIENTIFIC<br />
COOK MEDICAL<br />
COLOPLAST/PORGÈS<br />
GALIL MEDICAL<br />
GE HEALTHCARE<br />
KARL STORZ ENDOSCOPIA<br />
MOVI<br />
OLYMPUS<br />
SANOFI AVENTIS<br />
SILVER SPONSOR<br />
BAYER<br />
DIMED<br />
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL<br />
GLAXO SMITHKLINE<br />
IPSEN<br />
PHILIPS<br />
POLIMED<br />
ROCCHETTA<br />
SIGMA TAU<br />
TEGEA<br />
TELEFLEX<br />
OTHERS SPONSOR<br />
ASTELLAS PHARMA<br />
ASTRAZENECA<br />
BIOHEALTH<br />
CAO<br />
EMS<br />
KYOWA<br />
IDI PHARMA<br />
ITALFARMACO<br />
MON MEDICAL<br />
NYCOMED
ABSTRACTS<br />
Golden Communications<br />
18 Settembre 2007 15.30 – 16.30<br />
C1<br />
CONFRONTO TRA CHIRURGIA RETROGRA-<br />
DA INTRARENALE (RIRS) E LITOTRISSIA<br />
PERCUTANEA (PCNL) NEL TRATTAMENTO<br />
DI CALCOLI RENALI DI DIMENSIONI COM-<br />
PRESE FRA 1 E 2 cm<br />
G. Giusti, A. Piccinelli, G. Taverna, A. Benetti,<br />
O. Maugeri, L. Pasini, S. Zandegiacomo de<br />
Zorzi, M. Corinti, P. Graziotti<br />
U.O. di Urologia, Istituto Clinico Humanitas, IRCCS,<br />
Rozzano (Milano)<br />
Introduzione: Scopo di questo studio prospettico<br />
è confrontare i risultati della RIRS con quelli<br />
della PCNL allo scopo di capire quale di queste<br />
due metodiche è più vantaggiosa per<br />
pazienti affetti da calcolosi renale di diametro<br />
compreso fra 1 e 2,5 cm che richieda un trattamento<br />
attivo.<br />
Tabella 1.<br />
RIRS PNL<br />
Numero di pazienti 20 20<br />
Età media (years) 48 (29-70) 48.5 (23-77)<br />
BMI 27 25.1<br />
Stone burden (cm 2 ) 2.9 3.2<br />
<strong>7°</strong> <strong>Congresso</strong> <strong>Nazionale</strong><br />
Associazione Italiana di Endourologia<br />
16-19 Settembre 2007 - Orbassano (TO)<br />
Materiali e Metodi: A partire da giugno 2005,<br />
40 pazienti affetti da calcolosi renale di diametro<br />
compreso tra 1 e 2.5 cm sono stati randomizzati<br />
allo scopo di essere trattati con RIRS o<br />
PCNL.<br />
La RIRS viene eseguita con strumenti semirigidi<br />
e/o flessibili con l’utilizzo di laser ad olmio<br />
per la litotrissia; in 5 casi sono state utilizzate<br />
camicie operative. La PCNL è stata eseguita<br />
attraverso una camicia standard da 30F posizionata<br />
con l’ausilio del pallone da dilatazione.<br />
In 15 casi su 20 è stato possibile eseguire una<br />
procedura tubeless.<br />
Le caratteristiche dei pazienti sono riportate in<br />
Tabella 1.<br />
Risultati: I risultati sono riportati nella Tabella 2.<br />
Conclusioni: Il nostro studio dimostra che la<br />
RIRS offre una significativa riduzione di invasità<br />
nei confronti della PCNL (riduzione statisticamente<br />
significativa di perdite ematiche, di<br />
numero di pazienti trasfusi e tempo di recupero<br />
completo). Per contro, non sono state<br />
riscontrate differenze significative in termini di<br />
tempo operatorio, dolore postoperatorio e<br />
tempi di ospedalizzazione. Va peraltro sottolineata<br />
la percentuale di stone free sensibilmente<br />
ridotta dopo un intervento (70vs95%).<br />
Pertanto è nostra opinione che al momento la<br />
litotrissia percutanea rimane il gold standard in<br />
questi casi, ma comunque proporre la RIRS<br />
sembra una alternativa ragionevole. Va da sé<br />
che nel proporla ai pazienti che al giorno d’oggi<br />
sono sempre più motivati verso le procedu-<br />
Archivio Italiano di Urologia e Andrologia 2007, 79, 3, Supplemento 1 1
2<br />
<strong>7°</strong> <strong>Congresso</strong> <strong>Nazionale</strong> Associazione Italiana di Endourologia<br />
re miniinvasive, questi devono essere dettagliatamente<br />
informati sulla necessità di reintervento<br />
in una percentuale non trascurabile di casi per<br />
ottenere uno stone free rate analogo alla PCNL.<br />
C2<br />
URETEROSCOPIA SEMIRIGIDA E FLESSIBILE<br />
PER CALCOLOSI RENO-URETERALE: NOSTRA<br />
ESPERIENZA<br />
C.M. Scoffone, M. Poggio, C.M. Cracco, M. Cossu,<br />
S. Grande, M.Billia, F. Porpiglia, R.M. Scarpa<br />
Clinica Urologica, Università di Torino, Ospedale San<br />
Luigi di Orbassano (Torino)<br />
Introduzione: Negli ultimi vent’anni, grazie al<br />
progressivo miglioramento delle tecniche e dello<br />
strumentario endoscopico, l’ureteroscopia ha<br />
quasi completamente sostituito la chirurgia per<br />
il trattamento della calcolosi reno-ureterale. In<br />
questo lavoro abbiamo valutato retrospettivamente<br />
la nostra casistica inerente il trattamento<br />
della calcolosi mediante ureteroscopia.<br />
Materiali e Metodi: Da gennaio 2001 a dicembre<br />
del 2006 sono state eseguite 548 ureteroscopie<br />
per calcolosi reno-ureterale. L’età media dei<br />
pazienti era 50,2 ± 15,36 (range 15-86). Lo strumentario<br />
utilizzato comprendeva ureteroscopi<br />
flessibili e semirigidi, materiali monouso (fili<br />
Archivio Italiano di Urologia e Andrologia 2007, 79, 3, Supplemento 1<br />
Tabella 2.<br />
RIRS vs PNL<br />
Tempo operatorio 108.1 vs 95.9 p=0.112<br />
Hematocrit drop (%) 1.4 vs 5.5 p
in due casi è stata effettuata una litotrissia combinata<br />
(0,5%). Globalmente, nell’87% dei casi è<br />
stato applicato il JJ al termine della procedura. In<br />
450/548 casi (82%) la procedura è stata efficace<br />
con la rimozione del calcolo dopo l’intervento,<br />
mentre in 98 casi la prima procedura non è<br />
risultata risolutiva (push up, malformazioni,<br />
scarsa compliance ureterale, sanguinamento). Le<br />
complicanze maggiore sono state inferiori<br />
all’1%. I giorni di degenza post-operatori medi<br />
erano 2,8 die.<br />
Conclusioni: In base ai risultati della nostra casistica<br />
l’ureteroscopia semirigida e flessibile con<br />
l’utilizzo del laser ad olmio permette di raggiungere,<br />
già dopo un’unica procedura, percentuali<br />
molto elevate di stone free rate in pazienti con<br />
calcolosi reno-ureterale.<br />
C3<br />
VALUTAZIONE DI UN NUOVO POLIMERO PER<br />
PREVENIRE LA MIGRAZIONE RETROGRADA<br />
DEI CALCOLI DURANTE LA LITOTRISSIA<br />
ENDOSCOPICA CON LASER<br />
G. Mirabile 1 , C. K. Phillips 2 , G. W. Hruby 2 ,<br />
A. Campagna 1 , P. Bove 1 and J. Landman 2<br />
1 Cattedra di Urologia; Università di Tor Vergata,<br />
Roma; 2 Columbia Presbyterian Medical Center, New<br />
York, NY, U.S.A.<br />
Obiettivi: Abbiamo valutato la sicurezza e l’efficacia<br />
di un nuovo polimero termo-sensibile (Fossa<br />
Medical, Boston MA) creato per prevenire la<br />
migrazione dei calcoli durante le procedure<br />
endoscopiche.<br />
Materiali e Metodi: Unità urinarie porcine sono<br />
state immerse in soluzione salina a 3<strong>7°</strong> C. Sono<br />
state registrate la quantità di polimero, il tempo<br />
necessario per il raggiungimento dello stato solido,<br />
la lunghezza dell’uretere occupata dal polimero<br />
e la pressione necessaria per ottenere la sua<br />
dislocazione. Inoltre è stato registrato il tempo<br />
necessario alla completa dissoluzione del polimero<br />
con acqua fredda ed è stato esaminato l’assetto<br />
istopatologico della mucosa uretrale.<br />
Risultati: Il polimero è risultato essere radiopaco<br />
e facilmente visualizzabile con la fluoroscopia.<br />
Ad una temperatura media di 36,<strong>7°</strong>C (± 0.3 o),<br />
0.5 e 1 cc di polimero sono stati sufficienti per<br />
ottenere la completa occlusione del lume ureterale.<br />
Il tempo medio di solidificazione è stato di<br />
30 secondi (range 15-45). La lunghezza media di<br />
occlusione degli ureteri è stata rispettivamente di<br />
47mm (45-60) e 65.5mm (55-80), rispettivamente.<br />
La pressione media necessaria per ottene-<br />
<strong>7°</strong> <strong>Congresso</strong> <strong>Nazionale</strong> Associazione Italiana di Endourologia<br />
re la dislocazione del polimero è stata rispettivamente<br />
162.8 mmHg (92.5-251) e 155.5 mmHg<br />
(90.3-227.5). Dopo l’utilizzo non è stata dimostrata<br />
alcuna alterazione istologica della mucosa<br />
uretrale.<br />
Conclusioni: I nostri risultati indicano che questo<br />
polimero è sicuro e in grado di occludere temporaneamente<br />
il lume ureterale. È radiopaco,<br />
quindi visibile alla fluoroscopia e facilmente<br />
rimovibile dall’uretere. Ulteriori studi sono in<br />
corso per dimostrarne l’utilità clinica.<br />
VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DI UN NUOVO<br />
SISTEMA DI PROTEZIONE DELL’URETERO-<br />
SCOPIO DIGITALE CONTRO I DANNI DA ENER-<br />
GIA LASER<br />
G. Mirabile 1 , C. Sung 2 , H. Singh 2 , A. Campagna 1 ,<br />
P. Bove 1 , G.W. Hruby 2 , C.D. Ryan 2 , G. Vespasiani 1<br />
e J. Landman 2<br />
1 Cattedra di Urologia; Università di Tor Vergata,<br />
Roma; 2 Columbia Presbyterian Medical Center, New<br />
York, NY, U.S.A.<br />
Obiettivi: Valutare l’affidabilità e l’efficacia di un<br />
nuovo sistema di protezione dell’ureteroscopio<br />
(UPS) nei confronti dei danni direttamente causati<br />
dalle fibre laser.<br />
Materiali e Metodi: Abbiamo eseguito valutazioni<br />
in vitro di un nuovo prototipo UPS (Gyrus-<br />
ACMI, Southborough, MA), che utilizza un<br />
segnale di ritorno ottico dal sensore digitale dell’ureteroscopio<br />
DUR-D (Gyrus-ACMI,<br />
Southborough, MA) per interrompere l’energia<br />
laser prima dell’entrata della fibra all’interno<br />
dell’ureteroscopio. Abbiamo valutato varie velocità<br />
di retrazione (0.5, 2.0, e 5.0 cm/sec) in fisiologica<br />
(NS) e a varie concentrazioni di indigo<br />
carmine e sangue umano. Abbiamo anche valutato<br />
la distanza di protrusione alla quale avviene<br />
lo spegnimento ponendo il rivestimento a 0, 3,<br />
e 5-mm dalla fine della fibra. Sono stati eseguiti<br />
un totale 20 esperimenti.<br />
Risultati: In soluzione fisiologica e sangue diluito<br />
fino a 10 g/L, l’UPS ha funzionato con un efficacia<br />
del 100% in tutti gli esperimenti. Per diluizioni<br />
di sangue ≥10g/L e concentrazioni di indigo<br />
carmine ≥0.16g/L l’affidabilità dell’UPS è<br />
risultata inficiata. Per le fibre laser il cui rivestimento<br />
iniziava a 0, 3 e 5 mm lo spegnimento<br />
iniziava a 2.9±0.13, 5.1 ± 0.09, e 8.2 ± 0.15 mm<br />
dalla porzione terminale dell’ureteroscopio<br />
rispettivamente (p
4<br />
<strong>7°</strong> <strong>Congresso</strong> <strong>Nazionale</strong> Associazione Italiana di Endourologia<br />
nonostante le 120 retrazioni della fibra laser<br />
attivata nel canale operativo.<br />
Conclusioni: In questa valutazione, il nuovo<br />
sistema UPS è risultato altamente efficacie e<br />
affidabile. L’efficacia è stata compromessa dall’utilizzo<br />
in alte concentrazioni di indigo carmine<br />
e sangue umano. L’UPS dovrebbe essere<br />
utilizzato a complemento degli attuali tecniche<br />
di protezione dell’ureteroscopio piuttosto che<br />
in sostituzione.<br />
C4<br />
HOLMIUM LASER ENUCLEATION OF PROS-<br />
TATE (HOLEP)<br />
F. Blefari, P. Antonio Petroni, C. Radicchia,<br />
I. Vavassori 1<br />
U.O. Urologia ASL TR4, Orvieto; 1 Humanitas, Cliniche<br />
Gavazzeni, Bergamo<br />
Scopo del lavoro: Valutare sicurezza ed efficacia<br />
dell’enucleazione dell’adenoma prostatico<br />
mediante Laser ad Holmium secondo la tecnica<br />
descritta da P. Gilling.<br />
Materiali e Metodi: Da maggio 2006 a maggio<br />
2007 nel nostro centro sono stati trattati con<br />
enucleazione laser dell’adenoma prostatico e<br />
successiva morcellazione (HoLEP) (Versa Pulse.<br />
Lumenis 100W ® ) 41 Pazienti affetti da IPB.<br />
Tutti sono stati valutati preoperatoriamente ed a<br />
due mesi dall’intervento mediante punteggio<br />
sintomatologico (IPSS) ed uroflussometria con<br />
valutazione del residuo post-minzionale. In<br />
tutti è stata eseguita una ecografia prostatica<br />
trans rettale prima dell’intervento per la determinazione<br />
del volume dell’adenoma.<br />
Sono state inoltre valutati tempi operatori,<br />
degenza postoperatoria e le complicanze precoci<br />
e tardive.<br />
Risultati: I primi quattro Pazienti sono stati trattati<br />
da e sotto la guida di un tutor esperto.<br />
Sei Pazienti presentavano all’intervento litiasi<br />
vescicale associata. Il tempo medio operatorio è<br />
stato di 76,7 minuti, il volume medio dell’adenoma<br />
valutato preoperatoriamente era 49 cc<br />
mentre il peso medio del tessuto secco resecato<br />
è stato di 28,5 gr alla valutazione del patologo.<br />
La rimozione del catetere è avvenuta in prima o<br />
seconda giornata mentre il tempo medio di<br />
degenza post-operatoria è stato di 3,1 gg.<br />
Nessun paziente ha richiesto emotrasfusione. In<br />
un paziente si è osservata una lesione della capsula<br />
prostatica che ha richiesto un cateterismo<br />
di 4 gg ed in due è stato necessario riposizionare<br />
il catetere vescicale per ritenzione acuta post-<br />
Archivio Italiano di Urologia e Andrologia 2007, 79, 3, Supplemento 1<br />
operatoria. In un caso si è rilevata una lesione<br />
superficiale della mucosa vescicale da morcellatore<br />
che non ha richiesto alcun accorgimento.<br />
Nessuna differenza significativa è stata rilevata<br />
per i Pazienti con calcolosi vescicale associata.<br />
In 28 Pazienti si sono osservati sintomi<br />
irritativi che in due casi sono durati oltre un<br />
mese dall’intervento e trattati con blandi<br />
FANS.<br />
A due mesi dall’intervento in tutti si è osservato<br />
un netto miglioramento dei parametri di<br />
flusso nonché del punteggio sintomatologico.<br />
Discussione: La nostra casistica riflette un’esperienza<br />
iniziata recentemente dimostrando<br />
come la tecnica possa essere facilmente appresa<br />
ed eseguita anche in piccoli centri con risultati<br />
eccellenti. La durata della degenza media<br />
post-operatoria, più lunga di quanto riportato<br />
in letteratura, tiene conto dei Pazienti che sono<br />
incorsi in una ritenzione post-operatoria che<br />
ha allungato i tempi degenza, nonché di un<br />
nostro atteggiamento improntato alla prudenza<br />
essendo ancora la nostra esperienza iniziale. La<br />
riduzione dei costi legati alla degenza, il rapido<br />
ammortamento del costo di acquisto dell’apparecchiatura<br />
il basso costo del materiale di consumo<br />
rendono la metodica interessante anche<br />
sul piano economico.<br />
Bibliografia<br />
Gilling PJ, Aho TF, Frampton CM, King CJ, Fraundorfer MR.<br />
Holmium Laser Enucleation of the Prostate: Results at 6 Years. Eur<br />
Urol. 2007 Apr 23.<br />
Naspro R, Suardi N, Salonia A, Scattoni V, Guazzoni G, Colombo R,<br />
Cestari A, Briganti A, Mazzoccoli B, Rigatti P, Montorsi F. Holmium<br />
laser enucleation of the prostate versus open prostatectomy for<br />
prostates >70 g: 24-month follow-up. Eur Urol. 2006 Sep; 50<br />
(3):563-8.<br />
C5<br />
COMPARAZIONE DELL’ACCURATEZZA ISTO-<br />
LOGICA TRA BIOPSIA PRE E POST CRIABLA-<br />
ZIONE RENALE: ESPERIENZA SU MODELLO<br />
ANIMALE E INIZIALE ESPERIENZA CLINICA<br />
G. Mirabile1 , E.H. Lambert2 , G. Hruby2 , P. Bove1 ,<br />
C.K. Phillips2 , A. Campagna1 , G. Vespasiani1 ,<br />
J. Landman2 1Cattedra di Urologia, Università di Tor Vergata, Roma;<br />
2Columbia Presbyterian Medical Center, New York, NY,<br />
U.S.A.<br />
Obiettivi: Abbiamo esaminato la possibilità e la<br />
validità della biopsia renale prima e dopo il trattamento<br />
di crioablazione sul modello animale e<br />
nella pratica clinica.
Materiali e Metodi: con un doppio ciclo di congelamento<br />
sono state create 4 criolesioni bilateralmente<br />
in tessuto sano di rene porcino.<br />
Sono state eseguite, sotto visione diretta, biopsie<br />
con ago 16 G prima e dopo la crioablazione.<br />
Ogni campione bioptico è stato valutato<br />
per numero di glomeruli e arteriole. Successivamente,<br />
10 pazienti con piccole masse renali<br />
sono stati sottoposti a trattamento crioablativo<br />
laparoscopico utilizzando un doppio ciclo<br />
di congelamento e scongelamento. Un ago 18<br />
G è stato utilizzato per prelevare un singolo<br />
campione della lesione prima e dopo il trattamento.<br />
L’anatomopatologo ha valutato i campioni<br />
per valutare l’accuratezza istologica delle<br />
due tecniche di prelievo del tessuto tumorale.<br />
Risultati: Sono state ottenute 200 biopsie da<br />
tessuto renale porcino. Il numero medio di glomeruli<br />
per campione pre e post crioablazione è<br />
stato rispettivamente 9.6, e 7.8 (p=0.04). Il<br />
numero medio di arteriole per il gruppo pre e<br />
post crioablazione è stato rispettivamente 2.3<br />
and 1.9 (p=0.04). Durante l’applicazione clinica,<br />
6/10 biopsie pre-crioablazione, e 7/10 postcrioablazione<br />
risultavano diagnostiche<br />
(p=0.639). In tutti i 10 casi è stato possibile<br />
eseguire una diagnosi istopatologica: RCC convenzionale<br />
(7/10), variante papillare RCC<br />
(1/10), angiomiolipoma (1/10), and oncocitoma<br />
(1/10).<br />
Conclusioni: Il modello porcino ci ha permesso<br />
di stabilire la concreta possibilità di effettuare<br />
una diagnosi istologica dopo la crioablazione.<br />
La nostra iniziale esperienza clinica dimostra<br />
che la biopsia post crioterapia ha un accuratezza<br />
diagnostica simile a quella pre crioablazione.<br />
Il vantaggio della biopsia post-crioterapia è<br />
una teoretica riduzione del rischio di disseminazione<br />
tumorale e di emorragia.<br />
Golden video<br />
17 Settembre 2007 17.30 – 18.30<br />
V1<br />
NEFROLITOTRISSIA PERCUTANEA (PCNL)<br />
IN ETÀ PEDIATRICA: IL GOLD STANDARD<br />
A. Frattini, S. Ferretti, P. Salsi, F. Dinale,<br />
P. Granelli, P. Cortellini<br />
U.O. Urologia, Azienda Ospedaliera Universitaria<br />
di Parma<br />
VIDEO<br />
La PCNL in età pediatrica è una procedura<br />
infrequente perché la patologia litiasica nell'in-<br />
<strong>7°</strong> <strong>Congresso</strong> <strong>Nazionale</strong> Associazione Italiana di Endourologia<br />
fanzia è un evento raro. La risoluzione endourologica<br />
è però da considerarsi di prima scelta<br />
sia per la minor invasività sia per l'elevata frequenza<br />
di recidive e quindi di trattamenti ripetuti.<br />
In questo video illustriamo la tecnica percutanea<br />
ideale in termini di risultati e complicanze.<br />
Materiali e Metodi: La paziente di 11 anni è<br />
posta in decubito supino con l'arto inferiore<br />
controlaterale divaricato in modo tale da consentire<br />
l'introduzione dell'ureteroscopio flessibile.<br />
Il corretto accesso percutaneo transpapillare<br />
al calice prescelto, ecograficamente o<br />
radiologicamente, avviene sotto diretto controllo<br />
visivo transureterorenoscopico (procedura<br />
Endovision). La dilatazione del tramite è<br />
eseguita con set da mini-percutanea 14 Fr<br />
(MIPP set). La litotrissia si esegue con laser ad<br />
olmio (fibra 600 micron) in modo da consentire<br />
una fine frantumazione del calcolo, mentre<br />
il controllo ureteroscopico consente il continuo<br />
monitoraggio della clearance dei frammenti<br />
da ogni singolo calice. Al termine della<br />
procedura, in assenza di sanguinamento<br />
importante, si lascia a dimora soltanto un catetere<br />
ureterale a singolo pig-tail.<br />
Risultati: Nessun tipo di complicanza.<br />
Rimozione del monoJ dopo circa 36 ore.<br />
Discussione: Il mini accesso e quindi la minor<br />
invasività è certamente da preferirsi, quando<br />
possibile, in età pediatrica. Il controllo dell'accesso<br />
con tecnica Endovision consente la certezza<br />
di una corretta puntura transpapillare<br />
garantendo il presupposto più importante per<br />
la riduzione di complicanze emorragiche; tale<br />
metodo inoltre diminuisce l'esposizione radiologica<br />
in modo efficace. La possibilità dell'ureteroscopia<br />
contestuale consente il completo<br />
dominio della via escretrice aumentando la<br />
percentuale di stone-free. La PCNL tubeless è<br />
inoltre da preferirsi giacché molto spesso la<br />
nefrotomia percutanea è mal tollerata dai piccoli<br />
pazienti.<br />
Riteniamo, quindi, che la PCNL supina tubeless,<br />
con accesso Endovision, sia da considerarsi<br />
la terapia gold standard nelle calcolosi<br />
renali di grosse dimensioni in età pediatrica.<br />
V2<br />
E-TURP: EVOLUZIONE TECNICA DELLA<br />
TURP<br />
G. Breda, A. Celia, G. Zeccolini, S. El Dahshan<br />
Struttura Complessa di Urologia, Ospedale San<br />
Bassiano, Bassano del Grappa (Vicenza)<br />
Archivio Italiano di Urologia e Andrologia 2007, 79, 3, Supplemento 1 5
6<br />
<strong>7°</strong> <strong>Congresso</strong> <strong>Nazionale</strong> Associazione Italiana di Endourologia<br />
Introduzione: La TURP rappresenta il trattamento<br />
“Gold Standard” della iperplasia prostatica<br />
benigna (IPB).<br />
L’avvento del resettore bipolare ha permesso di<br />
migliorare la qualità della resezione e ne ha<br />
ridotto complicanze. Nonostante il miglioramento<br />
tecnologico, il trattamento di voluminosi<br />
adenomi prostatici è rimasto di appannaggio<br />
della chirurgia open (e recentemente laparoscopica).<br />
Il recente sviluppo ed impiego dei Laser<br />
potrebbe risultare una rivoluzione del trattamento<br />
endoscopico della IPB di qualsiasi volume.<br />
In particolare, la HoLEP consente un trattamento<br />
mini-invasivo ma radicale di adenomi<br />
anche di volumi molto elevati.<br />
In questo video presentiamo una evoluzione<br />
della tecnica TURP bipolare che mostra delle<br />
analogie con la tecnica HoLEP.<br />
Materiale e Metodi: Il video evidenzia i momenti<br />
salienti della tecnica proposta.<br />
Si parte con la tecnica di resezione endoscopica<br />
da noi preferita: la Nesbit. Dopo aver distaccato<br />
il lobo destro dell’adenoma alle ore 11, lo<br />
si enuclea per via retrograda, partendo dall’apice.<br />
Individuato il piano della capsula chirurgica,<br />
si utilizza l’azione meccanica del resettore<br />
per enucleare l’adenoma dalla capsula stessa,<br />
seguendo un piano praticamente avascolare<br />
(analogamente a quanto avviene nella HoLEP).<br />
L’ansa del resettore viene utilizzata solo per l’emostasi<br />
dei pochi rami vascolari penetranti<br />
dalla capsula all’adenoma.<br />
L’enucleazione dell’adenoma non deve essere<br />
completa, ma questo deve rimanere parzialmente<br />
adeso alla sua loggia. In tal modo sarà<br />
possibile resecare velocemente la massa avascolare.<br />
Il distacco completo dell’adenoma infatti comporterebbe<br />
una fluttuazione dello stesso in<br />
vescica, con necessità di usare un morcellatore,<br />
così come avviene nella HoLEP. Analoga procedura<br />
viene successivamente utilizzata per il<br />
lobo sinistro. L’intervento si completa con piccoli<br />
ritocchi della loggia prostatica ed una<br />
accurata emostasi.<br />
Conclusioni: La e-TURP si presenta come logica<br />
evoluzione della TURP, anche per voluminosi<br />
adenomi. Riteniamo che tale procedura sia eseguibile<br />
da operatori esperti in TURP e, potenzialmente,<br />
potrebbe diventare competitiva, per<br />
lo meno sul piano dei costi, con l’enucleazione<br />
Laser, che è comunque una tecnica ad alto<br />
costo e con una curva di apprendimento non<br />
facile.<br />
Archivio Italiano di Urologia e Andrologia 2007, 79, 3, Supplemento 1<br />
V3<br />
CORREZIONE DI CISTOCELE CENTRALE<br />
CON TECNICA TRANS-OTTURATORIA<br />
M. Simonazzi, S. Meli, F. Dinale, S. Fornia,<br />
P. Cortellini<br />
Unità Operativa di Urologia, Azienda Ospedaliero-<br />
Universitaria di Parma<br />
VIDEO<br />
L’approccio trans-otturatorio nella correzione<br />
del prolasso vaginale è di recente proposta per<br />
ridurre al minimo il rischio di lesioni vascolari<br />
e/o nervose. L’adattabilità dei mesh e la particolare<br />
conformazione degli aghi proposta<br />
dalla diverse aziende permette di ridurre l’entità<br />
dell’ incisione vaginale e della dissezione.<br />
La paziente viene posta in posizione litotomica.<br />
Dopo cateterizzazione, si procede con incisione<br />
longitudinale della parete vaginale anteriore,<br />
per circa 3 cm, 1 cm al di sotto del<br />
meato uretrale, previa infiltrazione con soluzione<br />
fisiologica per favorire la dissezione dei<br />
piani chirurgici.<br />
Si scolla la parete vaginale dalla vescica bilateralmente.<br />
Si procede alla correzione del prolasso<br />
mediante bendarella di polipropilene fissandola<br />
all’arco tendineo mediante tecnica<br />
transotturatoria.<br />
I dati in nostro possesso fanno riferimento a<br />
25 pazienti operate. La tecnica è per noi<br />
attualmente valida, facilmente ripetibile e con<br />
una breve curva di apprendimento.<br />
V4<br />
TRATTAMENTO ENDOSCOPICO PERCUTA-<br />
NEO DI NEOPLASIA UROTELIALE DELL’ALTA<br />
VIA ESCRETRICE<br />
B. Azizi, C. Vecchioli, A. Garritano, W. Giannubilo,<br />
V. Ferrara<br />
U.O. Urologia Ospedale Civile di Jesi (Ancona)<br />
Le neoplasie della alta via escretrice rappresentano<br />
il 2-4% dei tumori dell’apparato urinario<br />
e il 5% dei tumori uroteliali. Le localizzazioni<br />
più frequenti sono rappresentate dal sistema<br />
pielocaliceale e dal terzo distale dell’uretere.<br />
La Letteratura recente riporta buoni risultati<br />
clinici sul trattamento di queste forme in<br />
maniera conservativa in casi selezionati. Infatti,<br />
lo sviluppo delle tecniche di approccio miniinvasivo,<br />
limitato a forme di basso grado e stadio,<br />
hanno fornito tassi di sopravvivenza<br />
sovrapponibili alla nefroureterectomia, che<br />
comunque rappresenta il trattamento di scelta
in tutte le altre forme di neoplasia dell’altra via<br />
escretrice.<br />
Tali tecniche prevedono il trattamento endoscopico<br />
o percutaneo, attraverso cui si può<br />
utilizzare il laser o effettuare una resezione e/o<br />
coagulazione, similmente alla tecnica standard<br />
di resezione trans-uretrale della vescica.<br />
Ciò ha fatto sì che le indicazioni, inizialmente<br />
solo di necessità, diventassero anche di elezione,<br />
in casi selezionati.<br />
In pazienti con comorbilità severa, tumore<br />
bilaterale, rene unico, le tecniche mini-invasive<br />
rappresentano una opzione terapeutica<br />
valida.<br />
Presentiamo di seguito il caso clinico di un<br />
paziente con neoplasia sincrona della vescica,<br />
della via escretrice di sin, uretere dx e della<br />
pelvi renale dx. Il paziente è stato trattato con<br />
cistectomia radicale, uretrectomia (poichè la<br />
neoplasia interessava anche il collo vescicale e<br />
l'uretra prostatica), nefroureterectomia sin,<br />
ureterectomia e, successivamente è stata eseguita<br />
una resezione endoscopica, tramite<br />
accesso percutaneo, della lesione papillifera a<br />
carico della pelvi renale dx. Quindi è stata<br />
mantenuta la nefrostomia dx.<br />
Ciò ha consentito di evitare che il paziente<br />
diventasse africo, con indubbi vantaggi per la<br />
qualità di vita nei successivi 18 mesi di<br />
sopravvivenza.<br />
V5<br />
RIALLINEAMENTO DI URETERE RETROCAVA-<br />
LE CON PIELOPLASTICA LAPAROSCOPICA<br />
F. Porpiglia, J. Renard, M. Billia, S. Grande,<br />
M. Cossu, F. Ragni, M. Poggio, G. Biamino,<br />
M. Cussotto, I. Morra e R.M. Scarpa<br />
Università di Torino, Divisione Universitaria di<br />
Urologia, Ospedale San Luigi (Torino)<br />
Introduzione e Obiettivi: L’uretere retrocavale é<br />
una malformazione con incidenza pari a<br />
1/1500. Il trattamento chirurgico di questa<br />
patologia può essere eseguito mediante pielopieloanastomosi,<br />
uretero-ureteroanastomosi e<br />
pieloplastica sec. Anderson-Hynes. La laparoscopia<br />
rappresenta un'alternativa alla chirurgia<br />
a cielo aperto, ma é stata descritta raramente<br />
in letteratura. In questo video, presentiamo un<br />
caso di riallineamento laparoscopico di uretere<br />
retrocavale mediante pieloplastica sec.<br />
Anderson-Hynes.<br />
Metodi: La paziente é una giovane donna di 15<br />
anni, affetta di dolore lombare cronico. Alla<br />
<strong>7°</strong> <strong>Congresso</strong> <strong>Nazionale</strong> Associazione Italiana di Endourologia<br />
RMN era ben documentato uretere retrocavale<br />
destro con idronefrosi.<br />
La paziente viene posizionata in decubito laterale<br />
a 45°. Vengono inseriti 4 trocars e viene<br />
utilizzato un approccio transperitoneale. La<br />
procedura inizia con la mobilizzazione del<br />
colon asecendente e della flessura epatica. La<br />
vena cava inferiore viene dissecata e progressivamente<br />
esposta. Si identificano la pelvi renale<br />
e l'uretere che vengono successivamente<br />
dissecati. La porzione retrocavale dell'uretere<br />
viene liberata dalle aderenze alla vena cava<br />
eseguendo dissezione smussa fino alla sua<br />
completa mobilizzazione.<br />
La pelvi viene incisa, la giunzione pielo-ureterale<br />
viene resecata. L'uretere viene riposizionato<br />
lateralmente alla vena cava e viene spatulato.<br />
Si esegue pieloplastica sec. Anderson-<br />
Hynes. Prima del completamento dell'anastomosi<br />
viene inserito un doppio J, infine il peritoneo<br />
posteriore viene ricostruito e la flessura<br />
epatica riposizionata.<br />
Risultati: L’intervento è durato 3 ore. Non sono<br />
state registrate complicanze. Le perdite ematiche<br />
sono state 50 cc.<br />
Conclusioni: L’utilizzo della laparoscopia per il<br />
trattamento di malformazioni come l'uretere<br />
retrocavale é fattibile e sicuro ma presenta un<br />
alto grado di difficoltà.<br />
V6<br />
RIMOZIONE DI STENT ENDOURETERALE<br />
CALCIFICO IN PAZIENTE CON RENE TRA-<br />
PIANTATO MEDIANTE APPROCCIO ENDO-<br />
SCOPICO ANTERO-RETROGRADO IN POSI-<br />
ZIONE SUPINA<br />
C.M. Scoffone, M. Poggio, C. Cracco, R.M. Scarpa<br />
Clinica Urologica, Università di Torino, Ospedale San<br />
Luigi di Orbassano (Torino)<br />
VIDEO<br />
In questo video viene presentato un caso in cui<br />
vengono evidenziate le potenzialità di trattamento<br />
e risoluzione di problematiche mediante<br />
l’utilizzo della posizione supina, che permette<br />
di eseguire contestualmente manovre endoscopiche<br />
anterograde e retrograde.<br />
Presentiamo il caso di un paziente trapiantato<br />
di rene (in fossa iliaca destra) portatore di stent<br />
endoureterale calcifico non rimuovibile per via<br />
retrograda.<br />
Nel Dicembre 2005 il paziente veniva sottoposto<br />
a trapianto di rene in fossa iliaca destra<br />
mediante confezionamento di ureterocistoneo-<br />
Archivio Italiano di Urologia e Andrologia 2007, 79, 3, Supplemento 1 7
8<br />
<strong>7°</strong> <strong>Congresso</strong> <strong>Nazionale</strong> Associazione Italiana di Endourologia<br />
stomia. Nel Marzo 2006, in seguito alla comparsa<br />
di idronefrosi e insufficienza renale<br />
acuta, veniva sottoposto nuovamente a ureteroneocistostomia,<br />
posizionamento di nefrostomia<br />
e stent endoureterale, quest’ultimo rimosso<br />
dopo trattamento ESWL. Nel Novembre<br />
2006, vista la ricomparsa di idronefrosi, il rene<br />
trapiantato veniva sottoposto ad anastomosi<br />
con l’uretere sinistro nativo e successivo posizionamento<br />
di nefrostomia e stent endoureterale.<br />
Successivamente risultava infruttuoso il<br />
tentativo di rimozione dello stent anche dopo<br />
multipli tentativi anterogradi.<br />
Il paziente giungeva quindi alla nostra attenzione.<br />
Si posiziona il paziente in posizione supina sec.<br />
Valdivia-Uria mod. Galdakao. Si esegue un tentativo<br />
infruttuoso di incannulamento ureterale<br />
con filo guida per via retrograda. Si posiziona<br />
camicia nefrostomica a livello del calice superiore<br />
del rene destro e mediante nefroscopio<br />
rigido si individua l’estremità prossimale dello<br />
stent endoureterale ricoperta da grossolane calcificazioni,<br />
che vengono frammentate con<br />
pinza e litotrittore balistico tipo Lithoclast. Si<br />
rimuove infine lo stent con pinza da presa. Si<br />
procede quindi a ureteroscopia flessibile per<br />
via anterograda evidenziando alcuni frammenti<br />
litiasici endoluminali che vengono asportati<br />
con cestello. Si posiziona infine nefrostomia e<br />
stent endoureterale destro.<br />
Archivio Italiano di Urologia e Andrologia 2007, 79, 3, Supplemento 1<br />
Tabella 2.<br />
Tempo operatorio 121.4 (41.0-153.0)<br />
Hemoglobin drop (mg/dL) 1.0 (-0.4-2.7)<br />
Numero di pazienti trasfusi 0/25 (0%)<br />
Analgesici (mg di ketorolac) 70.5<br />
Sepsi 1/25 (4%)<br />
Hospital stay (gg) 1.5 (1-7)<br />
Tempo per recupero completo (gg) 11.4(4-30)<br />
Stone free rate dopo 1 procedura 17/25 (68%)<br />
Comunicazioni Aula Blu<br />
18 Settembre 08.00-09.00<br />
Endourologia alta via 1<br />
C6<br />
LITOTRISSIA URETERORENOSCOPICA RE-<br />
TROGRADA (RIRS) NEL TRATTAMENTO DI<br />
CALCOLI RENALI DI DIMENSIONI > 2 cm<br />
Introduzione: Scopo di questo studio è valutare<br />
i risultati della RIRS nel trattamento della calcolosi<br />
renale di diametro superiore ai 2 cm.<br />
Materiali e Metodi: A partire da giugno 2006,<br />
25 pazienti affetti da calcolosi renale di diametro<br />
> ai 2 cm sono stati sottoposti a RIRS presso<br />
il nostro stone center.<br />
La RIRS viene eseguita con strumenti semirigidi<br />
e/o flessibili (Circon-ACMI DUR-8 e DUR-<br />
D) con l’utilizzo di laser ad olmio per la lito-<br />
Tabella 1.<br />
RIRS<br />
Numero di pazienti 25<br />
Età media (years) 56.6 (36.3-78.0)<br />
BMI 28.3 (17.85-58.6)<br />
Stone burden (cm 2 ) 7 (3.3-19.5)<br />
RIRS vs PNL<br />
Stone free rate dopo 2 procedure (6 pazienti) 20/25 (80%) (1eswl, 1 ULT per steinstrasse pelvica; 4 RIRS 2nd look;<br />
1 paziente ha rifiutato ulteriore trattamento in quanto aveva risolto la<br />
sintomatologia con la sola bonifica pielica, 1 paziente non ulteriormente trattato<br />
per cardiopatia dilatativa in vista di trapianto con benessere per bonifica pielica)<br />
Stone free rate dopo 3 procedure (1 paziente) 21/25 (84%)<br />
N° medio di interventi per calcolo 1.37
trissia; in 5 casi sono state utilizzate camicie<br />
operative.<br />
Le caratteristiche dei pazienti sono riportate in<br />
Tabella 1.<br />
Risultati: I risultati sono riportati nella Tabella 2.<br />
Conclusioni: Il nostro studio dimostra che l’approccio<br />
retrogrado ai calcoli renali di dimensioni<br />
maggiori ai 2 cm comporta una significativa<br />
riduzione di invasività rispetto alla PCNL<br />
(assenza di trasfusioni ematiche), garantendo<br />
risultati accettabili in termini di stone free rate<br />
a fronte di una necessità di reintervento in circa<br />
1/4 dei pazienti. Va da sé che nel proporre la<br />
RIRS per calcoli di tali dimensioni, i nostri<br />
pazienti devono essere dettagliatamente informati<br />
sulla necessità di reintervento in una percentuale<br />
non trascurabile di casi per ottenere<br />
uno stone free rate accettabile.<br />
C7<br />
LITOTRISSIA PERCUTANEA: TUBELESS OR<br />
NOT TUBELESS?<br />
G. Giusti, A. Piccinelli, G. Taverna, A. Benetti,<br />
O. Maugeri, L. Pasini, S. Zandegiacomo de<br />
Zorzi, M. Corinti, P. Graziotti<br />
U.O. di Urologia, Istituto Clinico Humanitas, IRCCS,<br />
Rozzano (Milano)<br />
Introduzione: Scopo di questo studio retrospettivo<br />
è valutare i vantaggi della litotrissia percutanea<br />
Tubeless nei confronti della litotrissia<br />
percutanea standard.<br />
Materiali e Metodi: Da Giugno 2002 abbiamo<br />
eseguito 180 litotrissie percutanee per calcolosi<br />
renale. Di queste, 99 sono state eseguite con<br />
metodica standard e 81 con metodica “tube-<br />
Tabella 1.<br />
Standard PCNL vs Tubeless PCNL<br />
Tempo operatorio (min) 132 vs 98<br />
Variazione di Ematocrito (%) 6.0 vs 5.4 p=0.230<br />
N° di pazienti trasfusi 5/99 (5,05%) vs 1/81 (1,23%)<br />
Analgesici (mg) 83.8 vs 47.4 p=0.003<br />
Hospital Stay (days) 5.2 vs 2.1 p
10<br />
<strong>7°</strong> <strong>Congresso</strong> <strong>Nazionale</strong> Associazione Italiana di Endourologia<br />
colti i seguenti dati considerati predittivi di<br />
successo: sesso, età, BMI, altezza, dati anamnestici<br />
relativi a precedenti trattamenti (ESWL,<br />
URS, chirurgia), strumentazione di imaging<br />
costituita da ecografia dell'apparato urinario e<br />
Rx Urografia, la UroTC. 138 pazienti 41 donne<br />
di età media di 54 anni e 97 uomini di età<br />
media di 47,2 anni. 111 trattamenti per calcolosi<br />
reno ureterale e 27 per neoplasia dell’alta<br />
via escretrice.<br />
In 92/138 è stato posizionato stent ureterale JJ<br />
due settimane prima del trattamento.<br />
Lo strumentario in dotazione era costituito da<br />
ureteroscopi semirigidi da 7 e 10 F, ureteroscopio<br />
flessibile 7.5 F, SWISS Lithoclast, ultrasuoni,<br />
holmium: YAG laser.<br />
Il successo del trattamento è stato stabilito per<br />
una calcolosi residuale inferiore a 4 mm<br />
Risultati: Il BMI medio è stato 22,4 e l'altezza<br />
media di 177 cm.<br />
La percentuale di successo a 3 mesi è stata pari<br />
all'81% vs 93.7% a 12 mesi. Le complicanze<br />
sia della tecnica semirigida che della flessibile<br />
sono state complessivamente il 3.75%.<br />
La calcolosi del calice inferiore ha avuto una<br />
percentuale di ritrattamento pari al 23.3%.<br />
Dei 46 pazienti l'80% erano donne in menopausa,<br />
mentre nel restante 20% pazienti già<br />
trattati per litiasi reno ureterale.<br />
Discussione: È ipotizzabile che valutando BMI,<br />
altezza, età e fattori anamnestici strettamenti<br />
legati alla patologia insieme all'ausilio di tutto<br />
lo strumentario necessario per la procedura<br />
endoscopica la renoureteroscopia diventi una<br />
manovra più accessibile a tutti gli endourologi<br />
permettendo di poter prevenire tutte le possibili<br />
complicanze ed aumentando la percentuale<br />
di successo del trattamento.<br />
Conclusioni: L’applicazione dei fattori predittivi<br />
permette di selezionare categorie di pazienti<br />
con possibilità di successo superiore alla<br />
norma e fa sì che la renoureteroscopia sia una<br />
procedura a basso rischio di complicanze,<br />
anche rispetto alla PCNL, potendola considerare<br />
alternativa o prima scelta rispetto alla PCNL<br />
in casi selezionati.<br />
C9<br />
TRATTAMENTO DELLA LITIASI CON ESWL:<br />
VALUTAZIONE RETROSPETTIVA SU 584<br />
PAZIENTI<br />
A. Saita, A. Bonaccorsi, F. Marchese, M. Falsaperla,<br />
S.V. Condorelli, M. Motta<br />
Clinica Urologica Università degli Studi Catania (OVE)<br />
Archivio Italiano di Urologia e Andrologia 2007, 79, 3, Supplemento 1<br />
Scopo del lavoro: Scopo dello studio è stato<br />
quello di analizzare i risultati dei trattamenti di<br />
litotrissia extracorporea eseguiti presso la<br />
nostra divisione valutandone i parametri predittivi<br />
di successo e come questi abbiano cambiato<br />
l'approccio terapeutico.<br />
Materiali e Metodi: Dall’Aprile del 2001 al giugno<br />
2006 sono stati trattati 584 pazienti 222<br />
donne e 362 uomini di età media rispettivamente<br />
di 43,5 e 45 anni. Complessivamente<br />
sono stati eseguiti 614 trattamenti di litotrissia<br />
extracorporea con litotritore Delta Compact<br />
Magneto Lithotripter Dornier. In tutti i pazienti<br />
sono stati valutati: età, sesso, BMI, la dimensione<br />
ed il sito del calcolo,esame completo di<br />
sedimento e colturale delle urine, prove emocoagulative,<br />
Rx Urografia, opzionale UroTC. La<br />
tipologia di trattamento è stata decisa secondo<br />
gli algoritmi terapeutici che riguardano la calcolosi<br />
reno ureterale. Lo stone free rate è stato<br />
stabilito per frammenti litiasici < 4 mm.<br />
Risultati: I trattamenti ESWL sono stati stratificati<br />
per sito del calcolo: 83 calcoli del calice superiore,<br />
125 calice medio, calice inferiore 107,<br />
pelvi renale/giunto pielo ureterale151, uretere<br />
lombare 69, uretere iliaco 64, uretere pelvico 3.<br />
Le dimensioni medie sono state pari a 1,75<br />
mm (range 3 - 0.5). La composizione dei calcoli<br />
è stata nel 84% di Ossalato di calcio mono<br />
e diidrato, nel 10% di acido urico (pazienti<br />
resistenti alla chemiolisi), nel 5,83% di struvite<br />
e nello 0,17% di cistina.<br />
Lo stone free rate globale è stato pari a 78.2%.<br />
Nel 33,5% dei casi è stata eseguita ESWL previo<br />
posizionamento di stent ureterale JJ, tuttavia<br />
mentre nel 2001 la percentuale di stenting<br />
complessiva era del 45% nel 2006 è stata pari<br />
al 22%. Nel 6.3% dei casi è stata necessaria<br />
l’integrazione di vari trattamenti: ESWL post<br />
PCNL, post URS e URS post ESWL.<br />
Le complicanze complessivamente sono state<br />
dello 0,65%.<br />
in tutti i pazienti il follow up è stato eseguito a<br />
3, 6, 9 e 12 mesi.<br />
Discussione: Risulta importante l'anamnesi del<br />
paziente: una storia di diatesi litiasica aumenta<br />
la possibilità di completa clearence dei frammenti<br />
residuali. L’Rx Urografia consente di<br />
valutare la componente calcica del calcolo,<br />
direttamente proporzionale all’insuccesso<br />
dell’ESWL; l’anatomia dei calici, il diametro e<br />
la lunghezza dell'infundibulo sono predittivi di<br />
successo del trattamento. Infine l'ausilio di dispositivi<br />
terapeutici quali Citrati, Nifedipina<br />
cronoide e Prednisolone ha ridotto il ricorso a
manovre endourologiche per la rimozione dei<br />
frammenti residuali > ai 4 mm.<br />
Conclusioni: dalla revisione dei dati si è evinto<br />
come globalmente sia cambiato l'approccio<br />
all'ESWL.<br />
C10<br />
TRATTAMENTO DELLA CALCOLOSI URETE-<br />
RALE CON URETEROSCOPIO RIGIDO: VALU-<br />
TAZIONE DI 500 CASI CONSECUTIVI<br />
G. Deiana, L. Feroldi, L. P. Canclini, M. Nicolai,<br />
A. Lembo<br />
Unità Operativa di Urologia, Azienda Ospedaliera -<br />
Ospedali Riuniti di Bergamo<br />
Introduzione e Obiettivi: L’ureteroscopia si è<br />
affermata come metodica di comune utilizzo<br />
nel trattamento della calcolosi ureterale. La disponibilità<br />
di strumenti miniaturizzati ha reso la<br />
procedura minimamente invasiva, consentendo<br />
la frantumazione ed estrazione del calcoloin<br />
una elevata percentuale di casi. Questo studio<br />
retrospettivo ha lo scopo di valutare l’efficacia<br />
dell’ureteroscopia retrograda con strumento<br />
rigido nel trattamento della calcolosi ureterale.<br />
Metodi: Da gennaio/2003 ad agosto/2006, presso<br />
la nostra U.O. di urologia sono stati eseguiti<br />
500 interventi di ueteroscopia per calcolosi.<br />
Per la procedura è stato utilizzato un ureteroscopio<br />
rigido Wolf 6-7,5 Fr (333 casi) oppure<br />
7-8,5 Fr (167 casi), un litotritore pneumatico<br />
Swiss Lithoclast ed accessori per l’estrazione<br />
dei frammenti litiasici. I pazienti erano 335<br />
maschi e 165 femmine d’età compresa tra 10 e<br />
88 anni (media 51 ; mediana 52). Le dimensioni<br />
del calcolo erano comprese tra 4 mm e 25<br />
mm (media 10,5 mm; mediana 10 mm). Il calcolo<br />
era situato in uretere destro in 209 casi, in<br />
uretere sinistro in 291 casi, a livello lombare in<br />
216 casi, iliaco/pelvico in 191 casi e prevescicale/intramurale<br />
in 93 casi.<br />
Risultati: In 14 casi l’ureteroscopia è stata<br />
infruttuosa per la ristrettezza dell’uretere che<br />
non ha consentito la risalita dello strumento<br />
(10 calcoli dell’uretere lombare, 4 calcoli dell’uretere<br />
iliaco-pelvico) In questi casi è stato<br />
posizionato uno stent ureterale. In 181 casi è<br />
stato possibile effettuare l’introduzione diretta<br />
in uretere dell’ureteroscopio, mentre nei rimanenti<br />
casi è stato necessario l’ausilio di un filo<br />
guida. In 444 casi è stata ottenuta la frantumazione<br />
del calcolo. In 378 casi sono stati rimossi<br />
tutti i frammenti litiasici (112 calcoli dell’uretere<br />
lombare, 173 calcoli dell’uretere<br />
<strong>7°</strong> <strong>Congresso</strong> <strong>Nazionale</strong> Associazione Italiana di Endourologia<br />
iliaco/pelvico e 93 calcoli dell’uretere prevescicale/intramurale).<br />
In 66 casi alcuni frammenti<br />
litiasici sono migrati nel rene (56 calcoli<br />
dell’uretere lombare, 10 calcoli dell’uretere iliaco).<br />
In 42 casi la procedura è esitata in una<br />
retropulsione del calcolo nel rene (21 calcoli<br />
del giunto pielo-ureterale, 17 calcoli dell’uretere<br />
lombare, 4 calcoli dell’uretere iliaco). Nei<br />
casi di retropulsione totale del calcolo o di<br />
frammenti litiasici grossolani è stato posizionato<br />
uno stent ureterale e la bonifica della calcolosi<br />
è stata ottenuta mediante litotrissia extracorporea.<br />
Nella serie analizzata non si sono<br />
verificati danni permanenti dell’uretere. In un<br />
caso è stata osservata l’insorgenza precoce di<br />
una stenosi dell’orifizio ureterale che è stata<br />
trattata con successo mediante il posizionamento<br />
di uno stent ureterale per 40 giorni.<br />
Conclusioni: Nella nostra esperienza l’ureterolitotrissia<br />
retrograda con strumento rigido di<br />
piccolo calibro ha dimostrato essere una metodica<br />
minimamente invasiva, sicura ed efficace<br />
nell’ottenere la rapida disostruzione dell’uretere,<br />
consentendo l’asportazione completa del<br />
calcolo in una elevata percentuale di casi.<br />
Riteniamo che i fattori fondamentali per il successo<br />
della procedura siano la disponibilità di<br />
un ureteroscopio di piccolo calibro fornito di<br />
accessori efficaci per la frantumazione ed estrazione<br />
dei frammenti litiasici unitamente all’esperienza<br />
dell’operatore.<br />
C11<br />
PCNL IN POSIZIONE DI VALDIVIA-URIA<br />
MOD. GALDAKAO NEL TRATTAMENTO<br />
DELLA CALCOLOSI RENALE: NOSTRA ESPE-<br />
RIENZA<br />
C.M. Scoffone, C.M. Cracco, M. Cossu, M. Poggio,<br />
S. Grande, M. Billia, R.M. Scarpa<br />
Clinica Urologica, Università di Torino, A.S.O. San<br />
Luigi di Orbassano (Torino)<br />
Introduzione: Attualmente la PCNL continua ad<br />
essere un intervento di prima scelta per soggetti<br />
portatori di voluminosi calcoli renali; Al<br />
fine di migliorare il risultato della singola procedura<br />
sono state impiegate posizioni alternative<br />
a quella prona tra le quali la più vantaggiosa<br />
dal punto di vista urologico ed anestesiologico<br />
risulta essere quella supina secondo<br />
Valdivia ulteriormente migliorata per un agevole<br />
accesso retrogrado dalla combinazione<br />
con la posizione litotomica modificata secondo<br />
Galdakao.<br />
Archivio Italiano di Urologia e Andrologia 2007, 79, 3, Supplemento 1 11
12<br />
<strong>7°</strong> <strong>Congresso</strong> <strong>Nazionale</strong> Associazione Italiana di Endourologia<br />
Materiali e Metodi: Tale posizione è stata adottata<br />
dal Nostro centro, a partire dal Marzo 2003. Sino<br />
al Dicembre 2006 94 pazienti sono stati sottoposti<br />
a PCNL in posizione supina per calcolosi. L’età<br />
media era di 51,8 (range 19-73). Tutti gli interventi<br />
sono stati eseguiti in anestesia generale. Per<br />
la nefroscopia rigida è stato utilizzato strumento<br />
Storz di 26 CH. Al termine di tutte le procedure è<br />
stato eseguito un controllo delle cavità renali con<br />
il nefroscopio flessibile. La litotrissia è stata effettuata<br />
prevalentemente con strumento balistico<br />
(Lithoclast) ed in alcuni casi con il laser ad Olmio.<br />
Risultati: Il diametro medio dei calcoli trattati era<br />
di 27,4 mm (10-50 mm) di cui 19 (21%) a livello<br />
del calice inferiore, 5 nel calice medio (5%), 6<br />
nel calice superiore(6%), 36 pielici (37%) e 28 a<br />
stampo (30%). In quattro casi era presente<br />
anche calcolosi ureterale. La durata media della<br />
procedura è stata di 93 minuti. In 32 procedure<br />
è stato necessario l’approccio combinato. Lo<br />
stone-free rate immediato è stato di circa l’80 %.<br />
In 5 casi è stato necessario eseguire un second<br />
look endoscopico nei giorni successivi con una<br />
percentuale totale di successo del 92%. Nel postoperatorio<br />
vi sono state: 5 complicanze minori<br />
(5%) (lombalgia e dislocazione JJ), 5 anemizzazioni<br />
(5 %) con necessità di trasfusioni e 2 fistole<br />
artero-venose con ricorso all’embolizzazione<br />
selettiva (2 %).<br />
Conclusioni: La posizione di Valdivia modificata<br />
secondo Galdakao è senz’altro una posizione<br />
particolarmente versatile da utilizzare in corso di<br />
interventi per urolitiasi di una certa dimensione,<br />
apportando una serie di vantaggi urologici ed<br />
anestesiologici rispetto al decubito prono tradizionale,<br />
consentendo inoltre il trattamento di<br />
calcolosi complessa non altrimenti aggredibile<br />
con il solo approccio percutaneo senza la necessità<br />
di accessi multipli.<br />
Comunicazioni Aula Verde<br />
18 Settembre 08.00-09.00<br />
Endourologia alta via 2<br />
C12<br />
EFFICACIA E SICUREZZA DI UNA NUOVA<br />
SORGENTE DI HOLMIUM:YAG LASER NEL<br />
TRATTAMENTO ENDOSCOPICO DELLA CAL-<br />
COLOSI URETERALE<br />
L. Ruggera 1 , M. Zanin 1 , A. Aloisi 1 , P. Beltrami 1 ,<br />
M.A. Cerruto 1 , W. Cecchetti 2 , F. Zattoni 1<br />
1 Divisione Clinicizzata di Urologia, Policlinico “G.B. Rossi”,<br />
Verona; 2 Dipartimento Chimica Fisica, Università Cà<br />
Foscari, Venezia<br />
Archivio Italiano di Urologia e Andrologia 2007, 79, 3, Supplemento 1<br />
Introduzione e Obiettivi: Nel corso dell’ultimo<br />
decennio l’holmium:YAG (Ho:YAG) laser ha<br />
diffusamente sostituito le altre forme di energia<br />
come metodica di prima scelta nella litotrissia<br />
ureterorenoscopica. Obiettivo di questo studio<br />
prospettico è stato la valutazione del grado di<br />
efficacia e di sicurezza di una nuova sorgente<br />
Holmium:YAG laser caratterizzata da ridotta<br />
potenza di esercizio.<br />
Metodi: Da gennaio 2006 a dicembre 2006, 66<br />
pazienti (43 maschi e 23 femmine) affetti da<br />
calcolosi ureterale singola o multipla sono stati<br />
sottoposti ad URS e litotrissia laser. L’età media<br />
dei pazienti è risultata di 48 anni (17-77).<br />
Complessivamente sono stati trattati 100 calcoli:<br />
49 localizzati nell’uretere distale, 12 nell’uretere<br />
iliaco e 39 nel tratto prossimale. Sede<br />
e dimensioni dei calcoli sono state ottenute<br />
dalla radiografia diretta dell’addome, dall’ecografia<br />
addominale o dall’urografia. Sono stati<br />
utilizzati ureteroscopi semirigidi di 9.5 o 8 F di<br />
calibro, con canale operativo rispettivamente<br />
di 5 e 4 F. La litotrissia è stata eseguita con un<br />
generatore Holmium:YAG laser di nuova generazione,<br />
utilizzando fibre da 365 Ìm. Energia e<br />
frequenza di ripetizione degli impulsi sono<br />
state rispettivamente di 0,8 J e 6-8 Hz, equivalenti<br />
ad una potenza rispettivamente di 4,8 or<br />
6,4 Watt. Il follow-up ha previsto l’esecuzione<br />
di una radiografia dell’addome e di un’ecografia<br />
addomino-pelvica a 48 ore e a 30 giorni di<br />
distanza.<br />
Risultati: La superficie mediana dei calcoli trattati<br />
è risultata di 49 mm2 [range interquartile<br />
(R.I.) 27-79 mm2]. La percentuale di successo<br />
ottenuta con un singolo trattamento è risultata<br />
del 100% per i calcoli dell’uretere distale, del<br />
92% per quelli del tratto intermedio e del 95%<br />
per quelli del uretere prossimale. La composizione<br />
chimica del calcolo è risultata di ossalato<br />
e/o fosfato di calcio nel 74% dei casi, acido<br />
urico nel 9,7%, cistina nel 1,7% e mista nel<br />
rimanente 14,6%. Il tempo operatorio mediano<br />
è risultato di 60 minuti (R.I. 50-90). Al termine<br />
della procedura è stato posizionato uno<br />
stent ureterale single J in 14 casi, un doppio J<br />
in 37 ed un catetere ureterale retto in 12. Nei<br />
rimanenti 3 casi non abbiamo ritenuto necessario<br />
drenare la via escretrice. Sono state registrate<br />
complicanze in 5 casi: iperpiressia in 3<br />
pazienti (solo in 1 caso >38°C), macroematuria<br />
persistente in 1 caso ed una abrasione della<br />
mucosa ureterale con iniziale falsa strada.<br />
Nessuno di questi pazienti ha richiesto manovre<br />
accessorie oltre alla semplice terapia sinto-
matica. Non sono state registrate complicanze<br />
maggiori intra o post-operatorie.<br />
Conclusioni: I risultati ottenuti evidenziano<br />
come questa fonte Ho:YAG laser sia caratterizzata<br />
da un’eccellente efficacia nel trattamento<br />
dei calcoli ureterali, indipendentemente dal<br />
loro grado di durezza, con minime complicanze.<br />
E’ noto che il laser ad olmio provoca all’estremità<br />
della fibra ottica la formazione di una<br />
bolla di plasma: alte frequenze di ripetizione<br />
possono comportare il rischio di un eccessivo<br />
riscaldamento a carico della mucosa ureterale.<br />
Pertanto, le basse energie e frequenze di ripetizione<br />
degli impulsi da noi utilizzate, rispettivamente<br />
di 0,8 Joule e 6-8 Hz e corrispondenti<br />
ad una potenza media di 4,8 e 6,4 Watt, sono<br />
sufficienti ad ottenere un’eccellente litotrissia<br />
dei calcoli, col minimo incremento termico a<br />
carico della mucosa ureterale.<br />
C13<br />
NEFROLITIASI CISTINICA RICORRENTE:<br />
TRATTAMENTO MEDIANTE URETERORENO-<br />
SCOPIA CON STRUMENTO SEMI-RIGIDO<br />
E/O FLESSIBILE E LITOTRISSIA CON HOL-<br />
MIUM:YAG LASER<br />
Lorenzo Ruggera 1 , Martina Zanin 1 , Lorenzo<br />
Luciani 2 , Francesca Gigli 1 , Paolo Beltrami 1 ,<br />
Maria Angela Cerruto 1 , Filiberto Zattoni 1<br />
1 Divisione Clinicizzata di Urologia, Policlinico “G.B. Rossi”,<br />
Verona; 2 Reparto di Urologia, Ospedale S. Chiara, Trento<br />
Introduzione: L’ureterorenoscopia (URS) rappresenta<br />
attualmente una procedura efficace e sicura<br />
per il trattamento della nefrolitiasi, indipendentemente<br />
dalla composizione chimica e quindi<br />
dal grado di durezza del calcolo. La disponibilità<br />
di questa metodica terapeutica mini-invasiva<br />
rappresenta un indubbio vantaggio nel<br />
minimizzare la morbilità cumulativa di ripetuti<br />
trattamenti, frequentemente necessari nei<br />
pazienti affetti da calcolosi cistinica ricorrente.<br />
Materiali e Metodi: Dal 2002 al 2006 sono stati<br />
sottoposti ad URS 10 pazienti (4 maschi e 6<br />
femmine) affetti da calcolosi renale cistinica<br />
singola (70% dei casi) o multipla (30%).<br />
Complessivamente sono state eseguite 22 procedure<br />
con strumento semirigido e/o flessibile:<br />
un paziente è stato sottoposto a second-look<br />
per persistenza di frammenti litiasici significativi<br />
mentre un paziente è stato sottoposto a 2<br />
procedure e 5 pazienti a 3 URS per calcolosi<br />
recidivante. Il diametro massimo dei calcoli<br />
trattati, valutato con radiografia diretta dell’ad-<br />
<strong>7°</strong> <strong>Congresso</strong> <strong>Nazionale</strong> Associazione Italiana di Endourologia<br />
dome e con urografia, è risultato in media di<br />
11,2 mm (5-30 mm). In 6 casi è stata eseguita<br />
una litolapassi mentre in 10 casi è stata eseguita<br />
una litotrissia laser con strumento flessibile.<br />
Nei rimanenti 6 casi i calcoli sono stati spostati<br />
in uretere mediante lo strumento flessibile e<br />
successivamente frantumati con sonda laser<br />
utilizzando l’ureteroscopio semirigido. Energia<br />
e frequenza del laser sono state rispettivamente<br />
di 0.8 J e 6-8 Hz, con fibre di 365 Ìm per lo<br />
strumento semirigido e di 230 Ìm per quello<br />
flessibile. Il follow-up a breve termine ha previsto<br />
l’esecuzione di una radiografia diretta dell’addome<br />
e di un’ecografia addomino-pelvica a<br />
48 ore e a 30 giorni di distanza.<br />
Risultati: La bonifica completa è stata ottenuta<br />
in 16 su 22 procedure (73%) mentre in 5 casi<br />
(23%) sono residuati frammenti litiasici significativi<br />
(>2 mm di diametro). In 1 caso (4%)<br />
l’URS è risultata infruttuosa per l’inaccessibilità<br />
al calice contenente il calcolo. In 5 di questi 6<br />
casi sfavorevoli, la clearance completa è stata<br />
ottenuta con un trattamento ausiliario, rappresentato<br />
dalla litotrissia extracorporea (ESWL)<br />
in 2 casi, da un second-look ureteroscopico in<br />
un caso e da una PCNL negli ulteriori 2 casi.<br />
Nessun trattamento di completamento è stato<br />
attuato nel rimanente caso. Al termine dell’intervento<br />
è stato posizionato in 12 casi uno stent<br />
ureterale single J e in 9 casi un doppio J, mantenuti<br />
in sede per un tempo variabile da 2 a 30<br />
giorni. Solamente in un caso nel quale era stata<br />
eseguita la semplice litolapassi di un piccolo<br />
calcolo, non abbiamo ritenuto necessario posizionare<br />
uno stent. Non sono state registrate<br />
complicanze maggiori intra o post-operatorie.<br />
Conclusioni: L’URS sembra offrire indubbi vantaggi<br />
in questo gruppo di pazienti, affetti da<br />
calcolosi ricorrente e resistente al trattamento<br />
mediante ESWL, che frequentemente richiedono<br />
ripetuti trattamenti anche in periodi di<br />
tempo ravvicinati. Questa procedura miniinvasiva<br />
gravata da rare complicanze, permette<br />
di minimizzare la morbilità cumulativa dei<br />
ripetuti trattamenti spesso necessari in questi<br />
pazienti.<br />
C14<br />
URETERORENOSCOPIA: STUDIO PROSPET-<br />
TICO DEI POSSIBILI FATTORI PROGNOSTICI<br />
L. Ruggera, P. Beltrami, M.A. Cerruto, M. Zanin,<br />
A. Aloisi, F. Gigli, F. Zattoni<br />
Divisione Clinicizzata di Urologia, Policlinico “G.B. Rossi”,<br />
Verona<br />
Archivio Italiano di Urologia e Andrologia 2007, 79, 3, Supplemento 1 13
14<br />
<strong>7°</strong> <strong>Congresso</strong> <strong>Nazionale</strong> Associazione Italiana di Endourologia<br />
Introduzione e obiettivi: Obiettivo di questo studio<br />
prospettico è stato la ricerca di eventuali fattori<br />
prognostici condizionanti l’esito del trattamento<br />
della calcolosi reno-ureterale mediante ureterorenoscopia<br />
(URS), sia con strumento semirigido<br />
che flessibile.<br />
Metodi: Da Novembre 2005 ad Ottobre 2006, 91<br />
pazienti (57 maschi e 34 femmine) sono stati sottoposti<br />
ad URS per calcolosi renoureterale singola<br />
e multipla. Sono state eseguite in totale 101<br />
procedure con strumento semirigido e/o flessibile.<br />
66 pazienti erano affetti da calcolosi singola,<br />
35 da calcoli multipli. In 19 procedure è stata<br />
eseguita una litolapassi, in 14 una litotrissia balistica,<br />
in 57 una litotrissia laser e in 8 una litotrissia<br />
combinata balistica e laser. Nei rimanenti 3<br />
casi il trattamento dei calcoli è stato sospeso.<br />
Energia e frequenza di ripetizione degli impulsi<br />
del laser sono state rispettivamente di 0.8 J e 6-8<br />
Hz, corrispondenti ad una potenza media di 4,8<br />
e 6,4 Watt,. Il follow-up a breve termine ha previsto<br />
l’esecuzione di una radiografia diretta e di<br />
un’ecografia addominale a 48 ore e a 30 giorni di<br />
distanza, mentre solo in particolari situazioni si è<br />
fatto ricorso alla urografia. Frammenti residui di<br />
dimensioni ≤2 mm sono stati considerati come<br />
“stone free”.<br />
I parametri analizzati come possibili fattori prognostici<br />
sono stati: sede, numero e superficie<br />
del calcolo, composizione chimica, presenza di<br />
idroureteronefrosi, tipo di strumento e metodica<br />
di frantumazione utilizzata. I risultati sono<br />
stati riportati come mediane e range interquartilici<br />
(R.I.).<br />
L’analisi statistica è stata eseguita utilizzando i<br />
seguenti test statistici: test Chi quadro per il confronto<br />
delle variabili categoriche e regressione<br />
logistica per l’analisi multivariata. Un valore<br />
p≤0,05 è stato considerato statisticamente significativo<br />
(test a 2-code).<br />
Risultati: Complessivamente sono stati trattati<br />
134 calcoli: 41 localizzati nell’uretere distale, 7<br />
nel tratto intermedio e 18 nel prossimale, 22 in<br />
pelvi, 21 a livello caliceale inferiore e 25 nel<br />
gruppo caliceale medio-superiore. La superficie<br />
mediana dei calcoli, ottenuta dalla radiografia<br />
diretta dell’addome e dall’urografia, è risultata di<br />
47 mm2 (R.I. 20-79 mm2). La percentuale di<br />
risultati positivi dopo un singolo trattamento è<br />
risultata dell’81%; dopo un secondo trattamento<br />
dell’89%.<br />
All’analisi statistica univariata solamente la sede<br />
ed il tipo di strumento utilizzato sono risultati<br />
parametri in grado di associarsi significativamente<br />
con l’esito del trattamento. Alla successiva ana-<br />
Archivio Italiano di Urologia e Andrologia 2007, 79, 3, Supplemento 1<br />
Tabella 1. Analisi univariata (Chi quadro) e multivariata<br />
(regressione logistica) delle possibili associazioni<br />
fra esito del trattamento e parametri considerati<br />
Parametri Analisi Analisi<br />
univariata multivariata<br />
(p) (p)<br />
Sede 0.000 0.000<br />
Numero N.S. N.S.<br />
Superficie N.S. N.S.<br />
Composizione chimica N.S. N.S.<br />
Presenza di idroureteronefrosi N.S. N.S.<br />
Strumento rigido/flessibile 0.000 N.S.<br />
Energia di frantumazione N.S. N.S.<br />
N.S.: non significativo<br />
lisi multivariata soltanto la localizzazione del calcolo<br />
è risultata un fattore prognostico per l’esito<br />
dell’URS (Tabella 1).<br />
Conclusioni: Diversamente da quanto ampiamente<br />
segnalato in letteratura per la litotrissia extracorporea<br />
ad onde d’urto (ESWL), influenzata da<br />
sede, dimensioni e composizione chimica del<br />
calcolo, il nostro lavoro evidenzia come solo la<br />
sede del calcolo rappresenta un fattore potenzialmente<br />
predittivo per l’esito dell’URS. Tale parametro<br />
deve pertanto essere attentamente considerato<br />
ai fini della programmazione terapeutica<br />
in quanto una localizzazione caliceale inferiore<br />
può influenzare negativamente il risultato.<br />
C15<br />
TRATTAMENTO PERCUTANEO DI UROTELIO-<br />
MA DELLA PELVI RENALE CON ELETTROBI-<br />
STURI BIPOLARE A RADIOFREQUENZA:<br />
EVOLUZIONE DEL TRATTAMENTO ENDO-<br />
SCOPICO<br />
M. Tura, O. Fenice, M. Parravicini, P. Baroni<br />
U.O. Urologia, Policlinico di Monza<br />
Introduzione: Il trattamento d’elezione dei tumori<br />
uroteliali delle alte vie escretrice è la nefroureterectomia,<br />
tuttavia, in casi selezionati, è possibile eseguire<br />
un trattamento endourologica con altrettanti<br />
buoni risultati.<br />
Le indicazioni assolute per il trattamento endourologico<br />
includono rene unico, malattia bilaterale,<br />
insufficienza renale, rischio chirurgico elevato,<br />
malattia di basso grado, non infiltrante.
Materiali e Metodi: Presentiamo il caso di una<br />
paziente di 64 aa, in buone condizioni generali,<br />
sottoposta presso altro centro a cistectomia con<br />
neovescica ileale ed a nefroureterectomia sinistra<br />
per malattia uroteliale avanzata, ricoverata per il<br />
riscontro radiologico di recidiva a livello caliciale<br />
medio ed ureterale lombare.<br />
La paziente è stata sottoposta a trattamento ureteroscopico<br />
della recidiva ureterale ed a tentativo<br />
infruttuoso di trattamento della localizzazione<br />
caliciale; si è reso pertanto necessario confezionare<br />
un accesso percutaneo per eseguire una<br />
resezione della recidiva caliciale.<br />
Non abbiamo registrato complicazioni per o post<br />
operatorie significative e la paziente è stata controllata<br />
con ecografia ed rx urografia.<br />
Discussione: L’elettrobisturi bipolare a radiofrequenza<br />
rappresenta il modo più semplice e sicuro<br />
nel trattamento endoscopico dei casi “difficili”<br />
di recidiva uroteliale.<br />
Con l’apparecchiatura Gyrus la velocità di taglio<br />
e la precisione di coagulo è nettamente superiore<br />
alla normale ansa diatermica monopolare, permettendoci<br />
così di ridurre il tempo necessario<br />
per la resezione e la coagulazione.<br />
L’energia monopolare produce un riscaldamento<br />
tissutale di circa tremila gradi, con un’alterazione<br />
istologica fino a 4 mm di profondità. L’energia a<br />
radiofrequenza bipolare, innanzitutto, non attraversa<br />
il tessuto del paziente, inoltre, la vaporizzazione<br />
tissutale necessaria per il taglio la si ottiene<br />
con soli 70 gradi, e le alterazioni istologiche le<br />
si rilevano fino a soli 0.5 mm di profondità. Con<br />
quest’ultima metodica si ottiene anche una maggiore<br />
velocità di taglio, unita ad una maggiore<br />
precisione nel coagulo, permettendoci di ridurre<br />
i tempi dell’intervento e quindi anche della<br />
degenza post-operatoria a tutto vantaggio del<br />
paziente. Abbiamo inoltre un minore danno tessutale<br />
causato dalla temperatura elevata durante<br />
il taglio, fornendo all’anatomopatologo un tessuto<br />
istologicamente meno alterato ed una minore<br />
probabilità di perforazione<br />
Comunicazioni Aula Gialla<br />
18 SETTEMBRE 08.00-09.00<br />
Miscellanea 1<br />
C16<br />
TRATTAMENTO DEL CISTOCELE CON TECNI-<br />
CA TENSION FREE PER VIA TRANS-OTTU-<br />
RATORIA (PROLIFT A®).<br />
F. Blefari, C. Radicchia, P.A. Petroni<br />
U.O. Urologia ASL TR4, Orvieto<br />
<strong>7°</strong> <strong>Congresso</strong> <strong>Nazionale</strong> Associazione Italiana di Endourologia<br />
Scopo del lavoro: Valutare l’efficacia e la sicurezza<br />
della correzione del cistocele tramite<br />
sospensione vaginale anteriore con rete di polipropilene<br />
a maglia larga preconformata in<br />
quattro bracci applicata tension free per via<br />
transotturatoria.<br />
Materiali e Metodi: Dal Novembre 2005 a giugno<br />
2007 16 paz. affette da cistocele sintomatico<br />
sono state selezionate per essere sottoposte<br />
a correzione di tale patologia mediante sospensione<br />
vescicale con amaca anteriore transotturatoria<br />
tension (Prolift A ® ).<br />
La valutazione preoperatoria comprendeva,<br />
anamnesi, esame obiettivo, esame urodinamico<br />
con valutazione del LPP a cistocele ridotto,<br />
Qtip test, valutazione HWS del prolasso. Le<br />
Pazienti sono state rivalutate a 2 e 6 mesi dopo<br />
l’intervento.<br />
L’età media delle Pazienti era 68 anni (range<br />
59-71), tutte erano in menopausa, nessuna era<br />
stata preventivamente sottoposta ad isterectomia.<br />
Nessuna delle Pazienti presentava isterocele<br />
o rettocele significativi.<br />
Risultati: I tempi medi operatori sono risultati 42<br />
min e la durata media operatoria è stata 2,3 gg.<br />
Non vi sono state complicanze intraoperatorie.<br />
6 Pazienti presentavano disuria ostruttiva dopo<br />
l’intervento si è avuta la risoluzione della stessa<br />
documentata al controllo a 2 mesi e confermata<br />
a quello a 6. Non vi è stata comparsa di<br />
instabilità detrusoriale de novo né di ostruzione<br />
persistente.<br />
In una Paziente.si è assistito alla comparsa di<br />
isterocele ed in una alla comparsa di incontinenza<br />
urinaria da stress de novo corretta successivamente<br />
con sling suburetrale (TVT<br />
Secure ® ). In un caso si è osservato un ematoma<br />
retro vescicale che si è assorbito spontaneamente<br />
a 30 gg dall’intervento. Non sono state<br />
osservate erosioni della parete vaginale né della<br />
vescica.<br />
Discussione: Pur nella nostra esigua casistica la<br />
tecnica ci sembra affidabile e sicura consentendo<br />
una soluzione del problema in maniera<br />
miniinvasiva e con ridotti tempi di degenza.<br />
Abbiamo sceto di non trattare l’ipermobilità<br />
uretrale nella stessa seduta operatoria, rimandando<br />
il trattamento allorquando, a correzione<br />
del cistocele ormai stabilizzata, l’incontinenza<br />
sia manifesta. In tale caso l’approccio con TVT<br />
Secure ® ci sembra il più appropriato in quanto<br />
questa metodica non comporta il coinvolgimento<br />
dei forami otturatori per l’attraversamento<br />
con la rete sottouretrale essendo già<br />
questi “occupati” dalle reti del Prolift A ® .<br />
Archivio Italiano di Urologia e Andrologia 2007, 79, 3, Supplemento 1 15
16<br />
<strong>7°</strong> <strong>Congresso</strong> <strong>Nazionale</strong> Associazione Italiana di Endourologia<br />
Bibliografia<br />
Debodinance P, Cosson M, Collinet P, Boukerrou M, Lucot JP, Madi<br />
N. Synthetic meshes for transvaginal surgical cure of genital prolapse:<br />
evaluation in 2005. J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris).<br />
2006 Sep; 35 (5 Pt 1):429-54.<br />
Reisenauer C, Kirschniak A, Drews U, Wallwiener D. Anatomical<br />
conditions for pelvic floor reconstruction with polypropylene implant<br />
and its application for the treatment of vaginal prolapse. Eur J<br />
Obstet Gynecol Reprod Biol. 2007 Apr; 131(2):214-25.<br />
C17<br />
NOSTRA ESPERIENZA NEL TRATTAMENTO<br />
DELL’INCONTINENZA URINARIA DA SFOR-<br />
ZO MASCHILE CON PRO-ACT<br />
G. Zeccolini, A. Celia, A. Caruso, G. Breda<br />
Struttura Complessa di Urologia, Ospedale San<br />
Bassiano, Bassano del Grappa (Vicenza)<br />
Introduzione: L’incontinenza urinaria da sforzo<br />
secondaria a intervento di prostatectomia radicale,<br />
cistectomia radicale e neovescica ortotopica o<br />
resezione endoscopica della prostata è una complicanza<br />
che disturba gravemente la qualità di<br />
vita dei pazienti affetti (1). La riabilitazione pelviperineale<br />
ha un’efficacia limitata (2); le infiltrazioni<br />
ripetute di bulking intrauretrale, indicate<br />
solo nelle forme lievi di incontinenza, hanno<br />
anch’esse un basso tasso di successo (3). Lo sfintere<br />
artificiale, che rimane ancora il “gold standard”<br />
della terapia dell’incontinenza urinaria da<br />
sforzo secondaria a deficit sfinterico, è gravato da<br />
un tasso di complicanze relativamente elevato,<br />
che il paziente non è sempre disposto ad accettare<br />
(4).<br />
Il pro-ACT (prosthesis-Adjustable Continence<br />
Therapy) è uno strumento per il trattamento dell’incontinenza<br />
urinaria da sforzo lieve-moderata<br />
da offrire come possibile alternativa alle precedenti<br />
opzioni (5)<br />
Riportiamo i risultati dell’esperienza maturata<br />
nel nostro centro nel trattamento dell’incontinenza<br />
urinaria da sforzo con pro-ACT.<br />
Materiali e Metodi: Presso l’Unità Operativa di<br />
Urologia di Bassano del Grappa sono stati effettuati<br />
dall’11/2004 al 02/2006 8 impianti di Pro-<br />
ACT.<br />
Due palloncini vengono impiantati bilateralmente<br />
in prossimità dell’anastomosi vescicouretrale<br />
dopo prostatectomia radicale o neovescica<br />
ortotopica oppure dell’apice prostatico dopo<br />
TURP, per via percutanea perineale, sotto controllo<br />
fluoroscopico. Apposite porte in titanio<br />
collegate a ciascun palloncino vengono inserite<br />
nello scroto e restano accessibili per le regola-<br />
Archivio Italiano di Urologia e Andrologia 2007, 79, 3, Supplemento 1<br />
zioni. Il volume dei palloncini può essere regolato<br />
separatamente in qualsiasi momento durante<br />
e dopo l’intervento chirurgico con l’ausilio di<br />
un ago in anestesia topica. I due palloncini producono<br />
una compressione parauretrale bilaterale<br />
e, aumentando il volume dei palloncini, si<br />
raggiunge un equilibrio ottimale tra svuotamento<br />
e continenza.<br />
Risultati: L’età media degli 8 pazienti maschi trattati,<br />
al momento dell’impianto era 71 anni (range<br />
67-83).<br />
Tutti i Pazienti erano affetti da incontinenza urinaria<br />
da sforzo secondaria a deficit sfinterico. Il<br />
VLPP medio era di 40.5 cmH2O (range 30- 50<br />
cmH2O). Il numero medio di panni/die usati era<br />
di 3 (range 2-5). L’incontinenza urinaria era esito<br />
di resezione endoscopica di prostata in 1 paziente,<br />
di adenomectomia prostatica secondo Millin<br />
in 1 paziente, di prostatectomia radicale per eteroplasia<br />
prostatica in 5 pazienti (stadio patologico<br />
pT2), di cistectomia radicale e confezionamento<br />
di neovescica ileale ortotopica (VIP) in 1<br />
paziente (stadio pT0).<br />
Tutti i pazienti erano stati prima sottoposti a<br />
fisiochinesiterapia del piano pelvico senza beneficio.<br />
In 7 pazienti, essendoci una componente di<br />
“urgency incontinence”, era stata tentata la terapia<br />
anticolinergica per almeno 3 mesi, senza sortire<br />
miglioramento dell’incontinenza.<br />
Il numero medio dei riempimenti effettuati per<br />
raggiungere un adeguato livello di continenza è<br />
stato di 5.2 (range 2- 8).<br />
La risposta è stata valutata prevalentemente in<br />
base alla riduzione del numero di pannolini/die<br />
utilizzati.<br />
Il trattamento ha dato esito positivo in tutti gli 8<br />
pazienti di sesso maschile trattati. 5 pazienti<br />
hanno avuto un beneficio del 100%, riacquistando<br />
la continenza completa. I rimanenti 3 hanno<br />
avuto un beneficio parziale, riducendo ad 1 il<br />
numero dei pannolini usati; 1 di questi 3 pazienti,<br />
affetto da deficit sfinterico in esiti di TURP, pur<br />
riportando un miglioramento significativo dell’incontinenza<br />
(riducendo da 5 a 1 il numero dei<br />
panni usati), ha richiesto l’impianto di uno sfintere<br />
artificiale. Il follow-up medio disponibile è<br />
di 27.4 mesi. 1 paziente, dopo 24 mesi di beneficio,<br />
ha presentato una recidiva dell’incontinenza<br />
in forma lieve, che è stata trattata e risolta con<br />
l’ulteriore riempimento dei dispositivi con 1 cc<br />
di liquido bilateralmente.<br />
Conclusioni: Il Pro-ACT, nella nostra esperienza,<br />
ha dato una soddisfazione “insperata” nel trattamento<br />
di una tipologia di pazienti per i quali ci<br />
sarebbe ben poco altro da fare. La procedura è
elativamente semplice, riproducibile e, al<br />
momento, scevra da complicanze. L’ effetto sembra<br />
duraturo e “aggiustabile” nel tempo, sulla<br />
base dei follow-up medio-lunghi riportati dalla<br />
letteratura e dalla nostra esperienza.<br />
Bibliografia<br />
1. Majoras A. Neurourology and Urodynamics 25:2-7 (2006).<br />
2. Steineck G. New England J2002; 34:790-6.<br />
3. Lightner DJ. Curr Opin Urol 2002.<br />
4. Gregori A. J Urol 2006 Nov; 176 (5):965-9.<br />
5. Hubner WA. BJU Int. 2005 Sep; 96 (4):587-94.<br />
C18<br />
LO SCOLLAMENTO IDRAULICO DELLA FA-<br />
SCIA PELVICA NELLA PROSTATECTOMIA<br />
RADICALE NERVE SPARING: RISULTATI<br />
ISTOLOGICI E FUNZIONALI<br />
M. Mari, A. Ambu, S. Guercio, F. Mangione,<br />
M. Bellina<br />
U.O.C. Urologia, P.O. di Rivoli (Torino)<br />
Obiettivi: nei pazienti sottoposti a prostatectomia<br />
radicale il rispetto dei fasci del muscolo elevatore<br />
dell’ano e della fascia pelvica, in associazione<br />
alla conservazione dei fasci vascolo-nervosi, è di<br />
notevole importanza nel favorire il recupero<br />
della continenza e della potenza sessuale.<br />
Presentiamo i risultati della tecnica di scollamento<br />
idraulico per la preparazione della fascia<br />
pelvica, in pazienti sottoposti a prostatectomia<br />
radicale seminal - nerve sparing (PRSNS), al fine<br />
di ottenere un più anatomico rispetto dei bundles<br />
neuro-vascolari.<br />
Materiali e Metodi: Dal gennaio 2006 al marzo<br />
2007, 35 pazienti selezionati con adenocarcinoma<br />
prostatico localizzato (GS < 6, PSA 21) sono stati sottoposti<br />
a PRSNS. La fascia pelvica veniva preparata<br />
attraverso i seguenti step: realizzazione di una<br />
piccola breccia sulla faccia anterolaterale della<br />
prostata in sede paramediana bilateralmente<br />
(ore 11 e 13); scollamento idraulico, mediante<br />
ago bottonuto, della fascia pelvica dalla superficie<br />
anterolaterale della prostata con soluzione<br />
fisiologica; incisione della fascia sulle 2 linee<br />
paramediane e scollamento per via smussa della<br />
prostata dalla fascia pelvica con conseguente<br />
liberazione dei bundles. I risultati sulla continenza<br />
sono stati valutati a 3 mesi dall’intervento<br />
(continenza: non necessità di assorbenti), quelli<br />
sulla funzione sessuale nei pazienti con almeno<br />
<strong>7°</strong> <strong>Congresso</strong> <strong>Nazionale</strong> Associazione Italiana di Endourologia<br />
12 mesi di follow-up, mediante questionario<br />
IIEF-5.<br />
Risultati: L’età mediana dei pazienti era 63 aa.<br />
(range 50-72 aa.). Il follow-up mediano è stato<br />
di 12 mesi (range 3-17 mesi). In tutti i pazienti<br />
è stato possibile eseguire la tecnica descritta.<br />
All’esame istologico è stato rilevato un margine<br />
positivo in 5/35 pazienti (14%), in 2/5 casi<br />
(40%) a carattere focale (< 1 mm); in nessun<br />
paziente è stata osservata progressione sierologica<br />
durante il follow-up indicato. A 3 mesi dall’intervento<br />
33/35 pazienti (94%) sono risultati<br />
continenti;. 21/35 pazienti (60%) sono risultati<br />
continenti alla rimozione del catetere vescicale.<br />
21 pazienti hanno raggiunto 12 mesi di followup;<br />
dal punto di vista della funzione sessuale 3<br />
pazienti non risultavano valutabili; 11/18<br />
pazienti valutabili (61%) avevano erezioni valide<br />
con o senza ausilio di terapia per os.<br />
Conclusioni: L’idroscollamento permette una preparazione<br />
anatomica ed agevole della fascia pelvica,<br />
senza incremento nella percentuale dei<br />
margini positivi e con agevole preservazione dei<br />
bundles neurovascolari.<br />
C19<br />
LA LITOTRISSIA ENDCOSCOPIA SOVRAPU-<br />
BICA NEL TRATTAMENTO DELLA CALCOLO-<br />
SI VESCICALE<br />
A. Porreca, M. Preite, M. Frigo, V. Alfano,<br />
C. Tallarigo<br />
Polo Ospedaliero dell’Est Veronese, San Bonifacio<br />
(Verona)<br />
Introduzione: Il trattamento della litiasi vescicale<br />
è oggi essenzialmente costituito dalla cistolitotomia<br />
e dalla litotrissia endoscopica trans-uretrale.<br />
La cistolitotomia presenta lo svantaggio di una<br />
cateterizzazione prolungata e la necessità di<br />
dover eseguire un’adenomectomia chirurgica in<br />
caso di intervento disostruttivo contestuale. La<br />
litotrissia endoscopica trans-uretrale è spesso un<br />
intervento lungo specialmente in caso di litiasi<br />
multipla o voluminosa. La litotrissia endoscopica<br />
sovrapubica, rappresenta un buon compromesso<br />
tra la cistolitotomia e la litotrissia transuretrale<br />
superando gli svantaggi che ciascuna<br />
delle due tecniche presenta.<br />
Pazienti e Metodi: l’intervento inizia con il posizionamento<br />
di un trocar di Reuter sovrapubico<br />
che, su guida, viene sostituito con una camicia<br />
di Amplatz da 30 Ch che permette il passaggio<br />
di un cistonefroscopio per la litotrissia e la successiva<br />
estrazione di frammenti. Se alla litotrissia<br />
Archivio Italiano di Urologia e Andrologia 2007, 79, 3, Supplemento 1 17
18<br />
<strong>7°</strong> <strong>Congresso</strong> <strong>Nazionale</strong> Associazione Italiana di Endourologia<br />
segue una TURP la camicia di Amplatz svolge il<br />
ruolo di trocar per mantenere la pressione endovescicale<br />
bassa e permette anche il passaggio di<br />
frammenti di tessuto resecato. Alla fine dell’<br />
intervento si posiziona una cistostomia 16 Ch da<br />
rimuovere in prima giornata post-operatoria. Se<br />
il paziente ha eseguito anche un’Amplatz-TURP<br />
si posiziona un catetere trans-uretrale con lavaggio<br />
continuo. Dal Gennaio 2002 al Giugno 2007<br />
sono stati sottoposti a litotrissia endoscopica<br />
sovrapubica 25 pazienti. 19 pazienti sono stati<br />
sottoposti contestualmente ad Amplatz-TURP e<br />
1 a TUIP. 15 pazienti presentavano una calcolosi<br />
multipla e 10 pazienti una calcolosi singola.<br />
Risultati: La durata media dell’intervento di litotrissia<br />
è stata 21 min (15-36) in caso di calcolosi<br />
singola e 46 min (30-125) per calcolosi multiple.<br />
Nei pazienti sottoposti a TURP è stata osservata<br />
una durata media di 36 min superiore. Non si<br />
sono verificate complicanza maggiori intra e<br />
post-opertaorie. 24/25 (96%) pazienti hanno<br />
ottenuto uno stone-free con una sola procedura.<br />
In un caso di calcolosi multipla a stampo della<br />
vescica è stata eseguita una litotrissia in due<br />
tempi con TURP a completamento della seconda<br />
procedura. La dimissione è avvenuta in 3° giornata<br />
post-operatoria con tempo di cateterizzazione<br />
transuretrale di 2 giorni e lavaggio post-operatorio<br />
di 24 ore nei pazienti sottoposti a TURP.<br />
I pazienti sottoposti alla sola litotrissia sono stati<br />
dimessi in 1° giornata post-operatoria.<br />
Conclusioni: L’uso della camicia di Amplatz rende<br />
rapida la frammentazione dei calcoli e agevola<br />
l’estrazione dei frammenti. La possibilità di eseguire<br />
una TURP permette di risolvere in un<br />
unico intervento la calcolosi vescicale e l’ostruzione<br />
cervico-uretrale che l’ha causata. La litotrissia<br />
endoscopica sovrapubica con camicia di<br />
Amplatz permette di affrontare ogni tipo di litiasi<br />
vescicale associata ad ogni volume di adenoma<br />
prostatico lasciando alla chirurgia tradizionale<br />
solo rari casi di calcoli singoli o multipli a stampo<br />
della vescica e calcoli associati ad adenomi<br />
prostatici > di 120 ml.<br />
C20<br />
PSEUDODIVERTICOLO DELL’URETERE PEL-<br />
VICO E POSSIBILITÀ DI TRATTAMENTO<br />
ENDOUROLOGICO: CASE REPORT E REVI-<br />
SIONE DELLA LETTERATURA<br />
M. Zanin, L. Ruggera, F. Gigli, P. Beltrami, M.A.<br />
Cerruto, D. Schiavone, F. Zattoni<br />
Divisione Clinicizzata di Urologia, Policlinico “G.B.<br />
Rossi”, Verona<br />
Archivio Italiano di Urologia e Andrologia 2007, 79, 3, Supplemento 1<br />
Introduzione e Obiettivi: Il diverticolo ureterale<br />
rappresenta una rara anomalia della parete dell’uretere:<br />
in letteratura sono stati riportati, a partire<br />
dalla loro prima descrizione nel 1957, poco<br />
meno di 80 casi. Il diverticolo ureterale, in base<br />
alle caratteristiche anatomo-patologiche, è più<br />
frequentemente definito come pseudodiverticolo,<br />
essendo delimitato da tutti gli strati propri<br />
della parete ureterale.<br />
Presentiamo il caso di un diverticolo dell’uretere<br />
pelvico associato a doppia stenosi ureterale,<br />
trattato mediante ureteroscopia ed incisione con<br />
holmium:YAG (Ho:YAG) laser.<br />
Case Report: B.G., maschio di 42 anni, con<br />
riscontro ecografico occasionale di idroureteronefrosi<br />
sinistra, esegue un’urografia documentante<br />
la presenza di una estroflessione sacciforme<br />
a livello dell’uretere pelvico di sinistra, confermata<br />
all’ureteropielografia retrograda. Viene<br />
sottoposto ad ureteroscopia durante la quale si<br />
evidenzia la presenza di una doppia stenosi ureterale<br />
con, interposto, un ampio diverticolo ureterale<br />
a sviluppo postero-laterale. Si esegue incisione<br />
laser delle stenosi ureterali e del colletto<br />
diverticolare, ottenendo una ampia apertura del<br />
lume dell’uretere e dello sbocco del diverticolo e<br />
si lascia in sede uno stent doppio J.<br />
L’ureteropielografia retrograda e l’ureteroscopia<br />
di controllo eseguite a 30 giorni documentano la<br />
netta riduzione della cavità diverticolare con<br />
persistenza di una minima estroflessione.<br />
Un’urografia a 2 mesi conferma tale dato ed evidenzia<br />
la risoluzione della idroureteronefrosi.<br />
L’esame citologico delle urine eseguito a 3 mesi<br />
è risultato negativo.<br />
Risultati: I diverticoli ureterali sono spesso diagnosticati<br />
incidentalmente durante una ecografia<br />
di routine. Il sospetto di tale alterazione è<br />
posto sulla base di un’urografia o una ureteropielografia<br />
retrograda, dove essi appaiono come<br />
piccole estroflessioni sacciformi della parete ureterale,<br />
istologicamente caratterizzate da iperplasia/metaplasia<br />
uroteliale. Possono essere singoli<br />
o più frequentemente multipli (90% dei casi),<br />
unilaterali o bilaterali, e sono localizzati per lo<br />
più a livello del terzo medio-superiore dell’uretere.<br />
È stata documentata una frequente associazione<br />
tra pseudodiverticoli e neoplasie transizionali,<br />
soprattutto in presenza di multiple estroflessioni.<br />
Per tale motivo il diverticolo ureterale<br />
viene spesso considerato come un fattore di<br />
rischio per neoplasia transizionale, precedendola<br />
anche di 10 anni. È per tale motivo raccomandato<br />
un follow-up con esecuzione semestrale<br />
di esame delle urine e citologie urinarie.
Conclusioni: L’incisione laser per via retrograda<br />
è risultata a nostro parere una valida alternativa<br />
terapeutica nel caso descritto. Rimane<br />
comunque indispensabile uno stretto e prolungato<br />
follow-up per quanto riguarda l’evoluzione<br />
sia delle iniziali stenosi sia del diverticolo<br />
ureterale, in considerazione dell’elevata associazione<br />
di tale patologia con forme maligne.<br />
C21<br />
CISTOSCOPIA FLESSIBILE CON SISTEMA<br />
ENDOSHEATH SLIDE-ON, L’OTTIMIZZAZIO-<br />
NE DELL’USO DEGLI ENDOSCOPI FLESSIBILI<br />
A. Porreca, M. Preite, M. Frigo, V. Alfano, C.<br />
Tallarigo<br />
Polo Ospedaliero dell’Est Veronese, San Bonifacio<br />
(Verona)<br />
Introduzione: la cistoscopia flessibile è oggi una<br />
metodica di ampio utilizzo in urologia. Alcuni<br />
centri non eseguono cistoscopie flessibili poiché<br />
non dispongono di un numero di strumenti<br />
congruo o perché la sterilizzazione degli<br />
stessi è lunga e complessa. Il sistema<br />
EndoSheath slide-on annulla, ogni problematica<br />
di sterilizzazione o di approvvigionamento<br />
degli strumenti permettendo così a qualsiasi<br />
centro di endoscopia di poter eseguire routinariamente<br />
cistoscopie flessibili.<br />
Metodica: il sistema è costituito da due componenti:<br />
il cistoscopio e la guaina. Il cistoscopio<br />
flessibile CST-2000 Vision Sciences è privo di<br />
canali e ha una forma a D che si adatta alla<br />
guaina formando un ovale di 4.6 X5.6 mm. La<br />
guaina (EndoSheath) monouso è costituita da<br />
un raccordo rigido in plastica che la fissa al<br />
cistoscopio e ha un canale operatore interno di<br />
2,1 mm in poliestere intrecciato che corre<br />
lungo tutto lo strumento e permette il flusso di<br />
acqua e il passaggio di strumenti. La punta<br />
della guaina dispone di una finestra ottica che<br />
aderendo perfettamente alla punta del cistoscopio<br />
permette una visione ottimale.<br />
Risultati: presso il nostro centro di endoscopia<br />
abbiamo eseguito dall’Ottobre 2006 al Giugno<br />
2007 240 procedure con questa tecnica. Non<br />
abbiamo riscontrato alcuna complicanza e la<br />
procedura si è dimostrata ben tollerata da tutti<br />
i pazienti. La necessaria confidenza con la strumentazione<br />
viene raggiunta dopo un numero<br />
esiguo di procedure sia da parte dell’operatore<br />
che da parte dell’assistente infermieristico.<br />
Nella nostra esperienza il dispositivo lascia<br />
intatti tutti i vantaggi della cistoscopia flessibi-<br />
<strong>7°</strong> <strong>Congresso</strong> <strong>Nazionale</strong> Associazione Italiana di Endourologia<br />
le aggiungendone altri: 1. La sicurezza per il<br />
paziente di un sistema completamente monouso<br />
che azzera ogni possibilità di rischio infettivo.<br />
2. L’abbandono di qualsiasi dispositivo di<br />
sterilizzazione potenzialmente tossico per gli<br />
operatori e dannoso per gli strumenti. 3.<br />
L’assenza di pause durante il lavoro per la sterilizzazione<br />
degli strumenti, con aumento della<br />
produttività e riduzione della necessità di personale<br />
per la rigenerazione degli strumenti. 4.<br />
La possibilità di eseguire con un solo strumento<br />
consecutivamente e senza interruzione tutte<br />
le procedure che si desidera eseguire. Un’ analisi<br />
dei costi appare in favore di un tale dispositivo,<br />
infatti il costo delle guaine va controbilanciato<br />
al risparmino legato alla necessità di<br />
un solo endoscopio, alla riduzione dei costi di<br />
riparazione poiché la guaina protegge lo strumento<br />
e il non uso di agenti chimici germicidi<br />
ne evita l’usura, l’assenza di costi di sterilizzazione<br />
e l’aumento delle procedure eseguibili<br />
con un personale impegnato con maggior efficienza.<br />
Conclusioni: i vantaggi esposti hanno reso presso<br />
il nostro centro la cistoscopia flessibile con<br />
sistema EndoSheath slide-on lo standard per<br />
l’endoscopia di controllo nel follow-up delle<br />
neoplasie della vescica. Riteniamo che l’utilizzo<br />
di tale dispositivo possa permettere a molti<br />
altri centri di accostarsi all’ uso routinario della<br />
cistoscopia flessibile con i numerosi vantaggi<br />
che ciò comporta per il paziente.<br />
Video Aula Rossa<br />
18 Setttembre 08.00-09.00<br />
Laparoscopia 1<br />
V7<br />
PIELOPLASTICA LAPAROSCOPICA SINISTRA<br />
TRANSMESENTERICA CON ACCESSO DIRET-<br />
TO ALLA GIUNZIONE PIELO-URETERALE<br />
F. Porpiglia, M. Billia, J. Renard, I. Morra,<br />
M. Poggio, C. Scoffone, D. Vaccino, F. Ragni e<br />
R.M. Scarpa<br />
Università di Torino, Divisione Universitaria di<br />
Urologia, Ospedale San Luigi (Orbassano)<br />
Introduzione e Obiettivi: La pieloplastica laparoscopica<br />
transperitoneale sinistra viene generalmente<br />
eseguita mediante mobilizzazione del<br />
colon discendente. Tale manovra non permette<br />
sempre un'ottima esposizione dei reperi anatomici.<br />
Per ottenere un accesso diretto alla giunzione<br />
pielo-ureterale (GPU) ed evitare tale<br />
Archivio Italiano di Urologia e Andrologia 2007, 79, 3, Supplemento 1 19
20<br />
<strong>7°</strong> <strong>Congresso</strong> <strong>Nazionale</strong> Associazione Italiana di Endourologia<br />
manovra é possibile incidere il peritoneo viscerale<br />
posteriore in corrispondenza dello spazio<br />
mesenterico-colico. In questo video presentiamo<br />
un caso di pieloplastica transperitoneale<br />
laparosopica con un accesso diretto alla GPU.<br />
Metodi: Il paziente viene posizionato in un<br />
decubito laterale a 45°. Si induce pneumoperitoneo<br />
e vengono inseriti 3 trocars. Il piccolo<br />
intestino viene medializzato, la flessura colica<br />
viene sollevata esponendo così lo spazio<br />
mesenterico-colico sinistro. Si identificano: la<br />
vena mesenterica inferiore, la vena gonadica e<br />
l'uretere al di sotto del peritoneo. L'incisione<br />
del peritoneo viene praticata in una zona avascolare<br />
parallelamente e lateralmente alla vena<br />
mesenterica inferiore ed alla vena gonadica, tra<br />
l'arteria colica media e l’arteria colica sinistra<br />
creando un accesso al retroperitoneo. I piccoli<br />
vasi mesocolici vengono clippatti e sezionati. Si<br />
identificano l'uretere, la GPU e la pelvi che<br />
vengono dissecati. Per facilitare tale manovra,<br />
il margine superiore dell'incisione viene sospeso<br />
con un punto alla parete addominale laterale.<br />
La GPU viene sezionata e l'uretere viene<br />
spatulato. Si esegue pieloplastica sec.<br />
Anderson-Hynes con 2 suture continue. Prima<br />
di completare l'anastomosi viene inserito un<br />
doppio J. Per dare maggiore sicurezza, l'anastomosi<br />
viene ricoperta da 2 ml di colla di<br />
fibrina (Tissucol ® ). Il peritoneo posteriore<br />
viene ricostruito con 3 punti.<br />
Risultati: La procedura è durata 2 ore. Non<br />
sono state registrate complicanze.<br />
Conclusioni: L’accesso diretto alla GPU attraverso<br />
lo spazio mesenterico-colico rappresenta<br />
un'opzione all’accesso transperitoneale standard<br />
e dovrebbe essere preso in considerazione<br />
in tutti i pazienti con malattia giuntale, specialmente<br />
in presenza di soggetti magri e con pelvi<br />
distesa.<br />
V8<br />
PIELOPLASTICA SECONDO ANDERSON<br />
HYNES LAPAROSCOPICA ASSISTITA DAL<br />
ROBOT DA VINCI<br />
G.M. Ludovico, G.D. Vestita, G. Cardo,<br />
G. Pagliarulo 1 , M. Erinnio, F.P. Maselli, E. Restini 1<br />
Dipartimento delle Specialità Chirurgiche, Unità<br />
Operativa di Urologia Ospedale “S. Giacomo”<br />
Monopoli, Bari; 1 Dipartimento di Chirurgia Generale<br />
Mininvasiva e Robotica “La Madonnina” Bari<br />
Il video presenta le varie fasi della tecnica chirurgica<br />
laparoscopica della pieloplastica secon-<br />
Archivio Italiano di Urologia e Andrologia 2007, 79, 3, Supplemento 1<br />
do Anderson Hynes, assistita dal robot Da<br />
Vinci nella fase di ricostruzione.<br />
La morbilità postoperatoria, associata alle incisioni<br />
della chirurgia open, ha condotto, alla<br />
esplorazione di numerose procedure endoscopiche<br />
miniinvasive di endopielotomia anterograda<br />
e retrograda.<br />
Tali procedure chirurgiche offrono buoni risultati<br />
di successo (70-80%), ma non comparabili<br />
con quelli ottenuti con la pieloplastica secondo<br />
Anderson Hynes .<br />
La pieloplastica secondo Anderson Hynes eseguita<br />
per via laparoscopica consente di ottenere<br />
gli stessi risultati della chirurgia open, per<br />
quanto riguarda la rimozione dell’ostruzione e<br />
della sintomatologia, mediante un accesso<br />
miniinvasivo.<br />
Il sistema della chirurgia laparoscopica assistita<br />
dal Robot Da Vinci consente una più precisa<br />
ed efficiente sutura, superando i limiti della<br />
sutura laparoscopica che rappresentano uno<br />
dei maggiori impedimenti alla diffusione della<br />
tecnica.<br />
Il Da Vinci consente, infatti, nelle fasi ricostruttive<br />
una maggior precisione, rispetto alla<br />
tecnica laparoscopica, per i vantaggi offerti dal<br />
sistema che offre la possibilità di usufruire di<br />
multipli gradi di libertà dei movimenti, con<br />
conseguente maggiore articolazione degli stessi,<br />
oltre ad una visione tridimensionale magnificata<br />
del campo operatorio.<br />
La pieloplastica laparoscopica robot assistita<br />
nonostante il breve follow up rappresenta una<br />
tecnica sicura ed efficiente con una più precoce<br />
curva di apprendimento<br />
V9<br />
CORREZIONE LAPAROSCOPICA DI FISTOLA<br />
VESCICO-VAGINALE<br />
VIDEO<br />
F. Porpiglia, I. Morra, A. Volpe, M. Billia,<br />
R.M. Scarpa<br />
Divisione Universitaria di Urologia, Dipartimento di<br />
Scienze Cliniche e Biologiche, Ospedale San Luigi,<br />
Orbassano (Torino)<br />
Introduzione: L’isterectomia è la causa principale<br />
di fistola vescica-vaginale (FVV), la cui incidenza<br />
risulta pari a 1/1800 procedure e sino ad<br />
oggi, sono state descritte numerose tecniche<br />
per la correzione delle FVV. L’approccio open<br />
presenta efficacia dell’85-100% in base alla<br />
sede della fistola, similmente alla tecnica transvaginale,<br />
che però presenta minore morbilità,
ma è poco indicata per le fistole alte, la cui correzione<br />
risulta difficoltosa.<br />
La laparoscopia viene sempre più frequentemente<br />
impiegata per il trattamento di patologie<br />
complesse quali la FVV ed attualmente in letteratura<br />
sono stati riportati 31 correzioni di<br />
FVV, eseguite con tecniche differenti..<br />
Materiali e Metodi: In questo video descriviamo<br />
la tecnica di correzione laparoscopica di FVV<br />
da noi utilizzata in 3 pazienti consecutive.<br />
La procedura si articola in 3 fasi: escissione<br />
della fistola per via trans-vescicale, ricostruzione<br />
della vescica e della parete vaginale, interposizione<br />
di omento peduncolarizzato tra le<br />
due pareti.<br />
Con la paziente in posizione litotomica dorsale,<br />
si introducono 5 trocar con disposizione a<br />
ventaglio, si liberano le aderenze esito della<br />
pregressa isterectomia e si incide il peritoneo<br />
posteriore. Si separa la base della vescica dalla<br />
parete vaginale anteriore, quindi si apre la<br />
parete vescicale e si identifica l’orifizio fistoloso<br />
a livello del trigono vescicale. Si incide la<br />
cupola vaginale e si reseca il tramite fistoloso;<br />
si prepara quindi la parete vaginale che viene<br />
suturata con vicryl 0. Si sutura la parete vescicale<br />
in doppio strato con vicryl 2-0 e si interpone<br />
l’omento che viene fissato con un punto<br />
alla parete vaginale.<br />
Si completa l’intervento con la ricostruzione<br />
del peritoneo posteriore.<br />
Risultati: Nessuna complicanza è stata registrata<br />
ed il tempo medio di cateterizzazione è risultato<br />
8.2 giorni (7-12). La cistografia retrograda<br />
ed i controlli postoperatori hanno documentato<br />
la completa guarigione nel 100% dei casi.<br />
Conclusioni: Sulla base dei risultati ottenuti e<br />
dell’analisi della letteratura riteniamo che la<br />
correzione laparoscopica di FVV, grazie alla<br />
scarsa invasività e morbilità, rappresenti una<br />
valida opzione rispetto alle tecniche aperte tradizionali.<br />
V10<br />
ADENOMECTOMIA PROSTATICA LAPARO-<br />
SCOPICA EXTRAPERITONEALE<br />
A. Celia, G. Zeccolini, G. Breda<br />
Struttura Complessa di Urologia, Ospedale San<br />
Bassiano, Bassano del Grappa (Vicenza)<br />
Scopo: Lo scopo di questo video è di presentare<br />
“step by step” la nostra tecnica di adenomectomia<br />
prostatica laparoscopica con accesso<br />
extraperitoneale.<br />
<strong>7°</strong> <strong>Congresso</strong> <strong>Nazionale</strong> Associazione Italiana di Endourologia<br />
Materiali e Metodi: L’intervento inizia con la<br />
preparazione dello spazio extraperitoneale ed il<br />
posizionamento dei trocar operativi secondo lo<br />
schema abituale. Si prepara la loggia prostatica<br />
liberandola dal grasso periprostatico. Si isola<br />
successivamente il piano anteriore del collo<br />
vescicale scivolando sul margine convesso prostatico.<br />
Si apre anteriormente il collo vescicale<br />
e si incide la mucosa sul labbro posteriore dello<br />
stesso. Per questa via si scolla agevolmente il<br />
versante posteriore dell’adenoma dalla capsula.<br />
L’adenomectomia prostatica viene completata<br />
seguendo il piano dell’adenoma postero-lateralmente<br />
ed anteriormente. L’enucleazione<br />
strumentale dell’adenoma è possibile con minime<br />
perdite ematiche se si procede sul piano<br />
corretto, senza forzature e con l’impiego mirato<br />
dell’elettrobisturi.<br />
Giunti all’estremità distale, si incide sotto visione<br />
l’uretra in prossimità del veru montanum.<br />
Successivamente si migliora l’emostasi con<br />
coagulazioni selettive ed il passaggio di 2 punti<br />
laterali secondo l’abituale schema dell’adenomectomia<br />
a cielo aperto. Si esegue inoltre la<br />
cosiddetta “retrigonizzazione dell’uretra” con 3<br />
punti in Vycril 00. La capsula prostatica viene<br />
chiusa con sutura continua, previo posizionamento<br />
del catetere con 30-40 cc nel palloncino<br />
in loggia prostatica. L’intervento si conclude con<br />
la verifica della tenuta della sutura, l’asportazione<br />
dell’adenoma in endobag ed il posizionamento<br />
di un drenaggio tubulare nel Retzius.<br />
Discussione: Recentemente in letteratura sono<br />
state riportate in più centri esperienze di adenomectomia<br />
prostatica secondo Millin eseguita<br />
con tecnica laparoscopica. I risultati funzionali<br />
risultano sovrapponibili alla tecnica open ma i<br />
risultati complessivi sono migliorati dai vantaggi<br />
legati alla laparoscopia: mini-invasività, scarso<br />
sanguinamento e rapido recupero nel postoperatorio.<br />
Il confronto resta aperto con la Holep:<br />
entrambe le tecniche sono min-invasive e si prestano<br />
per il trattamento di grossi adenomi.<br />
Si tratta di valutare quale di queste 2 vie sia più<br />
conveniente in termini di curva di apprendimento,<br />
tempi di occupazione della sala operatoria,<br />
tempi di ospedalizzazione, complicanze,<br />
riammissioni precocci in ospedale, risultati a<br />
distanza e, ultimo ma non da meno, costi complessivi,<br />
all’interno dei quali va compreso<br />
anche il DRG che è il doppio per la Millin<br />
rispetto alla Holep!<br />
Oggi una risposta a questi dubbi ancora non<br />
c’è. L’implementazione e la diffusione della tecnica<br />
laparoscopica di rimozione dell’adenoma<br />
Archivio Italiano di Urologia e Andrologia 2007, 79, 3, Supplemento 1 21
22<br />
<strong>7°</strong> <strong>Congresso</strong> <strong>Nazionale</strong> Associazione Italiana di Endourologia<br />
prostatico vanno nella direzione giusta e ci<br />
consentiranno di dare una risposta al quesito.<br />
Conclusioni: L’adenomectomia prostatica laparoscopica<br />
extraperitoneale appare come una<br />
tecnica semplice e fattibile. Comunque ulteriori<br />
esperienze sono necessarie per stabilire il<br />
reale ruolo di questa procedura nell’ambito<br />
delle opzioni attualmente disponibili per il<br />
trattamento della ipertrofia prostatica.<br />
V11<br />
RIPARAZIONE LAPAROSCOPICA EXTRAPE-<br />
RITONEALE DI ERNIA INGUINALE<br />
A. Celia, G. Breda, G. Zeccolini<br />
Struttura Complessa di Urologia, Ospedale San<br />
Bassiano, Bassano del Grappa (Vicenza)<br />
Introduzione: La tecnica chirurgica della riparazione<br />
dell’ernia inguinale ha visto nel corso<br />
degli anni un’evoluzione dalla semplice riparazione<br />
tissutale secondo Bassini, all’impiego<br />
delle protesi per via aperta, alla riparazione<br />
laparoscopica. L’impiego della “mesh” ha ridotto<br />
il tasso di recidiva dal 15 all’1%.<br />
Obiettivi: Dimostrare in dettaglio la tecnica di<br />
riparazione laparoscopica extraperitoneale dell’ernia<br />
inguinale con mesh protesica.<br />
Materiali e Metodi: In questo video viene inizialmente<br />
descritta l’anatomia laparoscopica<br />
extraperitoneale dell’ernia inguinale diretta o<br />
indiretta e successivamente vengono evidenziati<br />
i momenti salienti dell’intervento. Creato<br />
lo spazio extraperitoneale, si identificano il<br />
sacco erniario ed il funicolo spermatico.<br />
L’intervento continua con l’isolamento e la<br />
retrazione del sacco erniario in cavità addominale<br />
dalla fossetta erniaria, ponendo particolare<br />
cura nell’evitare lesioni accidentali del peritoneo<br />
e dei vasi funicolari. Completato l’isolamento<br />
del funicolo spermatico, viene inserita a<br />
cavalcioni dello stesso una mesh di Prolene 10<br />
x 8 cm, sagomata con una particolare forma<br />
allo scopo di evitarne il dislocamento. La tecnica<br />
di modellaggio, posizionamento e fissaggio<br />
della mesh è sostanzialmente analoga per<br />
entrambi i tipi di ernia. Il tempo impiegato per<br />
la riparazione laparoscopica dell’ernia è di circa<br />
45 min. L’intervento si conclude con il posizionamento<br />
di un drenaggio in aspirazione<br />
per 12 ore nel Retzius al fine di evitare raccolte<br />
ematiche, potenziale causa di infezioni.<br />
Discussione: Nella nostra esperienza la riparazione<br />
laparoscopica extraperitoneale dell’ernia<br />
inguinale, eseguita in associazione ad altra<br />
Archivio Italiano di Urologia e Andrologia 2007, 79, 3, Supplemento 1<br />
patologia urologica, si è dimostrata una procedura<br />
semplice ed efficace e con un tasso di recidiva<br />
dello 0%.<br />
Riteniamo che l’urologo debba possedere nel<br />
suo armamentario chirurgico la tecnica di riparazione<br />
dell’ernia, open e/o laparoscopica,<br />
derivata dalla conoscenza e dalla competenza<br />
chirurgica della pelvi. Il nostro pensiero viene<br />
supportato dall’esperienza consolidata di molti<br />
centri urologici europei che eseguono tale procedura<br />
routinariamente. Ricordiamo inoltre<br />
che le linee guida dell’EAU, proposte nel 2002,<br />
presentano la “Laparoscopic Hernia Repair”<br />
come una procedura ad alto livello di raccomandazione<br />
(A).<br />
Conclusioni: La riparazione laparoscopica extraperitoneale<br />
con mesh rappresenta una opzione<br />
valida, rapida e sicura nel trattamento dell’ernia<br />
inguinale.<br />
Video Aula Arancione<br />
18 SETTEMBRE 08.00-09.00<br />
Laparoscopia 2<br />
V12<br />
CISTECTOMIA PARZIALE ENDO-LAPARO-<br />
SCOPICA PER ENDOMETRIOSI VESCICALE<br />
L. Carmignani, G. Aimi 1 , P. Vercellini 1 , M. Spinelli 2 ,<br />
G. Bozzini 2 , R. Anceschi 2 , F. Rocco 2 , L. Fedele 1<br />
UO Urologia IRCCS Policlinico San Donato (Milano);<br />
2 UO Urologia; 1 UO Ginecologia Ostetricia IRCCS<br />
Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regine<br />
Elena (Milano)<br />
Introduzione: La reale incidenza dell’endometriosi<br />
nella popolazione generale è poco definita;<br />
il gruppo italiano per l’endometriosi ritiene<br />
il riscontro del 12% di endometriosi pelvica in<br />
corso di chirurgia per fibromi uterini, un dato<br />
applicabile alla popolazione generale.<br />
Il coinvolgimento del tratto urinario in corso di<br />
endometriosi è un evenienza molto rara, stimata<br />
nell’ordine dello 0,5-1% dei casi totali di<br />
endometriosi.<br />
L’endometriosi vescicale descritta per la prima<br />
volta da Judd nel 1920, costituisce circa l’80%<br />
di tutte le localizzazioni della malattia a livello<br />
del tratto urinario, mentre l’endometriosi ureterale<br />
(Cullen 1917) circa il 10%; molto più rare<br />
sono le localizzazioni renali, uretrali e vaginali.<br />
Descrizione della tecnica: Presentiamo in questo<br />
video un tecnica chirurgica combinata endoscopica<br />
laparoscopica per l’esecuzione di<br />
cistectomia parziale nel trattamento dell’endo-
metriosi vescicale. Successivamente al posizionamento<br />
dei trocar operativi ed all’induzione<br />
del pneumoperitoneo si procede alla repertazione<br />
dell’utero e degli annessi. Si procede<br />
quindi con l’ausilio della pinza bipolare alla<br />
creazione del piano vescico uterino con liberazione<br />
della parete posteriore della vescica. Si<br />
passa quindi al tempo endoscopico eseguito<br />
con resettore ed ottica 0°. Con l’ansa viene<br />
delimitato il nodulo endometriosico lasciando<br />
almeno 5 mm. di tessuto sano perilesionale;<br />
successivamente si approfondisce l’exeresi fino<br />
al pericistio. Il perfezionamento della cistectomia<br />
parziale avviene con l’asportazione della<br />
lesione per via laparoscopica con forbici monopolari.<br />
Al termine del tempo demolitivo, la sintesi<br />
dei margini di resezione si ottiene in duplice<br />
strato (mucosa-detrusore, detrusore-pericistio)<br />
con due suture continue di Vicryl 2/0. Il<br />
controllo della tenuta idraulica del reservoir<br />
vescicale avviene per via endoscopica.<br />
Discussione: Solitamente i casi di endometriosi<br />
vescicale di dimensioni considerevoli e le localizzazioni<br />
ureterali richiedono, per essere efficacemente<br />
e definitivamente trattati, l’approccio<br />
chirurgico.<br />
Il razionale della terapia chirurgica dell’endometriosi<br />
urinaria risiede nel fatto che una completa<br />
exeresi della malattia in un’unica procedura chirurgica,<br />
riduce in maniera statisticamente significativa<br />
la sintomatologia dolorosa e disfunzionale<br />
e previene le recidive. Il trattamento dell’endometriosi<br />
vescicale rimane comunque dettato<br />
dall’età dalla paziente, dal suo stato di salute<br />
generale, dal suo desiderio riproduttivo, dalla<br />
severità dei sintomi e dalla localizzazione della<br />
lesione; comprende sia opzioni mediche che<br />
chirurgiche; il trattamento deve quindi essere<br />
personalizzato e multidisciplinare.<br />
Conclusioni: La tecnica combinata endoscopica<br />
laparoscopica di cistectomia parziale per endometriosi<br />
vescicale consente una soddisfacente<br />
radicalità con buon esito curativo. A tale caratteristica,<br />
raggiungibile anche nell’approccio<br />
open, va sommata la mininvasività e la migliore<br />
tollerabilità, tipiche degli interventi endolaparoscopici.<br />
V13<br />
DIVERTICULECTOMIA VESCICALE LAPARO-<br />
SCOPICA EXTRAPERITONEALE<br />
A. Celia, G. Zeccolini, G. Breda<br />
Struttura Complessa di Urologia, Ospedale San<br />
Bassiano, Bassano del Grappa (Vicenza)<br />
<strong>7°</strong> <strong>Congresso</strong> <strong>Nazionale</strong> Associazione Italiana di Endourologia<br />
Introduzione: Il riscontro di un diverticolo<br />
vescicale è spesso occasionale, in corso di indagini<br />
eseguite per una sintomatologia disurica<br />
da ostruzione cervico-uretrale.<br />
L’indicazione al trattamento è legata alla presenza<br />
di infezione urinaria, calcoli o tumori<br />
endodiverticolari.<br />
Negli ultimi anni la letteratura ha dimostrato<br />
come l’approccio “Endo-Laparoscopico”, combinando<br />
la diverticulectomia laparoscopica con<br />
la resezione endoscopica della prostata, sia<br />
superiore all’approccio open per via del minore<br />
sanguinamento intraoperatorio, della minore<br />
somministrazione di farmaci antalgici e<br />
durata del ricovero.<br />
Materiale e Metodi: In questo video presentiamo<br />
i momenti salienti dell’intervento.<br />
Dopo aver eseguito la enucleazione endoscopica<br />
di 2 piccoli lobi prostatici con Laser Tulio, si<br />
prosegue in laparoscopia con accesso extraperitoneale.<br />
Successivamente si isola il diverticolo<br />
vescicale in sede posterolaterale destra.<br />
L’isolamento viene facilitato dalla distensione<br />
endoscopica del diverticolo.<br />
Dopo aver completato l’isolamento diverticolare,<br />
spegnendo la luce del laparoscopio, si evidenzia<br />
per trasparenza la luce intradiverticolare<br />
emessa dal resettore, a ulteriore facilitazione<br />
della manovra. Si incide per via endoscopica il<br />
colletto diverticolare con laser Tulio, e per via<br />
laparoscopica si completa l’escissione seguendo<br />
tale linea.<br />
Si completa l’asportazione del diverticolo. La<br />
breccia vescicale viene suturata in duplice strato:<br />
in continua lo strato mucoso ed in punti<br />
staccati lo strato detrusoriale-pericistico.<br />
L’intervento si conclude con il controllo della<br />
tenuta della sutura, il posizionamento di un<br />
drenaggio tubulare nel Retzius e la rimozione<br />
in endobag del diverticolo vescicale e dei lobi<br />
prostatici precedentemente enucleati.<br />
Risultati: Il tempo operatorio è di 2,5 ore e le<br />
perdite ematiche sono non significative (< di<br />
100 cc). Il catetere è stato rimosso in VIII giornata<br />
dopo il controllo cistografico risultato<br />
negativo per spandimenti del m.d.c.<br />
Conclusioni: La simultanea enucleazione endoscopica<br />
della prostata con Laser Tulio e la<br />
diverticulectomia laparoscopica extraperitoneale<br />
si è dimostrata una efficace strategia nel<br />
trattamento della ipertrofia prostatica benigna<br />
associata a voluminoso diverticolo vescicale.<br />
Tale combinazione consente inoltre la rimozione<br />
degli interi lobi prostatici enucleati con il<br />
Laser, risparmiando così l’uso del morcellatore.<br />
Archivio Italiano di Urologia e Andrologia 2007, 79, 3, Supplemento 1 23
24<br />
<strong>7°</strong> <strong>Congresso</strong> <strong>Nazionale</strong> Associazione Italiana di Endourologia<br />
V14<br />
PROSTATECTOMIA LAPAROSCOPICA EXTRA-<br />
PERITONEALE ROBOT ASSISTITA: EVOLUZIO-<br />
NE DALLA TECNICA EXTRAFASCIALE A QUEL-<br />
LA INTRAFASCIALE<br />
G.M. Ludovico, G.D. Vestita, G. Cardo,<br />
G. Pagliarulo 1 , M. Erinnio, F. P. Maselli, E. Restini 1<br />
Dipartimento delle Specialità Chirurgiche, Unità<br />
Operativa di Urologia Ospedale “S. Giacomo” Monopoli,<br />
Bari; 1 Dipartimento di Chirurgia Generale Mininvasiva e<br />
Robotica “La Madonnina”, Bari<br />
Introduzione e Obiettivi: La tecnica della prostatectomia<br />
laparoscopica robotica per i pazienti<br />
con cr prostatico di recente ha assunto notevole<br />
interesse.<br />
Riportiamo di seguito la nostra esperienza con il<br />
da Vinci ® Robotic Surgical System (Intuitive<br />
Surgical, Inc., Sunnyvale, CA, USA) utilizzando<br />
l’accesso extraperitoneale.<br />
Materiali e Metodi: 50 pazienti sono stati sottoposti<br />
a prostatectomia laparoscopica robot assistita<br />
da ottobre 2005 a aprile 2007 per via extraperitoneale<br />
nel Dipartimento di Chirurgia Generale<br />
Mininvasiva e Robotica “La Madonnina” di Bari.<br />
In 39 casi si è utilizzata la tecnica extrafasciale ed<br />
in 11 casi si è adottata la procedura intrafasciale.<br />
Età media 65 anni (range 51-75), valore medio<br />
del PSA preoperatorio di 7.3 ng/mL (range 2.3 -<br />
18,4), gleason score medio 6 (4-9).<br />
Risultati: Tempo operativo effettivo medio è stato<br />
di 220 min (range 120-400), la perdita media di<br />
sangue intraopoeratoria è stata di 230 cc, l’emotrasfusione<br />
si è utilizzata in 12 paz soprattutto<br />
nella fase iniziale.<br />
In tre pazienti si è avuta conversione a cielo aperto<br />
di cui uno per problemi tecnici alla consolle.<br />
Rimozione drenaggio in terza e catetere vescicale<br />
in settima giornata post operatoria.<br />
Follow up medio di 10 mesi (3-18). Lo stadio<br />
patologico è stato pT2a nell’11%, pT2b nel 54%,<br />
pT3a 23% e pT3b 12%, con percentuale globale<br />
di margini positivi del 18%.<br />
La continenza (no pad) a tre e sei mesi è del 89%<br />
e del 96% rispettivamente con paziente asciutto<br />
alla rimozione del catetere o entro una settimana<br />
nel 42% e nel 64%.<br />
Il deficit erettile è presente nel 68% dei casi<br />
soprattutto nella serie extrafasciale giungendo al<br />
32% nella serie intrafasciale.<br />
Conclusioni: Nonostante il breve follow up, l’approccio<br />
extraperitoneale intrafasciale rappresenta<br />
una tecnica innovativae sicura che offre i<br />
vantaggi dell’articolazione e della destrezza dei<br />
bracci robotici. I risultati oncologici e funziona-<br />
Archivio Italiano di Urologia e Andrologia 2007, 79, 3, Supplemento 1<br />
li sembrano comparabili con le altre tecniche<br />
codificate.<br />
V15<br />
L’UTILIZZO DEL SISTEMA DI COAGULAZIONE<br />
GYRUS IN CORSO DI PROSTATECTOMIA<br />
RADICALE LAPAROSCOPICA (VIDEO)<br />
R.Tarabuzzi 1 , F. Varvello, S. Zaramella,<br />
G. Marchioro, G. Maso, S. Ranzoni e C. Terrone<br />
Ospedale Maggiore della Carità, Novara<br />
Obiettivi: La possibilità di utilizzare sistemi di<br />
emostasi efficaci contribuisce a ridurre i tempi<br />
della curva di apprendimento della prostatectomia<br />
laparoscopica.<br />
È noto come uno dei fattori di resistenza alla<br />
diffusione di questa tecnica sia rappresentato<br />
dal potenziale spreco di risorse in termini di<br />
utilizzo di ore di sala operatoria.<br />
Obiettivo del video è dimostrare come l’introduzione<br />
nella tecnica personale di uno strumento<br />
da taglio e coagulo abbinato alla tecnologia<br />
GYRUS abbia consentito di ottenere un<br />
rapido ed efficace controllo dell’emostasi in<br />
corso di prostatectomia radicale laparoscopica<br />
non nerve sparing.<br />
Materiali e Metodi: La tecnologia GYRUS mette<br />
a disposizione diversi presidi per emostasi utilizzabili<br />
in diverse modalità (chirurgia open,<br />
endoscopia, laparoscopia). Il sistema eroga una<br />
coagulazione bipolare a bassi voltaggi (< 200<br />
V) con minimo insulto tessutale, raggiungendo<br />
temperature inferiori rispetto alla comune<br />
coagulazione monopolare. Il sistema è utilizzabile<br />
in chirurgia laparotomica abbinato a pinze<br />
da coagulo monouso, in endoscopia abbinato<br />
ad anse monouso per resezione prostatica e<br />
vescicale e in laparoscopia abbinato ad una<br />
vasta gamma di pinze monouso da coagulo e<br />
da taglio e coagulo; in particolare per la chirurgia<br />
laparoscopica è disponibile in commercio<br />
una pinza da 5 mm di calibro che consente<br />
di coagulare e tagliare in successione automatica<br />
il tessuto coagulato.<br />
Questo dispositivo è stato introdotto di routine<br />
in corso di prostatectomia radicale laparoscopica<br />
non nerve sparing nella nostra fase<br />
inziale della curva di apprendimento. Il video<br />
dimostra l’impiego di questo strumento in<br />
alcuni tempi chirurgici a particolare rischio<br />
emorragico.<br />
Risultati: Da gennaio a dicembre 2006 sono<br />
state eseguite 19 prostatectomie radicali laparoscopiche<br />
non nerve sparing. La pinza da
emostasi GYRUS è stata introdotta a partire<br />
dalla quindicesima procedura.<br />
I tempi chirurgici in cui lo strumento ha dimostrato<br />
i maggiori vantaggi sono risultati la dissezione<br />
del piano prostato-vescicale ed il controllo<br />
dei peduncoli vascolari postero-laterali, mentre il<br />
controllo del plesso di Santorini ha sempre<br />
richiesto l’utilizzo di sutura intracorporea “free<br />
hands”.Il video dimostra anche che il controllo<br />
ottimale dell’emostasi rende molto più agevole e<br />
tecnicamente precisa la preparazione del collo<br />
vescicale, agevolando notevolmente anche la<br />
successiva anastomosi uretro-vescicale.<br />
Conclusioni: Nella nostra esperienza il sistema per<br />
emostasi GYRUS, con il costo di una unica macchina,<br />
offre il vantaggio di poter essere utilizzato<br />
con diversi presidi monouso come le anse da<br />
resezione prostatica, le pinze da emostasi per<br />
chirurgia laparotomica e le pinze da taglio e<br />
coagulo per laparoscopia.<br />
V16<br />
RIPARAZIONE LAPAROSCOPICA EXTRAPERI-<br />
TONEALE DI ERNIA INGUINALE<br />
A. Celia, G. Breda, G. Zeccolini<br />
Struttura Complessa di Urologia, Ospedale San Bassiano,<br />
Bassano del Grappa (Vicenza)<br />
Introduzione: La tecnica chirurgica della riparazione<br />
dell’ernia inguinale ha visto nel corso degli<br />
anni un’evoluzione dalla semplice riparazione<br />
tissutale secondo Bassini, all’impiego delle protesi<br />
per via aperta, alla riparazione laparoscopica.<br />
L’impiego della “mesh” ha ridotto il tasso di recidiva<br />
dal 15 all’1%.<br />
Obiettivi: Dimostrare in dettaglio la tecnica di<br />
riparazione laparoscopica extraperitoneale dell’ernia<br />
inguinale con mesh protesica.<br />
Materiale e Metodi: In questo video viene inizialmente<br />
descritta l’anatomia laparoscopica extraperitoneale<br />
dell’ernia inguinale diretta o indiretta<br />
e successivamente vengono evidenziati i<br />
momenti salienti dell’intervento. Creato lo spazio<br />
extraperitoneale, si identificano il sacco erniario<br />
ed il funicolo spermatico. L’intervento continua<br />
con l’isolamento e la retrazione del sacco erniario<br />
in cavità addominale dalla fossetta erniaria,<br />
ponendo particolare cura nell’evitare lesioni accidentali<br />
del peritoneo e dei vasi funicolari.<br />
Completato l’isolamento del funicolo spermatico,<br />
viene inserita a cavalcioni dello stesso una<br />
mesh di Prolene 10 x 8 cm, sagomata con una<br />
particolare forma allo scopo di evitarne il dislocamento.<br />
La tecnica di modellaggio, posiziona-<br />
<strong>7°</strong> <strong>Congresso</strong> <strong>Nazionale</strong> Associazione Italiana di Endourologia<br />
mento e fissaggio della mesh è sostanzialmente<br />
analoga per entrambi i tipi di ernia. Il tempo<br />
impiegato per la riparazione laparoscopica dell’ernia<br />
è di circa 45 min. L’intervento si conclude<br />
con il posizionamento di un drenaggio in aspirazione<br />
per 12 ore nel Retzius al fine di evitare raccolte<br />
ematiche, potenziale causa di infezioni.<br />
Discussione: Nella nostra esperienza la riparazione<br />
laparoscopica extraperitoneale dell’ernia<br />
inguinale, eseguita in associazione ad altra patologia<br />
urologica, si è dimostrata una procedura<br />
semplice ed efficace e con un tasso di recidiva<br />
dello 0%.<br />
Riteniamo che l’urologo debba possedere nel suo<br />
armamentario chirurgico la tecnica di riparazione<br />
dell’ernia, open e/o laparoscopica, derivata<br />
dalla conoscenza e dalla competenza chirurgica<br />
della pelvi. Il nostro pensiero viene supportato<br />
dall’esperienza consolidata di molti centri urologici<br />
europei che eseguono tale procedura routinariamente.<br />
Ricordiamo inoltre che le linee<br />
guida dell’EAU, proposte nel 2002, presentano la<br />
“Laparoscopic Hernia Repair” come una procedura<br />
ad alto livello di raccomandazione (A).<br />
Conclusioni: La riparazione laparoscopica extraperitoneale<br />
con mesh rappresenta una opzione<br />
valida, rapida e sicura nel trattamento dell’ernia<br />
inguinale.<br />
Comunicazioni Aula Blu<br />
19 SETTEMBRE 08.00-09.00<br />
Miscellanea 2<br />
C22<br />
TURP GYRUS CON INTENTO RADICALE COME<br />
MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEL CARCINO-<br />
MA PROSTATICO: DAL MITO ALLA REALTÀ<br />
M. Tura, O. Fenice, M. Parravicini, P. Baroni<br />
U.O. Urologia, Policlinico di Monza<br />
Introduzione: Poichè la prostatectomia radicale è<br />
ormai accettata come prima scelta per il carcinoma<br />
prostatico, il trattamento endoscopico rappresenta<br />
una vera e propria sfida per l’urologo<br />
sebbene la tecnologia e la tecnica operatoria si<br />
siano evolute sempre più, a partire dagli insegnamenti<br />
pioneristici di Reuter, ed anche la diagnostica<br />
possa ormai essere considerata ottimizzata.<br />
D’altra parte la motivazione personale<br />
dei pazienti diventa un fattore sempre più<br />
importante, oltre alle implicazioni legali offerte<br />
dal consenso informato al trattamento, enfatizzando<br />
il concetto, già attuale e pregnante, del<br />
mantenimento della qualità di vita.<br />
Archivio Italiano di Urologia e Andrologia 2007, 79, 3, Supplemento 1 25
26<br />
<strong>7°</strong> <strong>Congresso</strong> <strong>Nazionale</strong> Associazione Italiana di Endourologia<br />
Infatti nel caso di una malattia, comunque<br />
estremamente invalidante anche se poco<br />
aggressiva, com’è il carcinoma prostatico, il<br />
mantenimento della continenza urinaria e la<br />
preservazione della funzione sessuale come criteri<br />
di scelta nel trattamento chirurgico, oltre<br />
che il controllo oncologico, possono risultare<br />
determinanti nell’indirizzarci verso una metodica<br />
mini invasiva.<br />
Materiali e Metodi: Sulla scorta dell’esperienza<br />
di alcuni autorevoli autori che ci hanno preceduto<br />
nel trattamento endoscopico del carcinoma<br />
prostatico procediamo nella resezione completa<br />
del tessuto prostatico sino alla capsula:<br />
per verificare l’estensione raggiunta eseguiamo<br />
un controllo ecografica della prostata transrettale<br />
peroperatorio.<br />
La radicalità viene indirizzata dalla lateralità<br />
del tumore, desunta dall’esame anatomopatologico<br />
della biopsia prostatica, e viene confermata<br />
dall’esame estemporaneo al criostato;<br />
un’eventuale perforazione mirata della capsula,<br />
in caso di superamento della stessa, consente<br />
comunque la preservazione di almeno un<br />
fascio vascolo nervoso.<br />
Risultati: Il follow up dei pazienti trattati sinora,<br />
risulta inadeguato per caratterizzare la nostra<br />
esperienza, che risulta quindi anedottica.<br />
La chiave di successo del trattamento endoscopico<br />
risiede nell’utilizzo dell’elettrobisturi<br />
bipolare a radiofrequenza Gyrus che consente<br />
velocità di taglio e precisione di coagulo superiore<br />
alla normale ansa diatermica monopolare,<br />
permettendoci così di ridurre il tempo necessario<br />
per la resezione prostatica e coagulando più<br />
celermente le bocche venose aperte durante il<br />
taglio.<br />
Abbiamo registrato inoltre un minore danno<br />
tessutale causato dalla ridotta temperatura<br />
applicata durante il taglio, fornendo all’anatomopatologo<br />
un tessuto istologicamente meno<br />
alterato.<br />
Discussione: Riserviamo la modalità endoscopica<br />
di trattamento ai pazienti affetti da carcinoma<br />
prostatico non candidabili alla chirurgia, o<br />
che rifiutano differenti metodiche (radioterapia<br />
conformazionale, terapia interstiziale, crioterapia)<br />
ed alle forme localmente avanzate; è possibile<br />
inoltre applicare tale metodica con<br />
modalità di salvataggio dopo fallimento dopo<br />
radioterapia.<br />
La TURP GYRUS nelle nostre mani rappresenta<br />
un ausilio tecnologico che consente un trattamento<br />
semplice e sicuro del carcinoma prostatico.<br />
Archivio Italiano di Urologia e Andrologia 2007, 79, 3, Supplemento 1<br />
C23<br />
I BUCHI NERI IN ENDOUROLOGIA<br />
L. Defidio, M. De Dominicis<br />
U.O.C. di Urologia, Ospedale Cristo Re, Roma<br />
Introduzione: Nell’universo il buco nero è un<br />
corpo celeste dotato di un campo gravitazionale<br />
così intenso da impedire a qualsiasi oggetto e<br />
persino alla luce (emissione elettromagnetica) di<br />
allontanarsi da esso. Per tale motivo esso non<br />
può essere mai osservato direttamente e viene<br />
detto, appunto, “nero”. In endourologia il termine<br />
“buco nero” si riferisce a tutte quelle situazioni<br />
in cui esiste una comunicazione puntiforme<br />
tra la via escretrice e una cavità. Descriviamo i<br />
buchi neri che si possono incontrare durante l’esplorazione<br />
endoscopica del rene.<br />
Materiali e Metodi: Per l’esplorazione sistematica<br />
del rene abbiamo utilizzato l’ureterorenoscopio<br />
flessibile DUR-8 Elite ACMI-Gyrus introdotto<br />
per via retrograda. I casi osservati e trattati consistevano<br />
in 3 diverticoli caliceali complicati da<br />
calcolosi, 2 cisti comunicanti e 2 fistole venocaliceali.<br />
I diverticoli, entrambi del calice superiore,<br />
sono stati trattati con una apertura del<br />
colletto mediante laser e litolapassi. Le cisti, del<br />
polo superiore del rene, sono state trattate<br />
mediante una dilatazione meccanica del colletto<br />
con esplorazione della cavità. In uno dei 2<br />
casi di fistola veno-caliceale, in cui l’esplorazione<br />
del rene era stata dettata da una ematuria<br />
lateralizzata, poiché la fistola non sanguinava,<br />
fu esplorato il rene controlaterale. Nell’altro<br />
caso, per il dimostrato sanguinamento, fu programmata<br />
una embolizzazione superselettiva<br />
percutanea.<br />
Risultati: In tutti i casi l’aspetto endoscopico del<br />
tramite di comunicazione era un “buco nero”.<br />
Al controllo dopo 3 mesi i pazienti con diverticoli<br />
caliceali erano asintomatici con negatività<br />
ecografia e radiologica. Nei casi di cisti comunicanti<br />
l’ecografia ha dimostrato notevole riduzione<br />
delle cavità e un sistema non in tensione.<br />
Nei pazienti con ematuria lateralizzata con<br />
fistola veno-caliceale scomparve il sanguinamento:<br />
nel caso della fistola non sanguinante fu<br />
scoperto un tumore uroteliale di alto grado nel<br />
rene controlaterale con successiva nefroureterectomia;<br />
nel caso di fistola sanguinamte l’embolizzazione<br />
fu risolutiva.<br />
Conclusioni: Tutti i “buchi neri” nell’alta via<br />
escretrice sono patologici e devono essere studiati.<br />
Il trattamento non è sempre necessario<br />
(es. fistola non sanguinante). Nei casi di cisti<br />
comunicanti il drenaggio retrogrado è il tratta-
mento di scelta per la sua mininvasività ed efficacia.<br />
Per le cisti comunicanti del calice inferiore<br />
tale trattamento deve essere associato ad una<br />
diatermocoagulazione della parete.<br />
C24<br />
EFFETTI DEL CONTENUTO INTRALUMINALE<br />
SULLA CAPACITÀ COAGULATIVA DEI VASI<br />
OTTENUTA CON L’UTILIZZO DELL’HARMO-<br />
NIC ACE®E DEL LIGASURE V®<br />
G. Mirabile1 , C.K. Phillips2 , G.W. Hruby2 ,<br />
P. Bove1 , A. Campagna1 , D.S. Lehman2 , P. Wei<br />
Hong2 , J. Landman2 1Cattedra di Urologia, Università di Tor Vergata, Roma;<br />
2Columbia Presbyterian Medical Center, New York, NY,<br />
U.S.A.<br />
Introduzione: Gli apparecchi chirurgici che utilizzano<br />
energia (ESD:Energy-based surgical<br />
device) fanno parte della strumentazione più<br />
importante per ottenere l’emostasi durante gli<br />
interventi di chirurgia laparoscopica. Nonostante<br />
gli sforzi impiegati per ottimizzare l’intensità<br />
dell’effetto manipolando le fonti di energia<br />
e le pressioni, nessuno studio in precedenza<br />
ha valutato l’efficacia dei ESD in diverse condizioni<br />
fisiologiche. Abbiamo valutato l’effetto del<br />
contenuto dei vasi sulla pressione di coagulazione<br />
(BP bursting pressure) su due apparecchi<br />
(ESD) attualmente in commercio: l’ Harmonic<br />
ACE ® e il LigaSure V ® .<br />
Materiali e Metodi: Gli esperimenti sono stati<br />
eseguiti sulla vascolarizzazione di 24 maiali<br />
domestici. I vasi sanguigni sono stati riempiti<br />
con sangue a differenti concentrazioni o con<br />
soluzioni di albumina a vario contenuto proteico.<br />
Dopo l’utilizzo dello strumento per ogni<br />
vaso sono state registrate le dimensioni del vaso<br />
e la pressione di coagulazione.<br />
Risultati: Nelle arterie e vene di 0-3mm dopo<br />
l’utilizzo sia dell’Harmonic ACE ® che del<br />
LigaSure V ® , sono state registrate elevate pressioni<br />
di coagulazione (BP) con un ematocrito<br />
intraluminare superiore a quello fisiologico.<br />
Nelle arterie e vene coagulate con l’ Harmonic<br />
ACE ® , concentrazioni crescenti di albumina<br />
erano in grado di aumentare le pressioni di<br />
coagulazione, anche se queste risultavano inferiori<br />
alle quelle ottenute con livelli di ematocrito<br />
superiori alla norma. Utilizzando il LigaSure<br />
V ® non sono stati dimostrati aumenti pressori<br />
con concentrazioni di albumina crescenti.<br />
Entro i range testate, non si è registrata una<br />
riduzione della pressione di coagulazione asso-<br />
<strong>7°</strong> <strong>Congresso</strong> <strong>Nazionale</strong> Associazione Italiana di Endourologia<br />
ciata con le condizione di anemia.<br />
Conclusioni: In piccoli vasi, utilizzando sia<br />
l’Harmonic ACE ® che il LigaSure V ® , un ematocrito<br />
superiore alla norma è in grado di aumentare<br />
le pressioni di coagulazione sia delle arterie<br />
che delle vene. Nonostante fattori come la concentrazione<br />
proteica intraluminare potrebbe<br />
avere un ruolo con gli apparecchi ad energia<br />
ultrasonora, il meccanismo di incremento delle<br />
pressioni di coagulazione rimane non chiaro e<br />
richiede ulteriori valutazioni. Con gli strumenti<br />
testati, l’anemia non sembra avere effetti sulla<br />
pressione di coagulazione (BP). Una migliore<br />
comprensione degli apparecchi ESD aiuterà ad<br />
ottimizzare l’utilizzo della strumentazione<br />
attualmente in commercio e sarà utile nella progettazione<br />
della strumentazione futura.<br />
C24 1<br />
RUOLO DEL PHILLANTUS NIRURI (URISTON)<br />
COME TERAPIA AUDIUVANTE ALLA LITO-<br />
TRISSIA EXTRACORPOREA PER I CALCOLI<br />
RENALI<br />
S. Micali, M. Grande, M.C. Sighinolfi, S. De<br />
Stefani, C. De Carne, F. Fidanza, G. Bianchi<br />
Cattedra di Urologia, Università degli Studi di Modena<br />
e Reggio Emilia<br />
Introduzione e Obiettivi: Il Phyllanthus niruri e’<br />
una pianta utilizzata nella medicina popolare<br />
brasiliana per il trattamento della urolitiasi in<br />
quanto regola l’escrezione endogena degli inibitori<br />
della litogenesi.<br />
Abbiamo valutato l’efficacia del Phyllanthus<br />
niruri dopo ESWL nella calcolosi renale.<br />
Metodi: 118 pazienti affetti da calcolosi renale<br />
con sospetta o nota composizione di ossalato di<br />
calcio sono stati considerati prospettivamente.<br />
Le dimensioni medie dei calcoli erano di 9.94<br />
mm (4-25 mm). La localizzazione dei calcoli<br />
era cosi divisa: 20/118 in sede caliceale superiore,<br />
17/118 in sede caliceale medio, 41 in<br />
sede caliceale inferiore e 40/118 in sede pielica.<br />
Tutti i pazienti sono stati sottoposti ad un singolo<br />
trattamento ESWL (Dornier Lithotripter<br />
S), impiegando 3500 colpi ed energia media al<br />
65%. Successivamente in 72/118 pazienti<br />
(61%) è stata impostata terapia antidolorifica<br />
(Gruppo A), mentre in 46/118 (39%) è stata<br />
impostata terapia con Uriston ® (2 gr die) e terapia<br />
antidolorifica (Gruppo B). Riguardo la<br />
dimensione dei calcoli non vi erano significative<br />
differenze tra i due gruppi. La stone clerance<br />
e’stata valutata a 30, 90 e 180 giorni median-<br />
Archivio Italiano di Urologia e Andrologia 2007, 79, 3, Supplemento 1 27
28<br />
<strong>7°</strong> <strong>Congresso</strong> <strong>Nazionale</strong> Associazione Italiana di Endourologia<br />
te radiografia diretta dell’addome ed ecografia<br />
reno-vescicale. E’ stata considerata condizione<br />
di stone-free la completa clearance della calcolosi<br />
o la presenza di calcolosi residua di diametro<br />
inferiore a 3 mm.<br />
Risultati: La percentuale di stone-free globale (6<br />
mesi) era 80% nel Gruppo A e 97% nel Gruppo<br />
B (p = 0.000). La percentuale di stone-free nel<br />
Gruppo A era del 33,3% e 63,8% a 1 e 3 mesi<br />
rispettivamente; la percentuale di stone-free nel<br />
Gruppo B era 34,7% e 73,9% allo stesso followup<br />
(p = 0.75; p =0.01). È stato necessario eseguire<br />
un re-trattamento nel 38,8% dei casi del<br />
Gruppo A e nel 30,4% del Gruppo B (p=0.055).<br />
Tra i pazienti affetti da calcolosi caliceale inferiore<br />
è stata registrata una differenza significativa<br />
nella percentuale degli stone-free tra il<br />
gruppo non trattato (64,28%) rispetto al gruppo<br />
trattato (94,1%) (p = 0.000).<br />
Conclusioni: La terapia con Uriston ® determina<br />
un incremento globale della percentuale di<br />
stone-free ed una riduzione dei tempi di espulsione<br />
dei frammenti dopo ESWL.<br />
Particolare attenzione viene posta alla calcolosi<br />
caliceale inferiore, per la quale Uriston ® migliora<br />
l’efficacia del trattamento ESWL con percentuali<br />
di stone-free nettamente superiori ai dati<br />
presenti in Letteratura.<br />
C24 2<br />
DORNIER LITHOTRIPTER S: LA PRIMA CASI-<br />
STICA CON OLTRE 1000 TRATTAMENTI<br />
S. Micali, M. Grande, M.C. Sighinolfi, C. De<br />
Carne, F. Fidanza, S De Stefani, G. Bianchi<br />
Dipartimento di Urologia, Università di Modena e<br />
Reggio Emilia<br />
Obiettivi: Valutare l’efficacia e la sicurezza della<br />
litotrissia extracorporea (ESWL) con il Dornier<br />
Lithotripter S (Doli) nel trattare una gruppo di<br />
736 pazienti affetti da calcolosi renale ed ureterale.<br />
Questa è la prima casistica descritta in<br />
letteratura con oltre 1000 trattamenti eseguiti<br />
con lo stesso litotritore.<br />
Pazienti e Metodi: In un periodo compreso tra<br />
Gennaio 2003 e Maggio 2006, sono state eseguiti<br />
1168 ESWL (479 renali e 257 ureterali),<br />
con una media di 1,6 trattamenti a paziente.<br />
Tutti i trattamenti sono stati eseguiti in regime<br />
di “Day surgery” ed il controllo post litotrissia<br />
è stato eseguito ad 1 e 3 mesi dopo il trattamento.<br />
In tutti è stato valutato: dimensioni e<br />
sede del calcolo, numero di colpi e frequenza,<br />
successo del trattamento e complicanze.<br />
Archivio Italiano di Urologia e Andrologia 2007, 79, 3, Supplemento 1<br />
Risultati: Il successo del trattamento è stato per<br />
i calcoli renali del 60,5% ad 1 mese, 82,5% a 3<br />
mesi. Per i calcoli ureterali è stato del 58% ad<br />
1 mese, 82,9% a 3 mesi. Il totale dei pazienti<br />
“stone free” è stato rispettivamente del 59,6% e<br />
82,5% ad 1 e 3 mesi. L’anestesia non è stata<br />
necessaria in nessun caso, l’analgesia durante il<br />
trattamento (FANS) è stata necessaria in 15 pz.<br />
(2%). La più severa complicanza verificatasi<br />
durante il trattamento è stato un ematoma<br />
renale (0,1%), complicanze minori come<br />
ostruzione della via escretrice con sepsi e<br />
“steinstrasse” si sono verificate rispettivamente<br />
i tre (0,4%) e cinque (0,7%) pazienti.<br />
Conclusioni: Il Doli è una macchina sicura ed<br />
efficace nel trattare calcoli renali ed ureterali.<br />
Inoltre, le sue caratteristiche di non invasività<br />
lo pongono al di sopra delle altre tecniche mini<br />
invasive come l’ureterorenoscopia e la nefrolitotomia<br />
percutanea. Riteniamo che per la calcolosi<br />
non voluminosa o complessa la litotrissia<br />
debba essere considerata come trattamento<br />
di prima scelta.<br />
C24 3<br />
L’UTILIZZO DELLO STENT METALLICO “RESO-<br />
NANCE” NELLA PATOLOGIA OSTRUTTIVA<br />
DELL’URETERE<br />
D. Piccolotti, C. Aliberti 1 , S. Papa, F. Carparelli,<br />
E. Vece, G.R. Russo<br />
AUSL di Ferrara, U.O. di Urologia; 1 AUSL di Ferrara,<br />
U.O. di Diagnostica per Immagini<br />
Introduzione e Obiettivi: Patologie benigne e/o<br />
maligne che portano a ostruzione della via<br />
escretrice superiore obbligano talora in maniera<br />
temporanea o definitiva a trattamenti alternativi<br />
alla chirurgia. Il nostro obbiettivo è stato<br />
valutare un nuovo stent disponibile in commercio<br />
per verificarne le caratteristiche di<br />
impiego, l’efficacia, la tollerabilità in pazienti<br />
destinati a mantenere in sede lo stent per tempi<br />
superiori a sei mesi.<br />
Materiali e Metodi: abbiamo utilizzato stent ureterali<br />
tipo “Resonance” (Cook LTD, Irlanda)<br />
del diametro di 6 Ch e della lunghezza di 26 o<br />
28 cm. Le caratteristiche di questo stent sono di<br />
essere composto di materiale inossidabile e di<br />
avere una struttura a spirale serrata tale da permettere<br />
il deflusso di liquidi in vitro anche con<br />
pressioni esercitate superiori ai 1000 Newton<br />
(pari a circa 100 Kilogrammi forza). Il costo<br />
medio dello stent si è aggirato sui 600 euro.<br />
Sono stati trattati 9 pazienti e posizionati 11
stent in quanto in 1 sono stati posizionati bilateralmente<br />
e in 1 altro caso si è provveduto alla<br />
sostituzione trascorsi 12 mesi dal primo impianto.<br />
Per il posizionamento sono state utilizzate sia<br />
la tecnica anterograda, per via percutanea, che<br />
retrograda sotto guida fluoroscopica, rispettivamente<br />
in 6 e in 5 degli stent inseriti.<br />
Risultati: La tecnica di posizionamento è risultata<br />
agevole, non sono state riscontrate complicanze<br />
intra o postoperatorie. Il follow-up<br />
medio è stato di 10 mesi. In 1 caso è stato<br />
sostituito lo stent metallico con uno analogo<br />
dopo 12 mesi e in un altro caso la rimozione è<br />
avvenuta oltre il dodicesimo mese. In questo<br />
caso abbiamo notato una significativa perdita<br />
di elasticità che non ha però comportato danni<br />
apparenti alla mucosa. La presenza di materiale<br />
proteico e litiasico sugli stent rimossi è stata<br />
sempre minima o assente. In 1 ulteriore caso<br />
(9%) è stata riscontrata nuova ricomparsa dell’idronefrosi<br />
dopo circa un mese per inglobamento<br />
del tratto distale dello stent in una<br />
massa pelvica di origine uterina valutata<br />
mediante l’esecuzione di una Risonanza<br />
Magnetica Nucleare (RMN). I pazienti sono<br />
stati controllati a 2 settimane e successivamente<br />
in funzione della patologia di base mediante<br />
ecografia addome o TAC addome e pelvi con<br />
mezzo di contrasto per la valutazione dell’idronefrosi.<br />
Tutti i pazienti non hanno riferito alcuna<br />
sintomatologia di tipo irritativo mentre in 3<br />
si è presentata lieve ematuria risoltasi rapidamente<br />
con abbondante idratazione.<br />
Conclusioni: l’utilizzo dello stent “Resonance”<br />
nelle patologie ostruttive ureterali ha dimostrato,<br />
nella nostra esperienza, una maneggevolezza<br />
nell’uso ed un’ottima tollerabilità anche per<br />
lunghi periodi. Pensiamo che il “Resonance”<br />
possa essere un’ulteriore opzione terapeutica<br />
nelle ostruzioni ureterali.<br />
Comunicazioni Aula Verde<br />
19 SETTEMBRE 08.00-09.00<br />
Laparoscopia<br />
C25<br />
LA CRIOTERAPIA LAPAROSCOPICA PER IL<br />
TRATTAMENTO DELLE NEOFORMAZIONI<br />
RENALI: ESPERIENZA PRELIMINARE<br />
P. Bove 1 , G. Mirabile 1 , E. Finazzi Agrò 1 ,<br />
A. Campagna 1 , R. Miano 1 , F. Kim 2 , G. Vespasiani 1<br />
1 Cattedra di Urologia, Università di Roma “Tor<br />
Vergata”, Roma; 2 Department Of Urology, Denver<br />
Health Hospital, University of Colorado, USA<br />
<strong>7°</strong> <strong>Congresso</strong> <strong>Nazionale</strong> Associazione Italiana di Endourologia<br />
Introduzione e Obiettivi: La crioablazione renale<br />
è un’opzione mininvasiva che si è dimostrata<br />
promettente nel trattamento dei pazienti affetti<br />
da piccole lesioni solitarie del rene. Anche se i<br />
risultati a medio termine sono promettenti, esistono<br />
ancora pochi studi clinici su larga scala<br />
che analizzano questa promettente tecnica.<br />
Presentiamo i risultati iniziali di una coorte di<br />
pazienti sottoposti a crioterapia renale.<br />
Materiali e Metodi: Dal Maggio 2006 al Maggio<br />
2007, sono state eseguite 9 procedure di crioablazione<br />
renale con approccio laparoscopico<br />
trans-peritoneale. I pazienti (8 maschi e 1 femmina)<br />
di età compresa tra i 49 e 81 anni (età<br />
media 61) presentavano lesioni di dimensioni<br />
medie di 2,5 cm (range 1,5-4 cm). Prima del<br />
trattamento le lesioni sono state caratterizzate<br />
con sonda ecografica laparoscopica. In tutti i<br />
casi è stata eseguito almeno un prelievo bioptico<br />
per la diagnosi istologica. Per ogni procedura<br />
sono stati utilizzati 2 cicli di congelamento/scongelamento.<br />
Per valutare l’efficacia e la sicurezza del trattamento<br />
sono stati presi in considerazione: le<br />
perdite ematiche, il tempo di degenza, le complicanze<br />
intra, peri e postoperatorie, il risultato<br />
istologico delle biopsie ed i controlli di imaging<br />
con RM o TC.<br />
Risultati: Tutte le procedure sono state condotte<br />
a termine per via laparoscopica. Il tempo<br />
operatorio medio è stato di 130 minuti (range<br />
100-160 minuti). Le perdite ematiche sono<br />
state trascurabili in tutti gli interventi ad eccezione<br />
di un caso in cui è stato necessario convertire<br />
in nefrectomia laparoscopica. In un<br />
secondo caso, per una emorragia intraperitoneale<br />
in prima giornata postoperatoria, il<br />
paziente è stato sottoposto ad intervento di<br />
laparotomia esplorativa. In entrambi i casi i<br />
pazienti erano affetti da patologia ematologica.<br />
Nel postoperatorio si sono osservati 3 casi di<br />
ileo paralitico. La degenza postoperatoria<br />
media è stata di 4,1 giorni (range 2-14 giorni).<br />
Ad un follow-up medio di 6 mesi (range 1-12<br />
mesi) nessun paziente presenta esami diagnostici<br />
sospetti per recidiva o ripresa di malattia.<br />
Tutte le biopsie eseguite sono risultate sede di<br />
infiltrazione da neoplasia renale ad eccezione<br />
di una biopsia non diagnostica.<br />
Conclusioni: La crioterapia del rene risulta essere<br />
una opzione terapeutica valida per il trattamento<br />
piccole masse renali benché siano necessari<br />
maggiori dati sui risultati a lungo termine per<br />
confermarne l’efficacia. La crioterapia è da sconsigliare<br />
in pazienti affetti da discrasia ematica.<br />
Archivio Italiano di Urologia e Andrologia 2007, 79, 3, Supplemento 1 29
30<br />
<strong>7°</strong> <strong>Congresso</strong> <strong>Nazionale</strong> Associazione Italiana di Endourologia<br />
C26<br />
EFFETTO DELLA PRESSIONE DI ARGON<br />
SULLE DIMENSIONI E IL GRADO DI FORMA-<br />
ZIONE DELLA ICE BALL NELLE PROCEDURE<br />
DI CRIOABLAZIONE<br />
G. Mirabile1 , P.C. Sprenkle2 , P. Bove1 , A.<br />
Campagna1 , A. Edelstein2 , P. Wai Hong2 , G.W.<br />
Hruby2 , G. Vespasiani1 , J. Landman2 1Cattedra di Urologia; Università di Tor Vergata, Roma;<br />
2Columbia Presbyterian Medical Center, New York,<br />
NY, U.S.A.<br />
Introduzione: La crioablazione utilizza l’effetto<br />
Joule-Thomson, definito come lo spostamento<br />
da una camera interna ad alta pressione alla<br />
camera esterna della sonda, per raggiungere<br />
temperature molto basse. Abbiamo valutato la<br />
correlazione tra il grado di formazione e la<br />
dimensione finale della iceball come una funzione<br />
della pressione iniziale della bombola di<br />
gas Argon.<br />
Metodi: Tutti gli esperimenti sono stati eseguiti<br />
in un sistema standardizzato che consiste in un<br />
gel trasparente (Kraft, Knox Gelatin, Glenview,<br />
IL) miscelato a temperatura ambiente, utilizzando<br />
sonde di 1.47 mm (IceRod, Galil<br />
Medical, Plymouth Meeting, PA). È stata utilizzata<br />
una figura fissa di 4 termocoppie a distanza<br />
prestabilita (1.0, 1.5, 2.0 e 2.5 cm) dalla<br />
sonda. Le sonde da crioablazione sono state<br />
attivate per un singolo ciclo di congelamento<br />
da 8 minuti.<br />
Sono state documentate le dimensioni e il<br />
grado di formazione delle singole iceballs con<br />
una pressione iniziale della bombola di Argon<br />
variabile da 4500 a 3200 psi (intervalli di 100<br />
psi). Per documentare le dimensioni delle iceball<br />
sono state utilizzate fotografie a rallentatore<br />
scattate con intervalli di un minuto. Le<br />
dimensioni delle iceballs sono state misurate<br />
precisamente utilizzando tecniche di misurazione<br />
standardizzate. La temperatura registrata<br />
da ogni termo-coppia è stata documentata ad<br />
intervalli di 3.4 secondi per ogni esperimento.<br />
Per l’analisi statistica i gruppi sono stati stratificati<br />
per bassa (3200-3500 psi), intermedia<br />
(3600-3900 psi) e elevata pressione di partenza<br />
(>4000 psi). Le differenze nel diametro di<br />
formazione delle singole iceball e nelle temperature<br />
raggiunte sono state analizzate utilizzando<br />
tecniche ANOVA.<br />
Risultati: Per ogni gruppo sono stati eseguiti un<br />
totale di 10 esperimenti. I sistemi a bassa,<br />
intermedia e alta pressione hanno raggiunto<br />
una temperatura minima media rispettivamen-<br />
Archivio Italiano di Urologia e Andrologia 2007, 79, 3, Supplemento 1<br />
te di -2.52, -8.17, and -9.5<strong>7°</strong> C, misurata ad<br />
1cm (p
ilaterale in 3 casi, diretta e bilaterale nei restanti<br />
3 casi.<br />
Risultati: Il tempo medio operatorio legato all’isolamento<br />
del funicolo ed al posizionamento<br />
della mesh è stato di 35 minuti (min 15, max<br />
45). Le perdite ematiche sono risultate non<br />
significative (< di 100 cc). Il follow-up medio è<br />
di 6,9 mesi (min 1, max 12), con assenza di<br />
recidive erniarie.<br />
Discussione: Nella nostra esperienza la riparazione<br />
laparoscopica extraperitoneale dell’ernia<br />
inguinale, eseguita in associazione ad altra patologia<br />
urologica, si è dimostrata una procedura<br />
semplice ed efficace e con un tasso di recidiva<br />
dello 0%.<br />
Riteniamo che l’urologo debba possedere nel suo<br />
armamentario chirurgico la tecnica di riparazione<br />
dell’ernia, open e/o laparoscopica, derivata<br />
dalla conoscenza e dalla competenza chirurgica<br />
della pelvi e del canale inguinale. Il nostro pensiero<br />
viene supportato dall’esperienza consolidata<br />
di molti centri urologici europei che eseguono<br />
tale procedura routinariamente. Ricordiamo<br />
inoltre che le linee guida dell’EAU, proposte nel<br />
2002, presentano la “Laparoscopic Hernia<br />
Repair” come una procedura ad alto livello di<br />
raccomandazione (A).<br />
Conclusioni: La riparazione laparoscopica extraperitoneale<br />
con mesh rappresenta una opzione<br />
valida, rapida e sicura nel trattamento dell’ernia<br />
inguinale. Forse è tempo per l’urologo di riappropriarsi<br />
di un’area ad alto contenuto urologico:<br />
il canale inguinale.<br />
C28<br />
DUE MODELLI PER LA LAPAROSCOPIA URO-<br />
LOGICA: I NOSTRI RISULTATI DOPO TRE ANNI<br />
DI ATTIVITÀ<br />
P. Bove, A. Campagna, E. Finazzi Agrò, R. Miano,<br />
G. Virgili, G. Vespasiani<br />
Cattedra di Urologia, Università di Roma “Tor Vergata”,<br />
Roma<br />
Obiettivi: la laparoscopia è una delle più rivoluzionarie<br />
acquisizioni in ambito urologico con<br />
numerosi potenziali vantaggi derivanti dalla<br />
“mini-invasività” e dalla magnificazione del<br />
campo operatorio. Nonostante i numerosi corsi e<br />
stages proposti per acquisire la tecnica, la laparoscopia<br />
rimane una metodica complessa con una<br />
lunga e difficile curva d'apprendimento.<br />
Riportiamo la Nostra esperienza acquisita con<br />
due programmi di mentoring eseguiti con l'aiuto<br />
di due esperti.<br />
<strong>7°</strong> <strong>Congresso</strong> <strong>Nazionale</strong> Associazione Italiana di Endourologia<br />
Materiali e Metodi: dal Gennaio 2003 abbiamo<br />
iniziato due differenti programmi di mentoring<br />
laparoscopico: prostatectomia radicale e colposacropessi<br />
(programma A); chirurgia dell'alto<br />
apparato urinario (programma B). Il programma<br />
A si è svolto in quattro differenti step: i primi 5<br />
interventi sono stati eseguiti interamente dal chirurgo<br />
esperto (mentor) con il chirurgo discente<br />
come assistente (step 1); nei successivi 10 interventi<br />
il chirurgo discente ha eseguito esclusivamente<br />
la parte demolitiva della procedura (step<br />
2 = 5 procedure) e successivamente solo l'anastomosi<br />
vescico-uretrale (step 3 = 5 procedure);<br />
i successivi 10 interventi sono stati eseguiti interamente<br />
dal chirurgo discente (step 4). Il programma<br />
B si è svolto eseguendo interventi di difficoltà<br />
progressiva con il chirurgo discente come<br />
primo chirurgo ed il mentor come assistente.<br />
Tutti i parametri intra e postoperatori sono stati<br />
registrati per valutare l'impatto della curva d'apprendimento<br />
sulla morbilità e quindi sui risultati<br />
oncologici e funzionali della procedura.<br />
Risultati: abbiamo eseguito un totale di 172<br />
interventi: 70 prostatectomie radicali; 31 nefrectomie<br />
radicali; 10 nefrectomie parziali; 6 nefroureterectomie,<br />
8 resezione di cisti renali, 5 crioterapie<br />
renali, 14 ureterolitotomie, 10 pieloplastiche;<br />
15 colposacropessi, 2 cistectomie radicali, 1<br />
cistectomia parziale. Nel programma A (tot 25<br />
procedure di mentoring) 2 procedure sono state<br />
convertite “a cielo aperto” rispettivamente per<br />
emorragia e per una lesione del tratto intramurale<br />
dell'uretere. Un caso di colposacropessi ha<br />
richiesto una esplorazione laparotomica per una<br />
lesione dell'uretere. Nei restanti casi abbiamo<br />
avuto le seguenti complicanze: lesione del retto<br />
(1); fistole urinose (5), ematoma pelvico (1),<br />
ritenzione urinaria acuta (2), ematoma cutaneo<br />
(3), stenosi dell'anastomosi (2). Nel programma<br />
B (tot 30 procedure) tutte le procedure sono<br />
state portate a termine per via laparoscopica. In<br />
un caso è stata necessaria una esplorazione laparotomica<br />
per emorragia post-operatoria dopo<br />
intervento di crioterapia. Abbiamo avuto inoltre<br />
le seguenti complicanze minori: ileo paralitico<br />
(6), fistola urinosa (1), febbre (10), ematoma<br />
cutaneo (5).<br />
Conclusioni: i programmi di mentoring hanno<br />
consentito di mantenere elevato lo standard<br />
terapeutico con una percentuale di complicanze<br />
sovrapponibile a quella riportata in letteratura<br />
dai maggiori centri urologici. Un programma di<br />
mentoring laparoscopico è di fondamentale<br />
importanza per garantire al paziente un intervento<br />
senza “troppi rischi”.<br />
Archivio Italiano di Urologia e Andrologia 2007, 79, 3, Supplemento 1 31
32<br />
<strong>7°</strong> <strong>Congresso</strong> <strong>Nazionale</strong> Associazione Italiana di Endourologia<br />
C29<br />
STUDIO PROSPETTICO SULLA URETEROLITO-<br />
TOMIA LAPAROSCOPICA: APPROCCIO TRANS<br />
E RETROPERITONEALE A CONFRONTO<br />
P. Bove 1 , S. Micali 2 , G. Mirabile 1 , R. Miano 1 ,<br />
A. Campagna 1 , E. Botteri 3 , G. Bianchi 2 ,<br />
G. Vespasiani 1<br />
1 Cattedra di Urologia, Università di Roma “Tor<br />
Vergata”, Roma; 2 Cattedra di Urologia, Università di<br />
Modena e Reggio Emilia, Modena; 3 Dipartimento di<br />
Statistica, Istituto Europeo di Oncologia, Milano<br />
Obiettivi: L’intervento di Ureterolitotomia Laparoscopica<br />
è stato recentemente introdotto come<br />
trattamento di scelta per calcoli impattati o di<br />
grandi dimensioni dell’uretere prossimale.<br />
Obiettivo di questo studio è comparare, l’approccio<br />
trans vs retroperitoneale per il trattamento<br />
laparoscopico dei calcoli ureterali<br />
durante la curva di apprendimento in due differenti<br />
centri urologici,.<br />
Materiali e Metodi: Sono state valutate in maniera<br />
prospettica 35 procedure consecutive di ureterolitotomia<br />
laparoscopica eseguite da due<br />
diversi urologi durante la loro curva d’apprendimento.<br />
Ciascun chirurgo ha utilizzato un<br />
approccio differente: transperitoneale (Gruppo<br />
A) e retroperitoneale (Gruppo B). Per ogni procedura<br />
sono stati presi in considerazione i<br />
tempi per: mettere in posizione il paziente,<br />
posizionare i trocars, isolare l’uretere, estrarre il<br />
calcolo e suturare. Sono state inoltre registrate<br />
le eventuali complicanze intra e perioperatorie.<br />
Risultati: 18 procedure sono state eseguite per<br />
via transperitoneale (Gruppo A) e 17 per via<br />
retroperitoneale (Gruppo B). Differenze statisticamente<br />
significative tra il Gruppo A e B sono<br />
state osservate in termini di tempo per l’accesso<br />
al campo operatorio (medio 14 e 24 min.,<br />
rispettivamente, p=
vaso di urina è stato trattato conservativamente<br />
mediante apposizione per 4 settimane di<br />
stent doppio J. Ad un follow-up medio di 24<br />
mesi non è stata rilevata nessuna recidiva di<br />
malattia.<br />
Conclusioni: La LPN rappresenta oggi una tecnica<br />
ben codificata che tuttavia rimane, anche<br />
in mani esperte, di non facile esecuzione.<br />
Questa nostra esperienza iniziale ha fornito<br />
incoraggianti risultati perioperatori anche se il<br />
ridotto tempo di follow-up non permette ancora<br />
di trarre conclusioni sulla validità oncologica<br />
della metodica.<br />
C31<br />
NEFRECTOMIA LAPAROSCOPICA: EFFICA-<br />
CIA E SICUREZZA DI UNA TECNICA MINI-<br />
INVASIVA<br />
G. Porcu, G. Puggioni, P. Usai, A. De Lisa<br />
Università degli Studi di Cagliari, Clinica Urologica,<br />
Ospedale SS Trinità, Cagliari<br />
Obiettivo: Obiettivo del nostro studio è stato<br />
dimostrare la fattibilità, in termini di efficacia e<br />
sicurezza, della nefrectomia laparoscopica in<br />
caso di tumori renali in stadio localmente avanzato<br />
T2 e T3, e di dimensioni > 7 cm.<br />
Materiali e Metodi: Nel periodo compreso tra il<br />
Gennaio 2003 e il Febbraio 2007, presso la<br />
nostra clinica, sono stati eseguiti 84 interventi di<br />
nefrectomia per tumore renale. Da questi sono<br />
stati isolati 52 casi, suddivisi in 3 gruppi: Nel<br />
gruppo A sono stati inclusi 20 pz affetti da tumore<br />
renale in stadio precoce T1, con tumore di<br />
dimensioni < 7 cm (media circa 3,64 cm), operati<br />
con tecnica VLS; nel gruppo B sono stati<br />
inclusi 20 pz affetti da tumore renale localmente<br />
avanzato T2 e T3, con tumore di dimensioni >7<br />
cm (media circa 9,33 cm), operati con tecnica<br />
VLS; nel gruppo C sono stati inclusi 12 pz affetti<br />
da tumore renale di stadio clinico e dimensioni<br />
della massa variabili (media circa 5,65 cm),<br />
operati con tecnica open tradizionale con accesso<br />
lombotomico. Abbiamo considerato i seguenti<br />
parametri di confronto: sede e istotipo del<br />
tumore; dimensioni del tumore; stadiazione istopatologica;<br />
tempo operatorio; valore di Hb pre e<br />
post-operatoria; eventuale trasfusione; analgesia<br />
post-operatoria; valori di creatininemia pre e<br />
post-operatori; tempo di degenza; follow up,<br />
eseguito a distanza di 6 mesi e 1 anno dall’intervento<br />
chirurgico.<br />
Risultati: Il follow-up si è basato su esami di imaging<br />
(Ecografia renale e TC total body) ed ema-<br />
<strong>7°</strong> <strong>Congresso</strong> <strong>Nazionale</strong> Associazione Italiana di Endourologia<br />
tochimici, risultati tutti negativi per ripresa locale<br />
e a distanza. Valutando i termini di confronto<br />
considerati abbiamo riscontrato: riduzione delle<br />
perdite ematiche intra-operatorie; riduzione del<br />
periodo di degenza; riduzione della somministrazione<br />
di analgesici; rapida ripresa della deambulazione;<br />
tempo operatorio sovrapponibile; rischio<br />
di residuo o ripresa di malattia sovrapponibile;<br />
funzione renale post-operatoria equivalente.<br />
Conclusioni: La chirurgia laparoscopica risulta<br />
essere oggi una validissima alternativa alla chirurgia<br />
tradizionale, assolutamente efficace e sicura,<br />
non solo per tumori di basso stadio e piccole<br />
dimensioni, ma anche per masse renali più voluminose<br />
e di stadio localmente più avanzato.<br />
Video Aula Rossa<br />
19 SETTEMBRE 08.00-09.00<br />
Calcolosi<br />
V17<br />
TRATTAMENTO COMBINATO DI CALCOLOSI<br />
RENALE COMPLESSA CON ACCESSO PER-<br />
CUTANEO IN DECUBITO SUPINO, IN PAZIEN-<br />
TE OBESO<br />
S. Guercio, A. Ambu, F. Mangione, M. Mari,<br />
F. Vacca, M. Bellina<br />
U.O.C. Urologia, P.O. di Rivoli (Torino)<br />
Presentiamo il caso di un paziente di 56 anni,<br />
obeso, affetto da litiasi renale bilaterale complessa<br />
con IRC.<br />
Il paziente si presentava alla nostra attenzione<br />
per colica renale dx con peggioramento degli<br />
indici di funzione renale con valore di creatininemia<br />
di 6.2 mg/dl. La TC addome senza mezzo<br />
di contrasto evidenziava litiasi renale a stampo<br />
bilaterale e calcolo dell’uretere juxtavescicale dx.<br />
Il paziente veniva sottoposto, in regime di<br />
urgenza, a posizionamento di stent ureterale JJ<br />
bilaterale previa ureterolitotrissia dx.<br />
Si procedeva quindi a trattamento della litiasi<br />
renale sn.<br />
Si optava per accesso pecutaneo in posizione<br />
supina per controindicazione anestesiologica<br />
(severa BPCO) e per consentire trattamento<br />
endoscopico combinato anterogrado-retrogrado.<br />
Si accedeva al calice inferiore mediante<br />
guida ecografica e successivo controllo radiologico.<br />
Dilatazione del tramite con NephroMax e<br />
posizionamento di camicia di Amplatz e successiva<br />
trissia combinata (Swiss lithoclast<br />
Master), balistica e a ultrasuoni, del calcolo<br />
caliceale inferiore e pielico.<br />
Archivio Italiano di Urologia e Andrologia 2007, 79, 3, Supplemento 1 33
34<br />
<strong>7°</strong> <strong>Congresso</strong> <strong>Nazionale</strong> Associazione Italiana di Endourologia<br />
Si eseguiva quindi ureteroscopia retrograda che<br />
consentiva di raggiungere il calice medio, attraverso<br />
un colletto ristretto, da cui, mediante<br />
cestello si estraevano tutti i calcoli in esso contenuti<br />
e portati nella pelvi renale dove venivano<br />
estratti con il nefroscopio attraverso il tramite<br />
percutaneo.<br />
Sotto la guida dell’ureteroscopio si accedeva<br />
con il nefroscopio al calice superiore dove si<br />
eseguiva trissia completa, balistica e a ultrasuoni,<br />
dei frammenti litiasici residui.<br />
Al controllo endoscopico e radiologico non si<br />
evidenziavano calcoli residui.<br />
Si terminava la procedura posizionando stent<br />
ureterale JJ e nefrostomia.<br />
V19<br />
TRATTAMENTO MEDIANTE APPROCCIO<br />
ENDOSCOPICO COMBINATO ANTERO-<br />
RETROGRADO IN POSIZIONE SUPINA IN<br />
PAZIENTE CON NEOVESCICA AFFETTO DA<br />
CALCOLOSI URETERALE<br />
C.M. Scoffone, M. Poggio, C. Cracco , R.M. Scarpa<br />
Clinica Urologica, Università di Torino, Ospedale San<br />
Luigi di Orbassano (Torino)<br />
VIDEO<br />
In questo video presentiamo il caso di un<br />
paziente portatore di derivazione urinaria ortotopica<br />
(VIP) in seguito a cistoprostatectomia<br />
radicale per carcinoma vescicale, pervenuto<br />
alla nostra attenzione per insufficienza renale<br />
acuta e riscontro di idronefrosi bilaterale con<br />
riscontro di litiasi ureterale destra. In urgenza<br />
veniva sottoposto a posizionamento di stent<br />
endoureterali tipo JJ per via anterograda e<br />
nefrotomie bilaterali, essendo impossibilitati a<br />
trattare il paziente per via retrograda. Dopo<br />
alcuni giorni si assisteva a risoluzione del quadro<br />
di insufficienza renale.<br />
Alcune settimane dopo veniva sottoposto a<br />
trattamento della calcolosi già nota.<br />
Si posiziona il paziente in posizione supina sec.<br />
Valdivia-Uria mod. Galdakao. Si posiziona<br />
camicia nefrostomica (30 Ch) a destra e<br />
mediante nefroscopio rigido si rimuove lo stent<br />
endoureterale precedentemente posizionato. Si<br />
procede quindi a ureteroscopia flessibile per<br />
via anterograda incontrando a livello iliaco un<br />
calcolo impattato che ostruisce completamente<br />
il deflusso urinario. Si procede quindi a laserizzazione<br />
di tale calcolo e ad asportazione dei<br />
frammenti con cestello. Si posiziona quindi<br />
stent endoureterale per via anterograda.<br />
Archivio Italiano di Urologia e Andrologia 2007, 79, 3, Supplemento 1<br />
Conclusioni: La posizione supina del paziente<br />
permette di trattare i pazienti endoscopicamente<br />
per via combinata anterograda e retrograda<br />
in maniera sicura ed efficace, soprattutto<br />
nei casi in cui sarebbe impossibile il solo<br />
approccio retrogrado.<br />
V20<br />
PERCUTANEA “ENDOVISION”: QUANDO<br />
L’ACCESSO È DAVVERO CORRETTO<br />
A. Frattini, S. Ferretti, P. Salsi, F. Dinale,<br />
M. Ciuffreda, P. Cortellini<br />
U.O. Urologia, Azienda Ospedaliero - Universitaria di<br />
Parma<br />
VIDEO<br />
Obiettivi: Una delle maggiori cause di sanguinamento<br />
durante la puntura percutanea e’ l’incongrua<br />
puntura al calice renale.<br />
La procedura percutanea standard sotto guida<br />
fluoroscopica permette un accesso abbastanza<br />
corretto ma senza la sicurezza di una puntura<br />
renale trans-papillare.<br />
L’approccio ecoguidato è in grado di identificare<br />
meglio la papilla, ma non in grado di confermare<br />
la penetrazione dell’ago attraverso una<br />
teorica linea avascolare. Presentiamo qui la<br />
nostra personale tecnica di accesso al rene per<br />
via percutanea.<br />
Materiale e Metodi: Come illustrato nel video, la<br />
posizione supina nell’accesso percutaneo permette<br />
l’utilizzo contemporaneo dell’ureteroscopio<br />
flessibile per la selezione del calice corretto<br />
per la puntura percutanea.<br />
Il controllo diretto della perforazione indotta<br />
dall’ago sulla papilla renale (endovision) conferma<br />
o esclude il corretto accesso precedentemente<br />
eseguito sotto controllo radiologico<br />
biplanare.<br />
Abbiamo effettuato tali procedure di nefrolitotrissia<br />
percutanea in 12 pazienti.<br />
Risultati: Nessuna procedura è stata interrotta o<br />
convertita a cielo aperto. Tutti i pazienti sono<br />
risultati liberi da calcoli dopo una sola procedura.<br />
La durata media della procedura “endovision”<br />
è risultata 12 minuti più lunga rispetto<br />
alla procedura standard in posizione supina.<br />
L’esposizione a radiazioni ionizzanti e’ risultata<br />
inferiore rispetto all’intervento standard.<br />
Conclusioni: Possiamo concludere che 1) talvolta<br />
una puntura effettuata su guida radiologica,<br />
ed interpretata come corretta, corrisponde in<br />
realta’ per esempio ad una perforazione transcaliceale<br />
dell’infundibolo. 2) la procedura
endovision è piu’ sicura nell’approccio “tubeless”<br />
rispetto al tradizionale, e comporta una<br />
minor esposizione a radiazioni ionizzanti<br />
durante la creazione del tratto nefrostomico 3)<br />
la procedura endovision non è significativamente<br />
più lunga rispetto alla procedura standard<br />
4) il completo dominio della via escretrice<br />
(anterogrado/retrogrado) permette di<br />
aumentare la percentuale di pazienti stone-free<br />
dopo l’intervento.<br />
V21<br />
APPROCCIO ENDOSCOPICO COMBINATO<br />
ANTERO-RETROGRADO IN POSIZIONE SUPI-<br />
NA NELLA DIAGNOSTICA DI MACROEMATU-<br />
RIA IN PAZIENTE CON BRICKER<br />
C.M. Scoffone, M. Poggio, C. Cracco , R.M. Scarpa<br />
Clinica Urologica, Università di Torino, Ospedale San<br />
Luigi di Orbassano (Torino)<br />
VIDEO<br />
Introduzione: L’accesso percutaneo del rene in<br />
posizione supina presenta numerosi vantaggi<br />
rispetto alla posizione prona: infatti, oltre a<br />
favorire un’anestesia in maggior sicurezza, permette<br />
anche di eseguire interventi endourologici<br />
complessi mediante l’approccio combinato<br />
per via antero-retrograda, in pazienti affetti da<br />
patologie quali la calcolosi renale complessa e<br />
le stenosi dell’anastomosi uretero-ileale.<br />
In questo video presentiamo il caso di un<br />
paziente portatore di derivazione urinaria sec.<br />
Bricker in seguito a cistoprostatectomia radicale<br />
per carcinoma vescicale, con macroematuria<br />
da alcuni mesi e con sospetta stenosi a livello<br />
dell'anastomosi uretero-ileale sinistra alla TAC<br />
addominale; il paziente veniva sottoposto a<br />
procedura ureteroscopica diagnostica combinata<br />
per via antero-retrograda.<br />
Descrizione della procedura: Si pone il paziente<br />
in posizione supina sec. Valdivia-Uria. Si esegue<br />
preliminare condottoscopia dove si evidenzia<br />
il neomeato sinistro, non riuscendo<br />
però a far passare il filo guida per la stenosi serrata<br />
a livello dell'anastomosi uretero-ileale.<br />
Mediante guida ecografica e fluoroscopica si<br />
esegue quindi puntura della cavità renali di<br />
sinistra (dapprima il calice medio poi quello<br />
inferiore) e si inserisce quindi filo guida con il<br />
quale si riesce ad oltrepassare la stenosi della<br />
anastomosi uretero-ileale giungendo sino al<br />
condotto. Previa dilatazione progressiva si<br />
inserisce quindi una camicia ureterale nella<br />
quale si introduce l’ureteroscopio flessibile,<br />
<strong>7°</strong> <strong>Congresso</strong> <strong>Nazionale</strong> Associazione Italiana di Endourologia<br />
inserendo un altro filo guida, e giungendo sino<br />
all'anastomosi uretero-ileale che appare stenotica;<br />
non s’incontrano altre lesioni lungo tutto<br />
il decorso ureterale. Si pratica una biopsia con<br />
pinza. Si completa la procedura diagnostica<br />
eseguendo un’ureteroscopia semirigida per via<br />
retrograda che permette di oltrepassare la stenosi<br />
e non evidenzia ulteriori lesioni sospette.<br />
Applicazione di Mono J sinistro e nefrostomia<br />
sinistra al termine della procedura.<br />
Conclusioni: La posizione di Valdivia risulta essere<br />
particolarmente versatile, in quanto, oltre ad<br />
apportare vantaggi anestesiologici rispetto al<br />
decubito prono tradizionale, consente anche il<br />
trattamento di patologie complesse quali le stenosi<br />
delle anastomosi uretero-ileali in pazienti<br />
con derivazioni urinarie esterne, non altrimenti<br />
aggredibili solo per via retrograda.<br />
V22 1<br />
NEFROLITOTRISSIA PERCUTANEA CON PLU-<br />
RIMI ACCESSI ECOGUIDATI PER CALCOLO-<br />
SI A STAMPO COMPLESSA<br />
S. Micali, C. Di Pietro, S. De Stefani, F. Annino,<br />
C. De Carne, G. Bianchi<br />
Dipartimento di Urologia, Università di Modena e<br />
Reggio Emilia<br />
Introduzione: La tecnica della nefrolitotrissia<br />
percutanea (PCNL) ha subito negli ultimi anni<br />
un notevole miglioramento grazie al processo<br />
degli strumenti flessibili e delle fonti di energia<br />
per frammentare i calcoli. Tuttavia, nella maggior<br />
parte dei Centri, l’accesso al calice viene<br />
ancora eseguito sotto controllo fluoroscopico<br />
con esposizione ai raggi-x da parte del paziente<br />
e dell’operatore.<br />
Materiali: Da più di un anno presso il nostro<br />
centro eseguiamo tutte le procedure di PCNL<br />
con accesso al calice sotto guida ecografica ed<br />
utilizzando la fluoroscopia esclusivamente<br />
come controllo.<br />
Descriviamo il caso di un maschio di 34 anni<br />
con storia di litiasi urinaria bilaterale da alcuni<br />
anni, giunto alla nostra attenzione per IRA,<br />
urosepsi, calcolosi ureterale destra ostruente e<br />
calcolosi a stampo complessa della pelvi renale<br />
e di tutti i gruppi caliceali di sinistra. Si procedeva<br />
in fase acuta a posizionamento di nefrotomia<br />
bilaterale. Alla risoluzione del quadro settico<br />
dopo un mese, si procedeva ad ureterorenoscopia<br />
con litotrissia destra. Dopo 3 mesi si<br />
procedeva a PCNL sinistra che presentiamo ne<br />
video.<br />
Archivio Italiano di Urologia e Andrologia 2007, 79, 3, Supplemento 1 35
36<br />
<strong>7°</strong> <strong>Congresso</strong> <strong>Nazionale</strong> Associazione Italiana di Endourologia<br />
1° Tempo: paziente in posizione litotomica;<br />
posizionamento di cateterino ureterale 5 Ch<br />
per l’opacizzazione della via escretrice sinistra.<br />
2° Tempo: paziente in posizione prona; puntura<br />
ecoguidata di un calice inferiore con ago<br />
18G e creazione del tramite nefrostomico.<br />
Litotrissia dei calcoli maggiori con Swiss<br />
Lithoclast Master tramite nefoscopio rigido e<br />
dei calcoli minori in calici di difficile accesso<br />
con laser HolmiumYag tramite nefoscopio<br />
Circon ACMI con doppia deflessione.<br />
3° Tempo: creazione di secondo accesso ecoguidato<br />
da un calice medio e ripetizione della<br />
procedura.<br />
Si ottiene bonifica dei calcoli inferiori, calici<br />
medi, pelvi e parte dei calici superiori.<br />
Per l’alto rischio della manovra dovuto alla presenza<br />
di urine purulente in calice superiore, si<br />
decide di soprassedere alla terza puntura<br />
sovracostale, ove permane duplice calcolosi di<br />
2 cm.<br />
Risultati: La procedura è stata portata a termine<br />
in 108 minuti senza nessuna complicanza. È<br />
stata ottenuta la bonifica del 90% della calcolosi.<br />
Il paziente è stato dimesso in 5 a giornata<br />
post operatoria.<br />
La procedura è stata completata dopo 20 gg,<br />
con la bonifica dei calici superiori mediante<br />
PCNL con accesso intercostale.<br />
Conclusioni: La procedura di PCNL con litotrissia<br />
ad energia balistica ed ultrasuoni combinata<br />
rappresenta il “gold standard” per le calcolosi<br />
a stampo complesse e l’ausilio di nefoscopi<br />
flessibili e del laser può risultare utile nella loro<br />
gestione. L’accesso ecoguidato ai calici rende<br />
rapida, precisa e con minima esposizione ai<br />
raggi-X la creazione del tramite nefrostomico,<br />
rendendo ancora meno invasiva la procedura<br />
di PCNL.<br />
Video Aula Arancione<br />
19 SETTEMBRE 08.00-09.00<br />
Incontinenza - Laparoscopia<br />
V23<br />
IMPIANTO SIMULTANEO DI PROTESI PENIE-<br />
NA E SLING BULBO-URETRALE INAVNCE<br />
ATTRAVERSO UN UNICO ACCESSO PENO-<br />
SCROTALE<br />
I. Morra, F. Ragni, L. Rolle, A. Tamagnone,<br />
D. Fontana, R.M. Scarpa<br />
Divisione Universitaria di Urologia, Dipartimento di<br />
Scienze Cliniche e Biologiche, Università di Torino,<br />
Azienda Ospedaliera S. Luigi - Orbassano<br />
Archivio Italiano di Urologia e Andrologia 2007, 79, 3, Supplemento 1<br />
Introduzione: L’incontinenza urinaria e la disfunzione<br />
erettile costituiscono due importanti<br />
problemi della prostatectomia radicale. I trattamenti<br />
conservativi sia per il deficit erettile<br />
che per l’incontinenza urinaria rappresentano<br />
il primo approccio terapeutico.<br />
In caso di insuccesso la prostesi peniene gonfiabile<br />
rappresenta il gold standard per il trattamento<br />
del deficit erettile.<br />
Per il trattamento dell’incontinenza urinaria<br />
da sforzo post-prostatectomia le soluzioni proponiobili<br />
sono il bulking uretrale, lo sling e lo<br />
sfintere artificale (AUS).<br />
L’AUS è ritenuto attualmente il miglior trattamento<br />
per l’elevata percentuale di successi<br />
anche se recentemente lo sling bulbo-uretrale<br />
ha dimostrato di essere una valida soluzione<br />
miniinvasiva per il trattamento delle forma<br />
lievi e moderate.<br />
In questo video descriviamo la nostra tecnica<br />
per l’impianto contemporaneo di protesi<br />
peniena tricomponente (AMS CX 700) e sling<br />
bulbo-uretrale Invance attraverso una unica<br />
incisione peno-scrotale.<br />
Descrizione della tecnica: I pazienti sottoposti a<br />
questo intervento presentavano una incontinenza<br />
lieve o moderata associata a deficit erettile<br />
non responsivo alla terapia farmacologica.<br />
Si pone il paziente in posizione litotomica dorsale<br />
e dopo accurata preparazione cutanea<br />
viene inserito un catetere di 16 fr. Un’unica<br />
incisione a V rovesciata a livello peno scrotale<br />
consente l’esposizione dei corpi cavernosi e<br />
del corpo spongioso uretrale.<br />
Il primo tempo chirurgico prevede l’inserimento<br />
di 3 viti in titanio con sutura precaricata<br />
in prolene su ciascun ramo discendente dell’osso<br />
pubico. Durante questa manovra e’<br />
necessario far attenzione a non lesionare i<br />
corpi cavernosi.<br />
Il posizionamento delle viti avviene mediante<br />
utilizzo di trapano monouso “INVANCE”. Il<br />
tessuto adiposo che ricopre il muscolo bulbospongioso<br />
viene lasciato in sede.<br />
Il secondo tempo prevede il posizionamento<br />
della prostesi peniena tricomponente AMS CX<br />
700 “inhibizone” mediante due corporotomie<br />
longitudinali di 2 cm ciascuna.<br />
Si sviluppano gli spazi nei corpi cavernosi ed<br />
eseguite le misurazioni dei corpi cavernosi si<br />
applicano i cilidri della protesi.<br />
Si apre quindi la fascia trasversalis a livello<br />
dell’anello inguinale medialmente al funicolo<br />
spermatico e si posiziona il serbatoio nello<br />
spazio retropubico.
Il terzo tempo è costituito dal posizionamento<br />
della rete dello sling lascinado in sede il tessuto<br />
adiposo che ricopre l’uretra bulbare. Si allogia<br />
infine la pompa della protesi peniena nello<br />
scroto, si sutura la breccia chirurgica, e si<br />
applica drenaggio cistostomico.<br />
Risultati: Dal 2006 a oggi sono stati trattati 4<br />
pazienti.<br />
Il tempo operatorio medio è di circa 100<br />
minuti.<br />
La degenza media è di 2 giorni.<br />
Non si sono verificate complicanze peri e<br />
post-operatorie.<br />
Nessun paziente ha avuto complicanze infettive<br />
o erosioni da parte della protesi o dello<br />
sling.<br />
Attualmente i paziente presentano una soddisfacente<br />
vita sessuale con buona continenza.<br />
Commento: L’impianto simultaneo di protesi<br />
peniena e sling ha l’indubbio vantaggio di<br />
un'unica anestesia, una degenza e un tempo<br />
operatorio ridotti.<br />
In letteratura è riportata una esperienza di<br />
simultaneo impianto mediante doppio accesso<br />
peno-scotale per la protesi peniena e perineale<br />
per lo sling. Il doppio impianto mediante<br />
un unico accesso peno scrotale riduce teoricamente<br />
il rischio di infezioni perioperatorie<br />
poiché vi è una ridotta superficie di esposizione<br />
e un ridotto tempo operatorio; inoltre l’incisione<br />
a livello perineale presenta un alto<br />
rischio di contaminazione.<br />
Riteniamo che il doppio impianto di protesi<br />
peniene e sling bulbo-uretrale mediante un<br />
unico accesso rappresenti una valida soluzioni<br />
per quei pazienti sottoposti a prostatectomia<br />
radicale che presentano una incontinenza<br />
lieve o moderata associata defict erettile.<br />
V24<br />
ACCESSO PENO-SCROTALE PER IL TRATTA-<br />
MENTO DEL DEFICIT SFINTERIALE<br />
MASCHILE MEDIANTE SLING BULBO-URE-<br />
TRALE INVANCE<br />
I. Morra, F. Ragni, M. Poggio, C. Cracco,<br />
D. Vaccino, S. Grande, R.M.Scarpa<br />
Divisione Universitaria di Urologia, Dipartimento di<br />
Scienze Cliniche e Biologiche, Università di Torino,<br />
Azienda Ospedaliera S. Luigi - Orbassano<br />
Introduzione e Obiettivi: L’incontinenza urinaria<br />
rappresenta una delle complicanze più invalidanti<br />
della prostatectomia radicale. Lo sling<br />
bulbo-uretrale con ancoraggio osseo (Invance)<br />
<strong>7°</strong> <strong>Congresso</strong> <strong>Nazionale</strong> Associazione Italiana di Endourologia<br />
ha dimostrato in questi ultimi anni di essere<br />
una valida soluzione per il trattamento dell’incontinenza<br />
da sforzo lieve e moderata. La tecnica<br />
usualmente utilizzata prevede un approccio<br />
per via perineale; tale accesso presenta un<br />
rischio di contaminazione batterica sia in<br />
corso di intervento sia nel post-operatorio.<br />
In questo video presentiamo un accesso alternativo<br />
peno-scrotaler per l’applicazione dello<br />
sling bulbo-uretrale InVance al fine di ridurre<br />
il rischio infettivo.<br />
Descrizione della tecnica: Si pone il paziente in<br />
posizione litotomica dorsale e dopo accurata<br />
preparazione cutanea viene inserito un catetere<br />
di 16 Fr. Si esegue un’incisione a V rovesciata<br />
a livello peno scrotale. Si isola il bordo<br />
inferiore della branca ischio-pubica su<br />
entrambi i lati. Il periostio viene inciso con<br />
elettrobisturi, quindi, utilizzando il trapano<br />
monouso InVance si inseriscono 3 viti in titanio<br />
con sutura precaricata in prolene su ciascuna<br />
branca ponendo attenzione a non lesionare<br />
i corpi cavernosi.<br />
La prima vite viene applicata più in alto possibile<br />
subito sotto la sinfisi pubica, le successive<br />
distano un cm l’una dall’altra.<br />
Non si isola l’uretra bulbare lasciando il tessuto<br />
adiposo a ricoprire il muscolo bulbospongioso.<br />
Una rete in polipropilene, rivestita in silicone<br />
(Intemesh), viene dapprima solidarizzata alle<br />
viti di un lato tramite i fili di prolene, quindi,<br />
rimosso il catetere vescicale, la si fissa controlateralmente<br />
con adeguata tensione; a tal fine<br />
può essere necessario ritagliare la rete in eccesso<br />
adattandola alla conformazione anatomica<br />
del paziente.<br />
Si riposiziona il catetere vescicale e si sutura la<br />
breccia chirurgica. Il tempo operatorio è di 45<br />
minuti.<br />
Commenti: I dati della letteratura più recente<br />
dimostrano come lo sling bulbo-uretrale con<br />
ancoraggio osseo rappresenti una valida soluzione<br />
mini-invasiva per il trattamento dell’incontinenza<br />
maschile iatrogena lieve o moderata.<br />
L’approccio peno-scrotale, oltre a consentire<br />
una adeguata preparazione delle branche<br />
ischio-pubiche, presenta un minor rischio di<br />
contaminazione batterica sia durante l’intervento<br />
che nel post-operatorio.<br />
Nella nostra esperienza non si sono verificate<br />
infezioni della ferita o della rete. Tale accesso<br />
sembra inoltre più vantaggioso anche per il<br />
paziente poiché riduce il dolore perineale e<br />
facilita la medicazione<br />
Archivio Italiano di Urologia e Andrologia 2007, 79, 3, Supplemento 1 37
38<br />
<strong>7°</strong> <strong>Congresso</strong> <strong>Nazionale</strong> Associazione Italiana di Endourologia<br />
V25<br />
CORREZIONE DI PROLASSO VAGINALE<br />
TOTALE RECIDIVO PER VIA VAGINALE<br />
MEDIANTE UTILIZZO DEI DISPOSITIVI PERI-<br />
GEE E APOGEE<br />
I. Morra, F. Ragni, M. Poggio, C. Cracco,<br />
D. Vaccino, S. Grande, R.M.Scarpa<br />
Divisione Universitaria di Urologia, Dipartimento di<br />
Scienze Cliniche e Biologiche, Università di Torino,<br />
Azienda Ospedaliera S. Luigi - Orbassano<br />
Introduzione e Obiettivi: In questi anni numerose<br />
tecniche e materiali sono stati proposti per la<br />
correzione del prolasso vaginale. In questo<br />
video descriviamo l’utilizzo di due dispositivi<br />
dell’American Medical System, il sistema<br />
Perigee e il sistema Apogee, per il trattamento<br />
un voluminoso prolasso vaginale recidivo .<br />
Descrizione della tecnica: Si tratta di una paziente<br />
di 90 anni con prolasso vaginale totale determinante<br />
ritenzione totale di urina, iscuria paradossa<br />
e alterazione dello svuotamento dell’ampolla<br />
rettale. Entrambi i sistemi, Perigee e<br />
Apogee, sono costituiti da introduttori appositamente<br />
sagomati che permettono l’applicazione<br />
di reti in polipropilene opportunamente<br />
sagomate per la correzione del cistocele, del<br />
prolasso della cupola vaginale e del rettocele.<br />
La paziente dopo anestesia spinale, viene posta<br />
in posizione litotomica dorsale, quindi, dopo<br />
aver inserito il catetere e identificato l’apice<br />
della cupola vaginale, si esegue una colpotomia<br />
longitudinale mediana sulla parete anteriore;<br />
ampia dissezione della parete vaginale dalla<br />
vescica con individuazione della spina ischiatica<br />
bilateralmente e apertura della fascia pelvica.<br />
Il primo ago sagomato del Perigee viene<br />
inserito mediante piccola incisone nella piega<br />
inguinale all’altezza del clitoride e fatto fuoriuscire<br />
al disotto del collo vescicale. Il secondo<br />
ago sagomato viene inserito mediante una piccola<br />
incisione eseguita 2 cm più in basso e lateralmente<br />
rispetto alla precedente; la punta dell’ago<br />
viene diretta verso la spina ischiatica<br />
facendola fuoriuscire anteriormente a essa.<br />
Dopo ogni passaggio, verificata l’integrità delle<br />
strutture, vengono agganciati i bracci della rete<br />
agli introduttori che vengono estratti. Analoga<br />
procedura viene eseguita controlateralmente.<br />
Si distende la rete al di sotto della vescica e si<br />
procede quindi alla correzione del comparto<br />
posteriore e della cupola eseguendo una colpotomia<br />
longitudinale e dissecando il piano<br />
retto-vaginale fino a identificare la spina ischiatica<br />
bilateralmente. Due piccole incisioni<br />
Archivio Italiano di Urologia e Andrologia 2007, 79, 3, Supplemento 1<br />
vengo eseguite 3 cm lateralmente e posteriormente<br />
all’ano per introdurre l’ago dell’Apogee<br />
che viene fatto scorrere attraverso la fossa<br />
ischiorettale fino al davanti della spina ischiatica.<br />
Le estremità della mesh vengono fissate agli<br />
aghi che vengono quindi retratti. Le estremità<br />
distali della reti dell’Apogee e Perigee vengono<br />
fissate tra loro e traendo i rispettivi bracci si<br />
riporta in posizione fisiologica la cupola vaginale;<br />
il corpo della rete dell’Apogee viene utilizzato<br />
per correggere il rettocele. Si recenta la<br />
parete vaginale in eccesso e si sutura la parete<br />
vaginale.<br />
Al termine dell’intervento si pone uno zaffo in<br />
vagina.<br />
Commenti: I dati di letteratura sull’utilizzo del<br />
Perigee e dell’ Apogee dimostrano la buona<br />
efficacia e sicurezza di questi due prodotti per<br />
la correzione del prolasso vaginale.<br />
Nella nostra esperienza, l’utilizzo combinato di<br />
entrambi i dispositivi ha consentito una adeguata<br />
correzione dei prolassi vaginali totali con<br />
ripristino di una fisiologica anatomia vaginale e<br />
la ripresa di minzioni e defecazioni spontanee.<br />
Al controllo a 6 mesi non sono stati osservati<br />
segni di erosione o decubito della rete, nè di<br />
prolasso.<br />
V26<br />
NUOVO APPROCCIO CHIRURGICO MINI-<br />
INVASIVO NEL TRATTAMENTO DEL RETTO-<br />
CELE (APOGEE SYSTEM)<br />
S. Fornia, A. Salvaggio, M.. Ciuffreda, F. Dinale,<br />
M.Simonazzi<br />
Unità Operativa di Urologia, Azienda Ospedaliero-<br />
Universitaria di Parma<br />
VIDEO<br />
Nel video presentiamo una nuova tecnica chirurgica<br />
mini-invasiva transvaginale tension free<br />
per il trattamento e la correzione del prolasso<br />
posteriore degli organi pelvici.<br />
La paziente, dopo anestesia spinale, viene<br />
posta in posizione litotomica. Praticata cateterizzazione<br />
vescicale si infiltra con soluzione<br />
fisiologica la parete vaginale posteriore per<br />
favorire la dissezione dei piani chirurgici. Si<br />
incide il perineo longitudinalmente per 3-4 cm<br />
e si isola la parete vaginale dal retto fino al<br />
piano vescicale. Si posiziona la bendarella di<br />
polipropilene che viene ancorata tension free<br />
attraverso un passaggio trans-gluteo bilateralmente<br />
con ago ricurvo che passa a 2 cm sotto<br />
la spina ischiatica fino allo spazio precedente-
mente ricavato tra retto e vagina. Si regolarizza<br />
il posizionamento della bendarella con 2 punti<br />
di ancoraggio sul versante vescicale della vagina.<br />
L’esplorazione rettale conferma il corretto<br />
passaggio degli aghi.<br />
La tecnica di recente applicazione, seppur con<br />
follow up breve, permette una risoluzione chirurgica<br />
mini-invasiva, di facile esecuzione e<br />
riproducibilità.<br />
V27<br />
ESPLORAZIONE LAPAROSCOPICA DI UNA<br />
NEOFORMAZIONE RETROPERITONEALE SO-<br />
SPETTA PER RECIDIVA DI CARCINOMA A<br />
CELLULE RENALI<br />
A. Campagna, P. Bove, E. Finazzi Agrò, A.<br />
Asimakopoulos, R. Miano, G. Vespasiani<br />
Cattedra di Urologia, Università di Roma “Tor<br />
Vergata”, Roma<br />
Obiettivi: Descriviamo un case report relativo ad<br />
una sospetta recidiva retroperitoneale di carcinoma<br />
a cellule renali in un paziente sottoposto<br />
5 mesi prima a nefrectomia radicale.<br />
Materiali e Metodi: Nell’Ottobre 2006 un<br />
paziente di 70 anni viene sottoposto, presso la<br />
nostra Divisione di Urologia, a nefrectomia<br />
radicale sinistra per una neoformazione di<br />
circa 9 cm di diametro. L’esame istologico evidenziava<br />
un carcinoma a cellule renali non<br />
infiltrante il grasso perirenale ed il seno renale<br />
(pT2). Durante il follow-up, l’esame TC con<br />
m.d.c. eseguito nel febbraio 2007 mostrava, a<br />
livello della loggia renale di sinistra, una formazione<br />
rotondeggiante del diametro di circa<br />
2,3 cm con potenziamento parietale dopo<br />
somministrazione del m.d.c. ascrivibile a recidiva<br />
di malattia. Per tale motivo il paziente<br />
veniva sottoposto ad esplorazione laparoscopica<br />
transperitoneale che confermava la presenza<br />
di una lesione tondeggiante, ben capsulata,<br />
tenacemente adesa ai tessuti circostanti. Il<br />
controllo ecografico intraoperatorio evidenziava<br />
un contenuto della formazione solido,<br />
omogeneo e privo di vascolarizzazione.<br />
L’esame bioptico della parete mostrava il contenuto<br />
della lesione che si presentava con<br />
aspetto riferibile a mesh emostatico parzialmente<br />
riassorbito.<br />
Risultati: La sospetta neoformazione è stata<br />
asportata per via laparoscopica trans peritoneale.<br />
La durata dell’intervento è stata di 180<br />
minuti con perdite ematiche intraoperatorie<br />
trascurabili.<br />
<strong>7°</strong> <strong>Congresso</strong> <strong>Nazionale</strong> Associazione Italiana di Endourologia<br />
L’esame istologico della parete della lesione ha<br />
evidenziato tessuto fibro-muscolare sede di<br />
flogosi cronica, mentre il contenuto della<br />
lesione è stato descritto come materiale trombotico<br />
in fase di organizzazione. Il paziente<br />
veniva dimesso in terza giornata post-operatoria<br />
senza nessuna complicanza intra o postoperatoria.<br />
Discussione e Conclusioni: Ad oggi, non sono<br />
riportati in letteratura altri casi di “textiloma”<br />
dovuti ad incompleto riassorbimento di mesh<br />
emostatico (SURGICEL), sospetto per recidiva<br />
di neoplasia. Anche in questo caso, così come<br />
per i “textilomi” da tessuto non riassorbibile<br />
(i.e. garze chirurgiche), la reazione granulomatosa<br />
periferica può dare luogo a lesioni che<br />
all’esame TC appaiono caratterizzate da potenziamento<br />
parietale dopo infusione di m.d.c.;<br />
inoltre mentre le garze chirurgiche sono radiologicamente<br />
riconoscibili grazie al marker<br />
radiopaco i mesh emostatici ne sono privi ed<br />
offrono in caso di reazione granulomatosa,<br />
una difficoltà diagnostica superiore.<br />
V28<br />
NEFROURETERECTOMIA LAPAROSCOPICA<br />
DESTRA CON LITOTRISSIA DI CALCOLOSI Ø<br />
2 CM DELL’URETERE INTRAMURALE IN<br />
DOPPIO DISTRETTO COMPLETO (VIDEO)<br />
R. Tarabuzzi, F. Varvello, G. Marchioro, G. Maso,<br />
S. Ranzoni, F. Sogni, C. Terrone<br />
Ospedale Maggiore della Carità, Novara<br />
Introduzione: Riportiamo il caso di una donna<br />
di 39 anni, con storia di pielonefriti destre recidivanti<br />
associate, negli ultimi tempi, a disturbi<br />
minzionali della fase di svuotamento persistenti,<br />
con riscontro urografico e TC di doppio<br />
distretto completo a destra con calcolosi di diametro<br />
2 cm dell’uretere intramurale di pertinenza<br />
del distretto superiore.<br />
Materiali e Metodi: La paziente è stata sottoposta,<br />
previo controllo cistoscopico, a nefroureterectomia<br />
laparoscopica destra transperitoneale.<br />
Terminato il tempo demolitivo sul rene, dopo<br />
aver cambiato la posizione della paziente e<br />
degli operatori, si è passati all’isolamento della<br />
porzione terminale degli ureteri. Con l’aiuto di<br />
un ureteroscopio flessibile introdotto attraverso<br />
un trocar nel lume ureterale è stato localizzato<br />
l’uretere contenente il calcolo. Successivamente<br />
alla litotrissia i frammenti sono stati<br />
asportati mediante pinze di Johan. Al termine<br />
entrambi gli ureteri sono stati sezionati previa<br />
Archivio Italiano di Urologia e Andrologia 2007, 79, 3, Supplemento 1 39
40<br />
<strong>7°</strong> <strong>Congresso</strong> <strong>Nazionale</strong> Associazione Italiana di Endourologia<br />
chiusura con Hem-o-lok. Il rene è stato asportato<br />
mediante incisione di servizio di 4 cm su<br />
pregresso Pfannestiel. In quinta giornata postoperatoria<br />
la paziente è stata sottoposta a cistoscopia<br />
con litotrissia laser e asportazione dei<br />
frammenti residui. È stato inoltre esplorato il<br />
moncone ureterale distale in cui alloggiava il<br />
calcolo con evacuazione di minuscoli residui<br />
litiasici.<br />
Risultati: L’esame istologico ha confermato il<br />
GENERAL INFORMATION<br />
AIMS AND SCOPE<br />
“Archivio Italiano di Urologia e Andrologia” publishes<br />
papers dealing with the urological, nephrological and<br />
andrological sciences.<br />
Original articles on both clinical and research fields,<br />
reviews, editorials, case reports, abstracts from papers<br />
published elsewhere, book rewiews, congress proceedings<br />
can be published.<br />
Papers submitted for publication and all other editorial<br />
correspondence should be addressed to:<br />
Edizioni Scripta Manent s.n.c.<br />
Via Bassini 41<br />
20133 Milano - Italy<br />
Tel. +39 0270608091 - Fax +39 0270606917<br />
e-mail: scriman@tin.it architurol@tin.it<br />
www.architurol.it<br />
COPYRIGHT<br />
Papers are accepted for publication with the understanding<br />
that no substantial part has been, or will be published<br />
elsewhere.<br />
By submitting a manuscript, the authors agree that the<br />
copyright is transferred to the Publisher if and when the<br />
article is accepted for publication.<br />
Archivio Italiano di Urologia e Andrologia 2007, 79, 3, Supplemento 1<br />
quadro di pielonefrite cronica in rene idronefrotico.<br />
La paziente è stata dimessa in sesta<br />
giornata. La radiografia diretta eseguita a 1<br />
mese dall’intervento non ha dimostrato frammenti<br />
residui.<br />
Conclusioni: La tecnica laparoscopica abbinata<br />
all’utilizzo di endoscopi flessibili è risultata<br />
efficace e versatile consentendo un approccio<br />
mini invasivo anche nel caso di una situazione<br />
insolita come quella da noi affrontata.<br />
The copyright covers the exclusive rights to reproduce<br />
and distribute the article, including reprints, photographic<br />
reproduction and translation.<br />
No part of this publication may be reproduced, stored<br />
in a retrieval system, or transmitted in any form or by<br />
any means, electronic, mechanical, photocopying,<br />
recording or otherwise, without thr prior written permission<br />
of the Publisher.<br />
Registrazione: Tribunale di Milano n.289 del 21/05/2001<br />
Direttore Responsabile: Pietro Cazzola<br />
Direzione Generale: Armando Mazzù<br />
Direzione Marketing: Antonio Di Maio<br />
Consulenza grafica: Piero Merlini<br />
Impaginazione: Clementina Pasina<br />
Stampa:<br />
Parole Nuove s.r.l. - Via Garibaldi 58<br />
20047 Brugherio, Milano - Italy<br />
Ai sensi della legge 675/96 è possibile in qualsiasi momento opporsi all’invio della rivista comunicando per iscritto la propria decisione a:<br />
Edizioni Scripta Manent s.n.c. - Via Bassini, 41 - 20133 Milano
The role of fluorescent cystoscopy<br />
with hexaminolevulinate in the diagnosis<br />
of bladder cancer.<br />
A. Volpe, F. Porpiglia, M. Billia, R.M. Scarpa<br />
Urothelial carcinoma of the bladder is the sixth most common<br />
malignant disease in the world. In 75–85% of cases,<br />
bladder tumors are superficial at first diagnosis. However,<br />
50–70% of patients presenting with superficial bladder<br />
cancer will develop one or several recurrences after initial<br />
treatment with transurethral resection (TUR), while 10-<br />
20% will experience disease progression with infiltration of<br />
the bladder muscle. White light cystoscopy (WLC) and urinary<br />
cytology are the standard methods for detecting bladder<br />
cancer, but their sensitivity and specificity are not completely<br />
satisfactory, leading to a relatively frequent incomplete<br />
detection of primary or recurrent tumors (1,2). Flat<br />
urothelial lesions, such as CIS or urothelial dysplasia, are<br />
particularly difficult to visualize endoscopically with classical<br />
WLC because they are frequently located in unspecifically<br />
inflamed or normal appearing mucosa. Even the use<br />
of random biopsies does not result in a clinically relevant<br />
improvement in the diagnosis of CIS (3). This is particularly<br />
important since CIS is characterized by a higher risk<br />
of progression to muscle invasive disease.<br />
Furthermore, the risk of incomplete removal of tumour tissue<br />
during transurethral resection of bladder tumour<br />
(TURBT) is significant, either by overlooking flat dysplastic<br />
lesions extending from the resected tumour, or tiny papillary<br />
satellite tumours. Tumour remnants were found in up<br />
to over 50% of cases at a second-look resection 4-6 weeks<br />
after a first TURBT (4,5). The tumours that have been<br />
missed during the resection will account for at least part of<br />
the frequent positive cystoscopies 3-6 months after initial<br />
treatment and may be responsible for a decreased survival.<br />
To improve the sensitivity of WLC, especially for CIS, fluorescence<br />
cystoscopy (FC) has been studied extensively in<br />
the last few years (6). FC is a technique of photodynamic<br />
diagnosis (PDD). PDD is based on the interaction between<br />
a fluorochrome with a high selectivity for tumour cells and<br />
light with an appropriate wavelength, which is absorbed by<br />
the fluorochrome and reemitted with a different (longer)<br />
wavelength. Since the early 1990s, 5-aminolaevulinic acid<br />
(5-ALA) has been investigated for the fluorescent detection<br />
of urothelial cancer. ALA is a precursor in the heme biosynthesis<br />
pathway and induces an accumulation of fluorescent<br />
endogenous porphyrins, mainly protoporphyrin IX (PPIX)<br />
in tissues of epithelial origin (7).<br />
The mechanisms that lead to an increased production of<br />
fluorescent PPIX in cancerous tissue are currently not fully<br />
understood. Several theories have been proposed, including<br />
differences in the level of cellular metabolism, structur-<br />
<strong>7°</strong> <strong>Congresso</strong> <strong>Nazionale</strong> Associazione Italiana di Endourologia<br />
Divisione Universitaria di Urologia, ASO San Luigi Gonzaga, Orbassano, Università di Torino<br />
al characteristics of diseased urothelium, inflammation<br />
with consequent increase in permeability to ALA and<br />
hyperproliferation of the urothelium, leading to a cumulative<br />
effect. There are mainly two enzymes in the biosynthesis<br />
of heme considered responsible for a tumour cell-specific<br />
accumulation of PPIX: porphobilinogen deaminase<br />
and ferrochelatase. The former is the rate limiting enzyme<br />
and has been identified in greater concentrations in tumour<br />
tissue. Clinical results with 5-ALA cystoscopy have been<br />
very encouraging. Kriegmair et al. first evaluated the significance<br />
and feasibility of the procedure, comparing endoscopic<br />
findings under white light and fluorescent cystoscopy<br />
and histology. A very high correlation was<br />
observed between biopsies taken from areas with either<br />
negative or positive fluorescence and histological findings.<br />
In particular, a sensitivity of more than 95% and a specificity<br />
of 68.5% was achieved (8). Other series have subsequently<br />
confirmed these findings (9-12). Overall, FC<br />
accounts for an increase in the tumor detection rate<br />
between 18-76% as compared to WLC.<br />
Zaak et al. have the largest experience with 5-ALA FC. In<br />
their series tumors were detected only because of positive<br />
fluorescence in 26.4% of cases. The incidence of CIS and<br />
severe dysplasia in this patient group was 26.9%. Also, in<br />
cases of suspicious cytological findings with negative WLC,<br />
FC was able to considerably increase the tumor detection<br />
rate (7).<br />
In addition to flat urothelial lesions, the high rate of residual<br />
tumor after TUR represents another reason for the high<br />
recurrence rate of bladder tumors after the first resection. A<br />
multicentre, randomized prospective trial including 165<br />
patients was carried out in 1997-98 to investigate whether<br />
FC-guided TURBT is able to reduce the rate of overlooked<br />
tumors. The Authors compared the rate of residual<br />
tumours 10-14 days after initial resection and found that<br />
62% of patients were tumor-free after FC-guided TURBT<br />
vs. 41% of cases after WLC-guided TURBT (p < 0.01).<br />
Therefore, the rate of residual tumor could be reduced significantly<br />
by nearly 40% under fluoroscopic guidance (13).<br />
In another study of 191 patients with superficial bladder<br />
cancer, the residual tumour rate at 5-6 weeks from the initial<br />
resection was 25.2% in the WLC arm versus 4.5% in<br />
the FC arm (p < 0.0001) (14).<br />
Some studies have been also carried out to determine<br />
whether FC-guided TUR is able to increase recurrence free<br />
survival. Initial results showed a clear trend towards lower<br />
recurrence rates in patients who had been resected under<br />
Archivio Italiano di Urologia e Andrologia 2007, 79, 3, Supplemento 1<br />
41
42<br />
<strong>7°</strong> <strong>Congresso</strong> <strong>Nazionale</strong> Associazione Italiana di Endourologia<br />
5-ALA induced FC. To confirm these findings, European<br />
multicentre long-term follow-up studies are ongoing.<br />
Filbeck et al. published preliminary results, showing a significant<br />
higher recurrence-free survival in the FC group<br />
(89.6% vs. 65.9% at 24 months - p = 0.004). Recurrencefree<br />
survival after 12 and 24 months was 73.8% and 65.9%<br />
in the WLC group and 89.6% and 89.6% in the FC group,<br />
respectively (14).<br />
Recently, it has been shown that the esterification of ALA<br />
into more lipophilic derivates, such as Hexaminolevulinate<br />
(HAL) (Hexvix ® ) results in up to 25-fold increase of the fluorescence<br />
compound Protoporphyrin IX (15,16). HAL has<br />
several advantages compared to 5-ALA: 1) intravesical<br />
administration rather than systemic administration, 2) the<br />
need of a shorter instillation time (one hour), 3) higher<br />
selectivity and brighter fluorescence, 4) better contrast, 5)<br />
less photobleeching. These characteristics have the potential<br />
to make this technique a significant improvement in the<br />
detection of bladder tumours and in patient management.<br />
Several studies have been already published showing the<br />
feasibility and accuracy of HAL cistoscopy (17-19).<br />
Schmidbauer et al. were able to detect 28% more patients<br />
with CIS with HAL cystoscopy as compared to WLC.18<br />
Jocham et al. observed a significantly improved tumor<br />
detection rate compared to WLC (96% vs. 77%), particularly<br />
for dysplasia (93% vs. 48%), CIS (95% vs. 68%) and<br />
superficial papillary tumors (96% vs. 85%) (19).<br />
Furthermore, Witjes et al. and Loidl et al. have shown that<br />
HAL flexible cystoscopy is feasible and accurate, with<br />
results that are comparable to white light cystoscopy and<br />
slightly inferior to rigid HAL cystoscopy (20,21).<br />
Large multicentre, randomized prospective trials are needed<br />
to confirm the role of HAL cystoscopy in the diagnosis<br />
and treatment of bladder tumour and to assess whether<br />
HAL cystoscopy is able to decrease the rate of residual<br />
tumors after TURBT and to increase long-term recurrence<br />
free survival.<br />
REFERENCES<br />
1. Brausi M, Collette L, Kurth K, van der Meijden AP, Oosterlinck W,<br />
Witjes JA, Newling D, Bouffioux C and Sylvester RJ: Variability in the<br />
recurrence rate at first follow-up cystoscopy after TUR in stage Ta T1<br />
transitional cell carcinoma of the bladder: a combined analysis of seven<br />
EORTC studies. Eur Urol. 41: 523-31, 2002.<br />
2. Herr HW: The value of a second transurethral resection in evaluating<br />
patients with bladder tumors. J Urol. 162: 74-6, 1999.<br />
3. Witjes JA, Kiemeney LA, Verbeek AL, Heijbroek RP and Debruyne<br />
FM: Random bladder biopsies and the risk of recurrence in superficial<br />
bladder cancer. A prospective study in 1026 patients. . World J Urol.<br />
10: 231-4, 1992.<br />
4. Schwaibold HE, Sivalingam S, May F and Hartung R: The value of<br />
a second transurethral resection for T1 bladder cancer. BJU Int. 97:<br />
1199-201, 2006.<br />
5. Herr HW, Donat SM and Dalbagni G: Can restaging transurethral<br />
resection of T1 bladder cancer select patients for immediate cystectomy?<br />
J Urol. 177: 75-9; discussion 79, 2007.<br />
6. Zaak D, Hungerhuber E, Schneede P, Stepp H, Frimberger D,<br />
Corvin S, Schmeller N, Kriegmair M, Hofstetter A and Knuechel R:<br />
Role of 5-aminolevulinic acid in the detection of urothelial premalignant<br />
lesions. Cancer. 95: 1234-8, 2002.<br />
7. Zaak D, Karl A, Knuchel R, Stepp H, Hartmann A, Reich O,<br />
Archivio Italiano di Urologia e Andrologia 2007, 79, 3, Supplemento 1<br />
Bachmann A, Siebels M, Popken G and Stief C: Diagnosis of urothelial<br />
carcinoma of the bladder using fluorescence endoscopy. BJU Int. 96:<br />
217-22, 2005.<br />
8. Kriegmair M, Baumgartner R, Knuchel R, Stepp H, Hofstadter F<br />
and Hofstetter A: Detection of early bladder cancer by 5-aminolevulinic<br />
acid induced porphyrin fluorescence. J Urol. 155: 105-9; discussion<br />
109-10, 1996.<br />
9. Filbeck T, Roessler W, Knuechel R, Straub M, Kiel HJ and Wieland<br />
WF: Clinical results of the transurethreal resection and evaluation of<br />
superficial bladder carcinomas by means of fluorescence diagnosis after<br />
intravesical instillation of 5-aminolevulinic acid. J Endourol. 13: 117-<br />
21, 1999.<br />
10. De Dominicis C, Liberti M, Perugia G, De Nunzio C, Sciobica F,<br />
Zuccala A, Sarkozy A and Iori F: Role of 5-aminolevulinic acid in the<br />
diagnosis and treatment of superficial bladder cancer: improvement in<br />
diagnostic sensitivity. Urology. 57: 1059-62, 2001.<br />
11. Koenig F, McGovern FJ, Larne R, Enquist H, Schomacker KT and<br />
Deutsch TF: Diagnosis of bladder carcinoma using protoporphyrin IX<br />
fluorescence induced by 5-aminolaevulinic acid. BJU Int. 83: 129-35,<br />
1999.<br />
12. Riedl CR, Daniltchenko D, Koenig F, Simak R, Loening SA and<br />
Pflueger H: Fluorescence endoscopy with 5-aminolevulinic acid reduces<br />
early recurrence rate in superficial bladder cancer. J Urol. 165: 1121-<br />
3, 2001.<br />
13. Kriegmair M, Zaak D, Rothenberger KH, Rassweiler J, Jocham D,<br />
Eisenberger F, Tauber R, Stenzl A and Hofstetter A: Transurethral<br />
resection for bladder cancer using 5-aminolevulinic acid induced fluorescence<br />
endoscopy versus white light endoscopy. J Urol. 168: 475-8,<br />
2002.<br />
14. Filbeck T, Pichlmeier U, Knuechel R, Wieland WF and Roessler W:<br />
Clinically relevant improvement of recurrence-free survival with 5aminolevulinic<br />
acid induced fluorescence diagnosis in patients with<br />
superficial bladder tumors. J Urol. 168: 67-71, 2002.<br />
15. Lange N, Jichlinski P, Zellweger M, Forrer M, Marti A, Guillou L,<br />
Kucera P, Wagnieres G and van den Bergh H: Photodetection of early<br />
human bladder cancer based on the fluorescence of 5-aminolaevulinic<br />
acid hexylester-induced protoporphyrin IX: a pilot study. Br J Cancer.<br />
80: 185-93, 1999.<br />
16. Marti A, Jichlinski P, Lange N, Ballini JP, Guillou L, Leisinger HJ<br />
and Kucera P: Comparison of aminolevulinic acid and hexylester<br />
aminolevulinate induced protoporphyrin IX distribution in human<br />
bladder cancer. J Urol. 170: 428-32, 2003.<br />
17. Jichlinski P, Guillou L, Karlsen SJ, Malmstrom PU, Jocham D,<br />
Brennhovd B, Johansson E, Gartner T, Lange N, van den Bergh H et<br />
al.: Hexyl aminolevulinate fluorescence cystoscopy: new diagnostic tool<br />
for photodiagnosis of superficial bladder cancer--a multicenter study. J<br />
Urol. 170: 226-9, 2003.<br />
18. Schmidbauer J, Witjes F, Schmeller N, Donat R, Susani M and<br />
Marberger M: Improved detection of urothelial carcinoma in situ with<br />
hexaminolevulinate fluorescence cystoscopy. J Urol. 171: 135-8, 2004.<br />
19. Jocham D, Witjes F, Wagner S, Zeylemaker B, van Moorselaar J,<br />
Grimm MO, Muschter R, Popken G, Konig F, Knuchel R et al.:<br />
Improved detection and treatment of bladder cancer using hexaminolevulinate<br />
imaging: a prospective, phase III multicenter study. J<br />
Urol. 174: 862-6; discussion 866, 2005.<br />
20. Witjes JA, Moonen PM and van der Heijden AG: Comparison of<br />
hexaminolevulinate based flexible and rigid fluorescence cystoscopy<br />
with rigid white light cystoscopy in bladder cancer: results of a prospective<br />
Phase II study. Eur Urol. 47: 319-22, 2005.<br />
21. Loidl W, Schmidbauer J, Susani M and Marberger M: Flexible cystoscopy<br />
assisted by hexaminolevulinate induced fluorescence: a new<br />
approach for bladder cancer detection and surveillance? Eur Urol. 47:<br />
323-6, 2005.
<strong>7°</strong> <strong>Congresso</strong> <strong>Nazionale</strong> Associazione Italiana di Endourologia<br />
Mini-percutaneous procedure (MIPP): a new set.<br />
Summary<br />
Antonio Frattini, Stefania Ferretti, Paolo Salsi, Umberto Maestroni, Pietro Cortellini<br />
Urology Unit, Azienda Ospedaliero-Universitaria of Parma, Italy<br />
Objective: We are presenting our instrumental set for mini-percutaneous procedure<br />
(MIPP-set), manufactured in collaboration with RÜSCH Medical Company, along with<br />
our indications and clinical experience.<br />
Methods: From January 2002 to December 2006, we treated with MIPP, 63 patients,<br />
range 2-76 years. Percutaneous lithotripsy was performed in 57/63 patients, for stones<br />
of 21 ± 10 mm burden; 4/63 pts underwent a new recanalization for uroenteric strictures in 3<br />
neobladders and 1 ileal conduit; in 1/63 pt was performed a L.A.S.E.R. ablation of a small<br />
superficial transitional cell carcinoma; in 1/63 pt was extracted a ureteral stent migrated to the<br />
pelvis.<br />
Results: For 57 nephrolithotripsy procedures stone- free rate was 98.3%; 1 patient needed stenting<br />
for hydronephrosis and in 3 patients were positioned a monoJ catheter for haematuria for<br />
some days, totally 7/63 pts were transfused (11%); the mean extimated blood loss was 0,65 ±<br />
1,05 g/dL HB (range 0,1- 3,9 g/dL HB); for residual procedures (6 patients) there were no complications;<br />
the mean hospital stay was 4,2 ± 2,8 days (range 2- 14 days).<br />
Conclusions: The limits of this technique are: major operation times and consequently major<br />
costs; more difficulties in vision and operability. The advantages are: less trauma, reduction of<br />
bleeding, possibility of tubeless procedures and shorter recovery times. Supine position is certainly<br />
a step forward in terms of reducing operative times and percentage of clearance of the<br />
fragments. The progress mainly in optics and the miniaturization of instruments will make the<br />
procedure more useful and effective.<br />
KEY WORDS: Minipercutaneous procedure; Percutaneous nephrolithotripsy; MIPP-set; MINI-perc.<br />
INTRODUCTION<br />
Percutaneous nephrostomy procedures are generally<br />
safe. The associated mortality rate is approximately<br />
0,04% and the incidence of important complications is<br />
about 5%. But, if we consider other aspects such as: hospitality<br />
time, post-operative pain, patients with coagulation<br />
diseases or renal abnormalities or transplanted kidney,<br />
the minimal nephrostomy procedures are advisable.<br />
We are presenting our instrumental set for mini-percutaneous<br />
procedure (MIPP-set), manufactured in collaboration<br />
with RÜSCH Medical Company, along with our<br />
indications and clinical experience.<br />
METHOD AND MATERIAL<br />
We consider Minimal Percutaneous approach, a<br />
nephrostomy tract equal or less than 14 Fr (inner diameter).<br />
Our dilation set (MIPP PU/PVC by Frattini-<br />
Cortellini) consists of : a 17,5 Gauge needle, a 0,035 inch<br />
guide wire Lunderquist-type, 2 coaxial hydrophilic dilators<br />
(9,14 Fr), a 14 Fr Amplatz sheath and a 12 Fr silicone-<br />
coated nephrostomic catheter with metallic gauge<br />
(Figure 1); the operative instruments should be a 11 Fr<br />
Figure 1.<br />
The MIPP set.<br />
Archivio Italiano di Urologia e Andrologia 2007, 79, 3, Supplemento 1<br />
43
44<br />
<strong>7°</strong> <strong>Congresso</strong> <strong>Nazionale</strong> Associazione Italiana di Endourologia<br />
Renal stones equal or less than 1,5 cm diameter<br />
ESWL-refractory renal stones<br />
Adjuvant procedure during standard PNL<br />
Pediatric PNL<br />
Antegrade LASER endopyelothomy<br />
rigid ureteroscope (at the beginning of our experience)<br />
using a ballistic probe for lithotripsy or a LASER probe,<br />
or better a 14 Fr rigid nephroscope (6 Fr operative channel)<br />
and all flexible instrumentation. It depends on the<br />
instrument’s availability of each department. Our indication<br />
for MIPP are: renal stones equal or less than 1,5 cm<br />
diameter as first choice or SWL-refractory; as adjuvant<br />
procedure during standard percutaneous<br />
Nephrolitotripsy if it’s necessary a second access for complicated<br />
lithiasis or infra-costal approach; anterograde<br />
management of uro-enteric strictures in neobladder or<br />
ileal conduit with flexible ureteroscope and LASER incision<br />
or pneumatic dilation; antegrade endopielotomy;<br />
anterograde access to kidney transplanted for<br />
renal/ureteral lithotripsy or anastomotic strictures; pediatric<br />
nephrolithotripsy; anterograde ureteral lithotripsy<br />
when it’s impossible or complicated to a classic retrograde<br />
ureteral access; foreign body extraction (when the<br />
retrograde way is not possible); treatment of caliceal<br />
diverticula with or without calculus inside; endourological<br />
treatment of pyelocaliceal superficial transitional cell<br />
carcinoma less than 1,5 cm (Table 1).<br />
When it’s necessary to minimize a renal damage for<br />
example in patients whit renal failure or coagulation’s<br />
disorders.<br />
From January 2002 to December 2006, we treated with<br />
Archivio Italiano di Urologia e Andrologia 2007, 79, 3, Supplemento 1<br />
Table 2.<br />
Clinical Experience.<br />
First choice Nephrolithotripsy 38 pts (1 transplanted kidney; 2 with antegrade LASER<br />
endopyelothomy; 1 with lumbar stenosis dilation)<br />
ESWL- refractory stones 7 pts<br />
Adjuvant Nephrolithotripsy 9 pts<br />
Anterograde ureteroscopy for stones 1 pts<br />
Caliceal diverticula coagulation 2 pts<br />
Uretero-intestinal stenosis 4 pts (1 transplanted kidney in neobladder)<br />
Ablation of small, low grade renal TCC 1 pt<br />
Foreign body extraction 1 pt<br />
Table 1.<br />
MIPP: Our indications.<br />
Management of anastomotic strictures in entero- urinary diversions<br />
Antegrade ureteral lithotripsy<br />
Foreign body extraction when retrograde way is not possible<br />
Management of caliceal diverticula<br />
Management of small, superficial, low grade pyelocaliceal TCC<br />
MIPP, 63 patients (27 female and 36 male), mean age<br />
45+17 years (range 2-76 years); 37/63 percutaneous procedures<br />
were performed in supine position.<br />
Percutaneous lithotripsy was performed in 57/63<br />
patients, for stones of 21+10 mm burden (range 6-55<br />
mm); 1/57 was transplanted kidney; of these in 38/57<br />
pts was effected percutaneous lithotripsy as a first choice<br />
procedure; in 7/57 pts after ESWL procedure; in 2/57 pt<br />
was associated an endopyelotomy procedure with electric<br />
incision, in 2/57 pts a medial caliceal diverticulum<br />
was treated with diathermy; in 1/57 pt an infundibular<br />
stenosis was pneumatically dilated; 9/57 pts underwent<br />
adjuvant nephrolithotripsy with double access in complicated<br />
lithiasis; 2/57 pt needed a retrograde<br />
ureterolithotripsy with rigid ureteroscope for unaccesible<br />
ureter by retrograde access; 1/57 pneumatic dilation for<br />
a lombar stenosis after ureterolithotomy; 4/63 pts underwent<br />
a new recanalization for uroenteric strictures in 3<br />
neobladders (1 kidney transplant in a neobladder) and 1<br />
ileal conduit, after MIPP access a flexible ureteroscope<br />
allowed a pneumatic dilation of stenosis and a secondary<br />
LASER incision of the stenotic tract; double pig- tail stent<br />
was left for 3 weeks; in 1/63 pt was performed a LASER<br />
ablation of a small superficial transitional cell carcinoma;<br />
in 1/63 pt was extracted a ureteral stent migrated to the<br />
pelvis (Table 2).
RESULTS<br />
All patients are alive; for 57 nephrolithotripsy procedures<br />
stone-free rate was 98.3%; in 1 pt (1,7%) the procedure<br />
was unsuccessful (impossibility to perform<br />
nephrostomic access); in 3 pts (5,2%) occured bleeding<br />
with bladder plugging at drainage remove (3rd postoperative<br />
day) that needed stenting (mono J catheter for<br />
some days) and in two patients (2/3 pts) blood transfusion<br />
(3 units of heterologous blood in 1 pt and 1 unit of<br />
autologous blood in 1 pt); in 5 patients (8,7%) the postoperative<br />
anaemia without evidence of significant bleeding<br />
needed blood transfusion (2 units of autologous<br />
blood each in 4 patients and 1 unit of heterologous<br />
blood in 1 patient); totally, 7/63 pts were transfused<br />
(11%); in 1 patient in 7th postoperative day<br />
hydronephrosis without evidence of residual stones, that<br />
needed stenting; for residual procedures (6 patients)<br />
there were no complications; the mean extimated blood<br />
loss was 0,65 + 1,05 g/dL HB (range 0,1- 3,9 g/dL HB);<br />
the mean hospital stay was 4,2 + 2,8 days (range 2- 14<br />
days).<br />
DISCUSSION<br />
The recent introduction on the market of miniaturized<br />
instruments has given strong evidence to the possibilities<br />
of being less invasive in the percutaneous procedures.<br />
This was made possible by the small diameter probes<br />
suitable to be used with L.A.SE.R., which proves very<br />
useful in lithotripsy. Besides the presence of flexible<br />
fibroscopes is highly suitable for the exploration of the<br />
renal cavities.<br />
All this has led to the construction of operative nephroscopes,<br />
aimed to obtaining the same results with the least<br />
possible parenchymal loss.<br />
Until the last year the few experiences of “minipercutaneous<br />
procedures” had to be effected with a technology<br />
unfit for this purpose, but adapted to the specific case, as<br />
in our experience, with obvious limitations in use and<br />
indication.<br />
In literature too very little has been said about mini percutaneous<br />
but only about single or rare experiences,<br />
often in the pediatric field, without the necessary directions<br />
for the standardization of the technical and instrumental<br />
characteristics required by any procedure for an<br />
objective analysis of the result.<br />
If all the Authors mentioned have agreed on the need of<br />
being as least invasive as possible towards the kidney by<br />
effecting nephrostomic approach of small diameter, there<br />
is always the problem of using different instruments, so<br />
in the pediatric experience.<br />
Even if Traxers experimental reports do not show, after 6<br />
weeks, different functional results in terms of parenchimal<br />
damage, utilizing different sized nephrostomy tract<br />
(11 or 30 Fr)(1).<br />
Jackman et al (2). Helal et al (3) described initially the<br />
technique in children with the use of 11 Fr to 15 Fr peelaway<br />
and subsequently the use of a 13 Fr ureteroscopy<br />
sheath for working access. Feng et.(4) al in a prospective<br />
randomized trial to assess the efficacy and morbidity<br />
through standard PCN involved tract dilation to 30 Fr<br />
for passage of a 34 Fr working sheath and their 2 mini-<br />
<strong>7°</strong> <strong>Congresso</strong> <strong>Nazionale</strong> Associazione Italiana di Endourologia<br />
PCN involved tract dilation to 22 Fr for passage of a 26<br />
Fr sheath with tubeless procedure, no overall advantage<br />
was found for the mini-PCN versus the standard technique,<br />
imputing however the disadvantages of the microprocedures<br />
to the poorer visualization and optics and<br />
difficulty with the use of the nephroscopic graspers.<br />
Chan et al.(5) describes the use mini-PCN by means of<br />
13 Fr ureteroscopy and stresses how the procedure<br />
reduces morbidity compared with the standard procedure<br />
in terms of efficiency and effectiveness for stone<br />
removal.<br />
In the abstract “role of Miniperc in the management of<br />
urolithiasis”, Bhargava et al. (6) evaluate the effectiveness<br />
of the procedure with 14 Fr (19 cm Length) access<br />
ureteric sheath and the use of the ureteroscopy of 8 Fr<br />
and pneumatic lithotripsy in 30 patients. They conclude<br />
that ”Miniperc” is a safe and very useful procedure.<br />
Also Monga et al.(7) describes the miniaturization of percutaneous<br />
nephrolithotomy, a natural evolution of the<br />
gold standard by using of 20 Fr compared with the traditional<br />
30 Fr sheath. The Author points out that the<br />
reduction of the approach allows less bleeding and postoperative<br />
pain in 16 patients.<br />
Desai et al. (8) refers to a paediatric surgery experience<br />
with 45 renal Units in 40 cases using the paediatric<br />
nephroscope 14 Fr with a 2,4 mm working channel with<br />
dilatation of the approach from 18,5 to 24 Fr according<br />
to the age of the children. The Authors describes this<br />
procedure as safe ed appropriate option in the modern<br />
management of paediatric urolithiasis.<br />
Also Zattoni (9) in his personal experience (with the new<br />
17 Fr nephroscope in renal stone and nephrostomic<br />
channel of 20 Fr) of 9 cases including 6 children suggests<br />
that paediatric nephroscope should be considered a standard<br />
part of the endourologic equipment.<br />
In our experience, the miniperc procedures allows significant<br />
reduction in blood loss: in a previous study of<br />
our group (10) we have compared three groups of<br />
patients that’s undergoes percutaneous procedures with<br />
various techniques of nephrostomy tract dilation to 34<br />
Fr: 105 total patients, of which 59 progressive dilation<br />
with Amplatz metallic dilators, 36 with One- Shot technique<br />
and 15 with pneumatic dilation: in first group the<br />
extimated blood loss was 2,08 + 1,43 g/dL HB (0,3- 8,7<br />
g/dL), in second group 1,64 + 0,95 g/dL HB (0- 3,9<br />
g/dL), in third group 1,90 + 1,12 g/dL (0,2- 3,7 g/dL); in<br />
our actual series the extimated blood loss was 0,65 +<br />
1,05 g/dL (0,1- 3,9 g/dL); the data are particularly significant<br />
in comparison with first group (p < 0,001), but<br />
remains also significant in comparison with second<br />
group (p < 0,05) and third group (p < 0,02) (Table 3).<br />
In our previous study we have also evaluated mean operating<br />
times, that were respectively 38 minutes with<br />
Alken metallic dilators, and 29 minutes with One-Shot<br />
or pneumatic dilation. In actual series mean operating<br />
times are more of 60 minutes: a demonstration (statistically<br />
significant, but also intuitive) of major expensiveness<br />
in operating time of miniperc procedures in comparison<br />
with standard nephrostomy tract accesses, independently<br />
of dilation technique. The mean hospital stay<br />
in present study was 4,2 + 2,8 days (range 2- 14 days);<br />
in previous study was 5,74 +3,54 days (range 2-20 days)<br />
Archivio Italiano di Urologia e Andrologia 2007, 79, 3, Supplemento 1<br />
45
46<br />
<strong>7°</strong> <strong>Congresso</strong> <strong>Nazionale</strong> Associazione Italiana di Endourologia<br />
Table 3.<br />
Comparison of results in blood loss in various nephrostomy tract techniques.<br />
Technique Patients Ext. blood loss p (Miniperc vs all other)<br />
Miniperc 63 (actual series) 0,65 ± 1,05 g/dL<br />
Alken dilators 59 (previous series) 2,08 ± 1,43 g/dL < 0,001<br />
One- Shot 36 (previous series) 1,64 ± 0,95 g/dL < 0,05<br />
Pneumatic dilation 15 (previous series) 1,90 ± 1,12 g/dL < 0,02<br />
for patients with Alken dilators access; 4,75 + 1,99 days<br />
(range 2-13 days) for patients with One-Shot access;<br />
4,46 + 1,06 days (range 3-7 days) for patients with pneumatic<br />
dilation access; the data not reaches statistical significance,<br />
but the mean hospital stay after miniperc procedures<br />
seems shorter than after standard procedures.<br />
CONCLUSIONS<br />
Considering the literature that shows experiences mainly<br />
in paediatric surgery with different nephrostomic<br />
approach (reported range 11-24 Fr) it is opportune to<br />
put a limit to the mini percutaneous procedure. We agree<br />
to identifying “MINI perc” technique only to nephrostomic<br />
approach ≤ 14 Fr and have manufactured the set<br />
in accordance.<br />
Superior approach cannot be intended Mini procedures<br />
but just “MIDI”. Please consider that the main manufactures<br />
of endourologic equipment are moving in accordance<br />
with this line. In case of failure or operation difficulties<br />
the approach can be easily converted and<br />
increased to allow standard procedures.<br />
The limits of this technique are: major operation times<br />
and consequently major costs; more difficulties in vision<br />
and operability. The advantages are: less trauma, reduction<br />
of bleeding, possibility of tubeless procedures and<br />
shorter recovery times.<br />
Supine position is certainly a step forward in terms of<br />
reducing operative times and percentage of clearance of<br />
the fragments. In fact the LASER lithotripsy and the<br />
decubitus allow litholopaxy of the fragments thanks to<br />
the gravity and the retrograde continuous irrigation.<br />
Moreover the possibility of using flexible ureteroscopes<br />
allows a better access to all the kidney calices and consequently<br />
an easier extraction of fragments.<br />
We estimate, with the right indications, that the Miniperc<br />
should be more and more adopted by modern endourol-<br />
Archivio Italiano di Urologia e Andrologia 2007, 79, 3, Supplemento 1<br />
ogists. The progress mainly in optics and the miniaturization<br />
of instruments will make the procedure more<br />
useful and effective.<br />
REFERENCES<br />
1. Traxer O, Smith Thomas G.III, Pearle M S, Corvin T S,<br />
Saboorian H, Careddu JA: Renal parenchymal injury after standard<br />
and mini percutaneous nephrostolithotomy. J Urol 2001;<br />
165(5):1693-1695.<br />
2. Jackman SV, Docimo SG, Careddu JA et al: The “miniperc” tecnique:<br />
a less invasive alternative to percutaneous nephrolithotomy.<br />
World J Urol 1998; 16:371-374.<br />
3. Helal M, Black T, Lockhart J, et al: The Hickman peelaway<br />
sheath:alternative for pediatric percutaneous nephrolithotomy. J<br />
Endourol 1997; 11:171-172<br />
4. Feng MI, Tamaddon K, Mikhail A, Kaptein JS, Bellman GC:<br />
Prospective randomized study of various techniques of percutaneous<br />
nephrolithotomy. Urology 2001; 58(3):345-350.<br />
5. Chan D-Y; Jarrett TW: Mini-Percutaneous Nephrolithotomy.<br />
J.Endourol. 2000; 14(3):269-273.<br />
6. Bhargava A.,Gupta V.K: Role of “Mini-perc” in the management<br />
of urolithiasis.(abstract FP4-4) J Endourol 2003 (suppl) A36.<br />
7. Monga M, Oglevie S : Mini-Percutaneous nephrolithotomy:<br />
extended experience and follow-up.(abstract FP4-12) J Endourol<br />
2003 (suppl) A38.<br />
8. Desai M, Ridhorkar V, Patel S et al.: Pediatric percutnaeous<br />
nephrolithotomy : assessing impact of technical innovations on safety<br />
and efficacy. J Enrodurol 1999; 13(5):359-64.<br />
9. Zattoni F, Passerini-Glazel G, Tasca A.: Pediatric nephroscope for<br />
percutaneous stone removal. Urology 1989; 33:404-406.<br />
10. Frattini A, Barbieri A, Salsi P, Sebastio N, Ferretti S,<br />
Bergamaschi E, Cortellini P. One shot: A novel method to dilate the<br />
nephrostomy access for percutaneous lithotripsy. J Endourol 2001;<br />
15 (9):919-923.<br />
Correspondence: Stefania Ferretti M.D., Urology Unit, Azienda Ospedaliero-Universitaria of Parma, via Gramsci, 14 – 43100 Parma, Italy<br />
E-mail: ferretti@ao.pr.it
<strong>7°</strong> <strong>Congresso</strong> <strong>Nazionale</strong> Associazione Italiana di Endourologia<br />
Minimally invasive treatments for LUTS related to BPH:<br />
an update.<br />
Summary<br />
D. Prezioso, R. Galasso, G. Iapicca, E. Annunziata, F. Iacono<br />
Department of Urology, “Federico II” University of Naples<br />
Objective: The aim of our review is to provide updated information regarding the role<br />
of minimally invasive endourological techniques to treat lower urinary tract symptoms<br />
(LUTS) due to benign prostatic hyperplasia (BPH). We reviewed the literature and the<br />
BPH guidelines, focusing the attenction on randomized controlled trials with significant<br />
number of patients and long-term follow up series. We have considered a large<br />
number of parameters related to minimally invasive interventions, such as the short- and longterm<br />
outcome, complications, morbidity, need for anaesthesia, also comparing the current data<br />
regarding the trans-urethral resection of prostate (TURP).<br />
Results: The minimally invasive therapies can be divided into: thermal-based tehrapies, laser<br />
therapies, ablative therapies and other technologies. They represent a good alternative to<br />
TURP, with interesting results regarding their efficacy and tolerability. The most attractive<br />
treatments are high-energy trans-urethral microwave thermotherapy (TUMT), holmium-laser<br />
resection/enucleation (HoLRP/HoLEP), bipolar trans-urethral resection in saline (TURIS) and<br />
transurethral electrovaporization (TUVP). However, also other new interventions show a good<br />
safety profile and low economical costs.<br />
Conclusions: Today, minimally invasive treatments are a good alternative to traditional TURP,<br />
but prospective, long-term randomized trials are need to evaluate the real outcome.<br />
KEY WORDS: Minimally invasive treatments; Trans-urethral microwave thermotherapy;<br />
Holmium-laser resection/enucleation; Bipolar trans-urethral resection in saline;<br />
Transurethral electrovaporization, Trans-urethral needle ablation.<br />
INTRODUCTION<br />
For a long period of time, transurethral resection of the<br />
prostate (TURP) was considered the “gold standard” surgical<br />
therapy for patients with LUTS related to BPH (1),<br />
associated with significant efficacy (2), but also with<br />
severe morbidity (3-6).<br />
New surgical and minimally invasive treatments show a<br />
comparable efficacy to TURP, with better safety and<br />
lower costs, in terms of quality of life and time of hospitalization.<br />
Aim of this review is to provide updated information<br />
about the role of minimally invasive therapies, analyzing<br />
the evidence-based data of randomized clinical trials and<br />
the recommendations of BPH guidelines (7,8). We<br />
reviewed the literature and the BPH guidelines, focusing<br />
the attenction on randomized controlled trials with significant<br />
number of patients and long-term follow up<br />
series. We have considered a large number of parameters<br />
related to minimally invasive interventions, such as the<br />
short- and long-term outcome, complications, morbidity,<br />
need for anaesthesia, also comparing the current data<br />
regarding the trans-urethral resection of prostate<br />
(TURP).<br />
TRANS-URETHRAL MICROWAVE THERMOTHERAPY (TUMT)<br />
Thermotherapy uses high temperatures to produce coagulation<br />
necrosis of prostatic tissue. Microwaves delivered<br />
via the transurethral route have been the dominant<br />
means used to heat prostatic tissue. TUMT uses a special<br />
transurethral catheter with a microwave antenna that<br />
transmits heat into the prostate with the eventual goal of<br />
destroying tissue by achieving temperatures that exceed<br />
the cytotoxic threshold and inducing cell death. More<br />
specifically, heating in excess of 45°C results in coagulation<br />
necrosis. In addition, apoptosis has been observed,<br />
at temperatures lower than those inducing necrosis.<br />
Recently, it was demonstrated that TUMT increased the<br />
sensory threshold (evoked by electrical stimulation) in<br />
the posterior urethra by 30%, resulting in the alleviation<br />
of storage symptoms (9). During the last decade, numerous<br />
studies have been published presenting the clinical<br />
results from the application of TUMT for the treatment of<br />
LUTS associated with BPH. Many TUMT devices with<br />
different technical specifications and treatment protocols<br />
have been evaluated. Bolmsjo et al (10) reported substantial<br />
differences in heating profiles between devices<br />
with different microwave antenna designs. However, at<br />
Archivio Italiano di Urologia e Andrologia 2007, 79, 3, Supplemento 1<br />
47
48<br />
<strong>7°</strong> <strong>Congresso</strong> <strong>Nazionale</strong> Associazione Italiana di Endourologia<br />
present time there is not enough critical data to support the<br />
hypothesis that TUMT challenges TURP, further studies<br />
that provide high quality of evidence are needed. Hoffman<br />
et al (11) combined all evidence from randomized controlled<br />
trials evaluating the efficacy and safety of microwave<br />
thermotherapy in treating men with LUTS and BPH, in<br />
order to quantify the therapeutic efficacy. Overall, 540<br />
patients were randomized in the six eligible randomized<br />
studies, including 322 to TUMT and 218 to TURP. Patients<br />
included in the studies had moderate to severe LUTS, with<br />
decreased Qmax and moderately enlarged prostates.<br />
Studies generally excluded men with very large prostates<br />
(>100 g), prominent median lobes and in urinary retention.<br />
Treatment was offered by different TUMT devices and<br />
software including Prostatron (Prostatsoft 2.0 and 2.5) and<br />
ProstaLund Feedback. The mean (range) age was 67.8 (65-<br />
70) years, baseline symptom score 19.5 (15.7-21.3), baseline<br />
Qmax 8.6 (7.9-10.1) ml/sec and prostate volume 44.5<br />
(33.9-52.7) ml, and did not differ by treatment group. Two<br />
studies followed patients for 6 months and 4 studies provided<br />
a 12-month follow-up. Five studies found significant<br />
decreases in urinary symptoms and significant increases in<br />
Qmax between baseline and follow-up for both TURP and<br />
TUMT. Three studies (12-14) evaluated the effect of treatment<br />
on QOL using the eight IPSS question. The pooled<br />
mean QOL score for men undergoing TUMT decreased by<br />
58.5% (4.1 to 1.7) and by 63.4% (4.1 to 1.2) in men<br />
undergoing TURP. Although QOL significantly improved<br />
after both TUMT and TURP, there were no significant differences<br />
between treatments. Muttiasson et al (15,16) have<br />
published the results of a prospective randomised study,<br />
including 154 patients randomized to TUMT or TURP.<br />
Total IPSS decreased 3 months after surgery from 21 to 8<br />
(61.9%) in the TUMT group and from 20 to 7(65%) in the<br />
TURP group, which was sustained over 5 years. Max flow<br />
rate and IPSS QoL were comparable between the two<br />
groups. In the TUMT group were observed few severe<br />
complications (5%) and 10 % of patients needed additional<br />
treatment. The burning question for thermal-based treatment<br />
is how good the results remain in a long-term perspective.<br />
Historically the Low-Energy TUMT has been<br />
abandoned due to the disappointing durability of its<br />
effects. Recent studies confirm the limited durability of<br />
clinical outcome obtained by lower energy programs, with<br />
a retreatment rate as high as 84.4% after 5-year follow-up<br />
(17-19). In the randomized study with the longest available<br />
follow-up by Floratos et al (12), the results of 36 month<br />
follow-up were presented. Improvement in Qmax of the<br />
TUMT group from 9.2 ml/sec retreatment to 15.1 ml/sec,<br />
14.5 ml/sec and 11.9 ml/sec at 1-, 2 and 3 years, respectively,<br />
was reported, whilst the IPSS symptom score<br />
improved from 20 to 8, 9 and 12, respectively. These data<br />
indicate that the level of improvement is durable up to 3<br />
years. The retreatment rate for TUMT and TURP was<br />
19.8% and 12.9%, respectively. It is important to underline<br />
the different causes of retreatment. Retreatment was offered<br />
to the TUMT patients because of primary treatment failure,<br />
while in the TURP group, retreatment included reintervention<br />
mainly because of urethral strictures, bladder neck<br />
sclerosis, meatal stenosis, but rarely, treatment failure.<br />
Similarly, Trock et al (20) performed a pooled analysis of 6<br />
multicenter studies of cooled thermotherapy with compa-<br />
Archivio Italiano di Urologia e Andrologia 2007, 79, 3, Supplemento 1<br />
rable baseline measures. In total 541 patients were pooled<br />
and data showed an improvement of 55%, 53% and 51%<br />
in AUA symptom score, QOL and Qmax after TUMT,<br />
respectively. A slight decrease was observed at 48 months<br />
since subjective and objective improvement remained<br />
durable (43%, 50% and 35%, respectively). One of the<br />
commonly used arguments for the application of TUMT as<br />
an alternative to TURP for BPH is its low morbidity. The<br />
reported low morbidity and the absence of any need for<br />
spinal or general anesthesia make TUMT a true outpatient<br />
procedure, representing an excellent option for patients at<br />
high operative risk (American Society of Anesthiologists<br />
class 3 or 4) who are unsuitable for an invasive treatment.<br />
TRANS-URETHRAL NEEDLE ABLATION (TUNA)<br />
TUNA therapy uses low-level radiofrequency (RF) energy<br />
that is delivered by needles into the prostate and that produces<br />
localized necrotic lesions in the hyperplasic tissue.<br />
The inner region of the prostate is selectively ablated with<br />
temperatures approaching 90-100°C while the prostatic<br />
urothelium is preserved (21,22). The TUNA system consists<br />
of a special catheter attached to a generator. At the end<br />
of the catheter there are two needles that are withdrawn<br />
into two adjustable shields made from Teflon. The needles<br />
are advanced into the prostatic tissue and can be placed<br />
accurately into the required position. The generator produces<br />
a monopolar RF signal of 490 kHz, which allows<br />
excellent heat penetration and uniform tissue distribution<br />
of heat (21,22). The advantage of TUNA is that it can be<br />
delivered under topical anesthesia to patients with symptomatic<br />
BPH and is an attempt to minimize operative risk<br />
and reduce postoperative sequela and the need for a long<br />
recovery period, while optimizing the therapeutic benefit.<br />
There is a wide variety in the number of patients in each<br />
series and in the length of follow-up. It can be noted that<br />
most are open series, with a minority of randomized studies.<br />
The size of studies varies from 10 to 188 patients, and,<br />
in many cases, the number of patients, followed up for a<br />
long period of time is less than 50% of the original sample,<br />
which makes it difficult to draw definitive conclusions<br />
(22). The results of 5 year follow-up of the United States<br />
randomized clinical trial were presented (23). Following<br />
treatment, significant improvement from baseline occurred<br />
in symptom score, higher for TURP than for TUNA (statistically<br />
significant in the first 4 years). The two groups<br />
demonstrated a significant improvement in maximum urinary<br />
flow rate (greater for TURP patients). TUNA showed<br />
significantly fewer adverse events than TURP. The TURP<br />
group reported 41% retrograde ejaculation, while the<br />
TUNA group reported none. However, in the TUNA group<br />
14% required further intervention with additional treatment<br />
(TURP), against only 2% in the TURP cohort. The<br />
results of this study demonstrate stable treatment outcomes<br />
after 5 years of follow up and suggest that TUNA is an<br />
attractive treatment option for men with LUTS due to BPH.<br />
While the TURP improvement was superior, TUNA<br />
showed lower adverse events (23). Another randomized<br />
clinical trial comparing TUNA with TURP analyzed 59<br />
patients (24). Improvements in Qmax, post voiding residual<br />
volume (PVR), IPSS and the QOL score were statistically<br />
significant for both groups at 3 and 18 months of fol-
low-up. The increase in the mean Qmax of the TURP<br />
group was higher than that in the TUNA group, whereas<br />
no significant differences were found between the two<br />
groups regarding improvements in IPSS and QOL scores.<br />
There were no complications associated with the TUNA<br />
procedure, while after TURP 16 patients suffered from retrograde<br />
ejaculation, 4 from erectile impairment, 2 from<br />
urethral stenosis and 1 from urinary incontinence (24). A<br />
recent meta-analysis (25) analyzed the data from two randomized<br />
trials (23,26), two non-randomized protocols<br />
(27,28) and 10 single-arm studies conducted on TUNA<br />
(27,29,30,31,32,33,34,35,36).<br />
The effect of TUNA was a decrease of the mean IPSS by<br />
50% from baseline at 1 year after treatment. This effect<br />
maintained up to 5 years. The Qmax increased by 70%<br />
from baseline after 1 year in virtually all studies and<br />
approached or exceeded 15 ml/sec. Although there was a<br />
tendency for the Qmax to decline slightly over time, the<br />
mean Qmax 5 years after treatment was more than 50%<br />
improved compared to baseline. When only the two randomized<br />
trials are considered, the mean decline in IPSS<br />
was 11.6 after TUNA and 15.7 after TURP (difference statistically<br />
significant). The effect of TUNA therapy on Qmax<br />
(+7.0 ml/sec) was smaller than that of TURP (+11.6<br />
ml/sec= statistically significant) (25). This meta-analysis<br />
shows that TUNA is an effective and minimally invasive<br />
treatment for men, even with severe symptoms. There is a<br />
significant improvement in symptoms and flow rate after 1<br />
year which persists for at least 5 years. TUNA therapy<br />
would appear to be an alternative to surgery and an attractive<br />
option for men who do not wish to undergo long-term<br />
medical therapy, for men who are poor candidates for surgery<br />
or those concerned about the side-effects of TURP<br />
(25). Although a 14% requirement for re-operation due to<br />
the lack of efficacy of the primary treatment with TUNA<br />
may seem low, it occurred within 2 years (23). In addition,<br />
the 12.7% incidence reported by other authors also<br />
occurred within a 2 year period (27).<br />
INTERSTITIAL LASER COAGULATION OF THE PROSTATE (ILC)<br />
In 1991 Hofstetter introduced ILC of the prostate (37). In<br />
this technique, Nd: YAG, a diode or holmium laser fibers<br />
are placed directly into the prostatic adenoma. The fiber is<br />
fitted with a special diffuser tip or used as a bare fiber<br />
placed percutaneously through the perineum or directly<br />
through a cystoscope. The Nd: YAG laser fiber is left in<br />
position for 10 minutes at 5 to 10 W. The diode laser<br />
requires a 3-minute treatment at each location starting at<br />
20 W and decreasing to 7 W in the “turbo mode”. The aim<br />
of this technique is to preserve the urethra, thus preventing<br />
tissue sloughing with less storage symptoms than seen with<br />
other laser techniques. Martenson and de la Rosette<br />
(38,39) reported a comparative study between ILC and<br />
TURP in 30 and 14 patients, respectively with 2 years follow<br />
up. The retreatment rate for the ILC group was 21%<br />
compared to 7% in the TURP group, no incontinence was<br />
documented in either group, with one patient in the TURP<br />
group developing a urethral stricture. The storage symptoms<br />
are frequent and long post-operative catheterization is<br />
required for up to one month in some studies. To achieve<br />
immediate relief of obstruction, some authors perform a<br />
<strong>7°</strong> <strong>Congresso</strong> <strong>Nazionale</strong> Associazione Italiana di Endourologia<br />
limited resection of the coagulated tissues immediately<br />
after ILC (40).<br />
A multicenter randomized trial at six U.S hospitals comparing<br />
TURP (n=35) with ILC (n=37) was published by<br />
Kursh et al. (41). At 2-years follow up, the Qmax improved<br />
by 81% in the TURP group (from 9.1 to 16.5 ml/sec) and<br />
by 51% in the ILC group (from 9.2 to 13.9 ml/sec). The<br />
improvement in AUA symptom index was 70% in the<br />
TURP group and 63% in the ILC group. The ILC group<br />
had a significantly shorter hospital stay and a better sexual<br />
function score. The urinary tract infection rate in ILC group<br />
was 20%, the retreatment rate was 16% and no decrease in<br />
PSA was noted at 2 years (42). Floratos et al (43) reported<br />
on long-term follow up (34 to 53 months) after VLAP<br />
(n=107), contact laser (n=30), and ILC (n=53). The retreatment<br />
rate was higher in ILC group than other groups (41%<br />
vs 14%). Similar retreatment rate (35%) within 8 years<br />
after ILC was reported by Terada et al. (44). The EUA<br />
guidelines suggest using the ILC only in the treatment of<br />
high-risk patients (45).<br />
PHOTOSELECTIVE VAPORIZATION OF THE PROSTATE (PVP)<br />
The potassium Titanyl phosphate:YAG (KTP) laser is based<br />
on the technique of passing Nd: YAG laser light through a<br />
KTP crystal. This halves the wavelength of the emitted laser<br />
to 532 nm and doubles its frequency. The emitted light is a<br />
visible green light, which is strongly absorbed by red tissues<br />
and hemoglobin; this means that a blood rich organ<br />
such as the prostate gland is an excellent target. Based on<br />
these qualities, its name (photoselective vaporization of the<br />
prostate) was coined (46). Recently an 80 W KTP laser generator<br />
was developed. Hai and Te et al (47) reported the<br />
first multicenter study of 139 patients with a mean prostate<br />
volume of 54.6 cc who underwent 80 WKTP laser vaporization<br />
of the prostate with a 12- month follow-up. The<br />
mean operative time was 38.7 minutes, the mean catheterization<br />
time was 14 hours and 32% of patients required no<br />
post-operative catheterization, thus making PVP a costeffective<br />
procedure. There was an 82% improvement in<br />
symptom score, 190% improvement in Qmax, and 37%<br />
reduction in prostate volume. The postoperative complications<br />
included dysuria (9.4%), transient hematuria (8.6%),<br />
transient urge incontinence (6.5%) recatheterization (5%),<br />
retrograde ejaculation (36%) bladder neck contracture<br />
(1.4%) and urethral stricture (0.7%). Long-term results<br />
demonstrated sustained improvement in voiding parameters.<br />
Of 84 patients who underwent PVP, Malek and<br />
Kuntsman (48) reported 80% improvement in symptom<br />
score and 170% to 250% improvement in the Qmax after<br />
5 years follow- up, with no need for re-operation.<br />
HOLMIUM LASER RESECTION OF THE PROSTATE (HOLRP)<br />
This procedure is similar to the standard TURP. Resection<br />
of the prostate is achieved by using the end firing Ho: YAG<br />
laser fiber. The procedure is started with bilateral incisions<br />
to define the depth and amount of tissue to be removed. In<br />
1996 Gilling et al (49) reported the results of the initial 84<br />
patients who underwent HoLRP. The mean AUA symptom<br />
score improved from 21.3 pre-operatively to 4.1 at 3<br />
months. The mean Qmax increased from 7.5 to 19.3<br />
Archivio Italiano di Urologia e Andrologia 2007, 79, 3, Supplemento 1<br />
49
50<br />
<strong>7°</strong> <strong>Congresso</strong> <strong>Nazionale</strong> Associazione Italiana di Endourologia<br />
ml/sec at 3 months post-operatively. Only 2 patients’<br />
required bladder irrigation for hematuria and 5% of<br />
patients’ required recatheterization. Similar results were<br />
confirmed by other larger studies that demonstrated that<br />
HoLRP has equivalent or even better results than TURP<br />
(50). In 1999 Gilling et al (51) (level1) published the<br />
results of a prospective randomized trial with 1-year follow-up<br />
of patients assigned to HoLRP (n=61) and TURP<br />
(n=59). The improvement in flow rate and symptoms score<br />
was similar but the operating time was longer in the HoLRP<br />
group, however the nursing contact, catheter time (20 vs<br />
37.2 hours) and hospital stay (26.2 vs 47.5 hours) were<br />
significantly shorter than the TURP group. At 12 months,<br />
8.3% of the HoLRP group and 10.6% in the TURP group<br />
had deterioration in their level of potency compared to the<br />
preoperative level. Retrograde ejaculation developed in<br />
96% and 86% of the HoLRP and TURP groups, respectively.<br />
Re-operations included 1 bladder neck incision in the<br />
HoLRP group and 2 bladder neck incision sand 2 revisions<br />
in the TURP group. The long-term results showed no significant<br />
difference between the two groups in terms of<br />
symptom score or flow rate at 2 years and 4 years follow up<br />
(52). Fraundorfer et al (53) reported a comparison between<br />
HoLRP and TURP in terms of cost effectiveness. HoLRP<br />
offers a 24.5% cost saving over TURP and 93 procedures<br />
annually would cover the initial and maintenance cost of<br />
the laser machine. The 2 major critiques of the HoLRP procedure<br />
are the longer operative time than TURP (average<br />
16 minute) and the resulting difficulties with pathological<br />
interpretation of the resected small pieces of the adenoma<br />
that may have been affected by thermal damage (54).<br />
HOLMIUM LASER ENUCLEATION OF THE PROSTATE<br />
(HoLEP)<br />
Holmium Laser Enucleation of the prostate (HoLEP) is the<br />
most recent step in the evolution of holmium laser prostatectomy.<br />
Refinement of the holmium laser technique and development<br />
of an efficient tissue morcellator have led to the true<br />
anatomic enucleation of a prostatic adenoma of any size.<br />
Ho: YAG laser fiber acts like the index finger of the surgeon<br />
during an open prostatectomy peeling the median and lateral<br />
lobes off the surgical capsule. In contrast to TURP,<br />
HoLEP is equally suitable for small, medium sized and<br />
large prostate glands with a similar clinical outcome that is<br />
independent of the prostate size (55). Randomized comparative<br />
trials (level 1 evidence) have shown similar results<br />
for HoLEP and traditional surgery used to treat BPH. Tan<br />
et al (56) found that HoLEP is superior to TURP for relieving<br />
bladder outlet obstruction. HoLEP is also superior to<br />
TURP with less bleeding, amount of tissue removed,<br />
decreased catheter time and hospital stay (57,58). HoLEP<br />
group in contrast to the TURP group where the transfusion<br />
rate was 3.3%. In another study Montorsi et al (59) found<br />
that HoLEP and TURP were equally effective with similar<br />
rate of complications at 1 year follow-up. The erectile function<br />
did not show a decrease from baseline in either group.<br />
There was no TUR syndrome in the HoLEP group, versus<br />
in 2.2% of patients in the TURP group. Transient urge<br />
incontinence was reported in 44% and 38% of the HoLEP<br />
and TURP groups, respectively. This complication is usual-<br />
Archivio Italiano di Urologia e Andrologia 2007, 79, 3, Supplemento 1<br />
ly short term and self-limiting. Urethral stricture occurred<br />
in 1.7% in HoLEP group and 7.4% in the TURP group.<br />
Kuntz et al (60) reported that the AUA symptom scores<br />
improved 13-fold in the HoLEP and more than 5 fold in<br />
the TURP group, however, the maximum flow rate<br />
improved about 5-fold in each group. Of sexually active<br />
patients, 74% in the HoLEP group and 70.3% in the TURP<br />
group had retrograde ejaculation. The operative time was<br />
longer than TURP, which seems to be due to the significant<br />
learning curve of HoLEP, which is the main problem of the<br />
HoLEP Procedure Unlike HoLRP, there are no thermal tissue<br />
artefacts in the enucleated specimen in the HoLEP procedure<br />
which improves the histological assessment compared<br />
to TURP (61) HoLEP has the advantage of safely<br />
treating patients and anticoagulated patients, with low<br />
perioperative morbidity regardless of the prostate size (62).<br />
This justifies the suggestion that HoLEP is the modern<br />
gold standard alternative to TURP and open prostatectomy.<br />
It appears to be at least as effective as the traditional surgery<br />
of BPH in terms of its short and long- term efficacy<br />
and low perioperative complications (63).<br />
BIPOLAR TRANS-URETHRAL RESECTION IN SALINE<br />
(TURIS)<br />
The use of bipolar systems permits the coagulation at a<br />
much lower peak voltage of 65-120 V compared with<br />
monopolar systems of 500-800 V. it has been suggested<br />
that this lower peak volume of energy will cause fewer filling<br />
symptoms after resection than standard monopolar<br />
systems (64). The bipolar resection system makes it possible<br />
to use physiologic 0,9% saline as the irrigation fluid,<br />
which reduces the risk of TUR syndrome (65).<br />
Ho et al (66) presented the outcomes of a single-blind,<br />
prospective randomised trials comparing TURIS and<br />
TURP. TUR syndrome did not occur in the TURIS group.<br />
Recatheterisation (TURIS vs. TURP: 10,4% vs. 7,7%) and<br />
reoperation for bleeding (TURIS vs. TURP: 6,2% vs. 3,8%)<br />
were comparable in the two groups. The mean improvement<br />
rate in terms of flow max, post-voidal residual and<br />
IPSS score assessed at 1, 3, 6 and 12 months postoperatively<br />
was similar in both groups.<br />
CONCLUSION<br />
Various alternative to conventional TURP are currently<br />
available, which seem to have a comparable efficacy and<br />
better safety profile than TURP. However, more long-term<br />
data with follow-up of 5 years are needed to confirm the<br />
efficacy of all these techniques illustrated in many several<br />
study. Faced with the plethora of new, minimally invasive<br />
alternatives to TURP, the question of which modality to<br />
use in any given clinical setting is pertinent. It is apparent<br />
that different groups of clinicians have different skill sets<br />
and access to equipment; this translates in real life practice<br />
to centres that have expertise in certain areas. In reality,<br />
many factors lead to the adoption of a new surgical technology<br />
but only the improved efficacy and safety profiles<br />
are the most important. Until both procedural and contextual<br />
factors are in favour of a shift to a new “gold standard”,<br />
TURP will remain the primary choice for most practicing<br />
urologist.
REFERENCES<br />
1. Reich O, Gratzke C, Stief CG. Techniques and long-term results of<br />
surgical procedures for BPH. Eur Urol 2006; 49:970-978.<br />
2. Burnett AL, Wein AJ. Benign prostatic hyperplasia in primary care:<br />
what you need to know. J Urol 2006; 175:S19-24.<br />
3. Mebust WK, Holtgrewe HL, Cockett AT, Peters PC. Transuerthral<br />
prostatectomy: immediate and postoperative complications. A cooperative<br />
study of 13 participating institutions evaluating 3.885 patients. J<br />
Urol 1989; 141:243-247.<br />
4. Borboroglu PG, Kane CJ, Ward JF, Roberts JL, Sands JP. Immediate<br />
and postoperative complications of transurethral prostatectomy in the<br />
1990s. J Urol 1999; 162:1307-1310.<br />
5. Rassweiler J, Teber D, Kuntz R, Hofmann R. Complications of<br />
transurethral resection of the prostate (TURP)-incidence, management,<br />
and prevention. Eur Urol 2006; 50:969-980.<br />
6. Lynch M, Anson K. Time to rebrand transurethral resection of the<br />
prostate? Curr Opin Urol 2006; 16:20-24.<br />
7. de la Rosette J, Alivizatos G, Madersbacher S, et al. EAU guidelines<br />
on benign prostatic hyperplasia (BPH). Eur Urol 2001; 40:256-263.<br />
8. AUA Practice Guideline Committee. AUA guidelines on management<br />
of benign prostatic hyperplasia (2003). Chapter 1: Diagnosis and<br />
treatment recommendations. J Urol 2003; 170:530-547.<br />
9. Brehmer M and Nilsson BY. Elevation of sensory thresholds in the<br />
prostatic urethra after microwave thermotherapy. Br J Urol Int 2000;<br />
86:427-431.<br />
10. Bolmsjo M, Wagrell L, Hallin A, et al. The heat is on but how? A<br />
comparison of TUMT devices Br J Urol 1996; 78:564-572.<br />
11. Hoffman RM, McDonald R, Monga M, Wilt TJ. Transurethral<br />
microwave thermotherapy vs. transurethral resection for treating<br />
benign prostatic hyperplasic: a systematic review. Br J Urol Int 2004;<br />
94:1031-1036.<br />
12. Floratos DL, Kiemeney LA, Rossi C, Kortmann BB, et al. Longterm<br />
follow-up of randomized transurethral microwave thermotherapy<br />
versus transurethral prostatic resection study. J Urol 2001; 165:<br />
1533-1538.<br />
13. Norby B, Nielsen HV, Frimodt-Moller PC. Transurethral interstitial<br />
laser coagulation of the prostate and transurethral microwave thermotherapy<br />
vs. transurethral resection or incision of the prostate: results<br />
of a randomized, controlled study in patients with symptomatic benign<br />
prostatic hyperplasia. Br J Urol Int 2002; 90: 853-862.<br />
14. Wagrell L, Schelin S, Nordling J et al. Feedback microwave thermotherapy<br />
versus TURP for clinical BPH a randomized controlled<br />
multicentre study. Urology 2002; 60:292- 299.<br />
15. Mattiasson A, Schelin S, Magnusson B, et al. Coretherm ® treatment<br />
vs. TURP in patients with BPH: a prospective randomized multicentre<br />
study with 5-year follow-up. Eur Urol Suppl 2006; 5:310.<br />
16. Mattiasson A, Wargrell L, Schelin S, et al. Five-year follow-up of<br />
feedback microwave thermotherapy versus TURP for clinical BPH: a<br />
prospective randomized multicentre study. Urology 2007; 69:91-96.<br />
17. Tsai YS, Lin JSN, Tong YC, et al. Transurethral microwave thermotherapy<br />
for symptomatic benign prostatic hyperplasia: Long term<br />
durability with Prostcare. Eur Urol 2001; 39:688-694.<br />
18. Terada N, Aoki Y, Ichioka K, et al. Microwave thermotherapy for<br />
benign prostatic hyperplasia with the Dornier Urowave: response<br />
durability and variables potentially predicting response. Urology 2001;<br />
57:701-706.<br />
19. Ekstrand V, Westermark S, Wiksell H, et al. Long-term clinical<br />
outcome of transurethral microwave thermotherapy (TUMT) 1991-<br />
<strong>7°</strong> <strong>Congresso</strong> <strong>Nazionale</strong> Associazione Italiana di Endourologia<br />
1999 at Karolinska Hospital, Sweden. Scand J Urol Nephrol 2002;<br />
36: 113-118.<br />
20. Trock BJ, Brotzman M, Utz WJ, et al. Long-term pooled analysis of<br />
multicenter studies of cooled thermotherapy for benign prostatic hyperplasia<br />
results at three months through four years. Urology 2004; 63:<br />
716-721.<br />
21. Bruskewitz, R., Issa, M. M., Roehrborn, C. G., et al. A prospective,<br />
randomized 1-year clinical trial comparing transurethral needle ablation<br />
to transurethral resection of the prostate for the treatment of symptomatic<br />
benign prostatic obstruction. J Urol 1998; 159: 1588.<br />
22. Fitzpatrick JM, Mebust WK. Minimally invasive and endoscopic<br />
management of benign prostatic obstruction. In Walsh PC, Retik AB,<br />
Vaughn ED, Wein AJ eds. Campbell's Urology, 8th ed. Philadelphia:<br />
WB Saunders, 2002: 1379-1422.<br />
23. Hill B, Bel Ville W, Bruskewitz R, et al. Transurethral needle ablation<br />
versus transurethral resection of the prostate for the treatment of<br />
symptomatic benign prostatic obstruction: 5-year results of a prospective,<br />
randomized, multicentre clinical trial. J Urol 2004; 171(6, Part 1<br />
of 2):2336-2340.<br />
24. Cimentepe E, Unsal A, Saglam R. Randomized clinical trial comparing<br />
transurethral needle ablation with transurethral resection of the<br />
prostate for the treatment of benign prostatic obstruction: results at 18<br />
months. J Endourol 2003; 17:103–107.<br />
25. Boyle P, Robertson C, Vaughan ED, Fitzpatrick JM. A metanalysis<br />
of trials of trnasurethral needle ablation for treating symptomatic<br />
benign prostatic obstruction. Br J Urol Int 2004; 94(1):83-88.<br />
26. Chandrasekar P, Virdi JS. Transurethral needle ablation of the<br />
prostate (TUNA) – a prospective study, six year follow-up. AUA Annual<br />
Meeting Clinical Abstracts. Lippincott, Williams & Wilkins, 2001.<br />
27. Steele GS and Sleep, DJ. Transurethral needle ablation of the<br />
prostate: An urodynamically based study with 2-year follow up. J Urol<br />
1997; 158:1834.<br />
28. Schatzl G, Madersbacher S, Djavan B, et al. Two-year results of<br />
transurethral resection of the prostate versus four ‘less invasive’ treatment<br />
options. Eur Urol 2000; 37:695–701.<br />
29. Zlotta AR, Giannakopoulos X, Maehlum O, Ostrem T, Schulman<br />
CC. Long-term evaluation of transurethral needle ablation of the<br />
prostate (TUNA) for treatment of symptomatic benign prostatic<br />
obstruction: clinical outcome up to five years from three centers. Eur<br />
Urol 2003; 44: 89–93.<br />
30. Namiki K, Shiozawa H, Tsuzuki M, et al. Efficacy of transurethral<br />
needle ablation of the prostate for the treatment of benign prostatic<br />
obstruction. Int J Urol 1999; 6:341–345.<br />
31. Kahn SA, Alphonse P, Tewari A, Narayan P. An open study on the<br />
efficacy and safety of transurethral needle ablation of the prostate in<br />
treating symptomatic benign prostatic obstruction: the University of<br />
Florida experience. J Urol 1998; 160: 1695–1700.<br />
32. Naslund MJ, Benson RC, Cohen ES, Gutierrez-Aceves J, Issa<br />
MM. Transurethral needle ablation (TUNA) for BPO in patients with<br />
median lobe enlargement. Report of a prospective multicentre study.<br />
AUA Annual Meeting Clinical Abstracts. Lippincott, Williams &<br />
Wilkins, 2000.<br />
33. Bergamaschi F, Manzo M, Autieri G, Corrada P, Campo B. Five<br />
years experience using transurethral needle ablation (TUNA) in 204<br />
BPO patients. AUA Annual Meeting Clinical Abstracts. Lippincott,<br />
Williams & Wilkins, 2000.<br />
34. Apostolos A, George M, Dimitrios A, George D, Ioannis C. Longterm<br />
efficacy and safety of transurethral needle ablation of the prostate<br />
(TUNA) for bladder outlet obstruction of prostatic origin: five-year<br />
experience. Eur Urol 2002; 40 (Suppl 1):129.<br />
Archivio Italiano di Urologia e Andrologia 2007, 79, 3, Supplemento 1<br />
51
52<br />
<strong>7°</strong> <strong>Congresso</strong> <strong>Nazionale</strong> Associazione Italiana di Endourologia<br />
35. Murai M, Tachibana M, Mike M, et al. Transurethral needle ablation<br />
of the prostate: an initial Japanese clinical trial. Int J Urol 2001; 8:<br />
99–105.<br />
36. Rosario DJ, Woo H, Potts KL, et al. Safety and efficacy of<br />
transurethral needle ablation of the prostate for symptomatic outlet<br />
obstruction. Br J Urol 1997; 80:579–586.<br />
37. Hofsteter A. Interstitielle Thermokoagulation(ITK) von Prsoststatumoren.<br />
Lasermedizin 1991; 7:179.<br />
38. Keoghane SR, Lawrence KC, Gray AM, et al. Adouble blind randomized<br />
controlled trial and economic evaluation of transurethral resection<br />
vs contact laser vaporization for benign prostatic enlargement: a 3year<br />
follow-up. Br J Urol Int 2000; 85(1):74-78.<br />
39. Martenson AC, de la Rosette JJ. Interstitial laser coagulation in the<br />
treatment of benign prostatic obstruction using a diode laser system:<br />
results of an evolving technology. Prostate Cancer Prostatic Dis 1999;<br />
2(3): 148-154.<br />
40. Corvin S, Schneede P, Siakavara E, et al. Interstitial laser coagulation<br />
combined with minimal transurethral resection of the prostate for<br />
the treatment of benign prostatic obstruction. J Endourol 2002; 16(6):<br />
387-390.<br />
41. Kursh ED, Concepcion R, Chan S, Hudson P, Ratner M, Eyre R.<br />
Interstitial laser coagulation versus transurethral prostate resection for<br />
treating benign prostatic obstruction: a randomized trial with 2-year follow-up.<br />
Urology 2003; 61(3):573-578.<br />
42. Uchida T, Egawa S, Iwamura M, et al. A non-randomized comparative<br />
study of visual laser ablation and transurethral resection of the<br />
prostate in benign prostatic hyperplasia. Int J Urol 1996; 3:108-111.<br />
43. Floratos DL, Sonke GS, Francisca EA, Kiemeney LA, Debruyne<br />
FM, de la Rosette JJ. Long-term follow-up of laser treatment for lower<br />
urinary tract symptoms suggestive of bladder outlet obstruction.<br />
Urology 2000; 56(4):604-609.<br />
44. Terada N, Arai Y, Okubo K, et al. Interstitial laser coagulation for<br />
management of benign prostatic obstruction: long-term follow-up. Int J<br />
Urol 2004; 11(11):978-982.<br />
45. AUA Practice Guidelines Committee: AUA guideline on management<br />
of benign prostatic obstruction (2003). Chapter 1: Diagnosis and<br />
treatment recommendations. J Urol 2003; 170(2 Pt 1):530-547.<br />
46. Barber NJ, and Muir GH. High-power KTP laser prostatectomy: the<br />
new challenge to transurethral resection of the prostate. Curr Opin Urol.<br />
2004; 14(1):21-25.<br />
47. Te AE, Malloy TR, Stein BS et al: Photoselective vaporization of the<br />
prostate (PVP) for the treatment of benign proatate (BPO): 12 months<br />
results from the first U.S. multicenter prospective trial. J Urol 2003;<br />
169(suppl):465.<br />
48. Malek R, and Kuntsman RS, Photoselective vaporization of the<br />
prostate: 5 year experience with high power KTP laser. J Urol 2003; 169<br />
(4suppl):1457.<br />
49. Gilling PJ, Cass CB, Cresswell MD, and Fraundorfer MR: Holmium<br />
laser resection of the prostate: preliminary results of a new method for the<br />
treatment of benign prostatic obstruction. Urology 1996; 47(1):48-51.<br />
50. Cresswell MD, Cass CB, Fraundorfer MR, Gilling PJ. Holmium:<br />
YAG laser resection of the prostate: preliminary experience with the first<br />
400 cases. New Zel Med J 1997; 110(1039):76-78.<br />
Correspondence: Domenico Prezioso, via Manzoni, 71 - 80126 Napoli<br />
E-mail: dprezioso@libero.it<br />
Archivio Italiano di Urologia e Andrologia 2007, 79, 3, Supplemento 1<br />
51. Gilling PJ, Mackey M, Cresswell M, et al. Holmium laser versus<br />
transurethral resection of the prostate: a randomized prospective trial<br />
with 1-year followup. J Urol 1999; 162(5):1640-1644.<br />
52. Das A, Kennett K, Fraundorfer M, Gilling P. Holmium laser resection<br />
of the prostate (HoLRP): 2-year follow-up data. Tech Urol 2001;<br />
7(4):252-255.<br />
53. Fraundorfer MR, Gilling PJ, Kennett KM, Dunton NG. Holmium<br />
laser resection of the prostate is more cost effective than transurethral<br />
resection of the prostate: results of a randomized prospective study.<br />
Urology 2001; 57(3):454-458.<br />
54. Das A, Kennett KM, Sutton T, et al. Histologic effects of holmium:<br />
YAG laser resection versus transurethral resection of the prostate. J<br />
Endourol 2000; 14(5):459-462.<br />
55. Tan AH and Gilling PJ. Holmium laser prostatectomy: current techniques.<br />
Urology 2002; 60:152.<br />
56. Tan AH, Gilling PJ, Kennett KM, et al. A randomized trial comparing<br />
holmium laser enucleation of the prostate with transurethral resection<br />
of the prostate for the treatment of bladder outlet obstruction secondary<br />
to benign prostatic obstruction in large glands (40 to 200<br />
grams). J Urol 2003; 170(4 Pt 1):1270-1274.<br />
57. Larner TR, Agarwal D, Costello AJ. Day-case holmium laser enucleation<br />
of the prostate for gland volumes of < 60 mL: early experience.<br />
Br J Urol Int 2003; 91(1):61-64.<br />
58. Madersbacher S, Marszalek M, Ponholzer A, Brossner C. Holmium<br />
laser-enucleation of the prostate enables early catheter removal. Br J<br />
Urol Int 2004; 94(6):931-393.<br />
59. Montorsi F, Naspro R, Salonia A, et al. Holmium laser enucleation<br />
versus transurethral resection of the prostate: results from a 2-center,<br />
prospective, randomized trial in patients with obstructive benign prostatic<br />
obstruction. J Urol 2004; 172(5 Pt 1):1926-1929.<br />
60. Kuntz RM, Ahyai S, Lehrich K, Fayad A. Transurethral holmium<br />
laser enucleation of the prostate versus transurethral electrocautery<br />
resection of the prostate: a randomized prospective trial in 200 patients.<br />
J Urol 2004; 172(3): 1012-1016.<br />
61. Naspro R, Freschi M, Salonia A, et al. Holmium laser enucleation<br />
versus transurethral resection of the prostate. Are histological findings<br />
comparable? J Urol 2004; 171(3):1203-1206.<br />
62. Pedraza R, Samadi A, Eshghi M. Holmium laser enucleation of the<br />
prostate in critically ill patients with technique modification. J Endourol<br />
2004; 18(8): 795-798.<br />
63. Tooher R, Sutherland P, Costello A, Gilling P, Rees G, Maddern G.<br />
A systematic review of holmium laser prostatectomy for benign prostatic<br />
obstruction. J Urol 2004; 171(5): 1773-1781.<br />
64. Smith D, Khoubehi B, Patel A. Bipolar electrosurgery for BPH:<br />
transurethral electrovaporization and resection of prostate. Curr Opin<br />
Urol 2005; 15: 95-100.<br />
65. Singh H, Desai MR, Shrivastav P, Vani K. Bipolar versus Monopolar<br />
transurethral resection of prostate: randomized controlled study. J<br />
Endourol 2005; 19:333-338.<br />
66. Ho H, Lim KB, Yip S, Foo KT, Cheng C. A prospective randomized<br />
controlled trial comparing TURIS system and conventional monopolar<br />
TURP in men with BPH: 1 year’s clinical efficacy and safety. Eur Urol<br />
Suppl 2006; 5:308.