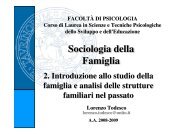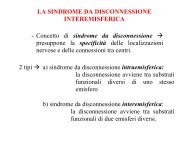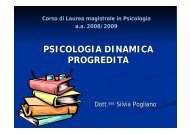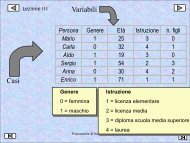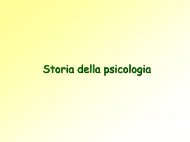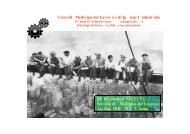4 Paradigma conflittuale.ppt_asc1.pdf - 49.35 Kb - Psicologia
4 Paradigma conflittuale.ppt_asc1.pdf - 49.35 Kb - Psicologia
4 Paradigma conflittuale.ppt_asc1.pdf - 49.35 Kb - Psicologia
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
LE TEORIE CONFLITTUALI<br />
OLTRE (NON CONTRO) LA PROSPETTIVA<br />
INTERAZIONISTA<br />
• Ritorno a interessi per dinamiche macrosociali<br />
• Non rifiuto del contributo dell’interazionismo, ma<br />
sforzo di situare scoperte in contesto di analisi<br />
globale su sistema sociale<br />
• Riferimento alla prospettiva <strong>conflittuale</strong> come teoria<br />
generale della società (contrapposta a prospettiva<br />
consensuale (espressa in funzionalismo)<br />
• D’altra parte, riflessione su sistema non di carattere<br />
astratto, ma con riferimento a sistema dominante in<br />
società occidentali (capitalismo)<br />
• Accentuazione di interesse per criminalità e per<br />
diritto penale, abbandono di enfasi su devianza<br />
(senza vittime) e su norme sociali
DUE TRADIZIONI CONFLITTUALISTICHE<br />
TEORIE CONFLITTUALI NON<br />
MARXISTE<br />
CONFLITTO<br />
TEORIE CONFLITTUALI<br />
MARXISTE<br />
TRA GRUPPI TRA CLASSI<br />
PER POTERE IN SFERA PER INTERESSI IN SFERA<br />
POLITICA<br />
ECONOMICA<br />
NATURA PERMANENTE, NATURA STORICAMENTE<br />
CONNATURATA IN OGNI<br />
SISTEMA SOCIALE<br />
DETERMINATA<br />
SUA INEVITABILITÀ SUO POSSIBILE<br />
SUPERAMENTO<br />
• Teorie conflittuali non–marxiste: conflitto tra gruppi<br />
è aspetto permanente e inevitabile della vita sociale,<br />
trova origine in interesse per distribuzione del potere.<br />
• Aspetti salienti:<br />
⇒contesto intellettuale simile a quello in cui si<br />
afferma l’interazionismo, riflette la differenziazione<br />
sempre più marcata delle società occidentali;<br />
⇒opere importanti come quelle di GOULDNER, La<br />
crisi della sociologia e di DAHRENDORF, Uscire<br />
dall’utopia, pongono in luce una nuova visione della<br />
società e criticano la funzione conservatrice delle<br />
posizioni consensuali, del funzionalismo;
⇒le strategie riformiste che vedono la luce pongono<br />
l’accento sulle funzioni del conflitto, al contributo che<br />
da alle dinamiche sociali (vedi l’opera di COSER, Le<br />
funzioni del conflitto sociale)<br />
⇒la criminalità è vista come espressione di conflitto<br />
“non realistico” e come status attribuito a seguito di<br />
un processo di criminalizzazione di alcune categorie<br />
di individui trattati come “capri espiatori” (l’invenzione<br />
di un nemico interno rafforza la coesione e sposta<br />
l’attenzione da altri problemi e conflitti potenziali);<br />
⇒l’interesse principale è per analisi della legislazione<br />
e dei processi di criminalizzazione, come<br />
espressione del conflitto di interessi (già in BECKER)<br />
e come mezzo di alcuni gruppi di difendere i propri;<br />
⇒i limiti sono in una visione semplicistica, astorica,<br />
formalista del conflitto, nella riduzione dello scontro<br />
alla sfera del politico, nella sostanziale adesione alla<br />
visione pluralista e riformista dei sistemi sociali.<br />
• Teorie conflittuali di ispirazione marxista: conflitto<br />
tra classi ha fondamento nella struttura economica, la<br />
sua connotazione va storicizzata, il suo superamento<br />
è possibile in società alternativa.<br />
• Aspetti salienti:<br />
⇒cenni nell’opera di MARX ed ENGELS, sui nessi<br />
tra condizioni economiche, materiali di sfruttamento e<br />
criminalità, prostituzione, alcolismo; passi ironici di
demistificazione del perbenismo borghese sulla<br />
funzione del crimine;<br />
⇒più interessante la riflessione sulla natura dello<br />
Stato e del diritto: componenti essenziali della<br />
sovrastruttura del sistema capitalistico;<br />
⇒natura storicamente determinata della legislazione<br />
che ha reso criminali certi comportamenti e sua<br />
natura ideologica;<br />
⇒riferimento a criminologia marxista: opera di<br />
BONGER, attribuzione a capitalismo responsabilità<br />
delle diverse forme di criminalità;<br />
⇒limiti: riduzione economicistica del tema delle<br />
motivazioni, schematicità di riflessioni su leggi<br />
(spesso espressione di lotte tra interessi dominanti e<br />
interessi di altri, spesso espressione di interessi<br />
propri del sistema politico e delle burocrazie);<br />
⇒in sintesi lettura importante ma non esaustiva<br />
(necessaria, ma non sufficiente) per assenza di<br />
approfondimento di intreccio tra fattori materiali e<br />
sovrastrutturali (cosa che tenteranno, ad esempio,<br />
Taylor, Walton e Young)
LE CRIMINOLOGIE RADICALI E CRITICHE<br />
• Panorama complesso in contesti diversi nel periodo<br />
di grandi fermenti che va dalla fine degli anni<br />
sessanta alla metà degli anni ottanta.<br />
• Tutte le posizioni riconoscono l’importanza del<br />
contributo interazionista e lo innestano in una<br />
riflessione connotata in chiave ideologica e politica.<br />
• Tutte le posizioni sono frutto non solo di una<br />
riflessione intellettuale, ma maturano in un contesto<br />
di sociologia e criminologia militante, di opposizione<br />
e/o di partecipazione.<br />
STATI UNITI GRAN<br />
BRETAGNA<br />
sociologia<br />
liberal<br />
criminologia<br />
radical<br />
School of<br />
Criminology di<br />
Berkeley<br />
D. Chapman:<br />
Lo stereotipo del<br />
criminale<br />
NationalDeviancy<br />
Conference:<br />
approccio scettico<br />
romantico<br />
critico<br />
Taylor, Walton e<br />
Young:<br />
The New<br />
Criminology<br />
GERMANIA<br />
ITALIA<br />
sociologia<br />
partecipativa<br />
sociologia<br />
dell’emarginazione<br />
criminologia critica<br />
(sociologia<br />
giuridico-penale)
TEORIE RADICALI E CRITICHE: USA, G.B.,ITALIA<br />
LA NUOVA CRIMINOLOGIA NEGLI STATI UNITI<br />
• Processo di radicalizzazione delle posizioni con il<br />
passaggio dalla sociologia liberal alla criminologia<br />
radical<br />
• Interessi preminenti: violazioni dei diritti delle<br />
minoranze, illegalismi del potere, repressione delle<br />
istanze di libertà, violenza nelle carceri e ruolo delle<br />
istituzioni totali (es. istituzioni per l’infanzia)<br />
• Visione del deviante come vittima del sistema e<br />
come potenzialmente rivoluzionario (devianza come<br />
azione cripto politica)<br />
• L’orizzonte entro cui ci si pone non è più quello<br />
della tolleranza, della sospensione del giudizio, del<br />
rispetto delle diversità, ma quello rivoluzionario<br />
dell’abbattimento del sistema<br />
L’EVOLUZIONE DELLE POSIZIONI IN G.B.<br />
• D. Chapman con il suo libro Lo stereotipo del<br />
criminale (vedi testo, p. 152-153) mette l’accento su:<br />
⇒il peso che gli stereotipi hanno nel definire il<br />
quadro conoscitivo della criminalità;<br />
⇒i nessi tra stereotipo e situazioni di potere /<br />
appartenenza di classe degli attori sociali;<br />
⇒le funzioni assolte dallo stereotipo del criminale;
⇒le condizioni di immunità che sono godute da<br />
appartenenti alle classi dominanti (si parla di<br />
distribuzione differenziale dell’immunità);<br />
⇒il ruolo delle istituzioni di controllo e delle istituzioni<br />
totali nella creazione del crimine;<br />
⇒la circolarità tra processo di selezione del criminale<br />
e del rafforzamento dello stereotipo.<br />
• La National Deviancy Conference raggruppa una<br />
serie di studiosi interessati in principio a sviluppare,<br />
in contrapposizione al conservatorismo della<br />
criminologia ufficiale britannica, le intuizioni<br />
dell’interazionismo statunitense, per poi intrecciare<br />
tali contenuti con l’analisi marxista. Interesse posto:<br />
⇒ sul ruolo dei media nella costruzione della<br />
definizione e dello stereotipo e nel sostegno alle<br />
campagne di allarme sociale (fase scettica);<br />
⇒sulla valorizzazione dei significati attribuiti<br />
all’azione deviante da parte dei protagonisti e delle<br />
istanze di rottura con il sistema che la devianza<br />
(soprattutto quella “espressiva”, il non conformismo)<br />
implicitamente esprime (fase romantica);<br />
⇒sulla valenza politica della gestione della<br />
criminalità e della devianza e sull’uso degli stessi<br />
fenomeni da parte del potere all’interno del dibattito<br />
teorico sulla natura e i limiti dell’egemonia borghese<br />
nei paesi a capitalismo avanzato (fase critica).
• L’opera di Taylor, Walton e Young, The New<br />
Criminology rappresenta un punto di sintesi piuttosto<br />
importante per lo sforzo di sintesi di posizioni<br />
teoriche diverse in un quadro di riferimento coerente,<br />
in una teoria compiuta che tenga conto dei nessi tra<br />
aspetti evidenziati da approcci e discipline differenti<br />
(economia, sociologia, psicologia sociale)<br />
FONDAMENTI GENERALI<br />
<br />
FONDAMENTI IMMEDIATI<br />
<br />
ATTO DEVIANTE<br />
DEFINIZIONE / STIGMA<br />
CONSEGUENZE (IDENTITÀ / OPPORTUNITÀ)<br />
<br />
FONDAMENTI IMMEDIATI DELLA REAZIONE<br />
<br />
FONDAMENTI GENERALI DELLA REAZIONE
DALLA CRIMINOLOGIA CRITICA<br />
AL REALISMO DI SINISTRA<br />
LA CRIMINOLOGIA CRITICA IN ITALIA<br />
• La criminologia critica in Italia si salda con le<br />
riflessioni della sociologia giuridico-penale di<br />
ispirazione marxista e pone al centro del proprio<br />
interesse:<br />
⇒la ricostruzione della natura e delle funzioni del<br />
diritto penale in un’ottica conflittualistica<br />
⇒la denuncia del carattere ideologico dei suoi<br />
assunti (vedi i principi testo, p. 163)<br />
⇒la selezione operata dal diritto circa i beni protetti<br />
penalmente (connessa alla tutela degli interessi<br />
dominanti) e dei comportamenti ritenuti meritevoli di<br />
sanzione penale (criminalizzazione primaria)<br />
⇒i meccanismi di funzionamento del sistema penale<br />
di controllo della devianza in termini di selezione<br />
degli individui (o delle categorie di individui)<br />
meritevoli di stigmatizzazione penale tra tutti quelli<br />
che violano le norme (criminalizzazione secondaria)<br />
• Sul tema del processo di criminalizzazione e dei<br />
nessi tra probabilità di essere oggetti di tale processo<br />
e condizione di classe è interessante lo schema<br />
riassuntivo di elaborato sulla base dei differenti<br />
apporti di cui abbiamo parlato da COTTINO:
OSTACOLI AL PROCESSO DI<br />
CRIMINALIZZAZIONE<br />
IMPEDIMENTO DI DEFINIZIONE DELLA NORMA<br />
(NORMA ASSENTE)<br />
SE NO<br />
<br />
CREAZIONE DI OSTACOLI<br />
ALLA SUA APPLICAZIONE EFFICACE<br />
SE NO<br />
<br />
GODIMENTO DI IMMUNITÀ ISTITUZIONALI<br />
SE NO<br />
<br />
PROTEZIONE DELLA PRIVACY<br />
IN AMBIENTI ISTITUZIONALI O PRIVATI<br />
SE NO<br />
<br />
GODIMENTO DI VANTAGGI DERIVANTI<br />
DA POLITICHE DI CONTROLLO SELETTIVO<br />
SE NO<br />
<br />
UTILIZZO SAPIENTE DELLE PROCEDURE E DEGLI ASPETTI DI<br />
DISFUNZIONALITÀ DELLA GIUSTIZIA<br />
SE NO<br />
<br />
FRUIZIONE DI UN TRATTAMENTO DIFFERENZIALE DA PARTE<br />
DEI TRIBUNALI<br />
SE NO<br />
<br />
CRIMINALIZZAZIONE
• Oltre alle analisi, nell’ambito del dibattito della<br />
criminologia critica si sviluppano diversi ragionamenti<br />
sulle possibilità di incidere sulle situazioni<br />
evidenziate, in primo luogo sulla possibile struttura di<br />
un diritto penale “minimo” capace di tutelare i beni<br />
meritevoli di difesa e di evitare gli effetti perversi dei<br />
processi di criminalizzazione, sulle specificità del<br />
fenomeno della criminalità organizzata, sulla natura e<br />
le funzioni del carcere (anche con riferimento a<br />
FOUCAULT)<br />
LE CRITICHE ALLE POSIZIONI DELLA<br />
CRIMINOLOGIA CRITICA<br />
• Non falsificabilità empirica di molte delle asserzioni:<br />
molte petizioni di principio e affermazioni ideologiche<br />
• Assenza di un ampio programma di ricerche<br />
empiriche<br />
• Maggiore capacità di negazione e distruzione delle<br />
prospettive altre che non di costruzione di una<br />
proposta alternativa capace di uscire dal<br />
determinismo economico<br />
• Enfasi su aspetto strumentale (da parte delle classi<br />
dominanti) della legislazione penale porta a<br />
sottovalutare bisogni e problemi di sicurezza avvertiti<br />
anche da classi sottoposte.
NUOVO REALISMO (O REALISMO DI SINISTRA)<br />
• Interesse da parte di criminologi di sinistra di<br />
contrastare criminologia realista, amministrativa<br />
(avversione per teorie sociologiche, enfasi su scelta<br />
razionale o determinanti individuali, approccio<br />
pragmatico fondato su valorizzazione della<br />
deterrenza, inasprimento delle sanzioni, importanza<br />
misure di controllo e repressione affidate ad apparati<br />
di polizia, prevenzione situazionale, ecc.)<br />
• Osservazione dell’importanza della microcriminalità<br />
e dei problemi di sicurezza che interessano gli strati<br />
popolari: necessità di prendere sul serio i fatti, non<br />
limitandosi a lavorare sulla definizione degli stessi<br />
• Critica all’idealismo di sinistra, alla sottovalutazione<br />
del problema eziologico, alla attribuzione a tutto il<br />
diritto penale di un carattere sempre strumentale<br />
(mentre in buona parte difende beni generali e non<br />
solo interessi delle classi dominanti)<br />
• Proposta di accompagnare alla sociologia del diritto<br />
penale (ovvero della definizione) e del controllo<br />
(ovvero della criminalizzazione) una sociologia<br />
dell’infrazione (ovvero della sua natura), del crimine<br />
(ovvero delle sue cause), dell’attore sociale (ovvero<br />
delle scelte individuali).
• Punti qualificanti:<br />
⇒la criminalità è problema reale, vero, causa di<br />
sofferenza non inventata<br />
⇒è indispensabile una vittimologia accurata che<br />
guardi alle caratteristiche reali della criminalità<br />
partendo dai danni inferti, alle aree di vittimizzazione,<br />
ai rapporti vittima-aggressore (e si scoprirà che<br />
appartengono a medesimi contesti, ovvero che la<br />
violenza è intra-classista e intra-razziale)<br />
⇒esiste un problema di sicurezza che i media<br />
enfatizzano ma non creano<br />
⇒occorre riprendere il discorso sulle cause della<br />
criminalità (così trascurato a partire dalla svolta<br />
interazionista), collegando meglio il livello macro (il<br />
capitalismo e le sue contraddizioni strutturali) e il<br />
livello micro (le deprivazioni relative, i rapporti<br />
esistenti all’interno di specifiche aree socio-culturali)<br />
⇒obiettivo è battere l’impossibilismo e l’astrattezza<br />
per competere con le altre criminologie conservatrici<br />
(che hanno molto seguito proprio presso le classi<br />
popolari perché si pongono il problema della<br />
sicurezza da esse sentito come reale) sul terreno<br />
delle proposte, con una chiara impostazione<br />
riformistica.