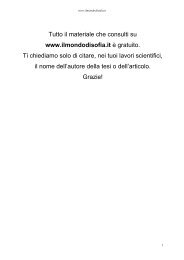Scarica la tesi - Il mondo di Sofia - Home
Scarica la tesi - Il mondo di Sofia - Home
Scarica la tesi - Il mondo di Sofia - Home
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
Tutto il materiale che consulti su<br />
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it è gratuito.<br />
Ti chie<strong>di</strong>amo solo <strong>di</strong> citare, nei tuoi <strong>la</strong>vori scientifici, il<br />
nome dell’autore del<strong>la</strong> <strong>tesi</strong> o dell’articolo.<br />
Grazie!
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE<br />
ORIENTALE<br />
“AMEDEO AVOGADRO”<br />
FACOLTA’ DI LETTERE E FILOSOFIA<br />
CORSO DI LAUREA IN FILOSOFIA<br />
TESI DI LAUREA<br />
IN<br />
ESTETICA<br />
L’ESTETICA DI CARLO MICHELSTAEDTER<br />
RELATORE: CANDIDATO:<br />
PROFESSOR LIVIO BOTTANI PAOLO PULCINA<br />
Anno Accademico 2001-2002<br />
1
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
ELENCO E SIGLE DELLE OPERE UTILIZZATE DI<br />
CARLO MICHELSTAEDTER (Gorizia 3 giugno 1887, ivi 17 ottobre 1910):<br />
Op= Opere Complete, Sansoni Firenze 1958, pp. 899.<br />
PeR= La Persuasione e <strong>la</strong> Rettorica , Adelphi Mi<strong>la</strong>no 1982, pp. 212.<br />
DDS= Dialogo del<strong>la</strong> Salute, Adelphi Mi<strong>la</strong>no 1988, pp. 140.<br />
Po= Poesie, Adelphi Mi<strong>la</strong>no 1987, pp. 112.<br />
Ep= Episto<strong>la</strong>rio, Adelphi Mi<strong>la</strong>no 1983, pp. 588.<br />
La persuasione e <strong>la</strong> rettorica – Appen<strong>di</strong>ci critiche, Vallecchi, Firenze 1922, pp.<br />
333.<br />
“Carducciana” e “Reminiscenze dei funerali del Carducci – Impressioni – La<br />
veglia”, in Corriere Friu<strong>la</strong>no del 22 febbraio 1907.<br />
“Più che l’amore <strong>di</strong> Gabriele D’Annunzio, al teatro <strong>di</strong> società”, in Corriere<br />
Friu<strong>la</strong>no del 6 maggio 1908.<br />
“Tolstoj”, in Corriere Friu<strong>la</strong>no del 18 settembre 1909.<br />
2
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
INDICE DELL’OPERA<br />
Introduzione 4<br />
I) Trattazione tematica del<strong>la</strong> persuasione e del<strong>la</strong> rettorica 7<br />
II) Sul<strong>la</strong> f ???????a , il possesso e l’angoscia 9<br />
III) L’adattamento sociale e religioso 23<br />
IV) Su giustizia e dovere 35<br />
V) L’ultimo presente 41<br />
VI) Su religione persuasa e religione sociale 45<br />
VII) Sul dolore, <strong>la</strong> colpa e <strong>la</strong> malinconia 52<br />
VIII) Sul silenzio e <strong>la</strong> paro<strong>la</strong> 60<br />
IX) Sull’amore come legame 64<br />
X) Sul dualismo insanabile del<strong>la</strong> vita 70<br />
XI) Sull’inevitabile destino dell’uomo 80<br />
XII) Breve raffronto fra persuasione michelstaedteriana, atarassia<br />
epicurea e apatia stoica 85<br />
XIII) Componenti estetiche del pensiero <strong>di</strong> Michelstaedter 94<br />
Conclusione 107<br />
Bibliografia 109<br />
3
itrovarsi». 1<br />
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
INTRODUZIONE<br />
«Se l’uomo non si fosse perduto nascendo, non dovrebbe cercarsi e<br />
Quest’aforisma <strong>di</strong> Otto Weininger, giovane filosofo contemporaneo <strong>di</strong><br />
Michelstaedter, e suicida come lui a soli ventitre anni, ci permette <strong>di</strong> iniziare a<br />
spiegare il senso <strong>di</strong> questo <strong>la</strong>voro sull’Autore Goriziano, spesso <strong>di</strong>menticato dal<strong>la</strong><br />
specu<strong>la</strong>zione filosofica e soltanto recentemente recuperato dal<strong>la</strong> critica letteraria.<br />
L’opera michelstaedteriana, infatti, è c<strong>la</strong>ssificabile in due <strong>di</strong>fferenti settori: <strong>la</strong><br />
letteratura e <strong>la</strong> filosofia, ma più sovente l’Autore viene annoverato fra i letterati<br />
piuttosto che fra i filosofi. Michelstaedter cresce e produce nel panorama italiano<br />
dei primi anni del Novecento, in un periodo dominato senza dubbio dal<br />
neoidealismo <strong>di</strong> Benedetto Croce, ma non ne viene partico<strong>la</strong>rmente influenzato.<br />
La sua riflessione, i concetti <strong>di</strong> persuasione e rettorica, si può definire inattuale.<br />
Egli segue il magistero degli antichi greci, che sente in partico<strong>la</strong>r modo vicini,<br />
sul<strong>la</strong> scia del pensiero <strong>di</strong> Nieztsche, che scrive: «solo in quanto allievo <strong>di</strong> epoche<br />
passate, specie <strong>di</strong> quel<strong>la</strong> greca, giungo ad esperienze così inattuali su <strong>di</strong> me come<br />
figlio dell’epoca moderna». 2 Si tenga presente che l’Autore recupera dal <strong>mondo</strong><br />
ellenico due fondamentali elementi culturali/specu<strong>la</strong>tivi: da un <strong>la</strong>to <strong>la</strong> ratio<br />
socratica, ossia <strong>la</strong> fiducia nel<strong>la</strong> conoscibilità del <strong>mondo</strong> (cosa che, in verità,<br />
Nietzsche rifiuta come illusione dettata da un cieco ottimismo, e che<br />
1 Otto Weininger, Delle cose Ultime, E<strong>di</strong>zioni Stu<strong>di</strong>o Tesi, Pordenone 1992, p. 83.<br />
2 Friedrich Nietzsche, Sull’utilità e il danno del<strong>la</strong> storia per <strong>la</strong> vita, Adelphi, Mi<strong>la</strong>no 1983, p. 4.<br />
4
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
Michelstaedter recupera invece come limite del<strong>la</strong> conoscenza stessa); dall’altro il<br />
senso del tragico, così bene rilevato da Michelstaedter sin dagli inizi, il cui<br />
pensiero tende a rappresentare in definitiva <strong>la</strong> completa fenomenologia dell’<br />
esistenza umana, le <strong>di</strong>mensioni esistenziali del<strong>la</strong> sofferenza dell’uomo. La<br />
ragione e il tragico si fondono e compenetrano nel<strong>la</strong> sua indagine filosofica sotto<br />
il segno del dolore, ambito senza dubbio fondamentale per <strong>la</strong> comprensione del<strong>la</strong><br />
<strong>tesi</strong> <strong>di</strong> <strong>la</strong>urea dell’Autore (La Persuasione e <strong>la</strong> Rettorica). <strong>Il</strong> dolore, frutto del<strong>la</strong><br />
vuota rincorsa al sod<strong>di</strong>sfacimento dei bisogni, si pone come un appello al<strong>la</strong><br />
ragione: dolore e ragione devono ricomporsi per permettere all’uomo il recupero<br />
del<strong>la</strong> sensibilità e dell’autenticità del<strong>la</strong> vita. Questo è per l’Autore il vero senso<br />
del<strong>la</strong> trage<strong>di</strong>a umana: essa c’è in quanto <strong>la</strong> vita non è, poiché <strong>la</strong> vita manca <strong>di</strong><br />
essere, non si compone mai, va ad infrangersi contro un <strong>mondo</strong> governato da<br />
necessità e bisogni.<br />
La specu<strong>la</strong>zione michelstaedteriana trae però materia <strong>di</strong> riflessione, oltre<br />
che dai tragici e dai lirici (come Sofocle, Euripide, Simonide, ecc.) e dai filosofi<br />
greci (su tutti P<strong>la</strong>tone, Aristotele, Eraclito e Parmenide), anche da autori a lui<br />
cronologicamente più vicini (come Ibsen, Schopenhauer e Nietzsche). Ed è<br />
specialmente il concetto <strong>di</strong> noluntas, recuperato da Schopenhauer, a farsi strada<br />
nel pensiero <strong>di</strong> Michelstaedter: l’uomo del<strong>la</strong> rettorica, l’illuso, il bisognoso, vuole<br />
in base alle sue necessità, è schiavo delle cose e teme ciò che gliele toglierà<br />
inevitabilmente, ovvero <strong>la</strong> morte. <strong>Il</strong> persuaso, per converso, è <strong>di</strong>silluso, non nutre<br />
falsi desideri, non vuole nul<strong>la</strong> perché è, e non ha bisogno <strong>di</strong> volere alcunché. Egli<br />
5
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
non teme <strong>la</strong> morte, perché è libero, sicuro <strong>di</strong> ritrovare <strong>la</strong> <strong>di</strong>mensione che vivendo<br />
nel<strong>la</strong> società dei retori ha dovuto smarrire: il persuaso vede solo nel<strong>la</strong> morte il<br />
perseguimento del<strong>la</strong> totalità del<strong>la</strong> vita. In questo punto si situa l’indagine del<strong>la</strong><br />
nostra <strong>tesi</strong>. Infatti, alcuni critici hanno sostenuto che il suici<strong>di</strong>o attuato da<br />
Michelstaedter il 17 ottobre 1910 fosse frutto più <strong>di</strong> una combinazione <strong>di</strong> eventi<br />
sfortunati, piuttosto che <strong>la</strong> drammatica ma inevitabile conclusione <strong>di</strong> una vita,<br />
seppur breve, spesa nel<strong>la</strong> lotta contro <strong>la</strong> vita inautentica. Quest’analisi non ci<br />
sembra per niente corretta, e tutto il pensiero <strong>di</strong> Michelstaedter sta a testimoniare<br />
l’erroneità. Quantunque Michelstaeder con<strong>di</strong>vida il pensiero <strong>di</strong> Weininger,<br />
quando scrive che «il suici<strong>di</strong>o non è segno <strong>di</strong> coraggio, ma <strong>di</strong> viltà, sebbene esso<br />
sia <strong>di</strong> tutte le viltà <strong>la</strong> più picco<strong>la</strong>» 3 , egli reputa in fondo che <strong>la</strong> morte sia l’unica<br />
scelta che rimanga all’uomo che non voglia abbandonarsi al<strong>la</strong> rettorica. La<br />
<strong>di</strong>mensione del<strong>la</strong> persuasione è irrealizzabile nel<strong>la</strong> vita, impossibile nel<strong>la</strong> società:<br />
il persuaso è compiutamente tale nel momento del<strong>la</strong> morte, che così rappresenta<br />
l’unica vera scelta <strong>di</strong> libertà dell’uomo.<br />
3 Otto Weininger, Delle cose ultime, cit., p. XXXII.<br />
6
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
I<br />
TRATTAZIONE TEMATICA DELLA PERSUASIONE E DELLA<br />
RETTORICA<br />
Per cogliere <strong>la</strong> complessità che La Persuasione e <strong>la</strong> Rettorica 4 rappresenta,<br />
bisogna fare una considerazione preliminare: <strong>la</strong> <strong>tesi</strong> <strong>di</strong> <strong>la</strong>urea in cui tale opera<br />
s’innesta, ha attraversato un lungo periodo <strong>di</strong> incertezza, derivante dall’incapacità<br />
<strong>di</strong> Michelstaedter <strong>di</strong> prevederne limiti e <strong>di</strong>mensioni, tanto che essa al<strong>la</strong> fine<br />
risulterà un <strong>la</strong>voro quasi assurdo da <strong>di</strong>scutere in sede universitaria. L’opera<br />
appare sempre sul punto <strong>di</strong> essere conclusa, ma <strong>la</strong> stesura si amplia via via<br />
allontanandosi dal progetto originario. A conferma <strong>di</strong> questo fatto ci sono le<br />
parole dell’Autore in<strong>di</strong>rizzate all’amico Gaetano Chiavacci 5 in data 15 ottobre<br />
1909:<br />
Io <strong>la</strong>voro solo da due settimane e non posso aver finito prima del<strong>la</strong> fine <strong>di</strong><br />
novembre. Informati, senza capire che lo fai per me, se posso ignorare i termini e<br />
consegnar <strong>la</strong> mia qualunque <strong>tesi</strong> al<strong>la</strong> fine <strong>di</strong> novembre (Op. 584).<br />
La <strong>tesi</strong> in realtà sarà pronta soltanto dopo un altro anno, in realtà: le parole sopra<br />
citate sono il segnale <strong>di</strong> un incerto dominio delle pagine e del materiale da<br />
4 Questo è il titolo del<strong>la</strong> principale opera <strong>di</strong> Michelstaedter, iniziata nell’autunno del 1909. Essa è <strong>la</strong> sua<br />
<strong>tesi</strong> <strong>di</strong> <strong>la</strong>urea, che l’Autore mai <strong>di</strong>scusse, e che spedì a Firenze, città dove stu<strong>di</strong>ava letteratura e filosofia.<br />
Michelstaedter si suicidò il 17 ottobre 1910, il giorno seguente aver terminato le Appen<strong>di</strong>ci Critiche al<strong>la</strong><br />
<strong>tesi</strong>.<br />
5 Ricordo che Chiavacci sarà il curatore <strong>di</strong> tutta <strong>la</strong> produzione letteraria <strong>di</strong> Michelstaedter, e raccoglierà<br />
tutti i suoi scritti nel volume Opere, e<strong>di</strong>to da Sansoni, Firenze 1958, mio punto <strong>di</strong> riferimento per <strong>la</strong><br />
stesura <strong>di</strong> questa <strong>tesi</strong>.<br />
7
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
inserirvi. Circa un mese più tar<strong>di</strong>, il 28 novembre, Michelstaedter scriverà ancora<br />
all’amico Chiavacci:<br />
Oggi però non sono molto più prossimo al<strong>la</strong> fine <strong>di</strong> quanto fossi allora (il<br />
riferimento è ad una precedente lettera datata 27 ottobre). La mia <strong>tesi</strong> è un mostro<br />
informe che crescit eundo et quod crescit non it. Ma io <strong>la</strong> <strong>la</strong>scio fare <strong>di</strong> suo<br />
capo…(Op 592).<br />
La <strong>tesi</strong> <strong>di</strong> <strong>la</strong>urea è <strong>la</strong> vita stessa, e razionalizzar<strong>la</strong> per espor<strong>la</strong> non è assolutamente<br />
facile, anzi: è gravoso per <strong>la</strong> mente e l’animo, e procede inevitabilmente a rilento.<br />
Michelstaedter non riesce e non può rettificare le trasformazioni e le<br />
mo<strong>di</strong>ficazioni, poiché il processo <strong>di</strong> creazione del<strong>la</strong> Persuasione è inizialmente<br />
sotterraneo, quasi subliminale, evolvente a sua stessa insaputa, cosicché pare<br />
lecito affermare che l’idea primigenia (<strong>di</strong> una trattazione storico-filologico-<br />
filosofica dei concetti <strong>di</strong> persuasione e rettorica) va smarrita. L’Autore si è spinto<br />
ben oltre, ha travalicato i limiti imposti, e lo scorrere delle settimane <strong>di</strong> <strong>la</strong>voro<br />
rende trabal<strong>la</strong>nte l’orizzonte entro cui Michelstaedter tenta <strong>di</strong> muoversi: il<br />
risultato non è più uno scritto destinato ad essere valutato da docenti universitari,<br />
ma un saggio <strong>di</strong> argomento universale, trattato come sistema del<strong>la</strong> vita in toto.<br />
«Michelstaedter non ha il tempo, forse <strong>la</strong> voglia <strong>di</strong> fermarsi, continua, tutto si<br />
concentra e rischia <strong>di</strong> esplodere, assistiamo al<strong>la</strong> sua formazione, una pagina<br />
attraversa più veli» 6 .<br />
L’intento <strong>di</strong> questa <strong>tesi</strong> è, così, quello <strong>di</strong> mettere in chiaro tutti gli<br />
argomenti filosofici ed estetici trattati da Michelstaedter, <strong>di</strong>videndoli e<br />
corre<strong>la</strong>ndoli allo stesso tempo, al fine <strong>di</strong> mostrare l’unità/unicità del suo pensiero.<br />
6 Pier Andrea Amato, L’attimo persuaso: filosofia e letteratura in C. Michelstaedter – estratto ricavato<br />
dal sito internet www.michelstaedter.it/amato.html.<br />
8
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
II<br />
SULLA FILOPSICHIA, IL POSSESSO E L’ANGOSCIA<br />
Filopsichia: “amar <strong>la</strong> vita” – è amare una cosa non perché sia un valore ma<br />
seguendo <strong>la</strong> necessità, equivale a non amare <strong>la</strong> libertà, rinunciare ad una vera<br />
essenza. – Ma finché uno suppone nel<strong>la</strong> vita valor i assoluti senza chiedersene<br />
ragione, egli crede d’essere nel<strong>la</strong> libertà e nell’essenza quando ama queste tali cose<br />
nel<strong>la</strong> vita, e per queste <strong>la</strong> vita. Così nel<strong>la</strong> lingua amor del<strong>la</strong> vita non ha per se un<br />
senso cattivo (Op 717).<br />
Si può affermare che <strong>la</strong> filopsichia (f ???????a) si presenta come <strong>la</strong> <strong>di</strong>retta<br />
ed acerrima rivale del<strong>la</strong> filosofia, in quanto rappresentante il motore che spinge<br />
l’uomo a comportarsi secondo rettorica: l’amore viscerale per <strong>la</strong> vita (qualunque<br />
vita sia) <strong>di</strong>mostra un attaccamento al<strong>la</strong> propria esistenza tale da offuscare<br />
qualunque riflessione profonda sul senso stesso del<strong>la</strong> vita e dell’essere. Questo<br />
attaccamento all’esistere, dovuto ad una tanto congenita quanto misteriosa paura<br />
del<strong>la</strong> morte (che è, poi, paura <strong>di</strong> perdere il senso <strong>di</strong> se stessi), stimo<strong>la</strong> l’in<strong>di</strong>viduo<br />
al<strong>la</strong> ricerca del piacere, impossessandosi del<strong>la</strong> sua volontà ed offuscando <strong>la</strong> sua<br />
coscienza. L’uomo rettorico si ritrova così a dover vivere tentando <strong>di</strong> ripetere il<br />
presente nel futuro, continuandosi, nel<strong>la</strong> ricerca <strong>di</strong> una stabilità e <strong>di</strong> una sicurezza<br />
impossibili da traguardare a causa del timore del<strong>la</strong> morte. L’angoscia che<br />
scaturisce da questa paura non dà scampo al<strong>la</strong> vita umana: l’uomo s’impiega nei<br />
suoi <strong>la</strong>vori al fine <strong>di</strong> non dover pensare al suo inevitabile destino, intorpi<strong>di</strong>sce il<br />
9
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
suo spirito, oblia il suo essere e si abbandona al<strong>la</strong> illusione del<strong>la</strong> rettorica. Accade<br />
così che «i segni del presente <strong>di</strong>ventano previsioni per l’avvenire; il presente si<br />
svuota <strong>di</strong> significato per ravvisare in un futuro sempre <strong>di</strong> là da venire <strong>la</strong> pienezza<br />
del<strong>la</strong> propria sicurezza. Non c’è presente, per l’uomo del<strong>la</strong> rettorica, se non in<br />
vista <strong>di</strong> un qualche futuro» 7 .<br />
La filopsichia induce così l’uomo all’aggregazione sociale, con lo scopo <strong>di</strong><br />
trovare una sicurezza ed una protezione comuni capaci <strong>di</strong> proteggere l’identità<br />
del<strong>la</strong> vita dal sopraggiungere del sentimento del<strong>la</strong> morte: <strong>la</strong> rettorica falsifica<br />
l’autenticità <strong>di</strong> ognuno, e l’uomo rettorico (che capiterà <strong>di</strong> chiamare<br />
semplicemente retore) non avrà coscienza <strong>di</strong> cercare <strong>la</strong> vera salvezza 8 .<br />
.<br />
Così muovendosi nel giro delle cose che gli fanno piacere, l’uomo (retore) si gira<br />
sul pernio che dal <strong>di</strong>o gli è dato (…) e cura <strong>la</strong> propria continuazione senza<br />
preoccuparsene, perché il piacere preoccupa il futuro per lui. Ogni cosa ha per lui<br />
questo dolce sapore, ch’egli <strong>la</strong> sente sua perché utile al<strong>la</strong> sua continuazione, e in<br />
ognuna con <strong>la</strong> sua potenza affermandosi egli ne ritrae sempre l’adu<strong>la</strong>zione ‘tu sei’<br />
(PeR 51).<br />
Da queste parole si ravvisa <strong>la</strong> nascita dell’uomo sufficiente, un tipo <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduo<br />
profondamente illuso nel<strong>la</strong> riuscita dei propri progetti proiettati nel futuro: ecco,<br />
dunque, che i retori «chiedono <strong>di</strong> essere per qualcuno, per qualcosa, ché <strong>di</strong> fronte<br />
al<strong>la</strong> richiesta del possesso si sentivano mancare» (PeR 93).<br />
<strong>Il</strong> tema del possesso è molto caro a Michelstaedter, ed è possibile<br />
accostarlo al concetto più profondo <strong>di</strong> vita proposto da Søren Kierkegaard, per<br />
7 Giorgio Brianese, L’arco e il destino, Francisci E<strong>di</strong>tore, Abano Terme 1985, p. 46.<br />
8 Michelstaedter in luogo del<strong>la</strong> paro<strong>la</strong> salvezza usa molto più sovente <strong>la</strong> parole salute, compresa nel titolo<br />
<strong>di</strong> un’importante sua opera: il Dialogo del<strong>la</strong> Salute.<br />
10
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
cui essa è definibile come vita perlustrata nel suo intimo dall’angoscia, che mette<br />
ognuno <strong>di</strong> fronte alle proprie ansie e paure 9 . <strong>Il</strong> possesso rettorico, similmente,<br />
viene a determinare l’angoscia nell’uomo del<strong>la</strong> società, poiché egli sente <strong>di</strong> voler<br />
possedere qualcosa ma non lo può fare in maniera autentica, a causa del<strong>la</strong> sua<br />
medesima inautenticità: il retore non possiede se stesso, il suo spirito, il suo<br />
essere-uno, e perciò è condannato ad una vita <strong>di</strong> inganni ed illusioni. Accade così<br />
che <strong>la</strong> vita del<strong>la</strong> società si manifesta come un insieme <strong>di</strong> coscienze sommamente<br />
infelici (il riferimento, ovviamente, riporta al concetto <strong>di</strong> coscienza infelice <strong>di</strong><br />
Hegel). <strong>Il</strong> retore vive una vita spersonalizzata, insulsa ed insapore 10 , abbandonata<br />
alle usanze e alle convenzioni che <strong>la</strong> storia ha provveduto a fornire alle società: è<br />
bisognoso, nutre in continuazione desideri e ansie <strong>di</strong> realizzazione, è<br />
manchevole, perennemente insod<strong>di</strong>sfatto, perché avverte, nel<strong>la</strong> sua più recon<strong>di</strong>ta<br />
intimità, <strong>di</strong> esistere in maniera errata. <strong>Il</strong> persuaso michelstaedteriano<br />
interverrebbe ammonendolo che «esser vivi si fa abitu<strong>di</strong>ne – e – chi incontra <strong>la</strong><br />
vita deve morire – e ancora – chi teme <strong>la</strong> morte è già morto» (PeR 69).<br />
Michelstaedter porta a testimonianza del suo pensiero un esempio tanto<br />
semplice quanto magistrale: l’esempio del peso.<br />
So che voglio e non ho cosa io voglia. Un peso pende ad un gancio, e per pender<br />
soffre che non può scendere: non può uscire dal gancio, poiché quant’è peso pende<br />
e quanto pende <strong>di</strong>pende. Lo vogliamo sod<strong>di</strong>sfare: lo liberiamo dal<strong>la</strong> sua<br />
9 «L’angoscia […] era il momento del<strong>la</strong> vita in<strong>di</strong>viduale», (S. Kierkegaard, <strong>Il</strong> concetto dell’angoscia, BiT,<br />
Mi<strong>la</strong>no 1995, p. 63). L’uomo del<strong>la</strong> critica kierkegaar<strong>di</strong>ana è privo <strong>di</strong> consapevolezza del peccato, ed è<br />
sconvolto quando gli si parano davanti quegli aspetti tremen<strong>di</strong> legati al timore del<strong>la</strong> morte. Per<br />
Michelstaedter accade che <strong>la</strong> rettorica stor<strong>di</strong>sca <strong>la</strong> coscienza umana, rendendo<strong>la</strong> infelice e falsificata,<br />
protesa al<strong>la</strong> realizzazione <strong>di</strong> obiettiv i comuni inutili al fine del recupero del<strong>la</strong> propria <strong>di</strong>mensione<br />
essenziale. La vita rettorica è basata sul dualismo manicheo vita-morte (onticità-ontologicità).<br />
10 Nei <strong>la</strong>vori <strong>di</strong> Michelstaedter spesso <strong>la</strong> paro<strong>la</strong> sapore è utilizzata in luogo <strong>di</strong> sapere (vedasi: DDS 46).<br />
11
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
<strong>di</strong>pendenza; lo <strong>la</strong>sciamo andare, che sazi <strong>la</strong> sua fame del più basso, e scenda<br />
in<strong>di</strong>pendente fino a che sia contento <strong>di</strong> scendere. – Ma in nessun punto raggiunto<br />
fermarsi lo accontenta e vuol pur scendere, ché al prossimo punto supera in<br />
bassezza quello che esso ogni volta tenga. E nessuno dei punti futuri sarà tale da<br />
accontentarlo, che necessario sarà al<strong>la</strong> sua vita , fintanto che lo aspetti più basso;<br />
ma ogni volta fatto presente, ogni punto gli sarà fatto vuoto d’ogni attrattiva non<br />
più essendo più basso; così che in ogni punto esso manca dei punti più bassi e<br />
vieppiù questi lo attraggono: sempre lo tiene un’ugual fame del più basso, e infinita<br />
gli resta pur sempre <strong>la</strong> volontà <strong>di</strong> scendere. Che se in un punto gli fosse finita e in<br />
punto potesse possedere l’infinito scendere dell’infinito futuro – in quel punto esso<br />
non sarebbe più quello che è: un peso. La sua vita è questa mancanza del<strong>la</strong> sua vita.<br />
[…] <strong>Il</strong> peso non può mai esser persuaso. (PeR 39)<br />
L’esempio sopra citato è emblematico e tagliente: il peso ha per sua natura <strong>la</strong><br />
tendenza a scendere, per poter saziare il suo bisogno. <strong>Il</strong> suo anelito essenziale che<br />
lo spinge verso il basso spera <strong>di</strong> riuscire a saziare <strong>la</strong> sua volontà. Ma il desiderio<br />
<strong>di</strong> giungere al<strong>la</strong> realizzazione definitiva del suo stimolo non verrà mai saziato,<br />
perché altrimenti il peso farebbe <strong>di</strong> se stesso fiamma, nel momento in cui<br />
cogliesse <strong>la</strong> persuasione (senza contare che il picco più basso non si potrà<br />
comunque raggiungere). <strong>Il</strong> peso non può mai raggiungere l’attimo del<strong>la</strong><br />
persuasione: il peso è sempre rettorico.<br />
Con questa metafora viene descritta <strong>la</strong> con<strong>di</strong>zione umana <strong>di</strong> singoli<br />
‘volenti’, sempre in cerca <strong>di</strong> un determinato oggetto, <strong>di</strong> una determinata realtà,<br />
incapaci però <strong>di</strong> conquistarli sinceramente a causa del desiderio angoscioso <strong>di</strong><br />
colmare qualche altro abituale bisogno: l’uomo non può mai smettere <strong>di</strong> volere,<br />
perché <strong>la</strong> sua natura in vita è <strong>di</strong> vivere nel suo stato <strong>di</strong> mancanza, nel<strong>la</strong> sua<br />
insod<strong>di</strong>sfazione.<br />
Questa è <strong>la</strong> struttura irreversibile del<strong>la</strong> vita rettorica, quel<strong>la</strong> vita che non si<br />
interessa del momento (nel<strong>la</strong> concezione artistica <strong>di</strong> Michelstaedter il momento è<br />
12
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
il tempo dell’arte) attuale e del<strong>la</strong> sua intensità, ma programma tutto<br />
riverberandosi scioccamente ed ingenuamente nel futuro prossimo, che sembra <strong>di</strong><br />
primo acchito il tempo più vicino, mentre, in realtà, risulta essere il più remoto.<br />
L’uomo insegue il suo progetto nel ‘dopo’, non nel ‘qui ed ora’, e non realizza<br />
mai se stesso.<br />
È bene, però, rendersi conto del<strong>la</strong> paradossale conclusione a cui si giunge se<br />
si segue il monito dell’Autore. Una vera società non esisterebbe mai, o, per lo<br />
meno, dovrebbe essere una società <strong>di</strong> persuasi. Ma, se così fosse, il persuaso non<br />
sarebbe più effettivamente persuaso, poiché <strong>la</strong> società gli imporrebbe il vincolo<br />
del<strong>la</strong> sicurezza e del bisogno. Nel contesto michelstaedteriano, il persuaso è tale<br />
soltanto nell’attimo in cui coglie <strong>la</strong> totalità <strong>di</strong> sé e del <strong>mondo</strong>, dell’essere e del<strong>la</strong><br />
sua perfezione: potrebbe, <strong>di</strong> conseguenza, mantenere salda <strong>la</strong> sua vita anche dopo<br />
questo momento? Si può reputare che sia davvero irrealizzabile: ecco il motivo<br />
del suici<strong>di</strong>o. Michelstaedter accusa i suici<strong>di</strong> <strong>di</strong> codar<strong>di</strong>a e vigliaccheria, ma è<br />
ovvio che si riferisca a chi non sopporta più il peso del bisogno, non potendolo<br />
sod<strong>di</strong>sfare secondo <strong>la</strong> <strong>di</strong>rettiva social-rettorica:<br />
Rettorica del suici<strong>di</strong>o: <strong>la</strong> rivoltel<strong>la</strong>, i veleni, perché l’uomo possa andarsene dal<strong>la</strong><br />
vita a sangue freddo, senza misurare nemmeno nell’istante estremo <strong>la</strong> profon<strong>di</strong>tà<br />
del<strong>la</strong> vita, del suo attaccamento al<strong>la</strong> vita, come sente il suicida che si mette in<br />
posizioni dove <strong>la</strong> morte appare nel<strong>la</strong> forma <strong>di</strong> mortale pericolo che il corpo<br />
istintivamente ha sempre sfuggito: pugnale, fuoco, salto precipitoso, ecc. […] <strong>Il</strong><br />
pessimista muore d’inerzia quando vi giunge attraverso l’attività, non si suicida<br />
(Op 761).<br />
13
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
Si può affermare che <strong>la</strong> morte sia invece l’ultima necessità <strong>di</strong> una vita<br />
desiderante: essa si muove sul limite su cui sta il <strong>mondo</strong> dell’essere e<br />
dell’assoluto, e <strong>la</strong> chiave per poter compenetrarsi in esso nell’istante è <strong>la</strong><br />
persuasione. Si potrebbe sostenere che in fondo <strong>la</strong> società rettorica serva a<br />
Michelstaedter come elemento <strong>di</strong> massima contrapposizione all’autenticità del<strong>la</strong><br />
vita del saggio, tanto che se l’umanità potesse essere un insieme <strong>di</strong> persuasi,<br />
allora l’umanità attuale non esisterebbe più.<br />
Ma è giusto rilevare che «se pur pensi, ben miserevole cosa sei, che volgi<br />
le spalle ad ogni forma <strong>di</strong> vita più forte, per il<strong>la</strong>ngui<strong>di</strong>rti nelle piccole gioie del<strong>la</strong><br />
tua solitu<strong>di</strong>ne: non l’amore, non <strong>la</strong> lotta, non <strong>la</strong> gloria: hai <strong>di</strong>strutto in te ogni<br />
umanità» (Op 664). In questo caso umanità è da intendersi come spirito<br />
dell’uomo (Menschheit). La cosa è catastrofica al<strong>la</strong> massima potenza, ma il<br />
messaggio dell’Autore sembra essere racchiuso proprio in questo concetto: <strong>la</strong><br />
persuasione è uno stato <strong>di</strong> coscienza superiore a quello in cui l’uomo sta vivendo<br />
(ecco perché Michelstaedter asserisce che <strong>la</strong> persuasione è incosciente: perché<br />
l’uomo rettorico non <strong>la</strong> può concepire come suo grado <strong>di</strong> coscienza).<br />
La società rappresenta, potremmo <strong>di</strong>re, il sostrato da cui emergono coloro<br />
che sentono nel profondo <strong>la</strong> trasformazione del<strong>la</strong> coscienza verso il recupero<br />
del<strong>la</strong> totalità e dell’autenticità: senza <strong>di</strong> essa non c’è neppure <strong>la</strong> rettorica. È<br />
questo, pertanto, il motivo per cui i concetti <strong>di</strong> persuasione e rettorica sono<br />
sempre inseparabili, tranne che nell’attimo che anticipa <strong>la</strong> morte; tanto più che<br />
14
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
l’uomo, volendo conseguire <strong>la</strong> propria autenticità, deve darsi un compito preciso:<br />
deve incontrare l’assoluto/morte e con-penetrarsi nell’unità-totalità.<br />
Si può asserire che il persuaso ed il retore sono il medesimo personaggio,<br />
mossi dal<strong>la</strong> stessa necessità <strong>di</strong> riunificazione, «solo che per il rettorico essa<br />
maschera <strong>la</strong> volontà <strong>di</strong> vivere sempre ulteriormente, al <strong>di</strong> là dell’unificazione<br />
presente, per il persuaso non nasconde più nul<strong>la</strong>, ma si traduce invece<br />
nell’imme<strong>di</strong>ata e concreta attuazione dell’unità» 11 .<br />
Ritornando al <strong>di</strong>scorso precedente, risulta chiaro che vivere nel<strong>la</strong><br />
preoccupazione del futuro è uccidere <strong>la</strong> vera essenza del tempo che lo spirito<br />
dell’uomo (spirito del<strong>la</strong> coscienza dell’uomo) concepisce. L’uomo rettorico crede<br />
<strong>di</strong> agire ed invece patisce, non si possiede, non si control<strong>la</strong> e perde <strong>la</strong> sua<br />
autenticità: è l’assassino del<strong>la</strong> coscienza. Le tendenza a nutrirsi del e nel futuro,<br />
programmando <strong>la</strong> propria vita nel tempo a venire, è, secondo Michelstaedter,<br />
un’operazione inadeguata al<strong>la</strong> vera vita, perché fondata sul mantenimento del<br />
vuoto a livello del presente, cioè a livello del tempo del<strong>la</strong> vita persuasa. Si nota<br />
bene qui l’influsso del<strong>la</strong> filosofia <strong>di</strong> Nietzsche, secondo cui il significato ultimo<br />
del<strong>la</strong> vita e delle cose sta nel presente: «In ogni istante ha principio l’essere;<br />
intorno ad ogni ‘qui’ ruota <strong>la</strong> sfera ‘là’. Dappertutto è il centro. Curvo è il<br />
sentiero dell’eternità» 12 .<br />
L’uomo del<strong>la</strong> retorica vive mancando <strong>di</strong> vita, sfugge volontariamente al<br />
presente per tentare una realizzazione <strong>di</strong> sé nel futuro, s’illude <strong>di</strong> possedere ed è<br />
11 Giorgio Brianese, L’arco e il destino, cit. pp. 61-62.<br />
12 F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra, Newton Economici, Roma 1997, p. 163.<br />
15
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
in verità posseduto dal suo stesso progettare; egli è colui che ha volontà <strong>di</strong><br />
possesso, mentre in realtà non possiede nul<strong>la</strong> e non può possedere nul<strong>la</strong>, perché<br />
in primo luogo non possiede se stesso, e cerca dunque <strong>di</strong> possedere qualcosa e<br />
qualcuno al fine <strong>di</strong> ‘darsi un senso’, inevitabilmente non frivolo e manchevole,<br />
lucido specchio del<strong>la</strong> sua vita inautentica.<br />
L’esempio del cloro e dell’idrogeno rafforza maggiormente <strong>la</strong> riflessione <strong>di</strong><br />
Michelstaedter sul<strong>la</strong> vita, tendendo a concepire il <strong>mondo</strong> come un affastel<strong>la</strong>to e<br />
farraginoso sovrapporsi <strong>di</strong> intenzioni e determinazioni <strong>di</strong> affermazioni fasulle.<br />
La loro vita è il suici<strong>di</strong>o.<br />
Per esempio, il cloro è sempre stato così ingordo che è tutto morto, ma se noi lo<br />
facciamo rinascere e lo mettiamo in vicinanza dell’idrogeno, esso non vivrà che per<br />
l’idrogeno. L’idrogeno sarà per lui l’unico valore del <strong>mondo</strong>: il <strong>mondo</strong>; <strong>la</strong> sua vita<br />
sarà unirsi all’idrogeno. E questo sarà luce a ognuno degli atomi del cloro nel<strong>la</strong><br />
breve vita al<strong>la</strong> vicina via del<strong>la</strong> compenetrazione. Ma sod<strong>di</strong>sfatto l’amore, <strong>la</strong> luce<br />
anche essa sarà spenta, e il <strong>mondo</strong> sarà finito per l’atomo <strong>di</strong> cloro. Poiché <strong>la</strong><br />
presenza dell’atomo d’idrogeno avrà fatto palpebra all’occhio dell’atomo <strong>di</strong> cloro,<br />
che non vedeva che idrogeno, e gli avrà chiuso l’orizzonte, che era tutto idrogeno.<br />
<strong>Il</strong> loro amore non è per <strong>la</strong> vita sod<strong>di</strong>sfatta, per l’essere persuaso, bensì pel<br />
vicendevole bisogno che ignora <strong>la</strong> vita altrui. I loro due mon<strong>di</strong> erano <strong>di</strong>versi ma<br />
corre<strong>la</strong>tivi così che dall’amplesso mortale avesse d’attender poi e soffrir <strong>la</strong> sua vita:<br />
l’acido cloridrico (PeR 46).<br />
Gli in<strong>di</strong>vidui si scaricano addosso le proprie insicurezze ed i propri timori<br />
facendo presuntuose affermazioni <strong>di</strong> se stessi. L’angoscia <strong>di</strong> non saper<br />
raggiungere <strong>la</strong> vita, a causa dell’affanno perdurante <strong>di</strong> poter perdere quest’unica<br />
occasione concessa, determina un vano inseguimento nel tentativo <strong>di</strong> far<strong>la</strong><br />
propria. Questa rincorsa va pertanto a costituire una alienazione: l’uomo retorico,<br />
non potendo trattenere <strong>la</strong> vita (perché intrattenibile), si espone alle angosce <strong>di</strong><br />
nuovi bisogni e desideri, per cercare <strong>di</strong> immobilizzare <strong>la</strong> sua esistenza che fugge.<br />
16
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
La rettorica spinge l’uomo verso <strong>la</strong> ricerca incessante del<strong>la</strong> sod<strong>di</strong>sfazione del<br />
desiderio, del<strong>la</strong> volontà, ed il soggetto (o, assecondando Michelstaedter,<br />
l’oggetto) agente accumu<strong>la</strong> giorno dopo giorno angosce su angosce.<br />
È proprio questa <strong>la</strong> vita senza vita <strong>di</strong> cui par<strong>la</strong> l’Autore, attingendo questa<br />
tematica anche dal pensiero <strong>di</strong> un grande letterato a lui contemporaneo: Lev<br />
Niko<strong>la</strong>ijevic Tolstoj 13 . Quest’ultimo aveva spesso espresso nelle sue opere (che<br />
tanto affascinavano Michelstaedter) un profondo senso <strong>di</strong> repulsione per <strong>la</strong><br />
moltitu<strong>di</strong>ne degli arrivati, per coloro che si credono sul<strong>la</strong> giusta strada che<br />
conduce ad un utile sicuro. Secondo Tolstoj, l’abitu<strong>di</strong>ne sociale (cioè il<br />
complesso <strong>di</strong> usanze e costumi determinato dall’altro-da-sè) <strong>di</strong>viene in tali<br />
uomini una sorta <strong>di</strong> precetto morale che cristallizza <strong>la</strong> loro anima: chi deraglia dai<br />
binari dell’abitu<strong>di</strong>ne (da intendere, in tal caso, al<strong>la</strong> stregua del<strong>la</strong> moda) viene<br />
bol<strong>la</strong>to come eretico. La moltitu<strong>di</strong>ne degli arrivati è un gruppo <strong>di</strong> anime indurite<br />
e sopite, i cui singoli componenti non possono accorgersi d’aver perso<br />
l’autenticità del<strong>la</strong> propria in<strong>di</strong>vidualità. Questa società è frutto <strong>di</strong> un ottimismo<br />
forzato, scaturente dall’angoscia accumu<strong>la</strong>ta, e dà corpo a quello che appare un<br />
<strong>mondo</strong> <strong>di</strong> cadaveri: «cadaveri che mangiano, bevono, dormono, par<strong>la</strong>no, ma non<br />
per ciò cessano <strong>di</strong> essere cadaveri» (Op 651).<br />
<strong>Il</strong> <strong>mondo</strong> michelstaedteriano del<strong>la</strong> rettorica è del tutto scentrato, non c’è<br />
salvezza al suo interno perché non è dato l’orizzonte soteriologico che soltanto <strong>la</strong><br />
13 Michelstaedter scrive <strong>di</strong> Tolstoj: «C’è un’evoluzione nell’arte del Tolstoj. Dall’arte esuberante dei<br />
primi romanzi all’arte sobria degli ultimi c’è quel caratteristico processo <strong>di</strong> purificazione che avviene<br />
negli uomini <strong>di</strong> pensiero. Quanto più il pensiero s’approfon<strong>di</strong>sce tanto meno l’arte <strong>di</strong>vaga in<br />
rappresentazioni inutili, ma incide forme c<strong>la</strong>ssiche in rapporto a un’intuizione più vasta e più perfetta», da<br />
“Tolstoj”, in Corriere Friu<strong>la</strong>no, n°218 <strong>di</strong> venerdì 18 settembre 1908.<br />
17
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
persuasione può offrire al ‘morto’ (intendo per morto, nel senso più autentico<br />
secondo Michelstaedter, colui che vive senza saper d’essere vivo, temendo <strong>la</strong><br />
morte e <strong>di</strong>scostandosi sommamente dall’essere che dovrebbe animargli <strong>la</strong><br />
coscienza). La salvezza offerta dal<strong>la</strong> persuasione è <strong>la</strong> salute del<strong>la</strong> coscienza e<br />
dell’anima, salute che interviene soltanto nell’istante che anticipa <strong>la</strong> morte: il<br />
momento fulmineo del<strong>la</strong> persuasione. «La vita – egli aggiunge – è un’infinita<br />
corre<strong>la</strong>tività <strong>di</strong> coscienze. <strong>Il</strong> senso del<strong>la</strong> vita (appare): ‘se mi è possibile qualche<br />
speranza c’è qualcosa per me’» (PeR 45).<br />
La corre<strong>la</strong>tività è il risultato proveniente da quel sentimento <strong>di</strong> sicurezza<br />
che l’uomo retorico tenta <strong>di</strong> ricreare nel<strong>la</strong> società: è, perciò, un falso sentimento<br />
interpersonale, più vicino al<strong>la</strong> politica che al<strong>la</strong> morale. La corre<strong>la</strong>zione delle<br />
coscienze è propria del<strong>la</strong> vita retorica, perché proveniente dal<strong>la</strong> filopsichia,<br />
l’amore incon<strong>di</strong>zionato per <strong>la</strong> vita, che Michelstaedter chiama anche ‘viltà’ (PeR<br />
50): «egli (il persuaso) deve sentir in sé l’insufficienza e rispettar in loro quello<br />
che essi stessi in sé non rispettano; perché dal suo amore attratti essi prendano <strong>la</strong><br />
persona ch’egli ama in loro: allora i ciechi vedranno» (PeR 84). <strong>Il</strong> sentimento<br />
del<strong>la</strong> filopsichia, pertanto, guida l’uomo verso ed attraverso l’esistenza retorica,<br />
illudendo l’in<strong>di</strong>viduo <strong>di</strong> vivere <strong>la</strong> miglior vita possibile perché vita propria. È<br />
vero, per l’Autore, proprio il contrario. L’assoluto valore, l’assoluto giu<strong>di</strong>zio,<br />
l’assoluta felicità e l’assoluta conoscenza sono proprie dell’essere persuaso, ma<br />
«bisogna essere morti per essere nelle con<strong>di</strong>zioni postu<strong>la</strong>te» (Op 715).<br />
18
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
La volontà, accompagnata dal<strong>la</strong> filopsichia – si è accennato poco sopra – è<br />
una volontà ingannevole, subdo<strong>la</strong>, perché generatrice <strong>di</strong> bisogni: avere volontà<br />
significa avere bisogno, ovvero ripetersi nel futuro a vuoto, senza colmarsi mai.<br />
Dunque <strong>la</strong> singole passioni sod<strong>di</strong>sfatte non danno mai un possesso: l’uomo che<br />
sfoga le passioni si determina in uno o nell’altro modo, entra in una ‘re<strong>la</strong>zione’<br />
verso una cosa, non l’’ha’, crede <strong>di</strong> affermare liberamente <strong>la</strong> sua in<strong>di</strong>v idualità e<br />
questa non è altro che complesso <strong>di</strong> necessità, crede <strong>la</strong> sua in<strong>di</strong>vidualità l’essere<br />
in<strong>di</strong>scutibile assoluto, ed essa non è che un complesso <strong>di</strong> re<strong>la</strong>zioni: cioè un nonente.<br />
La volontà d’un possesso vero è insieme volontà <strong>di</strong> libertà: l’eros p<strong>la</strong>tonico; e <strong>la</strong><br />
re<strong>la</strong>zione <strong>di</strong> possesso sarebbe philia <strong>di</strong> due anime nude nell’assoluto (idem velle<br />
atque idem nolle).<br />
Nel<strong>la</strong> vita ogni cosa ‘è’ in riguardo a un’altra.<br />
La vita è un complesso <strong>di</strong> ‘corre<strong>la</strong>zioni’ (koinonia kakon) (Op 819).<br />
Questo tipo <strong>di</strong> condotta è il non-essere dell’essere: l’uomo si crede <strong>di</strong> essere<br />
pienamente vivo, mentre è un ‘cadavere che vive’. Egli ricerca sempre e<br />
comunque il possesso delle cose: è trascinato da un impulso connaturato verso il<br />
controllo <strong>di</strong> sé e del tempo che lo investe. Ma, comunque, si accorge che non<br />
riesce ad attuare il suo programma <strong>di</strong> possesso: non possiede nul<strong>la</strong> in modo reale,<br />
ma solo in modo fittizio ed illusorio. Per <strong>di</strong> più, Michelstaedter sostiene che<br />
l’uomo retorico è posseduto dagli eventi e dalle cose come se anch’esso fosse un<br />
oggetto.<br />
In questa maniera nasce <strong>la</strong> corre<strong>la</strong>tività delle coscienze, cioè una sorta <strong>di</strong><br />
accordo subliminale fra uomini inautentici che tentano <strong>di</strong> creare attorno a sé un<br />
<strong>mondo</strong> sicuro ed or<strong>di</strong>nato. I sentimenti e le passioni sono i car<strong>di</strong>ni che danno le<br />
<strong>di</strong>rettive <strong>di</strong> questa società: non si ricerca mai il senso profondo delle cose e del<strong>la</strong><br />
19
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
vita, ma ci si abbandona ad atteggiamenti abituali che obliano tutto l’essere del<strong>la</strong><br />
realtà.<br />
La vita risultante è una sorta <strong>di</strong> fantasma del<strong>la</strong> vita persuasa. La rettorica<br />
prende possesso dell’esistenza, ed in<strong>di</strong>rizza l’uomo verso <strong>la</strong> ricerca <strong>di</strong> fini<br />
aleatori e banali: si può <strong>di</strong>re che l’uomo rettorico agisce perché deve agire<br />
all’interno del<strong>la</strong> società, ma da una prospettiva critica (senza dubbio più consona<br />
a colui che sia in<strong>di</strong>rizzato verso <strong>la</strong> persuasione) egli, in verità, patisce (ad<strong>di</strong>rittura<br />
si potrebbe affermare che è agito dalle cose, dagli altri e dagli eventi). <strong>Il</strong> retore si<br />
abbandona al<strong>la</strong> spersonalizzazione a causa del<strong>la</strong> sua inarrestabile inautenticità, e,<br />
pur <strong>di</strong> non sentirsi come dovrebbe (manchevole e vuoto), afferma <strong>di</strong> esser se<br />
stesso il centro del<strong>la</strong> propria vita, <strong>di</strong> avere controllo su <strong>di</strong> sé e sulle cose, <strong>di</strong> poter<br />
programmare <strong>la</strong> propria esistenza futura.<br />
È corretto asserire che <strong>la</strong> società sia un ambiente malsano, per<br />
Michelstaedter, secondo il quale «<strong>la</strong> società realizza una evoluzione, ma<br />
piuttosto nel senso <strong>di</strong> un progressivo aggravarsi <strong>di</strong> talune sue premesse<br />
negative» 14 . Tale comunità non è certo composta da persuasi, per i quali «egli<br />
prevede, come sappiamo, un’esperienza ininterrotta <strong>di</strong> autocreazione ed<br />
autoliberazione; si tratta, all’opposto, del<strong>la</strong> società nata dal<strong>la</strong> ‘paura del<strong>la</strong> morte’,<br />
scaturita cioè […] da una precisa ricerca <strong>di</strong> sicurezza, da un’esigenza, dunque,<br />
eminentemente rettorica» 15 .<br />
14 Marco Cerruti, Carlo Michelstaedter, Mursia, Mi<strong>la</strong>no 1967, p. 86.<br />
15 M. Cerutti, ivi, p. 86.<br />
20
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
<strong>Il</strong> retore vede esclusivamente se stesso e si inorgoglisce per essersi trovato nel<strong>la</strong><br />
società dei rettorici come lui, che faranno lo stesso. Come già citato, «l’esser vivi<br />
si fa un’abitu<strong>di</strong>ne» (PeR 57). <strong>Il</strong> retore è quello che si permette <strong>di</strong> <strong>di</strong>re ‘io sono’,<br />
perché sente profondamente <strong>di</strong> non essere nul<strong>la</strong>, <strong>di</strong> essere perennemente<br />
insod<strong>di</strong>sfatto, e per tentare <strong>di</strong> risolvere <strong>la</strong> sua ignavia, <strong>la</strong> sua manchevolezza, <strong>la</strong><br />
sua in<strong>di</strong>gesta fame continuata <strong>di</strong> necessità si abbandona ad un’esistenza<br />
programmata sul<strong>la</strong> ‘scelta dei fini’, su un teleologismo senza senso.<br />
Dice a tal proposito Michelstaedter:<br />
Perciò le cose non gli sono in<strong>di</strong>fferenti ma giu<strong>di</strong>cabili riguardo a un fine. Questo<br />
fine che è nel<strong>la</strong> sua coscienza gli è in<strong>di</strong>scutibile, fermo, luminoso fra le cose<br />
in<strong>di</strong>fferenti; quello che egli ogni volta fa, non è fatto a caso, ma certo e<br />
ragionevolmente subor<strong>di</strong>nato a fine. Come egli <strong>di</strong>ce ‘io sono’, così <strong>di</strong>ce ‘io sono<br />
quello che fo perché lo fo; non agisco a caso ma con piena coscienza e<br />
persuasione’. – È così che ciò che vive si persuade esser vita <strong>la</strong> qualunque vita che<br />
vive (PeR 52).<br />
<strong>Il</strong> <strong>di</strong>o supremo del<strong>la</strong> vita del<strong>la</strong> rettorica è – come già detto – <strong>la</strong> filopsichia, che fa<br />
smarrire l’uomo, allontanandolo dal suo essere assoluto, angosciandolo <strong>di</strong> non<br />
poter ottenere certezze e stabilità dai propri futili impegni sociali. Michelstaedter<br />
descrive l’uomo sociale così come descrive l’uomo rettorico: essi, in fin dei conti<br />
sono <strong>la</strong> medesima figura, possiedono i medesimi connotati. <strong>Il</strong> rettorico è uomo<br />
del<strong>la</strong> società, perché non saprebbe stare altrimenti (mancando <strong>di</strong> personalità<br />
in<strong>di</strong>pendente ed autentica); l’uomo sociale è rettorico proprio perché vive in<br />
quel<strong>la</strong> società; egli sente comunque <strong>di</strong> esser morto, ma continua a vivere perché<br />
teme profondamente <strong>la</strong> morte, e vuole a tutti i costi dare un senso, qualunque<br />
21
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
questo senso sia, al<strong>la</strong> propria anonima ed inutile esistenza. <strong>Il</strong> suo tempo è il<br />
futuro, mentre il tempo del<strong>la</strong> persuasione (e dell’arte) è il presente, il momento.<br />
Primo fra gli atteggiamenti dell’uomo sociale è l’attività (energia), che l’Autore<br />
vorrebbe sostituita dall’inerzia (argia). Le attività rettoriche si adoperano tutte,<br />
con taglio <strong>di</strong> presunzione e spocchia, ad offrire il proprio contributo «al<strong>la</strong> grande<br />
opera <strong>di</strong> civiltà in pro dell’umanità» 16 . L’uomo del<strong>la</strong> retorica si mette in moto per<br />
mostrare le proprie capacità ai suoi simili e occupando il suo tempo tenta <strong>di</strong><br />
scansare il monito inconscio del<strong>la</strong> persuasione. <strong>Il</strong> retore è impotente, vuole a tutti<br />
i costi <strong>la</strong> perpetuazione o <strong>la</strong> reiterazione del presente nel futuro; è debole, e ne<br />
<strong>di</strong>viene consapevole, ma il timore dell’angoscia dello smarrimento e del<strong>la</strong> morte<br />
lo inducono a volere vivere comunque, accettando qualsiasi compromesso: è<br />
l’adattamento (ko<strong>la</strong>keia).<br />
16 M. Cerruti, ivi, p. 87.<br />
22
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
III<br />
L’ADATTAMENTO SOCIALE SCIENTIFICO E RELIGIOSO<br />
Si potrebbe iniziare da un aforisma <strong>di</strong> Otto Weininger, in accordo con <strong>la</strong><br />
tematica michelstaedteriana: «‘Storia’ e ‘società’: le persone riunite in una stanza<br />
formano sempre una comunità che si oppone ai nuovi venuti» 17 .<br />
Michelstaedter sostiene che l’adattamento al<strong>la</strong> società è causato dal<strong>la</strong><br />
debolezza: essa induce tutti i miserabili <strong>di</strong> coscienza ad aggregarsi nel<strong>la</strong><br />
macchina che ‘istupi<strong>di</strong>sce’, nel<strong>la</strong> società. <strong>Il</strong> retorico teme <strong>la</strong> morte perché teme <strong>di</strong><br />
dover perdere quello che possiede nel<strong>la</strong> sua vita inautentica, ma questo è del tutto<br />
erroneo, poiché il retorico nel<strong>la</strong> sua esistenza non ha mai posseduto alcunché, per<br />
via dell’incapacità primaria <strong>di</strong> possedere se stesso. <strong>Il</strong> retorico è senza scampo:<br />
non possiede nul<strong>la</strong>, nemmeno <strong>la</strong> sua identità. E allora che cosa potrebbe temere<br />
se nul<strong>la</strong> possiede? <strong>Il</strong> retorico è illuso fino al midollo, non si accorge <strong>di</strong> nul<strong>la</strong><br />
perché è così che <strong>la</strong> sua volontà si muove: è ignorante (‘tutti hanno ragione,<br />
nessuno ha <strong>la</strong> ragione’).<br />
Dice Michelstaedter:<br />
Non portate <strong>la</strong> croce ma siete tutti crocefissi al legno del<strong>la</strong> vostra sufficienza, che<br />
v’è data, che più v’insistete e più sanguinate: vi fa comodo <strong>di</strong>re che portate <strong>la</strong> croce<br />
come un sacro dovere, mentre pesate col peso inerte delle vostre necessità. –<br />
Abbiate il coraggio <strong>di</strong> non ammetterle quelle necessità, <strong>di</strong> sollevarvi per voi<br />
stessi…<br />
17 Otto Weininger, Delle cose ultime, E<strong>di</strong>zioni Stu<strong>di</strong>o Tesi, Pordenone 1992, p. 104.<br />
23
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
Ma su quelle è misurato il vostro possibile e l’impossibile, il sopportabile e<br />
l’insopportabile dei doveri da compiere per guadagnarvi in pace <strong>la</strong> vita; quando<br />
v’adattate ai mo<strong>di</strong> del corpo, del<strong>la</strong> famiglia, del<strong>la</strong> città, del<strong>la</strong> religione, <strong>di</strong>te: ‘faccio<br />
i miei doveri d’uomo, <strong>di</strong> figlio, <strong>di</strong> citta<strong>di</strong>no, <strong>di</strong> cristiano’ e a questi doveri<br />
commisurate i <strong>di</strong>ritti. Ma il conto non torna (PeR 74).<br />
La filopsichia è l’amore per <strong>la</strong> vita qualunque, che Michelstaedter chiama anche<br />
<strong>di</strong>o del piacere, ingannatore principe dell’uomo a cui fa credere <strong>di</strong> essere in<br />
grado <strong>di</strong> poter ottenere qualunque cosa desideri (conseguimento del piacere,<br />
sod<strong>di</strong>sfacimento completo dei propri bisogni, perseguimento e realizzazione <strong>di</strong><br />
un ideale ipotetico).<br />
L’uomo è qui posto fuori <strong>di</strong> sé: si adatta ed è violento. «La retorica vale in<br />
quanto azione, capacità determinata <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>ficare lo stato preesistente<br />
dell’u<strong>di</strong>torio. Ciò che conta è l’effettiva forza del <strong>di</strong>scorso» 18 , e l’adu<strong>la</strong>zione <strong>di</strong> se<br />
stessi si sfoga nel<strong>la</strong> supremazia sugli altri: si potrebbe <strong>di</strong>re che oggi questa<br />
situazione si chiama arrivismo. L’importante è adattarsi al gioco-giogo del<strong>la</strong><br />
società, e sapersi <strong>di</strong>stricare nel<strong>la</strong> selva delle corre<strong>la</strong>zioni per poter emergere: <strong>la</strong><br />
retorica pretende forza ed efficacia, è violenta e chi non si adatta ai suoi<br />
parametri è tagliato fuori. Michelstaedter è <strong>di</strong> certo escluso dalle false<br />
riven<strong>di</strong>cazioni <strong>di</strong> potere propinate dal<strong>la</strong> retorica.<br />
Si può affermare tale concetto proprio in virtù del<strong>la</strong> inorganicità professata<br />
dall’Autore. Egli reputa che violenza ed organicità <strong>di</strong> fondo siano accordate da<br />
un piano d’azione ben preciso, che ha il compito <strong>di</strong> legare le singole entità del<strong>la</strong><br />
comunità. Michelstaedter, nel suo <strong>di</strong>scorrere piuttosto a-sistematico, evita<br />
18 Giorgio Brianese, “Michelstaedter e <strong>la</strong> Retorica”, in Dialoghi intorno a Michelstaedter, Biblioteca<br />
Statale Isontina, Gorizia 1988, p. 129.<br />
24
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
violenza e forzature, specialmente nel linguaggio, e tenta <strong>di</strong> esprimere in parole<br />
tutta l’evasività del<strong>la</strong> persuasione 19 .<br />
L’istinto violento che regge tutto l’apparato sociale è <strong>la</strong> sopravvivenza, non<br />
dunque <strong>la</strong> realizzazione dell’uomo: l’illusione dell’affermazione sociale in una<br />
vita timorata ed insensata.<br />
E rassicurati rifanno l’oscurità […] Egli (l’uomo retorico) sente d’esser già morto<br />
da tempo e pur vive e teme <strong>di</strong> morire. Di fronte al tempo che viene lento<br />
inesorabile, egli si sente impotente come un morto a curar <strong>la</strong> sua vita, e soffre ogni<br />
attimo il dolore del<strong>la</strong> morte. Questo dolore accomuna tutte le cose che vivono e<br />
non hanno in sé <strong>la</strong> vita, che vivono senza persuasione, che come vivono temono <strong>la</strong><br />
morte (PeR 58-59).<br />
L’uomo del<strong>la</strong> retorica accetta passivamente il dolore che il sentimento del<strong>la</strong> certa<br />
ed inequivocabile morte gli provoca, proprio per il fatto che egli non possiede ma<br />
è posseduto. L’uomo persuaso, viceversa, è libero dall’illusione dei fini e dal<br />
timore reverenziale del<strong>la</strong> morte, perché incontrando <strong>la</strong> vita egli si accorge che<br />
deve senza pretese morire per sublimare <strong>la</strong> sua essenza. La morte dell’uomo<br />
persuaso è ‘<strong>di</strong>sarmata’, perché affrontata con coraggio si trasforma nel<br />
trampolino <strong>di</strong> <strong>la</strong>ncio verso l’essere assoluto dell’uomo: il ritorno tanto ane<strong>la</strong>to<br />
all’Unità del<strong>la</strong> coscienza.<br />
Tutti gli aspetti del<strong>la</strong> società retorica sono deplorevoli per Michelstaedter,<br />
comprese <strong>la</strong> scienza e <strong>la</strong> religione. Quest’ultima è per Lui un'altra modalità <strong>di</strong><br />
fuga dal<strong>la</strong> natura assoluta ed unitaria dell’uomo, una elegante e apparentemente<br />
19 Per l’argomento si veda <strong>la</strong> trattazione <strong>di</strong> G. Brianese: «<strong>Il</strong> pazzo (colui che è considerato tale dal<strong>la</strong><br />
società) par<strong>la</strong> una lingua che non ha un riconoscimento intersoggettivo, in quanto tra<strong>di</strong>sce gli stereotipi ed<br />
i modelli precostituiti […] <strong>Il</strong> persuaso michelstaedteriano è l’in<strong>di</strong>viduo. <strong>Il</strong> suo linguaggio par<strong>la</strong>, non<br />
ripete», G. Brianese. op. cit., p. 122 sg.<br />
25
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
rispettabile maniera <strong>di</strong> affidarsi ad altro per non dover patire il tormento del<br />
possesso <strong>di</strong> sé. Prendendo a prestito alcune parole da un altro filosofo suicida<br />
contemporaneo dell’Autore, si può <strong>di</strong>re che «non pochi uomini credono <strong>di</strong><br />
sbarazzarsi del Dio unico, votandosi a parecchi altri» 20 . La religione rientra così<br />
fra le <strong>di</strong>mensioni più problematiche ed illusorie, perché anch’essa nega<br />
l’autenticità del singolo <strong>di</strong> fronte al<strong>la</strong> morte, una morte sua e soltanto sua (a<br />
questo proposito si può ricollegare il suo pensiero al<strong>la</strong> filosofia <strong>di</strong> Kierkegaard, il<br />
quale ravvisava nel<strong>la</strong> in<strong>di</strong>vidualità singo<strong>la</strong> il nucleo dell’esistenza e del<strong>la</strong> vita,<br />
in<strong>di</strong>rizzate all’atto <strong>di</strong> purificazione dell’angoscia 21 e del<strong>la</strong> fede, sebbene si possa<br />
scorgere quanto Michelstaedter si <strong>di</strong>scosti qui dall’apertura al<strong>la</strong> fede).<br />
Affidandosi al credo religioso, i retori perdono, così, <strong>la</strong> possibilità <strong>di</strong> rendere<br />
propria ed irripetibile persino <strong>la</strong> loro stessa morte: si abbandonano, senza mai<br />
potersi ritrovare.<br />
Anche <strong>la</strong> scienza e tutto l’apparato scientifico che <strong>la</strong> correda sono<br />
estremamente <strong>di</strong>ssuasivi nei confronti del<strong>la</strong> ricerca del sé. <strong>Il</strong> <strong>mondo</strong> del<strong>la</strong> scienza<br />
è passibile anch’esso dell’accusa del<strong>la</strong> continuazione filopsichica: <strong>la</strong> scienza<br />
obiettiva e comune ha <strong>la</strong> vanagloriosa propensione a garantire l’illusione del<br />
raggiungimento del<strong>la</strong> verità oggettiva, ed è uno dei mezzi con i quali l’uomo<br />
intende alleviare <strong>la</strong> con<strong>di</strong>zione angosciosa del proprio vivere, procurandosi, con<br />
<strong>la</strong> minor fatica possibile, ciò <strong>di</strong> cui crede <strong>di</strong> necessitare per <strong>la</strong> continuazione<br />
20 Otto Weininger, Delle cose ultime, cit. p. 105.<br />
21 Afferma Kierkegaard: «L’angoscia (Angst) era il momento del<strong>la</strong> vita in<strong>di</strong>viduale. Una categoria <strong>di</strong> cui<br />
si fa continuamente uso nel<strong>la</strong> filosofia moderna , tanto nelle ricerche logiche quanto in quelle storicofilosofiche,<br />
è <strong>la</strong> categoria del ‘passaggio’ […] Questa manifestazione (<strong>la</strong> trasparenza unita all’intuibilità)<br />
rivolta all’interno dovrebbe costituire l’essenza del sistema» (Søren A. Kierkegaard, <strong>Il</strong> concetto<br />
dell’angoscia, cit. p. 63).<br />
26
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
dell’esistenza. «E però procurare all’uomo ciò ch’egli vuole significa mantenerlo<br />
nel<strong>la</strong> sua illusione, imprigionarlo sempre <strong>di</strong> più e sempre <strong>di</strong> nuovo al<strong>la</strong> catena<br />
del<strong>la</strong> <strong>di</strong>pendenza» 22 . Michelstaedter non accetta quest’atteggiamento <strong>di</strong>struttivo<br />
dell’unità e dell’unicità irripetibile del<strong>la</strong> persona: <strong>la</strong> <strong>di</strong>cotomia antagonista fra<br />
soggettività ed oggettività è manifestamente foriera <strong>di</strong> quel<strong>la</strong> dualità che <strong>di</strong><strong>la</strong>nia<br />
senza scampo l’uomo posseduto dal<strong>la</strong> filopsichia.<br />
«L’uomo agisca in modo che in ogni singolo istante sia presente l’‘intera’<br />
sua in<strong>di</strong>vidualità» 23 . La scienza è strutturata secondo il tempo del<strong>la</strong> progettualità,<br />
secondo un presente funzionalizzato al futuro: mentre s’è detto che per<br />
Michelstaedter il tempo unico del<strong>la</strong> vita persuasa è solo il presente momentaneo:<br />
Chi vuol aver un attimo solo sua <strong>la</strong> sua vita, esser un attimo solo persuaso <strong>di</strong> ciò<br />
che fa, deve impossessarsi del presente; vedere ogni presente come l’ultimo, come<br />
se fosse certa dopo <strong>la</strong> morte: e nell’oscurità crearsi da sé <strong>la</strong> vita (PeR 69).<br />
<strong>Il</strong> <strong>mondo</strong> scientifico <strong>di</strong>strugge anche <strong>la</strong> concezione letteraria ed artistica del<br />
linguaggio: le formule, i simboli e <strong>la</strong> simbologia in generale, non fanno altro che<br />
affinare <strong>la</strong> <strong>la</strong>ma del coltello dell’inautenticità del<strong>la</strong> retorica. Lo scienziato è uno<br />
specialista, un esperto che può saper tutto del suo ambito <strong>di</strong> ricerca, ma resta un<br />
illuso: illuso del fatto che il <strong>mondo</strong> e <strong>la</strong> sua esistenza si risolvano in quello che fa,<br />
senza accorgersi che <strong>la</strong> sua vita è inghiottita dal<strong>la</strong> retorica, dal<strong>la</strong> falsità, che non<br />
ha l’energia per prendere possesso <strong>di</strong> sé condannandosi a farsi possedere.<br />
22 G. Brianese, L’Arco e il destino, cit. p. 94.<br />
23 Otto Weininger, Delle cose ultime, cit. p. 75.<br />
27
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
Nel <strong>mondo</strong> contemporaneo dell’occidente, è indubbio che ognuno <strong>di</strong>venti<br />
una sorta <strong>di</strong> tecnico specializzato. La tendenza del<strong>la</strong> civiltà scientifico-<br />
tecnologica, che si sviluppa oramai da alcuni secoli e si concretizza sempre più,<br />
non ha fatto altro che condurre a questa maturazione: <strong>la</strong> società occidentale è<br />
tutta strutturata sul<strong>la</strong> logica e <strong>la</strong> tecnologia, ogni forma <strong>di</strong> sapere è razionalizzato.<br />
Questa forma <strong>di</strong> conoscenza contribuisce in maniera deleteria e vigorosa al<strong>la</strong><br />
spersonalizzazione, all’oggettività, all’offuscamento delle pulsioni in<strong>di</strong>viduali,<br />
incatenando l’uomo agli schemi predefiniti dell’attività produttiva.<br />
Questo aspetto del<strong>la</strong> nostra cultura occidentale ha un duplice significato: si<br />
è prigionieri inevitabilmente del meccanismo delle specializzazioni dei vari<br />
settori d’impiego, e si consegue (altrettanto inevitabilmente) un ‘titolo’ da<br />
specialista, ispiratore <strong>di</strong> gesti e comportamenti. <strong>Il</strong> <strong>mondo</strong> del progresso e del<strong>la</strong><br />
tecnica (che Michelstaedter avrebbe voluto veder arrestarsi senza sconto) è una<br />
comunità in cui si appianano le <strong>di</strong>fferenze all’interno delle categorie, ma si<br />
acuiscono fra le varie competenze. Si può, a questo punto, <strong>di</strong>re che l’uomo<br />
contemporaneo <strong>di</strong>viene sempre più identico al<strong>la</strong> propria funzione (a sua volta<br />
sempre più limitata/delimitata), e sa sempre meno quello che sta facendo 24 ; «altri,<br />
forse, sanno: lui agisce, obbe<strong>di</strong>sce agli or<strong>di</strong>ni, esegue e via <strong>di</strong>cendo. È l’uomo<br />
pronto a <strong>di</strong>ventare strumento irresponsabile del potere costituito» 25 . Lo scopo che<br />
<strong>la</strong> comunità si prefigge è l’educazione <strong>di</strong> funzionari or<strong>di</strong>nati ed inquadrati,<br />
24 Michelstaedter scrive a tal proposito: «Ma qui troviamo questi in<strong>di</strong>vidui ridotti a meccanismi […] La<br />
loro degenerazione è detta educazione civile, <strong>la</strong> loro fame è attività <strong>di</strong> progresso, <strong>la</strong> loro paura è <strong>la</strong> morale,<br />
<strong>la</strong> loro violenza, il loro o<strong>di</strong>o egoistico […] È il regno del<strong>la</strong> rettorica» (PeR 144).<br />
25 G. Brianese, L’arco e il destino, cit. p. 104.<br />
28
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
uomini che compiono il proprio dovere senza domandarsi il perché <strong>di</strong> quel<br />
dovere e delle conseguenti azioni. È un <strong>mondo</strong> palesemente rettorico, secondo il<br />
pensiero dell’Autore. L’uomo rettorico è il virtuoso, lo specialista, una specie <strong>di</strong><br />
«uomo-macchina nel quale l’abilità meccanica ha soppiantato <strong>la</strong> sensibilità, <strong>la</strong><br />
ripetizione (ha soppiantato) l’originalità: l’uomo ideale del <strong>mondo</strong> tecnico-<br />
scientifico contemporaneo» 26 .<br />
<strong>Il</strong> <strong>mondo</strong> moderno è il <strong>mondo</strong> del<strong>la</strong> violenza e dell’efficacia sulle cose:<br />
l’uomo violenta le cose e le consuma, tanto che uno dei problemi o<strong>di</strong>erni è<br />
l’esaurimento dei materiali violentabili. Ogni soluzione prospettata da una buona<br />
intenzione per <strong>la</strong> salvaguar<strong>di</strong>a del <strong>mondo</strong> (in senso <strong>la</strong>to) è comunque sempre una<br />
violenza manifestata sotto altra forma, così che l’era del<strong>la</strong> scienza e del<strong>la</strong> tecnica<br />
ha il definitivo sopravvento, e l’uomo s’impegna al miglioramento del<strong>la</strong> propria<br />
vita proprio incentivando il potere che <strong>la</strong> <strong>di</strong>strugge.<br />
<strong>Il</strong> più grande male dell’uomo tecnologico è che «usa <strong>la</strong> scienza senza<br />
coscienza» 27 , e questo non può che trascinare l’umanità verso <strong>la</strong> più profonda<br />
retorica michelstaedteriana. Ciò che il <strong>mondo</strong> del<strong>la</strong> tecnica-rettorica chiede<br />
all’uomo è il compimento del proprio dovere/or<strong>di</strong>ne 28 nel miglior modo<br />
possibile, senza spazio per una riflessione/ribellione all’organizzazione globale<br />
del<strong>la</strong> <strong>di</strong>stribuzione dei suddetti. <strong>Il</strong> <strong>mondo</strong> contemporaneo è proprio <strong>di</strong> una<br />
sud<strong>di</strong>visione settoriale sempre più esasperata, e le conoscenze del singolo si<br />
26 G. Brianese, ivi, p. 104.<br />
27 L. Powels J. Bergier, <strong>Il</strong> mattino dei maghi, Mondatori, Mi<strong>la</strong>no 1997, p. 267.<br />
28 <strong>Il</strong> termine dovere, in questo caso, è usato sotto il profilo giuri<strong>di</strong>co e non secondo quello morale. È<br />
questa l’accusa <strong>di</strong> Michelstaedter: <strong>la</strong> morale (in<strong>di</strong>viduale ed assoluta) è soppiantata dal<strong>la</strong> giurisprudenza<br />
(logica e sistematica). Si può concludere <strong>di</strong>cendo che il dovere si identifica con l’esecuzione del compito<br />
specifico all’interno dell’organismo sociale complessivo.<br />
29
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
restringono all’appren<strong>di</strong>mento totale degli elementi del proprio settore: più<br />
questo sarà limitato, meno l’uomo avrà da conoscere ed imparare, e sempre<br />
meglio potrà affinare <strong>la</strong> ripetizione dei propri gesti. Tale condotta ripetitiva<br />
conferisce all’illuso retore maggior sicurezza, poiché il singolo si sente più<br />
tranquillo con meno competenze, ma meglio sperimentate. Solo che,<br />
Michelstaedter lo sa bene, lo scotto da pagare è «<strong>la</strong> <strong>di</strong>pendenza, l’inautenticità, <strong>la</strong><br />
nullità infine del<strong>la</strong> propria esistenza attuale» 29 .<br />
Ciò che viene <strong>di</strong> conseguenza da pensare del <strong>mondo</strong> (inteso come terra<br />
fisica) è che esso sia un insieme <strong>di</strong> elementi ed entità <strong>di</strong>sponibili al servizio del<br />
progresso, violentabili in nome dell’operatività del<strong>la</strong> scienza. <strong>Il</strong> risultato è<br />
l’inevitabile insorgere <strong>di</strong> frotte <strong>di</strong> specialisti:<br />
Virtuosità è identico con specialità : io ripeto, esagero, svolgo mostruosamente un<br />
dato atto, una tal serie d’atti – ed ho già una persona cospicua. Ho educato in me<br />
una macchina eccezionale. E <strong>la</strong> fatica bruta oscura del<strong>la</strong> minima vita ha il nome e il<br />
<strong>di</strong>ritto d’esistere del postu<strong>la</strong>to del<strong>la</strong> massima vita (PeR 130).<br />
E’ legittimo ritenere che, secondo Michelstaedter, in un futuro poco lontano e<br />
preve<strong>di</strong>bile, già innestatosi nel presente, gli uomini si trasformeranno in automi,<br />
saranno robotizzati ed potranno re<strong>la</strong>zionare solo in maniera fredda, meccanica,<br />
senza sentimento né pathos; quando, poi, ogni azione avrà raggiunto <strong>la</strong> massima<br />
efficienza, «<strong>la</strong> lingua <strong>di</strong> questa volontà <strong>di</strong> vivere, quasi inorganica, che è l’uomo<br />
29 G. Brianese, L’arco e il destino, cit., p. 105.<br />
30
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
sociale, attingerà infine il silenzio» 30 . Questa è <strong>la</strong> violenza generale e sociale<br />
del<strong>la</strong> rettorica.<br />
Una sua forma <strong>di</strong> attuazione efficiente è quel<strong>la</strong> operata ai danni del<br />
linguaggio, veicolo <strong>di</strong> espressione dello spirito. Esso è <strong>di</strong>ventato, secondo<br />
Michelstaedter, una combinazione <strong>di</strong> segni che rappresentano <strong>la</strong> violenza<br />
scientifica; esso non ha più potenzialità persuasiva, e finisce per <strong>la</strong>nguire nel<strong>la</strong><br />
melma del<strong>la</strong> retorica. <strong>Il</strong> linguaggio si è trasformato in simbologia, ed il simbolo<br />
ha capacità del tutto limitate e limitanti. <strong>Il</strong> simbolo imbriglia <strong>la</strong> natura essenziale<br />
dello spirito e l’essere delle cose stesse. <strong>Il</strong> linguaggio fisico-matematico, ad<br />
esempio, è esclusivamente simbolico, e manifesta freddamente <strong>la</strong> retorica del<strong>la</strong><br />
formu<strong>la</strong>zione scientifica, perché non concede spazio alcuno all’in<strong>di</strong>vidualità<br />
dello scienziato.<br />
In realtà, pare che lo scienziato sia coinvolto dal<strong>la</strong> scienza stessa: egli<br />
perde tutto il suo bagaglio <strong>di</strong> autenticità in nome del<strong>la</strong> verità oggettiva ed<br />
oggettivata che lo richiama. Questo è il punto criticato da Michelstaedter: non c’è<br />
personalità nell’essere specialisti, perché si è giunti ad una con<strong>di</strong>zione per cui <strong>la</strong><br />
scienza è un oggetto a sé stante, in<strong>di</strong>pendente, autonomo. La derivata modalità <strong>di</strong><br />
uso del linguaggio è violenta proprio per via del<strong>la</strong> sua inautenticità <strong>di</strong> fondo. La<br />
terminologia tecnico-scientifica viene a rappresentare <strong>la</strong> tendenza al<strong>la</strong> ricerca<br />
del<strong>la</strong> oggettività assoluta, quel<strong>la</strong> realtà incontestabile che si vuole delineare come<br />
verità. Quest’atteggiamento ermeneutico nel<strong>la</strong> considerazione del ‘vero’ è<br />
30 Marco Cerruti, Carlo Michelstaedter, cit. p. 94.<br />
31
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
inaccettabile per Michelstaedter, che crede fermamente nel<strong>la</strong> verità soggettiva<br />
del<strong>la</strong> propria irripetibile ed ineguagliabile esistenza.<br />
Lo scopo reale del<strong>la</strong> ricerca è l’unità ontologica che va ricreata<br />
nell’in<strong>di</strong>viduo, non <strong>la</strong> verità oggettiva che sta fuori dall’uomo stesso. L’Autore<br />
immagina che uno scienziato, che sentisse le obbiezioni mossegli e rivolte al suo<br />
metodo <strong>di</strong> essere/agire, possa sostenere che <strong>la</strong> scienza riporta il sapere filosofico<br />
sul<strong>la</strong> strada del<strong>la</strong> positività e non si perde in inutili e vaneggianti me<strong>di</strong>tazioni<br />
metafisiche. Michelstaedter vuole mostrare che lo scienziato nutre l’idea che lo<br />
stretto contatto con <strong>la</strong> realtà possa condurre allo sve<strong>la</strong>mento progressivo del<strong>la</strong><br />
verità (conoscenza assoluta). A tal punto, l’Autore ha pronta <strong>la</strong> replica <strong>la</strong>pidaria<br />
«imme<strong>di</strong>ata e decisiva: basterebbe chiedere che <strong>di</strong>fferenza ci sia fra realtà e<br />
verità, per <strong>la</strong> quale, pur essendo in contatto con <strong>la</strong> realtà, si debba ancora fare via<br />
per giungere al<strong>la</strong> verità» 31 . La ricerca scientifica è dannosa: essa è portatrice <strong>di</strong><br />
progresso tutto esteriorizzato, che non fa altro che annichilire l’uomo nel<strong>la</strong><br />
convenzione del<strong>la</strong> retorica; «tutti i progressi del<strong>la</strong> società sono regressi<br />
dell’in<strong>di</strong>viduo» (PeR 156), afferma Michelstaedter: più l’umanità si affida alle<br />
mani del progresso, più nell’uomo muore <strong>la</strong> sua peculiare essenza.<br />
<strong>Il</strong> massimo del<strong>la</strong> specializzazione collima inevitabilmente con il massimo<br />
dell’efficacia pratica e col minimo del<strong>la</strong> conoscenza, tanto che al<strong>la</strong> fine si giunge<br />
a non capir più nul<strong>la</strong> nemmeno del proprio settore, si giunge al gesto, al silenzio<br />
dell’esecuzione pura e semplice. L’autenticità dell’esistenza viene sempre più a<br />
mancare, e soltanto <strong>la</strong> ra<strong>di</strong>calità del silenzio può far in modo che l’uomo ritrovi <strong>la</strong><br />
31 M. Cerruti, ivi p. 83.<br />
32
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
sua strada. <strong>Il</strong> silenzio persuaso è ra<strong>di</strong>calmente <strong>di</strong>fferente dal silenzio gestico<strong>la</strong>nte<br />
del<strong>la</strong> rettorica, che è «<strong>la</strong> falsa apparenza dell’autentico silenzio, miracoloso, del<strong>la</strong><br />
persuasione» 32 .<br />
La scienza gira indefinitivamente nel cerchio del<strong>la</strong> causalità e del<br />
bisogno, senza ottenere niente <strong>di</strong> positivo; <strong>la</strong> concatenazione delle cause, su cui è<br />
imperniata tutta <strong>la</strong> struttura portante del<strong>la</strong> ricerca scientifica, offre solo un sapere<br />
inesaustivo e spersonalizzato, «non già il possesso pieno <strong>di</strong> se stessi nel quale<br />
Michelstaedter ravvisa l’unica possibile autenticità per l’uomo che non voglia<br />
restare prigioniero dello specialismo. Perché lo specialista è il retore del <strong>mondo</strong><br />
contemporaneo» 33 . La scienza sopprime <strong>la</strong> vitalità del linguaggio, e il <strong>mondo</strong><br />
tecnico-rettorico è il <strong>mondo</strong> dei servi.<br />
Prosegue Michelstaedter:<br />
Quello non c’è (dasein) poiché tutto ciò che è qui, c’è per causa <strong>di</strong> qualche cosa ed ha<br />
bisogno <strong>di</strong> qualche altra (l’esistenza delle cose nel tempo è corre<strong>la</strong>tiva). C’è ciò che non è<br />
– e che è non c’è […] Giusto è chi ha in sé <strong>la</strong> ragione poiché assoluto (Op 740).<br />
Par<strong>la</strong>ndo <strong>di</strong> da-sein, viene spontaneo rifarsi per un momento al<strong>la</strong> filosofia <strong>di</strong><br />
Heidegger 34 , in cui si nota come il silenzio sia realmente ed effettivamente una<br />
<strong>di</strong>mensione priva <strong>di</strong> qualunque rumore, dove risuonano solo le parole perfette<br />
del<strong>la</strong> poesia accompagnate dai tratti dell’arte figurativa. Questo silenzio sembra,<br />
32<br />
G. Brianese, L’arco e il destino, cit., p. 120.<br />
33<br />
Ivi, p. 110.<br />
34<br />
«Al<strong>la</strong> chiamata del<strong>la</strong> coscienza corrisponde un sentire possibile […] Inoltre non dobbiamo <strong>di</strong>menticare<br />
che il <strong>di</strong>scorso, e quin<strong>di</strong> anche <strong>la</strong> chiamata, non implicano necessariamente <strong>la</strong> comunicazione verbale.<br />
Quando <strong>la</strong> l’interpretazione quoti<strong>di</strong>ana par<strong>la</strong> <strong>di</strong> una ‘voce’ del<strong>la</strong> coscienza non intende alludere a una<br />
comunicazione verbale che, <strong>di</strong> fatti, non ha luogo; qui ‘voce’ significa ‘dare a comp rendere’» (M.<br />
Heidegger, Essere e tempo, Longanesi, Mi<strong>la</strong>no 1970, sez. II, pp. 54-55).<br />
33
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
dunque, <strong>la</strong> soglia sul<strong>la</strong> quale l’uomo possa ‘risvegliarsi’ e riprendere il cammino<br />
verso <strong>la</strong> propria autenticità, riaffermando <strong>la</strong> sua coscienza abbandonata nel<strong>la</strong><br />
retorica:<br />
<strong>Il</strong> senso delle cose, il sapore del <strong>mondo</strong> è solo pel continuare, esser nati non è che<br />
voler continuare: gli uomini vivono per vivere: per non morire. La loro persuasione<br />
è <strong>la</strong> paura del<strong>la</strong> morte, esser nati non è che temere <strong>la</strong> morte. Così che se si fa loro<br />
certa <strong>la</strong> morte in un certo futuro – si manifestano già morti nel presente. Tutto ciò<br />
che fanno e che <strong>di</strong>cono con ferma persuasione, per un certo fine, con evidente<br />
ragione non è che paura del<strong>la</strong> morte – ‘infatti temere <strong>la</strong> morte altro non è che<br />
credere d’esser saggio senza esserlo’ (PeR 69 35 ).<br />
35 Si veda anche <strong>la</strong> citazione <strong>di</strong> Michelstaedter in PeR 198 tratta dal<strong>la</strong> Apologia <strong>di</strong> Socrate.<br />
34
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
IV<br />
SU GIUSTIZIA E DOVERE<br />
La vita persuasa è descritta da Michelstaedter come un’iperbole asintotica<br />
alle linee car<strong>tesi</strong>ane del<strong>la</strong> giustizia. La giustizia è forse l’elemento car<strong>di</strong>ne per <strong>la</strong><br />
vera realizzazione del<strong>la</strong> vita autentica, poiché essa appare come una sorta <strong>di</strong><br />
entità sovrastante ogni altro tipo <strong>di</strong> realtà, raggiungibile soltanto sul<strong>la</strong> via del<strong>la</strong><br />
persuasione. È per tale motivo che Michelstaedter asserisce che nel<strong>la</strong> vita vissuta,<br />
<strong>di</strong> qualunque persona si tratti, <strong>la</strong> giustizia non può essere né trovata né tanto<br />
meno vissuta. La giustizia è il dovere del<strong>la</strong> persuasione, lo stimolo<br />
all’eliminazione del<strong>la</strong> violenza operata dal<strong>la</strong> rettorica:<br />
“Umano sei, non giusto” <strong>di</strong>ce Parini. Quando l’uomo giu<strong>di</strong>ca cosa che non abbia<br />
per lui alcun valor effettivo, giu<strong>di</strong>ca secondo <strong>la</strong> propria misura e accorda giusto<br />
l’effetto ad ogni motivo, che egli, perché tale lo ammetterebbe per sé, chiama<br />
umano. “E’ umano – <strong>di</strong>ce – è giusto”.<br />
Ma invero quanto è umano tanto è ingiusto, né umano criterio può giu<strong>di</strong>care il<br />
Giusto cosa sia.<br />
‘Uomo giusto’ è colui cui nessun umano argomento implica. Questi è l’‘Uomo’,<br />
che nul<strong>la</strong> ha più in sé <strong>di</strong> umano (Op 713).<br />
Sembrano rivivere le parole <strong>di</strong> ammonizione del Buddha: «Un uomo non è giusto<br />
perché si occupa <strong>di</strong> una questione con violenza, ma quel saggio che <strong>di</strong>scrimina<br />
fra le due cose: ciò che è reale e ciò che è irreale» 36 .<br />
36 Buddha, Aforismi e <strong>di</strong>scorsi, Newton&Compton, Roma 1994, p. 74.<br />
35
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
La giustizia viene rappresentata secondo un preciso schema all’interno de<br />
La Persuasione e <strong>la</strong> Rettorica. Essa è inserita in un sistema a piano car<strong>tesi</strong>ano,<br />
con i due assi coor<strong>di</strong>nati secondo precisi valori <strong>di</strong> riferimento: sull’asse delle<br />
ascisse (x) sta tutto l’insieme <strong>di</strong> cose che l’uomo ritiene giuste per sé; sull’asse<br />
delle or<strong>di</strong>nate (y), l’attività umana, il compimento del suo presunto dovere. Tutto<br />
lo spazio geometrico definito dal<strong>la</strong> moltiplicazione <strong>di</strong> X ed Y è lo spazio costante<br />
del<strong>la</strong> vita dell’uomo retorico nel <strong>mondo</strong> del<strong>la</strong> retorica, lo spazio dell’incapacità <strong>di</strong><br />
affermazione dell’uomo misero che si crede potente, «mentre vive cosa fra le<br />
cose» (PeR 79).<br />
Questo schema illustrativo, esplica perfettamente l’idea <strong>di</strong> Michelstaedter<br />
che <strong>la</strong> sublimazione del<strong>la</strong> vita umana, nel compimento estatico del<strong>la</strong> persuasione,<br />
non potrà mai e poi mai realizzarsi nel<strong>la</strong> vita vissuta, che sempre resta uno<br />
scoglio insormontabile composto da volontà, bisogni, desideri e false<br />
sod<strong>di</strong>sfazioni. In fondo bisogna confessare che <strong>la</strong> retorica è quasi inaggirabile: <strong>la</strong><br />
con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> illusione è insuperabile nel<strong>la</strong> vita sociale, tanto che «abituarsi a una<br />
paro<strong>la</strong> è come prendere un vizio» (PeR 101). Solo con il completo possesso <strong>di</strong> sé,<br />
effettuato grazie al<strong>la</strong> persuasione, si potrà tendere al<strong>la</strong> Giustizia:<br />
La giustizia, <strong>la</strong> persona giusta, l’in<strong>di</strong>viduo che ha in sé <strong>la</strong> ragione, è un iperbole –<br />
<strong>di</strong>cono tutti, e tornano a vivere come se già l’avessero – ma iperbolica è <strong>la</strong> via del<strong>la</strong><br />
persuasione che a quel<strong>la</strong> conduce. Poiché come infinitamente l’iperbole s’avvicina<br />
all’asintoto, così infinitamente l’uomo che vivendo voglia <strong>la</strong> sua vita s’avvicina<br />
al<strong>la</strong> linea retta del<strong>la</strong> giustizia; e come per picco<strong>la</strong> che sia <strong>la</strong> <strong>di</strong>stanza d’un punto<br />
dell’iperbole dall’asintoto, infinitamente deve prolungarsi <strong>la</strong> curva per giungere al<br />
contatto, così per poco che l’uomo vivendo chieda come giusto per sé, infinito gli<br />
resta il dovere verso <strong>la</strong> giustizia (PeR 78).<br />
36
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
La concezione del dovere è conseguente: il dovere proprio è quello del<strong>la</strong> persona<br />
persuasa, mentre il retorico non può che continuare l’esistenza in falsi ed illusori<br />
doveri. «A toglier questa (<strong>la</strong> giustizia) dalle ra<strong>di</strong>ci deve andar tutta <strong>la</strong> tua attività:<br />
tutto dare e niente chiedere: questo è il dovere – dove sono i doveri e i <strong>di</strong>ritti io<br />
non so» ( PeR 80). La giustizia, come ogni valore assoluto, è costitutivamente<br />
irraggiungibile, ed il persuaso interiorizza questa impossibilità e il dovere <strong>di</strong><br />
raggiunger<strong>la</strong>, e in base a quel contrasto, istituisce <strong>la</strong> sua vita, «consapevole tanto<br />
del<strong>la</strong> necessità <strong>di</strong> una vita autentica quanto dell’inevitabilità dello scacco» 37 .<br />
L’unico vero dovere che sia degno <strong>di</strong> tale definizione nell’ambito del<strong>la</strong> vita<br />
rettorica è l’anelito al superamento incon<strong>di</strong>zionato del<strong>la</strong> medesima, visto che<br />
l’intera attività umana non concretizza in realtà nul<strong>la</strong> <strong>di</strong> buono secondo<br />
Michelstaedter. Essa è attività nul<strong>la</strong> facente, <strong>la</strong>nguente verso una presunta<br />
sod<strong>di</strong>sfazione che non potrà giungere mai nel<strong>la</strong> vita quoti<strong>di</strong>ana:<br />
Quando (il retore) tra<strong>di</strong>sce <strong>la</strong> natura compie contro se stesso il più alto tra<strong>di</strong>mento.<br />
Gli uomini <strong>di</strong>cono che le bestie, ecc. – L’uomo nel<strong>la</strong> posizione conoscitiva è cieco<br />
del tutto. – Ma questo nel <strong>mondo</strong>, ma questo con le parole che sono soltanto del<strong>la</strong><br />
domanda del<strong>la</strong> persuasione (Op 728).<br />
È per questo che Michelstaedter asserisce che si deve passare «dall’attività<br />
all’inerzia» (PeR 89), ovvero bisogna riconoscere <strong>la</strong> fallimentare <strong>di</strong>sposizione<br />
del<strong>la</strong> vita retorica per poter rendersi effettivamente conto del<strong>la</strong> propria colpa. La<br />
vita rettorica è morte del<strong>la</strong> vita, o perpetuazione dello sforzo sciocco volto ad<br />
37 G. Brianese, L’arco e il destino, cit., p. 150.<br />
37
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
eludere il sentimento del dolore e del timore del<strong>la</strong> morte. La persuasione ha il<br />
compito <strong>di</strong> trasformare l’uomo, <strong>di</strong> annul<strong>la</strong>rlo nel dolore del<strong>la</strong> salute, al fine <strong>di</strong><br />
ottenere quel ‘beneficio’ assoluto che consiste nel superamento del<strong>la</strong> dualità<br />
apparente: «La persuasione è il possesso presente del<strong>la</strong> propria vita» (Op 728).<br />
Non si pensi mai, però, ad una sorta <strong>di</strong> percorso iniziatico del<strong>la</strong><br />
persuasione: essa non si raggiunge secondo un cammino, un iter evolutivo<br />
partico<strong>la</strong>re o predestinato. Essa è un dono: è il risveglio imme<strong>di</strong>ato<br />
dell’immanenza. Non c’è spazio per il concetto <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione nel<strong>la</strong> filosofia <strong>di</strong><br />
Michelstaedter, poiché essa è <strong>la</strong> peculiare caratteristica dello sviluppo sociale e<br />
scientifico, del<strong>la</strong> società illusa.<br />
La persuasione è un regalo, un dono che soltanto il persuaso sa<br />
riconoscere, perché ha annul<strong>la</strong>to <strong>la</strong> propria volontà bisognosa e desiderosa. La<br />
persuasione non può essere raggiunta da alcuna azione <strong>di</strong> stampo intenzionale, da<br />
alcuna volontà: è completamente estranea ed in<strong>di</strong>fferente al <strong>mondo</strong> del<strong>la</strong> logica<br />
storica, che, al contrario, è retta da una impostazione evolutiva <strong>di</strong> progresso<br />
sganciata da qualunque ricerca dell’essere <strong>di</strong> carattere scientifico. <strong>Il</strong> vivere<br />
persuaso è invece per Michelstaedter una rianimazione del<strong>la</strong> pienezza originaria,<br />
proveniente da un sapere mistico pre-socratico, totalmente avverso al<strong>la</strong> logica<br />
<strong>di</strong>ssipatrice cresciuta ed affermatasi infine nel massimo esponente del<strong>la</strong> retorica:<br />
Aristotele.<br />
Volendo iniziare <strong>la</strong> trattazione del<strong>la</strong> rettorica, Aristotele «deve intender <strong>di</strong><br />
far <strong>la</strong> teoria del<strong>la</strong> rettorica, egli dovrebbe voler rifar l’etica e <strong>la</strong> politica, seppur è<br />
38
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
giusta <strong>la</strong> loro vicendevole re<strong>la</strong>zione quale Aristotele stesso <strong>la</strong> stabilisce» 38 . Si<br />
viene a delineare così il quadro dell’essere del<strong>la</strong> comunità rettorico-scientifica.<br />
Lo spirito <strong>di</strong> una tale società è prigioniero dell’illusione del<strong>la</strong> propria capacità <strong>di</strong><br />
realizzare qualcosa: è l’inganno per non dover pensare al<strong>la</strong> reale destinazione<br />
dell’esistenza, ovvero <strong>la</strong> morte. Lo spirito non è libero, e Michelstaedter nota<br />
bene che <strong>la</strong> società tenta una vana autoprotezione, sacrificando <strong>la</strong> singo<strong>la</strong><br />
in<strong>di</strong>vidualità, irripetibile, irrisolvibile, ineguagliabile:<br />
Libertà? quale è <strong>la</strong> libertà dell’uomo in natura? è <strong>la</strong> libertà che tutte le parti<br />
dell’universo hanno: in quanto vivono secondo <strong>la</strong> loro legge senza averne<br />
coscienza. Ma se ne acquistano coscienza hanno nello stesso tempo <strong>la</strong> conoscenza<br />
che questa legge è <strong>la</strong> loro e che tanto sono schiave quanto dura <strong>la</strong> loro vita […]<br />
Dov’è allora <strong>la</strong> libertà per l’uomo? E’ nel suo pensiero, per<strong>di</strong>o, il quale per cerchi<br />
che s’al<strong>la</strong>rgano come l’onda dall’in<strong>di</strong>viduo attraverso tutti i gra<strong>di</strong> dell’umanità,<br />
fino all’universalità, giunge al<strong>la</strong> contemp<strong>la</strong>zione dell’infinito (Op 665 sg).<br />
<strong>Il</strong> tentativo <strong>di</strong> risvegliare l’uomo per elevarlo al<strong>la</strong> con<strong>di</strong>zione del<strong>la</strong> persuasione<br />
potrebbe far pensare ad una riscoperta dell’Übermensch nietzschiano, ma così<br />
non deve essere:<br />
<strong>Il</strong> valore del<strong>la</strong> conoscenza è soltanto negativo. Poiché questo ‘io’ <strong>di</strong>vino è il nostro<br />
‘io’ vivente nel<strong>la</strong> sua esistenza libera ed assoluta, verso il quale ten<strong>di</strong>amo e <strong>di</strong><br />
fronte al quale sentiamo <strong>la</strong> nullità del<strong>la</strong> nostra vita re<strong>la</strong>tiva e che sappiamo <strong>di</strong> non<br />
poter raggiungere che nel momento che rinunciamo al nostro ‘io’<br />
nell’annul<strong>la</strong>mento del<strong>la</strong> nostra vita (Op 829).<br />
38 Carlo Michelstaedter, Appen<strong>di</strong>ci Critiche al<strong>la</strong> Persuasione e <strong>la</strong> Rettorica, Vallecchi E<strong>di</strong>tore, Firenze<br />
1922, p. 275.<br />
39
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
In Nietzsche esiste il mito del<strong>la</strong> natura ritornante e rigeneratrice, c’è <strong>la</strong> teoria<br />
dell’eterno ritorno a far respirare lo spirito soffocato dall’avvilimento 39 . Per<br />
Michelstaedter, invece, questo non accade, perché l’anelito del<strong>la</strong> libertà dello<br />
spirito verso l’assoluto, verso <strong>la</strong> risoluzione nell’unità, è incalco<strong>la</strong>bile, non<br />
quantificabile: è pertanto imme<strong>di</strong>ato ed assoluto istantaneamente. Non c’è<br />
nessuna traccia <strong>di</strong> ciclicità dell’essere e dello spirito: l’immanenza è del tutto<br />
istantanea.<br />
<strong>Il</strong> dominio del<strong>la</strong> persuasione risulta così inequivocabile, non travisabile: è una<br />
grazia, e <strong>la</strong> sua idea si può definire ‘impossibile’. La vita dell’uomo del<strong>la</strong> persuasione è<br />
<strong>la</strong> vita a-cronica, <strong>la</strong> vita che non si può calco<strong>la</strong>re secondo il tempo sud<strong>di</strong>viso nelle sue<br />
tre fasi storicamente conosciute: passato, presente e futuro. Liberandosi ra<strong>di</strong>calmente<br />
da questa concezione agostiniana del tempo, Michelstaedter avverte che per <strong>la</strong> via al<strong>la</strong><br />
salute è necessario trasmutare il tempo composto in tempo unico, si potrebbe <strong>di</strong>re uni-<br />
fluente: l’attimo.<br />
39 «Anch’io parlo <strong>di</strong> ‘ritorno al<strong>la</strong> natura’, benché ciò sia propriamente non un regre<strong>di</strong>re, bensì un arrivare<br />
in alto – in alto nel<strong>la</strong> natura e nel<strong>la</strong> naturalità elevata, libera, persino terribile, che gioca, può giocare, con<br />
gran<strong>di</strong> compiti… Per <strong>di</strong>rlo con un paragone: Napoleone fu un frammento <strong>di</strong> ‘ritorno al<strong>la</strong> natura’ come<br />
l’intendo io» (F. Nietzsche, <strong>Il</strong> crepuscolo degli idoli, Newton&Compton, Roma 1994, p. 88).<br />
40
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
V<br />
L’ULTIMO PRESENTE 40<br />
L’attimo è il tempo del<strong>la</strong> sensazione, dell’estasi, del<strong>la</strong> propria autenticità e<br />
del possesso. I giorni, in fin dei conti non ci sono: si deve vivere il presente come<br />
se fosse sempre irrinunciabilmente ‘l’ultimo presente’:<br />
domani è finito tutto; il tuo corpo, <strong>la</strong> tua famiglia, i tuoi amici, <strong>la</strong> tua patria, quello<br />
che fai, quello che ancora puoi fare, il bene, il male, il vero, il falso, le tue idee, <strong>la</strong><br />
tua parte, id<strong>di</strong>o ed il suo regno, il para<strong>di</strong>so, l’inferno, tutto, tutto, domani è finito<br />
tutto – fra 24 ore è <strong>la</strong> morte (PeR 68).<br />
L’ultimo presente è riconoscibile e vi vibile soltanto dal persuaso, perché è il<br />
momento del posse<strong>di</strong>mento assoluto: il persuaso ha tutto ed offre tutto: «esser<br />
persuaso e persuadere, avere nel possesso del <strong>mondo</strong> il possesso <strong>di</strong> se stesso –<br />
esser uno egli e il <strong>mondo</strong>» (PeR 82).<br />
È proprio <strong>la</strong> <strong>di</strong>mensione temporale del<strong>la</strong> vita che garantisce <strong>la</strong><br />
<strong>di</strong>fferenziazione su cui si regge l’insieme del<strong>la</strong> corre<strong>la</strong>zione delle coscienze; il<br />
tempo medesimo è un’appen<strong>di</strong>ce non trascurabile del<strong>la</strong> retorica stessa: «Sono<br />
cre<strong>di</strong>tori (i retori) miserabili che non hanno un soldo ma hanno una cambiale: il<br />
presente è vuoto, ma contiene <strong>la</strong> promessa del<strong>la</strong> gioia. La vita è il debitore<br />
40 Una buona immagine del senso del tempo in questione è offerta dal filosofo francese Schwaller de<br />
Lubicz: «Sappi che nell’azione il pendolo che oscil<strong>la</strong> da un <strong>la</strong>to risale dall’altro, e qualunque sia <strong>la</strong> sua<br />
ampiezza esso batte sempre lo stesso tempo. <strong>Il</strong> Saggio non considera che questa uguaglianza del tempo, e<br />
<strong>la</strong>scia che l’insensato venga affascinato ora del<strong>la</strong> salita, ora dal<strong>la</strong> <strong>di</strong>scesa» (R. A. Schwaller de Lubicz,<br />
Verbo natura, E<strong>di</strong>tori Tre, Roma 1998, p. 57).<br />
41
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
insolvente – le scadenze sono corte […]» (DDS 67). Per questo motivo il tempo è<br />
il luogo del<strong>la</strong> rettorica, mentre il suo superamento viene attuato soltanto con <strong>la</strong><br />
‘illuminazione’ del<strong>la</strong> persuasione.<br />
La rettorica, non essendo in grado <strong>di</strong> superare <strong>la</strong> <strong>di</strong>mensione cronologica<br />
dell’esistere, resta imbrigliata in essa, e per dare sfogo al suo istinto <strong>di</strong><br />
sopravvivenza si espande nello spazio:<br />
Egli (il retore) crede reale quell’aspetto che le cose hanno nel momento attuale, e vi<br />
s’affida – mentre esso non appartiene che all’arbitrio del nemico che lo insi<strong>di</strong>a. –<br />
L’aspetto sufficiente perch’egli presuma <strong>di</strong> sé d’esser padrone delle cose […] Gli<br />
uomini s’affidano l’un l’altro il <strong>la</strong>voro che ognuno dovrebbe compiere per avere in<br />
sé <strong>la</strong> sicurezza <strong>di</strong> se stesso. Essi invece specu<strong>la</strong>no sul<strong>la</strong> comune debolezza per<br />
creare una sicurezza fatta <strong>di</strong> reciproca convenzione (DDS 66).<br />
Ecco <strong>la</strong> vera e propria natura del falso possesso: l’uomo rettorico presume <strong>di</strong><br />
possedere tutte le cose <strong>di</strong>verse che lo circondano, mentre anch’egli è <strong>di</strong>versa cosa<br />
fra le cose medesime, e ne è posseduto. Tale è <strong>la</strong> ra<strong>di</strong>ce del<strong>la</strong> inautenticità. Nel<br />
caso del<strong>la</strong> persuasione non potremo, allora, par<strong>la</strong>re <strong>di</strong> ‘<strong>mondo</strong>’, come accaduto<br />
per <strong>la</strong> rettorica, ma soltanto <strong>di</strong> ‘stato’: <strong>la</strong> persuasione è una sorta <strong>di</strong> quiescenza<br />
nell’assoluto essere. «La Persuasione è l’atto puro dell’essere nel suo stato <strong>di</strong><br />
perfezione» 41 : lo status del<strong>la</strong> persuasione è <strong>la</strong> luminosa aura che avvolge colui a<br />
cui si fa dono. Ne <strong>di</strong>scende che <strong>la</strong> determinazione autentica del persuaso (proprio<br />
per il carattere <strong>di</strong> staticità e totalità perfetta del<strong>la</strong> persuasione) si manifesti come<br />
affermazione del<strong>la</strong> propria essenza, che è affermazione del<strong>la</strong> volontà <strong>di</strong> non<br />
volere, <strong>di</strong> non continuare, <strong>di</strong> interrompere l’inganno.<br />
41 Gianni Carchia, Retorica del sublime, Laterza, Bari 1990, p. 22.<br />
42
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
Questo concetto michelstaedteriano <strong>di</strong> persuasione è talvolta accomunato<br />
al<strong>la</strong> illuminazione <strong>di</strong> cui tratta Arthur Schopenhauer nei suoi testi 42 , ma vi è una<br />
sostanziale <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> fondo. <strong>Il</strong> ‘risveglio’ schopenhaueriano è frutto <strong>di</strong> un<br />
processo <strong>di</strong> riconoscimento del<strong>la</strong> propria volontà limitata e limitante che pian<br />
piano si trasforma in una vera e propria noluntas, nel<strong>la</strong> rinuncia graduale al<strong>la</strong><br />
ricerca delle sod<strong>di</strong>sfazioni transitorie al fine <strong>di</strong> imboccare <strong>la</strong> via del<strong>la</strong> pace ed<br />
eliminare ogni forma <strong>di</strong> dolore. È l’ascesi.<br />
Dice Schopenhauer:<br />
L’adolescente crede che sia una cosa meravigliosa ciò che va colto nel <strong>mondo</strong>, se<br />
solo egli potesse sapere dove; il vecchio invece è pervaso dal<strong>la</strong> massima<br />
dell’Ecclesiaste ‘tutto è vano’, e sa che tutte le noci sono vuote, per quanto possono<br />
essere dorate. Nel<strong>la</strong> vecchiaia, dunque, ogni cosa si è p<strong>la</strong>cata […] Ora si conosce<br />
dunque ogni cosa in un modo più giusto e più chiaro e <strong>la</strong> si prende per quel<strong>la</strong> che è,<br />
essendo inoltre più o meno convinti del<strong>la</strong> nullità <strong>di</strong> tutti i fenomeni terreni 43 .<br />
La persuasione, invece, non è il risultato <strong>di</strong> un processo evolutivo progressivo, <strong>di</strong><br />
un viaggio scientemente attuato verso l’emancipazione dal sentimento del<br />
bisogno, del desiderio, dell’insufficienza insanabile, ma è un semplice atto:<br />
l’estasi istantanea in cui tutto è tutto, in cui l’uomo dà tutto e nul<strong>la</strong> chiede, in cui<br />
non esiste manchevolezza perché è assente del tutto <strong>la</strong> volontà 44 :<br />
42<br />
Per l’argomento vedasi Paolo Bernar<strong>di</strong>ni, “Dell’attimo come K? ???S”, in Dialoghi intorno a<br />
Michelstaedter, cit., pp. 99-100.<br />
43<br />
Arthur Schopenhauer, La saggezza del<strong>la</strong> vita – Aforismi, Newton&Compton, Roma 1994, p. 194.<br />
44<br />
«È da Schopenhauer – forse il primo filosofo stu<strong>di</strong>ato dal giovane – che Michelstaedter trae il concetto<br />
<strong>di</strong> volontà, che <strong>di</strong>viene per lui strumento d’analisi privilegiato del <strong>mondo</strong> in quanto rettorico» (Maddalena<br />
Dal<strong>la</strong> Mura, “Persuasione, tragico ed arte in C. Michelstaedter”, in Itinerari (rivista quadrimestrale <strong>di</strong><br />
filosofia), n°1/2001, Lanciano, p. 30).<br />
43
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
Non ci sono soste sul<strong>la</strong> via del<strong>la</strong> persuasione.<br />
La vita è tutta una dura cosa.<br />
Egli deve aver il coraggio <strong>di</strong> sentirsi ancora solo, <strong>di</strong> guardar ancora in faccia il<br />
proprio dolore, <strong>di</strong> sopportarne tutto il peso (PeR 83).<br />
Questo è il falso percorso denunciato da Michelstaedter: chi gode del dono<br />
supremo del<strong>la</strong> persuasione è irrime<strong>di</strong>abilmente solo, ed è già persuaso, poiché<br />
so<strong>la</strong>mente il persuaso sa riconoscere quando <strong>la</strong> persuasione fa dono <strong>di</strong> se stessa,<br />
altrimenti essa è fasul<strong>la</strong>, ovvero retorica:<br />
La realtà è dunque il contenuto d’ogni mio piacere: è <strong>la</strong> ‘mia coscienza’, è<br />
l’‘illusione’ del<strong>la</strong> mia ‘in<strong>di</strong>vidualità’ […] Colui che chiede veramente un Valore,<br />
l’‘essere’, […] non potrà volere ciò che non ha valore. Sarà libero da bisogni e<br />
insod<strong>di</strong>sfatto al tempo stesso. Riconosciuto il non valore dei valori in quanto tutti<br />
re<strong>la</strong>tivi solo a una volontà e al non valore del<strong>la</strong> coscienza in quanto contenente solo<br />
non valori, egli giungerà all’incoscienza: in<strong>di</strong>fferenza: inerzia (Op 759-760).<br />
Non è un caso che Michelstaedter ammonisca che lo scopo del<strong>la</strong> vita è <strong>di</strong><br />
calibrare <strong>la</strong> propria condotta spostando<strong>la</strong> verso quel<strong>la</strong> che lui chiama ‘argia’ (si<br />
ricor<strong>di</strong> anche che Argia era il nome del<strong>la</strong> donna amata dall’Autore), l’inerzia:<br />
Ogni suo attimo (<strong>di</strong> vita persuasa) è un secolo del<strong>la</strong> vita degli altri, – finché egli (il<br />
persuaso) faccia <strong>di</strong> se stesso fiamma e giunga a consistere nell’ultimo presente. In<br />
questo egli sarà persuaso – ed avrà nel<strong>la</strong> persuasione <strong>la</strong> pace. – ‘Dall’attività<br />
all’inerzia’ (PeR 89).<br />
44
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
VI<br />
SU RELIGIONE PERSUASA E RELIGIONE SOCIALE<br />
Lo stato perfetto <strong>di</strong> persuasione non è, riba<strong>di</strong>amolo, un premio<br />
conseguibile al<strong>la</strong> fine <strong>di</strong> un’educazione pratico-teoretica, come poteva richiedere<br />
<strong>la</strong> morale stoica. Non è permesso in Michelstaedter il presentarsi <strong>di</strong> un rituale<br />
cerimonioso che consenta l’adesione al<strong>la</strong> persuasione. Essa è un atto, uno stato<br />
(anzi, lo stato) <strong>di</strong> elezione suprema cui si viene chiamati e che non si può<br />
assolutamente scegliere in base al proprio desiderio o a propri arbitrari precetti.<br />
Sono queste caratteristiche <strong>di</strong> completa privazione <strong>di</strong> volontà, <strong>di</strong> totale<br />
presenza non intenzionale, <strong>di</strong> imme<strong>di</strong>atezza che rendono <strong>la</strong> grazia del<strong>la</strong><br />
persuasione il massimo dono, capace <strong>di</strong> levare all’uomo le briglie del<strong>la</strong> rettorica<br />
autoconservatrice. Per questo <strong>la</strong> vita persuasa non è paragonabile al<strong>la</strong> vita<br />
‘autarchica’ del saggio che ha raggiunto l’ascesi, anzi ne è piuttosto<br />
l’interpretazione contraria.<br />
Tutto questo <strong>di</strong>scorso chiarificatore sul<strong>la</strong> ‘via verso <strong>la</strong> salute’ mostra in<br />
maniera lucida che Michelstaedter, pensava al<strong>la</strong> persuasione come «pratica del<br />
beneficio (che) <strong>di</strong>venta qui via mistica <strong>di</strong> salvezza. Al <strong>di</strong> qua del<strong>la</strong> religione<br />
prometeica del sacrificio, che sancì l’ineliminabile <strong>di</strong>stanza fra gli uomini e gli<br />
45
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
dèi, Michelstaedter ritrova il cammino delle antiche religioni misteriche<br />
presocratiche» 45 .<br />
I culti misterici in<strong>di</strong>rizzavano l’adepto verso un cammino secondo cui<br />
l’unica modalità per ritrovare il «vero sé coincide con l’atto dell’in<strong>di</strong>arsi» 46 . La<br />
persuasione si rive<strong>la</strong> così essere quello stato ontologico che consente una<br />
comunione col <strong>di</strong>vino, e per ottener<strong>la</strong> non servono (e nemmeno basterebbero) né<br />
volontà né tangibilità <strong>di</strong> buone azioni, argomento del<strong>la</strong> religione rettorica.<br />
La religione ‘sociale’ e popo<strong>la</strong>re rientra, <strong>di</strong> conseguenza, nel dominio del<strong>la</strong><br />
logica del<strong>la</strong> rettorica, perché si artico<strong>la</strong> su compromessi <strong>di</strong> scambio e presunte<br />
stabilità dogmatiche. La logica del<strong>la</strong> rettorica è quel<strong>la</strong> del<strong>la</strong> ‘significazione<br />
sufficiente’, dello scambio re<strong>la</strong>zionale corre<strong>la</strong>to e finalizzato ad uno scopo,<br />
sottomesso al perseguimento dei fini <strong>di</strong> cui sopra s’è detto. La vita rettorica si<br />
artico<strong>la</strong> secondo uno schema semplice e preciso: l’alterità (<strong>la</strong> sfera dell’altro-da-<br />
sé) <strong>di</strong>viene il motore del<strong>la</strong> conduzione del<strong>la</strong> vita, <strong>la</strong> cui causa motrice è costituita<br />
dal bisogno, dal<strong>la</strong> necessità del desiderio, dal sod<strong>di</strong>sfacimento del<strong>la</strong> volontà:<br />
qualunque cosa uno <strong>di</strong>ca non <strong>di</strong>ce, ma attribuendosi voce a par<strong>la</strong>re si adu<strong>la</strong>. […]<br />
Così (fanno) gli uomini, che nel mancare, s’affermano inadeguatamente fingendosi<br />
il segno del<strong>la</strong> persona che non hanno, ‘il sapere’ come già in loro mano. […] Cerca<br />
ognuno <strong>la</strong> mano del compagno e <strong>di</strong>ce: ‘io sono, tu sei, noi siamo’, perché l’altro gli<br />
faccia da specchio e gli <strong>di</strong>ca: ‘tu sei, io sono, noi siamo’; ed insieme ripetono: ‘noi<br />
siamo, noi siamo, perché sappiamo, perché possiamo <strong>di</strong>rci le parole del sapere,<br />
del<strong>la</strong> conoscenza libera ed assoluta’. – Così si stor<strong>di</strong>scono l’un l’altro (PeR 99).<br />
45 G. Carchia, Retorica del sublime, cit., p. 24.<br />
46 G. Carchia, ivi, p. 24.<br />
46
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
È <strong>la</strong> vita scan<strong>di</strong>ta dal<strong>la</strong> manchevolezza, dal torpore del<strong>la</strong> coscienza, dal<strong>la</strong> illusoria<br />
conoscenza, dal<strong>la</strong> dualità insanabile, tanto che ci pare lecito citare le appropriate<br />
parole <strong>di</strong> un grande letterato:<br />
<strong>Il</strong> genere umano e, dal solo in<strong>di</strong>viduo in fuori, qualunque minima porzione <strong>di</strong> esso,<br />
si <strong>di</strong>vide in due parti: gli uni usano prepotenza, e gli altri <strong>la</strong> soffrono. Né legge né<br />
forza alcuna, né progresso <strong>di</strong> filosofia né civiltà potendo impe<strong>di</strong>re che uomo nato<br />
da nascere non sia degli uni o degli altri, resta che chi può eleggere, elegga 47 .<br />
La persuasione opera in totale contrasto al<strong>la</strong> rettorica: <strong>la</strong> sua logica è<br />
‘comunicativa’, non si adatta a schemi rigi<strong>di</strong> e prefissati, perché per sua<br />
medesima natura non consente l’ammissione degli ‘schemi <strong>di</strong> vita’. La logica<br />
del<strong>la</strong> persuasione si presenta come «una sorta <strong>di</strong> simbolica naturale<br />
imme<strong>di</strong>ata» 48 , una <strong>di</strong>rompente forza dell’essere che si sente ‘obliato’ (mutuando<br />
il termine da Heidegger). Essa è preposta ad un movimento senza sosta <strong>di</strong><br />
annul<strong>la</strong>mento del<strong>la</strong> oggettività del valore, al superamento completo dei vincoli<br />
del<strong>la</strong> convenzione del<strong>la</strong> società. «Tentiamo <strong>di</strong> vantarci <strong>di</strong> quei <strong>di</strong>fetti che non<br />
vogliamo correggere», afferma il letterato francese del XVII secolo François de<br />
La Rochefoucauld 49 .<br />
La società, secondo Michelstaedter, è così subdo<strong>la</strong> che offre a tutti<br />
l’illusione <strong>di</strong> poter produrre insieme qualcosa, mentre essa <strong>di</strong>strugge<br />
silenziosamente l’interiorità del singolo; ecco perché <strong>la</strong> forza del<strong>la</strong> persuasione è<br />
47 G. Leopar<strong>di</strong>, Pensieri, Garzanti, Mi<strong>la</strong>no 1995, p. 21.<br />
48 G. Carchia, Retorica del sublime, cit. p. 25.<br />
49 F. de <strong>la</strong> Rochefoucauld, Massime, Newton&Compton, Roma 1993, p. 54.<br />
47
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
rivolta allo sgreto<strong>la</strong>mento <strong>di</strong> ogni qualsivoglia oggettività delle re<strong>la</strong>zioni<br />
interpersonali.<br />
Uno dei sentimenti su cui è incar<strong>di</strong>nata <strong>la</strong> società è l’adu<strong>la</strong>zione (ko<strong>la</strong>keia).<br />
Chi ha tutto da sé – l’uomo in natura – non conosce <strong>la</strong> rabbia impotente – <strong>la</strong><br />
conosce chi ha bisogno dell’opera altrui, <strong>di</strong> singoli o <strong>di</strong> istituzioni; e che se questi<br />
anche d’un poco sgur<strong>la</strong>no, è in loro balia, <strong>di</strong>pende da loro e non può che con <strong>la</strong><br />
rabbia sfogare <strong>la</strong> sua impazienza e l’insopportabile senso del<strong>la</strong> <strong>di</strong>pendenza (DDS<br />
69).<br />
Essa è frutto <strong>di</strong> una vita che chiede <strong>la</strong> vita, <strong>di</strong> un desiderio che pur <strong>di</strong> non<br />
annul<strong>la</strong>rsi si continua in falsi sod<strong>di</strong>sfacimenti.<br />
<strong>Il</strong> tema del<strong>la</strong> sicurezza impotente del<strong>la</strong> società ritorna prepotentemente<br />
anche in questo caso: gli uomini avviliti dal<strong>la</strong> retorica cercano un vano riparo<br />
nel<strong>la</strong> costituzione <strong>di</strong> un gruppo compatto, che possa sfuggire al destino del<strong>la</strong><br />
morte. L’adu<strong>la</strong>zione entra in gioco perché il movimento verso <strong>la</strong> compattazione,<br />
scan<strong>di</strong>to dal «principio del<strong>la</strong> debolezza» (PeR 176), è guidato da coloro che<br />
socialmente occupano posizioni prestigiose, e che pertanto si reputano i più forti.<br />
Questi personaggi, figli primogeniti del<strong>la</strong> retorica, sono gli scienziati ed i giu<strong>di</strong>ci.<br />
Questo tipo <strong>di</strong> persone è sommamente convinto <strong>di</strong> poter cambiare <strong>la</strong> società e <strong>di</strong><br />
garantirne lo sviluppo etico, <strong>di</strong> mantenerne l’or<strong>di</strong>ne e <strong>di</strong> guidare l’uomo verso il<br />
progresso, mentre «illudendosi <strong>di</strong> propugnare idee proprie sono inconsci<br />
strumenti del<strong>la</strong> società» (PeR 181).<br />
La società ha una funzione organica e organizzatrice <strong>di</strong> se stessa: è <strong>la</strong><br />
‘officina dei valori assoluti’. Qui Michelstaedter mette bene in luce <strong>la</strong> tematica<br />
del<strong>la</strong> nullità del valore del<strong>la</strong> posizione sociale, del<strong>la</strong> inautenticità dell’adu<strong>la</strong>zione,<br />
48
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
per far risaltare invece quello del<strong>la</strong> sfera in<strong>di</strong>viduale, del<strong>la</strong> conoscenza e del<strong>la</strong><br />
persuasione:<br />
Due in<strong>di</strong>vidualità uguali si negano vicendevolmente, non s’identificano. Dunque<br />
identità equivale a ‘unità’ e presuppone <strong>la</strong> liberazione da ogni determinazione:<br />
unica – libera – essenza dello spirito assoluto. […] Ma se uno non ha più alcuna<br />
necessità (intendo ‘alcuna determinazione <strong>di</strong> volontà’ i.e. alcuna volontà) che<br />
cos’è? Qual è <strong>la</strong> sua coscienza? Quale <strong>la</strong> sua sod<strong>di</strong>sfazione? Quando non sente, non<br />
vuole più alcuna cosa, qual è il contenuto del<strong>la</strong> sua vita, quale il ‘portatore’ del<strong>la</strong><br />
libertà? essere = essere libero, ma ‘esser libero’ = non esser più (Op 818).<br />
La gente comune si abbandona (così come accade in ambito religioso) a quello<br />
che le viene propinato dal<strong>la</strong> scienza e dal<strong>la</strong> legge, non si presta ad un<br />
approfon<strong>di</strong>mento personale delle tematiche. La gente comune viene trascinata<br />
dalle in<strong>di</strong>cazioni scientifiche e legali, e non si preoccupa <strong>di</strong> assumere su <strong>di</strong> esse<br />
un atteggiamento critico e personalizzato. Questo è in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> indubbia<br />
spersonalizzazione e palese impossibilità <strong>di</strong> ricerca del<strong>la</strong> propria autenticità.<br />
È il trionfo del<strong>la</strong> volontà che vuole vivere perché non ha <strong>la</strong> vita. «La vita<br />
sarebbe se il tempo non le allontanasse l’essere costantemente nel prossimo<br />
istante» (PeR 43). E prosegue l’Autore: «Ma io, e con me il <strong>di</strong>vino Eresia, il<br />
Persuasore <strong>di</strong> morte, faremmo cori benevoli a quest’ultimo tuo monito, <strong>di</strong>cendo<br />
che <strong>la</strong> vita non ha altro scopo se non <strong>la</strong> vita stessa» (DDS 140).<br />
L’uomo persuaso non è coinvolto nel<strong>la</strong> corre<strong>la</strong>zione delle coscienze, ma è<br />
un ‘con-penetratore’ <strong>di</strong> coscienze, è colui che ritrova il primor<strong>di</strong>ale coraggio <strong>di</strong><br />
ritornare all’Uno, all’immanenza assoluta senza mezzi termini, è colui che crea<br />
da se stesso il <strong>mondo</strong> (ritorna ancora l’eco schopenhaueriana), colui che possiede<br />
tutto perché possiede se stesso, colui che da tutto perché tutto ha: «dare è fare<br />
49
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
l’impossibile: dare è avere» (PeR 82). Michelstaedter sta professando l’ideale<br />
romantico del<strong>la</strong> Menschheit 50 , sepolto da anni <strong>di</strong> stor<strong>di</strong>mento del<strong>la</strong> coscienza:<br />
Nell’universale egli (il persuaso) arriva a possedere se stesso; egli perde compito,<br />
attività, piacere e dolore: vita, egli muore. Infatti, se ci fosse un Dio egli sarebbe<br />
morto <strong>di</strong> ‘noia’ (Op 776).<br />
Egli professa una sorta <strong>di</strong> comunicazione assolutamente libera fra le anime<br />
umane, fra le coscienze persuase.<br />
Si colloca bene in questa parte <strong>di</strong> <strong>di</strong>scorso una breve chiarificazione del<br />
termine ‘persuasione’, che probabilmente fu ripreso da Michelstaedter proprio<br />
per il suo significato primigenio scomparso da tempo. <strong>Il</strong> significato del<strong>la</strong><br />
persuasione è <strong>di</strong> stampo pre-metafisico, misticheggiante, appartenente ai culti<br />
misterici delle filosofie presocratiche, al<strong>la</strong> mitologia olimpica: è <strong>la</strong> riscoperta<br />
del<strong>la</strong> <strong>di</strong>vinità Peitho. Essa è <strong>la</strong> persuasione <strong>di</strong>vinizzata, sovente presente nei<br />
cortei delle <strong>di</strong>vinità secondarie che accompagnano Afro<strong>di</strong>te (<strong>la</strong> dea dell’amore), e<br />
spesse volte ritenuta <strong>la</strong> figlia <strong>di</strong> Ate (l’‘errore’). Molto più spesso, però, Peitho si<br />
colloca come sorel<strong>la</strong> <strong>di</strong> Tiche (il ‘caso’) ed Eumonia (il ‘buon or<strong>di</strong>ne’).<br />
Essa è riscoperta da Michelstaedter in qualità <strong>di</strong> supremo stato dell’unità<br />
dell’essere, <strong>di</strong> estremo e perfetto momento del<strong>la</strong> comunicazione, antecedente in<br />
maniera obbligata <strong>la</strong> sfera del<strong>la</strong> ‘positività’ del<strong>la</strong> vita umana, in cui l’uomo vive<br />
morendo giorno dopo giorno, nell’abbandono ad una scissura insanabile fra<br />
ragione e passione, fra freddo calcolo scientifico e potenza emotivo-emozionale.<br />
50 Voglia considerarsi il termine Umanità come <strong>la</strong> qualità dell’uomo <strong>di</strong> porsi in re<strong>la</strong>zione con<br />
l’universalità dello spirito. <strong>Il</strong> sentimento <strong>di</strong> umanità è da un <strong>la</strong>to il sentimento del<strong>la</strong> simpatia universale,<br />
dall’altro è <strong>la</strong> facoltà <strong>di</strong> poter comunicare intimamente ed universalmente con l’assoluto. Esso è <strong>la</strong><br />
<strong>di</strong>sposizione dell’in<strong>di</strong>viduo all’universalità del<strong>la</strong> vita.<br />
50
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
«L’assoluto del<strong>la</strong> persuasione michelstaedteriana è, dunque, qualcosa <strong>di</strong><br />
ra<strong>di</strong>calmente <strong>di</strong>fferente dall’assoluto del<strong>la</strong> tra<strong>di</strong>zione metafisica» 51 , poiché per<br />
Michelstaedter esso è proprio un momento perdurante <strong>di</strong> perfezione <strong>di</strong>vinamente<br />
completa, totale ed esauriente.<br />
Ecco perché per l’uomo persuaso non è importante tanto vedere e<br />
riconoscere il bene, quanto invece lo è il farlo e farlo senza <strong>la</strong> minima<br />
intenzionalità, involontariamente, perché è proprio <strong>la</strong> sua natura <strong>di</strong> uomo graziato<br />
dal<strong>la</strong> persuasione ad in<strong>di</strong>rizzarlo verso tali comportamenti.<br />
51 G. Carchia, Retorica del sublime, cit., p. 26.<br />
51
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
VII<br />
SUL DOLORE, LA COLPA E LA MALINCONIA<br />
L’elemento fondante dell’autonomia assoluta dell’azione persuasa è l’idea<br />
<strong>di</strong> ‘dolore’:<br />
Allora il dolore muto e cieco <strong>di</strong> tutte le cose che in ciò che vogliono esser non<br />
sono, avrà per lui (il retore), che ne avrà presa <strong>la</strong> persona, <strong>la</strong> paro<strong>la</strong> eloquente e <strong>la</strong><br />
vista lontana, poiché nel piacere grigio, nei dolori finiti <strong>di</strong> tutte le cose, che, per <strong>la</strong><br />
paura del<strong>la</strong> morte, sempre lo riempiono, egli lo sentirà par<strong>la</strong>re e lo vedrà ‘guardare<br />
in attesa’ a un bene che quelle non hanno il coraggio <strong>di</strong> volere. […] Egli soffrirà<br />
nello stesso punto del<strong>la</strong> propria deficienza e del<strong>la</strong> loro: par<strong>la</strong>ndo <strong>la</strong> voce del proprio<br />
dolore egli parlerà loro <strong>la</strong> voce ad essi lontana del loro stesso dolore; come nel<strong>la</strong><br />
sua attività intensa egli sarà vic ino a saziar il proprio dolore, così a loro metterà<br />
vicina una vita, per <strong>la</strong> quale essi vedranno sciogliersi <strong>la</strong> trama <strong>di</strong> ciò che li preme,<br />
<strong>di</strong> ciò che via via li <strong>di</strong>strae (PeR 85-86).<br />
<strong>Il</strong> dolore è il sentimento principale e non ha i c<strong>la</strong>ssici connotati negativi <strong>di</strong><br />
malessere, <strong>di</strong> cattiva <strong>di</strong>sposizione del corpo o dello spirito. <strong>Il</strong> dolore<br />
michelstaedteriano è energia, è una fustigata istantanea e violenta che spezza <strong>la</strong><br />
catena del<strong>la</strong> corre<strong>la</strong>zione retorica, permettendo <strong>di</strong> riconoscere <strong>la</strong> falsità e <strong>la</strong><br />
‘sufficienza’ del<strong>la</strong> vita sociale: «<strong>Il</strong> dolore fino a che non è equivalente al<strong>la</strong><br />
volontà <strong>di</strong> vivere non annienta <strong>la</strong> vita. I supremi dolori sono <strong>la</strong> morte in ogni<br />
punto (morire: significa <strong>la</strong> per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> tutto il contenuto dell’illusione) e <strong>la</strong> noia<br />
(cioè io voglio vivere ma voglio: niente)» (Op 789).<br />
In maniera tragica, il dolore è <strong>la</strong> rappresentazione parabolica (<strong>di</strong>scendente)<br />
dell’impossibilità dell’affermazione del bene in questo <strong>mondo</strong>. «La sua chiusa e<br />
52
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
fonda naturalità è, però, anche il solo segno che abbiamo, nell’esperienza<br />
catartica del<strong>la</strong> persuasione, <strong>di</strong> una realtà spirituale suprema» 52 . <strong>Il</strong> dolore è il<br />
sangue del risvegliato che non ha seguito alcun corso <strong>di</strong> preparazione al<strong>la</strong><br />
riscoperta del<strong>la</strong> propria autenticità, avendo invece ricevuto istantaneamente <strong>la</strong><br />
scossa dall’essere. «<strong>Il</strong> dolore è l’unica iniziazione a questo assoluto» 53 , perché<br />
l’idea misticheggiante del<strong>la</strong> persuasione, intesa come proprietà del<strong>la</strong><br />
comunicazione (comunicabilità) suprema e perfetta, si può ben intendere come<br />
l’attività catartica del dolore, <strong>la</strong> funzione ineffabile dell’emendamento dal<strong>la</strong><br />
retorica sul<strong>la</strong> via verso l’unità e l’assolutezza.<br />
È il dolore <strong>la</strong> chiave <strong>di</strong> volta che spiana <strong>la</strong> strada a Michelstaedter anche<br />
nel<strong>la</strong> interpretazione del<strong>la</strong> società trasposta sul piano del<strong>la</strong> letteratura c<strong>la</strong>ssica, in<br />
partico<strong>la</strong>re nel<strong>la</strong> trage<strong>di</strong>a greca, dove Sofocle è portavoce del<strong>la</strong> persuasione 54 ed<br />
Euripide del<strong>la</strong> retorica. L’uomo sociale e retorico per l’Autore è l’uomo che sente<br />
e patisce fortemente il dolore, ma lo tiene apposta represso per fingere <strong>di</strong><br />
eluderlo, abbandonandosi al<strong>la</strong> supposizione religiosa che qualche <strong>di</strong>o possa<br />
sobbarcarsi i patimenti al posto suo: «<strong>Il</strong> <strong>di</strong>o che ti teneva in pie<strong>di</strong>, che ti faceva<br />
chiaro il giorno, e dolce il cibo, che ti dava <strong>la</strong> famiglia <strong>la</strong> patria, il para<strong>di</strong>so –<br />
quello ti tra<strong>di</strong>sce ora e t’abbandona, poiché è rotto il filo del<strong>la</strong> filopsichia» (PeR<br />
68). Ma <strong>la</strong> forza prorompente del dolore non tace mai, e per quanto si tenti <strong>di</strong><br />
52 G. Carchia, ivi, p. 28.<br />
53 G. Carchia, ivi, p. 28.<br />
54 Insieme a Sofocle, il drammaturgo del<strong>la</strong> persuasione, ovviamente fuori del contesto greco c<strong>la</strong>ssico, è<br />
Henrik Ibsen, che scrive: «Sì, sì, così! Scendere in sé. Questa è <strong>la</strong> vita. Questo il cammino. <strong>Il</strong> nostro<br />
cuore» (H. Ibsen, “Brand”, in Drammi, Einau<strong>di</strong>, Torino 1994, p. 570).<br />
53
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
oscurar<strong>la</strong> essa non scende mai sotto un certo limite, garantendo a chiunque il suo<br />
ineliminabile tormento:<br />
Che v’importa <strong>di</strong> vivere se rinunciate al<strong>la</strong> vita in ogni presente per <strong>la</strong> cura del<br />
possibile. Se siete nel <strong>mondo</strong> e non siete nel <strong>mondo</strong>, prendete le cose e non le<br />
avete, mangiate e siete affamati, dormite e siete stanchi, amate e vi fate violenza, se<br />
siete voi e non siete voi. – Dare è fare l’impossibile: dare è avere (PeR 82).<br />
Assieme a questa manifestazione <strong>di</strong> potenza angosciante e malinconica,<br />
«intuizione più o meno nitida del<strong>la</strong> precarietà del non essere, […] ‘dolore’<br />
significa per Michelstaedter anche con<strong>di</strong>zione universale del tutto nel suo<br />
perpetuo corre<strong>la</strong>rsi, dato in cui si troverebbero accomunate, insieme con l’uomo,<br />
tutte le cose che vivono» 55 .<br />
L’uomo social-retorico è così sempre più angosciato, come già detto, ed è il<br />
tormento procurato dal<strong>la</strong> sua incapacità <strong>di</strong> possesso ad infasti<strong>di</strong>rlo sempre più,<br />
tanto che «si sente <strong>di</strong>ssolvere, impotente, già morto e pur ancora vivo» 56 .<br />
E vogliono (i retori sociali) – prosegue Michelstaedter – continuare così come sono<br />
perché si credono d’esser persone vive: <strong>la</strong> loro scienza del<strong>la</strong> vita è loro sufficiente.<br />
Questa è <strong>la</strong> loro sicurezza e <strong>la</strong> loro pace, <strong>la</strong> loro coscienza e <strong>la</strong> loro gioia – questo il<br />
loro sguardo fidente volto al futuro […] E un lieve soffio basta a far vedere<br />
com’era malsicuro il loro fondamento <strong>di</strong> fronte al<strong>la</strong> necessità che s’illudevano<br />
d’aver superata, quanto inadeguata <strong>la</strong> loro sicurezza (PeR 175-176).<br />
Parafrasando anche le parole <strong>di</strong> una famosa canzone <strong>di</strong> Franco Battiato, può<br />
essere corretto affermare che Michelstaedter abbia voluto «emanciparsi<br />
dall’incubo delle passioni» 57 , proprio perché <strong>la</strong> continua (o sarebbe meglio <strong>di</strong>re<br />
55 M. Cerruti, Carlo Michelstaedter, cit., pp. 62-63.<br />
56 Maddalena Dal<strong>la</strong> Mura, in Itinerari, cit. p. 36.<br />
57 Franco Battiato, “E ti vengo a cercare”, in Fisionomica, EMI, Mi<strong>la</strong>no 1988.<br />
54
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
‘continuata’) opposizione fra sfera razionale e sfera emozionale determina<br />
l’incessante patimento del<strong>la</strong> dualità retorica, dell’illusione del<strong>la</strong> realizzazione. Si<br />
può senza problema affermare che il dolore trattato, vissuto e patito dall’Autore<br />
«appartiene ad ogni cosa che vive appunto e solo per il fatto stesso che essa è<br />
viva» 58 , e <strong>di</strong> tale dolore l’uomo del<strong>la</strong> persuasione dovrà necessariamente farsi<br />
carico, seguendo una sua propria ed autonoma opera redentrice, allo scopo <strong>di</strong><br />
riscattare le sofferenze dettate dal<strong>la</strong> piaga del<strong>la</strong> rettorica.<br />
<strong>Il</strong> dolore <strong>di</strong> Michelstaedter, però, si ba<strong>di</strong> bene, non segue minimamente<br />
l’idea cristiana del dolore inteso come purificatore, figlio del<strong>la</strong> penitenza, per <strong>la</strong><br />
colpa originale, né è una sorta <strong>di</strong> ‘nirvana’ bud<strong>di</strong>stico, luogo del<strong>la</strong><br />
contemp<strong>la</strong>zione perfetta. <strong>Il</strong> dolore si esprime <strong>di</strong>cendo «ora vengo io, da te che ti<br />
credevi sicuro, e non sei niente» (PeR 62). Sembra corretto affermare, a questo<br />
punto del<strong>la</strong> trattazione, che per Michelstaedter il dolore sia uno stato in cui vive<br />
l’uomo in<strong>di</strong>rizzato al<strong>la</strong> rettorica, stato che rappresenta il limite ultimo fra <strong>la</strong> vita<br />
secondo coscienza (sociale) e vita secondo incoscienza (persuasione):<br />
Vera coscienza è <strong>la</strong> coscienza del<strong>la</strong> nullità, cioè quel<strong>la</strong> che cessa <strong>di</strong> essere<br />
coscienza 59 […] Anche l’ultimo compagno serio s’annul<strong>la</strong>: il ‘dolore’. <strong>Il</strong> dolore che<br />
è stato il fondamento sicuro in ogni istante del<strong>la</strong> via, quello che ho sempre ritrovato<br />
al <strong>di</strong> sotto <strong>di</strong> ogni vana illusione, che io sentivo come l’essenza del<strong>la</strong> mia vita ,<br />
come <strong>la</strong> forza che mi faceva crescere e fiorire, anch’esso s’annul<strong>la</strong> poiché anche <strong>la</strong><br />
sua ragione d’essere altro non era che il voler essere – insod<strong>di</strong>sfatto (Op 779).<br />
58 G. Brianese, L’arco e il destino, cit. p. 50.<br />
59 Michelstaedter prosegue altrove sul<strong>la</strong> coscienza, <strong>di</strong>cendo: «<strong>Il</strong> nul<strong>la</strong> non è <strong>la</strong> coscienza del nul<strong>la</strong>.<br />
Coscienza del nul<strong>la</strong> come verità assoluta non esiste, in quanto implica <strong>la</strong> nullità <strong>di</strong> questa stessa facoltà <strong>di</strong><br />
riconoscere l’assoluto. Per me il nul<strong>la</strong> è <strong>la</strong> cessazione del<strong>la</strong> mia coscienza, è l’incoscienza» (Op 798).<br />
55
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
Esso è più propriamente il momento fulmineo e fulminante del riconoscimento <strong>di</strong><br />
una colpa: «tutti hanno ragione <strong>di</strong> vivere…che hanno avuto il torto <strong>di</strong> nascere»<br />
(PeR 77). Tale colpa può essere emendata esclusivamente nel<strong>la</strong> e dal<strong>la</strong> vita<br />
persuasa (è visibile qui <strong>la</strong> ripresa del concetto <strong>di</strong> dolore che l’Autore riscontrava<br />
nell’antica trage<strong>di</strong>a c<strong>la</strong>ssica 60 , e rilevante, in tempi a noi più vicini, nell’arte<br />
nor<strong>di</strong>ca del<strong>la</strong> pittura <strong>di</strong> Munch, del<strong>la</strong> musica <strong>di</strong> Beethoven, del<strong>la</strong> letteratura <strong>di</strong><br />
Tolstoj 61 ed Ibsen).<br />
Allora – prosegue Michelstaedter – il dolore muto e cieco <strong>di</strong> tutte le cose che in ciò<br />
che vogliono esser non sono, avrà per lui , che ne avrà presa <strong>la</strong> persona, <strong>la</strong> paro<strong>la</strong><br />
eloquente e <strong>la</strong> vista lontana, poiché nel piacere grigio, nei dolori finiti <strong>di</strong> tutte le<br />
cose, che, per <strong>la</strong> paura del<strong>la</strong> morte, sempre lo reprimono, egli lo sentirà par<strong>la</strong>re e lo<br />
vedrà ‘guardare in attesa’ a un bene che quelle non hanno il coraggio <strong>di</strong> volere<br />
(PeR 85).<br />
È così che <strong>la</strong> società continua per <strong>la</strong> sua inconcludente strada, si illude nel<strong>la</strong><br />
speranza dell’abbandono definitivo del senso del bisogno: il retore è un morto<br />
che <strong>di</strong>ce agli altri morti <strong>di</strong> essere vivo, come questi si fregiano con lui del<br />
medesimo titolo <strong>di</strong> ‘esser qualcuno’. <strong>Il</strong> persuaso, invece, è ‘liberato’, ‘scarcerato<br />
dal<strong>la</strong> prigione del<strong>la</strong> necessità’, colui che si è svinco<strong>la</strong>to da ogni legame per poter<br />
guardare in faccia l’entità del<strong>la</strong> propria insufficienza, rispondendole a tono che<br />
essa non ha più <strong>la</strong> forza <strong>di</strong> avvilirlo: «Nell’abio? bio? (vita che non è vita) <strong>la</strong><br />
potenza e l’atto sono <strong>la</strong> stessa cosa, poiché l’Atto trascendentale, ‘l’eternità<br />
60 Michelstaedter par<strong>la</strong>, a tal proposito, <strong>di</strong> ‘catarsi tragica’, Op 770.<br />
61 «Tolstoj non chiede soltanto lotta, ma anche devozione: potrebbe essere questo il pensiero<br />
michelstaedteriano più illuminante e chiarificatore […] L’uomo deve saper resistere alle seduzioni del<strong>la</strong><br />
società che egli giu<strong>di</strong>ca bastata sul falso e sul<strong>la</strong> prepotenza; egli deve uscirne ed abbandonarne tutto il<br />
sistema <strong>di</strong> vita» (Alberto Cavaglion, “Una giovinezza Immortale”, in Dialoghi intorno a Michelstaedter,<br />
op. cit. p. 78).<br />
56
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
raccolta e intera’, <strong>la</strong> persuasione, nega il tempo e <strong>la</strong> volontà in ogni tempo<br />
deficiente» (PeR 44).<br />
L’uomo persuaso potrà allora <strong>di</strong>re agli altri che «non c’è niente da temere,<br />
niente da cercare, niente da fuggire» (PeR 86), perché ha ritrovato quello che,<br />
sotto mentite spoglie, il retore cerca e non può trovare: <strong>la</strong> sua essenza, <strong>la</strong> sua<br />
natura, <strong>la</strong> sua autenticità. L’uomo persuaso è costantemente equilibrato nel<strong>la</strong> sua<br />
umanità (Menschheit), perché ha ottenuto quello stato benefico involontario che<br />
gli permette <strong>di</strong> non aver incertezze su nul<strong>la</strong>: il dolore, che fa rabbrivi<strong>di</strong>re il retore<br />
e lo angoscia, è invece vissuto integralmente in ogni suo punto dal persuaso:<br />
Amico io guardo ancora all’orizzonte<br />
dove il cielo ed il mare<br />
<strong>la</strong> vita fondon infinitamente.<br />
Guardo e chiedo <strong>la</strong> vita<br />
<strong>la</strong> vita del<strong>la</strong> mia forza selvaggia<br />
perch’io p<strong>la</strong>smi il mio <strong>mondo</strong> e perché il sole<br />
<strong>di</strong> me possa narrar l’ombra e le luci –<br />
<strong>la</strong> vita che mi <strong>di</strong>a pace sicura<br />
nel<strong>la</strong> pienezza dell’essere» (Po 53).<br />
La filopsichia non trova più terreno fertile nel<strong>la</strong> vita persuasa, perché il<br />
sentimento incontrol<strong>la</strong>to <strong>di</strong> devozione per <strong>la</strong> vita, qualunque essa sia, non può più<br />
attecchire: «Ma tu non vivi-morrai <strong>di</strong> ciò e per ciò (del <strong>mondo</strong> delle cose e degli<br />
eventi) – ma ti creerai da te, e in te ‘<strong>la</strong> vita’; rinato da te stesso non ti muoverai a<br />
<strong>di</strong>fferenza delle cose sognate; ma in uno sarai tu stesso e <strong>la</strong> vita: e farai <strong>di</strong> te<br />
stesso fiamma. Poiché tu sei il primo e l’ultimo» (Op 744).<br />
57
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
Si può <strong>di</strong>re che nel<strong>la</strong> filosofia <strong>di</strong> Michelstaedter proprio a questo punto <strong>la</strong><br />
filopsichia si trasforma in filo-sofia, una filosofia, però, totalmente involontaria.<br />
È necessario <strong>la</strong>sciare ancora una volta <strong>la</strong> paro<strong>la</strong> all’Autore:<br />
Ogni suo attimo (ogni attimo del<strong>la</strong> vita del persuaso) è un secolo del<strong>la</strong> vita degli altri, –<br />
finché egli faccia <strong>di</strong> se stesso fiamma e giunga a consistere nell’ultimo presente. In questo<br />
egli sarà persuaso – ed avrà nel<strong>la</strong> persuasione <strong>la</strong> pace. – ‘Dall’attività all’inerzia’ (PeR<br />
89).<br />
Proprio questa <strong>di</strong>citura, nel testo scritta in greco, si legge ai pie<strong>di</strong> del ritratto che<br />
Michelstaedter de<strong>di</strong>ca a Schopenhauer.<br />
La frase ‘far <strong>di</strong> se stesso fiamma’ funge da <strong>di</strong>dascalia ad uno dei suoi<br />
ultimi <strong>di</strong>segni, raffigurante una <strong>la</strong>mpada accesa con l’olio che l’alimenta quasi<br />
esaurito, posta sull’angolo <strong>di</strong> un tavolo in un ambiente scuro e tetro 62 . La fiamma<br />
<strong>di</strong> Michelstaedter è simbolo rappresentativo del<strong>la</strong> vita autentica, che per esser<br />
tale ha necessità impellente <strong>di</strong> esaurirsi nell’istante dell’estasi momentanea,<br />
nell’intuizione onto-soteriologica del<strong>la</strong> ‘salute’. La salvezza è scan<strong>di</strong>ta dal tempo<br />
del<strong>la</strong> persuasione e dell’arte: l’istante.<br />
È lecito affermare, quin<strong>di</strong>, che <strong>la</strong> fiamma che arde nell’anima del persuaso<br />
sia effettivamente <strong>la</strong> forza propulsiva più intima del<strong>la</strong> natura umana, capace <strong>di</strong><br />
bruciare in un solo momento <strong>di</strong> profonda incoscienza tutta l’energia dell’essere<br />
dell’uomo. L’essere dell’uomo viene esaurito in una sorta <strong>di</strong> ‘eroico furore’ 63<br />
62 Per l’argomento si veda L’immagine irraggiungibile – Dipinti e <strong>di</strong>segni <strong>di</strong> Carlo Michelstaedter,<br />
E<strong>di</strong>zioni del<strong>la</strong> Laguna, Gorizia 1992, p. 441.<br />
63 <strong>Il</strong> riferimento è ovviamente all’opera <strong>di</strong> Giordano Bruno del 1585 dal titolo De gli eroici furori.<br />
58
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
del<strong>la</strong> fiamma, ed una volta consumato <strong>la</strong> sua vita finisce, proprio in quell’istante<br />
in cui <strong>la</strong> Menschheit attinge il suo apogeo: <strong>la</strong> persuasione.<br />
E sentii <strong>la</strong> mia vita fiammeggiare<br />
ed il deserto farsi popoloso,<br />
credetti fosse giunto il luminoso<br />
mio giorno nel<strong>la</strong> notte e consumare<br />
quel<strong>la</strong> fiamma mi parve <strong>la</strong> mia vita (Po 93).<br />
La fiamma michelstaedteriana rappresenta anche <strong>la</strong> <strong>di</strong>sponibilità dell’uomo<br />
persuaso al silenzio, il più elevato mezzo del<strong>la</strong> comunicazione:<br />
Spenta ogni luce allora ed ogni via<br />
sbarrata, allor più presso <strong>la</strong> tenebra<br />
mi stringe sì che il cuor ignoto orrore<br />
m’invade, non per me se nel<strong>la</strong> notte<br />
solo io soccomba, ma per te, o compagna<br />
forte e sicura – […] (Po 86).<br />
Confermando un meccanismo che verrà sve<strong>la</strong>to da un altro grande filosofo<br />
contemporaneo, Henri Bergson 64 , si può asserire che l’Autore si accorga anche<br />
che il tempo spazializzato non assicura nessuna tipologia <strong>di</strong> possesso autentico<br />
all’uomo, ma consegna il possesso stesso all’angoscia (Angst).<br />
<strong>Il</strong> passato viene ripescato dal<strong>la</strong> memoria e riproposto coscientemente, e<br />
l’uomo si rende consapevole del fatto <strong>di</strong> non aver realmente vissuto <strong>la</strong> ‘propria’<br />
vita: ecco l’angoscia e <strong>la</strong> malinconia. «La malinconia […] è un punto cruciale<br />
64 «Cos’è il presente? La caratteristica del tempo è <strong>di</strong> scorrere; il tempo già trascorso è il passato, e<br />
chiamiamo presente l’istante in cui scorre. Ma qui non si può trattare <strong>di</strong> un istante matematico […] La<br />
materia, in quanto estesa nello spazio, deve essere definita, a nostro avviso, un presente che ricomincia<br />
incessantemente, e, inversamente, il nostro presente è <strong>la</strong> materialità stessa del<strong>la</strong> nostra esistenza, cioè un<br />
insieme <strong>di</strong> sensazioni e movimenti, e nient’altro che questo» (H. Bergson, Materia e memoria, Laterza,<br />
Bari 1996, p. 247 sg).<br />
59
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
per <strong>la</strong> filosofia <strong>di</strong> Michelstaedter e per <strong>la</strong> sua stessa esistenza, specu<strong>la</strong>rmente:<br />
grazie ad essa, senza avvedersene, egli riesce a porsi in questa prospettiva <strong>di</strong><br />
salvezza» 65 .<br />
65 Paolo Bernar<strong>di</strong>ni, in Dialoghi intorno a Michelstaedter, cit. p. 107.<br />
60
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
VIII<br />
SUL SILENZIO E LA PAROLA<br />
Non si deve innanzitutto <strong>di</strong>menticare che La Persuasione e <strong>la</strong> Rettorica<br />
nasce da un ambito <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o prettamente linguistico, essendo i due concetti<br />
chiave dell’opera due fondamentali mo<strong>di</strong> del<strong>la</strong> comunicazione. La paro<strong>la</strong>, per<br />
Michelstaedter, è importante in quanto veicolo imprescin<strong>di</strong>bile del pensiero al<br />
monito al<strong>la</strong> vita persuasa. Allo stesso tempo, però, egli si rende conto che questo<br />
mezzo <strong>di</strong> comunicazione resta innegabilmente immerso all’interno del<strong>la</strong> vita<br />
retorica, perché il linguaggio è so<strong>la</strong>mente un veicolo dello spirito, dell’essere,<br />
non lo spirito stesso. Lo stato del<strong>la</strong> persuasione non è quello in cui si possa dar<br />
cre<strong>di</strong>to e spazio al linguaggio che viene usato nel<strong>la</strong> vita <strong>di</strong> tutti i giorni, né tanto<br />
meno a quel linguaggio scientifico 66 responsabile principale del<strong>la</strong> manifestazione<br />
dell’oggettività del<strong>la</strong> vita, del<strong>la</strong> spersonalizzazione dell’uomo, del<strong>la</strong> inautenticità<br />
dell’in<strong>di</strong>vi duo:<br />
Infatti abituarsi a una paro<strong>la</strong> è come prendere un vizio. […] <strong>Il</strong> primo segno che<br />
uno dà del<strong>la</strong> sua rinuncia a impossessarsi delle cose – per ‘amor del sapere’, è<br />
l’accontentarsi al segno convenzionale che nasconde l’oscurità per ognuno in vario<br />
modo inafferrabile. […] <strong>Il</strong> sistema dei nomi tappezza <strong>la</strong> stanza del<strong>la</strong> miseria<br />
in<strong>di</strong>viduale, pei quali mille volte e sempre avanti infinitamente <strong>la</strong> stessa luce delle<br />
stesse cose in infiniti mo<strong>di</strong> è riflessa (PeR 101).<br />
66 «Nel linguaggio lo specialista rispecchia <strong>la</strong> violenza esercitata sulle cose», G. Brianese, L’arco e il<br />
destino, op. cit. p. 113.<br />
61
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
<strong>Il</strong> persuaso è colui che ascolta nel silenzio del<strong>la</strong> liberazione dal bisogno.<br />
Avendo perso questo status retorico <strong>di</strong> desiderio e necessità, non sente neppure<br />
l’anelito al<strong>la</strong> paro<strong>la</strong> verbalizzata: il persuaso sa, conosce, interpreta il pensiero e<br />
l’essere: «La stessa cosa è il mio vivere e il <strong>mondo</strong> che vivo . Così <strong>di</strong>ce<br />
Parmenide: ‘una cosa è il pensiero e <strong>la</strong> cosa ch’io penso’» (PeR 53).<br />
Per mezzo del<strong>la</strong> verbalizzazione del linguaggio l’uomo del <strong>mondo</strong> del<strong>la</strong><br />
tecnica tenta <strong>di</strong> comunicare, conferendo spessore al compimento del<strong>la</strong> rettorica.<br />
In realtà il tecnico si illude <strong>di</strong> poter comunicare, ma non <strong>di</strong>ce niente <strong>di</strong> autentico e<br />
finge <strong>la</strong> comunicazione, tanto più che gli scienziati, in definitiva, non producono<br />
nul<strong>la</strong> <strong>di</strong> autentico; «o meglio, combinano in infiniti mo<strong>di</strong> le medesime cose<br />
separate, che non per questo perdono <strong>la</strong> loro con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> separatezza. È <strong>la</strong><br />
rettorica fatta sistema» 67 . La vita del retore è, in termini parmenidei, <strong>la</strong> vita del<br />
<strong>di</strong>venire (via del<strong>la</strong> doxa), mentre quel<strong>la</strong> del persuaso è senza dubbio l’autentica<br />
vita dell’essere (via del<strong>la</strong> aletheia).<br />
Mentre l’uomo retorico è destinato al<strong>la</strong> morte nel<strong>la</strong> vita, in essa l’uomo<br />
persuaso è destinato al silenzio ed al<strong>la</strong> solitu<strong>di</strong>ne. In buona sostanza, è lecito<br />
affermare che il messaggio dell’Autore costituisce una denuncia ra<strong>di</strong>cale contro<br />
<strong>la</strong> incapacità <strong>di</strong> vera affermazione da parte dell’essere dell’uomo; l’in<strong>di</strong>viduo<br />
del<strong>la</strong> società, l’uomo comune schiavo dell’abitu<strong>di</strong>ne e del<strong>la</strong> moda, si affida a<br />
termini tecnici (come fa lo specialista-scienziato) che non si <strong>di</strong>fferenziano mai<br />
l’uno dall’altro se non per via del loro impiego.<br />
67 G. Brianese. ivi p. 115.<br />
62
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
La denuncia <strong>di</strong> Michelstaedter si rivolge a questo: non si bada all’essenza e<br />
all’entità prodotta dalle parole, ma solo al loro utilizzo occasionale, al<br />
simbolismo de-ontologizzato del<strong>la</strong> scienza e del<strong>la</strong> tecnica. Si perde l’autenticità<br />
del significato, in favore dell’asservimento al<strong>la</strong> consuetu<strong>di</strong>ne, al<strong>la</strong> continuazione.<br />
Pare proprio che il tentativo <strong>di</strong> Michelstaedter sia quello <strong>di</strong> riven<strong>di</strong>care i <strong>di</strong>ritti<br />
alienati dell’in<strong>di</strong>vidualità, da salvare sottraendoli ad un’epoca storico-sociale in<br />
cui si sviluppa un linguaggio in<strong>di</strong>fferente al<strong>la</strong> massima potenza, e per questo ci<br />
sembra appropriato e corretto asserire che secondo l’Autore «tutti par<strong>la</strong>no oramai<br />
<strong>la</strong> stessa lingua perché nessuno ha più nul<strong>la</strong> <strong>di</strong> personale da <strong>di</strong>re» 68 .<br />
L’uomo del<strong>la</strong> persuasione, al contrario, si esprime in maniera essenziale,<br />
non si mesco<strong>la</strong> al<strong>la</strong> ripetizione dei luoghi comuni; il suo par<strong>la</strong>re agisce così da<br />
esprimere in ogni istante il senso del<strong>la</strong> totalità dell’essere delle cose. In sostanza,<br />
il persuaso, quando par<strong>la</strong>, <strong>di</strong>ce sempre <strong>la</strong> Perfezione, il ‘medesimo’, perché non<br />
c’è altro da <strong>di</strong>re, mentre il retorico <strong>di</strong>ce sempre le medesime cose perché non<br />
hanno nul<strong>la</strong> <strong>di</strong> autentico da <strong>di</strong>re: «<strong>la</strong> lingua internazionale sarà <strong>la</strong> lingua dei<br />
termini tecnici» (PeR 135).<br />
L’Autore, in fin dei conti, ane<strong>la</strong> ad una specie <strong>di</strong> significativa ma<br />
assolutamente incomunicabile in<strong>di</strong>vidualità del persuaso, che si rive<strong>la</strong> essere<br />
sempre inevitabilmente solo. Tornando, per tanto, al tema del<strong>la</strong> solitu<strong>di</strong>ne, esso è<br />
estremamente caro a Michelstaedter, che più e più volte ha denunciato, nelle sue<br />
lettere al<strong>la</strong> famiglia e maggiormente nelle sue poesie, <strong>la</strong> impossibilità statutaria<br />
dell’uomo (che volga al<strong>la</strong> persuasione) <strong>di</strong> poter re<strong>la</strong>zionare con i rettorici:<br />
68 G. Brianese, ivi, p. 116.<br />
63
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
[…] sta sotto il cielo sul<strong>la</strong> buona terra<br />
questo ch’io chiamo ‘io’, ma ch’io non sono.<br />
No, non son questo corpo, queste membra<br />
Prostrate qui fra l’erbe sul<strong>la</strong> terra,<br />
più ch’io non sia gli insetti o l’erbe o i fiori<br />
o i falchi su nell’aria o il vento o il sole.<br />
Io son solo, lontano, io son <strong>di</strong>verso –<br />
Altro sole , altro vento e più superbo<br />
volo per altri cieli è <strong>la</strong> mia vita… (Po 69).<br />
Ritorna ancora una volta <strong>la</strong> <strong>di</strong>scussione sul<strong>la</strong> corre<strong>la</strong>zione delle coscienze propria<br />
del<strong>la</strong> retorica in contrapposizione all’autentica com-penetrazione del sentire del<br />
persuaso.<br />
64
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
IX<br />
SULL’AMORE COME LEGAME<br />
In questo contesto si inserisce anche <strong>la</strong> breve riflessione sull’amore che si<br />
presenta nel<strong>la</strong> Persuasione e <strong>la</strong> Rettorica, dove Michelstaedter spiega che <strong>la</strong><br />
volontà <strong>di</strong> ognuno instrada l’in<strong>di</strong>viduo, all’interno del<strong>la</strong> società, a volersi fregiare<br />
<strong>di</strong> una propria orgogliosa identità singo<strong>la</strong>re: è <strong>la</strong> presunta affermazione <strong>di</strong> sé (<strong>la</strong><br />
determinazione), che non può far altro che accrescere <strong>la</strong> miseria spirituale<br />
dell’uomo. Così, ci si ritrova ad osservare che i più vogliono far prevalere <strong>la</strong><br />
propria affermazione/in<strong>di</strong>vidualità su quel<strong>la</strong> degli altri, per il bisogno <strong>di</strong><br />
esorcizzare tutti i timori e le angosce che affliggono <strong>la</strong> massa.<br />
Questo bisogno conduce alle logiche <strong>di</strong> opportunità (o meglio <strong>di</strong><br />
opportunismo) e <strong>di</strong> teleologismo 69 sufficiente: ognuno si propone uno scopo<br />
(fallimentare comunque) ed utilizza gli altri al fine <strong>di</strong> raggiungere il suo<br />
traguardo prefisso. È tale critica al<strong>la</strong> progettualità, all’organizzazione del<strong>la</strong> vita<br />
nel futuro, quel<strong>la</strong> che Michelstaedter chiama «l’affermazione del<strong>la</strong> in<strong>di</strong>vidualità<br />
illusoria, che violenta le cose in ciò che s’afferma senza persuasione, poiché le<br />
informa al proprio fine illusorio come al fine dell’in<strong>di</strong>viduo assoluto che avesse<br />
in sé <strong>la</strong> ragione» (PeR 63).<br />
69 Con teleologismo si vuole in<strong>di</strong>care <strong>la</strong> tendenza dell’uomo rettorico al<strong>la</strong> progettazione del proprio<br />
futuro, senza vivere realmente <strong>la</strong> <strong>di</strong>mensione del presente (propria del persuaso): è un emblema del<strong>la</strong><br />
continuazione del<strong>la</strong> vita illusa (si veda PeR 146 sg.).<br />
65
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
<strong>Il</strong> bisogno reciproco che governa questa logica <strong>di</strong> vicendevole necessità si<br />
manifesta sotto l’apparenza dell’amore, che in realtà è αντερο? (amore<br />
ricambiato) e non ερο? (l’amore per definizione, il legame). L’amore ricambiato<br />
è l’amore rettorico, il falso legame che si fonda irrime<strong>di</strong>abilmente sul νεικο? (<strong>la</strong><br />
<strong>di</strong>scor<strong>di</strong>a <strong>di</strong> origine empedoclea contrapposta al<strong>la</strong> φιλια, l’armonia). D’altronde<br />
pare proprio verosimile il detto secondo cui «<strong>la</strong> vita è terribile. Essa ci domina;<br />
non siamo a dominar<strong>la</strong>» 70 . L’amore ‘anteros’<br />
è il doppio convergere del<strong>la</strong> mutazione nel pensiero <strong>di</strong> tutti e due gli enti, in pro’<br />
del<strong>la</strong> continuazione <strong>di</strong> tutti e due i nuclei <strong>di</strong> potenzialità […] Amare, finché si<br />
riguarda all’in<strong>di</strong>viduo finito, è sempre per un ‘suo’ bene. Se egli lo trova<br />
nell’amico, l’amico glielo rappresenta; egli non ama l’amico ma, per sé, quel bene<br />
in lui. Questa <strong>la</strong> universale forma d’‘amore nel<strong>la</strong> vita’; determinazioni <strong>di</strong> un<br />
in<strong>di</strong>viduo verso un altro in<strong>di</strong>viduo, cioè bisogni in<strong>di</strong>viduali sod<strong>di</strong>sfatti da un altro<br />
(Op 820 e 826).<br />
Di qui sorge inesorabilmente quello che è stato precedentemente chiamato<br />
adattamento, ovvero quel<strong>la</strong> volontà <strong>di</strong> dover comunque obbe<strong>di</strong>re senza conoscere<br />
il significato dell’obbe<strong>di</strong>enza, cosicché «col <strong>la</strong>voro dell’in<strong>di</strong>vidualità inferiore<br />
s’hanno i frutti dell’in<strong>di</strong>vidualità superiore: questo è il significato rettorico<br />
dell’ottimismo sociale» (PeR 172). L’uomo retorico non può far altro che<br />
sottomettersi al<strong>la</strong> presunta re<strong>la</strong>zione cogente con i suoi simili, perché così vuole<br />
quel<strong>la</strong> società formatasi sul<strong>la</strong> debolezza dello spirito dell’umanità:<br />
La picco<strong>la</strong> volontà ignara <strong>di</strong> tutto che non sia quell’oscuro senso delle sue<br />
necessità, che per queste nega, ignorando<strong>la</strong>, ogni altra volontà che ‘per parte sua’<br />
ucciderebbe tutto quanto vive, per continuare a vivere essa stessa, acquista così per<br />
70 Oscar Wilde, Aforismi, Newton&Compton, Roma 1993, p. 31.<br />
66
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
mezzo del<strong>la</strong> società forza intelligente e sicura contro ogni altra volontà, acquista<br />
potere su tutto ciò che i secoli passati hanno fatto, che il secolo presente produce<br />
(PeR 152).<br />
I retori si trovano ad agire senza ragione, senza coscienza, con superficialità e<br />
sufficienza, <strong>di</strong>sperati, nascostamente, nel profondo, per l’impossibilità <strong>di</strong><br />
possedere <strong>la</strong> loro vita, tanto che non è <strong>di</strong>fficile sposare le parole dell’Autore,<br />
secondo cui «colui che non vive con persuasione non può non obbe<strong>di</strong>re perché ha<br />
già obbe<strong>di</strong>to. “Proteso al<strong>la</strong> vita assume ogni forma obbedendo al<strong>la</strong> paura del<strong>la</strong><br />
morte chi agisca senza persuasione” 71 » (PeR 66).<br />
Si può <strong>di</strong>re senza ombra <strong>di</strong> dubbio che <strong>la</strong> vita qualunquista del<strong>la</strong> gente è in<br />
realtà una mera sopravvivenza, e Michelstaedter <strong>la</strong> taccia <strong>di</strong> quel dualismo<br />
colpevole che non consente <strong>di</strong> recuperare <strong>la</strong> <strong>di</strong>mensione primor<strong>di</strong>ale dell’unità-<br />
totalità. Quest’appunto critico è p<strong>la</strong>usibilmente recuperato dal<strong>la</strong> cultura filosofica<br />
dell’antica Grecia, avendo ben presente specialmente quel Parmenide che gli fu<br />
tanto caro per <strong>la</strong> sua devozione al<strong>la</strong> ricerca dell’essere, al<strong>la</strong> sfera del<strong>la</strong> perfezione.<br />
La vita effettiva-affettiva è retta da una duplicità non ricomponibile: da un <strong>la</strong>to<br />
c’è <strong>la</strong> gretta retorica, dall’altro l’impossibile attività del<strong>la</strong> persuasione; ma<br />
sebbene appaia che <strong>la</strong> retorica sia ineliminabile, <strong>la</strong> persuasione come dono e<br />
grazia può liberare l’in<strong>di</strong>viduo dal<strong>la</strong> sua inautenticità, può condurlo per mano<br />
verso <strong>la</strong> <strong>di</strong>rezione del<strong>la</strong> ricomposta esistenza, in cui teoria e prassi si<br />
congiungono in sublime compenetrazione.<br />
71 Vedere nota PeR 198, in cui Michelstaedter riporta solo <strong>la</strong> traduzione, senza citare <strong>la</strong> fonte.<br />
Sospettiamo possa essere un’espressione tratta da Empedocle, Simonide o P<strong>la</strong>tone, autori subito in<br />
precedenza citati nel<strong>la</strong> <strong>tesi</strong> <strong>di</strong> <strong>la</strong>urea.<br />
67
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
Questa realizzazione del<strong>la</strong> vita è però paradossale al<strong>la</strong> massima potenza,<br />
poiché Michelstaedter più e più volte ripete nei suoi testi che al fine <strong>di</strong> incontrare<br />
<strong>la</strong> vita (ovvero <strong>la</strong> vita persuasa, autentica, <strong>la</strong> vita del possesso <strong>di</strong> sé) è necessario<br />
terminare <strong>la</strong> vita, cioè morire: «[…] vedo che <strong>la</strong> felicità è una vana paro<strong>la</strong> e <strong>la</strong><br />
vita una dura necessità per ogni nato» (DDS 93). La vera vita è esplicabile<br />
esclusivamente con <strong>la</strong> negazione assoluta <strong>di</strong> ogni volontà: <strong>la</strong> morte.<br />
È dunque <strong>la</strong> nascita il caso mortale per cui gli uomini muoiono ad ogni istante in<br />
tutto ciò che vogliono […] e male è certo ad ognuno l’esser nato. Ma se via c’è che<br />
possa in qualche modo liberarci dal<strong>la</strong> nebbia, è quel<strong>la</strong> che insegna a non chiedere<br />
ciò che non può esser dato (DDS 72-73). 72<br />
La via al<strong>la</strong> persuasione sembra estendersi senza appello al<strong>la</strong> rinuncia al<strong>la</strong> vita 73 ,<br />
perché solo <strong>la</strong> sua cessazione garantirebbe <strong>la</strong> concretizzazione effettiva del<strong>la</strong><br />
persuasione stessa; in questa maniera tutta <strong>la</strong> filosofia michelstaedteriana sembra<br />
riassumersi in una irrisolvibile rincorsa verso lo stato perfetto, che in verità è<br />
irrealizzabile nel<strong>la</strong> vita biologica concessaci: ecco il motivo per cui si può<br />
72 Se trasposte all’ambito qui stu<strong>di</strong>ato, possono essere utili anche le parole <strong>di</strong> Nietzsche: «L’uomo non é<br />
più un artista, è <strong>di</strong>venuto opera d’arte: <strong>la</strong> potenza artistica dell’intera natura, con il massimo appagamento<br />
estatico dell’unità originaria, si rive<strong>la</strong> qui fra i brivi<strong>di</strong> dell’ebbrezza. Qui s’impasta e si leviga l’argil<strong>la</strong> più<br />
nobile, il marmo più prezioso, l’uomo, e ai colpi <strong>di</strong> scalpello del cosmico artista <strong>di</strong>onisiaco risuona <strong>la</strong><br />
voce dei misteri eleusini: ‘Vi prosternate milioni? Senti il creatore, <strong>mondo</strong>?’» (F. Nietzsche, La nascita<br />
del<strong>la</strong> trage<strong>di</strong>a, Newton&Compton, Roma 1995, p. 123).<br />
73 Pare più che legittimo citare anche le parole <strong>di</strong> Schopenhauer: «Me<strong>di</strong>ante codesto fenomeno (il<br />
manifestarsi del<strong>la</strong> malvagità a causa del<strong>la</strong> volontà) e per sua affermazione egli ha preso su <strong>di</strong> sé tutti<br />
dolori, che da tale volontà promanano; e giustamente li soffre fin quando egli è quel<strong>la</strong> volontà. Da questa<br />
conoscenza muove il veggente poeta Calderón in La vita è sogno: “Poiché il delitto maggiore dell’uomo è<br />
l’esser nato”. Come non dovrebbe essere una colpa, poi che per una eterna legge sopra v’incombe <strong>la</strong><br />
morte?» (Arthur Schopenhauer, <strong>Il</strong> <strong>mondo</strong> come volontà e rappresentazione, Laterza, Bari 1991, p. 466).<br />
68
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
definire <strong>la</strong> riflessione <strong>di</strong> Michelstaedter come un ‘sistema problematico<br />
dell’esistenza’ (s’intenda problematico in senso kantiano) 74 .<br />
È proprio il concetto <strong>di</strong> problema quello su cui si deve riflettere, poiché<br />
esso pare l’unico aggettivo che possa profondamente qualificare in sin<strong>tesi</strong> <strong>la</strong><br />
profon<strong>di</strong>tà e <strong>la</strong> genuinità del sentimento <strong>di</strong> Michelstaedter. Molti critici<br />
dell’Autore hanno infatti sostenuto che il suo suici<strong>di</strong>o non è legato al<strong>la</strong> visione<br />
che struttura <strong>la</strong> filosofia del<strong>la</strong> persuasione 75 ; ma questo è, a mio avviso, veritiero<br />
so<strong>la</strong>mente in parte. È proprio il bisogno, il desiderio che Michelstaedter aveva <strong>di</strong><br />
possedere <strong>la</strong> sua vita singo<strong>la</strong> ed irripetibile che lo fece in<strong>di</strong>rizzare, passo dopo<br />
passo, verso l’emendamento del<strong>la</strong> vita, del<strong>la</strong> volontà, del desiderio e del<strong>la</strong><br />
necessità stesse, tant’è vero che il suo gesto estremo si compì subito dopo un<br />
litigio con <strong>la</strong> madre, nel giorno del compleanno del<strong>la</strong> medesima, e subito dopo <strong>la</strong><br />
conclusione delle Appen<strong>di</strong>ci Critiche del<strong>la</strong> <strong>tesi</strong>. Sembra, così, corretto <strong>di</strong>re che in<br />
questo caso «il suici<strong>di</strong>o (sia) il modo perfetto <strong>di</strong> <strong>di</strong>mostrare <strong>la</strong> propria<br />
in<strong>di</strong>pendenza» 76 , dove in<strong>di</strong>pendenza si legga come maturata persuasione.<br />
Probabilmente era totalmente maturo per <strong>la</strong> decisione:<br />
Non chieder più nul<strong>la</strong>,<br />
sappi goder del tuo stesso dolore,<br />
non adattarti per fuggir <strong>la</strong> morte;<br />
anzi da te <strong>la</strong> vita nel deserto<br />
74 I. Kant par<strong>la</strong> <strong>di</strong> concetto problematico in riferimento al noumeno, limite del<strong>la</strong> conoscenza umana: esso<br />
è un concetto a cui non si può assegnare un oggetto del<strong>la</strong> nostra intuizione. In definitiva il senso <strong>di</strong> tale<br />
concetto è che esso è inconoscibile teoreticamente, ed esperibile solo moralmente. L’aggettivo<br />
‘problematico’ si inserisce in un contesto teoretico in cui egli descrive <strong>la</strong> impossibilità del<strong>la</strong> sua totale<br />
applicazione o totale eliminazione: è in<strong>di</strong>spensabile ed irrisolvibile al medesimo tempo. Vedasi I. Kant,<br />
Critica del<strong>la</strong> ragion pura, Laterza, Bari 1996, p. 228.<br />
75 Vedasi Maddalena Dal<strong>la</strong> Mura, in Itinerari, op. cit. pp. 28-36.<br />
76 F. Nietzsche, Sammelsurium, E<strong>di</strong>zioni Quid, Santa Marinel<strong>la</strong> (Rm) 1993, p. 15.<br />
69
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
fatti – che sia per gli altri nuova vita;<br />
non <strong>di</strong>sperare, ma rinuncia ai vani<br />
aspetti del<strong>la</strong> vita, e nel deserto<br />
sarai tranquillo: dal<strong>la</strong> tua rinuncia<br />
rifulgerà il tuo atto vittorioso,<br />
ΑΡΓΙΑ sarà il tuo posto ΔΙ’ΕΝΕΡΓΗΕΙΑΣ (PO 93).<br />
Queste sono le parole che Michelstaedter fa recitare al<strong>la</strong> dea Senia (<strong>la</strong> ‘straniera’)<br />
nel<strong>la</strong> composizione intito<strong>la</strong>ta appunto A Senia, redatta poco meno <strong>di</strong> un mese<br />
prima del suici<strong>di</strong>o. L’ideale del<strong>la</strong> persona persuasa che si evince dal<strong>la</strong> lettura<br />
compare ancora più forte ed eloquente nel<strong>la</strong> parte finale del<strong>la</strong> poesia intito<strong>la</strong>ta<br />
‘Onda per onda batte sullo scoglio’, che recita:<br />
Al mio sole, al mio mar per queste strade<br />
del<strong>la</strong> terra o del mar mi volgo invano,<br />
vana è <strong>la</strong> pena e vana <strong>la</strong> speranza,<br />
tutta è <strong>la</strong> vita arida e deserta,<br />
finché in un punto si raccolga in porto,<br />
<strong>di</strong> se stessa in un punto faccia fiamma (PO 74).<br />
Si avverte in un certo senso una specie <strong>di</strong> recupero del<strong>la</strong> <strong>di</strong>mensione religiosa nel<br />
suo più profondo significato; infatti <strong>la</strong> potenza dello spessore religioso viene<br />
raggiunta nel capo<strong>la</strong>voro poetico de<strong>di</strong>cato ai due Figli del mare Itti e Senia, dove<br />
Itti è appunto rappresentazione del Pesce simbolo del Cristo e del suo venerabile<br />
insegnamento (dall’Autore il Cristo era reputato uno dei più gran<strong>di</strong> persuasi del<strong>la</strong><br />
storia umanità 77 , ed il suo insegnamento era realizzabile non seguendolo, ma<br />
accostandosi al<strong>la</strong> sua persona e al<strong>la</strong> sua condotta. Non è rilevante ascoltare e<br />
copiare il maestro, ma ascoltare e rivivere il maestro medesimo: «Cristo ha<br />
77 Dice inoltre l’Autore: «Cristo è certo un ottimista, poiché visse finché ebbe fede, ma <strong>di</strong> fronte al<strong>la</strong><br />
adattabilità giudaica, non solo, ma <strong>di</strong> fronte al<strong>la</strong> serenità mondana del<strong>la</strong> vita c<strong>la</strong>ssica, Cristo è pessimista»<br />
(Op 825).<br />
70
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
salvato se stesso poiché dal<strong>la</strong> sua vita mortale ha saputo creare il <strong>di</strong>o: l’in<strong>di</strong>viduo;<br />
ma nessuno è salvato da lui che non segua <strong>la</strong> sua vita: ma seguire non è imitare,<br />
mettersi col proprio qualunque valore nei mo<strong>di</strong> nelle parole del<strong>la</strong> via del<strong>la</strong><br />
persuasione, col<strong>la</strong> speranza d’aver in quel<strong>la</strong> <strong>la</strong> verità» PeR 104), il simbolo<br />
rinnovato del<strong>la</strong> possibilità <strong>di</strong> poter salvare se stessi, mentre Senia osserva <strong>la</strong> vita<br />
e sostiene <strong>di</strong> voler morire:<br />
Senia, il porto è <strong>la</strong> furia del mare,<br />
è <strong>la</strong> furia nel nembo più forte,<br />
quando libera ride <strong>la</strong> morte<br />
a chi libero <strong>la</strong> sfidò (Po 84).<br />
La morte libera da ogni presunzione, da ogni patologia filopsichica, da ogni<br />
necessità: ma essa resta sempre e comunque cessazione del<strong>la</strong> vita.<br />
Uscire dal <strong>mondo</strong> senza conoscere <strong>la</strong> morte così come vivesti senza conoscere <strong>la</strong><br />
vita – ed è giusto. – pronuncia Rico, uno dei due protagonisti – Poiché <strong>la</strong> morte è<br />
detta solo in riguardo al<strong>la</strong> vita. – La vita è il bisogno – <strong>la</strong> morte <strong>la</strong> negazione del<br />
bisogno. Chi muore come tu <strong>di</strong>ci vuole ancora ingannar il destino con un calcolo –<br />
ma inganna se stesso. – Poiché <strong>la</strong> morte <strong>di</strong> fronte al<strong>la</strong> domanda non risponde con<br />
una realtà libera dal bisogno – ma con l’incoscienza. – La morte appare<br />
desiderabile a chi vive, soltanto perché gli appare come coscienza senza bisogno<br />
(DDS 74).<br />
Per questo, probabilmente, molti critici hanno voluto intendere <strong>la</strong> sua morte come<br />
eccesso del<strong>la</strong> ricerca del<strong>la</strong> persuasione, perché con essa nessuna essenza del<strong>la</strong><br />
vita è rinvenibile, e dunque nessuna esistenza persuasa. In effetti Michelstaedter<br />
propone una filosofia assolutamente irrealizzabile, auto<strong>di</strong>struttiva nel<strong>la</strong> ricerca<br />
del<strong>la</strong> completezza, che lo porta a formu<strong>la</strong>re un’espressione tanto drastica quanto<br />
71
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
tragica (come ripercussione ra<strong>di</strong>cale del pensiero sul<strong>la</strong> condotta <strong>di</strong> vita vissuta):<br />
«Nel<strong>la</strong> vita c’è <strong>la</strong> necessità del<strong>la</strong> morte» (Op 819).<br />
Si può, inoltre, giungere al<strong>la</strong> conclusione che «il suo pensiero fondamentale<br />
in<strong>di</strong>ca <strong>la</strong> duplicità incomponibile» 78 fra <strong>la</strong> rettorica e l’attività impossibile del<strong>la</strong><br />
persuasione. <strong>Il</strong> pensiero dell’Autore tende ad esprimere il concetto che il picco<br />
massimo del<strong>la</strong> vita vissuta si riduca ad un punto:<br />
poiché il <strong>mondo</strong> non è che il mio <strong>mondo</strong> e se lo posseggo ho me stesso. “Reagisci<br />
al bisogno d’affermare l’in<strong>di</strong>vidualità illusoria, abbi l’onestà <strong>di</strong> negare <strong>la</strong> tua stessa<br />
violenza, il coraggio <strong>di</strong> vivere tutto il dolore del<strong>la</strong> tua insufficienza in ogni punto –<br />
per giungere ad affermare <strong>la</strong> persona che ha in sé <strong>la</strong> ragione, per comunicare il<br />
valore in<strong>di</strong>viduale : ed esser in uno persuaso tu e il <strong>mondo</strong>” 79 (PeR 85).<br />
Lo ‘s<strong>la</strong>ncio dell’essere’ verso <strong>la</strong> sua autenticità è assoluto, e <strong>la</strong> sensibilità che lo<br />
accompagna è quasi clinicamente insostenibile: non si può reggere, sembra, <strong>la</strong><br />
violenza del<strong>la</strong> potenza verso <strong>la</strong> <strong>di</strong>mensione dell’unità assoluta, ma <strong>la</strong> persuasione<br />
è <strong>la</strong> so<strong>la</strong> strada che possa salvarci dal<strong>la</strong> morte nel<strong>la</strong> vita, dal<strong>la</strong> retorica. Cade qui a<br />
pennello <strong>la</strong> riflessione sul<strong>la</strong> in<strong>di</strong>vidualità come identità, che viene espressa<br />
dall’Autore nel modo seguente: «Dunque identità equivale a ‘unità’ e presuppone<br />
<strong>la</strong> liberazione da ogni determinazione: unica – libera – essenza dello spirito<br />
assoluto» (Op 819).<br />
Pare che Michelstaedter segua quasi una legge fisica legata all’impeto ed<br />
al culmine del<strong>la</strong> potenza dell’energia: non è un caso, credo, che egli affermi che<br />
si deve passare dall’attività (energia) all’inerzia (argia) se si rincorre <strong>la</strong><br />
78 G. Brianese, L’arco e il destino, cit., p. 17.<br />
79 Michelstaedter in questo brano cita le parole dell’Oracolo <strong>di</strong> Delfo (vedasi PeR 200).<br />
72
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
persuasione. Si potrebbe continuare, citando ancora Weininger, osservando che<br />
movimento e staticità si armonizzano in uno stato unitario: «spiritismo e<br />
materialismo sono una cosa so<strong>la</strong>, e due <strong>di</strong>verse fasi attraversate successivamente<br />
dal<strong>la</strong> stessa persona. Ciò che è spirituale perderebbe tutta <strong>la</strong> sua <strong>di</strong>gnità se si<br />
materializzasse» 80 , ove per spiritismo 81 si può intendere <strong>la</strong> manifestazione del<strong>la</strong><br />
potenza dell’essere (<strong>la</strong> staticità perfetta e compiuta), e per materialismo <strong>la</strong> sua<br />
fenomenologia (il movimento, l’azione transitoria).<br />
La spinta potentissima del<strong>la</strong> vita che improvvisamente si risveglia,<br />
dell’energia repentina dell’essere che rivuole <strong>la</strong> sua primor<strong>di</strong>ale unità perfetta<br />
sfocia in un turbine dal<strong>la</strong> forza <strong>di</strong>rompente, tanto che sopportar<strong>la</strong> è praticamente<br />
impossibile: <strong>la</strong> morte coglie colui che ha raggiunto <strong>la</strong> cuspide dell’attività, non<br />
colui che si spegne poco a poco: «La massima ενεργεια crea l’αργια» (Op 786).<br />
Come precedentemente ricordato, <strong>la</strong> via al<strong>la</strong> persuasione non è in verità un<br />
processo, una iniziazione misterica, una graduale educazione da impartire al<br />
neofita, ma è una specie <strong>di</strong> folgorazione, una grazia inattesa ma intuita in<br />
sottofondo.<br />
Questo è proprio il motivo per cui il compimento massimo del<strong>la</strong> vita<br />
persuasa sta proprio nell’annul<strong>la</strong>mento del<strong>la</strong> vita: perché essa non è attuabile<br />
essenzialmente nel<strong>la</strong> vita dei fatti e degli eventi. Questo atteggiamento filosofico<br />
ed esistenzialistico è straor<strong>di</strong>nariamente paradossale, poiché è assolutamente<br />
irrisolvibile: il vivo muore, mentre colui che vive nel<strong>la</strong> vana ricerca del<br />
80 Otto Weininger, Delle cose ultime, cit., p. 107.<br />
81 «Un posto speciale è occupato, infine, dal<strong>la</strong> teosofia e dallo spiritismo» (A. Cavaglion , in Dialoghi<br />
intorno a Michelstaedter, cit., p. 77).<br />
73
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
sod<strong>di</strong>sfacimento è ben morto, tanto che lo s<strong>la</strong>ncio garantito dal dono <strong>di</strong>vino del<strong>la</strong><br />
persuasione obbliga il persuaso allo spegnimento imme<strong>di</strong>ato del<strong>la</strong> realtà.<br />
La potenza inarrestabile dell’essere che risveglia all’improvviso <strong>la</strong><br />
coscienza conduce il persuaso al parossismo del<strong>la</strong> pienezza del<strong>la</strong> vita, tanto che<br />
non può tollerarne <strong>la</strong> foga investitrice: <strong>la</strong> morte è <strong>la</strong> conseguente ed unica<br />
soluzione: «La volontà d’un possesso vero è insieme volontà <strong>di</strong> libertà:<br />
l’ερο? p<strong>la</strong>tonico; e <strong>la</strong> re<strong>la</strong>zione <strong>di</strong> possesso sarebbe <strong>la</strong> φιλια <strong>di</strong> due anime nude<br />
nell’assoluto» (Op 819).<br />
Non può essere ammesso in alcun modo, nel pensiero michelstaedteriano,<br />
il concetto <strong>di</strong> affievolimento del<strong>la</strong> vita persuasa: questo tipo <strong>di</strong> vita è sempre<br />
ontologicamente al massimo livello, altrimenti non sarebbe qualificata come<br />
persuasa. La vita che si spegne passo dopo passo, giorno dopo giorno è soltanto<br />
quel<strong>la</strong> dell’uomo prigioniero del<strong>la</strong> retorica, ingabbiato in una trama falsificatrice,<br />
prodotta dal<strong>la</strong> realtà dualistica e convenzionale, inficiata dal coma profondo del<strong>la</strong><br />
coscienza che tenta d’ignorare <strong>la</strong> sua provenienza e <strong>la</strong> sua destinazione <strong>di</strong> ritorno.<br />
74
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
X<br />
SUL DUALISMO INSANABILE DELLA VITA<br />
Così Michelstaedter fa par<strong>la</strong>re l’uomo (persuaso) nel Dialogo fra <strong>la</strong> fol<strong>la</strong>,<br />
l’uomo e il singolo: «Diritto ha colui che vive; quello che afferma il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong><br />
vivere – non vive ancora e non ha alcun <strong>di</strong>ritto» (DDS 127). L’uomo sociale e<br />
scientifico reputa <strong>di</strong> possedere le cose in generale, si sente potente su <strong>di</strong> esse, ma<br />
così non può essere. Ricordando che il possesso primario è il possesso <strong>di</strong> se<br />
stessi, l’uomo retorico è illuso e prepotente perché sa che non si possiede, ma lo<br />
pretende: così le cose che lui pensa <strong>di</strong> possedere in realtà possiedono lui<br />
medesimo.<br />
<strong>Il</strong> rettorico è in balia <strong>di</strong> fatti, cose ed eventi, ed è ovviamente preda <strong>di</strong> tutti<br />
gli altri retori, che singo<strong>la</strong>rmente si comportano come lui: da qui sorge <strong>la</strong><br />
vergogna del<strong>la</strong> corre<strong>la</strong>zione delle coscienze che oblia tutto l’essere del<strong>la</strong><br />
singo<strong>la</strong>rità dell’in<strong>di</strong>viduo:<br />
Dunque le singole passioni sod<strong>di</strong>sfatte non danno mai un possesso: l’uomo che<br />
sfoga le passioni si determina in uno o nell’altro modo, entra in una ‘re<strong>la</strong>zione’<br />
verso una cosa, non l’‘ha’ […] Ogni cosa è dominatrice e schiava, possiede ed è<br />
posseduta, nel tempo stesso. L’universale ‘corre<strong>la</strong>zione’ è fatta dalle vicendevoli<br />
negazioni delle in<strong>di</strong>vidualità determinate e del loro vicendevole possesso (Op 819).<br />
75
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
Lo stato sociale <strong>di</strong> coscienze corre<strong>la</strong>te determina l’aspetto assolutamente<br />
dualistico del<strong>la</strong> realtà del<strong>la</strong> vita retorica: l’uomo viene così scisso in se medesimo<br />
ed altro-da-sé, non è capace <strong>di</strong> raccogliere in sé <strong>la</strong> sua vita:<br />
Possesso è identità: tanto posso possedere quanto vengo posseduto: cioè: il<br />
possesso non è in me né nel corre<strong>la</strong>tivo, ma nel principio che determina <strong>la</strong> nostra<br />
vicendevole re<strong>la</strong>zione […] Ma l’uomo riposa nel<strong>la</strong> ‘coscienza’ dell’‘io’ e gode<br />
nel<strong>la</strong> re<strong>la</strong>zione presente <strong>la</strong> potenzialità delle re<strong>la</strong>zioni future (Op 816-817).<br />
Questo gretto destino colpisce senza scampo tutti i membri del<strong>la</strong> farraginosa<br />
società, in cui <strong>la</strong> corre<strong>la</strong>zione delle coscienze si rive<strong>la</strong> null’altro che un innato<br />
accordo convenuto, al fine <strong>di</strong> poter mantenere un certo or<strong>di</strong>namento strutturale.<br />
La sua essenziale incapacità <strong>di</strong> fornire al singolo <strong>la</strong> propria autenticità fa del<strong>la</strong><br />
comunità rettorica uno scoglio ben arduo da superare.<br />
Sembra appropriato aggiungere che se «comprendere totalmente un uomo<br />
vuol <strong>di</strong>re superarlo» 82 , allora Michelstaedter ha colto perfettamente nel segno: <strong>la</strong><br />
sua ricerca filosofico-sociale è complessivamente volta al<strong>la</strong> <strong>di</strong>sassuefazione dal<strong>la</strong><br />
banalità e dall’impersonalità, dal<strong>la</strong> falsità e dall’illusione. Ma il dualismo del<strong>la</strong><br />
vita pende in<strong>di</strong>scutibilmente dal<strong>la</strong> parte del<strong>la</strong> rettorica, poiché essa rimane<br />
inaggirabile, insuperabile se non nel momento folgorante che sta sul limite fra<br />
vita e morte: il retore (uomo comune e qualunque) è incapace <strong>di</strong> arrestare il<br />
flusso del <strong>di</strong>venire dei fenomeni, poiché intriso <strong>di</strong> abitu<strong>di</strong>ne. <strong>Il</strong> retore trascorre il<br />
suo tempo spazializzato ad inseguire gli eventi, tentando <strong>di</strong> crearli e <strong>di</strong>sporli a<br />
proprio piacere, senza rendersi conto che tutto il suo operato è guidato<br />
82 Otto Weininger, Delle cose ultime, cit., p. 107.<br />
76
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
dall’illusione, senza accorgersi che non potrà essere salvato dall’angoscia che<br />
patisce. Soltanto il contatto con <strong>la</strong> totalità dell’essere, p<strong>la</strong>usibilmente<br />
riscontrabile nel punto critico del momento del<strong>la</strong> morte, può trasformare <strong>la</strong><br />
rettorica in persuasione, agendo istantaneamente. Soltanto in quell’attimo il<br />
retore riconosce <strong>la</strong> potenza <strong>di</strong> quel<strong>la</strong> persuasione che nel<strong>la</strong> vita abituale ha<br />
sempre ignorato.<br />
Non troviamo, comunque, in Michelstaedter, un’analisi esistenziale<br />
analoga a quel<strong>la</strong> esaminata dallo scrittore francese Albert Camus, perché <strong>la</strong> morte<br />
per l’Autore ha quasi <strong>la</strong> caratteristica dell’imprimatur. Per Camus, altrimenti, <strong>la</strong><br />
vita era il riconoscimento del fatto che siamo scaraventati nell’esistenza<br />
coscienziale e cosciente da un destino che vuole punirci per una qualche colpa:<br />
noi stiamo nel ‘qui ed ora’, e non possiamo sottrarci al<strong>la</strong> nostra vanagloriosa vita<br />
perché non dobbiamo essere impotenti 83 . È scopo dell’uomo, secondo Camus,<br />
riconoscere <strong>la</strong> vanità e <strong>la</strong> vacuità dei rime<strong>di</strong> propinati al fine <strong>di</strong> trovare <strong>la</strong><br />
salvezza, <strong>la</strong> presunzione del<strong>la</strong> giustificazione del<strong>la</strong> propria condotta: non c’è<br />
salvezza, ma c’è un fortissimo sentimento dell’assurdo che governa <strong>la</strong> vita <strong>di</strong> chi<br />
si accorge del<strong>la</strong> vita stessa. <strong>Il</strong> ‘persuaso’ camusiano è l’uomo che prende<br />
coscienza del suo cammino in una specie <strong>di</strong> inferno reale, tangibile, da cui<br />
comunque non può scappare, perché deve lottare (anche se sa <strong>di</strong> non avere<br />
possibilità <strong>di</strong> vittoria): <strong>la</strong> vita deve continuare.<br />
83 «Al meriggio del pensiero, l’uomo in rivolta rifiuta così <strong>la</strong> <strong>di</strong>vinità per con<strong>di</strong>videre le lotte e <strong>la</strong> sorte<br />
comune. Sceglieremo Itaca, <strong>la</strong> terra fedele, il pensiero audace e frugale, l’azione lucida, <strong>la</strong> generosità<br />
dell’uomo che sa. Nel<strong>la</strong> luce, il <strong>mondo</strong> resta il nostro primo e ultimo amore» (A. Camus, L’uomo in<br />
rivolta, Bompiani, Mi<strong>la</strong>no 1998, p. 334. All’interno del<strong>la</strong> stessa opera vedasi inoltre il capitolo “<strong>Il</strong> rifiuto<br />
del<strong>la</strong> salvezza”, pp. 65-73).<br />
77
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
Michelstaedter, abbiamo sin qui visto, <strong>la</strong> pensava in maniera ra<strong>di</strong>calmente<br />
<strong>di</strong>fferente, poiché il suo persuaso si accorge per una specie <strong>di</strong> folgorazione<br />
(grazie al<strong>la</strong> concessione inattesa del dono) del risveglio del<strong>la</strong> coscienza, e non<br />
può sopportare <strong>la</strong> potenza assoluta e <strong>di</strong>rompente dell’essere per molto tempo: il<br />
momento del<strong>la</strong> totale immersione nel<strong>la</strong> completezza dell’essere, nell’unità<br />
estatica, nell’autenticità del sé coincide senza rime<strong>di</strong>o con il termine del<strong>la</strong> vita<br />
stessa: «L’uomo è il nucleo in<strong>di</strong>viduale più vasto, in lui <strong>la</strong> materia (tutto il tempo<br />
e tutto lo spazio) vede se stessa […] <strong>Il</strong> <strong>di</strong>alogo dell’anima con se stessa ‘enuclea’<br />
tutto quanto si può conoscere» (Op 808).<br />
Pare quasi che Michelstaedter voglia in definitiva comunicarci che il<br />
segreto del<strong>la</strong> vita, il raggiungimento dell’inarrivabile profon<strong>di</strong>tà dell’essere, sta<br />
in un punto a<strong>di</strong>mensionale, un momento ineffabile. Per tale motivo, credo che si<br />
possa intendere questo istante <strong>di</strong>vino e mistico come quel punto che nel<strong>la</strong> fisica<br />
matematica raccoglie e fonde ogni <strong>di</strong>mensione: il punto <strong>di</strong> singo<strong>la</strong>rità 84 , dove le<br />
tre <strong>di</strong>mensioni, le forze conosciute e <strong>la</strong> struttura informata sullo spazio-tempo<br />
non hanno più valore corrente. A tale proposito, critici come Giorgio Brianese<br />
hanno voluto considerare l’interpretazione persuasa del<strong>la</strong> vita al<strong>la</strong> stregua <strong>di</strong> un<br />
ribaltamento del suo <strong>la</strong>to rettorico, cosicché per Brianese, ad esempio, <strong>la</strong> rettorica<br />
è una fortissima negazione del<strong>la</strong> vita a causa <strong>di</strong> una violenza verso <strong>di</strong> essa: tale<br />
concetto si è ben visto essere pienamente considerato da Michelstaedter.<br />
84 In matematica si <strong>di</strong>ce singo<strong>la</strong>re un punto, una funzione o un altro ente matematico che abbia un<br />
comportamento genericamente autonomo il termine viene anche usato per in<strong>di</strong>care un comportamento<br />
matematico anomalo, ma pur sempre riconducibile ad una funzione.<br />
78
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
Ma le <strong>di</strong>scordanze iniziano quando l’interpretazione <strong>di</strong> Brianese si spinge ad<br />
asserire che anche <strong>la</strong> persuasione è una forma <strong>di</strong> negazione del<strong>la</strong> vita dovuta al<strong>la</strong><br />
violenza:<br />
anche <strong>la</strong> persuasione è una forma <strong>di</strong> dominio; anzi, <strong>la</strong> forma <strong>di</strong> dominio<br />
massimamente efficace che, mettendo in gioco <strong>la</strong> totalità stessa, è in grado <strong>di</strong> non<br />
par<strong>la</strong>re più <strong>di</strong> violenza solo nel<strong>la</strong> misura in cui ha già violentato <strong>la</strong> totalità del<br />
violentabile, non <strong>la</strong>sciando sussistere più nul<strong>la</strong> oltre <strong>la</strong> propria affermazione<br />
totalizzante. <strong>Il</strong> persuaso non partecipa più al<strong>la</strong> lotta fra le determinazioni solo<br />
perché è rimasto l’unico a potersi affermare, ambizione sod<strong>di</strong>sfatta <strong>di</strong> assoluta<br />
potenza 85 .<br />
Brianese sembra dunque essere estremamente convinto del fatto che un vero<br />
superamento del<strong>la</strong> illusione e del<strong>la</strong> falsità del<strong>la</strong> vita inautentica non sia mai<br />
effettivamente realizzabile.<br />
Reputo che questo sia vero so<strong>la</strong>mente in parte, mentre sembra più<br />
evidente, al contrario, che dalle parole dell’Autore si possa evincere una<br />
fortissima convinzione del<strong>la</strong> realizzazione del momento del<strong>la</strong> persuasione. Va<br />
rilevato, però, che tale momento è perseguibile esclusivamente superando <strong>la</strong><br />
propria coscienza del<strong>la</strong> società e soltanto nell’attimo che separa <strong>la</strong> vita dal<strong>la</strong><br />
morte. Non è caso, pertanto, che per Michelstaedter <strong>la</strong> vita rettorica sia quel<strong>la</strong><br />
del<strong>la</strong> volontà e del<strong>la</strong> continuazione obbligata, mentre quel<strong>la</strong> persuasa sia il<br />
momento del<strong>la</strong> ‘fiamma’ che deve ardere tutta se stessa in un istante 86 . La<br />
possibilità <strong>di</strong> cogliere <strong>la</strong> vera essenza del<strong>la</strong> vita è un prezioso dono, e per goderlo<br />
85 G. Brianese, L’arco e il destino, cit., p. 37.<br />
86 «È il coraggio <strong>di</strong> vivere senza nul<strong>la</strong> sperare, senza nul<strong>la</strong> attendersi […] Così soltanto l’oscurità si fende<br />
in una scia luminosa» [Mario Gabriele Giordano, “<strong>Il</strong> pensiero e l’arte <strong>di</strong> Michelstaedter”, in Riscontri n°4<br />
(rivista trimestrale <strong>di</strong> cultura ed attualità), Sabatia, Avellino 1979, p. 19].<br />
79
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
l’uomo deve rinunciare al<strong>la</strong> sua esistenza, «venire a ferri corti col<strong>la</strong> propria vita<br />
(filopsichia)» (DDS 85).<br />
Comunque, si tenga sempre ben presente il fatto che «l’Autore […]<br />
respinge l’idea del suici<strong>di</strong>o come rime<strong>di</strong>o estremo per questa tragica con<strong>di</strong>zione<br />
dell’uomo» 87 , ed il togliersi <strong>la</strong> vita viene considerato un gesto affine al<strong>la</strong><br />
rettorica, tanto più che Michelstaedter riba<strong>di</strong>sce sovente, come detto, che <strong>la</strong><br />
persuasione è <strong>la</strong> vera autentica vita, e per meritarsi questa qualifica <strong>la</strong> vita deve<br />
incontrare <strong>la</strong> morte, entrando in connubio con essa:<br />
Poiché questo ‘io’ <strong>di</strong>vino è il nostro ‘io’ vivente nel<strong>la</strong> sua esistenza libera e<br />
assoluta, verso il quale ten<strong>di</strong>amo e <strong>di</strong> fronte al quale sentiamo <strong>la</strong> nullità del<strong>la</strong> nostra<br />
vita re<strong>la</strong>tiva e che sappiamo <strong>di</strong> non poter raggiungere che nel momento che<br />
rinunciamo al nostro ‘io’ nell’annul<strong>la</strong>mento del<strong>la</strong> nostra vita (Op 829).<br />
Esclusivamente in questo senso si può affermare con Brianese che <strong>la</strong> persuasione sia<br />
una negazione del<strong>la</strong> vita, ma non si può asserire che persuasione e rettorica neghino<br />
entrambe <strong>la</strong> pulsione vitale allo stesso grado sebbene da due prospettive <strong>di</strong>ametralmente<br />
opposte. Questo perché non c’è alcun <strong>di</strong>ametro separatore: <strong>la</strong> retorica è un modus<br />
viven<strong>di</strong> che inficia <strong>di</strong> morte l’uomo e <strong>la</strong> sua in<strong>di</strong>vidualità, mentre <strong>la</strong> persuasione è<br />
l’attimo fuggente del<strong>la</strong> grazia, l’istante fulmineo dell’assolutezza del<strong>la</strong> conoscenza (che<br />
si identifica con <strong>la</strong> morte): «Non è più innanzi a noi una determinata forma ma un fluire<br />
d’atomi» (DDS 50). Dunque, mi sembra evidente che si possa davvero essere persuasi,<br />
ma so<strong>la</strong>mente nello spazio limitato <strong>di</strong> un istante: l’istante che precede appena <strong>la</strong> morte.<br />
87 Mario G. Giordano, ivi, pp. 18-20.<br />
80
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
XI<br />
SULL’INEVITABILE DESTINO DELL’UOMO<br />
L’uomo che vive per il futuro perde se stesso: bisogna <strong>la</strong>sciare le lusinghe<br />
del futuro per de<strong>di</strong>carsi al tempo del<strong>la</strong> persuasione, il presente. <strong>Il</strong> futuro è <strong>la</strong><br />
morte, e lo si avverte nell’ultimo presente del<strong>la</strong> vita: <strong>la</strong> morte, meta sicura del<strong>la</strong><br />
sorte, ci perseguita ben prima del suo effetto cosicché l’uomo si trova, esistente,<br />
a temere sempre <strong>la</strong> morte. Non è dunque il passato (con il suo apparato <strong>di</strong><br />
tra<strong>di</strong>zioni) a rendere meccanico l’agire umano, ma il futuro, che a seconda delle<br />
società e dei perio<strong>di</strong> storici calza vesti <strong>di</strong>verse guidate dal medesimo sentimento:<br />
il timore inelu<strong>di</strong>bile del<strong>la</strong> morte.<br />
È molto chiaro che non si può trascinarsi in questa vita retorica secondo i<br />
‘dettami’ del<strong>la</strong> persuasione:<br />
ma ognuno deve trovarsi <strong>la</strong> via da sé, – e da sé batter<strong>la</strong> passo per passo – ché non ci<br />
sono né carte né mezzi <strong>di</strong> trasporto; chi non sente <strong>di</strong> dover<strong>la</strong>, <strong>di</strong> saper<strong>la</strong>, <strong>di</strong> voler<strong>la</strong><br />
fare, non è buono a far<strong>la</strong> e in vano spera l’aiuto altrui, invano altri vorrebbe aiutarlo<br />
– <strong>la</strong> può batter colui che già è sano – e <strong>la</strong> salute è un dono <strong>di</strong> Dio […] Allora<br />
convien guardar in faccia <strong>la</strong> morte e sopportar con gli occhi aperti l’oscurità e<br />
scender nell’abisso del<strong>la</strong> propria insufficienza: venire a ferri corti con <strong>la</strong> propria<br />
vita (DDS 94 e 84).<br />
L’esistenza del persuaso, nel<strong>la</strong> sua <strong>di</strong>mensione atemporale <strong>di</strong> ultimo presente,<br />
non può definirsi come un continuo perpetuarsi nell’ultimo presente, poiché<br />
81
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
assumerebbe inequivocabilmente i connotati del<strong>la</strong> continuazione del<strong>la</strong> vita<br />
retorica. La persuasione non <strong>la</strong>scia scampo tanto quanto <strong>la</strong> retorica, e su questo<br />
aveva strutturalmente visto bene Brianese, ma <strong>la</strong> retorica si muove nello spazio<br />
del<strong>la</strong> continuazione del tempo, mentre il soggetto del<strong>la</strong> persuasione «si contrae in<br />
un punto inesteso e resta <strong>la</strong> realtà ad esso coor<strong>di</strong>nata» 88 : esso non può che<br />
consumare in un istante tutto l’olio del<strong>la</strong> <strong>la</strong>mpada.<br />
La vita sarebbe una, immobile, informe se potesse consistere in un punto. La<br />
necessità del<strong>la</strong> fuga nel tempo implica <strong>la</strong> necessità del<strong>la</strong> <strong>di</strong><strong>la</strong>tazione nello spazio: <strong>la</strong><br />
perpetua mutazione: onde l’infinita varietà delle cose (PeR 43).<br />
L’estasi momentanea del<strong>la</strong> persuasione è <strong>la</strong> totalità del <strong>mondo</strong> e del tempo: nel<strong>la</strong><br />
<strong>di</strong>mensione del<strong>la</strong> persuasione il momento è l’intera vita. Non ci sono, pertanto, in<br />
questo stato, qualitative <strong>di</strong>fferenziazioni delle esistenze e degli in<strong>di</strong>vidui: il<br />
singolo supera totalmente <strong>la</strong> sua <strong>di</strong>alettica <strong>di</strong> identità-alterità e si fonde nel<strong>la</strong><br />
perfezione dell’essere, nel<strong>la</strong> suprema sod<strong>di</strong>sfazione del<strong>la</strong> coscienza,<br />
nell’immanenza dell’autenticità del<strong>la</strong> vita ontologica. Prendendo a prestito da<br />
Goethe alcune parole, si può tranquil<strong>la</strong>mente asserire che il persuaso<br />
michelstaedteriano ha il coraggio <strong>di</strong> <strong>di</strong>re «ho tante cose in me e ciò che sento per<br />
lei <strong>di</strong>vora tutto; ho tante cose e senza <strong>di</strong> lei non ho più nul<strong>la</strong>» 89 , dove questa ‘lei’<br />
non può che essere <strong>la</strong> persuasione.<br />
Nel<strong>la</strong> lettura delle opere <strong>di</strong> Michelstaedter si delinea sempre più il quadro<br />
del<strong>la</strong> vita persuasa, ma il concetto intrinseco <strong>di</strong> persuasione resta definitivamente<br />
88 L. Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, Einau<strong>di</strong>, Torino 1998, p.90.<br />
89 J. W. Goethe, I dolori del giovane Werther, Einau<strong>di</strong> Bilingue, Torino 1998, 193.<br />
82
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
ineffabile: «La volontà dell’assoluto si riduce al<strong>la</strong> negazione <strong>di</strong> me stesso,<br />
all’αργια». Questa ra<strong>di</strong>cale ed insolvibile <strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong> offrire una definizione<br />
sistematica e scientifica del<strong>la</strong> persuasione è stata una intuizione geniale e<br />
rispettosa <strong>di</strong> Michelstaedter allo scopo <strong>di</strong> conferire <strong>la</strong> massima coerenza al<strong>la</strong> sua<br />
filosofia.<br />
Si tenga presente che, sul piano generale, l’oggettività del valore <strong>di</strong><br />
un’entità è frutto dell’atteggiamento rettorico del falso posse<strong>di</strong>mento, del<strong>la</strong><br />
inautenticità, e quin<strong>di</strong> l’espressione che rappresenta quel dato concetto<br />
scientifico-sociale è specu<strong>la</strong>re del<strong>la</strong> sua rettoricità. La persuasione, viceversa, è<br />
inesprimibile proprio perché è inesprimibile il sentimento potentissimo che<br />
alberga nell’in<strong>di</strong>viduo persuaso: <strong>la</strong> verità che si porta dentro il messaggio del<strong>la</strong><br />
persuasione scatena quello che si può descrivere come lo s<strong>la</strong>ncio dell’essere<br />
dell’esserci 90 verso <strong>la</strong> sua autenticità. «Ma esser qui non è ‘vero’ essere: ma è<br />
‘voler essere’ che per l’illusione sod<strong>di</strong>sfatta ha l’apparenza dell’essere» (Op<br />
787). Ed ancora:<br />
Mi scroscia il tuono che<br />
m’assorda… io vivo<br />
e famelico aspetto ancor <strong>la</strong> vita.<br />
Altri <strong>la</strong>mpi, altri tuoni, ed il<br />
mistero<br />
in benefica pioggia si <strong>di</strong>ssolve<br />
(Po 68).<br />
90 <strong>Il</strong> riferimento va indubbiamente al<strong>la</strong> filosofia <strong>di</strong> Martin Heidegger: «C’è verità solo perché e fin che<br />
l’Esserci è» (M. Heidegger, Essere e tempo, cit., p. 335).<br />
83
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
Michelstaedter aveva pochi amici, a cui amava ripetere che lui era comunque<br />
<strong>di</strong>verso 91 . Detto ciò, credo non si possa in alcun modo definire positivamente <strong>la</strong><br />
persuasione: è molto più facile e verosimile affermare ciò che essa non è,<br />
piuttosto che tentare <strong>di</strong> esplicare cosa essa sia essenzialmente. Inoltre lo stato del<br />
persuaso non può certo accomunarsi al rifiuto del<strong>la</strong> compassione inteso in senso<br />
schopenhaueriano. Per quest’ultimo, infatti, <strong>la</strong> compassione è un sentimento<br />
simpatetico ambivalente, perché si <strong>di</strong>mostra inadeguato al fine <strong>di</strong> una vita privata<br />
del dolore (<strong>la</strong> compassione, infatti, fa partecipe l’uomo del dolore altrui), ma è<br />
comunque una tappa spirituale/filosofica sul<strong>la</strong> via che conduce al misticismo,<br />
all’ascesi (perché inizia a spogliare l’in<strong>di</strong>viduo del<strong>la</strong> sua corazza caratteriale,<br />
logorando il principium in<strong>di</strong>viduationis). 92<br />
Questo è impossibile in Michelstaedter: <strong>la</strong> persuasione è annul<strong>la</strong>mento <strong>di</strong><br />
ogni volontà, <strong>di</strong> ogni bisogno, <strong>di</strong> ogni desiderio, al fine del raggiungimento<br />
dell’unità estatica oltre lo spazio ed il tempo del<strong>la</strong> vita, tanto che possiamo<br />
sostenere che<br />
91 In una lettera al<strong>la</strong> madre Emma, Michelstaedter scrive: «Mi sento ingiusto in questa sosta forzata, mi è<br />
amaro ogni boccone che mangio […] Tu guar<strong>di</strong> gli altri giovani che sono al caffè con le loro famiglie e<br />
pensi a me con tristezza: essi hanno vuota <strong>la</strong> vita, e l’avranno sempre vuota – e <strong>la</strong> riempiono delle<br />
preoccupazioni per <strong>la</strong> carriera data agli altri, e <strong>la</strong> riempiono <strong>di</strong> vani piaceri che <strong>la</strong>sciano loro <strong>la</strong> bocca<br />
amara; stirano <strong>la</strong> loro noia attraverso tutti gli anni e tutti i giorni del<strong>la</strong> loro vita, attraverso i loro <strong>la</strong>vori<br />
oscuri ed insensati, i loro piaceri insipi<strong>di</strong>, le loro re<strong>la</strong>zioni familiari, o <strong>di</strong> amicizia, o <strong>di</strong> patria, ottuse e<br />
vuote» (Op 619).<br />
92 Per meglio chiarire l’argomento è necessario riportare le parole <strong>di</strong> Schopenhauer: «Ogni amore (a?ap?,<br />
caritas) è compassione […] <strong>Il</strong> puro amore è, per sua natura, compassione, sia pur grande o piccolo (è tra<br />
questi ogni desiderio inappagato) il dolore ch’esso lenisce […] Egoismo è l’e???; compassione è l’a?ap?.<br />
I due si trovano spesso frammisti. Perfino <strong>la</strong> vera amicizia è sempre mesco<strong>la</strong>nza <strong>di</strong> egoismo e<br />
compassione […] Solo il guardar <strong>di</strong> là da questo (oltre il principium in<strong>di</strong>viduationis) sopprime <strong>la</strong><br />
<strong>di</strong>stinzione tra l’in<strong>di</strong>viduo nostro e gli altri, e rende possibile e spiega <strong>la</strong> perfetta bontà dell’animo, fino al<br />
più <strong>di</strong>sinteressato amore e al più generoso sacrificio <strong>di</strong> sé» (Arthur Schopenhauer, <strong>Il</strong> <strong>mondo</strong> come volontà<br />
e rappresentazione, cit., pp.490-495).<br />
84
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
per Michelstaedter <strong>la</strong> persuasione è un atto, non un processo; essa dunque non è un<br />
itinerario dell’emancipazione quale si configura in Schopenhauer l’ascesi, fino allo<br />
stato d’illuminazione 93 .<br />
Non c’è <strong>di</strong>retto riscontro, quin<strong>di</strong>, del<strong>la</strong> nolontà/volontà <strong>di</strong> Arthur Schopenhauer,<br />
se non nel principio più generale del<strong>la</strong> eliminazione assoluta del dolore umano:<br />
93 G. Carchia, Retorica del sublime, cit., p. 22.<br />
È il piacere un <strong>di</strong>o pu<strong>di</strong>co<br />
fugge da chi l’invocò;<br />
ai piaceri egli è nemico,<br />
fugge da chi lo cercò.<br />
Egli ama quei che non lo<br />
invoca,<br />
egli ama quei che non lo sa;<br />
e dona <strong>la</strong> sua luce fioca<br />
a chi per altra luce va (Po 77).<br />
85
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
XII<br />
BREVE RAFFRONTO FRA PERSUASIONE MICHELSTAEDTERIANA,<br />
ATARASSIA EPICUREA E APATIA STOICA.<br />
<strong>Il</strong> superamento del<strong>la</strong> situazione dolorosa e drammatica in cui versa <strong>la</strong> vita<br />
umana è stato oggetto <strong>di</strong> molte correnti filosofiche, fra le quali si annoverano,<br />
come più note quel<strong>la</strong> epicurea e quel<strong>la</strong> stoica.<br />
Epicuro par<strong>la</strong>va dell’atarassia come supremo traguardo da raggiungere,<br />
senza che l’uomo debba troppo preoccuparsi del<strong>la</strong> morte e <strong>di</strong> ciò che <strong>la</strong> segue, né<br />
delle <strong>di</strong>vinità che conducono <strong>la</strong> loro esistenza beata nel <strong>mondo</strong> celeste, <strong>di</strong>staccato<br />
per intero da quello umano.<br />
La paro<strong>la</strong> atarassia (in greco αταραξια) significa propriamente<br />
imperturbabilità, cioè quello stato <strong>di</strong> coscienza in cui non è possibile che si venga<br />
frastornati, grazie al grado <strong>di</strong> spiritualità e <strong>di</strong> conoscenza raggiunto, <strong>di</strong> modo che<br />
per l’epicureo questa con<strong>di</strong>zione si raggiunga con <strong>la</strong> sopportazione del dolore e <strong>la</strong><br />
ricerca del piacere. <strong>Il</strong> saggio epicureo non ha dunque un sistema troppo<br />
complesso <strong>di</strong> ricerca del bene: l’atarassia è un piacere catastematico dello spirito,<br />
che si accompagna all’aponia (απονια, il piacere catastematico del corpo). <strong>Il</strong><br />
‘Bene’ dell’epicureo è sempre identificato con il piacere, e l’etica epicurea, <strong>di</strong><br />
derivazione cirenaica, è imperniata sull’eudemonismo. La felicità consiste<br />
indubbiamente nel piacere, e, a <strong>di</strong>fferenza dei cirenaici, Epicuro sostiene che i<br />
86
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
piaceri e i dolori psichici siano superiori a quelli <strong>di</strong> natura fisica. <strong>Il</strong> piacere risulta<br />
in tale maniera essere il criterio del<strong>la</strong> scelta e dell’avversione, e <strong>la</strong> felicità<br />
«consiste soltanto nel piacere stabile o negativo, nel non soffrire e nel non<br />
agitarsi, ed è quin<strong>di</strong> definita come atarassia (assenza <strong>di</strong> turbamento) e aponia<br />
(assenza <strong>di</strong> dolore)» 94 .<br />
S’inserisce, poi, in maniera perentoria il tema del<strong>la</strong> morte, che secondo<br />
Epicuro è un male psicologico che affligge, tramite <strong>la</strong> paura e l’angoscia, <strong>la</strong> vita<br />
umana. La risoluzione del problema è semplice: essa è un male so<strong>la</strong>mente per chi<br />
nutre false opinioni su <strong>di</strong> essa, e non ne abbia una conoscenza approfon<strong>di</strong>ta. Dato<br />
che l’uomo è un ‘composto anima’ in un ‘composto corpo’, <strong>la</strong> morte risulta<br />
essere solo <strong>la</strong> <strong>di</strong>ssoluzione dei due composti, in cui gli atomi (elementi<br />
in<strong>di</strong>visibili componenti ogni entità) si <strong>di</strong>leguano per ogni dove; «<strong>la</strong> coscienza e<br />
<strong>la</strong> sensibilità cessano totalmente, e così dell’uomo non restano che macerie che si<br />
<strong>di</strong>sperdono, cioè nul<strong>la</strong>» 95 . La morte, quin<strong>di</strong> non è paurosa <strong>di</strong> per sé, perché non<br />
appena essa sopraggiunga noi non abbiamo più sentore alcuno che possa turbarci:<br />
non sentiremo più nul<strong>la</strong>, non ci sarà nessun ‘dopo’.<br />
Nello stoicismo, invece, <strong>la</strong> ricerca del<strong>la</strong> vita beata coincide con <strong>la</strong> ricerca<br />
del<strong>la</strong> vita del saggio, del sapiente, che ha evoluto ad un livello quasi <strong>di</strong>vino <strong>la</strong><br />
propria mente, guidata dal supremo Logos. <strong>Il</strong> perseguimento del<strong>la</strong> vita perfetta<br />
secondo saggezza e sapienza, perseguibile ma non conseguibile del tutto in<br />
94<br />
Cito da Nico<strong>la</strong> Abbagnano, Storia del<strong>la</strong> filosofia – La filosofia Antica, vol. 1°, Tea, Mi<strong>la</strong>no 1995, p.<br />
227.<br />
95<br />
Cito da Giovanni Reale/Dario Antiseri, <strong>Il</strong> pensiero occidentale dalle origini ad oggi vol. 1°, E<strong>di</strong>trice La<br />
Scuo<strong>la</strong>, Brescia, 1983, p. 184 .<br />
87
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
questa vita terrena, si può praticare, secondo <strong>la</strong> dottrina stoica, so<strong>la</strong>mente<br />
emendando il proprio spirito da tutte le passioni e da ogni prospettiva soggettiva,<br />
tendendo al conseguimento dell’apatia. Questo termine (απατηεια in greco)<br />
significa appunto ‘privazione <strong>di</strong> passioni’, ed è solo grazie a questo stato che si<br />
potrà approdare al<strong>la</strong> serenità dell’anima. La virtù è veramente l’unico bene per<br />
gli stoici, e, come per gli epicurei, lo scopo è il raggiungimento del<strong>la</strong> felicità,<br />
conducendo una vita secondo natura. Di conseguenza, il male peggiore è il vizio,<br />
opposto <strong>di</strong> quel<strong>la</strong> virtù che costituisce <strong>la</strong> realizzazione nell’uomo dell’or<strong>di</strong>ne<br />
razionale del <strong>mondo</strong>. Tutte quelle cose che invece sono re<strong>la</strong>tive al corpo (sia che<br />
gli siano benefiche, sia che possano nuocergli) sono considerate ‘in<strong>di</strong>fferenti’<br />
(a<strong>di</strong>áphora), o per meglio <strong>di</strong>re ‘in<strong>di</strong>fferenti dal<strong>la</strong> prospettiva morale’.<br />
Fa, poi, parte integrante dell’etica stoica <strong>la</strong> negazione totale del valore<br />
dell’emozione (pathos). Essa infatti non ha <strong>la</strong>cuna funzione nell’economia<br />
generale del cosmo, perché le emozioni sono reputate «vere e proprie ma<strong>la</strong>ttie<br />
che affettano lo stolto, ma da cui il sapiente è immune. La con<strong>di</strong>zione del<br />
sapiente è quin<strong>di</strong> l’in<strong>di</strong>fferenza ad ogni emozione, l’apatia» 96 . <strong>Il</strong> concetto <strong>di</strong><br />
apatia si contrappone a quello dell’atarassia epicurea perché secondo <strong>la</strong> Stoà era<br />
importantissimo che l’uomo fosse attivo ed agisse nel<strong>la</strong> ricerca del<strong>la</strong> conoscenza,<br />
mentre <strong>la</strong> dottrina del ‘giar<strong>di</strong>no’ professava <strong>la</strong> rinuncia all’agire nel <strong>mondo</strong>.<br />
L’apatia stoica serviva da metabolizzante per le passioni dell’uomo, e avrebbe<br />
liberato i singoli in<strong>di</strong>vidui dall’eccesso <strong>di</strong>sor<strong>di</strong>nato <strong>di</strong> sentimenti.<br />
96 N. Abbagnano, Storia del<strong>la</strong> filosofia, cit., p. 218.<br />
88
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
Nel<strong>la</strong> scuo<strong>la</strong> scettica, invece, questa atarassia è una conseguenza del<strong>la</strong><br />
presa <strong>di</strong> posizione secondo <strong>la</strong> sospensione del giu<strong>di</strong>zio (epoché). Visto e<br />
considerato, affermano gli scettici, che non è possibile avere una reale e profonda<br />
conoscenza <strong>di</strong> tutto ciò che ci circonda e presumiamo ci riguar<strong>di</strong>, allora <strong>la</strong><br />
situazione migliore per l’uomo è l’atarassia come sospensione completa del<br />
proprio giu<strong>di</strong>zio in senso generale. La tranquillità <strong>di</strong> spirito, in cui consiste <strong>la</strong><br />
felicità, si raggiunge secondo gli scettici, non già affiliandosi ad una qualche<br />
scuo<strong>la</strong> <strong>di</strong> pensiero, ma rifiutando qualsiasi dottrina. L’indagine (skepsis) è il solo<br />
ed unico mezzo per giungere a questo rifiuto, e quin<strong>di</strong> all’atarassia.<br />
Ritornando a Michelstaedter, si può <strong>di</strong>re che <strong>la</strong> sua persuasione non sia<br />
paragonabile a nessuna delle tre suddette opzioni del<strong>la</strong> filosofia dell’antica<br />
Grecia, ma che attinga ecletticamente qualche elemento da ciascuna <strong>di</strong> esse. La<br />
sua <strong>tesi</strong> <strong>di</strong> <strong>la</strong>urea prende avvio dallo stu<strong>di</strong>o del<strong>la</strong> filosofia p<strong>la</strong>tonica e aristotelica.<br />
Per il concetto <strong>di</strong> persuasione egli attinge dal pensiero <strong>di</strong> Epicuro l’idea che gli<br />
dei non abbiano alcun tipo <strong>di</strong> rapporto con l’uomo e l’umanità. Infatti, nel<strong>la</strong><br />
filosofia dell’Autore non si trovano tracce <strong>di</strong> implicazione religiosa <strong>di</strong> carattere<br />
dottrinale o fideistico; anzi, una pesante accusa che egli rivolge all’uomo<br />
rettorico è quel<strong>la</strong> <strong>di</strong> fare troppo affidamento sul<strong>la</strong> voce rasserenante del proprio<br />
<strong>di</strong>o. Quest’ultimo funge da voce del<strong>la</strong> coscienza, che giustifica <strong>la</strong> maggior parte<br />
delle azioni compiute in nome <strong>di</strong> una qualche illusoria ‘universale benevolenza’:<br />
credo si possa <strong>di</strong>re che il <strong>di</strong>o rettorico è una neop<strong>la</strong>sia dello spirito dell’uomo.<br />
Massima inautenticità. La voce del<strong>la</strong> coscienza del<strong>la</strong> società retorica è obliata<br />
89
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
cantilena del<strong>la</strong> religione: l’uomo retorico si affida al<strong>la</strong> competenza <strong>di</strong> un <strong>di</strong>o<br />
qualunque che al posto suo gli risolva il problema del<strong>la</strong> vita e del<strong>la</strong> morte:<br />
‘Dio m’aiuti’ – perché io non ho il coraggio d’aiutarmi da me (afferma il retore)<br />
[…] I primi cristiani – prosegue Michelstaedter – facevano il segno del pesce e si<br />
credevano salvi; avessero fatto più pesci e sarebbero stati salvi davvero (PeR 103).<br />
Questo è lo squallore dell’aspetto religioso del<strong>la</strong> società che Michelstaedter<br />
segna<strong>la</strong> nei suoi scritti; egli rimase sempre estraneo a qualunque osservanza<br />
religiosa in termini pratici: mentre <strong>la</strong> famiglia era molto osservante, egli sentiva il<br />
vigore dell’essere autentico in<strong>di</strong>cargli <strong>la</strong> via verso <strong>la</strong> salute e il <strong>di</strong>sgusto per<br />
attività para-carnevalesche. La persuasione ricercata, però, non è mera ricerca del<br />
piacere e fuga dal dolore: «il piacere è il fiore del dolore, il dolce è il fiore<br />
dell’acerbo» (PeR 105).<br />
Chi lo cerca non lo trova,<br />
chi lo trova non lo sa;<br />
il suo nome mette a prova<br />
questa fiacca umanità. –<br />
È il piacere l’Id<strong>di</strong>o pu<strong>di</strong>co<br />
Ch’ama quello che non lo sa:<br />
se lo cerchi se’ già men<strong>di</strong>co,<br />
t’ha già vinto l’oscurità (Po 77).<br />
Si è visto che il dolore è in fondo il motore che alimenta <strong>la</strong> coscienza dell’uomo<br />
verso il risveglio, verso il riappropriamento <strong>di</strong> se stessi, e dunque il dolore è<br />
paradossalmente salutare: solo che <strong>la</strong> salute non è fatta per il futuro:<br />
90
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
Niente da aspettare<br />
niente da temere<br />
niente da chiedere – e tutto dare<br />
non andare<br />
ma permanere. –<br />
Non c’è premio – non c’è posa.<br />
La vita è tutta una dura cosa<br />
Ma <strong>la</strong> salute è <strong>di</strong> quello che in mezzo a queste (le cose) consiste – che il proprio<br />
bisogno <strong>la</strong> propria fame <strong>la</strong>scia fluire attraverso a sé e consiste – che se mille<br />
braccia l’afferrino e con sé lo vogliano trascinare, consiste e per <strong>la</strong> propria<br />
fermezza rende gli altri fermi. – Non ha niente da <strong>di</strong>fendere dagli altri e niente da<br />
chieder loro poiché per lui non c’è futuro, che nul<strong>la</strong> spetta (DDS 85).<br />
Infatti, chi davvero raggiunga lo stato del<strong>la</strong> salute, del<strong>la</strong> persuasione, ed incontri<br />
<strong>la</strong> vita, dovrà necessariamente eliminare le necessità e <strong>la</strong> volontà: deve morire.<br />
Quin<strong>di</strong>, in questo caso, l’atarassia potrà essere soltanto istantanea: è nel momento<br />
del<strong>la</strong> salute che, prima <strong>di</strong> morire, il persuaso è perfettamente imperturbabile.<br />
Per quanto riguarda il rapporto con <strong>la</strong> posizione stoica, credo si possa<br />
affermare che <strong>la</strong> persuasione possa in qualche modo paragonarsi ad uno stato <strong>di</strong><br />
apatia, scaturente però da una situazione <strong>di</strong>ametralmente contraria a quel<strong>la</strong> del<strong>la</strong><br />
Stoà:<br />
Poiché in quanto virtus – <strong>di</strong>ce Diogene nel ‘Dialogo fra Diogene e Napoleone’ –<br />
essa (<strong>la</strong> virtù stessa) è <strong>di</strong>sposizione ad una cosa (possibilità), in quanto tua virtus è<br />
bisogno <strong>di</strong> questa cosa anche in rapporto alle virtutes negative degli stoici che sono<br />
negative in riguardo ai bisogni ma positive riguardo al<strong>la</strong> vita, cioè esser felici senza<br />
quei bisogni: gli stoici avevano d’accorgersi che esistevano anche senza quei<br />
bisogni, essi esistevano e credevano d’essere solo in quanto negavano l’una cosa e<br />
l’altra e affermavano così in rapporto a queste cose del<strong>la</strong> vita <strong>la</strong> loro in<strong>di</strong>vidualità.<br />
Dunque gli Stoici hanno possibilità <strong>di</strong> vivere senza bisogni ma bisogno <strong>di</strong> viver<br />
come tali (DDS 107).<br />
91
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
Infatti, il persuaso è colui che riappropriatosi <strong>di</strong> se stesso non teme più nul<strong>la</strong>,<br />
nemmeno <strong>la</strong> morte, perché <strong>la</strong> potenza assoluta dell’essere che fluisce in lui<br />
annul<strong>la</strong> ogni volontà ed ogni sistematico desiderio <strong>di</strong> necessità: il persuaso è<br />
completamente e perfettamente <strong>di</strong>staccato da qualunque re<strong>la</strong>zione, da qualunque<br />
elemento effettivo ed affettivo del<strong>la</strong> vita.<br />
Questa con<strong>di</strong>zione assomiglia molto, a mio avviso, al<strong>la</strong> posizione del<br />
saggio stoico, sebbene, riba<strong>di</strong>sco, il metodo da seguire sia incompatibile al<br />
massimo grado, perché <strong>la</strong> persuasione scaturisce da una sorta <strong>di</strong> dono <strong>di</strong>vino,<br />
mentre l’apatia è il risultato <strong>di</strong> un grande <strong>la</strong>voro <strong>di</strong> educazione <strong>di</strong> se stessi: <strong>la</strong><br />
prima <strong>la</strong> si possiede imme<strong>di</strong>atamente, <strong>la</strong> seconda va costruita passo dopo passo.<br />
Ecco il motivo per cui, secondo Michelstaedter, non ci si deve porre un obiettivo,<br />
una base solida da cui partire per il suo raggiungimento: perché questo è il<br />
percorso illusorio del<strong>la</strong> rettorica.<br />
Si è detto che <strong>la</strong> persuasione è un dono, una grazia, e non è il risultato <strong>di</strong><br />
una preparazione spirituale a sfondo ascetico o ritualistico. Non c’è spazio<br />
dunque, come nel pensiero stoico, per il programmatico iter evolutivo secondo<br />
l’appren<strong>di</strong>mento e l’azione nel <strong>mondo</strong>: Michelstaedter ripete più volte che<br />
l’ultima necessità è quel<strong>la</strong> <strong>di</strong> non avere necessità, quel<strong>la</strong> <strong>di</strong> passare dal<strong>la</strong> attività<br />
all’inerzia. In quest’ambito è possibile ravvisare, secondo il mio punto <strong>di</strong> vista,<br />
una minima presenza <strong>di</strong> stoicismo nel pensiero dell’Autore, seppur solo dal punto<br />
<strong>di</strong> vista formale: nell’istante dell’ultimo presente <strong>la</strong> persuasione assomiglia molto<br />
92
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
all’apatia, mentre nel programma etico <strong>di</strong> ricerca del<strong>la</strong> beatitu<strong>di</strong>ne <strong>la</strong> <strong>di</strong>fferenza<br />
fra Michelstaedter e <strong>la</strong> Stoà è abissale.<br />
Fa bene a notare Carchia che lo stoicismo, al<strong>la</strong> fine dei conti, è più che<br />
altro una sorta <strong>di</strong> etica del<strong>la</strong> sensibilità prospettata da una visuale negativa del<br />
valore: «dal punto <strong>di</strong> vista morale (essa è) soprattutto una sorta <strong>di</strong> paradossale<br />
‘etica del<strong>la</strong> sensibilità’, il cui proposito è <strong>la</strong> realizzazione, per una via negativa<br />
assai più che non attraverso <strong>la</strong> pura potenza del bene, <strong>di</strong> una vita conciliata, in cui<br />
le istanze dell’in<strong>di</strong>viduo siano capaci <strong>di</strong> scegliere e trovare giusti punti<br />
d’inserzione con l’Intero, sia naturale che storico» 97 .<br />
L’ossessionante ricerca del<strong>la</strong> oggettività è inconciliabile con il sentimento<br />
dell’in<strong>di</strong>vidualità e dell’acosmicità michelstaedteriani, cosicché lo stoicismo si<br />
rive<strong>la</strong> ben presto una specie <strong>di</strong> spoglio praticantato del<strong>la</strong> virtù obiettiva e<br />
insensibile, <strong>la</strong>sciando spazio a quel<strong>la</strong> corre<strong>la</strong>tività delle coscienze tanto<br />
indesiderata dal<strong>la</strong> persuasione, che mira all’autentica compenetrazione. La<br />
morale degli stoici è inevitabilmente strutturata sul<strong>la</strong> legge-logos che governa<br />
l’intero universo, e <strong>la</strong> pratica del<strong>la</strong> virtù secondo questa legge non si può sposare<br />
con l’istantaneità dell’ultimo presente michelstaedteriano.<br />
La legge degli stoici non reprime <strong>la</strong> natura ma tenta <strong>di</strong> or<strong>di</strong>nar<strong>la</strong>; <strong>la</strong> salute<br />
<strong>di</strong> Michelstaedter non or<strong>di</strong>na nul<strong>la</strong>, ma tenta <strong>di</strong> riportare all’unità extramondana e<br />
immanente dell’essere come totalità. <strong>Il</strong> persuaso michelstaedteriano, in definitiva,<br />
possiede se stesso e il <strong>mondo</strong> in un istante, e fa <strong>di</strong> se stesso fiamma nel momento<br />
97 G. Carchia, Retorica del sublime, cit., p. 23.<br />
93
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
in cui può toccare l’essere: sul punto del<strong>la</strong> morte, in cui <strong>la</strong> coscienza è<br />
incosciente.<br />
La coscienza del saggio stoico è, invece, ancora coscienza sociale, mentre<br />
quel<strong>la</strong> del persuaso è coscienza ontologica in<strong>di</strong>viduale. La legge stoica vuole<br />
or<strong>di</strong>nare il cosmo; <strong>la</strong> legge <strong>di</strong> Michelstaedter vuole il possesso dell’autenticità e<br />
dell’assolutezza dell’essere. Ciò ci porta ad asserire che <strong>la</strong> prima è un percorso da<br />
sviluppare nel<strong>la</strong> vita, maturando se stessi da stolti a saggi; <strong>la</strong> seconda, per<br />
converso, è una specie <strong>di</strong> folgorazione che permette <strong>di</strong> accorgersi del<strong>la</strong> falsità<br />
del<strong>la</strong> vita sociale e dei sui ritmici preconcetti.<br />
94
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
XIII<br />
COMPONENTI ESTETICHE DEL PENSIERO DI MICHELSTAEDTER<br />
Considerando tutto ciò che è stato fin qui detto, possiamo asserire che<br />
l’estetica <strong>di</strong> Michelstaedter è un momento acuto, imbevuto <strong>di</strong> reazione al<br />
positivismo, al naturalismo e al razionalismo, «ma non si inserisce nell’estetica<br />
neoidealistica me<strong>di</strong>atrice fra le sorgenti kantiane e quelle hegeliane» 98 . L’Autore<br />
conserva, nel suo aspetto più significativo, «elementi estremoromantici, ossia<br />
attivistici, irrazionalistici, mistici, <strong>la</strong> cui componente trasgressiva, con apparente<br />
paradosso, afferisce per altro con energia al<strong>la</strong> dominante <strong>di</strong>mensione etica». 99<br />
Michelstaedter era fortemente attratto dall’arte e dalle sue svariate modalità<br />
<strong>di</strong> rappresentazione, tanto che giunto a Venezia, in piazza San Marco, sul<strong>la</strong> strada<br />
verso Firenze, egli annotò:<br />
Mi sembra d’essere un altro, ad ogni istante, ho perduto il sentimento del<strong>la</strong><br />
continuità del mio ‘io’. Solo il dolore tenace, profondo, mi congiunge al passato. È<br />
il dolore l’ultimo anello che mi lega al<strong>la</strong> vita. Io credo che impazzirò (Op 419).<br />
98<br />
Vittorio Stel<strong>la</strong>, “La riflessione sull’arte in Michelstaedter”, in Dialoghi intorno a Michelstaedter, cit., p.<br />
158.<br />
99<br />
Per quello che riguarda l’etica, nell’arte dell’Autore essa traspare in maniera vigorosa, e potremmo <strong>di</strong>re<br />
che essa serve a Michelstaedter per denunciare ed evidenziare <strong>la</strong> decadenza spirituale che caratterizza <strong>la</strong><br />
società dei rettorici. La morale è un punto focale del<strong>la</strong> sua produzione filosofico-artistica, e in senso<br />
profondo l’Autore intende ripercorrere abbastanza fedelmente uno dei capisal<strong>di</strong> del<strong>la</strong> filosofia kantiana:<br />
l’autonomia dell’etica. A tal proposito riportiamo le parole <strong>di</strong> Kant: «A coloro che deridono ogni moralità<br />
come pura fantasticheria <strong>di</strong> una umana immaginazione che, presuntuosamente, pretenda <strong>di</strong> sollevarsi al <strong>di</strong><br />
sopra <strong>di</strong> se stessa, non si può del resto rendere servizio più gra<strong>di</strong>to se non quello <strong>di</strong> accordare che i<br />
concetti del dovere debbano essere tratti soltanto dall’esperienza» (I. Kant, Fondazione del<strong>la</strong> metafisica<br />
dei costumi, Laterza, Bari 1997, p. 47).<br />
95
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
Queste parole racchiudono in nuce l’intera concezione estetica <strong>di</strong> Michelstaedter:<br />
l’istantaneità che produce smarrimento nel<strong>la</strong> coscienza, ed il dolore inguaribile<br />
che lega l’esteta al ricordo. La <strong>tesi</strong> è confermata nel giorno dell’arrivo a Firenze,<br />
quando Michelstaedter «in rabdomantico abbandono raggiunge Santa Maria del<br />
Fiore e il Campanile <strong>di</strong> Giotto, dove, nel<strong>la</strong> luce del tramonto, le costruzioni gli<br />
sembrano non opera <strong>di</strong> uomini, ma cose messe lì per incanto, <strong>di</strong>afane,<br />
immateriali» 100 .<br />
La ricerca artistica <strong>di</strong> Michelstaedter procedette sempre e comunque <strong>di</strong> pari<br />
passo con <strong>la</strong> specu<strong>la</strong>zione filosofica: in ogni creazione artistica si possono<br />
riscontrare i tratti ben delineati del<strong>la</strong> filosofia de La Persuasione e <strong>la</strong> Rettorica.<br />
Le opere d’arte suscitano nell’Autore un forte senso <strong>di</strong> inquietu<strong>di</strong>ne che fa<br />
smarrire l’orientamento, ed è proprio riguardo ai concetti <strong>di</strong> sensazione, dolore e<br />
libertà che si sviluppa <strong>la</strong> sua riflessione estetica. Egli desiderava <strong>di</strong>ventare un<br />
affermato pittore; era attratto fortemente dal<strong>la</strong> p<strong>la</strong>sticità, dal candore, dal<strong>la</strong><br />
perfezione e dal<strong>la</strong> nobiltà dell’arte c<strong>la</strong>ssica, mentre invece sono lo schizzo a<br />
matita, <strong>la</strong> caricatura ed il ritratto i capisal<strong>di</strong> del<strong>la</strong> sua opera grafica:<br />
Lo schizzo doveva <strong>di</strong>ventare popo<strong>la</strong>re tra gli artisti espressionisti, proprio per <strong>la</strong><br />
sua natura antiretorica. La vita è spesso abitata dal dolore e dal<strong>la</strong> noia; <strong>la</strong> bel<strong>la</strong><br />
faccia esteriore è solo una pietosa illusione. Gli schizzi <strong>di</strong> questi artisti (fra cui<br />
inseriamo a pieno titolo anche Michelstaedter, sebbene non sia ufficialmente<br />
annoverato fra i pittori/ritrattisti del<strong>la</strong> corrente espressionista) furono un’opera<br />
polemica contro una tra<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> idealizzazione; il loro fine esprime quello che sta<br />
<strong>di</strong>etro all’armoniosa apparenza del<strong>la</strong> superficie. 101<br />
100 Alessandro Arbo, Carlo Michelstaedter, E<strong>di</strong>zioni Stu<strong>di</strong>o Tesi, Pordenone 1996, p. 31.<br />
101 Danie<strong>la</strong> Bini, in L’immagine irraggiungibile – Dipinti e <strong>di</strong>segni <strong>di</strong> Carlo Michelstaedter, E<strong>di</strong>zioni<br />
del<strong>la</strong> Laguna, Gorizia 1992, pp. 20-21.<br />
96
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
Riprendendo il <strong>di</strong>scorso da un punto <strong>di</strong> vista più teorico, è bene chiarire quale sia,<br />
per Michelstaedter, il meccanismo che determina il movimento del<strong>la</strong><br />
rappresentazione artistica: il suo motore è il dolore austero, che mette a nudo le<br />
pretese illusioni dei retori, e che denuncia violentemente l’impossibilità <strong>di</strong> un<br />
vero e reale possesso del<strong>la</strong> vita, delle cose e degli eventi. Tenendo ben presente<br />
che «l’artista (esteta/filosofo, in Michelstaedter sono sinonimi) […] è una carta<br />
topografica <strong>di</strong> fronte ad una carta geografica», considerando quest’ultima come<br />
<strong>la</strong> società umana in generale, l’esteta/artista ha il ruolo <strong>di</strong> spogliare da ogni<br />
presunzione e vanagloriosa illusione le necessità ed i desideri del<strong>la</strong> società<br />
rettorica: l’esteta, dunque, è l’equivalente artistico del filosofo, ed ha il compito<br />
<strong>di</strong> combattere <strong>la</strong> rettorica, in nome del<strong>la</strong> persuasione, con <strong>la</strong> raffigurazione che<br />
più si presta a questo ruolo, ovvero <strong>la</strong> caricatura. 102 Questa forma <strong>di</strong><br />
rappresentazione consentiva all’Autore <strong>di</strong> trascrivere in termini <strong>di</strong> linee, segni,<br />
tratti e colori tutto quello che era espresso con le parole nel<strong>la</strong> Persuasione e <strong>la</strong><br />
Rettorica. <strong>Il</strong> circolo che si determina fra raffigurazione segnica ed espressione<br />
letteraria è virtuoso, e le tematiche del<strong>la</strong> filosofia michelstaedteriana sono sempre<br />
presenti: il sentimento del persuaso (che, come citato sopra, è comunque il dolore<br />
,insieme al<strong>la</strong> repulsione per <strong>la</strong> vita insipida e meccanica del<strong>la</strong> rettorica) induce<br />
obbligatoriamente al<strong>la</strong> denuncia degli aspetti in cui l’inautenticità dei retori si<br />
manifesta. Nel<strong>la</strong> caricatura è possibile ri<strong>di</strong>colizzare una ‘forma sociale’ <strong>di</strong><br />
102 «La <strong>di</strong>sinvoltura con cui Michelstaedter delineava i suoi personaggi <strong>di</strong>mostra una pronunciata capacità<br />
<strong>di</strong> adeguare lo strumento espressivo all’immagine secondo una sollecitazione interiore che lo portava a<br />
decifrare gli aspetti peculiari dell’uomo e del<strong>la</strong> società contemporanea» (Fulvio Monai, “Michelstaedter<br />
anticipatore in arte”, in Dialoghi intorno a Michelstaedter, cit., p. 160).<br />
97
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
rettorica (ad esempio, <strong>la</strong> caricatura del docente, membro del<strong>la</strong> comunel<strong>la</strong> <strong>di</strong><br />
malvagi, evidenzia sempre lo sguardo assonnato nascosto <strong>di</strong>etro gli occhiali ed il<br />
capo chino, elementi che suscitano facilmente noia e spocchia), facendo risaltare<br />
i tratti retorici delle vittime. <strong>Il</strong> persuaso mette a nudo qui <strong>la</strong> vita delle forme<br />
sociali. L’espressione caricaturale, pertanto, offre <strong>la</strong> possibilità <strong>di</strong> deformare <strong>la</strong><br />
logica e l’or<strong>di</strong>ne falsificatori del<strong>la</strong> società dei retori. 103<br />
Bisogna sottolineare, però, che le sensazioni che suscitano le opere<br />
artistiche servono, per l’Autore, a superare l’illusione e le necessità, dettate dal<strong>la</strong><br />
rettorica, in modo in<strong>di</strong>vidualizzato. Ovvero, il persuaso/artista/esteta coglie<br />
intuitivamente le forme artistiche, poiché è instradato verso l’autenticità ed il<br />
possesso del<strong>la</strong> vita. Dovendo <strong>di</strong>stricarsi fra <strong>la</strong> moltitu<strong>di</strong>ne dei retori, non produce<br />
alcuna realizzazione statica o idealistica, ma si limita ad una produzione che<br />
denunci <strong>la</strong> presenza del<strong>la</strong> rettorica, in forma quasi surreale. Ognuna <strong>di</strong> tali<br />
rappresentazioni artistiche è comunque fortemente soggettiva/soggettivizzata,<br />
perché è l’in<strong>di</strong>viduo a fare del<strong>la</strong> persuasione (assoluta) <strong>la</strong> sua vita (singo<strong>la</strong>re): il<br />
dono del<strong>la</strong> persuasione, in fin dei conti, si esprime in ogni persuaso secondo i<br />
medesimi canoni, ma con forme e manifestazioni personalizzate. Non è un caso<br />
che Michelstaedter asserisca che «l’arte ci presta una in<strong>di</strong>vidualità» (Op 745).<br />
103 «La bruttezza fisica che <strong>la</strong> caricatura ritrae è chiaramente espressione del<strong>la</strong> bruttezza spirituale che<br />
l’osservatore, in questo caso l’artista/esteta, condanna. Quelli che hanno riconosciuto in Michelstaedter<br />
solo una vena giocosa sono lontani dal<strong>la</strong> realtà. L’incomprensione delle sue caricature preclude una<br />
valutazione equilibrata <strong>di</strong> Michelstaedter, il filosofo del<strong>la</strong> persuasione. Con pochissime eccezioni, infatti,<br />
nei suoi <strong>di</strong>pinti non c’è alcun tocco leggero, ma un severo giu<strong>di</strong>zio moralistico su una società che egli<br />
<strong>di</strong>sprezzava profondamente, <strong>la</strong> koinonia kakon de La persuasione e <strong>la</strong> rettorica» (Danie<strong>la</strong> Bini,<br />
L’immagine irraggiungibile, cit., p. 33).<br />
98
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
Come potrebbe essere altrimenti, visto che l’oggettività (logico-scientifica) è<br />
figlia del<strong>la</strong> rettorica, opponendosi all’autenticità del singolo uomo?<br />
Le sensazioni suscitate, in definitiva, collimano con il dolore/motore<br />
dell’arte, e, determinando un forte sentimento malinconico, consentono il<br />
superamento del<strong>la</strong> <strong>di</strong>mensione rettorica e <strong>di</strong> esse stesse: l’arte, perciò, è una<br />
specie <strong>di</strong> filosofia delle sensazioni, che si spoglia <strong>di</strong> queste allorché il dolore<br />
mette a nudo <strong>la</strong> verità del<strong>la</strong> vita 104 . La fusione fra bellezza artistica e singo<strong>la</strong>rità<br />
consente <strong>di</strong> trovare un modo <strong>di</strong> espressione «rappresentando <strong>la</strong> forma assoluta<br />
dell’‘io’» (Op 716). A questo punto sembra appropriato citare <strong>la</strong> <strong>di</strong>stinzione che<br />
Michelstaedter sancisce fra due tipi <strong>di</strong> artista: il debole (quello che vive nel<br />
<strong>mondo</strong> del<strong>la</strong> rettorica e rappresenta <strong>la</strong> realtà secondo i suoi canoni: illusorietà,<br />
falso possesso, falsa sicurezza) e l’autentico (quello che nelle sue opere<br />
manifesta <strong>la</strong> <strong>di</strong>mensione del<strong>la</strong> persuasione, per quanto sia possibile, e che non si<br />
affilia ad alcuna corrente artistica riconosciuta, proprio per sfuggire alle<br />
c<strong>la</strong>ssificazioni del<strong>la</strong> società):<br />
Lo scrittore forte (si può intendere, in questo caso, lo scrittore anche<br />
semplicemente come l’artista in senso generale) sente che o <strong>la</strong> cosa <strong>la</strong> <strong>di</strong>ce sempre<br />
in ogni punto tutta o non <strong>la</strong> <strong>di</strong>ce mai affatto, e non teme che un’impressione gli<br />
sfugga poiché con tutta <strong>la</strong> sua vita egli (<strong>la</strong>) contende al<strong>la</strong> verità, e l’intuizione<br />
creatrice si rinnova con forza inesauribile cercando nel masso <strong>la</strong> forma perfetta. Gli<br />
artisti deboli ‘si sfruttano’, si adagiano nelle loro impressioni, ricercano le<br />
contingenze che possono produrle, temono pel proprio organismo ‘creatore’ e si<br />
vuotano. L’artista forte non vuole essere artista ma ‘vuole essere’, e dal<strong>la</strong> lotta e dal<br />
dolore trae <strong>la</strong> salute e <strong>la</strong> gioia (Op 707).<br />
104 Michelstaedter reputa che l’artista e l’esteta/filosofo siano effettivamente più che compatibili, anzi<br />
compenetrabili ed identificabili; per ques to scrive che «chi sente il bello ha l’anima d’artista, chi ne sa le<br />
ragioni è filosofo» (C. Michelstaedter, in L’immagine irraggiungibile, cit., p 81).<br />
99
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
Ecco che <strong>la</strong> figura dell’artista autentico, persuaso, si spinge oltre <strong>la</strong> <strong>di</strong>mensione<br />
del reale, al<strong>la</strong> ricerca <strong>di</strong> quell’unità/totalità che l’accomuna al filosofo:<br />
Ma chi vuole <strong>la</strong> vita veramente, rifiuta <strong>di</strong> vivere in rapporto a quelle cose che fanno<br />
<strong>la</strong> vana gioia e il vano dolore degli altri – e non accontentandosi d’alcun possesso<br />
illusorio chiede il vero possesso, così che in lui prende forma e si rive<strong>la</strong> il muto e<br />
oscuro dolorare <strong>di</strong> tutte le cose.<br />
La sua vita è il rifiuto e <strong>la</strong> lotta contro tutte le tentazioni degli illusori<br />
sod<strong>di</strong>sfacimenti, e non <strong>di</strong>sperdendosi nell’atto delle continue corre<strong>la</strong>zioni (possessi<br />
illusori) si afferma e prende forma e si crea da se stessa: questa è l’arte.<br />
L’arte è dunque il più forte dolore e <strong>la</strong> più forte vita e dà <strong>la</strong> più forte gioia<br />
nell’affermazione <strong>di</strong> se stessa (Op 705).<br />
Come detto in precedenza, l’esteta michelstaedteriano, per le sue peculiarità, è<br />
annoverabile, a nostro avviso, fra gli espressionisti: egli non ricerca mai<br />
l’idealizzazione dell’arte/pensiero, ma <strong>la</strong> sua totalità/autenticità 105 . Egli, come fa<br />
proprio l’Autore nelle sue opere (grafiche e letterarie), sente il bisogno <strong>di</strong><br />
scomporre i personaggi presi a tema, perché il suo scopo unico è <strong>di</strong> afferrare <strong>la</strong><br />
vita nuda, spogliare <strong>la</strong> natura e mostrar<strong>la</strong> senza or<strong>di</strong>ne, contrad<strong>di</strong>ttoria quale è.<br />
Non è affatto un caso che l’Autore sia fortemente attratto da un quadro intenso e<br />
violento come l’Urlo <strong>di</strong> Edvard Munch 106 . In quest’opera Michelstaedter ravvisa<br />
105 Sembra corretto citare ancora le parole del<strong>la</strong> Bini: «Tra i molti <strong>di</strong>segni, Michelstaedter ha <strong>la</strong>sciato<br />
varie caricature, che sono state praticamente ignorate del<strong>la</strong> maggior parte dei critici, forse perché ritenute<br />
incoerenti con <strong>la</strong> serietà del<strong>la</strong> sua <strong>di</strong>ssertazione e del suo gesto finale. Tale giu<strong>di</strong>zio non può ovviamente<br />
sod<strong>di</strong>sfare. Carlo era altrettanto serio come filosofo che come caricaturista […] Umorista al<strong>la</strong> maniera<br />
pirandelliana, le sue caricature rendono concreto il ‘senso del contrario’ che costringe l’artista a<br />
rappresentare una realtà nuda, spogliata dal<strong>la</strong> rettorica delle apparenze. Dal punto <strong>di</strong> vista filosofico <strong>la</strong><br />
scelta del<strong>la</strong> caricatura segna <strong>la</strong> fase del<strong>la</strong> negatività, del<strong>la</strong> <strong>di</strong>struzione delle belle apparenze. Momento<br />
rivoluzionario, grido <strong>di</strong> protesta, ma anche grido <strong>di</strong> Angst, come quello agghiacciante <strong>di</strong> Munch» (Danie<strong>la</strong><br />
Bini, L’immagine irraggiungibile, cit., p. 25).<br />
106 Lo statuto dell’artista, secondo Munch, è <strong>la</strong> separazione: dall’impossibile integrazione nel <strong>mondo</strong><br />
nasce l’opera d’arte, e l’artista sta in una regione al limite dello smarrimento e del<strong>la</strong> ma<strong>la</strong>ttia. Dice<br />
Munch: «La mia arte ha le sue ra<strong>di</strong>ci nelle riflessioni sul perché non sono uguale agli altri, sul perché ci fu<br />
una male<strong>di</strong>zione sul<strong>la</strong> mia cul<strong>la</strong>, sul perché sono stato gettato nel <strong>mondo</strong> senza poter scegliere […] Ho<br />
dovuto seguire un sentiero lungo un precipizio, una voragine senza fondo. Ho dovuto saltare da una pietra<br />
all’altra. Qualche volta ho <strong>la</strong>sciato il sentiero per buttarmi nel vortice del<strong>la</strong> vita. Ma sempre ho dovuto<br />
100
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
il più profondo senso <strong>di</strong> angoscia (Angst) che destabilizza <strong>la</strong> illusoria sicurezza<br />
del<strong>la</strong> società rettorica: il violento amalgama <strong>di</strong> tratti e colori rendono l’opera <strong>di</strong><br />
Munch un perfetto esempio <strong>di</strong> persuasione, agli occhi <strong>di</strong> Michelstaedter.<br />
La possibilità <strong>di</strong> afferrare <strong>la</strong> vita nel<strong>la</strong> sua imme<strong>di</strong>atezza, come nuda e<br />
spoglia dagli abiti del<strong>la</strong> falsità, rimanda <strong>di</strong>rettamente al concetto, trattato nei<br />
capitoli precedenti, del tempo del persuaso/artista. Ma qual è, allora, il tempo in<br />
cui l’opera artistica va ad inserirsi? Come può, in termini <strong>di</strong> tempo, l’artista<br />
(come il persuaso) denunciare ai retori <strong>la</strong> loro rettoricità? <strong>Il</strong> tempo dell’artista è il<br />
tempo del persuaso, ossia l’attimo, l’istante, che consente <strong>di</strong> cogliere il carattere<br />
<strong>di</strong> acosmicità ed ultimità delle rappresentazioni: questo accade in virtù del punto<br />
<strong>di</strong> singo<strong>la</strong>rità (<strong>di</strong> cui si è par<strong>la</strong>to a p. 73), in cui l’essere che si ce<strong>la</strong> <strong>di</strong>etro le<br />
apparenze (ovvero l’essere autentico) pare venir colto:<br />
Nell’operazione che consente <strong>la</strong> riappropriazione del se stesso nel e attraverso il<br />
<strong>di</strong>spiegarsi del tempo, l’istante svolge un ruolo essenziale: esso non è più il mero<br />
tramite per un futuro che si risolve ogni volta <strong>di</strong> nuovo, però, in istanti inessenziali<br />
in sé e non vissuti se non, a loro volta all’infinito, come strumenti per un avvenire<br />
che non esiste; bensì, <strong>di</strong>viene il momento in cui <strong>la</strong> stessa eternità è vissuta appieno,<br />
e per cui si annul<strong>la</strong> ogni altra aspettativa e ogni rimando che falsifichi e renda<br />
puramente per sé, inessenziale, il vivere presente, l’istantaneità in cui si presenta<br />
ogni avvenimento umano 107 .<br />
La sensazione del<strong>la</strong> profon<strong>di</strong>tà artistica è istantanea, repentina, così come lo è il<br />
dono del<strong>la</strong> persuasione: <strong>la</strong> vita autentica è tutta raccolta in un punto, dove si trova<br />
anche l’autenticità del<strong>la</strong> rappresentazione. L’istante è il tempo dell’arte e del<strong>la</strong><br />
ritornare su questo sentiero sul ciglio d’un precipizio» (in Munch, <strong>di</strong> Eva Di Stefano, Giunti Art Dossier,<br />
Brescia 1994, p. 8).<br />
107 Paolo Bernar<strong>di</strong>ni, “Dell’attimo come ?????S”, in Dialoghi intorno a Michelstaedter, cit., p. 115.<br />
101
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
persuasione; in esso si ravvisa <strong>la</strong> perfetta oggettività (non rettorica) che non si<br />
può apprezzare nel<strong>la</strong> vita sociale. L’oggettività si fonde con <strong>la</strong> soggettività per<br />
ricreare il <strong>mondo</strong> perduto del<strong>la</strong> unità-totalità, quel<strong>la</strong> <strong>di</strong>mensione dell’essere-<br />
autenticità che si nasconde <strong>di</strong>etro il paravento rettorico del<strong>la</strong> società. Sembra che,<br />
secondo Michelstaedter, l’artista ed il fruitore d’arte debbano smarrirsi in una<br />
sorta <strong>di</strong> stato <strong>di</strong> grazia, in cui soggetto ed oggetto si recuperano nel<strong>la</strong> forma<br />
immobile e perfetta dell’assoluto; in quei momenti si coglie <strong>la</strong> perfezione<br />
dell’essere, ma non si può esserne coscienti:<br />
in quegli istanti noi siamo partecipi del<strong>la</strong> verità oggettiva ed unica ma non ne siamo<br />
coscienti. Quando le impressioni prime vengono ed arrivano al<strong>la</strong> nostra coscienza<br />
assumono <strong>la</strong> forma speciale del<strong>la</strong> nostra in<strong>di</strong>vidualità. E similmente<br />
nell’ispirazione produttiva freme nell’animo l’immagine irraggiungibile del vero e<br />
il <strong>la</strong>bbro canta ed il pennello scorre inconscio. 108<br />
La creazione dell’opera d’arte è prodotta da una intuizione formale soggettiva <strong>di</strong><br />
una entità oggettiva trascendente, cosicché l’opera d’arte è <strong>la</strong> soggettiva<br />
riproduzione dello spirito delle cose, riproduzione completamente spontanea ed<br />
ispirata:<br />
E <strong>di</strong>cendo spirito voglio <strong>di</strong>re che il pittore non ci darà il suo oggetto linea per linea,<br />
il poeta non si affaticherà a par<strong>la</strong>rci con dettagli infiniti, ma ambedue daranno al<strong>la</strong><br />
loro opera quel fascino <strong>di</strong> linee e <strong>di</strong> parole che loro detta il cuore e che è atto a<br />
risvegliare in noi il sentimento che li anima. 109<br />
108 Carlo Michelstaedter, riportato ne L’immagine irraggiungibile, cit., p. 81.<br />
109 AA VV, ivi, p. 81.<br />
102
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
La produzione artistica, a causa del<strong>la</strong> propria e peculiare forma <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduazione<br />
del singolo, è scan<strong>di</strong>ta dai ritmi del<strong>la</strong> in<strong>di</strong>vidualizzazione, dallo stigma<br />
dell’in<strong>di</strong>viduo. Questo è l’intimo scopo dell’artista michelstaedteriano: <strong>la</strong><br />
soggettivazione dell’oggettività del<strong>la</strong> perfezione artistica. Secondo l’Autore,<br />
un’opera d’arte è <strong>la</strong> produzione necessariamente soggettiva dello spirito delle<br />
cose, e il compito dell’artista è sentire, provare sentimento, in<strong>di</strong>vidualizzare le<br />
proprie sensazioni ed emozioni, riproducendo l’oggettività in modo in<strong>di</strong>viduale.<br />
È una sorta <strong>di</strong> processo alchimistico e metabolico. Infatti in alchimia, per<br />
giungere al<strong>la</strong> perfezione del<strong>la</strong> materia metallica, è in<strong>di</strong>spensabile conoscere lo<br />
‘spirito’ del metallo, farlo <strong>di</strong>gerire dal fuoco curato dall’operatore, e poi far<br />
rinascere <strong>la</strong> materia ‘morta’ tramite una coagu<strong>la</strong>zione <strong>di</strong> forme e sostanze<br />
oggettive e soggettive. Non è un caso che l’alchimia sia definita dai filosofi<br />
chimici l’‘Arte’ per eccellenza 110 .<br />
L’artista michelstaedteriano si comporta in maniera intuitiva: egli<br />
intuisce 111 <strong>la</strong> perfezione e l’assolutezza delle concezioni del bello, le interiorizza,<br />
le metabolizza e, infine, le esteriorizza con le proprie capacità secondo<br />
determinate forme. È specialmente per questo motivo che l’Autore può affermare<br />
che «l’arte, l’arte…..l’arte non si definisce» (DDS 59). È necessario però prestare<br />
molta attenzione al concetto stesso dell’artista: si può <strong>di</strong>re tale solo chi sia un<br />
110 Per questo argomento si veda Titus Burckhardt, L’alchimia, Guanda, Parma 1996, (in maniera speciale<br />
i capitoli “Le nozze chimiche” a p. 121, e “La Tavo<strong>la</strong> Smeral<strong>di</strong>na” <strong>di</strong> Ermete Trismegisto a p. 169).<br />
111 In questa occasione si può intendere l’intuizione al<strong>la</strong> stessa maniera che poi penserà Henri Bergson,<br />
cioè come l’organo del<strong>la</strong> metafisica. Nel<strong>la</strong> riflessione post-idealistica, l’intuizione designa un tipo <strong>di</strong><br />
conoscenza sui generis; Bergson <strong>la</strong> concepisce, appunto, come una conoscenza imme<strong>di</strong>ata e non<br />
razionale, come una simpatia attraverso cui il soggetto può inserirsi nell’interiorità <strong>di</strong> un oggetto, al fine<br />
<strong>di</strong> entrare in connubio con <strong>la</strong> sua singo<strong>la</strong>rità intima. Per approfon<strong>di</strong>re l’argomento è consigliabile <strong>la</strong><br />
lettura <strong>di</strong> H. Bergson, Materia e memoria, cit., pp. 178-195.<br />
103
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
esteta (in questo caso sinonimo <strong>di</strong> filosofo) persuaso, perché quelli che fanno, o<br />
si credono, o sono dal<strong>la</strong> società stimati artisti, sono falsi esteti, secondo l’Autore,<br />
essendo retori e perciò illusi del<strong>la</strong> conoscenza dell’arte:<br />
Ogni attimo – è Rico che par<strong>la</strong> ironicamente – del<strong>la</strong> sua vita è prezioso a questo<br />
artista, egli sa che basta che lo scriva, lo <strong>di</strong>pinga, lo canti, e l’ha reso immortale;<br />
perciò in ogni cosa egli non vive volgarmente come un uomo che soffre e gioisce,<br />
vuole, o rifiuta, che ha affetti, passioni, speranza, me<strong>la</strong>nconia – <strong>di</strong>sperazione –<br />
come sarebbe volgare tutto ciò! Ma egli vive da artista, egli è al <strong>di</strong> fuori <strong>di</strong> tutto<br />
questo (DDS 61).<br />
Solo colui che davvero intuisce <strong>la</strong> bellezza e le sue sfaccettature sa rappresentare<br />
le sensazioni che prova tramite determinate forme, e non se ne fa vanto: egli<br />
esprime <strong>la</strong> coscienza <strong>di</strong> se stesso. Le impressioni prime che colpiscono <strong>la</strong><br />
sensibilità dell’artista hanno bisogno, però, per essere comprese e fruite, <strong>di</strong> una<br />
riorganizzazione che solo l’intelletto può offrire; cosicché l’opera d’arte esprime<br />
<strong>la</strong> più intima profon<strong>di</strong>tà dell’autore, e l’esteta deve poter comprender<strong>la</strong>. Lo può<br />
fare grazie al<strong>la</strong> facoltà dell’intelletto: «l’intelligenza è quel<strong>la</strong> facoltà che serve a<br />
rior<strong>di</strong>nare, a rievocare, a stabilire il nesso fra le impressioni ricevute e quin<strong>di</strong> è<br />
opera del<strong>la</strong> matematica meccanica tirarne le conseguenze» 112 .<br />
La figura dell’esteta è perciò quel<strong>la</strong> <strong>di</strong> un uomo persuaso che sappia<br />
cogliere <strong>la</strong> persuasione dalle prospettive <strong>di</strong> arte e filosofia, e le sappia unificare,<br />
coagu<strong>la</strong>re, per reimpossessarsi dell’autenticità <strong>di</strong> sé e delle cose: il<br />
filosofo/artista è dunque un in<strong>di</strong>viduo capace <strong>di</strong> intuire e rior<strong>di</strong>nare <strong>la</strong> bellezza:<br />
112 AA VV, L’immagine irraggiungibile, cit., p. 81.<br />
104
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
La mente d’un filosofo dunque è un complesso <strong>di</strong> sentimento d’arte (intendendo<br />
con arte l’essenza <strong>di</strong> tutte le cose) e d’intelligenza. 16+16= 32. 113<br />
Come detto in precedenza, <strong>la</strong> persuasione è il momento in cui ragione ed istinto<br />
si fondono. Nel<strong>la</strong> vita vissuta, invece, tale atteggiamento è irrealizzabile: <strong>la</strong><br />
rettorica del<strong>la</strong> società rimane inaggirabile. La rappresentazione artistica<br />
michelstaedteriana ha sempre ricercato <strong>di</strong> mettere bene in luce questa verità: <strong>la</strong><br />
<strong>di</strong>cotomia fra mente e cuore è insanabile. La massima espressione <strong>di</strong> questi<br />
sentimenti contrastanti sono rintracciabili, secondo lui, nell’arte norvegese <strong>di</strong><br />
Munch, per quello che riguarda <strong>la</strong> pittura, e <strong>di</strong> Ibsen per <strong>la</strong> letteratura.<br />
Specialmente nel<strong>la</strong> pittura violenta del norvegese Michelstaedter ritrova <strong>la</strong> triade<br />
<strong>di</strong> componenti del mistero del<strong>la</strong> vita terrena: il male, l’istinto e l’inconscio 114 .<br />
Questi tre elementi sembrano molto cari a Michelstaedter, tanto che nei suoi<br />
<strong>di</strong>segni e ritratti essi si porranno in primo piano all’attenzione del fruitore.<br />
Nell’arte nor<strong>di</strong>ca emerge l’angoscia stessa, e Michelstaedter trova in questa<br />
modalità <strong>di</strong> espressione tutti quegli elementi che affliggono <strong>la</strong> natura decaduta<br />
dell’uomo nel<strong>la</strong> vita vissuta, ossia <strong>la</strong> paura del<strong>la</strong> morte, il timore dell’ignoto.<br />
Svegliato dall’incoscienza e messo col<strong>la</strong> coscienza nello spazio e nel tempo nel<br />
mezzo delle contingenze, il filosofo non cerca che <strong>di</strong> liberarsene […] L’assoluto sta<br />
nell’assenza dell’ombra, nell’incoscienza (Op 691).<br />
113 AA VV, ivi, p. 81. A mio modo <strong>di</strong> vedere il commento 16+16=32 è solo una maniera <strong>di</strong> manifestare <strong>la</strong><br />
re<strong>la</strong>zione omotetica (intendendo con omotetia matematica proprio <strong>la</strong> omologia fra due piani o spazi) che<br />
insiste fra i due piani dell’arte e del<strong>la</strong> filosofia.<br />
114 «A volte – scrive Edvard Munch – gli argini saltano e l’angoscia oscura <strong>la</strong> mente, si è nu<strong>di</strong> nel proprio<br />
malessere mentre attorno si svolge una lotta <strong>di</strong> cui non si ha il controllo […] Un uccello da preda si è<br />
fissato dentro <strong>di</strong> me. I suoi artigli sono penetrati nel mio cuore, il suo becco ha trafitto il mio petto, e il<br />
battito delle ali ha offuscato il mio cervello» (in Munch, <strong>di</strong> Eva Di Stefano, Art Dossier, Giunti, Firenze<br />
1994, pp. 9-11).<br />
105
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
La concezione estetica dell’Autore è pertanto volta ad offrire una visione del<br />
bello come una specie <strong>di</strong> flusso canalizzato, capace <strong>di</strong> esteriorizzarsi in varie<br />
raffigurazioni: nei ritratti e nelle caricature, in special modo, con ruvidezza e<br />
spigolosità. Per l’autore l’idea <strong>di</strong> bellezza ha a che fare con un forte impulso<br />
all’espressione del sentimento artistico soggettivo, che «l’anima dell’artista<br />
imprime [a] suggello del<strong>la</strong> sua in<strong>di</strong>vidualità» 115 , <strong>di</strong> modo che i mezzi del<strong>la</strong><br />
rappresentazione e gli elementi del<strong>la</strong> tecnica siano strettamente <strong>di</strong>pendenti dal<strong>la</strong><br />
partico<strong>la</strong>re ed irripetibile con<strong>di</strong>zione del suo spirito, immerso nel<strong>la</strong> realtà ma<br />
trascinato verso il <strong>mondo</strong> dell’essere assoluto. Ecco dunque, a conferma <strong>di</strong><br />
quanto detto precedentemente, che il contenuto <strong>di</strong> denuncia e manifestazione<br />
mantiene una netta priorità sul<strong>la</strong> tecnica e sul<strong>la</strong> forma; ma «ammessa (questa)<br />
priorità e quin<strong>di</strong> l’irrilevanza del concetto <strong>di</strong> un linguaggio innovatore, è<br />
sintomatico il fatto che nelle sue ultime opere e specificamente negli autoritratti<br />
degli ultimi due anni il comico si <strong>di</strong>ssolve del tutto e l’immagine si trasferisce in<br />
una <strong>di</strong>mensione tragica, dove non c’è contestazione ma profetica intuizione <strong>di</strong> un<br />
epilogo inevitabile» 116 .<br />
Inoltre, un passo del<strong>la</strong> Persuasione conferma quanto l’Autore non si<br />
riconoscesse nel concetto comune <strong>di</strong> artista (cioè in quell’artista «impegnato<br />
[presumibilmente] in un’attività destinata a manifestarsi pubblicamente e a<br />
115 C. Michelstaedter, Scritti sco<strong>la</strong>stici, Istituto per gli Incontri M itteleuropei, Gorizia 1976, pp. 3-4.<br />
116 Fulvio Monai, in Dialoghi intorno a Michelstaedter, cit. p. 167.<br />
106
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
procurare vantaggi economici» 117 ), ammettendo, per <strong>di</strong> più, <strong>la</strong> sua totale<br />
estraneità al<strong>la</strong> massa degli artisti, che definiva vanitosi, presuntuosi e subdoli:<br />
Così gli artisti impotenti […] cercano l’‘impressione’ mettendosi e rimettendosi<br />
nelle posizioni note, che come <strong>la</strong> cercano così non l’hanno, ma hanno solo <strong>la</strong><br />
propria volontà d’aver<strong>la</strong> e sfruttano invano nel<strong>la</strong> pietosa rettorica il loro prezioso<br />
organismo dalle sensazioni raffinate (PeR 107). 118<br />
<strong>Il</strong> bello michelstaedteriano sta in stretto rapporto con l’essenzialità <strong>di</strong> una<br />
personalità autonoma che, volendosi emancipare da ogni legame dettato dal<strong>la</strong><br />
consueta analisi stilistica del<strong>la</strong> storia, «si propone come un frutto atipico <strong>di</strong><br />
un’atmosfera culturale avvertita attraverso i filtri <strong>di</strong> una sensibilità tutta personale<br />
e <strong>di</strong> un’intelligenza anticipatrice». 119 <strong>Il</strong> sentimento dell’artista persuaso è dunque<br />
intriso <strong>di</strong> libertà, e <strong>la</strong> bellezza è essenzialmente coor<strong>di</strong>nata da un atteggiamento<br />
esistenziale; ecco perché possiamo concludere, servendoci ancora delle parole del<br />
Monai, che in Michelstaedter «lo schizzo, il <strong>di</strong>segno imme<strong>di</strong>ato, l’aforisma<br />
figurativo si può considerare una traduzione visiva del<strong>la</strong> via verso <strong>la</strong> persuasione.<br />
La linea, secondo una grammatica preespressionista, si spezza in segmenti, si<br />
anima in curve ed evoluzioni, si condensa con insistenze e ripetizioni in alcuni<br />
passaggi per poi sfumarsi ed annul<strong>la</strong>rsi in altri». 120<br />
117 F. Monai, ivi, p. 168.<br />
118 Prosegue l’Autore in nota: «Che del<strong>la</strong> stessa impressione <strong>di</strong> questo vuoto si può far dell’arte, il nostro<br />
tempo c’insegna. Qualunque cosa io <strong>di</strong>ca, poiché io sono l’artista, l’ho detta, dunque è arte per forza»<br />
(PeR 107).<br />
119 Fulvio Monai, in Dialoghi intorno a Michelstaedter, cit., p. 171.<br />
120 Fulvio Monai, ivi, p. 173.<br />
107
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
In conclusione, finiamo con un’ultima citazione significativa, capace<br />
probabilmente <strong>di</strong> sintetizzare appieno tutta una breve vita trascorsa ai limiti<br />
estremi dell’esistenza:<br />
<strong>Il</strong> falco vo<strong>la</strong> prima <strong>la</strong>to – poi piomba sul<strong>la</strong> preda. Del resto si può prendere dove si<br />
vuole, il volo è sempre quello e in questo <strong>la</strong> sua qualunque forza, quanto possa, in<br />
ogni (suo) punto manifesta (Op 729).<br />
108
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
CONCLUSIONE<br />
L’esposizione del pensiero <strong>di</strong> Michelstaedter, svolto nei capitoli <strong>di</strong> questa<br />
<strong>tesi</strong>, ci conduce inevitabilmente a pensare che <strong>la</strong> <strong>di</strong>mensione del<strong>la</strong> persuasione sia<br />
irrealizzabile, come effettivamente è. La filosofia dell’Autore sembra un<br />
compen<strong>di</strong>o del nichilismo nietzschiano e del<strong>la</strong> noluntas schopenhaueriana,<br />
riassunte in un breve <strong>la</strong>sso temporale. L’unica salvezza per l’uomo che voglia<br />
davvero approfon<strong>di</strong>re <strong>la</strong> propria umanità è <strong>la</strong> rinuncia a tutto, l’annul<strong>la</strong>mento<br />
del<strong>la</strong> volontà e del desiderio, l’emancipazione dalle passioni e dalle necessità.<br />
Abbiamo sostenuto sin dall’inizio che il suicido dell’Autore fu dettato<br />
principalmente da questo intento, e non, come alcuni erroneamente credono, da<br />
una situazione <strong>di</strong> occasionale debolezza. Michelstaedter comincia a concepire le<br />
ragioni del<strong>la</strong> sua <strong>tesi</strong> quando ha appena 19 anni: non ci sembra un caso che <strong>la</strong> sua<br />
maturazione si svolga sempre sotto il segno dell’inseguimento del<strong>la</strong> persuasione.<br />
<strong>Il</strong> suo gesto è <strong>la</strong> sublimazione del suo pensiero e del<strong>la</strong> sua arte, non un gesto <strong>di</strong><br />
debolezza nei confronti del<strong>la</strong> sopportazione del<strong>la</strong> vita. La vita non va sopportata,<br />
ma vissuta, approfon<strong>di</strong>ta, e dopo ciò va ripulita del suo stato materiale per<br />
ricongiungersi all’essere/totalità/unità. Conclu<strong>di</strong>amo affermando che solo nel<br />
momento finale, trattato nel corso del nostro <strong>la</strong>voro, in cui <strong>la</strong> decisione del<strong>la</strong><br />
morte sta prendendo il sopravvento, il persuaso si qualifica completamente come<br />
tale, tanto che ci sembra corretto asserire che <strong>la</strong> morte è, per Michelstaedter,<br />
l’elemento completante sotto il cui segno sta <strong>la</strong> vita autentica: questa fu <strong>la</strong> sorte<br />
109
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
che, secondo lui, toccò liberamente anche al Cristo. Questi (accomunato a<br />
Socrate) attesta il male <strong>di</strong> vivere, il dolore e <strong>la</strong> sofferenza cui l’essere umano è<br />
condannato; al contempo, però, spiega quale possa essere l’unica possibilità del<strong>la</strong><br />
vita (potremmo <strong>di</strong>re del<strong>la</strong> persuasione): «Per loro (i retori) <strong>di</strong>sse Cristo:<br />
“chiunque cerchi <strong>di</strong> assicurarsi <strong>la</strong> conservazione del<strong>la</strong> propria persona – <strong>la</strong><br />
porterà al <strong>di</strong>ssolvimento” […] Cristo ha salvato se stesso poiché dal<strong>la</strong> sua vita<br />
mortale ha saputo creare il <strong>di</strong>o: l’in<strong>di</strong>viduo» (PeR 114-145).<br />
Secondo Michelstaedter, Cristo non ha <strong>la</strong> pretesa <strong>di</strong> salvare l’uomo con il<br />
suo messaggio, perché l’approdo al<strong>la</strong> persuasione è un’operazione<br />
esclusivamente in<strong>di</strong>viduale (proprio come accade per <strong>la</strong> realizzazione del<strong>la</strong><br />
Grande Opera alchemica, cui si è accennato nell’ultimo capitolo). <strong>Il</strong> Cristo<br />
dell’Autore è l’uomo forte (viene richiamato, secondo noi, lo stesso concetto <strong>di</strong><br />
artista forte, <strong>di</strong> cui sopra, a p. 94), che porta sulle spalle tutto il peso del dolore<br />
senza soccombere, almeno fino al compimento del proprio percorso in<strong>di</strong>viduale.<br />
Cristo rappresenta, pertanto, l’affermazione del<strong>la</strong> vita singo<strong>la</strong>, l’assenso al<br />
dolore, in opposizione al<strong>la</strong> religione istituzionalizzata che vive nel<strong>la</strong> speranza<br />
del<strong>la</strong> redenzione. Ma anche Cristo, in fin dei conti, decide <strong>di</strong> suicidarsi: non<br />
volendo rinunciare al suo messaggio <strong>di</strong> autenticità egli si è condannato a morte.<br />
Compie il suo destino <strong>di</strong> persuaso.<br />
Ma può esistere, forse, un altro ‘luogo’ in cui il persuaso possa realizzarsi?<br />
La solitu<strong>di</strong>ne e <strong>la</strong> malinconia non trovano concretizzazione nel<strong>la</strong> vita effettiva?<br />
La risposta può probabilmente essere positiva, considerando specialmente le<br />
110
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
poesie dell’Autore: «Per rendere <strong>la</strong> persuasione un’alternativa vivibile […]<br />
Michelstaedter in<strong>di</strong>ca all’uomo persuaso il suo luogo: il mare. […] <strong>Il</strong> mare è lo<br />
spazio del persuaso, il mare è l’ou-topia, il suo mai luogo privo <strong>di</strong> confini dove<br />
sempre si è stranieri, presenti solo a se stessi». 121 <strong>Il</strong> mare simboleggia lo spazio<br />
senza leggi, senza limiti, luogo sconfinato dove <strong>la</strong> comunel<strong>la</strong> dei malvagi non<br />
può inoltrarsi, dove ci si può autenticamente affermare, dove non vigi<strong>la</strong> <strong>la</strong> falsa<br />
organizzazione degli illusi retori. Questo è il solo posto dove il persuaso si possa<br />
sentire libero dal<strong>la</strong> propria sofferenza, e possa comportarsi come il solo gestore<br />
del<strong>la</strong> propria in<strong>di</strong>vidualità: nessun contatto sociale, nessuna ombra <strong>di</strong> rettorica.<br />
Ogni azione è risolutiva, finale, ultima, estrema: è l’ultimo presente.<br />
Lasciami andare, Pau<strong>la</strong>, nel<strong>la</strong> notte<br />
a crearmi <strong>la</strong> luce da me stesso,<br />
<strong>la</strong>sciami andare oltre il deserto, al mare<br />
perch’io ti porti il dono luminoso<br />
… molto più che non cre<strong>di</strong> mi sei cara (Po 72)<br />
Questo mare è il luogo del<strong>la</strong> definitiva libertà che Michelstaedter sogna per tutta<br />
<strong>la</strong> sua vita, <strong>di</strong>spensata dal soffocante giogo dell’agire che <strong>la</strong> società pretende: «<strong>la</strong><br />
via del<strong>la</strong> persuasione è terribile, perché non ammette deroghe». 122<br />
Ma, in ultima istanza, è p<strong>la</strong>usibilmente realizzabile questo tipo <strong>di</strong> vita? <strong>Il</strong><br />
risultato del nostro <strong>la</strong>voro è che per il persuaso nessuna vita è davvero vita se non<br />
incontra <strong>la</strong> morte, come l’Autore ripete spesso ne La Persuasione e <strong>la</strong> Rettorica.<br />
121 Pier Andrea Amato, L’attimo persuaso: filosofia e letteratura in C. Michelstaedter, estratto ricavato<br />
dal sito internet www.michelstaedter.it/amato.html.<br />
122 Pier Andrea Amato, ivi.<br />
111
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
BIBLIOGRAFIA GENERALE<br />
Bergson Henri, Materia e memoria, Laterza, Bari 1996, pp. 208.<br />
Bottani Livio, Malinconoia ed epoché, E<strong>di</strong>zioni Mercurio, Vercelli 1995, pp. 189.<br />
Brianese Giorgio, Congetture e confutazioni <strong>di</strong> Popper e il <strong>di</strong>battito epistemologico<br />
post-popperiano, Paravia, Torino 1988, pp. 232.<br />
Brianese G., La volontà <strong>di</strong> potenza <strong>di</strong> Nietzsche e il problema filosofico del superuomo,<br />
Paravia, Torino, 1989, pp. 327.<br />
Buddha, Aforismi e <strong>di</strong>scorsi, Newton&Compton, Roma 1994, pp. 95.<br />
Burckhardt Titus, Alchimia, Guanda, Parma 1996, pp. 189.<br />
Camus Albert, L’uomo in rivolta, Compiano Tascabili, Mi<strong>la</strong>no 1998, pp. 335.<br />
Heidegger Martin, Kant e il problema del<strong>la</strong> metafisica, Laterza, Bari 1989, pp. 241.<br />
Hölderlin Friedrich, Sul tragico, Feltrinelli, Mi<strong>la</strong>no 1994, pp. 111.<br />
Ibsen Henrik, Drammi, Einau<strong>di</strong>, Torino 1995, pp. 785.<br />
Kant Immanuel, Critica del<strong>la</strong> ragion pura, Laterza, Bari 1996, pp. 629.<br />
Kant I., Critica del giu<strong>di</strong>zio, Laterza, Bari 1996, pp. 483. Di Stefano Eva, Munch, Art<br />
Dossier Giunti, Firenze 1994, pp. 50.<br />
Evo<strong>la</strong> Julius, Rivolta contro il <strong>mondo</strong> moderno, Me<strong>di</strong>terranee, Roma 1994, pp. 520<br />
Goethe Wolfgang J., I dolori del giovane Werther, Einau<strong>di</strong> Bilingue, Torino 1998, pp.<br />
285.<br />
Guenon Renè, La grande triade, Adelphi, Mi<strong>la</strong>no 1980, pp. 207.<br />
112
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
Kant I., Fondazione del<strong>la</strong> metafisica dei costumi, Laterza Economica, Bari 1997, pp.<br />
170.<br />
Kierkegaard Søren Aabye, <strong>Il</strong> concetto dell’angoscia, BiT, Mi<strong>la</strong>no 1995, pp. 125.<br />
Kierkegaard S. A., La ma<strong>la</strong>ttia mortale, Newton&Compton, Roma 1995, pp. 98.<br />
La Rochefoucauld François de, Massime, Newton&Compton, Roma 1993, pp. 97.<br />
Leopar<strong>di</strong> Giacomo, Pensieri, Garzanti, Mi<strong>la</strong>no 1995, pp. 103.<br />
Long Anthony A., La filosofia ellenistica, <strong>Il</strong> Mulino, Bologna 1997, pp. 314.<br />
Magherini Graziel<strong>la</strong>, La sindrome <strong>di</strong> Stendhal, Ponte alle Grazie, Firenze 1995, pp. 219.<br />
Nietzsche Friedrich, <strong>Il</strong> crepuscolo degli idoli, Newton&Compton, Roma 1994, pp. 97.<br />
Nietzsche F., Così parlò Zarathustra, Newton Tris, Roma 1997, pp. 477.<br />
Nietzsche F., La nascita del<strong>la</strong> trage<strong>di</strong>a, Newton, Roma 1995, pp. 309.<br />
Nigro Covre Jo<strong>la</strong>nda, Espressionismo, Art Dossier Giunti, Firenze 1997, pp. 48.<br />
Powels Louis e Bergier Jacque, <strong>Il</strong> mattino dei maghi, Mondatori, Mi<strong>la</strong>no 1997, pp. 516.<br />
Schopenhauer Arthur, La saggezza del<strong>la</strong> vita - Aforismi, Newton&Compton, Roma<br />
1994, pp. 198.<br />
Schopenhauer A., <strong>Il</strong> <strong>mondo</strong> come volontà e rappresentazione, Laterza, Bari 1991, 2<br />
vol., pp. 688.<br />
Schwaller de Lubicz Renè Adolphe, Verbo Natura, E<strong>di</strong>tori Tre, Roma 1998, pp. 120.<br />
Tolstoj Lev Niko<strong>la</strong>jevic, Romanzi brevi, Casini, Roma/Firenze 1964, pp. 631.<br />
Weininger Otto, Delle cose Ultime, E<strong>di</strong>zioni Stu<strong>di</strong>o Tesi, Pordenone 1992, pp. 276.<br />
Wilde Oscar, Aforismi, Newton&Compton, Roma 1992, pp. 97.<br />
Wittgenstein Ludwig, Tractatus Logico-philosophicus e Quaderni 1914-1916, Einau<strong>di</strong>,<br />
Torino 1998, pp. 311.<br />
113
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
BIBLIOGRAFIA CRITICA<br />
Arbo Alessandro, Carlo Michelstaedter, E<strong>di</strong>zioni Stu<strong>di</strong>o Tesi, Pordenone 1996, pp. 128.<br />
Asor Rosa Alberto, “Michelstaedter: <strong>la</strong> persuasione e <strong>la</strong> rettorica”, in Letteratura<br />
Italiana vol. 4° - Le opere - <strong>Il</strong> novecento, Einau<strong>di</strong>, Torino 1995, pp. 265-331.<br />
AA VV, Dialoghi intorno a Michelstaedter (a cura <strong>di</strong> Sergio Campail<strong>la</strong>), Biblioteca<br />
Statale Isontina, Gorizia 1988, pp. 175.<br />
AA VV, L’immagine irraggiungibile. Dipinti e <strong>di</strong>segni <strong>di</strong> Carlo Michelstaedter,<br />
E<strong>di</strong>zioni del<strong>la</strong> Laguna, Gorizia 1992, pp. 453.<br />
Brianese Giorgio, L’arco e il destino, Francisci E<strong>di</strong>tore, Abano Terme 1985, pp. 157.<br />
Campail<strong>la</strong> Sergio, A ferri corti con <strong>la</strong> vita, Comune <strong>di</strong> Gorizia 1974, pp. 141.<br />
Campail<strong>la</strong> S., Pensiero e poesia <strong>di</strong> Carlo Michelstaedter, Patron, Bologna 1974, pp.<br />
175.<br />
Carchia Gianni, Retorica del sublime, Laterza, Bari 1990, pp. 187.<br />
Carchia G., “Linguaggio e mistica in Carlo Michelstaedter”, in Rivista <strong>di</strong> Estetica n° 9<br />
1981, pp. 126-132.<br />
Cecchi Emilio, “Un precursore dell’esistenzialismo”, in Corriere del<strong>la</strong> Sera, Mi<strong>la</strong>no, 8<br />
agosto 1958.<br />
Cerruti Marco, Carlo Michelstaedter: con alcuni testi ine<strong>di</strong>ti, Mursia, Mi<strong>la</strong>no 1967, pp.<br />
190.<br />
Dal<strong>la</strong> Mura Maddalena, “Persuasione, tragico ed arte in Carlo Michelstaedter”, in<br />
Itinerari (quadrimestrale <strong>di</strong> filosofia) 1/2001, E<strong>di</strong>trice Itinerari, Lanciano, pp. 23-62.<br />
Giordano Mario Gabriele, “<strong>Il</strong> pensiero e l’arte <strong>di</strong> Carlo Michelstaedter”, in Riscontri<br />
(trimestrale <strong>di</strong> attualità e cultura) 1/1978, Sabatia, Avellino, pp. 7-23.<br />
114
www.il<strong>mondo</strong><strong>di</strong>sofia.it<br />
Michelis Ange<strong>la</strong>, Carlo Michelstaedter: il coraggio dell’impossibile, Città Nuova,<br />
Roma 1997, pp. 242.<br />
Papini Giovanni, “Un suici<strong>di</strong>o metafisico”, in <strong>Il</strong> resto del Carlino, Bologna, 5 novembre<br />
1910.<br />
Pieri Piero, La scienza del tragico. Saggio su Carlo Michelstaedter, Cappelli, Bologna<br />
1989, pp. 543.<br />
Piromalli Antonio, Carlo Michelstaedter, La Nuova Italia, Firenze 1974, pp. 95.<br />
Pulina Giuseppe, L’imperfetto pessimista. Saggio sul pensiero <strong>di</strong> Carlo Michelstaedter,<br />
Lalli, Poggibonsi 1996, pp. 95..<br />
Ranke Joachim, “<strong>Il</strong> pensiero <strong>di</strong> Carlo Michelstaedter. Un contributo allo stu<strong>di</strong>o<br />
dell’esistenzialismo italiano”, in Giornale critico <strong>di</strong> filosofia italiana, Gorizia 1962, pp.<br />
518-539.<br />
www.michelstaedter.it<br />
BIBLIOGRAFIA INTERNET<br />
www.igxserver.uniba.it/lei/filosofi/michelstaedter.it<br />
115