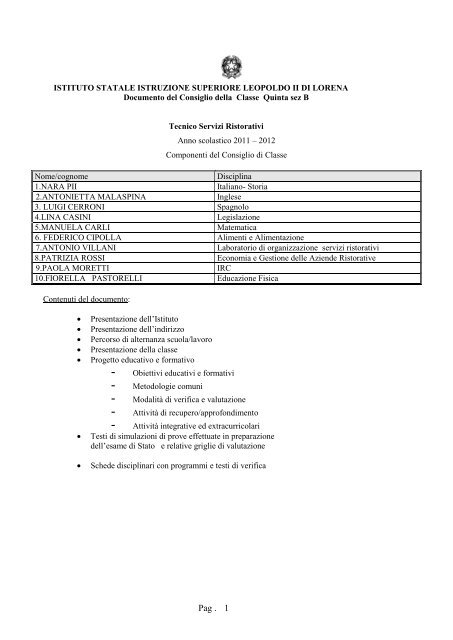Pag . 1 - Organigramma
Pag . 1 - Organigramma
Pag . 1 - Organigramma
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE LEOPOLDO II DI LORENA<br />
Documento del Consiglio della Classe Quinta sez B<br />
Tecnico Servizi Ristorativi<br />
Anno scolastico 2011 – 2012<br />
Componenti del Consiglio di Classe<br />
Nome/cognome Disciplina<br />
1.NARA PII Italiano- Storia<br />
2 2 2.ANTONIETTA MALASPINA Inglese<br />
3. LUIGI CERRONI Spagnolo<br />
4.LINA CASINI Legislazione<br />
5.MANUELA CARLI Matematica<br />
FE 6. FEDERICO CIPOLLA Alimenti e Alimentazione<br />
77 7.ANTONIO VILLANI Laboratorio di organizzazione servizi ristorativi<br />
8.PATRIZIA ROSSI Economia e Gestione delle Aziende Ristorative<br />
9. 9.PAOLA MORETTI IRC<br />
10.FIORELLA PASTORELLI Educazione Fisica<br />
Contenuti del documento:<br />
Presentazione dell’Istituto<br />
Presentazione dell’indirizzo<br />
Percorso di alternanza scuola/lavoro<br />
Presentazione della classe<br />
Progetto educativo e formativo<br />
- Obiettivi educativi e formativi<br />
- Metodologie comuni<br />
- Modalità di verifica e valutazione<br />
- Attività di recupero/approfondimento<br />
- Attività integrative ed extracurricolari<br />
Testi di simulazioni di prove effettuate in preparazione<br />
dell’esame di Stato e relative griglie di valutazione<br />
Schede disciplinari con programmi e testi di verifica<br />
<strong>Pag</strong> . 1
1. Italiano pag. 47-56<br />
2. Storia pag. 57-62<br />
3. Inglese pag. 63-68<br />
4. Spagnolo pag. 69- 73<br />
5. Legislazione pag. 74- 79<br />
6. Matematica pag. 80 -84<br />
7. Alimenti e Alimentazione pag. 85- 88<br />
8. Laboratorio di organizzazione servizi ristorativi pag. 89- 93<br />
9. Economia e Gestione delle Aziende Ristorative pag. 94- 100<br />
7. IRC pag. 101-102<br />
8. Educazione Fisica pag. 103-106<br />
<strong>Pag</strong> . 2
L’IDENTITA’ DELL’ISTITUTO<br />
PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO<br />
L’ I.S.I.S. “Leopoldo II di Lorena” costituisce una nuova Istituzione Scolastica nata a seguito della<br />
Delibera regionale in materia di programmazione della rete scolastica e al dimensionamento delle<br />
Istituzioni scolastiche autonome (DGRT n°40 del gennaio 2011)<br />
La nuova realtà scolastica, in cui sono confluiti l’Istituto Superiore di Istruzione tecnica e<br />
Professionale “Leopoldo II di Lorena” e parte dell’Istituto Professionale “L.Einaudi”. Entrambi<br />
le scuole, si sono sempre distinte per la capacità di promuovere valori come la salvaguardia<br />
dell’ambiente, lo sviluppo sostenibile, la sana alimentazione e la valorizzazione delle tipicità del<br />
territorio, educando gli studenti a comportamenti basati sul rispetto dell’ambiente e sulla<br />
solidarietà.<br />
L’attuale configurazione della scuola nel nuovo ordinamento voluto dalla riforma propone un’ampia<br />
e differenziata offerta formativa articolata in due filiere: la filiera agroalimentare e la filiera<br />
sanitaria.<br />
filiera agro-alimentare<br />
istituto tecnico settore tecnologico<br />
indirizzo agraria e agroindustria con le articolazioni<br />
o gestione ambiente e territorio<br />
o produzioni e trasformazioni<br />
o viticoltura ed enologia<br />
istituto professionale settore servizi<br />
servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale<br />
servizi per l’enogastronomia e l’ospitalita’ alberghiera con le articolazoni:<br />
o accoglienza turistica<br />
o sala e vendita<br />
o enogastronomia<br />
filiera sanitaria<br />
istituto tecnico settore tecnologico<br />
indirizzo chimica, materiali e biotecnologie con articolazione<br />
o biotecnologie sanitarie<br />
istituto professionale settore servizi<br />
indirizzo socio sanitario<br />
o servizi socio sanitari<br />
istituto professionale Chimico biologico ( vecchio ordinamento) : classi 3°,4° e 5°.<br />
La scuola, inoltre, ponendosi sia come centro di formazione professionale, sia come polo di<br />
formazione integrata superiore, ha acquisito nel suo insieme una nuova identità educativa e<br />
culturale che affonda le sue radici nel territorio maremmano e che attraverso la logica della filiera<br />
vuole prospettare orizzonti di crescita culturale e professionale.<br />
L’orientamento, infine, rappresenta lo sfondo integratore del progetto educativo: le sue azioni<br />
sono principalmente rivolte allo sviluppo di competenze orientative quali: l’attivazione critica<br />
nei confronti dei problemi, la canalizzazione delle energie rispetto agli obiettivi, la<br />
responsabilizzazione verso gli impegni. La prima forma di orientamento avviene attraverso<br />
l’Accoglienza che non si limita alla fase iniziale del percorso , ma è sentita piuttosto come un<br />
<strong>Pag</strong> . 3
principio informatore ed una modalità permanente di relazione con lo studente. L’ impegno<br />
continuo a rilevare bisogni espliciti ed impliciti degli studenti si traduce in interventi di riorientamento<br />
in itinere in funzione delle loro attitudini e aspirazioni. Alla fine del percorso agli<br />
studenti sono fornite una serie di informazioni sulle prospettive legate alla prosecuzione degli<br />
studi o all’inserimento nel mondo del lavoro, che, unite al bagaglio di formazione e di<br />
autoconsapevolezza, ne facilitano la frequenza di corsi universitari e/o di corsi post-diploma e/o<br />
di specializzazione o, in alternativa, l’avvio di attività lavorative.<br />
<strong>Pag</strong> . 4
IL PROFILO PROFESSIONALE<br />
PRESENTAZIONE DELL’INDIRIZZO<br />
Le attuali classi quinte, non ancora coinvolte nel riordino degli Istituti Professionali introdotto con<br />
DPR 87/2010, hanno, per quadro normativo, un percorso formativo che prevede, al termine del<br />
terzo anno, una Qualifica Professionale di Operatore a cui segue un biennio cosidetto di “postqualifica”.<br />
TECNICO DEI SERVIZI RISTORATIVI<br />
La tipologia delle qualifiche, dei diplomi<br />
- Operatore dei Servizi di Cucina oppure Operatore dei Servizi di Sala e Bar, alla fine del<br />
terzo anno<br />
- Tecnico dei Servizi Ristorativi alla fine del quinto anno.<br />
Il Tecnico dei Servizi di Ristorazione è il responsabile delle attività di ristorazione nelle varie<br />
componenti in cui essa si articola, in rapporto anche alla specifica tipologia della struttura<br />
ristorativa in cui opera. La sua formazione è orientata a sviluppare sia le competenze relative alla<br />
produzione che quelle relative alla distribuzione delle bevande e dei pasti e dei relativi abbinamenti.<br />
Dovrà avere specifiche competenze nel campo dell’approvvigionamento delle derrate, del controllo<br />
qualità-quantità-costi della produzione e distribuzione dei pasti, dell’allestimento di buffet e di<br />
banchetti (organizzati in occasioni conviviali sia all’interno che all’esterno dell’azienda), della<br />
organizzazione del lavoro e della guida di un gruppo e delle sue relazioni con gruppi di altri servizi.<br />
Poiché potrà assumere livelli di responsabilità che possono essere anche elevati, dovrà possedere<br />
conoscenze culturali, tecniche e organizzative rispetto all’intero settore e in particolare sulle<br />
seguenti problematiche:<br />
Il mercato ristorativo e i suoi principali segmenti<br />
L’andamento degli stili alimentari e dei consumi locali, nazionali, internazionali<br />
L’igiene professionale,nonché le condizioni igienico-sanitarie del posto di lavoro<br />
I moderni impianti tecnologici, le attrezzature e le dotazioni di servizio<br />
Le tecniche di lavorazione, la cottura e la presentazione degli alimenti<br />
La merceologia e le più innovative tecniche di conservazione degli alimenti anche alla luce<br />
della moderna dietetica<br />
L’antinfortunistica e la sicurezza dei lavoratori nel reparto<br />
I principali istituti giuridici che interessano la vita di un’azienda ristorativi<br />
Gli strumenti che può utilizzare un’azienda per conoscere il mercato, per programmare e<br />
controllare la sua attività e quella dei singoli reparti.<br />
Date le sue funzioni di organizzazione del reparto e di coordinamento con gli altri reparti nonché di<br />
rapporto con i fornitori e i clienti, il Tecnico dei servizi di Ristorazione deve saper utilizzare due<br />
lingue straniere e possedere capacità di comunicazione, di comprensione delle esigenze del<br />
personale e della clientela e di rappresentazione delle finalità dell’azienda.<br />
Sono numerose le occasioni offerte agli studenti di confrontarsi con i colleghi di altri istituti<br />
partecipando ai concorsi organizzati sul territorio nazionale e con le problematiche connesse alle<br />
attività lavorative, anche di natura imprenditoriale, come la gestione di eventi all’interno della<br />
scuola e la partecipazione a manifestazioni organizzate da enti esterni.<br />
<strong>Pag</strong> . 5
PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO<br />
L’alternanza scuola lavoro, introdotta dall’art.4 della legge n.53 del 28/03/2003 e disciplinata dal D.<br />
Lg.vo n. 77 del 15 aprile 2005, si configura come una metodologia innovativa di apprendimento.<br />
Lo stesso Decreto Legislativo, all’ art1.c1 definisce l’alternanza scuola lavoro come una “modalità<br />
di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell'istruzione e<br />
della formazione professionale, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base,<br />
l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro” e, all’art.1 c.2 attribuisce la<br />
responsabilità di progettare, attuare, verificare e valutare i percorsi in alternanza all’Istituzione<br />
Scolastica<br />
L’alternanza “risponde a bisogni individuali di istruzione e formazione” attraverso finalità ben<br />
definite:<br />
attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed<br />
educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente<br />
la formazione in aula con l'esperienza pratica;<br />
arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di<br />
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;<br />
favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli<br />
stili di apprendimento individuali;<br />
realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo<br />
del lavoro e la società civile;<br />
correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.<br />
Nell’Istruzione Professionale, nelle quarte e quinte classi funzionanti a partire dall’anno scolastico<br />
2010/2011 e sino alla messa a regime del nuovo ordinamento di Riordino dell’Istruzione,<br />
l’alternanza scuola lavoro, con un monte orario complessivo di 132 ore nel biennio, va a sostituire<br />
la storica area di professionalizzazione. (Art. 8. D.P.R. 15 marzo 2010, n.87)<br />
Nell’a.s. 2010/2011 tutte le classi IV dell’ex Istituto “L.Einaudi” hanno svolto 104 ore certificabili<br />
di Alternanza scuola lavoro.<br />
Nell’a.s. 2011/12 le ore svolte nelle V classi sono:<br />
Indirizzo Servizi Sociali: 90 ore<br />
Indirizzo Turistici: 32 ore nella classe 5AST e 37 nella 5BST<br />
Indirizzo Servizi Ristorativi: 32 ore<br />
L'alternanza scuola lavoro si fonda sull'intreccio tra le scelte educative della scuola, i fabbisogni<br />
professionali delle imprese del territorio, le personali esigenze formative degli studenti.<br />
Tutti i Docenti del Consiglio di Classe seguono gli allievi durante le loro attività di alternanza<br />
scuola lavoro e tutti prendono parte alla valutazione del loro operato. ( Delibera Collegio Docenti 7<br />
febbraio 2012). Tale valutazione espressa dall’intero Consiglio di classe, che si traduce in un<br />
punteggio che va da 0,00 a 0,50, va a sommarsi alla media finale dei voti riportati da ogni singolo<br />
alunno secondo la seguente tabella:<br />
GIUDIZIO PUNTEGGI<br />
Sufficiente 0,00 o 0,10<br />
Discreto 0,10 o 0,20<br />
Buono 0,20 o 0,30<br />
Distinto 0,30 o 0,40<br />
Ottimo 0,40 o 0,50<br />
<strong>Pag</strong> . 6
Tale procedura fornisce una valutazione specifica e autonoma di un segmento fondamentale della<br />
formazione che, negli Istituti Professionali, diventa obbligatoria.<br />
Per la classe IV il punteggio relativo all’alternanza viene assegnato nello scrutinio finale (giugno se<br />
lo studente non ha la sospensione del giudizio, agosto in caso di giudizio sospeso). Per la classe V il<br />
punteggio viene assegnato a giugno in fase di ammissione e viene attribuito nella sua totalità solo<br />
nel caso in cui non si rilevino discrepanze tra le proposte di voto dei docenti nelle singole discipline<br />
e la valutazione finale assegnata dal C.d.C.<br />
Tutte le attività, coerenti con il POF e con i profili in uscita, sono progettate e realizzate con<br />
l’obiettivo di sviluppare competenze trasversali e tecnico-professionali alla cui osservazione<br />
partecipano oltre ai docenti della classe anche i tutor aziendali e gli esperti esterni.<br />
Nella valutazione le attività, mirate all’acquisizione delle competenze, incidono sul punteggio finale<br />
per 80%, mentre la partecipazione e la frequenza alle attività progettate e realizzate per il restante<br />
20%.<br />
Il Consiglio di Classe nel processo di valutazione è chiamato a pronunciarsi su tre competenze<br />
trasversali comuni a tutti gli indirizzi:<br />
Senso di iniziativa e di imprenditorialità: saper tradurre le idee in azione grazie alla<br />
creatività, l’innovazione e l’assunzione di rischi e la capacità di pianificare e di gestire<br />
progetti per raggiungere obiettivi<br />
Collaborare e partecipare: lavorare insieme per uno scopo comune, o anche prestare il<br />
proprio aiuto a qualcuno. Prendere parte a un’attività insieme ad altre persone<br />
Imparare a imparare: acquisire conoscenze e capacità attraverso lo studio, l'esperienza e<br />
il confronto con gli altri. Essere capaci di studiare autonomamente, e soprattutto di<br />
comprendere di cosa si ha bisogno per aumentare le proprie conoscenze e le proprie<br />
competenze anche al di fuori della scuola<br />
Accanto a queste competenze è stata individuata, per ogni indirizzo di studio, una specifica<br />
competenza tecnico professionale. Per il Tecnico dei Servizi Ristorativi è: saper valorizzare<br />
l’utilizzo dei prodotti tipici del territorio per una cucina di qualità, realizzando eventi a tema e<br />
rispondendo all’evoluzione del gusto e ai moderni stili alimentari.<br />
Il modulo pratico di indirizzo ha avuto come filo conduttore la valorizzazione dei prodotti tipici del<br />
territorio e la sana alimentazione nella logica della filiera agro-alimentare. Le attività pratiche si<br />
sono concluse con i pranzo-evento “Fantasie di prodotti tipici” , “Pranzo con delitto al ristorante” e<br />
con la visita presso la Fiera Enogastronomica “Tirreno CT” di Massa Carrara.<br />
<strong>Pag</strong> . 7
EVOLUZIONE DELLA CLASSE<br />
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE<br />
L’attuale classe proviene dagli studenti di seconda lingua spagnolo che, alla fine del monoennio,<br />
dopo il conseguimento della qualifica di Operatore Servizi Cucina ed Operatore Servizi Sala Bar,<br />
sono andati a costituire la classe 4 sez. B dei Servizi Ristorativi.<br />
In questo gruppo, composto da n. 23 alunni n. 4 studenti provenivano dai Servizi Sala–Bar, n. 14<br />
dai Servizi Cucina e n° 5 erano ripetenti.<br />
Il quadro didattico si presentava insoddisfacente per la preparazione debole ed incerta di diversi<br />
studenti, per la scarsa motivazione allo studio e la limitata disponibilità a recepire gli stimoli<br />
culturali offerti.<br />
Il rendimento scolastico era inoltre condizionato dalla presenza di un nutrito numero di allievi,<br />
soprattutto i ripetenti, i quali, poco inclini allo studio, spesso confusionari e poco corretti,<br />
influenzavano il comportamento degli altri rallentando talvolta il normale svolgimento delle<br />
lezioni.<br />
Nella classe si sono comunque sempre evidenziati un ristretto gruppo di alunni diligenti e<br />
partecipi che realizzavano un discreto profitto pur non riuscendo a coinvolgere i compagni nella<br />
crescita culturale.<br />
A conclusione del quarto anno alcuni allievi, potenziando l’applicazione e l’impegno, avevano<br />
conseguito progressi nel profitto e recuperato in parte le carenze di base, pertanto venivano<br />
ammessi alla classe successiva.<br />
Complessivamente: n. 3 degli studenti ripetenti cessarono la frequenza già poco dopo l’avvio<br />
dell’anno, per n. 4 studenti fu deliberata la non ammissione, poiché non si era registrato alcun<br />
miglioramento, nonostante gli interventi e le strategie messe in atto e, pertanto, solo n.16 allievi, di<br />
cui n. 2 con debito formativo, superato nel mese di agosto, venivano ammessi alla classe quinta.<br />
PROFILO DELLA CLASSE<br />
La V sez. B SR è attualmente costituita da n. 17 alunni, (n. 11 femmine e n. 6 maschi), compresa<br />
una studentessa ripetente ,proveniente dalla classe quinta A SR dello scorso anno scolastico.<br />
Dall’ a.s. 2007/2008 è presente un’allieva straniera, originaria dell’Albania, che ha raggiunto un<br />
sufficiente livello di competenze linguistiche, sia nella produzione scritta, che in quella orale.<br />
Le lingue straniere studiate sono l’Inglese e lo Spagnolo.<br />
Nel passaggio dalla classe quarta alla quinta sono cambiati i docenti di : Spagnolo, Legislazione,<br />
Educazione Fisica , Economia e Gestione delle Aziende Ristorative, Matematica; tale avvicendarsi<br />
di insegnanti non sempre ha favorito l’acquisizione dei contenuti disciplinari e il relativo<br />
rendimento.<br />
La maggioranza del gruppo è pendolare e risiede in comuni diversi della provincia.<br />
Due sono studenti lavoratori e quasi tutti gli altri , durante i giorni feriali/ festivi o nel periodo<br />
estivo, si dedicano ad attività lavorative nell’ambito dell’indirizzo di studio.<br />
Gli alunni, mediamente dotati di buone attitudini pratiche e molto motivati verso le attività<br />
laboratoriali dello specifico settore ristorativo, si sono, quasi tutti, mostrati disponibili a partecipare<br />
a banchetti, eventi, concorsi sia nelle iniziative curricolari che extra curricolari organizzate dalla<br />
scuola; i risultati conseguiti sono stati spesso positivi e degni di nota. Nelle materie più teoriche<br />
purtroppo il livello generale di formazione si è mantenuto debole, per conoscenze poco solide, per<br />
carenze logico-linguistiche e di utilizzo del linguaggio tecnico, per la produzione di testi poco<br />
approfonditi, per la lentezza nella rielaborazione delle tematiche prese in esame.<br />
<strong>Pag</strong> . 8
Per diversi alunni lo studio è stato poco costante e finalizzato soprattutto alle verifiche, per molti<br />
di questi studenti è forte la motivazione ad inserirsi nel mondo del lavoro e a realizzarsi nel settore<br />
alberghiero e della ristorazione.<br />
Da questo quadro emerge qualche alunno, che avendo partecipato con interesse e in modo<br />
costruttivo al dialogo educativo fin dall’inizio dell’anno, dimostra di essere in possesso sia di una<br />
adeguata preparazione in tutte le discipline che di discrete attitudini nel settore professionale.<br />
PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AL DIALOGO EDUCATIVO<br />
Gli incontri con le Famiglie sono stati rari, e limitati ai ricevimenti generali, tenuti il 13 Dicembre<br />
e il 12 Aprile di questo a. s. Le informazioni sull’andamento didattico/disciplinare sono state<br />
veicolate soprattutto attraverso le valutazioni periodiche trasmesse alle famiglie, nel mese di<br />
Novembre, Gennaio (pagella) e Marzo. In taluni casi il coordinatore ha contattato direttamente la<br />
famiglia. Costante è stata la rilevazione della frequenza, sia da parte della scuola (con mezzi<br />
informatici) , che del coordinatore della classe.<br />
<strong>Pag</strong> . 9
PROGETTO EDUCATIVO-FORMATIVO<br />
Considerati i livelli di partenza e la fisionomia della classe gli interventi del consiglio sono stati<br />
finalizzati alla crescita individuale, al recupero delle competenze, abilità e conoscenze di base, al<br />
superamento delle specifiche carenze disciplinari anche con alcuni interventi pomeridiani, al<br />
consolidamento del metodo di studio poco organizzato e bisognoso di guida, all’acquisizione delle<br />
nuove tematiche affrontate. Progressivamente la classe ha seguito le attività didattiche in un clima<br />
più sereno, pur seguendo i propri ritmi, e si è potuto verificare un maggior senso di responsabilità e<br />
di maturità cognitiva.<br />
Sul piano comportamentale episodicamente è stato necessario fare ricorso, sia a richiami personali<br />
che generali e concordare obiettivi comportamentali finalizzati ad un maggior rispetto delle<br />
regole previste dal regolamento di Istituto, e, in particolare, ad un maggior rispetto nelle relazioni<br />
all’interno del gruppo e verso i docenti. Tali finalità sono state conseguite riscontrando<br />
miglioramenti nella seconda fase dell’anno scolastico.<br />
OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVI<br />
Considerando che la figura del Tecnico dei servizi Ristorativi implica la fruizione di competenze<br />
non solo sul piano professionale, ma anche su quello culturale, il C.d.C. ha previsto il<br />
conseguimento dei seguenti obiettivi educativi disciplinari e trasversali, concordati nelle riunioni di<br />
consiglio di classe o di dipartimento disciplinare e fatti propri:<br />
o capacità di esprimersi con un linguaggio chiaro e corretto<br />
o capacità di analisi e collegamento autonomo delle conoscenze<br />
o capacità di operare collegamenti, anche in ambito pluridisciplinare<br />
o capacità di esprimere giudizi personali<br />
o capacità di organizzare il proprio lavoro in maniera autonoma<br />
I docenti hanno pertanto finalizzato i loro interventi a potenziare l’uso di un lessico specifico, a<br />
favorire collegamenti interdisciplinari, a creare occasioni di sviluppo delle capacità logicolinguistiche<br />
e di sistematizzazione dei contenuti<br />
Come obiettivi formativi il consiglio di classe ha previsto:<br />
o la disponibilità alla crescita e al cambiamento<br />
o l’acquisizione del senso di responsabilità in ambito scolastico e lavorativo<br />
La classe conferma un profilo didattico eterogeneo riguardo a conoscenze, capacità e competenze;<br />
si distinguono tre livelli di preparazione:<br />
il primo è caratterizzato da pochi elementi che, per l’impegno e prerequisiti, sono in grado di<br />
rielaborare quanto appreso, di esprimersi con una certa proprietà ed hanno conseguito una discreta<br />
preparazione globale.<br />
Il secondo, che interessa gran parte della classe, si attesta globalmente nell’area della sufficienza o<br />
quasi sufficienza, ma evidenzia una preparazione poco approfondita e/o disorganica.<br />
Il terzo livello comprende alcuni allievi i quali, per ricorrenti assenze effettuate ed impegno non<br />
adeguato, hanno conseguito una formazione incerta e settoriale<br />
<strong>Pag</strong> . 10
METODOLOGIE COMUNI<br />
L’attività di tutti i docenti si è concentrata nello sviluppo e consolidamento del livello di formazione<br />
della classe, in vista della preparazione agli esami di Stato.<br />
Le metodologie comuni individuate dal consiglio di classe sono le seguenti:<br />
o Articolazione del lavoro in moduli<br />
o Lezione frontale e/o partecipata<br />
o Svolgimento di attività pratico/operative<br />
o Studio guidato ai fini dell’acquisizione di un adeguato metodo di lavoro<br />
o Esercitazioni da svolgere a casa<br />
o Lettura e interpretazione di vari testi<br />
o Prove strutturate, verifiche in itinere e sommative a conclusione di ciascun modulo<br />
o Interrogazioni, anche programmate<br />
MEZZI E STRUMENTI<br />
Libro di testo, fotocopie ad integrazione del manuale in adozione, schematizzazioni, sussidi<br />
audiovisivi e multimediali.<br />
MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE<br />
Per la valutazione il CdC ha fatto riferimento ai criteri adottati nel Collegio dei docenti, fatti propri<br />
da questo C.d.C. e riportati nella Tabella che segue:<br />
<strong>Pag</strong> . 11
CRITERI DI VALUTAZIONE<br />
Approvati nel Collegio Docenti 4-10- 2011<br />
LIVELLO VOTO DESCRIZIONE<br />
1° 1-2 Non conosce e/o ricorda regole, termini, concetti, procedimenti; non<br />
comprende adeguatamente il testo e non riesce ad eseguire semplici<br />
compiti; non applica adeguatamente regole e procedimenti; non<br />
evidenzia capacità di analisi e di sintesi; non possiede capacità di<br />
valutazione; non è in grado di utilizzare i contenuti delle unità<br />
didattiche. Rifiuta la partecipazione al dialogo educativo e non<br />
raggiunge nessuno degli obiettivi curriculari previsti<br />
2° 3 Conosce e/o ricorda regole, termini, concetti, procedimenti in modo<br />
estremamente frammentario e superficiale; non comprende<br />
adeguatamente il testo e commette gravi errori nell’esecuzione di<br />
semplici compiti; non applica adeguatamente regole e procedimenti;<br />
non evidenzia autonome capacità di analisi e di sintesi; non possiede<br />
capacità di valutazione; non è in grado di utilizzare i contenuti delle<br />
unità didattiche.<br />
3° 4 Non conosce e/o ricorda parzialmente regole, termini, concetti,<br />
procedimenti; comprende faticosamente e parzialmente il testo; applica con<br />
serie difficoltà regole e procedimenti; evidenzia insufficienti capacità di analisi<br />
e di sintesi; possiede insufficienti capacità di valutazione; non è in grado di<br />
utilizzare correttamente i contenuti delle unità didattiche.<br />
4° 5 Conosce e/o ricorda sufficientemente regole, termini, concetti,<br />
procedimenti; comprende sufficientemente il testo; applica con<br />
difficoltà e in maniera non appropriata regole e procedimenti; evidenzia scarse<br />
capacità di analisi, di sintesi e di valutazione; utilizza in maniera imprecisa i<br />
contenuti delle unità didattiche<br />
5° 6 Conosce e/o ricorda sufficientemente regole, termini, concetti,<br />
procedimenti; comprende sufficientemente il testo; applica in modo<br />
sufficientemente corretto regole e procedimenti; evidenzia mediocri<br />
capacità di analisi, di sintesi e di valutazione; è in grado di utilizzare<br />
correttamente i contenuti delle unità didattiche<br />
6° 7 Conosce e/o ricorda discretamente regole, termini, concetti,<br />
procedimenti; comprende adeguatamente il testo; applica in modo<br />
adeguato regole procedimenti e processi; evidenzia sufficienti capacità<br />
di analisi, di sintesi e di valutazione; utilizza razionalmente i contenuti<br />
delle unità didattiche.<br />
7° 8 Conosce e comprende bene regole, termini, concetti e procedimenti ed è<br />
perfettamente in grado di applicarli; evidenzia discreta capacità di<br />
analisi, di sintesi e valutazione<br />
8° 9-10 Conosce e comprende bene regole, termini, concetti e procedimenti ed è<br />
perfettamente in grado di applicarli; evidenzia buone o ottime capacità di<br />
analisi, di sintesi e valutazione<br />
Si ritengono criteri fondamentali di valutazione, in aggiunta a quelli cognitivi, tali anche da<br />
modificarli :<br />
o il livello di partenza<br />
o i progressi<br />
o l’impegno e la partecipazione<br />
La valutazione prevede l’uso di numeri interi.<br />
•<br />
<strong>Pag</strong> . 12
Le verifiche si sono realizzate in prove strutturate, verifiche scritte in itinere e sommative al termine<br />
di ciascun modulo, verifiche orali e scritte con particolare cura alla specificità del linguaggio,<br />
simulazioni, analisi di casi, problem solving, esercitazioni pratiche<br />
ATTIVITÀ DI RECUPERO/APPROFONDIMENTO<br />
Sono state attivate strategie adeguate al contenimento dei rischi di insuccesso/difficoltà: recupero<br />
in itinere e sviluppo di abilità-competenze in alcune discipline, recupero di parti del programma,<br />
potenziamento del parlato attraverso frequenti verifiche orali e talvolta, per andare incontro alle<br />
esigenze degli studenti, interrogazioni programmate.<br />
L’attività è stata svolta in itinere; è stato gestita in modo autonomo da ogni docente per tutto l’a.s. e<br />
durante le pause didattiche .<br />
A partire dal giorno 08 febbraio e fino al 19 marzo è stato attuato il recupero pomeridiano di<br />
Matematica, disciplina in cui la classe presentava difficoltà inerenti al linguaggio tecnico, alla<br />
risoluzione di esercizi e alla comprensione di concetti inerenti al programma. I risultati ottenuti<br />
sono stati parziali .<br />
E’ in fase di attuazione un’attività di approfondimento pomeridiano per Alimenti ed Alimentazione<br />
resasi necessaria per approfondire alcune tematiche anche in previsione dell’esame di Stato.<br />
MODULI TRASVERSALI E PLURIDISCIPLINARI<br />
Nella seconda fase dell’a.s. si è svolto il modulo trasversale “ IL LAVORO ED I CONTRATTI<br />
ATIPICI”<br />
Il modulo è stato affrontato contestualmente al programma di Storia, di Economia e Gestione delle<br />
Aziende Ristorative, Legislazione.<br />
La competenza relativa alla capacità di operare collegamenti, anche in ambito pluridisciplinare è<br />
stata globalmente raggiunta.<br />
ATTIVITÀ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICOLARI<br />
Alternanza scuola lavoro<br />
Le attività inerenti il modulo pratico di indirizzo sono iniziate il 18 febbraio e si sono concluse il 31<br />
Marzo. Le esercitazioni riferite al settore cucina si sono sviluppate su piatti a base di pesce (per<br />
sette studenti) o sui formaggi (per sei studenti); i quattro studenti provenienti dalla qualifica di salabar<br />
hanno svolto esercitazioni pratiche di approfondimento nel proprio settore di riferimento.<br />
Il 18 aprile si è svolto l’evento conclusivo .<br />
Le lezioni sono state tenute da esperti, sia interni all’Istituto che provenienti dal mondo del lavoro..<br />
Teoria e pratica si sono fusi perfettamente durante queste attività in cui gli studenti hanno<br />
evidenziato tutte le loro conoscenze e abilità per la buona progettazione e realizzazione dell’evento.<br />
I docenti del consiglio di classe hanno preso parte allo svolgimento del modulo pratico di indirizzo<br />
ai fini del monitoraggio sulla frequenza, partecipazione, comportamento e cura del materiale e della<br />
valutazione finale del percorso, tenuto conto anche della valutazione degli esperti. La presenza del<br />
gruppo è risultata globalmente puntuale, la partecipazione e l’interesse profusi abbastanza vivaci ,<br />
inoltre sono stati apprezzabili i risultati conseguiti durante la fase operativa e durante l’evento<br />
finale.<br />
Nel progettare il percorso di Alternanza scuola lavoro la scuola ha ritenuto importante sia far vivere<br />
ai propri studenti esperienze di confronto con altre realtà alberghiere o del mondo della ristorazione<br />
sia farli partecipare a convegni o corsi di approfondimento/conoscenza di tematiche di settore. In tal<br />
senso si menziona:<br />
<strong>Pag</strong> . 13
o Concorso “Giovani alla Ribalta” che si è tenuto presso le Terme di Chianciano nei giorni<br />
12 e 13 Ottobre, (hanno partecipato con successo 2 studenti)<br />
o Corso di 1° livello per aspiranti assaggiatori formaggio organizzato dall’ONAF nei<br />
giorni 02,16, 17, 23 Aprile (hanno partecipato 2 studenti)<br />
o Convegno “ Recupero, caratterizzazione e salvaguardia del patrimonio genetico locale<br />
della Maremma grossetana”, tenuto Ad Alberese il giorno 03 Aprile (due studentesse<br />
impegnate in attività di slow food).<br />
o Incontro con Legambiente “Mediterraneau Action Day”<br />
o Preparazione buffet per l’inaugurazione della nuova autonomia scolastica”Leopoldo II di<br />
Lorena”<br />
o Lezione sulle varie tipologie di formaggi, prodotti dal Caseificio di Manciano, con<br />
relativa degustazione tenuta dal direttore del Consorzio del Pecorino Toscano<br />
o Lezione sull’olio d’oliva IGP toscano e Dop Seggiano con relativa degustazione tenuta<br />
da esperto “Capo Panel”<br />
o Lezione sulle tecniche di cristallizazione del cioccolato con relativa elaborazione di<br />
dolci a base di cioccolato<br />
o Lezione sulle valorizzazione del pesce della costa con relativa elaborazione di ricette a<br />
base di pesce<br />
o Lezione sulla degustazione dei vini toscani con abbinamento cibo-vino tenuta da esperto<br />
Sommelier<br />
o Visita in fiera enogastronomica “Tirreno CT” a Massa Carrara<br />
o Evento organizzato con le scuole medie di <strong>Pag</strong>anico”Delitto di Classe”<br />
o Manifestazione “Formaremma” per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari del<br />
territorio<br />
o Dimostrazioni professionali per l’orientamento delle scuole medie<br />
Altre attività’<br />
o Visite guidate e viaggi d’Istruzione:<br />
o partecipazione di due studenti alla “Giornata della Memoria” tenuta presso il Mandela<br />
Forum di Firenze il 26/12/2012<br />
o Attività sportive: partecipazione a tornei di pallamano, presso il Palazzetto dello Sport<br />
di via Lago di Varano.<br />
o Tornei di calcio e di corsa campestre a cui hanno partecipato alcuni studenti<br />
o Attività di volontariato: incontro con volontari Avis, il 14/ 01/2012.<br />
o Una alunna ha aderito alla iniziativa per la donazione del sangue<br />
o Due studenti sono donatori di sangue presso l’ASL N° 9 – AREA GROSSETANA<br />
o Due alunne hanno aderito all’attività di volontariato presso la Ludoteca Stragatto di<br />
Castiglione della Pescaia ,organizzato dalla Diocesi di Grosseto, per n. 16 ore su 16 ore<br />
previste.<br />
<strong>Pag</strong> . 14
SIMULAZIONE DELLE PROVE DI ESAME<br />
( Nel corso dell’a.s.)<br />
PRIMA PROVA:<br />
Analisi di un testo letterario, in prosa e/o in poesia.<br />
Il saggio breve<br />
Articolo di giornale:l' articolo di opinione e/o di fondo<br />
Il Tema Tipologia C/D<br />
SECONDA PROVA :<br />
ALIMENTI E ALIMENTAZIONE<br />
Svolgimento di un tema. Prova relazionale<br />
SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA D' ESAME N°1<br />
Sono state effettuate due simulazioni : una il giorno 12 aprile , la seconda il 3 maggio .<br />
Materie : Storia, Inglese, Matematica, Economia e gestione aziendale ristorazione, Economia e<br />
gestione aziendale ristorazione<br />
Tipologia B/ C<br />
<strong>Pag</strong> . 15
ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE LEOPOLDO II DI LORENA<br />
SIMULAZIONE TERZA PROVA<br />
Anno scolastico 2011/2012<br />
Tipologia B/C<br />
Classe V B Operatore Servizi ristorativi<br />
CANDIDATO/A…………………………………………………… DATA 12/ 04/ 2012<br />
MATERIE :<br />
Storia,<br />
Inglese<br />
Matematica<br />
Economia e gestione aziendale ristorazione<br />
Laboratorio di organizzazione servizi ristorativi<br />
Per ogni materia vengono proposti 6 quesiti ( 4 a scelta multipla ; 2 aperti)<br />
Punteggio per ogni disciplina : punti 3 ( 0,25 per ciascuna domanda a scelta multipla ; 1 per<br />
ciascuna domanda aperta )<br />
Tempo previsto : 90 min.<br />
Punteggio raggiunto<br />
Storia …………………………. /15<br />
Inglese …………………………./15<br />
Matematica …………………………../15<br />
Econ. e gest. Az. ristorazione ……………………… /15<br />
Laboratorio org. Serv. ristorativi ………………………… /15<br />
TOTALE …………………………/15<br />
<strong>Pag</strong> . 16
STORIA<br />
1. Il processo di industrializzazione nell’Unione sovietica si svolse:<br />
(una sola risposta corretta )<br />
seguendo l’indicazione di Lenin, attraverso l’incentivazione della piccola attività<br />
imprenditoriale<br />
secondo le pianificazioni di Stalin, che ponevano al primo posto la costruzione di una grande<br />
industria pesante e degli armamenti, mediante un processo di industrializzazione forzata<br />
secondo le linee dettate da Stalin, con lo scopo di garantire ai cittadini sovietici un benessere<br />
paragonabile a quelli dei cittadini statunitensi<br />
secondo il programma di Trotskj, incentivando l’attività delle piccole industrie agricole<br />
2. Le condizioni di pace stipulate con la Germania dopo la I° guerra mondiale stabilivano:<br />
(una sola risposta corretta)<br />
il mantenimento da parte della Germania del “Corridoio polacco”, rivendicato alla Polonia<br />
la ricongiunzione alla Germania delle minoranze che abitavano la Cecoslovacchia, nella zona<br />
dei monti Sudeti<br />
la restituzione dell’Alsazia /Lorena alla Francia e la perdita temporanea dei bacini carboniferi<br />
della Saar e della Rhur, a vantaggio di Francia e Belgio<br />
la spartizione dei possedimenti coloniali tra le tre potenze vincitrici: Italia, Francia e Inghilterra<br />
3. La crisi che interessò gli Stati Uniti nel ’29 fu determinata :(una sola risposta corretta)<br />
dalla sospensione di ogni rapporto commerciale con l’Europa, a causa della situazione di<br />
arretratezza economica in cui questa versava nel dopoguerra<br />
dai debiti contratti dall’America per gli aiuti economici e militari offerti all’Europa durante la<br />
prima guerra mondiale<br />
dalla forte sovrapproduzione industriale ,per speculazioni finanziare incontrollate e per la corsa<br />
agli investimenti in borsa<br />
dalla politica liberista instaurata da Franklin Delano Roosenvelt durante la sua presidenza<br />
4. La conferenza di Monaco del 1938 stabiliva: (una sola risposta corretta )<br />
che Francia e Inghilterra avrebbero mantenuto una politica di appeasement verso la Germania<br />
accordandole il consenso di estendere i propri confini soltanto alla zona dei Sudeti , in<br />
Cecoslovacchia<br />
che Hitler avrebbe potuto annettersi tutta la Cecoslovacchia , ma non la Polonia<br />
che Mussolini avrebbe avuto il consenso per l’annessione dell’ Albania e della Grecia<br />
che la Germania avrebbe dovuto rinunciare al suo progetto di espansione per conquistare lo<br />
spazio vitale<br />
<strong>Pag</strong> . 17
5.ESPONI LA POLITICA RAZZIALE DI ADOLF HITLER ( max 8 righe)<br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
6. ESPONI LE CAUSE CHE DETERMINARONO LO SCOPPIO DELLA II° GUERRA<br />
MONDIALE<br />
(max.8 righe)<br />
.......................................................................................................……………………………………<br />
.........................................................................................................……………………………………<br />
.........................................................................................................……….……………………………<br />
..........................................................................................………………………………………………<br />
………………………………………………………………………………………………………………<br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
<strong>Pag</strong> . 18
LINGUA INGLESE<br />
1) Talk about :” COMMUNICATION AND INFORMATION”<br />
2) Talk about :” TIMING”<br />
1) A functions is:<br />
a) The service of food and drink<br />
b) The service of Chinese food<br />
c) The service of wine and champagne<br />
d) The service of food<br />
2 )Social functions are:<br />
a) weddings, anniversaries<br />
b) conferences, dinner dances<br />
c)meetings<br />
d) corporate entertaining<br />
<strong>Pag</strong> . 19
3) A banquet :<br />
a) is a large formal occasion<br />
b) provides bar facilities during a conference<br />
c) is an informal occasion<br />
d) is a corporate entertaining<br />
4) What are the most important elements the caterer has to consider?<br />
a) number of guests<br />
b) the wine price<br />
c) the age of guests<br />
d) price per couvert<br />
<strong>Pag</strong> . 20
MATEMATICA<br />
1. Il grafico in figura rappresenta:<br />
a) Una funzione di dominio R<br />
b) Una funzione di dominio R-xo<br />
c) Una relazione<br />
d) Una relazione di equivalenza<br />
2. La funzione<br />
2<br />
x 4<br />
y 2<br />
x 5x<br />
6<br />
Presenta:<br />
a) una discontinuità di prima specie e una di seconda<br />
b) una discontinuità di prima specie e una di terza<br />
c) due discontinuità di seconda specie<br />
d) una discontinuità di terza specie e una di seconda<br />
3. La funzione y=x 4 + x 2 è nel suo dominio:<br />
a) Positiva pari<br />
b) Positiva dispari<br />
c) Monotona pari<br />
d) Monotona dispari<br />
4. Se una funzione y=f(x), nel suo dominio, ha derivata prima sempre positiva allora la funzione:<br />
a) è crescente<br />
b) è decrescente<br />
c) presenta almeno un massimo<br />
d) presenta almeno un minimo<br />
1. Descrivi il grafico che segue relativamente a:<br />
a) C.d.E<br />
b) Intersezione con gli assi<br />
c) Segno<br />
d) Limiti, discontinuità, asintoti<br />
2. Della funzione<br />
<br />
ln 3 5<br />
Calcola derivata prima e seconda<br />
2<br />
y<br />
x x <br />
<strong>Pag</strong> . 21
Domande a risposta multipla :<br />
EGAR<br />
1. Il calcolo dei riscontri è una registrazione facente parte di:<br />
a) scritture di completamento<br />
b) scritture di integrazione<br />
c) scritture di ammortamento<br />
d) scritture di rettifica<br />
2. L’ammortamento è un procedimento tecnico contabile che serve a :<br />
a) deprezzare il valore di un costo pluriennale<br />
b) ripartire il valore di un costo pluriennale<br />
c) rivalutare il valore di un costo pluriennale<br />
d) ripartire e deprezzare il valore di un costo pluriennale<br />
3. Il bilancio d’esercizio è formato da :<br />
a) Stato patrimoniale e nota integrativa<br />
b) Conto economico e Stato patrimoniale<br />
c) Stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa<br />
d) Conto economico e nota integrativa<br />
4. E’ una caratteristica del finanziamento con Capitale proprio:<br />
a) l’obbligo della remunerazione<br />
b) l’obbligo della scadenza<br />
c) il maggior rischio<br />
d) il minor rischio<br />
Domande aperte :<br />
1. Indicate a cosa servono le scritture di assestamento , quando si redigono e come si articolano;<br />
________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________<br />
_______________________________________________________________________________<br />
2. Spiegate quali sono i principi contabili su cui si basa il Bilancio d’esercizio , facendo anche gli<br />
opportuni riferimenti formativi ;<br />
________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________<br />
<strong>Pag</strong> . 22
LABORATORIO SERVIZI RISTORATIVI<br />
Test a scelta multipla<br />
Rispondi a questa domanda segnalando la risposta giusta con una x<br />
1. Il servizio per regole è un metodo gestionale che si addice:<br />
a) solo alle catene di ristorazione<br />
b) alle catene di ristorazione e alla ristorazione industriale<br />
c) a tutti i tipi di ristorazione<br />
d) solo a quelli industriali<br />
2. Il metodo guida per un’organizzazione razionale consiste nel:<br />
a) controllare i processi di produzione<br />
b) definire gli standard di servizio per ottimizzare i mezzi a disposizione<br />
c) pianificare, svolgere il lavoro, controllare, revisionare le procedure<br />
d) controllare il personale<br />
3. Lo scopo principale dell’organigramma delle presenze è quello di :<br />
a) visualizzare la presenza del personale nell’arco della giornata per migliorare l’organizzazione<br />
b) controllare immediatamente eventuali ritardi nell’entrata in servizio<br />
c) assegnare gli incarichi a ogni addetto<br />
d) visualizzare la presenza dei faccini<br />
4. Il diagramma di funzione è utile per :<br />
a) valutare il tempo dedicato alle singole operazioni e la produttività di ogni addetto<br />
b) capire il funzionamento del piano dei lavori e delle presenze<br />
c) controllare la funzionalità dei percorsi e dei possibili incidenti<br />
d) controllare e capire la qualità della materia prima<br />
Rispondi alle seguenti domande :<br />
1) A cosa serve una scheda tecnica di produzione ?<br />
________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________<br />
_______________________________________________________________________________<br />
2) In che cosa consiste la tecnica della scomposizione in sottogruppi?<br />
________________________________________________________________________________<br />
_______________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________<br />
<strong>Pag</strong> . 23
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA<br />
CANDIDATO/A___________________________________<br />
RISPOSTE<br />
MULTIPLA<br />
A SCELTA PUNTEGGIO PUNTI OTTENUTI<br />
SCELTA MULTIPLA 1 O,25<br />
SCELTA MULTIPLA 2 O,25<br />
SCELTA MULTIPLA 3 O,25<br />
SCELTA MULTIPLA 4 O,25<br />
TOTALE PUNTI 1<br />
RISPOSTE SINGOLE PUNTEGGIO PUNTI<br />
OTTENUTI<br />
RISPOSTA 5 Contenuto: Linguaggio Capacità di analisi<br />
appropriato e sintesi<br />
Nullo 0 Nullo 0 Nullo 0<br />
Insuffic. 0,10 Insuffic. 0,05 Insufficiente 0<br />
Mediocre 0,30 Mediocre 0,10 Mediocre 0<br />
Sufficiente 0,50 Sufficiente 0,15 Sufficiente 0,05<br />
Buono 0,70 Buono 0,20 Buono 0,10<br />
TOTALE PUNTI 1<br />
RISPOSTA 6 Contenuto: Linguaggio Capacità di analisi<br />
appropriato e sintesi<br />
Nullo 0 Nullo 0 Nullo 0<br />
Insuffic. 0,10 Insuffic.<br />
0,05<br />
Insufficiente 0<br />
Mediocre 0,30 Mediocre 0,10 Mediocre 0<br />
Sufficiente 0,50 Sufficiente 0,15 Sufficiente<br />
0,05<br />
Buono 0,70 Buono<br />
Buono<br />
0,20<br />
0,10<br />
TOTALE PUNTI 1<br />
TOTALE PUNTEGGIO OTTENUTO _____/03<br />
<strong>Pag</strong> . 24
CAMPUS<br />
SIMULAZIONE PROVE ESAME<br />
26 APRILE I° PROVA : Italiano (Tutte le tipologie in linea con le disposizioni ministeriali)<br />
Tempi di svolgimento : 5 ore<br />
La simulazione della II° PROVA : ALIMENTI E ALIMENTAZIONE ,prevista per il 27 aprile è<br />
stata posticipata al 09 Maggio per motivi organizzativi.<br />
Tempi di svolgimento : 5 ore<br />
03 MAGGIO III° PROVA Tipologia B/C<br />
Tempi di svolgimento : 90 minuti<br />
04/05 Maggio : simulazione del colloquio : durata 5 ore<br />
PER I CRITERI DI VALUTAZIONE SI FA RIFERIMENTO ALLE GRIGLIE ALLEGATE<br />
ALLE SIMULAZIONI DELLE PROVE SVOLTE E ADOTTATE DAL C.D.C. DURANTE IL<br />
CORRENTE A.S.<br />
<strong>Pag</strong> . 25
ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE LEOPOLDO II DI LORENA<br />
SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA<br />
ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO DI ISTRUZIONE<br />
SECONDARIA SUPERIORE<br />
CAMPUS<br />
PROVA DI ITALIANO<br />
(per tutti gli indirizzi: di ordinamento e sperimentali)<br />
A.S. 2011/ 2012<br />
26/ 04/2012<br />
Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte<br />
TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO<br />
TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN SAGGIO BREVE O DI UN ARTICOLO DI<br />
GIORNALE<br />
1. AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO<br />
2. AMBITO SOCIO - ECONOMICO<br />
3. AMBITO STORICO - POLITICO<br />
4. AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO<br />
TIPOLOGIA C - TEMA DI ARGOMENTO STORICO<br />
TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE<br />
<strong>Pag</strong> . 26
TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO<br />
Analizza la parte finale del romanzo La coscienza di Zeno pubblicato nel 1923 dall’editore<br />
Cappelli di Bologna:<br />
“La vita attuale è inquinata alle radici. L’uomo s’è messo al posto degli alberi e delle bestie ed ha<br />
inquinata l’aria, ha impedito il libero spazio. Può avvenire di peggio. Il triste e attivo animale<br />
potrebbe scoprire e mettere al proprio servizio delle altre forze. V’è una minaccia di questo genere<br />
in aria. Ne seguirà una grande ricchezza…nel numero degli uomini. Ogni metro quadrato sarà<br />
occupato da un uomo. Chi ci guarirà della mancanza di aria e di spazio? Solamente al pensarci<br />
soffoco!<br />
Ma non è questo, non è questo soltanto.<br />
Qualunque sforzo di darci la salute è vano. Questa non può appartenere che alla bestia che conosce<br />
un solo progresso, quello del proprio organismo. Allorché la rondinella comprese che per essa non<br />
c’era altra possibile vita fuori dell’emigrazione, essa ingrossò il muscolo che muove le sue ali e che<br />
divenne la parte più considerevole del suo organismo. La talpa s’interrò e tutto il suo corpo si<br />
conformò al suo bisogno. Il cavallo s’ingrandì e trasformò il suo piede. Di alcuni animali non<br />
sappiamo il progresso, ma ci sarà stato e non avrà mai leso la loro salute.<br />
Ma l’occhialuto uomo, invece, inventa gli ordigni 1 fuori del suo corpo e se c’è stata salute e nobiltà<br />
in chi li inventò, quasi sempre manca in chi li usa. Gli ordigni si comperano, si vendono e si rubano<br />
e l’uomo diventa sempre più furbo e più debole. Anzi si capisce che la sua furbizia cresce in<br />
proporzione della sua debolezza. I primi suoi ordigni parevano prolungazioni del suo braccio e non<br />
potevano essere efficaci che per la forza dello stesso, ma oramai, l’ordigno non ha più alcuna<br />
relazione con l’arto. Ed è l’ordigno che crea la malattia con l’abbandono della legge che fu su tutta<br />
la terra la creatrice 2 . La legge del più forte sparì e perdemmo la selezione salutare. Altro che<br />
psicanalisi ci vorrebbe: sotto la legge del possessore del suo maggior numero di ordigni<br />
prospereranno malattie e ammalati.<br />
Forse traverso una catastrofe inaudita prodotta dagli ordigni ritorneremo alla salute. Quando i gas<br />
velenosi 3 non basteranno più, un uomo fatto come tutti gli altri, nel segreto di una stanza di questo<br />
mondo, inventerà un esplosivo incomparabile, in confronto al quale gli esplosivi attualmente<br />
esistenti saranno considerati quali innocui giocattoli. Ed un altro uomo fatto anche lui come tutti gli<br />
altri, ma degli altri un po’ più ammalato, ruberà tale esplosivo e s’arrampicherà al centro della terra<br />
per porlo nel punto ove il suo effetto potrà essere il massimo. Ci sarà un’esplosione enorme che<br />
nessuno udrà e la terra ritornata alla forma di nebulosa errerà nei cieli privi di parassiti e di<br />
malattie.”<br />
1. qui il termine non indica solo le armi, ma anche gli altri prodotti e le invenzioni della sua mente<br />
2. la legge della selezione naturale<br />
3. sono i gas asfissianti, come quelli usati nel corso della prima guerra mondiale<br />
Rispondi alle seguenti domande:<br />
1. Come si inserisce questo brano all’interno de La coscienza di Zeno?<br />
2. Che tipo di narratore abbiamo ? Quali sono le tecniche narrative che Svevo utilizza ?<br />
3. Cosa intende Svevo quando chiama l’uomo “triste e attivo animale”?<br />
4. Cosa significa la frase “qualunque sforzo di darci la salute è vano”?<br />
5. Caratterizza la malattia della .<br />
6. In quali passi del testo puoi intravedere anticipazioni di alcuni fra i più drammatici problemi<br />
attuali (questione ambientale, esplosione demografica, minaccia nucleare)?<br />
7. Si può dire che, secondo Svevo, l’uomo ha abbandonato e superato la legge della selezione<br />
naturale?<br />
<strong>Pag</strong> . 27
8. Zeno dice di essere guarito, il dottor S, lo ha invece negato nella prefazione. Chi ha ragione?<br />
Secondo te:<br />
è veramente guarito<br />
è diversamente ammalato<br />
rifiuta ogni distinzione tra malattia e salute<br />
mente<br />
dopo aver barrato l’opzione, spiega i motivi della tua scelta.<br />
9. Rifletti sulla profezia finale. L’esplosione di cui parla Zeno viene da lui temuta o auspicata? O<br />
sono vere tutte e due le cose? Rispondi sulla base del testo.<br />
TIPOLOGIA B-REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI<br />
GIORNALE”<br />
(puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti)<br />
AMBITO ARTISTICO LETTERARIO<br />
CONSEGNE<br />
Sviluppa l’argomento scelto o in forma di “saggio breve” o di “articolo di giornale”, utilizzando i<br />
documenti e i dati che lo corredano.<br />
Se scegli la forma del “saggio breve”, interpreta e confronta i documenti e i dati forniti e su<br />
questa base svolgi, argomentandola, la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue<br />
conoscenze ed esperienze di studio<br />
Da’ al saggio un titolo coerente con la tua trattazione e ipotizzane una destinazione editoriale<br />
(rivista specialistica, fascicolo scolastico di ricerca e documentazione, rassegna di argomento<br />
culturale, altro). Se scegli ” l’articolo di giornale” indica il titolo dell’articolo ed il tipo di<br />
giornale sul quale pensi che l’articolo debba essere pubblicato. Per entrambe le forme di scrittura<br />
non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo.<br />
ARGOMENTO : GLI AFFETTI FAMILIARI<br />
DOCUMENTI<br />
RITRATTO DELLA MIA BAMBINA<br />
La mia bambina con la palla in mano,<br />
con gli occhi grandi colore del cielo,<br />
e dell'estiva vesticciola: "Babbo<br />
- mi disse - voglio uscire oggi con te-.<br />
5 Ed io pensavo: Di tante parvenze<br />
che s'ammirano al mondo, io ben so a quali<br />
posso la mia bambina assomigliare.<br />
Certo alla schiuma, alla marina schiuma<br />
che sull'onde biancheggia, a quella scia<br />
10 ch'esce azzurra dai tetti e il vento sperde;<br />
anche alle nubi, insensibili nubi<br />
che si fanno e disfanno in chiaro cielo;<br />
e ad altre cose leggere e vaganti.<br />
[Umberto Saba :Cose leggere e vaganti, 1920]<br />
<strong>Pag</strong> . 28
A MIO PADRE<br />
Padre, se anche tu non fossi il mio<br />
padre, se anche fossi a me un estraneo,<br />
per te stesso egualmente t’amerei.<br />
Ché mi ricordo d’un mattin d’inverno<br />
che la prima viola sull’opposto<br />
muro scopristi dalla tua finestra<br />
e ce ne desti la novella allegro.<br />
Poi la scala di legno tolta in spalla<br />
di casa uscisti e l’appoggiasti al muro.<br />
Noi piccoli stavamo alla finestra.<br />
E di quell’altra volta mi ricordo<br />
che la sorella mia piccola ancora<br />
per la casa inseguivi minacciando<br />
(la caparbia avea fatto non so che).<br />
Ma raggiuntala che strillava forte<br />
dalla paura ti mancava il cuore:<br />
ché avevi visto te inseguir la tua<br />
piccola figlia, e tutta spaventata<br />
tu vacillante l’attiravi al petto,<br />
e con carezze dentro le tue braccia<br />
l’avviluppavi come per difenderla<br />
da quel cattivo ch’era il tu di prima.<br />
Padre, se anche tu non fossi il mio<br />
padre, se anche fossi a me un estraneo,<br />
fra tutti quanti gli uomini già tanto<br />
pel tuo cuore fanciullo t’amerei. (Camillo Sbarbaro : Pianissimo 1913)<br />
<strong>Pag</strong> . 29
IN MORTE DEL FRATELLO GIOVANNI<br />
Un dì, s'io non andrò sempre fuggendo<br />
di gente in gente, me vedrai seduto<br />
su la tua pietra, o fratel mio, gemendo<br />
il fior de' tuoi gentil anni caduto.<br />
La Madre or sol suo dì tardo traendo<br />
parla di me col tuo cenere muto,<br />
ma io deluse a voi le palme tendo<br />
e sol da lunge i miei tetti saluto.<br />
Sento gli avversi numi, e le secrete<br />
cure che al viver tuo furon tempesta,<br />
e prego anch'io nel tuo porto quiete.<br />
Questo di tanta speme oggi mi resta!<br />
Straniere genti, almen le ossa rendete<br />
allora al petto della madre mesta. (Ugo Foscolo, da Sonetti 1803 )<br />
LO SHIAFFO DEL PADRE MORENTE<br />
(………)Fu allora che avvenne la scena terribile che non dimenticherò mai e che gettò lontano<br />
lontano la sua ombra, che offuscò ogni mio coraggio, ogni mia gioia. Per dimenticarne il dolore, fu<br />
d'uopo che ogni mio sentimento fosse affievolito dagli anni.L'infermiere mi disse:- Come sarebbe<br />
bene se riuscissimo di tenerlo a letto. Il dottore vi dà tanta importanza!Fino a quel momento io ero<br />
rimasto adagiato sul sofà. Mi levai e andai al letto ove, in quel momento, ansante piú che mai,<br />
l'ammalato s'era coricato. Ero deciso: avrei costretto mio padre di restare almeno per mezz'ora nel<br />
riposo voluto dal medico. Non era questo il mio dovere?Subito mio padre tentò di ribaltarsi verso la<br />
sponda del letto per sottrarsi alla mia pressione e levarsi. Con mano vigorosa poggiata sulla sua<br />
spalla, gliel'impedii mentre a voce alta e imperiosa gli comandavo di non moversi. Per un breve<br />
istante, terrorizzato, egli obbedí. Poi esclamò:- Muoio!E si rizzò. A mia volta, subito spaventato dal<br />
suo grido, rallentai la pressione della mia mano. Perciò egli poté sedere sulla sponda del letto<br />
proprio di faccia a me. Io penso che allora la sua ira fu aumentata al trovarsi - sebbene per un<br />
momento solo - impedito nei movimenti e gli parve certo ch'io gli togliessi anche l'aria di cui aveva<br />
tanto bisogno, come gli toglievo la luce stando in piedi contro di lui seduto. Con uno sforzo<br />
supremo arrivò a mettersi in piedi, alzò la mano alto alto, come se avesse saputo ch'egli non poteva<br />
comunicarle altra forza che quella del suo peso e la lasciò cadere sulla mia guancia. Poi scivolò sul<br />
letto e di là sul pavimento. Morto!Non lo sapevo morto, ma mi si contrasse il cuore dal dolore della<br />
punizione ch'egli, moribondo, aveva voluto darmi. Con l'aiuto di Carlo lo sollevai e lo riposi in<br />
letto. Piangendo, proprio come un bambino punito, gli gridai nell'orecchio:- Non è colpa mia! Fu<br />
quel maledetto dottore che voleva obbligarti di star sdraiato!Era una bugia. Poi, ancora come un<br />
bambino, aggiunsi la promessa di non farlo piú:- Ti lascerò movere come vorrai.L'infermiere disse:-<br />
E’ morto. Dovettero allontanarmi a viva forza da quella stanza. Egli era morto ed io non potevo piú<br />
provargli la mia innocenza!Nella solitudine tentai di riavermi. Ragionavo: era escluso che mio<br />
padre, ch'era sempre fuori di sensi, avesse potuto risolvere di punirmi e dirigere la sua mano con<br />
tanta esattezza da colpire la mia guancia…(…)(………)Poi, al funerale, riuscii a ricordare mio<br />
padre debole e buono come l'avevo sempre conosciuto dopo la mia infanzia e mi convinsi che<br />
quello schiaffo che m'era stato inflitto da lui moribondo, non era stato da lui voluto. Divenni buono,<br />
buono e il ricordo di mio padre s'accompagnò a me, divenendo sempre piú dolce. Fu come un sogno<br />
delizioso: eravamo oramai perfettamente d'accordo, io divenuto il piú debole e lui il piú<br />
<strong>Pag</strong> . 30
forte.Ritornai e per molto tempo rimasi nella religione della mia infanzia. Immaginavo che mio<br />
padre mi sentisse e potessi dirgli che la colpa non era stata mia, ma del dottore. La bugia non aveva<br />
importanza perché egli oramai intendeva tutto ed io pure. E per parecchio tempo i colloqui con mio<br />
padre continuarono dolci e celati come un amore illecito, perché io dinanzi a tutti continuai a ridere<br />
di ogni pratica religiosa, mentre è vero - e qui voglio confessarlo - che io a qualcuno giornalmente e<br />
ferventemente raccomandai l'anima di mio padre. È proprio la religione vera quella che non occorre<br />
professare ad alta voce per averne il conforto di cui qualche volta - raramente - non si può fare a<br />
meno. (Italo Svevo : La Coscienza di Zeno 1923 )<br />
AMBITO SOCIO - ECONOMICO<br />
ARGOMENTO : SIAMO QUEL CHE MANGIAMO<br />
DOCUMENTI<br />
"Le evidenze scientifiche pubblicate nell'ultimo anno non lasciano dubbi - dice Massimo Volpe,<br />
presidente della Siprec ( Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare) - la vita sedentaria è<br />
un rischio per il cuore. Se a questo si aggiunge che spesso si mangia male, il quadro generale<br />
peggiora. Commettiamo troppi peccati di gola, trascuriamo la dieta mediterranea e gli alimenti<br />
cardine di una sana alimentazione. Pochissimi sanno davvero giudicare la salubrità di un alimento,<br />
molti si nutrono in modo disorganizzato". Il 95 per cento, continua l'esperto, dichiara che il pranzo è<br />
il pasto più importante, ma poi l'80 per cento sceglie una pasta molto condita accompagnata dal<br />
pane. Un italiano su due mangia carne magra, ora c'è un buon 20 per cento che sceglie carni grasse<br />
più volte alla settimana: Il 45 per cento consuma formaggi come minimo tre volte a settimana. Uno<br />
su tre, poi, mangia pesce appena una volta alla settimana mentre andrebbe consumato almeno due,<br />
tre volte. "Dobbiamo modificare le nostre abitudini - dice il cardiologo - e renderci conto che la<br />
salute del cuore si costruisce mattone dopo mattone, proprio come una casa. Sia il medico che il<br />
paziente possono imparare a fare prevenzione". Adele SARNO, Otto ore seduti? Il cuore rischia<br />
doppio, Arriva l'auto-test per la prevenzione, ("la Repubblica" - 1 aprile 2011)<br />
"Mercoledì 17 novembre 2010. La quinta sessione del Comitato dell'UNESCO [...] ha iscritto la<br />
Dieta Mediterranea nella prestigiosa lista (sc. del patrimonio culturale immateriale dell'umanità).<br />
[...] La Dieta Mediterranea rappresenta un insieme di competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni<br />
che vanno dal paesaggio alla tavola, includendo le colture, la raccolta, la pesca, la conservazione, la<br />
trasformazione, la preparazione e, in particolare, il consumo di cibo. La Dieta Mediterranea è<br />
caratterizzata da un modello nutrizionale rimasto costante nel tempo e nello spazio, costituito<br />
principalmente da olio di oliva, cereali, frutta fresca o secca, e verdure, una moderata quantità di<br />
pesce, latticini e carne, e molti condimenti e spezie, il tutto accompagnato da vini o infusi, sempre<br />
in rispetto delle tradizionii di ogni comunità. Tuttavia, la Dieta Mediterranea (dal greco diaita, o<br />
stile di vita) è molto più che un semplice alimento. Essa promuove l'interazione sociale, poiché il<br />
punto in comune è alla base dei costumi sociali e delle festività condivise da una data comunità, e<br />
ha dato luogo a un notevole corpo di conoscenze, canzoni, massime, racconti e leggende. La Dieta<br />
si fonda nel rispetto per il territorio e la biodiversità, e garantisce la conservazione e lo sviluppo<br />
delle attività tradizionali e dei mestieri collegati alla pesca e all'agricoltura nelle comunità del<br />
Mediterraneo" (CNI-UNESCO, La Dieta Mediterranea è patrimonio immateriale dell'Umanità, ww.<br />
unesco.it)<br />
"La politica alimentare [...] si deve basare sul concetto che l'energia primaria della vita è il cibo. Se<br />
il cibo è energia allora dobbiamo prendere atto che l'attuale sistema di produzione alimentare è<br />
fallimentare. [...] Il vero problema è che da un lato c'è una visione centralizzata dell'agricoltura,<br />
fatta di monoculture e allevamenti intesivi altamente insostenibili. Una visione meccanicista finisce<br />
con il ridurre il valore del cibo a una mera commodity, una semplice merce. é per questo che per<br />
<strong>Pag</strong> . 31
quanto riguarda il cibo abbiamo ormai perso la percezione della differenza tra valore e prezzo:<br />
facciamo tutti molta attenzione a quanto costa, ma non più al suo profondo significato [...]<br />
Scambiare il prezzo del cibo con il suo valore ci ha distrutto l'anima. Se il cibo è una merce non<br />
importa se lo sprechiamo. in una società consumistica tutto si butta e tutto si può sostituire, anzi, si<br />
deve sostituire. Ma il cibo non funziona così." Carlo PETRINI in Petrini-Rifkin. Il nuovo patto per<br />
la natura, "la Repubblica" - 9 giugno 2010<br />
"Mangiare mentre si legge la posta, si gioca o si lavora al pc può avere serie conseguenze sulla<br />
nostra forma fisica. [...] Secondo quanto riportato dalla rivista American Journal of Clinical<br />
Nutrition, chi mangia svolgendo altre attività, sia questa navigare in internet o sui profili degli amici<br />
su Facebook, è più propenso ad esagerare con le quantita in quanto non ha il senso delle calorie che<br />
sta realmente introducendo e inoltre ha più voglia di dolci [...]. Quindi nonostante sia costume<br />
sempre più diffuso quello di mangiare rimanendo "connessi" con il mondo intorno a noi, per chi ci<br />
tiene a non mettere su chili di troppo, meglio evitare le distrazioni durante i pasti e focalizzare<br />
l'attenzione su quello che si sta consumando". (Silvia MAGLIONI, Mangiare davanti al computer<br />
fa male alla linea, www. leonardo. It)<br />
AMBITO STORICO - POLITICO<br />
ARGOMENTO : IL FASCISMO, I FASCISMI<br />
DOCUMENTI<br />
Arrivato al potere a undici anni di distanza dal fascismo italiano, di quest'ultimo il<br />
nazionalsocialismo ha ripetuto le motivazioni esterne di carattere generale : le conseguenze della<br />
guerra e della crisi postbellica, in un paese sconfitto e non solo scosso dalla agitazione per la<br />
"vittoria mutilata". Soprattutto però il nazionalsocialismo ha messo in evidenza le tappe della<br />
sconfitta del più avanzato esperimento democratico dell'Europa degli anni venti... (Enzo Collotti,<br />
Fascismo, fascismi )<br />
Il regime di cui Francisco Franco Bahamonte prese corpo durante la guerra civile del 1936-1939.<br />
Più precisamente se ne può fissare l'inizio al 1° ottobre 1936, data in cui Franco venne nominato<br />
capo delle forze militari ribelli e capo del governo. Le origini del franchismo sono da collocare<br />
nell'Europa degli anni trenta e nel contesto dei regimi fascisti o tendenzialmente tali del periodo.<br />
Ciò non perché la sollevazione del 1936 avesse inizialmente per obiettivo la costituzione di un<br />
regime di questo tipo, o la conseguente guerra civile abbia avuto le caratteristiche di rivoluzione<br />
fascista, quanto piuttosto perché la tempestiva internazionalizzazione del conflitto e gli aiuti militari<br />
forniti dall'Italia fascista e dalla Germania hitleriana influirono notevolmente nel rafforzare le<br />
tendenze fasciste all'interno del blocco franchista. Sicché, pur in presenza di alcune non trascurabili<br />
differenze, il regime che andò configurandosi durante la guerra civile rappresentò a tutti gli effetti<br />
una variante del fascismo, mantenendone le caratteristiche fino a che l'andamento della seconda<br />
guerra mondiale non costrinse Franco a prendere le distanze dall'Asse. (Alfonso Botti, Franchismo,<br />
in Il fascismo. Dizionario di storia )<br />
È possibile azzardare una doppia tipologia di massima del fascismo. Una tipologia più ampia e più<br />
rigida, che tendesse cioè a ricondurre sotto un unico comune denominatore altri aspetti del fascismo<br />
(o addirittura altre realtà che talvolta vengono definite fasciste), sarebbe difficile a stabilire. Basti<br />
pensare che una componente essenziale del nazionalsocialismo come il razzismo e l'antisemitismo<br />
non fu tale per il falangismo e il franchismo spagnoli e in realtà neppure per il fascismo italiano che<br />
la conobbe molto più tardi e la fece propria più per opportunità politica che per interna necessità<br />
della sua ideologia e della sua politica. (Renzo De Felice, Interpretazioni del fascismo )<br />
<strong>Pag</strong> . 32
Il primo esperimento di vera e propria politica razziale promosso dal fascismo si ebbe con la guerra<br />
d'Etiopia, dove gli italiani si distinsero per l'uso su vasta scala di armi chimiche, per le uccisioni di<br />
massa, per le devastazioni di interi villaggi, per una violenta e sanguinosa repressione della<br />
guerriglia contro le truppe d'occupazione. L'organica legislazione razziale applicata nei territori<br />
dell'Africa italiana rappresenta un precedente di rilievo per comprendere gli accadimenti del 1938,<br />
quando verrà pubblicato il Manifesto degli scienziati razzisti e soprattutto saranno emanate una<br />
serie di norme antisemite [...]. Con la definizione di uno stato di inferiorità dei cittadini italiani di<br />
origine ebraica si porranno le basi della successiva (1943) estensione anche all'Italia della pratica<br />
nazista della deportazione di massa nei campi di sterminio, un o dei quali fu attivo nel territorio<br />
nazionale, a Trieste, la cosiddetta Risiera di San Sabba. (Luca Baldissara, Razzismo, in Dizionario<br />
di storia )<br />
Nel De Felice al di sopra di ogni altra considerazione sembra diventata ossessiva la preoccupazione<br />
di allontanare dal fascismo italiano il peso delle responsabilità dei gravi crimini di cui si è<br />
macchiato il nazismo a costo di rischiare una caricatura del fascismo buono a confronto di quello<br />
cattivo. La visione riduttiva del regime fascista cui egli è pervenuto attraverso vari passaggi,<br />
muovendo dalla personalizzazione del regime sino alla sua identificazione con la figura di<br />
Mussolini, ha reso sempre più incerta la collocazione stessa del fascismo rispetto alla storia d'Italia,<br />
quasi che alla dittatura fascista non si debba attribuire più alcuna specificità né alcun carattere<br />
periodizzante nella storia d'Italia. [...] Il De Felice nega in realtà l'esistenza del fenomeno del<br />
fascismo. Il fascismo scade a mero accidente della storia, in una scadente versione della teoria di<br />
Benedetto Croce della parentesi. (Enzo Collotti, Fascismo, fascismi )<br />
AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO<br />
ARGOMENTO: SOCIAL NETWORK, INTERNET, NEW MEDIA<br />
DOCUMENTI<br />
«Immagino che qualcuno potrebbe dire: “Perché non mi lasciate da solo? Non voglio far parte della<br />
vostra Internet, della vostra civiltà tecnologica, o della vostra società in rete! Voglio solo vivere la<br />
mia vita!” Bene, se questa è la vostra posizione, ho delle brutte notizie per voi. Se non vi occuperete<br />
delle reti, in ogni caso saranno le reti ad occuparsi di voi.Se avete intenzione di vivere nella società,<br />
in questa epoca e in questo posto, dovrete fare i conti con la società in rete.<br />
Perché viviamo nella Galassia Internet.» (M. CASTELLS¸ Galassia Internet, trad. it., Milano<br />
2007)<br />
«C’è una mutazione in atto ed ha a che fare con la componente “partecipativa” che passa attraverso<br />
i media. [...] Questa mutazione sta mettendo in discussione i rapporti consolidati tra produzione e<br />
consumo, con ricadute quindi sulle forme e i linguaggi dell’abitare il nostro tempo. Questo processo<br />
incide infatti non solo sulle produzioni culturali, ma anche sulle forme della politica, sulle<br />
dinamiche di mercato, sui processi educativi, ecc. [...] D’altra parte la crescita esponenziale di<br />
adesione al social network ha consentito di sperimentare le forme partecipative attorno a<br />
condivisione di informazioni e pratiche di intrattenimento, moltiplicando ed innovando le occasioni<br />
di produzione e riproduzione del capitale sociale.» (G. BOCCIA ARTIERI, Le culture partecipative<br />
dei media. Una introduzione a Henry Jenkins, (Prefazione a H. JENKINS, Fan, Blogger e<br />
Videogamers. L’emergere delle culture partecipative nell’era digitale, Milano 2008)Ciò che<br />
conosciamo, il modo in cui conosciamo, quello che pensiamo del mondo e il modo in cui riusciamo<br />
a immaginarlo sono cruciali per la libertà individuale e la partecipazione politica. Il fatto che oggi<br />
così tanta gente possa parlare, e che si stia raggruppando in reti di citazione reciproca, come la<br />
<strong>Pag</strong> . 33
logosfera, fa sì che per ogni individuo sia più facile farsi ascoltare ed entrare in una vera<br />
conversazione pubblica. Al contempo, sulla Rete ci sono un sacco di sciocchezze. Ma incontrare<br />
queste assurdità è positivo. Ci insegna a essere scettici, a cercare riferimenti incrociati e più in<br />
generale a trovare da soli ciò che ci serve. La ricerca di fonti differenti è un’attività molto più<br />
coinvolgente e autonoma rispetto alla ricerca della risposta da parte di un’autorità.» (Y. BENKLER,<br />
Intervista del 10 maggio 2007, in omniacommunia.org)…..«Siamo in uno stato di connessione<br />
permanente e questo è terribilmente interessante e affascinante. È una specie di riedizione del mito<br />
di Zeus Panopticon che sapeva in ogni momento dove era nel mondo, ma ha insito in sé un grande<br />
problema che cela un grave pericolo: dove inizia il nostro potere di connessione inizia il pericolo<br />
sulla nostra libertà individuale. Oggi con la tecnologia cellulare è possibile controllare chiunque,<br />
sapere con chi parla, dove si trova, come si sposta. Mi viene in mente Victor Hugo che chiamava<br />
tomba l’occhio di Dio da cui Caino il grande peccatore non poteva fuggire. Ecco questo è il grande<br />
pericolo insito nella tecnologia, quello di creare un grande occhio che seppellisca l’uomo e la sua<br />
creatività sotto il suo controllo. [...] Come Zeus disse a Narciso “guardati da te stesso!” questa frase<br />
suona bene in questa fase della storia dell’uomo.»(D. DE KERCKHOVE, Alla ricerca<br />
dell’intelligenza connettiva, Intervento tenuto nel Convegno Internazionale “Professione<br />
Giornalista: Nuovi Media, Nuova Informazione” – Novembre 2001<br />
«Agli anziani le banche non sono mai piaciute un granché. Le hanno sempre guardate col cipiglio di<br />
chi pensa che invece che aumentare, in banca i risparmi si dissolvono e poi quando vai a chiederli<br />
non ci sono più. [...] È per una curiosa forma di contrappasso che ora sono proprio gli anziani, e non<br />
i loro risparmi, a finire dentro una banca, archiviati come conti correnti. Si chiama “banca della<br />
memoria” ed è un sito internet [...] che archivia esperienze di vita raccontate nel formato della<br />
videointervista da donne e uomini nati prima del 1940. [...] È una sorta di “YouTube” della terza<br />
età.» (A. BAJANI, «YouTube» della terza età, in “Il Sole 24 ORE”, 7 dicembre 2008)<br />
«Una rivoluzione non nasce dall’introduzione di una nuova tecnologia, ma dalla conseguente<br />
adozione di nuovi comportamenti. La trasparenza radicale conterà come forza di mercato solo se<br />
riuscirà a diventare un fenomeno di massa; è necessario che un alto numero di consumatori<br />
prendano una quantità enorme di piccole decisioni basate su questo genere di informazioni. […]<br />
Grazie al social networking, anche la reazione di un singolo consumatore a un prodotto si trasforma<br />
in una forza che potrebbe innescare un boicottaggio oppure avviare affari d’oro per nuove imprese.<br />
[...] I più giovani sono sempre in contatto, attraverso Internet, come non è mai accaduto prima d’ora<br />
e si scambiano informazioni affidabili, prendendosi gioco, al contempo, di quelle fonti su cui si<br />
basavano le generazioni precedenti. Non appena i consumatori – specialmente quelli delle ultime<br />
generazioni – si sentono compiaciuti o irritati per la cascata di rivelazioni che la trasparenza offre<br />
sui prodotti, diffondono istantaneamente le notizie.» (D. GOLEMAN, Un brusio in rapida crescita,<br />
in Intelligenza ecologica, Milano 2009)<br />
TIPOLOGIA C - TEMA DI ARGOMENTO STORICO<br />
I due volti del Novecento: da un lato esso è secolo di grandi conquiste civili, economiche, sociali,<br />
scientifiche, tecniche; dall'altro è secolo di grandi tragedie storiche.<br />
Rifletti su tale ambivalenza del ventesimo secolo, illustrandone i fatti più significativi.<br />
TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE<br />
Numerosi bisogni della società trovano oggi una risposta adeguata grazie all'impegno civile e al volontariato<br />
di persone, in particolare di giovani, che, individualmente o in forma associata e cooperativa, realizzano<br />
interventi integrativi o compensativi di quelli adottati da Enti istituzionali. Quali, secondo te, le origini e le<br />
motivazioni profonde di tali comportamenti?Affronta la questione con considerazioni suggerite dal tuo<br />
percorso di studi e dalle tue personali esperienze.<br />
<strong>Pag</strong> . 34
CRITERI DI VALUTAZIONE E RELATIVI PUNTEGGI PRIMA PROVA<br />
TIPOLOLOGIA A ANALISI DEL TESTO<br />
PUNTEGGIO IN QUINDICESIMI<br />
CANDIDATO /A______________________________<br />
Indicatori<br />
GI<br />
Correttezza morfosintattica<br />
e 1.03<br />
punteggiatura<br />
Correttezza 0.45<br />
ortografica<br />
Proprietà lessicale 0.45<br />
Conoscenze e<br />
comprensione del<br />
testo<br />
Analisi del testo<br />
Contestualizzazione<br />
1.03<br />
1.03<br />
0.32<br />
IN<br />
1.40<br />
QS<br />
1.75<br />
SU<br />
2.00<br />
<strong>Pag</strong> . 35<br />
PS<br />
2.25<br />
DI<br />
2.50<br />
BU<br />
2.75<br />
OT<br />
3.00<br />
%<br />
3.00%<br />
0.70 0.88 1.00 1.13 1.25 1.38 1.50 1.50%<br />
0.70<br />
1.40<br />
1.40<br />
0.47<br />
0.88 1.00 1.13 1.25 1.38 1.50 1.50%<br />
1.75<br />
1.75<br />
0.58<br />
2.00<br />
2.00<br />
0.67<br />
2.25<br />
2.25<br />
0.75<br />
2.50<br />
2.50<br />
0.83<br />
2.75<br />
2.75<br />
0.92<br />
3.00<br />
3.00<br />
1.00<br />
3.00%<br />
3.00%<br />
1.00%<br />
Approfondimento 0.68 0.94 1.16 1.33 1.50 1.66 1.83 2.00 2.00%<br />
Totale p.<br />
Punti<br />
NOTE: GI (gravemente insufficiente), IN(insufficiente), QS(quasi sufficiente), SU(sufficiente),<br />
PS(più che sufficiente), DI(discreto), BU(buono), OT(ottimo)<br />
N.B: il punteggio complessivo, risultante dalla somma dei punteggi attribuiti dai singoli descrittori,<br />
in presenza di numeri decimali, viene approssimato all’intero più prossimo
TIPOLOLOGI B REDAZIONE DI UN SAGGIO BREVE O DI UN ARTICOLO DI GIORNALE<br />
PUNTEGGIO IN QUINDICESIMI<br />
CANDIDATO /A______________________________<br />
Indicatori<br />
GI IN<br />
QS<br />
Correttezza morfosintattica<br />
e<br />
punteggiatura<br />
1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.00%<br />
Correttezza<br />
ortografica<br />
0.40 0.63 0.88 1.00 1.13 1.25 1.38 1.50 1.50%<br />
Proprietà lessicale 0.40 0.50 0.58 0.67 0.75 0.83 0.92 1.00 1.00%<br />
Adeguatezza del<br />
registro<br />
Pertinenza al titolo<br />
e ai documenti<br />
Organizzazione<br />
delle informazioni<br />
Ricchezza<br />
informazioni e<br />
argomentazioni<br />
Capacità di<br />
rimanere coerenti<br />
nell’argomentazion<br />
e<br />
Capacità di<br />
riflessione e di<br />
giudizio motivato<br />
0.20<br />
0.60<br />
0.80<br />
0.80<br />
0.40<br />
0.80<br />
0.25<br />
0.75<br />
1.00<br />
1.00<br />
0.50<br />
1.00<br />
0.29<br />
1.16<br />
1.16<br />
1.16<br />
0.58<br />
1.16<br />
SU<br />
0.33<br />
1.33<br />
1.33<br />
1.33<br />
0.67<br />
1.33<br />
<strong>Pag</strong> . 36<br />
PS<br />
0.37<br />
150<br />
150<br />
150<br />
0.75<br />
150<br />
DI<br />
0.41<br />
1.66<br />
1.66<br />
1.66<br />
0.83<br />
1.66<br />
BU<br />
0.45<br />
1.83<br />
1.83<br />
1.83<br />
0.92<br />
1.83<br />
OT<br />
0.50<br />
2.00<br />
2.00<br />
2.00<br />
1.00<br />
2.00<br />
%<br />
0.50%<br />
2.00%<br />
2.00%<br />
2.00%<br />
1.00%<br />
2.00%<br />
Totale p.<br />
Punti<br />
NOTE: GI (gravemente insufficiente), IN(insufficiente), QS(quasi sufficiente), SU(sufficiente),<br />
PS(più che sufficiente), DI(discreto), BU(buono), OT(ottimo)<br />
N.B: il punteggio complessivo, risultante dalla somma dei punteggi attribuiti dai singoli descrittori,<br />
in presenza di numeri decimali, viene approssimato all’intero più prossimo
TIPOLOLOGIA C/D<br />
TEMA DI ARGOMENTO STORICO<br />
TEMA DI ORDINE GENERALE<br />
PUNTEGGIO IN QUINDICESIMI<br />
CANDIDATO /A______________________________<br />
INDICATORI<br />
Correttezza<br />
morfo-sintattica e<br />
punteggiatura<br />
Correttezza<br />
ortografica<br />
Proprietà<br />
lessicale<br />
Adeguatezza del<br />
registro<br />
Pertinenza del<br />
contenuto<br />
Organizzazione<br />
del contenuto<br />
Conoscenza del<br />
contenuto<br />
Ricchezza<br />
informazioni<br />
Capacità di<br />
riflessione<br />
GI<br />
1.25<br />
IN<br />
1.50<br />
QS<br />
1.75<br />
SU<br />
2.00<br />
<strong>Pag</strong> . 37<br />
PS<br />
2.25<br />
DI<br />
2.50<br />
BU<br />
2.75<br />
OT<br />
3.00<br />
%<br />
3.00%<br />
0.60 0.75 0.88 1.00 1.13 1.25 1.38 1.50 1.50%<br />
0.42 0.50 0.58 0.67 0.75 0.83 0.92 1.00 1.00%<br />
0.20<br />
0.83<br />
0.83<br />
0.83<br />
0.42<br />
0.83<br />
0.25<br />
1.00<br />
1.00<br />
1.00<br />
0.50<br />
1.00<br />
0.29<br />
1.16<br />
1.16<br />
1.16<br />
0.58<br />
1.16<br />
0.33<br />
1.33<br />
1.33<br />
1.33<br />
0.67<br />
1.33<br />
0.37<br />
150<br />
150<br />
150<br />
0.75<br />
150<br />
0.41<br />
1.66<br />
1.66<br />
1.66<br />
0.83<br />
1.66<br />
0.45<br />
1.83<br />
1.83<br />
1.83<br />
0.92<br />
1.83<br />
0.50<br />
2.00<br />
2.00<br />
2.00<br />
1.00<br />
2.00<br />
0.50%<br />
2.00%<br />
2.00%<br />
2.00%<br />
1.00%<br />
2.00%<br />
Totale p.<br />
Punti<br />
NOTE: GI (gravemente insufficiente), IN(insufficiente), QS(quasi sufficiente), SU(sufficiente),<br />
PS(più che sufficiente), DI(discreto), BU(buono), OT(ottimo)<br />
N.B: il punteggio complessivo, risultante dalla somma dei punteggi attribuiti dai singoli descrittori,<br />
in presenza di numeri decimali, viene approssimato all’intero più prossimo
SIMULAZIONE 2^ PROVA ESAME DI STATO<br />
Svolgimento di un tema breve<br />
ALIMENTI E ALIMENTAZIONE<br />
Uno dei problemi che l’uomo ha avuto da sempre, sia che fosse cacciatore che agricoltore, e’ stato<br />
la conservazione del cibo in eccesso. oggi la conservazione degli alimenti e’ una necessita’ legata<br />
allo stile di vita moderna.<br />
Il candidato illustri i vari metodi, fisici, chimici e biologici utilizzati per la conservazione degli<br />
alimenti cercando di specificare la tipologia di intervento conservativo più adatto alle varie<br />
categorie di alimenti.<br />
GRIGLIA DI VALUTAZIONE II PROVA<br />
CANDIDATO /A______________________________<br />
Indicatori<br />
Conoscenza dei<br />
contenutui<br />
Correttezza<br />
formale e proprietà<br />
di linguaggio<br />
Capacità di<br />
elaborazione<br />
critica<br />
Punteggio<br />
massimo<br />
15<br />
9<br />
4<br />
2<br />
Livelli e relativi punteggi<br />
insufficiente 0-3<br />
mediocre 3.1-5<br />
sufficiente 5.1-6<br />
discreto 6.1-7<br />
buono 7.1-8<br />
ottimo 8.1-9<br />
insufficiente 0-1<br />
mediocre 1.1-2<br />
sufficiente 2.1-2.7<br />
discreto 2.8-3.5<br />
buono/ottimo 4<br />
insufficiente 0.5<br />
mediocre 1<br />
sufficiente 1.3<br />
discreto 1.6<br />
buono/ottimo 2<br />
<strong>Pag</strong> . 38<br />
Punteggio totale<br />
Punteggio ottenuto
STITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE LEOPOLDO II DI LORENA<br />
SIMULAZIONE TERZA PROVA<br />
Anno scolastico 2011/2012<br />
Tipologia B/C<br />
Classe V B Operatore Servizi ristorativi<br />
CANDIDATO/A…………………………………………………… DATA 03/ 05/ 2012<br />
MATERIE :<br />
Storia,<br />
Inglese<br />
Matematica<br />
Economia e gestione aziendale ristorazione<br />
Laboratorio di organizzazione servizi ristorativi<br />
Per ogni materia vengono proposti 6 quesiti ( 4 a scelta multipla ; 2 aperti)<br />
Punteggio per ogni disciplina : punti 3 ( 0,25 per ciascuna domanda a scelta multipla ; 1 per<br />
ciascuna domanda aperta )<br />
Tempo previsto : 90 min.<br />
Punteggio raggiunto<br />
Storia …………………………. /15<br />
Inglese …………………………./15<br />
Matematica …………………………../15<br />
Econ. e gest. Az. ristorazione ……………………… /15<br />
Laboratorio org. Serv. ristorativi ………………………… /15<br />
TOTALE …………………………/15<br />
<strong>Pag</strong> . 39
STORIA<br />
1. Durante la II guerra mondiale veniva definito Collaborazionista: (una sola risposta corretta)<br />
un governo sostenitore dei nazisti nei territori occupati dai Tedeschi<br />
un governo che collaborava con gli Alleati nella lotta partigiana<br />
un collaboratore dei partigiani nella lotta contro i fascisti<br />
un prigioniero costretto a lavorare gratuitamente nei lager<br />
2. La Resistenza fu: (una sola risposta corretta)<br />
un movimento di opposizione ai regimi nazi/fascisti condotta dai CNL attraverso azioni di<br />
guerriglia e sabotaggio solo contro esponenti dell’esercito tedesco<br />
un movimento organizzato e condotto dai CNL attraverso azioni di guerriglia e sabotaggio che<br />
si configura come rivolta civile, patriottica e sociale<br />
un movimento di opposizione ai regimi nazi/fascisti condotta dai CNL attraverso azioni di<br />
guerriglia e sabotaggio contro esponenti del regime fascista<br />
un movimento di opposizione ai regimi nazi/fascisti condotta dai CNL attraverso azioni di<br />
guerriglia e sabotaggio contro esponenti dell’esercito tedesco e del regime fascista<br />
3. La“Repubblica Sociale italiana”fu: (una sola risposta corretta)<br />
lo Stato che governò l’Italia centro settentrionale dal 1943 al 1945. Essa va considerata uno<br />
Stato indipendente perché tutte le decisioni erano prese dal partito fascista<br />
lo Stato che governò l’Italia dal 1943 al 1945. Essa va considerata uno stato fantoccio, perché di<br />
fatto quasi tutte le decisioni erano prese dai Tedeschi<br />
lo Stato che governò l’Italia centro settentrionale dal 1941 al 1945. Essa va considerata uno<br />
Stato indipendente perché tutte le decisioni erano prese dal partito fascista<br />
lo Stato che governò l’Italia dal 1940 al 1945. Essa va considerata uno stato fantoccio, perché di<br />
fatto quasi tutte le decisioni erano prese dai Tedeschi<br />
4. La “guerra fredda” fu :(una sola risposta corretta)<br />
un lungo periodo di tensioni politiche e militari instauratosi tra USA e URSS, dopo la seconda<br />
guerra mondiale<br />
un lungo periodo di conflitti ideologici tra USA e CINA<br />
un lungo periodo di tensioni politiche e militari tra URSS, CINA e potenze occidentali<br />
un lungo periodo di conflitti ideologici tra potenze rette da governi democratici ed i Paesi<br />
socialisti<br />
<strong>Pag</strong> . 40
5. Quali avvenimenti accaddero in Italia,dopo l'8 settembre 1943 ? (max.8 righe)<br />
____________________________________________________________________________<br />
___________________________________________________________________________<br />
____________________________________________________________________________<br />
____________________________________________________________________________<br />
____________________________________________________________________________<br />
____________________________________________________________________________<br />
____________________________________________________________________________<br />
____________________________________________________________________________<br />
6. Quali eventi bellici caratterizzarono l’ultimo anno del II conflitto mondiale, nel Pacifico?<br />
(max. 8 righe )<br />
______________________________________________________________________________<br />
______________________________________________________________________________<br />
______________________________________________________________________________<br />
_______________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________<br />
<strong>Pag</strong> . 41
LINGUA INGLESE<br />
1) Talk about : “ Function catering responsibilities “<br />
________________________________________________________________________________<br />
_______________________________________________________________________________<br />
_______________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________<br />
2) Talk about : “ cheese “<br />
1)Semi – hard cheese hare :<br />
a)Gorgonzola, Bel Paese, Provolone<br />
b)Fontina, Brie, Camambert<br />
c)Bel Paese, Gorgonzola, Fontina<br />
d)Fontina, Provolone, Romano<br />
2) Butter is made of :<br />
a) Milk and sour cream<br />
b) Milk and cream<br />
c) Cheese and milk<br />
d) Cream and cheese<br />
3) The “ sprig tables “ are :<br />
a) Those “joined” at one end of the “long” table<br />
b) Those joined at one end of the top table<br />
c) Those joined at one end of the round table<br />
d) Those joined at the entrance of the banqueting hall<br />
4) The banqueting head “waiter” is responsible for :<br />
a) The banqueting halls and food to be served<br />
b) Decorations and settings required<br />
c) Number of guests and costs<br />
d) Organization of the function and the banqueting halls<br />
<strong>Pag</strong> . 42
MATEMATICA<br />
1. Sia y=f(x) una funzione continua in un intervallo ed ivi derivabile allora se in un suo punto<br />
x0 risulta che la derivata prima si annulla ne segue che il punto di ascissa x0 è punto di:<br />
a) Massimo<br />
b) Minimo<br />
c) Flesso<br />
d) Massimo, minimo o flesso.<br />
2. Considerate due variabili reali x e y, si dice che y è funzione di x se<br />
a) ad ogni valore di x corrisponde un solo valore di y;<br />
b) a qualche valore di x corrisponde un solo valore di y;<br />
c) ad ogni valore di y corrisponde un solo valore di x;<br />
d) a valori di x corrispondono valori di y<br />
3. Indica il dominio della funzione<br />
x 2<br />
y <br />
x 1<br />
a) x(-, -2] U (1, +)<br />
b) x [-2,1)<br />
c) x(-, -2) U [1, +)<br />
d) x(-2,1]<br />
4. La funzione<br />
2<br />
x 4<br />
y<br />
<br />
x 2<br />
presenta in x=2<br />
e) una discontinuità di prima specie<br />
f) una discontinuità di seconda specie<br />
g) una discontinuità di terza specie<br />
h) è continua<br />
5. Calcola la derivata di y= (2x 3 - e x ) 1/2<br />
6. Calcolare il valore del seguente limite e quali conclusioni puoi trarre nello studio<br />
della funzione:<br />
3x<br />
2<br />
lim<br />
x 2<br />
4x<br />
5x<br />
1<br />
<strong>Pag</strong> . 43<br />
5x<br />
1
Domande a risposta multipla:<br />
1. Le scritture di assestamento servono:<br />
EGAR<br />
a) ad inserire costi e ricavi di competenza;<br />
b) a togliere costi e ricavi di non competenza;<br />
c) a determinare l’esatta competenza economica dei costi e dei ricavi;<br />
d) ad ammortizzare i costi pluriennali.<br />
2. La retribuzione è disciplinata nella nostra Costituzione all’art:<br />
a) 35;<br />
b) 36;<br />
c) 37;<br />
d) 38.<br />
3. Gli allegati del Bilancio d’esercizio sono:<br />
a) La relazione degli amministratori;<br />
b) La relazione dei sindaci;<br />
c) La relazione dei revisori contabili;<br />
d) La relazione degli amministratori e la relazione dei sindaci.<br />
4. Affinché ci sia equilibrio tra fonti e impieghi:<br />
a) Il Capitale permanente (CP+Pass. Consolidate) deve essere > di AI(attivo immob.);<br />
b) Il Capitale permanente (CP+Pass. Consolidate) deve essere < di AI(attivo immob.);<br />
c) Le Passività correnti > dell’attivo circolante;<br />
d) Il Capitale proprio > delle Passività.<br />
Domande aperte:<br />
1. Spiegate cosa sono i risconti, quando sono attivi e quando sono passivi e fate un esempio;<br />
__________________________________________________________________________<br />
__________________________________________________________________________<br />
__________________________________________________________________________<br />
__________________________________________________________________________<br />
__________________________________________________________________________<br />
p.ti 01<br />
2. Indicate in ordine di importanza le fonti di diritto che tutelano il lavoro dipendente.<br />
__________________________________________________________________________<br />
__________________________________________________________________________<br />
__________________________________________________________________________<br />
__________________________________________________________________________<br />
_________________________________________________________________________<br />
p.ti 01<br />
<strong>Pag</strong> . 44<br />
Punteggio conseguito _____/03
Test risposta multipla<br />
LABORATORIO SERVIZI RISTORATIVI<br />
Rispondi a queste domande segnalando la risposta giusta con una X<br />
1.Il termine gastronomia fa riferimento a:<br />
a . uno standard per misura di recipienti<br />
b. un’unità di misura di peso<br />
c. una teglia di materiale particolare<br />
d. un tegame di alluminio<br />
2.I cibi cotti vengono confezionati sottovuoto:<br />
a. quando si sono completamente raffreddati<br />
b. quando sono ancora caldi<br />
c. subito dopo la cottura<br />
d. a mezza cottura<br />
3. La cucina tradizionale evoluta è costituita da:<br />
a. suddivisione degli spazi in settore<br />
b. necessaria presenza di una cucina satellite<br />
c. in presenza di cucina spaziale<br />
d. non suddivisa in settore<br />
4. Nel tegame refrigerato i cibi vengono conservati a :<br />
a.+ 3° c per 5/6 giorni<br />
b. 0° c per 21 giorni<br />
c. - 20° c per alcuni mesi<br />
d. -18 c per 2 settimane<br />
5. Che cosa si intende per cucina diretta e indiretta?<br />
______________________________________________________________________________<br />
______________________________________________________________________________<br />
6. Con quali tecniche può avvenire la cottura sottovuoto?<br />
______________________________________________________________________________<br />
______________________________________________________________________________<br />
______________________________________________________________________________<br />
<strong>Pag</strong> . 45
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE<br />
CANDIDATO/A_________________________________<br />
Descrittori Fascia di<br />
Argomento posto dal<br />
candidato<br />
(max 4 punti)<br />
Colloquio<br />
(max 23<br />
punti)<br />
Conoscenza<br />
(max 10<br />
punti)<br />
Abilità<br />
(max 5 punti)<br />
Competenze<br />
(max 8 punti)<br />
Discussione degli<br />
elaborati (max 3 punti)<br />
Argomentazioni<br />
rielaborazione<br />
incerte, scarsa<br />
Lavoro essenziale ed esposizione<br />
sufficientemante corretta<br />
Lavoro adeguato, significativo ed<br />
originale<br />
Lacunose e/o frammentate 2/3<br />
Lacunose e/o generiche 4/5<br />
Sufficienti 6<br />
Organiche con approfondimenti 7/8<br />
Complete e organizzate con<br />
approfondimento<br />
Argomentazione e uso di un<br />
linguaggio non sempre appropriati<br />
Argomentazione quasi sufficiente e<br />
uso di un linguaggio non proprio<br />
scientifico<br />
Argomentazione sufficiente e<br />
chiarezza espositiva adeguata<br />
Argomentazione ottima e chiarezza<br />
espositiva<br />
Collegamenti non adeguati e<br />
mancanza di consequenzialità logica<br />
Collegamenti sufficienti e adeguata<br />
consequenziabilità logica<br />
Buona capacità di collegamenti e<br />
consequenziabilità logica<br />
Discussione degli elaborati<br />
sufficiente con alcune incertezze, e<br />
parziale correzione degli errori<br />
commessi<br />
<strong>Pag</strong> . 46<br />
punteggio<br />
2<br />
3<br />
4<br />
9/10<br />
Discussione degli elaborati autonoma<br />
e sicura, correzione degli errori<br />
commessi<br />
3<br />
Totale dei punti assegnati 30/30<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
5<br />
6<br />
7/8<br />
1/2<br />
Punteggio<br />
assegnato
SCHEDA DISCIPLINARE<br />
Disciplina ITALIANO<br />
Docente : Nara Pii<br />
Libro di testo.<br />
Titolo: Mappe di letteratura<br />
Il Novecento<br />
Autore: Paolo Di Sacco<br />
Edizioni scolastiche Bruno Mondadori<br />
Contenuti dei moduli preparati per l’esame e tempi di svolgimento<br />
MODULO I<br />
Il Saggio breve; l’articolo di giornale (articolo di opinione e/o di fondo)<br />
L' analisi del testo ( in prosa ed in poesia )<br />
Il tema:tipologia C/D<br />
Tempi: in itinere<br />
MODULO II<br />
STORICO CULTURALE<br />
DAL DECADENTISMO AL FUTURISMO<br />
Il Decadentismo francese ed italiano<br />
Il Simbolismo<br />
Le Avanguardie:<br />
Il Futurismo : il contesto storico ; le coordinate culturali<br />
Filippo Tommaso Marinetti : biografia e poetica<br />
Il Manifesto del futurismo. Il manifesto tecnico della letteratura futurista<br />
Tempi: settembre/ Ottobre<br />
MODULO III<br />
PER GENERE<br />
IL Genere lirico<br />
La lirica decadente e simbolista<br />
Charles Baudelaire<br />
Biografia, poetica<br />
Analisi delle liriche:”Corrispondenze” “Spleen”“L’albatro”<br />
Tempi: Novembre<br />
<strong>Pag</strong> . 47
Gabriele D' Annunzio<br />
Biografia, poetica<br />
Trama di “Il piacere” Analisi di “Il ritratto dell’esteta”<br />
“L’ Innocente”: trama Visione del film<br />
I romanzi della rosa: “Il trionfo della morte”: trama.<br />
I romanzi del giglio: “La vergine delle rocce .<br />
Da “Alcione “: “La Pioggia nel pineto” “La sera fiesolana “”I pastori”<br />
Da “Notturno” Analisi del passo:”Imparo un’arte nuova”<br />
Pascoli<br />
tempi :Dicembre/ Gennaio /<br />
Giovanni Pascoli<br />
Biografia, poetica<br />
Il fanciulloni : analisi del passo “Il fanciullo che è in noi”<br />
Da “Myricae”<br />
Analisi delle liriche:” Novembre “” Lavandare” “ Arano” “Il tuono””Il lampo” “X Agosto””La<br />
cavalla storna”<br />
Da “I canti di Castelvecchio”: “Il gelsomino notturno”<br />
Da “I poemetti” : “ Digitale purpurea”<br />
Tempi : Febbraio<br />
MODULO IV<br />
IL ROMANZO DEL NOVECENTO<br />
Italo Svevo<br />
Biografia; Le idee Il contesto culturale<br />
Da “Una vita”trama<br />
analisi di :”Gabbiani e pesci”<br />
Da “Senilità”trama<br />
Analisi di:” La metamorfosi strana di Angiolina”<br />
Da “La coscienza di Zeno”La trama e la struttura dell’opera<br />
Analisi di :”Il fumo” “Il funerale mancato ” “Psico-analisi”<br />
tempi : Febbraio Marzo<br />
Luigi Pirandello<br />
Biografia; le idee.<br />
La vita e la forma. Il relativismo conoscitivo. La lanterninosofia.<br />
L’umorismo<br />
Da “Novelle per un anno”: “Il treno Ha fischiato”<br />
Trama dei romanzi :”Il fu Mattia Pascal” “Analisi di “Adriano Meis””Io sono il fu Mattia Pascal”<br />
Uno,nessuno,centomila”: analisi di “Il naso di Moscarda<br />
L’esclusa”:trama<br />
Tempi : Marzo/prima decade di Aprile<br />
<strong>Pag</strong> . 48
MODULO V<br />
PER GENERE<br />
LA POESIA DEL NOVECENTO<br />
La lirica della guerra<br />
Giuseppe Ungaretti<br />
Biografia, poetica. Le scelte stilistiche e formali<br />
Da “Allegria dei naufragi”<br />
Analisi di: “Veglia”, “Natale” S. Martino del Carso” “Sono una creatura” “ I fiumi”<br />
”In memoria”<br />
“Il male di vivere”<br />
Eugenio Montale<br />
Biografia , poetica<br />
Da “Ossi di Seppia”<br />
Analisi di :”Meriggiare pallido e assorto” “Spesso il male di vivere”<br />
Da “Occasioni”: “Non recidere, forbice,quel volto”……..<br />
Da “Satura” Ho sceso dandoti il braccio”<br />
Tempi: Aprile / prima decade Maggio<br />
Umberto Saba<br />
Analisi di : “Ritratto della mia bambina” “La capra”(a Maggio)<br />
Salvatore Quasimodo<br />
Analisi di :”Ed è subito sera” “Alle fronde dei salici”(a Maggio)<br />
MODULO VI<br />
PER TEMA<br />
LA NARRATIVA DEL NOVECENTO<br />
Primo Levi “ Se questo è un uomo “ : Analisi dei brani : Hurbinek e “ Sul fondo”<br />
Metodologie :<br />
Le tematiche sono state presentate attraverso lezione frontale . lezione dialogata, lettura dei brani<br />
relativi alle opere prese in esame, schematizzazioni , presa di appunti.<br />
E’ stata mensilmente svolta la redazione di varie tipologie testuali, attraverso verifiche scritte<br />
intorno a contenuti svolti e/o non affrontati.<br />
Le conoscenze acquisite sono state verificate attraverso interrogazioni, a conclusione della<br />
trattazione di ciascun modulo.<br />
Mezzi/strumenti<br />
Libro di testo e fotocopie ad integrazione del testo in adozione.<br />
Risultati ottenuti<br />
La classe, eccetto pochi studenti, ha mostrato scarso interesse per le discipline letterarie,<br />
accompagnato da un impegno discontinuo e superficiale ,soprattutto nel primo periodo dell’a.s.<br />
L’impegno modesto di una buona parte degli alunni ha comportato la riduzione di alcune unità<br />
didattiche, rispetto alla programmazione iniziale , per la necessità di rivedere e chiarire tematiche<br />
<strong>Pag</strong> . 49
già svolte , ovvero, di recuperare verifiche scritte od orali per alunni assenti , per potere procedere<br />
alle valutazioni periodiche. Relativamente ai risultati attesi un esiguo gruppo ha conseguito un<br />
discreto livello di profitto per conoscenze, rielaborazione di tematiche, per competenze<br />
linguistiche e di scrittura di varie tipologie testuali. Il resto della Classe si attesta sulla quasi<br />
sufficienza,relativamente a finalità generali ed obiettivi specifici disciplinari, a competenze<br />
comunicative, capacità di lettura e di rielaborazione personale. Per alcuni,a causa di ricorrenti<br />
assenze e di un impegno discontinuo e selettivo la conoscenza dei contenuti proposti risulta<br />
incerta,e disomogenea, ai limiti della sufficienza.<br />
Strumenti di valutazione<br />
Interrogazioni. Verifiche scritte intorno ai contenuti presi in esame, o a tematiche di attualità o non<br />
analizzate in classe.<br />
I criteri di valutazione hanno tenuto conto di impegno, interesse profuso , partecipazione<br />
e motivazione in classe,regolarità nella frequenza,progressi e miglioramenti effettivamente realizzati.<br />
Tipologia delle prove<br />
Sono state proposte le tipologie testuali previste per lo svolgimento della prova di italiano in sede<br />
di esame di Stato ( saggio breve, analisi di un testo, tema di attualità o storico ) La scelta della<br />
maggioranza della classe si è soprattutto orientata verso le tipologie A/B<br />
Si allegano testi di verifiche svolte dalla classe durante l’a.s.<br />
<strong>Pag</strong> . 50
TESTI DI SIMULAZIONI DI PROVE EFFETTUATE IN PREPARAZIONE<br />
DELL’ESAME DI STATO<br />
TIPOLOGIA A - ANALISI DI UN TESTO POETICO<br />
IL GELSOMINO NOTTURNO (G. Pascoli, I Canti di Castelvecchio )<br />
E s’aprono i fiori notturni,<br />
nell'ora che penso a' miei cari.<br />
Sono apparse in mezzo ai viburni * piccoli arbusti<br />
le farfalle crepuscolari.<br />
Da un pezzo si tacquero i gridi:<br />
là sola una casa bisbiglia.<br />
Sotto l'ali dormono i nidi,<br />
come gli occhi sotto le ciglia.<br />
Dai calici aperti si esala<br />
l'odore di fragole rosse<br />
Splende un lume là nella sala.<br />
Nasce l'erba sopra le fosse.<br />
Un'ape tardiva sussurra<br />
trovando già prese le celle.<br />
La Chioccetta per l'aia azzurra<br />
va col suo pigolìo di stelle.<br />
Per tutta la notte s’esala<br />
l'odore che passa col vento.<br />
Passa il lume su per la scala;<br />
brilla al primo piano: s’è spento...<br />
È I’alba, si chiudono i petali<br />
un poco gualciti; si cova,<br />
dentro l'urna molle e segreta,<br />
non so che felicità nuova.<br />
Giovanni Pascoli nacque a San Mauro di Romagna nel 1855. L'uccisione del padre, avvenuta nel<br />
1867 per mano ignota, fu l'inizio di una serie di disgrazie e lutti familiari che lascirono un segno<br />
profondo nella sua personalità e in tutte le sue opere. Pascoli scrisse questa poesia in occasione del<br />
matrimonio dell’amico Gabriele Briganti , strutturandola sull’analogia tra le nozze e la<br />
fecondazione del fiore.<br />
1.Comprensione complessiva: esponi il contenuto della lirica.<br />
1.Qual è il tema centrale della lirica, e in quale occasione è stata scritta? 2.La lirica si articola su due<br />
piani: uno descrittivo, con notazioni impressionistiche sulla notte, l’altro allusivo, simbolico.<br />
<strong>Pag</strong> . 51
Indica le frasi e le immagini corrispondenti. 3.Quali sono le immagini che rinviano alla solitudine<br />
del poeta? 4.Dove assistiamo alla contrapposizione vita – morte?<br />
2. Analisi del testo : Esamina il testo a livello metrico - ritmico: il tipo di versi, le rime e gli<br />
eventuali enjambement. 1. Ci sono metafore significative? Individuale e spiega il loro significato.<br />
2.Cosa suggerisce il verbo "bisbiglia" riferito a "una casa"? 3.Evidenzia le sinestesie presenti nella<br />
lirica. 4."Sotto l'ali dormono i nidi": che valore assume il termine "nido"? Può essere contrapposto a<br />
"casa"? E perché?<br />
3. Approfondimenti 1.Rifletti sul significato del "nido" nella poesia del Pascoli. 2.Qual è la<br />
funzione della natura nella poesia pascoliana?<br />
TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI<br />
GIORNALE”<br />
CONSEGNE Sviluppa l’argomento scelto o in forma di “saggio breve” o di “articolo di<br />
giornale”, utilizzando i documenti e i dati che lo corredano.<br />
Se scegli la forma del “saggio breve”, interpreta e confronta i documenti e i dati forniti e su<br />
questa base svolgi, argomentandola, la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue<br />
conoscenze ed esperienze di studio<br />
Da’ al saggio un titolo coerente con la tua trattazione e ipotizzane una destinazione editoriale<br />
(rivista specialistica, fascicolo scolastico di ricerca e documentazione, rassegna di argomento<br />
culturale, altro). Se scegli ” l’articolo di giornale” indica il titolo dell’articolo ed il tipo di<br />
giornale sul quale pensi che l’articolo debba essere pubblicato. Per entrambe le forme di scrittura<br />
non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo.<br />
AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO<br />
ARGOMENTO: AMORE, ODIO, PASSIONE.<br />
1.«Tra l’altre distinzioni e privilegi che le erano stati concessi, per compensarla di non poter esser<br />
badessa, c’era anche quello di stare in un quartiere a parte. Quel lato del monastero era contiguo a<br />
una casa abitata da un giovine, scellerato di professione, uno de’ tanti, che, in que’ tempi, e co’ loro<br />
sgherri, e con l’alleanze d’altri scellerati, potevano, fino a un certo segno, ridersi della forza<br />
pubblica e delle leggi. Il nostro manoscritto lo nomina Egidio, senza parlar del casato. Costui, da<br />
una sua finestrina che dominava un cortiletto di quel quartiere, avendo veduta Gertrude qualche<br />
volta passare o girandolar lì, per ozio, allettato anzi che atterrito dai pericoli e dall’empietà<br />
dell’impresa, un giorno osò rivolgerle il discorso. La sventurata rispose.» (Alessandro MANZONI,<br />
I promessi sposi, 1840-42)<br />
2.«Ed avrebbe voluto strapparsi gli occhi per non vedere quelli della Lupa, che quando gli si<br />
ficcavano ne’ suoi gli facevano perdere l’anima ed il corpo. Non sapeva più che fare per svincolarsi<br />
dall’incantesimo. <strong>Pag</strong>ò delle messe alle anime del Purgatorio e andò a chiedere aiuto al parroco e al<br />
brigadiere. A Pasqua andò a confessarsi, e fece pubblicamente sei palmi di lingua a strasciconi sui<br />
ciottoli del sacrato innanzi alla chiesa, in penitenza, e poi, come la Lupa tornava a tentarlo:<br />
- Sentite! le disse, non ci venite più nell’aia, perché se tornate a cercarmi, com’è vero Iddio, vi<br />
ammazzo!<br />
- Ammazzami, rispose la Lupa, ché non me ne importa; ma senza di te non voglio starci.<br />
Ei come la scorse da lontano, in mezzo a’ seminati verdi, lasciò di zappare la vigna, e andò a<br />
staccare la scure dall’olmo. La Lupa lo vide venire, pallido e stralunato, colla scure che luccicava al<br />
sole, e non si arretrò di un sol passo, non chinò gli occhi, seguitò ad andargli incontro, con le mani<br />
<strong>Pag</strong> . 52
piene di manipoli di papaveri rossi, e mangiandoselo con gli occhi neri. - Ah! malanno all’anima<br />
vostra! balbettò Nanni.» (Giovanni VERGA, La Lupa, in Vita dei campi, 1880)<br />
3.«Ella pareva colpita dal suono insolito della voce di Giorgio; e un vago sbigottimento cominciava<br />
a invaderla.<br />
– Ma vieni!<br />
Ed egli le si appressò con le mani tese. Rapidamente l’afferrò per i polsi, la trascinò per un piccolo<br />
tratto; poi la strinse tra le braccia, con un balzo, tentando di piegarla verso l’abisso.<br />
– No, no, no...<br />
Con uno sforzo rabbioso ella resistette, si divincolò, riuscì a liberarsi, saltò indietro anelando e<br />
tremando.<br />
– Sei pazzo? – gridò con l’ira nella gola. – Sei pazzo?<br />
Ma, come se lo vide venire di nuovo addosso senza parlare, come si sentì afferrata con una violenza<br />
più acre e trascinata ancóra verso il pericolo, ella comprese tutto in un gran lampo sinistro che le<br />
folgorò l’anima di terrore.<br />
– No, no, Giorgio! Lasciami! Lasciami! Ancóra un minuto! Ascolta! Ascolta! Un minuto! Voglio<br />
dirti...<br />
Ella supplicava, folle di terrore, divincolandosi. Sperava di trattenerlo, d’impietosirlo.<br />
– Un minuto! Ascolta! Ti amo! Perdonami! Perdonami!<br />
Ella balbettava parole incoerenti, disperata, sentendosi vincere, perdendo terreno, vedendo la morte.<br />
– Assassino! – urlò allora furibonda.<br />
E si difese con le unghie, con i morsi, come una fiera.<br />
– Assassino! – urlò sentendosi afferrare per i capelli, stramazzando al suolo su l’orlo dell’abisso,<br />
perduta.Il cane latrava contro il viluppo.Fu una lotta breve e feroce come tra nemici implacabili che<br />
avessero covato fino a quell’ora nel profondo dell’anima un odio supremo.<br />
E precipitarono nella morte avvinti.» (Gabriele D’ANNUNZIO, Il trionfo della morte, 1894)<br />
5.«Emilio poté esperimentare quanto importante sia il possesso di una donna lungamente desiderata.<br />
In quella memorabile sera egli poteva credere d’essersi mutato ben due volte nell’intima sua natura.<br />
Era sparita la sconsolata inerzia che l’aveva spinto a ricercare Angiolina, ma erasi anche annullato<br />
l’entusiasmo che lo aveva fatto singhiozzare di felicità e di tristezza. Il maschio era oramai<br />
soddisfatto ma, all’infuori di quella soddisfazione, egli veramente non ne aveva sentita altra. Aveva<br />
posseduto la donna che odiava, non quella ch’egli amava. Oh, ingannatrice! Non era né la prima, né<br />
– come voleva dargli ad intendere – la seconda volta ch’ella passava per un letto d’amore. Non<br />
valeva la pena di adirarsene perché l’aveva saputo da lungo tempo. Ma il possesso gli aveva data<br />
una grande libertà di giudizio sulla donna che gli si era sottomessa. – Non sognerò mai più – pensò<br />
uscendo da quella casa. E poco dopo, guardandola, illuminata da pallidi riflessi lunari: – Forse non<br />
ci ritornerò mai più. – Non era una decisione. Perché l’avrebbe dovuta prendere? Il tutto mancava<br />
d’importanza.»(Italo SVEVO, Senilità, 19272 (1a ed. 1898)<br />
TIPOLOGIA D – TEMA DI ATTUALITA’<br />
Immigrazione: risorsa o problema?L'immigrazione esiste fin dai tempi più antichi, ma al giorno<br />
d'oggi sta prendendo una piega che preoccupa molte persone. In molti sopratutto in Italia infatti si<br />
sentono "in pericolo" a causa di tutti gli immigrati che provengono dagli stati del bacino del<br />
Mediterraneo, ma in molti invece sono convinti (giustamente) che gli immigrati possono dare un<br />
grande aiuto al nostro paese che è sempre più in crisi. Esponi le tue conoscenze sulla tematica e<br />
riferisci se, a tuo avviso, potrebbe essere possibile una vera integrazione ed una pacifica convivenza<br />
nel nostro Paese.<br />
<strong>Pag</strong> . 53
PROGRAMMA SVOLTO<br />
A.s. 2011/2012<br />
Classe V B S R<br />
Disciplina ITALIANO<br />
Docente : Nara Pii<br />
Libro di testo.<br />
Titolo: Mappe di letteratura<br />
Il Novecento<br />
Autore: Paolo Di Sacco<br />
Edizioni scolastiche Bruno Mondadori<br />
MODULO I<br />
Il Saggio breve; l’articolo di giornale (articolo di opinione e/o di fondo)<br />
L' analisi del testo ( in prosa ed in poesia )<br />
Il tema:tipologia C/D<br />
MODULO II<br />
STORICO CULTURALE<br />
DAL DECADENTISMO AL FUTURISMO<br />
Il Decadentismo francese ed italiano<br />
Il Simbolismo<br />
Le Avanguardie:<br />
Il Futurismo : il contesto storico ; le coordinate culturali<br />
Filippo Tommaso Marinetti : biografia e poetica<br />
Il Manifesto del futurismo. Il manifesto tecnico della letteratura futurista<br />
MODULO III<br />
PER GENERE<br />
IL Genere lirico<br />
La lirica decadente e simbolista<br />
Charles Baudelaire<br />
Biografia, poetica<br />
Analisi delle liriche:”Corrispondenze” “Spleen”“L’albatro”<br />
<strong>Pag</strong> . 54
Gabriele D' Annunzio<br />
Biografia, poetica<br />
Trama di “Il piacere” Analisi di “Il ritratto dell’esteta”<br />
“L’ Innocente”: trama Visione del film<br />
I romanzi della rosa: “Il trionfo della morte”: trama.<br />
I romanzi del giglio: “La vergine delle rocce .<br />
Da “Alcione “: “La Pioggia nel pineto” “La sera fiesolana “”I pastori”<br />
Da “Notturno” Analisi del passo:”Imparo un’arte nuova”<br />
Giovanni Pascoli<br />
Biografia, poetica<br />
Il fanciulloni : analisi del passo “Il fanciullo che è in noi”<br />
Da “Myricae”<br />
Analisi delle liriche:” Novembre “” Lavandare” “ Arano” “Il tuono””Il lampo” “X Agosto””La<br />
cavalla storna”<br />
Da “I canti di Castelvecchio”: “Il gelsomino notturno”<br />
Da “I poemetti” : “ Digitale purpurea”<br />
MODULO IV<br />
IL ROMANZO DEL NOVECENTO<br />
Italo Svevo<br />
Biografia; Le idee Il contesto culturale<br />
Da “Una vita”trama<br />
analisi di :”Gabbiani e pesci”<br />
Da “Senilità”trama<br />
Analisi di:” La metamorfosi strana di Angiolina”<br />
Da “La coscienza di Zeno”La trama e la struttura dell’opera<br />
Analisi di :”Il fumo” “Il funerale mancato ” “Psico-analisi”<br />
Luigi Pirandello<br />
Biografia; le idee.<br />
La vita e la forma. Il relativismo conoscitivo. La lanterninosofia.<br />
L’umorismo<br />
Da “Novelle per un anno”: “Il treno Ha fischiato”<br />
Trama dei romanzi :”Il fu Mattia Pascal” “Analisi di “Adriano Meis””Io sono il fu Mattia Pascal”<br />
Uno,nessuno,centomila”: analisi di “Il naso di Moscarda<br />
L’esclusa”:trama<br />
MODULO V<br />
PER GENERE<br />
LA POESIA DEL NOVECENTO<br />
La lirica della guerra<br />
Giuseppe Ungaretti<br />
Biografia, poetica. Le scelte stilistiche e formali<br />
Da “Allegria dei naufragi”<br />
Analisi di: “Veglia”, “Natale” S. Martino del Carso” “Sono una creatura” “ I fiumi”<br />
”In memoria” Da “Sentimento del tempo”: “La madre”<br />
“Il male di vivere”<br />
<strong>Pag</strong> . 55
Eugenio Montale<br />
Biografia , poetica<br />
Da “Ossi di Seppia”<br />
Analisi di :”Meriggiare pallido e assorto” “Spesso il male di vivere”<br />
Da “Occasioni”: “Non recidere, forbice,quel volto”……..<br />
Da “Satura” Ho sceso dandoti il braccio”<br />
Umberto Saba<br />
Analisi di : “Ritratto della mia bambina” “La capra”<br />
Salvatore Quasimodo<br />
Analisi di :”Ed è subito sera” “Alle fronde dei salici”<br />
MODULO VI<br />
PER TEMA<br />
LA NARRATIVA DEL NOVECENTO<br />
Primo Levi : da “ Se questo è un uomo “ : Analisi del brano : HurbineK<br />
“Sul fondo”<br />
09 –Maggio 2012<br />
L’insegnante Gli Studenti<br />
Nara Pii<br />
<strong>Pag</strong> . 56
SCHEDA DISCIPLINARE<br />
STORIA<br />
Docente : NARA PII<br />
libro di testo : Il tempo e le idee<br />
Vol 2 : dal primo dopoguerra al mondo globale<br />
Autori:F. M.Feltri – M.M. Bertazzoni –F. Neri<br />
Edizioni SEI<br />
Contenuti dei moduli preparati per l' esame e tempi di svolgimento<br />
MODULO I<br />
MODULO DI RACCORDO CON LA CLASSE IV<br />
LE PROBLEMATICHE DELL’ITALIA POST UNITARIA<br />
Tempi : Settembre/Ottobre<br />
MODULO II<br />
L’ITALIA LIBERALE<br />
MODULO III<br />
LE GUERRE DEL NOVECENTO<br />
La I° guerra mondiale<br />
Il dopoguerra e le sue problematiche<br />
La Rivoluzione russa<br />
Tempi : Novembre/ Dicembre/Gennaio/<br />
MODULO IV<br />
LE DITTATURE MODERNE<br />
Stalinismo<br />
Fascismo<br />
Nazismo<br />
Tempi : Febbraio /Marzo<br />
MODULO V<br />
LE GUERRE DEL NOVECENTO<br />
La II° guerra mondiale<br />
Il mondo bipolare<br />
La guerra fredda<br />
Tempi: Aprile<br />
<strong>Pag</strong> . 57
MODULO VI<br />
L' ITALIA REPUBBLICANA<br />
La Costituzione<br />
La fine della guerra fredda<br />
Cenni sulle guerre del mondo contemporaneo<br />
Tempi : Maggio<br />
MODULO VII<br />
IL LAVORO<br />
La situazione socio economica nel dopoguerra<br />
Il biennio rosso e lo sciopero<br />
Il Fascismo ed il mondo del lavoro<br />
La nascita delle Confederazioni sindacali<br />
Il lavoro nella Costituzione<br />
La legge 30 Biagi<br />
Tempi: in itinere<br />
Metodologie<br />
L’insegnamento della disciplina è stato finalizzato al potenziamento/conseguimento delle seguenti<br />
competenze : sapere riconoscere eventi e problematiche di un periodo storico,utilizzare le<br />
conoscenze storiche per interpretare e capire il presente,individuare le differenze tra Stato liberale e<br />
Stato totalitario,distinguere comportamenti,ideologie e politiche,utilizzare il lessico specifico in<br />
forma corretta e appropriata. Conoscere eventi di storia contemporanea.<br />
Le varie tematiche sono state presentate attraverso le seguenti metodologie:<br />
lezione frontale e dialogata; approfondimenti attraverso l' analisi di documenti.; verifiche orali;<br />
prove strutturate e semistrutturate, schematizzazioni.<br />
Mezzi / strumenti<br />
Libro di testo e fotocopie ad integrazione del testo in adozione.<br />
Risultati ottenuti<br />
La maggioranza della classe ha mostrato un certo interesse per le tematiche affrontate, anche se lo<br />
studio e l’impegno,poco regolari e un po’ superficiali , sono stati profusi solo da un numero limitato<br />
di allievi.<br />
Il livello di formazione raggiunto è pertanto il seguente: un numero esiguo di alunni ha conseguito<br />
finalità , obiettivi e competenze disciplinari : conosce fatti , contesti ; ha sviluppato capacità<br />
interpretative di problematiche e di fenomeni, utilizza abbastanza correttamente il linguaggio<br />
specifico.<br />
Alcuni studenti , sebbene in possesso di prerequisiti e potenzialità,hanno raggiunto un profitto<br />
globalmente sufficiente, seppure abbastanza mnemonico. Altri presentano un livello di formazione<br />
generale,disorganico, e ai limiti della sufficienza.<br />
Strumenti di valutazione<br />
La valutazione ha tenuto conto degli effettivi apprendimenti, delle finalità conseguite, delle<br />
abilità / competenze sviluppate, nonché di eventuali progressi, di regolarità di impegno e di<br />
partecipazione.<br />
Tipologia delle prove<br />
Verifiche orali. Interventi e dibattiti individuali , durante o a conclusione di ogni modulo, prove<br />
strutturate e semistrutturate. ( secondo la tipologia B/C) .<br />
<strong>Pag</strong> . 58
Si allega un testo di verifica svolta dalla classe durante l’a.s.<br />
TIPOLOGIA B/C<br />
Domande a scelta multipla punti 0,25 Domande aperte punti 1<br />
CRITERI DI VALUTAZIONE:<br />
Correttezza ed ampiezza delle risposte<br />
Linguaggio specifico corretto<br />
1. Durante le sue fasi iniziali, il movimento fascista si basò sull’appoggio : (una sola risposta<br />
corretta)<br />
dei socialisti, con i quali condivideva alcuni principi di politica sociale<br />
degli agrari della pianura padana, intenzionati a reprimere l’organizzazione politica dei<br />
braccianti<br />
dei cattolici popolari, spaventati dall’avanzata delle sinistre<br />
della monarchia, che ne apprezzava l’ispirazione nazionalistica<br />
2. Il biennio rosso fu : (una sola risposta corretta)<br />
un periodo di violenze che caratterizzò i primi due anni della rivoluzione bolscevica<br />
i primi anni di lotta politica del partito comunista in Italia<br />
i primi due anni in cui si affermò il regime di Stalin dopo la formazione dell’U.R.S.S<br />
un periodo di lotte politiche e di scioperi che caratterizzarono l' Italia dopo la '' Grande guerra''<br />
3. Cosa si intende per politica autarchica?:(una sola risposta corretta)<br />
è la politica estera seguita da Benito Mussolini, mirante a ridurre al minimo la dipendenza da<br />
stati stranieri sviluppando al massimo l’autonomia nazionale<br />
è una politica di autonomia economica, rivolta a ridurre al minimo le importazioni, sviluppando<br />
al massimo la produzione interna per contenere il deficit nazionale<br />
è una politica economica tesa a ridurre al minimo la dipendenza dalle esportazioni sviluppando<br />
al massimo il consumo delle merci prodotte in patria<br />
è una politica interna rivolta a ridurre al minimo la dipendenza dalle ideologie straniere<br />
4.Le leggi “fascistissime” prevedevano: (una sola risposta corretta)<br />
che B. Mussolini avrebbe dovuto rispondere del suo operato solo dinanzi al Parlamento<br />
che il Parlamento avrebbe mantenuto la sua validità e che sarebbe stato affiancato nella sua<br />
attività dal Gran Consiglio del Fascismo<br />
che il Re sarebbe potuto intervenire contro il governo affidato a Benito Mussolini<br />
che il Parlamento veniva privato della propria funzione e che Mussolini avrebbe dovuto<br />
rispondere del suo operato solo davanti al re Vittorio Emanuele III<br />
<strong>Pag</strong> . 59
5.Esponi come si svolse la “Marcia su Roma”ed in quale data<br />
________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________<br />
6.Cosa fu la “Secessione dell’Aventino?<br />
________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________<br />
_______________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________<br />
<strong>Pag</strong> . 60
PROGRAMMA SVOLTO<br />
A.s. 2011/2012<br />
Classe V B S R<br />
STORIA<br />
Docente : NARA PII<br />
libro di testo : Il tempo e le idee<br />
Vol 2 : dal primo dopoguerra al mondo globale<br />
Edizioni SEI<br />
MODULO I<br />
MODULO DI RACCORDO CON LA CLASSE IV<br />
LE PROBLEMATICHE DELL’ITALIA POST UNITARIA<br />
MODULO II<br />
L’ITALIA LIBERALE<br />
MODULO III<br />
LE GUERRE DEL NOVECENTO<br />
La I° guerra mondiale<br />
Il dopoguerra e le sue problematiche<br />
La Rivoluzione russa:<br />
la rivoluzione di febbraio, la rivoluzione di ottobre<br />
Lenin : le tesi d’Aprile. Il comunismo di guerra. La Nep<br />
la guerra civile<br />
La nascita dell’U.R.S.S.<br />
MODULO IV<br />
LE DITTATURE MODERNE<br />
Stalinismo:<br />
l’industrializzazione forzata. I piani quinquennali<br />
Il dopoguerra in Italia<br />
Fascismo:<br />
lo squadrismo e la marcia su Roma<br />
Il delitto Matteotti<br />
La Chiesa ed il Fascismo<br />
La politica economica : la battaglia del grano; la quota “90<br />
Le coorporazioni<br />
la politica estera : la guerra d’Etiopia<br />
Le leggi raziali<br />
Nazismo:<br />
Il dopoguerra in Germania<br />
L’ascesa di A. Hitler<br />
<strong>Pag</strong> . 61
Politica interna ed estera di A. Hitler<br />
Le leggi razziali e la Shoah<br />
La crisi del 1929 e la grande depressione negli USA<br />
MODULO V<br />
LE GUERRE DEL NOVECENTO<br />
La II° guerra mondiale<br />
Il mondo bipolare<br />
La guerra fredda<br />
MODULO VI<br />
L' ITALIA REPUBBLICANA<br />
La Costituzione<br />
La fine della guerra fredda<br />
Cenni sulle guerre del mondo contemporaneo<br />
MODULO VII<br />
IL LAVORO<br />
La situazione socio economica nel dopoguerra<br />
Il biennio rosso e lo sciopero<br />
La costituzione italiana ed il lavoro<br />
La nascita delle Confederazioni sindacali<br />
La legge 30 Biagi<br />
09-Maggio 2012<br />
L’insegnante Gli Studenti<br />
Nara Pii<br />
<strong>Pag</strong> . 62
DISCIPLINA : Lingua inglese<br />
DOCENTE : Antonietta Malaspina<br />
LIBRI DI TESTO : Catering Land<br />
SCHEDA DISCIPLINARE<br />
CLASSE 5 sez.B<br />
a.s. 2011/2012<br />
MODULI PREPARATI PER L’ESAME E TEMPI DI SVOLGIMENTO<br />
Settembre : Banqueting<br />
Ottobre : Functions ( definitions )<br />
Novembre/Dicembre : Healthy eating : dietary recommendations and food guides<br />
Gennaio : The importance of advertising<br />
Timing<br />
Communication and information<br />
Febbraio : The function catering staff<br />
The food pyramid<br />
Marzo: Milk<br />
Cheese<br />
Aprile: Function Catering<br />
Function Catering Responsibilities<br />
Seating Plan<br />
Maggio: Buffet Service<br />
Buffet Table Arrangement<br />
Preparing the buffet table<br />
The HACCP System<br />
METODOLOGIE<br />
Per conseguire gli obiettivi previsti all’inizio dell’anno la programmazione disciplinare ha utilizzato<br />
lezioni frontali , lavori individuali , lettura e comprensione dei testi riguardanti il settore dei servizi<br />
ristorativi a cui e’ seguito l’accertamento della comprensione globale del testo . In seguito,<br />
attraverso opportuni esercizi , gli alunni sono stati guidati all’analisi delle funzioni , delle strutture<br />
grammaticali e delle espressioni idiomatiche della lingua fondamentale e specialistica.<br />
Questa attività ha avuto come fine il raggiungimento di un’espressione corretta e il più personale<br />
possibile sia nella lingua scritta che nell’espressione orale, il consolidamento e l’ampliamento delle<br />
strutture linguistiche e del patrimonio lessicale.<br />
MEZZI/STRUMENTI<br />
Sono stati utilizzati : libro di testo , fotocopie , materiale autentico , materiale tratto dal web e<br />
materiale prodotto dall’insegnante.<br />
Sono state effettuate verifiche del processo di apprendimento ( formative e sommative ) .<br />
Questo ha permesso di verificare le effettive conoscenze e competenze acquisite da ogni singolo<br />
studente e di effettuare un processo di recupero in itinere tutte le volte che si e’ reso necessario .<br />
<strong>Pag</strong> . 63
Le verifiche sono state costituite da colloqui , prove strutturate e semistrutturate,comprensione del<br />
testo scritto con domande aperte , tipologie previste in Terza Prova ( domande a scelta multipla e<br />
aperte ) .<br />
Per quanto riguarda la valutazione ho seguito le indicazioni generali e la scala numerica decisa e<br />
approvata all’inizio dell’anno scolastico dal consiglio di classe .<br />
RISULTATI OTTENUTI<br />
La classe non ha sempre evidenziato un costante interesse nei confronti delle attivita’ svolte .<br />
Gli alunni risultano piuttosto eterogenei per quanto riguarda le capacita’ personali , disponibilita’ a<br />
lavorare , tempi di attenzione , gradi di assimilazione dei contenuti .<br />
Non tutti gli alunni si sono impegnati con la stessa assiduita’ e questo , insieme alle diverse<br />
capacita’ logiche e alla diversa situazione di partenza , ha portato a risultati e profitti differenziati .<br />
Durante il corso dell’anno numerose sono state le assenze per alcuni alunni e questo ha in parte<br />
rallentato lo svolgimento delle attivita’ curriculari e impedito il raggiungimento di alcune delle<br />
competenze previste per questo anno .<br />
All’interno della classe si e’ distinto un piccolo gruppo di alunni motivati , con una partecipazione<br />
propositiva e produttiva verso le varie attivita’ didattiche raggiungendo un profitto piu’ che buono ;<br />
la maggior parte si e’ impegnata in modo accettabile raggiungendo il piano della piena sufficienza .<br />
Una sola alunna , per elevato numero di assenze , gravi lacune di base e impegno assente presenta<br />
un profitto gravemente insufficiente .<br />
Si allegano uno o più testi di verifiche svolte dalla classe durante l’a.s.2011/2012<br />
<strong>Pag</strong> . 64
SECTION 1<br />
1 Look through the text and find the English correspondent for the following ltalian words "‘<br />
or phrases.<br />
How do you like your water?<br />
lt seems ironic that when we British go abroad we become snooty about drinking the local water,<br />
when<br />
it seems some of us are not exactly keen to drink our own. In theory though, 99.7% of UK tap water<br />
meets European purity standards. Ofwat, the water watchdog, says that pesticides have been<br />
“almost<br />
eliminated” from UK tap water.<br />
Still, it's not difficult to see why people are attracted to bottled water. Buzzwords such as “natural”,<br />
“spring" and “pure” conjure up images of healthy living and fitness. But surely no one would waste<br />
their money on water that was no purer or better tasting than tap water — would they?<br />
In one blind tasting conducted by The Sunday Times, a panel of drink, food and water-quality<br />
experts<br />
graded plain old tap water as highly as bottled. In another experiment, Which? magazine found<br />
similar results.<br />
So are we fooling ourselves about bottled water? The argument rages on, but there are other<br />
reasons<br />
why buying bottled water may be less than desiderable. Friends of Earth is concerned about the<br />
envi-<br />
ronmental impact - we currently dispose of about 600,000 tonnes of plastic water bottles every year<br />
in landfill sites. To say nothing of the lunacy of transporting the stuff from such far-flung places as<br />
Argentina.<br />
Elixir of life<br />
Why do we need to drink so much water anyway? Nutritionist Jane‘Clarke, author of Body Foods<br />
for<br />
Life (Weidenfeld & Nicolson), explains: “Water keeps the body flushed of waste products and helps<br />
to keep the skin, hair and organs healthy. It aids digestion and enables the body to take up essential<br />
nutrients from food”. -<br />
Clarke believes that many health problems could be avoided if we drank more water. In addition,<br />
she<br />
says “central heating and air-conditioning cause us to lose more water than before, plus our diets<br />
contain more salt, additives and sugar — all of which places more strain on the body’s water<br />
reserves”.<br />
Research carried out in April this year by Gallup showed that nearly 60% of us drink less than four<br />
glasses of water a day — a worrying statistic. Yet most of us find it difficult to get through even a<br />
litre<br />
a day, let alone the two or three recommended. Clarke advises us to get into the habit of taking fre-<br />
quent sips — keep a bottle of fresh chilled water in the fridge/on your desk/in the car, as well as<br />
drinking a glass every hour if you can. But which is the best, bottled or tap water? “l think it’s a<br />
question of<br />
taste. The tap water in your area may be indistinguishable from the purest mineral water. If you’re<br />
unsure, you could always use a water filter’.<br />
<strong>Pag</strong> . 65<br />
(Adapted from: Good Food)
1 diventare snob, sdegnoso ….................................................................................................<br />
2 entusiasta ….........................................................................................................................<br />
3 acqua del rubinetto ..............................................................................................................<br />
4 acqua di sorgente, di ionte ...................................................................................................<br />
5 impatto ambientale ..............................................................................................................<br />
6 prodotti di scarto, di rifiuto .................................................................................................<br />
7 riscaldamento centralizzato .................................................................................................<br />
8 sforzo,sollecitazione ..............................................................................................................<br />
9 sorso …...................................................................................................................................<br />
<strong>Pag</strong> . 66<br />
Points …..../9<br />
2 Now read the text and decide the following statements are true or false. Then correct<br />
the false one.<br />
False<br />
True<br />
1 When the British go abroad, they do not mind drinking the local water <br />
.................................................................................................................<br />
2 People are attracted to bottled water because labels use words which give <br />
images of healty living and fitness.<br />
.................................................................................................................<br />
3 Food and water quality experts graded bottled water more higly than plain <br />
tap water.<br />
.................................................................................................................<br />
4 Jane Clark is a journalist <br />
.................................................................................................................<br />
5 Many health problems could be avoided by drinking more water <br />
.................................................................................................................<br />
6 Our body needs more water today than in the past partlu beacuse of our diets, <br />
which contain more salt, additives and sugar<br />
.................................................................................................................<br />
7 Experts say we should drink between two and three litres of water a day <br />
.................................................................................................................<br />
8 If you use a water filter, tap water can taste better than bottled water <br />
.................................................................................................................
3 Answer the following questions<br />
1 Why are environmentalists concerned about buying bottled water? <br />
<br />
.................................................................................................................<br />
2 Why do people need to drink water for their health? <br />
.................................................................................................................<br />
3 What does Jane Clarke advise the reader about water drinking habits? <br />
.................................................................................................................<br />
4 Do people prefer tap water or bottled water? Why? <br />
.................................................................................................................<br />
5 Why are statistics worrying about people's drinking habits? <br />
.................................................................................................................<br />
<strong>Pag</strong> . 67
Programma di lingua inglese<br />
Anno scolastico2011/2012<br />
Dal testo : Catering Land<br />
CLASSE 5 B SR<br />
Banqueting<br />
Functions<br />
Healthy eating : dietary recommendations and food guides<br />
The importance of advertising<br />
Timing<br />
Communication and information<br />
The function catering staff<br />
The food pyramid<br />
Milk<br />
Cheese<br />
Function catering<br />
Function catering responsibilities<br />
Seating plan<br />
Buffet service<br />
Buffet table arrangement<br />
Preparing the buffet table<br />
The HACCP System<br />
L’insegnante Gli alunni<br />
<strong>Pag</strong> . 68
SCHEDA DISCIPLINARE<br />
DISCIPLINA : SPAGNOLO-LINGUA E CIVILTÀ ( SERVIZI DI RISTORAZIONE )<br />
DOCENTE Cerroni Luigi<br />
LIBRI DI TESTO ¡En Su Punto ! Ed. Hoepli: per la sezione: Servizi Ristorativi<br />
MODULI PREPARATI PER L’ESAME E TEMPI DI SVOLGIMENTO<br />
MODULO N. 1 di 2<br />
TITOLO: RINFORZO LINGUISTICO<br />
REQUISITI<br />
NECESSARI PER<br />
AFFRONTARE IL<br />
MODULO<br />
COMPETENZA IN<br />
USCITA<br />
ABILITÀ<br />
RILEVATORI<br />
DELLA<br />
COMPETENZA<br />
TEMPI<br />
COLLEGAMENTI<br />
INTERDISCIPLINARI<br />
Conoscenza generale delle strutture linguistiche studiate durante gli anni<br />
precedenti.<br />
Conoscenza generale delle principali funzioni comunicative studiate<br />
durante gli anni precedenti.<br />
Conoscenza delle competenze di base uniformemente al protocollo<br />
stabilito a livello disciplinare –linguistico.<br />
Sapere:<br />
Svolgere esercizi strutturati in lingua.<br />
Comunicare in lingua sulla routine quotidiana al presente ed esprimere<br />
azioni trascorse utilizzando il passato, parlare di piani e progetti futuri,<br />
dare indicazioni, esprimere opinioni.<br />
Saper utilizzare correttamente competenze linguistiche di base sia nella<br />
produzione orale (libera e guidata), sia nella produzione scritta<br />
(strutturata e semi-strutturata).<br />
Ottobre – Dicembre ( 32 ore )<br />
Italiano e lingue straniere.<br />
<strong>Pag</strong> . 69
MODULO N.2 di 2<br />
TITOLO: PRODOTTI TIPICI SPAGNOLI<br />
REQUISITI<br />
NECESSARI PER<br />
AFFRONTARE IL<br />
MODULO<br />
COMPETENZA IN<br />
USCITA<br />
ABILITÀ<br />
RILEVATORI<br />
DELLA<br />
COMPETENZA<br />
Tempi: Febbraio-Aprile (30 ore)<br />
METODOLOGIE<br />
Conoscenza delle strutture linguistiche di base studiate negli anni<br />
precedenti.<br />
Conoscenza del vocabolario specifico su pasti e bevande studiato durante<br />
gli anni precedenti.<br />
Conoscenza delle funzioni comunicative di base studiate negli anni<br />
precedenti.<br />
L’alunno deve saper presentare le specialità spagnole.<br />
Sapere:<br />
Riferire le conoscenze specifiche sui vari aspetti della Spagna.<br />
Presentare le specialità spagnole.<br />
Operare confronti.<br />
Esprimere opinioni personali.<br />
La differenza tra i diversi ristoranti tipici spagnoli (restaurantes<br />
tradicionales, de entretenimiento, etnico, mesones y tabernas, de comida<br />
rápida).<br />
Risposte a questionari a scelta multipla o a risposta libera di<br />
comprensione del testo.<br />
Presentare con pronuncia corretta le conoscenze acquisite. Relazionare,<br />
con linguaggio semplice e corretto le conoscenze acquisite.<br />
Lezione frontale, lavoro a coppie e individuale. Lavoro di arricchimento del vocabolario.<br />
MEZZI/STRUMENTI<br />
Esercizi strutturati e semistrutturati di completamento dati.<br />
Risposte a questionari a scelta multipla o a risposta libera di comprensione del testo.<br />
RISULTATI OTTENUTI<br />
Solo in alcuni casi si sono ottenuti dei livelli apprezzabili, trattandosi comunque di studenti già in<br />
possesso di buone competenze. Per il resto, si è cercato di non lasciar disperdere i patrimoni<br />
lessicali e grammaticali conseguiti durante gli anni precedenti, riuscendo generalmente a far<br />
riguadagnare, con le esercitazioni relative, un buon livello di apprendimento.<br />
<strong>Pag</strong> . 70
Si allegano testi di verifiche svolte dalla classe durante l’a.s.<br />
A) Riportare di seguito due dialoghi in cui compaiano altrettante tipiche situazioni di sala e/o di<br />
cucina<br />
B)Paella.<br />
Limpiar los mejillones y ponerlos en una cacerola con una taza de agua al fuego hasta que se abran.<br />
Colar el caldo y reservar ambas cosas. Pelar los langostinos y cocer las cabezas y las cáscaras en<br />
dos tazas de agua y sal durante diez minutos; colar y reservar el caldo. Calentar dos cucharadas de<br />
aceite en una sartencita y añadir los ajos picados; cuando estén dorados, agregar las ñoras (1)<br />
limpias y troceadas, el azafrán y perejil picado. Mantener en el fuego 1-2 minutos y machacar todo<br />
en el mortero hasta conseguir una pasta compacta. Calentar el aceite restante en la paellera y freír el<br />
pollo con sal hasta que esté ligeramente dorado.incorporar la cebolla y cuando esté transparente,<br />
añadir los calamares limpios y troceados, y las verduras. Revolver y mantener en el fuego hasta que<br />
el tomate comience a ponerse oscuro. Agregar el arroz, dar unas vueltas e incorporar el caldo de los<br />
mejillones y de las cabezas de los langostinos, con el majado preparado. ( El caldo debe ser el doble<br />
del volumen que el del arroz ). Si el caldo de mejillones y langostinos no fuese suficiente, se<br />
completará con agua o caldo. Cocer a fuego vivo unos diez minutos, añadir los mejillones sin<br />
concha, reservando unos cuantos para adornar y los langostinos pelados. Continuar cociendo unos<br />
5-6 minutos a fuego suave. Tapar con un paño y dejar reposar unos cinco minutos.<br />
( 1 )La ñora Es una variedad cultivada de Capsicum o pimiento, denominada "bola" en Murcia y<br />
Alicante de las<br />
cuales se considera originaria, de pequeño tamaño, forma redonda y color rojo, que se deja secar al<br />
sol.<br />
Tiene un sabor dulce y es muy utilizada en la gastronomía del Levante español, sobre todo en la<br />
Región de Murcia, la Comunidad Valenciana (Alicante) y en Cataluña<br />
Completare le seguenti domande:<br />
2. Los mejillones deben de estar ...................<br />
3. Cuando los mejillones estén abiertos, tendrás que ...................<br />
4. Cueces las cabezas y las cáscaras para obtener .................... (2 palabras)<br />
5. Calientas el aceite para sofreír ....................... ( 2 palabras )<br />
6. ................. agua o caldo si el caldo de mariscos no te basta.<br />
Rispondere alle seguenti domande:<br />
e) ¿ A qué se refiere “unos cuantos” ? (línea 17)<br />
f) ¿ De qué manera el tomate podría “ponerse oscuro”?<br />
<strong>Pag</strong> . 71
Programma<br />
DISCIPLINA Spagnolo-Lingua e Civiltà ( Servizi di Ristorazione )<br />
DOCENTE Cerroni Luigi<br />
LIBRI DI TESTO ¡En Su Punto ! Ed. Hoepli: per la sezione: Servizi Ristorativi<br />
MODULI PREPARATI PER L’ESAME E TEMPI DI SVOLGIMENTO<br />
MODULO N. 1 di 2<br />
TITOLO: RINFORZO LINGUISTICO<br />
REQUISITI<br />
NECESSARI PER<br />
AFFRONTARE IL<br />
MODULO<br />
COMPETENZA IN<br />
USCITA<br />
ABILITÀ<br />
RILEVATORI<br />
DELLA<br />
COMPETENZA<br />
TEMPI<br />
COLLEGAMENTI<br />
INTERDISCIPLINA<br />
RI<br />
Conoscenza generale delle strutture linguistiche studiate durante gli anni<br />
precedenti.<br />
Conoscenza generale delle principali funzioni comunicative studiate<br />
durante gli anni precedenti.<br />
Conoscenza delle competenze di base uniformemente al protocollo<br />
stabilito a livello disciplinare –linguistico.<br />
Sapere:<br />
Svolgere esercizi strutturati in lingua.<br />
Comunicare in lingua sulla routine quotidiana al presente ed esprimere<br />
azioni trascorse utilizzando il passato, parlare di piani e progetti futuri,<br />
dare indicazioni, esprimere opinioni.<br />
Saper utilizzare correttamente competenze linguistiche di base sia nella<br />
produzione orale (libera e guidata), sia nella produzione scritta<br />
(strutturata e semi-strutturata).<br />
Ottobre – Dicembre ( 32 ore )<br />
Italiano e lingue straniere.<br />
TITOLO: PRODOTTI TIPICI SPAGNOLI<br />
<strong>Pag</strong> . 72
REQUISITI<br />
NECESSARI PER<br />
AFFRONTARE IL<br />
MODULO<br />
COMPETENZA IN<br />
USCITA<br />
ABILITÀ<br />
RILEVATORI<br />
DELLA<br />
COMPETENZA<br />
Tempi: Febbraio-Aprile (30 ore)<br />
Il Docente<br />
Conoscenza delle strutture linguistiche di base studiate negli anni<br />
precedenti.<br />
Conoscenza del vocabolario specifico su pasti e bevande studiato durante<br />
gli anni precedenti.<br />
Conoscenza delle funzioni comunicative di base studiate negli anni<br />
precedenti.<br />
L’alunno deve saper presentare le specialità spagnole.<br />
Sapere:<br />
Riferire le conoscenze specifiche sui vari aspetti della Spagna.<br />
Presentare le specialità spagnole.<br />
Operare confronti.<br />
Esprimere opinioni personali.<br />
La differenza tra i diversi ristoranti tipici spagnoli (restaurantes<br />
tradicionales, de entretenimiento, etnico, mesones y tabernas, de comida<br />
rápida).<br />
Risposte a questionari a scelta multipla o a risposta libera di<br />
comprensione del testo.<br />
Presentare con pronuncia corretta le conoscenze acquisite. Relazionare,<br />
con linguaggio semplice e corretto le conoscenze acquisite.<br />
Cerroni Luigi Gli Studenti<br />
<strong>Pag</strong> . 73
DISCIPLINA Legislazione della ristorazione<br />
DOCENTE Prof. Lina Casini<br />
SCHEDA DISCIPLINARE<br />
LIBRI DI TESTO Crocetti-Papa Diritto per le aziende della ristorazione Ed.Tramontana<br />
MODULI PREPARATI PER L’ESAME E TEMPI DI SVOLGIMENTO<br />
L’imprenditore commerciale e le società ( settembre-ottobre )<br />
Le obbligazioni ( ottobre – novembre )<br />
Il contratto ( novembre-dicembre )<br />
I contratti dell’impresa ristorativi ( compravendita, locazione, leasing, deposito in albergo e<br />
ristorante)( gennaio-marzo )<br />
Il diritto del lavoro ( aprile-maggio)<br />
Il contratto di lavoro (maggio)<br />
METODOLOGIE<br />
Lezione frontale<br />
Lezione partecipata<br />
Problem solving<br />
Risoluzione di casi pratici<br />
Lavoro di gruppo<br />
RISULTATI OTTENUTI<br />
Nel complesso sufficienti per tutta la classe con alcuni elementi particolarmente preparati ed<br />
interessati alla materia e punte di eccellenza.<br />
Si allegano due testi di verifiche svolte dalla classe durante l’a.s.<br />
1)Non rientra tra gli elementi del rapporto obbligatorio<br />
a) Il fine che le parti intendono perseguire<br />
b) Il soggetto passivo o debitore<br />
c) La prestazione<br />
d) Il soggetto attivo o creditore<br />
2) Le obbligazioni solidali attive:<br />
a) sono obbligazioni con un solo creditore ed un solo debitore<br />
b) sono obbligazioni che prevedono l’obbligo che ciascun debitore esegua l’intera prestazione<br />
c) sono obbligazioni che prevedono il diritto di ciascun creditore di pretendere l’intera prestazione<br />
d) sono obbligazioni con più soggetti, ciascuno dei quali ha un’obbligo parziale , in quanto è<br />
obbligato solo per la propria quota<br />
<strong>Pag</strong> . 74
3) Cos’è la prestazione? ----------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
4) Giovanni non ha consegnato a Gino, titolare di un ristorante, le 10 torte, già pagate, che si<br />
era impegnato a fornire<br />
a) Il danno emergente è rappresentato dal prezzo pagato ed il lucro cessante dal mancato guadagno<br />
che Gino avrebbe realizzato con la vendita delle torte.<br />
b) Il danno emergente è rappresentato dal mancato guadagno che Gino avrebbe realizzato con la<br />
vendita delle torte.<br />
c) Il danno emergente è rappresentato dalla perdita d’immagine e di clientela subita da Gino.<br />
d) Il lucro cessante è rappresentato dalla perdita causata dalla mancata consegna della merce.<br />
.<br />
5) Obbligazione di mezzi ed obbligazioni di risultato ----------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
6) Cos’è l’adempimento? Può essere parziale?-------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
7) Carlo, proprietario di un ristorante, ha allestito un pranzo per il compleanno di Giovanna,<br />
Silvia e Carlotta. Il conto ammonta ad € 600,00.<br />
a) Carlo deve rivolgersi a ciascuna delle ragazze perché paghi la somma di € 200,00 ciascuna<br />
b) Ciascuna delle ragazze deve versare la propria quota per liberarsi dall’obbligazione.<br />
c) Carlo può rivolgersi a ciascuna delle ragazze per il pagamento dell’intero conto: la<br />
solidarietà attiva è presunta dalla legge<br />
d) Carlo può rivolgersi a ciascuna delle ragazze per il pagamento dell’intero conto: la<br />
solidarietà passiva è presunta dalla legge.<br />
<strong>Pag</strong> . 75
8) Le fonti non contrattuali delle obbligazioni--------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
9) E’ una conseguenza dell’inadempimento<br />
1) L’estinzione dell’obbligazione.<br />
2) La responsabilità contrattuale ed il risarcimento del danno.<br />
3) La responsabilità extracontrattuale<br />
4) La responsabilità civile.<br />
10) Gianni viene investito mentre si reca in una casa privata dove è stato ingaggiato da Silvia<br />
per allestire un pranzo di compleanno. In conseguenza di ciò<br />
a) Egli è soggetto alla responsabilità contrattuale e dovrà pagare il risarcimento dei danni a Luca, in<br />
particolare il danno emergente<br />
b) Egli è soggetto alla responsabilità contrattuale e dovrà pagare il risarcimento dei danni a Luca, in<br />
particolare il lucro cessante<br />
c) Egli non è soggetto alla responsabilità patrimoniale perché può fornire prova dell’impossibilità, a<br />
lui non imputabile, della prestazione.<br />
c) Egli è soggetto alla responsabilità extracontrattuale da fatto illecito.<br />
1)Il contratto di deposito irregolare è:<br />
a) Un contratto ad effetti reali<br />
b) Un contratto reale<br />
c) Ha per oggetto cose infungibili<br />
d) Un contratto formale<br />
2) Non rientra tra i principali obblighi delle parti nella compravendita<br />
a) La consegna della cosa<br />
b) La riserva di gradimento<br />
c) Il pagamento del prezzo<br />
d) La garanzia per i vìzi e l’evizione<br />
3) Tratta del contratto di deposito al ristorante -----------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
________________________________________________________________________________<br />
<strong>Pag</strong> . 76
4) Nel contratto di leasing operativo<br />
a) L’utilizzatore non può recedere prima della scadenza<br />
b) Di solito è prevista la possibilità di riscattare il bene alla scadenza.<br />
c) L’ impresa produttrice fornisce servizi accessori di assistenza e manutenzione dei beni<br />
d) La società di leasing non fornisce servizi accessori<br />
5) La responsabilità dell’ albergatore sussiste<br />
a) per le cose di cui il cliente deve liberarsi per fruire al meglio del servizio alberghiero<br />
b) per tutte le cose che il cliente porta con sé nell’albergo<br />
c) per le sole cose che il cliente espressamente gli affida<br />
d)per le sole cose per cui viene pagato un corrispettivo per la custodia<br />
6) Cos’è il deposito regolare? Quali obblighi assume il depositante ? In cosa differisce detto<br />
contratto dal deposito irregolare?-----------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
<strong>Pag</strong> . 77
Prof.ssa Lina Casini<br />
ISIS GROSSETO<br />
Anno scolastico 2011/2012<br />
LEGISLAZIONE DELLA RISTORAZIONE<br />
Classe V B/C servizi di ristorazione<br />
L’IMPRENDITORE COMMERCIALE E LE SOCIETA’<br />
Riepilogo generale<br />
I DIRITTI DI OBBLIGAZIONE<br />
Il rapporto obbligatorio<br />
Le obbligazioni multiple e solidali<br />
La classificazione delle obbligazioni<br />
Le obbligazioni pecuniarie<br />
La prestazione<br />
Le fonti delle obbligazioni<br />
Il contratto ed il fatto illecito come fonte delle obbligazioni<br />
L’art. 2043 c.c.<br />
Vari tipi di illecito: contrattuale, extracontrattuale<br />
L’estinzione delle obbligazioni<br />
L’inadempimento e la responsabilità<br />
La mora ed il risarcimento del danno.<br />
IL CONTRATTO<br />
Il contratto in generale<br />
Gli elementi essenziali<br />
Gli elementi accidentali<br />
Gli effetti del contratto<br />
Il recesso<br />
L’invalidità, rescissione e risoluzione<br />
La classificazione dei contratti<br />
I CONTRATTI DELL’IMPRESA RISTORATIVA<br />
I contratti commerciali<br />
La vendita ed i vari tipi di vendita<br />
Obbligazioni delle parti e garanzia per la vendita dei beni di consumo<br />
Particolari tipi di vendita nel settore ristorativo<br />
La locazione<br />
La locazione di immobili urbani a scopo abitativo e non abitativo<br />
L’affitto<br />
Il deposito<br />
Il deposito in albergo ed al ristorante<br />
Il leasing<br />
Il contratto di banqueting<br />
Il contratto di catering<br />
Il contratto d’albergo<br />
<strong>Pag</strong> . 78
IL CONTRATTO DI LAVORO<br />
Il lavoro subordinato<br />
Il lavoro autonomo<br />
Il lavoro parasubordinato<br />
Fonti del diritto del lavoro<br />
Fonti interne<br />
La Costituzione, le leggi ( lo Statuto dei Lavoratori-Legge Biagi etc.)<br />
Fonti esterne comunitarie ed internazionali<br />
Fonti contrattuali<br />
Il contratto collettivo<br />
IL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO<br />
Il contratto individuale di lavoro<br />
Il periodo di prova<br />
La costituzione del rapporto di lavoro<br />
Il collocamento<br />
La disoccupazione<br />
I soggetti del rapporto di lavoro<br />
L’oggetto del rapporto di lavoro<br />
Gli obblighi ed i diritti del lavoratore<br />
Gli obblighi ed i poteri del datore di lavoro<br />
La cessazione del rapporto di lavoro<br />
Il licenziamento<br />
Il trattamento di fine rapporto<br />
Grosseto, 15 maggio 2012<br />
<strong>Pag</strong> . 79<br />
L’insegnante<br />
Prof Lina Casini
DISCIPLINA: MATEMATICA<br />
DOCENTE: Manuela Carli<br />
SCHEDA DISCIPLINARE<br />
LIBRO DI TESTO: BERGAMINI M. TRIFONE A.“LINEAMENTI DI ANALISI 2ED.MODULI<br />
S,<br />
U, V” ED. ZANICHELLI<br />
MODULI PREPARATI PER L’ESAME E TEMPI DI SVOLGIMENTO<br />
Mod 1: LE FUNZIONI (da settembre a novembre)<br />
Mod 2: I LIMITI (da dicembre-marzo)<br />
Mod 3: LE DERIVATE (da aprile a maggio)<br />
Mod 4: LO STUDIO DI FUNZIONE (in progress durante tutto l’anno via via che si<br />
aggiungevano nuovi contenuti)<br />
METODOLOGIE<br />
Gli studenti di questa classe hanno, di anno in anno e salvo alcune eccezioni riferite al primo<br />
biennio, cambiato l’insegnante di matematica.<br />
La verifica sui livelli di partenza ha evidenziato una classe con carenze di tipo logico-linguistico e<br />
con una scarsa abitudine a studiare.<br />
Ad eccezione di pochi casi è stata verificata una limitata padronanza degli strumenti specifici che<br />
costituiscono prerequisito e, per taluni studenti, una scarsa motivazione per “lo studio della<br />
matematica” dovuto ad insuccessi pregressi, unito comunque ad una volontà a migliorarsi.<br />
L’acquisizione delle conoscenze è stata impostata sulla base di concettualizzazioni essenziali e sul<br />
recupero mirato. Le lezioni frontali hanno avuto lo scopo di sistematizzare i nuovi concetti. Alcune<br />
lezioni sono state condotte allo scopo di far scoprire nessi, relazioni, proprietà.<br />
Durante l’anno è stato dato ampio spazio alla correzione degli esercizi; l’insegnamento è stato<br />
condotto per gradi; lo studio di funzione ha fatto da filo conduttore e gli studenti si sono abituati a<br />
far “crescere il grafico della funzione” via via che si aggiungevano nuove conoscenze. Di rimando è<br />
stato spesso richiesto loro di saper individuare le caratteristiche di una funzione di cui è noto il<br />
grafico.<br />
MEZZI/STRUMENTI<br />
Oltre al libro di testo è stato utilizzato il “distillato verticale” e si è fatto ricorso a schemi e mappe<br />
concettuali<br />
RISULTATI OTTENUTI<br />
La classe può essere divisa in due fasce di livello.<br />
Nella prima sono compresi gli alunni che riescono autonomamente ad individuare le strategie<br />
risolutive, utilizzano consapevolmente gli strumenti di calcolo e riescono ad esprimersi con<br />
sufficiente proprietà di linguaggio.<br />
Nella seconda sono compresi gli alunni che colgono solo le caratteristiche essenziali dei quesiti<br />
proposti, non sempre riescono a rispondere esaurientemente al comando e usano un lessico ridotto.<br />
Si allegano due testi di verifica svolti dalla classe durante l’a.s, della tipologia riproposta poi<br />
in III prova.<br />
<strong>Pag</strong> . 80
MATEMATICA<br />
1. La funzione y=│x 2 -4│nel punto P di ascissa x=2 presenta:<br />
a) un massimo<br />
b) un minimo<br />
c) un flesso<br />
d) una cuspide<br />
2. Una funzione reale di variabile reale y=f(x) è una relazione che associa<br />
a) ad ogni x reale almeno un y reale<br />
b) ad ogni x reale uno ed un solo y reale<br />
c) ad un x reale esattamente un y reale<br />
d) ad un x reale almeno un y reale<br />
3. Nel calcolo dei limiti la forma +∞-∞ è<br />
a) +∞<br />
b) -∞<br />
c) 0<br />
d) Indeterminata<br />
4. La derivata di y= x 2 - 3x+5 in x0 =3 è<br />
a) 3<br />
b) –3<br />
c) 0<br />
d) 2<br />
5. Calcola la derivata prima e seconda di y= ln(7x 2 +3x+2)<br />
6. Data la funzione y= (x 2 +4x+3) / (x-5)(x+1) indica:<br />
a) C.d.E<br />
b) Intersezione con gli assi<br />
c) Segno<br />
d) Limiti asintoti e discontinuità<br />
MATEMATICA<br />
7. Il teorema di Rolle afferma: “se una funzione è continua in un intervallo chiuso e limitato<br />
[a,b] e derivabile in (a,b) con f(a)= f(b) allora<br />
a) esiste almeno un punto x0 interno all’intervallo in cui si annulla la sua derivata prima<br />
b) esiste un solo punto x0 interno all’intervallo in cui si annulla la sua derivata prima<br />
c) esiste almeno un punto x0 interno all’intervallo la sua derivata è positiva<br />
d) esiste un punto x0 interno all’intervallo in cui la funzione assume lo stesso segno<br />
della derivata prima.<br />
8. Quale delle seguenti proposizioni è vera<br />
a) Una funzione continua in x0 è in quel punto derivabile<br />
b) Una funzione continua in un intervallo è derivabile in quell’intervallo<br />
c) Una funzione derivabile in x0 è in quel punto continua<br />
d) Una funzione derivabile in x0 può non essere in quel punto continua<br />
<strong>Pag</strong> . 81
9. Una funzione è crescente in un suo intervallo se la sua derivata prima in quell’intervallo è:<br />
e) nulla<br />
f) positiva<br />
g) negativa<br />
h) costante<br />
10. Quale è la funzione derivata di<br />
2<br />
a) f '(<br />
x)<br />
3(<br />
1<br />
2x)<br />
( 1<br />
x)<br />
2<br />
b) f'( x) 3x 6x 3<br />
c)<br />
d)<br />
f '( x)<br />
6(<br />
1<br />
2x)<br />
f'(x) 3x<br />
2<br />
11. Dall'analisi del seguente grafico:<br />
2<br />
f ( x)<br />
( 1<br />
2x)<br />
ricava le informazioni richieste:<br />
a) il dominio della funzione che esso rappresenta<br />
b) le equazioni degli asintoti<br />
c) il comportamento della funzione nell'intorno del punto x= -4 e nell'intorno del punto x =12<br />
12. A partire dal grafico dell’esercizio 5 traccia il grafico di y=│f(x)│ e quello di y=f(x)-4<br />
<strong>Pag</strong> . 82<br />
3
Programma di MATEMATICA<br />
CLASSE 5 sez.B<br />
a.s. 2011/2012<br />
MOD 1: LE FUNZIONI<br />
Definizione di funzione.<br />
Funzioni iniettive, suriettive, biettive.<br />
Funzioni reali di variabile reale.<br />
Classificazione delle funzioni.<br />
Grafici notevoli di funzioni elementari (retta, parabola).<br />
Campo di esistenza di funzioni algebriche razionali (intere e fratte), di funzioni algebriche<br />
irrazionali (intere e fratte). Campo di esistenza di semplici funzioni esponenziali e logaritmiche.<br />
Intersezioni con gli assi cartesiani e studio del segno di funzioni razionali (intere facilmente<br />
scomponibili in fattori di I e II grado e fratte con numeratore e denominatore facilmente<br />
scomponibile in fattori primi), di semplici funzioni irrazionali contenenti un solo radicale.<br />
Funzioni pari, funzioni dispari<br />
Definizione di funzioni crescenti, decrescenti, non crescenti, non decrescenti<br />
MOD 2: I LIMITI<br />
Concetto intuitivo di limite<br />
Definizione di limite finito e infinito per la variabile x che tende ad un valore finito o ad infinito e<br />
rispettivo significato geometrico (asintoti verticali e orizzontali di una funzione).<br />
Limite destro e limite sinistro.<br />
Funzione continua in un punto e in un intervallo.<br />
Discontinuità di I, II, III specie<br />
Semplici calcoli di limiti.<br />
Forme indeterminate (0/0, ∞/∞, o*∞, +∞-∞)<br />
Teorema di unicità del limite.(solo enunciato)<br />
MOD 3: LE DERIVATE<br />
Rapporto incrementale e suo significato geometrico<br />
Derivata di una funzione in un punto e suo significato geometrico<br />
Derivate di alcune funzioni elementari.<br />
Regole di derivazione.<br />
Funzioni crescenti e decrescenti.<br />
Punti di massimo e minimo relativi e assoluti, flessi a tangente orizzontale (studiati con il segno<br />
della derivata prima)<br />
Teorema di Rolle, Cauchy e Lagrange (solo enunciato)<br />
Teorema: derivabilità e continuità (solo enunciato)<br />
Punti di cuspide<br />
<strong>Pag</strong> . 83
MOD 4: LO STUDIO DI FUNZIONE<br />
Studio di una funzione algebrica razionale o irrazionale, intera o fratta (della tipologia indicata<br />
nel Modulo 1)<br />
- Dominio.<br />
- Intersezioni con gli assi cartesiani.<br />
- Intervalli di positività e negatività.<br />
- Limiti, asintoti, discontinuità.<br />
- Intervalli di crescenza e decrescenza.<br />
- Punti di massimo e minimo relativi ed assoluti.<br />
- Punti di flesso a tangente orizzontale.<br />
- Rappresentazione grafica<br />
Dedurre dal grafico di una funzione:<br />
- Dominio.<br />
- Intersezioni con gli assi cartesiani.<br />
- Intervalli di positività e negatività.<br />
- Eventuali simmetrie<br />
- Asintoti (verticali, orizzontali ed eventualmente obliqui)<br />
- Intervalli di crescenza e decrescenza.<br />
- Punti di massimo e minimo relativi ed assoluti.<br />
- Punti di flesso a tangente orizzontale.<br />
Trasformazione di grafici di funzioni<br />
- A partire da un grafico di funzione y = f (x) dedurre caratteristiche e grafici di funzioni<br />
trasformate del tipo y = f (x) + h , y = k f (x) , y =| f (x)|<br />
Grosseto 7 maggio 2012<br />
Gli Studenti Il Docente<br />
<strong>Pag</strong> . 84
Docente: Federico Cipolla<br />
Disciplina: Alimenti ed alimentazione<br />
SCHEDA DISCIPLINARE<br />
Libro di testo: A. Machado - “SICUREZZA ALIMENTARE E DIETETICA” - Casa Editrice<br />
Poseidonia Scuola<br />
Moduli svolti / Tempi di svolgimento<br />
Modulo 1: I RISCHI E LA SICUREZZA ALIMENTARE<br />
Fattori tossici e contaminazioni: tipi di contaminazioni; fattori antinutrizionali; significato di<br />
qualità di un alimento; qualità organolettiche; le ammine Biogene; le micotossine; i<br />
fitofarmaci e gli zoo farmaci; contenitori ed imballaggi; I metalli pesanti; i radionuclidi. La<br />
contaminazione biologica degli alimenti: le malattie trasmesse con gli alimenti; agenti<br />
biologici e contaminazioni; i prioni (BSE); fattori di sviluppo dei microrganismi. Dose<br />
infettante minima; periodo di incubazione; portatore sano; i virus e le malattie di origine<br />
virale; i batteri e le principali tossinfezioni alimentari; i funghi microscopici (lieviti e<br />
muffe); le parassitosi.<br />
Alimento OGM: gli Alimenti geneticamente modificati;<br />
Tempi: settembre/ottobre/novembre/dicembre<br />
Modulo 2: LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO PER LA SICUREZZA ALIMENTARE<br />
Igiene sicurezza nell’ambiente ristorativo; posizione dell’azienda e requisiti dei locali e delle<br />
attrezzature; organizzazione del lavoro;<br />
La conservazione degli alimenti; alterazione degli alimenti; tecnologie di conservazione;<br />
metodi di conservazione; tecnologie emergenti.<br />
Controllo qualità e sicurezza alimentare (HACCP); sistemi di gestione della sicurezza<br />
alimentare; l’autocontrollo ed il sistema HACCP; i controlli in Italia e le frodi alimentari; la<br />
qualità degli alimenti.<br />
Tempi: gennaio/febbraio/marzo<br />
Modulo 3: LE DIETE<br />
Dietologia: diete per fasce d’età: la dieta nelle diverse età e condizioni fisiologiche; la dieta<br />
dell’età evolutiva; la dieta del neonato (l’alimentazione complementare); la dieta del<br />
bambino e dell’adolescente; la dieta dell’adulto; la dieta nella terza età;<br />
Le diete: significato di piramidi alimentari: la dieta mediterranea; la dieta in gravidanza;<br />
altre diete.<br />
Tempi: aprile/maggio<br />
<strong>Pag</strong> . 85
Modulo 4: DIETOTERAPIA<br />
Malattie dell’apparato digerente (dello stomaco, del fegato,dell’intestino),del sistema<br />
cardiocircolatorio (Ipertensione, ipercolesterolemia, aterosclerosi). Malattie dismetaboliche<br />
(Diabete). Obesità e magrezza. Disturbi psico-nutrizionali (Anoressia, Bulimia, Ortoressia,<br />
Vigoressia).<br />
Tempi : maggio<br />
Metodologie: lezione frontale, lavoro in gruppi, elaborazione di mappe concettuali, elaborazione di<br />
schemi e tabelle, risoluzione di casi pratici.<br />
Mezzi/Strumenti: libro di testo, audiovisivi, grafici e tabelle, materiale informativo tratto da<br />
quotidiani o riviste, utilizzo di altri testi specifici, materiale multimediale e ricerca con Internet.<br />
Risultati ottenuti: Gli obiettivi prefissati per i singoli moduli (in termini di conoscenze,<br />
competenze e capacità) sono stati solo in parte raggiunti dalla quasi totalità della classe.<br />
<strong>Pag</strong> . 86
ALCUNE VERIFICHE DI ALIMENTI E ALIMENTAZIONE<br />
Anno Scolastico 2011-2012<br />
Docente: Federico Cipolla<br />
Classe: 5^ B Servizi della Ristorazione<br />
1^ TRACCIA: La qualità di un alimento deriva da vari fattori. Descrivi brevemente quali sono le<br />
principali fonti di contaminazione alimentare.<br />
2^ TRACCIA: La conservazione degli alimenti rappresenta da sempre uno dei problemi che più<br />
hanno interessato l’umanità. Dopo un escursus storico descrivi le tecniche attuali di conservazione e<br />
la shelf-life.<br />
Grosseto, 15 maggio 2012 L’insegnante<br />
Federico Cipolla<br />
<strong>Pag</strong> . 87
PROGRAMMA DI ALIMENTI E ALIMENTAZIONE<br />
Anno Scolastico 2011-2012<br />
Docente: Federico Cipolla<br />
Classe: 5^ B Servizi della Ristorazione<br />
Modulo 1: I RISCHI E LA SICUREZZA ALIMENTARE<br />
Fattori tossici e contaminazioni: tipi di contaminazioni; fattori antinutrizionali; significato<br />
di qualità di un alimento; qualità organolettiche; le ammine Biogene; le micotossine; i<br />
fitofarmaci e gli zoo farmaci; contenitori ed imballaggi; I metalli pesanti; i radionuclidi. La<br />
contaminazione biologica degli alimenti: le malattie trasmesse con gli alimenti; agenti<br />
biologici e contaminazioni; i prioni (BSE); fattori di sviluppo dei microrganismi. Dose<br />
infettante minima; periodo di incubazione; portatore sano; i virus e le malattie di origine<br />
virale; i batteri e le principali tossinfezioni alimentari; i funghi microscopici (lieviti e muffe);<br />
le parassitosi.<br />
Alimento OGM: gli Alimenti geneticamente modificati;<br />
Modulo 2: LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO PER LA SICUREZZA ALIMENTARE<br />
Igiene sicurezza nell’ambiente ristorativo; posizione dell’azienda e requisiti dei locali e<br />
delle attrezzature; organizzazione del lavoro;<br />
La conservazione degli alimenti; alterazione degli alimenti; tecnologie di conservazione;<br />
metodi di conservazione; tecnologie emergenti.<br />
Controllo qualità e sicurezza alimentare (HACCP); sistemi di gestione della sicurezza<br />
alimentare; l’autocontrollo ed il sistema HACCP; i controlli in Italia e le frodi alimentari; la<br />
qualità degli alimenti.<br />
Modulo 3: LE DIETE<br />
Dietologia: diete per fasce d’età: la dieta nelle diverse età e condizioni fisiologiche; la dieta<br />
dell’età evolutiva; la dieta del neonato (l’alimentazione complementare); la dieta del<br />
bambino e dell’adolescente; la dieta dell’adulto; la dieta nella terza età;<br />
Le diete: significato di piramidi alimentari: la dieta mediterranea; la dieta in gravidanza;<br />
altre diete.<br />
Modulo 4: DIETOTERAPIA<br />
Malattie dell’apparato digerente (dello stomaco, del fegato,dell’intestino),del sistema<br />
cardiocircolatorio (Ipertensione, ipercolesterolemia, aterosclerosi). Malattie dismetaboliche<br />
(Diabete). Obesità e magrezza. Disturbi psico-nutrizionali (Anoressia, Bulimia, Ortoressia,<br />
Vigoressia).<br />
Grosseto, 15 maggio 2012 L’insegnante<br />
Federico Cipolla<br />
<strong>Pag</strong> . 88
SCHEDA DISCIPLINARE<br />
Disciplina: Laboratorio di Organizzazione e Gestione dei Servizi Ristorativi<br />
Docente: Antonio Villani<br />
Moduli preparati per l’esame e tempi di svolgimento<br />
Modulo 1 RIEPILOGHI E APPROFONDIMENTI SUI MODULI TRATTATI NELCORSO DEL<br />
QUARTO ANNO SCOLASTICO CON APPROFONDIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE<br />
DELLA CUCINA<br />
7. Il mondo della ristorazione<br />
8. La costruzione del menu<br />
9. I prodotti alimentari e l’approvvigionamento<br />
Tempi: Settembre- Novembre<br />
Modulo 2 ORGANIZZAZIONE DELLA CUCINA<br />
g) la progettazione dell’impianto<br />
h) l’organizzazione dell’impianto<br />
Tempi: Dicembre -Gennaio<br />
Modulo 3 LA VENDITA DEI PRODOTTI / SERVIZI<br />
3. la sala ristorante e il servizio<br />
4. le bevande nella ristorazione<br />
Tempi: Febbraio-Aprile<br />
Modulo 4 BUFFET, CATERING E BANQUETING<br />
e) buffet e cocktail party<br />
f) il servizio di catering<br />
g) il servizio di banqueting<br />
Tempi: Marzo-Aprile<br />
Modulo 5 ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEL LAVORO<br />
4. l’organizzazione del servizio “per regole”<br />
5. la programmazione del lavoro<br />
6. programmazione e coordinamento delle risorse umane<br />
Tempi:Dicembre-Aprile<br />
Modulo 6 IGIENE PROFESSIONALE E SISTEMA DI QUALITA’ NELLA RISTORAZIONE<br />
e) igiene degli alimenti,<br />
f) igiene della persona e degli alimenti,<br />
g) il sistema HACCP,<br />
h) manuale di autocontrollo igienico: indicazioni per la redazione<br />
Tempi: -Maggio -Giugno<br />
Metodologia: Il processo di perseguimento degli obiettivi e la realizzazione dei moduli è stato<br />
caratterizzato dall’articolazione delle seguenti attività:<br />
Lezioni frontali per la presentazione degli argomenti ; lavoro di gruppo ; esperienze pratiche nel<br />
laboratorio della scuola; esperienze di stage e di lavoro nelle aziende, realizzate nel settore cucina e<br />
nel settore distribuzione-sala, in diverse situazioni aziendali; partecipazioni a manifestazioni<br />
gastronomiche; esercitazioni su esercizi proposti dall’insegnante.<br />
<strong>Pag</strong> . 89
Strumenti: Gli argomenti sono stati trattati con l’ausilio del libro di testo “La Scuola di<br />
Ristorazione” ed. Calderini, gli appunti dell’insegnante, per quel che riguarda le esercitazioni<br />
pratiche, in laboratorio di cucina, sala e computer con le attrezzature ivi presenti.<br />
Verifiche e valutazioni : Il processo di apprendimento – insegnamento e stato sottoposto a<br />
continue verifiche, attraverso: Gli schemi di progettazione, le schede guida per l’osservazione delle<br />
realizzazione pratiche, gli schemi di valutazione; le prove oggettive e prove strutturate e<br />
semistrutturate; le prove formative e sommative; i rapporti di ricerca su visite, esperienze di lavoro<br />
e interventi d’esperti.<br />
Risultati ottenuti: Non tutti gli obiettivi preventivati all’inizio dell’anno scolastico sono stati<br />
raggiunti, poiché l’interesse e la partecipazione è stata saltuaria sia a casa che in classe . Lo<br />
svolgimento degli argomenti è stato adattato alle conoscenze e abilità dei discenti, rafforzando le<br />
competenze professionali raggiunte negli anni precedenti e sviluppando le capacità di intervento<br />
sui problemi organizzativi, gestionali e programmatori delle aziende ristorative<br />
Gli alunni hanno sviluppato le seguenti abilità e competenze:<br />
5. conoscono e sanno organizzare impianti di cucina in funzione dei servizi per regole e per<br />
eccezioni;<br />
6. conoscono e sanno valutare i problemi della programmazione e del coordinamento del<br />
personale addetto ad un reparto, controllare l’efficienza e l’efficacia del lavoro e favorire<br />
la comunicazione e l’interscambio funzionale tra i vari membri;<br />
7. conoscono la sala ristorante e il suo arredamento, sono in grado di organizzare un<br />
servizio, accogliere la clientela e comporre una carta di vini e d’acqua in base al menù;<br />
8. conoscono le caratteristiche che assume la domanda dell’utenza, delle nuove possibilità<br />
che offrono la dietetica e l’industria agro-alimentare;<br />
9. conoscono le tipologie di buffet, il servizio di catering e di banqueting;<br />
10. sanno realizzare, attraverso le proprie prestazioni, una sintesi concreta e di elevata<br />
qualità tra la creatività e la standardizzazione;<br />
Si allegano una o più verifiche<br />
<strong>Pag</strong> . 90<br />
Il prof. Antonio Villani<br />
________________________
N°1<br />
Test risposta multipla<br />
Rispondi a queste domande segnalando la risposta giusta con una x<br />
10. Il servizio per regole è un metodo gestionale che si addice:<br />
i) solo alle catene di ristorazione<br />
j) alle catene di ristorazione e alla ristorazione industriale<br />
k) a tutti i tipi di ristorazione<br />
l) solo a quella industriale<br />
5. Il metodo guida per un organizzazione razionale consiste nel:<br />
h) controllare i processi di produzione<br />
i) definire gli standard di servizio per ottimizzare i mezzi a disposizione<br />
j) pianificare, svolgere il lavoro, controllare, revisionare le procedure<br />
k) controllare il personale<br />
7. Lo scopo principale dell’organigramma delle presenze è quello di:<br />
8. visualizzare la presenza del personale nell’arco della giornata per migliorare<br />
l’organizzazione<br />
9. controllare immediatamente eventuali ritardi nell’entrata in servizio<br />
10. assegnare gli incarichi ad ogni addetto<br />
11. visualizzare la presenza dei facchini<br />
i) Il diagramma di funzione è utile per:<br />
j) valutare il tempo dedicato alle singole operazioni e la produttività di ogni addetto<br />
k) capire il funzionamento del piano dei lavori e delle presenze<br />
l) controllare la funzionalità dei percorsi e dei possibili incidenti<br />
m) controllare e capire la qualità della materia prima<br />
Rispondi alle seguenti domande:<br />
11. A cosa serve una scheda tecnica di produzione?<br />
12. in che cosa consiste la tecnica della scomposizione in sottogruppi?<br />
<strong>Pag</strong> . 91
N°2<br />
Test risposta multipla<br />
Rispondi a queste domande segnalando la risposta giusta con una x<br />
1. Il termine Gastronorm fa riferimento a:<br />
a. uno standard di misura per recipienti<br />
b. un unità di misura di peso<br />
c. una teglia di materiale particolare<br />
d. un tegame di alluminio<br />
2. I cibi cotti vengono confezionati sottovuoto :<br />
a. quando si sono completamente raffreddati<br />
b. quando sono ancora caldi<br />
c. subito dopo la cottura<br />
d. a mezza cottura<br />
3. la cucina tradizionale evoluta è contraddistinta da:<br />
a. suddivisione degli spazi in settori<br />
b. necessaria presenza di una cucina satellite<br />
c. in presenza di cucina spaziale<br />
d. non suddivisa in settori<br />
4. Nel legame refrigerato i cibi vengono conservati a:<br />
a. + 3° c per 5/6 giorni<br />
b. 0° c per 21 giorni<br />
c. -20° c per alcuni mesi<br />
d. -18° c per 2 settimane<br />
Che cosa si intende per cucina diretta e indiretta?<br />
_______________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________<br />
Con quali tecniche può avvenire la cottura sottovuoto?<br />
________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________<br />
<strong>Pag</strong> . 92
PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2011-12 NELLA CLASSE V B SR<br />
Disciplina: Laboratorio di Organizzazione e Gestione dei Servizi Ristorativi<br />
Docente:Antonio- Villani<br />
Moduli preparati per l’esame e tempi di svolgimento<br />
Modulo 1 RIEPILOGHI E APPROFONDIMENTI SUI MODULI TRATTATI NELCORSO<br />
DEL QUARTO ANNO SCOLASTICO CON APPROFONDIMENTO<br />
DELL’ORGANIZZAZIONE DELLA CUCINA<br />
11. Il mondo della ristorazione<br />
12. La costruzione del menu<br />
13. I prodotti alimentari e l’approvvigionamento<br />
Tempi: Settembre- Novembre<br />
Modulo 2 ORGANIZZAZIONE DELLA CUCINA<br />
m) la progettazione dell’impianto<br />
n) l’organizzazione dell’impianto<br />
Tempi: Dicembre -Gennaio<br />
Modulo 3 LA VENDITA DEI PRODOTTI / SERVIZI<br />
6. la sala ristorante e il servizio<br />
7. le bevande nella ristorazione<br />
Tempi:febbraio-Aprile<br />
Modulo 4 BUFFET, CATERING E BANQUETING<br />
l) buffet e cocktail party<br />
m) il servizio di catering<br />
n) il servizio di banqueting<br />
Tempi: Marzo-Aprile<br />
Modulo 5 ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEL LAVORO<br />
12. l’organizzazione del servizio “per regole”<br />
13. la programmazione del lavoro<br />
14. programmazione e coordinamento delle risorse umane<br />
Tempi: dicembre- Febbraio<br />
Modulo 6 IGIENE PROFESSIONALE E SISTEMA DI QUALITA’ NELLA<br />
RISTORAZIONE<br />
n) igiene degli alimenti,<br />
o) igiene della persona e degli alimenti,<br />
p) il sistema HACCP,<br />
q) manuale di autocontrollo igienico: indicazioni per la redazione<br />
Tempi: -Maggio-Giugno<br />
Gli Studenti L’Insegnante<br />
<strong>Pag</strong> . 93<br />
Antonio-Villani
SCHEDA DISCIPLINARE<br />
DISCIPLINA:E.G.A.R. (ECONOMIA E GESTIONE DELLE AZIENDE RISTORATIVE)<br />
DOCENTE: ROSSI PATRIZIA<br />
LIBRI DI TESTO: “ECONOMIA E GESTIONE DELL’IMPRESA RISTORATIVA” di<br />
DE LUCA E FANTOZZI casa editrice LIVIANA<br />
MODULI PREPARATI PER L’ESAME E TEMPI DI SVOLGIMENTO<br />
1° MODULO: IL PATRIMONIO (Cos’è il patrimonio; il prospetto del patrimonio: la Situazione<br />
patrimoniale; la classificazione degli elementi del patrimonio: attività, passività, patrimonio netto;<br />
come si assegna il valore agli elementi del patrimonio: i valori finanziari e i valori economici; i<br />
criteri di valutazione: l’ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali, la<br />
valutazione delle rimanenze di magazzino).<br />
TEMPI: SET/OTT<br />
2° MODULO: LA GESTIONE ECONOMICA (Reddito globale e reddito d’esercizio; i cicli<br />
aziendali; i costi e i ricavi e la loro competenza economica; i ratei e i risconti e il prospetto della<br />
situazione economica; la classificazione dei costi: costi fissi e variabili, costi diretti e indiretti, costi<br />
figurativi e costi standard; la graduale formazione del costo di produzione; il break even point; i<br />
metodi di calcolo per la determinazione dei prezzi di vendita: metodo del costo totale, metodo del<br />
food cost, metodo del bep). TEMPI: OTT/NOV/DIC<br />
3° MODULO: LE RISORSE FINANZIARIE (La stima del fabbisogno finanziario: al momento<br />
della costituzione e durante la gestione; le fonti di finanziamento e loro caratteristiche; le fonti<br />
interne: capitale proprio e autofinanziamento; le fonti esterne: il credito mercantile, i prestiti<br />
bancari; il prestito obbligazionario; i finanziamenti pubblici; il leasing; il factoring).<br />
TEMPI: GEN/FEB<br />
4° MODULO: LA GESTIONE AMMINISTRATIVA (La contabilità aziendale: le scritture<br />
contabili obbligatorie secondo la normativa civilistica, secondo la normativa fiscale e secondo la<br />
normativa di tutela del lavoro; la contabilità elementare delle imprese ristorative; la contabilità<br />
generale: il conto e il quadro dei conti; il metodo della partita doppia; analisi e rilevazione dei<br />
principali fatti di gestione; le principali scritture di assestamento; la chiusura generale dei conti; il<br />
bilancio d’esercizio, i principi di redazione del bilancio, le parti del bilancio: Lo Stato patrimoniale,<br />
il Conto economico, la Nota integrativa; il bilancio in forma abbreviata; gli allegati del bilancio).<br />
TEMPI: FEB/MAR<br />
5° MODULO: LE RISORSE UMANE (L’assunzione del personale: pianificazione, reperimento e<br />
selezione; la normativa sul lavoro: articoli della Costituzione, Codice civile, Leggi speciali,<br />
Contrattazione collettiva con i suoi vari livelli e contrattazione individuale; il costo del lavoro: la<br />
retribuzione e i suoi elementi aggiuntivi e sottrattivi, i contributi previdenziali e assistenziali e gli<br />
enti che gestiscono le assicurazioni sociali obbligatorie, l’addestramento e la formazione, il TFR, i<br />
libri obbligatori).<br />
TEMPI: APR/MAG<br />
6° MODULO: IL MARKETING (Un po’ di storia; il marketing turistico; il marketing strategico e<br />
operativo: la raccolta dei dati, l’analisi della situazione esterna e interna, definizione degli obiettivi<br />
di marketing, le strategie di marketing relative alle 4 P, il marketing mix, il ciclo di vita del<br />
prodotto, il controllo dei risultati e la valutazione; esempio di piano di marketing di un’impresa<br />
ristorativa) TEMPI: MAG/GIU<br />
<strong>Pag</strong> . 94
METODOLOGIE<br />
Si è cercato di mettere in risalto gli aspetti fondamentali di ciascuna delle tematiche affrontate con<br />
l’utilizzo di schemi e appunti, successivamente dagli schemi si è passati agli approfondimenti con<br />
discussioni, lezioni frontali, lezioni partecipate, problem solving.<br />
MEZZI/STRUMENTI<br />
Si è utilizzato il libro di testo e gli appunti scritti o dettati.<br />
RISULTATI OTTENUTI<br />
Nel primo trimestre quando si procedeva soprattutto al recupero degli argomenti affrontati nel<br />
precedente anno scolastico e si curava più la parte pratica che la teoria, la classe rispondeva<br />
sufficientemente, tranne qualche caso. Nel secondo pentamestre, invece, si è curata di più la parte<br />
teorica dei contenuti e la maggior parte della classe ha manifestato scarso impegno e varie<br />
difficoltà. Pertanto alla fine dell’anno si è registrata la seguente situazione: diversi alunni hanno<br />
raggiunto con difficoltà la sufficienza, altri permangono nell’insufficienza, soprattutto per lo scarso<br />
impegno, nonché per le lacune di base, pochi, invece raggiungono risultati più che sufficienti e<br />
dimostrano serietà ed impegno costante.<br />
Si allegano uno o più testi di verifiche svolte dalla classe durante l’a.s.<br />
<strong>Pag</strong> . 95
VERIFICA SUL BEP E SUI COSTI DI PRODUZIONE<br />
CLASSE 5° S.R. FILA “A”<br />
1. Un Hotel con 70 camere doppie e 30 camere singole, aperto 320 giorni l’anno, presenta costi<br />
fissi annui per € 500.000, un costo variabile per persona di € 25 e vende un posto letto al prezzo<br />
di € 75. Determinate il Bep e dopo aver riempito la seguente tabella, rappresentatelo<br />
graficamente.<br />
N°posti<br />
letto<br />
occupati<br />
5.000<br />
10.000<br />
15.000<br />
25.000<br />
35.000<br />
CF CV CT RT U o P %<br />
2. Un albergo presenta i seguenti dati:<br />
DATI ROOM DIVISION FOOD & BEVERAGE<br />
Ricavi annui € 4.500.000 € 3.400.000<br />
Costo del personale € 1.100.000 € 1.000.000<br />
Costo materie prime € 400.000 € 800.000<br />
Costo lavanderia € 500.000 € 200.000<br />
<strong>Pag</strong> . 96<br />
p.ti 14<br />
Sapendo che i costi comuni o indiretti pari a € 1.200.000 vanno ripartiti, con il metodo a base<br />
unica, in proporzione al costo primo e gli oneri figurativi pari a € 790.000 vanno ripartiti in base<br />
al fatturato annuo, determinare il costo economico – tecnico dei due centri di costo.<br />
p.ti 06<br />
VERIFICA SULLA CONTABILITA’<br />
CLASSE 5° “FILA A”<br />
1. Parlate ampiamente delle scritture obbligatorie ai fini civilistici e fiscali.<br />
_____________________________________________________________________________<br />
_____________________________________________________________________________<br />
_____________________________________________________________________________<br />
_____________________________________________________________________________<br />
_____________________________________________________________________________<br />
_____________________________________________________________________________<br />
p.ti 05
2. Indicate quali sono i conti finanziari e come funzionano.<br />
_____________________________________________________________________________<br />
_____________________________________________________________________________<br />
_____________________________________________________________________________<br />
_____________________________________________________________________________<br />
_____________________________________________________________________________<br />
_____________________________________________________________________________<br />
p.ti 05<br />
3. Analizzate e successivamente riportate sul giornale in P.D. i seguenti fatti di gestione: il 26/01<br />
ricevuta fattura n° 90 dal fornitore Belli, per acquisti per il ristorante per € 4.500 + IVA 10%,<br />
regolamento a 30 giorni. Dopo i 30 giorni si paga la fattura con assegni bancari.<br />
p.ti 05<br />
4. Dopo aver parlato delle scritture di assestamento, soffermarsi su quelle di integrazione.<br />
_____________________________________________________________________________<br />
_____________________________________________________________________________<br />
_____________________________________________________________________________<br />
_____________________________________________________________________________<br />
_____________________________________________________________________________<br />
_____________________________________________________________________________<br />
_____________________________________________________________________________<br />
VERIFICA SULLA SITUAZIONE ECONOMICA<br />
E PATRIMONIALE CLASSE 5° FILA “A”<br />
<strong>Pag</strong> . 97<br />
p.ti 05<br />
Il 12 giugno si costituisce un’impresa ristorativa con la forma giuridica di s.n.c. formata da tre soci<br />
che apportano un Capitale sociale di 500.000 euro così composto: Fabbricato € 300.000; Automezzi<br />
€ 50.000; c/c bancario € 100.000; Valori in cassa € 50.000. Successivamente durante il periodo<br />
amministrativo si compiono le seguenti operazioni:<br />
Si acquistano Mobili e Arredi per € 70.000, regolamento ½ con A/B e il resto con cambiali<br />
passive;<br />
Si acquistano Attrezzature per € 20.000, regolamento ½ per contanti e ½ con dilazioni di<br />
pagamento;<br />
Si noleggia il 22 giugno la Biancheria con contratto di leasing annuale per € 7.000 pagati per<br />
contanti;<br />
Si acquistano generi alimentari per € 25.000, regolamento 1/5 per contanti, 2/5 con A/B e il<br />
resto con dilazioni di pagamento;<br />
Si vendono pasti per € 130.000, regolamento 3/5 con la banca, 1/5 con cambiali attive e il resto<br />
con dilazioni di pagamento;<br />
Si pagano bollette per € 4.500 a mezzo banca;<br />
Si pagano costi per il personale per € 35.000 a mezzo banca;
Si riceve l’1/11 un mutuo passivo di € 120.000 che ci viene accreditato sul c/c bancario e sul<br />
quale maturano interessi quadrimestrali posticipati al tasso del 9% e alle date di godimento 1/11<br />
– 1/3 – 1/7.<br />
Al 31/12<br />
Si calcola l’ammortamento delle immobilizzazioni: fabbricato 3%, Mobili e Arredi 20%,<br />
Attrezzature 25%, Automezzi 30%.<br />
Si accantonano a TFR € 8.700<br />
Si valutano le rimanenze finali per 4.000<br />
Si svalutano genericamente i crediti del 5%<br />
Si calcolano i ratei e i risconti<br />
E si predispone la situazione patrimoniale iniziale, finale e la situazione economica al 31/12.<br />
VERIFICA DI E.G.A.R. SULLE RISORSE FINANZIARIE<br />
CLASSE V S.R. FILA “B”<br />
1. Indicare dettagliatamente le fonti di finanziamento per un’azienda.<br />
_____________________________________________________________________________<br />
_____________________________________________________________________________<br />
_____________________________________________________________________________<br />
_____________________________________________________________________________<br />
_____________________________________________________________________________<br />
_____________________________________________________________________________<br />
p.ti 05<br />
2. Dopo aver parlato del fido bancario, spiegare quali possono essere le garanzie da offrire.<br />
_____________________________________________________________________________<br />
_____________________________________________________________________________<br />
_____________________________________________________________________________<br />
_____________________________________________________________________________<br />
____________________________________________________________________________<br />
p.ti 04<br />
3. Dopo aver parlato dei finanziamenti con Capitale di terzi a md e lg termine, soffermarsi sui<br />
prestiti obbligazionari e svolgere il seg. esercizio: una s.p.a. ha emesso un prestito<br />
obbligazionario per € 800.000, con obbligazioni del valore nominale di € 1000 al prezzo di €<br />
950, tasso d’interesse netto 3,50%, godimento (1/4-1/10); determinare il capitale versato dagli<br />
obbligazionisti al momento della sottoscrizione e l’interesse semestrale percepito da un<br />
obbligazionista che ha acquistato 50 obbligazioni.<br />
_____________________________________________________________________________<br />
_____________________________________________________________________________<br />
_____________________________________________________________________________<br />
_____________________________________________________________________________<br />
_____________________________________________________________________________<br />
_____________________________________________________________________________<br />
p.ti 04<br />
<strong>Pag</strong> . 98
4. Dopo aver parlato del factoring, caratteristiche e classificazioni, svolgere il seg esercizio: un<br />
albergatore che vanta crediti per € 15.000, con scadenza a 120 gg, stipula il 19 aprile un<br />
contratto di factoring con accredito immediato dell’80% e per la parte rimanente, con accredito<br />
in c/c alla scadenza, al netto di commissioni pari a € 90 e sconto commerciale del 7% sulla parte<br />
anticipata. Determinare l’importo netto accreditato alla scadenza.<br />
_____________________________________________________________________________<br />
_____________________________________________________________________________<br />
_____________________________________________________________________________<br />
_____________________________________________________________________________<br />
_____________________________________________________________________________<br />
_____________________________________________________________________________<br />
p.ti 05<br />
5. Che cosa sono i finanziamenti pubblici e come possono essere<br />
_____________________________________________________________________________<br />
_____________________________________________________________________________<br />
_____________________________________________________________________________<br />
_____________________________________________________________________________<br />
_____________________________________________________________________________<br />
_____________________________________________________________________________<br />
<strong>Pag</strong> . 99<br />
p.ti 02
PROGRAMMA SVOLTO<br />
DISCIPLINA: E. G. A. R. (ECONOMIA E GESTIONE DELLE AZIENDE RISTORATIVE)<br />
ANNO SCOLASTICO 2011/2012<br />
CLASSE V B SR<br />
DOCENTE: ROSSI PATRIZIA<br />
LIBRI DI TESTO: “ECONOMIA E GESTIONE DELL’IMPRESA RISTORATIVA” di<br />
DE LUCA E FANTOZZI casa editrice LIVIANA<br />
1° MODULO: IL PATRIMONIO (Cos’è il patrimonio; il prospetto del patrimonio: la Situazione<br />
patrimoniale; la classificazione degli elementi del patrimonio: attività, passività, patrimonio netto;<br />
come si assegna il valore agli elementi del patrimonio: i valori finanziari e i valori economici; i<br />
criteri di valutazione: l’ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali, la<br />
valutazione delle rimanenze di magazzino).<br />
2° MODULO: LA GESTIONE ECONOMICA (Reddito globale e reddito d’esercizio; i cicli<br />
aziendali; i costi e i ricavi e la loro competenza economica; i ratei e i risconti e il prospetto della<br />
situazione economica; la classificazione dei costi: costi fissi e variabili, costi diretti e indiretti, costi<br />
figurativi e costi standard; la graduale formazione del costo di produzione; il break even point; i<br />
metodi di calcolo per la determinazione dei prezzi di vendita: metodo del costo totale, metodo del<br />
food cost, metodo del bep).<br />
3° MODULO : LE RISORSE FINANZIARIE (La stima del fabbisogno finanziario: al momento<br />
della costituzione e durante la gestione; le fonti di finanziamento e loro caratteristiche; le fonti<br />
interne: capitale proprio e autofinanziamento; le fonti esterne: il credito mercantile, i prestiti<br />
bancari; il prestito obbligazionario; i finanziamenti pubblici; il leasing; il factoring).<br />
4° MODULO: LA GESTIONE AMMINISTRATIVA (La contabilità aziendale: le scritture<br />
contabili obbligatorie secondo la normativa civilistica, secondo la normativa fiscale e secondo la<br />
normativa di tutela del lavoro; la contabilità elementare delle imprese ristorative; la contabilità<br />
generale: il conto e il quadro dei conti; il metodo della partita doppia; analisi e rilevazione dei<br />
principali fatti di gestione; le principali scritture di assestamento; la chiusura generale dei conti; il<br />
bilancio d’esercizio, i principi di redazione del bilancio, le parti del bilancio: Lo Stato patrimoniale,<br />
il Conto economico, la Nota integrativa; il bilancio in forma abbreviata; gli allegati del bilancio).<br />
5° MODULO: LE RISORSE UMANE (L’assunzione del personale: pianificazione, reperimento e<br />
selezione; la normativa sul lavoro: articoli della Costituzione, Codice civile, Leggi speciali,<br />
Contrattazione collettiva con i suoi vari livelli e contrattazione individuale; il costo del lavoro: la<br />
retribuzione e i suoi elementi aggiuntivi e sottrattivi, i contributi previdenziali e assistenziali e gli<br />
enti che gestiscono le assicurazioni sociali obbligatorie, l’addestramento e la formazione, il TFR, i<br />
libri obbligatori).<br />
6° MODULO: IL MARKETING (Un po’ di storia; il marketing turistico; il marketing strategico e<br />
operativo: la raccolta dei dati, l’analisi della situazione esterna e interna, definizione degli obiettivi<br />
di marketing, le strategie di marketing relative alle 4 P, il marketing mix, il ciclo di vita del<br />
prodotto, il controllo dei risultati e la valutazione; esempio di piano di marketing di un’impresa<br />
ristorativa)<br />
L’insegnante Gli Studenti<br />
Patrizia Rossi<br />
<strong>Pag</strong> . 100
SCHEDA DISCIPLINARE<br />
DISCIPLINA RELIGIONE CATTOLICA<br />
DOCENTE Paola Moretti<br />
LIBRI DI TESTO Religione e religioni S. Bocchini Edizioni Devoniane Bologna<br />
MODULI PREPARATI PER L'ESAME E ETEMPI DI SVOLGIMENTO<br />
Modulo N°1 “Etica e sue problematiche”<br />
14. l'etica religiosa<br />
15. uomini e donne responsabili<br />
16. valori da vivere<br />
Tempo di svolgimento: mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre<br />
Modulo N°2 “Giovani e valori”<br />
o) incontro con l'altro e condivisione<br />
p) solidarietà e giustizia<br />
q) volontariato<br />
r) famiglia e matrimonio<br />
Tempo di svolgimento: mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio<br />
METODOLOGIE<br />
L'impostazione metodologica seguita durante le lezioni parte dalla vita concreta dei giovani e dal<br />
loro mondo interiore nel rispetto delle finalità della scuola. Attraverso un linguaggio semplice ed<br />
immediato per ogni modulo sono stati messi in risalto i nuclei essenziali mediante un approccio<br />
interculturale e un'attenzione al dialogo interreligioso.<br />
MEZZI/STRUMENTI<br />
Durante le lezioni sono state utilizzate fotocopie , articoli di giornale e mappe concettuali per<br />
stimolare la partecipazione e il dialogo educativo.<br />
RISULTATI OTTENUTI<br />
La classe ha raggiunto nel corso dell'anno un risultato più che discreto, mostrando un interesse ed<br />
impegno. Gli obiettivi previsti sono stati globalmente raggiunti.<br />
<strong>Pag</strong> . 101
CLASSE 5° ALBERGHIERO<br />
8. Che cos'è l'etica?<br />
9. Etiche contemporanee e relativismo etico<br />
10. Etica religiosa<br />
11. Religione e valori<br />
12. Valori da vivere<br />
13. Incontrare l'altro, fermarsi e condividere<br />
14. Solidarietà e giustizia<br />
15. Volontariato attivo.<br />
16. Famiglia e matrimonio<br />
PROGRAMMA SVOLTO<br />
MATERIA RELIGIONE CATTOLICA<br />
ANNO SCOLASTICO 2011/2012<br />
CLASSE VBSR<br />
L’insegnante Gli Studenti<br />
Paola Moretti<br />
<strong>Pag</strong> . 102
DISCIPLINA : EDUCAZIONE FISICA<br />
Docente : prof.ssa Fiorella Pastorelli<br />
SCHEDA DISCIPLINARE<br />
Libro di testo “In movimento” Fiorini-Coretti-Bocchi<br />
Moduli preparati per l'esame e tempi di svolgimento<br />
Regolamenti essenziali delle principali tecniche degli sports conosciuti. (Periodo : tutto<br />
l'anno )<br />
Terminologia specifica. (Periodo : tutto l'anno )<br />
Nozioni fondamentali di anatomia e fisiologia (riferite in particolare all'apparato<br />
locomotore) del metabolismo energetico ,delle attività aerobiche e anaerobiche.( Periodo:<br />
Gennaio- Febbraio per un tot. di ore 6 ).<br />
Principi fondamentali dell'allenamento (Periodo : Marzo per un tot. di ore 4 ).<br />
Alimentazione dell'atleta ,uso degli integratori e del doping nello sport. ( Periodo : Aprile<br />
per un tot. di ore 6 )<br />
Educazione alla salute .Elementi di pronto soccorso e primo intervento ( Periodo: Maggio<br />
per un tot. di ore 3 )<br />
Metodologie<br />
Globale -analitico-globale attraverso :<br />
s) lezioni frontali<br />
t) esercitazioni<br />
u) lavori di gruppo<br />
v) ricerche<br />
Mezzi e strumenti<br />
Libro di testo, schede, fotocopie. Palestra, grandi e piccoli attrezzi, campi di calcio, da tennis,<br />
piscina, ambiente naturale .<br />
<strong>Pag</strong> . 103
Risultati ottenuti<br />
Conoscenze: Livello di acquisizione<br />
Dei contenuti della disciplina discreto<br />
Dei procedimenti e delle metodologie sufficiente<br />
Abilità :<br />
E' riuscita a migliorare le capacità coordinative e condizionali buono<br />
E' riuscita a memorizzare informazioni e sequenze motorie discreto<br />
E' in grado di comprendere informazioni riconoscendo i dati discreto<br />
fondamentali<br />
E' in grado di applicare regole , tecniche , procedimenti , metodi<br />
discreto<br />
Percepisce e analizza dati, informazioni, modelli ,derivanti sufficiente<br />
dall'esperienza vissuta.<br />
Competenze :<br />
Sa utilizzare il lessico specifico sufficiente<br />
Sa utilizzare in modo consapevole procedimenti tecniche,<br />
principi in contesti diversi sufficiente<br />
Sa gestire in modo autonomo situazioni di diverso contenuto sufficiente<br />
Test di verifiche durante l'anno<br />
Sono stati effettuati colloqui orali e dimostrazioni pratiche alla fine di ogni modulo ;<br />
una simulazione della terza prova .<br />
<strong>Pag</strong> . 104
DISCIPLINA : EDUCAZIONE FISICA<br />
DOCENTE : FIORELLA PASTORELLI<br />
MODULI SVOLTI:<br />
Controllo e sviluppo degli schemi motori di base :<br />
affinamento ed integrazione degli schemi motori<br />
capacità coordinative,percettive motorie<br />
sviluppo delle variabili spazio tempo<br />
Controllo e sviluppo delle capacità condizionali :<br />
mobilità articolare<br />
velocità<br />
resistenza<br />
forza<br />
controllo e sviluppo delle abilità motorie :<br />
PROGRAMMA SVOLTO<br />
ANNO SCOLASTICO : 20011/2012<br />
CLASSE : 5^B SR<br />
attuare movimenti complessi in forma automatica ed economica<br />
Avviamento alla pratica sportiva (tecnica e regolamenti) di :<br />
pallavolo fondamentali del trattamento palla (palleggio,bagher, battuta, schiacciata) e regole<br />
fondamentali del gioco<br />
basket elementi fondamentali e principali regole di gioco<br />
<strong>Pag</strong> . 105
pallamano<br />
atletica leggera attività primaria per il movimento della corsa e preatletici con particolare attenzione<br />
alla disciplina degli ostacoli.<br />
Educazione alla salute:<br />
anatomia e fisiologia dell’apparato locomotore<br />
elementi di pronto soccorso e primo intervento<br />
L’insegnante Gli Studenti<br />
Fiorella Pastorelli<br />
<strong>Pag</strong> . 106
<strong>Pag</strong> . 107