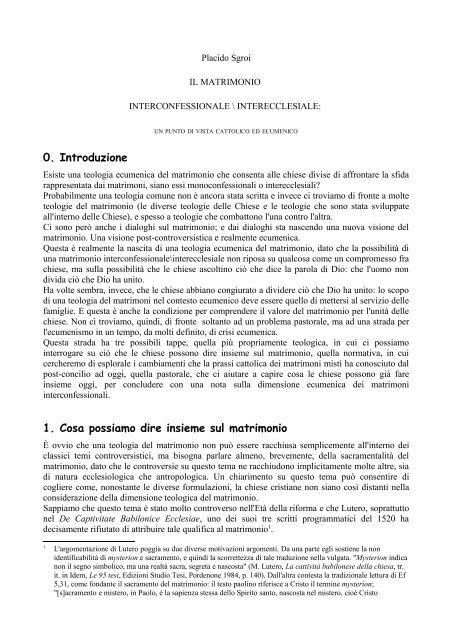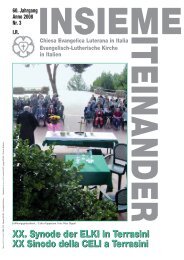Placido Sgroi: Il matrimonio interconfessionale ... - Nemesistemi.It
Placido Sgroi: Il matrimonio interconfessionale ... - Nemesistemi.It
Placido Sgroi: Il matrimonio interconfessionale ... - Nemesistemi.It
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
0. Introduzione<br />
<strong>Placido</strong> <strong>Sgroi</strong><br />
IL MATRIMONIO<br />
INTERCONFESSIONALE \ INTERECCLESIALE:<br />
UN PUNTO DI VISTA CATTOLICO ED ECUMENICO<br />
Esiste una teologia ecumenica del <strong>matrimonio</strong> che consenta alle chiese divise di affrontare la sfida<br />
rappresentata dai matrimoni, siano essi monoconfessionali o interecclesiali?<br />
Probabilmente una teologia comune non è ancora stata scritta e invece ci troviamo di fronte a molte<br />
teologie del <strong>matrimonio</strong> (le diverse teologie delle Chiese e le teologie che sono stata sviluppate<br />
all'interno delle Chiese), e spesso a teologie che combattono l'una contro l'altra.<br />
Ci sono però anche i dialoghi sul <strong>matrimonio</strong>; e dai dialoghi sta nascendo una nuova visione del<br />
<strong>matrimonio</strong>. Una visione post-controversistica e realmente ecumenica.<br />
Questa è realmente la nascita di una teologia ecumenica del <strong>matrimonio</strong>, dato che la possibilità di<br />
una <strong>matrimonio</strong> <strong>interconfessionale</strong>\interecclesiale non riposa su qualcosa come un compromesso fra<br />
chiese, ma sulla possibilità che le chiese ascoltino ciò che dice la parola di Dio: che l'uomo non<br />
divida ciò che Dio ha unito.<br />
Ha volte sembra, invece, che le chiese abbiano congiurato a dividere ciò che Dio ha unito: lo scopo<br />
di una teologia del matrimoni nel contesto ecumenico deve essere quello di mettersi al servizio delle<br />
famiglie. E questa è anche la condizione per comprendere il valore del <strong>matrimonio</strong> per l'unità delle<br />
chiese. Non ci troviamo, quindi, di fronte soltanto ad un problema pastorale, ma ad una strada per<br />
l'ecumenismo in un tempo, da molti definito, di crisi ecumenica.<br />
Questa strada ha tre possibili tappe, quella più propriamente teologica, in cui ci possiamo<br />
interrogare su ciò che le chiese possono dire insieme sul <strong>matrimonio</strong>, quella normativa, in cui<br />
cercheremo di esplorale i cambiamenti che la prassi cattolica dei matrimoni misti ha conosciuto dal<br />
post-concilio ad oggi, quella pastorale, che ci aiutare a capire cosa le chiese possono già fare<br />
insieme oggi, per concludere con una nota sulla dimensione ecumenica dei matrimoni<br />
interconfessionali.<br />
1. Cosa possiamo dire insieme sul <strong>matrimonio</strong><br />
È ovvio che una teologia del <strong>matrimonio</strong> non può essere racchiusa semplicemente all'interno dei<br />
classici temi controversistici, ma bisogna parlare almeno, brevemente, della sacramentalità del<br />
<strong>matrimonio</strong>, dato che le controversie su questo tema ne racchiudono implicitamente molte altre, sia<br />
di natura ecclesiologica che antropologica. Un chiarimento su questo tema può consentire di<br />
cogliere come, nonostante le diverse formulazioni, la chiese cristiane non siano così distanti nella<br />
considerazione della dimensione teologica del <strong>matrimonio</strong>.<br />
Sappiamo che questo tema è stato molto controverso nell'Età della riforma e che Lutero, soprattutto<br />
nel De Captivitate Babilonice Ecclesiae, uno dei suoi tre scritti programmatici del 1520 ha<br />
decisamente rifiutato di attribuire tale qualifica al <strong>matrimonio</strong> 1 .<br />
1 L'argomentazione di Lutero poggia su due diverse motivazioni argomenti. Da una parte egli sostiene la non<br />
identificabilità di mysterion e sacramento, e quindi la scorrettezza di tale traduzione nella vulgata. "Mysterion indica<br />
non il segno simbolico, ma una realtà sacra, segreta e nascosta" (M. Lutero, La cattività babilonese della chiesa, tr.<br />
it. in Idem, Le 95 tesi, Edizioni Studio Tesi, Pordenone 1984, p. 140). Dall'altra contesta la tradizionale lettura di Ef<br />
5,31, come fondante il sacramento del <strong>matrimonio</strong>: il testo paolino riferisce a Cristo il termine mysterion;<br />
"[s]acramento e mistero, in Paolo, è la sapienza stessa dello Spirito santo, nascosta nel mistero, cioè Cristo
Se la contestazione del fondamento teologico della sacramentalità del <strong>matrimonio</strong> è totale, appare<br />
però in Lutero una certa disponibilità ad un'altra interpretazione della sacramentalità del<br />
<strong>matrimonio</strong>.<br />
"Sia dunque il <strong>matrimonio</strong> allegoria di Cristo e della chiesa; sacramento, ma non di origine<br />
divina, bensì istituito dagli uomini nella chiesa, per ignoranza. Poiché tale ignoranza, tuttavia,<br />
non danneggia la fede, lo si deve tollerare in spirito di carità, come molte altre<br />
manifestazioni di debolezza e di ignoranza umana sono sopportate nella chiesa, finché non<br />
recano danno alla fede e non contrastano la sacra scrittura" 2 .<br />
L'asprezza polemica del contesto e della modalità espressiva non dovrebbe impedirci di vedere la<br />
possibilità di una comprensione complementare della sacramentalità: se il <strong>matrimonio</strong> non è un<br />
sacramento di origine divina, però esso può essere compreso come sacramento della chiesa 3 , che<br />
può essere accettato, in quanto non contrasta la Scrittura.<br />
Quest'ultima affermazione di Lutero può indicare, se si può eliminare l'appellativo di ignoranza, il<br />
fatto che vi è una libertà di istituzione sacramentale nella chiesa, che corrisponde ad una esigenza<br />
"pastorale". Non è molto rispetto alla prospettiva cattolica, ma indica già un'apertura della stessa<br />
concezione della sacramentalità, nel tempo della controversia 4 .<br />
Non va dimenticato che, anche nella prospettiva della storia del dogma, che la comprensione della<br />
sacramentalità del <strong>matrimonio</strong> è avvenuta da una parte come conseguenza di una sempre più<br />
spiccata attenzione pastorale nei suoi confronti e, dall'altra, di una progressiva ecclesiasticizzazione<br />
del rito. La teologia luterana può essere anche lette come appello a riscoprire la dimensione<br />
creaturale dello stesso 5 .<br />
È necessario fare un salto nel tempo di quasi 600 anni per poter vedere riaperta la questione, e<br />
precisamente porsi dopo dopo la svolta ecumenica del Concilio Vaticano II per vedere sorgere una<br />
lunga serie di dialoghi sul <strong>matrimonio</strong>. Questi dialoghi non hanno avuto solo solo scopo di risolvere<br />
problemi pastorali, ma anche di conseguenze teologiche, cioè la possibilità di proporre una nuova<br />
comprensione del <strong>matrimonio</strong>, al di dà della controversia fra la sua attribuzione o meno all'ambito<br />
sacramentale. Ci soffermeremo su due soli esempi.<br />
Uno di più importanti contributi a livello di dialogo internazionale è sicuramente<br />
identificabile nel testo La teologia del <strong>matrimonio</strong> e i problemi dei matrimoni interconfessionali,<br />
edito nel 1976 da una Commissione di studio formata da rappresentanti cattolici, luterani e<br />
riformati 6 .<br />
…" (Lutero, La cattività..., p. 141). E quindi, conclusivamente: "Cristo e la chiesa, dunque, sono un mistero, cioè<br />
sono una realtà segreta e grande, che fu possibile e doveroso raffigurare con l'allegoria del <strong>matrimonio</strong>, ma questo<br />
non giustifica che si definisca il <strong>matrimonio</strong> un sacramento […] manca sia l'atto dell'istituzione che la promessa<br />
divina, i quali solo costituiscono un sacramento." (Lutero, La cattività..., p. 141)<br />
2 Lutero, La cattività, p. 142.<br />
3 Uno degli sforzi della teologia cattolica contemporanea è stato quello di comprendere come i sacramenti restino di<br />
origine divina proprio perché istituiti dalla Chiesa, superando la contrapposizione fra le due modalità di istituzione<br />
nella visione di una Chiesa che istituisce i sacramenti in quanto agente a partire un mandato divino, ovvero<br />
attraverso la sua stessa esistenza in quanto chiesa. Anche la teologia protestante ha potuto superare la<br />
contrapposizione fra sacramenti istituiti direttamente da Gesù e dalla chiesa attraverso la constatazione che non si<br />
può propriamente attribuire a Gesù l'istituzione di nessun sacramento, quanto piuttosto l'effettuazione di gesti<br />
profetici, raccolti e ripetuti dalla comunità cristiane primitive...<br />
4 Così la sacramentalità del <strong>matrimonio</strong> sembrerebbe poter rientrare fra i cosiddetti adiaphora. V. CA art. XV (R.<br />
Fabbri (ed.), Confessioni di fede delle chiese cristiane, EDB, Bologna 1996, n. 45) e ACA art. XV (R. Fabbri (ed.),<br />
Confessioni, nn. 384-400).<br />
5 L'affermazione luterana per cui il <strong>matrimonio</strong> è uno stato santo che appartiene all'ordine della creazione, può essere<br />
certamente recepita anche da parte cattolica, nella misura in cui non osta alla possibilità di farne intravvedere anche<br />
la dimensione sacramentale.<br />
6 EO1, 1758-1871. <strong>Il</strong> testo si distingue per l'ampiezza della sua elaborazione, per l'organicità con cui affronta le<br />
problematiche e per la ricerca di una stretta connessione fra la discussione teologica e l'approfondimento delle<br />
problematiche pastorali, a cui viene dedicato un spazio equilibrato. Potremmo definirlo in questo contesto come un<br />
vero e proprio «classico» e un punto di riferimento ancora attuale per una teologia ecumenica del <strong>matrimonio</strong>.
<strong>Il</strong> testo non tace le profonde differenze che si celano dietro alla indicazione divergente delle<br />
confessioni circa la sacramentalità del <strong>matrimonio</strong>, in particolare la contrapposizione fra dottrina<br />
della giustificazione e dottrina della santificazione, e il timore da parte evangelica, che la<br />
concezione sacramentale cattolica abbia come conseguenza un certo automatismo della grazia, che<br />
sembra trascurare il carattere mondano del <strong>matrimonio</strong> e l'esigenza che pure il <strong>matrimonio</strong> riceva la<br />
grazia salvifica.<br />
Una revisione del rapporto fra dottrina della creazione e dottrina della redenzione, in rapporto al<br />
<strong>matrimonio</strong>, può aiutare a superare questo baratro apparentemente incolmabile. Cattolici e<br />
protestanti possono riconoscere insieme che<br />
"[l]a rivelazione ci insegna prima di tutto che Dio è il Dio vivo e vero, non soltanto non è<br />
estraneo alla grandezza umana dell'amore, ma ne è, a titolo personale, il principio e la<br />
sorgente. In effetti, solo l'amore spiega come Dio sia realmente creatore e come abbia<br />
concepito il disegno di fare esistere la famiglia umana di cui l'amore sia insieme la condizione<br />
e la vita Ora, questo Dio che desidera che l'umanità diventi a ogni costo una comunità di<br />
libertà e di amore, non vuole compiere questo disegno senza il ministero coniugale dell'uomo<br />
e della donna. Progetto di comunione totale che avrà per conseguenza di procreare e far<br />
crescere umanamente gli esseri umani, l'amore coniugale manifesta perciò il disegno<br />
creatore di Dio che vuole un mondo in cui gli uomini sono creati a sua immagine e vivono<br />
secondo essa [...] tuttavia Dio non è semplicemente alla sorgente creatrice del mondo e<br />
dell'umanità. Egli stesso ha dato nella storia un esempio di amore ineguagliato e<br />
ineguagliabile. <strong>Il</strong> popolo dell'alleanza sorse nel corso dei tempi come il beneficiario unico e<br />
come il testimone profetico per tutti di un amore senza riserve che nulla può esaurire o<br />
distruggere. Assai di più, questo amore condusse Dio alla condivisione integrale della nostra<br />
propria condizione nell'incarnazione di suo Figlio. Unendosi per sempre nella carne di Cristo<br />
alla nostra umanità, Dio rivela che il suo patto di amore è paragonabile all'amore coniugale.<br />
Coniuge pienamente fedele del popolo d'Israele Dio si rivela in Cristo come lo sposo per<br />
eccellenza, lui che prova il suo amore assoluto verso la chiesa e l'umanità offrendo se stesso<br />
per esse sulla croce." (nn. 14.15 / EO1 1777.1778)<br />
La dinamica dell'alleanza non contrappone creazione e redenzione, ma vede nella seconda il<br />
compimento della prima 7 .<br />
La dinamica dell'alleanza è appunto quella che consente, uscendo da formulazioni rigidamente<br />
codificate, di individuare nella grazia la reazione di Cristo con la comunità coniugale.<br />
"Così, senza essere contenuta nello stato matrimoniale come se fosse una realtà<br />
indipendente da Gesù Cristo o come se il <strong>matrimonio</strong> la producesse da se stesso, la grazia è<br />
interamente un dono di Cristo agli sposi. Questa grazia, accordata principalmente come una<br />
promessa durevole è altrettanto duratura quanto il <strong>matrimonio</strong> stesso è chiamato a<br />
esserlo." (n.17/EO1 1780)<br />
<strong>Il</strong> testo propone quindi di trovare anche un accordo terminologico, che consenta di individuare in<br />
modo comune la relazione di grazia fra Cristo e il <strong>matrimonio</strong>:<br />
"Noi tutti crediamo che il termine biblico di alleanza caratterizzi veramente il mistero del<br />
<strong>matrimonio</strong>." (n. 18/EO1 1781)<br />
L'attribuzione o meno a questa alleanza del termine di sacramento, deriva dai diversi modi di<br />
7 "Un tale mistero, ne siamo convinti, non è, non può essere estraneo alla situazione coniugale. Di fatto, l'alleanza,<br />
progettata fin dalla creazione del mondo, manifestata in Israele, realizzata in Gesù Cristo, annunciata dalla chiesa<br />
degli apostoli, comunicata dallo Spirito santo, rivela che Dio s'impegna lui stesso in Gesù Cristo a condurre ogni<br />
forma di amore alla sua totale verità. Se ci viene chiesto chi è questo Cristo che svolge un tale ruolo nell'amore<br />
coniugale noi rispondiamo senza esitare: è il Signore della promessa, il Signore dell'alleanza e della grazia. Perciò,<br />
senza mai dimenticare l'azione dello Spirito in seno a ogni amore coniugale il fatto che i cristiani appartengano al<br />
Signore attraverso la loro incorporazione battesimale alla sua vita riguarda anche la loro esistenza coniugale." (n. 16/<br />
EO1 1779)
concepire l'uso di questo termine in modi più generali, e spiega le difficoltà della Riforma in questo<br />
senso 8 . <strong>Il</strong> ritrovamento di un linguaggio comune, dovrebbe impedire che le difficoltà del passato<br />
possano ancora ostacolare il cammino verso una più profonda comunione sulla questione del<br />
<strong>matrimonio</strong>.<br />
"In tal modo i cattolici non dovrebbero concepire la grazia come una specie di dono<br />
puramente oggettivo che agirebbe incondizionatamente sugli sposi, ma come un'esperienza<br />
di fedeltà e di vita che Cristo suscita nei loro cuori mediante il dono dello Spirito. I luterani e<br />
i riformati da parte loro riconoscono che la promessa suggellata nella morte di Cristo e nella<br />
sua risurrezione è attiva nel cuore e nella vita dei coniugi che vivono del mistero di Cristo e<br />
che divengono così suoi beneficiari e suoi testimoni." (n. 23/EO1 1786)<br />
L'individuazione di un linguaggio teologico comune, benché possa consentire di dissolvere gli<br />
equivoci del passato, non risolve tutti i problemi legati alla diversità della prassi matrimoniale, ma<br />
apre alla possibilità di un confronto più serrato, partendo dalla constatazione dell'inesauribilità del<br />
mistero di grazia contenuto nel <strong>matrimonio</strong>, mistero che supera le frontiere della vita cristiana e che<br />
non esclude dai benefici dell'alleanza nemmeno le coppie che non credono.<br />
Alla luce dell'alleanza come dono e compito, anche le chiese evangeliche possono accettare di<br />
parlare di una aspetto sacramentale del <strong>matrimonio</strong>, anche se la loro storia e il loro linguaggio tipico<br />
può ostacolare una definizione esplicita della sua sacramentalità. La questione della sacramentalità<br />
viene così, correttamente riportata alla gerarchia delle verità, anche riguardo al <strong>matrimonio</strong>,<br />
riscoprendo il fondamento comune (l'alleanza) a cui si connettono le diverse, e a questo punto non<br />
più incompatibili, terminologie della teologia matrimoniale.<br />
La fortuna di questo testo può essere valutare alla luce della sua recezione, che mi sembra<br />
significativa in particolare per l'area italiana, come possiamo vedere dai due documenti di dialogo<br />
fra cattolici e valdesi e fra cattolici e battisti 9 , che riprendono entrambi il tema dell'alleanza come<br />
chiave teologia per la comprensione del <strong>matrimonio</strong>.<br />
L’alta parola che la Bibbia pronuncia sul <strong>matrimonio</strong> è<br />
quella secondo cui esso è presentato come una parabola della<br />
Alleanza tra Dio e il suo popolo (Osea 2,16-19) e segno<br />
presente dell’unione tra Cristo e la chiesa (Efesini 5,31-32).<br />
La parola di Dio manifesta il livello profondo in cui al<br />
credente è dato di vivere il <strong>matrimonio</strong>.<br />
<strong>Il</strong> riferimento all’Alleanza conferisce al <strong>matrimonio</strong> una forza<br />
La Parola di Dio manifesta il livello<br />
profondo in cui al credente è dato di vivere<br />
il <strong>matrimonio</strong> quando lo presenta come<br />
parabola dell’alleanza tra Dio e il suo<br />
popolo (Os 2,16-19) e segno presente<br />
dell’unione tra Cristo e la Chiesa (Ef<br />
5,31-32).<br />
8 Ma dietro alla differente terminologia, sta una visone comune del <strong>matrimonio</strong> come alleanza. "In effetti, siamo tutti<br />
convinti che il <strong>matrimonio</strong> ha un rapporto stretto con la promessa di Dio. Questa promessa non è altro che Cristo<br />
stesso che si rivolge agli sposi affinché il loro amore divenga anch'esso una unione reale e duratura. Questa<br />
promessa non è una semplice idea; è la realtà stessa di Gesù Cristo. Poiché è il volto di Cristo rivolto verso la vita<br />
coniugale, questa promessa non potrebbe mai essere subordinata a coloro che sono chiamati a beneficiarne. È data<br />
loro senza che mai essi ne possano divenire i proprietari. Perciò presuppone un annuncio della Parola esplicito e<br />
sempre rinnovato, che non è prerogativa del ministro più di quanto lo sia dei beneficiari della grazia del <strong>matrimonio</strong>.<br />
Questa promessa possiede dunque fin dall'inizio e detiene sempre l'iniziativa. Ha una sorta di autonomia in rapporto<br />
agli sposi. Li esorta incessantemente a lasciarsi formare da essa, senza che essi credano mai di essere giunti a<br />
identificarsi pienamente con la sua ricchezza di esigenza e di grazia. Associare in questo modo l'iniziativa della<br />
promessa riguardo agli sposi e l'esperienza ricreatrice che essi sono chiamati a fare della sua potenza su di loro, è<br />
parlare del carattere sacramentale del <strong>matrimonio</strong> considerato alla luce dell'alleanza. Significa anche che il<br />
<strong>matrimonio</strong> è segno dell'alleanza. Compreso in tal modo, il <strong>matrimonio</strong> conferisce ai cristiani una responsabilità di<br />
beneficiari e di testimoni. Gli sposi accettano in modo più particolare di vivere il loro amore secondo questa<br />
promessa di grazia, di cui sanno che rende loro possibile concretare il loro desiderio profondo dell'uno per l'altro<br />
mediante un dono di sé senza riserve, così come permette anche di superarne le ambiguità." (nn. 19-22/EO1<br />
1782-1785)<br />
9 Ccr-met-vald (<strong>It</strong>alia), I matrimoni interconfessionali, EO4, 1665-1753, d'ora in poi Testo comune. Per il dialogo fra<br />
cattolici e valdesi, mi riferisco al testo messo a nostra disposizione dal pastore Tomasetto, d'ora in poi Documento<br />
comune.
e una ricchezza di significati maggiori di quelle espresse da<br />
una concezione puramente contrattuale del <strong>matrimonio</strong><br />
stesso; mentre la precisazione paolina di "mistero grande" in<br />
riferimento a "Cristo e la chiesa" rivela la qualità e<br />
l’intensità dell’amore che governa la vita coniugale nella<br />
luce della salvezza che ci è data in Cristo. È questa la<br />
vocazione iscritta nel rapporto coniugale uomo-donna<br />
secondo la Parola di Dio. (Testo comune, n. 1.3)<br />
<strong>Il</strong> riferimento all’alleanza e l’indicazione<br />
paolina del “mistero grande” rivela la<br />
vocazione iscritta nel rapporto uomodonna<br />
secondo la parola di Dio, e cioè la<br />
qualità e l’intensità dell’amore che<br />
governa la vita coniugale alla luce della<br />
salvezza che ci è data in Cristo.<br />
(Documento comune, n. 1.3)<br />
Fin qui il dialogo del mondo cattolico con le diverse espressioni della Riforma 10 , ma ci<br />
possiamo anche chiedere se l'incontro fra cattolici e luterani, spesso così fecondo 11 , non possa<br />
portare ad un ulteriore avvicinamento nella teologia del <strong>matrimonio</strong>, avvicinamento che è<br />
ovviamente, reso possibile dai progressi compiuto nel dialogo sui <strong>matrimonio</strong>, ma anche da quelli<br />
proprio dell'incontro fra cattolici e luterani.<br />
In questo senso il punto di riferimento obbligato è lo studio realizzato negli anni '80 dal Circolo di<br />
lavoro ecumenico dei teologi evangelici e cattolici, Lehrverurteilungen-kirchentrennend?, sotto la<br />
direzione di W. Pannenberg, K. Lehmann e Th. Schneider 12 . Un testo che si è interrogato sulla<br />
possibilità che le condanne del XVI non potessero più costituire un motivo ancora valido di<br />
divisione delle chiese, stante l'attuale autocomprensione delle chiese stesse e dei temi<br />
tradizionalmente controversi.<br />
All'interno dei 4 volumi che rappresentano l'esito dello studio, il <strong>matrimonio</strong> riceve una attenzione<br />
specifica nell'ambito della teologia dei sacramenti.<br />
Secondo il testo cattolico-luterano la possibilità di trovare un consenso fra luterani e cattolici si può<br />
basare sul fatto che al <strong>matrimonio</strong> siano legate, la salvezza di Dio, la promessa, la benedizione e la<br />
grazia.<br />
Luterani e cattolici concordano sul fatto che il sacramento del <strong>matrimonio</strong> non contiene di per se<br />
stesso nessuna giustificazione, ma che l’esistenza cristiana è, come tale, partecipazione alla grazia e<br />
che, per la vita matrimoniale, l’essere cristiani ha un significato essenziale.<br />
La tradizionale fermezza della teologia cattolica nella definizione del <strong>matrimonio</strong> come sacramento,<br />
può incontrare la riflessione della teologia riformata che non pone in alternativa ordine della<br />
creazione e della redenzione: appartiene alla struttura fondamentale del sacramento che in esso le<br />
esigenze creaturali, quotidiane, normali e vitali divengono segni della vicinanza di Dio e della sua<br />
azione salvifica.<br />
Non è il <strong>matrimonio</strong> in quanto tale ma solo il <strong>matrimonio</strong> sotto Cristo che può essere definito<br />
sacramento: la comprensione del <strong>matrimonio</strong> cristiano come sacramento presuppone la permanente<br />
relazione ad entrambi i sacramenti fondamentali del battesimo e dell’eucarestia; soggetto primario<br />
dell’evento di grazia nel sacramento del <strong>matrimonio</strong> resta Gesù Cristo 13 .<br />
Di fronte agli specifici doveri degli sposi alla loro intensiva comunione di vita e al loro essere<br />
dipendenti dalla benedizione divina si potrebbe anche da parte evangelica parlare di sacramento del<br />
<strong>matrimonio</strong>, pur mantenendo la differenza fondamentale rispetto ai sacramenti del battesimo e della<br />
cena e descrivendo tale sacramento in relazione alla comunicazione di Cristo, mediata attraverso<br />
l’annuncio, il battesimo e la cena 14 .<br />
10 Ho dato per acquisita, nei documenti e nelle chiesa una comprensione personalistico-relazionale del <strong>matrimonio</strong>, che<br />
sta essa pure alla base del possibile dialogo su questo tema.<br />
11 Esemplare, per quanto non ancora risolutivo negli esiti della sua recezione è la Dichiarazione congiunta sulla<br />
dottrina della giustificazione, EO8, 1831-1883.<br />
12 Lehmann K. – Pannenberg W. (edd.), Lehveruteilugen-kirchentrennend?, Herder, Freiburg i.B., 1985ss. <strong>Il</strong> testo è<br />
presentato in Neuner P., Teologia ecumenica, Queriniana, Brescia 2000, p. 178ss.<br />
13 Questo vale anche per la riflessione sul <strong>matrimonio</strong> come sacramento della vita matrimoniale.<br />
14 La distinzione fra sacramenta maiora (battesimo ed eucarestia) e sacramenta minora (confermazione,<br />
riconciliazione, unzione degli infermi, <strong>matrimonio</strong>, ordine) non è estranea alla tradizione cattolica, e può essere<br />
compresa alla luce di una teologia dei sacramenti che non nasca dalla definizione generale di sacramento per<br />
giungere poi ai singoli sacramenti particolari, ma dalla concreta centralità dell'eucarestia e del battesimo che ci<br />
consentono di cogliere l'esistenza di una rete di atti sacramentali. V. P. <strong>Sgroi</strong>, Segni della koinonia. Linee del
Gli sposi realizzano in modo specifico, riferendosi alla loro relazione reciproca e ai compiti comuni,<br />
il dono di tutti i cristiani e il dovere di Gesù Cristo: al cristiano lo Spirito santo è dato come spirito<br />
di Cristo che si manifesta anche nella corporeità, i frutti dello Spirito trovano nel <strong>matrimonio</strong> un<br />
specifica caratterizzazione.<br />
La definizione del <strong>matrimonio</strong> come sacramento può pure concordare con la comprensione<br />
riformata del <strong>matrimonio</strong> per il fatto che esso è uno stato santo e divino, dato che la santità del<br />
cristiano è causata dallo spirito di Cristo 15 .<br />
Una possibilità di comprensione comune sorge anche dalla comparazione veterotestamentaria tra<br />
<strong>matrimonio</strong> e relazione fra Dio e popolo, sotto la parola chiave di alleanza. La teologica cattolica<br />
accetta la descrizione del <strong>matrimonio</strong> come segno dell’amore e della fedeltà di Dio al suo popolo;<br />
essa cerca quindi di scoprire la relazione essenziale tra i segni e ciò che viene definito da essi: il<br />
<strong>matrimonio</strong> è, in quanto grandezza creaturale, il migliore e più adatto segno per rappresentare la<br />
realtà di Dio nel vivere e nell’agire umano, per cogliere l’operare dello Spirito santo nella comunità<br />
umana. La reciproca inerenza di creazione ed alleanza, che esprime ciò che è caratteristico della<br />
<strong>matrimonio</strong> cristiano, è legata all’essenza dell’uomo. Nella misura in cui l’inclinazione di Dio per<br />
l’uomo si mostra definitivamente e insuperabilmente in Gesù Cristo, in tale misura anche il<br />
<strong>matrimonio</strong>, che riconosce questa rivelazione di Dio, guadagna il carattere di un segno di<br />
consistenza nuova e diviene un sacramento della nuova alleanza.<br />
La fondazione biblica di questa visione non viene più cercata dalla teologia cattolica in un singolo<br />
versetto o concetto, ma nel contesto globale di Ef 5,32: ciò segue le tracce di quanto ha fatto il<br />
redattore della Lettera agli Efesini il quale ha accennato al “grande mistero” facendo riferimento a<br />
Gen 2,24: tutto questo riguarda la relazione vitale Cristo-chiesa, nel quadro di una parenesi sul<br />
modello del <strong>matrimonio</strong> cristiano. <strong>Il</strong> legame carnale fra uomo e donna, che trova il suo fondamento<br />
nell’ordine della creazione è l’immagine originaria dell’unione di Cristo il Redentore, con il suo<br />
corpo, la chiesa; questa unione diviene dalla sua parte l’immagine originaria e il modello del<br />
<strong>matrimonio</strong> cristiano. La dipendenza fondamentale della relazione Cristo/chiesa-<strong>matrimonio</strong> (uomo/<br />
donna) supera la relazione morale modello-copia ed è da comprendere come relazione di grazia ed<br />
esistenziale fra modello e immagine. Questa caratterizzazione corrisponderà alla struttura di<br />
indicativo-imperativo dell’esistenza cristiana nelle lettere paoline.<br />
<strong>Il</strong> documento tedesco conclude la sua riflessione sulla sacramentalità del <strong>matrimonio</strong> augurandosi<br />
che ulteriori dialoghi stabiliscano se sarà possibile superare i pregiudizi ancora esistenti tra le<br />
diverse tradizioni sulla base di una comune interpretazione di Ef 5,21-32 e formulare una<br />
responsabile dottrina del <strong>matrimonio</strong> cristiano e della sue implicazioni morali e giuridiche.<br />
Cattolici e luterani possono dire insieme, a determinate condizioni, che il <strong>matrimonio</strong> è sacramento,<br />
ma questa consapevolezza nasce dalla capacità di relativizzare correttamente, cioè di porre nella<br />
reciproca relazione, le teologie confessionali rispetto alla Sache del <strong>matrimonio</strong>, così come è stato<br />
fatto con la Dichiarazione congiunta sulla dottrina della giustificazione.<br />
2. La normativa cattolica: una realtà in evoluzione<br />
<strong>Il</strong> problema dei cosiddetti matrimoni misti 16 cominciò a manifestarsi effettivamente per la chiesa<br />
latina solo a partire dal XVI secolo, con l’Età delle riforme religiose e la conseguente rottura<br />
dell’unità ecclesiale dell’Europa occidentale 17 . Anche se, con l’espansione del movimento<br />
dibattito ecumenico sui sacramenti, in Quaderni di Studi Ecumenici 15 (2007), pp. 237-268.<br />
15 Resta il problema di capire se una tale interpretazione pneumatologica sia compatibile con la formula cattolica dei<br />
sacramenti come mediatori della grazia; v. DH 1801.<br />
16 La nomenclatura con cui le chiese definiscono tali situazioni è variegata: matrimoni misti, matrimoni<br />
interconfessionali, interchurch marriages, foyer mixtes, konfessionsverschiedene Ehe. In area tedesca si sta<br />
diffondendo la locuzione konfessionsverbindende Ehe (letteralmente: <strong>matrimonio</strong> che unisce le confessioni), che<br />
sottolinea il carisma ecumenico di questi matrimoni.<br />
17 La chiesa indivisa aveva proibito severamente il <strong>matrimonio</strong> tra battezzati, in cui uno dei partner appartenesse a una<br />
setta eretica o scismatica, in forza dei cann. 10 e 31 del sinodo di Laodicea (347-381), del can. 50 del IV concilio<br />
ecumenico di Calcedonia (451), e del canone 72 del concilio di Trullo (691). “Dopo la rottura di comunione<br />
ecclesiastica tra oriente e occidente, le due Chiese, cattolica e ortodossa, hanno seguito una propria disciplina sui
missionario si aprì anche il problema dei matrimoni interreligiosi nei territori di missione 18 . Alla<br />
situazione occidentale fecero riferimento anche i primi provvedimenti legislativi che la Chiesa<br />
cattolica prese nei confronti di queste situazioni.<br />
L’evoluzione della normativa canonica sui matrimoni misti può essere opportunamente divisa in tre<br />
grandi tappe:<br />
• la fase antecedente alla promulgazione del primo Codice di diritto canonico della Chiesa<br />
cattolica di rito latino, nel 1917, potremmo definirla la fase dell’oscillazione fra tutela dei<br />
diritti soggettivi e istanze proselitistiche;<br />
• quella rappresentata dall’entrata in vigore del Codice del 1917, che potremmo definire la<br />
fase della diffidenza;<br />
• e quella successiva al Concilio Vaticano II, che potremmo definire della crescente apertura,<br />
su cui ci soffermiamo brevemente.<br />
Benché il Concilio Vaticano II non si sia occupato direttamente della questione dei matrimoni<br />
misti 19 la decisa svolta verso una concezione personalistica del <strong>matrimonio</strong> che esso implica e<br />
l’apertura al movimento ecumenico consentono una revisione della normativa fino ad allora<br />
vigente.<br />
L’evoluzione della normativa canonica può essere ordinata secondo alcune tappe fondamentali:<br />
• l'Istruzione della Sacra Congregazione per la Dottrina della fede Matrimonii Sacramentum<br />
(1966) 20 ;<br />
• il Decreto della Congregazione per le Chiese orientali Crescens Matrimoniorum del 1967 21. ;<br />
matrimoni misti, la quale ha subito un’evoluzione secondo le circostanze dei tempi, lo stato dei rapporti e le tensioni<br />
tra di esse, diventato ora più accondiscendente ora più rigida”. (D. Salachas, I matrimoni misti nel Codice latino e in<br />
quello delle Chiese orientali cattoliche, in Aa. Vv., I matrimoni misti, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano<br />
1998, p. 65 n. 28)<br />
18 Bisogna subito dire che la seconda questione è affrontata principalmente in termini di validità o meno di un<br />
precedente legame fra coniuge cattolico e coniuge non cristiano.<br />
19 Se si esclude il votum del concilio stesso al Papa per una nuova legislazione in materia (V. Gianesin B., Matrimoni<br />
misti, EDB, Bologna 1991, p. 128s) e il n. 18 del decreto Orientalium ecclesiarum che prevede che per i cattolici di<br />
rito orientale che sposano un partner ortodosso la dispensa dalla forma canonica condizioni solo la liceità, ma non la<br />
validità del <strong>matrimonio</strong>, bastante per questa la presenza di una ministro sacro validamente ordinato (quindi anche<br />
quelli ortodossi che sono riconosciuti nella successione apostolica da parte della chiesa cattolica).<br />
20 V. EV 2/655ss. I primi passi nella revisione della normativa della Chiesa cattolica seguono quasi immediatamente<br />
il Concilio Vaticano II e rappresentano un già significativo mutamento dell’atteggiamento complessivo della norma<br />
canonica verso i matrimoni misti. In particolare Matrimonii sacramentum, pur ribadendo gli aspetti fondamentali<br />
della normativa tradizionale (la mixta religio come impedimento, la necessità, quindi, di una dispensa per la<br />
celebrazione del <strong>matrimonio</strong>, il sistema della cauzioni per la parte cattolica) contiene anche delle novità<br />
significative, sia riguardo agli obblighi della parte non cattolica, che alla forma di celebrazione del <strong>matrimonio</strong>.<br />
Rispetto alle norme del CJC del 1917 Matrimonii sacramentum limita il coinvolgimento della parte non-cattolica<br />
alla promessa di non ostacolare la parte non cattolica nel rispetto degli obblighi da essa sottoscritti, senza chiedere<br />
ad essa un impegno positivo nei loro confronti. Anche le cauzioni a cui la parte cattolica è tenuta per ottenere la<br />
dispensa si modificano, in quanto cade la richiesta di operare per la conversione del coniuge, che viene sostituta<br />
dall’esigenza di una testimonianza significativa della propria fede cattolica, e l’obbligo del battesimo cattolico dei<br />
figli si trasforma nella promessa di fare quanto possibile perché ciò avvenga. La trasformazione merita di essere<br />
evidenziata, dato che alla rigidezza della norma, e all’esercizio di una giurisdizione sul coniuge non cattolico, si<br />
sostituisce una prospettiva che chiede, sostanzialmente, al coniuge cattolico un atteggiamento coerente con la<br />
propria identità eccleisale, senza imporre nulla al coniuge non cattolico se non il rispetto per il diritto della parte<br />
cattolica. Anche per quanto riguarda la questione della forma canonica, che resta normativa, l’istruzione rinvia ad un<br />
possibile provvedimento ad hoc della Santa Sede. Non va dimenticato che Matrimonii sacramentum revoca la<br />
scomunica precedentemente comminata dal CJC a coloro che si erano sposati senza rispettare la norme canoniche.<br />
Per un approfondimento v. Gianesin B., Matrimoni misti, EDB, Bologna 1991, p. 128ss.<br />
21 V. EV 2/961ss. In tempi molto vicini a Matrimonii sacramentum la Congregazione per le chiese orientali emana il<br />
Decreto Crescens Matrimoniorum, che assimila i cattolici di rito latino a quelli di rito bizantino, per quanto riguarda<br />
il <strong>matrimonio</strong> con un partner ortodosso: anche ad essi viene estesa la norma conciliare che prevedeva che la forma<br />
canonica fosse ritenuta necessario solo “ad liceitatem” ma non “ad validitatem”, quando il matrimono veniva<br />
celebrato da un presbitero ortodosso. V. Gianesin, Matrimoni misti, p. 127ss. Non bisogna dimenticare che il Codice<br />
dei canoni delle chiese orientali (cattoliche) del 1990 contiene una specifica normativa per i fedeli greco-cattolici; v.
• il Motu proprio Matrimonia Mixta (1970) 22 ;<br />
• il nuovo Codex Iuris Canonici (1983);<br />
• il nuovo Direttorio Ecumenico (1993).<br />
La vera rivoluzione nella canonistica cattolica è da far risalire al Motu proprio di Paolo VI<br />
Matrimonia mixta 23 che fece seguito al Sinodo dei vescovi dedicato al <strong>matrimonio</strong> (1967). <strong>Il</strong><br />
documento comporta per più aspetti una profonda modificazione non solo della norma giuridica, ma<br />
anche dell’approccio teologico pastorale ai matrimoni misti.<br />
Per prima cosa Matrimonia mixta non considera più la mixta religio un impedimento<br />
proibente alla celebrazione del <strong>matrimonio</strong>, ma lo riclassifica come atto che richiede una esplicita<br />
licenza dell’autorità ecclesiastica ordinaria, in quanto situazione pastoralmente peculiare, anche la<br />
condizione per tale concessione (causa giusta e ragionevole) appare diversa da quella<br />
precedentemente invocata.<br />
Anche il sistema della cauzioni è profondamente riformato, sia per quanto si richiede al<br />
coniuge cattolico, ma soprattutto perché si rinuncia ad esercitare qualsiasi giurisdizione sul partner<br />
non cattolico, il quale deve semplicemente essere informato degli obblighi della parte cattolica, ma<br />
non è tenuto, da parte sua, a sottoscrivere alcuna promessa o condizione. Per quanto riguarda poi la<br />
forma della celebrazione del <strong>matrimonio</strong>, pur restando normativa quella canonica, Matrimonia<br />
mixta consente allo stesso ordinario la dispensa, aprendo di fatto alla possibilità del riconoscimento<br />
di un <strong>matrimonio</strong> celebrato da un cattolico presso la comunità del partner. Viene mantenuta la<br />
revoca della scomunica per quanti non si sono in precedenza attenuti alle norme allora in vigore.<br />
<strong>Il</strong> nuovo Codice di diritto canonico del 1983 24 e il Direttorio ecumenico del 1993 25 non<br />
si discosteranno, di fatto, da quanto stabilito da Matrimonia mixta, che resta quindi il punto di<br />
arrivo dell’evoluzione della canonistica cattolica, a livello universale, essendo sostanzialmente<br />
recepito dal Codice di diritto canonico del 1983. Merita però di essere notato come l’emanazione di<br />
Matrimonia mixta porta ad una intensificazione del dialogo bilaterale, soprattutto a livello locale,<br />
dato che il nuovo quadro normativo consente non solo una adattamento della prassi universale alle<br />
diverse condizioni locali, ma rilancia anche la ricerca di una comune comprensione del <strong>matrimonio</strong><br />
cristiano, qua talis, e non solo di quelli misti.<br />
Mettiamo a confronto, per cogliere meglio l’evoluzione, i tre passi fondamentali della<br />
canonistica cattolica riguardo ai matrimoni misti.<br />
Tabella 1: L'evoluzione normativa<br />
CIC 1917 Istruzione MS 1966 MM 1970 + CIC 1983<br />
Impedimento proibente Impedimento proibente Licenza dell'autorità<br />
Dispensa se sussiste una causa Dispensa se sussiste una causa Se sussiste causa giusta e<br />
grave<br />
grave<br />
ragionevole<br />
<strong>Il</strong> coniuge cattolico deve:<br />
<strong>Il</strong> coniuge cattolico deve:<br />
<strong>Il</strong> coniuge cattolico deve:<br />
• conservare l'integrità della fede • conservare l'integrità della fede • conservare l'integrità della fede<br />
• lavorare prudentemente alla • offrire all'altro coniuge e ai figli<br />
conversione dell'altro coniuge un esempio luminoso<br />
Promessa da parte dei nubendi di • fare quanto può per allevare i • fare quanto può per allevare i<br />
far battezzare e allevare figli nella religione cattolica figli nella religione cattolica<br />
cattolicamente la prole<br />
La parte acattolica deve essere La parte non cattolica deve essere<br />
D. Salachas, <strong>Il</strong> sacramento del <strong>matrimonio</strong> nel Nuovo Diritto Canonico delle Chiese orientali, EDB, Bologna 1994.<br />
22 V. EV 3/2415ss.<br />
23 V. Gianesin, Matrimoni misti, p. 132ss.<br />
24 V. anche Schöpsdau W., Konfessionsverschiedene Ehe, Vandenhoeck und Ruprecht, Goettingen 1995, p. 73ss.<br />
25 <strong>Il</strong> Direttorio ecumenico tratta i matrimoni misti ai nn. 143-160 e non si limita a riprendere le normative canoniche,<br />
ma le colloca in un contesto pastorale, con particolare attenzione alla preparazione del <strong>matrimonio</strong> stesso (nn.<br />
143-150), alle scelte riguardanti l’educazione dei figli (nn. 151-152), alle condizioni per la dispensa dalla forma<br />
canonica (153-156), alla partecipazione dei ministri delle due comunità ecclesiali alla celebrazione del <strong>matrimonio</strong><br />
(157-158), alla condivisione eucaristica (159-160).
avvisata degli obblighi di quella c. e avvisata degli obblighi di quella<br />
promettere di non creare ostacolo cattolica<br />
Osservanza della forma canonica Forma canonica possibile Possibile dispensa dalla forma<br />
appello alla S.Sede<br />
canonica ordinario<br />
Divieto di seconda celebrazione Divieto di seconda celebrazione Divieto di seconda celebrazione<br />
Scomunica Revoca della scomunica Revoca della scomunica<br />
Credo che meriti di essere fatto un cenno anche alla peculiarità della figura del diritto canonico<br />
nella prospettiva cattolica, dato che esso non vuole semplicemente esprimere una regola pratica di<br />
organizzazione della vita ecclesiale, quanto piuttosto realizzare concretamene una certa visione<br />
ecclesiologica, esso ha quindi una radice teologica e non puramente pragmatica. In questo senso la<br />
sua evoluzione testimonia anche una evoluzione, di fatto e di diritto dell'autocomprensione<br />
cattolica, ma anche, come nel caso del <strong>matrimonio</strong>, il rilievo ecclesiolgico e teologico che i temi<br />
pastorali ed ecumenici possono acquisire 26 .<br />
<strong>Il</strong> CIC viene anche incontro al problema di comprendere o meno la sacramentalità di un <strong>matrimonio</strong><br />
intercclesiale, dato che nel can. 1055 §2 afferma: "Pertanto tra i battezzati non può sussistere un<br />
valido contratto matrimoniale, che non sia per ciò stesso sacramento".<br />
Quanto sopra ci permette di evidenziare come un <strong>matrimonio</strong> mista rappresenti una forma<br />
assolutamente valida, dal punto di vista cattolico, per stringere il patto matrimoniale, e quindi esso è<br />
dotato di carattere pienamente sacramentale 27 .<br />
3. Possibilità e limiti di una pastorale ecumenica dei matrimoni<br />
misti<br />
Tabella 2: Problemi aperti nei matrimoni interconfessionali<br />
Problemi aperti fra le chiese nei confronti dei matrimoni<br />
misti interconfessionali<br />
• Sacramentaliltà del <strong>matrimonio</strong>;<br />
• ministerialità (nel <strong>matrimonio</strong>);<br />
• procedure di riconoscimento e celebrazione;<br />
• conseguenze dell’accettazione dei matrimoni<br />
interconfessionali;<br />
• identità della coppia e poi della famiglia<br />
<strong>interconfessionale</strong> (in particolare dei figli);<br />
• ammissione del partner “altro” ai sacramenti;<br />
• (in)dissolubilità e cura pastorale dei matrimoni<br />
falliti;<br />
• questioni di etica sessuale.<br />
Problemi aperti dal punto di vista delle coppie<br />
interconfessionali<br />
• Accoglienza dei partner da parte delle famiglie<br />
di origine dell’altro partner;<br />
• Accoglienza da parte delle comunità di origine o<br />
di inserimento;<br />
• Identità ecclesiale (connesso ma non identico<br />
alla questione dell’ammissione ai sacramenti);<br />
• educazione dei figli;<br />
• vocazione ecumenica: famiglia come chiesa<br />
domestica.<br />
I documenti più attenti alle problematiche pastorali 28 evidenziano come la pastorale<br />
prematrimoniale risulti essere il primo momento del cammino verso il <strong>matrimonio</strong><br />
<strong>interconfessionale</strong>, e quindi un momento importante e delicato, perché già in esso si possono creare,<br />
o risolvere, difficoltà non irrilevanti per la vita della futura coppia. <strong>Il</strong> problema di una pastorale<br />
26 Una felice conseguenza di ciò è, per esempio, la possibilità data alle singole conferenze episcopali di legiferare sui<br />
matrimoni misti dei fedeli cattolici di loro pertinenza, ma anche di concludere accordi ecumenici locali con le altre<br />
Chiese cristiane. Questi accordi, come il doppio dialogo italiano con valdesi e battisti testimoniano, possono essere<br />
caratterizzati da un consistente creatività, sia a livello liturgico che pastorale.<br />
27 Diversamente da un <strong>matrimonio</strong> interreligioso, che non è concluso, appunto, fra due battezzati. In questo senso si<br />
esprime anche il Testo comune fra cattolici e valdesi: "Secondo la dottrina cattolica il fondamento della<br />
sacramentalità del <strong>matrimonio</strong> è il battesimo. Perciò ogni <strong>matrimonio</strong> fra due battezzati è considerato<br />
sacramento" (Testo comune, n. 2.1).<br />
28 Per esempio, proprio il dialogo fra cattolici, metodisti e valdesi in <strong>It</strong>alia, I matrimoni interconfessionali (1993), EO4<br />
1665-1753 e la stessa bozza di accordo fra cattolici e battisti.
prematrimoniale veramente ecumenica è complicato da una pluralità di situazioni che riguardano sia<br />
i pastori, che le coppie.<br />
È ovvio che da parte dei pastori si evidenzi la necessità di una doppia fedeltà, da una parte alla<br />
propria appartenenza confessionale, con tutto quello che essa implica anche da un punto di vista<br />
normativo 29 , e dall'altra quella alla dimensione ecumenica del <strong>matrimonio</strong> che vanno a preparare.<br />
Questa duplice fedeltà può esprimersi in un minimo di correttezza ecumenica, ad esempio<br />
nell'invito al partner di altra confessione a prendere contatto con il proprio pastore, fino ad un<br />
massimo di progettazione pastorale, realizzato dalla creazione di specifici momenti di preparazione<br />
al <strong>matrimonio</strong>, per coppie interconfessionali, organizzati e gestiti ecumenicamente. I dialoghi<br />
sembrano indicare questi due estremi come ambito di esercizio di una pastorale ecumenica che<br />
prepari al <strong>matrimonio</strong>.<br />
L'eventuale gradazione delle scelte è legata anche all'effettiva situazione della coppia<br />
<strong>interconfessionale</strong>: coppie di praticanti motivati presentano una situazione sicuramente diversa da<br />
altre in cui uno solo dei due fa un effettivo riferimento alla propria confessione, o ancora da altre in<br />
cui le appartenenze confessionali sono puramente nominali. Non è quindi possibile individuare, né<br />
nei dialoghi né a livello di riflessione teologico-pastorale, un quadro definito per tale approccio, ma<br />
esso va calibrato, come è giusto dal punto di vista pastorale, all'effettiva sensibilità ecumenica dei<br />
pastori e dei nubendi, facendo comunque attenzione ad evitare che la pastorale prematrimoniale<br />
possa far sospettare una tentazione proselitistica.<br />
Strettamente legato a quanto detto sopra è anche il problema della forma celebrativa,<br />
che è però in parte risolto da una più articolata serie di accordi fra le diverse chiese. Anche in questo<br />
caso elementi giuridici e attenzione pastorale si sommano (talvolta si contrastano).<br />
<strong>Il</strong> <strong>matrimonio</strong> fra coniugi protestanti e cattolici costituisce, anche per quanto riguarda la scelta della<br />
forma celebrativa, la situazione in cui si è avuta la più spettacolare evoluzione, per cui in tal caso<br />
l'alternativa, fatte salve le cauzione cattoliche, è data fra forma canonica cattolica, rito evangelico e<br />
rito civile 30 : la scelta della forma viene in questo caso, correttamente, rinviata ad una decisione degli<br />
sposi, nel dialogo con i rispettivi pastori.<br />
La questione della forma celebrativa ha una interessante espansione per quanto riguarda i ministri<br />
delle diverse chiese. Stante il fatto che la celebrazione del <strong>matrimonio</strong> avverrà secondo il rito di una<br />
delle due Chiese, e che solo il ministro della chiesa ospitante riceverà il consenso, i testi prevedono<br />
la possibilità della partecipazione attiva del ministro dell'altra chiesa, in forme che potranno esser<br />
concordate fra gli sposi e i ministri, in particolare nella liturgia della Parola 31 .<br />
Un dettaglio non secondario è l'indicazione per una celebrazione del <strong>matrimonio</strong> con la sola liturgia<br />
della Parola 32 , che corrisponde anche alla recente revisione della liturgia cattolica del <strong>matrimonio</strong> in<br />
lingua italiana (2002) 33 . Va precisato che non si tratta di una specifica liturgia ecumenica, ma della<br />
29 Pensiamo ad esempio alla situazione dei parroci cattolici rispetto al problema della licenza, dell'eventuale dispensa<br />
dalla forma canonica e in particolare al problema delle promesse coniuge cattolico, oppure a quella del parroco<br />
ortodosso, la cui chiesa ammette come valido un <strong>matrimonio</strong> ortodosso: anche nel caso essi simpatizzino con la<br />
coppia <strong>interconfessionale</strong> e ne comprendano intimamente la problematica, ciò non toglie che debbano anche far<br />
valere la normativa vigente che li riguarda.<br />
30 In questi termini si esprimono sia l'accordo fra cattolici e valdesi che la bozza del Testo comune fra cattolici e<br />
battisti (nn.. Va rilevato che questa è una delle pochissime situazioni in cui la chiesa cattolica riconosce (attraverso<br />
l'apposita licenza) il valore religioso del <strong>matrimonio</strong> civile. La situazione è interessante perché riconosce una prassi<br />
che potrebbe portare ad interessanti sviluppi. Nel caso del <strong>matrimonio</strong> con rito civile i due testi italiani suggeriscono<br />
la possibilità di una successiva celebrazione ecumenica che, senza ripetizione del consenso, "al fine dell’annuncio<br />
dell’Evangelo e per invocare sui coniugi e sulla loro famiglia la benedizione del Signore" (Testo comune 3.3. c);<br />
analogamente, ma entrando maggiormente in dettaglio Documento comune 4.32)<br />
31 v. Testo comune n. 3.3. a) e b); Documento comune 4.24, che parla esplicitamente di predicazione.<br />
32 <strong>Il</strong> Testo comune parla esplicitamente della possibilità di celebrarlo all'interno della Messa (v. Testo comune n. 3.3.<br />
a)), mentre nel Documento comune non si fa menzione di questa possibilità (v. Documento comune n. 4.26, che<br />
motiva con le difficoltà circa l'ospitalità eucaristica questa opzione).<br />
33 Che al n. 36 delle Premesse generali recita: "Se il Matrimonio avviene tra una parte cattolica e una parte battezzata<br />
non cattolica, si deve usare il rito della celebrazione del Matrimonio nella liturgia della Parola (nn. 96-146); se la<br />
circostanza lo richiede, e con il consenso dell'Ordinario del luogo, si può usare il rito del Matrimonio durante la<br />
Messa (nn, 45-95); quanto ad ammettere la parte non cattolica alla comunione eucaristica, si osservino le norme
liturgia da utilizzare in tutti i casi in cui non sia opportuna una celebrazione del <strong>matrimonio</strong> con<br />
contestuale liturgia eucaristica 34 .<br />
Abbiamo già citato il tema della cautele confessionali, la cui attualizzazione pastorale,<br />
stante il permanere immodificato sia della posizione cattolica (dato che il CIC del 1983 non ha<br />
modificato la normativa del 1970) che di quella ortodossa, si realizza tutta nel fornire<br />
un'interpretazione ecumenicamente accettabile di tali cautele. <strong>Il</strong> dialoghi più attenti a questa<br />
problematica 35 convengono nell'interpretare tali cautele alla luce dell'autocomprensione delle<br />
singole chiese, e quindi delle richieste che essi fanno ai propri fedeli, non più come espressioni<br />
diffidenza ecumenica verso l'altra chiesa e i suoi ministri.<br />
Per quanto riguarda il problema dell'appartenenza ecclesiale della coppia<br />
<strong>interconfessionale</strong>, dal punto di vista strettamente pastorale si può solo dire che un'attenzione<br />
pastorale a tale realtà va posta, indipendentemente da una soddisfacente soluzione della parallela<br />
problematica teologica. Anche qui il contributo dei dialoghi sembra andare da un minimum, che<br />
vuole assicurare a ciascun partner la continuità del proprio riferimento ecclesiale, e che invita i<br />
pastori a farsi carico di questo problema, all'ipotesi di una più ampia attenzione a questo specifico<br />
problema, fino a suggerire forme di ospitalità "liturgica" per uno dei coniugi in momenti<br />
significativi della vita ecclesiale della comunità dell'altro 36 .<br />
Battesimo ed educazione dei figli sono probabilmente ancora problematiche di<br />
frontiera che trovano una spazio limitato negli stessi dialoghi. In genere i testi invitano i genitori ad<br />
una scelta precisa ed unitaria circa l'appartenenza confessionale dei figli, scelta che deve essere fatta<br />
dai genitori stessi senza subire pressioni esterne che turbino la loro libera scelta. Alcuni testi<br />
sottolineano la possibilità di celebrazioni battesimali che abbiano una dimensione ecumenica 37 ,<br />
mentre il tema dell'educazione dei figli si limita, di norma, ad evidenziare il diritto per ogni genitore<br />
alla testimonianza della propria posizione.<br />
La posizione delle autorità centrali cattoliche riguardo all'ospitalità eucaristica è<br />
riassunta adeguatamente nel Direttorio per l’applicazione dei principi e delle norme<br />
sull’ecumenismo del 1993, ai nn. 122-136, che prescrive, le condizioni alle quali un non-cattolico<br />
può essere ammesso all’eucarestia celebrata nella chiesa cattolica. Tali condizioni riguardano, da<br />
una parte, le circostanze in cui si trova la persona che richiede i sacramenti ad un ministro cattolico,<br />
dall’altra le sue personali qualità, che riassumiamo di seguito.<br />
Tabella 3: condizioni per l’ammissione di un non-cattolico alla comunione eucaristica nella chiesa cattolica<br />
Circostanze (v. Direttorio, n. 130) Condizioni personali (v. Direttorio, n. 131)<br />
Pericolo di morte Impossibilità di accedere al proprio ministro<br />
Situazioni di grave e pressante necessità 38 Richiesta del tutto spontanea del sacramento<br />
stabilite per i vari casi. Se il Matrimonio avviene tra una parte cattolica e una parte catecumena o non cristiana, si usi<br />
il rito che appresso (nn. 147-170) è indicato, tenendo conto delle varianti previste per le diverse situazioni". È da<br />
notare che il rituale cattolico distingue fra il Rito del <strong>matrimonio</strong> nella celebrazione della Parola e il Rito del<br />
<strong>matrimonio</strong> tra una parte cattolica e una parte catecumena o non cristiana. Questo terzo rituale è tenuto presente<br />
nel Documento comune fra cattolici e battisti nel caso di appertenenti alla Chiesa battista non ancora battezzati, che<br />
vengono classificati come catecumeni (v. Documento comune n. 2.5).<br />
34 Naturalmente questo apre al problema dell'ospitalità eucaristica per le coppie e le famiglie interecclesiali, non solo<br />
in occasione della celebrazione del <strong>matrimonio</strong>, che affronto alla fine di questa breve rassegna di temi pastorali.<br />
35 Ad esempio, ARCIC, La teologia del <strong>matrimonio</strong> e la sua applicazione ai matrimoni misti (1975), EO1 181-260.<br />
36 La riflessione teologica si è spinta oltre, fino ad eleaborare il concetto di duplice appartenenza; v. Beaupere R.,<br />
Double Belonging: Some Reflections, in One in Christ 18 (1982) e Kilcourse G., Double Belonging. Interchurch<br />
Families and Christian Unity, Paulist Press, New York 1992.<br />
37 Così ad esempio il Testo applicativo (contenuto in Commissione episcopale della CEI per l'ecumenismo e il dialogo,<br />
I matrimoni tra cattolici e valdesi o metodisti in <strong>It</strong>alia, EDB, Bologna 2001, p. 91ss.) dell'accordo fra cattolici e<br />
valdesi ai nn. 30-40 e Documento comune, n. 4.33<br />
38 In realtà il CIC al can. 844 §4 parla semplicemente di grave necessità: “alia urgeat gravis necessitas”.
Manifestazione della fede cattolica circa il sacramento<br />
richiesto<br />
Possesso delle dovute disposizioni 39<br />
Tali condizioni constano anche nel caso di un <strong>matrimonio</strong> misto 40 .<br />
<strong>Il</strong> magistero episcopale è chiamato a confrontarsi con la questione dell’ospitalità eucaristica proprio<br />
a partire dal fatto che le posizione dell’autorità centrale romana hanno valore universale e quindi<br />
richiedono di essere calate nelle diverse situazione locali, secondo le peculiarità proprie di<br />
ciascuna 41 .<br />
<strong>Il</strong> documento degli istituti ecumenici franco-tedeschi propone un esauriente elenco di prese di<br />
posizioni di episcopati locali che regolano l’accesso dei non cattolici all’eucarestia celebrata nella<br />
chiesa cattolica 42 . Di queste meritano di essere citate in particolare quelle dei Paesi Bassi, che già<br />
nel 1968 autorizzano i sacerdoti cattolici a dare la comunione anche la coniuge non cattolico in<br />
occasione del <strong>matrimonio</strong>, le Istruzioni sull’ospitalità eucaristica per i matrimoni misti,<br />
dell’arcivescovo di Strasburgo, Elchinger, che indica quattro condizioni di base che consentono<br />
l’accesso di un cristiano non cattolico all’eucarestia 43 , le indicazioni del Sinodo della diocesi di<br />
Basilea (1972) che concede l’intercomunione alle coppie interconfessionali, il Direttorio<br />
sull’ecumenismo dei Vescovi del Sudafrica (1998-2000) 44 .<br />
<strong>Il</strong> quadro che emerge è complessivamente positivo per le coppie interconfessionali che vedono un<br />
generale riconoscimento della loro condizione come una di quelle riconoscibili nei casi di grave<br />
necessità che rendono possibile l’ammissione del partner non cattolico alla celebrazione cattolica 45 ,<br />
anche se tale ammissione resta non generalizzabile ma condizionata al discernimento dei singoli<br />
casi, da parte dei pastori cattolici 46 . Più controversa resta la questione della reciprocità nella<br />
39 V. Ecclesia de Eucarestia nn. 37 e 38.<br />
40 V. Direttorio per l’applicazione dei principi e delle norme sull’ecumenismo, nn. 159 e 160; anche se il n. 159<br />
specifica che “la decisione di ammettere o no la parte non-cattolica del <strong>matrimonio</strong> alla comunione eucaristica va<br />
presa in conformità alle norme generali esistenti in materia […] e tenendo conto di questa situazione particolare, che<br />
cioè ricevono il sacramento del <strong>matrimonio</strong> cristiano due cristiani battezzati”. Da questo punto di vista, anche<br />
l'Enciclica Ecclesia De Eucharistia non aggiunge nulla di nuovo. Anche la specificazione che essa introduce al n.<br />
46, annotando come fra le condizioni di manifestazione di una fede «cattolica» circa l’eucarestia vi è anche “quella<br />
concernente la necessità del sacerdozio ministeriale”, non restringe le condizioni poste dal CIC al can. 844 e ribadite<br />
dal Direttorio…. Ecclesia De Eucharistia, come atto interno alla chiesa cattolica, non chiede nulla di più al non<br />
cattolico se non il riconoscimento che, nella chiesa cattolica, una valida celebrazione eucaristica ha come condizione<br />
la sua celebrazione da parte di un ministro validamente ordinato all’interno della chiesa cattolica. Nulla di nuovo si<br />
dice riguardo al problema della validità dei ministeri presso le chiese non cattoliche e al significato dell’eucarestia in<br />
esse celebrato.<br />
41 Così il CIC al can. 844 §5 e il Direttorio… al n. 130.<br />
42 V. Istituti teologici ecumenici in Germania, L’ospitalità eucaristica è possibile, in <strong>Il</strong> Regno-documenti 11/2003,<br />
351-371. A p. 356-358 che cita i casi dei Paesi Bassi (1968 e 1970), delle diocesi di Strasburgo e di Basilea (1972),<br />
della Germania (1971-1975), della Conferenza episcopale francese (1983), delle diocesi australiane di Brisbane<br />
(1995) e di Rockhampton (1998), del Sudafrica (1998), dell’arcidiocesi di Vienna (1999) e del Canada (2000).<br />
43 Cit. in L’ospitalità eucaristica è possibile, p. 356: “a) il cristiano in questione, in base ad una sufficiente<br />
conoscenza della fede eucaristica della Chiesa cattolica, deve manifestare il suo accordo essenziale con essa; b) deve<br />
avere effettivi collegamenti con la vita della Chiesa cattolica, per esempio attraverso il suo consorte o i suoi figli<br />
come membri della Chiesa cattolica o attraverso una profonda conoscenza e un impegno assunto insieme ai fratelli<br />
cattolici; c) deve manifestare un sincero bisogno spirituale di partecipare all’eucarestia e di potersi accostare alla<br />
comunione insieme al suo partner, per potere in tal modo manifestare e rafforzare l’unita della comunione familiare<br />
che entrambi vogliono costruire insieme su Cristo; d) la chiesa cui appartiene questo cristiano non può opporsi alla<br />
sua intenzione e il vescovo deve ritenere soddisfatte queste condizioni.”<br />
44 Southern African Catholic Bishops Conference, Directory of Ecumenism (2000), nn. 7.12 e 7.13, in<br />
http://www.sacbc.org.za/ecume.htm.<br />
45 L’ospitalità eucaristica è possibile, p. 356: “Fra queste gravi necessità sono state inserite nel frattempo anche le<br />
necessità spirituali, fra cui soprattutto la situazione di fede nei matrimoni misti.”<br />
46 Così, ad esempio, si è espressa la Commissione ecumenica della Conferenza episcopale tedesca in Ökumene-<br />
Kommission der Deutschen Bischofskonferenz, Zur Frage der eucharistischen Gastfreundschaft bei<br />
konfessionsverschiedenen Ehen und Familien, in Una Sancta 1/97, n. 5 [la traduzione inglese è reperibile in
condivisione eucaristica, che rappresenta il vero punctum dolens della discussione 47 e in cui le<br />
posizioni degli episcopati non vanno oltre la raccomandazione a quei cattolici che, per motivi di<br />
coscienza, decidono di partecipare alla Santa Cena evangelica di non danneggiare il senso di<br />
appartenenza alla propria chiesa, riconoscendo che tale prassi, pur non corrispondendo alla<br />
normativa ufficiale non porta alla rottura, di per sé, della comunione ecclesiale.<br />
“Le norme, molto varie, adottate nella Chiesa cattolica dimostrano che per i cattolici<br />
l’ospitalità eucaristica non viene affatto esclusa in linea di principio. […] Ma se la possibilità<br />
dell’ospitalità eucaristica non è esclusa in linea di principio, allora la sua regolamentazione è<br />
questione di considerazioni teologico-pastorali. La cerchia di coloro che sono invitati<br />
all’eucarestia è modificabile e bisogna interrogarsi sui criteri di scelta. Ma soprattutto bisogna<br />
chiarire se non esista, al di là della non impossibilità in linea di principio dell’ospitalità<br />
eucaristica, la sua possibilità in linea di principio.” 48<br />
Una via alla concreta soluzione della condivisione eucaristica è legata al crescente interesse per il<br />
§4 del can. 844 del codice di diritto canonico, che abbiamo più sopra richiamato. In particolare<br />
l’espressione «gravis necessitas» ha suscitato le riflessioni più feconde. <strong>Il</strong> Codice di diritto<br />
canonico non specifica cosa si intenda per grave necessità che può consentire o addirittura<br />
raccomandare 49 la communio in sacris fra cattolici e non cattolici. Nella riflessione degli episcopati<br />
locali il concetto è stato interpretato in senso spirituale, per cui tale necessità può corrispondere ad<br />
una profonda esigenza spirituale di condivisione eucaristica, motivata da situazioni personali<br />
oggettive: il <strong>matrimonio</strong> misto pare essere una delle condizioni particolari in cui questa situazione<br />
di necessità spirituale si manifesta con maggior frequenza e intensità 50 e che quindi rende possibile<br />
l’accesso di un non cattolico all’eucarestia celebrata nella chiesa cattolica.<br />
Ne emerge che la prassi pastorale è in grado di affrontare in modo efficace l’istanza che nasce<br />
dall’esperienza vissuta delle coppie e che può offrire originali vie di soluzione alle problematiche,<br />
vie che non sono prive di valore anche dal punto di vista teologico 51 .<br />
Ciò che ci possiamo chiedere è se, assodata l’identificazione del <strong>matrimonio</strong> misto come una delle<br />
condizione di grave necessità che rendono possibile la condivisione eucaristica, tale situazione sia<br />
da identificare come un caso particolare e assoluto, o invece come un modello che può spingere<br />
innanzi la riflessione e la prassi 52 .<br />
È possibile ricavare una sensazione d'insieme dagli spunti pastorali presenti nei diversi testi?<br />
http://www.aifw.org/journal/98ja10.shtm].<br />
47 Lo stesso L’ospitalità eucaristica è possibile riporta solo pochi casi di discussione aperta sulla reciprocità<br />
dell’ospitalità eucaristica: le riflessioni del Vescovo di Stasburgo Elchinger (1972), le conclusioni del Sinodo di<br />
Basilea (1972) e quelle del Sinodo di Würzburg (1971-1975); v. L’ospitalità eucaristica è possibile, p. 356s.<br />
48 V. L’ospitalità eucaristica è possibile, p. 358.<br />
49 Così il Direttorio al n. 129. “… in certe circostanze, in via eccezionale e a determinate condizioni, l’ammissione a<br />
questi sacramenti può essere autorizzata e perfino raccomandata a cristiani di altre Chiese e Comunità ecclesiali.”<br />
50 Questa situazione è stata esplicitamente riconosciuta come significativa dal Sinodo di Würzburg (1971-1975), dal<br />
documento delle conferenze episcopali delle isole britanniche Un solo pane, un solo corpo (1998), dal Direttorio<br />
sull’ecumenismo dei vescovi del Sud Africa (2000), dalla Guida pratica dei vescovi canadesi (2000).<br />
51 Contro ogni tentazione di squalificare l’approccio pastorale come banalizzante rispetto ad un approccio sistematico;<br />
in realtà pastorale e riflessione sistematica dovrebbero, correttamente, comprendersi come grandezze legate<br />
strettamente in un circolo indissolubile, il circolo prassi – teoria – prassi.<br />
52 Una felice interazione fra prassi pastorale e riflessione teologica può essere riscontrata nel testo collettivo<br />
Forschungsgruppe der Theologische Fakultät Innsbruck, Silvia Hell (ed.) Die Zulassung nichtkatholischer Christen<br />
zur Kommunion in der römisch-katholischen Kirche, Ökumenische Rundschau 47/4 (1998) 534-542 (traduzione<br />
inglese in http://www.aifw.org/confer/innsbruk.shtm), che partendo dall’analisi del canone 844 del CIC giunge a<br />
concludere che l’ospitalità eucaristica “non costituisce un problema di intercomunione, ma di permesso di<br />
ammissione, sotto specifiche condizioni, alla comunione nella chiesa cattolica romana di un cristiano che non è<br />
cattolico romano [… e che] ci sono situazioni in cui la «grave necessità» deve essere compresa come una necessità<br />
spirituale e in cui è moralmente impossibile raggiungere un ministro della propria comunità. <strong>Il</strong> nostro desiderio in<br />
questa impresa è stato quello di chiarire che un allargamento della nostra comprensione [del canone 844] («necessità<br />
spirituale» e «impossibilità morale di raggiungere un ministro della propria comunità») non si trova in opposizione<br />
con la tradizione del Diritto canonico.” (mia traduzione)
Forse il dato che li accomuna è la percezione di un'urgenza, quella di un'organica pastorale<br />
ecumenica del <strong>matrimonio</strong>, soprattutto in quelle situazioni in cui il <strong>matrimonio</strong> <strong>interconfessionale</strong> è<br />
la norma, urgenza che è accentuata dalla crisi dell'istituzione matrimoniale che tutte le chiese si<br />
trovano a fronteggiare.<br />
A questa percezione non corrisponde sempre un'adeguata risposta e il cammino verso tale pastorale<br />
sembra veramente timido, o almeno limitato a momenti, come quello della celebrazione, che<br />
risultano essere di effettivo «contatto istituzionale» fra le diverse chiese. Forse la potenzialità<br />
ecumenica del momento pastorale, così rilevante in altri ambiti del cammino ecumenico, non è<br />
pienamente compresa o valorizzata.<br />
Esperienze come quelle delle coppia interconfessionali e dei movimenti da loro creati farebbero<br />
però propendere per una più ottimistica valutazione di questa possibilità.<br />
Dal punto di vista cattolico (e forse non solo cattolico) va segnalato anche il problema della<br />
recezione pastorale di quanto i testi di dialogo e accordo affermano. Non dico nulla di nuovo<br />
affermando che questa recezione è assai diversificata nelle situazioni locali, in funzione della<br />
frequenza dei matrimoni interecclesiali, di fatto molto rari in passato, e ora in crescita a seguito del<br />
fenomeno dell'immigrazione, e della specifica sensibilità delle diverse diocesi e in particolare dei<br />
responsabili degli uffici matrimoni. Faccio un esempio che mi riguarda da vicino, quello della<br />
Diocesi di Verona, in cui, di fatto, la consulenza sulle diverse tipologie di <strong>matrimonio</strong> misto e sulle<br />
singole concrete situazioni ha visto il crescente coinvolgimento dell'Ufficio Ecumenismo e Dialogo<br />
interreligioso, spesso più attrezzato di altri a discernere la singole vicende e a supportare i parroci in<br />
una corretta pastorale di questi matrimoni. È quindi importante che i pastori che vogliono<br />
accompagnare i propri fedeli in un <strong>matrimonio</strong> con partner cattolico non solo conoscano la<br />
normativa cattolica vigente, ma cerchiano anche i riferimenti ecumenici più opportuni, non<br />
fermandosi ad eventuali contatti con il solo parroco cattolico di pertinenza. è chiaro che un accordo<br />
fra la C.E.L.I. e la C.E.I. semplificherebbe di molto questi aspetti normativi, oltre a costituire un<br />
concreto e interessante terreno di dialogo e incontro fra luterani e cattolici.<br />
La pastorale dei matrimoni falliti è un argomento che esula, almeno in parte dai temi che<br />
affrontiamo oggi, ma che merita un rapido cenno.<br />
I documenti di dialogo italiani mettono ben in luce che sia per cattolici che per valdesi e battisti il<br />
<strong>matrimonio</strong> è una realtà intrinsecamente duratura 53 . Questo è uno degli elementi fondamentali che<br />
consente la celebrazione di un <strong>matrimonio</strong> misto, dal punto di vista cattolico. Ciò che cambia è il<br />
trattamento pastorale dei matrimoni falliti, trattamento che procede secondo due diversi modelli<br />
giuridico-pastorali: dal punto di vista cattolico si propende a sottolineare la dimensione oggettiva<br />
del sacramento e quindi la sua indissolubilità dal punto di vista giuridico, con la conseguenza della<br />
impossibilità ad accedere a nuove nozze religiose per coloro che sono legati da un precedente<br />
<strong>matrimonio</strong> canonico 54 , dal punto di vista protestante la possibilità di nuove nozze religiose per<br />
persone divorziate, non è esclusa, ma ammessa secondo una prudente valutazione pastorale. Questa<br />
discordanza nella prassi, come dicono i documenti sul <strong>matrimonio</strong>, non osta ad una celebrazione del<br />
<strong>matrimonio</strong> fra sposi di diversa appartenenza ecclesiale. <strong>Il</strong> nucleo della differenze sembra sussistere<br />
quindi nel complesso intreccio fra giurisdizione e pastorale: le chiese della Riforma hanno<br />
rinunciato ad esercitare una giurisdizione propria sul <strong>matrimonio</strong> e quindi si pongono nei suoi<br />
confronti con un atteggiamento puramente pastorale, lasciando a Cesare ciò che è di Cesare, la<br />
Chiesa cattolica ha voluto conservare la propria giurisdizione ecclesiastica, che si somma, secondo i<br />
diversi concordati, a quella civile. Un interessante caso intermedio è dato dalla posizione ortodossa<br />
che pur recependo una teologia dell'indissolubilità sostanzialmente analoga a quella cattolica ritiene<br />
53 "<strong>Il</strong> <strong>matrimonio</strong> è un patto senza scadenze" (Testo comune, n. 1.6); "<strong>Il</strong> <strong>matrimonio</strong> è un patto per la<br />
vita." (Documento comune, n. 1.6).<br />
54 La figura dell'annullamento corrisponde alla possibilità di individuare ragioni giuridiche per cui il <strong>matrimonio</strong><br />
celebrato era in realtà nullo fin dalla sua origine, esso non si può quindi comparare al divorzio, anche se nella attuale<br />
situazione sociologica non è impossibile ritenere che molti matrimoni fra cattolici non rispondano alle esigenze che<br />
qualificano un <strong>matrimonio</strong> come tale (unità, indissolubilità e apertura alla vita).
coerente con la tradizione antica la possibilità di ammettere al <strong>matrimonio</strong>, per oikonomia, anche<br />
coloro che vengono da un precedente <strong>matrimonio</strong> fallito. Rispetto alla celebrazione delle nuove<br />
nozze non è quindi in gioco tanto la natura sacramentale del <strong>matrimonio</strong>, quanto piuttosto il<br />
trattamento pastorale delle relazioni fallite 55 . Nella storia della chiesa cattolica questa pastorale ha<br />
avuto una vicenda piuttosto complessa, che si è snodata sostanzialmente intorno al nucleo<br />
dell'ammissione ai sacramenti, che la chiesa cattolica rifiuta a coloro che si risposano civilmente<br />
dopo il divorzio. L'approccio recente dell'arcivescovo di Milano 56 ha certamente il pregio di portare<br />
la questo sul significato dell'appartenenza ecclesiale di queste coppia, che pur non potendo accedere<br />
ai sacramenti non sono "scomunicate", ma posso partecipare alla vita di fede della comunità<br />
cristiana, non senza offrire ad essa un prezioso contributo. Questo è probabilmente il massimo che<br />
attualmente la Chiesa cattolica può offrire, dal punto di vista spirituale e pastorale, a queste coppie,<br />
nei limiti dell'attuale normativa. È certamente rilevante che la pastorale non cessi di interrogarsi sul<br />
possibilità del coinvolgimento nella vita cristiana dei fedeli che si trovano in questa condizione,<br />
ponendo alla teologia e al diritto gli interrogativi conseguenti.<br />
4. La funzione ecumenica del <strong>matrimonio</strong> <strong>interconfessionale</strong><br />
<strong>Il</strong> cammino del movimento ecumenico è stato certamente proficuo per le coppie che vivono<br />
l'esperienza del <strong>matrimonio</strong> <strong>interconfessionale</strong>, e che possono ora non sentirsi più poste ai margini<br />
delle proprie comunità ecclesiali; ma l'esperienza dei matrimoni misti può costituire essa stessa un<br />
dono e un'occasione per il movimento ecumenico e per le chiese?<br />
È possibile dare una risposta positiva sottolineando la dimensione profetica dei matrimoni<br />
interconfessionali.<br />
Individuare il significato profetico dei matrimoni misti in relazione al cammino del movimento<br />
ecumenico significa prima di tutto mettere in evidenza che la coppia e la famiglia interconfessionali<br />
rappresentano una comunità ecumenica, di fatto (e di diritto) esistente, non semplicemente sperata,<br />
con un proprio status ecclesiale, nonostante la diversità confessionale dei suoi componenti. È forse<br />
l'unica comunità ecumenica di cui le chiese, coinvolte nei dialoghi bilaterali, riconoscono lo statuto<br />
proprio, irriducibile ad una singola comunità ecclesiale.<br />
In questa prospettiva si potrebbe recuperare anche un'intuizione biblica circa l'interpretazione<br />
profetica del <strong>matrimonio</strong>, che è letto come immagine dell'alleanza 57 : restando fedeli al dato biblico<br />
il <strong>matrimonio</strong> potrebbe occupare un ruolo profetico non soltanto per quanto riguarda la relazione<br />
Dio-popolo e/o Cristo-chiesa (cioè il possibile aggancio sacramentale), ma anche in prospettiva<br />
ecumenica.<br />
Sarebbe troppo ardito parlare del <strong>matrimonio</strong> <strong>interconfessionale</strong> come di un «sacramento»<br />
ecumenico? Cioè come di un luogo in cui si fa carne quella koinonia fra le chiese che il movimento<br />
ecumenico cerca, ma non ha ancora realizzato?<br />
Se applicassimo a questa ipotesi la dottrina dell'indissolubilità del <strong>matrimonio</strong> risulterebbe che, dato<br />
il simbolismo coniugale, in forza della possibilità riconosciuta e valorizzata dai matrimoni<br />
interconfessionali, anche l'unione delle chiese è un fatto indissolubile, reale e già presente nella<br />
storia.<br />
<strong>Il</strong> <strong>matrimonio</strong> <strong>interconfessionale</strong> rappresenta, insomma, quella comunione reale, benché imperfetta,<br />
che unisce le chiese cristiane già oggi, in forza del vincolo della comune fede, al di là di quanto esse<br />
siano in grado imperfettamente, come del resto in ogni vicenda matrimoniale, di vivere e<br />
rappresentare l'unità che possiedono.<br />
55 Questa mi sembra l'ipotesi più coerente con i dialoghi ecumenici e in particolare con quanto affermato nella prima<br />
parte di questo intervento. Diversamente si dovrebbe tematizzare la divergenza nella prassi come esito di una<br />
radicale divergenza teologica, per cui i protestanti ammettono il divorzio perché non danno al <strong>matrimonio</strong> alcun<br />
significato religioso, mentre i cattolici non lo ammettono perché lo ritengono un sacramento, ma il risultato del<br />
confronto teologico, e la posizione ortodossa più sopra richiamata, sembra smentire questa seconda possibilità.<br />
56 D. Tettamanzi, <strong>Il</strong> Signore è vicino a chi ha il cuore ferito. Lettera agli sposi in situazione di separazione, divorzio e<br />
nuova unione, Centro Ambrosiano, Milano 2007.<br />
57 V. in particolare Osea e poi Geremia, Ezechiele e Isaia.
Nella comunità ecumenica, come nel <strong>matrimonio</strong>, i diversi convivono senza fondersi e le tensioni<br />
trovano un loro punto di equilibrio nella concreata dinamica della vita 58 .<br />
È proprio in forza di questa analogia che va, in conclusione, evidenziata l'urgenza di una teologia<br />
del <strong>matrimonio</strong> che restituisca la parola all'esperienza delle coppie cristiane, tanto più per i<br />
matrimoni interconfessionali, quindi una teologia che si ponga in ascolto della vita di queste realtà<br />
ormai numerosissime. L'elaborazione scientifica ha evidentemente un significato nella posizione<br />
delle problematiche e nell'esplorazione della dimensione storico-positiva del <strong>matrimonio</strong><br />
<strong>interconfessionale</strong>, ma anche la più documentata elaborazione sistematica non si può produrre, in<br />
modo significativo, senza la riflessione sull'esperienza.<br />
Questa riflessione non ha solo un significato pastorale o spirituale, ma anche conseguenze primarie<br />
per l'etica matrimoniale e per lo stesso aspetto dogmatico; la soluzione di rilevanti problemi<br />
dogmatici, ad esempio la questione del sacramento, anzi la stessa posizione del problema non può<br />
avvenire senza interrogarne il significato per le coppie che lo vivono, quindi, ad esempio, i<br />
movimenti interecclesiali di coppie.<br />
58 In questo senso anche la divisione fra le chiese rappresenta, come il fallimento delle vita matrimoniale, qualcosa<br />
che non è secondo il progetto di Dio, ma che va al limite accettato come situazione di emergenza e necessità di fatto,<br />
da interpretare però nella tensione verso una nuova e più sincera unità.
Appendice<br />
La normativa canonica del 1983<br />
I canoni sui matrimoni misti (cann. 1124-1129) costituiscono il VI Capitolo del titolo dedicato al<br />
<strong>matrimonio</strong> (Titolo VII) all’interno della prima parte del IV Libro – La funzione di santificare della<br />
Chiesa, del Codice di Diritto Canonico per la Chiesa cattolica di rito latino, promulgato da<br />
Giovanni Paolo II nel 1983 59 .<br />
Si tratta quindi di un numero di canoni assai ridotto, ma non per questo meno importanti, dato che<br />
la loro promulgazione costituisce il punto di arrivo di un cammino lungo e controverso.<br />
Diciamo subito che tale capitolo riguarda esclusivamente il “<strong>matrimonio</strong> fra due persone battezzate,<br />
delle quali ansia battezzata nella chiesa cattolico o in essa accolta dopo il battesimo…, l’altra sia<br />
invece iscritta ad una Chiesa o comunità ecclesiale non in piena comunione con la Chiesa<br />
cattolica…” (can. 1124), questa normativa non riguarda direttamente i cosiddetti matrimoni<br />
“dispari”, cioè quelli tra cattolici e non battezzati, che ricadono invece nei casi previsti dal can.<br />
1086 60 .<br />
Possiamo ora esaminare più da vicino i singoli canoni che costituiscono il capitolo VI – I matrimoni<br />
misti.<br />
Can. 1124 – <strong>Il</strong> <strong>matrimonio</strong> fra due persone battezzate, delle quali una sia battezzata nella<br />
Chiesa cattolica o in essa accolta dopo il battesimo e non separata dalla medesima con atto<br />
formale, l’altra invece sia iscritta a una Chiesa o comunità ecclesiale non in piena comunione<br />
con la Chiesa cattolica, non può essere celebrato senza espressa licenza della competente<br />
autorità.<br />
<strong>Il</strong> canone 1124 esplicita la definizione di <strong>matrimonio</strong> misto, come patto coniugale che sussiste fra<br />
due battezzati, anche là dove uno di essi non appartenga alla chiesa cattolica. La presenza di un<br />
battesimo riconosciuto fa quindi, di questo <strong>matrimonio</strong>, un <strong>matrimonio</strong> valido e pienamente<br />
sacramentale, dal punto di vista cattolico 61 , in forza della comunione che esista di fatto, per quanto<br />
non pienamente, fra i due partner, dal punto di vista ecclesiale.<br />
Lo stesso canone specifica che tale <strong>matrimonio</strong> può essere celebrato solo dietro concessione di una<br />
“espressa licenza della competente autorità”.<br />
È interessante soffermasi pure sull’istituto della licenza, in questa situazione particolare.<br />
<strong>Il</strong> codice del 1917 non distingueva canonicamente i matrimoni misti fra battezzati (quelli che<br />
ricadevano sotto l’impedimento cosiddetto di mixta religio) e quelli interreligiosi (che ricadevano<br />
sotto l’impedimento di disparitas cultus); nella codificazione post-conciliare solo i secondi sono<br />
ancora gravati da un impedimento 62 , cioè da un vincolo normativo che di per sé rende invalido il<br />
<strong>matrimonio</strong>, laddove non se ne sia ottenuta la dispensa. I matrimoni misti fra battezzati richiedono<br />
invece una specifica autorizzazione che va sotto il nome di licenza e che si differenzia per statuto<br />
giuridico dall’impedimento:<br />
• essa, prima di tutto, riguarda il ministro chiamato ad assistere alla celebrazione del<br />
<strong>matrimonio</strong> piuttosto che i nubendi stessi;<br />
• in secondo luogo è un atto che va compiuto nella preparazione al <strong>matrimonio</strong> e non un<br />
59 Con la Costituzione apostolica Sacrae disciplinae leges del 25gennaio 1983.<br />
60 Anche se lo stesso canone rinvia alla normativa sui matrimoni misti (cann. 1125s) per gli adempimenti da compiere<br />
in questi casi.<br />
61 Can. 1055 - §1. <strong>Il</strong> patto matrimoniale con cui l'uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, per<br />
sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla procreazione e educazione della prole, tra i battezzati è stato elevato da<br />
Cristo Signore alla dignità di sacramento. §2. Pertanto tra i battezzati non può sussistere un valido contratto<br />
matrimoniale, che non sia per ciò stesso sacramento.<br />
62 Can. 1086 - §1. È invalido il <strong>matrimonio</strong> tra due persone, di cui una sia battezzata nella Chiesa cattolica o in essa<br />
accolta e non separata dalla medesima con atto formale, e l'altra non battezzata.
elemento che si pone come dirimente rispetto al <strong>matrimonio</strong> 63 ;<br />
• in terzo luogo la licenza per i matrimoni misti ricade all’interno di una casistica più ampia,<br />
contenuta nel can. 1071 e che si configura come atto di particolare attenzione da parte<br />
dell’autorità ecclesiastica verso quei matrimoni in cui la peculiarità della situazione degli<br />
sposi richiede un supplemento di discernimento ed attenzione pastorale nei confronti del<br />
possibile successo della futura vita matrimoniale 64 ;<br />
• in quarto luogo la stessa collocazione in uno specifico capitolo, distinto da quello<br />
riguardante gli impedimenti 65 , conferma la diversa natura giuridica di questo peculiare<br />
istituto.<br />
Non si può evitare la considerazione che il cammino ecumenico compiuto dalla Chiesa cattolica a<br />
partire dal Concilio Vaticano II, con il riconoscimento della comunione reale ma imperfetta fra le<br />
stessa Chiesa cattolica e le altre comunione cristiane, abbia consentito una conversione anche<br />
dell’approccio giuridico a questi matrimoni, che rientrano ormai fra i casi normali della pastorale<br />
matrimoniale ed ecumenica e possono essere visti con maggiore favore e minore diffidenza.<br />
Can. 1125 – L’Ordinario del luogo, se vi è una causa giusta e ragionevole, può concedere<br />
tale licenza; ma non la conceda se non dopo il compimento delle seguenti condizioni: 1) la<br />
parte cattolica si dichiari pronta ad allontanare i pericoli di abbandonare la fede e prometta<br />
sinceramente di fare quanto è in suo potere perché tutti i figli siano battezzati ed educati<br />
nella Chiesa cattolica; 2) di queste promesse che deve fare la parte cattolica, sia<br />
tempestivamente informata l’altra parte, così che consti che questa è realmente consapevole<br />
della promessa e dell’obbligo della parte cattolica; 3) entrambe le parti siano istruite sui fini e<br />
le proprietà essenziali del <strong>matrimonio</strong>, che non devono essere esclusi da nessuno dei due<br />
contraenti.<br />
<strong>Il</strong> canone 1125 racchiude tre importanti indicazioni:<br />
• affida all’Ordinario del luogo la competenza di concedere la licenza,<br />
• evidenzia la necessità di una causa giusta e ragionevole per tale concessione,<br />
• individua alcune condizioni previe alla concessione della licenza.<br />
<strong>Il</strong> trasferimento all’Ordinario locale del titolo a concedere la licenza va sottoposto ad una<br />
duplice letture, ecclesiologica e pastorale.<br />
Dal punto di vista ecclesiologico ciò evidenzia la rivalutazione del ruolo dei vescovi, come autentici<br />
leader delle loro chiese locali e non semplici delegati della potestà papale; dal punto di vista<br />
pastorale evidenzia come sia possibile a chi vive la concreta situazione locale emettere un giudizio<br />
adeguato sulla richiesta in oggetto.<br />
La causa “giusta e ragionevole” si distingue sufficientemente da quella “grave” richiesta<br />
dalla normativa del 1917. <strong>Il</strong> codice non specifica cosa si intenda per tale causa, ma essa va<br />
interpretata nel contesto generale delle condizioni che consentono la celebrazione del <strong>matrimonio</strong> e<br />
dei suoi fini. Per cui si dovrebbe presumere che essa non riguardi solo condizioni materiali (la<br />
difficoltà a incontrare un potenziale partner cattolico in un territorio di minoranza per i cattolici o<br />
l’opportunità di sanare un’unione illegittima), ma anche quelle spirituali (l’esistenza di un<br />
consolidato e consapevole progetto di vita matrimoniale, che tenga conto della peculiarità della<br />
condizione di una coppia e famiglia mista).<br />
Anche la terza condizione merita un approfondito esame, dato che essa richiama le<br />
cautiones presenti nella normativa precedente.<br />
<strong>Il</strong> can. 1125 parla ora esplicitamente di condizioni e ne elenca con precisione tre:<br />
• la prima riguarda il partner cattolico a cui è richiesto, in continuità con la normativa<br />
63 Ciò nonostante l’originale latino affermi che tale <strong>matrimonio</strong> “sine espressa auctoritatis competentis licentia<br />
prohibitum est” (can. 1124). È da notare che il canone dice appunto “prohibitum” e non “invalidum”, come nel caso<br />
del <strong>matrimonio</strong> “dispari” (v. can. 1086 §1), dal che deriverebbe che un cattolico che si unisse in <strong>matrimonio</strong> ad un<br />
partner non-cattolico senza licenza compirebbe un atto illecito, ma di per sé non nullo.<br />
64 La condizione della licenza può quindi essere ritenuta un atto che esprime l’esigenza di una particolare cura<br />
pastorale di questi matrimoni, come appare anche dai canoni seguenti.<br />
65 Capitolo III, in cui rientra anche il canone 1086 sui matrimoni fra battezzati e non-battezzati.
precedente, di dichiarare l’intenzione di allontanare i pericoli di abbandonare la fede e, con<br />
significativa innovazione, di “promettere sinceramente di fare quanto è in suo potere perché<br />
tutti i figli siano battezzati ed educati nella Chiesa cattolica”. La dichiarazione e la promessa<br />
chieste al partner cattolico implicano che egli sia consapevole che la peculiare condizione<br />
matrimoniale a cui accederà non deve costituire un elemento che porti all’indifferentismo<br />
nei confronti della fede cattolica, ma che in essa è tenuto a mantenere con coerenza la<br />
propria appartenenza ecclesiale, anche per quanto riguarda i suoi doveri educativi nei<br />
confronti dei figli. <strong>Il</strong> Codice riconosce però che tale dovere educativo è solo relativo (se<br />
omnia pro viribus facturam esse), relativo alla condizione di una coppia mista in cui anche il<br />
partner può trovarsi vincolato da un’analoga esigenza. È quindi notevole che per quanto<br />
riguarda questo nulla venga più chiesto al partner non cattolico, in sintonia con quanto<br />
affermato nella dichiarazione conciliare sulla libertà religiosa 66 .<br />
• La seconda condizione riguarda il partner non cattolico, nella forma di una comunicazione<br />
tempestiva di quanto la parte cattolica ha promesso. È interessante notare come il Codice,<br />
non imponendo alcuna dichiarazione alla parte non cattolica, richieda per essa una reale<br />
consapevolezza (vere consciam) di quanto la parte cattolica ha promesso: la chiarezza nei<br />
confronti delle rispettive posizioni ecclesiali è una condizione per la fruttuosa celebrazione<br />
di un matrimoni misto.<br />
• La terza condizione riguarda entrambe le parti, ma essa non si distingue per nulla in ciò che<br />
viene chiesto ai partner di un <strong>matrimonio</strong> cattolico 67 .<br />
Can. 1126 – Spetta alla conferenza Episcopale sia stabilire il modo in cui devono essere fatte<br />
tali dichiarazioni e promesse, sempre necessarie, sia determinare la forma per cui di esse<br />
consti nel foro esterno e la parte non cattolica ne sia informata.<br />
<strong>Il</strong> canone 1126 chiama in causa un nuovo importante attore, cioè le Conferenze episcopali. Anche in<br />
questo caso ci possiamo riferire alla rivoluzione ecclesiologia del Vaticano II, che viene qui<br />
interpretata con particolare attenzione ai risvolti pastorali di quello che è uno dei momenti più<br />
delicati nella celebrazione di un <strong>matrimonio</strong> misto, appunto devono essere organizzate la prima e la<br />
seconda condizione per la concessione della licenza 68 . Non è casuale che ad un organismo di<br />
comunione fra chiese particolari omogenee per territorio e cultura venga demandato il compito di<br />
definire i modi in cui le dichiarazioni e promesse devono essere fatte e le forme della loro<br />
comunicazione al partner non cattolico. Una felice recezione di questo principio è riscontrabile<br />
nell’ingente numero di dialoghi intessuti sia a livello internazionale che locale fra la chiesa<br />
cattoliche e la altre comunità cristiane sul tema dei matrimoni misti, alla ricerca di modalità<br />
condivise non solo per la celebrazione dei matrimoni misti, ma per la stessa comprensione del<br />
<strong>matrimonio</strong> cristiano 69 .<br />
Can. 1127 - §1. Relativamente alla forma da usare nel <strong>matrimonio</strong> misto, si osservino le<br />
disposizioni del can. 1108; se tuttavia la parte cattolica contrae <strong>matrimonio</strong> con una parte<br />
66 DH 5: “5Ad ogni famiglia -società che gode di un diritto proprio e primordiale- compete il diritto di ordinare<br />
liberamente la propria vita religiosa domestica sotto la direzione dei genitori. A questi spetta il diritto di determinare<br />
l'educazione religiosa da impartire ai propri figli secondo la propria persuasione religiosa. Quindi deve essere dalla<br />
potestà civile riconosciuto ai genitori il diritto di scegliere, con vera libertà, le scuole e gli altri mezzi di educazione,<br />
e per una tale libertà di scelta non debbono essere gravati, né direttamente né indirettamente, da oneri ingiusti.<br />
Inoltre i diritti dei genitori sono violati se i figli sono costretti a frequentare lezioni scolastiche che non<br />
corrispondono alla persuasione religiosa dei genitori, o se viene imposta un'unica forma di educazione dalla quale<br />
sia esclusa ogni formazione religiosa”.<br />
67 E cioè l’accertamento che le parti condividano le proprietà essenziali del <strong>matrimonio</strong>, come indicate nel can. 1056<br />
(Le proprietà essenziali del <strong>matrimonio</strong> sono l'unità e l'indissolubilità, che nel <strong>matrimonio</strong> cristiano conseguono una<br />
peculiare stabilità in ragione del sacramento) e non escludano positivamente la possibilità di avere prole.<br />
68 V. anche J.T.M. De Agar, Le competenze della Conferenza episcopale, in Aa.Vv., I matrimoni misti, Libreria<br />
Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1998, pp. 139-157.<br />
69 Per l’area italiana il riferimento obbligato è naturalmente al doppio documento del 1997 - 2000 Conferenza<br />
episcopale italiana–Chiesa evangelica valdese, I matrimoni miti tra cattolici e valdesi o metodisti in <strong>It</strong>alia, Elledici-<br />
Claudiana, Torino 2001.
non cattolica di rito orientale, l’osservanza della forma canonica della celebrazione è<br />
necessaria solo per la liceità; per la validità, invece, si richiede l’intervento di un ministro<br />
sacro, salvo quant’altro è da osservarsi a norma del diritto.<br />
§2. Qualora gravi difficoltà si oppongano alla osservanza della forma canonica, l’Ordinario del<br />
luogo della parte cattolica ha il diritto di dispensare da essa in singoli casi, previa<br />
consultazione, però, dell’Ordinario del luogo in cui viene celebrato il <strong>matrimonio</strong>, e salva, per<br />
la validità, una qualche forma pubblica di celebrazione; spetta alla Conferenza Episcopale<br />
stabilire norme per le quali la predetta dispensa venga concessa per uguali motivazioni.<br />
§3. È vietato, sia prima sia dopo la celebrazione canonica a norma del §1, dar luogo a<br />
un’altra celebrazione religiosa del medesimo <strong>matrimonio</strong> nella quale si dia o si rinnovi il<br />
consenso matrimoniale; parimenti non si deve fare una celebrazione religiosa in cui<br />
l’assistente cattolico e il ministro non cattolico, celebrando ciascuno il proprio rito, richiedano<br />
insieme il consenso delle parti.<br />
<strong>Il</strong> canone 1127 affronta globalmente il tema della celebrazione dei matrimoni misti fra battezzati.<br />
Esso va letto in sinergia con il can. 1108, che viene citato nel § 1, e con il can. 1118 70 .<br />
<strong>Il</strong> § 1 contiene prima di tutto una norma generale e poi una indicazione particolare.<br />
La norma generale fa riferimento appunto al canone 1108, che prescrive generalmente la forma<br />
canonica per la valida celebrazione di un <strong>matrimonio</strong>; esso continua la tradizione normativa<br />
instaurata dal decreto Tametsi. In questo senso i matrimoni misti non sono sottoposti ad alcuna<br />
eccezione generale rispetto a matrimoni fra cattolici. L’indicazione particolare, che recepisce<br />
quanto già indicato dal decreto Crescens <strong>matrimonio</strong>rum (1967) riguarda il caso del <strong>matrimonio</strong> fra<br />
cattolici e cristiani di rito orientale, <strong>matrimonio</strong> che avviene di norma in una celebrazione non<br />
cattolica 71 e che è riconosciuto, ipso facto, valido, anche laddove non si ottemperi la forma<br />
canonica. Dietro a tale disposizione sta, da una parte, il riconoscimento della validità del ministero<br />
delle chiese ortodosse ed orientali, dall’altra la volontà di non mettere in condizioni di particolare<br />
difficoltà i partner cattolici di matrimoni misti con coniugi ortodossi o orientali.<br />
<strong>Il</strong> §2 introduce la possibilità di una dispensa dalla forma canonica del <strong>matrimonio</strong>, “qualora<br />
gravi difficoltà si oppongano”. Gli attori di tale facoltà sono, ancora una volta in sinergia, il vescovo<br />
locale, a cui spetta la concessione della dispensa, e la Conferenza episcopale, chiamata a legiferare<br />
sulle norme di concessione e sulle motivazioni. Anche in questo caso il Codice non specifica la<br />
natura delle gravi difficoltà, ma lascia alla competenza della Conferenze episcopali il compito di<br />
individuare i criteri a partire dai quali tale dispensa può essere concessa, criteri che possono quindi<br />
differenziarsi da luogo a luogo. Va pure notato come il canone preveda comunque l’esigenza di una<br />
qualche pubblicità nella forma celebrativa, che ne sancisca giuridicamente l’avvenuta celebrazione.<br />
<strong>Il</strong> § 3 affronta il delicato problema posto dalla ipotesi di una doppia celebrazione. Essa è<br />
esplicitamente proibita, sia nel caso il <strong>matrimonio</strong> sia avvenuto in forma canonica che in altra<br />
forma, quando questa seconda celebrazione preveda un rinnovo del consenso. Dato che, nella<br />
concezione teologia latina, sono gli sposi i ministri del <strong>matrimonio</strong> e lo scambio pubblico del<br />
70 Can. 1108 - §1. Sono validi soltanto i matrimoni che si contraggono alla presenza dell'Ordinario del luogo o del<br />
parroco o del sacerdote oppure diacono delegato da uno di essi che sono assistenti, nonché alla presenza di due<br />
testimoni, conformemente, tuttavia, alle norme stabilite nei canoni seguenti, e salve le eccezioni di cui ai cann. 144,<br />
1112, §1, 1116 e 1127, §§2-3. §2. Si intende assistente al <strong>matrimonio</strong> soltanto colui che, di persona, chiede la<br />
manifestazione del consenso dei contraenti e la riceve in nome della Chiesa.<br />
Can. 1118 - §1. <strong>Il</strong> <strong>matrimonio</strong> tra cattolici o tra una parte cattolica e l'altra non cattolica battezzata sia celebrato nella<br />
chiesa parrocchiale; con il permesso dell'Ordinario del luogo o del parroco potrà essere celebrato in altra chiesa o<br />
oratorio. §2. L'Ordinario del luogo può permettere che il <strong>matrimonio</strong> sia celebrato in altro luogo conveniente. §3. <strong>Il</strong><br />
<strong>matrimonio</strong> tra una parte cattolica e l'altra non battezzata potrà essere celebrato in chiesa o in un altro luogo<br />
conveniente.<br />
71 A causa del fatto che le Chiese ortodosse, diversamente da quelle di tradizione latina, identificano nel sacerdote, e<br />
non negli sposi, il ministro del <strong>matrimonio</strong>, non riconoscendo dunque i matrimoni celebrati secondo la forma<br />
canonica latina.
consenso sancisce il patto matrimoniale, anche nella sua sostanza sacramentale, sarebbe insensato<br />
che esso venisse ripetuto una seconda volta, perché ciò porterebbe a far ritenere che vi fosse un<br />
dubbio riguardo alla prima espressione del consenso. È importante notare che tale indicazione vale<br />
anche laddove il <strong>matrimonio</strong> sia avvenuto in forma non canonica: la scambio pubblico del consenso<br />
sembra godere il favore del diritto rispetto alla forma in cui esso viene prestato.<br />
Dalla medesima esigenza è pure motivato il secondo divieto del § 3, che impone di non procedere<br />
ad alcuna inter-celebrazione del <strong>matrimonio</strong>: non si dà quindi possibilità di celebrare un <strong>matrimonio</strong><br />
“ecumenico”, ma gli sposi sono invitati a scegliere con chiarezza il luogo e la forma celebrativa<br />
dello stesso (anche tramite l’istituto dell’eventuale dispensa dalla forma canonica) che non potrà<br />
non essere che quella di una delle due comunità di appartenenza dei partner. <strong>Il</strong> canone non vieta<br />
però che al rito, comunque celebrato, possa essere presente e possa partecipare il ministro dell’altra<br />
comunità, come diversi accordi ecumenici a livello locale prevedono.<br />
Can. 1128 – Gli Ordinari del luogo e gli altri pastori d’anime facciano in modo che al coniuge<br />
cattolico e ai figli nati da <strong>matrimonio</strong> misto non manchi l’aiuto spirituale per adempiere i loro<br />
obblighi, e aiutino i coniugi ad accrescere l’unione della vita coniugale e familiare.<br />
<strong>Il</strong> can. 1128, che rappresenta un’autentica novità rispetto all’impostazione del precedente CIC, è di<br />
indole squisitamente pastorale. Anche in questo caso sono da tener presenti due indicazioni<br />
convergenti ma distinte:<br />
nella prima si fa carico ai pastori d’anime di prestare al coniuge cattolico e agli eventuali figli di un<br />
<strong>matrimonio</strong> misto quella assistenza spirituale che è necessaria in relazione a quanto contenuto nella<br />
dichiarazione e nella promessa da questi prestata a norma del can. 1125 § 3;<br />
nella seconda l’oggetto dell’attenzione pastorale sono entrambe i coniugi, non solo quello cattolico,<br />
e l’obiettivo è la promozione dell’unità nella vita coniugale e familiare (ad vitae coniugalis et<br />
familiaris fovendam unitatem)<br />
Potremmo osservare che il canone prescrive ai pastori l’esigenza di non abbandonare le coppie e le<br />
famiglie miste al momento della celebrazione del <strong>matrimonio</strong>, ma impone di farne oggetto di una<br />
specifica cura pastorale, che sembra andare da un minimo (la cura per le parti cattoliche di una<br />
famiglia mista) ad un massimo, l’attenzione pastorale all’intera famiglia <strong>interconfessionale</strong>. In<br />
questo secondo caso l’attenzione pastorale assume un tono realmente ecumenico dato che i pastori<br />
cattolici sono chiamati a promuovere l’unità di quella peculiare realtà ecumenica che è una famiglia<br />
<strong>interconfessionale</strong>: la cura pastorale esce quindi dai limiti di una attenzione al proprio “gregge”, per<br />
farsi promotrice del carisma peculiare delle famiglie interconfessionali. È una importante<br />
indicazione normativa circa l’esigenza di una autentica pastorale ecumenica.<br />
Can. 1129 – Le disposizioni dei cann. 1127 e 1128 si devono applicare anche ai matrimoni ai<br />
quali si oppone l’impedimento di disparità di culto, di cui al can. 1086, §1.<br />
<strong>Il</strong> can. 1129 costituisce un riferimento circolare al can. 1086, che riguarda l’impedimento per<br />
“disparitas cultus”, cioè i matrimoni interreligiosi. Esso dispone che le indicazioni normative dei<br />
cann. 1127 e 1128 vengano applicate anche in questi casi, pur mutando la fattispecie giuridica di<br />
questi matrimoni.<br />
Se vogliamo tentare di cogliere in prospettiva unitaria lo spirito di questo apparato normativo penso<br />
che sia possibile fare una duplice considerazione:<br />
● da una parte il capitolo VI del titolo sul <strong>matrimonio</strong> costituisce certamente il punto di arrivo di un<br />
lungo percorso della chiesa cattolica, non solo da un punto di vista giuridico, ma soprattutto<br />
pastorale e teologico, che potremmo riassumere come un cammino che va dalla diffidenza<br />
all’accoglienza prudente. Se la chiesa cattolica ha sentito, fino al Vaticano II, di doversi difendere<br />
dai pericoli rappresentati dai matrimoni misti, ora, in forza del doppio contributo fornito dalla<br />
partecipazione al movimento ecumenico e dalla recezione del principio della libertà religiosa, tale<br />
atteggiamento si è convertito in una prudente accoglienza di questa realtà ormai diffusa e<br />
irreversibile. In questo senso complessivo, accoglienza prudente, mi pare possa essere interpretato il
complesso normativo sui matrimoni misti per come è esposto nei canoni che abbiamo analizzato.<br />
● Se prendiamo, però, il Codice del 1983 in rapporto non solo alla storia che lo precede, ma alla sua<br />
recezione successiva e alla storia dei suoi effetti 72 , e cioè all’evoluzione che la prassi dei matrimoni<br />
misti ha subito nel ventennio successivo alla promulgazione del Codice, potremmo parlare di un<br />
ulteriore cammino da un’accoglienza prudente a un’accoglienza piena. Non è la normativa<br />
canonica generale che testimonia questa ulteriore evoluzione, quanto piuttosto quella serie di<br />
dialoghi locali che, sfruttando le aperture previste dalla normativa 73 , mostrano nel complesso una<br />
positiva accoglienza della realtà delle famiglie miste sia dal punto di vista normativo che nella<br />
valorizzazione del loro inequivocabile carisma di “laboratorio” ecumenico.<br />
72 Non possiamo non far entrare in gioco, inevitabilmente, le categorie ermeneutiche in questo caso.<br />
73 Sui dialoghi fra le chiese in tema di <strong>matrimonio</strong> si può vedere P. <strong>Sgroi</strong>, I matrimoni interconfessionali, sfida e risorsa<br />
per le chiese. Verso una teologia ecumenica del <strong>matrimonio</strong>, in Quaderni di Studi Ecumenici n. 9 (2004), pp. 138-216.