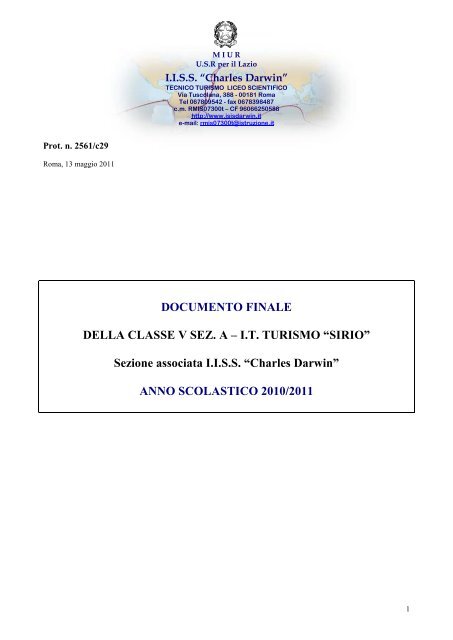Documento sezione a - IISS Darwin
Documento sezione a - IISS Darwin
Documento sezione a - IISS Darwin
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Prot. n. 2561/c29<br />
Roma, 13 maggio 2011<br />
M I U R<br />
U.S.R per il Lazio<br />
I.I.S.S. “Charles <strong>Darwin</strong>”<br />
TECNICO TURISMO LICEO SCIENTIFICO<br />
Via Tuscolana, 388 - 00181 Roma<br />
Tel 067809542 - fax 0678398487<br />
c.m. RMIS07300t – CF 96066250588<br />
http://www.isisdarwin.it<br />
e-mail: rmis07300t@istruzione.it<br />
DOCUMENTO FINALE<br />
DELLA CLASSE V SEZ. A – I.T. TURISMO “SIRIO”<br />
Sezione associata I.I.S.S. “Charles <strong>Darwin</strong>”<br />
ANNO SCOLASTICO 2010/2011<br />
1
INDICE<br />
Scheda<br />
Il Progetto Sirio nel Turistico 1<br />
Profilo d’indirizzo 2<br />
Presentazione della classe 3<br />
Elenco alunni 4<br />
Composizione del Consiglio di Classe 5<br />
Criteri metodologici e valutativi 6<br />
Attività svolte nel Triennio 7<br />
Schede per singole materie 8<br />
Programmi svolti 9<br />
Simulazione di prima prova effettuata 10<br />
Simulazione di seconda prova effettuata 11<br />
Simulazione di terza prova effettuata 12<br />
Griglie di correzione 13<br />
Firme e qualifiche docenti 14<br />
2
Scheda n° 1<br />
IL PROGETTO SIRIO NEL TURISTICO<br />
I profondi cambiamenti determinatisi nella società contemporanea richiedono che anche il sistema<br />
formativo si trasformi, passando dall‘attuale struttura rigida ad una più decentrata e flessibile che<br />
risponda ai bisogni di coloro che intendono rientrare nel sistema formativo, organizzando forme di<br />
intervento per il recupero delle carenze nella formazione di base per la riconversione professionale e<br />
per l‘educazione permanente (EDA).<br />
Il Progetto Assistito SIRIO si inserisce in questo contesto formativo, onde offrire a un‘utenza<br />
adulta occasioni di promozione socio-culturale e stimolare la ripresa degli studi per migliorare<br />
l‘inserimento nel mondo del lavoro.<br />
L‘indirizzo turistico nell‘ambito del Progetto Assistito SIRIO è nato nel 1999 dalla considerazione<br />
che il settore del turismo coinvolge un numero crescente di persone ( sia come addetti che come<br />
utenti ) e che, particolarmente in Italia, esso rappresenta un‘attività economica e culturale di tutto<br />
rilievo la quale necessita, per il suo funzionamento e per un corretto sviluppo, di personale<br />
preparato non solo a livello esecutivo, ma anche in compiti di coordinamento e promozione<br />
intermedia. Tale Progetto, pertanto, che prevede il conseguimento del diploma di perito turistico,<br />
intende fornire un massimo di ―cultura turistica‖ ed un minimo di ―competenze esecutive"<br />
offrendo:<br />
formazione culturale generale<br />
obiettivo comune a tutta l'istruzione secondaria superiore<br />
competenza linguistica e comunicativa<br />
intesa come strumento di interscambio pratico, ma anche come mezzo per comprendere, con la<br />
lingua, la "cultura" dei viaggiatori stranieri, le loro aspettative, i loro bisogni, ecc….<br />
competenza professionale<br />
intesa come la capacità di gestire una piccola o media azienda turistica in modo attuale ed<br />
efficace, anche in rapporto alla multiforme normativa di settore, italiana ed europea, che<br />
influenza in misura crescente la vita delle aziende turistiche.<br />
Il Progetto Sirio differisce dai curricoli istituzionali tanto da connotarsi come vera e propria<br />
"seconda via" all‘istruzione, e si caratterizza, come nei settori citati, per:<br />
- la riduzione dell‘orario settimanale delle lezioni;<br />
- il riconoscimento di crediti formativi;<br />
- il tutoring e le metodologie didattiche tendenti a valorizzare le esperienze culturali e<br />
professionali degli studenti.<br />
Il sistema formativo degli adulti, infatti, deve assolvere due funzioni:<br />
qualificare giovani e adulti privi di professionalità aggiornata;<br />
consentire la riconversione professionale di coloro che, già inseriti in ambito lavorativo,<br />
intendano riconvertire la propria identità professionale.<br />
L‘idea-forza di questo Progetto consiste, quindi, in un percorso flessibile che valorizzi l‘esperienza<br />
di cui sono portatori i soggetti e che si fondi sull‘approccio al sapere in età adulta e<br />
sull‘integrazione delle competenze relative alla cultura generale e alla formazione professionale.<br />
3
La flessibilità riguarda:<br />
a) l'orario delle lezioni;<br />
b) il calendario scolastico;<br />
c) la possibilità di aggregazione degli studenti in gruppi scolastici per livelli di padronanza dei<br />
saperi riferiti alle diverse materie, superando la comune nozione di classe mediante l‘adozione<br />
di percorsi scolastici individualizzati;<br />
d) le valutazioni periodiche, che utilizzano il voto unico per tutte le discipline.<br />
CONOSCENZE<br />
CAPACITA‘<br />
COMPETENZE<br />
Scheda n° 2<br />
PROFILO D’INDIRIZZO<br />
Adeguata formazione culturale generale nel settore umanistico e<br />
tecnico professionale, solida preparazione linguistica e<br />
comunicativa.<br />
Il diplomato deve essere capace di progettare, organizzare,<br />
promuovere e vendere servizi turistici sia in Italia che all'Estero.<br />
Il diplomato opera nel settore della produzione,<br />
commercializzazione ed effettuazione dei servizi turistici,<br />
all‘interno di aziende private e di enti pubblici. Si occupa sia di<br />
turismo di accoglienza, sia di turismo di uscita, in Italia ed<br />
all‘Estero, con particolare riguardo ai Paesi Europei e del Bacino<br />
del Mediterraneo<br />
4
Scheda n° 3<br />
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE<br />
Composizione della classe<br />
La classe Va Sirio risulta composta da 17 studenti e si presenta eterogenea per<br />
provenienza geografica e percorso scolastico effettuato. Sono presenti elementi<br />
interni sin dal biennio o comunque provenienti dalla 4^ dello scorso anno, altri<br />
acquisiti alla 5^A per colloquio di accertamento delle competenze e provenienti da<br />
altri istituti. Nel gruppo classe nel corso dell‘anno si è instaurato un clima di<br />
collaborazione; gli studenti hanno dimostrato affiatamento e coesione.<br />
Andamento didattico-disciplinare<br />
La classe VA Sirio si presenta eterogenea sia per livello di preparazione che per<br />
partecipazione a causa soprattutto degli obblighi lavorativi degli studenti che<br />
condizionano spesso i tempi e l‘impegno scolastico.<br />
Nonostante questo dato la maggior parte della classe ha seguito le lezioni con<br />
costanza, partecipando vivacemente alle attività didattiche e svolgendo puntualmente<br />
le verifiche.<br />
Il gruppo di corsisti che ha partecipato in modo più assiduo al dialogo educativo<br />
evidenziando un notevole impegno, ha ottenuto risultati generalmente positivi e in<br />
qualche caso decisamente buoni.<br />
Studenti lavoratori<br />
Quasi tutti gli studenti svolgono un‘attività lavorativa, spesso caratterizzata dalla<br />
precarietà, dagli orari su turni e dalla non regolarità delle condizioni d‘impiego.<br />
E‘ opportuno sottolineare che tale status incide non poco sulla frequenza e<br />
sull‘impegno scolastico penalizzando a volte notevolmente i risultati<br />
5
Scheda n° 4<br />
ELENCO CORSISTI VA Sirio<br />
N° CORSISTI<br />
1 CAPONE ROBERTO<br />
2 CIOBANU TATIANA<br />
3 CLEMENTE GLORIA<br />
4 COLABUCCI VALENTINA<br />
5 DODDI CARLO<br />
6 FORMICA JESSICA<br />
7 FRANCO CAROLINA<br />
8 GAUDIOSO AGNESE<br />
9 GHAZOINI EL HASSANIA<br />
10 GHAZOINI SARA<br />
11 GIANCOLA DAVIDE<br />
12 JOCSON JOEL DE LOS REYES<br />
13 MORNERI MARTINA<br />
14 OLARU GEORGIANA<br />
15 SAVOIA EMANUELE<br />
16 TOMEI JESSICA<br />
17 TOMEI SIMONE<br />
6
DOCENTE<br />
Scheda n° 5<br />
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE<br />
DISCIPLINA INSEGNATA<br />
CONTINUITÀ<br />
DIDATTICA<br />
3° 4°<br />
ALFONSI LUCIA Italiano e Storia Sì Sì<br />
FAILLA GAETANO Arte e territorio NO NO<br />
GATTI BERNARDINO Lingua Inglese Teoria Sì Sì<br />
DESIATO FILOMENA Lingua Inglese Conversazione Sì Sì<br />
PRATESI FRANCESCA Lingua Francese Teoria Sì Sì<br />
QUINET EMILIE Lingua Francese Conversazione NO Sì<br />
PISANI ANNA Lingua Spagnola Teoria NO Sì<br />
HUARCAYA LUZ Lingua Spagnola Conversazione NO NO<br />
RUSSO MARIA Matematica e informatica Sì Sì<br />
SANTILLI GIUSEPPE Discipline Aziendali e Turistiche Sì Sì<br />
CARACUZZO<br />
GIANCARLO<br />
Diritto/Econ. Politica NO NO<br />
SANTILLI FELICE Geografia Turistica NO NO<br />
7
CRITERI METODOLOGICI<br />
Scheda n° 6<br />
CRITERI METODOLOGICI E VALUTATIVI<br />
Gli interventi didattici sono stati tesi a creare nella classe un clima di fiducia riguardo<br />
alla possibilità di riuscita e di successo, tenendo conto del vissuto degli studenti oltre<br />
che dei loro ritmi e stili di apprendimento. Si è cercato, laddove possibile, di<br />
valorizzare le esperienze umane, culturali e professionali degli studenti, motivandoli<br />
alla partecipazione e allo studio attraverso la chiara indicazione di traguardi<br />
raggiungibili e di compiti realizzabili.<br />
Assumendo la cooperazione come stile relazionale e modalità di lavoro, sono state<br />
favorite attività di ricerca e di studio in gruppo incoraggiando le strategie di problem<br />
solving quali le più consone allo stile di apprendimento degli adulti.<br />
Ampio spazio è stato dedicato alla preparazione di uscite sul territorio.<br />
VERIFICA E VALUTAZIONE<br />
La verifica degli apprendimenti è avvenuta tenendo conto delle esigenze lavorative<br />
espresse dai singoli , concordando i tempi e le modalità di verifica a coloro i quali<br />
non potevano frequentare regolarmente.<br />
La valutazione formativa ha avuto lo scopo di accertare i progressi e di predisporre<br />
interventi in caso di scostamento tra risultati e obiettivi per adeguare metodi, tecniche<br />
e strumenti.<br />
La valutazione sommativa, come stabilito nel Patto Formativo, ha tenuto conto dei<br />
seguenti indicatori:<br />
- l‘impegno e la partecipazione al dialogo;<br />
- il profitto<br />
- le capacità manifestate (capacità di analisi, di sintesi, ecc.);<br />
Per ogni studente, inoltre, sono stati considerati i comportamenti assunti e la qualità<br />
raggiunta nella realizzazione di lavori e progetti di gruppo.<br />
8
Scheda n° 7<br />
ATTIVITA‘ SVOLTE NEL PRESENTE ANNO SCOLASTICO<br />
TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DATA DURATA<br />
Proiezioni<br />
cinematografi<br />
che<br />
The Tourist Cinema Trianon 22 Dicembre 2010 2 ore<br />
La donna che canta Cinema Quattro Fontane 8 febbraio 2011 3 ore<br />
Habemus Papam Cinema Maestoso 20 Aprile 2011 3 ore<br />
Arte Itinerario archeologico nella<br />
Roma antica: Colosseo, Foro<br />
e Pantheon<br />
Mostra: i 100 capolavori<br />
dell‘Espressionismo<br />
Roma 7 Maggio 2011 3 ore<br />
Roma 14 Maggio 2011 3 ore<br />
Teatro Il Berretto a sonagli Roma 2 Marzo 2011 3 ore<br />
Conferenze Settimana della Storia Roma, Ara Pacis 3-5-6 Novembre<br />
2010.<br />
Programma TV Le storie, Rai 3 Roma, studi DEAR 31 Marzo 2011 3 ore.<br />
3 ore ciascuna<br />
conferenza.<br />
9
Scheda n° 8<br />
SCHEDA PER SINGOLA MATERIA<br />
MATERIA: ITALIANO DOCENTE: LUCIA ALFONSI<br />
TESTO ADOTTATO AAVV. BIBLIOTECA, Vol. III ed. Archimede<br />
AL TRI STRUMENTI<br />
DIDATTICI<br />
NUMERO DI ORE ANNUALI<br />
PREVISTO<br />
NUMERO DI ORE ANNUALI<br />
SVOLTE AL 15 MAGGIO<br />
METODOLOGIE ADOTTATE<br />
ATTIVITA' DI RECUPERO E<br />
APPROFONDIMENTO<br />
SVOLTE<br />
ATTIVITA'<br />
EXTRASCOLASTICHE<br />
SPECIFICHE<br />
TEMI GENERALI DEL<br />
PROGRAMMA SVOLTO<br />
Fotocopie, proiezione film<br />
92<br />
Lezione frontale, colloquio, ricerca<br />
In itinere<br />
99<br />
Realismo, Decadentismo italiano ed estero, poesia di fine e inizio secolo,<br />
il teatro<br />
VERIFICHE<br />
TIPOLOGIA NUMERO<br />
Scritte 4<br />
Orali 4<br />
OTTIMO<br />
OBIETTIVI MEDIAMENTE RAGGIUNTI DALLA CLASSE<br />
LIVELLO RISULTATI<br />
BUONO<br />
DISCRETO<br />
SUFFICIENTE X<br />
MEDIOCRE<br />
SCARSO<br />
10
Scheda n° 8<br />
SCHEDA PER SINGOLA MATERIA<br />
MATERIA: STORIA DOCENTE: LUCIA ALFONSI<br />
TESTO ADOTTATO AAVV. Codice Storia, vol.III, ed. Paravia<br />
AL TRI STRUMENTI<br />
DIDATTICI<br />
NUMERO DI ORE ANNUALI<br />
PREVISTO<br />
NUMERO DI ORE ANNUALI<br />
SVOLTE AL 15 MAGGIO<br />
METODOLOGIE ADOTTATE<br />
ATTIVITA' DI RECUPERO E<br />
APPROFONDIMENTO<br />
SVOLTE<br />
ATTIVITA'<br />
EXTRASCOLASTICHE<br />
SPECIFICHE<br />
TEMI GENERALI DEL<br />
PROGRAMMA SVOLTO<br />
Fotocopie<br />
51<br />
Lezione frontale, discussione, contestualizzazione, letture documenti<br />
In itinere<br />
Seconda rivoluzione industriale; la Prima Guerra Mondiale; Il<br />
Dopoguerra; crisi Totalitarismi; Seconda Guerra Mondiale; i<br />
trattati di pace; la ―Guerra Fredda‖<br />
VERIFICHE<br />
TIPOLOGIA NUMERO<br />
Orali 4<br />
OTTIMO<br />
OBIETTIVI MEDIAMENTE RAGGIUNTI DALLA CLASSE<br />
LIVELLO RISULTATI<br />
BUONO<br />
DISCRETO<br />
SUFFICIENTE X<br />
MEDIOCRE<br />
SCARSO<br />
66<br />
11
Scheda n° 8<br />
SCHEDA PER SINGOLA MATERIA<br />
MATERIA: Francese teoria e conversazione DOCENTI: Francesca Pratesi/Emilie Quinet<br />
TESTO ADOTTATO<br />
ALTRI STRUMENTI<br />
DIDATTICI<br />
NUMERO DI ORE ANNUALI<br />
PREVISTO<br />
NUMERO DI ORE ANNUALI<br />
SVOLTE AL 15 MAGGIO<br />
METODOLOGIE ADOTTATE<br />
ATTIVITA‘ DI RECUPERO E<br />
APPROFONDIMENTO SVOLTE<br />
TEMI GENERALI DEL<br />
PROGRAMMA SVOLTO<br />
Parodi – Vallacco, Un monde de voyages, Juvenilia<br />
Ponzi, Visintainer, Rousseau, Décriptez le tourisme, Lang<br />
Fotocopie degli argomenti letterari svolti<br />
Fotocopie sul Lazio<br />
56 Curricolari<br />
56 Curricolari<br />
1-2 h./sett. Recupero/Approfondimento<br />
Lezione frontale<br />
Conversazioni<br />
Ricerche individuali su Internet<br />
Esercitazioni scritte guidate, monitorate e autonome<br />
Comprensione scritta<br />
2 ore settimanali di sportello/assistenza allo studio (comuni con le altre classi)<br />
per quasi tutto l‘anno scolastico<br />
L‘offerta turistica in Francia: la Corsica<br />
L‘offerta turistica in Italia: il Lazio<br />
2 autori francesi (Settecento e Ottocento)<br />
Redazione di itinerari<br />
VERIFICHE<br />
TIPOLOGIA NUMERO<br />
Questionari a risposta aperta (o aperta e multipla) 1<br />
Itinerari (da completare o da formulare per intero) 3<br />
Colloqui ed esposizioni turistiche Varie in itinere<br />
OTTIMO<br />
BUONO<br />
DISCRETO<br />
SUFFICIENTE<br />
MEDIOCRE<br />
SCARSO<br />
(*) Osservazione al 15 maggio<br />
OBIETTIVI MEDIAMENTE RAGGIUNTI DALLA CLASSE*<br />
LIVELLO RISULTATI<br />
X<br />
12
Scheda N° 8<br />
SCHEDA PER SINGOLA MATERIA<br />
MATERIA: Inglese teoria e<br />
conversazione<br />
DOCENTI: Bernardino Gatti/Filomena Desiato<br />
TESTO ADOTTATO Keyword Tourism<br />
ALTRI STRUMENTI Fotocopie contenenti informazioni di base su brochure, itinerari,<br />
DIDATTICI<br />
materiale sulla cultura e la società del Lazio;<br />
NUMERO DI ORE<br />
ANNUALI PREVISTO<br />
NUMERO DI ORE<br />
ANNUALI SVOLTE AL 15<br />
MAGGIO<br />
METODOLOGIE ADOTTATE<br />
ATTIVITA' DI RECUPERO E<br />
APPROFONDIMENTO SVOLTE<br />
66 fino al termine delle lezioni<br />
Curricolari 56<br />
TEMI GENERALI DEL PROGRAMMA<br />
SVOLTO<br />
VERIFICHE<br />
Lezioni frontali; Consultazioni di materiali<br />
autentici; Riproduzione di materiali turistici<br />
(compilazione di un itinerario turistico in LS);<br />
Attività di sportello;<br />
La stesura di un itinerario turistico;<br />
Il Lazio;<br />
Le città d‘arte italiane;<br />
Le caratteristiche principali di una crociera;<br />
TIPOLOGIA NUMERO<br />
Scritte 4<br />
Orali 2\3<br />
OTTIMO<br />
BUONO<br />
DISCRETO<br />
SUFFICIENTE<br />
MEDIOCRE<br />
SCARSO<br />
OBIETTIVI MEDIAMENTE RAGGIUNTI DALLA CLASSE<br />
LIVELLO RISULTATI<br />
X<br />
13
Scheda n° 8<br />
SCHEDA PER SINGOLA MATERIA<br />
MATERIA: Spagnolo teoria e conversazione DOCENTI: Anna Pisani Luz Huarcaya<br />
TESTO ADOTTATO ¡ Buen Viaje! Zanichelli<br />
ALTRI STRUMENTI<br />
DIDATTICI<br />
NUMERO DI ORE ANNUALI<br />
PREVISTO<br />
NUMERO DI ORE ANNUALI<br />
SVOLTE AL 15 MAGGIO<br />
Materiale fornito dalle docenti: fotocopie, brochures turistiche, materiale pubblicitario,<br />
film in lingua originale.<br />
99<br />
Curricolari 84<br />
Sportello recupero<br />
orario<br />
STRATEGIE DI RECUPERO In itinere<br />
METODOLOGIE ADOTTATE<br />
ATTIVITA‘ DI RECUPERO E<br />
APPROFONDIMENTO SVOLTE<br />
ATTIVITA‘ EXTRASCOLASTICHE<br />
SPECIFICHE<br />
TEMI GENERALI DEL<br />
PROGRAMMA SVOLTO<br />
25<br />
Lezioni frontali: lettura e comprensione del testo<br />
Attività di ascolto e comprensione<br />
Attività di produzione orale su traccia guidata<br />
Attività di produzione scritta su traccia guidata<br />
Sportello pomeridiano, visione di film in lingua originale, utilizzo di realia<br />
Visione del film in spagnolo ―La Comunidad‖.<br />
Contenuti nozionali e funzionali relativi all‘ambito del turismo e nozioni<br />
grammaticali correlate.<br />
Geografia turistica della Spagna<br />
VERIFICHE<br />
TIPOLOGIA NUMERO<br />
Scritte:esercizi di completamento, creazione di dialoghi su traccia,<br />
traduzioni, comprensione del testo,<br />
Orali: conoscenza del lessico specialistico, simulazioni di diaolghi tipo 2+2<br />
OTTIMO<br />
OBIETTIVI MEDIAMENTE RAGGIUNTI DALLA CLASSE<br />
2+3<br />
LIVELLO RISULTATI<br />
BUONO X<br />
DISCRETO<br />
SUFFICIENTE<br />
MEDIOCRE<br />
SCARSO<br />
14
Scheda N° 8<br />
SCHEDA PER SINGOLA MATERIA<br />
MATERIA: Diritto DOCENTI: CARACUZZO GIANCARLO<br />
TESTO ADOTTATO Diritto ed economia del Turismo, Mantellini ed. CLITT<br />
ALTRI STRUMENTI<br />
DIDATTICI<br />
NUMERO DI ORE ANNUALI<br />
PREVISTO<br />
NUMERO DI ORE ANNUALI<br />
SVOLTE AL 15 MAGGIO<br />
METODOLOGIE ADOTTATE<br />
ATTIVITA‘ DI RECUPERO E<br />
APPROFONDIMENTO<br />
SVOLTE<br />
TEMI GENERALI DEL<br />
PROGRAMMA SVOLTO<br />
68<br />
75<br />
LEZIONI FRONTALI<br />
RECUPERI INDIVIDUALI IN ITINERE<br />
La legge 135/01, principi e competenze nel settore turistico;<br />
struttura amministrativa del settore turistico<br />
Impresa turistica alberghiera; agenzie di viaggio; il contratto e i<br />
principali contratti del settore turistico<br />
VERIFICHE<br />
TIPOLOGIA NUMERO<br />
Colloqui orali e prove scritte Due per quadrimestre<br />
OTTIMO<br />
BUONO<br />
DISCRETO<br />
OBIETTIVI MEDIAMENTE RAGGIUNTI DALLA CLASSE<br />
LIVELLO RISULTATI<br />
SUFFICIENTE X<br />
MEDIOCRE<br />
SCARSO<br />
15
Scheda N. 8<br />
SCHEDA PER SINGOLA MATERIA<br />
MATERIA: Tecnica Turistica DOCENTE: GIUSEPPE SANTILLI<br />
TESTO ADOTTATO Manuale di Tecnica Turistica amministrativa, G. Castaldi, Hoepli<br />
ALTRI STRUMENTI<br />
DIDATTICI<br />
NUMERO DI ORE ANNUALI<br />
PREVISTO<br />
NUMERO DI ORE ANNUALI<br />
SVOLTE fino al 15 maggio<br />
METODOLOGIE ADOTTATE<br />
ATTIVITA‘ DI RECUPERO E<br />
APPROFONDIMENTO SVOLTE<br />
ATTIVITA‘ EXTRASCOLASTICHE<br />
SPECIFICHE<br />
TEMI GENERALI DEL<br />
PROGRAMMA SVOLTO<br />
120<br />
114 Curricolari<br />
Lezione frontale<br />
Problem solving<br />
Recupero individuale in itinere<br />
Mark up -BEP-Prezzo medio- Advance booking- Last minute<br />
Business Plan- Budget<br />
VERIFICHE<br />
TIPOLOGIA NUMERO<br />
Scritte 2+2<br />
Orali 2+2<br />
OTTIMO<br />
BUONO<br />
DISCRETO<br />
LIVELLI DI PREPARAZIONE MEDIAMENTE RAGGIUNTI DALLA CLASSE<br />
SUFFICIENTE X<br />
MEDIOCRE<br />
SCARSO<br />
16
Scheda n° 8<br />
SCHEDA PER SINGOLA MATERIA<br />
MATERIA: GEOGRAFIA TURISTICA DOCENTE: SANTILLI FELICE<br />
TESTO ADOTTATO<br />
BIANCHI-KOHLER-MORONI, PASSAPORTO PER IL MONDO. DE<br />
AGOSTINI<br />
ALTRI STRUMENTI LAVAGNA, CARTE GEOGRAFICHE, GRAFICI, FOTO,<br />
DIDATTICI<br />
STATISTICHE, DEPLIANTS, RIVISTE SPECIALIZZATE<br />
NUMERO DI ORE ANNUALI<br />
PREVISTO<br />
66<br />
NUMERO DI ORE ANNUALI<br />
SVOLTE AL 15 MAGGIO<br />
METODOLOGIE ADOTTATE<br />
ATTIVITA‘ DI RECUPERO E<br />
APPROFONDIMENTO<br />
SVOLTE<br />
TEMI GENERALI DEL<br />
PROGRAMMA SVOLTO<br />
50<br />
Lezione frontale-Lezione interattiva<br />
Brainstorming- Lettura di dati, carte, grafici ed immagini<br />
Azioni di recupero in itinere<br />
Il mercato turistico extraeuropeo-Africa settendrionale-Asia<br />
occidentale- Asia orientale- America anglosassone- Australia<br />
VERIFICHE<br />
TIPOLOGIA NUMERO<br />
VERIFICHE ORALI 2 PER PERIODO<br />
SIMULAZIONE 3° PROVA SCRITTA 1<br />
OTTIMO<br />
BUONO<br />
DISCRETO<br />
OBIETTIVI MEDIAMENTE RAGGIUNTI DALLA CLASSE<br />
LIVELLO RISULTATI<br />
SUFFICIENTE X<br />
MEDIOCRE<br />
SCARSO<br />
17
Scheda n° 8<br />
SCHEDA PER SINGOLA MATERIA<br />
MATERIA: ARTE E TERRITORIO DOCENTE: FAILLA GAETANO<br />
TESTO ADOTTATO CRICCO, DI TEODORO ―ITINERARIO NELL‘ARTE‖ ZANICHELLI<br />
ALTRI STRUMENTI<br />
DIDATTICI<br />
NUMERO DI ORE ANNUALI<br />
PREVISTO<br />
NUMERO DI ORE ANNUALI<br />
SVOLTE AL 15 MAGGIO<br />
METODOLOGIE ADOTTATE<br />
ATTIVITA‘ DI RECUPERO E<br />
APPROFONDIMENTO<br />
SVOLTE<br />
TEMI GENERALI DEL<br />
PROGRAMMA SVOLTO<br />
53<br />
60<br />
Lezione frontale<br />
L‘età contemporanea, dal Classicismo all‘Espressionismo, l‘età<br />
moderna, il Barocco ripasso programma precedente<br />
VERIFICHE<br />
TIPOLOGIA NUMERO<br />
VERIFICHE FRONTALI 1° QUADRIMESTRE 2<br />
OTTIMO<br />
BUONO<br />
DISCRETO<br />
OBIETTIVI MEDIAMENTE RAGGIUNTI DALLA CLASSE<br />
2° QUADRIMESTRE 3<br />
LIVELLO RISULTATI<br />
SUFFICIENTE X<br />
MEDIOCRE<br />
SCARSO<br />
18
Scheda N. 8<br />
SCHEDA PER SINGOLA MATERIA<br />
DOCENTE: Russo Maria<br />
MATERIA: Matematica<br />
CLASSE: VA Sirio<br />
Bergamini Trifone Barozzi Mod. S: Le disequazioni e le funzioni – Mod.<br />
TESTO ADOTTATO<br />
U: I limiti Ed. Zanichelli<br />
ALTRI STRUMENTI<br />
DIDATTICI<br />
NUMERO DI ORE ANNUALI<br />
PREVISTO<br />
NUMERO DI ORE ANNUALI<br />
SVOLTE fino al 15 maggio<br />
METODOLOGIE ADOTTATE<br />
ATTIVITA‘ DI RECUPERO E<br />
APPROFONDIMENTO<br />
SVOLTE<br />
TEMI GENERALI DEL<br />
PROGRAMMA SVOLTO<br />
Fotocopie - appunti insegnante<br />
66<br />
57 Curricolari<br />
15 Recupero/Appr.<br />
10 Attività extrascolastiche generali<br />
Lezione frontale<br />
Esercitazioni guidate<br />
Problem Solving<br />
In itinere soprattutto per consolidare le conoscenze di base<br />
Sportello didattico<br />
Le disequazioni<br />
Le funzioni<br />
I limiti<br />
VERIFICHE<br />
TIPOLOGIA NUMERO<br />
Esercizi - Quesiti a risposta aperta e chiusa 4 scritte<br />
Interrogazioni frontali ed esercitazioni alla lavagna 4 orali<br />
OTTIMO<br />
BUONO<br />
DISCRETO<br />
OBIETTIVI MEDIAMENTE RAGGIUNTI DALLA CLASSE<br />
LIVELLO RISULTATI<br />
SUFFICIENTE X<br />
MEDIOCRE<br />
SCARSO<br />
19
A.S. 2010/11<br />
Classe V sez. A Progetto Sirio<br />
La filosofia positivista.<br />
L‘applicazione del metodo scientifico in letteratura.<br />
Scheda n° 9<br />
PROGRAMMI SVOLTI<br />
Materia: ITALIANO<br />
I.T.T. ―<strong>Darwin</strong>‖<br />
PROGRAMMA DI ITALIANO<br />
IL SECONDO OTTOCENTO: LA PROSA<br />
Il Naturalismo in Francia: Il romanzo sperimentale di Emile Zola<br />
Il romanzo verista.<br />
GIOVANNI VERGA: la vita e le opere.<br />
Da ―Novelle rusticane‖:<br />
―La roba‖ , ―Rosso Malpelo‖<br />
Il romanzo verista ―I Malavoglia‖:<br />
― Mastro don Gesualdo‖<br />
L‘epilogo<br />
IL DECADENTISMO: caratteri generali.<br />
La crisi della scienza e la crisi dei modelli positivisti.<br />
GIOVANNI PASCOLI: la vita e le opere.<br />
La teoria della poesia: significato de ―Il fanciullino‖<br />
Da ―Mirycae‖ analisi delle liriche:<br />
―Lavandare‖.<br />
―X agosto‖.<br />
―Il tuono‖<br />
―Il lampo‖<br />
Da ―Canti di Castelvecchio‖ analisi delle liriche:<br />
―Nebbia‖<br />
―Gelsomino notturno‖<br />
IL VERISMO<br />
20
GABRIELE D‘ANNUNZIO: la vita e le opere.<br />
Il romanzo decadente: ―Il piacere‖ (l‘esteta) .<br />
Da ―Il Piacere‖: lettura e analisi dei brani ―Andrea Sperelli‖ e ― Aspettando Elena‖<br />
Dall‘―oltre-uomo‖ di Nietzsche al ―Superuomo‖ di D‘Annunzio.<br />
Da ― Le vergini delle rocce‖ : Andrea Cantelmo (il ―Superuomo‖), lettura e analisi.<br />
Le ―Laudi‖.<br />
Da ―Alcyone‖:<br />
―La pioggia nel pineto‖. Lettura e analisi.<br />
LE FORME DELLA POESIA DEL PRIMO NOVECENTO:<br />
IL FUTURISMO: elementi generali.<br />
Lettura e analisi del ―Manifesto‖ del 1909<br />
L‘ERMETISMO.<br />
Le esperienze poetiche di Ungaretti e Montale.<br />
GIUSEPPE UNGARETTI:<br />
Lettura e analisi delle liriche<br />
Da ―Vita di un uomo‖:<br />
―Fratelli‖<br />
―San Martino del Carso‖.<br />
―Soldati‖<br />
EUGENIO MONTALE:<br />
Lettura e analisi delle liriche<br />
Da ―Ossi di seppia‖:<br />
―Spesso il male di vivere‖.<br />
Da ―Le occasioni‖:<br />
―La casa dei doganieri‖<br />
LA PROSA DEL PRIMO 900<br />
LUIGI PIRANDELLO:<br />
Il dramma dell‘uomo moderno nell‘opera di Luigi Pirandello.<br />
―Il fu Mattia Pascal‖: significato dell‘opera.<br />
Da ―Novelle per un anno‖:<br />
―La Patente‖<br />
―Il treno ha fischiato‖<br />
―Ciaula scopre la luna‖<br />
Il teatro pirandelliano: il ―teatro nel teatro‖.<br />
Lettura e analisi di pagine scelte da ―Enrico IV‖<br />
IL ROMANZO DEL NOVECENTO<br />
La figura dell‘‖ inetto‖<br />
ITALO SVEVO<br />
Da ―La coscienza di Zeno‖, lettura e analisi de<br />
― L‘ultima sigaretta‖<br />
FEDERICO TOZZI<br />
Da ― Tre Croci‖, lettura e analisi de<br />
― La morte di Enrico‖<br />
21
L‘ORRORE DELLA GUERRA<br />
PRIMO LEVI<br />
― Se questo è un uomo‖<br />
IL NEOREALISMO<br />
Caratteri generali: gli ideali della Resistenza ed il valore degli affetti<br />
ELIO VITTORINI<br />
―Uomini e no‖<br />
Lettura e commento del bran ― Passati per le armi‖<br />
Visione e commento del film ―Roma città aperta‖ di R. Rossellini e ―Sciuscià‖ di V. De Sica<br />
Roma, li 15 Maggio 2011<br />
L‘insegnante Gli alunni<br />
22
Scheda n° 9<br />
PROGRAMMI SVOLTI<br />
Materia: STORIA<br />
I.T.T. ―<strong>Darwin</strong>‖<br />
A.S. 2010/11 Classe V A Progetto SIRIO<br />
La II rivoluzione industriale.<br />
PROGRAMMA DI STORIA<br />
L‘evoluzione della scienza e della tecnica: le grandi scoperte di fine secolo.<br />
Dall‘imperialismo alla I guerra mondiale.<br />
Il pensiero nazionalista e la corsa agli armamenti.<br />
Dalla Germania di Bismark alla politica di Guglielmo II.<br />
L‘età giolittiana.<br />
Il decollo dell‘industria italiana (la nascita della Fiat).<br />
Tensioni sociali e la crisi di fine secolo.<br />
La I guerra mondiale: le cause del conflitto e la sua evoluzione.<br />
La conferenza di Parigi e i trattati di pace.<br />
Crollo degli imperi e conseguenze politico-sociali.<br />
Il drammatico dopoguerra<br />
La Germania di Weimar e la nascita del Nazionalsocialismo.<br />
Il Fascismo in Italia, la nascita della dittatura e la costruzione dello stato totalitario.<br />
23
I Totalitarismi<br />
La politica internazionale tra le due guerre.<br />
Verso la II guerra mondiale.<br />
La II guerra mondiale: le cause, l‘andamento, dalla ―guerra lampo‖ alla ―guerra totale‖.<br />
L‘entrata in guerra dell‘Italia, l‘armistizio, la guerra civile, la Resistenza.<br />
La sconfitta tedesca e la nascita delle Nazioni Unite.<br />
La conferenza di Yalta: USA e URSS potenze mondiali.<br />
La nascita della Repubblica Italiana.<br />
Il dopoguerra. La ―guerra fredda‖<br />
Roma, li 15 Maggio 2011<br />
L‘insegnante Gli alunni<br />
24
Scheda n° 9<br />
PROGRAMMA SVOLTO<br />
Materia: INGLESE – Teoria e Conversazione<br />
A.S. 2010- 2011<br />
Programma svolto da metà settembre alla seconda metà di maggio<br />
Lingua INGLESE (Teoria e Conversazione)<br />
CLASSE VA SIRIO<br />
DOCENTI: Bernardino Gatti - Filomena Desiato (insegnante di conversazione)<br />
OBIETTIVI DIDATTICI<br />
- Utilizzare la lingua inglese come strumento per la formazione professionale in ambito turistico;<br />
- Individuare e descrivere informazioni pratiche e aspetti turistici di una città e di un paese;<br />
- Acquisizione di alcuni elementi di geografia, storia e società dell‘Italia e capacità di esprimerli in LS.<br />
- Progettare e redigere itinerari turistici in un paese e in una città;<br />
- Acquisire e rinforzare le nozioni fondamentali della lingua inglese (livello beginner);<br />
-Descrivere luoghi;<br />
-Informazioni relative ai luoghi, agli orari, ai prezzi;<br />
ARGOMENTI<br />
English for Tourism<br />
Culture and traditions da Keyword Tourism – Modulo 6<br />
―Regions of Italy‖<br />
Langhe;<br />
Liguria;<br />
North East Italy;<br />
―Cities of Art‖,<br />
Venice,<br />
Florence,<br />
Rome;<br />
―The Jewels of Italy‖,<br />
The Best of Sicily;<br />
ELENCO DEL MATERIALE FORNITO DAL DOCENTE SU FOTOCOPIA (IN POSSESSO DEL COORDINATORE DI<br />
CLASSE)<br />
5 ITINERARI SUL LAZIO<br />
- (materiale fornito dal docente);<br />
PROMOTING AND SELLING TOURISM<br />
- Elaboration of an Itinerary: Itineraries in Rome;<br />
(materiale fornito dal docente);<br />
TOURS AND HOLIDAYS<br />
- Descrizione delle caratteristiche salienti di una crociera;<br />
(materiale fornito dal docente – in allegato);<br />
Brochure della Regione Lazio in L.S.<br />
MODALITÀ DI LAVORO<br />
-Test d‘entrata per stabilire il livello di conoscenza della lingua<br />
-Lezioni frontali<br />
-Esercizi di comprensione orale in classe dal libro di testo<br />
-Lettura e comprensione di testi semplici<br />
STRUMENTI<br />
-Libro di testo Keyword Tourism; autori: Anna Ferranti e Jennifer Rice; edizione Juvenilia Scuola;<br />
- Distribuzione di materiale integrativo a cura dell‘insegnante;<br />
- Materiale sulla preparazione di itinerari in L2 a cura dell‘insegnante;<br />
VERIFICHE<br />
-Interrogazioni orali;<br />
- Test di writing con domande aperte;<br />
- Simulazione terza prova a tipologia mista;<br />
- Elaborazioni di itinerari in L2;<br />
VALUTAZIONE<br />
rispetto al punto di partenza;<br />
al contributo personale e agli standard intermedi e finali conseguiti.<br />
25
Scheda n° 9<br />
PROGRAMMI SVOLTI<br />
Materia: FRANCESE – Teoria e Conversazione<br />
LINGUA FRANCESE<br />
CLASSE 5ª A Sirio<br />
MODULO N. 1 - PERIODO : ottobre, novembre<br />
Titolo : « Sujet : narrative »<br />
La narrative et le voyage au 18 e siècle :<br />
Montesquieu, «Un Persan à Paris», da Lettres<br />
Persanes<br />
Le thème du voyage et l‘ironie dans l‘œuvre de<br />
Montesquieu<br />
MODULO N. 2 - PERIODO: dicembre, gennaio<br />
Titolo : « L‘offre<br />
touristique en France : la<br />
Corse »<br />
Situation géographique – Histoire – Attraits<br />
touristiques – Gastronomie – Manifestations<br />
culturelles – Achats – Equipement hôtelier – Villes<br />
MODULO N. 3 - PERIODO: febbraio, marzo<br />
Titolo : « L‘offre<br />
touristique en Italie : le<br />
Latium »<br />
Cadre général du Latium touristique<br />
Viterbe<br />
Les jardins du Haut Latium (Caprarola, Bagnaia,<br />
Bomarzo)<br />
Les Etrusques : Cerveteri, Pyrgi, Tarquinia, Veies,<br />
Vulci<br />
MODULO N. 4 - PERIODO: aprile, maggio<br />
Titolo : « L‘offre<br />
touristique en Italie :<br />
itinéraires à thème dans le<br />
Latium »<br />
Tivoli et ses trois villas<br />
Les Châteaux Romains<br />
La Ciociaria: (abbayes et villes d‘art)<br />
Localités d‘intérêt de la côte<br />
A. S. 2010-2011<br />
La narrative et le voyage au 19 e siècle :<br />
E. Zola, «Rome», da Rome<br />
Emile Zola<br />
L‘importance de Zola et du Naturalisme<br />
au 19 e siècle<br />
Les itinéraires (1)<br />
Les itinéraires (2)<br />
Itinéraires thématiques (étude<br />
individuelle)<br />
I CORSISTI LE DOCENTI<br />
26
Scheda n° 9<br />
PROGRAMMI SVOLTI<br />
Materia: SPAGNOLO – Teoria e Conversazione<br />
PROGRAMMA SVOLTO<br />
LINGUA E CIVILTA‘ SPAGNOLA<br />
CLASSE VA SIRIO A.S.2010/2011<br />
ITT ―DARWIN‖<br />
PROF. ANNA PISANI<br />
Libro di testo: ¡Buen Viaje! Zanichelli, fotocopie e materiale fornito dalla docente.<br />
MODULO 1, Unità 8<br />
Proporre offerte di viaggio<br />
Il meccanismo della prenotazione 1<br />
Il meccanismo della prenotazione 2<br />
CONTENUTI GRAMMATICALI<br />
Il neutro, los indefinidos, imperfecto de sujuntivo<br />
MODULO 2, Unità 9<br />
Organizzare una riunione professionale 1<br />
Organizzare una riunione professionale 2<br />
Organizzare mostre e fiere<br />
CONTENUTI GRAMMATICALI<br />
Subordinate condizionali con si, uso di otros, también,<br />
hasta, tampoco/ni siquiera.<br />
MODULO 3, Unità10<br />
Rispondere alle lamentele<br />
Rispondere a lettere di lamentela<br />
CONTENUTI GRAMMATICALI<br />
Uso del congiuntivo/indicativo con verbi ed espressioni di probabilità, dubbio e speranza, uso del futuro/condizionale,<br />
congiunzioni e locuzioni avversative.<br />
MODULO 4, Unità 11<br />
Richiedere e dare informazioni su voli, treni e orari.<br />
Comprare e vendere biglietti<br />
CONTENUTI GRAMMATICALI<br />
Subordinate relative, costruzioni temporali.<br />
MODULO 5, Unità 12<br />
Presentare una zona turistica<br />
27
Organizzare itinerari<br />
Presentare itinerari<br />
CONTENUTI GRAMMATICALI<br />
Subordinate finali e consecutive,uso di mucho/tanto/bastante, subordinate concessive<br />
MODULO 6, Unità 13<br />
Presentare turisticamente una città o un paese<br />
Organizzare un percorso in una città<br />
CONTENUTI GRAMMATICALI<br />
La forma passiva e passiva riflessa, ripasso dell‘uso del congiuntivo<br />
CIVILTA‘, STORIA, GEOGRAFIA.<br />
Libro di testo Buen Viaje, Zanichelli, parte tercera.<br />
MODULO1 ―Barcelona‖<br />
MODULO2 ―Madrid‖<br />
MODULO 3 ―el camino de Santiago y la España verde‖.<br />
MODULO 4 . El sur de España‖<br />
28
Scheda n° 9<br />
PROGRAMMI SVOLTI<br />
Materia: MATEMATICA<br />
I.S.I.S. ―CHARLES DARWIN‖ - Tecnico Turistico Sirio – Roma<br />
Programma svolto di MATEMATICA<br />
Classe : VA sirio a.s. 2010/2011 Docente: Russo Maria<br />
Modulo 1 : Le disequazioni.<br />
Intervalli di numeri reali.<br />
Intervalli limitati e illimitati, aperti e chiusi.<br />
Disequazioni equivalenti.<br />
Disequazioni intere di primo grado.<br />
Studio del segno di un prodotto.<br />
Disequazioni intere di secondo grado.<br />
Le disequazioni di secondo grado e la parabola.<br />
Risoluzione grafica di una disequazione di secondo grado.<br />
Sistemi di disequazioni.<br />
Disequazioni fratte.<br />
Disequazioni in cui figura un valore assoluto.<br />
Disequazioni del tipo A(x) k.<br />
Modulo 2 : Le funzioni.<br />
Concetto di funzione.<br />
Funzioni numeriche.<br />
Dominio e codominio di una funzione.<br />
Classificazione delle funzioni.<br />
Funzione lineare. Funzione quadratica.<br />
Determinazione del dominio di una funzione razionale intera o fratta.<br />
Determinazione del dominio di una funzione irrazionale intera o fratta.<br />
Funzioni crescenti e decrescenti in un intervallo.<br />
Funzioni pari e funzioni dispari.<br />
La funzione esponenziale.<br />
Modulo 3 : I limiti delle funzioni.<br />
Intorno completo e circolare di un punto.<br />
Intorno destro e sinistro di un punto.<br />
Punto isolato; punto di accumulazione.<br />
Definizione di limite finito di una funzione in un punto.<br />
Il limite destro e il limite sinistro di una funzione.<br />
Verifica del limite finito di una funzione in un punto (per funzioni lineari).<br />
Definizione di limite infinito di una funzione in un punto.<br />
Le operazioni sui limiti: il limite della somma algebrica di due funzioni, il limite del prodotto<br />
di due funzioni, il limite del quoziente di due funzioni.<br />
Funzioni continue.<br />
Calcolo di semplici limiti.<br />
Limiti che si presentano nella forma indeterminata 0/0.<br />
GLI ALUNNI IL DOCENTE<br />
Maria Russo<br />
29
LE IMPRESE TURISTICHE<br />
Scheda n° 9<br />
PROGRAMMI SVOLTI<br />
Materia: TECNICA TURISTICA<br />
A.S. 2010- 2011<br />
CLASSE VA SIRIO<br />
1. LE NORME<br />
2. I TOUR OPERATOR<br />
3. LA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO TURISTICO<br />
4. LE AGENZIE DI VIAGGIO RIVENDITRICI<br />
5. L‘ATTIVITÁ DELLE AGENZIE INTERMEDIARIE<br />
6. L‘ACCOGLIENZA TURISITCA<br />
7. GLI ALBERGHI: GESTIONE E CONTABILITÁ<br />
8. GLI ESERCIZI EXTRALBERGHIERI<br />
LA COSTRUZIONE DEI PACCHETTI TURISTICI<br />
1. I PREZZI<br />
2. I SERVIZI LOCALI<br />
3. I VIAGGI ORGANIZZATO<br />
RIFERIMENTI DEL III E IV ANNO<br />
MODULI<br />
TURISMO, AMBIENTE, ECONOMIA E SOCIETÁ<br />
TURISMI E MERCATI<br />
UNITA’ DIDATTICHE<br />
1.IL MARKETING TURISTICO<br />
MODULO : IMPRESE, SOCIETÁ E GRUPPI<br />
3. LE IMPRESE: PATRIMONIO E GESTIONE<br />
4. LE IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE<br />
GLI STUDENTI IL DOCENTE<br />
30
Scheda n° 9<br />
PROGRAMMI SVOLTI<br />
Materia: DIRITTO<br />
Il turismo, definizione e caratteri. La legge 135 /01, principi e competenze nel settore<br />
turistico oggi.<br />
La struttura amministrativa del settore turistico. Amministrazione diretta e indiretta<br />
centrale. L’amministrazione periferica diretta e indiretta. Gli enti non territoriali.<br />
Cenni su: il turismo nel trattato istitutiva delle CCE. Gli organi comunitari nel settore<br />
turistico e i loro atti in materia turistica. Le disposizioni UE nel turismo. Il turismo in<br />
ambito internazionale.<br />
Le imprese turistiche- l’impresa alberghiera e il sistema alberghiero in Italia. Le<br />
agenzie<br />
di viaggio e la loro disciplina giuridica. Contratto d’albergo e di pacchetti turistici. Le<br />
professioni turistiche. L’imprenditore, i segni distintivi dell’impresa, le procedure<br />
concorsuali<br />
IL DOCENTE<br />
GIANCARLO CARACUZZO<br />
31
Scheda n° 9<br />
PROGRAMMI SVOLTI<br />
Materia: GEOGRAFIA TURISTICA<br />
Premessa 1: d‘ogni area geografica sono state considerate le caratteristiche generali del<br />
territorio (geomorfologia, idrografia, climi, vegetazione) e della popolazione (densità e<br />
distribuzione demografica, cenni storico-politici e culture, inquadramento socio-economico,<br />
mercato, strutture e risorse del turismo).<br />
Premessa 2: d‘ogni Paese sono stati analizzati i caratteri fisici essenziali (paesaggio<br />
naturale, idrografia, climi, vegetazione), i tratti economici e storico-culturali fondamentali,<br />
gli elementi basilari dell‗industria turistica (flussi interni e internazionali, bilancia turistica,<br />
strutture ricettive, vie di comunicazione) e le principali risorse turistiche naturali e culturali,<br />
compresi i beni dichiarati Patrimonio Mondiale dell‘Umanità dall‘UNESCO.<br />
1) IL TURISMO GLOBALE<br />
Il mercato mondializzato: i flussi turistici internazionali di persone e i<br />
movimenti finanziari di capitali tra regioni attive e ricettive<br />
L‘Organizzazione Mondiale del Turismo<br />
Il Patrimonio Culturale e Naturale Mondiale dell‘Umanità dell‘UNESCO<br />
2) AFRICA MEDITERRANEA<br />
Egitto: i centri della Valle del Nilo e le località del mar Rosso<br />
Tunisia: i siti archeologici e i centri islamici, le località balneari e le oasi<br />
Marocco: le Città Imperiali e le località balneari atlantiche e mediterranee<br />
3) ASIA OCCIDENTALE<br />
Israele: il turismo religioso e Gerusalemme, la natura e il turismo balneare<br />
Turchia: centri archeologici e storico-artistici e Istanbul, il turismo balneare<br />
Arabia Saudita: le città sante dell‘Islam (La Mecca e Medina)<br />
4) ASIA MERIDIONALE, ORIENTALE E SUD-ORIENTALE<br />
Thailandia: le tre capitali storiche siamesi e le località balneari<br />
India: l‘arte indo-islamica, il turismo religioso, naturalistico e balneare<br />
Giappone: le tre capitali storiche, il turismo religioso, termale e naturalistico<br />
Cina: le città dell‘est e i centri archeologici e storico-artistici imperiali<br />
5) IL MONDO ANGLOSASSONE EXTRAEUROPEO<br />
Australia: i parchi naturali terrestri e marini, la cultura aborigena e le città<br />
Canada: i parchi nazionali e le città<br />
USA: New York e le altre città dell‘est, la Florida e la California, i parchi<br />
naturali e i parchi artificiali a tema<br />
Gli alunni Prof. FELICE SANTILLI<br />
32
Scheda n° 9<br />
PROGRAMMI SVOLTI<br />
Materia: ARTE E TERRITORIO<br />
Programma di ARTE E TERRITORIO<br />
Svolto entro il 15/05/10 nella classe VA Sirio – a. s. 2010/11<br />
Testo utilizzato: E. Bernini, C. Campanini, C. Casoli Arti nella storia, vol. B Dal Seicento a oggi, Laterza<br />
Introduzione al XVII secolo: origini e motivazioni della nascita dell‘arte barocca<br />
M. Merisi da Caravaggio: la formazione e il primo periodo romano. Gli juvenilia: il Bacco degli Uffizi.<br />
Le prime commissioni pubbliche: il Martirio di san Matteo nella Cappella Contarelli.<br />
Le incomprensioni e il rifiuto dei committenti: La morte della Vergine.<br />
G. Bernini e l‘‖invenzione‖ del barocco. Le opere per il Cardinal Borghese: Apollo e Dafne.<br />
I lavori in San Pietro: Il baldacchino e il colonnato della basilica.<br />
F. Borromini e l‘inquietudine della ricerca: S. Carlino alle Quattro Fontane. L‘Oratorio dei Filippini e Sant‘Ivo alla<br />
Sapienza.<br />
Il Neoclassicismo: poetica ed etica<br />
La teorizzazione di Winckelmann<br />
Scultura<br />
A. Canova, la produzione giovanile: Dedalo e Icaro. Alla ricerca della bellezza ideale: Amore e Psiche.<br />
Pittura<br />
J. L. David e l‘ideale etico: Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat.<br />
L'Ottocento<br />
Il Romanticismo: caratteri e diffusione del movimento in Europa.<br />
Il Romanticismo ―di storia‖ in Francia<br />
T. Géricault: La zattera della Medusa<br />
E. Delacroix: La Libertà guida il popolo sulle barricate<br />
L’Impressionismo : presupposti tecnico-teorici<br />
E. Manet: Le déjeuner sur l‘herbe, Olympia<br />
C. Monet: Impression, soleil levant, La cathedrale de Rouen<br />
A. Renoir: Le Moulin de la Galette.<br />
E. Degas: La classe de danse, l‘Absinthe<br />
P. Cézanne : La maison du pendu<br />
Il Post-impressionismo e la ricerca di nuove esperienze<br />
Le origini dell'arte contemporanea:<br />
V. van Gogh: I mangiatori di patate, Campo di grano con volo di corvi<br />
P. Gauguin: Il Cristo giallo<br />
L’Espressionismo francese e tedesco: Matisse, Kirchner, Munch<br />
Les Fauves - Matisse: La danse<br />
Il Cubismo - P. Picasso: Il periodo blu e il periodo rosa; Les demoiselles d‘Avignon e i successivi sviluppi<br />
33
TIPOLOGIA<br />
A,B, C, D<br />
Secondo il dossier<br />
ministeriale<br />
dell‘Esame di Stato<br />
giugno 2010<br />
TIPOLOGIA<br />
Tema di discipline<br />
Turistiche e Aziendali<br />
Secondo il dossier<br />
dell‘Esame di Stato<br />
2009<br />
TIPOLOGIA<br />
Mista: B + C quesiti a<br />
risposta singola e<br />
quesiti a risposta<br />
multipla (2+4)<br />
Pag. 1/7 Sessione ordinaria 2010<br />
Prima prova scritta<br />
Scheda n° 10<br />
SIMULAZIONE DELLA I PROVA<br />
NUMERO<br />
SIMULAZIONI<br />
DATA<br />
MATERIE<br />
COINVOLTE<br />
1 28 Marzo 2011 Italiano<br />
Scheda n° 11<br />
SIMULAZIONE DELLA II PROVA<br />
NUMERO<br />
SIMULAZIONI<br />
DATA<br />
1 29 Marzo 2011<br />
Scheda n° 12<br />
SIMULAZIONE DELLA III PROVA<br />
NUMERO<br />
SIMULAZIONI<br />
DATA<br />
1 4 aprile 2011<br />
MATERIE<br />
COINVOLTE<br />
Discipline Turistiche<br />
e Aziendali<br />
MATERIE<br />
COINVOLTE<br />
Geografia Turistica,<br />
Arte e Territorio,<br />
Inglese e Francese<br />
TEMPO<br />
ASSEGNATO<br />
5 ore<br />
TEMPO<br />
ASSEGNATO<br />
5 ore<br />
TEMPO<br />
ASSEGNATO<br />
1, 30 ore<br />
34
Ministero dell’Istruzione dell’Università e<br />
della Ricerca<br />
P000 - ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO DI<br />
ISTRUZIONE<br />
SECONDARIA SUPERIORE<br />
PROVA DI ITALIANO<br />
(per tutti gli indirizzi: di ordinamento e sperimentali)<br />
Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte.<br />
TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO<br />
Primo Levi, dalla Prefazione di La ricerca delle radici. Antologia personale, Torino 1981<br />
5<br />
10<br />
15<br />
20<br />
25<br />
30<br />
Poiché dispongo di input ibridi, ho accettato volentieri e con curiosità la proposta di comporre anch‘io<br />
un‘«antologia personale», non nel senso borgesiano di autoantologia, ma in quello di una raccolta,<br />
retrospettiva e in buona fede, che metta in luce le eventuali tracce di quanto è stato letto su quanto è stato<br />
scritto. L‘ho accettata come un esperimento incruento, come ci si sottopone a una batteria di test; perché<br />
placet experiri e per vedere l‘effetto che fa.<br />
Volentieri, dunque, ma con qualche riserva e con qualche tristezza. La riserva principale nasce appunto<br />
dal mio ibridismo: ho letto parecchio, ma non credo di stare inscritto nelle cose che ho letto; è probabile che<br />
il mio scrivere risenta più dell‘aver io condotto per trent‘anni un mestiere tecnico, che non dei libri ingeriti;<br />
perciò l‘esperimento è un po‘ pasticciato, e i suoi esiti dovranno essere interpretati con precauzione.<br />
Comunque, ho letto molto, soprattutto negli anni di apprendistato, che nel ricordo mi appaiono stranamente<br />
lunghi; come se il tempo, allora, fosse stirato come un elastico, fino a raddoppiarsi, a triplicarsi. Forse lo<br />
stesso avviene agli animali dalla vita breve e dal ricambio rapido, come i passeri e gli scoiattoli, e in genere a<br />
chi riesce, nell‘unità di tempo, a fare e percepire più cose dell‘uomo maturo medio: il tempo soggettivo<br />
diventa più lungo.<br />
Ho letto molto perché appartenevo a una famiglia in cui leggere era un vizio innocente e tradizionale,<br />
un‘abitudine gratificante, una ginnastica mentale, un modo obbligatorio e compulsivo di riempire i vuoti di<br />
tempo, e una sorta di fata morgana nella direzione della sapienza. Mio padre aveva sempre in lettura tre libri<br />
contemporaneamente; leggeva «stando in casa, andando per via, coricandosi e alzandosi» (Deut. 6.7); si<br />
faceva cucire dal sarto giacche con tasche larghe e profonde, che potessero contenere un libro ciascuna.<br />
Aveva due fratelli altrettanto avidi di letture indiscriminate; i tre (un ingegnere, un medico, un agente di<br />
borsa) si volevano molto bene, ma si rubavano a vicenda i libri dalle rispettive librerie in tutte le occasioni<br />
possibili. I furti venivano recriminati pro forma, ma di fatto accettati sportivamente, come se ci fosse una<br />
regola non scritta secondo cui chi desidera veramente un libro è ipso facto degno di portarselo via e di<br />
possederlo. Perciò ho trascorso la giovinezza in un ambiente saturo di carta stampata, ed in cui i testi<br />
scolastici erano in minoranza: ho letto anch‘io confusamente, senza metodo, secondo il costume di casa, e<br />
devo averne ricavato una certa (eccessiva) fiducia nella nobiltà e necessità della carta stampata, e, come<br />
sottoprodotto, un certo orecchio e un certo fiuto. Forse, leggendo, mi sono inconsapevolmente preparato a<br />
scrivere, così come il feto di otto mesi sta nell‘acqua ma si prepara a respirare; forse le cose lette riaffiorano<br />
qua e là nelle pagine che poi ho scritto, ma il nocciolo del mio scrivere non è costituito da quanto ho letto.<br />
Mi<br />
sembra onesto dirlo chiaramente, in queste «istruzioni per l‘uso» della presente antologia.<br />
Primo Levi (Torino 1919-87) è l‘autore di Se questo è un uomo (1947) e La tregua (1963), opere legate alla<br />
esperienza della deportazione, in quanto ebreo, nel campo di Buna-Monowitz presso Auschwitz, e del lungo<br />
e<br />
avventuroso viaggio di rimpatrio. Tornato in Italia, fu prima chimico di laboratorio e poi direttore di<br />
fabbrica. A<br />
partire dal 1975, dopo il pensionamento, si dedicò a tempo pieno all‘attività letteraria. Scrisse romanzi,<br />
racconti,<br />
saggi, articoli e poesie.<br />
35
A proposito di La ricerca delle radici, Italo Calvino così scrisse in un articolo apparso su «la Repubblica»<br />
dell‘11 giugno 1981: «L‘anno scorso Giulio Bollati ebbe l‘idea di chiedere ad alcuni scrittori italiani di<br />
comporre una loro «antologia personale»: nel senso d‘una scelta non dei propri scritti ma delle proprie letture<br />
considerate fondamentali, cioè di tracciare attraverso una successione di pagine d‘autori prediletti un<br />
paesaggio<br />
letterario, culturale e ideale. […] Tra gli autori che hanno accettato l‘invito, l‘unico che finora ha tenuto fede<br />
all‘impegno è Primo Levi, il cui contributo era atteso come un test cruciale per questo tipo d‘impresa, dato<br />
che<br />
in lui s‘incontrano la formazione scientifica, la sensibilità letteraria sia nel rievocare il vissuto sia<br />
nell‘immaginazione, e il forte senso della sostanza morale e civile d‘ogni esperienza».<br />
Pag. 2/7 Sessione ordinaria 2010<br />
Prima prova scritta<br />
Ministero dell’Istruzione dell’Università e<br />
della Ricerca<br />
1. Comprensione del testo<br />
Dopo una prima lettura, riassumi il contenuto informativo del testo.<br />
2. Analisi del testo<br />
2.1 Quali sono per Levi le conseguenze degli «input ibridi» (r. 1) e dell‘«ibridismo» (r. 7)?<br />
2.2 Spiega le considerazioni di Levi sul «tempo soggettivo» (r. 13).<br />
2.3 Perché si leggeva molto nella famiglia di Levi? Spiega, in particolare, perché leggere era «una sorta<br />
di fata morgana nella direzione della sapienza» (r. 17).<br />
2.4 Soffermati su ciò che Levi dichiara di avere ricavato dalle sue letture (rr. 24-29). In particolare, spiega<br />
l‘atteggiamento di Levi nei confronti della «carta stampata» (r. 26).<br />
2.5 Esponi le tue osservazioni in un commento personale di sufficiente ampiezza.<br />
3. Interpretazione complessiva ed approfondimenti<br />
Proponi una tua interpretazione complessiva del brano e approfondiscila con opportuni collegamenti al libro<br />
da<br />
cui il brano è tratto o ad altri testi di Primo Levi. In alternativa, prendendo spunto dal testo proposto, proponi<br />
una<br />
tua «antologia personale» indicando le letture fatte che consideri fondamentali per la tua formazione.<br />
TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI GIORNALE”<br />
(puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti)<br />
CONSEGNE<br />
Sviluppa l’argomento scelto o in forma di «saggio breve» o di «articolo di giornale», utilizzando, in tutto o<br />
in parte, e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti.<br />
Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue<br />
conoscenze ed esperienze di studio.<br />
Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi.<br />
Se scegli la forma dell’«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul quale pensi<br />
che l’articolo debba essere pubblicato.<br />
Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo.<br />
1. AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO<br />
ARGOMENTO: Piacere e piaceri.<br />
DOCUMENTI<br />
«La passione li avvolse, e li fece incuranti di tutto ciò che per ambedue non fosse un godimento immediato.<br />
Ambedue,<br />
mirabilmente formati nello spirito e nel corpo all‘esercizio di tutti i più alti e i più rari diletti, ricercavano<br />
senza tregua<br />
il Sommo, l‘Insuperabile, l‘Inarrivabile; e giungevano così oltre, che talvolta una oscura inquietudine li<br />
prendeva pur<br />
nel colmo dell‘oblio, quasi una voce d‘ammonimento salisse dal fondo dell‘esser loro ad avvertirli d‘un<br />
ignoto castigo,<br />
d‘un termine prossimo. Dalla stanchezza medesima il desiderio risorgeva più sottile, più temerario, più<br />
imprudente;<br />
36
come più s‘inebriavano, la chimera del loro cuore ingigantiva, s‘agitava, generava nuovi sogni; parevano non<br />
trovar<br />
riposo che nello sforzo, come la fiamma non trova la vita che nella combustione. Talvolta, una fonte di<br />
piacere<br />
inopinata aprivasi dentro di loro, come balza d‘un tratto una polla viva sotto le calcagna d‘un uomo che vada<br />
alla<br />
ventura per l‘intrico d‘un bosco; ed essi vi bevevano senza misura, finché non l‘avevano esausta. Talvolta,<br />
l‘anima,<br />
sotto l‘influsso dei desiderii, per un singolar fenomeno d‘allucinazione, produceva l‘imagine ingannevole<br />
d‘una<br />
esistenza più larga, più libera, più forte, «oltrapiacente»; ed essi vi s‘immergevano, vi godevano, vi<br />
respiravano come<br />
in una loro atmosfera natale. Le finezze e le delicatezze del sentimento e dell‘imaginazione succedevano agli<br />
eccessi<br />
della sensualità.»<br />
Gabriele D‘ANNUNZIO, Il piacere, 1889 (ed. utilizzata 1928)<br />
Pag. 3/7 Sessione ordinaria 2010<br />
Prima prova scritta<br />
Ministero dell’Istruzione dell’Università e<br />
della Ricerca<br />
Sandro BOTTICELLI<br />
Nascita di Venere, circa 1482-85<br />
Pablo PICASSO<br />
I tre musici, 1921<br />
Henri MATISSE<br />
La danza, 1909-10<br />
«Piacer figlio d‘affanno; «Volti al travaglio<br />
gioia vana, ch‘è frutto come una qualsiasi<br />
del passato timore, onde si scosse fibra creata<br />
e paventò la morte perché ci lamentiamo noi?<br />
chi la vita abborria; Mariano il 14 luglio 1916»<br />
onde in lungo tormento, GiuseppeUNGARETTI, Destino, in Il Porto Sepolto, 1916<br />
fredde, tacite, smorte,<br />
sudàr le genti e palpitàr, vedendo «Il primo sguardo dalla finestra il mattino<br />
mossi alle nostre offese il vecchio libro ritrovato<br />
folgori, nembi e vento. volti entusiasti<br />
O natura cortese, neve, il mutare delle stagioni<br />
son questi i doni tuoi, il giornale<br />
questi i diletti sono il cane<br />
che tu porgi ai mortali. Uscir di pena la dialettica<br />
è diletto fra noi. fare la doccia, nuotare<br />
Pene tu spargi a larga mano; il duolo musica antica<br />
spontaneo sorge: e di piacer, quel tanto scarpe comode<br />
che per mostro e miracolo talvolta capire<br />
nasce d‘affanno, è gran guadagno. Umana musica moderna<br />
prole cara agli eterni! assai felice scrivere, piantare<br />
se respirar ti lice viaggiare<br />
d‘alcun dolor: beata cantare<br />
se te d‘ogni dolor morte risana.» essere gentili.»<br />
Giacomo LEOPARDI, La quiete dopo la tempesta, vv. 32-54, Bertolt BRECHT, Piaceri, 1954/55, trad. di R. Fertonani,<br />
1829 (in G. Leopardi, Canti, 1831) (in B. Brecht, Poesie, trad. it., 1992)<br />
«Il piacere è veramente tale quando non si rende conto né delle proprie cause né dei propri effetti. (È<br />
immediato,<br />
irrazionale). Il piacere della conoscenza fa eccezione? No. Il piacere della conoscenza procede dal razionale<br />
ed è<br />
irrazionale.»<br />
37
Andrea EMO, Quaderni di metafisica (1927-1928), in A. Emo, Quaderni di metafisica 1927-1981, 2006<br />
«I filosofi ed i sinonimisti vi spiegano con paziente sollecitudine la differenza precisa che passa fra la<br />
giustizia, la<br />
bontà e il dovere; ma voi stessi potete persuadervi che essi fabbricano un mondo di carta pesta. Ciò che è<br />
giusto è<br />
buono, ciò che è dovere è giustizia, e ciò che si deve fare è ciò che è giusto e buono. Ma non vedete voi il<br />
circolo<br />
eterno del cosmo, la volta infinita del cielo che non comincia in un alcun luogo e mai non finisce? Studiate il<br />
cerchio, perché in verità vi dico che la sua geometria morale abbraccia la storia del mondo. Le gioie della<br />
giustizia e del dovere esercitano la più benefica influenza sulla felicità della vita e, rendendoci calmi e<br />
soddisfatti<br />
nel presente, ci preparano un avvenire felice. Chi possiede maggiori ricchezze di fortuna, di mente e di cuore,<br />
ha<br />
anche maggiori doveri da esercitare; ma tutti gli uomini, purché abbiano soltanto un‘individualità morale,<br />
devono<br />
essere giusti e buoni, e devono quindi rendersi degni di gustare queste gioie sublimi.»<br />
Paolo MANTEGAZZA, Fisiologia del piacere, 1992 (1ª edizione 1854)<br />
Pag. 4/7 Sessione ordinaria 2010<br />
Prima prova scritta<br />
Ministero dell’Istruzione dell’Università e<br />
della Ricerca<br />
2. AMBITO SOCIO - ECONOMICO<br />
ARGOMENTO: La ricerca della felicità.<br />
DOCUMENTI<br />
«Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di<br />
razza, di<br />
lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.<br />
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la<br />
libertà<br />
e l‘eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l‘effettiva partecipazione<br />
di<br />
tutti i lavoratori all‘organizzazione politica, economica e sociale del Paese.»<br />
Articolo 3 della Costituzione della Repubblica Italiana<br />
«Noi riteniamo che sono per sé stesse evidenti queste verità: che tutti gli uomini sono creati eguali; che essi<br />
sono<br />
dal Creatore dotati di certi inalienabili diritti, che tra questi diritti sono la Vita, la Libertà, e il perseguimento<br />
della<br />
Felicità.»<br />
Dichiarazione di indipendenza dei Tredici Stati Uniti d’America, 4 luglio 1776<br />
«La nostra vita è un‘opera d‘arte – che lo sappiamo o no, che ci piaccia o no. Per viverla come esige l‘arte<br />
della vita<br />
dobbiamo – come ogni artista, quale che sia la sua arte – porci delle sfide difficili (almeno nel momento in<br />
cui ce le<br />
poniamo) da contrastare a distanza ravvicinata; dobbiamo scegliere obiettivi che siano (almeno nel momento<br />
in cui li<br />
scegliamo) ben oltre la nostra portata, e standard di eccellenza irritanti per il loro modo ostinato di stare<br />
(almeno per<br />
quanto si è visto fino allora) ben al di là di ciò che abbiamo saputo fare o che avremmo la capacità di fare.<br />
Dobbiamo<br />
tentare l’impossibile. E possiamo solo sperare – senza poterci basare su previsioni affidabili e tanto meno<br />
certe – di<br />
riuscire prima o poi, con uno sforzo lungo e lancinante, a eguagliare quegli standard e a raggiungere quegli<br />
obiettivi,<br />
dimostrandoci così all‘altezza della sfida.<br />
L‘incertezza è l‘habitat naturale della vita umana, sebbene la speranza di sfuggire ad essa sia il motore delle<br />
attività<br />
38
umane. Sfuggire all‘incertezza è un ingrediente fondamentale, o almeno il tacito presupposto, di qualsiasi<br />
immagine<br />
composita della felicità. È per questo che una felicità «autentica, adeguata e totale» sembra rimanere<br />
costantemente a<br />
una certa distanza da noi: come un orizzonte che, come tutti gli orizzonti, si allontana ogni volta che<br />
cerchiamo di<br />
avvicinarci a esso.»<br />
Zygmunt BAUMAN, L’arte della vita, trad. it., Bari 2009 (ed. originale 2008)<br />
«Nonostante le molte oscillazioni, la soddisfazione media riportata dagli europei era, nel 1992, praticamente<br />
allo<br />
stesso livello di 20 anni prima, a fronte di un considerevole aumento del reddito pro capite nello stesso<br />
periodo.<br />
Risultati molto simili si ottengono anche per gli Stati Uniti. Questi dati sollevano naturalmente molti dubbi<br />
sulla<br />
loro qualità e tuttavia, senza entrare nel dettaglio, numerosi studi provenienti da altre discipline come la<br />
psicologia e la neurologia ne supportano l‘attendibilità. Citiamo solo la critica che a noi pare più comune e<br />
che si<br />
potrebbe formulare come segue: in realtà ognuno si dichiara soddisfatto in relazione a ciò che può<br />
realisticamente<br />
ottenere, di conseguenza oggi siamo effettivamente più felici di 20 anni fa ma non ci riteniamo tali perché le<br />
nostre aspettative sono cambiate, migliorate, e desideriamo sempre di più. Esistono diverse risposte a questa<br />
critica. In primo luogo, se così fosse, almeno persone nate negli stessi anni dovrebbero mostrare una crescita<br />
nel<br />
tempo della felicità riportata soggettivamente. I dati mostrano invece che, anche suddividendo il campione<br />
per<br />
coorti di nascita, la felicità riportata non cresce significativamente nel tempo. Inoltre, misure meno<br />
soggettive del<br />
benessere, come la percentuale di persone affette da depressione o il numero di suicidi, seguono andamenti<br />
molto<br />
simili alle risposte soggettive sulla felicità e sulla soddisfazione. Ma allora cosa ci rende felici?»<br />
Mauro MAGGIONI e Michele PELLIZZARI, Alti e bassi dell’economia della felicità, «La Stampa», 12 maggio 2003<br />
Pag. 5/7 Sessione ordinaria 2010<br />
Prima prova scritta<br />
Ministero dell’Istruzione dell’Università e<br />
della Ricerca<br />
«Il tradimento dell‘individualismo sta tutto qui: nel far creder che per essere felici basti aumentare le utilità.<br />
Mentre sappiamo che si può essere dei perfetti massimizzatori di utilità anche in solitudine, per essere felici<br />
occorre essere almeno in due. La riduzione della categoria della felicità a quella della utilità è all‘origine<br />
della<br />
credenza secondo cui l‘avaro sarebbe, dopotutto, un soggetto razionale. Eppure un gran numero di<br />
interazioni<br />
sociali acquistano significato unicamente grazie all‘assenza di strumentalità. Il senso di un‘azione cortese o<br />
generosa verso un amico, un figlio, un collega sta proprio nel suo essere gratuita. Se venissimo a sapere che<br />
quell‘azione scaturisce da una logica di tipo utilitaristico e manipolatorio, essa acquisterebbe un senso<br />
totalmente<br />
diverso, con il che verrebbero a mutare i modi di risposta da parte dei destinatari dell‘azione. Il Chicago man<br />
–<br />
come Daniel McFadden ha recentemente chiamato la versione più aggiornata dell‘homo oeconomicus – è un<br />
isolato, un solitario e dunque un infelice, tanto più egli si preoccupa degli altri, dal momento che questa<br />
sollecitudine altro non è che un‘idiosincrasia delle sue preferenze. [...] Adesso finalmente comprendiamo<br />
perché<br />
l‘avaro non riesce ad essere felice: perché è tirchio prima di tutto con se stesso; perché nega a se stesso quel<br />
valore di legame che la messa in pratica del principio di reciprocità potrebbe assicuragli.»<br />
Stefano ZAMAGNI, Avarizia. La passione dell’avere, Bologna 2009<br />
3. AMBITO STORICO - POLITICO<br />
ARGOMENTO: Il ruolo dei giovani nella storia e nella politica. Parlano i leader.<br />
39
DOCUMENTI<br />
«Ma poi, o signori, quali farfalle andiamo a cercare sotto l‘arco di Tito? Ebbene, dichiaro qui, al cospetto di<br />
questa<br />
Assemblea e al cospetto di tutto il popolo italiano, che io assumo, io solo, la responsabilità politica, morale,<br />
storica di<br />
tutto quanto è avvenuto. (Vivissimi e reiterati applausi — Molte voci: Tutti con voi! Tutti con voi!) Se le<br />
frasi più o<br />
meno storpiate bastano per impiccare un uomo, fuori il palo e fuori la corda; se il fascismo non è stato che<br />
olio di<br />
ricino e manganello, e non invece una passione superba della migliore gioventù italiana, a me la colpa!<br />
(Applausi).<br />
Se il fascismo è stato un‘associazione a delinquere, io sono il capo di questa associazione a delinquere!<br />
(Vivissimi e<br />
prolungati applausi — Molte voci: Tutti con voi!)»<br />
Benito MUSSOLINI, Discorso del 3 gennaio 1925<br />
(da Atti Parlamentari – Camera dei Deputati – Legislatura XXVII – 1a sessione – Discussioni – Tornata del 3 gennaio<br />
1925<br />
Dichiarazioni del Presidente del Consiglio)<br />
«Diciamo le cose come stanno. I giovani che vengono al nostro partito devono essere stabilmente conquistati<br />
ai grandi<br />
ideali del socialismo e del comunismo, se non vogliamo che essi rimangano dei «pratici», o, peggio, dei<br />
politicanti.<br />
Essi devono acquistare la certezza – volevo dire la fede – che l‘avvenire e la salvezza della società umana sta<br />
nella sua<br />
trasformazione socialista e comunista, e questa certezza deve sorreggerli, guidarli, illuminarli in tutto il<br />
lavoro pratico<br />
quotidiano. […] Quanto alle grandi masse della gioventù, quello cui noi aspiriamo è di dare un potente<br />
contributo<br />
positivo per far loro superare la crisi profonda in cui si dibattono. Non desideriamo affatto staccare i giovani<br />
dai<br />
tradizionali ideali morali e anche religiosi. Prima di tutto, però, vogliamo aiutarli a comprendere come si<br />
svolgono le<br />
cose nel mondo, a comprendere il perché delle lotte politiche e sociali che si svolgono nel nostro paese e<br />
sulla scena<br />
mondiale, e quindi il perché delle sciagure della nostra patria e della triste sorte odierna della sua gioventù.<br />
Tutto<br />
questo non si capisce, però, se non si riesce ad afferrare che quello a cui noi assistiamo da due o tre decenni<br />
non è che<br />
la faticosa gestazione di un mondo nuovo, del mondo socialista, che si compie suscitando la resistenza<br />
accanita di un<br />
mondo di disordine, di sfruttamento, di violenza e di corruzione, il quale però è inesorabilmente condannato<br />
a sparire.»<br />
Palmiro TOGLIATTI, Discorso alla conferenza nazionale giovanile del PCI, Roma, 22-24 maggio 1947<br />
(da P. TOGLIATTI, Discorsi ai giovani, Prefazione di E. Berlinguer, Roma 1971)<br />
Pag. 6/7 Sessione ordinaria 2010<br />
Prima prova scritta<br />
Ministero dell’Istruzione dell’Università e<br />
della Ricerca<br />
«Il potere si legittima davvero e solo per il continuo contatto con la sua radice umana, e si pone come un<br />
limite<br />
invalicabile le forze sociali che contano per se stesse, il crescere dei centri di decisione, il pluralismo che<br />
esprime la<br />
molteplicità irriducibile delle libere forme di vita comunitaria. I giovani e i lavoratori conducono questo<br />
movimento<br />
e sono primi a voler fermamente un mutamento delle strutture politiche ed un rispettoso distacco; i giovani<br />
chiedono<br />
40
un vero ordine nuovo, una vita sociale che non soffochi ma offra liberi spazi, una prospettiva politica non<br />
conservatrice o meramente stabilizzatrice, la lievitazione di valori umani. Una tale società non può essere<br />
creata<br />
senza l‘attiva presenza, in una posizione veramente influente, di coloro per i quali il passato è passato e che<br />
sono<br />
completamente aperti verso l‘avvenire. La richiesta di innovazione comporta naturalmente la richiesta di<br />
partecipazione. Essa è rivolta agli altri, ma anche e soprattutto a se stessi: non è solo una rivendicazione, ma<br />
anche un<br />
dovere e una assunzione di responsabilità. L‘immissione della linfa vitale dell‘entusiasmo, dell‘impegno, del<br />
rifiuto<br />
dell‘esistente, propri dei giovani, nella società, nei partiti, nello Stato, è una necessità vitale, condizione<br />
dell‘equilibrio e della pace sociale nei termini nuovi ed aperti nei quali in una fase evolutiva essi possono<br />
essere<br />
concepiti.»<br />
Aldo MORO, Discorso all’XI Congresso Nazionale della DC, 29 giugno 1969<br />
(da A. MORO, Scritti e discorsi, Volume Quinto: 1969-1973, a c. di G. Rossini, Roma 1988)<br />
«L‘individuo oggi è spesso soffocato tra i due poli dello Stato e del mercato. Sembra, infatti, talvolta che egli<br />
esista<br />
soltanto come produttore e consumatore di merci, oppure come oggetto dell‘amministrazione dello Stato,<br />
mentre si<br />
dimentica che la convivenza tra gli uomini non è finalizzata né al mercato né allo Stato, poiché possiede in se<br />
stessa un<br />
singolare valore che Stato e mercato devono servire. L‘uomo è, prima di tutto, un essere che cerca la verità e<br />
si sforza<br />
di viverla e di approfondirla in un dialogo che coinvolge le generazioni passate e future. Da tale ricerca<br />
aperta della<br />
verità, che si rinnova a ogni generazione, si caratterizza la cultura della Nazione. In effetti, il patrimonio dei<br />
valori<br />
tramandati e acquisiti è sempre sottoposto dai giovani a contestazione. Contestare, peraltro, non vuol dire<br />
necessariamente distruggere o rifiutare in modo aprioristico, ma vuol significare soprattutto mettere alla<br />
prova nella<br />
propria vita e, con tale verifica esistenziale, rendere quei valori più vivi, attuali e personali, discernendo ciò<br />
che nella<br />
tradizione è valido da falsità ed errori o da forme invecchiate, che possono esser sostituite da altre più<br />
adeguate ai<br />
tempi.»<br />
GIOVANNI PAOLO II, Lettera enciclica Centesimus annus nel centenario della Rerum novarum, 1° maggio 1991<br />
(da Tutte le encicliche di Giovanni Paolo II, Milano 2005)<br />
4. AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO<br />
ARGOMENTO: Siamo soli?<br />
DOCUMENTI<br />
«Alla fine del Novecento la ricerca dell‘origine della vita sulla Terra era pronta a riprendere il cammino, ora<br />
pienamente integrata fra gli obiettivi dell‘esobiologia [= Studio della comparsa e dell‘evoluzione della vita<br />
fuori del<br />
nostro pianeta], con un piccolo gruppo di biologi che continuavano a perseguire entusiasticamente la ricerca<br />
dell‘universalità e uno status di pari dignità con le scienze fisiche che una biologia universale avrebbe<br />
portato con sé.<br />
In questa ricerca, però, essi si sarebbero dovuti scontrare con i biologi evoluzionisti, molto pessimisti sulla<br />
morfologia, se non sulla stessa esistenza degli extraterrestri, che smorzavano, quindi, le aspirazioni di chi<br />
cercava di<br />
estendere i principi della biologia terrestre, con tanta fatica conquistati, all‘universo nel suo complesso o di<br />
incorporare tali principi in una biologia più generale.»<br />
Steven J. DICK, Vita nel cosmo. Esistono gli extraterrestri?, Milano 2002 (ed. originale 1998)<br />
«Gli UFO: visitatori non invitati? In conseguenza delle pressioni dell‘opinione pubblica, negli anni passati,<br />
furono<br />
condotte diverse indagini sugli UFO soprattutto da parte dell‘aeronautica americana, per appurare la natura<br />
del<br />
41
fenomeno. [...] La percentuale, tra i presunti avvistamenti dei casi per i quali non è stato possibile addivenire<br />
a una<br />
spiegazione, allo stato attuale delle nostre conoscenze, è molto bassa, esattamente intorno al 1,5 - 2%. Questa<br />
piccola<br />
percentuale potrebbe essere attribuita in gran parte a suggestioni o visioni, che certamente esistono. [...] Sono<br />
numerose le ipotesi che possono spiegare la natura degli UFO. Si potrebbe, per esempio, pensare che<br />
all‘origine di un<br />
certo numero di avvistamenti vi siano, in realtà, fenomeni geofisici ancora poco conosciuti, oppure velivoli<br />
sperimentali segreti, senza tuttavia escludere del tutto la natura extraterrestre. La verità è che noi non<br />
possiamo<br />
spiegare tutto con la razionalità e le conoscenze. [...] A quanto sembra, logica e metodo scientifico non<br />
sembrano<br />
efficaci nello studio degli UFO per i quali qualsiasi spiegazione è insoddisfacente e/o troppo azzardata.»<br />
Pippo BATTAGLIA -Walter FERRERI, C‘è vita nell’Universo? La scienza e la ricerca di altre civiltà, Torino 2008<br />
Pag. 7/7 Sessione ordinaria 2010<br />
Prima prova scritta<br />
Ministero dell’Istruzione dell’Università e<br />
della Ricerca<br />
«Se fosse possibile assodare la questione mediante una qualche esperienza, io sarei pronto a scommettere<br />
tutti i<br />
miei averi, che almeno in uno dei pianeti che noi vediamo vi siano degli abitanti. Secondo me, perciò, il fatto<br />
che<br />
anche in altri mondi vi siano abitanti non è semplicemente oggetto di opinione, bensì di una salda fede<br />
(sull‘esattezza di tale credenza, io arrischierei infatti molti vantaggi della vita).»<br />
Immanuel KANT, Critica della ragione pura, Riga 1787 (1a ed. 1781)<br />
«Come si spiega dunque la mancanza di visitatori extraterrestri? È possibile che là, tra le stelle, vi sia una<br />
specie<br />
progredita che sa che esistiamo, ma ci lascia cuocere nel nostro brodo primitivo. Però è difficile che abbia<br />
tanti<br />
riguardi verso una forma di vita inferiore: forse che noi ci preoccupiamo di quanti insetti o lombrichi<br />
schiacciamo sotto<br />
i piedi? Una spiegazione più plausibile è che vi siano scarsissime probabilità che la vita si sviluppi su altri<br />
pianeti o<br />
che, sviluppatasi, diventi intelligente. Poiché ci definiamo intelligenti, anche se forse con motivi poco<br />
fondati, noi<br />
tentiamo di considerare l‘intelligenza una conseguenza inevitabile dell‘evoluzione, invece è discutibile che<br />
sia così. I<br />
batteri se la cavano benissimo senza e ci sopravviveranno se la nostra cosiddetta intelligenza ci indurrà ad<br />
autodistruggerci in una guerra nucleare. [...] Lo scenario futuro non somiglierà a quello consolante definito<br />
da STAR<br />
TRECK, di un universo popolato da molte specie di umanoidi, con una scienza ed una tecnologia avanzate<br />
ma<br />
fondamentalmente statiche. Credo che invece saremo soli e che incrementeremo molto, e molto in fretta, la<br />
complessità biologica ed elettronica.»<br />
Stephen HAWKING, L’universo in un guscio di noce, Milano 2010 (ed. originale 2001)<br />
«La coscienza, lungi dall‘essere un incidente insignificante, è un tratto fondamentale dell‘universo, un<br />
prodotto<br />
naturale del funzionamento delle leggi della natura, alle quali è collegata in modo profondo e ancora<br />
misterioso. Ci<br />
tengo a ripeterlo: non sto dicendo che l‘Homo sapiens in quanto specie sia inscritto nelle leggi della natura; il<br />
mondo non è stato creato per noi, non siamo al centro del creato, né ne siamo la cosa più significativa. Ma<br />
questo<br />
non vuol dire neanche che siamo completamente privi di significato! Una delle cose più deprimenti degli<br />
ultimi tre<br />
secoli di scienza è il modo in cui si è cercato di emarginare, rendere insignificanti, gli esseri umani, e quindi<br />
42
alienarli dall‘universo in cui vivono. Io sono convinto che abbiamo un posto nell‘universo, non un posto<br />
centrale,<br />
ma comunque una posizione significativa. […] Se questo modo di vedere le cose è giusto, se la coscienza è<br />
un<br />
fenomeno basilare che fa parte del funzionamento delle leggi dell‘universo, possiamo supporre che sia<br />
emersa<br />
anche altrove. La ricerca di esseri alieni può dunque essere vista come un modo per mettere alla prova<br />
l‘ipotesi che<br />
viviamo in un universo che non solo è in evoluzione, come dimostra l‘emergere della vita e della coscienza<br />
dal caos<br />
primordiale, ma in cui la mente svolge un ruolo fondamentale. A mio avviso la conseguenza più importante<br />
della<br />
scoperta di forme di vita extraterrestri sarebbe quella di restituire agli esseri umani un po‘ di quella dignità di<br />
cui la<br />
scienza li ha derubati.»<br />
Paul C.W. DAVIES, Siamo soli? Implicazioni filosofiche della scoperta della vita extraterrestre, Roma-Bari 1998 (1a ed.<br />
1994)<br />
TIPOLOGIA C - TEMA DI ARGOMENTO STORICO<br />
Ai sensi della legge 30 marzo 2004, n. 92, ―la Repubblica riconosce il 10 febbraio quale «Giorno del<br />
ricordo» al fine di<br />
conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell‘esodo<br />
dalle loro terre<br />
degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale‖.<br />
Il candidato delinei la ―complessa vicenda del confine orientale‖, dal Patto (o Trattato) di Londra (1915) al<br />
Trattato di<br />
Osimo (1975), soffermandosi, in particolare, sugli eventi degli anni compresi fra il 1943 e il 1954.<br />
TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE<br />
La musica — diceva Aristotele (filosofo greco del IV sec. a.C.) — non va praticata per un unico tipo di<br />
beneficio<br />
che da essa può derivare, ma per usi molteplici, poiché può servire per l‘educazione, per procurare la catarsi<br />
e in<br />
terzo luogo per la ricreazione, il sollievo e il riposo dallo sforzo.<br />
Il candidato si soffermi sulla funzione, sugli scopi e sugli usi della musica nella società contemporanea.<br />
Se lo ritiene opportuno, può fare riferimento anche a sue personali esperienze di pratica e/o di ascolto<br />
musicale.<br />
__________________________<br />
Durata massima della prova: 6 ore.<br />
È consentito soltanto l‘uso del dizionario italiano.<br />
Non è consentito lasciare l‘Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.<br />
43
Testo della simulazione della terza prova scritta (tipologia mista)<br />
GEOGRAFIA TURISITCA<br />
1) Gerusalemme è una città santa per queste tre grandi religioni monoteistiche:<br />
a. Buddismo, ebraismo e cristianesimo<br />
b. Islamismo, cristianesimo e buddismo<br />
c. Ebraismo, islamismo e induismo<br />
d. Cristianesimo, ebraismo e islamismo<br />
2) Lo Stato turisticamente più importante nel mercato internazionale è sicuramente:<br />
a. Turchia<br />
b. Israele<br />
c. Arabia Saudita<br />
d. Giordania<br />
3) Nel corso della sua storia, la capitale economica, culturale e turistica della Turchia ha<br />
cambiato nome, in questo ordine cronologico, dal più antico all’attuale:<br />
a. Troia, Bisanzio, Costantinopoli, Istanbul<br />
b. Bisanzio, Costantinopoli, Istanbul<br />
c. Bisanzio, Troia, Costantinopoli, Istanbul<br />
d. Costantinopoli, Bisanzio, Istanbul<br />
4) Lo Stato che possiede il maggior numero di beni naturali, culturali e misti, dichiarati dall’UNESCO<br />
patrimonio dell’umanità è:<br />
a. Israele<br />
b. Siria<br />
c. Arabia Saudita<br />
d. Turchia<br />
TEST A RISPOSTA APERTA (max 8 righe per quesito)<br />
5) Quali sono i luoghi più visitati dei grandi centri religiosi, mete di pellegrinaggio, che<br />
si trovano nell‘Asia occidentale?<br />
____________________________________________________________________<br />
____________________________________________________________________<br />
____________________________________________________________________<br />
____________________________________________________________________<br />
____________________________________________________________________<br />
____________________________________________________________________<br />
____________________________________________________________________<br />
_____________________________________<br />
6) Quali sono i principali fattori culturali, economici e politici della forte instabilità che<br />
caratterizza l‘Asia occidentale?<br />
________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________<br />
_________________________________<br />
45
1) Solo una di queste affermazioni<br />
è corretta<br />
2) L‘Impressionismo è:<br />
Prova simulata di Storia dell‘Arte<br />
a) Gli Impressionisti mantennero i<br />
legami con la pittura accademica.<br />
b)La prima mostra si tenne al<br />
bar delle Folies-Bergères<br />
c) Gli Impressionisti dipingono<br />
usando il metodo en plein-air<br />
d) Gli Impressionisti colgono della<br />
realtà l‘attimo pregnante.<br />
a)una corrente artistica della II<br />
metà dell‘800 il cui precursore fu E. Manet.<br />
b)una corrente artistica della II metà<br />
dell‘800 che usa una tecnica cromatica molto pastosa.<br />
c)un movimento artistico le cui opere<br />
vengono realizzate solo in atelier.<br />
d) Un movimento artistico della I metà<br />
dell‘800 che studia la realtà cogliendone l‘impressione<br />
46
3) L‘autore di ―Colazione sull‘erba‖ è :<br />
4)L‘autore de ―I papaveri‖ è<br />
Si commenti in cinque righe ―La lezione di ballo‖ di Degas<br />
a)E. Manet<br />
b) C. Monet<br />
c) E. Degas<br />
d)P. Cézanne<br />
a) C. Monet<br />
b) E. Degas<br />
c) E. Manet<br />
d) P. Cézanne<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
Si commenti in cinque righe ―Impressione sole nascente‖ di C. Monet<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
47
SIMULAZIONE LINGUA INGLESE - TERZA PROVA -V A-B SIRIO –A.S. 2010/11<br />
ANSWER TO THE FOLLOWING QUESTIONS - CHOOSE THE RIGHT OPTION<br />
1) In the “Tomba dei rilievi” you can see stuccoes depicting:<br />
a) Animals, tools and beds cut in stone<br />
b) Shields and chairs<br />
c) Tools, animals and scenes of everyday life<br />
d) Six beds with pillows<br />
2) The Necropolis of Monterozzi boasts:<br />
a) The ruins of the ancient city Caere<br />
b) Roads and tombs which look like houses<br />
c) Tombs with wonderful paintings<br />
d) A museum with important Etruscan artcrafts<br />
3) Caere was:<br />
a) A burial ground<br />
b) An Unesco awarded city<br />
c) A merchant city<br />
d) A battle ground<br />
4) In the historic centre of Tarquinia you can see:<br />
a) The ―Fontana del mascherone‖<br />
b) A castle<br />
c) Palazzo Vitelleschi<br />
d) The church of Santa Maria Maggiore<br />
Describe the historic centres of Tarquinia and Cerveteri<br />
________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________<br />
What part of Italy does Canino belong to? What can you see in and around the city?<br />
________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________<br />
48
FRANCESE<br />
Simulazione terza prova di Esame di Stato ―Sirio Turistico‖ A.S. 2010-2011<br />
Corsista______________________<br />
Classe____________<br />
Quesiti con risposta a scelta multipla (segnare con una croce la risposta esatta)<br />
1. Comment se présente la côte de la Corse?<br />
basse et sablonneuse<br />
sableuse à l‘est et rocheuse à l‘ouest<br />
rocheuse à l‘est et sableuse à l‘ouest<br />
la Corse n‘a pas de côte, car c‘est une région de l‘intérieur de la France métropolitaine<br />
2. Qui est Pascal Paoli?<br />
le propriétaire d‘une chaîne hôtelière corse<br />
le premier Consul corse, élu en 1680<br />
un général de l‘armée napoléonienne<br />
un indépendantiste corse<br />
3. Laquelle des propositions suivantes caractérise le Naturalisme?<br />
Le Naturalisme est un courant artistique comprenant la poésie, la peinture et l‘architecture<br />
Le Naturalisme se développa en France au début du XIX e siècle<br />
Le Naturalisme ne peut pas être considéré une école littéraire, car son seul représentant est E. Zola<br />
Le Naturalisme veut faire du roman un instrument scientifique d‘analyse de l‘homme<br />
4. Qu‘est-ce que les Lettres Persanes?<br />
Un recueil de lettres trouvées par Montesquieu au cours de son voyage en Perse<br />
Un drame par lettres dont les protagonistes sont deux fiancés Persans<br />
Un roman par lettres rentrant dans la catégorie des récits de voyage<br />
Le récit des voyages de Montesquieu en Orient<br />
Quesiti a risposta aperta (rispondere rispettando il limite di cinque righe)<br />
5. Qu‘est-ce qu‘on peut admirer dans le jardin de Bomarzo ?<br />
_____________________________________________________________________________<br />
_____________________________________________________________________________<br />
_____________________________________________________________________________<br />
_____________________________________________________________________________<br />
_____________________________________________________________________________<br />
6. Quel(s) élément(s) historique(s) caractérise(nt) la ville de Viterbe ?<br />
_____________________________________________________________________________<br />
_____________________________________________________________________________<br />
_____________________________________________________________________________<br />
_____________________________________________________________________________<br />
_____________________________________________________________________________<br />
49
Scheda n° 13<br />
GRIGLIE DI CORREZIONE<br />
ALUNNO__________________________________________ classe___________<br />
TIPOLOGIA A (Analisi e commento di un testo)<br />
GRIGLIE DI CORREZIONE DELLA I PROVA<br />
Indicatori Descrittori Punteggio Punteggio<br />
prova<br />
a Completa 4<br />
Comprensione del testo<br />
b Parziale<br />
c Frammentaria<br />
3<br />
2<br />
Capacità di analisi del testo<br />
Conoscenza relativa agli<br />
approfondimenti<br />
Uso del linguaggio<br />
TIPOLOGIA B (Saggio breve o articolo di giornale)<br />
d Scarsa 1<br />
a Dettagliata e argomentata 4<br />
b Parziale ma argomentata 3<br />
c Parziale e mnemonica, ma pertinente 2<br />
d Frammentaria ma pertinente 1<br />
a Ricca e pertinente 4<br />
b Parziale ma pertinente 3<br />
c Frammentaria ma pertinente 2<br />
d Frammentaria e poco pertinente 1<br />
a Padroneggiato e pertinente 3<br />
b Non sempre corretto, ma pertinente 2<br />
Non sempre corretto e pertinente, ma<br />
c<br />
comprensibile<br />
1<br />
PUNTEGGIO DELLA PROVA /15<br />
Indicatori Descrittori Punteggio Punteggio<br />
prova<br />
Utilizzazione della<br />
documentazione fornita<br />
Rispetto della consegna<br />
(scelta del titolo,<br />
a Ampia o coerente 3<br />
b Parziale ma coerente 2<br />
c Scarsa ma coerente 1<br />
a Coerente e originale 3<br />
b Non sempre coerente ma originale 2<br />
50
destinazione editoriale,<br />
ampiezza del testo,<br />
adeguatezza del registro)<br />
Informazioni, conoscenze<br />
relative agli argomenti<br />
trattati<br />
Capacità di argomentazione<br />
Uso del linguaggio<br />
TIPOLOGIA C (Sviluppo di un argomento storico)<br />
TIPOLOGIA D (Trattazione di un tema)<br />
c Parzialmente coerente 1<br />
a Corrette e pertinenti 4<br />
b Parziali ma pertinenti 3<br />
c Frammentarie ma pertinenti 2<br />
d Frammentarie e poco pertinenti 1<br />
a Logica, coesa, coerente 2<br />
b Parzialmente logica e coerente 1<br />
a Padroneggiato e pertinente 3<br />
b Non sempre corretto, ma pertinente 2<br />
Non sempre corretto e pertinente, ma<br />
c<br />
comprensibile<br />
1<br />
PUNTEGGIO DELLA PROVA /15<br />
GRIGLIE DI CORREZIONE DELLA I PROVA<br />
Indicatori Descrittori Punteggio Punteggio<br />
prova<br />
Uso del linguaggio<br />
Conoscenza relativa agli<br />
argomenti trattati<br />
Capacità di elaborazione<br />
delle conoscenze<br />
Capacità di argomentazione<br />
Capacità di organizzazione<br />
del testo<br />
a Padroneggiato e pertinente 3<br />
b Non sempre corretto, ma pertinente 2<br />
Non sempre corretto e pertinente, ma<br />
c<br />
comprensibile<br />
1<br />
a Approfondita e pertinente 4<br />
b Parziale ma pertinente 3<br />
c Frammentaria ma pertinente 2<br />
d Frammentaria e poco pertinente 1<br />
a Personale e critica 3<br />
b Mnemonica ma pertinente 2<br />
c Mnemonica e poco pertinente 1<br />
a Rigorosa, coesa, coerente 2<br />
b Parzialmente logica e coerente 1<br />
a Testo coeso, ben strutturato 3<br />
b Parzialmente organico 2<br />
c Poco coeso, poco organico 1<br />
PUNTEGGIO DELLA PROVA /15<br />
51
Scheda n 13<br />
GRIGLIA DI CORREZIONE<br />
52
Scheda n 13<br />
GRIGLIA DI CORREZIONE III PROVA<br />
Simulazione della Terza Prova – Formato misto (B + C)<br />
4 quesiti a risposta multipla a tre item; 2 quesiti a risposta singola (max 6 righe)<br />
Griglia di valutazione Terza Prova per MATERIA ____________________<br />
CORSISTA ____________________________ Classe ______________<br />
Scala di valutazione dei quesiti a risposta multipla<br />
Punti 2 Risposta esatta<br />
Punti 0 Risposta errata<br />
Quesiti a risposta multipla Punti<br />
QUESITO 1<br />
QUESITO 2<br />
QUESITO 3<br />
QUESITO 4<br />
Totale /8<br />
Scala di valutazione dei quesiti a risposta singola – QUESITO 5<br />
Punti Giudizio Indicatori Indicatori Indicatori<br />
USO DEL LINGUAGGIO CONOSCENZA<br />
SINTESI<br />
SPECIFICO<br />
DELL’ARGOMENTO<br />
3.50 Ottimo Elaborato, di ottimo livello Ottima Di ottimo livello<br />
3 Buono Appropriato Buona Buona<br />
2.50 Discreto Abbastanza corretto Discreta Abbastanza buona<br />
2 Sufficiente Non sempre corretto Essenziale Accettabile<br />
1.50 Mediocre Poco corretto Piuttosto ristretta Limitata<br />
1 Insufficiente Scorretto e/o frammentario Molto parziale Inadeguata<br />
0.50 Gravemente Nullo Pressoché inesistente o Assente<br />
insufficiente<br />
nulla<br />
Punti: Punti: Punti:<br />
Scala di valutazione dei quesiti a risposta singola – QUESITO 6<br />
Punti Giudizio Indicatori Indicatori Indicatori<br />
USO DEL LINGUAGGIO CONOSCENZA<br />
SINTESI<br />
SPECIFICO<br />
DELL’ARGOMENTO<br />
3.50 Ottimo Elaborato, di ottimo livello Ottima Di ottimo livello<br />
3 Buono Appropriato Buona Buona<br />
2.50 Discreto Abbastanza corretto Discreta Abbastanza buona<br />
2 Sufficiente Non sempre corretto Essenziale Accettabile<br />
1.50 Mediocre Poco corretto Piuttosto ristretta Limitata<br />
1 Insufficiente Scorretto e/o frammentario Molto parziale Inadeguata<br />
0.50 Gravemente Nullo Pressoché inesistente o Assente<br />
insufficiente<br />
nulla<br />
Punti: Punti: Punti:<br />
N.B. Lo 0.50 viene arrotondato per eccesso. Sommare i punteggi e dividere per tre.<br />
Quesiti a risposta singola Punti<br />
QUESITO 5<br />
QUESITO 6<br />
Totale /7<br />
TOTALE COMPLESSIVO DEI 6 QUESITI Punti /15<br />
53
ISTITUTO TECNICO STATALE PER IL TURISMO<br />
“MARCO POLO”<br />
Griglia di valutazione della Simulazione diTerza Prova<br />
Formato misto (B + C)<br />
Risultato globale di tutte le materie<br />
16 quesiti a risposta multipla a 4 item (4 per ciascuna materia)<br />
8 quesiti a risposta singola (2 per ciascuna materia, max 5 righe)<br />
CORSISTA ____________________________ Classe ______________<br />
Materia 1 Singolo<br />
Materia 2 Singolo<br />
Materia 3 Singolo<br />
Materia 4 Singolo<br />
TOTALE:<br />
Punteggio<br />
N. B. Dividere per 4 il totale riportato in base alla somma dei singoli punteggi ottenuti nelle quattro<br />
materie<br />
Risultato finale della prova Punti: /15<br />
54
Scheda N. 14<br />
FIRME E QUALIFICHE DOCENTI<br />
nome Disciplina firma<br />
ALFONSI LUCIA Italiano e Storia<br />
FAILLA GAETANO Arte e Territorio<br />
SANTILLI FELICE Geografia Turistica<br />
CARACUZZO GIANCARLO Legislaz. Turistica ed<br />
Economia<br />
SANTILLI GIUSEPPE Discipline Turistiche e<br />
Aziendali<br />
RUSSO MARIA Matematica<br />
GATTI BERNARDINO Lingua e civilta‘ Inglese<br />
DESIATO FILOMENA Conversazione Inglese<br />
PISANI ANNA Lingua e civilta‘ Spagnola<br />
HUARCAYA LUZ Conversazione Spagnola<br />
PRATESI FRANCESCA Lingua e civilta‘ Francese<br />
QUINET EMILIE Conversazione Francese<br />
55