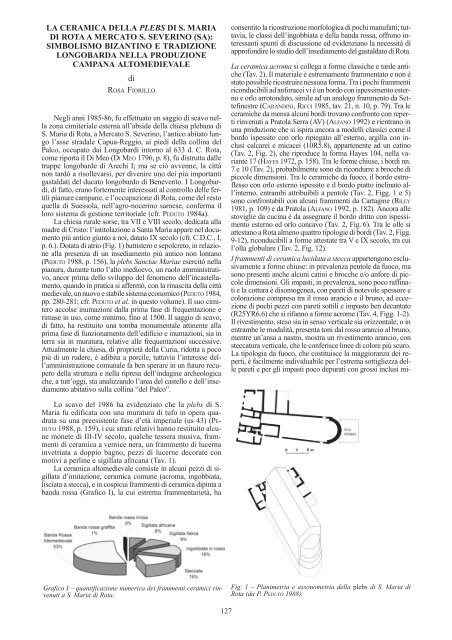LA CERAMICA DELLA PLEBS DI S. MARIA DI ROTA A ... - BibAr
LA CERAMICA DELLA PLEBS DI S. MARIA DI ROTA A ... - BibAr
LA CERAMICA DELLA PLEBS DI S. MARIA DI ROTA A ... - BibAr
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>LA</strong> <strong>CERAMICA</strong> DEL<strong>LA</strong> <strong>PLEBS</strong> <strong>DI</strong> S. <strong>MARIA</strong><br />
<strong>DI</strong> <strong>ROTA</strong> A MERCATO S. SEVERINO (SA):<br />
SIMBOLISMO BIZANTINO E TRA<strong>DI</strong>ZIONE<br />
LONGOBARDA NEL<strong>LA</strong> PRODUZIONE<br />
CAMPANA ALTOME<strong>DI</strong>EVALE<br />
di<br />
ROSA FIORILLO<br />
Negli anni 1985-86, fu effettuato un saggio di scavo nella<br />
zona cimiteriale esterna all’abside della chiesa plebana di<br />
S. Maria di Rota, a Mercato S. Severino, l’antico abitato lungo<br />
l’asse stradale Capua-Reggio, ai piedi della collina del<br />
Palco, occupato dai Longobardi intorno al 633 d. C. Rota,<br />
come riporta il Di Meo (<strong>DI</strong> MEO 1796, p. 8), fu distrutta dalle<br />
truppe longobarde di Arechi I; ma se ciò avvenne, la città<br />
non tardò a risollevarsi, per divenire uno dei più importanti<br />
gastaldati del ducato longobardo di Benevento. I Longobardi,<br />
di fatto, erano fortemente interessati al controllo delle fertili<br />
pianure campane, e l’occupazione di Rota, come del resto<br />
quella di Suessola, nell’agro-nocerino sarnese, conferma il<br />
loro sistema di gestione territoriale (cfr. PEDUTO 1984a).<br />
La chiesa rurale sorse, tra VII e VIII secolo, dedicata alla<br />
madre di Cristo: l’intitolazione a Santa Maria appare nel documento<br />
più antico giunto a noi, datato IX secolo (cfr. C.D.C., I,<br />
p. 6.). Dotata di atrio (Fig. 1) battistero e sepolcreto, in relazione<br />
alla presenza di un insediamento più antico non lontano<br />
(PEDUTO 1988, p. 156), la plebs Sanctae Mariae esercitò nella<br />
pianura, durante tutto l’alto medioevo, un ruolo amministrativo,<br />
ancor prima dello sviluppo del fenomeno dell’incastellamento,<br />
quando in pratica si affermò, con la rinascita della città<br />
medievale, un nuovo e stabile sistema economico (PEDUTO 1984,<br />
pp. 280-281; cfr. PEDUTO et al. in questo volume). Il suo cimitero<br />
accolse inumazioni dalla prima fase di frequentazione e<br />
rimase in uso, come minimo, fino al 1500. Il saggio di scavo,<br />
di fatto, ha restituito una tomba monumentale attinente alla<br />
prima fase di funzionamento dell’edificio e inumazioni, sia in<br />
terra sia in muratura, relative alle frequentazioni successive.<br />
Attualmente la chiesa, di proprietà della Curia, ridotta a poco<br />
più di un rudere, è adibita a porcile, tuttavia l’interesse dell’amministrazione<br />
comunale fa ben sperare in un futuro recupero<br />
della struttura e nella ripresa dell’indagine archeologica<br />
che, a tutt’oggi, sta analizzando l’area del castello e dell’insediamento<br />
abitativo sulla collina “del Palco”.<br />
Lo scavo del 1986 ha evidenziato che la plebs di S.<br />
Maria fu edificata con una muratura di tufo in opera quadrata<br />
su una preesistente fase d’età imperiale (us 43) (PE-<br />
DUTO 1988, p. 159), i cui strati relativi hanno restituito alcune<br />
monete di III-IV secolo, qualche tessera musiva, frammenti<br />
di ceramica a vernice nera, un frammento di lucerna<br />
invetriata a doppio bagno, pezzi di lucerne decorate con<br />
motivi a perline e sigillata africana (Tav. 1).<br />
La ceramica altomedievale consiste in alcuni pezzi di sigillata<br />
d’imitazione, ceramica comune (acroma, ingobbiata,<br />
lisciata a stecca), e in cospicui frammenti di ceramica dipinta a<br />
banda rossa (Grafico I), la cui estrema frammentarietà, ha<br />
Grafico I – quantificazione numerica dei frammenti ceramici rinvenuti<br />
a S. Maria di Rota.<br />
127<br />
consentito la ricostruzione morfologica di pochi manufatti; tuttavia,<br />
le classi dell’ingobbiata e della banda rossa, offrono interessanti<br />
spunti di discussione ed evidenziano la necessità di<br />
approfondire lo studio dell’insediamento del gastaldato di Rota.<br />
La ceramica acroma si collega a forme classiche e tarde antiche<br />
(Tav. 2). Il materiale è estremamente frammentato e non è<br />
stato possibile ricostruire nessuna forma. Tra i pochi frammenti<br />
riconducibili ad anforacei vi è un bordo con ispessimento esterno<br />
e orlo arrotondato, simile ad un analogo frammento da Settefinestre<br />
(CARAN<strong>DI</strong>NI, RICCI 1985, tav. 21, n. 10, p. 79). Tra le<br />
ceramiche da mensa alcuni bordi trovano confronto con reperti<br />
rinvenuti a Pratola Serra (AV) (ALFANO 1992) e rientrano in<br />
una produzione che si ispira ancora a modelli classici come il<br />
bordo ispessito con orlo ripiegato all’esterno, argilla con inclusi<br />
calcarei e micacei (10R5.8), appartenente ad un catino<br />
(Tav. 2, Fig. 2), che riproduce la forma Hayes 104, nella variante<br />
17 (HAYES 1972, p. 158). Tra le forme chiuse, i bordi nn.<br />
7 e 10 (Tav. 2), probabilmente sono da ricondurre a brocche di<br />
piccole dimensioni. Tra le ceramiche da fuoco, il bordo estroflesso<br />
con orlo esterno ispessito e il bordo piatto inclinato all’interno,<br />
entrambi attribuibili a pentole (Tav. 2, Figg. 1 e 5)<br />
sono confrontabili con alcuni frammenti da Cartagine (RILEY<br />
1981, p. 109) e da Pratola (ALFANO 1992, p. 182). Ancora alle<br />
stoviglie da cucina è da assegnare il bordo dritto con ispessimento<br />
esterno ed orlo concavo (Tav. 2, Fig. 6). Tra le olle si<br />
attestano a Rota almeno quattro tipologie di bordi (Tav. 2, Figg.<br />
9-12), riconducibili a forme attestate tra V e IX secolo, tra cui<br />
l’olla globulare (Tav. 2, Fig. 12).<br />
I frammenti di ceramica lucidata a stecca appartengono esclusivamente<br />
a forme chiuse: in prevalenza pentole da fuoco, ma<br />
sono presenti anche alcuni catini e brocche e/o anfore di piccole<br />
dimensioni. Gli impasti, in prevalenza, sono poco raffinati<br />
e la cottura è disomogenea, con pareti di notevole spessore e<br />
colorazione compresa tra il rosso arancio e il bruno, ad eccezione<br />
di pochi pezzi con pareti sottili e impasto ben decantato<br />
(R25YR6.6) che si rifanno a forme acrome (Tav. 4, Figg. 1-2).<br />
Il rivestimento, steso sia in senso verticale sia orizzontale, o in<br />
entrambe le modalità, presenta toni dal rosso arancio al bruno,<br />
mentre un’ansa a nastro, mostra un rivestimento arancio, con<br />
steccatura verticale, che le conferisce linee di colore più scuro.<br />
La tipologia da fuoco, che costituisce la maggioranza dei reperti,<br />
è facilmente individuabile per l’estrema sottigliezza delle<br />
pareti e per gli impasti poco depurati con grossi inclusi mi-<br />
Fig. 1 – Planimetria e assonometria della plebs di S. Maria di<br />
Rota (da P. PEDUTO 1988).
Tav. 1 – Ceramica sigillata<br />
cacei; tuttavia l’estrema frammentarietà dei reperti, per la maggior<br />
parte relativa a pareti, ha limitato la ricostruzione morfologica.<br />
Due fondi con piede a disco presentano stringente analogia<br />
con manufatti di V-VI secolo da Lacco Ameno (NA)<br />
(D’AGOSTINO, MARAZZI 1985, fig. 2 tipo 1-2, p. 720), S. Pietro<br />
a Corte (SA) e, ancora una volta, da Pratola Serra (SAPORI-<br />
TO 1992, tav. LXI n. 112) (Tav. 3, Fig. 4).<br />
Per la ceramica ingobbiata, ben attestata sul territorio nazionale<br />
tra V e VII secolo, sono stati recuperati frammenti distinguibili<br />
in due tipologie: semplice e a decorazione graffita. All’ingobbiata<br />
semplice rinvenuta a Rota sono riconducibili forme<br />
da mensa e da cucina ulteriormente distinte in due gruppi.<br />
Ad un primo insieme sono da assegnare frammenti che possono<br />
essere considerati un ottimo tentativo d’imitazione della<br />
ceramica sigillata. I bordi appartengono a catini e piatti di grandi<br />
dimensioni (Ø 32-50 cm), con impasti ben decantati di colore<br />
rosso-arancio, pochi inclusi, coperta brillante d’ottima fattura,<br />
conforme a quella del biscotto, in numerosi casi ben stesa solo<br />
sulla superficie a vista del manufatto, (Tav. 4, Figg. 5-8 e 15)<br />
peculiarità attestata anche tra i reperti di Pratola Serra (ALFA-<br />
NO 1992, p. 173) (tra questi prodotti alcuni potrebbero rientrare<br />
nella classe della cosidetta sigillata d’imitazione, ma non<br />
essendo ancora del tutto definite le modalità distintive per questa<br />
tipologia, ho ritenuto più opportuno, per il momento, includere<br />
questi manufatti nella classe dell’ingobbiata). Il frammento<br />
della n. 15 della Tav. 4, caratterizzato dal bordo con inflessione<br />
interna ed esterna e orlo convesso (Ø 32 cm), è del tutto<br />
simile ad un frammento acromo (Tav. 2, Fig. 2); entrambi i<br />
reperti sono confrontabili con un frammento acromo da Pratola<br />
Serra (ALFANO 1992, p. 179 e tav. LVI n. 57) che, a differenza,<br />
mostra un diametro inferiore (Ø 24 cm) e si rifanno ancora a<br />
modelli in terra sigillata di fine IV e inizi del V secolo. Diversi<br />
frammenti, più numerosi, presentano un impasto meno depurato<br />
di colore chiaro e una dipintura evanide, di un rosso meno<br />
brillante, stesa non più per immersione, ma a pennellate (Tav.<br />
4, Figg. 11 e 16) come il bordo con orlo estroflesso e tesa<br />
terminante a punta (Tav. 4, Fig. 16) che, attestato anche nella<br />
produzione di ceramica acroma, richiama una forma relativa<br />
alla ceramica comune di I-III sec. d.C. ed è confrontabile con<br />
un reperto napoletano (cfr. CARSANA 1994, fig. 109, n. 14.5,<br />
p. 231) databile tra la fine del V e l’inizio del VI secolo. Un<br />
bordo con inflessione interna, orlo arrotondato e pareti svasate,<br />
riconducibile ad una ciotola (Ø 18 cm), presenta, all’interno,<br />
tracce di steccatura. L’impasto, colore rosso-arancio, è ben<br />
depurato (25YR6.6) e il pezzo è confrontabile con un analogo<br />
reperto rinvenuto sempre a Pratola Serra (SAPORITO 1992, tav.<br />
LXII n. 126) datato tra VI e VII secolo (Tav. 4 Fig. 14). Alla<br />
128<br />
Tav. 2 – Ceramica acroma altomedievale<br />
produzione di ceramica ingobbiata meno raffinata appartengono<br />
anche alcuni frammenti che si distinguono ulteriormente<br />
per la presenza dell’ingobbio rosso che, dato in maniera disomogenea,<br />
è talmente sottile e rado da essersi conservato solo<br />
in parte (Tav. 4, Figg. 1, 3, 4, 10, 12); il fondo con piede a<br />
disco raccordato alla parete da una scanalatura ha un ingobbio<br />
opaco steso a risparmio (Tav. 4, Fig. 18).<br />
Per la tipologia da fuoco relativa alla ceramica ingobbiata,<br />
i manufatti presentano un impasto grossolano con
Tav. 3 – Ceramica lisciata a stecca<br />
numerosi macroinclusi e ingobbio di colore scuro steso a<br />
pennellate (Tav. 4, Figg. 1, 7, 9, 13); anche per questa tipologia<br />
è evidente il richiamo a forme classiche. Il bordo con<br />
orlo concavo, ispessimento interno e parete interna concava<br />
è il rifacimento di una tipologia classica attestata tra il<br />
150 e il 200 d.C. (Tav. 4, Fig. 13), mentre il bordo con orlo<br />
ispessito e ripiegato verso l’esterno, relativo ad una probabile<br />
casseruola (Tav. 4, Fig. 1), è confrontabile con un frammento<br />
rinvenuto a Pratola Serra. La posizione delle tracce<br />
di bruciato orienta verso un uso dei manufatti per la preparazione<br />
di cibi a riverbero, forse la cottura di zuppe, mentre<br />
l’ingobbio, dove steso all’interno e all’esterno, si presenta<br />
più spesso e potrebbe svolgere una funzione isolante.<br />
Un frammento di ceramica ingobbiata graffita, appartenente<br />
a una forma aperta, è stato rinvenuto in uno strato di<br />
riporto alluvionale. Per l’Italia meridionale questa tipologia<br />
è ulteriormente testimoniata in Campania con due forme chiuse<br />
dallo scavo di Carminiello ai Mannesi a Napoli (ARTHUR<br />
1994, p. 187 e 216), con un boccale dalla chiesa di S. Tommaso<br />
a Cimitile, vicino Nola, esposto nell’antiquarium del<br />
complesso cimiteriale (EBANISTA 2001, p. 68, fig. 51) e con<br />
una brocchetta funeraria da Pontecagnano (SA) (PASTORE<br />
1994). In Basilicata l’ingobbiata graffita è attestata a Ruoti<br />
(PZ) con alcuni frammenti di catini, anfore e brocche<br />
(FREED 1983). Per tutti questi manufatti la datazione sembra<br />
non superare il VII secolo, e il frammento di Rota è da<br />
collocare cronologicamente tra V e VII secolo.<br />
La ceramica a banda rossa rinvenuta a Rota è stata distinta in<br />
banda rossa semplice, banda rossa incisa e banda rossa graffita.<br />
La banda rossa semplice e la banda rossa incisa, sebbene<br />
riconducibili prevalentemente a forme chiuse, brocche, anfore<br />
e olle di medie e piccole dimensioni, presentano un numero<br />
minimo di frammenti appartenenti a catini e coppette. Per la<br />
banda rossa semplice, la decorazione si svolge attraverso spesse<br />
linee verticali in rosso, talvolta in bruno, ad onda e a nastro, e<br />
interessa la pancia, il collo e le anse dei contenitori di forma<br />
chiusa. Nelle forme aperte, il motivo ornamentale è presente<br />
sul bordo e sulla pancia alta, tranne che per un catino e alcune<br />
piccole coppe, dove tracce di decorazione si ritrovano anche<br />
all’interno dei recipienti, probabilmente a causa della colatura<br />
del decoro sul bordo. Le argille ben depurate, i pochi inclusi<br />
micacei e l’assenza di tracce di bruciato confinano l’uso di<br />
questi manufatti all’ambito della mensa e della dispensa o a<br />
quello funerario. Alcuni reperti trovano confronto stringente<br />
con analoghi manufatti rinvenuti in Campania, come il frammento<br />
dell’olla dal bordo estroflesso raffrontabile con un frammento<br />
di Pratola Serra (cfr. SAPORITO 1992, tav. LX n. 101), il<br />
fondo di brocchetta con banda verticale comparabile con una<br />
brocchetta da Altavilla Silentina (SA) (cfr. IACOE 1984, p. 101<br />
129<br />
e tav. XX tipo a) e il fondo con piede a disco, confrontabile con<br />
un analogo reperto rinvenuto a S. Salvatore Telesino (BN) (cfr.<br />
<strong>DI</strong> COSMO 1993, tav. 4, n. 5) (Tav. 5, Figg. 2-4).<br />
I tre reperti di banda rossa incisa, molto frammentari,<br />
sono riconducibili a forme aperte come testimonia il bordo<br />
con incisione ad onda sul bordo esterno e sul corpo (Tav. 5).<br />
Il frammento trova ampi confronti con reperti campani come<br />
quelli dell’area arechiana salernitana (Tav. 6) (768-IX secolo),<br />
di Capaccio (IANNELLI 1984A-B, tavv. 39 e 41), di<br />
Napoli (ARTHUR 1994), di Montella (EBANISTA 1998) e di<br />
Benevento, dove, presente con un’alta percentuale di forme<br />
aperte tale tipologia è datata tra l’VIII e l’XI secolo<br />
(CARSANA, SCARPATI 1998, pp. 135 ss.). A questi rinvenimenti<br />
campani vanno aggiunti i manufatti provenienti dallo scavo<br />
della grotta di S. Michele ad Olevano sul Tusciano (IX-<br />
X secolo), per i quali si rimanda all’articolo presentato nel<br />
volume (SAPORITO infra). In Italia meridionale, inoltre, la<br />
banda rossa incisa è attestata in Calabria dove è presente a<br />
Casignana Palazzi (BARELLO, CARDOSA 1991), Calandrino<br />
(ROMA 2001, p. 22), Cropani (cfr. in questo volume AIZA,<br />
CORRADO, DE VINGO).<br />
La banda rossa graffita, attestata con dieci frammenti, è<br />
riconducibile ad almeno sette forme chiuse (Tav. 5, Figg. 7-<br />
10). La lavorazione è raffinata, con pareti sottili e argilla ben<br />
depurata priva di inclusi e il colore della decorazione varia dal<br />
rosso al bruno. I motivi dipinti, in considerazione della frammentarietà<br />
dei reperti, sono da ricondurre a linee parallele, e in<br />
due casi al motivo dell’arco decorato con linee verticali, rinvenuto<br />
anche a Salerno e ampiamente attestato a Benevento. I<br />
frammenti salernitani provengono dall’area palaziale<br />
arechiana, e sono stati rinvenuti in strati formatisi tra la fine<br />
dell’VIII secolo e il IX, mentre quelli di Benevento provengono<br />
in misura maggiore da contesti datati tra fine VIinizi<br />
VII e il XII secolo. A tale proposito va precisato che nel<br />
caso di S. Maria non è possibile ricondurre i frammenti né a<br />
corredi funerari né a suppellettili da mensa, in quanto questi,<br />
così come quelli con decorazione incisa, sono stati rinvenuti in<br />
uno strato di terreno di riporto alluvionale (US 9). Recuperati,<br />
dunque, insieme a materiali premedievali e moderni, non sono<br />
nemmeno databili stratigraficamente, pertanto la loro attribuzione<br />
al V secolo, proposta alcuni anni fa (PASTORE 1995), è<br />
metodologicamente errata; essa si basava principalmente sul<br />
confronto tra questi reperti e alcuni manufatti in comune dipinta<br />
incisa, come la brocchetta da Pontecagnano rinvenuta in<br />
una tomba nel 1929, e i rinvenimenti dall’area del S. Giovanni<br />
di Ruoti (PZ), che, ingobbiati a risparmio, furono dalla Pastore<br />
associati alla classe della banda rossa. Si vuole pertanto<br />
qui precisare che quando si parla di “graffita” ci si riferisce<br />
alla tecnica decorativa che, mediante l’uso di una punta o di<br />
una stecca, asporta la decorazione superficiale della banda in-
Tav. 4 – Ceramica ingobbiata<br />
sieme ad una parte dell’argilla, realizzando una voluta bicromia.<br />
Il termine “incisa” è riferito all’uso che vede l’asportazione<br />
dell’argilla non cotta prima della dipintura, sicché il colore<br />
rosso sovrapposto ne riempie i solchi. Pochi frammenti, inoltre,<br />
provenienti sia da S. Maria di Rota e sia da Salerno, mostrano<br />
una decorazione non propriamente incisa, ma piuttosto<br />
realizzata a sgraffio sopra la banda, con uno strumento molto<br />
sottile che scalfisce appena il manufatto, apparentemente dopo<br />
la cottura. Da quanto esposto in precedenza, la datazione dei<br />
frammenti di banda rossa graffita dalla plebs di S. Maria, per<br />
confronto con analoghi materiali stratigraficamente datati, è<br />
da collocare tra il VII e il XII secolo, come quelli con decorazione<br />
incisa; inoltre se in strati di XII secolo la banda rossa<br />
graffita risulta residua protremmo dire che questa tipologia<br />
si colloca tra VII e X-XI secolo, ma in ogni caso non prima,<br />
in relazione all’attestarsi della banda rossa a partire dal VII<br />
130<br />
secolo in poi. Per ceramica a banda, infatti, si deve intendere<br />
un manufatto dove la decorazione, realizzata con ossidi metallici,<br />
è espressione di un preciso intento decorativo, e va distinta<br />
dalla ceramica “dipinta” in rosso a risparmio, in realtà ingobbiata,<br />
con la quale, in presenza di piccoli frammenti, può<br />
essere confusa. I manufatti a banda rossa, inoltre, in considerazione<br />
dell’alta incidenza di forme chiuse su quelle aperte,<br />
paiono realizzati per contenere liquidi (acqua, olio, vino) e forse,<br />
in una prima fase, affiancarono sulla mensa le produzioni ingobbiate<br />
che, al contrario, mostrano una prevalenza di forme<br />
aperte. In particolare per la Campania, in contesti abitativi il<br />
motivo della banda appare su olle, anfore e brocche di medie<br />
dimensioni, più raramente su catini, mentre la presenza di piccoli<br />
contenitori è scarsamente documentata; in aree cimiteriali<br />
la banda rossa è largamente attestata su brocche, boccali, piccole<br />
anfore e fiasche, mentre in ambito cultuale, come nel caso
Tav. 5 – Ceramica a banda rossa (1-4); banda rossa incisa (5-6); banda rossa graffita (7-10).<br />
Tav. 6 – BR incisa dall’area palaziale di S. Pietro a Corte (SA).<br />
131
Tav. 7 – Sarcofago da Poitiers e tegole da Altavilla Silentina.<br />
specifico della chiesa di S. Maria, la ritroviamo sviluppata anche<br />
su forme aperte riferibili a catini, probabilmente utilizzati<br />
per contenere acqua lustrale nell’ambito di attività religiose,<br />
ma anche vino e olio, ampiamenti impiegati in funzioni liturgiche.<br />
Brocche e anfore dello stesso tipo di quelle di S. Maria,<br />
collocabili tra VII e VIII secolo, e bacini databili tra VII e X<br />
secolo, sono stati reperiti, in Campania, negli scavi di Capaccio<br />
Vecchia (MAETZKE 1976, pp. 86-90), San Lorenzo ad<br />
Altavilla Silentina (SA) (IACOE 1984, pp. 99-102; BISOGNO,<br />
GUARINO 1984, pp. 106-124), Santa Restituta a Ischia (GUARI-<br />
NO, MAURO, PEDUTO 1988, pp. 449-460), San Giovanni di Pratola<br />
Serra (AV) (SAPORITO 1992, pp. 198-202), il castello di Salerno<br />
(PASTORE 1993, pp. 113-122), San Pietro a Corte (SA), a<br />
Napoli (ARTHUR 1994, p. 183, tipo 10, fig. 80 e pp. 214-216) e<br />
negli scavi della citata area di Santa Sofia (CARSANA,<br />
SCARPATI 1998, p. 135, figg. 75-86), con evidente funzione funeraria<br />
e liturgica, pratica, del resto, diffusa in molti contesti<br />
dell’Italia meridionale e della Sicilia. Il bordo con orlo maggiormente<br />
ispessito all’esterno e meno all’interno (Ø 44 cm.)<br />
(Tav. 5, n. 5) è confrontabile con uno dei catini di Ischia datato<br />
al VII secolo: la banda scura presente lungo il bordo e sulla<br />
pancia alta, in alcuni punti è gocciolata all’interno. I contenitori<br />
campani in numerosi casi mostrano motivi ad onda, disegnati<br />
e incisi, in altri bande verticali, in altri ancora i decori<br />
ricordano lo svolgersi di un nastro (Tav. 6), in casi più rari<br />
figurano croci, come la brocchetta proveniente da una sepoltura<br />
nel castello di Salerno che reca dipinta sul fondo proprio<br />
una croce (PASTORE 1993, p. 117, fig. 2). Si vuole ancora qui<br />
segnalare come tali decorazioni siano individuabili, in ambito<br />
funerario, sulle tegole di sepoltura di numerosi cimiteri d’area<br />
romano-bizantina, non solo dell’Italia meridionale, ma anche<br />
del Centro e del Nord. In particolare nei siti cimiteriali di<br />
Altavilla Silentina (BISOGNO 1984, pp. 150-151; tav. LV, figg.<br />
5 e 6; tav. LVI), Pratola Serra (SAPORITO 1992, tav. LXVIII), S.<br />
Pietro a Corte (FIORILLO 1999, pp. 23 e 25; fig. 2), Gravina di<br />
Puglia (D’ANGE<strong>LA</strong> 1988, tav. IV, fig. 4), S. Giusto (DE SANTIS<br />
1998), si è notata una cospicua presenza di tegole decorate con<br />
un simbolo simile ad un nodo, impresso dal figulo con le dita<br />
prima della cottura. In un primitivo tentativo di scioglierne il<br />
significato ritenni possibile per questo segno la derivazione<br />
dalla croce copta, originata a sua volta dall’ankh, il simbolo<br />
della vita usato dagli Egizi sulle tavolette funerarie (FIORILLO<br />
1999, p. 23). La presenza di tegole con tali impressioni in nu-<br />
132<br />
Tav. 8 – Decorazioni ad arco e a graticcio su materiali altomedievali.<br />
merosi cimiteri altomedievali di tutta Italia, elimina l’ipotesi di<br />
un simbolo fortuito, orientando verso una consuetudine comune<br />
ben nota e attestata anche fuori del territorio nazionale,<br />
come dimostra la presenza di questo segno su tegole di VII<br />
secolo esposte nella moschea di Cordova in Spagna. Tale uso<br />
indurrebbe anche a considerare possibile la produzione di tegole<br />
funerarie, come sembra indicare l’embrice di circa 75 cm,<br />
utilizzato come piano di deposizione di una sepoltura infantile<br />
bisoma salernitana e che presenta inciso al centro il medesimo<br />
segno. La presenza di tegole segnate con il nodo a Monte Barro<br />
(UBOL<strong>DI</strong> 2001, pp. 193-196, fig. 202), utilizzate per la copertura<br />
di un tetto, potrebbe essere un reimpiego fortuito, oppure<br />
rappresentare la volontà da parte del costruttore di porre a copertura<br />
dell’abitazione tegole con un simbolo apotropaico. Di<br />
fatto, se il motivo ad onda può essere considerato pregno di<br />
significato sia in ambito pagano sia cristiano, il simbolo impresso<br />
con le dita, che su tegole in successione ricorda proprio<br />
lo svolgersi di un nastro, diviene espressione figurativa puntuale<br />
sul coperchio in pietra di uno dei sarcofagi d’età merovingia<br />
conservato nella chiesa di S. Giovanni a Poitiers, che<br />
raffigura due tegole contrapposte a doppio spiovente entrambe<br />
con il segno del nodo. Ritengo che tale consuetudine ancora<br />
una volta ci conduca ad antiche tradizioni bizantine (Tav.<br />
7), alcune di matrice copta. L’Eucologio Barberini (VIII secolo),<br />
ritenuto inizialmente compilato a Costantinopoli, ed in seguito<br />
attribuito all’Italia meridionale, presenta formule che si<br />
collegano a espressioni rituali italo-greche di area egizia (JACOB<br />
1974). Ritornando al motivo a nastro decorato in rosso sui<br />
contenitori dell’Italia meridionale va detto che, in ambito greco,<br />
l’uso del rosso, simbolo della vita, aveva valenza apotropaica.<br />
Le fonti riportano che, nei riti funerari, esisteva l’antica<br />
usanza, legata all’agape, di portare sulla tomba dei propri<br />
defunti uova colorate di rosso (ancora oggi, in Grecia, nel<br />
giorno di Pasqua si usa decorare di rosso le uova). In Grecia,<br />
inoltre, durante le veglie funebri, per mandare via il demonio,<br />
si dipingevano col sangue le guance dei defunti e le vedove,<br />
nella sepoltura del loro congiunto, depositavano fettucce<br />
di tessuto rosso che stracciavano dal proprio vestito per consegnarsi<br />
al lutto (KOIUKOULES 1940, pp. 4-79). Il nastro rosso<br />
lo rintracciamo ancora una volta in ambito funerario bizantino,<br />
adoperato per legare i capelli del defunto, che raffigurano,<br />
ancora oggi, nell’immaginario popolare, la forza della<br />
vita e in area greca erano considerati sede dell’anima, ragione<br />
accettabile per collegare il pettine al corredo funerario. Le<br />
fasce in rosso, dunque, come già indicava Paolo Peduto (PE-<br />
DUTO 1984b, p. 63; ID 1995), venivano eseguite sui manufatti<br />
sia per allontanare la cattiva sorte, intesa come protezione
contro gli spiriti maligni, sia con funzione apotropaica affinchè<br />
il liquido contenuto non si versasse, e quindi non andasse<br />
perso. Sui bacini rinvenuti nei complessi liturgici e sulle<br />
brocchette funerarie è probabile che stesse ad indicare la sacralità<br />
del liquido utilizzato per le funzioni, tra cui anche il<br />
battesimo o l’estrema unzione.<br />
Stella Patitucci già nel 1977 evidenziava il parallelismo<br />
tra la ceramica a bande dell’Italia meridionale e la ceramica<br />
«a decorazione dipinta in rosso opaco con ampie<br />
linee curve, emersa dagli scavi dell’Agorà di Atene»<br />
(ROBINSON 1959) attribuendole un’origine bizantina (PATI-<br />
TUCCI UGGERI 1977, p. 73). Tale ceramica, secondo Whitehouse,<br />
viene soppiantata a partire dal IX secolo da ceramica<br />
a banda sottile, di origine islamica nord africana (WHITE-<br />
HOUSE 1966). Anche Arthur nel 1994 si sofferma sull’argomento,<br />
ritenendo possibile la derivazione della ceramica<br />
dipinta a bande dalla ingobbiata a risparmio (ARTHUR 1994,<br />
pp. 219-220). Allo stato attuale degli studi una linea di continuità<br />
o forse, di contemporaneità tra la ceramica ingobbiata<br />
e la banda rossa è fornita dal boccale in comune dipinta<br />
graffita rinvenuto a Cimitile. Il piccolo contenitore<br />
mostra una decorazione ad archi, realizzata dopo la dipintura,<br />
del tutto simile alle decorazioni presenti sulle bande<br />
rosse graffite (Tav. 8) di S. Maria di Rota, Salerno e in particolare<br />
Benevento (CARSANA, SCARPATI 1998 in particolare<br />
tav. 16 fig. 8), dove un frammento a banda rossa graffita<br />
(Ibidem 1998, n. 135 della fig. 94, p. 166) mostra una decorazione<br />
radiale del tutto simile ad una analoga decorazione<br />
presente su un frammento di ceramica steccata rinvenuto a<br />
Napoli (ARTHUR 1994, fig. 99, tipo 144.2, p. 212).<br />
Da quanto esposto in precedenza, la brocchetta di<br />
Pontecagnano e il boccale di Cimitile, entrambi in comune<br />
dipinta, il frammento di sigillata napoletana e la<br />
ceramica a banda rossa incisa e graffita di S. Maria di<br />
Rota, Salerno e Benevento, e i rinvenimenti di ceramica<br />
a banda sull’intero territorio campano, mostrano, elementi<br />
comuni, riconducibili alle decorazioni, in alcuni casi alla<br />
morfologia e, nel caso specifico di Rota e Salerno anche<br />
agli impasti, che orientano verso una continuità di produzione,<br />
che pone in primo piano il VII secolo. Inoltre è<br />
possibile cogliere una stretta analogia tra decorazioni<br />
graffite e incise correnti su queste ceramiche campane e<br />
quelle ben più famose, realizzate su pettini in osso, su<br />
placchette da cintura (<strong>LA</strong> ROCCA 1998) e su ceramica sia<br />
a stampo che a sgraffio provenienti dai sepolcreti di VI-<br />
VII secolo di area longobarda (Tav. 7) (cfr. in questo stesso<br />
volume M. DE MARCHI). Questi ornati, che paiono così<br />
perpetuarsi sulla ceramica per circa sei secoli (VI-XI sec.),<br />
sono riconducibili sia a piccoli cerchietti impressi a stampo,<br />
sia a incisioni o sgraffiture di graticci, palmette, linee<br />
ondulate e, in particolare, all’arco decorato con linee verticali<br />
che, ancora a Benevento, rintracciamo anche impresso<br />
a stampo su una lucerna, associato al motivo del quadrupede<br />
(CARSANA, SCARPATI 1998, fig. 67, n. 10, p. 123).<br />
La presenza di queste ceramiche nei siti dei Longobardi<br />
e i motivi raffigurati, vicini alla loro tradizione, ma usati anche<br />
in associazione con alcuni decori della sigillata africana,<br />
consentono di ipotizzare per questi contenitori una specifica<br />
committenza, che parrebbe così attestarsi già a partire dal<br />
VI-VIII secolo e fondere insieme due culture, quella bizantina<br />
e quella longobarda. Inizialmente utilizzate su ceramica<br />
liturgica e funeraria (VI-VII secolo), come sembrano orientare<br />
i rinvenimenti di Cimitile e Pontecagnano, queste decorazioni<br />
dall’VIII secolo in poi continuano ad essere realizzate,<br />
probabilmente su ceramica liturgica e da mensa, assicurando<br />
alla banda rossa incisa e graffita, altri quattro secoli di<br />
produzione. Col tramontare della pratica funeraria relativa<br />
all’uso del corredo, la persistenza dei motivi decorativi di<br />
stampo, per così dire, neolongobardo su ceramiche fini da<br />
mensa, suggerisce la volontà di un popolo che, proprio<br />
nell’VIII secolo, avverte la necessità di ricollegarsi alle proprie<br />
origini attingendo addirittura ai propri antichi decori.<br />
133<br />
BIBLIOGRAFIA<br />
ALFANO L. 1992, Ceramica tardoantica e altomedievale, in P. PE-<br />
DUTO (a cura di), S. Giovanni di Pratola Serra. Archeologia e<br />
storia nel ducato longobardo di Benevento, Salerno, pp. 167-<br />
196.<br />
ARTHUR P. (a cura di) 1994, Ceramica comune tardo-antica e altomedievale,<br />
in Il complesso archeologico di Carminiello ai<br />
Mannesi, Napoli (scavi 1983-84), Galatina (LE), pp. 181-220-<br />
258.<br />
BARELLO F., CARDOSA M. 1991, Casignana Palazzi, in La Calabre<br />
de la fin de l’antiquité au Moyen Âge, Actes de la Table ronde,<br />
(Rome 1er-2 décembre 1989), «MEFRM», 103-2, pp. 669-687.<br />
BISOGNO G. 1984, Tegole e mattoni, in P. PEDUTO (a cura di), Villaggi<br />
fluviali nella Pianura Pestana del secolo VII. La chiesa e la<br />
necropoli di S. Lorenzo di Altavilla Silentina, Salerno, pp. 149-<br />
156.<br />
BISOGNO D., GUARINO V. 1984, La ceramica, in P. PEDUTO (a cura di),<br />
Villaggi fluviali nella Pianura Pestana del secolo VII. La chiesa<br />
e la necropoli di S. Lorenzo di Altavilla Silentina, Salerno,<br />
pp. 103-124.<br />
CARAN<strong>DI</strong>NI A., RICCI A. (a cura di) 1985, Settefinestre. Una villa<br />
schiavistica nell’Etruria romana. La villa e i suoi reperti, III,<br />
Modena.<br />
CARSANA V. 1994, Ceramica da cucina tardoantica e altomedievale,<br />
in P. ARTHUR (a cura di), Il complesso archeologico, cit.,<br />
pp. 221-258.<br />
CARSANA V. 1998, Catalogo. Forme aperte, in V. CARSANA, C.<br />
SCARPATI, Ceramica dipinta a bande larghe, in A. LUPIA (a<br />
cura di), Testimonianze di epoca altomedievale a Benevento.<br />
Lo scavo del Museo del Sannio, Napoli, pp. 138-154.<br />
CARSANA V., SCARPATI C. 1998, La ceramica dipinta e graffita, in<br />
A. LUPIA (a cura di), Testimonianze di epoca altomedievale a<br />
Benevento. Lo scavo del Museo del Sannio, pp. 164-167.<br />
C.D.C. = Codex Diplomaticus Cavensis, vol. I, p. 6.<br />
D’AGOSTINO M., MARAZZI F. 1985, Notizia preliminare sullo studio<br />
dei materiali tardo-antichi di Lacco Ameno, «Archeologia<br />
Medievale», XII, Firenze, fig. 2 tipo 1-2, p. 720.<br />
D’ANGE<strong>LA</strong> C. (a cura di) 1988, Gli scavi del 1953 nel Piano di<br />
Carpino (FG). Le terme e la necropoli altomedievale della<br />
villa di Avicenna, Taranto.<br />
DE SANTIS P. 1998, Le sepolture, in G. VOLPE (a cura di), S. Giusto.<br />
La villa, le ecclesie, Bari, pp. 203-220.<br />
<strong>DI</strong> COSMO L. 1993, La ceramica dipinta a bande rosse della Campania,<br />
in A.U.T., 12, Milano, pp. 149-168.<br />
<strong>DI</strong> MEO 1796, Annali critico-diplomatici del Regno di Napoli e<br />
della mezzana età, Napoli, II.<br />
EBANISTA 1998, La ceramica del castello di Montella (AV), Tesi di<br />
Dottorato in Archeologia medievale.<br />
EBANISTA C. 2001, Il complesso basilicale, in C. EBANISTA,<br />
F. FUSARO, Cimitile. Guida al complesso basilicale e alla città,<br />
Cimitile, pp. 19-88.<br />
FIORILLO R. 1999, Sepolture e società nella Salerno medievale: il<br />
caso di S. Pietro a Corte, «Apollo. Bollettino dei Musei Provinciali»,<br />
XIV, 1998, Napoli, pp. 20-35.<br />
FREED J. 1983, Pottery from the late middens at San Giovanni, in<br />
M. GUALTIERI, M. SALVATORE, A. SMALL (a cura di), Lo scavo<br />
di S. Giovanni di Ruoti e il periodo tardo antico in Basilicata,<br />
Atti della Tavola Rotonda (Roma, 4 luglio 1981), Bari,<br />
pp. 91-103.<br />
GUARINO V., MAURO D., PEDUTO P. 1988, Un tentativo di recupero<br />
di una stratigrafia e materiali vari da collezione: il caso del<br />
complesso ecclesiastico di S. Restituta a Lacco Ameno di<br />
Ischia, «Archeologia Medievale», XV, Firenze, pp. 439-469.<br />
HAYES J.W. 1972, Late roman pottery, London.<br />
IACOE A. 1984 = IACOE, I corredi tombali, in P. PEDUTO (a cura di),<br />
Villaggi fluviali nella Pianura Pestana del secolo VII. La<br />
chiesa e la necropoli di S. Lorenzo di Altavilla Silentina, Salerno,<br />
pp. 97-102.<br />
IANNELLI M.A. 1984a, Quadrato CC19, in Caputaquis Medievale<br />
II, Salerno, pp. 119-139.<br />
IANNELLI M.A. 1984b, Quadrato FFF19, in Caputaquis Medievale<br />
II, Salerno, pp. 163-191.<br />
JACOB A. 1974, L’evoluzione dei libri liturgici bizantini in Calabria<br />
e Sicilia dall’VIII al XIV secolo, con particolare riguardo<br />
ai riti eucaristici, in Calabria bizantina. Vita religiosa e<br />
strutture amministrative, Atti del I e II incontro di Studi Bizantini,<br />
Reggio Calabria, pp. 47-69.
KOIUKOULES 1940 = RF. KOIUKOULES, Buzantin ~ wn nekrik¦ eqima,<br />
EHBS 16 1940, pp. 4-79.<br />
<strong>LA</strong> ROCCA C. 1989, Catalogo, in D. MODONESI, C. <strong>LA</strong> ROCCA (a<br />
cura di), Materiali di età longobarda nel Veronese, Verona,<br />
pp. 125-128 e p. 139.<br />
MAETZKE G. 1976, La ceramica, in P. DELOGU et al., Caputaquis<br />
Medievale I, Salerno, pp. 85-97.<br />
PASTORE I. 1993, La ceramica a bande rosse del castello di Salerno,<br />
«Apollo. Bollettino dei Musei Provinciali», IX, Napoli,<br />
pp. 113-122.<br />
PASTORE I. 1994, Una brocchetta altomedievale da Pontecagnano,<br />
«Apollo. Bollettino dei Musei Provinciali», X, Napoli,<br />
pp. 53-55.<br />
PASTORE I. 1995, La ceramica medievale del castello e dell’area<br />
urbana di Salerno, in E. DE MINICIS (a cura di), Le ceramiche<br />
di Roma e del Lazio in età medievale e moderna, 2, Roma,<br />
pp. 252-264.<br />
PATITUCCI S. 1977, La ceramica medievale pugliese alla luce degli<br />
scavi di Mesagne, Mesagne.<br />
PEDUTO P. 1984a, Torri e castelli longobardi in Italia meridionale:<br />
una nuova proposta, in R. COMBA, A. SETTIA (a cura di),<br />
Castelli. Storia e Archeologia, Torino, pp. 391-399.<br />
PEDUTO P. 1984b, Lo scavo della Plebs, in P. PEDUTO (a cura di),<br />
Villaggi fluviali nella Pianura Pestana del secolo VII. La<br />
chiesa e la necropoli di S. Lorenzo di Altavilla Silentina, Salerno,<br />
pp. 29-78.<br />
PEDUTO P. 1988, Dalla città di Rota al castello dei Sanseverino:<br />
un progetto di scavo territoriale, «Rassegna Storica Salernitana»,<br />
n.s. V 1, pp. 155-160.<br />
134<br />
PEDUTO P. 1992, Le scoperte di Pratola Serra e l’evoluzione dei<br />
Longobardi in Campania, in P. PEDUTO (a cura di), S. Giovanni<br />
di Pratola Serra. Archeologia e storia nel ducato longobardo<br />
di Benevento, Salerno, pp. 11-50.<br />
PEDUTO P. 1994, La Campania, in R. FRANCOVICH, G. NOYÉ (a cura<br />
di), La storia dell’alto Medioevo italiano (VI-X secolo) alla<br />
luce dell’archeologia, Firenze, pp. 279, 287.<br />
PEDUTO P. 1995, Caronte. Un obolo per l’aldilà, «La parola del<br />
passato», L (1995), III-IV, pp. 311-318.<br />
RILEY J.A. 1981, The pottery from Cisterns 1977.1, 1977.2, 1977.3,<br />
in Excavation at Chartage 1977 conducted by University of<br />
Michigan VI, Tunis.<br />
ROBINSON H.S. 1959, The Atenian Agora V. Pottery of the roman<br />
period: cronology, Princeton.<br />
ROMA G. 2001, La necropoli di Calandrino, in G. ROMA (a cura di)<br />
Necropoli e insediamenti forticati nella Calabria Settentrionale,<br />
I, Le necropoli altomedievali, Modugno (BA), pp. 11-24.<br />
SAPORITO P. 1992, Ceramica dipinta e lisciata a stecca, in P. PEDUTO<br />
(a cura di), S. Giovanni di Pratola Serra. Archeologia e storia<br />
nel ducato longobardo di Benevento, Salerno, pp. 197-230.<br />
SCARPATI C. 1998, La ceramica comune ingubbiata, in A. LUPIA<br />
(a cura di), Testimonianze di epoca altomedievale a Benevento.<br />
Lo scavo del Museo del Sannio, Napoli, pp. 126-134.<br />
UBOL<strong>DI</strong> M. 2001, Prodotti laterizi, in G.P. BROGIOLO, L. CASTEL-<br />
LETTI (a cura di), Archeologia a Monte Barro. II – Gli scavi<br />
1990-97 e le ricerche al S. Martino di Lecco, Lecco, pp. 193-<br />
196, fig. 202.<br />
WHITEHOUSE D. 1966, Medieval painted pottery in south and central<br />
Italy, «Medieval Archeology», 10, pp. 30-44.