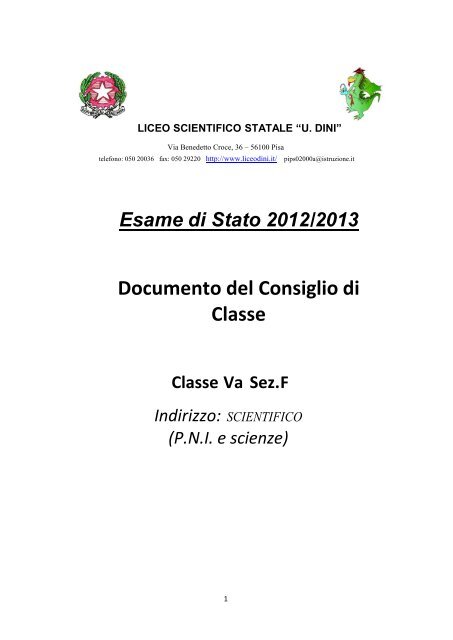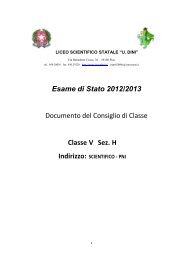5 F - Liceo Scientifico Ulisse Dini
5 F - Liceo Scientifico Ulisse Dini
5 F - Liceo Scientifico Ulisse Dini
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
LICEO SCIENTIFICO STATALE “U. DINI”<br />
Via Benedetto Croce, 36 – 56100 Pisa<br />
telefono: 050 20036 fax: 050 29220 http://www.liceodini.it/ pips02000a@istruzione.it<br />
Esame di Stato 2012/2013<br />
Documento del Consiglio di<br />
Classe<br />
Classe Va Sez. F<br />
Indirizzo: SCIENTIFICO<br />
(P.N.I. e scienze)<br />
1
Indice<br />
Composizione del Consiglio di classe pag.3<br />
Finalità dell’indirizzo e quadro orario pag.4<br />
Elenco dei candidati pag. 5<br />
Presentazione e storia della classe pag.6 ,7<br />
Continuità didattica pag. 8, 9<br />
Estratto del Consiglio di classe (ottobre 2012) pag.10<br />
Obiettivi trasversali pag.11<br />
Metodologie pag.12<br />
Strumenti di verifica/criteri di valutazione pag.13<br />
Percorsi formativi, progetti, attività extracurricolari pag.14<br />
Schede riassuntive e osservazioni sulle simulazioni delle prove esame pag.15<br />
Griglie di valutazione delle prove scritte pag. 17<br />
Relazioni pag. 28<br />
Programmi delle singole discipline pag. 46<br />
2
Composizione del Consiglio di Classe<br />
Nome e cognome del docente Materia/e di insegnamento Firma del docente<br />
LAURA RABUANO *<br />
GIANFRANCO GIOVANNONE<br />
ANTONIA PELLEGRINO<br />
ADELE PELLEGRINO<br />
ISABELLA MARINI<br />
ISABELLA GIANNETTONI *<br />
*<br />
ALESSANDRA BECHELLI<br />
LUCIANO PRATESI<br />
Italiano e Latino<br />
Lingua inglese<br />
Storia e Filosofia<br />
Matematica e Fisica<br />
Scienze<br />
Disegno e Storia dell’arte<br />
Educazione fisica<br />
Religione<br />
* Con l’asterisco sono contrassegnati i commissari interni<br />
3
FINALITA’ DELL’ INDIRIZZO (dal P.O.F. a.s. 2012/13)<br />
In accordo con i principi fondamentali sanciti dalla Costituzione, il <strong>Liceo</strong> <strong>Dini</strong> si è sempre<br />
proposto come finalità principale la formazione di un cittadino consapevole, educato allo<br />
spirito critico, all'esercizio della libertà e al rispetto del pluralismo democratico;<br />
sul piano culturale, si è dato come traguardo la preparazione di uno studente dotato di una<br />
solida formazione di base, il quale, all’interno di un percorso di studi scientifico nei metodi di<br />
indagine e nell’indirizzo delle conoscenze, abbia ricevuto una formazione di qualità anche<br />
nell’ambito umanistico, avendo modo di definire nel tempo le proprie attitudini e i propri<br />
interessi e risultando in grado di proseguire gli studi in qualunque settore; la maggior parte<br />
dei nostri allievi si iscrive all'università, distribuendosi in tutte le facoltà, anche se sono<br />
privilegiate quelle scientifiche<br />
QUADRO ORARIO<br />
I II III IV V<br />
Religione/Att. alt. 1 1 1 1 1<br />
Lingua e lett.italiana 4 4 4 3 4<br />
Lingua e lett. latina 4 5 4 4 3<br />
Lingua Straniera 3 4 3 3 4<br />
Storia 3 2 2 2 3<br />
Geografia 2 - - - -<br />
Filosofia - - 2 3 3<br />
Matematica 5 5 5 5 5<br />
Fisica 3 3 3 3 3<br />
Scienze 3 4 4 4 3<br />
Dis. e Storia Arte 2 2 2 2 2<br />
Ed.Fisica 2 2 2 2 2<br />
Totale 32 32 32 32 33<br />
4
ELENCO dei CANDIDATI<br />
Cognome Nome<br />
1 BERNARDESCHI LORENZO<br />
2 CARDELLI ELISA<br />
3 COLLE ROBERTO<br />
4 CONTE FILIPPO<br />
5 GALLI LEONARDO<br />
6 GIONFRIDDO GIANLUCA<br />
7 GORI SERENA<br />
8 LIRIO JOHN CARLO<br />
9 MARIANI ISABEL<br />
10 MODA MARCO<br />
11 ORSELLI MATTEO<br />
12 POLICELLA MATTEO<br />
13 RAZZAUTI CLAUDIA<br />
14 ROMANO VALERIO<br />
15 SPADA CLAUDIO<br />
16 VOLTERRANI ELENA<br />
Privatista:<br />
17 POGGI MARCO<br />
5
PRESENTAZIONE E STORIA DELLA CLASSE<br />
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA V F<br />
COMPOSIZIONE della CLASSE e del CONSIGLIO di classe<br />
La V F è formata da 16 alunni, cinque femmine e undici maschi.<br />
L'esiguo numero di studenti rimasti -la classe in prima ne contava 26-<br />
deriva da una drastica contrazione dovuta sia ad una selezione naturale,<br />
sia al cambiamento di sezione effettuato da alcuni alunni durante il quinquennio.<br />
Nel corso del quinquennio (come si evince dalle tabelle di seguito allegate)<br />
solo in pochi casi è stata fatta salva la continuità didattica.<br />
PROFILO della CLASSE<br />
La 5 F presenta nel suo complesso un livello di preparazione soddisfacente e<br />
rispondente agli obiettivi proposti.<br />
Il livello di acquisizione dei contenuti, di approfondimento e<br />
quindi di profitto è comunque diversificato a seconda delle discipline e della capacità<br />
di ricezione e di rielaborazione degli alunni.<br />
Nella classe, infatti, si distingue un piccolo gruppo che presenta una preparazione non del<br />
tutto omogenea derivante in parte da un’organizzazione poco efficace;<br />
tuttavia la costanza nell’impegno ha permesso a questi allievi di raggiungere una<br />
conoscenza adeguata delle tematiche proposte<br />
o comunque migliore rispetto ai livelli rilevati in partenza.<br />
Un secondo gruppo è costituito da alunni diligenti e assidui che hanno puntato su uno studio<br />
attento, forse non sempre critico ma sicuramente serio.<br />
L'ultima parte della classe, è composta da studenti dotati di buone qualità che,<br />
alla serietà di comportamento e alla volontà di conseguire risultati positivi,<br />
hanno associato disponibilità in classe e studio approfondito e personale a casa.<br />
Il profilo della quinta F risulta anche in parte condizionato<br />
da problematiche personali e familiari che, specialmente in passato, hanno pesato<br />
sulla capacità di concentrazione di alcuni.<br />
Durante il corso di studi la classe si è particolarmente distinta per la disponibilità nei<br />
confronti delle iniziative di volta in volta proposte dai docenti<br />
La totalità degli alunni ha seguito con regolarità le lezioni.<br />
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DISCIPLINARI E TRASVERSALI<br />
6
Gli obiettivi disciplinari, in relazione alle finalità formative generali,<br />
sono stati raggiunti dalla quasi totalità della classe<br />
(solo in alcuni casi parzialmente).<br />
Anche in considerazione del grado di difficoltà crescente degli argomenti proposti, i docenti<br />
possono affermare che gli alunni hanno mostrato<br />
un progresso nell’apprendimento,<br />
specialmente per quanto riguarda la forma scritta delle diverse discipline.<br />
I docenti hanno affrontato gli argomenti programmati approfondendo all’interno di ogni<br />
disciplina sia la preparazione teorica che la parte applicativa,<br />
attraverso considerazioni e analisi sulla realtà .<br />
Al fine di approfondire le conoscenze apprese sono stati messi a disposizione degli studenti<br />
dispense, materiale didattico, appunti forniti dai diversi insegnanti,<br />
materiale multimediale e on- line.<br />
La metodologia di insegnamento ha visto l'alternarsi di lezioni frontali con iniziative individuali<br />
e di gruppo, con l’obiettivo comune<br />
di favorire l'apprendimento e l'aspetto collaborativo.<br />
Area affettiva<br />
I rapporti interni tra gli studenti, nonostante qualche screzio,<br />
sono stati improntati al rispetto reciproco.<br />
Anche nei confronti degli insegnanti gli alunni hanno sempre mantenuto<br />
un atteggiamento corretto e costruttivo, non ricorrendo a strategie<br />
per evadere dai propri impegni e dalle proprie responsabilità.<br />
La fiducia reciproca ha consentito di stabilire un dialogo proficuo e continuativo.<br />
Area cognitiva<br />
La scarsa continuità didattica degli insegnanti ha in parte condizionato lo<br />
svolgimento dei programmi durante il quinquennio.<br />
Nonostante questo gli obiettivi didattici e formativi programmati quest'anno<br />
dal consiglio di classe sono stati in buona parte raggiunti,<br />
come si evidenzia dalle relazioni individuali dei docenti.<br />
Per quanto riguarda le metodologie didattiche, il Consiglio si è attenuto a quanto previsto<br />
nella Programmazione di inizio anno (vedi estratto del Consiglio di Classe).<br />
Attualmente la classe appare diversificata nei risultati,<br />
con qualche punta di eccellenza.<br />
7
CONTINUITA’ DIDATTICA<br />
COMPOSIZIONE ATTUALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE<br />
2012/13<br />
NOME MATERIA Note<br />
RABUANO LAURA Italiano e latino<br />
GIANNETTONI ISABELLA Storia dell'Arte e Disegno coordinatrice<br />
PELLEGRINO ADELE Matematica e Fisica<br />
PELLEGRINO ANTONIA Storia e Filosofia<br />
MARINI ISABELLA Scienze<br />
PRATESI LUCIANO Religione<br />
GIOVANNONE<br />
GIANFRANCO<br />
Inglese<br />
BECHELLI ALESSANDRA Educazione fisica<br />
ANNO 2008/2009<br />
e variazioni nella composizione dello stesso<br />
NOME MATERIA Note<br />
MESSINA SALVATORE Italiano, storia e geografia<br />
GIANNETTONI ISABELLA Storia dell'Arte e Disegno<br />
PISTELLI FABIO Matematica coordinatore<br />
MIGLI ELISABETTA Fisica<br />
ROME' ANDREA Scienze<br />
PRATESI LUCIANO Religione<br />
PATTITONI NALDINA Inglese<br />
RIPOLI GABRIELLA Latino<br />
BASTIANINI CARLO Educazione fisica<br />
8
ANNO 2009/2010<br />
NOME MATERIA Note<br />
RIPOLI GABRIELLA Italiano, storia e latino<br />
GIANNETTONI ISABELLA Storia dell'Arte e Disegno<br />
PISTELLI FABIO Matematica coordinatore<br />
MIGLI ELISABETTA Fisica<br />
ROME' ANDREA Scienze<br />
PRATESI LUCIANO Religione<br />
GOZZINI PAOLO Inglese<br />
BASTIANINI CARLO Educazione fisica<br />
ANNO 2010/2011<br />
NOME MATERIA Note<br />
RIPOLI GABRIELLA Latino<br />
GIANNETTONI ISABELLA Storia dell'Arte e Disegno coordinatrice<br />
PELLEGRINO ADELE Matematica<br />
PROFETI SANDRA Fisica<br />
TURINI MANUELA Scienze<br />
PRATESI LUCIANO Religione<br />
BELLINI SILVANO Inglese<br />
RABUANO LAURA Italiano<br />
SIMONCINI PAOLA Storia e Filosofia<br />
BECHELLI ALESSANDRA Educazione fisica<br />
ANNO 2011/2012<br />
NOME MATERIA Note<br />
RABUANO LAURA Italiano e Latino<br />
GIANNETTONI ISABELLA Storia dell'Arte e Disegno coordinatrice<br />
9
PELLEGRINO ADELE Matematica<br />
PROFETI SANDRA Fisica<br />
TURINI MANUELA Scienze<br />
PRATESI LUCIANO Religione<br />
FINZI MUGHETTO Inglese<br />
BENTIVOGLIO FABIO Filosofia<br />
COSTA DEANNA Storia<br />
BECHELLI ALESSANDRA Educazione fisica<br />
Estratto del Consiglio di Classe della VF del 1 ottobre 2012 ristretto alla sola<br />
componente docenti per la programmazione dell'anno scolastico 2012 - 13<br />
Oggi, 1 ottobre 2012, nell’aula 1.14 del <strong>Liceo</strong> <strong>Scientifico</strong> “<strong>Ulisse</strong> <strong>Dini</strong>” di Pisa, alle ore 15.30<br />
si è riunito il Consiglio di Classe della Va F con il seguente o. d. g.:<br />
1. Esito di eventuali prove di ingresso e analisi didattico- disciplinare dei livelli di<br />
partenza della classe, utile alla stesura della programmazione<br />
2. Obiettivi trasversali comuni a tutte le discipline<br />
3. Programmazione di classe e coordinamento tra i docenti<br />
4. Eventuali proposte di attività extracurricolari, lezioni fuori sede, viaggi di istruzione<br />
5. Varie ed eventuali<br />
Punto 1.<br />
Omissis<br />
Punto 2: Obiettivi trasversali comuni a tutte le discipline<br />
I docenti, facendo riferimento a quanto dichiarato nel POF dell'Istituto e tenendo conto della<br />
fisionomia specifica della classe, discutono e approvano gli obiettivi trasversali evidenziati<br />
nell' allegato A ;<br />
tra di essi, ciascun insegnante espliciterà nel proprio piano di lavoro quelli al cui<br />
conseguimento ritiene di poter dare particolare contributo con la propria azione didattica.<br />
Punto 3: Programmazione di classe e coordinamento tra docenti<br />
Il consiglio di classe approva i metodi didattici e gli strumenti di lavoro, i criteri e gli strumenti<br />
di valutazione e verifica indicati nell' allegato B in quanto comuni alle diverse aree<br />
disciplinari.<br />
.<br />
► Viene concordato di effettuare tre simulazioni di “terze prove”<br />
così articolate:<br />
tipologia “B” , quattro discipline (massimo 6/8 righe)<br />
Periodo Discipline<br />
7 febbraio I Inglese Scienze Storia Storia<br />
10
2013 dell'Arte<br />
9<br />
2013<br />
aprile II Scienze Fisica Filosofia Latino<br />
7 maggio III Latino Filosofia Storia Ed. fisica<br />
2013<br />
dell'Arte<br />
Allegato A<br />
OBIETTIVI TRASVERSALI<br />
(ciascun insegnante espliciterà nel proprio piano di lavoro quelli al cui conseguimento<br />
ritiene di poter dare particolare contributo con la propria azione didattica)<br />
OBIETTIVI FORMATIVI :<br />
1. Rispetto di sé e degli altri, delle diversità personali e culturali<br />
2. Disponibilità al confronto<br />
3. Capacità di autovalutazione per quanto attiene tanto il profitto scolastico quanto il<br />
comportamento<br />
4. Capacità di organizzare in modo autonomo e responsabile il proprio lavoro<br />
5. Capacità di rapportarsi agli altri in un lavoro di gruppo<br />
6. Capacità di rispettare gli impegni assunti e le consegne ricevute<br />
7. Sviluppare interesse e curiosità autonomi nei confronti delle discipline di studio<br />
OBIETTIVI COGNITIVI :<br />
1. Conoscere i contenuti fondamentali delle discipline<br />
2. Esprimere le proprie conoscenze attraverso l'uso dei linguaggi e degli strumenti<br />
specifici delle singole discipline<br />
3. Operare confronti e sintesi di contenuti attinenti a singoli percorsi disciplinari o ad<br />
ambiti disciplinari diversi<br />
4. Applicare le procedure logiche ed i metodi di analisi appresi anche all'esame di<br />
contenuti nuovi, se pur afferenti ad ambiti disciplinari noti.<br />
5. Approfondire alcuni temi o problemi in modo autonomo e personale.<br />
OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI (si vedano i piani di lavoro individuali)<br />
RECUPERO<br />
11
Il recupero è stato effettuato -per tutte le discipline- in orario curricolare attraverso un costante<br />
ritorno su argomenti<br />
risultati particolarmente difficili e assegnando, in alcuni casi,<br />
lavori scritti individuali ogni volta corretti e discussi con gli interessati.<br />
Allegato B<br />
METODI DIDATTICI E STRUMENTI DI LAVORO<br />
Il Consiglio di classe ribadisce come<br />
fondamento metodologico la centralità dello studente<br />
nei processi di apprendimento.<br />
Quindi, oltre a far uso delle lezioni frontali, tutti i docenti assegneranno un ruolo insostituibile<br />
al lavoro in classe, sotto forma di dialogo, discussione, formulazione e verifica di ipotesi,<br />
soluzioni di problemi.<br />
Indispensabile per il conseguimento di un’efficace azione formativa sarà comunque il lavoro<br />
autonomo di rielaborazione e di acquisizione delle conoscenze<br />
che ciascun allievo sarà tenuto a svolgere.<br />
Si cercherà di aprire l’attività didattica al rapporto con l’esterno,<br />
allo scopo di creare occasioni di apprendimento stimolanti, innovative e culturalmente<br />
avanzate promuovendo incontri con esperti o partecipando alle iniziative culturali promosse<br />
dall’Istituto o da altri enti operanti sul territorio.<br />
In sintesi si adotteranno:<br />
- Lezione frontale o interattiva<br />
- Lavoro di gruppo<br />
- Attività di laboratorio per le lingue, l'informatica, la fisica, la biologia e la<br />
chimica<br />
12
- Utilizzo guidato di riviste, libri, sussidi audiovisivi<br />
- Lezioni fuori sede<br />
- Visite guidate<br />
- Partecipazione ai progetti del <strong>Liceo</strong><br />
- Sviluppo di attività e progetti personali<br />
o testi<br />
o dispense<br />
STRUMENTI ED ATTREZZATURE<br />
o materiale cartaceo, audiovisivo e digitale<br />
o riproduzione di documenti<br />
o laboratori<br />
o palestra<br />
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE E VERIFICA<br />
o Verifiche scritte in classe strutturate e non (almeno 2 per il primo trimestre ed almeno<br />
4 nel successivo semestre) secondo la tipologia ritenuta di volta in volta più consona<br />
dal docente e che verrà resa nota alla classe.<br />
o Verifica del regolare svolgimento dei compiti assegnati per casa e della loro<br />
esecuzione in modo corretto ed attento.<br />
o Verifiche orali (interrogazioni, risposte a domanda del docente, interventi spontanei<br />
dal posto, esposizioni autonome o guidate di ricerche, approfondimenti, contributi<br />
personali o di gruppo).<br />
o Relazioni sulle attività di laboratorio<br />
o Test di ascolto in lingua straniera<br />
o Contributi in forma scritta per la partecipazione alle attività dei progetti<br />
o Analisi di testi, immagini o documenti, risoluzione di problemi o di esercizi, tavole<br />
grafiche di disegno.<br />
o Analisi di progetti personali<br />
CRITERI DI VALUTAZIONE:<br />
Il Consiglio di Classe si atterrà ai criteri di valutazione individuati dal Collegio dei Docenti.<br />
I docenti si impegnano a consegnare tempestivamente le verifiche, corrette e valutate, in<br />
modo che gli studenti possano effettuare i necessari interventi prima della verifica<br />
successiva.<br />
CRITERI DI VALUTAZIONE IN DECIMI<br />
13
gravemente insufficiente (fino a 4): conoscenza mancata o gravemente lacunosa dei<br />
contenuti minimi, incapacità di orientarsi, serie difficoltà di esposizione<br />
insufficiente(5): conoscenza parziale dei contenuti minimi, difficoltà nell’orientamento,<br />
esposizione incerta e poco appropriata<br />
sufficiente(6): conoscenza dei contenuti minimi, capacità di orientarsi con l’aiuto del<br />
docente, espressione globalmente corretta<br />
discreto (7): conoscenza abbastanza estesa dei contenuti,esposizione corretta, capacità di<br />
applicazione degli strumenti acquisiti<br />
buono (8): conoscenza ampia e sicura dei contenuti, padronanza del linguaggio specifico,<br />
capacità di collegamento all’interno della disciplina<br />
ottimo (9-10): autonomia e precisione nel metodo di lavoro, conoscenza approfondita,<br />
rielaborazione personale di quanto appreso con eventuali collegamenti interdisciplinari.<br />
Si specifica che:<br />
o Nel rispetto della normativa vigente, sarà adottata l’intera scala numerica di voti,<br />
dall’uno al 10.<br />
o Gli insegnanti potranno eventualmente utilizzare sul registro personale annotazioni<br />
diverse dal voto purché chiarite da una legenda<br />
o Nel caso di impreparazione dell'allievo, il docente potrà apporre sul registro personale<br />
tanto un voto quanto un simbolo chiarito dalla legenda.<br />
o Il voto di condotta verrà assegnato dal Consiglio di Classe nel rispetto della vigente<br />
normativa e del Regolamento di Istituto.<br />
14
Attività extracurricolari<br />
Per tutto il quinquennio gli alunni hanno partecipato attivamente a progetti e ad attività<br />
integrative proposte dalla scuola.<br />
Per quanto riguarda l'adesione dell'intera classe si segnala:<br />
►Olimpiadi di matematica (terzo e quinto anno)<br />
►Olimpiadi di fisica (quinto anno)<br />
► Kangaroo di matematica (primo anno)<br />
► Progetto contro le mafie (quinto anno)<br />
► Progetto “La scuola adotta un monumento”St. Arte (primo /secondo anno)<br />
► Progetto “Culture” : un “logo” per la città -Disegno-(quarto anno)<br />
► Progetto “Educare al presente”, Economia-Arte (quinto anno)<br />
► Orienteering di educazione fisica (quarto anno)<br />
Alcuni alunni hanno partecipato a gruppi e/o individualmente a:<br />
► GARE SPORTIVE:<br />
di atletica (Bernardeschi, Orselli, Spada, Volterrani) Gionfriddo (medaglia d'oro)<br />
tornei di pallavolo (Bernardeschi, Cardelli, Colle, Gionfriddo, Gori, Lirio, Moda, Orselli,<br />
Razzauti, Romano, Spada, Volterrani) (medaglie oro: secondo e terzo anno)<br />
squadra di basket :(Colle)<br />
squadra di calcio: (Gionfriddo, Orselli, Spada)<br />
gare di nuoto (Moda)<br />
arbitro di calcio di istituto (Gionfriddo)<br />
► Certamen di LATINO (Bernardeschi, Cardelli, Gionfriddo e Mariani)<br />
► Laboratorio TEATRALE (Galli, Gionfriddo e Volterrani)<br />
► CORO del <strong>Liceo</strong> (Lirio)<br />
► OLIMPIADI di CHIMICA -quarto anno-<br />
(Bernardeschi, Gionfriddo, Lirio, Mariani, Orselli e Spada)<br />
► OLIMPIADI di BIOLOGIA (Cardelli, Colle, Galli, Mariani, Orselli e Spada )<br />
► Master Class di FISICA(Gionfriddo)<br />
► Settimana scientifica (Gionfriddo, Orselli e Moda)<br />
► Progetto legato alla Shoah -quarto anno- (Lirio e Mariani)<br />
Si sono distinti all'interno del <strong>Liceo</strong> come:<br />
► Rappresentante di Istituto (Gionfriddo)<br />
► Rappresentanti dell'Istituto in visita a Carpi dopo il terremoto<br />
(Gionfriddo, Orselli e Spada)<br />
► Donatori di sangue (Bernardeschi, Galli, Lirio, Moda)<br />
La classe ha svolto due viaggi di Istruzione<br />
► PRAGA ( in quarta)<br />
► METEORE e GRECIA CLASSICA (in quinta)<br />
15
Scheda informativa sulle terze prove simulate svolte durante l’anno<br />
Nel Consiglio di Classe di ottobre 2012 (allegato) si era stabilito di effettuare, nel corso<br />
dell’anno,<br />
tre simulazioni di terze prove (tipologia B, con un totale di dodici quesiti distribuiti tra<br />
quattro discipline).<br />
Le prove, sono state tutte preparate conformemente a quanto deliberato<br />
considerando di far utilizzare da sei a otto righe per quesito.<br />
Data<br />
svolgimento<br />
di Tempo assegnato Discipline coinvolte Tipologia di verifica<br />
7 febbraio 2013 2 ore e 30 Lingua-<br />
Storia-Scienze-<br />
Storia dell’Arte<br />
B<br />
9 aprile 2013 2 ore e 30 Latino-Scienze-<br />
Fisica- Filosofia<br />
B<br />
7 maggio 2013 2 ore e 30 Storia dell'Arte-<br />
Filosofia- Scienze-<br />
Educazione fisica<br />
B<br />
Obiettivi particolari attribuiti dai vari insegnanti alla terza prova<br />
Latino La valutazione considera le conoscenze dell’argomento proposto, la<br />
pertinenza e la completezza delle risposte, l’uso di un linguaggio<br />
corretto, la capacità d sintesi e la capacità di operare confronti<br />
Lingua Obiettivi di verifica: conoscenza dei contenuti, chiarezza e concisione<br />
espositiva, correttezza formale, comprensione del testo<br />
Storia Le domande sono state intese come strumenti di verifica di conoscenze<br />
e non di capacità di analisi o di riflessione e confronto (oggetto dei temi<br />
di argomento storico). Pertanto i quesiti hanno richiesto risposte di<br />
carattere descrittivo ed hanno riguardato informazioni particolari<br />
Filosofia Le domande, pur non essendo analitiche come quelle di storia, hanno<br />
avuto lo stesso carattere descrittivo ed hanno riguardato argomenti<br />
abbastanza circoscritti<br />
Fisica Le domande sono state mirate alla verifica del possesso di conoscenze<br />
ben delimitate e di linguaggio specifico preciso e corretto, di capacità di<br />
sintesi e completezza e/o di applicazione di leggi fisiche a situazioni<br />
semplici<br />
Scienze I quesiti sono stati mirati a verificare il possesso di linguaggio scientifico<br />
corretto e rigoroso, la conoscenza dei contenuti, la capacità di sintesi e<br />
di collegamento all’interno della disciplina<br />
Storia dell’arte Le domande sono state formulate in modo da poter verificare sia la<br />
conoscenza d specifici argomenti in forma sintetica, sia la capacità di<br />
Educazione<br />
fisica<br />
confronto e di riflessione sugli autori e sulle tematiche affrontate<br />
Obiettivi di verifica: conoscenza degli argomenti trattati, uso corretto del<br />
linguaggio specifico e capacità espositive<br />
16
Tipologia A<br />
6° livello<br />
(fino a 6<br />
punti)<br />
5° livello<br />
( 7- 8 punti)<br />
4° livello<br />
(punti 9)<br />
3° livello<br />
(punti 10-11)<br />
2° livello<br />
(punti 12-13)<br />
1° livello<br />
(punti 14-15)<br />
1) Dimostra di non comprendere i contenuti informativi del testo.<br />
2) Alcune risposte risultano non date e quelle presenti dimostrano<br />
competenze di analisi assolutamente inadeguate.<br />
3) Gli approfondimenti mancano.<br />
Le carenze espressive sono di gravità tale da pregiudicare la<br />
comprensione della totalità dei punti trattati.<br />
1) Comprende in maniera assai ridotta, lacunosa e/o superficiale. Nella<br />
sintesi non espone o espone solo parzialmente i nuclei tematici<br />
fondamentali.<br />
2) Dà risposte incomplete o poco pertinenti, che dimostrano competenze di<br />
analisi del testo limitate /molto limitate.<br />
3) Gli approfondimenti mancano o risultano troppo generici o non sono<br />
pertinenti.<br />
Si esprime in modo scorretto; usa un lessico improprio e povero.<br />
L’esposizione appare frammentaria e/o disorganica.<br />
1) Comprende in maniera parziale e/o poco approfondita. Nella sintesi<br />
espone in modo semplice e con ripetizioni del testo.<br />
2) Dà risposte poco approfondite e/o troppo brevi e/o non completamente<br />
esaurienti, dimostrando competenze poco solide nell’analisi del testo.<br />
3) Gli approfondimenti si basano su argomentazioni semplici e riferimenti e<br />
confronti poco significativi.<br />
Si esprime in modo spesso scorretto; usa un lessico povero e non sempre<br />
appropriato. L’esposizione appare troppo schematica.<br />
1) Comprende il testo cogliendo i nuclei tematici fondamentali che<br />
sintetizza in modo semplice.<br />
2) Dà risposte pertinenti alle richieste e che dimostrano capacità di analisi<br />
essenziale.<br />
3) Gli approfondimenti sono sviluppati argomentando in modo semplice,<br />
con riferimenti e confronti abbastanza pertinenti.<br />
Si esprime in forma sostanzialmente corretta; usa un lessico ridotto ma<br />
appropriato.<br />
L’esposizione è abbastanza ordinata.<br />
1) Dimostra di comprendere anche qualche aspetto meno esplicito del<br />
testo. Sintetizza in modo appropriato utilizzando una forma abbastanza<br />
articolata.<br />
2) Dà risposte abbastanza approfondite e attraverso l’analisi sa cogliere<br />
informazioni utili per una rielaborazione più ampia e complessa.<br />
3) Gli approfondimenti denotano ordine e una certa efficacia<br />
nell’argomentazione, anche grazie a significativi riferimenti e confronti.<br />
Si esprime con un lessico corretto e con efficace coesione sintattica.<br />
1) Comprende in maniera ben approfondita il testo anche in aspetti impliciti<br />
e profondi. Sintetizza con chiarezza.<br />
2) Le risposte sono approfondite e ben articolate ed evidenziano capacità<br />
di rielaborazione critica e/o originalità interpretativa.<br />
3) Negli approfondimenti usa le conoscenze che possiede per affrontare /<br />
padroneggiare questioni complesse che sa rielaborare in modo autonomo<br />
e/o originale.<br />
Si esprime con fluidità, senza errori, mostrando una buona coesione
sintattica; il lessico è corretto e pertinente.<br />
n.b. Se l’elaborato si inserisce completamente in una fascia con punteggio variabile,<br />
sarà assegnato il punteggio più alto.
Tipologia B<br />
6° livello<br />
(fino a 6<br />
punti)<br />
5° livello<br />
( 7 - 8 punti)<br />
4° livello<br />
(punti 9)<br />
3° livello<br />
(punti 10-11)<br />
2° livello<br />
(punti 12-13)<br />
1° livello<br />
(punti 14-15)<br />
Non rispetta le consegne e svolge l’argomento in modo non pertinente.<br />
Dimostra di non possedere alcuna conoscenza relativa all’argomento.<br />
Dimostra di non riuscire a ricavare alcuna informazione dai documenti. Le<br />
carenze espressive sono di gravità tale da pregiudicare la comprensione<br />
dell’elaborato per una parte preponderante della sua estensione.<br />
Non rispetta le consegne e svolge l’argomento in modo non pertinente.<br />
Dimostra di avere conoscenze superficiali e/o ripropone piattamente solo<br />
le informazioni esplicite contenute nei documenti.<br />
Sviluppa la proprie argomentazioni in modo frammentario e/o incompleto;<br />
rielabora e sintetizza a fatica. Si esprime in modo scorretto; usa un lessico<br />
improprio e povero.<br />
Rispetta solo in parte le consegne e svolge l’argomento in modo poco<br />
pertinente. Dimostra di avere conoscenze non ampie e/o poco<br />
approfondite; si limita a usare le informazioni esplicite contenute nei<br />
documenti operando, a partire da esse, soltanto argomentazioni poco<br />
significative.<br />
Sviluppa la proprie argomentazioni in modo poco articolato; le capacità di<br />
rielaborazione e sintesi sono ridotte. Si esprime in modo spesso scorretto;<br />
usa un lessico povero e non sempre appropriato.<br />
Rispetta le consegne e svolge l’argomento in modo pertinente. Dimostra di<br />
avere conoscenze abbastanza ampie ma non approfondite (oppure:<br />
dimostra di possedere conoscenze approfondite ma non ampie). Dà prova<br />
di saper utilizzare i documenti cogliendone le informazioni essenziali e<br />
rielaborandole in modo semplice..<br />
Sviluppa la proprie argomentazioni in modo poco articolato ma<br />
apprezzabile sul piano dei contenuti (oppure: abbastanza organico anche<br />
se limitato nei contenuti); si esprime in modo occasionalmente scorretto /<br />
con sufficiente correttezza; usa un lessico ridotto ma in genere appropriato<br />
/ appropriato<br />
Rispetta le consegne e svolge l’argomento in modo pertinente. Dimostra di<br />
avere conoscenze abbastanza ampie e approfondite. Sa cogliere nei<br />
documenti informazioni utili per una rielaborazione più ampia e complessa.<br />
Svolge il discorso in modo articolato argomentando con ordine e con una<br />
certa efficacia; si esprime con lessico corretto e coesione sintattica.<br />
Rispetta le consegne e svolge l’argomento in modo pertinente. Dimostra di<br />
avere conoscenze ampie e ben approfondite sull’argomento trattato e di<br />
comprendere attraverso precise connessioni diversi aspetti impliciti e<br />
profondi dei documenti.. Sa utilizzare i documenti per affrontare /<br />
padroneggiare questioni complesse che rielabora in modo autonomo e<br />
originale.<br />
Si esprime con fluidità, mostrando una buona coesione sintattica; il lessico<br />
è corretto, ampio e pertinente.<br />
n.b. Se l’elaborato si inserisce completamente in una fascia con punteggio variabile,<br />
sarà assegnato il punteggio più alto.
Tipologia C e D<br />
6° livello<br />
(fino a 6<br />
punti)<br />
5° livello<br />
( 7 - 8 punti)<br />
4° livello<br />
(punti 9)<br />
3° livello<br />
(punti 10-11)<br />
2° livello<br />
(punti 12-13)<br />
1° livello<br />
(punti 14-15)<br />
Non rispetta le richieste della traccia e svolge l’argomento in modo non<br />
pertinente. Dimostra di non possedere alcuna conoscenza relativa<br />
all’argomento. Le carenze espressive sono di gravità tale da pregiudicare<br />
la comprensione dell’elaborato per una parte preponderante della sua<br />
estensione.<br />
Svolge l’argomento in modo non pertinente e non rispetta le richieste della<br />
traccia.. Dimostra di avere conoscenze (assai) ridotte, lacunose e<br />
superficiali.<br />
Svolge il discorso in modo frammentario e incompleto; rielabora e<br />
sintetizza a fatica. Si esprime in modo scorretto; usa un lessico improprio e<br />
povero.<br />
Svolge l’argomento in modo poco pertinente e rispetta solo in parte le<br />
richieste della traccia. Dimostra di avere conoscenze non ampie e/o poco<br />
approfondite<br />
Svolge il discorso in modo poco articolato; le capacità di rielaborazione e<br />
sintesi sono ridotte. Si esprime in modo spesso scorretto; usa un lessico<br />
povero e non sempre appropriato.<br />
Rispetta le richieste della traccia e svolge l’argomento in modo pertinente.<br />
Dimostra di avere conoscenze abbastanza ampie ma non ben<br />
approfondite (oppure: dimostra di possedere conoscenze anche<br />
approfondite ma settoriali).<br />
Svolge il discorso in modo poco articolato ma apprezzabile sul piano dei<br />
contenuti (oppure abbastanza organico anche se limitato nei contenuti); si<br />
esprime in modo occasionalmente scorretto/ con sufficiente correttezza;<br />
usa un lessico ridotto ma in genere appropriato / appropriato.<br />
Rispetta le richieste della traccia e svolge l’argomento in modo pertinente.<br />
Dimostra di avere conoscenze abbastanza ampie e approfondite.<br />
Svolge il discorso in modo articolato argomentando con ordine e con una<br />
certa efficacia; si esprime con lessico corretto e coesione sintattica.<br />
Rispetta le richieste della traccia e svolge l’argomento in modo pertinente.<br />
Dimostra di avere conoscenze ampie e ben approfondite sull’argomento<br />
trattato e capacità di rielaborazione autonoma e/o originale.<br />
Si esprime con fluidità, mostrando una buona coesione sintattica; il lessico<br />
è corretto, ampio e pertinente.<br />
n.b. Se l’elaborato si inserisce completamente in una fascia con punteggio variabile,<br />
sarà assegnato il punteggio più alto.
Griglia di valutazione:<br />
<strong>Liceo</strong> <strong>Scientifico</strong> “U.<strong>Dini</strong>” - Anno Scolastico 2012/13<br />
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA<br />
VALUTAZIONE DESCRITTORI<br />
Apprendimento molto lacunoso<br />
Conoscenza frammentaria dei contenuti<br />
minimi e incapacità di orientarsi.<br />
(1-5)<br />
Apprendimento gravemente insufficiente Conoscenza lacunosa dei contenuti minimi,<br />
scarsa capacità di orientarsi, serie difficoltà di<br />
(6-7)<br />
esposizione.<br />
Apprendimento mediocre<br />
Conoscenza dei contenuti superficiale,<br />
esposizione incerta o poco appropriata.<br />
(8-9)<br />
Apprendimento sufficiente<br />
Conoscenza dei contenuti minimi, espressi in<br />
modo privo di gravi scorrettezze anche se<br />
( 10 )<br />
non del tutto organizzato.<br />
Apprendimento discreto<br />
Conoscenza abbastanza estesa dei<br />
(11-12)<br />
contenuti, esposizione corretta, capacità di<br />
applicare gli strumenti acquisiti.<br />
Apprendimento buono<br />
Conoscenza esauriente dei contenuti,<br />
capacità di rielaborazione autonoma,<br />
(13-14)<br />
esposizione<br />
lessico.<br />
corretta e appropriata nel<br />
Apprendimento ottimo<br />
Conoscenza puntuale e sicura dei concetti,<br />
( con rielaborazione critica e autonoma,<br />
15 )<br />
collegamenti all’interno della disciplina o in<br />
direzione<br />
precisa.<br />
interdisciplinare, esposizione<br />
Quadro informativo delle equivalenze tra voti in decimi e in quindicesimi:<br />
Sufficienze:<br />
10-9 9 8½ 8+ 8 8- 7½ 7 + 7-/<br />
6½<br />
6+ 6<br />
15 14.5 14 13.5 13 12.5 12 11.5 11 10.5 10<br />
Insufficienze:<br />
6-<br />
/5½<br />
5+ 5 5- 4½ 4+ 4<br />
9.5 9 8.5 8 7.5 7.5 7
Griglia di valutazione (a):<br />
<strong>Liceo</strong> <strong>Scientifico</strong> “U.<strong>Dini</strong>” - Anno Scolastico 2012/13<br />
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA<br />
Livello di prestazione Voto in quindicesimi<br />
Presenza di gravissime lacune di base nella conoscenza dei<br />
contenuti disciplinari; totale fraintendimento delle domande<br />
Fino a 5 punti<br />
proposte; disorientamento di ordine logico, linguistico e<br />
metodologico<br />
Gravi carenze e lacune nell’acquisizione dei contenuti; utilizzo<br />
6-7<br />
superficiale delle conoscenze acquisite e genericità<br />
nell’inserimento del contesto; difficoltà nell’affrontare e organizzare<br />
le informazioni acquisite, utilizzo di una terminologia impropria e<br />
scorretta<br />
Informazioni frammentarie o non sempre corrette; alcune difficoltà<br />
8-9<br />
nell’identificare e utilizzare gli strumenti adeguati alla risoluzione<br />
del quesito proposto; organizzazione approssimativa dei contenuti,<br />
linguaggio incerto o poco appropriato<br />
Conoscenza corretta ma essenziale degli argomenti proposti;<br />
10-11<br />
utilizzo sostanzialmente corretto delle conoscenze acquisite;<br />
sufficiente capacità di organizzazione dei contenuti, linguaggio<br />
privo di gravi scorrettezze<br />
Possesso dei contenuti disciplinari fondamentali; apprezzabile<br />
12-13<br />
efficacia di orientamento tra i contenuti acquisiti; capacità di<br />
rielaborazione dei contenuti acquisiti,discreta proprietà di<br />
linguaggio<br />
Conoscenza esauriente degli argomenti proposti; utilizzo sicuro<br />
14<br />
delle conoscenze acquisite; capacità di rielaborazione autonoma<br />
degli argomenti proposti; linguaggio appropriato<br />
Conoscenza puntuale e sicura degli argomenti proposti; completo<br />
15<br />
e coerente utilizzo delle informazioni acquisite; rigore di analisi e<br />
sintesi; linguaggio pienamente pertinente<br />
N.B: Il punteggio complessivo è il risultato della media matematica dei punteggi parziali,<br />
con i convenzionali arrotondamenti
Candidato<br />
TERZA PROVA-GRIGLIA (b)<br />
MATERIA____________________________________________<br />
Descrittori Ottimo Buono Discreto Sufficiente Insufficiente Gravemente<br />
insufficiente<br />
Conoscenze 6<br />
5,5<br />
5<br />
4,5<br />
4<br />
3,5<br />
1. comprensione Risposta Riposta Risposte Risposte con Risposte Risposte con<br />
precisa e corretta e corrette anche conoscenze parziali o errori o molto<br />
dettagliata completa se non essenziali e superficiali o parziali o<br />
2. pertinenza<br />
approfondite piccole<br />
incertezze<br />
frammentarie lacunose<br />
Competenze<br />
1. correttezza<br />
formale<br />
2. lessico<br />
Capacità<br />
1. capacità<br />
argomentativa<br />
2. rielaborazione<br />
5<br />
Esposizione<br />
accurata e<br />
discorso ben<br />
articolato<br />
4<br />
Elabora i<br />
concetti<br />
chiave e li<br />
collega con<br />
precisione e<br />
chiarezza<br />
4,5<br />
Esposizione<br />
chiara e<br />
corretta con<br />
linguaggio<br />
adeguato<br />
3,5<br />
Coglie i<br />
concetti<br />
chiave e li<br />
elabora in<br />
modo<br />
corretto<br />
4<br />
Esposizione<br />
chiara e<br />
corretta,<br />
linguaggio in<br />
genere<br />
appropriato<br />
3<br />
Coglie i<br />
concetti chiave<br />
e li elabora in<br />
modo<br />
sostanzialment<br />
e<br />
corretto<br />
3,5<br />
Esposizione<br />
semplice con<br />
qualche lieve<br />
imprecisione<br />
2<br />
Individua i<br />
concetti<br />
chiave ma<br />
non li elabora<br />
sempre in<br />
modo<br />
corretto<br />
3<br />
Esposizione<br />
con alcune<br />
imprecisioni o<br />
approssimati<br />
va<br />
2<br />
Individua i<br />
concetti<br />
chiave ma<br />
non li elabora<br />
sempre in<br />
modo<br />
corretto<br />
3<br />
Esposizione<br />
con alcune<br />
imprecisioni o<br />
approssimati<br />
va<br />
1,5<br />
Non ha<br />
individuato<br />
tutti i concetti<br />
chiave<br />
Scarsa Punti<br />
3<br />
Nessuna<br />
risposta o<br />
risposta<br />
errata<br />
2-2,5<br />
Esposizione<br />
del tutto<br />
confusa o<br />
con molti<br />
errori formali<br />
1<br />
Nessuna<br />
capacità<br />
rielaborativa<br />
Q.1<br />
Q.2<br />
Q.1<br />
Q.2<br />
Q.1<br />
Q.2
TOTALE/2 = ____ /15
LICEO SCIENTIFICO ' U. DINI'<br />
anno scolastico 2012 – 2013<br />
RELAZIONE SULLA CLASSE V F<br />
MATEMATICA<br />
La classe è formata soltanto da 16 alunni in quanto nel corso del triennio ha subito una<br />
drastica<br />
contrazione dovuta sia ad una selezione naturale, sia al cambiamento di sezione effettuato<br />
da alcuni<br />
studenti. Essa ha avuto, comunque, continuità didattica per quanto riguarda la<br />
matematica.<br />
Durante tale periodo i ragazzi sono stati stimolati ad effettuare uno studio organizzato,<br />
alla crescita delle capacità critiche e alla rielaborazione personale degli argomenti trattati<br />
attraverso il lavoro in classe: compiti, interrogazioni, esercitazioni, spiegazioni, chiarimenti,<br />
discussioni collettive. La classe però, specialmente nel primo periodo dell'ultimo anno, non<br />
sempre<br />
ha risposto in maniera positiva: infatti alcuni alunni si sono mostrati spesso restii ad una<br />
partecipazione attiva e costruttiva alle lezioni.<br />
Tuttavia la maggior parte della classe ha effettuato uno studio costante e adeguato alla<br />
crescente difficoltà degli argomenti trattati,ottenendo dei risultati tra l'ottimo e il discreto;<br />
i rimanenti, a causa di un impegno non sempre continuo e per scarso spirito critico, hanno<br />
raggiunto risultati solo sufficienti o non del tutto sufficienti.<br />
Lo svolgimento del programma è stato regolare e in linea con la programmazione di inizio<br />
anno.<br />
Modalità di svolgimento del programma:<br />
Lezioni frontali<br />
Discussioni collettive<br />
Lezioni per problemi<br />
Tipologia delle prove di verifica:<br />
_ Compiti tradizionali ( durata di 2 o 3 ore)<br />
_ Questionari<br />
_ Colloqui orali individuali e collettivi<br />
Criteri di valutazione:<br />
SCHEDA INFORMATIVA:<br />
_ In generale il criterio di sufficienza ha tenuto conto dell'acquisizione accettabile dei<br />
contenuti, di esposizione globalmente corretta, della serietà dell'impegno di studio e<br />
della frequenza scolastica. Per quanto riguarda le prove scritte, per i criteri di<br />
valutazione, si è fatto riferimento a quelli indicati dal dipartimento di matematica,
evidenziati dalla griglia allegata<br />
L'INSEGNANTE<br />
Adele Pellegrino<br />
LICEO SCIENTIFICO ' U. DINI'<br />
anno scolastico 2012 – 2013<br />
RELAZIONE SULLA CLASSE V F<br />
FISICA<br />
La classe, per quanto riguarda la fisica, non ha avuto continuità didattica durante il<br />
triennio.<br />
Questo alternarsi di insegnanti potrebbe essere la causa dello scarso interesse con cui<br />
una parte<br />
Degli studenti, all'inizio dell'anno scolastico, ha affrontato lo studio della fisica.<br />
Comunque , per tutto l'anno, la classe è stata stimolata ad effettuare uno studio critico<br />
degli<br />
Argomenti trattati e ad un lavoro di rielaborazione personale.<br />
La maggior parte degli alunni ha risposto in maniera adeguata mostrando interesse,<br />
studiando in<br />
maniera costante, riuscendo a collegare i vari concetti studiati e ottenendo quindi dei<br />
risultati soddisfacenti; la parte rimanente invece, non avendo sempre mostrato interesse<br />
per la<br />
materia,ha lavorato in maniera discontinua non riuscendo sempre così ad organizzare i<br />
contenuti e<br />
ad ottenere una certa padronanza della materia, di conseguenza la preparazione risulta un<br />
po’<br />
superficiale e mnemonica.<br />
Il programma comunque è stato svolto come da programmazione di inizio anno.<br />
Modalità di svolgimento del programma:<br />
Lezioni frontali<br />
Discussioni collettive<br />
Esperienze di laboratorio<br />
Tipologia delle prove di verifica:<br />
_ Compiti tradizionali<br />
_ Questionari<br />
SCHEDA INFORMATIVA:
_ Colloqui orali individuali e collettivi<br />
_ Verifiche del tipo di terze prove<br />
Criteri di valutazione:<br />
_ In generale il criterio di sufficienza ha tenuto conto dell'acquisizione accettabile dei<br />
contenuti, di esposizione globalmente corretta, della serietà dell'impegno di studio e<br />
della frequenza scolastica.<br />
L' INSEGNANTE<br />
Adele Pellegrino<br />
LICEO SCIENTIFICO “ULISSE DINI” – PISA<br />
RELAZIONE SULLA CLASSE V, SEZIONE F, ANNO SCOLASTICO 2012/2013<br />
DOCENTE: ANTONIA PELLEGRINO<br />
MATERIE D’INSEGNAMENTO: FILOSOFIA E STORIA<br />
Per gli insegnamenti di Filosofia e Storia la classe V F non ha potuto beneficiare della<br />
continuità didattica, cambiando insegnante ogni anno del triennio. In quarta, inoltre, gli<br />
insegnamenti sono stati disgiunti e affidati a due diversi docenti. Questo ha comportato<br />
inevitabilmente un certo disorientamento negli alunni, che hanno di volta in volta dovuto<br />
adattarsi a metodologie e stili di insegnamento per forza di cose almeno parzialmente<br />
diversi.<br />
Va sottolineato che nel corso di quest'ultimo anno scolastico la classe, pur costretta a<br />
fronteggiare l'ennesimo cambiamento, nondimeno ha dimostrato una considerevole<br />
disponibilità verso la nuova docente. Non sono emerse particolari difficoltà nell’instaurare<br />
un rapporto di collaborazione e di fiducia con la classe, e questo ne testimonia<br />
sicuramente la maturità e un grado apprezzabile di versatilità.<br />
La partecipazione al dialogo educativo è stata costante e vivace da parte di un gruppo di<br />
alunni, mentre la maggior parte della classe è caratterizzata da un'attitudine ricettiva;<br />
tuttavia, questa distinzione non coincide con quella tra diversi gradi di interesse e di<br />
profitto: alcuni degli alunni più motivati e assidui, per motivi caratteriali, tendono ad esporsi<br />
poco e con difficoltà, anche se nel corso dell'anno scolastico hanno cercato di superare<br />
gradualmente questa loro naturale ritrosia.<br />
La classe ha dimostrato sin dall'inizio, nel suo complesso, un vivace interesse per<br />
l'attualità, che purtroppo non è stato possibile alimentare quanto avrebbe meritato,<br />
considerata l'esiguità delle ore a disposizione rispetto all'estensione del programma<br />
ministeriale di Storia: tuttavia sono state almeno poste le basi per un primo orientamento
nelle tematiche principali della seconda metà del Novecento.<br />
Considerata nel suo complesso, la classe ha un livello di preparazione discreto:<br />
permangono tuttavia alcune difficoltà nell'uso dei linguaggi specifici e soprattutto<br />
nell'organizzare l'esposizione orale. Queste ultime riguardano anche alcuni alunni che<br />
sono interessati, assidui, capaci di utilizzare il lessico specifico nella forma scritta e in<br />
complesso forniti di un bagaglio di conoscenze e competenze buono o più che buono.<br />
In conclusione, anche se alcuni allievi hanno evidenziato alcune difficoltà nell'acquisizione<br />
dei contenuti e del metodo di studio, dovute principalmente ad una intermittente assiduità<br />
nello studio oltre che alle vicissitudini prima esposte, la maggior parte della classe ha<br />
dimostrato un grado di impegno in generale soddisfacente; un gruppo ristretto di allievi ha<br />
raggiunto un livello di preparazione ottimo.<br />
È da segnalare infine che tutta la classe, nel corso di questo anno scolastico, ha<br />
partecipato con grande motivazione alle iniziative del progetto di Istituto “Incontro con la<br />
legalità”, che ha offerto agli alunni l'opportunità di confrontarsi con il procuratore aggiunto<br />
di Reggio Calabria, Nicola Gratteri, con lo scrittore e giornalista Antonio Nicaso, e con<br />
Attilio Bolzoni, giornalista di “Repubblica”, sui temi della lotta alla criminalità organizzata.<br />
Questo percorso ha trovato il suo coronamento nella partecipazione della V F alla<br />
manifestazione nazionale di “Libera” a Firenze, il 16 marzo 2013, in occasione della<br />
Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie.<br />
Pisa, 7 maggio 2013 In fede,<br />
Pellegrino)<br />
(Antonia
LICEO SCIENTIFICO STATALE ULISSE DINI PISA<br />
RELAZIONE FINALE CLASSE VF<br />
LINGUA E LETTERATURA INGLESE<br />
Gli studenti della classe quinta F(che hanno frequentato le lezioni di inglese insieme agli<br />
studenti del corso di inglese della quinta C) di cui sono stato titolare solo nell’anno<br />
scolastico 2012-2013 non hanno avuto purtroppo una adeguata continuità didattica nel<br />
loro corso di studi, avendo spesso cambiato il docente di lingua straniera. Questa<br />
situazione non ha forse favorito la spinta motivazionale e la consapevolezza<br />
dell’importanza della competenza comunicativa della lingua straniera, l’inglese in<br />
particolare, nel complesso contesto comunicativo contemporaneo.<br />
Fin dall’inizio dell’anno comunque la classe si è mostrata rispettosa, diligente e interessata<br />
al dialogo educativo,anche se non si può parlare di partecipazione attiva alle varie attività<br />
proposte, sia quelle storico-culturali e letterarie, sia quelle di General English mirate a<br />
sviluppare la competenza comunicativa nella lingua straniera, in particolare la<br />
comunicazione e l’espressione orale.<br />
Molto più positiva, sin dall’inizio, si è dimostrata la comprensione della lingua scritta nelle<br />
varie tipologie proposte, generalmente soddisfacente e in alcuni casi eccellente. Anche<br />
l’espressione scritta, migliorata rispetto all’inizio dell’anno, è generalmente adeguata,<br />
corretta, con un lessico appropriato e in qualche caso abbastanza ricco e flessibile.<br />
La fisionomia della classe è comunque buona: gli studenti sono stati sempre attenti<br />
durante le lezioni,hanno dimostrato un buon impegno e questo ha permesso lo<br />
svolgimento regolare dei programmi e il sostanziale raggiungimento degli obiettivi generali<br />
e specifici previsti nella programmazione annuale.<br />
Professor Gianfranco Giovannone
Relazione finale del docente<br />
Materia Educazione fisica Classe 5°F A.S.<br />
2012/2013<br />
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi<br />
in termini di:<br />
CONOSCENZE: la classe, complessivamente, è riuscita ad acquisire i termini del<br />
linguaggio specifico della disciplina. Conosce il regolamento e la tecnica individuale sia di<br />
giochi di squadra come la pallavolo, pallacanestro e alcuni propedeutici, sia delle principali<br />
discipline dell’atletica leggera e della ginnastica.<br />
Possiede informazioni fondamentali sulla struttura e il funzionamento dell’apparato<br />
locomotore, e sui sistemi energetici.<br />
COMPETENZE: nella classe ci sono elementi che hanno raggiunto buoni risultati nelle<br />
diverse discipline proposte, e tutti hanno raggiunto gli obiettivi minimi previsti. Gli alunni<br />
sanno tutti<br />
- Compiere movimenti semplici nella maniera più conveniente ed adatta alla situazione<br />
- Eseguire movimenti con una buona escursione articolare<br />
- Eseguire i fondamentali individuali di pallavolo e pallacanestro<br />
- Eseguire gli schemi di base d'attacco e difesa di questi giochi sportivi<br />
- Ideare e realizzare progetti motori finalizzati all’esecuzione di gesti sportivi<br />
.<br />
CAPACITA’: la classe ha raggiunto una buona padronanza del proprio corpo e del<br />
movimento in genere e una discreta capacità espressiva.<br />
Inoltre ha raggiunto gli obiettivi riguardanti il miglioramento delle capacità condizionali<br />
(forza, resistenza e velocità), e delle capacità coordinative generali e speciali quali la<br />
capacità di controllo, d'adattamento e d'apprendimento motorio, in maniera tale da<br />
permettere agli alunni di affrontare attività sportive in alcuni casi con risultati più che
sufficienti, e per altri molto buoni.<br />
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER:<br />
- Unità didattiche e/o<br />
- Moduli e/o<br />
- Percorsi formativi ed<br />
- Eventuali approfondimenti<br />
U.D. - Modulo - Percorso Formativo - approfondimento<br />
Attività rivolte al potenziamento fisiologico per sviluppare le qualità condizionali (forza,<br />
resistenza, velocità, mobilità articolare) e coordinative.<br />
Rielaborazione di schemi motori sempre più complessi e conoscenza degli obiettivi e delle<br />
caratteristiche dell’attività motoria.<br />
Pratica sportiva dei fondamentali e conoscenza del regolamento tecnico in forma<br />
elementare della pallavolo e pallacanestro.<br />
Affinamento dei gesti sportivi delle principali discipline dell’atletica e ginnastica.<br />
METODOLOGIE (lezioni).<br />
Recupero - sostegno e integrazione, ecc.:<br />
Lezioni frontali, di gruppo, adattate alle capacità di ciascun alunno.<br />
Non ci sono stati interventi di recupero o sostegno, in quanto tutti gli alunni hanno<br />
raggiunto gli obiettivi minimi richiesti.<br />
Lezioni di potenziamento individualizzate secondo le capacità personali di alcuni alunni<br />
(gruppo sportivo).<br />
MATERIALI DIDATTICI (testo adottato, orario settimanale di laboratorio, spazi,<br />
biblioteca, tecnologie audiovisive e/o multimediali, ecc.):<br />
Per quanto riguarda la parte pratica che si è svolta nella palestra dell’istituto, sono stati<br />
utilizzati piccoli e grandi attrezzi.<br />
DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE<br />
Prove scritte, verifiche orali, test oggettivi come previsti dalla terza prova, etc.:<br />
Test motori oggettivi; osservazione soggettiva fatta con riferimento ai risultati oggettivi<br />
dell’azione.<br />
Verifiche pratiche singole e di gruppo.<br />
La classe ha mostrato un notevole interesse all'attività pratica con rilevante<br />
partecipazione alle attività curricolari e agli approfondimenti demandati alle attività<br />
di Gruppo Sportivo Scolastico. L'interesse dimostrato ha permesso di rivolgersi con<br />
grande successo verso la quasi totalità delle altre attività motorie proposte.<br />
Una buona parte della classe ha condotto o conduce attività sportiva in ambiente<br />
societario e/o scolastico (Campionati Studenteschi, in particolare calcio, pallavolo,<br />
pallacanestro, atletica leggera e campestre) con ottimi risultati, entrando a far parte<br />
delle rappresentative a livello scolastico.<br />
L'interesse al ciclo di lezioni teoriche è stato buono e le verifiche scritte effettuate<br />
hanno avuto un esito soddisfacente. L'attività motoria, in quest'ultimo anno, si è
svolta ad un livello inferiore rispetto ai precedenti.<br />
Pisa, 10/5/2013 Firma del docente<br />
Bechelli<br />
<strong>Liceo</strong> scientifico “U.<strong>Dini</strong>”<br />
CLASSE VF Anno Scolastico 2012/13<br />
LATINO<br />
RELAZIONE FINALE<br />
Alessandra<br />
La situazione oggettiva di buona parte della classe, che non sempre è riuscita a colmare lacune<br />
pregresse e non ha trovato nella disciplina sufficienti motivazioni per una applicazione sistematica,<br />
ha inciso non poco sullo svolgimento del programma. La difficoltà, poi, degli argomenti trattati ha<br />
imposto un lavoro sistematico di analisi strutturale e lessicale dei testi affrontati. A seguito di questo,<br />
solo alcuni alunni hanno acquisito le seguenti abilità:<br />
capacità di contestualizzare storicamente un'opera;<br />
comprensione e corretta interpretazione della stessa;<br />
capacità di cogliere la specificità di un testo attraverso il lessico e gli eventuali procedimenti retorici<br />
presenti e di evidenziare gli spetti caratterizzanti la personalità dell'autore;<br />
capacità di individuare la persistenza di generi e topoi della letteratura latina nella produzione<br />
letteraria italiana.<br />
STRUMENTI<br />
Lezioni frontali, comprendenti l'analisi testuale di passi antologici e l’illustrazione di opere<br />
particolarmente significative di cui si è ritenuta opportuna la lettura integrale in traduzione; relazioni<br />
svolte da singoli alunni su questioni inerenti all’affinamento di certe abilità come: la traduzione<br />
contrastiva o all’approfondimento di argomenti ripresi dalla letteratura greca.<br />
traduzioni in classe o svolte autonomamente a casa.<br />
VERIFICHE
Colloqui orali; le verifiche scritte, oltre a comprendere traduzioni di brani di autori noti (limitatamente<br />
al primo trimestre),hanno mirato ad un accertamento delle conoscenze del pensiero degli autori e<br />
delle loro peculiarità stilistiche attraverso questionari inerenti ai passi trattati ed alle opere lette; è<br />
stata effettuata inoltre una simulazione di terza prova per verificare le capacità di comprensione ,di<br />
riflessione critica ed intertestuale degli alunni.<br />
VALUTAZIONE<br />
La valutazione ha tenuto conto della correttezza interpretativa e delle conoscenze teoriche e della<br />
capacità di operare inferenze significative.<br />
RECUPERO<br />
Il recupero è stato effettuato in orario curriculare secondo le seguenti modalità: ulteriori spiegazioni<br />
e costante ritorno, diluito nel tempo, sui contenuti relativamente ai quali sono emerse carenze e<br />
difficoltà da parte degli alunni.<br />
Pisa 15 Maggio 2013<br />
Prof.ssa Laura Rabuano
Classe VF Anno scolastico 2012/13<br />
ITALIANO<br />
RELAZIONE FINALE<br />
A conclusione di un lavoro ampio ed articolato volto allo sviluppo delle abilità e delle competenze<br />
disciplinari, la classe ha mostrato, in parte, di aver raggiunto alcuni fondamentali obiettivi:<br />
conoscenza ed uso degli strumenti metodologici necessari per interpretare il prodotto letterario;<br />
comprensione delle strutture organizzative di un testo;<br />
capacità di contestualizzarlo nel preciso momento storico in cui è stato prodotto;<br />
conoscenza delle fondamentali linee di sviluppo della letteratura italiana messa in rapporto, ove<br />
necessario, con quelle straniere;<br />
padronanza degli strumenti espressivi nelle produzioni orali e scritte di vario tipo;<br />
conoscenza delle diverse tecniche compositive.<br />
STRUMENTI<br />
Lezioni frontali, lezioni dialogate (relazioni di singoli o gruppi di alunni, esposte alla classe con<br />
domande di chiarimento); discussioni collettive per accertare la corretta assimilazione dei contenuti;<br />
analisi testuale di passi significativi o di opere lette integralmente; uso di sussidi audiovisivi.<br />
VERIFICHE<br />
Prove orali finalizzate all'accertamento del possesso dei contenuti, della capacità di riflessione<br />
personale e dell'uso corretto degli strumenti espressivi;<br />
prove scritte di varia tipologia (articolo, saggio breve, recensione, analisi di testi letterari).<br />
In data 28/05/13 sarà effettuata una simulazione di prima prova, elaborata dal Dipartimento di<br />
lettere. Tale prova sarà seguita da una correzione collegiale di alcuni elaborati scelti a campione fra<br />
le classi partecipanti , allo scopo di uniformare, per quanto possibile, i criteri di correzione.<br />
Il Dipartimento di lettere, come ogni anno, provvederà ad elaborare per le varie tipologie diverse<br />
griglie di correzione che verranno allegate al presente documento, unitamente al dossier<br />
contenente dette prove.<br />
VALUTAZIONE<br />
Il criterio di sufficienza adottato ha tenuto conto, per le prove orali, dell'acquisizione dei contenuti,<br />
della capacità di rielaborarli e di esporli in modo adeguato; per le prove scritte, della coerenza, della<br />
consequenzialità logica, della ricchezza argomentativa e della adeguatezza degli strumenti<br />
espressivi.<br />
RECUPERO<br />
Il recupero è stato effettuato in orario curricolare attraverso un costante ritorno su argomenti risultati<br />
particolarmente difficili e assegnando, in alcuni casi, lavori scritti individuali ogni volta corretti e<br />
discussi con gli interessati.<br />
PISA 15 Maggio 2013<br />
Prof.ssa Laura Rabuano
Obiettivi concordati<br />
all’inizio dell’anno<br />
scolastico<br />
<strong>Liceo</strong> scientifico “U. <strong>Dini</strong>” - Pisa<br />
RELAZIONE FINALE A.S. 2012/13<br />
Classe - 5 – sezione F -<br />
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE<br />
Docente: Isabella Giannettoni<br />
Sviluppare l'acquisizione critica delle conoscenze e le<br />
capacità di collegamento interdisciplinare.<br />
Saper leggere l’opera d’arte e proporre un metodo di analisi<br />
critico e flessibile attraverso una serie di parametri centrati su<br />
particolari aspetti dell’opera:<br />
tecnico-materiale, iconografico- rappresentativo, visivo-<br />
strutturale e linguistico- espressivo.
Livelli di partenza<br />
Attività di<br />
potenziamento<br />
Rapporti con le famiglie<br />
Obiettivi di<br />
apprendimento<br />
raggiunti<br />
Verifica e valutazione<br />
La classe 5F è composta da 16 alunni, 11 maschi e 5<br />
femmine, tutti iscritti per la prima volta all’ultimo anno di<br />
corso.<br />
La classe già dai primi anni ha evidenziato vivacità<br />
intellettuale, adeguato interesse e partecipazione per lo<br />
più attiva alla vita di classe. Seppure condizionata da un<br />
impegno più accurato rivolto allo studio in occasione delle<br />
verifiche, negli ultimi anni la classe ha mostrato più<br />
disponibilità e motivazione all'approfondimento;<br />
ciò ha contribuito ad una graduale crescita culturale di<br />
tutto il gruppo classe,<br />
anche se differenziata in relazione alle potenzialità, alla<br />
preparazione di base e agli interessi dei singoli individui.<br />
Gli obiettivi didattici prefissati nella materia sono stati<br />
raggiunti dalla totalità della classe con un livello di<br />
profitto sicuramente buono.<br />
Confronto fra le esposizioni orali dei<br />
compagni ricercandone pregi e difetti per<br />
ottenere un linguaggio più adeguato ed una<br />
terminologia più consona alla materia.<br />
Partecipazione a progetti e visione di<br />
musei, mostre e collezioni d'arte.<br />
I rapporti con le famiglie sono stati molto radi e per<br />
qualcuno anche inesistente, tenendo conto comunque<br />
che tutti gli alunni sono maggiorenni e quindi<br />
responsabili del loro percorso formativo.<br />
Conoscenza dei termini specifici;<br />
Comprensione dell’ambiente;<br />
Comprensione degli “oggetti artistici” attraverso<br />
l’analisi formale;<br />
Comprensione degli “oggetti artistici”attraverso le<br />
motivazioni religiose-sociali e storiche;<br />
Sviluppo delle capacità di analisi e sintesi e di<br />
valutazione autonoma del linguaggio visivo.<br />
Le verifiche si sono articolate su ogni singolo argomento<br />
trattato (modulo),<br />
tramite verifiche orali e/o scritte per valutare la capacità<br />
di analisi dell’opera d’arte e l’esposizione appropriata e<br />
sistematica dei contenuti.<br />
I criteri di valutazione adottati sono stati quelli stabiliti a<br />
suo tempo dal dipartimento:<br />
Gravemente insufficiente (< 4)<br />
mancata conoscenza dei contenuti<br />
Insufficiente ( 5 )<br />
conoscenza lacunosa dei contenuti<br />
esposizione stentata e frammentata<br />
Sufficiente ( 6 )
Tipologie delle prove di<br />
verifica utilizzate per<br />
la valutazione<br />
acquisizione dei contenuti minimi disciplinari,<br />
esposizione globalmente corretta e pertinente<br />
Discreto ( 7 )<br />
conoscenza adeguata dei contenuti<br />
esposizione corretta ed appropriata<br />
Buono ( 8 )<br />
padronanza dei linguaggi specifici<br />
capacità di collegamenti disciplinari e discrete<br />
capacità di rielaborazione autonoma<br />
Ottimo/Eccellente ( 9/10 )<br />
capacità di rielaborare in maniera autonoma e<br />
critica operando collegamenti interdisciplinari<br />
esposizione sicura ed appropriata dei linguaggi<br />
specifici<br />
Sono state utilizzate prove scritte costituite da verifiche<br />
semi strutturate, comprensive di quesiti per la verifica<br />
della conoscenza del linguaggio specifico per la lettura<br />
dell'opera d'arte. La valutazione è stata completata da<br />
verifiche orali degli studenti in forma diretta o tramite<br />
lezioni interattive.<br />
Nel corso dell'anno (oltre a due prove grafiche scritte),<br />
sono state effettuate cinque prove scritte (e alcuni<br />
interventi orali) per ogni studente per quanto riguarda<br />
storia dell'arte.
Osservazioni sullo svolgimento del programma<br />
I contenuti del corrente anno scolastico sono stati svolti rispettando quanto previsto.<br />
Il programma di disegno geometrico è stato concluso alla fine del primo trimestre:<br />
ciò ha permesso di dedicare più spazio alla storia dell'arte (materia di esame alla<br />
maturità).<br />
Sono stati ampliati alcuni argomenti seguendo particolari interessi dimostrati dagli alunni.<br />
Profitto medio ottenuto e criteri di valutazione<br />
Tenendo presente che all'interno della classe si individuano fasce di livello differenziate<br />
per impegno e capacità, gli alunni hanno mediamente raggiunto buoni risultati.<br />
La valutazione è stata riferita alla competenza acquisita, intesa come padronanza verbale,<br />
scritta e grafica delle tematiche affrontate.<br />
Metodologie e sussidi impiegati<br />
I contenuti di Disegno sono stati trasmessi con spiegazioni orali supportate da grafici alla<br />
lavagna.<br />
Per quanto riguarda la Storia dell'Arte, le tematiche affrontate sono state trattate con<br />
lezioni frontali supportate da immagini (libro di testo, video, computer...).<br />
Per sviluppare l'interesse, la partecipazione attiva e il confronto, la classe è stata più volte<br />
invitata a fare approfondimenti con successive discussioni in classe.<br />
La lettura delle opere è stata affrontata seguendo uno schema iconologico condiviso.<br />
Progetti e iniziative svolte<br />
La classe ha partecipato al Progetto “Educare al presente” della Strozzina<br />
(centro di cultura contemporanea di Palazzo Strozzi) aderendo al percorso “Economia e<br />
Arte”<br />
La classe ha partecipato alla “Giornata contro le mafie” Progetto “Incontro con la legalità”<br />
(realizzando personalmente fiori)<br />
-Alcuni alunni hanno aderito a “Scienza? Al <strong>Dini</strong>!”partecipando al laboratorio<br />
“Occhio e visione: Uno sguardo verso la mente e l'arte”.<br />
Sono state effettuate le seguenti lezioni fuori sede:<br />
Pisa: mostra dedicata a V. Kandinskij (Palazzo Blu, Pisa)<br />
Crespina (Pisa): collezione Carlo Pepi<br />
(opere di artisti Macchiaioli, post-macchiaioli, dell'avanguardia italiana e estera)<br />
- Viaggio d'istruzione in Grecia (Meteore e Grecia classica)<br />
Pisa, 15 Maggio 2013 Professoressa Giannettoni Isabella
Contenuto disciplinare svolto:<br />
Il quinto comandamento.<br />
<strong>Liceo</strong> scientifico “U. <strong>Dini</strong>”<br />
Relazione finale – a.s. 2012 – 2013 - Classe 5F<br />
Religione Cattolica – Docente Luciano Pratesi<br />
La pena di morte nella Bibbia e nella dottrina cattolica.<br />
L’omicidio volontario.<br />
Il suicidio.<br />
La legittima difesa.<br />
L’eutanasia.<br />
L’aborto.<br />
La guerra e la promozione della pace.<br />
La fecondazione assistita e l’adozione.<br />
Mc 9,38ss: i piccoli e lo scandalo.<br />
L’omossessualità. Gn 19,1-29; Rm 1,24-27; I Cor 6,10; I Tim 1,10.<br />
Il senso cristiano della vita.<br />
Il sacramento del matrimonio.<br />
Il Conclave. Elezione del capo della Chiesa cattolica.<br />
La libertà. La legge naturale. Il libero arbitrio. Libertà come dovere.<br />
Gli studenti Il docente
Profilo della classe<br />
Gli alunni hanno mantenuto un atteggiamento rispettoso nei confronti del docente e<br />
i rapporti interpersonali sono stati caratterizzati da una buona collaborazione;<br />
tuttavia, pur mostrandosi attenti e interessati agli argomenti trattati, non tutti gli<br />
studenti hanno sempre partecipato in modo attivo al dialogo educativo.<br />
Metodi utilizzati<br />
Congrue lezioni frontali sono state utilizzate per introdurre, esporre e spiegare gli<br />
argomenti. Gli alunni sono stati poi invitati ad approfondirli ed enuclearli attraverso sia il<br />
metodo induttivo che deduttivo. Per alcune tematiche particolari, inoltre, mi sono avvalso<br />
del metodo “per scoperta”, perché proprio attraverso le esperienze autonome dei singoli<br />
siamo potuti risalire all’argomento oggetto della nostra indagine.<br />
Mezzi e strumenti<br />
Bibbia, documenti del Magistero, schede didattiche, fotocopie.<br />
Criteri di valutazione adottati<br />
I criteri di valutazione hanno tenuto conto della partecipazione, dell’interesse,<br />
dell’impegno nonché delle capacità critiche e di rielaborazione, di analisi e sintesi in<br />
rapporto coerente al tema proposto.<br />
Obiettivi raggiunti<br />
Nel complesso gli alunni conoscono gli argomenti trattati, sanno rielaborarli<br />
criticamente mostrando buone capacità di analisi e sintesi.<br />
Pisa, 07.05.13 Il docente<br />
Prof. Luciano Pratesi<br />
LICEO SCIENTIFICO “U. DINI” -ANNO SCOLASTICO 2012-13<br />
CLASSE 5 SEZIONE F<br />
DISCIPLINA SCIENZE NATURALI
DOCENTE PROF. ISABELLA MARINI<br />
Relazione finale e Programma svolto<br />
Dopo un iniziale atteggiamento silenzioso ed apparentemente passivo, la classe ha<br />
gradualmente manifestato sempre più interesse nei confronti delle tematiche affrontate,<br />
ma il lavoro domestico non è sempre stato continuo ed approfondito. Alcune carenze<br />
contenutistiche e soprattutto metodologiche hanno rallentato all'inizio dell'anno scolastico<br />
lo svolgimento del programma. In quest'ultimo periodo l'impegno si è generalmente fatto<br />
più serio e tutti i ragazzi sono riusciti a far registrare significativi miglioramenti nella<br />
preparazione. Per quanto riguarda il profitto la classe appare suddivisa in tre fasce di<br />
livello. Una prima fascia (4 ragazzi), caratterizzata da continuità nell'impegno e vivo<br />
interesse, ha conseguito un buon livello di preparazione; gli alunni sono in grado di<br />
descrivere le principali vie metaboliche, di spiegarne criticamente gli aspetti chimici,<br />
sequenziali, energetici e regolatori e di identificare le caratteristiche emergenti nel<br />
passaggio macroscopico-microscopico-molecolare che caratterizzano la logica molecolare<br />
dei viventi. Sono poi in grado di correlare la struttura degli acidi nucleici alle funzioni di<br />
conservazione ed espressione dell'informazione genetica. Una seconda fascia, costituita<br />
da più di metà classe, ha manifestato un buon interesse ma discontinuità nell'impegno ed<br />
ha raggiunto una preparazione complessivamente più che sufficiente; gli alunni sono in<br />
grado di schematizzare le principali vie metaboliche, di spiegarne i principali aspetti<br />
energetici e regolatori e di identificare le caratteristiche emergenti nel passaggio<br />
macroscopico-microscopico-molecolare che caratterizzano la logica molecolare dei viventi,<br />
oltre a correlare la struttura degli acidi nucleici alle funzioni di conservazione ed<br />
espressione dell'informazione genetica. Una terza fascia (2-3 ragazzi) ha incontrato alcune<br />
difficoltà o è stata condizionata da un impegno inizialmente modesto ed ha conseguito una<br />
preparazione ai limiti della sufficienza.<br />
Tre alunni hanno partecipato all’iniziativa “Scienza? Al <strong>Dini</strong>” con un percorso sulla<br />
neurobiologia della visione, in particolare sulla fisiologia e biochimica del cristallino, sulla<br />
visione dei colori e sul fenomeno delle ombre colorate.<br />
Cinque ragazzi hanno partecipato alla fase d'Istituto delle Olimpiadi di Biologia.
<strong>Liceo</strong> <strong>Scientifico</strong> “U. <strong>Dini</strong>”<br />
PROGRAMMA DI MATEMATICA<br />
Classe V F a.s. 2012 - 2013<br />
Testo : Dodero – Baroncini : Nuovi elementi di matematica – mod. G<br />
PREMESSE ALL’ANALISI INFINITESIMALE<br />
Principio di induzione.<br />
Successioni. Progressioni aritmetiche e geometriche.<br />
Estremo superiore e inferiore di un insieme limitato su R<br />
Intorni di un punto . Punti di accumulazione<br />
LIMITI E CONTINUITA’ DELLE FUNZIONI DI UNA VARIABILE REALE<br />
Successioni.Limiti di successioni: verifiche.<br />
Limite di funzioni: definizione e verifiche.<br />
Teoremi fondamentali sui limiti : teorema dell’unicità del limite ( con dimostrazione ),<br />
teorema della permanenza del segno (con dimostrazione ),teorema del confronto ( con<br />
dimostrazione )<br />
Operazioni sui limiti ( somma, prodotto, quoziente ) Forme indeterminate<br />
Limite destro e sinistro. Limiti di funzioni monotone.<br />
Il numero e.<br />
Funzioni continue: definizione. Continuità delle funzioni elementari . Calcolo di limiti. Limiti<br />
fondamentali e limiti ad essi riconducibili<br />
Proprietà delle funzioni continue: teorema di esistenza degli zeri, teorema di Weiestrass,<br />
teorema dei valori intermedi. Teorema della continuità delle funzioni inverse<br />
Punti di discontinuità.<br />
Asintoti verticali, orizzontali, obliqui.<br />
DERIVATE DELLE FUNZIONI REALI DI UNA VARIABILE REALE<br />
Definizione di derivata e suo significato geometrico<br />
Regole di derivazione( somma, prodotto, quoziente con dimostrazione ), derivata di<br />
funzione di funzione, derivate delle funzioni inverse, derivate di ordine superiore<br />
Teorema di Rolle , teorema di Lagrange, conseguenze del teorema di Lagrange, teorema<br />
di Cauchy, teoremi di L’Hopital e loro applicazioni<br />
Applicazioni del calcolo differenziale per lo studio di una funzione: punti di massimo e di<br />
minimo relativi, punti di flesso, monotonia, concavità e convessità, punti singolari.<br />
Massimi e minimi assoluti<br />
Problemi di massimo e minimo<br />
Differenziale e suo significato geometrico.<br />
Applicazione delle derivate alla fisica.
INTEGRAZIONE DELLE FUNZIONI DI UNA VARIABILE REALE<br />
Integrali indefiniti: definizione<br />
Integrazioni immediate, integrazione per sostituzione, integrazione per parti, integrazione<br />
di funzioni razionali fratte.<br />
Integrale definito : definizione<br />
Teorema della media ( con dimostrazione ), teorema fondamentale del calcolo integrale (<br />
con dimostrazione )<br />
Calcolo di aree e di volumi.<br />
Integrali impropri<br />
Applicazione del calcolo integrale alla fisica.<br />
ANALISI NUMERICA<br />
Ricerca degli zeri di una funzione con il metodo di bisezione<br />
Integrazione numerica con il metodo dei rettangoli e dei trapezi.<br />
CALCOLO DELLE PROBABILITA’ E STATISTICA<br />
Elementi di statistica descrittiva: tabelle – medie – indici di variabilità.<br />
Variabile casuale discreta e continua : funzione di ripartizione, valore medio,<br />
varianza,<br />
scarto quadratico medio. Funzione di distribuzione.<br />
Distribuzioni tipiche di probabilità: distribuzione binomiale, distribuzione Gaussiana<br />
GLI ALUNNI L’ INSEGNANTE
Testo : Typler – L’elettromagnetismo<br />
<strong>Liceo</strong> <strong>Scientifico</strong> “U. <strong>Dini</strong>”<br />
PROGRAMMA DI FISICA<br />
Classe V F a.s. 2012 - 2013<br />
ELETTROSTATICA<br />
Carica elettrica. Legge di Coulomb.<br />
Campo elettrico. Linee di forza.<br />
Flusso e teorema di Gauss.<br />
Calcolo del campo elettrico per particolari distribuzioni di carica.<br />
Potenziale elettrico.<br />
Circuitazione del campo elettrico.<br />
Esperienza di Millikan.<br />
Capacità di un conduttore. Condensatore piano<br />
Condensatori in serie e parallelo<br />
Energia immagazzinata in un condensatore.<br />
Moto di una carica in un campo elettrico.<br />
LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA<br />
La corrente elettrica continua<br />
Il circuito elettrico<br />
Leggi di Ohm.<br />
Conduttori in serie e in parallelo<br />
La forza elettromotrice e la resistenza interna di un generatore di tensione<br />
Le leggi di Kirchoff<br />
Energia e potenza di una corrente continua<br />
La corrente nei conduttori metallici. L’effetto Joule<br />
Carica e scarica di un condensatore<br />
ELETTROMAGNETISMO<br />
Magneti artificiali e naturali: magneti e circuiti creano un campo magnetico<br />
Linee di forza del campo magnetico<br />
Confronto tra campo magnetico e campo elettrico<br />
Forze che si esercitano tra magneti e correnti e tra correnti e correnti.<br />
L’intensità del campo magnetico<br />
La forza esercitata da un campo magnetico su un filo percorso da corrente<br />
Momento magnetico di una spira<br />
Il campo magnetico di un filo rettilineo percorso da corrente<br />
Il campo magnetico di una spira e di un solenoide<br />
La forza di Lorentz<br />
Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme - selettore di velocità, spettrografo di
massa –Esperienza di Thomson.<br />
Il flusso del campo magnetico<br />
La circuitazione del campo magnetico<br />
Le correnti indotte<br />
La legge di Faraday-Neumann<br />
La legge di Lenz<br />
Produzione e trasporto dell’energia elettrica<br />
LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE<br />
Il campo elettrico indotto<br />
La corrente di spostamento<br />
Le equazioni di Maxwell<br />
Le onde elettromagnetiche (cenni)<br />
ESPERIENZE DI LABORATORIO<br />
Esperienze di elettrostatica.<br />
Esperienze sui condensatori.<br />
Resistenze in serie e in parallelo<br />
Esperienze di elettrodinamica.<br />
Effetto Joule.<br />
Scarica di un condensatore.<br />
Esperienze qualitative sull’interazione campo magnetico - corrente<br />
Esperienze sull’induzione elettromagnetica.<br />
GLI ALUNNI L’ INSEGNANTE
A.S. 2012-2013<br />
CLASSE V F<br />
LICEO SCIENTIFICO "ULISSE DINI" PISA<br />
PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE<br />
Ins. Gianfranco Giovannone<br />
Libri di testo adottati o comunque utilizzati nel corso dell’anno:<br />
A.A.V.V Lit &Lab From the Early Romantics to the Present Age, Zanichelli.<br />
Materiale Fotocopiato<br />
Film: Francis Ford Coppola Apocalypse Now!<br />
Alex Proyax The Crow<br />
MODULO 1 IL ROMANZO GOTICO<br />
The Gothic Novel Introduzione Lit &Lab p.283<br />
The Gothic Novel Introduzione Lit &Lab p.368<br />
A.Radcliffe From “The Mysteries of the Lit &Lab p.284<br />
Udolpho”<br />
M.Gregory Lewis From “The Monk” Lit &Lab pp. 369-370<br />
The Crow Video<br />
The Crow: classic and Fotocopia<br />
modern Gothic<br />
MODULO 2 LA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE E LA LETTERATURA INGLESE (1)<br />
Il Contesto storico-culturale Lit &Lab pp. 272-277<br />
William Wordsworth<br />
“Lyrical Ballads” Introduzione Lit &Lab pp. 292-3<br />
From “The Preface to The Lit &Lab pp. 293-295<br />
Lyrical Ballads”<br />
William Wordsworth “Daffodils” Lit &Lab pp.297-298<br />
William Wordsworth “Westminster Bridge” (Fotocopia)<br />
S.T. Coleridge “The Rime of the Ancient Lit &Lab pp. 298-301<br />
Mariner” Introduzione<br />
S.T. Coleridge From “The Rime of The Lit &Lab pp. 301-306<br />
Ancient Mariner”<br />
S.T. Coleridge “The Rime of the Ancient Fotocopia<br />
Mariner”<br />
critici<br />
Approfondimenti<br />
John Keats “Ode on a Grecian Urn” Lit &Lab pp. 333-335<br />
MODULO 3 LA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE E LA CULTURA INGLESE (2)<br />
The Victorian Age: Historical Lit &Lab pp. 402-407<br />
Context<br />
The Victorian Novel: Lit &Lab p.408<br />
introduzione<br />
Charles Dickens’s Biography Lit &Lab pp. 478-479<br />
Charles Dickens From “Hard Times” Lit &Lab pp. 409-411<br />
Charles Dickens From “Hard Times” Lit &Lab pp. 489-492
Charles Dickens From “Oliver Twist” Lit &Lab pp. 480-483<br />
Charles Dickens From “Oliver Twist” Fotocopia<br />
MODULO 4 PARADOSSI VITTORIANI<br />
G.B.Shaw From "Mrs Warren's Fotocopia<br />
Profession"<br />
G.B.Shaw ‘s biography Lit &Lab p. 453<br />
Oscar Wilde<br />
Oscar Wilde’s biography and Lit &Lab pp. 508-509<br />
themes<br />
From "The Picture of Dorian Lit &Lab pp. 510-512<br />
Gray"<br />
From "The Picture of Dorian Lit &Lab pp 513-516<br />
Gray"<br />
Oscar Wilde From "The Importance of Lit &Lab pp.517-520<br />
Being Earnest"<br />
Oscar Wilde Lady Bracknell Cross<br />
Examination<br />
MODULO 5 IMPERIALISMO E ANTIIMPERIALISMO<br />
Joseph Conrad and Heart of<br />
Darkness<br />
Fotocopia<br />
Lit &Lab pp.607-610.<br />
Joseph Conrad From “Heart of Darkness” Lit &Lab pp.610-613<br />
Joseph Conrad From “Heart of Darkness” Lit &Lab pp.613-615<br />
Joseph Conrad From “Heart of Darkness”<br />
Francis Ford Coppola Apocalypse Now! Film<br />
(Fotocopia)<br />
E.M.Forster From “A passage to India Lit &Lab p.682-687<br />
Victoriam Imperialism Lit &Lab pp.530-532<br />
Rudyard Kiplimg “The White Man’s Burden” Fotocopia<br />
MODULO 6 IL ROMANZO INGLESE DEL '900. IL MODERNISMO<br />
James Joyce Lit &Lab pp 688-692<br />
James Joyce From “Dubliners” Eveline Lit &Lab pp 692-697<br />
& The Dead<br />
James Joyce From “ Ulysses” Lit &Lab pp 701-704<br />
James Joyce’s Second Fotocopia<br />
Period + Molly’s<br />
Monologue.<br />
Time in modernist Fiction Fotocopia<br />
Virginia Woolf From Modern Fiction Fotocopia<br />
Virginia Woolf From "Mrs Dalloway” Lit &Lab pp 707-711<br />
Virginia Woolf biography<br />
and works.<br />
Lit &Lab pp 705-707
MODULO 7 IL ROMANZO UTOPISTICO INGLESE ***<br />
George Orwell Life & Works Lit &Lab pp 718-720<br />
George Orwell From “1984” Lit &Lab pp.724-726<br />
George Orwell From “1984” Lit &Lab pp.727-729<br />
William Golding From “Lord of the Flies” Lit &Lab pp.627-629<br />
William Golding Life & works Lit &Lab pp.625-626<br />
Gli studenti<br />
______________________________<br />
______________________________ L'insegnante<br />
Gianfranco Giovannone
LICEO SCIENTIFICO “ULISSE DINI” - PISA<br />
PROGRAMMA di DISEGNO e STORIA DELL’ARTE – A.S.2012/2013 – classe 5 F<br />
Professoressa Giannettoni Isabella<br />
I macro argomenti sono stati trattati inquadrandoli nel contesto storico-artistico.<br />
Gli artisti sono stati affrontati tratteggiandone la vita e scegliendo alcune opere<br />
significative.<br />
- G. Courbet: Lo spaccapietre<br />
- J-F. Millet: L'Angelus<br />
REALISMO:<br />
ROMANTICISMO:<br />
C. D. Friedrich: Il naufragio della Speranza, Il viandante sul mare di nebbia;<br />
J. Turner: Vapore durante una tempesta di mare, Pioggia, vapore e velocità;<br />
J. Constable: Studi di nuvole;<br />
T. Gèricault: La zattera della Medusa;<br />
F. Heyez: Il bacio;<br />
E. Delacroix: La Libertà che guida il popolo.<br />
MACCHIAIOLI<br />
Caratteri distintivi e differenze con gli artisti Impressionisti<br />
G. Fattori: visione delle opere della Collezione Carlo Pepi a Crespina (Pisa)<br />
IMPRESSIONISTI:<br />
E. Manet: Olympia, Déjeuner sur l’herbe, Il bar alle Folies-Bergère, C. Monet che<br />
dipinge sulla sua barca;<br />
C. Monet: Impressione-il tramonto del sole, La Grenouillere, Regata ad Argenteuil,<br />
La Cattedrale di Rouen, Ninfee;<br />
P. A. Renoir: La Grenouillere, Bal au Moulin de la Galette, L’altalena;<br />
B. Morisot: La culla, Giorno d'estate;<br />
E. Degas: Fantini davanti alle tribune, La classe di danza del signor Pierrot,<br />
L’assenzio;<br />
P. Cezanne: I giocatori di carte, La montagna Sainte-Victoire.<br />
POSTIMPRESSIONISMO:<br />
P. Gauguin: Il Cristo giallo, Donne tahitiane,<br />
Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?;<br />
V. Van Gogh: I mangiatori di patate, La camera da letto, La chiesa di Auvers,<br />
Campo di grano con volo di corvi, La notte stellata.<br />
G. Seurat: Una domenica pomeriggio alla Grande Jatte.<br />
ART NOUVEAU<br />
Caratteri generali ; denominazioni e caratteristiche espressive nei vari paesi.
Spagna (modernismo): A. Gaudì ( Sagrada Familia)<br />
Secessione austriaca: G. Klimt ( Il bacio, Giuditta)<br />
Secessione di Berlino; E. Munch (L’urlo, )<br />
FAUVES espressionismo in Francia<br />
H. Matisse : Ritratto con riga verde, La danza.<br />
DIE BRUCKE espressionismo in Germania<br />
E.L.Kirchner: Marcella<br />
CUBISMO:<br />
caratteri distintivi (proto cubismo, analitico e sintetico)<br />
- P. R. Picasso: vita, poetica e vari momenti espressivi con relative opere.<br />
Analisi più puntuale delle opere Les demoiselles d'Avignon e Guernica.<br />
FUTURISMO:<br />
F. T. Marinetti: Manifesti futuristi<br />
U. Boccioni: Autoritratto, Officine a Porta Romana, La città che sale, Stati d’animo;<br />
G. Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio, Le mani del violinista.<br />
ASTRATTISMO<br />
Der blaue Reiter :V. Kandinskij: primo acquerello astratto, La mucca, Composizioni;<br />
Visione della mostra dedicata all'artista (palazzo Blu, Pisa)<br />
REALISMO ESPRESSIONISTA IN GERMANIA:<br />
O. Dix: Il venditore di fiammiferi, La grande città;<br />
G. Grosz: Le colonne della società.<br />
L' INFORMALE -ESPRESSIONISMO ASTRATTO<br />
La pittura in America: L’Action painting<br />
Jackson Pollock: l’informale attraverso il “dripping”-Alchimia-<br />
Keit Haring: Tutto mondo<br />
-Cenni sull'Architettura moderna<br />
POP ART<br />
Graffiti art in America<br />
-Arte contemporanea: “arte e denaro” (percorso Palazzo Strozzi)<br />
Altri movimenti e/o artisti sono stati oggetto di approfondimento individuale<br />
da parte degli alunni (seguiti e verificati dall'insegnante)<br />
PROGRAMMA DI DISEGNO GEOMETRICO
-Ripreso sinteticamente la teoria dei metodi di rappresentazione svolti<br />
(proiezione ortogonale, assonometrica e prospettica) sottolineando le fondamentali<br />
operazioni di proiezione e sezione.<br />
Pisa, 15 Maggio 2013<br />
TEORIA DELLE OMBRE:<br />
applicazione alle proiezioni ortogonali e assonometriche<br />
(figure piane, solide e gruppi di solidi).<br />
L’Insegnante Alunni<br />
Isabella Giannettoni
Programma di Educazione Fisica classe V F<br />
Considerate le finalità dell’educazione fisica e gli obiettivi di apprendimento<br />
indicati nei programmi ministeriali, si è ritenuto d’organizzare le attività senza<br />
una suddivisione temporale rigida in unità didattiche. Questo per tener conto sia<br />
delle situazioni ambientali (utilizzo di palestre o impianti esterni in relazione a<br />
disponibilità e condizioni meteorologiche), sia della complessità del gesto<br />
motorio, sia della necessità di variare le proposte e alternare le attività.<br />
Test di verifica dei singoli obiettivi sono state utilizzate mediante applicazione<br />
sul campo delle regole e dei fondamentali dei giochi sportivi e l’apprendimento<br />
delle tecniche elementari di varie discipline dell’atletica leggera con loro<br />
misurazione (getto del peso, salto in alto, sprint di 30 metri).<br />
Sono inoltre stati utilizzati alcuni test sufficientemente validi, affidabili e obiettivi,<br />
capaci di misurare le capacità di forza veloce degli arti inferiori:<br />
Sergent test e lungo da fermo (vincere resistenze rappresentate dal<br />
carico naturale)<br />
Indicazioni<br />
metodologiche – Miglioramento delle qualità<br />
fisiche<br />
Miglioramento della resistenza. Corsa continua protratta – Giochi sportivi<br />
codificati (pallacanestro, pallavolo, calcio)<br />
Miglioramento della forza (veloce e resistente). Lungo da fermo – Lanci con<br />
palloni medicinali – Balzi alternati – Balzi a rana – Saltelli vari su una o due<br />
gambe - Skip - Rinforzo della muscolatura addominale, dorsale, dei glutei, degli<br />
arti inferiori e superiori a carico naturale - Esercitazioni dinamiche di<br />
coordinazione e sensibilizzazione propriocettiva etc.<br />
Miglioramento della velocità. Prove ripetute su brevi distanze<br />
Miglioramento della mobilità articolare. Attività ed esercizi a carico naturale –<br />
Rilassamento muscolare – Stretching – Esercitazioni di corsa in decontrazione-<br />
Affinamento funzioni neuro-muscolari. Esercizi di coordinazione vari – Controllo<br />
delle righe per l’equilibrio in fase dinamica (giochi sportivi) –<br />
Acquisizione delle capacità operative e sportive. Approccio globale e<br />
precisazione tecnica di:<br />
pallavolo (palleggio, bagher, battuta tennis, schiacciata, gioco, applicazione di<br />
semplici schemi), pallacanestro (palleggio, terzo tempo, “dai e vai”, arresto e<br />
tiro, piede perno, rimbalzo, passaggio etc., gioco, applicazione di semplici<br />
schemi), calcio (gioco) ed altri.<br />
Passaggio ostacoli: passaggi laterali di prima e seconda gamba, ritmica a passi<br />
pari e dispari con ostacoli a varie altezze. Salto in alto tipo Fosbury. Getto del<br />
57
peso.<br />
La pratica di queste esercitazioni sportive individuali e di squadra, anche<br />
quando hanno assunto carattere di competitività, sono state realizzate in<br />
armonia con l’istanza educativa, in modo da promuovere in tutti gli studenti,<br />
anche nei meno dotati, l’abitudine alla pratica motoria e sportiva. E’ stata<br />
favorita negli allievi l’assunzione di ruoli diversi e di responsabilità specifiche,<br />
promuovendo una maggior capacità decisionale, di giudizio e di<br />
autovalutazione.<br />
Si è cercato di favorire il passaggio da un’attività globale di tipo espressivo<br />
comunicativo, a varie tecniche di comunicazione non verbale che consentissero<br />
di leggere criticamente i messaggi corporei altrui (come il linguaggio gestuale<br />
arbitrale) e quelli utilizzati dai mezzi di comunicazione di massa.<br />
Per quanto riguarda l’aspetto teorico-pratico, sono state impartite norme<br />
elementari di comportamento al fine della prevenzione degli infortuni e della<br />
prestazione dei primi soccorsi. Sono state inoltre effettuate lezioni teoriche<br />
relative a<br />
Apparato scheletrico<br />
Paramorfismi nell’età scolare<br />
Apparato articolare<br />
Sistema muscolare<br />
Capacità condizionali (Forza, resistenza, velocità)<br />
Capacità coordinative<br />
Principi fondamentali della teoria e metodologia dell'allenamento<br />
Le droghe e il doping: educazione e prevenzione<br />
Per acquisire una consolidata cultura del movimento e dello sport che si fosse<br />
tradotta in costume di vita, lo studente è stato chiamato ad interiorizzare principi<br />
e valori ad essi collegati, tramite informazioni sulla teoria del movimento e sulle<br />
metodologie dell’allenamento correlate all’attività svolta.<br />
Gli studenti sono inoltre stati informati sulla corretta terminologia delle posizioni<br />
corporee e di movimento segmentario.<br />
Nel triennio è stato ricercato l’espletamento di compiti più complessi,<br />
l’affinamento dei fondamentali, la loro messa in pratica e l’applicazione delle<br />
regole che definiscono le pratiche sportive.<br />
Gli Studenti Il Professore<br />
58<br />
Alessandra Bechelli
Programma di Italiano (classe 5ªF anno scolastico 2012-2013)<br />
Libro di testo: Rosa fresca aulentissima, Corrado Bologna,Paola Rocchi.<br />
Volumi 4,5,6,7.<br />
L’età napoleonica<br />
Lo scenario: storia, società, cultura, idee ;<br />
Neoclassicismo :Johann Joachim Winckelmann;<br />
Il Preromanticismo: caratteri;<br />
L’estetica del sublime; lo Sturm und Drang: Friedrich Schiller:”Poesia degli<br />
antichi e poesia dei moderni”<br />
I poeti sepolcrali.<br />
Il romanticismo<br />
Johann Wolfgang Goethe;<br />
I dolori del giovane Werther;<br />
“Il duplice volto della natura”<br />
Ugo Foscolo:<br />
La vita;<br />
La cultura e le idee;<br />
Le Ultime lettere di Jacopo Ortis;<br />
“Il sacrificio della patria nostra è consumato” dalle Ultime lettere di Jacopo<br />
Ortis;<br />
“Il colloquio con Parini: la delusione storica” dalle Ultime lettere di Jacopo Ortis;<br />
“La lettera da Ventimiglia: la storia e la natura” dalle Ultime lettere di Jacopo<br />
Ortis;;<br />
I Sonetti ;<br />
“Solcata ho fronte”<br />
“In morte del fratello Giovanni”<br />
“A Zacinto”<br />
“Alla sera”.<br />
Dei sepolcri;<br />
“Dei sepolcri” ( lettura integrale);<br />
Le Grazie ;<br />
“Proemio” dalle Grazie vv.1-27;<br />
“La nascita delle Grazie”<br />
Altri scritti letterari;<br />
“Didimo Chierico, l’anti-Ortis” dalla Notizia intorno a Didimo Chierico;<br />
L’età del Romanticismo:<br />
Lo scenario: storia, società, cultura, idee ;<br />
Il movimento romantico in Italia;<br />
Madame de Staël;<br />
“Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni”;<br />
Giovanni Berchet<br />
59
“Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliuolo”<br />
Giacomo Leopardi:<br />
La vita;<br />
Il pensiero;<br />
La poetica del «vago e indefinito»;<br />
“La teoria del piacere” dallo Zibaldone;<br />
“Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza” dallo Zibaldone ;<br />
“L’antico” dallo Zibaldone;<br />
“Indefinito e infinito” dallo Zibaldone;<br />
“Il vero è brutto” dallo Zibaldone;<br />
“Teoria della visione” dallo Zibaldone;<br />
“Parole poetiche” dallo Zibaldone;<br />
“Ricordanza e poesia” dallo Zibaldone;<br />
“Teoria del suono” dallo Zibaldone;<br />
“Indefinito e poesia” dallo Zibaldone;<br />
“Suoni indefiniti ” dallo Zibaldone;<br />
“La doppia visione” dallo Zibaldone;<br />
“La rimembranza” dallo Zibaldone;<br />
I Canti;<br />
“L’infinito”;<br />
“Ultimo canto di Saffo” ;<br />
" A Silvia";<br />
“Le ricordanze”;<br />
“Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”: confronto con Petrarca:<br />
"Movesi il vecchierel canuto e biancho" e con " Ne la stagion che'l ciel rapido<br />
inchina" (testi in fotocopia);<br />
“La ginestra o il fiore del deserto ;<br />
Le Operette morali e l’«arido vero»;<br />
“Dialogo della Natura e di un Islandese”;<br />
“Dialogo di Plotino e di Porfirio<br />
"Dialogo di Tristano e di un amico".<br />
Lettura di pagine scelte dal saggio di Luporini : “Leopardi progressivo”<br />
Alessandro Manzoni:<br />
La vita;<br />
Dopo la conversione: la concezione della storia e della letteratura;<br />
Le unità aristoteliche T2" Il romanzesco e il reale" dalla Lettre a M. Chauvet;<br />
" Storia e invenzione poetica" dalla Lettre a M. Chauvet;<br />
" L' utile, il vero, l'interessante dalla Lettera sul Romanticismo;<br />
" I promessi sposi" (Lettura integrale).Dal Fermo e Lucia ai Promessi sposi;<br />
I promessi sposi e il romanzo storico; Il quadro polemico del Seicento; L' ideale<br />
manzoniano di società; Liberalismo e cristianesimo<br />
;La concezione manzoniana della Provvidenza; L' ironia verso la narrazione e i<br />
lettori; L' ironia verso i personaggi; Il problema della lingua e le diverse redazioni<br />
del romanzo;<br />
" La lingua dell' uso" da Sentir messa ( Testo in fotocopia);<br />
Dopo I promessi sposi: il distacco dalla letteratura.<br />
60
Il Positivismo ed il Naturalismo<br />
“Un manifesto del Naturalismo” dalla prefazione a Germinie Lacerteux,<br />
Edmond e Jules de Goncourt.<br />
Emile Zola:<br />
Prefazione a “La fortuna dei Rougon”<br />
Testi tratti da “Il romanzo sperimentale”.<br />
Il Verismo italiano<br />
Giovanni Verga<br />
La vita;<br />
I romanzi preveristi;<br />
La svolta verista;<br />
Poetica e tecnica narrativa del Verga verista;<br />
“Fantasticheria” da Vita dei campi;<br />
“Rosso Malpelo” da Vita dei campi ;<br />
Lotta per la vita e “darwinismo sociale”;<br />
Il ciclo dei vinti;<br />
“I «vinti» e la «fiumana del progresso»” dalla prefazione a I Malavoglia;<br />
I Malavoglia ( lettura integrale);<br />
“La Roba” dalle Novelle rusticane;<br />
“Libertà”.<br />
I prodromi del Decadentismo<br />
Charles Baudelaire<br />
La vita;<br />
I fiori del male;<br />
“Corrispondenze” da I fiori del male;<br />
“L’albatro” da I fiori del male;<br />
“Spleen” da I fiori del male;<br />
“Perdita d’aureola” da Lo spleen di Parigi ;<br />
La poesia simbolista<br />
Paul Verlaine ;<br />
“Arte poetica” da Un tempo e poco fa;<br />
“Languore”<br />
Rimbaud<br />
“Vocali”da Poesie;<br />
“La metamorfosi del poeta” da “La lettera del veggente”<br />
Oscar Wilde;<br />
“I principi dell’estetismo” dalla prefazione a Il ritratto di Dorian Gray;<br />
Il Decadentismo : categoria storica e categoria culturale<br />
Gabriele D’Annunzio<br />
La vita ;<br />
La fase dell'estetismo<br />
“Il piacere” :lettura capp.I, II parteI e cap.I parte II;<br />
I romanzi del superuomo<br />
“Il programma politico del superuomo” da Le vergini delle rocce, libro I;<br />
" Il superomismo dannunziano" Carlo Salinari" ( testo in fotocopia);<br />
61
Le Laudi;<br />
“Le città terribili” da Maya, XVI, vv.211-294;<br />
“La sera fiesolana” da Alcyone ;<br />
“La pioggia nel pineto” da Alcyone ;<br />
“Meriggio” da Alcyone;<br />
" Stabat nuda aestas" da Alcyone<br />
Giovanni Pascoli<br />
La vita;<br />
La visione del mondo;<br />
La poetica; “ Il fanciullino”, passi scelti;<br />
Myricae;<br />
“X Agosto” da Myricae;<br />
“L’assiuolo” da Myricae;<br />
“Novembre” da Myricae;<br />
“Temporale” da Myricae;<br />
“Il tuono” da Myricae;<br />
“Il lampo” da Myricae;<br />
“Piccolo bucato”da Myricae<br />
I Poemetti;<br />
“Digitale purpurea” dai Poemetti ;<br />
I Canti di Castelvecchio;<br />
“Il gelsomino notturno” dai Canti di Castelvecchio;<br />
" Nebbia"dai Canti di Castelvecchio;<br />
I Poemi conviviali;<br />
“Alexandros” dai Poemi conviviali;<br />
Il discorso “La grande Proletaria si è mossa”;<br />
Critica a: Il sabato del villaggio di Leopardi da Il sabato;<br />
Il primo Novecento<br />
Luigi Pirandello<br />
La vita;<br />
La visione del mondo; la poetica; L’umorismo; lettura passi scelti.<br />
Novelle per un anno; Lettura e analisi dei seguenti testi:<br />
“La carriola”, “La patente”,” Marsina stretta”.<br />
I romanzi: Il fu Mattia Pascal ( lettura integrale); Uno, nessuno, centomila (<br />
cenni).<br />
Il teatro: le fasi.<br />
“Sei personaggi in cerca d’autore” ( lettura integrale)<br />
Italo Svevo<br />
La vita e la cultura;<br />
I primi due romanzi:”Una vita” e “Senilità”;<br />
“La coscienza di Zeno”:la struttura.<br />
Lettura di Prefazione e Preambolo; Il fumo (cap.III), La morte del padre(cap.IV),<br />
Il finale (cap.VIII).<br />
Il Futurismo*<br />
Manifesto del Futurismo<br />
Manifesto tecnico della letteratura futurista.<br />
62
L’Ermetismo: definizione*<br />
Giuseppe Ungaretti*<br />
La vita; il pensiero e la poetica; le raccolte poetiche e le scelte formali;<br />
Il porto sepolto; da L’allegria di naufragi a L’Allegria: una poesia in fieri.<br />
da "L'Allegria"<br />
“Noia”;<br />
“In memoria”;<br />
“Il porto sepolto”;<br />
“Veglia”;<br />
“I fiumi”;<br />
“San Martino del Carso”;<br />
“Soldati”;<br />
“Natale”<br />
.<br />
Eugenio Montale*<br />
La vita; il pensiero e la poetica; la poetica dell’oggetto; Eliot e Montale: il<br />
“correlativo oggettivo”.<br />
Ossi di seppia : scelte formali e sviluppi tematici.<br />
Da “Ossi di seppia”<br />
“I limoni”;<br />
“Non chiederci la parola”;<br />
“Meriggiare pallido e assorto”;<br />
“Spesso il male di vivere …”;<br />
“Cigola la carrucola del pozzo”.<br />
Cenni alle altre raccolte( Le occasioni, La bufera e altro, Satura).<br />
Pisa 15 Maggio 2013<br />
L'insegnante Gli alunni<br />
Rabuano Laura<br />
63
Programma di Latino (classe 5ªF Anno scolastico 2012-2013)<br />
Libro di testo: “ELECTA” (volume 2) autore Giovanna Garbarino; Casa editrice<br />
Paravia.<br />
L’età imperiale:<br />
Dalla repubblica al Principato :il problema istituzionale<br />
La pax Augusta ;la restaurazione morale e religiosa;la politica culturale:<br />
Mecenate e gli altri<br />
promotori di cultura, la nuova figura del letterato.<br />
Virgilio:<br />
Dati biografici,contenuti e cronologia delle opere;<br />
Le Bucoliche . cronologia e struttura, il modello teocriteo, gli elementi di<br />
originalità.<br />
Ecloga I: lettura integrale in traduzione;<br />
Ecloga IV: la traslatio. Lettura integrale in traduzione,<br />
Le Georgiche:.la struttura, le fonti, la concezione del lavoro fra Esiodo e<br />
Lucrezio; Ipotesi sulla conclusione della IV.<br />
Eneide:la struttura, i contenuti, il rapporto con i modelli, il messaggio ideologico;<br />
Analisi, traduzione e commento del Proemio vv. 1-11<br />
Eneide IV vv.1-11 (lettura in latino);<br />
Eneide IVvv.304-323 ( lettura in latino);<br />
Eneide IV vv. 612-629 ( lettura in latino);<br />
Lettura integrale libro IV (in italiano)<br />
Orazio:<br />
Dati biografici, contenuti e cronologia delle opere ;<br />
I Sermones:le caratteristiche, il messaggio.<br />
Sermones I,9 (lettura integrale in italiano);<br />
I Carmina: il rapporto con i modelli, i filoni tematici, lo stile;<br />
Carmina, I, 9 ( lettura in latino);<br />
Carmina, I,11 (lettura in latino);<br />
Carmina I, 37 (lettura in latino);<br />
Carmina III, 30 ( lettura in latino)<br />
Il motivo simposiaco: differenze rispetto al modello greco.<br />
L'Ars poetica, cenno ai contenuti.<br />
Tito Livio<br />
Dati biografici;<br />
Ab urbe condita libri : la struttura dell’opera;<br />
Le fonti ed il metodo storiografico;<br />
La Praefatio e la visione della storia, il rapporto con il principato;<br />
Lettura della Praefatio in italiano.<br />
Seneca<br />
Dati biografici;<br />
Da Apokolokyntosis Divi Claudii: lettura in latino del capitolo 5;<br />
Le Epistulae morales ad Lucilium: caratteri generali e precedenti nella<br />
64
letteratura latina;<br />
Da Epistulae morales ad Lucilium: lettura in latino dell’epistola 1,1;<br />
Lettura integrale in traduzione del De brevitate vitae.<br />
Tacito*<br />
Dati biografici;<br />
Da AnnalesXV 59-65 :La congiura dei Pisoni (in traduzione); confronto con il<br />
racconto di Dione Cassio e Svetonio.*<br />
Da Annales XVI La morte di Seneca ; la morte di Petronio*<br />
Petronio<br />
Il Satyricon: il problema del genere letterario*<br />
Lettura in traduzione de La matrona di Efeso e di parte della Cena<br />
Trimalchionis*<br />
Pisa 15 Maggio 2013<br />
L'insegnante Gli alunni<br />
Rabuano Laura<br />
PROGRAMMA<br />
Le biomolecole e la cellula.<br />
Le proteine. Le classi di amminoacidi. Il legame peptidico. Caratteristiche<br />
acido-basiche degli amminoacidi e pH. Costruzione di un peptide e<br />
determinazione della carica a diversi pH. Principi dell'elettroforesi. Le strutture<br />
secondaria, terziaria e quaternaria.<br />
I carboidrati. Struttura aperta ed emiacetalica di glucosio, fruttosio e ribosio. I<br />
legami glicosidici α(1,4), α(1,6) e β(1,4). I disaccaridi. I polisaccaridi amido,<br />
glicogeno e cellulosa. Idrolisi di un polisaccaride. Test di Fehling per gli zuccheri<br />
riducenti. Test di Lugol per l'amido.<br />
I lipidi. Gli acidi grassi e la loro esterificazione a trigliceridi. I fosfolipidi e le<br />
membrane biologiche.<br />
Gli acidi nucleici. Le basi azotate, i nucleosidi ed i nucleotidi. Il legame<br />
fosfodiesterico. Differenze tra DNA ed RNA. Duplicazione del DNA, principali<br />
enzimi coinvolti. Caratteristiche della DNA polimerasi, i frammenti di Okazaki.<br />
L'articolo di Watson e Crick e il modello strutturale del DNA. Differenze tra DNA<br />
procariotico ed eucariotico. Il DNA mitocondriale e l'evoluzione.<br />
L’ultrastruttura della cellula. Struttura e funzioni di tutti organuli intracellulari.<br />
Gli enzimi.<br />
Catalisi, energia di attivazione e velocità di reazione. Fattori che influenzano la<br />
velocità delle reazioni catalizzate da enzimi. L'equazione di Michaelis & Menten<br />
e la trasformazione dei doppi reciproci. Gli enzimi allosterici. La velocità di<br />
reazione, le unità enzimatiche, il numero di turnover.<br />
65
Bioenergetica. Le leggi della termodinamica. L'energia libera e i sistemi<br />
biologici. L’ATP e le reazioni accoppiate. I trasportatori di elettroni (NAD + e FAD)<br />
e le redox.<br />
L'emoglobina. Correlazione struttura-funzione. L'importanza della struttura<br />
quaternaria per l'allosterismo, strutture T ed R. La curva di ossigenazione di<br />
individui normali. Gli effettori allosterici negativi. L'effetto Bohr. L'adattamento<br />
alle alte quote. L'intossicazione da CO. L'anemia falciforme e il polimorfismo<br />
bilanciato.<br />
Metabolismo. Catabolismo ed anabolismo. Modelli di vie e strategie<br />
metaboliche. Il ruolo degli enzimi allosterici nella regolazione.<br />
Metabolismo dei carboidrati.<br />
Glicolisi. Le reazioni e la struttura bifasica. Il ruolo della fosfofruttochinasi.<br />
Regolazione. La fermentazione lattica ed alcoolica. Resa energetica.<br />
Il ciclo di Krebs. Compartimentazione e struttura del mitocondrio. La reazione<br />
del complesso della piruvato deidrogenasi. Le reazioni e la struttura ciclica. Il<br />
ciclo di Krebs come via anfibolica e strettamente aerobia. Resa energetica.<br />
La catena respiratoria e la fosforilazione ossidativa. I complessi<br />
trasportatori di elettroni. Il modello chemio-osmotico di Mitchell. L'ATP sintasi.<br />
Resa energetica nei procarioti e negli eucarioti. I disaccoppianti.<br />
La gluconeogenesi e la sua regolazione.<br />
Glicogenosintesi e glicogenolisi. Le glicogenosi.<br />
*Regolazione ormonale del metabolismo. Gli ormoni: natura chimica e<br />
secrezione. Azione di adrenalina, insulina e glucagone sul metabolismo<br />
glucidico e lipidico. Meccanismi molecolari di trasduzione del segnale. Il ruolo<br />
dell'cAMP, della PKA, delle fosfatasi e delle fosforilazioni.<br />
*Biologia molecolare. La duplicazione del DNA. La biosintesi delle proteine,<br />
trascrizione e traduzione. Il codice genetico. Le mutazioni. Il concetto di gene.<br />
Proteine costitutive ed inducibili. Promotore, il lac operon. La regolazione della<br />
sintesi delle proteine nei procarioti e negli eucarioti. Organizzazione molecolare<br />
dei cromosomi. Espressione genica e fenotipo. Le malattie metaboliche.<br />
Genoma, proteoma e trascrittoma.<br />
La tecnologia del DNA ricombinante e l’ingegneria genetica. L'esempio<br />
dell'insulina.<br />
*= da completare<br />
66