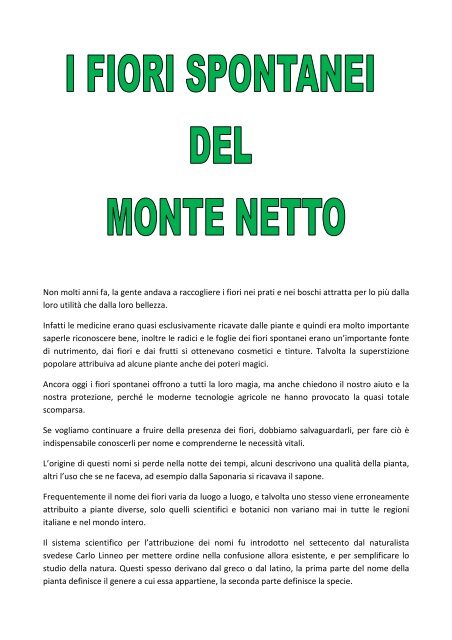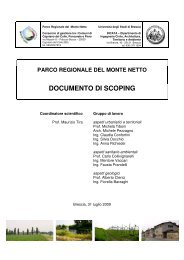Clicca qui per visualizzare il file. - Parco Agricolo Regionale del ...
Clicca qui per visualizzare il file. - Parco Agricolo Regionale del ...
Clicca qui per visualizzare il file. - Parco Agricolo Regionale del ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Non molti anni fa, la gente andava a raccogliere i fiori nei prati e nei boschi attratta <strong>per</strong> lo più dalla<br />
loro ut<strong>il</strong>ità che dalla loro bellezza.<br />
Infatti le medicine erano quasi esclusivamente ricavate dalle piante e <strong>qui</strong>ndi era molto importante<br />
sa<strong>per</strong>le riconoscere bene, inoltre le radici e le foglie dei fiori spontanei erano un’importante fonte<br />
di nutrimento, dai fiori e dai frutti si ottenevano cosmetici e tinture. Talvolta la su<strong>per</strong>stizione<br />
popolare attribuiva ad alcune piante anche dei poteri magici.<br />
Ancora oggi i fiori spontanei offrono a tutti la loro magia, ma anche chiedono <strong>il</strong> nostro aiuto e la<br />
nostra protezione, <strong>per</strong>ché le moderne tecnologie agricole ne hanno provocato la quasi totale<br />
scomparsa.<br />
Se vogliamo continuare a fruire <strong>del</strong>la presenza dei fiori, dobbiamo salvaguardarli, <strong>per</strong> fare ciò è<br />
indispensab<strong>il</strong>e conoscerli <strong>per</strong> nome e comprenderne le necessità vitali.<br />
L’origine di questi nomi si <strong>per</strong>de nella notte dei tempi, alcuni descrivono una qualità <strong>del</strong>la pianta,<br />
altri l’uso che se ne faceva, ad esempio dalla Saponaria si ricavava <strong>il</strong> sapone.<br />
Frequentemente <strong>il</strong> nome dei fiori varia da luogo a luogo, e talvolta uno stesso viene erroneamente<br />
attribuito a piante diverse, solo quelli scientifici e botanici non variano mai in tutte le regioni<br />
italiane e nel mondo intero.<br />
Il sistema scientifico <strong>per</strong> l’attribuzione dei nomi fu introdotto nel settecento dal naturalista<br />
svedese Carlo Linneo <strong>per</strong> mettere ordine nella confusione allora esistente, e <strong>per</strong> semplificare lo<br />
studio <strong>del</strong>la natura. Questi spesso derivano dal greco o dal latino, la prima parte <strong>del</strong> nome <strong>del</strong>la<br />
pianta definisce <strong>il</strong> genere a cui essa appartiene, la seconda parte definisce la specie.
Qui vogliamo presentarvi alcune schede di fiori spontanei <strong>del</strong> <strong>Parco</strong> <strong>del</strong> Monte Netto, in esse<br />
trovate <strong>il</strong> nome volgare, alcune foto ut<strong>il</strong>i <strong>per</strong> l’identificazione, la nomenclatura scientifica, la<br />
classificazione botanica ed alcune brevi note descrittive.<br />
Le piante si suddividono in:<br />
Autoctone: quelle che si sono originate ed evolute nel territorio in cui si trovano o che vi sono<br />
immigrate autonomamente da lungo tempo, stab<strong>il</strong>endovi popolazioni che si auto sostengono.<br />
Alloctone: quelle che sono state importate in una data regione dall’uomo (es: la comunissima<br />
Robinia pseudoacacia che proviene dal Nord America).<br />
Tra le Alloctone possiamo annoverare anche quelle provenienti da nazioni esotiche che hanno<br />
raggiunto <strong>il</strong> Monte Netto in modo fortuito: introdotte inavvertitamente dagli immigrati, attecchite<br />
nel substrato di piante coltivate altrove e da noi importate. Definiremo queste come alloctone<br />
occasionali se non hanno raggiunto una consistenza tale da <strong>per</strong>mettere loro una sopravvivenza<br />
continua nel tempo.<br />
Nel parco non sussistono piante spontanee Endemiche, cioè quelle che sono esclusive si un dato<br />
territorio.
Ach<strong>il</strong>lea m<strong>il</strong>lefolium L.<br />
ACHILLEA MILLEFOGLIE<br />
Famiglia: Compositae<br />
Sinonimi: Ach<strong>il</strong>lea setacea Waldstein et Kitaibel<br />
Nomi volgari: m<strong>il</strong>lefoglie, m<strong>il</strong>lefoglio, ach<strong>il</strong>lea,erba dei tagli,sanguinella, erba formica..<br />
Etimologia: <strong>il</strong> nome <strong>del</strong> genere, rimanda ad Ach<strong>il</strong>le, l’eroe greco che secondo la leggenda, ne scoprì le<br />
proprietà medicinali, m<strong>il</strong>lefoglie invece, <strong>per</strong> le sue foglie frastagliate.<br />
Morfologia:<br />
pianta erbacea, <strong>per</strong>enne, aromatica, con rizoma ramificato e strisciante, fusto eretto, striato e pubescente.<br />
Le foglie sono alterne, bi-tripennate, divise in strette lacinie, pelose durante la crescita, poi glabre.<br />
I fiori riuniti in corimbi, sono dotati di involucri ovali verde-gialli, <strong>il</strong> ricettacolo conico, porta 2 tipi di fiori: al<br />
centro i fiori <strong>del</strong> disco, tubulosi bianchi o gialli con 5 petali e sono ermafroditi; alla <strong>per</strong>iferia sono disposti 5<br />
fiori-femmina ligulati e simmetrici, bianchi o rosa.<br />
I frutti sono acheni compressi, senza pappo.<br />
Distribuzione – habitat – fioritura:<br />
presente in tutto <strong>il</strong> continente Europeo, anche in Siberia e sull’Himalaya, in Italia è comune. Pianta che non<br />
soffre la siccità e neppure <strong>il</strong> freddo, teme <strong>per</strong>ò i ristagni idrici e l'eccesso di umidità, talora ha carattere<br />
infestante. Pred<strong>il</strong>ige i terreni arg<strong>il</strong>losi e poveri di potassio, vegeta nei prati aridi, nei pascoli, negli incolti, al<br />
margini dei sentieri e <strong>del</strong>le strade, fiorisce da maggio a ottobre sino a 2.000 m.<br />
Proprietà ed usi:<br />
possiede proprietà vulnerarie, stimolanti, astringenti, sudorifere, digestive, antipiretiche, cicatrizzanti e<br />
emostatiche.<br />
Per uso esterno in caso di ferite, epistassi, ulcere, occhi arrossati e emorroidi.<br />
Attenzione l’uso prolungato può provocare fenomeni di fotosensib<strong>il</strong>izzazione <strong>del</strong>la pelle.<br />
L’infuso, usato <strong>per</strong> sciacquare i capelli, pare sia un ottimo rimedio contro la forfora, e favorirebbe anche la<br />
crescita.<br />
In Svezia si usava <strong>il</strong> m<strong>il</strong>lefoglio <strong>per</strong> preparare una birra piuttosto forte, ma serve anche <strong>per</strong> preparare infusi<br />
digestivi.
Abut<strong>il</strong>on theophrasti Medicus<br />
CENCIO MOLLE<br />
( Abut<strong>il</strong>on avicennae Gaertner- Abut<strong>il</strong>on pubescens Moench-Abut<strong>il</strong>on M<strong>il</strong>ler)<br />
Forma biologica :T scap (Terofite scapose. Piante annue con asse fiorale allungato, spesso privo di foglie.)<br />
Descrizione : pianta annuale con fusto alto da 30- 150 cm , tomentoso e con cime addensate.<br />
Foglie lunghe fino a 15-20 cm., cordato-orbicolari, acuminate, molliccie a margine leggermente dentato. .<br />
Fiori ascellari solitari o appaiati di ca. 2 cm. di grandezza con peduncolo e petali liberi di ca. 1 cm.di<br />
grandezza, di un color giallo intenso con belle venature evidenti sull’arancio.<br />
I sepali ovali saldati alla base, mucronati ,pubescenti, ma senza epicalice .<br />
Frutto: mericarpi pubescenti e deiscenti, a forma di reni disposti a raggiera in una sorta di capsula.<br />
Antesi: Giugno- Settembre<br />
Tipo corologico : S. Siber- Pontica Originaria Sud-Sibirica<br />
Distribuzione in Italia : Piemonte, Lombardia ,Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Em<strong>il</strong>ia Romagna,<br />
Toscana, Lazio, Campania e Sic<strong>il</strong>ia. .<br />
Specie considerata infestante <strong>del</strong>le culture a ciclo primaver<strong>il</strong>e- estivo Questa specie deve la sua espansione<br />
all‘enorme quantità di semi prodotti ed alla capacità di questi di propagarsi tramite i mezzi meccanici, quali<br />
mietitrebbie,usati <strong>per</strong> la raccolta nei coltivi.<br />
Habitat :terreni umidi ed incolti, orti e campi coltivati .<br />
Proprietà: Ha proprietà emollienti ed antifiammatorie<br />
E’ conosciuta anche come Altea indiana, poichè contiene alcuni principi attivi <strong>del</strong>l’Altea officinalis, come la<br />
muc<strong>il</strong>lagine e l’asparagina, che ha potere diuretico ed antisettico.Vengono usate le radici. le foglie ed <strong>il</strong> fusto<br />
<strong>per</strong> l’alto contenuto di muc<strong>il</strong>lagine, <strong>per</strong> lenire le mucose <strong>del</strong> sistema respiratorio ed urinario.e produce effetti<br />
calmanti anche su ferite ed ulcere.<br />
I semi hanno potere lassativo e sono molto ut<strong>il</strong>i <strong>per</strong> eliminare gli ossiuri dall’intestino dei bambini.
Agrimonia eupatoria L.<br />
AGRIMONIA<br />
Famiglia: Rosaceae<br />
Sinonimi: Agrimonia odorata Gouan. M<strong>il</strong>l., Agrimonia officinarum Pit. Tourn.T., Aagrimonia officinalis<br />
Lamk., Agrimonia p<strong>il</strong>osa Ledeb., Agrimonia viscidula Bunge .<br />
Nomi volgari: agrimonia, eupatoria, eupatorio dei greci, erba di S. Guglielmo, erba <strong>del</strong> taglio, erba<br />
vettonica.<br />
Morfologia:<br />
pianta <strong>per</strong>enne, di aspetto erbaceo, munita di breve rizoma, ha fusto eretto, pubescente, semplice o poco<br />
ramificato, può raggiungere <strong>il</strong> metro d’altezza anche se generalmente non su<strong>per</strong>a i 60 cm.<br />
Nel primo anno di vita, questa pianta produce solamente una rosetta basale, successivamente con<br />
l’apparire <strong>del</strong> fusto, solo nella parte inferiore <strong>del</strong>lo stesso, compaiono le foglie cauline. Queste foglie alla<br />
base sono munite di due stipole avvolgenti <strong>il</strong> fusto, sono picciolate, imparipennate, di forma ovale, con<br />
margine dentato, di colore verde scuro nella pagina su<strong>per</strong>iore e grigio-biancastre in quella inferiore <strong>per</strong> la<br />
presenza di peli.<br />
Il fusto termina in un lungo racemo spiriforme, i fiori peduncolati, hanno corolla giallo-uovo formata da 5<br />
petali,obovato-ellittici. La base <strong>del</strong> fiore, legnosa e scanalata, porta una piccola corona di peli uncinati e duri<br />
che servono <strong>per</strong> fac<strong>il</strong>itare la dis<strong>per</strong>sione <strong>del</strong> frutto.<br />
I frutti sono acheni, racchiusi nel calice che, essendo uncinato, favorisce la disseminazione <strong>per</strong>ché si attacca<br />
al pelo degli animali che in questo modo lo trasportano.<br />
Distribuzione – habitat – fioritura:<br />
pianta diffusa in gran parte <strong>del</strong>le regioni <strong>del</strong> mondo, in Italia è specie comune in tutto <strong>il</strong> territorio, nei<br />
pascoli, nei prati, nei luoghi incolti, nelle siepi, ai margini dei prati soleggiati; pred<strong>il</strong>ige i terreni ben drenati<br />
in posizione soleggiata. Fiorisce da giugno a luglio sino a 1.200 m.<br />
Proprietà ed usi:<br />
erba amara, ricca di tannino, di resine e soprattutto di acido salic<strong>il</strong>ico, leggermente astringente, tonica,<br />
diuretica, antinfiammatoria, antiemorragica; migliora le funzioni epatiche e <strong>del</strong>la b<strong>il</strong>e.<br />
Per <strong>il</strong> contenuto di acido ursolico, che ha applicazioni analoghe a quelle <strong>del</strong> cortisone, è ut<strong>il</strong>e nella cura <strong>del</strong>le<br />
allergie.<br />
Nell’Europa <strong>del</strong> nord l’infuso, che ha un sapore gradevole, viene usato come un comune tè stimolante.
Ajuga reptans<br />
Sinonimi<br />
Ajuga barrelieri Ten. (1839)<br />
Ajuga breviproles Borbás (1899)<br />
Ajuga nantii Boreau (1863)<br />
Ajuga stolonifera Jeanb. & Timb.-Lagr. (1879)<br />
Tassonomia<br />
Regno: Plantae<br />
Divisione: Magnoliophyta<br />
Classe: Magnoliopsida<br />
Ordine: Lamiales<br />
Famiglia: Lamiaceae<br />
Nome italiano<br />
Bugola o Bugula, Iva comune, Erba di S.Lorenzo<br />
BUGOLA<br />
Descrizione<br />
A. reptans è una pianta erbacea <strong>per</strong>enne, stolonifera, alta fino a circa 20 cm.<br />
La radice è fascicolata; fusti a sezione tetragonale glabrescenti o pubescenti su coppie di facce opposte<br />
alternantisi ad ogni internodo, quelli fioriferi eretti, arrossati e con tomento lanoso (sempre su facce<br />
opposte) nella porzione apicale (e <strong>qui</strong>ndi anche sul rachide <strong>del</strong>l'infiorescenza); stoloni basali epigei e<br />
striscianti, lunghi fino a 30 (40) cm, foliosi e radicanti ai nodi.<br />
Foglie<br />
Foglie basali in rosette dense, <strong>per</strong>sistenti alla fioritura, con picciolo lungo come la lamina (questa 2-4 x 8-15<br />
cm), che è ovato-spatolata con margine da subintero a crenato.<br />
Foglie cauline più piccole (larghe 1,5-3 cm e lunghe 3-5 cm), opposte e sess<strong>il</strong>i, o subsess<strong>il</strong>i, a lamina ovata<br />
con margine subintero o crenato, di colore verde chiaro e lucide.<br />
Brattee fiorali (foglie cauline modificate) progressivamente più piccole dal basso verso l'alto, a maturità di<br />
colore purpureo-violaceo.
Fiori<br />
Infiorescenza a spicastro denso, lunga 10-15 cm, con i fiori disposti in pseudo-vertic<strong>il</strong>li all'ascella <strong>del</strong>le<br />
brattee. Brattee più brevi dei fiori, che così risultano ben visib<strong>il</strong>i.<br />
Fiori ermafroditi, con forma tipica <strong>del</strong>la famiglia.<br />
Calice sub-attinomofo, a sepali saldati in un tubo lungo 4-6 mm, peloso, con 5 denti calicini di pari<br />
lunghezza, o poco più lunghi.<br />
Corolla zigomorfa, gamopetala, con tubo corollino pubescente, lungo 9-10 mm, di colore variab<strong>il</strong>e<br />
dall'azzurro-violetto al bianco (comprese le tonalità intermedie).<br />
Labbro su<strong>per</strong>iore nullo, labbro inferiore lungo 6 mm, tr<strong>il</strong>obo (lobo centrale maggiore dei laterali). Lobi con<br />
venature bianche e nervature longitudinali più scure (o completamente bianchi negli esemplari<br />
apocromici).<br />
Stami 4, con antere giallastre, completamente emergenti dalla fauce.<br />
Ovario semiinfero, stigma bifido lungo e sporgente, che in mancanza <strong>del</strong> labbro su<strong>per</strong>iore viene protetto<br />
dalla pioggia dalle brattee <strong>del</strong> vertic<strong>il</strong>lo soprastante.<br />
Impollinazione entomof<strong>il</strong>a (farfalle e api).<br />
Frutti<br />
Il frutto è uno schizocarpo (tetrachenio reticolato) formato da 4 nucule con su<strong>per</strong>ficie rugosa.<br />
Periodo di fioritura<br />
Fioritura precoce (Gennaio-Marzo) in Sic<strong>il</strong>ia, più tardiva (Apr<strong>il</strong>e-Luglio) nel Nord e sulle Alpi.<br />
Territorio di crescita<br />
Specie spontanea <strong>del</strong> Continente Europeo (fino al Caucaso e ad eccezione di Scandinavia e fascia a clima più<br />
tipicamente mediterraneo), Medio Oriente e Africa settentrionale; in Italia è comune su tutto <strong>il</strong> territorio,<br />
ad eccezione <strong>del</strong>la Sardegna, meno frequente al Sud.<br />
Habitat<br />
Prati fert<strong>il</strong>i e concimati, lungo le siepi e margini dei sentieri, boschi di latifoglie, dal livello <strong>del</strong> mare fino a<br />
circa 1500 m di quota.<br />
Uso Alimentare<br />
I germogli e le foglie possono venire mangiati in insalata.<br />
Uso Cosmetologico<br />
Estratti <strong>del</strong>la pianta sono largamente ut<strong>il</strong>izzati in prodotti contro la caduta dei capelli e <strong>per</strong> la protezione e<br />
riparazione <strong>del</strong> cuoio capelluto. Un infuso <strong>del</strong>la pianta, ricca di tannini, è ut<strong>il</strong>e alle pelli <strong>del</strong>icate fac<strong>il</strong>mente<br />
arrossab<strong>il</strong>i e predisposte alla cou<strong>per</strong>ose.<br />
Uso Farmacologico<br />
La ricerca in campo farmacologico ha evidenziato che estratti <strong>del</strong>la pianta sono in grado di esercitare<br />
attività antiossidante ed anti radicali liberi. Possono venire utlizzati <strong>per</strong> uno svariato numero di patologie<br />
allergiche, sia sistemiche che cutanee e l'attività che esplicano è in grado di proteggere l'organismo dai<br />
danni causati dall'accumulo di metalli pesanti, come <strong>per</strong> esempio l'emosiderosi polmonare: una malattia<br />
caratterizzata da un accumulo di ferro nei polmoni.
Alliaria petiolata<br />
ALLARIA<br />
Sinonimi<br />
Alliaria officinalis Andrz., Arabis alliaria (L) Bernh., Erysimum alliaria L., Sisymbrium alliaria Scop.<br />
Tassonomia<br />
Regno:Plantae<br />
Divisione: Magnoliophyta<br />
Classe: Magnoliopsida<br />
Ordine: Capparales<br />
Famiglia: Brassicaceae (Cruciferae)<br />
Nomi italiano<br />
Alliaria, Alliaria comune, Lunaria selvatica.<br />
Descrizione<br />
Pianta erbacea alta fino a cm. 80-100, bienne, glabra con qualche pelo ai bordi <strong>del</strong>le foglie e nella parte<br />
alta; <strong>il</strong> fusto, generalmente semplice, ramoso solo nella parte più alta, è pubescente-v<strong>il</strong>loso soprattutto alla<br />
base; tutta la pianta, se stropicciata, emana un marcato odore di aglio; anche <strong>il</strong> sapore è agliaceo.<br />
Foglie<br />
Le foglie sono molto rugose ed intere: quelle su<strong>per</strong>iori sono più o meno romboidali, mentre le inferiori,<br />
provviste di lungo peduncolo, hanno una forma cordato-reniforme e sono sommariamente crenate; al<br />
momento <strong>del</strong>la fioritura le foglie inferiori cadono.<br />
Fiori<br />
I fiori sono riuniti in racemi corimbosi e presentano 4 petali bianchi, di lunghezza inferiore ad 8 mm.; i sepali<br />
sono verdastri ed in numero di 4, mentre gli stami, piuttosto corti, sono 6.<br />
Molto profumati, attirano api e farfalle che provvedono all'impollinazione.<br />
Frutti<br />
Si tratta di s<strong>il</strong>ique tetragonali eretto-patenti di cira 5-6 cm con piccoli semi grigi.
Periodo di fioritura<br />
Fiorisce da Apr<strong>il</strong>e a Luglio, a seconda <strong>del</strong>la quota.<br />
Habitat<br />
Comune in tutto <strong>il</strong> territorio italiano e assente in Sardegna; in Sic<strong>il</strong>ia e lungo le coste è meno frequente; in<br />
altitudine si può trovare fino ai 1600-1700 metri <strong>del</strong>la zona subalpina; pred<strong>il</strong>ige luoghi freschi. In alcune<br />
zone tende ad essere infestante.<br />
Somiglianze e varietà<br />
Non presenta grandi problemi di confusione con altre specie.<br />
Specie protetta<br />
Non risultano segnalazioni di norme a carattere generale, regionale, locale, che proteggano questa pianta.<br />
Costituenti chimici<br />
Mirosina, glucosidi solforati, cartenoidi, olio essenziale, vitamina C e petcina.<br />
Uso Alimentare<br />
Le foglie ed i fiori, di sapore molto sim<strong>il</strong>e all'aglio, ma più digerib<strong>il</strong>i di questo, vengono ut<strong>il</strong>izzati nei misti di<br />
insalate e cicorie, e con varie carni, ottimi anche in pa<strong>del</strong>la e nelle farciture di arrosti.<br />
I semi contengono un olio che viene ut<strong>il</strong>izzato <strong>per</strong> dare sapore a vari piatti, come quello di senape.<br />
Uso Cosmetologico<br />
Non conosciuto e non r<strong>il</strong>evato.<br />
Uso Farmacologico<br />
I semi di Alliaria petiolata possiedono proprietà stimolanti <strong>del</strong>l’appetito; viene anche ut<strong>il</strong>izzata quale<br />
espettorante, antiscorbuto, revulsivo, cicatrizzante, diuretica, vermifuga.<br />
Medicina alternativa e Curiosità<br />
Per non <strong>per</strong>dere i preziosi principi terapeutici si consiglia di ut<strong>il</strong>izzare solo la pianta fresca, non essiccata.<br />
Contiene diversi principi ut<strong>il</strong>i in fitoterapia quali oli, enzimi, glocosidi ecc.<br />
Il succo <strong>per</strong> uso esterno o la decozione serve nei casi di piaghe di diffic<strong>il</strong>e guarigione, ferite infette, ragadi e<br />
geloni ulcerati.<br />
Viene ut<strong>il</strong>izzata anche <strong>per</strong> produrre coloranti
Allium neapolitanum<br />
Sinonimi<br />
Allium candidissimus Cav.<br />
Allium album Santi<br />
Tassonomia<br />
Regno:Plantae<br />
Divisione:Magnoliophyta<br />
Classe:L<strong>il</strong>iopsida<br />
Ordine:L<strong>il</strong>iales<br />
Famiglia:L<strong>il</strong>iaceae<br />
Nomi italiano<br />
Aglio bianco,aglio napolitano.<br />
AGLIO BIANCO<br />
Descrizione<br />
Pianta erbacea <strong>per</strong>enne, bulbosa, alta fino a 50cm. Il bulbo è formato da molti bulb<strong>il</strong>li.<br />
Foglie<br />
Le foglie piatte e lineari, partono dal bulbo centrale e possono raggiungere i 40 cm di altezza.<br />
Fiori<br />
I fiori hanno uno stelo, senza foglia, alto fino a 50cm, sono portati in ombrella terminale, tale infiorescenza<br />
prima di sbocciare è racchiusa in una guaina membranacea. Le ombrelle possono essere costituite da un<br />
numero variab<strong>il</strong>e di corolle che possono raggiungere anche <strong>il</strong> numero di 40 unità. Sono di colore bianco<br />
candido, profumate, al loro interno spiccano le antere di colore quasi nero.<br />
Frutti<br />
I frutti sono capsule che crescono quando si seccano i tepali.
Periodo di fioritura<br />
Fiorisce da Apr<strong>il</strong>e a Giugno.<br />
Territorio di crescita<br />
Cresce in tutto <strong>il</strong> territorio italiano, fino ad 800m, ad esclusione <strong>del</strong>la Val d'Aosta e Piemonte.<br />
Habitat<br />
Luoghi erbosi litoranei e collinari, prati, cigli stradali e bordi boschivi.<br />
Somiglianze e varietà<br />
Allium ursinum.<br />
Specie protetta<br />
Non si riscontrano note di protezione <strong>del</strong>la specie, se non <strong>per</strong> l'Allium narcissiflorum V<strong>il</strong>l. (Aglio<br />
piemontese).<br />
Costituenti chimici<br />
Tutte le specie <strong>del</strong> genere allium contengono vitamina A, B1, B2, C, PP. Molti sali minerali:potassio,<br />
magnesio, calcio, ferro, manganese, selenio e pectina. Un antibiotico di nome Allicina.<br />
Uso Alimentare<br />
Tutti gli allium selvatici sono commestib<strong>il</strong>i. Gli steli, le foglie e i bulbi, si possono usare sia <strong>per</strong> insalate, sia<br />
<strong>per</strong> minestre o insaporire carni e frittate. I bulbi raccolti in estate e fatti seccare si conservano come l'aglio<br />
coltivato. Mettendo a macerare i bulbi nell'olio se ne ottiene un infuso aromatico <strong>per</strong> condire.<br />
Uso Farmacologico<br />
Avendo proprietà:antisettiche, colagoghe, coleretiche, espettoranti, ipotensive, stimolanti, toniche,<br />
vermifughe, viene usato come diuretico e depurativo <strong>del</strong> sangue. Fresco è un ottimo antireumatico, lenitivo<br />
e antibatterico. E' controindicato nelle gastriti e in chi soffre di pressione bassa,malati di fegato e mamme<br />
che allattano.<br />
Medicina alternativa e Curiosità<br />
Si usano le foglie e i bulbi pestati <strong>per</strong> disinfettare ferite. Cotto nel latte e poi fatto bere ai bambini,è un<br />
ottimo vermifugo intestinale. Nei fiori di Bach l'essenza floreale <strong>del</strong>l’aglio elimina le paure e le tensioni,<br />
porta forza e resistenza, mentre l'essenza di aglio possiede virtù stimolanti. Alcune molecole contenute<br />
nell'aglio, legandosi a mercurio e piombo, hanno <strong>il</strong> potere di espellerlo dal corpo umano.
Allium ursinum<br />
Aglio orsino, Aglio selvatico, Aglio dei boschi<br />
AGLIO ORSINO<br />
Forma biologica :G. bulb. Geofite bulbose. Piante <strong>il</strong> cui organo <strong>per</strong>ennante è un bulbo da cui, ogni anno,<br />
nascono fiori e foglie<br />
Descrizione: pianta <strong>per</strong>enne alta 20-40 cm provvista di un bulbo sott<strong>il</strong>e oblungo attorniato da tuniche<br />
intere biancastre membranose e scapo semic<strong>il</strong>indrico angoloso.<br />
Foglie generalmente 2 basali, ovali-lanceolate, lunghe 10-20 cm. e larghe 3-6, munite di un lungo picciolo<br />
alato, lungo 5-15 cm. di un colore verde br<strong>il</strong>lante, emananti un forte odore agliaceo<br />
Le infiorescenze, alla sommità <strong>del</strong>lo scapo, si riuniscono ad ombrella di 6-20 fiori , di forma subsferica<br />
irregolare di 3-6 cm. di diametro. Sono racchiuse prima <strong>del</strong>la fioritura da una spata cartacea intera o divisa<br />
in 2-3 lobi, caduca, che non su<strong>per</strong>a la grandezza <strong>del</strong>l’ombrella.<br />
I fiori sono formati da 6 tepali bianchi lanceolati lunghi ca. 1 cm., più lunghi degli stami e con un peduncolo<br />
lungo sino a 2 cm.<br />
Frutti capsule che si aprono longitudinalmente lasciando fuoriuscire i semi.<br />
Antesi: apr<strong>il</strong>e- giugno<br />
Tipo corologico: Eurasiatico- Tem<strong>per</strong>.<br />
Distribuzione in Italia : comune in tutto <strong>il</strong> territorio, esclusa la Sardegna, anche se nella pianura padana è<br />
ora raro o scomparso, in Sic<strong>il</strong>ia e Corsica si trova soprattutto sui r<strong>il</strong>ievi.<br />
Habitat: Si diffonde soprattutto nei boschi di latifoglie, luoghi ombrosi ed umidi, e particolarmente nelle<br />
vallecole umide in colonie numerose su terreni fert<strong>il</strong>i e ricchi.di humus, dal piano fino alla fascia<br />
submontana 1500 mt.<br />
Proprietà: Le proprietà <strong>del</strong>l’aglio orsino sono praticamente le medesime <strong>del</strong>l’aglio comune= A. sativum e<br />
gode fama principalmente quale antielmintico, ma è anche un buon diuretico, stimolante gastrico,<br />
antisettico, coleretico (ossia agisce sulle b<strong>il</strong>e) ed è un efficace depurativo disintossicante <strong>del</strong> sangue. Le
foglie fresche sulla pelle hanno proprietà rubefacenti ed usate pestate quale cataplasma leniscono gli<br />
ascessi ed i foruncoli.<br />
Ut<strong>il</strong>izzi in cucina: In campo culinario, nel <strong>per</strong>iodo primaver<strong>il</strong>e, sono raccomandate le foglie tenere,finemente<br />
tritate, <strong>per</strong> insaporire le insalate o aromatizzare <strong>il</strong> burro dando un sapore <strong>del</strong>icato e gradevole alle carni e<br />
non così deciso rispetto agli altri agli. Sono inoltre ut<strong>il</strong>izzate <strong>per</strong> insaporire patate, cicorie, uova, zuppe, brodi<br />
avendo cura di aggiungerle all’ultimo momento <strong>per</strong> apprezzare appieno <strong>il</strong> loro aroma.<br />
In cucina <strong>il</strong> bulbo può essere sostituto all’A. sativum.<br />
In Slovenia viene prodotto un'olio a base di foglie di aglio orsino da usare quale condimento su patate lesse,<br />
pane tostato, pasta e particolarmente consigliato <strong>per</strong> insaporire piatti di pesce, quali sgombro o merluzzo.<br />
Il preparato richiama in un certo senso <strong>il</strong> pesto alla genovese ed è composto da ca. <strong>il</strong> 40% di foglie di alglio<br />
orsino tagliate finemente, una manciata di mandorle tritate, sale e pepe quanto necessita, <strong>il</strong> tutto<br />
completato e ben rico<strong>per</strong>to da olio extra vergine di oliva.<br />
Quest'ultimo prezioso suggerimento ci è <strong>per</strong>venuto dal nostro carissimo socio ed amico Orionmax, che<br />
ringraziamo <strong>per</strong> la sua cortese collaborazione.<br />
Avvertenze e Curiosità: Le foglie <strong>del</strong>l’A. ursinum si possono scambiare con quelle <strong>del</strong>la Convallaria majalis<br />
L.= mughetto (pianta tossica), quando le piante non sono ancora in fiore, ma si riconoscono bene<br />
stropicciandole <strong>per</strong> <strong>il</strong> forte odore agliaceo.<br />
L’Allium ursinum e l’Allium victorialis( che è più raro e si trova in zone montane più elevate) sono gli unici<br />
agli ad avere foglie grandi lanceolate,a differenza degli altri che hanno foglie lunghe e strette
Sinonimi<br />
Ranunculus sylvarum Clus.<br />
Anemanthus morosus (L.) Fourr.<br />
Anemonanthea nemorosa (L.) S.F. Gray<br />
Anemone pentaphylla Hooker f<strong>il</strong>. ex Pritzel<br />
Anemone <strong>qui</strong>nquefolia L.<br />
Anemone nemorosa L.<br />
Tassonomia<br />
Regno: Plantae<br />
Divisione: Magnoliophyta<br />
Classe: Magnoliopsida<br />
Ordine: Ranunculales<br />
Famiglia: Ranunculaceae<br />
Nome italiano<br />
Anemone dei boschi, Anemone bianca, S<strong>il</strong>via<br />
ANEMONE DEI BOSCHI<br />
Descrizione<br />
Anemonoides nemorosa (L.) Holub è una pianta erbacea <strong>per</strong>enne, alta fino a 30 cm, con rizoma orizzontale<br />
di colore brunastro e dotato di squamosità effimera scura, dal quale, ogni anno, si originano numerose<br />
nuove radichette, che si immergono profondamente nel terreno, e nuovi fusti fiorali glabri, eretti e<br />
monocefali.<br />
Nelle ore serali o quando piove, A. nemorosa reclina i fiori, e li richiude parzialmente in modo da<br />
proteggere le parti fert<strong>il</strong>i.<br />
Foglie<br />
Foglie radicali decidue, assenti all'antesi, con picciolo eretto e lamina palmatosetta o bipalmatosetta, divisa<br />
in 3-5 lobi lanceolati irregolari, a loro volta più o meno profondamente divisi.<br />
Foglie cauline picciolate, con lamina come sopra, raggruppate in un vertic<strong>il</strong>lo di 3 situato all’altezza di circa i<br />
4/5 <strong>del</strong> fusto, con indumento sericeo.
Fiori<br />
Fiore ermafrodito singolo su un peduncolo di 2-3 cm lievemente peloso. I (5) 6 (12) sepali petaloidei sono<br />
ellittici e bianchi (più di rado bianco-rosei o bianco-celestini), spesso con striature roseo-violette nella faccia<br />
inferiore, lunghi da (10) 12-15 a 20-22 mm. Stami numerosissimi con antere gialle. Gineceo formato da<br />
numerosi carpelli liberi. Impollinazione entomof<strong>il</strong>a.<br />
Frutti<br />
Infruttescenza (poliachenio) globosa composta da tanti piccoli acheni ovoidali rico<strong>per</strong>ti da fitta pelosità<br />
sericea, ciascuno derivante dalla fecondazione e maturazione di un singolo carpello, <strong>il</strong> cui st<strong>il</strong>o <strong>per</strong>sistente<br />
va a formare un piccolo rostro apicale.<br />
Periodo di fioritura<br />
(Gennaio) febbraio - maggio. La fioritura inizia precocemente sui suoli appena abbandonati dalla neve.<br />
Territorio di crescita<br />
Specie spontanea <strong>del</strong> Continente Europeo, Medio Oriente e America Settentrionale. Presente, allo stato<br />
spontaneo, in tutta Italia - isole escluse - dal piano basale a quello montano, con frequenza decrescente da<br />
Nord a Sud, dove la sua presenza è limitata alla zona montana ed è dubbia <strong>per</strong> la Calabria.<br />
Habitat<br />
Pred<strong>il</strong>ige sottoboschi chiari di latifoglie (soprattutto querce e faggi) e radure ombrose, con terreni ricchi di<br />
humus e freschi, neutri o calcarei, dal livello <strong>del</strong> mare fin oltre i 1600 m di quota.<br />
Uso Alimentare<br />
La pianta non è commestib<strong>il</strong>e.<br />
Uso Cosmetologico<br />
Nessun uso cosmetico è conosciuto: tutte le parti <strong>del</strong>la pianta fresca contengono protoanemonina, una<br />
sostanza che può provocare serie irritazioni topiche.<br />
Uso Farmacologico<br />
Non esiste un uso farmacologico moderno di questa specie che, al momento attuale, è trascurata anche<br />
dalla ricerca in campo fitochimico e farmacologico.
Bellis <strong>per</strong>ennis<br />
Sinonimi<br />
Bellis hybrida Ten.<br />
Tassonomia<br />
Regno:Plantae<br />
Divisione:Magnoliophyta<br />
Classe:Magnoliopsida<br />
Ordine:Asterales<br />
Famiglia:Asteraceae<br />
Nome italiano<br />
Pratolina, margheritina, bellide dei prati.<br />
PRATOLINA<br />
Descrizione<br />
Piccola pianta erbacea, <strong>per</strong>enne, pubescente in ogni sua parte (ad eccezione dei singoli fiori), non più alta di<br />
12-15 cm e con robusta radice fittonante.<br />
Foglie<br />
Le foglie, disposte di solito in rosetta basale aderente al suolo, sono di colore verde, talora glaucescenti,<br />
con picciolo alato, a lamina spatolata e margine crenato, con ben visib<strong>il</strong>e la sola nervatura mediana.<br />
Fiori<br />
In capolini solitari raggiati, con diametro mediamente di 2 cm (carattere abbastanza costante) o<br />
leggermente maggiore, presenti quasi tutto l'anno, su scapi semplici, af<strong>il</strong>li, o portanti al più qualche foglia<br />
nella porzione basale fino ad un paio di cm d'altezza; le brattee involucrali, ovali ad apice arrotondato o ±<br />
acuto, sono disposte su due ranghi e sono pelose su tutta la lamina; su un ricettacolo conico insiste un disco<br />
di fiori ermafroditi tubulosi e attinomorfi, gialli, contornato da fiori ligulati (i cosiddetti "fiori <strong>del</strong> raggio")<br />
con ligule bianche ± sfumate di rosso-violetto all'apice. Il capolino si comporta come un unico fiore: di notte<br />
e quando <strong>il</strong> cielo è nuvoloso, oppure c'è molta umidità, si inclina e si richiude, mentre di giorno segue <strong>il</strong><br />
corso <strong>del</strong> sole, orientandosi verso di esso.
Frutti<br />
Frutto secco indeiscente (achenio) di forma ovale e contenente un seme privo di endos<strong>per</strong>ma, sprovvisto di<br />
pappo; la sua su<strong>per</strong>ficie può essere pubescente; la dis<strong>per</strong>sione avviene dopo la caduta, a contatto col<br />
terreno, <strong>per</strong> mezzo di formiche e altri insetti terricoli.<br />
Periodo di fioritura<br />
La fioritura avviene praticamente durante tutto l'anno nelle zone più fresche (montagna), con riposo<br />
vegetativo estivo altrove.<br />
Territorio di crescita<br />
Cresce su tutto <strong>il</strong> territorio italiano.<br />
Habitat<br />
Cresce nei prati umidi, negli incolti e nei giardini, dal piano fino a 2000 metri di quota.<br />
Costituenti chimici<br />
Acido ascorbico, malico, fumarico, tartarico, caffeico, acetico e ossalico, resine, olio essenziale, oli grassi,<br />
zuccheri, tannini, un principio amaro, inulina, muc<strong>il</strong>lagini, poliine, una saponina, triterpeni.<br />
Uso Alimentare<br />
Possono essere ut<strong>il</strong>izzate le foglie raccolte prima <strong>del</strong>la fioritura, in insalata o <strong>per</strong> le zuppe; i capolini possono<br />
essere preparati sott'aceto.<br />
Uso Cosmetologico<br />
In cosmesi si ut<strong>il</strong>izza <strong>per</strong> schiarire la pelle, detergere zone macerate dal sudore, decongestionare <strong>il</strong> viso<br />
attorno agli occhi.<br />
Uso Farmacologico<br />
La ricerca in campo fitofarmacologico sulla B. <strong>per</strong>ennis ha confermato che la pianta è moderatamente attiva<br />
come astringente, <strong>per</strong> ridurre la produzione di muco e <strong>per</strong> l'azione antinfiammatoria. Sono in corso studi<br />
<strong>per</strong> accertare l'efficacia <strong>del</strong>la saponina estratta dai fiori nell'inibire l'innalzamento <strong>del</strong> livello dei trigliceridi<br />
nell'organismo.
Bryonia dioica<br />
VITE BIANCA<br />
Sinonimi : Bryonia cretica L. subs dioica (Jacq.) Tutin<br />
Famiglia : Cucurbitaceae<br />
Nome volgare : Vite bianca; Zucca selvatica<br />
Etimologia: Il nome <strong>del</strong> genere deriva dal greco Bryo = crescere con vigore, con allusione alla potenza <strong>del</strong>le<br />
sue radici e allo sv<strong>il</strong>uppo rigoglioso <strong>del</strong>la pianta.<br />
Morfologia:<br />
Pianta erbacea <strong>per</strong>enne, rampicante, pelosa e ruvida, con grossa radice a fittone lunga circa 15 cm, che con<br />
la parte <strong>del</strong> fusto sotterranea forma una ceppaia carnosa, con scorza di colore giallastro che a primavera<br />
emette le gemme che daranno vita ai nuovi, fusti, frag<strong>il</strong>i con lunghi viticci arrotolati a spirale, lunghi 2-4 m.<br />
Le foglie alterne, dotate di un robusto picciolo, di colore verde opaco. sono palmato-lobate lunghe fino a 10<br />
cm , apice spesso ottuso e base cuoriforme, con 3-5 lobi e la su<strong>per</strong>ficie è cosparsa di peli irti che le rendono<br />
ruvida al tatto, sono palminervie, senza stipole, dotate di robusti cirri che <strong>per</strong>mettono alla pianta di<br />
aggrapparsi a qualsiasi sostegno. I fiori hanno calice a tubo diviso in 5 lobi, mentre la corolla a forma di<br />
campana, di colore giallo pallido striata di verde, ha anch’essa 5 lobi ovali-lanceolati. I fiori masch<strong>il</strong>i sono<br />
lunghi fino a 2 cm e sono circa <strong>il</strong> doppio di quelli femmin<strong>il</strong>i, hanno 5 stami di cui 4 saldati a due a due ed<br />
uno libero, mentre i fiori femmin<strong>il</strong>i hanno tre st<strong>il</strong>i saldati alla base che terminano con 3 stimmi globosi e<br />
pelosi, l’ovario è tr<strong>il</strong>oculare e ciascuna loggia contiene due ovuli. I frutti sono bacche globose, lisce, <strong>del</strong>la<br />
taglia di un chicco di ribes, di colore verde, poi rosso vivo a maturazione.<br />
Distribuzione – Habitat – Fioritura:<br />
Di origine europea zone mediterranee, è comune in ogni regione italiana con esclusione <strong>del</strong>la Sardegna.<br />
Vegeta in ambienti ruderali, boschi a mezz’ombra, siepi, dal mare alla regione sub-montana ( da 0 a 1000<br />
m) e fiorisce da Apr<strong>il</strong>e a Maggio.<br />
Proprietà ed ut<strong>il</strong>izzi:<br />
Pianta velenosa in tutte le sue parti, dalla radice alle bacche, <strong>per</strong> <strong>il</strong> suo contenuto di diverse Cucurbitacine<br />
amare, Bryoside, Triterpene brionolo, Acido crisofanico, Polisaccaridi, è stata in passato usata comunque a<br />
scopi terapeutici, contro le affezioni alle vie respiratorie e le congestioni epato-b<strong>il</strong>iari.
Calystegia sepium<br />
V<strong>il</strong>ucchio bianco, Campanelle bianche<br />
VILUCCHIO BIANCO<br />
Descrizione: Pianta <strong>per</strong>enne, erbacea, con fusti volub<strong>il</strong>i, glabri, lunghi sino a 3 m.<br />
Le foglie picciolate, alterne, ovate o ovato-lanceolate, sagittate, con base cordata ed apice acuto, margine<br />
ondulato, lunghe sino a 10 cm .<br />
I fiori solitari, su lunghi peduncoli, all'ascella <strong>del</strong>le foglie; calice con cinque lobi spesso screziato di rosso,<br />
racchiuso da 2 grandi brattee, ovali, fogliacee. La corolla, campanulata con diametro di 4-6 cm è<br />
leggermente lobata, bianca, raramente appena tendente al rosa.<br />
I frutti sono capsule ovoidali contenenti 2-4 semi tondi e neri.<br />
Antesi: Maggio – Settembre<br />
Tipo corologico: Paleotemp.<br />
Distribuzione in Italia: Pianta comune in tutto <strong>il</strong> territorio.<br />
Habitat: Infestante <strong>del</strong>le colture erbacee, dei cereali, dei vigneti e degli incolti, sulle siepi, nelle radure dei<br />
boschi da 0 a 1.400 m. Pred<strong>il</strong>ige suoli arg<strong>il</strong>losi, umidi e ricchi di elementi nutritivi.<br />
Note di sitematica: Sim<strong>il</strong>e è Ipomea purpurea Roth., con grandi corolle azzurre o porporine, coltivata come<br />
ornamentale; originaria <strong>del</strong>l’America tropicale.<br />
Proprietà e ut<strong>il</strong>izzi: Pianta colagoga, purgante, lenitiva, febbrifuga, diuretica.<br />
L’infuso di foglie risulta ut<strong>il</strong>e <strong>per</strong> favorire le funzioni <strong>del</strong> fegato e nella cura <strong>del</strong>la stitichezza.<br />
Curiosità: I fiori si chiudono quando piove o <strong>il</strong> cielo è co<strong>per</strong>to, ma spesso restano a<strong>per</strong>ti di notte, in questo<br />
modo vengono visitati da falene ed altri insetti notturni. In particolare <strong>il</strong> fiore attrae la Herse convolvuli (L.),<br />
farfalla dalla lunga spirotromba, adatta a succhiare <strong>il</strong> nettare secreto alla base <strong>del</strong> fiore, che così viene<br />
impollinato.
Campanula rapunculus<br />
Tassonomia<br />
Regno:Plantae<br />
Divisione: Magnoliophyta<br />
Classe: Magnoliopsida<br />
Ordine: Campanulales<br />
Famiglia: Campanulaceae<br />
Nome italiano<br />
Raponzolo, campanula commestib<strong>il</strong>e.<br />
RAPONZOLO<br />
Descrizione<br />
Pianta a ciclo biennale, a portamento erbaceo alta fino a oltre 1-1,5 m; con fusto eretto o ascendente,<br />
spigoloso, glabro o poco peloso almeno alla base, poco ramoso oltre la metà apicale, o semplice; radice<br />
fittonante ingrossata, carnosa o lignificata, biancastra.<br />
Foglie<br />
Nel primo anno le foglie, lunghe da 4-6 cm a 12-13 cm, sono tutte disposte ± in rosetta basale aderente al<br />
terreno, a lamina spatolato-oblunga o obovata, picciolate; nel secondo anno sono presenti anche quelle<br />
cauline, lunghe 1,5-8 cm, sess<strong>il</strong>i e strettamente lanceolate o sublineari, diminuenti via via di dimensioni<br />
verso l’apice <strong>del</strong> fusto; margine da sub-intero o ondulato a dentellato; pelosità molto variab<strong>il</strong>e, semplice, o<br />
assente.<br />
Fiori<br />
Infiorescenze racemose lasse e strette, a volte poco ramificate; peduncoli fiorali molto brevi o comunque<br />
generalmente più corti dei fiori, con brattea lineare inserita all’incirca alla loro base; <strong>il</strong> calice, lungo fino a<br />
2/3 <strong>del</strong>la corolla, porta 5 lobi lineari-lesiniformi, da eretto-patenti a patenti in piena antesi, a volte poco<br />
revoluti, glabri; corolla campanulata azzurro-pallida, rosea, o bianca, lunga da 10-12 fino a 20-23 mm,<br />
generalmente glabra e divisa sino ad 1/3 <strong>del</strong>la sua lunghezza in 5 lobi lanceolati, leggermente revoluti, a<br />
volte con breve mucrone apicale; stami 5 con antere bianco-giallastre, ovario infero tr<strong>il</strong>oculare, st<strong>il</strong>o diviso
all’apice in 3 segmenti stigmatici; sia stami che st<strong>il</strong>o sono più brevi <strong>del</strong>la corolla.<br />
Frutti<br />
I frutti sono capsule poricide (pori laterali o nella parte apicale); semi numerosi, bruni e di piccole<br />
dimensioni.<br />
Periodo di fioritura<br />
Fiorisce da marzo a settembre.<br />
Territorio di crescita<br />
Cresce in tutto <strong>il</strong> territorio italiano, ad esclusione <strong>del</strong>le isole.<br />
Habitat<br />
Prati, anche alberati, cigli <strong>del</strong>le strade, fra l'erba, dal livello <strong>del</strong> mare fino a oltre 1500 m di quota.<br />
Uso Alimentare<br />
Il ra<strong>per</strong>onzolo è una apprezzata e ben nota specie commestib<strong>il</strong>e. Le radici possono essere consumate sia<br />
fresche che cotte. Da fresche costituiscono una piacevole aggiunta alle insalate primaver<strong>il</strong>i. Cotte hanno un<br />
sapore dolce, in qualche modo sim<strong>il</strong>e a quello <strong>del</strong>le noci, che le rende molto gustose. Le foglie cotte<br />
costituiscono un apprezzato contorno. I giovani germogli, in primavera, una volta sbollentati possono<br />
essere consumati come asparagi.<br />
Uso Cosmetologico<br />
Non si conoscono usi nella moderna cosmetologia <strong>per</strong> questa specie. Nella medicina popolare si consigliava<br />
di applicare un cataplasma di foglie <strong>per</strong> combattere le verruche.<br />
Uso Farmacologico<br />
L’inulina e la vitamina C presenti nella radice la rendono un efficace diuretico e rinfrescante. In particolare<br />
l’inulina, un oligosaccaride composto da catene di fruttosio, favorisce la digestione, riduce la produzione di<br />
gas intestinali ed ha un effetto lassativo.<br />
Medicina alternativa e Curiosità<br />
Nella moderna fitoterapia non c’è particolare uso di questa specie. Per uso alimentare, tuttavia, i principi<br />
attivi presenti le conferiscono proprietà vulnerarie, antisettiche, astringenti, rinfrescanti e lassative. La<br />
radice, priva di amido, può essere consumata anche dai diabetici. Con le foglie ed i fiori, lasciati in infuso, si<br />
prepara un colluttorio ut<strong>il</strong>e a combattere <strong>il</strong> mal di gola e le infiammazioni <strong>del</strong> cavo orale.
Capsella bursa-pastoris<br />
BORSA DEL PASTORE<br />
Famiglia: Cruciferae<br />
Sinonimi: Thlaspi busa pastoris (L.)<br />
Nomi volgari: borsa <strong>del</strong> pastore, cassella, erba di Giuda, erba ra<strong>per</strong>ina, borsacchina, borsacchia, cassetta,<br />
scarsellina, erba storna.<br />
Etimologia:dal latino capsella = cofanetto, piccola borsa, con riferimento alla forma dei frutti, sim<strong>il</strong>i alle<br />
vecchie bisacce dei pastori.<br />
Morfologia:<br />
Pianta erbacea, annuale o biennale, con fusto eretto,es<strong>il</strong>e, ramificato e co<strong>per</strong>to di corti peli, alta sino a 60<br />
cm, con radice legnosa, a fittone e poco ramificata. Se viene stropicciata emana un forte odore di solforato.<br />
Le foglie hanno forma estremamente variab<strong>il</strong>e, le basali sono lanceolate-lobate, dentate o intere e formano<br />
rosetta; le cauline sono sess<strong>il</strong>i, inguainanti, glabre.<br />
I fiori sono ermafroditi, riuniti in piccoli grappoli terminali, di colore bianco, hanno calice composto da 4<br />
sepali verdi, ovali, a<strong>per</strong>ti. La corolla comprende 4 petali bianchi, opposti, più lunghi dei sepali <strong>del</strong> calice.<br />
Frutti: sono s<strong>il</strong>iquette appiattite, cuoriformi, contenenti semi oblunghi di colore marrone.<br />
Distribuzione – habitat – fioritura:Originaria probab<strong>il</strong>mente, <strong>del</strong>le regioni mediterranee, si è diffusa con le<br />
coltivazioni <strong>del</strong> frumento, divenendo una <strong>del</strong>le infestanti più cosmopolite. In Italia è pianta comune<br />
ovunque,cresce sino a 2.300 m adattandosi ad ogni tipo di clima vegeta negli orti, nelle vigne, nei muri, nei<br />
luoghi coltivati, nelle radure dei boschi; si tratta di piante a più cicli, i semi cadono appena nascono, <strong>per</strong> cui<br />
la si può trovare fiorita tutto l’anno.<br />
Proprietà ed usi:<br />
La borsa <strong>del</strong> pastore ha proprietà emostatiche, astringenti, antiemorragiche, in particolare principi attivi<br />
presenti nella pianta consentono di far contrarre la muscolatura <strong>del</strong>l’utero <strong>per</strong> cui ne frenano le emorragie,<br />
regolarizzando <strong>il</strong> ciclo mestruale. Ut<strong>il</strong>e anche nella cura <strong>del</strong>le epistassi, <strong>del</strong>le diarree, <strong>del</strong>le emorroidi e <strong>del</strong>le<br />
varici. Lo stelo fresco, tritato e macerato <strong>per</strong> 24 ore nell’aceto può essere applicato sulle infezioni cutanee.<br />
Dai semi, in tempo di carestia, si estraeva olio.
Centaurea jacea<br />
Famiglia: Compositae.<br />
Nomi volgari: Erba amara, fiordaliso stoppione.<br />
ERBA AMARA<br />
Morfologia:<br />
pianta <strong>per</strong>enne, erbacea, con la radice principale più sv<strong>il</strong>uppata rispetto alle secondarie, non o poco<br />
ramosa, fusto eretto e co<strong>per</strong>to di tormento biancastro, questo dona alla pianta <strong>il</strong> caratteristico colore<br />
verde-salvia. Alta sino a 100 cm, ma normalmente 30-70 cm.<br />
Foglie vagamente dentate, le inferiori sono picciolate, ovato lanceolate spesso pennatifide, le su<strong>per</strong>iori<br />
intere, lanceolate e sess<strong>il</strong>i.<br />
I fiori viola-porpora, sono capolini solitari, globulosi con i fiori, tutti ligulati, <strong>per</strong>iferici più grandi di quelli<br />
centrali. Involucro a bratte esterne e medie con appendice scariosa piuttosto ampia, bruna, giallastra o<br />
scolorata, intera o più o meno lacera al margine o frangiata.<br />
Il frutto è un achenio bianco.<br />
Distribuzione – habitat – fioritura:<br />
Originaria <strong>del</strong>l’Europa sud orientale, in Italia è pianta molto comune dei cespugli, dei prati dei pendii<br />
soleggiati, fiorisce principalmente da Giugno a Agosto, ma la si può trovare fiorita anche a settembre, dal<br />
piano sino a 1.500 m.<br />
Proprietà ed ut<strong>il</strong>izzi:<br />
I suoi principi attivi sono costituiti da Centaurina, potassio, magnesio e tannini che le conferiscono<br />
proprietà tonificanti, amaricanti, stomachiche e diuretiche e digestive. Viene impiegata anche <strong>per</strong> calmare<br />
l’ardore <strong>del</strong>le febbri infant<strong>il</strong>i e d<strong>il</strong>uita in acqua come collirio <strong>per</strong> le congiuntiviti.
Chelidonium majus<br />
CELIDONIA<br />
Famiglia: Papaveraceae<br />
Nomi volgari: celidonia, erba da porri, erba nocca, erba porraia, chelidonia grande, erba purinea, erba de<br />
caol, cir<strong>il</strong>onia, selidonia, erba de ranas.<br />
Morfologia:<br />
pianta <strong>per</strong>enne, di aspetto erbaceo, cespitoso, ha fusto prostrato o ascendente ramoso e munito di peli<br />
sparsi, alta sino a 70 cm. Tutti gli organi <strong>del</strong>la pianta sono <strong>per</strong>corsi da una rete di canali laticiferi, nei quali<br />
scorre un succo arancione aspro e caustico, che fuoriesce alla minima incisione. Tutta la pianta emana un<br />
odore forte e sgradevole.<br />
Il rizoma è c<strong>il</strong>indrico, ramificato, esternamente è bruno-rosso, giallo all’interno, produce diverse radichette<br />
di color arancio-bruno.<br />
Le foglie, più chiare nella pagina inferiore, sono alterne, imparipennate, con segmenti lobati, dei quali<br />
l’apicale è tr<strong>il</strong>obato; le inferiori sono picciolate, mentre le cauline sono sess<strong>il</strong>i.<br />
I fiori dal lungo peduncolo, formano piccole ombrelle apicali,o solitari all’ascella fogliare, i 2 sepali <strong>del</strong> calice<br />
sono precocemente caduchi, la corolla ha 4 petali ovali di colore giallo oro e molti stami a f<strong>il</strong>amenti rigonfi<br />
appena sotto le antere.<br />
I frutti sono capsule lineari che contengono un gran numero di semi reniformi, br<strong>il</strong>lanti e neri, muniti di<br />
un’escrescenza polposa e gelatinosa, molto apprezzata dalle formiche, che in questo modo provvedono alla<br />
disseminazione.<br />
Distribuzione – habitat – fioritura:<br />
è presente in tutta Europa sino alle regioni subartiche, in Italia è pianta moltocomune nei luoghi ombrosi,<br />
lungo le strade, vicino agli immondezzai e alle macerie, sui vecchi muri e negli incolti; vegeta sino a 1.300 m<br />
e fiorisce da marzo ad ottobre.<br />
Proprietà ed usi:<br />
ATTENZIONE tutte le parti <strong>del</strong>la pianta e specialmente le radici risultano tossiche <strong>per</strong> <strong>il</strong> loro contenuto in<br />
alcaloidi: chelidonina e cheleritrina, quest’ultima fa starnutire e provoca sensazione di soffocamento.<br />
I suoi principi attivi sono affini a quelli <strong>del</strong>l’oppio, <strong>per</strong> cui <strong>il</strong> suo impiego è volto soprattutto a calmare <strong>il</strong><br />
dolore, fa parte infatti <strong>del</strong>la composizione di diversi farmaci spasmolitici, calmanti, batteriostatici; è inoltre
oftalmica, purgante, stomachica e diuretica<br />
È efficace contro taluni tipi di funghi microscopici e certi protozoi parassiti.<br />
Es<strong>per</strong>imenti rivelerebbero una sua azione inibitrice contro le cellule tumorali.<br />
Il latice che se ingerito causa bruciori alla bocca e alla faringe, vomito, paralisi e anche coma, è efficace<br />
invece nel trattamento <strong>del</strong>le verruche, dei calli e duroni.<br />
Fusti e foglie essiccate, nella medicina popolare, venivano consigliati <strong>per</strong> ped<strong>il</strong>uvi atti a riattivare la<br />
circolazione.<br />
Questa pianta, essendo molto tossica, deve essere usata solo sotto stretto controllo medico.<br />
Curiosità:<br />
<strong>per</strong> gli alchimisti <strong>del</strong> medioevo, era un ingrediente indispensab<strong>il</strong>e <strong>per</strong> la fabbricazione <strong>del</strong>la pietra f<strong>il</strong>osofale;<br />
fa parte <strong>del</strong>le “erbe magiche <strong>del</strong>la notte di S. Giovanni”( erbe che vengono colte all’alba <strong>del</strong> 24 giugno), con<br />
le quali si preparano potentissimi f<strong>il</strong>tri, talismani, oli, ma soprattutto i famosi"sali". Ci sono quelli <strong>per</strong><br />
l'amore, <strong>il</strong> lavoro, la fortuna, la guarigione e altro, con la celidonia si preparano i "sali <strong>per</strong> togliere le<br />
negatività".<br />
Questo sale misto a celidonia , dopo vari riti magici eseguiti rigorosamente in una notte di luna piena, potrà<br />
essere usato solo con la luna nuova e <strong>il</strong> suo potere durerà un anno.<br />
Messo sotto lo zerbino, ad esempio, allontana <strong>per</strong> sempre i falsi amici e gli invidiosi protegge dai malefici,<br />
favorisce le risoluzioni legali<br />
La leggenda vuole che le rondini facciano cadere una goccia di latice di celidonia negli occhi ancora chiusi<br />
dei rondinotti aiutandoli in questo modo ad aprirli.
Cichorium intybus<br />
Radicchio selvatico<br />
RADICCHIO SELVATICO<br />
Fusto prostrato od eretto, ispido <strong>per</strong> peli rivolti in basso. Foglie irregolarmente pennato-partite o pennatosette,<br />
con segmenti triangolari acuti, generlamente alterne. Fiori disposti in capolini numerosi, sess<strong>il</strong>i o<br />
peduncolati, con corolla azzurro intenso. Il frutto è un achenio con pappo formante una breve coroncina<br />
apicale.<br />
La raccolta:<br />
Di tutte le erbe spontanee dei nostri campi, la cicoria può vantare diversi primati: in primo luogo è quella<br />
che più ha contribuito al sostentamento dei nostri avi in ogni epoca, pane e cicoria ripassata era uno dei<br />
pasti più diffusi e tipici. In secondo luogo, è l’erba che più di tutte è rimasta impressa nella memoria sociale<br />
<strong>del</strong> popolo romano, ed ancora oggi torme di cittadini <strong>del</strong> tutto privi <strong>del</strong> rapporto con la campagna,<br />
conoscono almeno di nome la cicoria. Storicamente la cicoria proprio <strong>per</strong> la sua onnipresenza era raccolta<br />
da tutti, ma <strong>per</strong> chi non voleva stancarsi, esisteva <strong>il</strong> cicoriaro, raccoglitore professionale, che con <strong>il</strong> suo<br />
sacco a spalla ed <strong>il</strong> suo caratteristico coltello lungo e sott<strong>il</strong>e andava <strong>per</strong> campi <strong>per</strong> raccogliere e vendere. La<br />
cicoria presentava e presenta un solo grande inconveniente: bisogna “caparla”, ovvero mondarla da foglie<br />
vecchie, terra e radici. Per comprendere in quale considerazione era tenuta la cicoria a Roma, cito un passo<br />
di Cesare Pascarella (La sco<strong>per</strong>ta <strong>del</strong>l’America), <strong>per</strong> dimostrare la magnificenza <strong>del</strong>la nuova terra appena<br />
sco<strong>per</strong>ta, viene tirata in ballo la cicoria!
Cirsium vulgare<br />
CARDO ASININO<br />
( Carduus lanceolatus L., Cirsium lanceolatum Scopoli, Cnicus lanceolatus W<strong>il</strong>ldenow)<br />
Cardo asinino,Stoppione maggiore, Spione maggiore, Cardoncello maggiore.<br />
Forma biologica : H. bienn. Emicriptofite bienni. Piante a ciclo biennale con gemme poste a livello <strong>del</strong><br />
terreno.<br />
Descrizione: pianta erbacea biennale con fusto eretto, ramoso completamente co<strong>per</strong>to di aculei di 3 mm.<br />
ca. con ali spinose, può raggiungere anche i 2 metri di altezza.<br />
Foglie rade, decorrenti lungo <strong>il</strong> fusto, di un colore verde sopra, biancastre e tomentose sotto,<br />
profondamente incise, più o meno triangolari-lanceolate, a lobi ineguali, terminanti con una spina<br />
giallastra.<br />
Infiorescenze a capolino, racchiuso da un involucro ovoide lungo 3-5 cm.con brattee terminanti con spina a<br />
punta triangolare e corolla rosso porpora. Fiori ermafroditi, impollinazione tramite farfalle ed api.<br />
I frutti sono acheni di 3-4 mm., con pappo bianco setoloso di 2-3 cm.<br />
Antesi :giugno- ottobre<br />
Tipo corologico : Paleotem<strong>per</strong>ata. Eurasiatiche in senso lato, che ricompaiono anche nel Nord Africa.(<br />
Specie divenuta cosmopolita).<br />
Distribuzione in Italia : presente in tutte le regioni ed isole.<br />
Habitat :cresce nei luoghi incolti, ai margini dei fossati e dei canali e nelle praterie, dalla pianura alla<br />
montagna sino 1700 metri.<br />
Proprietà : la pianta è una buona mellifera.
Colchicum autumnale<br />
Tassonomia<br />
Regno:Plantae<br />
Divisione:Magnoliophyta<br />
Classe:L<strong>il</strong>iopsida<br />
Ordine:L<strong>il</strong>iales<br />
Famiglia:L<strong>il</strong>iaceae<br />
FALSO ZAFFERANO<br />
Nomi italiani<br />
Falso zafferano, Colchico autunnale, Zafferano bastardo, Giglio matto, Freddolina.<br />
Descrizione<br />
Pianta <strong>per</strong>enne con bulbo verticale, a forma di <strong>per</strong>a e rico<strong>per</strong>to da una tunica bronzea, che non emette fiori<br />
finché ci sono le foglie. Foglie e semi appaiono in primavera, poi seccano e spariscono lasciando posto ai<br />
fiori in autunno. Tutta la pianta è velenosa.<br />
Foglie<br />
Le foglie <strong>del</strong> Colchicum spuntano in primavera e muoiono in autunno prima che compaiano i fiori; sono di<br />
colore verde scuro, lunghe fino a 30 cm, larghe circa 7cm, con leggere striature più scure.<br />
Fiori<br />
I fiori, sim<strong>il</strong>i a quelli dei Crocus, spuntano in autunno nascendo direttamente dal bulbo sotterraneo, <strong>per</strong> lo<br />
più a mazzetti di 3 ma anche fino a 7; hanno 6 tepali di colore viola/rosa non variegati, fusi in un unico tubo<br />
<strong>per</strong>igoniale. Il fiore (lobi + tubo) è lungo complessivamente fino a 20 cm; ermafrodita, ha antere gialle su 6<br />
stami, 3 dei quali più lunghi dei restanti, e 3 st<strong>il</strong>i sporgenti dal tubo e separati tra loro.<br />
Frutti<br />
I frutti sono capsule ovoidali, verdi, collocate nel cuore <strong>del</strong>le foglie in primavera; contengono circa 200 semi<br />
che sono dapprima bianco lattiginosi ma col passare <strong>del</strong> tempo scuriscono.<br />
Periodo di fioritura
I fiori spuntano fra agosto e ottobre.<br />
Territorio di crescita<br />
C. autumnale è diffuso e comune nel nord Italia fino alla Toscana. La specie è stata ritrovata anche in<br />
Sardegna.<br />
Habitat<br />
Cresce nelle radure boschive, nei prati e nei luoghi umidi, ma non in substrato calcareo.<br />
Uso Alimentare<br />
Per la sua tossicità è altamente vietato <strong>il</strong> consumo alimentare umano; anche le bestie di grossa taglia lo<br />
evitano, mentre gli ovini se ne cibano voracemente, col risultato di produrre poi un latte non commestib<strong>il</strong>e.<br />
Uso Cosmetologico<br />
Data la tossicità <strong>del</strong>l'intera pianta non si conoscono usi cosmetologici.<br />
Uso Farmacologico<br />
Oltre che <strong>per</strong> le forme acute di gotta è ut<strong>il</strong>e <strong>per</strong> la cura di alcune forme di epatite cronica. Trova impieghi<br />
anche nel trattamento esterno di alcune forme tumorali grazie alle sue capacità di ridurre la duplicazione<br />
cellulare. Gli ut<strong>il</strong>izzi in farmacologia di questa pianta, contenente sostanze tra le più velenose, sono<br />
necessariamente riservati ai medici e si limitano all'ut<strong>il</strong>izzo <strong>del</strong>la sola colchicina pura.<br />
Pianta da evitare e non ut<strong>il</strong>izzata in fitoterapia <strong>per</strong> la sua velenosità.<br />
Medicina alternativa e Curiosità<br />
In omeopatia <strong>il</strong> C. autumnale viene usato, in minime dosi, <strong>per</strong> la poliartrite e nella ritenzione degli acidi urici<br />
che provoca la gotta. Mentre in veterinaria come diuretico e <strong>per</strong> curare i malanni articolari degli animali.<br />
Anticamente <strong>il</strong> decotto <strong>del</strong>la pianta veniva frizionato sul derma <strong>per</strong> <strong>il</strong> trattamento <strong>del</strong>le sciatalgie e nelle<br />
affezioni <strong>del</strong> trigemino
Convolvulus arvensis<br />
Tassonomia<br />
Regno: Plantae<br />
Divisione: Magnoliophyta (Angios<strong>per</strong>mae)<br />
Classe: Magnoliopsida (Dicotyledones)<br />
Ordine: Solanales<br />
Famiglia: Convolvulaceae<br />
Nome italiano<br />
V<strong>il</strong>ucchio comune<br />
Nomi locali: liatorja (Sard.)<br />
VILUCCHIO COMUNE<br />
Descrizione<br />
Pianta <strong>per</strong>enne, rizomatosa, strisciante o rampicante, glabra o con poca e corta pubescenza; fusti ramificati,<br />
volub<strong>il</strong>i, a sezione in genere poligonale, lunghi fino a 2 m; si arrampica alle altre specie erbacee, o alle<br />
recinzioni, avvolgendosi ad essi (da cui <strong>il</strong> nome <strong>del</strong> genere), anche grazie a particolari alette longitudinalielicoidali<br />
di cui sono dotati i fusti.<br />
Foglie<br />
Picciolate, con lamina astata o sagittata, ± allungata o arrotondata, margine intero, spesso ondulato e ±<br />
revoluto, apice da ottuso a subacuto, a volte mucronato; <strong>il</strong> picciolo è lungo all’incirca quanto la lamina nella<br />
parte basale <strong>del</strong> fusto, diventandone rapidamente più breve verso l’apice.<br />
Fiori<br />
Solitari o in coppie, portati all’ascella <strong>del</strong>le foglie; peduncoli lunghi e ± rigidi, con 2 brattee lineari ± opposte<br />
<strong>il</strong> cui nodo è, sovente, ginocchiuto; calice 5-mero dialisepalo, sepali oblunghi ad apice ottuso, o smarginato,<br />
o troncato, mucronato, ± pubescenti sul dorso, margine ± c<strong>il</strong>iato; corolla gamopetala, imbutiforme, da<br />
completamente biancastra a completamente rosacea, o, ancora più frequentemente, con 5 bande<br />
longitudinali bianche alternate ad altrettante rosate, sulla faccia abassiale sono presenti, centrate all'incirca<br />
sull'asse di quelle rosate (se evidenti), 5 ulteriori bande radiali liguliformi porporine, congiunte, e verdigiallastre,<br />
alla base; stami 5, di diversa lunghezza e con antere sagittate; st<strong>il</strong>o f<strong>il</strong>iforme, stigma bifido.
Frutti<br />
Capsula glabra, ellissoideo-sferoidale, più lunga <strong>del</strong> calice portante 3-4 semi scuri.<br />
Periodo di fioritura<br />
Potenzialmente tutto l’anno, a seconda <strong>del</strong>le condizioni climatiche.<br />
Territorio di crescita<br />
Specie diffusa in tutta la fascia tem<strong>per</strong>ata e subtropicale <strong>del</strong> nostro pianeta, ad eccezione <strong>del</strong>l’Australia; è<br />
presente in tutte le Regioni italiane.<br />
Habitat<br />
Prati incolti o coltivati, a volte anche infestante, bordi <strong>del</strong>le strade, da 0 a 1500 m di quota.<br />
Uso Alimentare<br />
Non si conoscono usi alimentari <strong>per</strong> questa pianta, che costituisce foraggio <strong>per</strong> gli animali al pascolo.<br />
Uso Farmacologico<br />
L’ estratto di C. arvensis L. è la fonte di una speciale classe di glicoproteine (Proteoglycan) che si sono<br />
dimostrate efficaci nell’inibire l’angiogenesi ossia <strong>il</strong> processo attraverso <strong>il</strong> quale i tumori favoriscono la<br />
crescita di nuovi vasi sangugni nell’organismo, necessari alla crescita <strong>del</strong> tumore stesso. La radice e le parti<br />
verdi <strong>del</strong>la pianta contengono un glucoside resinoso (convolvolina) che ha effetti purgativi.<br />
Medicina alternativa e Curiosità<br />
Tulle le parti <strong>del</strong>la pianta, specialmente le radici, possono essere ut<strong>il</strong>izzate come rimedi fitoterapici ( infuso,<br />
soluzione idroalcolica, polvere, succo fresco ) <strong>per</strong> le proprietà lassative, colagoghe e toniche <strong>del</strong>la<br />
digestione. La pianta intera macinata, <strong>per</strong> uso esterno, è ut<strong>il</strong>e a maturare foruncoli ed ascessi e in caso di<br />
emorroidi. In Sic<strong>il</strong>ia , secondo una tradizione popolare, la pianta viene usata <strong>per</strong> nutrire i conigli<br />
inappetenti. I Greci, nell’antichità, ritenevano che le Baccanti fossero use adormarsi <strong>il</strong> capo con corone di<br />
edera e fiori di convolvolo. La tendenza di C. arvensis a ricoprire qualunque sostegno e a invadere <strong>il</strong> terreno<br />
a discapito <strong>del</strong>le altre piante ne ha fatto <strong>il</strong> simbolo <strong>del</strong>l’invadenza e <strong>del</strong>la civetteria. In una fiaba dei fratelli<br />
Grimm, “ Il Bicchierino <strong>del</strong>la Madonna” , la vergine beve <strong>il</strong> vino offertole da uno stanco carrettiere nella<br />
corolla di un fiorellino: <strong>il</strong> fior di convolvolo.
Daucus carota<br />
Sinonimi<br />
Daucus gingidium L. subsp. gingidium<br />
Daucus gingidium L.<br />
Daucus communis Rouy & E.G.Camus<br />
Tassonomia<br />
Regno: Plantae<br />
Divisione:Magnoliophyta<br />
Classe: Magnoliopsida<br />
Ordine: Apiales<br />
Famiglia:Apiaceae<br />
Nome italiano<br />
Carota selvatica, cepo bianco, pastinaca, gallinaccio.<br />
CAROTA SELVATICA<br />
Descrizione<br />
Pianta erbacea biennale, a volte <strong>per</strong>ennante, con radice a fittone verticale ± ingrossato e lignificato, di<br />
colore giallo-biancastro; scapo fiorale rigido e irsuto, può essere semplice o ramificato fin dalla base,<br />
assumendo un portamento da slanciato a semi-cespuglioso, raggiunge in genere l'altezza di 1 m, potendo, a<br />
volte, su<strong>per</strong>are anche 1,70-2 m.<br />
Foglie<br />
Le foglie sono picciolate e abbraccianti <strong>il</strong> fusto, da 1 a 4-pennatosette (sono divise fino alla nervatura<br />
principale), quelle basali con un numero maggiore di divisioni, e di dimensioni maggiori, rispetto a quelle<br />
<strong>del</strong>la parte apicale; i segmenti sono da lineari a oblunghi a lanceolati, in prevalenza lineari nella foglie <strong>del</strong>la<br />
porzione apicale.<br />
Fiori<br />
Infiorescenze ad ombrella composta di dimensioni variab<strong>il</strong>i e portanti alla base un numero variab<strong>il</strong>e di
attee in genere pennatosette con divisioni ± lineari e la cui lunghezza non eccede mai <strong>il</strong> raggio<br />
<strong>del</strong>l'ombrella; alla base <strong>del</strong>le ombrelline secondarie sono presenti brattee di dimensioni più piccole e con<br />
lamina <strong>del</strong>la stessa forma, ma con meno divisioni; fiori minuti, <strong>del</strong>icatamente profumati, o quasi inodori,<br />
zigomorfi e con 5 petali da biancastri a ± rosati, quelli più esterni all'ombrella di dimensioni maggiori; al<br />
centro <strong>del</strong>l'ombrella è generalmente presente (ma può anche non esserci) un fiore ster<strong>il</strong>e con corolla di un<br />
colore porporino assai scuro, tendente al nero.<br />
Frutti<br />
Acheni da bruni a ± rossastri a maturità, da ovali a ellittici, con due ordini di coste longitudinali, uno con soli<br />
peli semplici, l'altro portante solo aculei; durante la fruttificazione le brattee alla base <strong>del</strong>la infiorescenza<br />
tendono a chiudersi a protezione dei frutti assumendo spesso una forma globosa.<br />
Periodo di fioritura<br />
Fiorisce da Apr<strong>il</strong>e a Ottobre inoltrato.<br />
Territorio di crescita<br />
Il Daucus carota si trova su tutto <strong>il</strong> territorio italiano fino a 1400 mt.<br />
Habitat<br />
Considerata pianta infestante, si trova fac<strong>il</strong>mente in posti assolati, prati, ambienti rurali e <strong>per</strong>fino lungo le<br />
strade <strong>per</strong>iferiche di città.<br />
Costituenti chimici<br />
Nel Daucus sono state segnalate numerose sostanze: acetone, asarone, colina, etanolo, acido formico,<br />
saccarosio, glucosio, glutatione, asparagina, Carotene, vitamine B1, B2, C, PP, E, D. La pianta contiene<br />
inoltre glucidi, provitamina A, vitamina B e C, sali minerali e pectite.<br />
Uso Alimentare<br />
La pianta non ha usi particolari alimentari,benchè si possano usare le foglie tenere in insalata e le radici<br />
tagliate a pezzi e fatte bollire,poi condite.Dai semi si estrae un olio, ut<strong>il</strong>izzato nella fabbricazione di liquori e<br />
nella preparazione di composti aromatici.<br />
Uso Cosmetologico<br />
L’olio dal <strong>del</strong>icato profumo di iris, viene impiegato in profumeria e nelle creme antirughe miscelato e<br />
combinato con altri oli di origine vegetale. Le radici vengono impiegate nell'industria <strong>per</strong> l'estrazione di<br />
carotene e di coloranti. Ut<strong>il</strong>izzata anche <strong>per</strong> la preparazione <strong>del</strong>le più note maschere di bellezza, la cui<br />
ricetta prodigiosa sembrerebbe essere una miscela <strong>per</strong>fetta <strong>del</strong>la polpa di questa pianta, con avocado e<br />
cetriolo.<br />
Uso Farmacologico<br />
In fitoterapia viene indicata come vitaminica, rimineralizzante, stimolatrice <strong>del</strong>le difese immunitarie,<br />
oftalmica, diuretica e cicatrizzante. Per applicazioni dermatologiche, dai semi si ottiene un olio essenziale,<br />
ut<strong>il</strong>issimo <strong>per</strong> la cura <strong>del</strong>la psoriasi, degli eczemi e <strong>del</strong>le dermatiti. I semi e i frutti <strong>del</strong>la carota selvatica<br />
hanno proprietà diuretiche. L'infuso di carota selvatica è efficace in caso di difficoltà di urinare.
Erigeron annuus<br />
CESPICA ANNUA<br />
Famiglia: Compositae<br />
Sinonimi: Stenactis annua ((L.)Less.), Aster annuus L.<br />
Nomi volgari: Cespica annua, Cespola annua.<br />
Etimologia: <strong>il</strong> nome generico dal greco “er” = “sollecito” e “gerou” = “vecchio”, con riferimento alla breve<br />
durata <strong>del</strong>la fioritura.<br />
Morfologia:<br />
pianta annua, spesso bienne, pelosetta, di aspetto erbaceo, fusti eretti semplici o ramificati in alto, con<br />
radici fibrose, altezza sino a 150 cm.<br />
Le foglie basali sono picciolate, lanceolato-dentate, le cauline sono sess<strong>il</strong>i, lanceolate o lineari, intere, con<br />
margine c<strong>il</strong>iato, pubescenti da entrambi i lati, lunghe sino a 9-10 cm.<br />
I corimbi terminali portano capolini dal diametro 2 cm, con i fiori <strong>del</strong> raggio ligulati di colore biancovioletto,<br />
quelli <strong>del</strong> disco gialli e tubulosi.<br />
I frutti sono acheni con pappo molle di peli radi.<br />
Distribuzione – habitat – fioritura:<br />
originaria <strong>del</strong> Nord America ora è specie naturalizzata in Europa; In Italia è comune nelle regioni<br />
settentrionali e centrali, dove possiamo trovarla nelle aree antropizzate, negli incolti e nelle macerie.<br />
Fiorisce da giugno a novembre sino a 1.200 m.
Fragaria vesca<br />
FRAGOLINA DI BOSCO<br />
Sinonimi<br />
Fragaria vulgaris Ehrh. - Potent<strong>il</strong>la vesca (L.) Scop. - Fragaria sylvestris (L.) Duchesne<br />
Tassonomia<br />
Regno: Plantae<br />
Divisione: Magnoliophyta<br />
Classe: Magnoliopsida<br />
Ordine: Rosales<br />
Famiglia: Rosaceae<br />
Nomi italiano<br />
Fragolina di bosco, fragola comune, fragola selvatica.<br />
Descrizione<br />
si tratta di una pianta rizomatosa, erbacea, <strong>per</strong>enne, che si sv<strong>il</strong>uppa con lunghi cordoni rizomatosi radicanti,<br />
presentante piccoli fusti eretti e a consistenza legnosa, alti dai 5 a 15 cm.<br />
Foglie<br />
Le foglie sono riunite con lunghi piccioli in rosette caratteristiche trifogliate, hanno un margine nettamente<br />
denticolato, la faccia inferiore è decisamente più smorta, biancastra e moderatamente pubescente. Hanno<br />
una lunghezza media che osc<strong>il</strong>la tra i 5 e i 7 cm.<br />
Fiori<br />
L'infiorescenza è composta con pochi fiori bianchi, portanti normalmente cinque petali (possib<strong>il</strong>i anche 4 o<br />
6) e aventi un diametro di poco su<strong>per</strong>iore al centimetro.<br />
Frutti
Il frutto apparente si presenta globoso, cm un diametro di circa 2 cm e di un bel colore rosso scarlatto. In<br />
realtà dal punto di vista botanico si tratta di un "falso frutto" esito <strong>del</strong> rigonfiamento <strong>del</strong> ricettacolo floreale<br />
prodottosi conseguentemente alla fecondazione <strong>del</strong> fiore, questa struttura sferoide porta sulla sua<br />
su<strong>per</strong>ficie numerosi piccoli acheni neri, che altro non sono che <strong>il</strong> frutto vero e proprio.<br />
Periodo di fioritura<br />
Secondo <strong>il</strong> sito geografico di crescita (Nord/Sud, pianura/montagna), la fioritura si realizza da Marzo a<br />
Luglio.<br />
Territorio di crescita<br />
Pianta ubi<strong>qui</strong>taria la troviamo ovunque, presente in tutte le regioni d'Italia, cresce sia in pianura che in<br />
montagna sino al limite <strong>del</strong>la vegetazione.<br />
Habitat<br />
Cresce nel sottobosco, lungo i margini <strong>del</strong>le stradine interne <strong>del</strong> bosco, nelle scarpate in genere.<br />
Uso Alimentare<br />
<strong>il</strong> frutto viene consumato da tempi immemorab<strong>il</strong>i sia crudo che cotto, viene ut<strong>il</strong>izzato <strong>per</strong> la preparazione di<br />
macedonie e marmellate, spesso si accompagna al gelato. Con l'infuso di foglie si produce una bevanda<br />
gradevolissima dall'intenso sapore e profumo.<br />
Uso Cosmetologico<br />
La polpa dei suoi frutti schiacciati viene applicata con maschere finalizzate a schierire zone epidermiche<br />
fortemente pigmentate e melaminiche.<br />
Uso Farmacologico<br />
Viene usata come astringente intestinale, antinfiammatorio, ipotensivo, diuretico, antigottoso, rinfrescante<br />
e <strong>qui</strong>ndi consigliata in modo particolare nel trattamento <strong>del</strong>la diarrea, pelle e mucose arrossate, ematuria,<br />
ittero. La polpa schiacciata può essere applicata sul derma <strong>per</strong> trattare gli eritemi dovuti ad eccessi<br />
nell'esposizione solare.<br />
Tutti i trattamenti farmacologici e sanitari devono sempre essere eseguiti sotto stretto e diretto controllo<br />
medico.<br />
Medicina alternativa e Curiosità<br />
Secondo le indicazioni di Bach la fragola sarebbe ut<strong>il</strong>e a rafforzare <strong>il</strong> senso di dignità, l'e<strong>qui</strong>librio psicofisico,<br />
l'affermazione <strong>del</strong> proprio io. Secondo la medicina Antroposofica le foglie di vite e fragola sono consigliate<br />
<strong>per</strong> le patologie epatiche. Nel linguaggio dei fiori la fragola rappresenta l'Amore e la Stima. Nel Medioevo le<br />
foglie essiccate di fragola intrecciate e raccolte in appositi cordoni, se indossate come cinte, si ritenevano<br />
ut<strong>il</strong>i come rimedio protettivo contro <strong>il</strong> morso dei serpenti. I viandanti che riposavano all'a<strong>per</strong>to a tale scopo<br />
proteggevano i giacigli circondandoli con foglie di fragola.
Galega officinalis<br />
CAPRAGGINE<br />
Capraggine, Ruta di Capra,Lavamani , Chiappamosche, Aruta Capraria<br />
Descrizione: è una pianta erbacea <strong>per</strong>enne, da 50 cm. a 1 mt. di altezza, con corto rizoma, da cui parte un<br />
abbondante sistema radicale.<br />
Fusto erbaceo, eretto, glabro, cavo all’interno, alla base <strong>del</strong> picciolo sono inserite 2 stipole allungateaccuminate.<br />
Le foglie glabre, imparipennate con 11-19 foglioline,che sono oblunghe-lanceolate,mucronate all’apice,con<br />
margine intero.<br />
I fiori, sfumati dal l<strong>il</strong>la al rosa ed al bianco, sono disposti in racemi all’ascella <strong>del</strong>le foglie su<strong>per</strong>iori di ca, 10-<br />
20 cm. Il calice, di forma campanulata, ha 5 denti triangolari allungati, mentre la corolla è formata da 1<br />
carena, 2 ali ed 1 vess<strong>il</strong>lo. Il frutto è un legume sinuoso e strozzato tra un seme e l‘altro, di lunghezza 2-3<br />
cm.<br />
Antesi: Maggio - Luglio<br />
Distribuzione in Italia: Presente in tutta la penisola, assente nelle isole<br />
Habitat: Cresce nei terreni freschi, rive dei fossi, dei fiumi e canali, dal mare alla regione sub montana di<br />
tutta Italia, ma più rara nell’Italia Meridionale, fino a 800 m.<br />
Proprietà, usi e curiosità: Nei tempi passati è stata usata nell’alimentazione umana <strong>per</strong> <strong>il</strong> suo potere<br />
nutritivo, <strong>per</strong> le sue proprietà diaforetiche, contro le febbri e la peste, quale antidoto. Infatti, uno dei suoi<br />
nomi popolari ,in Germania ,era “ Pest<strong>il</strong>enzkraut”, ossia erba <strong>del</strong>la peste.<br />
Nella tradizione popolare , l’uso <strong>del</strong>la droga,ormai molto limitato, veniva impiegato oltre che sudorifero ed<br />
antitossico di ordine generale, come stimolatore <strong>per</strong> aumentare la portata lattea alle nutrici. Il suo potere<br />
galattogeno era così apprezzato, che in alcune zone <strong>del</strong>la pianura padana, era consuetudine somministrare<br />
decotti alle puer<strong>per</strong>e.<br />
Così pure nelle campagne veniva considerata una ottima foraggera e si coltivava <strong>per</strong> arricchire i foraggi di<br />
principi attivi stimolanti la secrezione di latte nelle bovine e <strong>per</strong> conservare a lungo la portata di latte.<br />
Alcuni studiosi confermarono queste proprietà ed altri in seguito le negarono. Molti ricercatori moderni,che<br />
hanno affrontato la verifica di codeste proprietà, non sono riusciti ad affermarle con certezza, anche se in<br />
alcuni casi si sono riscontrati miglioramenti di volume e <strong>del</strong>la circolazione <strong>del</strong>le ghiandole mammarie.
Galium aparine<br />
ATTACCAMANO<br />
Attaccamano, Caglio as<strong>per</strong>ello, Attaccaveste, Attaccaroba, Erba taca, Reseghetta, Strozzagalline,<br />
Scattalingula.<br />
Forma biologica: T scap<br />
Descrizione: Pianta annua erbacea, strisciante o ascendente, spesso rampicante su altre piante;<br />
fusti angolosi, robusti e tenaci, scabri <strong>per</strong> la presenza di irti aculei reflessi; lunghezza sino a 2 m.<br />
Le foglie sono vertic<strong>il</strong>late 6÷9, lineari÷lanceolate o ellittiche hanno apice mucronato spinulose sul bordo e<br />
sulla nervatura centrale, sulla pagina inferiore <strong>del</strong> lembo f<strong>il</strong>e di peli duri.<br />
I fiori formano cime bipare ascellari e peduncolate, piccole corolle bianco÷verdi, i lobi <strong>del</strong>la corolla sono<br />
nettamente separati.<br />
I frutti sono diacheni co<strong>per</strong>ti di setole uncinate che si fissano solidamente ad ogni appiglio, fac<strong>il</strong>itando in<br />
questo modo la dis<strong>per</strong>sione.<br />
Antesi: Marzo÷Settembre<br />
Tipo corologico: Eurasiat.<br />
Distribuzione in Italia: Presente in tutto <strong>il</strong> territorio, isole comprese.<br />
Habitat: Comune sui bordi stradali, campi incolti, siepi, boscaglie da 0 a 1.700 m.<br />
Proprietà ed usi: Erba amara rinfrescante dal sapore salato, leggermente lassativa<br />
depurativa, diuretica, antinfiammatoria, astringente, tonica sul sistema linfatico.<br />
Come la maggior parte dei Galium ha fama di alterativo e tonico linfatico efficace in caso di eczema e<br />
psoriasi e altre condizioni infiammatorie croniche.<br />
Per uso interno in caso di febbri ghiandolari, tons<strong>il</strong>liti, cistite, eczema psoriasi.<br />
Per uso esterno in caso di ulcere, infiammazioni cutanee, piccole lesioni e psoriasi.<br />
In cucina i cinesi lo ut<strong>il</strong>izzano come verdura, mentre i semi tostati possono essere ut<strong>il</strong>izzati come surrogato<br />
<strong>del</strong> caffè.
Galium verum<br />
CAGLIO ZOLFINO<br />
Caglio zolfino, Gallio, Caglio, Erba da caglio, Erba zolfina, Ingrassabue, Presuola.<br />
Foma biologica: H scap (Emicriptofite scapose. Piante <strong>per</strong>ennanti <strong>per</strong> mezzo di gemme poste a livello <strong>del</strong><br />
terreno e con asse fiorale allugato, spesso privo di foglie).<br />
Descrizione: Pianta <strong>per</strong>enne, erbacea, rizomatosa, raggiunge 1 m di altezza. Fusti c<strong>il</strong>indrici o<br />
subquadrangolari, glabrescenti o solcati da 4 linee di peli annerenti nel secco, poco ramificati.<br />
Le foglie sono riunite in vertic<strong>il</strong>li di 8-12 elementi, strette, lineari, con stipole sim<strong>il</strong>i a foglie, lucide sopra e<br />
pubescenti di sotto, revolute al margine, hanno una nervatura centrale r<strong>il</strong>evata, molto evidente.<br />
I fiori portati da brevi peduncoli, sono di colore giallo intenso, molto piccoli, disposti in folte pannocchie<br />
terminali, glabri e profumati. La corolla di 2-4 mm. è divisa un 4 punte, tra la quali si intercalano 4 stami<br />
dalle antere marrone.<br />
I frutti sono acheni glabri, levigati e brunastri.<br />
Antesi: Giugno – Settembre<br />
Distribuzione in Italia: Presente in tutto <strong>il</strong> teritorio.<br />
Habitat: Prati aridi, lungo i sentieri, ai margini dei boschi, nei luoghi sabbiosi e sassosi sino a 1.700 m.<br />
Proprietà ed ut<strong>il</strong>izzi: Pianta diuretica, antireumatica, antispasmodica, sedativa, astringente, indicata contro<br />
le malattie <strong>del</strong>l’apparato urinario.<br />
Per uso esterno può essere impiegata <strong>per</strong> combattere le dermatosi, le piaghe che cicatrizzano con difficoltà<br />
e le affezioni <strong>del</strong>la pelle in genere.<br />
Anticamente era erba usata <strong>per</strong> la coagulazione <strong>del</strong> latte, oggi, <strong>il</strong> caglio, si estrae dall’abomaso dei vitelli<br />
lattanti.<br />
Questa pianta, come altri Galium, ha la proprietà di tingere i tessuti: in giallo se si usano i fiori, in rosso se si<br />
usano le radici.
Geranium molle<br />
Sinonimi<br />
Geranium stipulare Kunze<br />
Tassonomia<br />
Regno: Plantae<br />
Divisione: Magnoliophyta (Angios<strong>per</strong>mae)<br />
Classe: Magnoliopsida (Dicotyledones)<br />
Ordine: Geraniales<br />
Famiglia: Geraniaceae<br />
Nome italiano<br />
Geranio comune<br />
GERANIO COMUNE<br />
Descrizione<br />
Pianta erbacea annuale alta fino a 30 (40) cm, con fitta pelosità biancastra, morbida e variegata,<br />
generalmente <strong>per</strong> peli semplici lunghi fino a circa 2 mm e peli semplici o ghiandolari vistosamente<br />
più brevi. Fusticini es<strong>il</strong>i, ma rigidi, sub-eretti o ascendenti, arrossati, scanalati almeno nella parte<br />
basale.<br />
Foglie<br />
Picciolate, con lamina da sub-orbicolare a reniforme, palmatifida con segmenti principali a loro<br />
volta divisi in (2)3(4) lobi generalmente arrotondati, più di rado ulteriormente divisi; pelosità<br />
appressata alla lamina, o al più eretto-patente, sia semplice che ghiandolare, avvertib<strong>il</strong>e al tatto<br />
come velluto, su entrambe le facce; picciolo lungo fino a 12-14 cm nelle foglie basali,<br />
progressivamente più breve andando verso l’apice dei fusti; divisioni <strong>del</strong>la lamina più marcate<br />
nelle foglie su<strong>per</strong>iori, che hanno dimensioni più ridotte rispetto alle altre e sono divise in 5 lobi,<br />
interi o, a loro volta, divisi in 2-3 segmenti. Stipole pelose su almeno una faccia e sul margine, ±<br />
erette e leggermente involute.<br />
Fiori<br />
In cimette generalmente 2-flore, in posizione opposta alle foglie su<strong>per</strong>iori e apicali; peduncolo con<br />
indumento sim<strong>il</strong>e ai fusti, e portante un vertic<strong>il</strong>lo di piccole brattee scariose e v<strong>il</strong>lose, all’incirca
sub-erette e lanceolate o 2-lobate, alla base <strong>del</strong>la diramazione dei pedicelli di ciascun fiore; calice<br />
5-mero <strong>per</strong>sistente, ma non accrescente, alla fruttificazione, con sepali liberi, lanceolati e pelosi, ±<br />
appressati ai petali, e con breve (< 0,2 mm) mucrone, generalmente arrossato, all’apice; corolla 5mera<br />
dialipetala, da rosea a violetto-porporina, con petali eretto-patenti, glabri almeno sulla<br />
pagina su<strong>per</strong>iore, largamente ellittici e smarginati all’apice, oppure 2-lobati, più lunghi dei sepali;<br />
stami 10 con f<strong>il</strong>amenti biancastri e antere violacee; ovario su<strong>per</strong>o 5-loculare, st<strong>il</strong>o unico, diviso<br />
all’apice in 5 segmenti revoluti, e disposti, <strong>qui</strong>ndi, radialmente.<br />
Frutti<br />
Infruttescenza a schizocarpo, formata, alla base, da 5 acheni (mericarpi) glabri occultati dal calice,<br />
e da un becco tozzo e pubescente <strong>per</strong> brevi peli eretto-patenti, ristretto e portante i resti degli<br />
stigmi all’apice; la lunghezza complessiva non su<strong>per</strong>a, di solito, i 10 mm, e a maturità assume un<br />
colore brunastro.<br />
Periodo di fioritura<br />
Da marzo a settembre; nelle regioni con estati molto torride e inverni moderatamente freddi la<br />
fioritura si arresta all'inizio <strong>del</strong>l'estate con successivo disseccamento <strong>del</strong>la pianta, ma può essere<br />
anticipata anche di 1 o 2 mesi durante l'inverno.<br />
Territorio di crescita<br />
Specie originaria <strong>del</strong>l'Europa e <strong>del</strong> continente Asiatico, è stata introdotta in quasi tutte le restanti<br />
parti <strong>del</strong> Globo, divenendo così subcosmopolita; in Italia è presente allo stato spontaneo in tutte le<br />
Regioni.<br />
Habitat<br />
Prati, coltivi, vigne, generalmente in zone ben antropizzate, dal livello <strong>del</strong> mare fino a circa 1000 m<br />
di quota, nelle zone più tem<strong>per</strong>ate può spingersi anche ad altezze più elevate.<br />
Uso Alimentare<br />
Indagini etnobotaniche nel territorio <strong>del</strong>la Garfagnana hanno documentato un uso alimentare<br />
<strong>del</strong>le foglie di G. molle come ingrediente nelle zuppe.<br />
Uso Cosmetologico<br />
Non si conoscono usi cosmetici <strong>per</strong> questa specie.<br />
Uso Farmacologico<br />
Il contenuto in tannino conferisce attività astringente e quello in terpeni attività antisettica.<br />
Medicina alternativa e Curiosità<br />
Nella medicina popolare la pianta è considerata astringente, vulneraria ed anodina (agisce sul<br />
cervello e sul Sistema Nervoso, diminuendo la sensib<strong>il</strong>ità al dolore).<br />
Nicholas Culpe<strong>per</strong>, insigne botanico, erborista, medico ed astrologo britannico, vissuto nella prima<br />
metà <strong>del</strong> Seicento, sosteneva che questa specie ha un ampio spettro di usi medicinali e che<br />
costituisce un’eccellente rimedio <strong>per</strong> ferite e <strong>per</strong> sanguinamenti di vario genere, in grado di<br />
favorire la coagulazione e di curare dolori di varia natura, ulcere e fistole.
Geranium pratense<br />
Geranio dei prati<br />
Forma biologica: H scap<br />
GERANIO DEI PRATI<br />
Descrizione: Pianta erbacea <strong>per</strong>enne, con fusti pubescenti, eretti ramificati con biforcazioni dicotome .<br />
Le foglie palamto partite a lobi acuti, basali e cauline sono profondamente divise in 5-7 lobi aguzzi, incisidentati,<br />
quelle radicali sono larghe e sv<strong>il</strong>uppate. Le cauline sono opposte e più piccole verso l’alto.<br />
I fiori a simmetria radiata, hanno corolla da blu-violetta a rosa, qualche volta quasi bianca, con petali di 2<br />
cm col fondo disegnato da venature più scure. Hanno 5 sepali lanceolati trinervi e con mucrone terminale,<br />
5 petali obovati e ovario su<strong>per</strong>o circondato da 10 stami saldati alla base.<br />
L’ovario dà luogo a capsule che a maturità si separano in 5 acheni. Caratteristica <strong>del</strong> frutto è di essere<br />
ripiegato verso <strong>il</strong> basso.<br />
Antesi: Guigno – Agosto<br />
Tipo corologico: Eurosiber.<br />
Distribuzione in Italia: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia<br />
Giulia, Liguria, Em<strong>il</strong>ia Romagna, Toscana.<br />
Habitat: Prati falciab<strong>il</strong>i e pingui, suoli freschi generalmente umidi e ricchi di humus, neutri o alcalini, da 500<br />
a 1300 m.<br />
Proprietà ed ut<strong>il</strong>izzi: Pianta antinfiammatoria, analgesica, febbrifuga e vulneraria.
Helianthus tuberosus<br />
ELIANTO<br />
Famiglia: Compositae<br />
Nomi volgari: elianto, topinambur, tartufo di canna, patata <strong>del</strong> Canadà, patata selvatica, girasole tuberoso,<br />
carciofo <strong>del</strong> Canadà, tartufola bastarda, fior di sole, <strong>per</strong>a di terra.<br />
Etimologia: <strong>il</strong> nome <strong>del</strong> genere che significa “sole fiore” è dovuto ai grandi capolini raggiati sim<strong>il</strong>i al sole, <strong>il</strong><br />
nome specifico si riferisce agli organi ipogei.<br />
Morfologia:<br />
pianta <strong>per</strong>enne, erbacea, infestante, con robusti rizomi tuberosi, fusti eretti, irsuti alta sino a 3 m.<br />
Le foglie sono picciolate, pubescenti, le inferiori ovato-cordate, le altre ovate o lanceolate attenuate alla<br />
base, opposte ed alterne hanno lamina su<strong>per</strong>iore verde scura, dentellata.<br />
I capolini, di colore giallo intenso e larghi fino a 8 cm, sono portati da lunghi e sott<strong>il</strong>i peduncoli spesso riuniti<br />
in gruppi di 4-5 o più, presentano fiori <strong>per</strong>iferici con lunghe ligule gialle solcate.<br />
I frutti sono acheni.<br />
Distribuzione – habitat – fioritura:<br />
originaria <strong>del</strong>l’America, alcuni sostengono settentrionale altri meridionale, si è diffusa come infestante in<br />
tutta l’Europa, si adatta fac<strong>il</strong>mente alle tem<strong>per</strong>ature più diverse, cresce sia nei terreni arg<strong>il</strong>losi, umidi e<br />
pesanti sia nei terreni, asciutti e sabbiosi, anche se pred<strong>il</strong>ige questi ultimi. In Italia la si può trovare negli<br />
incolti, nei luoghi umidi lungo le rive dei corsi d’acqua, negli ambienti ruderali. Fiorisce da agosto a ottobre<br />
sino a 800 m.<br />
Proprietà ed usi:<br />
<strong>il</strong> tubero che somiglia <strong>per</strong> forma e consistenza ad una patata ma, contrariamente alla patata non contiene<br />
amido, contiene invece <strong>il</strong> 15% circa di glucidi composti quasi esclusivamente dal polisaccaride inulina;<br />
adatto <strong>qui</strong>ndi, nei regimi ipocalorici degli obesi e dei diabetici. Ricco di vitamine A e B. Il Lactobac<strong>il</strong>lus che<br />
contiene lo rende ut<strong>il</strong>e alle donne che allattano, buon energetico, adatto nell’alimentazione degli anziani<br />
dei convalescenti e dei bambini. Ut<strong>il</strong>e <strong>per</strong> chi soffre di cattiva digestione e stitichezza.<br />
In America è stata sin dai tempi più remoti un’importante pianta alimentare, oggi vive un <strong>per</strong>iodo di<br />
risco<strong>per</strong>ta grazie al diffondersi dei prodotti salutisti, si può usare in cucina in ogni ricetta che richiede la<br />
presenza di patate o di farine, con modalità e risultai identici.
Hy<strong>per</strong>icum <strong>per</strong>foratum<br />
Sinonimi<br />
Hy<strong>per</strong>icum veronense Schrank<br />
Hy<strong>per</strong>icum noeanum Boiss.<br />
Tassonomia<br />
Regno: Plantae<br />
Divisione: Magnoliophyta<br />
Classe: Magnoliopsida<br />
Ordine: Theales<br />
Famiglia: Clusiaceae o Guttiferae<br />
ERBA DI SAN GIOVANNI<br />
Nome italiano<br />
I<strong>per</strong>ico, Erba di San Giovanni, Cacciadiavoli, M<strong>il</strong>lebuchi, Erba <strong>del</strong>l´olio rosso, P<strong>il</strong>atro, Erba trona<br />
Descrizione<br />
Pianta erbacea <strong>per</strong>enne alta 20 - 80 cm, glabra in tutte le sue parti; fusto fiorifero rigido,<br />
legnosetto alla base, e ramificato, non <strong>per</strong>sistente (si secca) dopo la fruttificazione; fusticini ster<strong>il</strong>i<br />
prostrati e striscianti, privi di foglie durante <strong>il</strong> <strong>per</strong>iodo riproduttivo, <strong>per</strong>sistenti e fogliosi durante lo<br />
svernamento, in cui, dunque, la pianta assume portamento reptante.<br />
Foglie<br />
Foglie sess<strong>il</strong>i, opposte, da lanceolate a ovali, ristrette verso la base <strong>del</strong>la lamina, con margine<br />
intero e ottuse all'apice, ghiandolose <strong>per</strong> ghiandole scure concentrate <strong>per</strong> lo più lungo <strong>il</strong> margine<br />
<strong>del</strong>la pagina inferiore <strong>del</strong>la lamina e traslucide su tutta la lamina, tali <strong>qui</strong>ndi che, se guardate<br />
controluce, diano l'impressione di essere bucherellate (da cui l'epiteto <strong>per</strong>foratum).<br />
Fiori<br />
Infiorescenze in corimbi apicali. Fiori attinomorfi pentameri.<br />
Sepali interi, da strettamente ovati a lesiniformi, sempre acuti o acuminati.<br />
Petali ellittici, asimmetrici, di colore giallo intenso, ghiandolosi e macchiettati di nero sul margine,<br />
irregolarmente dentellati o crenati.<br />
Ovario su<strong>per</strong>o 3-carpellare, st<strong>il</strong>i 3, liberi, con stigma rossastro.
Stami numerosi (50 - 60), saldati alla base in 3 gruppi, in modo da formare altrettanti fasci.<br />
Frutti<br />
Il frutto è una capsula ovale setticida, che contiene semi di colore bruno.<br />
Periodo di fioritura<br />
Maggio-Agosto<br />
Territorio di crescita<br />
Pianta originaria <strong>del</strong>l’arcipelago britannico, è oggi diffusa in tutto <strong>il</strong> mondo e presente senza<br />
eccezioni in tutte le regioni d'Italia.<br />
Habitat<br />
Pred<strong>il</strong>ige terreni asciutti, margini <strong>del</strong>le strade e dei campi, radure soleggiate, dal piano basale al<br />
piano montano.<br />
Uso Alimentare.<br />
Talvolta la pianta ed <strong>il</strong> frutto vengono ut<strong>il</strong>izzati come sostituto <strong>del</strong> tea. I fiori possono venire usati<br />
<strong>per</strong> fare l'Idromele.<br />
Uso cosmetologico<br />
L'estratto oleoso entra nella composizione di cosmetici emollienti ed idratanti, <strong>per</strong> pelli secche,<br />
screpolate e sensib<strong>il</strong>i e tendenti alla cou<strong>per</strong>ose. L'attività dermoprotettiva e decongestionante<br />
<strong>del</strong>l'olio di i<strong>per</strong>ico ne fa un ingrediente elettivo in prodotti doposole e dopobarba. Assolutamente<br />
controindicato invece <strong>per</strong> l'esposizione al sole, in quanto fotosensib<strong>il</strong>izzante.<br />
Uso Farmacologico<br />
Molti studi in campo farmacologico sono in corso sulle proprietà di questa specie. Prove di<br />
laboratorio hanno verificato l'efficacia degli estratti <strong>del</strong>la pianta come antinfiammatori e <strong>per</strong><br />
l'azione contro <strong>il</strong> batterio che provoca la Tubercolosi. Poiché due dei suoi componenti, l'hy<strong>per</strong>icina<br />
e la pseudohy<strong>per</strong>icina, hanno manifestato una forte attività antiretrovirale, priva di seri effetti<br />
collaterali, sono in corso ricerche <strong>per</strong> verificarne l'efficacia nel trattamento <strong>del</strong>l'AIDS. Ugualmente<br />
ne è allo studio l'efficacia terapeutica <strong>per</strong> varie forme di tumore, <strong>per</strong> alcune malattie <strong>del</strong>la pelle fra<br />
cui la psoriasi, <strong>per</strong> l'artrite reumatoide, l'ulcera peptica, l'Alzheimer e <strong>per</strong>sino <strong>per</strong> i postumi<br />
<strong>del</strong>l'ubriachezza. Pianta elettiva nella medicina popolare e in erboristeria <strong>per</strong> trattare la<br />
depressione, man mano che gli studi sull'Hy<strong>per</strong>icum aumentano, si fa strada anche nella medicina<br />
occidentale moderna l'accettazione <strong>del</strong>la sua efficacia in questo senso.<br />
Tutti i trattamenti farmacologici e sanitari devono sempre essere eseguiti sotto stretto e diretto<br />
controllo medico.
Lamium maculatum<br />
FALSA ORTICA<br />
Sinonimi<br />
Lamium affine Guss. & Ten. in Ten. [1835-1838, Fl. Nap., App. 4 : 10]<br />
Lamium album L. var. maculatum L. [1753, Sp. Pl. : 579]<br />
Lamium cupreum Schott & al. [1855, Ísterr. Bot. Wochenbl., 1855 : 357]<br />
Lamium foliosum Crantz [1769, Stirp. Austr., ed. 2, 4 : 258]<br />
Lamium laevigatum L. [1763, Sp. Pl., ed. 2 : 808]<br />
Lamium melissifolium M<strong>il</strong>l. [1768, Gard. Dict., ed. 8 : n_ 5]<br />
Lamium mutab<strong>il</strong>e Dumort. [1829, Flor. Belg. : 45]<br />
Lamium niveum Schrad. [1841, Linnaea, 15, Litt. : 94]<br />
Lamium pallidiflorum Beck [1887, Ann. Naturhist. Hofmus. Wien, 2 : 144]<br />
Lamium rugosum Aiton [1789, Hort. Kew., ed. 1, 2 : 296]<br />
Tassonomia<br />
Regno: Plantae<br />
Divisione: Magnoliophyta<br />
Classe: Magnoliopsida<br />
Ordine: Lamiales<br />
Famiglia: Lamiaceae<br />
Nomi italiano<br />
Falsa ortica (<strong>per</strong> la somiglianza con l'Ortica) - Dolcimele (<strong>per</strong> <strong>il</strong> gusto dolce <strong>del</strong> fiore).<br />
Descrizione<br />
E' una pianta erbacea <strong>per</strong>enne alta mediamente cm 20-40 (80); <strong>il</strong> fusto, verde, quasi glabro, presenta una<br />
sezione quadrangolare e, quando si adagia sul terreno, emette <strong>del</strong>le radici in corrispondenza dei nodi; L.<br />
maculatum è una piantina che, se l'ambiente lo consente, tende a diventare tappezzante ed infestante.<br />
Foglie<br />
Nei climi meridionali è una pianta sempreverde, mentre, altrove, <strong>per</strong>de le foglie in autunno <strong>per</strong> germogliare<br />
nuovamente ai primissimi torpori pre-primaver<strong>il</strong>i; le foglie sono crenate, opposte, di forma ovale e<br />
pubescenti; <strong>il</strong> colore è verde, spesso con macchia biancastra lungo la nervatura centrale, mentre le<br />
dimensioni non su<strong>per</strong>ano i 5-6 cm di lunghezza.<br />
Fiori<br />
Di colore rosa, lavanda con macchie porpora e sfumature biancastre, sono posti a piccoli grappoli in<br />
corrispondenza <strong>del</strong>l'apice <strong>del</strong> fusto e alle ascelle dei nodi <strong>del</strong>la parte alta.
Frutti<br />
Piccolissimi acheni brunastri, esteticamente insignificanti.<br />
Periodo di fioritura<br />
La fioritura avviene da Marzo a Giugno ma, in particolari condizioni climatiche, si protrae fino all'autunno<br />
inoltrato.<br />
Territorio di crescita<br />
E' presente in tutte le regioni italiane con minore frequenza al Sud, praticamente assente in Sic<strong>il</strong>ia;<br />
da 0 a 1300 metri slm e, nelle regioni meridionali, arriva a 1800.<br />
Periodo di fioritura Fiorisce da Marzo a Giugno ma, in particolari condizioni climatiche, continua fino<br />
all'autunno inoltrato.<br />
Habitat<br />
Gradisce posizioni semiombreggiate ma luminose e fresche: prati, margine dei boschi e degli orti, terreni<br />
abbandonati ed incolti; non sopporta <strong>il</strong> gelo ed i caldi esas<strong>per</strong>ati.<br />
Uso Alimentare<br />
Le foglie di L. purpureum ed altri Lamium, vengono raccolte prima <strong>del</strong>la fioritura e consumate crude in<br />
insalata, oppure cotte da sole o insieme ad altre erbe selvatiche.<br />
Uso Cosmetologico<br />
Infusi di tutte le parti <strong>del</strong>la pianta <strong>per</strong> compresse, lavande e frizioni; con l'acqua dist<strong>il</strong>lata dei fiori e <strong>del</strong>le<br />
foglie si preparano colliri.<br />
Uso Farmacologico<br />
Questa pianta è ut<strong>il</strong>izzata <strong>per</strong> le sue proprietà depurative, astringenti, antiemorragiche.<br />
Tutti i trattamenti farmacologici e sanitari devono sempre essere eseguiti sotto stretto e diretto controllo<br />
medico.<br />
Medicina alternativa e Curiosità<br />
In passato veniva usata <strong>per</strong> combattere la scrofolosi, eruzione cutanea causata da una forma di tubercolosi.
Leontodon hispidus<br />
DENTE DI LEONE COMUNE<br />
Famiglia: Compositae<br />
Sinonimi: Leontodon proteiformis V<strong>il</strong>l.<br />
Nomi volgari: dente di leone comune.<br />
Etimologia: dal greco, <strong>il</strong> nome <strong>del</strong> genere, a indicare <strong>il</strong> margine dentato <strong>del</strong>le foglie.<br />
Morfologia:<br />
pianta <strong>per</strong>enne, di aspetto erbaceo, eretto, da peloso ispida a quasi glabra, alta sino a 45 cm.<br />
Le foglie, riunite in rosetta basale, sono lievemente dentate. Gli scapi fiorali portano un fiore solitario,<br />
pendulo prima <strong>del</strong>la fioritura, con fiori ligulati gialli, a volte con striature rossastre.<br />
I frutti sono acheni con pappo piumoso color marrone chiaro.<br />
Distribuzione – habitat – fioritura:<br />
diffusa in tutta l’Europa continentale, in Italia è pianta molto comune nei prati, nei pascoli e lungo i sentieri.<br />
Fiorisce da giugno a ottobre sino a 2.700 m.<br />
Proprietà ed usi:<br />
è pianta buona diuretica.
Linaria vulgaris<br />
LINAJOLA COMUNE<br />
Linajola comune, Linajola campestre, Erba strega, Linaria Cordiali, Tentennino.<br />
Forma biologica: H scap (Emicriptofite scapose-Piante <strong>per</strong>ennanti <strong>per</strong> mezzo di gemme poste a livello <strong>del</strong><br />
terreno e con asse fiorale allugato, spesso privo di foglie).<br />
Descrizione: Pianta <strong>per</strong>enne, grac<strong>il</strong>e, di aspetto erbaceo, con rizoma strisciante, lignificata alla base, fusti<br />
eretti, ramosi, pelosi e ghiandolosi in alto. Altezza 30-80 cm.<br />
Le foglie sono sono sess<strong>il</strong>i, alterne, lanceolate, acute, lineari, con margine revoluto, uninervie, un po’<br />
glauche.<br />
I fiori sono eliotropici, peduncolati, accompagnati da bratteee lineari, formano grappolo dapprima conico,<br />
poi allungato; tutta l'infiorescenza è pelosa con ghiandole frammiste ai peli. La corolla giallo zolfo, ha una<br />
macchia arancione sulla volta arcuata <strong>del</strong> labbro inferiore, termina con uno s<strong>per</strong>one ricurvo.<br />
I frutti sono capsule ovoidi, che contengono una gran quantità di piccoli semi neri.<br />
Antesi: Giugno – Ottobre.<br />
Tipo corologico: Euroasit.( Eurasiatiche in senso stretto, dall'Europa al Giappone).<br />
Distribuzione in Italia: Specie comune in tutta la penisola, assente in Sic<strong>il</strong>ia e Sardegna.<br />
Habitat: Incolti, ruderi, macerie, massicciate ferroviarie, in posizione soleggiata 0-1.500 m.<br />
Proprietà ed ut<strong>il</strong>izzi: Erba amara, acre, astringente, emolliente, depurativa, diuretica e lassativa. Attiva<br />
soprattutto sul fegato.<br />
Pianta impiegata nel passato come diuretico, in caso di edema, oggi usata raramente.<br />
Per uso interno: in caso di disturbi <strong>del</strong>la pelle, enterite, epatite, problemi alla cistifellea e edema.<br />
Per uso esterno: contro emorroidi, eruzioni cutanee, piaghe ed ulcere, buon emostatico.<br />
I fiori, raccolti giovani, sono commestib<strong>il</strong>i in insalata.
GINESTRINO<br />
Lotus corniculatus<br />
( Lotus corniculatus var. arvensis Pers., Lotus corniculatus var. genuinus Pospichal)<br />
Ginestrino, Ginestrina comune, Trifoglina.<br />
Forma biologica: H scap (Emicriptofite scapose. Piante <strong>per</strong>ennanti <strong>per</strong> mezzo di gemme poste a livello <strong>del</strong><br />
terreno e con asse fiorale allungato, spesso privo di foglie.)<br />
Descrizione: Pianta <strong>per</strong>enne, di aspetto erbaceo prostrato, molto variab<strong>il</strong>e, caratterizzata da un rizoma<br />
sv<strong>il</strong>uppato in più direzioni; fusti lignificati alla base, striati, glabri o scarsamente pelosi, prostrati o<br />
ascendenti, non molto ramificati; altezza sino a 40 cm.<br />
Le foglie alterne, con 5 segmenti, i 2 inferiori inseriti all’attaccatura <strong>del</strong> fusto e sim<strong>il</strong>i a stipole, gli altri 3<br />
brevemente picciolati da oblanceolati o ellittici; sia <strong>il</strong> margine che le nervature possono presentare lunghi<br />
peli, oppure essere glabri.<br />
I fiori di colore giallo intenso, talora screziati di rosso, formano ombrelle pauciflore portate da lunghi<br />
peduncoli. Cinque sepali, che fondendosi formano <strong>il</strong> calice tubolare, con denti più o meno uguali. Hanno<br />
corolla pap<strong>il</strong>ionacea con vess<strong>il</strong>lo ripiegato verso l’alto, 2 petali laterali liberi mentre i 2 petali inferiori sono<br />
fusi tra loro a formare la carena terminante a forma di becco, rivolta verso l’alto.<br />
I frutti sono baccelli sott<strong>il</strong>i c<strong>il</strong>indrici, che contengono numerosi semi lucidi, di colore marrone con segni più<br />
scuri.<br />
Antesi: Apr<strong>il</strong>e÷Settembre<br />
Tipo corologico: Paleotemp divenuta Cosmopol.<br />
Distribuzione in Italia: Molto comune in tutto <strong>il</strong> territorio.<br />
Habitat: Prati, pascoli aridi, incolti erbosi, da 0 a 1.800 m.<br />
Proprietà ed ut<strong>il</strong>izzi: Proprietà sedative, antispasmodiche, antiinfiammatorie, astringenti.<br />
In fitoterapia la pianta è impiegata come tonico cardiaco.<br />
Il Ginestrino, da cui è possib<strong>il</strong>e estrarre un colorante giallo, è stato coltivato sin dal XVIII secolo, in quanto<br />
ottimo foraggio dalle scarse esigenze, può essere ut<strong>il</strong>izzato <strong>per</strong> la produzione di fieno o destinato al pascolo<br />
diretto, poiché non crea problemi di meteorismo agli animali.
Lythrum salicaria<br />
(Salicaria spicata Lamk., Salicaria vulgaris Moench).<br />
SALCERELLA<br />
Salcerella, Riparella, Lisimachia rossa, Verga rossa dei fossi, Stipa marina.<br />
Descrizione: Pianta <strong>per</strong>enne erbacea, rizomatosa, fusti eretti semplici o ramificati, leggermente legnosi alla<br />
base, tetragoni, pubescenti. Altezza 40 - 120 cm.<br />
Le foglie ellittiche sess<strong>il</strong>i, lanceolate, cuoriformi alla base, a margine intero, la pagina inferiore nervata;<br />
quelle alla base sono opposte, le su<strong>per</strong>iori alterne.<br />
Da brattee ascellari sbocciano fiori rosa-violaceo, che formano lunghe e vistose spighe terminali. Il calice è<br />
formato da sepali triangolari, epicalice con segmenti di 1-2.5 mm più lunghi e più stretti dei sepali, la<br />
corolla formata da 6 petali patenti, lanceolati, ottusi, stami 12.<br />
I frutti sono capsule b<strong>il</strong>oculari, ovoidi, deiscenti, contengono diversi semi bruno-giallastri.<br />
Antesi: Giugno – Settembre<br />
Tipo corologico: Subcosmop.<br />
Distribuzione in Italia: Diffusa in tutto <strong>il</strong> territorio.<br />
Habitat: Luoghi umidi, paludi, sponde di laghi e fiumi, ambienti salmastri, sino a 1.200 m.<br />
Note di sistematica: Nel Meridione sembra prevalere una popolazione con foglie e calici fortemente<br />
tomentosi e in tutto <strong>il</strong> territorio si presentano fiori con st<strong>il</strong>o di misure variab<strong>il</strong>i, più breve o più lungo degli<br />
stami.<br />
Specie sim<strong>il</strong>e Lythrum virgatum L., rara e diffusa in alcune zone <strong>del</strong>la Lombardia. <strong>del</strong> Piemonte e <strong>del</strong>l’Em<strong>il</strong>ia;<br />
si differenzia <strong>per</strong> le dimensioni inferiori, le foglie attenuate alla base, i denti <strong>del</strong> calice tutti di uguale<br />
dimensione.<br />
Proprietà ed ut<strong>il</strong>izzi e curiosità: Pianta astringente, antibatterica diuretica, antiemorragica.<br />
Per uso interno in caso di diarrea, dissenteria, <strong>per</strong> regolarizzare <strong>il</strong> flusso mestruale.<br />
Per uso esterno, in infuso, <strong>per</strong> detergere piaghe, ferite e dermatiti da contatto; come antinfiammatorio <strong>del</strong><br />
cavo orale, in caso di pelle grassa e comedonica, ottimo anche come detergente intimo e in caso di cuoio<br />
capelluto grasso e con forfora; in compresse su emorroidi e vene varicose.<br />
La radice, ricca di tannino, un tempo veniva usata <strong>per</strong> la concia <strong>del</strong>le pelli, mentre dai fiori, veniva estratto<br />
un colorante usato in pasticceria e e <strong>per</strong> tingere le fibre naturali, soprattutto di cotone o di lana.<br />
I giovani germogli possono essere impiegati con altre erbe, in insalta, le foglie essiccate come surrogato <strong>del</strong><br />
tè. Diffusa come ornamentale, in alcune zone <strong>del</strong> mondo viene considerata infestante.
Malva sylvestris<br />
Sinonimi<br />
Malva ruderalis Salisb.<br />
Malva sinensis Cav.<br />
Malva vulgaris Ten.<br />
Malva racemosa C. Presl in J. & C. Presl.<br />
Malva mauritiana L.<br />
Malva recta Opiz<br />
Malva ambigua Guss.<br />
Tassonomia<br />
Regno:Plantae<br />
Divisione:Magnoliophyta<br />
Classe:Magnoliopsida<br />
Ordine:Malvales<br />
Famiglia:Malvaceae<br />
Nomi italiano<br />
Malva selvatica.<br />
MALVA SELVATICA<br />
Descrizione<br />
La malva è una pianta erbacea <strong>per</strong>enne, cespugliosa, con fusti eretti, a volte striscianti, può raggiungere e<br />
oltrepassare <strong>il</strong> metro di altezza, la radice è un fittone verticale. La pianta è eliotropica cioè segue <strong>il</strong> sole.<br />
Foglie<br />
Le foglie, di colore verde, sono disposte a ventaglio, con 5 o 7 lobi, con forma rotondeggiante o dentata,<br />
portate da un lungo picciolo.<br />
Fiori<br />
I fiori sbocciano in primavera e sono di colore rosa-violetto, la corolla è formata da 5 petali con striature più<br />
scure e si trovano all'ascella <strong>del</strong>le foglie, in coppia o a mazzetti.<br />
Frutti<br />
I frutti sono piccoli e tondi e reticolati, di forma schiacciata e contengono un unico seme.<br />
Periodo di fioritura<br />
Da Marzo a Luglio.
Territorio di crescita<br />
Cresce su tutto <strong>il</strong> territorio italiano fino a 1600 mt.<br />
Habitat<br />
Vive e cresce fra le rovine, ai margini <strong>del</strong>le strade, nei prati.<br />
Uso Alimentare<br />
Decisamente conosciuto e diffuso l'uso alimentare <strong>del</strong>le foglie di questa pianta, crude in insalata o cotte nei<br />
misti di verdure, nelle minestre e nelle zuppe. Trovano anche impiego nella preparazione <strong>del</strong> ripieno dei<br />
ravioli, spesso vengono aggiunte ed ut<strong>il</strong>izzate nell'impasto <strong>del</strong>le polpette.<br />
Uso Cosmetologico<br />
Contiene importanti principi emollienti e lenitivi, grazie a tali proprietà entra nella composizione di una<br />
miriade di prodotti cosmetologici. Le radici presentano proprietà risolventi e ut<strong>il</strong>izzate con impacchi caldi<br />
sul viso, sono efficaci <strong>per</strong> <strong>il</strong> trattamento <strong>del</strong>le foruncolosi. Masticare le radici o frizionarci i denti, favorisce<br />
lo splendore e la salute degli stessi. Infusi di malva aggiunti nell'acqua <strong>del</strong> bagno, possono trovare un<br />
ottimo impiego <strong>per</strong> realizzare immersioni emollienti e r<strong>il</strong>assanti.<br />
Uso Farmacologico<br />
I prodotti contenenti la malva vengono usati contro le infiammazioni <strong>del</strong> cavo orofaringeo, acidità gastrica,<br />
gengiviti e coliti. Queste indicazioni terapeutiche sono dovute al fatto che la pianta svolge una forte azione<br />
antiinfiammatoria su tutte le mucose sulle quali viene applicata. Inoltre svolgendo una decisa azione che<br />
desensib<strong>il</strong>izza le terminazioni nervose, riduce e controlla <strong>il</strong> bruciore che accompagna sempre gli stati<br />
infiammatori in genere.<br />
Tutti i trattamenti farmacologici e sanitari devono sempre essere eseguiti sotto stretto e diretto controllo<br />
medico.<br />
Medicina alternativa e Curiosità<br />
Nel linguaggio dei fiori la malva è <strong>il</strong> simbolo <strong>del</strong>l'Amore materno, <strong>del</strong>la dolcezza e <strong>del</strong>la tran<strong>qui</strong>llità. Non<br />
esistono conferme scientifiche che supportano le indicazioni terapeutiche <strong>del</strong>la malva, rivolte alla cura <strong>del</strong>le<br />
malattie <strong>del</strong>l'apparato urinario e respiratorio, spesso indicate nella medicina popolare. I bambini <strong>del</strong>le<br />
campagne liguri mangiavano i semi che chiamavano"panini", erano morbidi e dolci e le mamme dicevano<br />
che levavano loro le infiammazioni alle gengive. La cultura spagirica ritiene che questa pianta subisca<br />
l'influenza di Venere, amplificando e migliorando tutti gli aspetti collegati alla sfera sessuale direttamente o<br />
indirettamente: in sequenza, <strong>il</strong> desiderio, la fert<strong>il</strong>ità, <strong>il</strong> parto e l'allattamento, ne sarebbero beneficamente<br />
influenzati. In passato la malva era considerata una dei più potenti afrodisiaci, un piccolo contenitore di<br />
stoffa con i semi <strong>del</strong>la pianta, preparato in concomitanza di una complicatissima situazione astrale, veniva<br />
collocato in prossimità dei organi genitali e si era convinti che questo accendesse momenti di libido<br />
incontenib<strong>il</strong>i. Salvo poi trasformarsi dopo qualche secolo in un vegetale da considerarsi eccellente, quale<br />
calmante ad uso anafrodisiaco. Infine nel medioevo, era considerata una pianta test <strong>per</strong> la fert<strong>il</strong>ità o <strong>per</strong><br />
segnalare la verginità, bagnando con l'urina di una fanciulla una piantina di malva ed attendendo gli esiti di<br />
tale applicazione <strong>per</strong> qualche giorno, a seconda che la pianta morisse o meno, si stab<strong>il</strong>iva la fert<strong>il</strong>ità o la<br />
verginità <strong>del</strong>la fanciulla sottoposta al test.
Medicago lupulina<br />
ERBA MEDICA LUPULINA<br />
Erba medica lupulina, Trifoglino selvatico, Erba medica nera, Trifoglio <strong>del</strong> luppolo, Erba medica <strong>del</strong><br />
luppolo.<br />
Forma biologica:T scap (H scap)<br />
Descrizione: Pianta erbacea, annua, talora <strong>per</strong>enne, fusti angolosi, talora lignificati alla base, ramoso<br />
ascendenti, pelosi; altezza 5÷25 cm.<br />
Le foglie sono trifogliate, pelose nella pagina inferiore, glabre in quella su<strong>per</strong>iore, munite di piccioli (quello<br />
centrale più lungo) e stipole lanceolate e un piccolo mucrone, hanno forma ellittica con margine lievemente<br />
dentato nel ½ apicale, e con venature laterali parallele.<br />
I fiori sono riuniti in capolini leggermente ovoidi, portati da peduncoli che partono all’ascella <strong>del</strong>le foglie;<br />
sono di colore giallo, hanno corolla tipicamente pap<strong>il</strong>lionacea. Il calice è corto-peloso con un tubo lungo 0,5<br />
mm.<br />
I frutti sono legumi reniformi (2mm), raggiunta la maturazione <strong>il</strong> colore volge al nero, contengono un solo<br />
seme.<br />
Antesi: Apr<strong>il</strong>e-Luglio ( Non è raro trovare fioriture già a febbraio÷marzo, che si protraggono sino in autunno<br />
inoltrato)<br />
Tipo corologico: Paletemp.<br />
Distribuzione in Italia: Presente in tutto <strong>il</strong> territorio.<br />
Habitat: Ambienti ruderali, incolti aridi, bordi dei campi e scarpate. Da 0 a 1.500 m, talvolta sino a 2.000 m.<br />
Medicago minima (L.) Bartal.che ha legume a spirale e con spine<br />
Trifolium dubium Sibth., che si differenzia <strong>per</strong> non avere foglie mucronate e <strong>per</strong> l'ecologia: Medicago<br />
lupulina si trova in ambienti xerici, mentre Trifolium dubium in prati fert<strong>il</strong>i e campi.<br />
Trifolium campestre Schreber.<br />
Mentre <strong>il</strong> genere Medicago si caratterizza <strong>per</strong> i frutti spiraliformi, Medicago lupulina ha frutti reniformi.<br />
Proprietà ed ut<strong>il</strong>izzi: Pianta antibatterica e lenitiva. Discreta foraggera, è buona mellifera ricercata dalle<br />
api. I semi hanno certo valore <strong>per</strong> gli uccelli ed i roditori.
Medicago sativa<br />
ERBA MEDICA<br />
Famiglia: Leguminosae<br />
Sinonimi:Medicago agropyretorum Vass<strong>il</strong>czenko, Medicago jemenensis Sinskaya, Medicago ladak<br />
Vass<strong>il</strong>czenko, Medicago sogdiana Vass<strong>il</strong>czenko, Medicago tibetana Vass<strong>il</strong>czenko, Medicago transoxana<br />
Vass<strong>il</strong>czenko,<br />
Medicago vera Kirschleger<br />
Nomi volgari: erba medica, erba Spagna, alfa-alfa, luzerne.<br />
Morfologia:<br />
pianta <strong>per</strong>enne, di aspetto erbaceo, fusto ramificato,eretto e ricco di numerosi germogli laterali, dai quali,<br />
dopo <strong>il</strong> taglio, si originano nuovi fusti, rizomatosa. Alta sino a 80 cm.<br />
Le foglie stipolate, sono oblunghe, alterne, trifogliate e con margine denticolato, la foglia mediana,<br />
presenta un breve picciolo. I fiori di colore violetto, nascono riuniti in racemi all’ascella <strong>del</strong>le foglie, sono<br />
pentapetali: i due petali inferiori, più o meno saldati fra loro, formano la carena, ai lati altri due petali e<br />
su<strong>per</strong>iormente <strong>il</strong> <strong>qui</strong>nto petalo, detto stendardo.<br />
I frutti sono legumi spiralati con su<strong>per</strong>ficie reticolata e pubescente, contenenti numerosi semi lucidi.<br />
Distribuzione – habitat – fioritura:<br />
originaria <strong>del</strong>l'Asia occidentale e divenuta cosmopolita, in Italia è molto comune in tutto <strong>il</strong> territorio. Cresce<br />
nei prati aridi, negli incolti, nei luoghi erbosi ,bordo dei campi; fiorisce da apr<strong>il</strong>e a settembre sino a 1.200 m.<br />
Proprietà ed usi:<br />
al contrario degli uomini, i cavalli e gli animali domestici, fin da tempi lontanissimi, si sono cibati di erba<br />
medica giovandosi <strong>del</strong>le sue benefiche proprietà.<br />
Erba dolciastra, astringente, rinfrescante, antiemorragica, diuretica e ricca di minerali, è preziosa <strong>per</strong> <strong>il</strong> suo<br />
alto contenuto in vitamina A, vitamina liposolub<strong>il</strong>e nei grassi, di conseguenza resta sostanzialmente intatta<br />
anche quando viene essiccata, contiene quantità sostenute, di vitamine A, E, C, D, K, B1, B2, alcuni derivati<br />
cumarinici, fosforo, zolfo, calcio, magnesio, ferro e potassio.<br />
In medicina, in quanto ricca di vitamine e minerali, è un rimedio ricostituente e preventivo, stimola<br />
l'appetito, ut<strong>il</strong>e nelle convalescenze, nell'anemia, nelle emorragie e nell'osteoporosi. Previene <strong>il</strong> colesterolo<br />
alto, sembra abbia effetti protettivi verso le malattie degenerative, agisce come tonico generale<br />
rimuovendo tossine dal sangue, favorisce la digestione e rinforza unghie e capelli.<br />
Attenzione l’erba medica contiene anche porfirine, che influenzano la funzione epatica e possono causare<br />
fotosensib<strong>il</strong>izzazione, <strong>qui</strong>ndi cautela.<br />
In cucina le foglie si possono consumare crude o cotte come verdura, mentre i semi vengono fatti<br />
germinare e usati <strong>per</strong> insaporire insalate. Le foglie possono essere usate come <strong>il</strong> tè.
ACETOSELLA DEI BOSCHI<br />
Oxalis acetosella<br />
Acetosella dei boschi, Pane degli angeli, Pancuculo, Trifoglio acetoso.<br />
Forma biologica : G. rhiz. Geofite rizomatose.Piante con un particolare fusto sotterraneo, detto rizoma, che<br />
ogni anno emette radici e fusti avventizi<br />
Descrizione : pianta acaule <strong>per</strong>enne erbacea, eretta, di 5- 15 cm. di altezza, con rizoma squamoso con<br />
scaglie carnose munite di peli.<br />
Le foglie tutte basali, con lungo picciolo, nascenti dal ceppo radicale, sono formate da tre foglioline<br />
obcordate, cuoriformi.<br />
I fiori solitari su peduncoli di 5-10 cm. sono bianchi, di 12-20 mm. di grandezza, con venature di color<br />
malva-l<strong>il</strong>la, raramente rosa ed una macchia basale gialla. La corolla è formata da 5 petali spatolati ed <strong>il</strong><br />
calice è munito di 5 sepali elittici smussati, 10 stami di cui 5 lunghi, e 5 corti.<br />
La pianta produce 2 tipi di infiorescenza, la prima a primavera che dà origine a pochi semi, mentre la<br />
seconda in estate, con peduncoli cortissimi, si autoimpollina e produce la maggior quantità di semi <strong>per</strong> la<br />
riproduzione di piante successive.<br />
Il frutto è una capsula lunga 4-10 mm., che a maturità proietta i semi a distanza.<br />
Antesi : Apr<strong>il</strong>e- giugno.<br />
Tipo corologico : Circumboreale. Zone fredde e tem<strong>per</strong>ate fredde <strong>del</strong>l’Europasiberia e Nord-America.<br />
Distribuzione in Italia :E’ diffusa e spontanea nelle regioni settentrionali e centrali, dalla pianura alla<br />
montagna, nel meridione nelle zone montane, assente nelle zone litoranee e nelle isole.<br />
Habitat :boschi di carpini e faggi, ad essenze miste, su terreni acidi ricchi di humus, su ceppaie marcescenti,<br />
e generalmente su pendii esposti a nord.Pianta molto sensib<strong>il</strong>e alla luce, infatti durante le ore più calde sia i<br />
fiori che le foglie tendono a richiudersi. Per compiere la sua fotosintesi necessita solo di l/10 di luce diurna,<br />
<strong>per</strong> questo motivo vive in luoghi esclusivamente ombrosi ( pianta sciaf<strong>il</strong>a).<br />
Proprietà ed Ut<strong>il</strong>izzi : questa pianta erbacea di piccole dimensioni ha proprietà rinfrescanti, astringenti,<br />
depurative e <strong>per</strong> via esterna ha potere antinfiammatorio e decongestionante. E’ considerata anche pianta<br />
antiscorbutica <strong>per</strong> <strong>il</strong> suo contenuto di vitamina C.Purtroppo è controindicata ai sofferenti di disturbi renali,<br />
epatici ed ai gottosi, <strong>per</strong> <strong>il</strong> suo elevato contenuto di ossalato acido di potassio, che ad elevate dosi, può<br />
causare calcolosi, intossicazioni e gravi lesioni renali. In cucina si impiegavano le foglioline tenere <strong>per</strong> le<br />
insalate miste e salse verdi <strong>per</strong> renderle più gradevoli con quello spiccato sapore acidulo e penetrante,<br />
sempre naturalmente usate con molta parsimonia.
Phytolacca americana<br />
Sinonimi<br />
Phytolacca decandra L.<br />
Tassonomia<br />
Regno: Plantae<br />
Divisione: Magnoliophyta<br />
Classe: Magnoliopsida<br />
Ordine: Caryophyllales<br />
Famiglia: Phytolaccaceae<br />
Nome italiano<br />
Uva turca, Cremesina, Amaranto<br />
UVA TURCA<br />
Descrizione<br />
P. americana è una pianta erbacea <strong>per</strong>enne, con un grosso fittone fusiforme, e con fusto eretto lignificato<br />
alla base, succulento in alto, che si sv<strong>il</strong>uppa in altezza fino a 3,5 m con ramificazioni regolari. Fusto<br />
principale a sezione tetragonale e rami subc<strong>il</strong>indrici (o leggermente tetragonali), lisci, glabri, e di colore che<br />
varia dal verde chiaro ad un rosso violaceo br<strong>il</strong>lante che diviene <strong>il</strong> colore dominante con l’avanzare <strong>del</strong>la<br />
stagione.<br />
Foglie<br />
Grandi foglie alterne, brevemente picciolate (picciolo sott<strong>il</strong>e, lungo 1-2 cm), ovali- (o ellittico-) -lanceolate, a<br />
margine intero o ondulato, apice acuto e spesso mucronato, base cuneata o arrotondata, lunghe fino a 25<br />
cm e larghe fino a 10 cm. Pagina su<strong>per</strong>iore di colore verde chiaro e lucido, che tende ad ingiallire nelle<br />
stazioni più soleggiate, e pagina inferiore opaca con nervatura r<strong>il</strong>evata e, non di rado, arrossata.<br />
Fiori<br />
Riuniti in racemi eretti e lassi, subc<strong>il</strong>indrici, lunghi fino a 15 cm e larghi 2,5-3 cm, inseriti nei fusti in<br />
posizione opposta alle foglie; fiori minuti, ermafroditi, su brevi peduncoli patenti o sub-patenti da biancoverdastri<br />
a rosati a porporini, a seconda <strong>del</strong>lo stadio di sv<strong>il</strong>uppo; <strong>per</strong>ianzio attinomorfo <strong>del</strong> diametro di 6-7<br />
mm formato da 4-5 (6) elementi sepaloidi bianchi, verdastri o rosa, <strong>per</strong>sistenti e riflessi alla maturazione dei<br />
frutti. Stami mediamente 10; ovario su<strong>per</strong>o verdastro costituito da 10 carpelli concresciuti al centro <strong>del</strong><br />
fiore, st<strong>il</strong>i brevi e <strong>per</strong>sistenti.<br />
Frutti<br />
Durante la maturazione dei frutti, i racemi da eretti diventano penduli.
Il frutto immaturo, originato dall’insieme dei carpelli, ha colore verde e forma sim<strong>il</strong>e a quella di una zucca;<br />
sono ancora ben visib<strong>il</strong>i le commessure tra i dieci carpelli originari. Giunto a maturazione, è una bacca<br />
lucida, globosa ± appiattita, con un diametro di 7-8 mm, e di colore porpora molto scuro, quasi nero. Ogni<br />
frutto contiene 10 semi lucidi e neri, di forma lenticolare.<br />
La spremitura <strong>del</strong> frutto produce un succo fortemente colorante in viola.<br />
Periodo di fioritura<br />
Luglio-Ottobre<br />
Territorio di crescita<br />
Originaria <strong>del</strong>le regioni orientali <strong>del</strong> Nordamerica dove cresce spontanea, risulta naturalizzata in tutto <strong>il</strong><br />
territorio italiano.<br />
Habitat<br />
P. americana è pianta ruderale, che cresce di preferenza in terreni incolti, bordi di strade, massicciate<br />
ferroviarie, terrapieni, rive dei corsi d'acqua, in pianura e in collina; pred<strong>il</strong>ige terreni freschi e ricchi di<br />
humus, dal livello <strong>del</strong> mare ai 350 (400) m di quota.<br />
Uso Alimentare<br />
Malgrado la tossicità <strong>del</strong>la pianta è diffuso l'uso alimentare di alcune sue parti. Le foglie si mangiano lessate<br />
come gli spinaci, con l'indicazione di cambiare almeno una volta l'acqua <strong>del</strong>la bollitura e di ut<strong>il</strong>izzare solo<br />
foglie giovani poiché l'effetto tossico aumenta con l'età.<br />
I giovani getti vengono cotti e ut<strong>il</strong>izzati come gli asparagi ed anche molto apprezzati: questo ut<strong>il</strong>izzo<br />
alimentare, diffuso soprattutto nei paesi di cultura anglosassone come gli USA, è comunque da guardare<br />
con diffidenza a causa <strong>del</strong>la tossicità confermata di tutta la pianta. Anche i frutti vengono ut<strong>il</strong>izzati <strong>per</strong> fare<br />
dolci o come colorante alimentare: poiché sono fra le parti più tossiche, sembra saggio astenersi dal loro<br />
consumo.<br />
Uso Cosmetologico<br />
Non si conoscono usi cosmetologici <strong>per</strong> questa specie: alcuni componenti tossici possono fac<strong>il</strong>mente<br />
attraversare la barriera cutanea e, in particolare, la linfa può provocare dermatiti da contatto in soggetti<br />
sensib<strong>il</strong>i.<br />
Uso Farmacologico<br />
Da un punto di vista fisiologico la fitolacca è attiva sulla pelle, sulle strutture ghiandolari, specie <strong>del</strong> cavo<br />
orale, sul sistema sessuale e, con particolare efficacia, sulle ghiandole mammarie. Inoltre è attiva sui tessuti<br />
fibrosi e sierosi e sulle mucose degli apparati digestivo ed urinario.<br />
Esercita attività antinfiammatoria, antivirale, immunostimolante, antitumorale, espettorante, emetica,<br />
catartica, ipnotica, purgativa, antiepatotossica.<br />
Attualmente la ricerca su questa specie si concentra, con speciale interesse, sull'effetto di alcuni<br />
componenti su diverse forme di cancro, come la leucemia e i carcinomi e sulla Sindrome da<br />
Immunodeficienza Ac<strong>qui</strong>sita. In particolare dalla Fitolacca è stata isolata una proteina (PAP) che è<br />
attualmente usata <strong>per</strong> inibire la replicazione <strong>del</strong> virus HIV nelle cellule umane.<br />
Tutti i trattamenti farmacologici e sanitari devono sempre essere eseguiti sotto stretto e diretto controllo<br />
medico.
Plantago lanceolata<br />
LINGUA DI CANE<br />
Famiglia: Plantaginaceae<br />
Sinonimi: Plantago minor L.<br />
Nomi volgari: piantaggine minore, piantaggine femmina, lanciola, petacciola, centonervi, cinquenervi,<br />
lingua di cane, Pio <strong>qui</strong>nto, erba di S.Antonio, erba pitocchina, scontamano, piantana, orecchie di gatto,<br />
orecchie d’asino.<br />
Morfologia:<br />
pianta <strong>per</strong>enne, erbacea, con breve e grosso rizoma, alta sino a 45 cm.<br />
Le foglie in rosetta basale, sono lunghe, diritte, lanceolate, a margine intero o dentato, munite di un breve<br />
picciolo, solitamente glabre. I lembi fogliari sono <strong>per</strong>corsi da 5 nervature principali parallele ben marcate.<br />
All’altezza <strong>del</strong>le foglie basali spuntano scapi fiorali, co<strong>per</strong>ti di peli irti, con 5 striature longitudinali,<br />
terminano con una spiga di fiori ovale o conica.<br />
I fiori si sv<strong>il</strong>uppano all’altezza <strong>del</strong>le brattee membranose brune. Il calice è composto di 2 sepali liberi e di 2<br />
saldati, che sono diritti con una nervatura centrale verde. La corolla è tubolare e in forma di imbuto, divisa<br />
in 4 punte ovali bruno-rosa. I 4 stami dotati di lunghi f<strong>il</strong>etti e di antere gialle oltrepassano la corolla<br />
biancastra.<br />
I frutti sono capsule ovali che contengono più semi..<br />
Distribuzione – habitat – fioritura:<br />
diffusa in quasi tutta Europa, in Italia è pianta molto comune in tutto <strong>il</strong> territorio; vegeta negli orti, nelle<br />
macerie, lungo le strade, nei campi e nei pascoli, fiorisce da apr<strong>il</strong>e a giugno sino a 2.000 m.<br />
Proprietà ed usi:<br />
pianta antibatterica, espettorante, emostatica, astringente, oftalmica, lenitiva, lassativa, emolliente.<br />
I semi contengono sino al 30% di muc<strong>il</strong>lagine che gonfiandosi nell’intestino, agisce da lassativo<br />
decongestionando le mucose irritate, un glucoside, l’anacubina, che stimola la secrezione di acido urico,<br />
sostanze battericide, flavonoidi, tannino, vitamine A C K, pectine. Se ne fanno infusi, succhi, decotti. Se<br />
ingerita in quantità elevata può provocare stitichezza.<br />
Indicata nelle affezioni <strong>del</strong>le vie respiratorie, nella cura <strong>del</strong>le affezioni <strong>del</strong> cavo orale e <strong>del</strong>la gola, nei<br />
disturbi gastrici, in caso di punture d'insetti, in caso di congiuntivite, ulcere, ferite e bruciature.<br />
Questa pianta è ut<strong>il</strong>izzata e coltivata dall’industria farmaceutica <strong>per</strong> preparare sciroppi contro la tosse.<br />
Attenzione: avendo la pianta proprietà emostatiche e coagulanti, è consigliab<strong>il</strong>e consultare <strong>il</strong> medico<br />
prima <strong>del</strong>l’uso.
Portulaca oleracea<br />
PORCELLANA<br />
Famiglia: Portulacaceae<br />
Nomi volgari: porcellana, procacchia, procaccia, sportellacchia.<br />
Morfologia:<br />
pianta annua, di aspetto erbaceo, dotata di fusti prostrato-striscianti, eretti in situazioni di scarsa<br />
<strong>il</strong>luminazione, lisci, carnosi, cavi, spesso rossastri, molto ramificati; alta sino a 30 cm.<br />
Le foglie verde chiaro, carnose e sess<strong>il</strong>i sono alternate spatolate, ovali, glabre, lunghe sino a 3 cm,<br />
vertic<strong>il</strong>late attorno ai fiori.<br />
Fiori piccoli <strong>per</strong> nulla appariscenti, gialli, con 4-6 petali, si aprono <strong>per</strong> poche ore durante <strong>il</strong> mattino,<br />
solamente quando c'è <strong>il</strong> sole, sono solitari o riuniti in gruppetti di 2-5.<br />
I frutti sono capsule membranose contenenti molti semi.<br />
Distribuzione – habitat – fioritura:<br />
originaria <strong>del</strong>l'Eurasia , diffusa in quasi tutte le regioni <strong>del</strong> mondo, in Italia è comune infestante in tutto <strong>il</strong><br />
territorio; cresce senza problemi in qualsiasi terreno, si adatta ai suoli sabbiosi e detritici, infestante <strong>del</strong>le<br />
colture, la si trova fac<strong>il</strong>mente nei campi, nei luoghi incolti, nelle aree antropizzate, soprattutto su suoli<br />
pesanti.<br />
Fiorisce da maggio ad ottobre sino a 1.700 m.<br />
Proprietà ed usi:<br />
erba acida, rinfrescante, antiscorbutica, depurativa, vermifuga, febbrifuga, diuretica, tonica.<br />
In medicina, <strong>per</strong> uso interno, in caso di dissenteria, enterite acuta, emorroidi ed emorragie post-partum.<br />
Per uso esterno in caso di foruncoli, punture d’api ed eczema.<br />
Studi recenti hanno dimostrato come la Portulaca oleracea sia una ricca fonte di acidi grassi omega-3,<br />
probab<strong>il</strong>mente importanti <strong>per</strong> la prevenzione degli attacchi cardiaci e nell’aumento <strong>del</strong>le difese <strong>del</strong> sistema<br />
immunitario.<br />
Già nota agli antichi Egizi, questa pianta compare nella letteratura medica cinese attorno al 500, è oggi<br />
coltivata come verdura in diverse parti <strong>del</strong> mondo, soprattutto in Francia.<br />
In cucina le foglie dal sapore acidulo, crude o cotte, si consumano in insalata e mescolate all’acetosa; sono<br />
ut<strong>il</strong>izzate <strong>per</strong> preparare minestre saporite e rinfrescanti., si possono conservare sottaceto.
Potent<strong>il</strong>la reptans<br />
Erba pecorina, Cinquefoglie comune, Sp<strong>il</strong>labuco.<br />
ERBA PECORINA<br />
Forma biologica: H ros (Emicriptofite rosulate. Piante <strong>per</strong>ennanti <strong>per</strong> mezzo di gemme poste a livello <strong>del</strong><br />
terreno e con foglie disposte in rosetta basale).<br />
Descrizione: Pianta <strong>per</strong>enne, stolonifera, di aspetto erbaceo, strisciante, con grosso rizoma; i fusti, lunghi<br />
40-100 cm, normalmente pubescenti, mettono radici in corrispondenza dei nodi.<br />
Le foglie sono palmate, la lamina è divisa in 5 segmenti, oblungo-ovati, dentati, alla base <strong>del</strong>le foglie sono<br />
presenti 2 stipole.<br />
I fiori solitari, portati da lunghi piccioli eretti all'ascella <strong>del</strong>le foglie <strong>del</strong>la rosetta basale, sono di color giallo<br />
oro, la corolla è composta da 5 petali smarginati all’apice, hanno parecchi pist<strong>il</strong>li elicati.<br />
I frutti sono piccoli acheni.<br />
Antesi: Maggio – Settembre<br />
Tipo corologico: Paleotemp. (Eurasiatiche in senso lato, che ricompaiono anche nel nord-africa), divenuta<br />
sub-cosmopolita (in quasi tutte le zone <strong>del</strong> mondo, ma con lacune importanti: un continente, una zona<br />
climatica).<br />
Distribuzione in Italia: Pianta comune in tutto <strong>il</strong> territorio<br />
Habitat: Vegeta lungo i sentieri, negli incolti, negli ambienti ruderali, nei prati erbosi, nei luoghi umidi sino a<br />
1.600 m.<br />
Proprietà ed usi: Proprietà astringenti, febbrifughe e debolmente antispasmodiche.<br />
In decotto è un buon rimedio contro la dissenteria.<br />
In passato, tutta la pianta godeva fama di antidoto atto a guarire dalle morsicature degli animali velenosi,<br />
al succo venivano attribuite proprietà ut<strong>il</strong>i nella cura <strong>del</strong>le malattie polmonari.
Prunella vulgaris<br />
Labiatae<br />
Prunella comune, Brunella, Morella<br />
Forma biologica: H scap<br />
PRUNELLA COMUNE<br />
Descrizione : Pianta <strong>per</strong>enne, erbacea, strisciante, rizomatosa, i fusti spesso brunastri o violacei sono poco<br />
ramificati co<strong>per</strong>ti di peli radi; raggiunge i 20 cm di altezza.<br />
Le foglie <strong>del</strong>la rosetta basale sono picciolate disposte a 2-6 paia con lamina lanceolata intera o<br />
irregolarmente crenulata, quelle su<strong>per</strong>iori sono sess<strong>il</strong>i, lanceolate e intere, <strong>il</strong> paio estremo si trova subito<br />
sotto l’infiorescenza.<br />
I fiori con corolla blu violetta, raramente bianchi, sono b<strong>il</strong>abiati, caratterizzati da un labbro su<strong>per</strong>iore alto<br />
ed arcuato, sono riuniti a spiga compatta, nascono all’ascella <strong>del</strong>le 2 foglie più elevate; brattee reniformi<br />
lungamente appuntite<br />
I frutti sono poliacheni rotondi.<br />
Antesi: Apr<strong>il</strong>e÷Ottobre<br />
Tipo corologico: Circumbor.<br />
Distribuzione in Italia: Presente in tutto <strong>il</strong> territorio, isole comprese.<br />
Habitat: Prati pascoli, luoghi erbosi da 0÷200 m slm.<br />
Proprietà ed ut<strong>il</strong>izzi: Acido rosmarinico, acido oleanolico, acido betulinico, acido ursolico, triterpenoidi,<br />
flavonoidi, tannini e polisaccaridi.<br />
Pianta antibatterica, antispasmodica, antipiretica, ipotensiva, antisettica, astringente, febbrifuga,<br />
vermifuga, vulneraria, diuretica, stomachica, stitica e tonica.<br />
Per uso interno in caso di emorragie e mestruazioni abbondanti, mal di testa, pressione sanguigna elevata,<br />
mastite e congiuntivite.<br />
Per uso esterno può essere impiegata <strong>per</strong> cicatrizzare e curare piccole lesioni, piaghe, scottature, contusioni.<br />
Come collutorio favorisce la regressione <strong>del</strong>le infiammazioni e <strong>del</strong>le piccole ulcerazioni <strong>del</strong>le mucose <strong>del</strong>la<br />
bocca legate a disordini alimentari.
Ranunculus ficaria<br />
Sinonimi<br />
Ficaria degenii Hervier<br />
Ficaria verna Hudson<br />
Ficaria vulgaris A.St.-H<strong>il</strong>.<br />
Ficaria ranunculoides Roth<br />
Tassonomia<br />
Regno: Plantae<br />
Divisione: Magnoliophyta<br />
Classe: Magnoliopsida<br />
Ordine: Ranunculales<br />
Famiglia: Ranunculaceae<br />
Nome italiano<br />
Favagello, erba fava, erba da emorroidi.<br />
FAVAGELLO<br />
Descrizione<br />
Ranunculus ficaria L. è una pianta erbacea <strong>per</strong>enne, glabra, con radici fascicolate e carnose, biancastre, e<br />
con tuberetti radicali bianco-brunastri (4,5 x 10 mm) a forma di fico oppure di dimensioni maggiori,<br />
oblunghi (lunghezza fino a 3 cm); fusti con asse cavo, prostrato-ascendenti e radicanti ai nodi, che si ergono<br />
solo con scapi uniflori alti fino a un massimo di 30 cm e con diametro max di 5 mm.<br />
Foglie<br />
Le foglie sono picciolate, subcarnose e glabre; picciolo slargato alla base; lamina da ovata a reniforme, con<br />
base sempre cordata, sulla pagina su<strong>per</strong>iore di colore verde intenso e lucido, spesso con maculatura<br />
biancastra fra le nervature principali e/o scuramente brunastre a cavallo <strong>del</strong> nervo mediano (a volte anche<br />
di alcuni nervi laterali), pagina inferiore di un verde più opaco; nervatura radiato-reticolata evidente su<br />
entrambe le pagine; margine da subintero a ondulato, a volte lobato nella porzione basale, apice ottuso.<br />
Foglie radicali con lamina mediamente 5 x 6,5 cm, lungamente (7-11 cm) picciolate; quelle cauline di<br />
dimensioni ridotte (2 x 2,5cm), con picciolo decisamente più breve e portante, generalmente, dei bulb<strong>il</strong>li<br />
all'ascella (che consentono la propagazione agamica <strong>del</strong>la pianta).<br />
Fiori<br />
Caratteristica <strong>del</strong> genere Ranunculus è la disposizione vertic<strong>il</strong>lata degli elementi <strong>per</strong>ianziali (calice e corolla)<br />
e spiralata degli elementi sessuali (stami e carpelli).<br />
Calice generalmente costituito da 3 sepali (raramente 4 o 5) ovati e ± scariosi, di colore verde-biancastro o
verde-giallastro.<br />
Corolla dialipetala con (6)8-11(14) petali da ellittici o obovati a lungamente ovati o oblunghi, di colore giallo<br />
vivo e lucente, alla base dei quali si trova una squama nettarifera di colore dorato. In popolazioni<br />
geograficamente separate si è riscontrata una cospicua differenza nel numero medio di petali (da circa 9 a<br />
circa 11) <strong>per</strong> esemplare, differenza che non sembra <strong>per</strong>ò avere implicazioni sistematiche.<br />
Stami in numero molto elevato, come in tutte le piante <strong>del</strong> genere Ranunculus; antere gialle; gineceo<br />
apocarpico, cioè costituito da numerosi carpelli non saldati tra loro.<br />
Frutti<br />
Poliachenio, ossia infruttescenza costituita da numerosi achenii, in R. ficaria lunghi mediamente 2,5 mm,<br />
pubescenti o irsuti.<br />
Periodo di fioritura<br />
R. ficaria L. fiorisce da gennaio a maggio (con variazioni altitudinali e regionali).<br />
Territorio di crescita<br />
R. ficaria L. è specie spontanea <strong>del</strong>l'Europa, Medio Oriente e Africa settentrionale; presente in tutto <strong>il</strong><br />
territorio italiano, isole comprese, con popolamenti aventi, in qualche caso, <strong>il</strong> carattere di tribù locali.<br />
Habitat<br />
Zone fresche e umide dei prati ai margini dei boschi, o lungo i corsi d'acqua, nei piani basale e montano fino<br />
a 1300 m s.l.m.<br />
Uso alimentare<br />
Questa pianta entra nella lista <strong>del</strong> Ministero <strong>del</strong>la Salute <strong>per</strong> l'impiego non ammesso nel Settore degli<br />
Integratori Alimentari.<br />
Malgrado alcuni dei componenti le conferiscano un variab<strong>il</strong>e grado di tossicità, è considerata commestib<strong>il</strong>e,<br />
anche se soltanto prima <strong>del</strong>la fioritura, durante e dopo la quale si sv<strong>il</strong>uppa la protoanemonina, una<br />
sostanza irritante <strong>per</strong> le mucose e <strong>per</strong> la pelle.<br />
Le foglie giovani possono essere ut<strong>il</strong>izzate fresche, in insalata, o cotte e consumate come gli spinaci. I tuberi<br />
sono nutrienti e possono essere cotti ed usati come contorno vegetale. I boccioli, ancora chiusi, in alcune<br />
culture vengono messi in conserva e ut<strong>il</strong>izzati come i cap<strong>per</strong>i.<br />
E' comunque consigliab<strong>il</strong>e molta cautela nel consumo.<br />
Uso cosmetologico<br />
I componenti attivi rendono questa pianta irritante <strong>per</strong> pelle e mucose e non si conoscono usi cosmetici <strong>per</strong><br />
essa.<br />
Uso Farmacologico<br />
Per uso topico, le saponine presenti esercitano attività antiemorrodale, fungicida e, insieme al tannino,<br />
hanno potere astringente. La protoanemonina presente nella pianta fresca ha proprietà antibatteriche,<br />
rubefacienti, vescicatorie e revulsive.<br />
Tutti i trattamenti farmacologici e sanitari devono sempre essere eseguiti sotto stretto e diretto controllo<br />
medico.<br />
Medicina alternativa e Curiosità<br />
Nel nostro paese questa specie è compresa nell’elenco <strong>del</strong>le piante di esclusiva ut<strong>il</strong>izzazione<br />
medicamentosa, vendib<strong>il</strong>i solo in farmacia.Nella medicina popolare Ranunculus ficaria è stata<br />
tradizionalmente ut<strong>il</strong>izzata nel trattamento topico di ulcere, emorroidi, ragadi anali, e <strong>per</strong> favorire la<br />
guarigione <strong>del</strong>l'episiotomia, dopo <strong>il</strong> parto. Per l'uso interno se ne conoscono ut<strong>il</strong>izzi tradizionali, in varie<br />
culture, come astringente. I petali sono stati ut<strong>il</strong>izzati <strong>per</strong> sbiancare i denti.La presenza di principi tossici<br />
rende consigliab<strong>il</strong>e l'ut<strong>il</strong>izzo terapeutico esclusivamente sotto controllo medico.
Rosa canina<br />
Famiglia: Rosaceae<br />
Nomi volgari: rosa di macchia, rosa selvatica.<br />
ROSA SELVATICA<br />
Morfologia:<br />
arbusto legnoso, con rami pendenti cosparsi di robusti aculei uncinati, raramente dritti.<br />
In ambiente a<strong>per</strong>to si tratta di un arbusto tondeggiante alto 1-3 m, con ampia ramificazione, negli arbusteti,<br />
invece, è poco ramificato e tende ad arrampicarsi sugli arbusti circostanti. Pianta eliof<strong>il</strong>a che radica in<br />
profondità<br />
Le foglie alterne con alla base 2 stipole lanceolate, sono divide in 5-7 foglioline ovali o ovato ellittiche,<br />
appuntite, generalmente glabre o lievemente pubescenti, dentellate ai margini.<br />
I fiori peduncolati, solitari o in gruppi di 2-3 , profumati, hanno 5 petali bianchi o rosati, i sepali sono<br />
concrescenti e formano un ricettacolo sim<strong>il</strong>e a una coppa chiusa che contiene molti ovari. A maturità<br />
questo ricettacolo, divenuto rosso vivo, si trasforma in frutto, <strong>il</strong> cinorrodio.<br />
I frutti sono piriformi, contengono moltissimi acheni durissimi e rico<strong>per</strong>ti di corti peli rigidi.<br />
Distribuzione – habitat – fioritura:<br />
diffusa in gran parte <strong>del</strong>l’Europa, a nord fino alla Scandinavia meridionale, in Italia e è frequente nelle sue<br />
diverse forme e varietà, in tutto <strong>il</strong> territorio; nelle radure e, in qualità di arbusto pioniero, nei prati, pascoli,<br />
campi e vigneti abbandonati. Su suoli abbastanza profondi, limosi, moderatamente aridi.<br />
Fiorisce da maggio a luglio sino a 1.600 m, fruttifica tra settembre e ottobre.<br />
Proprietà ed usi:<br />
i frutti sono ricchi di vitamina C, acidi organici, tannini, pectine carotenoidi e soprattutto bioflavonoidi,<br />
pigmenti naturali dall´importante azione antiossidante.<br />
La vitamina C è sinergica con i bioflavonoidi, aiuta la cicatrizzazione di ferite, ustioni, gengive sanguinanti,<br />
abbassa l’ incidenza dei coaguli sanguigni, previene le infezioni virali e batteriche.<br />
Pianta antinfiammatoria, antiallergica, astringente, blandamente diuretica, cicatrizzante, antisettica,<br />
vasoprotettrice.<br />
In medicina <strong>per</strong> uso interno: in caso di raffreddori, influenza, gastrite e diarrea.<br />
I frutti si usano <strong>per</strong> preparare sciroppo, impiegato come integratore alimentare, in particolare nella dieta<br />
dei neonati e usato dall’industria farmaceutica come aromatizzante <strong>del</strong>le medicine. Gli estratti dei frutti si<br />
aggiungono alle pastiglie di Vitamina C.<br />
I petali sono ut<strong>il</strong>i <strong>per</strong> combattere la diarrea, <strong>il</strong> mal di gola se spremuti, possono essere usati <strong>per</strong> preparare<br />
un buon collirio.<br />
Alcuni impiegano le foglie e i boccioli come blando lassativo e cicatrizzante; le galle ricche di tannino hanno<br />
proprietà astringenti e toniche.
Uso cosmetico: la maschera di bellezza ottenuta omogeneizzando con frullatore i "frutti" freschi (tagliati,<br />
svuotati con cura e lavati più volte <strong>per</strong> eliminare i piccoli peli aguzzi che possono conficcarsi nella pelle) è<br />
una <strong>del</strong>le più efficaci <strong>per</strong> <strong>il</strong> suo effetto schiarente, levigante e tonificante <strong>del</strong>la pelle.<br />
In cucina: i frutti raccolti dopo la prima gelata, sono ottimi <strong>per</strong> preparare conserve e marmellate. Seccati e<br />
macerati in acquavite e zucchero danno un ottimo liquore; seccati e tritati si possono usare <strong>per</strong> fare tè e<br />
seccati e ridotti in farina sono stati ut<strong>il</strong>izzati anticamente <strong>per</strong> fare una specie di pane.<br />
Una rosa lasciata riposare <strong>per</strong> una settimana nella grappa, conferirà alla stessa un colore rosato ed un<br />
aroma <strong>del</strong>icato, molto indicata nella grappa di moscato.<br />
Gli steli <strong>del</strong>la Rosa canina costituiscono i portainnesti ideali <strong>per</strong> le rose coltivate.<br />
Curiosità:<br />
narra la leggenda, che se oggi possiamo ammirare la bellezza <strong>del</strong>la rosa, lo dobbiamo al dio <strong>del</strong> vino Bacco<br />
che , invaghitosi di una ninfa, tentò di con<strong>qui</strong>starla, ma lei fuggì finché non inciampò in un cespuglio.<br />
Cespuglio che <strong>per</strong> riconoscenza Bacco trasformò in rosa, facendogli spuntare splendidi fiori di un <strong>del</strong>icato<br />
color rosato, <strong>il</strong> colore <strong>del</strong>le guance <strong>del</strong>la sua ninfa.<br />
Lasciando la mitologia <strong>per</strong> la scienza, apprendiamo che la rosa è nata in realtà più di quaranta m<strong>il</strong>ioni di<br />
anni fa, datano a quel tempo i re<strong>per</strong>ti foss<strong>il</strong>i di questo fiore ritrovati nel Colorado e nell´Oregon.<br />
Le rose erano già importanti nell’antichità dove venivano ut<strong>il</strong>izzate nei rituali, nella fabbricazione di<br />
cosmetici, in profumeria e in campo medico.<br />
Fu la poetessa greca Saffo (IV secolo a.C.) a definire la rosa “regina dei fiori”<br />
Gli Assiri, pare, furono i primi a scoprirne le virtù. In età romana si usavano i petali di rosa <strong>per</strong> fare "<strong>il</strong> piatto<br />
di rose con cervella, uova, vino e salsa di pesce".<br />
Greci Romani e Persiani impiegavano diverse specie di rose a scopo terapeutico, nel 77 d.C. Plinio citava<br />
ben 32 disturbi che potevano essere curati con preparati a base di rose.<br />
La famosa acqua di rose, venne inventata da Avicenna, un celebre medico <strong>per</strong>siano, tra <strong>il</strong> IX e <strong>il</strong> X secolo.<br />
Gli alchimisti <strong>per</strong>siani <strong>del</strong> XVI secolo producevano un essenza su<strong>per</strong>iore <strong>per</strong> dist<strong>il</strong>lazione. L’essenza è un<br />
prodotto costosissimo, se si considera che <strong>per</strong> produrre 300 grammi di olio serve circa una tonnellata di<br />
petali, <strong>per</strong> questo motivo oggi viene largamente sintetizzata.<br />
Circa <strong>il</strong> 96% dei profumi femmin<strong>il</strong>i e <strong>il</strong> 46% di quelli masch<strong>il</strong>i contengono essenza di rosa.<br />
La rosa canina ha avuto un ruolo importante nella fornitura di vitamina C ai bambini britannici durante la<br />
seconda guerra mondiale (i suoi frutti erano detti “arance <strong>del</strong> nord”), in sostituzione <strong>del</strong>la fonte normale<br />
degli agrumi (allora diffic<strong>il</strong>i da re<strong>per</strong>ire).<br />
Nel linguaggio dei fiori alla rosa si attribuisce un duplice significato: <strong>del</strong>icatezza e piacere, ma anche<br />
sofferenza e dolore fisico.
Rumex acetosa<br />
Romice, Acetosa, Erba brusca, Soleggiola, Ossalida.<br />
ROMICE<br />
Descrizione: Pianta <strong>per</strong>enne, erbacea, con sott<strong>il</strong>e rizoma orizzontale, fusti eretti, scanalati, arrossati in<br />
basso, fogliosi fin sotto l’infiorescenza, ramosi all'infiorescenza.. Altezza 40-110 cm.<br />
Le foglie basali picciolate, picciolo 1,5 volte la lamina che è larga 2-3x5-7 cm, ovvero 2-3 volte più lunga che<br />
larga, strette, con base astata; le cauline su<strong>per</strong>iormente sess<strong>il</strong>i, con lobi divergenti, acuti o arrotondati,<br />
diretti verso <strong>il</strong> basso ma non amplessicauli.<br />
L’infiorescenza è compatta, costituita da piccoli fiori dal <strong>per</strong>ianzio verde formato da 6 elementi di cui i 4<br />
esterni rotondo-ovoidali, con escrescenze dure, rotonde o tetragonali. I sepali interni si arrotolano al<br />
momento <strong>del</strong>la fruttificazione.<br />
I futti sono acheni neri e lucenti, protetti da tepali <strong>per</strong>sistenti che assumono colore rosso ruggine.<br />
Antesi: Maggio – Agosto<br />
Tipo corologico: Circumbor. (Zone fredde e tem<strong>per</strong>ato-fredde <strong>del</strong>l'Europa, Asia e Nordamerica).<br />
Distribuzione in Italia: Comune in tutto <strong>il</strong> territorio.<br />
Habitat: Prati fert<strong>il</strong>i e concimati, lungo i fossati e nei pascoli, pred<strong>il</strong>ige terreno arg<strong>il</strong>loso e ricco. Diffusione<br />
altitudinale da 0 a 1.800 m.<br />
Proprietà ed ut<strong>il</strong>izzi: Erba acida, antiscorbutica, astringente, rinfrescante, depurativa, diuretica, lassativa.<br />
La pianta contiene vitamina C, ossalato di potassio e acido ossalico, ferro.<br />
La maggior parte <strong>del</strong>le specie di Rumex, contiene ossalati sim<strong>il</strong>i a quelli <strong>del</strong>lo spinacio e <strong>del</strong> rabarbaro,<br />
queste sostanze in eccesso sono velenose. Qundo si trova nel foraggio fresco, in dosi eccessive, può causare<br />
distrubi digestivi, specialmente ai cavalli e alle pecore.<br />
In passato i bimbi che abitavano in campagna, staccavano le cime <strong>del</strong> Romice <strong>per</strong> masticarle e <strong>per</strong> gustarne<br />
<strong>il</strong> succo leggermente acidulo. Dalle mie parti, nella bergamasca, veniva chiamata “erba cicia”, proprio a<br />
indicare questa abitudine.<br />
Impiegata, grazie alle proprietà depurative e drenanti, nella cura <strong>del</strong>le malattie cutanee, quali l'acne, le pelli<br />
grasse e le punture degli insetti, in caso di eccessiva sudorazione e alitosi.<br />
Le foglie fresche, sminuzzate e applicate sul viso, hanno effetto astringente sui pori d<strong>il</strong>atati.<br />
In cucina le foglie giovani e fresche, possono essere impiegate <strong>per</strong> insaporire insalate, salse, minestre,<br />
formaggi molli, frittate.
Rumex crispus<br />
( Lapathum crispum Scopoli)<br />
Romice crespo, Lapazio<br />
ROMICE CRESPO<br />
Descrizione: Pianta erbacea <strong>per</strong>enne, glabra, con radice fittonante, fusto c<strong>il</strong>indrico, striato, eretto, spesso<br />
soffuso di rosso-bruno, ramoso alla sommità. Altezza sino a 120 cm.<br />
Le foglie inferiori hanno lungo picciolo amplessicaule, lamina oblungo-lanceolata ondulata con margine<br />
crespo, quelle inserite sul fusto, sono alterne con picciolo ridotto sott<strong>il</strong>i ovali ed appuntite. I piccioli sono<br />
scanalati, sovente lievemente arrotolati sulla pagina inferiore <strong>del</strong>le foglie, dove formano una guaina<br />
membranosa.<br />
I fiori riuniti in vertic<strong>il</strong>li all’ascella <strong>del</strong>le foglie su<strong>per</strong>iori, formano dense infiorescenze verdastre.<br />
Hanno <strong>per</strong>igonio erbaceo <strong>per</strong>sistente diviso in 6 lacinie.<br />
I frutti sono piccoli acheni cuoriformi, rico<strong>per</strong>titi dalle valve membranose <strong>del</strong> <strong>per</strong>ianzio.<br />
Antesi: Maggio-Luglio<br />
Tipo corologico: Subcosmop<br />
Distribuzione in Italia: Presente in tutto <strong>il</strong> territorio.<br />
Habitat: Terreni umidi e arg<strong>il</strong>losi, nei prati e ai margini <strong>del</strong>le strade, ruderi, da 0 a 1.500 m.<br />
Proprietà ed ut<strong>il</strong>izzi: Erba amara, astringente, depurativa, rinfrescante, antianemica.<br />
Impiegata in caso d<strong>il</strong>aringite,tosse secca e mal di gola.<br />
La sua radice, molto ricca di ferro, è ut<strong>il</strong>izzata come antianemico, tonico-ricostituente, astringente.<br />
Per uso esterno, cataplasmi di foglie possono essere impiegati in presenza di dermatiti, affezioni cutanee,<br />
foruncoli.<br />
Le giovani foglie possono essere usate nelle minestre, oppure miste ad altre erbe cucinate lesse.<br />
Curiosità: Rumex crispus L. in America, è fra le poche piante che naturalizzate dall’Europa, sono state<br />
adottate da alcune tribù indiane e ut<strong>il</strong>izzate insieme ad altre specie native d Rumex, in particolare i teton<br />
dakota applicavano le foglie verdi tritate ai foruncoli <strong>per</strong> promuoverne <strong>il</strong> processo suppurativo. Le radici<br />
contenenti tannino erano invece ut<strong>il</strong>izzate dai flambeau ojibwa <strong>per</strong> favorire la cicatrizzazione e la chiusura<br />
dei tagli.
Saponaria officinalis<br />
SAPONARIA<br />
Famiglia: Caryophyllaceae<br />
Nomi volgari: saponaria, saponella, garofano a mazzetti, condizi, gelsomino matto, savonea.<br />
Etimologia: <strong>il</strong> nome <strong>del</strong> genere driva dal latino”sapo” = “sapone e si riferisce all’alto contenuto di saponine<br />
di queste piante, che fanno schiuma come <strong>il</strong> sapone.<br />
Morfologia:<br />
pianta <strong>per</strong>enne, di aspetto erbaceo, provvista di rizoma strisciante, ramificato di colore bruno rossastro;<br />
fusti eretti o ascendenti, glabri o leggermente pubescenti, talvolta legnosi alla base. Alta sino a 1 m.<br />
Gli steli ster<strong>il</strong>i o semplici hanno foglie opposte, ovali, oblunghe e ricurve. Le inferiori brevemente picciolate<br />
, le su<strong>per</strong>iori sess<strong>il</strong>i e opposte ai nodi, rico<strong>per</strong>te di peli corti o glabre, rugose sugli orli, con 3 nervature<br />
r<strong>il</strong>evate.<br />
I fiori di colore rosa più o meno intenso, con 5 petali appena smarginati , calice violaceo, tubuloso e<br />
pubescente, sono riuniti in cime compatte alla sommità degli steli. Emanano un <strong>del</strong>icato profumo,<br />
soprattutto verso sera.<br />
I frutti sono capsule oblungo-piriformi che contengono numerosi semi neri.<br />
Distribuzione – habitat – fioritura:<br />
propria <strong>del</strong>le zone eurosiberiane, diffusa in tutta l’Europa continentale, in Italia è molto comune ama i<br />
terreni freschi e umidi: le rive dei corsi d’acqua, gli ambienti ruderali, campi e aree antropizzate.<br />
Fiorisce da giugno ad agosto sino a 1.000 m.<br />
Proprietà ed usi:<br />
conosciuta sin dall’antichità, oltre che saponina, un glucoside tossico, contiene resina e vitamina C.<br />
Usare con prudenza e solo dietro prescrizione medica.<br />
Le sue proprietà sono principalmente depurative, diuretiche, espettoranti, sudorifere e toniche.<br />
In medicina <strong>per</strong> uso interno in caso di gotta e dermatiti, congestioni bronchiali e ittero.<br />
Oggi è usata raramente <strong>per</strong> <strong>il</strong> suo effetto irritante sull’apparato digerente. In eccesso distrugge i globuli<br />
rossi, provoca paralisi dei centri vasomotori.<br />
Per uso esterno <strong>il</strong> decotto è ut<strong>il</strong>e in caso di dermatiti e <strong>per</strong> pelle colpita da acne o da psoriasi.<br />
Sebbene talvolta venga consigliata come shampoo, può causare gravi irritazioni agli occhi.<br />
La radice e le foglie essiccate venivano impiegate, prima che fosse avviata la produzione commerciale <strong>del</strong><br />
sapone, intorno ai primi <strong>del</strong>l’Ottocento, come detergente <strong>per</strong> lavare capi <strong>del</strong>icati.<br />
Un decotto di saponaria, ottenuto facendo bollire le diverse parti <strong>del</strong>la pianta in acqua piovana è <strong>il</strong> rimedio<br />
ideale <strong>per</strong> ridare splendore a pizzi, ricami, tessuti in seta e f<strong>il</strong>ati, tessuti antichi i cui colori siano stati<br />
offuscati dalla polvere e dal tempo.
S<strong>il</strong>ene alba<br />
SILENE BIANCA<br />
Famiglia: Caryophyllaceae<br />
Sinonimi: Lychnis alba M<strong>il</strong>ler, Melandryum pratense Roehling, Melandryum album Garcke, Melandryum<br />
ves<strong>per</strong>tinum Fries.<br />
Nomi volgari: s<strong>il</strong>ene bianca, orecchiella, orecchietta, boccon di pecora.<br />
Etimologia: <strong>il</strong> nome <strong>del</strong> genere deriva da S<strong>il</strong>eno, accompagnatore ebbro di Bacco, dal ventre rigonfio come<br />
<strong>il</strong> calice di queste piante, <strong>il</strong> nome specifico indica <strong>il</strong> colore <strong>del</strong> fiore.<br />
Morfologia:<br />
pianta <strong>per</strong>enne, di aspetto erbaceo, ascendente, fusto ramificato, viscoso-glanduloso; alta fino a 80 cm.<br />
Le foglie lanceolate, opposte, lungamente v<strong>il</strong>lose sono spesso accompagnate da un fascetto di foglie più<br />
piccole.<br />
Specie dioica con fiori solitari che si aprono la sera, impollinati da farfalle crepuscolari; hanno calice<br />
rigonfio, tubuloso, bruno-rossastro, peloso e 5 petali bianchi, b<strong>il</strong>obati.<br />
I frutti sono capsule piriformi, deiscenti, con molti semi.<br />
Distribuzione – habitat – fioritura:<br />
pianta di provenienza eurasiatica, in Italia è comune in tutto <strong>il</strong> territorio, la si può trovare nei coltivi, sui<br />
detriti, negli incolti ai margini <strong>del</strong>le strade e aree antropizzate. Ama <strong>il</strong> caldo e i terreni ricchi di sostanze<br />
azotate. Fiorisce da maggio a ottobre sino a 1.300 m.<br />
Proprietà ed usi:<br />
con le giovani foglie si possono preparare ottime zuppe, oppure si possono consumare bollite e saltate in<br />
pa<strong>del</strong>la.<br />
L’intera pianta viene ut<strong>il</strong>izzata nella preparazione <strong>del</strong>la “minestrella” , zuppa antica e poverissima composta<br />
da 27 erbe che viene solitamente accompagnata da focaccette di granoturco.
Solanum nigrum<br />
ERBA MORELLA<br />
Famiglia: Solanaceae<br />
Sinonimi: Solanum vulgatum W<strong>il</strong>ld., Solanum vulgare Park., Solanum hortense Dod. Ger., Solanum Morella<br />
Desvaux.<br />
Nomi volgari: erba morella, morella comune, pomidorella, ballerina, erba puzza, iritrigno, uva lupina,<br />
sondra, solatro ortolano, cerasella selvaggia.<br />
Morfologia:<br />
pianta erbacea annuale o <strong>per</strong>enne, con radice a fittone, ha fusti eretti o coricati, con due striature<br />
longitudinali, glabri o scarsamente pelosi, angolosi e ramificati, alta sino a 80 cm.<br />
Le foglie sono alterne, ovali, intere o marginate, con denti radi.<br />
I piccoli fiori sono riuniti in cime lasse all’ascella <strong>del</strong>le foglie, hanno calice conico, corolla a 5 petali appuntiti<br />
di colore bianco con antere gialle riunite a cono.<br />
I frutti sono bacche globose, prima verdi, poi nere, piene di minuscoli semi.<br />
Distribuzione – habitat – fioritura:<br />
diffusa in tutta Europa, in Italia è molto comune in tutto <strong>il</strong> territorio, vegeta negli ambienti ruderali e<br />
antropizzati, è infestante <strong>del</strong>le coltivazioni di bietola e di mais, fiorisce da marzo a novembre sino a 900 m.<br />
Proprietà ed usi:<br />
pianta velenosa <strong>per</strong> <strong>il</strong> suo contenuto di solanina un alcaloide tossico che attacca i globuli rossi, ha<br />
comunque proprietà antispasmodiche, analgesiche, narcotico-sedative, emollienti, febbrifughe, diuretiche<br />
e purganti, se ne sconsiglia l’uso in automedicazione, le preparazioni potrebbero risultare nocive.<br />
Nel passato, la medicina popolare, consigliava l’uso <strong>del</strong>le foglie schiacciate come rimedio <strong>per</strong> le bruciature e<br />
<strong>per</strong> i foruncoli.<br />
Note:<br />
alla famiglia <strong>del</strong>le Solanaceae appartengono molte specie economicamente importanti, alcune originarie<br />
<strong>del</strong>le Americhe, come la melanzana (Solanum melongenum), la patata (Solanum tuberosum), <strong>il</strong> pe<strong>per</strong>one<br />
(Capsicum annuum), <strong>il</strong> tabacco (Nicotiana tabacum), <strong>il</strong> pomodoro (Lyco<strong>per</strong>sicon esculentum). Altre specie<br />
sono coltivate a scopo ornamentale, ad esempio diverse cultivar <strong>del</strong> genere Petunia e la Solanum<br />
dulcamara variegatum, quest’ultima un bel rampicante dalle bacche rosse.<br />
Specie sim<strong>il</strong>e è la Solanum luteum che si differenzia <strong>per</strong> i frutti di colore rosso-arancio.
Stachys sylvatica<br />
Stregona dei boschi, Matricale<br />
STREGONA DEI BOSCHI<br />
Forma biologica: H scap (Emicriptofite scapose. Piante <strong>per</strong>ennanti <strong>per</strong> mezzo di gemme poste a livello <strong>del</strong><br />
suolo e con asse fiorale allungato, spesso privo di foglie).<br />
Descrizione: Pianta erbacea, <strong>per</strong>enne, dall’odore sgradevole; fusti pelosi, ramosi in alto a sezione<br />
quadrata, altezza sino a 60 cm.<br />
Le foglie sono picciolate, vellutate, opposte, con lamina ovale e bordi dentati. Le su<strong>per</strong>iori, che portano le<br />
infiorescenze sono più sott<strong>il</strong>i e con picciolo più breve.<br />
I fiori, sono disposti in glomeruli vertic<strong>il</strong>lati di 3-6 fiori, all’ascella <strong>del</strong>le foglie su<strong>per</strong>iori. Calice vellutato e<br />
glanduloso a 5 denti. Corolla, b<strong>il</strong>abiata, purpurea, pubescente esternamente, <strong>il</strong> labbro inferiore è tr<strong>il</strong>obato e<br />
striato di bianco.<br />
I frutti sono acheni.<br />
Antesi: Giugno – Agosto<br />
Tipo corologico: Eurosiber.<br />
Distribuzione in Italia: Presente in tutto <strong>il</strong> territorio<br />
Habitat: Boschi di latifoglie, luoghi erbosi, terreno umido, zone ombrose da 0 a 1.700 m.<br />
Proprietà ed ut<strong>il</strong>izzi: Pianta emmenagoga, diuretica, stiptica, tonica.<br />
Dai fusti è possib<strong>il</strong>e ricavare una fibra dura.<br />
Come la Stachys officinalis era, nel passato, considerata un toccasana <strong>per</strong> molte malattie. Veniva coltivata<br />
negli orti dei monasteri. Era inoltre diffusa la convinzione che tenesse lontani i serpenti.
TRIFOGLIO CAMPESTRE<br />
Trifolium campestre<br />
(Trifolium procumbens L.; T.rifolium agrarium Auct Fl. Ital.non L.; Mel<strong>il</strong>otus agraria Desfontaines )<br />
Trifoglio campestre.<br />
Forma biologica: T. scap -Terofita scaposa. (Piante annue con asse fiorale allungato, spesso privo di foglie).<br />
Descrizione: Pianta erbacea, annua con fusti es<strong>il</strong>i, eretti o ascendenti, talvolta ramificati alla base,<br />
pubescenti, portanti 1-2 capolini. Altezza 5-20 cm.<br />
Le foglie con 2 stipole lanceolate, sono alterne, trifogliate, ellittiche, brevemente picciolate le laterali, la<br />
mediana ha picciolo più lungo, <strong>il</strong> margine su<strong>per</strong>iore lievemente dentellato.<br />
Inflorescenze in piccoli capolini ovati, portati da peduncoli ascellari, sono costituiti da 20-30 fiori, calice con<br />
5 denti, i due su<strong>per</strong>iori piú lunghi, gli altri tre piú brevi, corolla prima gialla, dopo l’antesi, bruno rossiccia.<br />
I frutti sono piccoli legumi.<br />
Antesi: Apr<strong>il</strong>e – Agosto<br />
Tipo corologico: W-Paleotemp.<br />
Distribuzione in Italia: Comune in tutto <strong>il</strong> territorio.<br />
Habitat: Presente al bordo dei campi, mei sentieri, negli incolti aridi da 0 a 800 m.<br />
Note di sitermatica: Sono descritte 2 varietà<br />
Proprietà ed ut<strong>il</strong>izzi: Pianta diuretica e buona mellifera.
Trifolium repens<br />
TRIFOGLIO BIANCO<br />
Famiglia: Leguminosae<br />
Nomi volgari: Trifoglio bianco, Trifoglio ladino, Trifoglio rampiacante.<br />
Etimologia: <strong>il</strong> nome <strong>del</strong> genere deriva dal latino “tri” = “tre” e “folium” = “foglia”, con riferimento alle foglie<br />
ternate.<br />
Morfologia:<br />
pianta bi-triennale in condizioni non umide, mentre è <strong>per</strong>enne nelle zone irrigue-umide <strong>del</strong>la Lombardia di<br />
aspetto erbaceo, con rizomi riccamente ramificati, fusti striscianti, stoloniferi, solo in alcuni casi cespugliosi,<br />
e sovente violacei, ascendenti nella parte su<strong>per</strong>iore e talvolta rico<strong>per</strong>ti di corti peli. Non su<strong>per</strong>a mai i 30 cm<br />
di altezza e forma vasti tappeti nei prati; è fac<strong>il</strong>mente distinguib<strong>il</strong>e dagli altri trifogli <strong>per</strong> le foglie spesso<br />
vagamente chiazzate di bianco.<br />
Le foglie alterne, sono trifogliate con lunghi piccioli e grandi stipule terrestri membranose. Le stipule sono<br />
saldate alla base e appuntite all’estremità. Le foglioline sono sess<strong>il</strong>i, larghe ovali, finemente dentate, di<br />
colore verde con una chiazza bianca.<br />
I fiori sono capolini globosi, solitari, bianchi, verdastri o rosa, composti da 40-80 elementi all’apice di<br />
peduncoli eretti, più alti <strong>del</strong>le foglie. Dopo la fioritura i fiori diventano penduli e bruni.Il calice campanulato,<br />
<strong>per</strong>corso da 10 nervature è diviso in 5 denti appuntiti (2 lunghi e 3 corti). La corolla simmetrica racchiude 10<br />
stami, di cui 9 saldati da f<strong>il</strong>etti.<br />
I frutti sono legumi, lineari, appiattiti, con 3-4 semi cuoriformi, di colore variab<strong>il</strong>e giallo, arancio e rosso che<br />
rimangono nel calice disseccato.<br />
Distribuzione – habitat – fioritura:<br />
specie paleotem<strong>per</strong>ata, divenuta subcosmopolita, in Italia è molto comune lungo le strade campestri, al<br />
margine dei boschi, nei prati, in qualsiasi tipo di terreno tranne in quelli troppo compatti o, all'opposto,<br />
troppo sabbiosi. In montagna si spinge fino a 2.000 metri fiorisce da apr<strong>il</strong>e a ottobre.<br />
Proprietà ed usi:<br />
pianta antireumatica, depurativa, oftalmica, detergente, tonica.<br />
Indicata <strong>per</strong> i distrurbi <strong>del</strong>la digestione e le diarree ostinate, le infiammazioni <strong>del</strong>le vie respiratorie, i<br />
reumatismi; <strong>per</strong> uso esterno, è antisettico.<br />
Unito alle graminacee rappresenta un ottimo foraggio e a questo scopo è anche seminato, si estende con<br />
grande rapidità, migliora i pascoli magri. Fornisce 5-8 sfalci di ottima qualità che, normalmente, sono<br />
ut<strong>il</strong>izzati come foraggio verde.<br />
I fiori possono essere ut<strong>il</strong>izzati in frittata , uniti alle foglioline possono essere ut<strong>il</strong>izzati come ingredienti <strong>per</strong><br />
una bevanda tipo “sangr<strong>il</strong>la”.<br />
In una brocca spremere <strong>il</strong> succo di un'arancia e tagliare la buccia in piccoli pezzi (solo la parte colorata),
aggiungere una bottiglia di vino rosso secco e una bottiglia di vino bianco secco. Unire 5 o 6 manciate di<br />
fiori di trifoglio e foglie tenere, mescolare accuratamente. Lasciare a riposare in frigorifero avendo<br />
l’accortezza di coprire <strong>il</strong> recipiente, <strong>per</strong> un paio di giorni, mescolando una volta al giorno. F<strong>il</strong>trare <strong>il</strong> li<strong>qui</strong>do e<br />
aggiungere una pesca matura, ma soda tagliata a pezzetti e circa 100 grammi di zucchero di canna e<br />
mescolare bene. Servire freddissimo.<br />
Nel passato, durante <strong>per</strong>iodi di carestia, i capolini secchi venivano raccolti <strong>per</strong> essere macinati, integrando<br />
in questo modo la farina.<br />
Come tutte le specie appartenenti al genere Trifolium rappresenta un'ottima fonte sia di nettare che di<br />
polline <strong>per</strong> le api, anche se la riduzione <strong>del</strong>la coltivazione con <strong>il</strong> sistema <strong>del</strong>le "marcite" lombarde ha ridotto<br />
notevolmente la produzione di miele allo stato uniflorale.<br />
Curiosità:<br />
dalla "Flora <strong>del</strong>l'apicoltore lombardo", pubblicata sulla rivista "L'Apicoltore" nell'anno 1873.<br />
"Fra le moltissime specie di trifoglio l'apicoltore deve conoscerne tre che tanto <strong>per</strong> la loro diffusione, come<br />
<strong>per</strong> la quantità di miele che somministrano riescono d'una importanza non comune. Le tre specie sono: <strong>il</strong><br />
Trifoglio pratense, o di Lombardia, o di Stiria, <strong>il</strong> Trifoglione, o incarnato, ed <strong>il</strong> Trifoglio ladino, o cavallino, o<br />
domestico.<br />
Alcuni apicoltori dissero che le api non raccolgono miele sul Trifoglio incarnato in causa <strong>del</strong>la profondità <strong>del</strong><br />
calice, anzi alcuni vorrebbero che l'ape italiana <strong>per</strong> avere una lingua più allungab<strong>il</strong>e <strong>del</strong>la tedesca <strong>per</strong><br />
raccogliere miele da codesto fiore mentre l'ape tedesca non lo può.<br />
In ogni modo l'importanza di codesto Trifoglio è molto minore <strong>del</strong>le altre due, e specialmente <strong>del</strong> Trifoglio<br />
ladino che dà ottimo e abbondante miele.<br />
Note:<br />
<strong>il</strong> genere venne istituito da Linneo, ad esso attualmente, si attribuiscono circa trecento specie distribuite<br />
essenzialmente nelle regioni tem<strong>per</strong>ate e subtropicali <strong>del</strong>l'emisfero nord; poche specie vivono spontanee<br />
sulle Ande e nell'Africa meridionale.<br />
La flora spontanea <strong>del</strong>l'Italia è ricca di specie di Trifolium; <strong>il</strong> Fiori ne indica una sessantina; <strong>il</strong> Fenaroli, nella<br />
descrizione <strong>del</strong>la flora <strong>del</strong>le Alpi, una dozzina, alcune localizzate in forme endemiche nelle zone più alte<br />
<strong>del</strong>le Alpi e degli Appennini. Piante annuali o <strong>per</strong>enni, a foglie composte da 3 foglioline,raramente 5-7.<br />
Alcune specie di trifoglio producono acido cianidrico,letale <strong>per</strong> <strong>il</strong> bestiame, quando crescono in determinate<br />
condizioni ambientali.<br />
Nella specie T. repens si distinguono tipi diversi:<br />
- var. sylvestre o selvatica a foglie piccole, comprende le forme che entrano come componenti naturali dei<br />
prati e dei pascoli e che si sono selezionate a seconda <strong>del</strong>la forma di ut<strong>il</strong>izzazione. Sono forme <strong>per</strong>enni, con<br />
elevata capacità di radicamento, in grado di colonizzare velocemente <strong>il</strong> suolo. Le dimensioni degli organi<br />
vegetativi e riproduttivi sono ridotte.<br />
- var. hollandicum o comune a foglie medie, poco diffusa in Italia.<br />
- var. giganteum, o ladino a foglie larghe, varietà gigante selezionatasi nelle zone <strong>del</strong> Cremonese e <strong>del</strong><br />
Lodigiano caratterizzate da terreni alluvionali freschi e leggeri. Si differenzia dal trifoglio bianco <strong>per</strong> le<br />
maggiori dimensioni degli organi vegetativi e riproduttivi. La selezione ha portato a che questa varietà<br />
sopporti con difficoltà la mancanza nel terreno di adeguati livelli di umidà.
Verbena officinalis<br />
Verbenaceae<br />
VERBENA<br />
Verbena, Erba corce, Erba sacra, Erba colombina, Erba crocina, Erba turca, Barbegna, Erba <strong>del</strong>la m<strong>il</strong>za,<br />
Birbina, Virminaca, Crebena.<br />
Forma Biologica: H scap - Emicriptofite scapose. Piante <strong>per</strong>ennanti <strong>per</strong> mezzo di gemme poste a livello <strong>del</strong><br />
terreno e con asse fiorale allugato, spesso privo di foglie.<br />
Descrizione: Pianta <strong>per</strong>enne, di aspetto erbaceo ascendente, con radice fusiforme; fusto ruvido,<br />
quadrangolare, legnoso alla base ramificato nella parte su<strong>per</strong>iore, alta sino a 1 m.<br />
Le foglie inferiori sono opposte, oblunghe, si restringono in un corto picciolo. Le mediane sono più grandi,<br />
tr<strong>il</strong>obate, con <strong>il</strong> segmento centrale più sv<strong>il</strong>uppato dei 2 laterali, questi ultimi sono oblunghi lineari e dentati.<br />
Le foglie cauline sono sess<strong>il</strong>i, lanceolate, dentate o intere si riducono progressivamente. Tutte le foglie sono<br />
coriacee, di colore grigio-verde, pelose e rugose.<br />
I fiori sono raccolti in lunghe spighe che formano una pannocchia all’ascella <strong>del</strong>le piccole brattee. Il calice è<br />
tubuloso, glanduloso, diviso in 4-5 denti. La corolla possiede 2 labbra poco distinte, rosa- l<strong>il</strong>la o bianche.<br />
I frutti sono capsule compresse cuoriformi, all'interno divise in 4 logge contenenti ciascuna un seme.<br />
Tipo corologico: Paleotemp.divenuta Cosmop.<br />
Distribuzione in Italia: Presente in tutto <strong>il</strong> territorio.<br />
Proprietà ed ut<strong>il</strong>izzi: Erba molto amara, aromatica, rinfrescante, diuretica, antinfiammatoria e analgesica:<br />
calma i nervi, aumenta la sudorazione e la secrezione lattea, frena le emorragie, migliora <strong>il</strong> funzionamento<br />
di fegato e cistifellea, stimola l’utero. Antinevralgica ut<strong>il</strong>e <strong>per</strong> alleviare i dolori mestruali; emmenagoga,<br />
stimola <strong>il</strong> flusso mestruale se scarso.<br />
In caso di sinusite, si possono effettuare inalazioni respirando direttamente i vapori di un decotto di verbena<br />
caldo.<br />
Grazie alle sue proprietà astringenti si può assumere in caso di diarrea o coliche intestinali. Nell’uso interno,<br />
essa stimola la produzione di succo gastrico e favorisce gli scambi metabolici.<br />
Tran<strong>qui</strong>llante naturale, ut<strong>il</strong>e nell'ansia, nell'insonnia e nella tensione nervosa.<br />
L’infusione costituisce un eccellente gargarismo <strong>per</strong> le infiammazioni <strong>del</strong>la cavità orale e <strong>per</strong> le piccole<br />
emorragie <strong>del</strong>le gengive, ottimo rimedio anche <strong>per</strong> detergere le piccole lesioni e infiammazioni <strong>del</strong>la pelle.<br />
In cosmesi l’infuso può essere <strong>per</strong> usato come decongestionante <strong>per</strong> gli occhi.
Veronica chamaedrys<br />
VERONICA COMUNE<br />
Veronica comune, Occhi <strong>del</strong>la Madonna, Crescione dei prati.<br />
Forma biologica: H scap (Emicriptofite scapose. Piante <strong>per</strong>ennanti <strong>per</strong> mezzo di gemme poste a livello <strong>del</strong><br />
terreno e con asse fiorale allungato, spesso privo di foglie.)<br />
Descrizione: Pianta <strong>per</strong>enne, erbacea, fusti eretti o ascendenti, spesso rossastri, semplici o ramosi, glabri o<br />
con 2<br />
linee di peli, altezza 10÷30 cm.<br />
Le foglie sono opposte, sess<strong>il</strong>i o brevemente picciolate, pelosette, lamina ovato÷lanceolata, a margine<br />
seghettato.<br />
I fiori in lunghe infiorescenze portati da peduncoli, sbocciano all’ascella <strong>del</strong>le foglie in racemi multiflori,<br />
generalmente opposti. Calice con 4 lacinie lanceolate spesso pelose, corolla blu÷celeste con un anello<br />
bianco centrale.<br />
I frutti sono capsule triangolari, pelose e compresse.<br />
Antesi: Apr<strong>il</strong>e÷Giugno<br />
Tipo corologico: Euro÷Sib. (Europa meridionale e zone subsiberiane.)<br />
Distribuzione in Italia: Presente in tutta la penisola. Comune nelle regioni settentrionali, più rara in quelle<br />
centro÷meridionali, assente in Sardegna e Sic<strong>il</strong>ia.<br />
Habitat: Prati, pascoli, boschi, luoghi ricchi di nitrati; da 0 a 2.200 m.<br />
Proprietà ed ut<strong>il</strong>izzi÷Curiosità: Ha proprietà espettoranti, toniche, stomachiche, vulnerarie.<br />
Amara e stimoltante, entra nella composizione <strong>del</strong> "tè svizzero".<br />
È tra le piante che i coloni europei hanno introdotto in nord America.
VERONICA A FOGLIE DI SERPILLO<br />
Veronica serpyllifolia<br />
(= Veronica borealis (Laest.) Neuman,Veronica. humifusa Dicks., Veronica tenella All.)<br />
Veronica a foglie di Serp<strong>il</strong>lo, Veronica con foglie di Timo.<br />
Descrizione: Pianta erbacea <strong>per</strong>enne, fusti brevemente pubescenti, striscianti e radicanti ai nodi, ramificati<br />
con rami fioriferi eretti.<br />
Le foglie sono picciolate, ovali, intere o lievemente crenate, glabre opposte salvo che nell’infiorescenza dei<br />
fiori ascellari, dove sono ridotte a brattee.<br />
I fiori, in racemi lassi all’ascella <strong>del</strong>le brattee fogliari, sono brevemente picciolati, hanno lacinie calicine<br />
ellittico-ovali. 4 petali, <strong>il</strong> su<strong>per</strong>iore più grande dei laterali, quello inferiore più stretto, compongono la<br />
piccola corolla 5÷8 mm, biancastra o celeste striata di blu o viola, glabra esternamente, pubescente<br />
all’interno. Stami 2, ovario su<strong>per</strong>o 2 carpelli.<br />
I frutti sono capsule più larghe che lunghe, con calice <strong>per</strong>sistente, compresse, subrotonde, con peli<br />
ghiandolari, 20÷30 semi giallo chiari, con eleosoma.<br />
Antesi: Maggio÷Ottobre<br />
Tipo corologico: Circumbor.divenuta subcosmop.<br />
Distribuzione in Italia: Presente in tutto <strong>il</strong> territorio, isole comprese, 0÷2500 m<br />
Habitat: Luoghi freschi e umidi, lungo i corsi d’acqua, prati, torbiere, sentieri, magaforbieti.
Vinca Minor<br />
Sinonimi<br />
Vinca ellipticifolia Stokes<br />
Vinca hum<strong>il</strong>is Salisb.<br />
Vinca intermedia Tausch<br />
Tassonomia<br />
Regno: Plantae<br />
Divisione: Magnoliophyta<br />
Classe: Magnoliopsida<br />
Ordine: Gentianales<br />
Famiglia: Apocynaceae<br />
PERVINCA MINORE<br />
Nomi italiano<br />
Pervinca minore.<br />
Nomi locali: Scio da morto (Lig); Chiocchinet e Viola d'spagna (Piem); Carniola e fiur de mort<br />
(Lomb); Campanelle (Ven); Viola mata (Em); Erba vinca e Mortine (Tosc); Vinga-<strong>per</strong>vinga (Abr);<br />
Viola e ciucciu (Camp)<br />
Descrizione<br />
Pianta erbacea <strong>per</strong>enne, rizomatosa, con foglie sempreverdi, fusti fioriferi semplici, ± eretti o<br />
ascendenti e alti fino a 30 cm, e stoloni lunghi fino a 80-100 cm, ster<strong>il</strong>i, con radici nodali.<br />
Foglie<br />
Le foglie sono opposte, coriacee, glabre e brevemente picciolate, quelle all'apice dei fusti ster<strong>il</strong>i in<br />
vertic<strong>il</strong>lo di 3-4; picciolo subnullo nelle foglie inferiori, nelle su<strong>per</strong>iori lungo generalmente 2-4 mm<br />
(solo raramente più lungo, fino a 8 mm); lamina da lanceolata o ovato-lanceolata a ellittica, lunga<br />
da 1,5 a 4,5-5 cm, con margine intero (non c<strong>il</strong>iato) e apice acuto, di colore verde-scuro e lucida<br />
sulla pagina su<strong>per</strong>iore, più chiara in quella inferiore; nervatura r<strong>il</strong>evata su entrambe le pagine, più<br />
marcata su quella inferiore.<br />
Fiori<br />
Fiori solitari, ermafroditi, attinomorfi, pentameri, portati da un lungo (a volte più <strong>del</strong>la foglia<br />
ascellante) peduncolo inserito all'ascella <strong>del</strong>le foglie su<strong>per</strong>iori. Calice minuto, gamosepalo,
aderente al tubo corollino, con tubo breve, di circa 1,5 mm, e lacinie da ovate a triangolari lunghe<br />
3-4 mm (o poco più), glabre, a margine intero, con 1 dentello <strong>per</strong> lato nella porzione basale.<br />
Corolla ipocrateriforme da azzurra a porporino-violacea, a volte anche rosea o bianca, spesso<br />
biancastra alla bocca <strong>del</strong> tubo, con limbo di 25-35 mm di diametro e tubo di 9-11 (14) mm,<br />
internamente peloso all'altezza <strong>del</strong>le parti fert<strong>il</strong>i; lobi da largamente spatolati a cuneati, troncati<br />
obliquamente.<br />
Androceo e gineceo completamente inclusi nel tubo corollino.<br />
Stami 5, con f<strong>il</strong>amenti bruscamente incurvati alla base, e ivi portanti, ciascuno, un fascetto di peli;<br />
antere giallastre, appiattite, pubescenti sul dorso, con porzione apicale incurvata verso lo stigma e<br />
al di sopra di esso, in modo tale che, viste dall'alto, lo occultino quasi completamente (ad<br />
esclusione <strong>del</strong>la parte centrale).<br />
Ovario su<strong>per</strong>o 2-carpellare, glabro, con 2 nettarii basali; st<strong>il</strong>o giallastro f<strong>il</strong>iforme, con stigma,<br />
su<strong>per</strong>ato in altezza dalle antere, formato da una porzione basale slargata in alto (a mo' di testa di<br />
chiodo) e da un articolo apicale verdastro portante 5 folti ciuffi di peli bianchi disposti attorno<br />
all'a<strong>per</strong>tura stigmatica.<br />
Frutti<br />
Il frutto è formato da due (a volte uno, <strong>per</strong> aborto <strong>del</strong>'altro) follicoli subparalleli o poco divergenti,<br />
di forma subc<strong>il</strong>indrica e portanti un piccolo becco apicale, brunastri a maturità e lunghi 20-25 mm;<br />
la deiscenza avviene lungo la linea ventrale di sutura, liberando fino a 8 semi lungamente<br />
ellissoidali (1,5-2,5 x 5,5-7 mm), con solco longitudinale ventrale, glabri, brunastri con su<strong>per</strong>ficie da<br />
striata a reticolata.<br />
Periodo di fioritura<br />
Febbraio – apr<strong>il</strong>e. Nelle stazioni più elevate la fioritura inizia più tardi, protraendosi fino a maggiogiugno.<br />
Territorio di crescita<br />
Pianta diffusa nelle regioni tem<strong>per</strong>ate <strong>del</strong>l’Europa e <strong>del</strong>l’Asia, in Italia è presente in tutte le regioni<br />
tranne la Sardegna.<br />
Habitat<br />
Vive nei luoghi freschi ed ombrosi, pred<strong>il</strong>igendo i boschi caducifogli (soprattutto farneti e rovereti)<br />
o le siepi; non ama terreni poveri o troppo asciutti e i climi torridi; vegeta dal piano basale fino a<br />
quello montano (1300 m circa), formando spesso vasti tappeti che, grazie al loro sv<strong>il</strong>uppo radicale,<br />
riescono a consolidare i pendii.<br />
Uso Alimentare<br />
Non si conoscono usi alimentari <strong>per</strong> questa specie che rientra nella lista <strong>del</strong> Ministero <strong>del</strong>la Salute<br />
<strong>per</strong> l’impiego non ammesso nel settore degli integratori alimentari.<br />
Uso Cosmetologico<br />
Le foglie sono in grado di esercitare una blanda attività antinfiammatoria e possono venire<br />
ut<strong>il</strong>izzate <strong>per</strong> eczemi, foruncoli e nelle dermatosi. Un infuso di foglie, nell’acqua <strong>del</strong> bagno o come<br />
impacco da applicare sul viso, ha un effetto calmante su pelli <strong>del</strong>icate ed irritab<strong>il</strong>i.<br />
Uso Farmacologico<br />
In medicina ufficiale trova applicazioni nelle affezioni vascolari che limitano l'afflusso <strong>del</strong> sangue al
cervello e nei casi di Diarrea, Epistassi, Ferite, I<strong>per</strong>tensione, Tons<strong>il</strong>lite, Leucemia. L’alcaloide<br />
vincristina è un potente citotossico, ut<strong>il</strong>izzato nella cura chemioterapica dei tumori.<br />
E' stata usata in passato <strong>per</strong> diminuire la portata lattea, ma attualmente viene sconsigliata <strong>per</strong> i<br />
possib<strong>il</strong>i effetti tossici <strong>per</strong> <strong>il</strong> lattante.<br />
Tutti i trattamenti farmacologici e sanitari devono sempre essere eseguiti sotto stretto e diretto<br />
controllo medico.