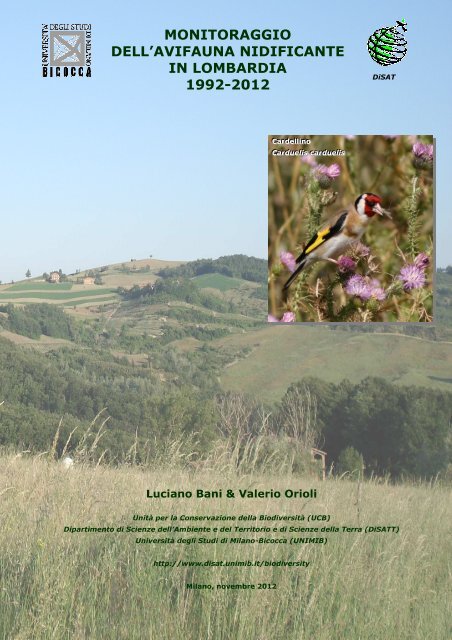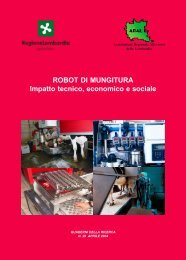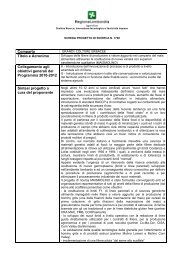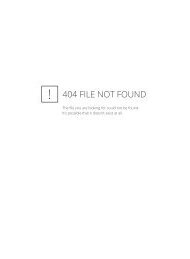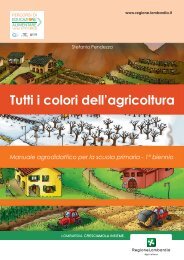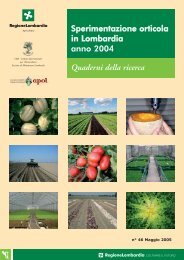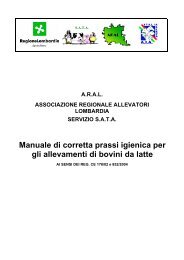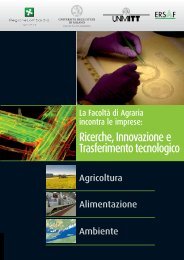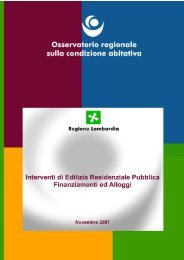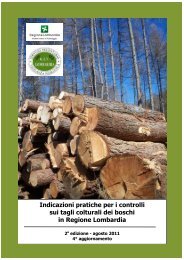Bani-Univ.Mi-Bicocca_Relazione_Monitoraggio Avifauna 2012
Bani-Univ.Mi-Bicocca_Relazione_Monitoraggio Avifauna 2012
Bani-Univ.Mi-Bicocca_Relazione_Monitoraggio Avifauna 2012
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
MONITORAGGIO<br />
DELL’AVIFAUNA NIDIFICANTE<br />
IN LOMBARDIA<br />
1992-<strong>2012</strong><br />
Luciano <strong>Bani</strong> & Valerio Orioli<br />
Unità per la Conservazione della Biodiversità (UCB)<br />
Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e del Territorio e di Scienze della Terra (DiSATT)<br />
<strong>Univ</strong>ersità degli Studi di <strong>Mi</strong>lano-<strong>Bicocca</strong> (UNIMIB)<br />
http://www.disat.unimib.it/biodiversity<br />
<strong>Mi</strong>lano, novembre <strong>2012</strong><br />
CCaarrddeel ll li innoo<br />
CCaarrdduueel li iss<br />
ccaarrdduueel li iss<br />
DiSAT
MONITORAGGIO<br />
DELL’AVIFAUNA NIDIFICANTE<br />
IN LOMBARDIA<br />
1992-<strong>2012</strong><br />
Responsabile scientifico<br />
della ricerca: Dott. Luciano <strong>Bani</strong><br />
Unità per la Conservazione della Biodiversità<br />
http://www.disat.unimib.it/biodiversity/<br />
Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e del Territorio<br />
e di Scienze della Terra<br />
<strong>Univ</strong>ersità degli Studi di <strong>Mi</strong>lano-<strong>Bicocca</strong><br />
Piazza della Scienza 1, <strong>2012</strong>6, <strong>Mi</strong>lano<br />
Tel. 02.6448.2936 / .2944 / .2918<br />
Fax. 02.6448.2994<br />
e-mail: luciano.bani@unimib.it<br />
<strong>Mi</strong>lano, novembre <strong>2012</strong>
Convenzione tra ERSAF e <strong>Univ</strong>ersità degli Studi di <strong>Mi</strong>lano-<strong>Bicocca</strong> per l'attuazione del<br />
progetto:<br />
“<strong>Monitoraggio</strong> dell’avifauna nidificante in Lombardia, 1992-<strong>2012</strong>”,<br />
per conto di Regione Lombardia,<br />
Unità Organizzativa Multifunzionalità e Sostenibilità del Territorio<br />
Direzione Generale Agricoltura, Regione Lombardia<br />
Ente committente: ERSAF<br />
Struttura Valorizzazione della Biodiversità e<br />
Servizi al Sistema Agroforestale<br />
Dirigente responsabile<br />
per l’ente committente: Dott. Paolo Nastasio<br />
Ente di ricerca affidatario: <strong>Univ</strong>ersità degli Studi di <strong>Mi</strong>lano-<strong>Bicocca</strong><br />
Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e del Territorio<br />
e di Scienze della Terra<br />
Responsabile scientifico della ricerca<br />
per l’ente affidatario: Dott. Luciano <strong>Bani</strong><br />
Rilevamenti faunistici e ambientali: Luciano <strong>Bani</strong><br />
Matteo Bonetti<br />
Lucio Bordignon<br />
Monica Carabella<br />
Alberto Forelli<br />
Valerio Orioli
INDICE<br />
INTRODUZIONE 6<br />
MATERIALI E METODI<br />
Dati faunistici<br />
Progetti di censimento dell’avifauna nidificante in Lombardia 8<br />
Il piano di campionamento del monitoraggio dell’avifauna nidificante in Lombardia 8<br />
Tecnica di rilevamento 11<br />
Dati ambientali 12<br />
Analisi statistica 14<br />
RISULTATI 18<br />
DISCUSSIONE 36<br />
SVILUPPI FUTURI 42<br />
BIBLIOGRAFIA 44<br />
APPENDICE 48<br />
Poiana Buteo buteo 49<br />
Gheppio Falco tinnunculus 49<br />
Quaglia Coturnix coturnix 50<br />
Fagiano Phasianus colchicus 50<br />
Gallinella d’acqua Gallinula chloropus 51<br />
Colombaccio Columba palumbus 51<br />
Tortora dal collare Streptopelia decaocto 52<br />
Tortora Streptopelia turtur 42<br />
Cuculo Cuculus canorus 53<br />
Rondone Apus apus 53<br />
Torcicollo Jynx torquilla 54<br />
Picchio verde Picus viridis 54<br />
Picchio rosso maggiore Dendrocopos major 45<br />
Allodola Alauda arvensis 55<br />
Rondine Hirundo rustica 56<br />
Balestruccio Delichon urbicum 56<br />
Prispolone Anthus trivialis 57<br />
Spioncello montano Anthus spinoletta 57<br />
Cutrettola Motacilla flava 58<br />
Ballerina gialla Motacilla cinerea 58<br />
Ballerina bianca Motacilla alba 59<br />
Scricciolo Troglodytes troglodytes 59<br />
Passera scopaiola Prunella modularis 60<br />
Pettirosso Erithacus rubecula 60<br />
Usignolo Luscinia megarhynchos 61<br />
Codirosso spazzacamino Phoenicurus ochruros 61<br />
Codirosso Phoenicurus phoenicurus 62<br />
Saltimpalo Saxicola torquata 62<br />
Culbianco Oenanthe oenanthe 63<br />
Merlo Turdus merula 63<br />
Tordo bottaccio Turdus philomelos 64<br />
Usignolo di fiume Cettia cetti 64<br />
Canapino Hippolais polyglotta 65<br />
Capinera Sylvia atricapilla 65<br />
Luì bianco Phylloscopus bonelli 66<br />
Luì piccolo Phylloscopus collybita 66<br />
Regolo Regulus regulus 67<br />
Fiorrancino Regulus ignicapilla 67<br />
Pigliamosche Muscicapa striata 68<br />
Codibugnolo Aegithalos caudatus 68<br />
Cincia bigia Poecile palustris 69<br />
Cincia bigia alpestre Poecile montana 69<br />
Cincia dal ciuffo Lophophanes cristatus 70<br />
Cincia mora Periparus ater 70<br />
Cinciarella Cyanistes caeruleus 71<br />
Cinciallegra Parus major 71<br />
Picchio muratore Sitta europaea 72<br />
Rigogolo Oriolus oriolus 72<br />
Averla piccola Lanius collurio 73<br />
Ghiandaia Garrulus glandarius 73<br />
Gazza Pica pica 74<br />
Cornacchia grigia Corvus cornix 74<br />
Storno Sturnus vulgaris 75<br />
Passero d’Italia Passer italiae 75<br />
Passero mattugio Passer montanus 76<br />
Fringuello Fringilla coelebs 76<br />
Verzellino Serinus serinus 77<br />
Verdone Carduelis chloris 77<br />
Cardellino Carduelis carduelis 78<br />
Ciuffolotto Pyrrhula pyrrhula 78
6<br />
INTRODUZIONE<br />
La Lombardia è stata la prima regione italiana ad avviare uno studio<br />
quantitativo dell’avifauna su ampia scala. Nel 1986 infatti la DG<br />
Agricoltura, in collaborazione con l’<strong>Univ</strong>ersità degli Studi di <strong>Mi</strong>lano, vara il<br />
progetto Atlante degli Uccelli svernanti in Lombardia (Fornasari et al.<br />
1992): si tratta del primo atlante quantitativo italiano in Italia che riporta<br />
la distribuzione e l’abbondanza dell’avifauna, secondo una maglia<br />
identificata dalle Tavolette IGM in scala 1:25.000 (circa 100 km 2 di<br />
estensione), per un intero territorio regionale. Tale lavoro segna la<br />
transizione dagli atlanti qualitativi, indicanti la semplicemente la<br />
presenza, certa, probabile o possibile, agli atlanti quantitativi. Dopo tale<br />
esperienza, nel 1992, la DG Agricoltura della Regione Lombardia<br />
riconosce l’utilità di un analogo studio quantitativo dell’avifauna sul<br />
territorio regionale durante la stagione di nidificazione, promuovendo<br />
l’avvio di un monitoraggio a lungo termine delle popolazioni nidificanti sul<br />
territorio regionale.<br />
Il Progetto (Fornasari et al. 1998), iniziato nel 1992, nonostante alcune<br />
interruzioni nei primi anni di esecuzione, rappresenta oggi il programma<br />
di monitoraggio dell’avifauna nidificante su ampia scala più longevo a<br />
scala nazionale e, per la vastità e la diversità ambientale del territorio<br />
indagato, è in grado di fornire una valutazione approfondita ed esauriente<br />
delle dinamiche di popolazione delle diverse specie di uccelli che si<br />
riproducono sul versante meridionale delle Alpi e nella Pianura Padana.<br />
Oggi il progetto è promosso e finanziato da Regione Lombardia, U.O.<br />
Sviluppo e Tutela del Territorio Rurale e Montano, Direzione Generale<br />
Agricoltura. La serie storica di dati georeferenziati è attualmente<br />
archiviata nella banca dati faunistica regionale e costituisce un patrimonio<br />
di grandissimo valore per l’utilizzo che può esserne fatto nell’ambito di<br />
studi con finalità prevalentemente gestionali e applicative (Massa et al.<br />
2003; Vigorita & Cucé 2008; <strong>Bani</strong> et al. 2009a; Massimino et al. 2010;<br />
<strong>Bani</strong> et al. 2009b; Ambrosini et al. 2011a; Massimino et al. submitt.)<br />
piuttosto che di interesse principalmente scientifico (<strong>Bani</strong> et al. 2002;<br />
<strong>Bani</strong> et al. 2006; Massimino et al. 2008; Ambrosini et al. 2011b).<br />
Una prima importante informazione che emerge dalla loro analisi è<br />
l’andamento demografico delle popolazioni regionali delle specie di uccelli<br />
nidificanti. Tale informazione è la base indispensabile per predisporre<br />
ricerche specifiche in grado di analizzare criticamente i processi in corso;
infatti, la conoscenza dei fattori che determinano delle dinamiche di<br />
popolazione permette di adottare adeguate azione finalizzate alla<br />
conservazione e gestione dell’avifauna.<br />
È evidente che queste finalità possono essere raggiunte tanto più<br />
efficientemente quanto più le informazioni sono raccolte con accuratezza<br />
e con costanza nel tempo grazie ai programmi di monitoraggio, ossia<br />
schemi di censimento nel corso dei quali i dati sono raccolti regolarmente<br />
nel tempo, con una metodologia standardizzata e per mezzo di un<br />
appropriato piano di campionamento. Ciò è quello che la DG Agricoltura<br />
della Regione Lombardia – U.O. Sviluppo e Tutela del Territorio Rurale e<br />
Montano e l’ERSAF (Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle<br />
Foreste) si propongono di sostenere nell’ambito dei loro Programmi di<br />
Ricerca.<br />
L’urgenza di adottare misure di gestione e conservazione per particolari<br />
specie o di pianificare una gestione territoriale ecologicamente sostenibile<br />
si scontra spesso sia con i tempi tecnici necessari per l’ottenimento di<br />
informazioni sui possibili scenari di evoluzione demografica, sia con<br />
l’impossibilità di recuperare dati pregressi utilizzabili per una corretta<br />
valutazione dell’andamento demografico in corso.<br />
In questa, ricerca al fine di valutare le dinamiche di popolazione, sono<br />
stati utilizzati i dati raccolti nel corso del programma di monitoraggio<br />
(1992, 1995-1996, 2000-<strong>2012</strong>). Le lacune temporali dovute alla<br />
mancanza di continuità del programma di monitoraggio sono state<br />
colmate integrando i dati del monitoraggio con altri provenienti da<br />
progetti con finalità differenti. Ciò comporta una disomogeneità del<br />
campione e rende i dati non direttamente confrontabili.<br />
Per tali motivi la nostra Unità di ricerca (Unità per la Conservazione della<br />
Biodiversità del Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e del Territorio e di<br />
Scienze della Terra – <strong>Univ</strong>ersità degli Studi di <strong>Mi</strong>lano-<strong>Bicocca</strong>) ha messo a<br />
punto una metodologia in grado di utilizzare le informazioni raccolte,<br />
ancorché non standardizzate, ossia raccolte con piani di campionamento<br />
differenti (Massimino et al. 2008; <strong>Bani</strong> et al. 2009a). La metodologia<br />
permette l’utilizzo di dati raccolti con la stessa tecnica di rilevamento<br />
nell’ambito di diversi progetti, ciascuno con un proprio schema di<br />
campionamento, superando la disomogeneità del campione e fornendo un<br />
indice di popolazione annuale oggettivo (surrogato da una statistica<br />
specifica) che può essere confrontato nel tempo e dal quale si può<br />
evincere l’andamento demografico delle popolazioni.<br />
Lo scopo di questa ricerca è stato quindi la stima delle popolazioni di 60<br />
specie comuni di uccelli nidificanti in Lombardia ed i loro andamenti<br />
demografici tra il 1992 ed il <strong>2012</strong>.<br />
7
Dati faunistici<br />
8<br />
MATERIALI E METODI<br />
Progetti di censimento dell’avifauna nidificante in Lombardia<br />
Il database faunistico utilizzato nella presente ricerca comprende dati<br />
sull’avifauna nidificante in Lombardia raccolti dal 1992 al <strong>2012</strong> in progetti<br />
con differenti piani di campionamento. Non ci sono tuttavia dati<br />
disponibili per gli anni 1993 e 1994, mentre i dati, pur non numerosi,<br />
raccolti nel 1997 e 1998 dall’Unità per la Conservazione della Biodiversità<br />
del Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e del Territorio e di Scienze<br />
della Terra hanno permesso comunque di valutare l’entità delle<br />
popolazioni di uccelli in questi anni per la maggior parte delle specie<br />
studiate (tabella 1).<br />
Il piano di campionamento del monitoraggio dell’avifauna nidificante in<br />
Lombardia.<br />
Il monitoraggio dell’avifauna nidificante in Lombardia, da quando è stato<br />
ripreso nel 2005 in forma standardizzata, ha previsto un campionamento<br />
di tipo stratificato, con una preliminare suddivisione del territorio<br />
regionale in insiemi omogenei (unità di campionamento primarie) di<br />
Tavolette IGMI (unità di campionamento secondarie) sulla base della loro<br />
composizione ambientale (uso del suolo DUSAF 2.0). In ogni unità<br />
primaria è effettuata ogni anno una selezione di unità secondarie, in<br />
modo tale da raccogliere un campione rappresentativo di punti di ascolto<br />
(unità di rilevamento).<br />
Per ogni anno di esecuzione del programma di monitoraggio si prevede la<br />
selezione di 30 unità di campionamento secondarie delle 284 in cui è<br />
idealmente suddivisa la regione, corrispondenti ad altrettante Tavolette<br />
IGMI. Le 30 unità individuate sono scelte in modo proporzionale<br />
all’estensione delle unità di campionamento primarie (aree omogenee) e,<br />
di anno in anno, sono selezionate 30 differenti unità di campionamento<br />
secondarie (figura 1). In questo modo, raccogliendo annualmente un<br />
campione rappresentativo del territorio regionale, si privilegiano gli<br />
aspetti legati al monitoraggio delle popolazioni di uccelli nidificanti<br />
nell’intera area di studio.
Nome del progetto 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 <strong>2012</strong> Totale<br />
Progetto pilota per il<br />
monitoraggio a<br />
lungo termine<br />
<strong>Monitoraggio</strong> a<br />
lungo termine<br />
387 - - - - - - - - - - - - - - - - 387<br />
- - - 295 284 - - - - - - - - 468 438 731 708 762 753 818 782 6.039<br />
Progetto foreste - - - 105 187 - - 1.115 625 219 123 67 18 - - - - 2.459<br />
Progetto bassa<br />
pianura<br />
Progetto alta<br />
pianura<br />
Database faunistico<br />
regionale<br />
- - - 195 240 - - - 297 348 44 - - - - - - 1.124<br />
- - - - - 149 258 - - - - - - - - - - 407<br />
- - - - - - - - 581 464 387 551 437 564 - - - 2.984<br />
Progetto Greenways - - - - - - - - - - 86 61 - - - - - 147<br />
Totale 387 - - 595 711 149 258 1.115 1.503 1.031 640 679 455 1.032 438 731 708 762 753 818 782 13.547<br />
Tabella 1. Dati utilizzati per la stima degli indici di popolazione annuali.
Inoltre, dal 2007 per un periodo di almeno 5-6 anni, è prevista<br />
l’esecuzione di rilevamenti in altre 22 unità di campionamento<br />
secondarie, che rimarranno fisse, e utilizzate per verificare la<br />
rappresentatività dei dati raccolti nelle altre 30 unità di campionamento<br />
secondarie che di anno in anno saranno diverse.<br />
Complessivamente si prevede l’esecuzione di circa 400-450 rilevamenti<br />
nelle 30 unità di campionamento secondarie che di anno in anno saranno<br />
sostituite da altre, e di circa 300-350 rilevamenti nelle 22 unità di<br />
campionamento secondarie fisse.<br />
Il mantenimento di uno sforzo di campionamento costante nel tempo<br />
permetterà la copertura completa del territorio regionale in 10 anni.<br />
Figura 1. Suddivisione della Lombardia in 7 aree omogenee (unità di campionamento<br />
primarie) sulla base della composizione ambientale, secondo la classificazione DUSAF,<br />
delle tavolette IGMI 1:25.000 (unità di campionamento secondarie). In blu le unità<br />
secondarie di campionamento mantenute fisse (tra parentesi il numero di tavolette, con<br />
presenza importante di territorio regionale, in ciascuna area omogenea. Nell’Alta pianura e nei Boschi<br />
di latifoglie sono compresi anche porzioni di territorio appenninico con caratteristiche ambientali<br />
simili a quelle prealpine).<br />
1) viola: Alpi (21) 5)<br />
arancione: Pianura urbana (23)<br />
2) grigio: Boschi di conifere (41) 6) senape: Pianura seminativa (91)<br />
3) verde: Boschi di latifoglie (52) 7) rosa: Pianura risicola (23)<br />
4) azzurro: Alta pianura (31)<br />
10
Tecnica di rilevamento<br />
Tutti i dati faunistici sono stati raccolti usando la tecnica dei punti di<br />
ascolto a distanza illimitata della durata di 10 minuti. I rilevamenti sono<br />
stati eseguiti dal 10 maggio al 20 giugno di ogni anno, al fine di evitare il<br />
principale flusso migratorio primaverile (e quindi il conteggio degli<br />
individui di passo) e nel contempo di concentrare i rilevamenti all’interno<br />
del periodo in cui si ha la massima attività canora territoriale degli<br />
individui (e quindi la maggiore probabilità di rilevarli). L’orario di<br />
rilevamento va dall’alba alle 11 (ora solare) in tutti i giorni senza pioggia,<br />
nebbia o forte vento (Blondel et al. 1981; Fornasari et al. 1998). Questa<br />
tecnica fornisce un valore di abbondanza relativa (Blondel et al. 1970;<br />
Bibby et al. 2000). Tutti i conteggi sono espressi in numero di coppie,<br />
calcolate secondo il metodo descritto da Blondel et al. (1981). La minima<br />
distanza tra due punti è stata fissata in 0,5 km.<br />
La tecnica dei punti d’ascolto permette di raccogliere dati utili su gran<br />
parte dell’avifauna presente sul territorio, in particolare sugli uccelli<br />
appartenenti agli ordini Columbiformes, Cuculiformes, Apodiformes,<br />
Coraciiformes, Piciformes e Passeriformes, tra i quali vi sono molte delle<br />
specie di interesse conservazionistico, gestionale e venatorio, così come<br />
individuate dal Piano Faunistico Venatorio Regionale. La tecnica può<br />
essere efficacemente usata anche per censire alcune tre le specie più<br />
comuni di Accipitriformes, Falconiformes, Galliformes e Gruiformes, quali<br />
la poiana Buteo buteo, il gheppio Falco tinnunculus, la quaglia Coturnix<br />
coturnix, il fagiano Phasianus colchicus e la gallinella d’acqua Gallinula<br />
chloropus.<br />
La tecnica è particolarmente idonea per i rilevamenti all’interno di ambiti<br />
ad elevata eterogeneità ambientale, poiché la raccolta di informazioni<br />
puntiformi relative a un determinato intorno ambientale consente di<br />
stabilire precisi legami quali-quantitativi tra avifauna e ambiente fisico,<br />
pur riducendo al minimo i tempi di rilevamento e, quindi, massimizzando<br />
l’efficienza della raccolta dati (all’aumento della numerosità di unità<br />
campionare, cioè i punti di ascolto, corrisponde un aumento della<br />
rappresentatività del dato raccolto). Altri metodi di rilevamento, per<br />
contro, sono poco indicati per uno studio come il presente. Il mappaggio,<br />
infatti, è una tecnica che prevede l’identificazione di tutti i territori<br />
individuali presenti all’interno dell’area di studio per ciascuna specie<br />
presente. Da un lato si tratta di una tecnica che, rispetto ai punti<br />
d’ascolto, permette di definire ancora meglio i legami tra avifauna e<br />
ambiente; tuttavia la notevole quantità di tempo che essa richiede (sono<br />
necessarie più visite all’interno di ogni singola stagione riproduttiva) ne<br />
sconsiglia l’utilizzo per aree di studio medie e grandi. Anche i transetti<br />
lineari, che consistono, come i punti di ascolto, nel conteggio di tutti gli<br />
individui appartenenti alle diverse specie identificate a vista oppure<br />
11
ascoltate in canto, ma lungo percorsi predefiniti, anziché in stazioni fisse,<br />
non appaiono particolarmente indicati. La tecnica del transetto, infatti,<br />
pur possedendo un buon rendimento di raccolta dati su vaste aree di<br />
studio, non consente di stabilire precisi legami tra avifauna e ambiente se<br />
non all’interno di ambiti di studio particolarmente omogenei dal punto di<br />
vista ambientale.<br />
Tutti i punti d’ascolto sono stati georeferenziati (UTM 32N, datum ED50).<br />
Ciò ci ha permesso di legare i dati faunistici con quelli ambientali relativi<br />
all’uso del suolo e alla geografia e topologia del territorio.<br />
Dati ambientali<br />
I dati relativi all’uso del suolo derivano dalla carta di Destinazione d’Uso<br />
dei Suoli Agricoli e Forestali (DUSAF 2.0, ERSAF 2010), dalla Carta dei<br />
Tipi Forestali (ERSAF 2006), entrambe realizzate dall’Ente Regionale per i<br />
Servizi all’Agricoltura e alle Foreste, e dalla cartografia CORINE Land<br />
Cover 2000 (EEA 2004). Si è inoltre utilizzato il Modello Digitale del<br />
Terreno (Regione Lombardia 2003).<br />
Dalle cartografie tematiche sono state estratte le variabili relative agli usi<br />
del suolo e ai tipi forestali riportate in tabella 2. Inoltre, la carta DUSAF è<br />
stata utilizzata anche per l’elaborazione di indici paesaggistici che<br />
descrivono la connettività, la contiguità e la forma delle parcelle costituite<br />
dalle tre principali classi di uso del suolo: ambienti urbani (U), aperti (A)<br />
e forestali (B).<br />
Una breve descrizione degli indici utilizzati è riportata in tabella 3. È stato<br />
inoltre utilizzato lo strato relativo alla distribuzione dei filari realizzato con<br />
il progetto DUSAF. Infine, dal Modello Digitale del Terreno sono state<br />
invece ricavate le variabili topografiche che descrivono la quota,<br />
l’esposizione e la pendenza dei versanti.<br />
12
Descrizione della variabile<br />
• Tessuto urbano continuo<br />
• Tessuto urbano discontinuo<br />
• Zone verdi urbane<br />
• Seminativi<br />
• Risaie<br />
• Colture permanenti<br />
• Arboricoltura da legno<br />
• Prati stabili<br />
• Zone agricole eterogenee<br />
• Aree a pascolo naturale e<br />
praterie<br />
• Brughiere e cespuglieti<br />
• Rocce nude, rupi e affioramenti<br />
• Aree con vegetazione rada<br />
• Zone umide interne<br />
• Greti<br />
Tabella 2. Elenco delle variabili di uso del suolo e dei tipi forestali e relativa fonte<br />
cartografica.<br />
Indici paesaggistici Descrizione delle misure espresse dagli indici<br />
MPI (Modified Proximity Index)<br />
<strong>Bani</strong> et al. 2006.<br />
Cartografia<br />
di origine<br />
CORINE<br />
DUSAF<br />
Descrizione della variabile<br />
• Abieteti<br />
• Aceri-frassineti ed acereti<br />
• Alneti<br />
• Betuleti e corileti<br />
• Castagneti<br />
• Faggete<br />
• Formazioni antropogene<br />
(robinieti e rimboschimenti a<br />
latifoglie)<br />
• Formazioni particolari<br />
(pioppeti naturali, saliceti,<br />
formazioni di maggiociondolo<br />
o sorbo)<br />
• Formazioni preforestali<br />
• Lariceti e larici-cembrete<br />
• Mughete<br />
• Orno-ostrieti<br />
• Peccete<br />
• Piceo-faggete<br />
• Pinete di pino silvestre<br />
• Querceti<br />
• Querco-carpineti e carpineti<br />
• Rimboschimenti di conifere<br />
• Formazioni preforestali miste<br />
<strong>Mi</strong>sura di connessione tra parcelle della stessa classe principale<br />
di uso del suolo in relazione alla loro superficie e vicinanza.<br />
CONTIG (Contiguity Index) <strong>Mi</strong>sura di continuità tra parcelle della stessa classe principale di<br />
uso del suolo espressa da un indice di adiacenza in relazione<br />
alla superficie occupata.<br />
FRAC (Fractal Index) <strong>Mi</strong>sura della complessità della forma di una parcella espressa<br />
come dimensione frattale, in relazione al rapporto tra<br />
perimetro ed area.<br />
Tabella 3. Elenco degli indici calcolati a scala di paesaggio e loro descrizione.<br />
Cartografia di<br />
origine<br />
Carta dei Tipi<br />
Forestali<br />
13
Analisi statistica<br />
Il numero e le specie di uccelli presenti in ogni unità campionaria (punto<br />
di ascolto) sono fortemente influenzati dalle sue caratteristiche<br />
ambientali. Per stimare gli andamenti delle popolazioni non è quindi<br />
possibile comparare direttamente il numero di coppie rilevate in ogni<br />
anno in quei casi, come il nostro, in cui lo sforzo di campionamento non è<br />
omogeneo per tutti gli ambienti. Pertanto abbiamo pesato il numero di<br />
coppie contate in ciascuna unità di campionamento per l’idoneità<br />
ambientale stimata nello stesso punto, per ciascuna delle 60 specie<br />
considerate, mediante un modello lineare generalizzato (GLM,<br />
Generalized Linear Model).<br />
I GLM sono stati introdotti da Nelder & Wedderburn (1972) e poi<br />
sviluppati da McCullagh & Nelder (1989) per superare la limitazione dei<br />
modelli di regressione lineare che presuppongono una distribuzione<br />
normale dei residui. Un GLM, come i modelli di regressione lineare, mette<br />
in relazione i predittori, cioè le variabili indipendenti (che possono essere<br />
anche interazioni tra le stesse), con una risposta, cioè la variabile<br />
dipendente. A differenza della regressione lineare, però, i predittori sono<br />
legati alla risposta mediante una funzione legame (link function). Un GLM<br />
si esprime quindi come:<br />
14<br />
g(E(Y)) = β0 + Σ βiXi<br />
dove g è la link function, E(Y) è il valore atteso della variabile dipendente<br />
Y, βi sono i coefficienti da stimare e Xi le variabili indipendenti.<br />
La link function è scelta secondo la distribuzione di probabilità della<br />
variabile dipendente. Se essa è un conteggio, tipicamente la sua<br />
distribuzione è poissoniana o binomiale negativa, da cui segue che<br />
occorre usare quale link function la funzione logaritmo (McCullagh e<br />
Nelder 1989; Quinn e Keough 2002). Il GLM risulta diventa quindi:<br />
log(E(Y)) = β0 + Σ βiXi<br />
La scelta tra un modello realizzato con distribuzione dei dati poissoniana<br />
oppure binomiale negativa è stata effettuata in funzione del migliore<br />
adattamento dei dati stessi al modello.<br />
Mentre la variabile dipendente è il numero di coppie censite della specie<br />
in esame in ogni punto di ascolto, le variabili indipendenti sono:<br />
- le variabili di uso del suolo e forestali (tabella 2), misurate come la loro<br />
abbondanza relativa in un raggio di 250 metri centrato in ogni punto;<br />
- i quadrati dell’abbondanza relativa in un raggio di 250 metri delle<br />
principali classi di uso del suolo (ambienti urbani, U, aperti, A, e<br />
forestali, B);<br />
- la densità dei filari, misurata sempre in un raggio di 250 metri;
- l’altitudine;<br />
- la pendenza e l’esposizione dei versanti;<br />
- la longitudine e la latitudine;<br />
- i valori massimi, in un raggio di 250 m, degli indici paesaggistici<br />
(tabella 3);<br />
- l’interazione tra l’altitudine e gli indici paesaggistici calcolati per gli<br />
ambienti aperti (A).<br />
L’utilizzo dei quadrati dell’abbondanza delle principali classi di uso del<br />
suolo (ambienti urbani, U, aperti, A, e forestali, B), permette di stimare<br />
una parabola convessa che permette di valutare l’importanza dell’effetto<br />
margine sull’abbondanza delle specie. L’interazione tra l’altitudine e gli<br />
indici paesaggistici calcolati per gli ambienti aperti (A) ha consentito di<br />
discriminare l’importanza degli ambienti aperti di alta quota (es. aree a<br />
pascolo naturale e praterie) rispetto a quelli di pianura (es. seminativi).<br />
Ogni modello può essere valutato calcolando la devianza residua G 2 , che<br />
rappresenta la differenza tra la verosimiglianza del modello in esame e la<br />
verosimiglianza del modello saturato, cioè del modello con un numero di<br />
parametri pari al numero di osservazioni. <strong>Mi</strong>nore è la devianza residua,<br />
maggiore è l’aderenza del modello ai dati.<br />
Poiché una diminuzione della devianza può essere ottenuta anche<br />
aumentando impropriamente il numero di predittori utilizzati, per<br />
valutare i modelli si usa solitamente il criterio informativo di Akaike (AIC,<br />
Akaike Information Criterion; Akaike 1973; Rushton et al. 2004; Guisan e<br />
Thuiller 2005; Brotons et al. 2007), che penalizza i modelli con un<br />
eccessivo numero di predittori confrontato con il numero di osservazioni:<br />
15<br />
AIC = G 2 – n + 2p<br />
Dove n è il numero di osservazioni e p il numero di predittori. I modelli<br />
migliori saranno quindi quelli con bassi valori di AIC.<br />
Nel nostro caso le variabili indipendenti sono state selezionate per mezzo<br />
di un processo stepwise di selezione del modello con il più basso valore di<br />
AIC.<br />
Le regressioni lineari generalizzate e la selezione stepwise delle variabili<br />
sono state eseguite per mezzo del software statistico R (R Development<br />
Core Team 2008).<br />
Per ogni specie, abbiamo validato il GLM per mezzo della tecnica di<br />
validazione incrociata leave more out (Guisan & Thuiller 2005),<br />
suddividendo casualmente il campione in 4 sottoinsiemi di dimensioni<br />
uguali. Ogni GLM è stato quindi eseguito 4 volte, usando 3 sottoinsiemi<br />
come insieme di apprendimento (training set) e il restante come insieme<br />
di valutazione (test set). Abbiamo quindi calcolato la devianza residua<br />
come la discordanza tra i valori stimati dal modello costruito sull’insieme<br />
di apprendimenti ed i valori osservati nell’insieme di valutazione. La
devianza residua così calcolata è stata quindi confrontata con la devianza<br />
residua del GLM di idoneità ambientale per valutare la capacità predittiva<br />
del modello (Vernier et al. 2002).<br />
L’idoneità ambientale, data dal numero di coppie attese (cait) di ogni<br />
specie stimate dal GLM in ogni punto i nell’anno t, è stata usata come<br />
denominatore per pesare il numero di coppie osservate (coit) nel punto.<br />
Abbiamo quindi definito un indice di popolazione annuale (It) come la<br />
media annuale del rapporto tra coppie osservate e stimate in ogni punto:<br />
16<br />
It = Σ (coit / cait) / Nt<br />
dove Nt è il numero totale di punti d’ascolto nell’anno t.<br />
Per calcolare questa media sono stati scartati quei punti aventi idoneità<br />
ambientale molto bassa che contenevano solo il 5% di tutte le coppie<br />
contate, poiché il rapporto tra coppie osservate ed attese avrebbe potuto<br />
assumere valori abnormi privi di senso nei rari casi di coppie rilevate in<br />
punti con idoneità ambientale prossima a zero.<br />
Al fine di valutare la significatività della variazione dell’indice di<br />
popolazione nel corso degli anni, abbiamo stimato con metodo bootstrap i<br />
suoi intervalli di confidenza al 95% (Efron 1982).<br />
L’andamento complessivo dal 1992 al <strong>2012</strong> è stato valutato interpolando<br />
l’indice con un modello di crescita di una popolazione che si riproduce<br />
stagionalmente (crescita geometrica; si veda, per esempio, Gotelli 2001):<br />
It = I0 (1+R) t<br />
dove It è l’indice di popolazione al tempo t, I0 è l’indice di popolazione al<br />
tempo 0 (anno 1992 nel nostro caso) e R è il tasso geometrico di<br />
crescita.<br />
La curva di crescita assume esplicitamente l’autocorrelazione dei dati di<br />
serie storica e non necessita di correzione dei livelli di significatività che<br />
invece richiedono altre analisi di regressione quali i metodi Monte Carlo<br />
basati su Catene di Markov (si veda Visser 2004; Gregory et al. 2007).<br />
Poiché l’indice di popolazione annuale è una media calcolata per unità di<br />
campionamento il cui numero varia di anno in anno, abbiamo usato la<br />
regressione ai minimi quadrati pesati (si veda Quinn & Keough 2002),<br />
dove il peso è l’inverso dell’errore standard dell’indice calcolato con<br />
metodo bootstrap per ogni anno.<br />
Gli indici e gli andamenti delle popolazioni sono stati stimati per tutte le<br />
specie aventi una frequenza media annuale di rilevamento pari o<br />
superiore al 2%, ad esclusione del piccione Columba livia.
Gli andamenti demografici delle popolazioni delle specie indagate sono<br />
stati calcolati sia a livello regionale sia a livello di ogni singola area<br />
omogenea contenente almeno il 10% della popolazione regionale.<br />
Per stimare la consistenza delle popolazioni ci si è basati sul modello di<br />
idoneità ambientale che stima, in ogni cella di 100 m di lato in cui è stata<br />
appositamente suddiviso il territorio regionale, l’abbondanza di ciascuna<br />
specie espressa in coppie/punto di ascolto. Se si sommano tutti i valori di<br />
idoneità ambientale ottenuti in tutte le celle di 100 m di lato e si divide<br />
tale somma per la superficie di un cerchio avente raggio pari al raggio di<br />
rilevamento (espresso in hm) della specie, si ottiene una stima della<br />
popolazione media su tutto il periodo considerato al fine di elaborare il<br />
modello, quindi nel nostro caso su tutto il periodo di studio. A questo<br />
punto è sufficiente moltiplicare questa popolazione media per l’indice di<br />
popolazione di uno specifico anno per ottenere una stima della<br />
popolazione nell’anno stesso. Il procedimento è stato eseguito per<br />
ciascuna specie in ogni anno del periodo di studio.<br />
Per quanto riguarda la valutazione della funzionalità del metodo di<br />
campionamento, basata sull’analisi dei dati provenienti dai punti di<br />
rilevamento reiterati nel corso degli anni di monitoraggio, si è ritenuto<br />
prematuro produrla nella presente relazione, avendo a disposizione<br />
soltanto pochi anni confrontabili tra loro. Si rinvia pertanto tale<br />
valutazione ai prossimi anni, quando la serie sarà costituita da più<br />
repliche.<br />
17
18<br />
RISULTATI<br />
Nel corso della stagione di rilevamento del <strong>2012</strong> sono stati effettuati 782<br />
punti di ascolto in 52 Tavolette IGMI (e 2 tavolette appendice, contigue<br />
alle 52 selezionate, in cui rientra solo una piccola porzione di territorio<br />
lombardo) suddivise nelle 7 aree omogenee (unità di campionamento<br />
primarie). Delle 52 tavolette esplorate, 22 sono fisse, ovvero esplorate<br />
ogni anno nelle stesse stazioni (salvo inagibilità temporanea locale),<br />
mentre 30 sono estratte casualmente all’interno delle aree omogenee<br />
secondo quanto previsto dal piano di campionamento (tabella 3).<br />
I rilevamenti hanno permesso l’identificazione di 26.668 individui<br />
corrispondenti, secondo le convenzioni di Blondel et al. (1981), a<br />
12.325,5 coppie, appartenenti a 158 specie.<br />
Area omogenea<br />
Numero<br />
tavolette<br />
Tavolette IGMI estratte<br />
per il <strong>2012</strong><br />
Numero punti<br />
di ascolto<br />
Numero<br />
tavolette<br />
Tavolette IGMI fisse<br />
Numero punti<br />
di ascolto<br />
Ambienti alpini 3 (+1) 44 3 (+1) 45<br />
Boschi di conifere 4 50 3 36<br />
Boschi di latifoglie 5 72 4 57<br />
Alta pianura / collina 3 46 3 50<br />
Pianura urbana 3 46 2 29<br />
Pianura seminativa 9 142 5 83<br />
Pianura risicola 3 47 2 35<br />
Totale 30 (+1) 447 22 (+1) 335<br />
Totale complessivo 52 (+2) Tavolette IGMI 782 Punti di ascolto<br />
Tabella 3. Tavolette IGMI esplorate e punti di ascolto effettuati (unità di campionamento<br />
primarie) per area omogenea nel <strong>2012</strong> (tra parentesi, numero di tavolette appendice).<br />
I modelli di idoneità ambientale sviluppati per mezzo delle tecniche<br />
statistiche GLM hanno permesso di spiegare una percentuale di devianza<br />
del campione per ogni specie compresa tra circa il 10% e l’85%.<br />
Il modello di crescita usato per valutare gli andamenti delle popolazioni<br />
tra il 1992 e il <strong>2012</strong> ha restituito una stima del tasso geometrico di<br />
crescita R, che rappresenta la percentuale annua di crescita o decrescita<br />
della popolazione sull’intero periodo.
In tabella 4a sono riportate, per ogni specie, la stima del tasso<br />
geometrico di crescita R e la sua significatività p espressa come<br />
probabilità che tale tasso sia nullo a scala regionale. In tabella 4b sono<br />
invece indicati gli andamenti a livello di ogni area omogenea contenete<br />
almeno il 10% della popolazione regionale.<br />
In tabella 5a sono indicati i raggi di rilevamento utilizzati per la<br />
trasformazione da abbondanza rilevata (coppie o individui su punto di<br />
ascolto) in stima di densità (coppie / unità di superficie) e, quindi, di<br />
popolazione regionale (coppie). In tabella 5b sono presentate le stime<br />
delle popolazioni regionali per ogni anno di cui si hanno dati sufficienti.<br />
19
20<br />
Nome italiano Nome latino R P<br />
Poiana Buteo buteo 0,021 0,255<br />
Gheppio Falco tinnunculus 0,037 0,024<br />
Quaglia Coturnix coturnix 0,018 0,541<br />
Fagiano Phasianus colchicus 0,085
Nome italiano<br />
Tabella 4b. Percentuale della popolazione regionale ospitata in ciascuna area omogenea. In grassetto le<br />
popolazioni che nelle singole aree omogenee raggiungono almeno il 10% della popolazione regionale e per le<br />
quali è stato valutato l’andamento a scala sub-regionale tra il 1992 e il <strong>2012</strong> (vedi tabella 4c).<br />
Nell’intestazione, tra parentesi è indicato il numero di specie valutate per ogni area omogenea.<br />
21<br />
Boschi di<br />
conifere<br />
(31)<br />
Alta<br />
pianura<br />
(29)<br />
Pianura<br />
seminativa<br />
(39)<br />
Boschi di<br />
latifoglie<br />
(39)<br />
Pianura<br />
risicola<br />
(14)<br />
Alpi<br />
(9)<br />
Pianura<br />
urbana<br />
(17)<br />
Poiana 16 14 19 37 8 1 5<br />
Gheppio 12 6 42 7 9 18 6<br />
Quaglia 3 6 74 3 4 1 8<br />
Fagiano comune 1 7 62 3 19 0 7<br />
Gallinella d'acqua 0 4 48 4 36 0 8<br />
Colombaccio 1 23 42 9 12 0 13<br />
Tortora dal collare 0 9 63 3 9 0 14<br />
Tortora 2 18 52 9 8 0 12<br />
Cuculo 11 10 33 29 9 2 5<br />
Rondone 6 14 38 15 10 3 15<br />
Torcicollo 7 14 45 18 3 0 12<br />
Picchio verde 9 30 13 30 10 1 6<br />
Picchio rosso maggiore 8 24 25 21 13 1 8<br />
Allodola 2 3 77 2 6 3 7<br />
Rondine 2 8 61 8 9 0 12<br />
Balestruccio 6 16 36 19 5 1 17<br />
Prispolone 56 0 0 33 0 11 0<br />
Spioncello alpino 51 0 0 6 0 43 0<br />
Cutrettola 0 1 86 0 8 0 5<br />
Ballerina gialla 33 5 13 26 1 20 3<br />
Ballerina bianca 18 15 22 28 4 6 7<br />
Scricciolo 27 19 6 34 3 7 4<br />
Passera scopaiola 24 0 0 3 0 72 0<br />
Pettirosso 21 25 4 42 2 2 3<br />
Usignolo 1 8 64 4 14 0 9<br />
Codirosso spazzacamino 50 2 1 10 0 36 1<br />
Codirosso 23 17 7 44 1 2 7<br />
Saltimpalo 8 8 52 20 5 1 7<br />
Culbianco 57 0 0 6 0 37 0<br />
Merlo 8 21 28 25 5 1 13<br />
Tordo bottaccio 43 7 1 39 0 8 1<br />
Usignolo di fiume 0 4 64 6 13 0 12<br />
Canapino 2 19 40 15 14 0 9<br />
Capinera 11 17 27 28 8 1 8<br />
Lui bianco 11 5 1 80 0 1 2<br />
Lui piccolo 31 8 1 53 1 5 1<br />
Regolo 57 2 1 32 0 7 1<br />
Fiorrancino 43 6 1 44 0 4 2<br />
Pigliamosche 11 17 25 31 4 0 11<br />
Codibugnolo 15 20 10 43 5 1 5<br />
Cincia bigia 14 26 4 52 1 1 3<br />
Cincia bigia alpestre 59 0 0 17 0 24 0<br />
Cincia del ciuffo 54 6 1 32 0 7 1<br />
Cincia mora 52 3 1 30 0 13 1<br />
Cinciarella 12 23 8 46 5 1 4<br />
Cinciallegra 7 20 29 26 8 0 10<br />
Picchio muratore 13 34 4 40 3 1 5<br />
Rigogolo 1 8 60 4 19 0 7<br />
Averla piccola 14 11 29 33 5 1 7<br />
Ghiandaia 20 17 8 48 3 1 3<br />
Gazza 0 6 75 2 7 0 9<br />
Cornacchia grigia 2 10 44 8 28 0 8<br />
Storno 1 9 64 4 11 0 11<br />
Passero d'Italia 2 9 56 7 12 0 13<br />
Passero mattugio 1 8 61 5 14 0 10<br />
Fringuello 22 18 11 35 3 4 7<br />
Verzellino 6 29 25 16 2 0 22<br />
Verdone 2 19 40 15 4 0 19<br />
Cardellino 4 14 46 15 9 0 13<br />
Ciuffolotto 57 1 0 34 0 9 0
Specie Regione<br />
22<br />
Boschi di<br />
conifere<br />
(31)<br />
Alta<br />
pianura<br />
(29)<br />
Pianura<br />
seminativa<br />
(39)<br />
Boschi di<br />
latifoglie<br />
(39)<br />
Pianura<br />
risicola<br />
(14)<br />
Alpi<br />
(9)<br />
Pianura<br />
urbana<br />
(17)<br />
Poiana = = = = =<br />
Gheppio +3,7 = +7,3 =<br />
Quaglia = =<br />
Fagiano comune +8,5 +12,5 +7,2<br />
Gallinella d'acqua = = (‒3,4)<br />
Colombaccio +13,6 (+4,5) +17,2 +8,5 +13,5<br />
Tortora dal collare +5,0 +5,8 +7,8<br />
Tortora = = = =<br />
Cuculo = = +4,0 = +4,4<br />
Rondone = = = = (‒4,0) =<br />
Torcicollo (‒3,3) = (‒5,6) = (‒4,8)<br />
Picchio verde +5,5 = +23,0 = =<br />
Picchio rosso maggiore +7,8 +7,8 +7,0 +9,5 =<br />
Allodola ‒9,6 ‒10,1<br />
Rondine ‒4,6 ‒3,1 =<br />
Balestruccio = = = ‒3,7 =<br />
Prispolone +7,5 +8,6 ‒5,2 +9,5<br />
Spioncello alpino +5,6 +8,9 (+3,0)<br />
Cutrettola = =<br />
Ballerina gialla (‒3,5) = = = =<br />
Ballerina bianca ‒4,5 (‒3,7) ‒5,9 ‒6,1 (‒3,2)<br />
Scricciolo ‒1,9 ‒2,2 = =<br />
Passera scopaiola +7,2 +5,7 +10,1<br />
Pettirosso = = = =<br />
Usignolo ‒2,1 (‒1,8) =<br />
Codirosso spazzacamino +9,9 = +23,2 +2,8<br />
Codirosso +4,5 +7,9 +6,1 =<br />
Saltimpalo ‒4,9 ‒6,0 =<br />
Culbianco +12,8 (+7,3) +9,7<br />
Merlo = = ‒2,6 = =<br />
Tordo bottaccio +10,9 +9,3 +20,2<br />
Usignolo di fiume (‒4,0) (‒3,8) = =<br />
Canapino +8,2 = = = =<br />
Capinera = = = = =<br />
Lui bianco = = =<br />
Lui piccolo ‒3,8 (‒2,9) ‒3,8<br />
Regolo ‒5,2 ‒5,2 ‒9,5<br />
Fiorrancino +9,2 +9,2 +8,3<br />
Pigliamosche +4,9 = (+4,3) (+6,3) +8,3 =<br />
Codibugnolo +4,4 = = +12,9 =<br />
Cincia bigia +8,9 +9,8 = +11,5<br />
Cincia bigia alpestre = = = =<br />
Cincia del ciuffo = = =<br />
Cincia mora = = = =<br />
Cinciarella +4,6 = +6,9 +3,3<br />
Cinciallegra +3,2 +2,2 +4,8 +2,6 =<br />
Picchio muratore = = ‒6,5 =<br />
Rigogolo = = =<br />
Averla piccola ‒9,0 = = ‒15,5 ‒11,1<br />
Ghiandaia +4,5 = +6,4 +5,6<br />
Gazza +7,8 +8,5<br />
Cornacchia grigia (+1,0) = = =<br />
Storno (+1,9) +4,3 = =<br />
Passero d'Italia ‒5,2 ‒7,2 ‒7,2 =<br />
Passero mattugio (‒2,4) = = (‒3,4)<br />
Fringuello = (+1,4) = = =<br />
Verzellino = ‒4,3 = (+4,5) =<br />
Verdone ‒5,5 ‒8,7 ‒5,6 = ‒6,0<br />
Cardellino ‒6,4 ‒8,0 ‒6,0 ‒7,6 ‒4,9<br />
Ciuffolotto = = =<br />
Tabella 4c. Variazione percentuale media annua delle popolazioni dal 1992 al <strong>2012</strong> nelle aree omogenee.<br />
Dove indicato il tasso si intende significativo, con p
Nome italiano Nome latino r(m)<br />
Poiana* Buteo buteo 400<br />
Gheppio Falco tinnunculus 400<br />
Quaglia Coturnix coturnix 250<br />
Fagiano Phasianus colchicus 300<br />
Gallinella d’acqua Gallinula chloropus 200<br />
Colombaccio Columba palumbus 250<br />
Tortora dal collare Streptopelia decaocto 200<br />
Tortora Streptopelia turtur 200<br />
Cuculo Cuculus canorus 500<br />
Rondone Apus apus 300<br />
Torcicollo Jynx torquilla 250<br />
Picchio verde Picus viridis 250<br />
Picchio rosso maggiore Dendrocopos major 150<br />
Allodola Alauda arvensis 200<br />
Rondine Hirundo rustica 250<br />
Balestruccio Delichon urbicum 200<br />
Prispolone Anthus trivialis 250<br />
Spioncello Anthus spinoletta 250<br />
Cutrettola Motacilla flava 250<br />
Ballerina gialla Motacilla cinerea 150<br />
Ballerina bianca Motacilla alba 200<br />
Scricciolo Troglodytes troglodytes 200<br />
Passera scopaiola Prunella modularis 200<br />
Pettirosso Erithacus rubecula 200<br />
Usignolo Luscinia megarhynchos 250<br />
Codirosso spazzacamino Phoenicurus ochruros 250<br />
Codirosso Phoenicurus phoenicurus 200<br />
Saltimpalo Saxicola torquata 150<br />
Culbianco Oenanthe oenanthe 150<br />
Merlo Turdus merula 300<br />
23<br />
Nome italiano Nome latino r(m)<br />
Tordo bottaccio Turdus philomelos 200<br />
Usignolo di fiume Cettia cetti 250<br />
Canapino Hippolais polyglotta 200<br />
Capinera Sylvia atricapilla 200<br />
Luì bianco Phylloscopus bonelli 200<br />
Luì piccolo Phylloscopus collybita 200<br />
Regolo Regulus regulus 100<br />
Fiorrancino Regulus ignicapilla 100<br />
Pigliamosche Muscicapa striata 100<br />
Codibugnolo Aegithalos caudatus 150<br />
Cincia bigia Poecile palustris 200<br />
Cincia bigia alpestre Poecile montana 250<br />
Cincia dal ciuffo Lophophanes cristatus 150<br />
Cincia mora Periparus ater 150<br />
Cinciarella Cyanistes caeruleus 150<br />
Cinciallegra Parus major 200<br />
Picchio muratore Sitta europaea 150<br />
Rigogolo Oriolus oriolus 300<br />
Averla piccola Lanius collurio 100<br />
Ghiandaia Garrulus glandarius 200<br />
Gazza Pica pica 300<br />
Cornacchia grigia Corvus cornix 500<br />
Storno Sturnus vulgaris 300<br />
Passero d'Italia Passer italiae 150<br />
Passero mattugio Passer montanus 150<br />
Fringuello Fringilla coelebs 250<br />
Verzellino Serinus serinus 200<br />
Verdone Carduelis chloris 200<br />
Cardellino Carduelis carduelis 200<br />
Ciuffolotto Pyrrhula pyrrhula 100<br />
Tabella 5a. Raggio di rilevamento r utilizzato per il calcolo delle stime delle popolazioni annuali.
Nome italiano Nome latino 1992 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Poiana* Buteo buteo 200 600 400 400 1.300 1.200 1.000 1.200 1.800 600 1.200 800 1.200 600 700 800 1.000 600 1.000<br />
Gheppio Falco tinnunculus 400 400 400 1.100 1.400 900 1.000 1.300 900 1.300 1.500 1.500 2.100 1.400 1.500 900 1.000 1.300 1.200<br />
Quaglia Coturnix coturnix 2.800 6.400 600 3.600 11.800 4.600 5.100 5.000 3.200 3.400 2.200 14.200 5.800 3.200 4.200 2.600 4.900 3.000 3.200<br />
Fagiano Phasianus colchicus 5.500 2.000 3.600 5.000 1.500 4.200 4.600 3.600 4.800 6.000 3.600 4.500 7.000 8.100 5.900 9.600 10.000 9.900 9.500<br />
Gallinella d’acqua Gallinula chloropus 9.600 16.600 13.700 2.600 8.400 11.700 16.300 12.900 12.700 12.700 10.600 14.800 14.000 6.000 8.600 14.300 13.600 8.000 8.900<br />
Colombaccio Columba palumbus 10.000 6.400 1.900 8.100 3.400 4.900 6.000 4.800 3.700 4.000 3.600 4.600 9.300 7.400 10.500 10.500 14.900 21.200 17.500<br />
Tortora dal collare Streptopelia decaocto 26.000 20.300 37.100 31.600 41.100 51.100 56.500 66.100 82.100 87.500 78.300 80.500 70.900 68.900 67.600 68.800 72.900 77.400 96.800<br />
Tortora Streptopelia turtur 16.100 23.100 5.000 6.600 14.400 20.200 19.200 10.300 16.300 10.000 8.200 11.500 11.200 17.400 18.600 18.800 17.600 11.400 15.800<br />
Cuculo Cuculus canorus 11.500 9.700 5.500 3.900 3.800 8.100 6.600 6.000 7.500 7.400 7.000 8.900 8.400 9.100 5.800 6.500 8.700 10.200 6.500<br />
Rondone Apus apus 178.500 88.800 69.900 89.600 106.600 112.900 94.600 100.900 131.900 161.600 191.200 113.800 120.800 42.500 64.700 64.900 117.500 93.900 82.400<br />
Torcicollo Jynx torquilla 5.800 3.600 2.200 3.300 3.300 4.400 3.900 3.200 4.300 2.200 4.600 2.600 1.300 6.400 4.400 3.000 2.900 1.200 1.800<br />
Picchio verde Picus viridis 3.600 1.100 1.500 N.D. 5.800 4.400 4.900 6.000 2.900 5.100 2.800 4.000 5.800 5.100 6.400 4.000 7.300 7.800 10.500<br />
Picchio rosso maggiore Dendrocopos major 7.900 3.800 2.900 28.100 12.700 16.700 12.100 14.000 16.100 18.100 10.200 21.800 25.500 22.900 15.900 16.900 20.400 31.500 32.000<br />
Allodola Alauda arvensis 166.800 79.700 71.100 93.100 131.700 99.400 54.000 50.100 58.300 50.300 41.400 37.300 38.900 34.800 26.200 25.200 20.800 13.900 20.100<br />
Rondine Hirundo rustica 222.800 146.500 160.500 121.600 95.900 235.300 163.000 145.400 158.200 112.000 132.200 116.900 150.200 87.800 73.600 69.500 126.900 78.300 59.900<br />
Balestruccio Delichon urbicum 66.900 46.500 65.600 N.D. 40.600 80.400 94.900 91.200 122.300 120.900 78.800 71.600 87.900 65.300 59.800 46.100 106.600 67.200 53.000<br />
Prispolone Anthus trivialis 14.100 1.500 3.100 N.D. N.D. 10.000 5.900 8.500 6.900 8.400 8.900 12.200 10.100 10.200 13.600 9.900 9.600 13.600 11.100<br />
Spioncello Anthus spinoletta 7.100 31.700 41.700 N.D. N.D. 19.200 14.100 21.100 35.100 22.900 23.200 30.900 30.600 31.100 36.700 38.900 30.800 38.800 33.000<br />
Cutrettola Motacilla flava 26.200 16.800 18.200 N.D. N.D. 12.400 20.900 16.500 16.700 19.100 15.200 15.200 20.800 21.400 21.100 25.800 16.600 15.100 13.200<br />
Ballerina gialla Motacilla cinerea 7.700 15.200 19.300 N.D. N.D. 8.200 13.700 8.500 6.000 11.300 4.700 10.900 6.800 5.300 6.400 7.600 8.400 7.300 17.000<br />
Ballerina bianca Motacilla alba 17.600 14.100 12.700 12.500 21.300 11.800 12.400 14.600 14.800 11.100 12.700 9.500 10.800 7.300 7.600 5.500 6.800 9.900 6.900<br />
Scricciolo Troglodytes troglodytes 42.600 40.500 38.100 N.D. 42.900 42.700 41.600 53.300 45.400 37.100 33.600 34.700 31.500 30.200 53.500 28.800 33.700 39.200 27.200<br />
Passera scopaiola Prunella modularis 5.100 5.100 33.800 N.D. N.D. 15.800 17.300 20.500 36.700 14.600 16.000 21.600 19.000 27.000 26.800 33.500 27.100 32.000 40.400<br />
Pettirosso Erithacus rubecula 38.100 29.500 42.600 N.D. N.D. 50.100 41.200 56.100 50.000 28.000 27.700 41.200 36.000 46.000 39.200 38.100 35.900 47.700 39.800<br />
Usignolo Luscinia megarhynchos 135.700 88.100 66.000 54.600 63.500 77.900 66.100 64.700 51.400 59.100 69.700 73.800 62.100 79.800 70.100 65.800 68.800 52.600 52.200<br />
Codirosso spazzacamino Phoenicurus ochruros 2.300 9.300 4.600 N.D. N.D. 2.300 4.000 10.400 7.600 24.900 16.200 9.100 18.100 8.300 12.200 7.100 11.400 26.300 22.200<br />
Codirosso Phoenicurus phoenicurus 7.300 12.400 11.400 16.500 22.900 12.300 16.200 22.900 15.400 14.500 9.700 21.200 19.800 23.200 22.300 16.900 21.300 32.800 22.300<br />
Saltimpalo Saxicola torquata 14.300 5.600 14.200 7.500 24.300 18.100 16.700 19.300 17.200 13.500 13.800 18.600 5.200 9.700 9.800 4.400 5.200 2.400 2.700<br />
Culbianco Oenanthe oenanthe 2.900 10.000 N.D. N.D. N.D. 11.800 9.600 9.900 11.100 6.000 7.500 16.500 25.800 19.900 21.600 23.600 20.900 26.200 15.800<br />
Merlo Turdus merula 99.100 71.200 61.500 80.700 79.300 84.700 56.000 60.700 65.200 54.300 52.600 62.200 59.400 68.000 70.600 72.900 71.200 75.800 77.000<br />
Tabella 5b. Stime delle popolazioni annuali (segue a pagina successiva).<br />
* Oltre al raggio di rilevamento per la stima della popolazione di poiana è stato utilizzato anche un parametro relativo alla probabilità di rilevamento (p=0,4) che, per un rapace<br />
parzialmente “veleggiatore” tendente a sfruttare le correnti termiche ascensionali, riduce l’effetto della sua mancata osservazione nelle prime ore della giornata. N.D.: popolazione<br />
non definita in quanto non stimabile.
Nome italiano Nome latino 1992 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Tordo bottaccio Turdus philomelos 2.100 2.400 N.D. N.D. N.D. 5.700 2.800 6.700 9.300 8.300 2.900 3.900 6.200 9.100 13.600 11.900 6.700 9.700 17.000<br />
Usignolo di fiume Cettia cetti 8.400 13.700 N.D. N.D. N.D. 17.900 14.400 20.400 4.500 6.000 14.300 15.100 5.000 5.800 9.800 6.500 4.300 6.400 3.000<br />
Canapino Hippolais polyglotta 2.500 5.100 400 4.200 1100 5.700 3.500 3.600 4.600 5.500 2.300 3.300 3.200 4.400 4.900 5.100 5.500 7.000 8.300<br />
Capinera Sylvia atricapilla 207.900 176.900 177.100 N.D. 181.000 193.900 158.900 185.700 185.900 172.400 136.100 182.100 180.200 184.400 191.900 191.500 202.000 198.000 192.400<br />
Luì bianco Phylloscopus bonelli 7.400 19.700 8.800 N.D. N.D. 20.800 14.500 11.900 17.100 20.600 6.100 12.700 11.500 13.800 13.600 9.000 15.700 11.100 22.800<br />
Luì piccolo Phylloscopus collybita 71.600 87.500 135.000 N.D. N.D. 98.900 64.000 78.800 62.900 61.300 56.800 47.300 41.200 70.200 78.700 47.400 59.500 66.100 35.400<br />
Regolo Regulus regulus 33.800 39.200 91.100 N.D. N.D. 45.000 56.900 43.700 69.600 40.500 24.600 25.900 15.100 34.000 29.900 6.900 18.400 17.500 41.600<br />
Fiorrancino Regulus ignicapilla 5.300 9.400 17.600 N.D. N.D. 18.100 24.500 24.600 19.900 9.500 26.900 19.500 19.400 19.600 39.800 38.100 33.000 59.200 29.900<br />
Pigliamosche Muscicapa striata 59.900 30.400 20.100 89.300 79.700 50.900 46.900 71.200 55.900 41.700 41.600 37.400 52.900 70.600 83.800 77.100 56.200 79.800 121.700<br />
Codibugnolo Aegithalos caudatus 8.900 20.200 14.900 19.200 24.200 25.500 19.600 31.100 27.200 19.000 11.400 31.100 25.800 38.200 36.600 25.000 29.100 43.200 27.700<br />
Cincia bigia Poecile palustris 2.000 8.600 5.400 N.D. 13.500 7.000 3.800 5.100 14.600 7.100 13.400 8.500 12.700 19.000 12.900 17.400 14.300 38.600 13.500<br />
Cincia bigia alpestre Poecile montana 19.300 13.200 13.900 N.D. N.D. 7.800 5.500 14.600 14.700 17.400 7.500 8.700 7.200 16.900 4.500 8.800 18.500 14.600 4.000<br />
Cincia dal ciuffo Lophophanes cristatus 2.300 8.500 14.300 N.D. N.D. 16.500 12.600 4.700 18.400 8.800 12.800 10.500 5.700 9.300 7.900 5.400 10.100 9.900 8.400<br />
Cincia mora Periparus ater 71.000 51.500 116.100 N.D. N.D. 84.400 63.200 83.000 93.200 61.500 59.700 65.200 74.100 88.100 55.500 48.300 60.700 75.000 106.100<br />
Cinciarella Cyanistes caeruleus 21.500 19.200 37.600 11.400 51.800 25.500 31.500 36.500 38.700 47.400 30.700 34.700 37.300 39.200 56.000 39.600 38.700 56.100 53.400<br />
Cinciallegra Parus major 63.300 45.300 40.700 58.600 44.000 63.800 45.300 58.600 45.500 77.400 59.500 66.000 66.900 71.400 65.500 64.000 76.400 84.100 90.200<br />
Picchio muratore Sitta europaea 9.900 6.500 7.100 21.400 18.900 11.900 9.500 14.100 16.200 4.500 3.100 8.700 15.600 11.800 10.300 12.700 8.100 13.700 14.400<br />
Rigogolo Oriolus oriolus 10.700 6.800 4.600 N.D. N.D. 5.600 4.700 3.800 5.000 8.600 4.900 7.400 6.100 9.400 6.700 4.900 5.600 5.300 6.700<br />
Averla piccola Lanius collurio 52.100 34.000 20.700 8.600 17.200 25.100 17.500 23.200 14.000 4.800 9.900 17.100 12.200 16.700 15.000 10.300 13.300 6.000 2.600<br />
Ghiandaia Garrulus glandarius 6.000 6.700 4.300 2.900 6.700 8.500 6.300 5.200 9.900 11.600 8.400 7.700 10.100 10.000 6.400 12.400 14.000 13.600 9.700<br />
Gazza Pica pica 2.300 5.300 5.500 N.D. N.D. 5.900 4.600 4.400 10.000 10.300 7.800 9.200 12.500 7.200 8.600 10.400 11.100 9.900 14.800<br />
Cornacchia grigia Corvus cornix 30.400 19.700 19.700 22.500 21.300 28.900 24.200 27.900 26.100 20.700 23.600 25.200 30.800 24.700 27.500 22.900 26.600 30.200 29.200<br />
Storno Sturnus vulgaris 309.100 141.300 99.400 89.500 150.700 241.300 184.600 131.900 182.700 150.300 188.500 193.700 181.800 175.500 184.700 158.700 211.200 186.000 221.900<br />
Passero d'Italia Passer italiae 652.000 410.400 441.200 N.D. 355.400 664.900 391.200 287.900 352.600 273.800 284.800 276.100 232.000 243.300 194.800 193.200 214.500 183.200 174.400<br />
Passero mattugio Passer montanus 86.000 50.900 45.100 35.700 50.000 74.600 53.200 52.200 25.700 27.100 29.600 36.700 44.900 56.400 58.700 62.900 37.400 29.800 27.900<br />
Fringuello Fringilla coelebs 97.800 101.100 95.100 N.D. 111.200 103.900 86.800 105.600 99.600 103.500 96.900 110.400 110.900 106.600 114.800 110.100 95.000 104.100 108.900<br />
Verzellino Serinus serinus 38.200 25.500 23.200 N.D. N.D. 32.100 43.000 38.300 35.200 37.300 48.100 42.100 44.200 47.200 51.200 39.300 47.000 36.700 55.700<br />
Verdone Carduelis chloris 107.800 89.700 89.500 100.200 122.400 112.100 107.500 72.500 69.500 61.500 45.400 53.700 45.600 58.000 57.600 28.700 33.200 46.800 67.700<br />
Cardellino Carduelis carduelis 62.500 46.800 60.400 54.600 67.400 60.100 55.400 60.900 40.000 54.500 36.400 39.300 23.700 25.500 24.700 17.800 15.000 15.100 22.700<br />
Ciuffolotto Pyrrhula pyrrhula 8.700 21.700 2.400 N.D. N.D. 23.000 15.600 31.400 24.900 19.500 19.300 24.000 4.600 11.500 28.500 10.100 30.900 30.000 26.500<br />
Tabella 5b (cont.). Stime delle popolazioni annuali (segue da pagina precedente). N.D.: popolazione non definita in quanto non stimabile.
Tra le 60 specie analizzate 12 mostrano un declino significativo (R
significativo: la gallinella d’acqua Gallinula chloropus (‒3,4%) e il<br />
rondone Apus apus (‒4,0%).<br />
L’analisi a scala sub-regionale consente inoltre di apprezzare meglio<br />
l’importanza delle variazioni che, analizzate a scala di area omogenea,<br />
offrono un immagine di maggior dettaglio circa la dinamica delle<br />
popolazioni all’interno di ambiti geografici più ristretti. Ciò consente<br />
anche di evidenziare alcune dinamiche comuni a più specie, sintomo di<br />
minacce comuni che intervengono in aree caratterizzate da analoghi<br />
processi.<br />
Per esempio è possibile osservare come per le specie in maggior regresso<br />
quali l’allodola, il calo demografico che colpisce la specie sia ancora più<br />
importante se analizzato a scala sub-regionale della “Pianura seminativa”,<br />
un’area che rappresenta la roccaforte delle popolazioni regionali, con il<br />
77% della popolazione regionale (tabella 4b): se il calo demografico è<br />
valutato in circa il 9,6% annuo, la principale popolazione della specie<br />
diminuisce a un ritmo del 10,1% medio annuo.<br />
Un analogo discorso vale per l’averla piccola: se a scala regionale<br />
decresce in media annualmente dell’9,0%, le popolazioni della “Pianura<br />
seminativa”, che rappresentano poco meno di un terzo della popolazione<br />
regionale, regrediscono all’impressionante tasso del 15,5% (il tasso<br />
negativo in assoluto più elevato registrato per tutte le specie); la specie<br />
evidenzia inoltre un altro preoccupante declino nell’area omogenea dei<br />
“Boschi di latifoglie” (con il 33% della popolazione regionale), con una<br />
diminuzione media annua dell’11,1%.<br />
Il saltimpalo, che a scala regionale mostra un decremento significativo<br />
pari al 4,9% medio annuo, a livello della “Pianura seminativa”, area che<br />
ospita la principale popolazione regionale (52%), il decremento ammonta<br />
al 6,0%.<br />
Il verdone (‒5,5%) e il cardellino (‒6,4%) sono altre due specie in<br />
significativo regresso a scala regionale che evidenziano diminuzioni<br />
superiori a scala sub-regionale; il primo cala del 8,7% nell’”Alta pianura”<br />
e del 6,0% nella “Pianura urbana”, ossia negli ambiti a maggiore<br />
pressione antropica di tipo insediativo e industriale (il decremento nelle<br />
“Pianura seminativa” appare invece in linea con quello regionale: ‒5,6%).<br />
Il cardellino evidenzia cali differenziati tra le differenti aree omogenee:<br />
decrementi superiori alla media regionale pari all’8,0% si hanno nell’area<br />
dell’“Alta pianura” e al 7,6% in quella dei “Boschi di latifoglie”; la specie<br />
risulta sempre in declino, seppur meno marcato, nella “Pianura<br />
seminativa” (‒6,0%) e nella “Pianura urbana” (‒4,9%).<br />
Anche la ballerina bianca (‒4,5% a scala regionale) evidenzia cali<br />
decisamente più importanti a scala sub-regionale: nell’“Alta pianura” e<br />
27
nella “Pianura seminativa” diminuisce infatti rispettivamente del 5,9% e<br />
del 6,1%.<br />
Una situazione simile è osservabile per il passero d’Italia: a fronte di un<br />
regresso a scala regionale del 5,2% medio annuo, nella “Pianura<br />
seminativa”, con il 61% della popolazione regionale, il calo arriva al<br />
7,2%, tasso eguagliato nella “Pianura risicola” con il 14% della<br />
popolazione regionale.<br />
La rondine, che evidenzia una declino generalizzato a scala regionale con<br />
un decremento medio annuo del 4,6%, non mostra decrementi localizzati<br />
di particolare rilievo; infatti, a livello della principale popolazione<br />
regionale, quella della “Pianura seminativa” (61%), si ha un regresso<br />
significativo pari al 3,1%. Il più alto tasso negativo registrato a scala<br />
regionale, lascia perciò presagire che le popolazioni più piccole di rondine,<br />
quelle connesse con le aree a minore vocazione per la specie, stiano<br />
andando incontro ad una repentina scomparsa.<br />
Tra le specie tipiche degli agro-ecosistemi che evidenziano un declino<br />
(‒3,3%), seppur marginalmente significativo, vi è il torcicollo. Si tratta<br />
dell’unico piciforme migratore trans-sahariano della nostra avifauna, che<br />
nidifica all’interno dei paesaggi agrari con diffusa presenza di filari<br />
utilizzati per la nidificazione. La riduzione di questi elementi ha senz’altro<br />
causato una rarefazione della specie in buona parte della pianura<br />
agricola; alla sua scomparsa possono aver giocato diversi altri fattori,<br />
quali la riduzione delle specie preda in seguito all’uso di insetticidi, così<br />
come possibili fenomeni di avvelenamento. Tuttavia, le variabilità e<br />
l’incertezza nella stima delle popolazioni annuali fanno presagire il<br />
possibile influsso di fattori stocastici ambientali che, su una specie<br />
migratrice e a lungo raggio e in genere presente in basse densità, può<br />
determinare forti oscillazioni interannuali, alle quali contribuisce anche<br />
l’elevato potenziale biotico della specie, che consente in anni favorevoli<br />
un repentino recupero degli effettivi.<br />
Un’ultima specie che abita le aree planiziali e che mostra un declino<br />
marginalmente significativo (‒4,0%) è l’usignolo di fiume. Si tratta di una<br />
specie tipicamente residente che subisce fortemente i forti rigori<br />
invernali, soprattutto nei valori estremi; questo è osservabile dalle<br />
notevoli oscillazioni demografiche, il cui legame con le avversità invernali<br />
resta ancora da appurare. L’andamento negativo a lungo termine, seppur<br />
non appaia al momento direttamente collegabile a qualche specifico<br />
fattore di origine antropica, potrebbe essere imputabile al generale<br />
degrado degli ecosistemi marginali nelle aree agricole, il cui effetto<br />
avverso potrebbe avere colpito l’usignolo di fiume così come ha<br />
certamente condizionato il destino di molte altre specie della pianura<br />
agricola.<br />
28
La maggior parte delle specie finora esaminate sono perlopiù legate a<br />
ambienti rurali ed agricoli: certamente si tratta nel complesso della<br />
situazione più allarmante poiché la generale dinamica negativa della<br />
popolazioni è direttamente riconducibile a cause di tipo antropico<br />
(intensificazione delle pratiche agricole che limitano la disponibilità di<br />
habitat e risorse per l’avifauna tipica della pianura irrigua).<br />
Tuttavia alcune significative diminuzioni, le cui possibili cause restano<br />
ancora da appurare, colpiscono alcune specie forestali.<br />
Una di queste è quella che colpisce il luì piccolo, che a scala regionale<br />
diminuisce del 3,8% medio annuo; tasso eguagliato nell’area omogenea<br />
dei “Boschi di latifoglie”, dove si trova il 53% della popolazione regionale.<br />
Anche il regolo denota importanti cali: a scala regionale diminuisce ogni<br />
anno in media del 5,2%; lo stesso andamento (‒5,2%) si registra a<br />
livello dell’’area omogenea “Boschi di conifere”, dove troviamo il 57%<br />
della popolazione regionale, mentre un calo più consistente (‒9,5%) si<br />
osserva nell’area “Boschi di latifoglie”, che ospita una popolazione<br />
comunque di una certa rilevanza (32%).<br />
Da notare che a un calo della popolazione di regolo corrisponde un<br />
aumento significativo della popolazione regionale della specie “sorella”, il<br />
fiorrancino, che incrementa mediamene ogni anno del 9,2%; il fiorrancino<br />
è una specie più termofila rispetto al regolo, che si adatta meglio rispetto<br />
al congenere anche alla presenza di boschi misti di conifere e latifoglie e,<br />
probabilmente, risulta anche favorito dalla ricorrenza di inverni sempre<br />
meno severi. A scala sub-regionale la sua popolazione incrementa del<br />
9,2% nel “Boschi di conifere”, e dell’8,3% nei “Boschi di latifoglie”.<br />
Le figure 2a e 2b indicano il numero di specie in incremento, in<br />
diminuzione o con andamento non significativo per le diverse specie<br />
raggruppate, rispettivamente, per ambiente di nidificazione e per<br />
strategia migratoria come da classificazione riportata in tabella 6.<br />
Osservando i gruppi ecologici, il gruppo più problematico, ossia con il<br />
maggior numero di specie in regresso, è quello delle comunità ornitiche<br />
che vivono in rapporto con l’uomo, all’interno degli agro-ecosistemi: 10<br />
su 19 possiedono un andamento negativo a lungo termine. Decisamente<br />
migliore la condizione delle specie che abitano ambienti semi-naturali,<br />
come gli ambienti forestali o pre-forestali oppure gli ambenti aperti di<br />
media e alta quota, dove la pressione antropica è minore rispetto alla<br />
pianura. Per quanto riguarda i gruppi fenologici, invece, appare evidente<br />
che le popolazioni con il miglior status di conservazione sono quelle<br />
relative all’avifauna residente, con ben 12 specie su 16 che mostrano un<br />
andamento positivo e soltanto 2 in regresso (passero d’Italia e usignolo<br />
di fiume).<br />
29
Le figure 3, 4 e 5, indicano gli andamenti demografici per gruppi<br />
fenologici di specie, rispettivamente residenti, migratori parziali o a corto<br />
raggio e migratori a lungo raggio (trans-sahariani). Il solo gruppo<br />
fenologico che evidenzia un andamento significativo a lungo termine è il<br />
gruppo di specie residenti, con un incremento medio annuo del 2,8%<br />
(p
Specie Ambienti Strategia migratoria Andamento<br />
Poiana Buteo buteo foreste e/o arbusteti migr. parziale/corto raggio n.s.<br />
Gheppio Falco tinnunculus aperti residente +<br />
Quaglia Coturnix coturnix agro-ecosistemi migr. trans-sahariana n.s.<br />
Fagiano Phasianus colchicus agro-ecosistemi residente +<br />
Gallinella d’acqua Gallinula chloropus agro-ecosistemi migr. parziale/corto raggio n.s.<br />
Colombaccio Columba palumbus agro-ecosistemi migr. parziale/corto raggio +<br />
Tortora dal collare Streptopelia decaocto urbani residente +<br />
Tortora Streptopelia turtur agro-ecosistemi migr. trans-sahariana n.s.<br />
Cuculo Cuculus canorus foreste e/o arbusteti migr. trans-sahariana n.s.<br />
Rondone Apus apus urbani migr. trans-sahariana n.s.<br />
Torcicollo Jynx torquilla agro-ecosistemi migr. trans-sahariana (‒)<br />
Picchio verde Picus viridis foreste e/o arbusteti residente +<br />
Picchio rosso maggiore Dendrocopos major foreste e/o arbusteti residente +<br />
Allodola Alauda arvensis agro-ecosistemi migr. parziale/corto raggio ‒<br />
Rondine Hirundo rustica agro-ecosistemi migr. trans-sahariana ‒<br />
Balestruccio Delichon urbicum urbani migr. trans-sahariana n.s.<br />
Prispolone Anthus trivialis foreste e/o arbusteti migr. trans-sahariana +<br />
Spioncello Anthus spinoletta aperti migr. parziale/corto raggio +<br />
Cutrettola Motacilla flava agro-ecosistemi migr. trans-sahariana n.s.<br />
Ballerina gialla Motacilla cinerea aperti migr. parziale/corto raggio (‒)<br />
Ballerina bianca Motacilla alba agro-ecosistemi migr. parziale/corto raggio ‒<br />
Scricciolo Troglodytes troglodytes foreste e/o arbusteti migr. parziale/corto raggio ‒<br />
Passera scopaiola Prunella modularis foreste e/o arbusteti migr. parziale/corto raggio +<br />
Pettirosso Erithacus rubecula foreste e/o arbusteti migr. parziale/corto raggio n.s.<br />
Usignolo Luscinia megarhynchos foreste e/o arbusteti migr. trans-sahariana (‒)<br />
Codirosso spazzacamino Phoenicurus ochruros aperti migr. parziale/corto raggio +<br />
Codirosso Phoenicurus phoenicurus foreste e/o arbusteti migr. trans-sahariana +<br />
Saltimpalo Saxicola torquata agro-ecosistemi migr. parziale/corto raggio ‒<br />
Culbianco Oenanthe oenanthe aperti migr. trans-sahariana +<br />
Merlo Turdus merula foreste e/o arbusteti migr. parziale/corto raggio n.s.<br />
Tordo bottaccio Turdus philomelos foreste e/o arbusteti migr. parziale/corto raggio +<br />
Usignolo di fiume Cettia cetti agro-ecosistemi residente ‒<br />
Canapino Hippolais polyglotta foreste e/o arbusteti migr. trans-sahariana +<br />
Capinera Sylvia atricapilla foreste e/o arbusteti migr. parziale/corto raggio n.s.<br />
Luì bianco Phylloscopus bonelli foreste e/o arbusteti migr. trans-sahariana n.s.<br />
Luì piccolo Phylloscopus collybita foreste e/o arbusteti migr. parziale/corto raggio ‒<br />
Regolo Regulus regulus foreste e/o arbusteti migr. parziale/corto raggio ‒<br />
Fiorrancino Regulus ignicapilla foreste e/o arbusteti migr. parziale/corto raggio +<br />
Pigliamosche Muscicapa striata foreste e/o arbusteti migr. trans-sahariana +<br />
Codibugnolo Aegithalos caudatus foreste e/o arbusteti residente +<br />
Cincia bigia Poecile palustris foreste e/o arbusteti residente +<br />
Cincia bigia alpestre Poecile montana foreste e/o arbusteti residente n.s.<br />
Cincia dal ciuffo Lophophanes cristatus foreste e/o arbusteti residente n.s.<br />
Cincia mora Periparus ater foreste e/o arbusteti residente n.s.<br />
Cinciarella Cyanistes caeruleus foreste e/o arbusteti residente +<br />
Cinciallegra Parus major foreste e/o arbusteti residente +<br />
Picchio muratore Sitta europaea foreste e/o arbusteti residente n.s.<br />
Rigogolo Oriolus oriolus foreste e/o arbusteti migr. trans-sahariana n.s.<br />
Averla piccola Lanius collurio agro-ecosistemi migr. trans-sahariana ‒<br />
Ghiandaia Garrulus glandarius foreste e/o arbusteti residente +<br />
Gazza Pica pica agro-ecosistemi residente +<br />
Cornacchia grigia Corvus cornix agro-ecosistemi residente (+)<br />
Storno Sturnus vulgaris agro-ecosistemi migr. parziale/corto raggio (+)<br />
Passero d'Italia Passer italiae urbani residente ‒<br />
Passero mattugio Passer montanus agro-ecosistemi migr. parziale/corto raggio (‒)<br />
Fringuello Fringilla coelebs foreste e/o arbusteti migr. parziale/corto raggio n.s.<br />
Verzellino Serinus serinus urbani migr. parziale/corto raggio n.s.<br />
Verdone Carduelis chloris agro-ecosistemi migr. parziale/corto raggio ‒<br />
Cardellino Carduelis carduelis agro-ecosistemi migr. parziale/corto raggio ‒<br />
Ciuffolotto Pyrrhula pyrrhula foreste e/o arbusteti migr. parziale/corto raggio n.s.<br />
Tabella 6. Classificazione delle specie sulla base dei principali ambienti frequentati e della<br />
strategia migratoria, andamento della popolazione regionale (+: aumento significativo;<br />
‒: diminuzione significativa; tra parentesi: quasi significativo; n.s.: andamento non<br />
significativo).<br />
31
Foreste/arbusteti<br />
Figura 2a. Sintesi degli andamenti demografici per specie raggruppate secondo ambiente<br />
di nidificazione.<br />
Figura 2b. Sintesi degli andamenti demografici per specie raggruppate secondo strategia<br />
migratoria.<br />
32<br />
Ambienti aperti<br />
Ambienti urbani<br />
Agro-ecosistemi<br />
<strong>Mi</strong>gr. transahariani<br />
<strong>Mi</strong>gr. parziali<br />
Residenti<br />
1<br />
5<br />
14<br />
4<br />
4<br />
3<br />
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%<br />
In aumento Non significativo In diminuzione<br />
5<br />
7<br />
12<br />
8<br />
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%<br />
In aumento Non significativo In diminuzione<br />
8<br />
13<br />
10<br />
4<br />
8<br />
4<br />
1<br />
1<br />
4<br />
2
Figura 3. Indice di popolazione e suo andamento per il gruppo fenologico delle specie<br />
residenti (18 specie): R=0,028; p
Figura 6. Indice di popolazione e suo andamento per il gruppo ecologico di specie di<br />
ambienti urbani (5 specie): R=‒0,001; p=0,956.<br />
Figura 7. Indice di popolazione e suo andamento per il gruppo ecologico di specie di<br />
ambienti aperti (5 specie): R=0,055; p
35<br />
8-a) specie di<br />
agro-ecosistemi<br />
(19 specie):<br />
R=‒0,012;<br />
p=0,065.<br />
8-b) specie<br />
residenti di<br />
agro-ecosistemi<br />
(4 specie):<br />
R=0,033;<br />
p
36<br />
9-a) specie di<br />
ambienti forestali e/o<br />
arbustivi - tutte le<br />
specie (31 specie):<br />
R=0,022; p
37<br />
DISCUSSIONE<br />
I programmi di monitoraggio sono un utile strumento di valutazione della<br />
distribuzione, consistenza e andamento delle popolazioni animali. La<br />
conoscenza di queste informazioni è a sua volta indispensabile per<br />
intraprendere studi specifici finalizzati ad indagare le cause che<br />
determinano le dinamiche di popolazione, per adottare misure di<br />
gestione, conservazione e per avviare progetti di ripristino per le specie<br />
sottoposte a qualche forma di minaccia. Tuttavia, l’ottenimento di queste<br />
informazioni richiede adeguate e spesso indisponibili risorse economiche<br />
e umane. Perciò è spesso necessario ricorrere a strategie alternative atte<br />
a sfruttare tutti i dati raccolti in diverse circostanze, ovvero informazioni<br />
pertinenti a diversi progetti aventi finalità specifiche differenti. Tali<br />
strategie, pur consentendo di massimizzare l’efficienza economica, non<br />
possono sempre garantire la massima accuratezza del risultato.<br />
Tale approccio, messo in atto nella presente ricerca, ha permesso di<br />
ottenere l’andamento delle popolazioni nidificanti a partire dal 1992, con<br />
l’esclusione di pochi anni, per i quali purtroppo non è stato possibile<br />
ottenere l’informazione desiderata. Purtroppo si è trattato di anni cruciali<br />
(1993 e 1994) per le sorti delle molte popolazioni connesse agli agroecosistemi,<br />
nel corso dei quali si è verosimilmente registrato uno dei cali<br />
più importanti di queste specie.<br />
In ogni caso, negli ultimi anni è possibile disporre di una serie storica<br />
continua e standardizzata che sta permettendo di statistiche sempre più<br />
robuste e informazioni utilizzabili per ulteriori indagini e specifici<br />
approfondimenti.<br />
In questo progetto è stato applicato il metodo descritto in Massimino et<br />
al. (2008) e <strong>Bani</strong> et al. (2009a) per utilizzare i dati di censimenti<br />
dell’avifauna nidificante derivanti da progetti con diverse finalità e che,<br />
quindi, prevedevano piani di campionamento ad hoc, consentendo di<br />
ottenere una serie storica quanto più completa possibile.<br />
Il campione complessivo era costituito da una serie di dati disomogenea e<br />
l’informazione grezza contenuta non poteva fornire dati direttamente<br />
utilizzabili per le finalità specifiche della ricerca, ossia la stima dei trend a<br />
lungo termine delle popolazioni di uccelli nidificanti in Lombardia. Il<br />
metodo impiegato ha quindi permesso di omogeneizzare il campione<br />
rendendo possibile il confronto dei dati contenuti in una serie storica che<br />
va dal 1992 al <strong>2012</strong>, definendo un indice di popolazione, il cui andamento<br />
riflette quello delle popolazioni delle 60 specie analizzate. L’indice è stato<br />
successivamente convertito in popolazione riproduttiva espressa in
coppie; tale conversione è stata possibile assegnando ad ogni specie un<br />
relativo raggio di rilevamento expert-based, ossia concordato dai<br />
rilevatori sulla scorta della propria esperienza.<br />
Alcune specie, come lo spioncello montano, la ballerina gialla, il luì bianco<br />
e il picchio muratore, mostrano intervalli di confidenza piuttosto ampi<br />
della stima di popolazione. Ciò può essere dovuto alla loro specificità<br />
ecologica, che corrisponde ad una scarsa diffusione del loro habitat e,<br />
quindi, un campione relativamente piccolo (pochi punti di ascolto<br />
ricadono in aree idonee) oppure alla loro bassa densità, che causa<br />
un’elevata varianza interna al campione. Nel caso del picchio muratore,<br />
una specie piuttosto comune nella nostra regione, la motivazione può<br />
essere la sua selettività per variabili ambientali che non è stato possibile<br />
considerare nel modello, come la struttura forestale (<strong>Bani</strong> et al. 2006) e<br />
la sua composizione floristica (Matthysen 1987).<br />
L’aggiornamento dei dati relativi all’avifauna nidificante in Lombardia, ha<br />
consentito di appurare il persistere di un andamento negativo per le<br />
specie legate agli ambienti agricoli.<br />
Quelle che suscitano maggiori preoccupazioni sono, come evidenziato già<br />
negli altri anni di studio, l’averla piccola e l’allodola, il cui modello di<br />
crescita della popolazione, applicato sui 21 anni, stima un declino della<br />
popolazione dal 1992 al <strong>2012</strong>, rispettivamente, del 86,2% e del 88,0% 1 .<br />
Queste due specie hanno subito simili riduzioni anche in altre popolazioni<br />
europee: tra il 1970 ed il 1990 l’allodola diminuì di oltre il 50% nel Regno<br />
Unito, nei Paesi Bassi ed in Germania, mentre l’averla piccola ebbe un<br />
declino meno grave, ma comunque superiore al 20% in oltre la metà<br />
della popolazione europea (Tucker & Heath 1994). Negli anni ’90 il<br />
declino di queste specie rallentò in alcune parti del loro areale, ma<br />
proseguì nella maggior parte dei paesi europei (BirdLife International<br />
2004). Le principali cause sono da ricercare nelle modifiche dei loro<br />
habitat causate dall’intensificazione delle pratiche agricole (Newton<br />
2004). In particolare, l’allodola è sensibile alla riduzione della diversità<br />
dei coltivi, all’incremento delle pratiche di aratura e semina autunnali ed<br />
all’uso massiccio di fertilizzanti e pesticidi (de Carli et al. 1998; Donald et<br />
al. 2002), mentre l’averla piccola subisce la rimozione di siepi, filari,<br />
cespuglieti e prati (Shrubb 2003). È probabile che questi processi<br />
giochino un ruolo importante anche nella nostra regione, ove l’agricoltura<br />
intensiva è molto diffusa. Si consideri, ad esempio, che il raccolto medio<br />
1 variazione percentuale delle popolazione = {[(1+R)^(<strong>2012</strong>-1992)]-1}*100<br />
38
di cereali per unità di superficie, ritenuto un ottimo indice di intensità<br />
agricola (Donald et al. 2006), è stato nel 2005 pari a 10 t/ha (ISTAT<br />
2007), più alto del valore medio di qualsiasi altro paese europeo (FAO<br />
2007).<br />
Oltre ad allodola e averla piccola, altre specie di ambienti agricoli o rurali<br />
hanno mostrato un declino tra il 1992 ed il <strong>2012</strong>: si tratta di passero<br />
d’Italia (‒65,6% di diminuzione nel periodo di studio), verdone (‒67,7%),<br />
cardellino (‒73,4%), rondine (‒61,0%), ballerina bianca (‒60,0%). La<br />
rondine e il passero europeo Passer domesticus, che è vicario del passero<br />
d’Italia, sono in diminuzione anche a scala continentale (Pazderová &<br />
Vorisek 2007). Ci sono molte evidenze che anche per loro la causa<br />
principale è l’intensificazione dell’agricoltura. In particolare, la rondine<br />
soffre della perdita di prati (Evans et al. 2007) e della diminuzione del<br />
numero di allevamenti di bestiame (Ambrosini et al. 2002), con<br />
conseguente riduzione delle popolazioni di insetti volanti. È in ogni caso<br />
da considerare che la rondine potrebbe soffrire anche dei cambiamenti<br />
climatici nelle aree di svernamento (Sanderson et al. 2006). Il passero<br />
europeo ha sofferto principalmente della riduzione della disponibilità<br />
alimentare in inverno, sempre dovuta all’intensificazione dell’agricoltura<br />
(Hole et al. 2002). Il declino del passero d’Italia in Lombardia è<br />
confermato anche da uno studio recente di Brichetti et al. (2008) che<br />
hanno stimato una diminuzione del 50% della popolazione nidificante in<br />
città dal 1996 al 2006. Il verdone, invece, è stimato in aumento in<br />
Europa (Donald et al. 2006), ma occorre considerare che per i paesi<br />
mediterranei, dove nidifica la maggior parte della popolazione europea,<br />
gli andamenti sono poco noti e non sono disponibili dati quantitativi<br />
(BirdLife International 2004).<br />
Tra le specie che, pur avendo attualmente un andamento negativo solo<br />
marginalmente significativo, richiedono una certa attenzione vi è il<br />
passero mattugio Passer montanus. Le specie ha mostrato un forte<br />
declino tra il 1992 e il 1995 e, da allora ad oggi, alterna fasi di recupero e<br />
di perdita. Ancora oggi, nel <strong>2012</strong>, il passero mattugio possiede una delle<br />
popolazioni minori dell’intero periodo di monitoraggio, con un valore di<br />
circa 28.000 coppie, valore molto al di sotto della consistenza registrata<br />
all’inizio del periodo di monitoraggio con 86.000 coppie. Il calo della<br />
popolazione di passero mattugio nell’ultima decade del secolo scorso è<br />
confermata anche per molti altri paesi europei (BirdLife International<br />
2004).<br />
Un’altra specie tipica dei paesaggi agricoli sulla quale deve essere posta<br />
l’attenzione, poiché mostra un seppur lieve ma significato declino<br />
(‒2,1%), è l’usignolo. La specie oltre a manifestare significative variazioni<br />
tra un anno e l’altro, mantiene una popolazione su livelli molto inferiori a<br />
39
quelli registrati nel 1992, tanto che oggi le coppie nidificanti sono circa il<br />
40% di quelle censite all’epoca.<br />
Per quanto concerne invece i paesaggi dominati da ambienti seminaturali,<br />
va notato come solo alcune specie siano in regresso<br />
significativo, il regolo e luì piccolo, o quasi significativo, la ballerina gialla,<br />
rispetto all’andamento generale positivo dell’avifauna che qui si<br />
riproduce. In particolare il regolo mostra forti e a volte significative<br />
oscillazioni interannuali con anni decisamente sfavorevoli (come il 2009<br />
con circa 7000 coppie) e anni in cui si assiste ad un deciso recupero (ad<br />
esempio il <strong>2012</strong> con poco più di 40.000 coppie; nonostante il recente<br />
recupero, la popolazione appare comunque ridotta rispetto ai valori medi<br />
osservati nella prima parte della serie temporale con picchi di 90.000-<br />
70.000 coppie. Anche il luì piccolo, come il regolo, ha manifestato<br />
un’esplosione demografica nel 1996 (135.000 coppie), a cui è seguita<br />
una fase di calo demografico pressoché costante, se si eccettua un<br />
parziale recupero nel biennio 2007-2008 (70.000-80.000 coppie circa);<br />
oggi la sua popolazione si attesta intorno alle 35.000 coppie, valore tra i<br />
più bassi, ma in linea con quelli degli anni più sfavorevoli. La ballerina<br />
gialla, invece, dopo i picchi demografici del biennio 1995-1996 (15.000-<br />
18.000 coppie) è andata calando, seppur con oscillazioni, fino al 2006,<br />
quando la popolazione si è assestata intorno alle 5000-8000 coppie fino<br />
al. 2011. Nel <strong>2012</strong> la specie ho mostrato un certo incremento (seppur il<br />
dato denoti una discreta incertezza nella stima della popolazione),<br />
raggiungendo le circa 17.000 coppie. Nonostante ciò la tendenza a lungo<br />
termine appare marginalmente significativa, con una diminuzione media<br />
annua del ‒3,5%.<br />
Infine, l’andamento a lungo termine negativo e quasi significativo del<br />
merlo è dovuto alla flessione della sua popolazione dal 1992 al 2004<br />
(quando scende sotto le 55.000 coppie), in parte spiegabile con gli effetti<br />
della patologia legata alla diffusione dell’USUTU virus che ha colpito molte<br />
popolazioni europee di questa specie nel 2000-2001; dal 2005 in poi<br />
invece il merlo ha mostrato una fase di recupero degli effettivi<br />
stabilizzandosi negli ultimi anni ad un livello intorno alle 75.000 coppie,<br />
valore comunque significativamente lontano dalle circa 100.000<br />
registrate nel 1992.<br />
Complessivamente la ricerca ha permesso di mettere a fuoco quelle che<br />
sono le principali criticità relativamente all’avifauna nidificante. Senza<br />
dubbio i gruppi più colpiti, come risulta dall’andamento significativo e<br />
negativo su lungo periodo, sono quelli delle specie migratrici a lungo<br />
raggio e delle migratrici parziali o a corto raggio che si riproducono negli<br />
agro-ecosistemi (figure 8-c e 8-d). Tali gruppi sono rappresentati da<br />
specie che compiono il loro ciclo vitale annuale in aree geografiche<br />
40
diverse, e sono quindi costrette a movimenti migratori che riportano gli<br />
uccelli dai quartieri di svernamento a quelli di nidificazione e viceversa.<br />
Affinché le risorse possano essere adeguatamente utilizzate, i movimenti<br />
migratori devono essere sincronizzati con i periodi in cui si rendono<br />
disponibili le risorse. Dal momento che i movimenti migratori sono<br />
regolati da fattori endogeni ed esogeni piuttosto rigidi che attivano i<br />
processi fisiologici necessari a dare inizio al viaggio migratorio, appare<br />
difficile modificarli ad un ritmo pari a quello con cui avanza la primavera<br />
climatica. D’altro canto, essendo che la disponibilità di risorse è invece<br />
legata a fattori proprio di tipo climatico e, quindi, differenti da quelli che<br />
agiscono sugli uccelli, ciò può produrre una sfasamento tra la disponibilità<br />
di risorse e l’arrivo dell’avifauna nelle aree riproduttive. Al documentato<br />
anticipo della primavera climatica, non corrisponde quindi un altrettanto<br />
avanzamento della primavera migratoria. Questo si concretizza con un<br />
verosimile svantaggio per le specie migratrici che, non trovandosi “nel<br />
luogo giusto al momento giusto” perdono la possibilità di un adeguato<br />
sfruttamento delle risorse. Per contro, il gruppo delle specie residenti (sia<br />
considerando l’intero gruppo fenologico, sia soltanto le specie residenti<br />
connesse agli agro-ecosistemi) può trarre beneficio delle risorse non<br />
appena queste si rendono disponibili, mentre i gruppi migratori (a corto e<br />
lungo raggio), tendono a presentarsi all’appuntamento con le risorse con<br />
un ritardo più o meno marcato.<br />
È tuttavia interessante notare che gli effetti demografici del ritardo non si<br />
osservano se considerate tutte le specie migratrici nel loro insieme (lungo<br />
e corto raggio), ma appare evidente solo per le specie che si riproducono<br />
negli agro-ecosistemi. È possibile che le specie migratrici che si<br />
riproducono negli ambienti naturali e semi-naturali (boschi, arbusteti,<br />
ambienti aperti di media e alta quota) non subiscano una limitazione di<br />
risorse come invece sembra avvenire negli ambienti coltivati di pianura.<br />
Potrebbe trattarsi di ambienti non ancora saturati nella loro capacità,<br />
come evidenziati dalle tendenze demografiche in significativa ascesa<br />
(l’unico gruppo non in crescita significativa, ma ai limiti della<br />
significatività, p=0,113, è quello delle specie migratrici parziali di<br />
ambienti forestali e/o arbustivi).<br />
Andamenti generalmente favorevoli sono stati invece riscontrati nelle<br />
specie forestali (figura 9-a). Nel complesso, l’andamento positivo delle<br />
popolazioni lombarde delle specie sensibili alla struttura forestale (es.<br />
piciformi, cincia bigia, ...) può essere parzialmente spiegato dalla<br />
riduzione della raccolta del legname che ha permesso un aumento medio<br />
della maturità forestale a scala regionale (ASR della Lombardia 2005),<br />
che ha reso alcune risorse evidentemente meno limitanti.<br />
41
Sostanzialmente stabili sono invece le popolazioni delle altre specie<br />
forestali, ad eccezione del luì piccolo e del regolo. La ragione del calo di<br />
queste due specie potrebbe essere l’oggetto di specifiche ricerche. Per<br />
quanto riguarda il luì piccolo, infatti, è in calo anche in altri paesi Europei,<br />
tra cui la Francia, dove nidifica la principale popolazione continentale<br />
(Jiguet et al. 2006).<br />
Dato il generalizzato e allarmante declino delle specie di ambiente<br />
agricolo, soprattutto relativamente alle specie migratrici, è auspicabile la<br />
prosecuzione del monitoraggio, in modo da valutare su un arco temporale<br />
quanto più lungo possibile le tendenze in atto e, laddove possibile,<br />
intraprendere progetti per la valutazione dei processi in corso e in modo<br />
da progettare specifiche azioni di pianificazione e/o di ripristino che<br />
consentirebbero di programmare nel modo più appropriato una politica di<br />
gestione sostenibile del territorio. Il quanto meno ineluttabile declino<br />
prodotto dai cambiamenti climatici che favorisce residenti rispetto alle<br />
migratrici, potrebbe essere contrastato da azioni locali finalizzate a<br />
limitare gli effetti negativi prodotti dallo sfasamento temporale della<br />
migrazione. Tali azioni, identificabili grazie alla predisposizione di<br />
specifiche ricerche, rendendo meno limitanti alcuni fattori locali,<br />
analogamente a quanto è avvenuto per le specie migratrici che si<br />
riproducono in ambienti naturali o semi-naturali.<br />
42
43<br />
SVILUPPI FUTURI<br />
Due sono gli aspetti tecnici intrinseci al programma di monitoraggio che<br />
dovrebbero essere superati per ottenere informazioni ancora più<br />
dettagliate per il loro utilizzo in campo conservazionistico e gestionale.<br />
Uno primo problema che si può evidenziare riguarda la difficoltà nel<br />
passare dall’abbondanza alla densità e, quindi, ad una stima accurata<br />
dell’entità della popolazione. La causa di questo problema risiede nella<br />
difficoltà oggettiva di stimare il raggio di rilevamento specie-specifico,<br />
ossia il raggio entro il quale è possibile rilevare una data specie.<br />
Una seconda difficoltà riguarda invece la possibilità di stimare la<br />
probabilità di rilevamento, altro parametro importante per arrivare a<br />
superare la stima in difetto della popolazione totale.<br />
Nonostante queste due problematiche, la stima dell’andamento della<br />
popolazione rimane comunque robusto e affidabile, in quanto è<br />
indipendente sia dalla densità, sia dalla probabilità di rilevamento.<br />
Tuttavia, la stima delle densità e della popolazione totale, potrebbero<br />
essere di interesse per diverse valutazioni di tipo conservazionistico e<br />
gestionale. Pertanto, un ulteriore sviluppo del presente programma di<br />
monitoraggio potrebbe prendere in considerazione la pianificazione di<br />
ricerche mirate per ovviare ai succitati problemi.<br />
Una quantificazione oggettiva dei raggi di rilevamento specie-specifici<br />
potrebbe essere effettuata per mezzo dell’impiego di telemetri in grado di<br />
valutare la distanza tra il rilevatore e gli individui censiti. Mentre la<br />
valutazione della probabilità di rilevamento potrebbe essere effettuata<br />
pianificando una reiterazione dei censimenti (<strong>Bani</strong> et al. in prep.)<br />
Un interessante sviluppo futuro della presente ricerca deriva dai risultati<br />
messi in risalto dalla stessa.<br />
Per valutare i fattori e i processi che hanno determinato, e tutt’oggi<br />
producono, un marcato calo demografico delle specie legate agli agroecosistemi<br />
durante il periodo riproduttivo, sarebbe utile avviare una<br />
ricerca volta a chiarire come differenti tipologie colturali (individuate in<br />
4/5 aree campione) agiscano nel limitare lo spazio ecologico delle diverse<br />
specie di uccelli, colpendo le loro popolazioni in modo diretto (es.<br />
riduzione dell’habitat disponibile) o indiretto (limitazione delle risorse<br />
trofiche per massiccio uso di pesticidi). Tale ricerca potrebbe rendere più<br />
comprensibili anche gli effetti prodotti dallo sfasamento dei movimenti
migratori alla luce di un avanzamento della primavera climatica e capire<br />
come agiscono differentemente all’interno degli agro-ecosistemi piuttosto<br />
che nei paesaggi forestali.<br />
Le specie che maggiormente si prestano a questo studio e che, peraltro,<br />
evidenziano i cali o variazioni più marcati sono:<br />
• quaglia, specie di interesse conservazionistico e<br />
venatorio;<br />
• allodola, specie di interesse conservazionistico e<br />
venatorio;<br />
• rondine, specie di interesse conservazionistico;<br />
• averla piccola, specie di interesse comunitario ai sensi<br />
della Direttiva 79/409/CEE (Direttiva Uccelli).<br />
La ricerca potrebbe valutare quantitativamente gli effetti prodotti dalle<br />
pratiche gestionali e colturali che inducono riduzione, degrado,<br />
frammentazione e isolamento degli habitat; tale analisi potrebbe essere<br />
condotta facendo ricorso alle più aggiornate tecnologie e informazioni<br />
disponibili (foto aeree, cartografie digitali, banche dati ambientali)<br />
elaborate per mezzo di Sistemi Informativi Territoriali e programmi<br />
statistici.<br />
In aggiunta, la ricerca potrebbe indagare l’entità delle risorse trofiche<br />
disponibili e la loro abbondanza relativa in diversi contesti ambientali.<br />
Infine, si potrebbero valutare gli effetti prodotti dalle moderne pratiche<br />
agricole e dall’uso di fitofarmaci o pesticidi (erbicidi e insetticidi) quale<br />
fattori limitanti le risorse trofiche delle specie e gli effetti del loro ingresso<br />
nella catena trofica: in questo caso sarebbe possibile accertare la<br />
presenza di prodotti xenobionti per mezzo di analisi eco-tossicologiche,<br />
facendo ricorso a moderne tecnologie gas-cromatografiche per la<br />
determinazione dei composti chimici eventualmente accumulati nelle<br />
specie-preda. Significativi risultati potrebbero essere ottenuti già dopo un<br />
anno di attività.<br />
44
45<br />
BIBLIOGRAFIA<br />
Akaike H. 1973. Information Theory and an Extension of the Maximum Likelihood<br />
Principle. In B.N. Petrov & F. Csaki (eds.), 2nd International Symposium on Information<br />
Theory. Akademia Kiado, Budapest.<br />
Ambrosini R., <strong>Bani</strong> L., Massimino D., Fornasari L. & Saino N. 2011a. Large scale spatial<br />
distribution of breeding Barn Swallows Hirundo rustica in relation to cattle farming. Bird<br />
Study.<br />
Ambrosini R, Massimino D., Orioli V. & <strong>Bani</strong> L. 2011b. Identification of putative wintering<br />
areas and ecological determinants of population dynamics of Common House-Martin<br />
(Delichon urbicum) and Common Swift (Apus apus) breeding in Northern Italy. Avian<br />
Conservation and Ecology - Écologie et conservation des oiseaux 6(1): 3.<br />
http://dx.doi.org/10.5751/ACE-00439-060103<br />
Ambrosini R., Bolzern A.M., Canova L., Arieni S., Møller A.P. & Saino N. 2002. The<br />
distribution and colony size of barn swallows in relation to agricultural land use. Journal of<br />
Applied Ecology 39: 524-534.<br />
ASR della Lombardia. 2005. Annuario statistico regionale della Lombardia. Regione<br />
Lombardia, <strong>Mi</strong>lano.<br />
http://www.ring.lombardia.it/asrnewe/index.html.<br />
<strong>Bani</strong> L., Baietto M., Bottoni L. & Massa R. 2002. The Use of Focal Species to Design a<br />
Habitat Network for a Lowland Area of Lombardy, Italy. Conservation Biology 16 (3): 826-<br />
831.<br />
<strong>Bani</strong> L., Massimino D., Bottoni L. & Massa R. 2006. A multiscale method for selecting<br />
indicator species and priority conservation areas: a case study for broadleaved forests in<br />
Lombardy, Italy. Conservation Biology 20: 512-526.<br />
<strong>Bani</strong> L., Massimino D., Orioli V., Bottoni L. & Massa R. 2009. Assessment of population<br />
trends of common breeding birds in Lombardy, northern Italy, 1992-2007. Ethology<br />
Ecology & Evolution 21: 27-44.<br />
<strong>Bani</strong> L., Massimino D., Orioli V., Vigorita V, Cucè L. & Massa R. 2009. Analisi degli<br />
andamenti demografici dal 1992 ad oggi di 60 specie di uccelli nidificanti in Lombardia.<br />
Alula XVI (1-2): 467-472.<br />
Bibby C.J., Burgess N.D., Hill D.A. & Mustoe S. 2000. Bird census techniques. 2 a edizione,<br />
Academic Press, London.<br />
BirdLife International. 2004. Birds in Europe: population estimates, trends and<br />
conservation status. BirdLife International, Cambridge.<br />
Blondel J., Ferry C. & Frochot B. 1970. La méthode des indices ponctuels d’abondance<br />
(I.P.A.) ou des relevés d’avifaune par “stations d’écoute”. Alauda 38: 55-71.<br />
Blondel J., Ferry C. & Frochot B. 1981. Point counts with unlimited distance. In C.J. Ralph<br />
e J.M. Scott (curatori). Estimating numbers of terrestrial birds. Studies in Avian Biology 6:<br />
414-420.<br />
Brichetti P., Rubolini D., Galeotti P. & Fasola M. 2008. Recent declines in urban Italian<br />
Sparrow Passer (domesticus) italiae populations in northern Italy. Ibis 150: 177-181.<br />
Brotons L., Herrando S. & Pla M. 2007. Updating bird species distribution at large spatial<br />
scales: applications of habitat modelling to data from long-term monitoring programs.<br />
Diversity and Distributions 13: 276-288.<br />
de Carli, E., Fornasari L., <strong>Bani</strong> L. & Bottoni L. 1998. Trends in distribution, abundance and<br />
habitat features of skylark (Alauda arvensis) in northern Italy. Gibier Faune Sauvage-<br />
Game Wildl. 15, parte 2: 387-396.
Donald P.F., Evans A.D., Muirhead L.B., Buckingham D.L., Kirby W.B. & Schmitt S.I.A.<br />
2002. Survival rates, causes of failure and productivity of Skylark Alauda arvensis nests<br />
on lowland farmland. Ibis 144: 652-664.<br />
Donald P.F., Sanderson F.J., Burfield I.J. & van Bommel F.P.J. 2006. Further evidence of<br />
continent-wide impacts of agricultural intensification on European farmland birds, 1990-<br />
2000. Agriculture, Ecosystems and Environment 116: 189-196.<br />
EEA 2004. Corine Land Cover 2000. European Environment Agency.<br />
Efron B. 1982. The jackknife, the bootstrap and other resampling methods. Society for<br />
Industrial and Applied Mathematics, CBMS-NSF Monograph 38. Philadelphia.<br />
ERSAF. 2010. Uso del suolo in Regione Lombardia: i dati Dusaf. Ente Regionale per i<br />
Servizi all’Agricoltura e alle Foreste.<br />
ERSAF. 2006. Carta dei Tipi Forestali. Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle<br />
Foreste.<br />
Evans K.L., Wilson J.D. & Bradbury R.B. 2007. Effects of crop type and aerial invertebrate<br />
abundance on foraging barn swallows Hirundo rustica. Agriculture, Ecosystems &<br />
Environment 122: 267-273.<br />
FAO. 2007. Faostat core production data. Food and Agriculture Organization of the united<br />
nations. http://faostat.fao.org/site/340/default.aspx.<br />
Fornasari L., <strong>Bani</strong> L., de Carli E. & Massa R. 1998. Optimum design in monitoring common<br />
birds and their habitat. Gibier Faune Sauvage-Game Wildl. 15, Parte 2: 309-322.<br />
Gotelli N.J. 2001. A primer of Ecology. 3 a edizione, Sinauer Associates, Sunderland.<br />
Gregory R.D., Vorisek P., van Strien A., Meyling A.W.G., Jiguet F., Fornasari L., Reif J.,<br />
Chylarecki P. & Burfeld I.J. 2007. Population trends of widespread woodland birds in<br />
Europe. Ibis 149: 78-97.<br />
Guisan A. & Thuiller W. 2005. Predicting species distribution: offering more than simple<br />
habitat models. Ecology Letters 8: 993-1009.<br />
Hole D.G., Whittingham M.J., Bradbury R.D., Anderson G.Q.A., Lee P.L.M., Wilson J.D. &<br />
Krebs J.R. 2002. Widespread local house-sparrow extinctions. Nature 418: 931-932.<br />
ISTAT. 2007. Dati su agricoltura e zootecnia. Istituto Nazionale di Statistica.<br />
http://www.istat.it/agricoltura/datiagri/coltivazioni/.<br />
Jiguet F., Julliard R. & Weltz M. 2006. État de santé des populations d’Oiseaux nicheurs en<br />
France de 1989 à 2001. http://www.mnhn.fr/mnhn/crbpo/.<br />
Massa R., <strong>Bani</strong> L., Massimino D. & Bottoni L. 2003. La biodiversità delle foreste valutata<br />
per mezzo delle comunità di uccelli. Progetto strategico 9.1.6: Azioni di salvaguardia del<br />
patrimonio boschivo. Fase VII: Conservazione e incremento della biodiversità delle foreste<br />
mediante interventi di gestione integrata della componente faunistica. Regione<br />
Lombardia–Agricoltura.<br />
Massimino D., Gagliano C., Gasparini P., Orioli V. & <strong>Bani</strong> L. Sottoposto. Influence of forest<br />
characteristics on the abundance of bird indicator species in Lombardy, Italy. Ethology<br />
Ecology & Evolution.<br />
Massimino D., Orioli V., Massa R. & <strong>Bani</strong> L. 2008. Population trend assessment on a large<br />
spatial scale: integrating data collected with heterogeneous sampling schemes by means<br />
of habitat modelling. Ethology Ecology & Evolution 20:141-153.<br />
Massimino D., Orioli V., Massa R. & <strong>Bani</strong> L. 2008. Population trend assessment on a large<br />
spatial scale: integrating data collected with heterogeneous sampling schemes by means<br />
of habitat modelling. Ethology Ecology & Evolution 20: 141-153.<br />
Massimino D., Orioli V., Pizzardi F., Massa R. & <strong>Bani</strong> L. 2010. Usefulness of coarse grain<br />
data on forest management to improve bird abundance models. Italian Journal of Zoology<br />
77: 71-80<br />
Matthysen E. 1987. A long-term study on a population of the European nuthatch Sitta<br />
europaea caesia Wolf. Sitta 1: 2-17<br />
46
McCullagh P. & Nelder J.A. 1989. Generalized Linear Models. 2 a edizione, Chapman and<br />
Hall, London.<br />
Nelder J.A. & Wedderburn R.W.M. 1972. ‘Generalized linear models. Journal of the Royal<br />
Statistical Society, Series A 135: 370-384.<br />
Newton I. 2004. The recent declines of farmland bird populations in Britain: an appraisal<br />
of causal factors and conservation actions. Ibis 146: 579-600.<br />
Pazderová A. & Vorisek P. 2007. Trends of common birds in Europe, 2007 update.<br />
European Bird Census Council. http://www.ebcc.info/index.php?ID=148.<br />
Quinn G.P. & Keough M.J.. 2002. Experimental Design and data Analysis for Biologists.<br />
Cambridge <strong>Univ</strong>ersity Press, Cambridge.<br />
R Development Core Team. 2008. R: a language and environment for statistical<br />
computing. R Foundation for Statistical Computing. Vienna.<br />
Regione Lombardia. 2003. DTM 20 Modello Digitale del Terreno1.0. Regione Lombardia.<br />
Direzione Generale Territorio e Urbanistica.<br />
Rushton S.P., Ormerod S.J. & Kerby G. 2004. New paradigms for modelling species<br />
distribution? Journal of Applied Ecology 41: 193-200.<br />
Sanderson F.J., Donald P.F., Pain D.J., Burfield I.J. & van Bommell F.P.J. 2006. Long-term<br />
population declines in Afro-Palearctic migrant birds. Biological Conservation 131: 93-105.<br />
Shrubb M. 2003. Birds, Scythes and Combines. A History of Birds and Agricultural<br />
Change. Cambridge <strong>Univ</strong>ersity Press, Cambridge.<br />
Tucker G.M. & Heath M.F.. 1994. Birds in Europe: their conservation status. BirdLife<br />
International, Cambridge.<br />
Vernier P.R., Schmiegelow F.K.A. & Cumming S.G. 2002. Modelling bird abundance from<br />
forest inventory data in the boreal mixed-wood forests of Canada. In Scott J.M., Heglund<br />
P.J., Morrison M.L., Haufler J.B., Raphael M.G., Wall W.A. & Samson F.B. (eds.),<br />
Predicting Species Occurrences. Issues of accuracy and scale. Island Press, Washington.<br />
Vigorita V. & Cucé L. (red.). 2008. La Fauna selvatica in Lombardia. Rapporto 2008 su<br />
distribuzione, abbondanza e stato di conservazione di Uccelli e Mammiferi. Regione<br />
Lombardia-DG Agricoltura, <strong>Univ</strong>ersità degli Studi di <strong>Mi</strong>lano-<strong>Bicocca</strong>, <strong>Univ</strong>ersità<br />
dell’Insubria, <strong>Univ</strong>ersità degli Studi di Pavia.<br />
Visser H. 2004. Estimation and detection of flexible trends. Atmospheric Environments<br />
38: 4135-4145.<br />
47
48<br />
APPENDICE<br />
MONITORAGGIO DELL’AVIFAUNA NIDIFICANTE IN LOMBARDIA<br />
1992-<strong>2012</strong><br />
Grafici degli andamenti di popolazione commentati con indicazione<br />
dell’andamento regionale ed eventuali significativi andamenti a scala subregionale.<br />
Nel grafico, tra parentesi, è indicato il numero di rilevamenti<br />
utilizzati per il calcolo dell’indice di popolazione annuale.
Poiana Buteo buteo Andamento a scala regionale: n.s.<br />
La popolazione della poiana non evidenzia un andamento significativo a lungo termine. Tuttavia è<br />
abbastanza evidente come nel periodo centrale del monitoraggio le consistenze risultino, in qualche annata,<br />
significativamente più elevate. Infatti, ad una crescita registrata nella metà degli anni ’90, con una<br />
popolazione massima nel 2002 di circa 1800 coppie, è seguita una fase di modesto regresso fluttuante che<br />
fa attestare la popolazione regionale negli ultimi quattro anni tra 600 e 1000 coppie circa. La ricerca delle<br />
cause di questo andamento andrebbe svolta per mezzo di ulteriori analisi, esplorando i possibili effetti di<br />
condizioni meteo-climatiche nella stagione riproduttiva e in quella di svernamento.<br />
Gheppio Falco tinnunculus Andamento a scala regionale: +3,7%<br />
Il gheppio è una specie in significativa espansione numerica in regione Lombardia, la cui ascesa graduale e<br />
regolare è documentata dall’inizio del periodo di monitoraggio fino al 2006, anno in cu si è registrata la<br />
massima popolazione (circa 2100 coppie). Da questo anno in poi è invece seguita una significativa fase di<br />
regresso che fa attestare attualmente la popolazione regionale a circa 1200 coppie. Questa flessione<br />
potrebbe essere interpretata come un meccanismo dinamico innescato da una ripresa relativamente rapida<br />
della popolazione, in seguito ad un uso più razionale di pesticidi in campo agricolo, a cui può seguire una<br />
serie di oscillazioni attorno alla capacità portante del sistema. Analisi esplorative inoltre portano a non<br />
escludere un possibile effetto negativo giocato da eccessive precipitazioni nel corso della stagione di<br />
nidificazione precedente che, limitando il successo riproduttivo, influiscono sull’entità della popolazione<br />
registrata l’anno seguente.<br />
49<br />
Coppie nidificanti Coppie nidificanti
Quaglia Coturnix coturnix Andamento a scala regionale: n.s.<br />
L’andamento demografico della quaglia risulta abbastanza peculiare, sopratutto per l’evidente picco<br />
demografico del 2005. Dopo accurate verifiche, tale dato non risulterebbe essere il prodotto di un artefatto e<br />
l’ingente popolazione registrata, circa 14.000 coppie, potrebbe essere il risultato di irruzioni di individui<br />
riproduttori ed estivanti provenienti da aree a clima più mediterraneo in anni in cui tali aree sono soggette a<br />
condizioni di particolare siccità. Non è inoltre da escludere l’effetto di particolari condizioni favorevoli nel<br />
corso della stagione riproduttiva precedente o nei quartieri di svernamento sub-sahariani. Per il resto, se si<br />
esclude un minimo meno di 1000 coppie nel 1996, la popolazione risulta moderatamente fluttuante tra circa<br />
2500 e 6000 coppie.<br />
Fagiano Phasianus colchicus Andamento a scala regionale: +8,5%<br />
Andamento a scala sub-regionale: Pianura seminativa: +12,5%<br />
Pianura risicola: +7,2%<br />
Al di là di possibili variazioni demografiche imputabili a ripopolamenti per scopi venatori, la popolazione<br />
lombarda di fagiano evidenzia un incremento significativo nel corso del periodo di monitoraggio, un aumento<br />
medio annuo a scala regionale del 8,5%. Attualmente la popolazione ammonta a quasi 10.000 coppie, che<br />
rappresenta la consistenza massima stimata per l’intero periodo di monitoraggio. L’incremento massimo<br />
avviene a livello della principale popolazione lombarda, quella della “Pianura seminativa” (62% della<br />
popolazione regionale), con un aumento medio annuo del 12,5%.<br />
50<br />
Coppie nidificanti<br />
Coppie nidificanti
Gallinella d’acqua Gallinula chloropus Andamento a scala regionale: n.s.<br />
Andamento a scala sub-reg.: Pianura risicola: (-3,4%)<br />
La popolazione di gallinella d’acqua non mostra un andamento significativo tra il 1992 e il <strong>2012</strong>. Sono<br />
tuttavia evidenti alcune significative fluttuazioni che portano la popolazione ad oscillare tra una stima<br />
minima del 2007 con circa 6000 coppie a una massima del 2000 con oltre 16.000 coppie. Tale andamento<br />
potrebbe in parte essere spiegato dall’esistenza di una relazione positiva con le precipitazioni durante il<br />
periodo di nidificazione nella stagione precedente che se troppo scarse possono parzialmente compromette il<br />
successo della riproduzione. Attualmente la popolazione ammonta a circa 9000 coppie.<br />
Colombaccio Columba palumbus Andamento a scala regionale: +13,6%<br />
Andamento a scala sub-regionale: Alta pianura: (+4,5%)<br />
Pianura seminativa: +17,2%<br />
Pianura risicola: +8,5%<br />
Pianura urbana +13,5%<br />
Il colombaccio evidenzia un incremento significativo a lungo termine (+13,6%). Tuttavia, la principale fase<br />
di espansione demografica coincide con gli ultimi anni del periodo di monitoraggio (dal 2006), poiché se si<br />
considera il periodo 1992-2004 la popolazione ha oscillato tra le 8000 e le 3500 coppie, semmai con una<br />
lieve tendenza al regresso. Negli ultimi due anni la popolazione regionale ha raggiunto la massima<br />
consistenza dall’inizio del periodo di monitoraggio, con un numero di coppie stimato di circa 17.500 e con un<br />
aumento che interessa la principale popolazione lombarda, quella della “Pianura seminativa” (42% della<br />
popolazione regionale), dove l’incremento medio annuo registrato ammonta al 17,2%. Aumenti importanti i<br />
hanno anche per la “Pianura urbana” (+13,5%) e la “Pianura risicola” (+8,5%).<br />
51<br />
Coppie nidificanti<br />
Coppie nidificanti
Tortora dal collare Streptopelia decaocto Andamento a scala regionale: +5,0%<br />
Andamento a scala sub-reg.: Pianura seminativa: +5,8%<br />
Pianura urbana: +7,8%<br />
La tortora dal collare evidenza un andamento della popolazione molto peculiare. Infatti, appare evidente<br />
come dopo un’ascesa piuttosto regolare, che ha portato a raggiungere il massimo della popolazione<br />
regionale nel 2003 (con 87.500 coppie nidificanti), sia intervenuta una fase oscillatoria con una modesta<br />
flessione e un nuovo recupero fino al raggiungimento dell’attuale massimo sull’intero periodo di<br />
monitoraggio di circa 97.000 coppie. La tendenza a lungo termine rimane decisamente positiva a scala<br />
regionale, con un incremento medio annuo del 5,0%. Un tasso di incremento maggiore, pari al 5,8%, si ha<br />
per la principale popolazione regionale (63%), quella della “Pianura seminativa”, mentre la seconda<br />
popolazione per importanza (14%) quella della “Pianura urbana” cresce al ritmo medio annuo del 7,8%.<br />
Tortora Streptopelia turtur Andamento a scala regionale: n.s.<br />
La tortora, nell’arco temporale del monitoraggio, non evidenzia un andamento significativo delle sue<br />
popolazioni; mostra piuttosto fasi cicliche di espansione e regresso, con alcune significative oscillazioni che<br />
potrebbero essere in parte dovute alla variazione delle condizioni meteorologiche e ambientali sia nei luoghi<br />
di nidificazione sia in quelli di svernamento. La popolazione attuale si attesta su valori medi con un numero<br />
di coppie nidificanti pari a circa 16.000 coppie.<br />
52<br />
Coppie nidificanti<br />
Coppie nidificanti
Cuculo Cuculus canorus Andamento a scala regionale: n.s.<br />
Andamento a scala sub-regionale: Alta pianura: +4,0%<br />
Boschi di latifoglie: +4,4%<br />
L’analisi dell’andamento demografico del cuculo evidenzia la sostanziale stabilità delle sue popolazioni a<br />
scala regionale. La popolazione massima è stata tuttavia stimata per il primo anno di monitoraggio con<br />
11.500 coppie, mentre dal 1996, anno di minima popolazione con circa 5500 coppie, appare oscillare tra le<br />
6000 e le 9000 coppie circa. Tali variazioni potrebbero essere in parte spiegate dall’effetto negativo<br />
determinato da un eccesso di precipitazioni piovose nel corso della stagione di nidificazione precedente che<br />
sarebbero in grado di influenzare negativamente il successo riproduttivo della specie e quindi della<br />
popolazione censita l’anno successivo. Da notare invece che le popolazioni dell’“Alta pianura” e quella dei<br />
“Boschi di latifoglie” crescono con un tasso medio annuo rispettivamente del 4,0% e 4,4%.<br />
Rondone Apus apus Andamento a scala regionale: n.s.<br />
Andamento a scala sub-regionale: Pianura risicola: (-4,0%)<br />
Attualmente la popolazione di rondone non risulta significativamente in regresso a scala regionale, anche se<br />
sono evidenti forti oscillazioni interannuali. Dopo un calo marcato tra 1992 e 1995, la specie ha riguadagnato<br />
lentamente i propri effettivi, tanto che nel 2004 la popolazione raggiungeva una consistenza simile a quella<br />
del 1992 (poco meno di 200.000 coppie). Successivamente la popolazione si è nuovamente contratta, tanto<br />
da raggiungere un minimo storico nel 2007 con 42.500 coppie. La popolazione si è poi moderatamene<br />
ripresa e oggi si attesta a circa 82.000 coppie. Le marcate e significative fluttuazioni interannuali potrebbero<br />
essere dovute a eccessi di precipitazioni nel corso della stagione riproduttiva dell’anno precedente rispetto a<br />
quello di censimento: l’eccesso di piovosità può infatti determinare un diminuzione del successo riproduttivo.<br />
Un contributo alle fluttuazioni demografiche è dato anche da fattori che agiscono nelle aree di svernamento<br />
sub-sahariane.<br />
53<br />
Coppie nidificanti<br />
Coppie nidificanti
Torcicollo Jynx torquilla Andamento a scala regionale: (-3,3%)<br />
Andamento a scala sub-regionale: Pianura seminativa: (-5,6%)<br />
Pianura urbana:(-4,8%)<br />
La popolazione di torcicollo complessivamente mostra a lungo termine una tendenza marginalmente<br />
significativa, lo stesso avviene per la “Pianura seminativa” e per la “Pianura urbana”. Dal grafico regionale<br />
sono inoltre evidenti alcune marcate fluttuazioni interannuali. Particolarmente evidente è quella registrata<br />
tra il 2006 e il 2007 quando la popolazione, al di là degli intervalli di confidenza, risulta quintuplicata. Tale<br />
fenomeno, pur spiegabile in termini di capacità biologica della specie (il torcicollo può arrivare a deporre fino<br />
a 12 uova per nidiata, e può portare a termine due covate per stagione), resta da interpretare dal punto di<br />
vista ecologico. Almeno per quanto riguarda le condizioni durante il periodo riproduttivo, non sono evidenti<br />
significative relazioni con piovosità e temperatura. Restano tuttavia da indagare possibili fattori che possono<br />
aver agito nei quartieri di svernamento sub-sahariani.<br />
Picchio verde Picus viridis Andamento a scala regionale: +5,5%<br />
Andamento a scala sub-regionale - Pianura seminativa: +23,0%<br />
Il picchio verde mostra un andamento demografico in crescita. Il significativo incremento, che<br />
contraddistingue molte altre specie forestali, potrebbe essere imputabile a una diminuzione dello<br />
sfruttamento forestale che ha comportato una evoluzione delle cenosi boschive verso condizione di maggiore<br />
maturità, favorendo l’espansione demografica e, in alcuni, casi anche in areale delle specie più esigenti che<br />
nidificano in cavità persino all’interno di aree meno idonee (come testimonia l’elevato tasso di incremento<br />
del picchio verde nella “Pianura seminativa”). L’espansione areale del picchio verde è documentata per la<br />
provincia di Bergamo, dove la specie ha ricolonizzato alcune aree dove si era estinta, mentre un marcato<br />
aumento demografico si è riscontrato nella “Pianura seminativa” dove la specie ha avuto un incremento<br />
medio annuo decisamente elevato pari al 23,0%.<br />
54<br />
Coppie nidificanti<br />
Coppie nidificanti
Picchio rosso maggiore Dendrocopos major Andamento a scala regionale: +7,8%<br />
Andamento a scala sub-reg.: Pianura seminativa: +7,0%<br />
Boschi di latifoglie: +9,5% Alta pianura: +7,8%<br />
Come buona parte delle specie forestali, il picchio rosso maggiore ha un andamento demografico in aumento<br />
significativo. Dal 2005 si stima che in regione Lombardia nidifichino non meno di 15.000 coppie, con punte di<br />
oltre 30.000 nel 2011 e <strong>2012</strong>. I livelli più bassi sono stati invece registrati nel biennio 1995 e 1996 quando<br />
la consistenza era stimata in meno di 4000 coppie. Si notano anche modeste oscillazioni che possono essere<br />
in parte spiegate dall’effetto giocato da particolari condizioni meteorologiche avverse durante il periodo<br />
invernale: la specie sembra, infatti, risentire negativamente di un eccesso di precipitazioni durante i mesi più<br />
freddi di gennaio e febbraio.<br />
Allodola Alauda arvensis Andamento a scala regionale: -9,6%<br />
Andamento a scala sub-regionale: Pianura seminativa: -10,1%<br />
L’allodola, insieme all’averla piccola, al passero d’Italia, al verdone e al cardellino, rappresenta una delle<br />
specie con la maggiore contrazione demografica sul territorio regionale. Nell’analisi demografica è possibile<br />
identificare quattro principali momenti di riduzione numerica: il più evidente si ha tra il 1992 e il 1995<br />
quando la popolazione regionale viene dimezzata, passando da circa 165.000 coppie a circa 80.000, valori<br />
che, come ordine di grandezza, vengono mantenuti fino al 1999, quando avviene una successiva e<br />
importante diminuzione che porterà la popolazione ad oscillare attorno al valore di 50.000 coppie circa fino<br />
al 2003; nel 2004 si registra infatti un nuovo calo che porterà a valori prossimi alle 40.000 coppie. Infine,<br />
negli ultimi quattro anni la popolazione è ulteriormente e costantemente diminuita arrivando nel 2011 ad un<br />
minimo storico di circa 14.000 (meno di 1/10 della popolazione censita nel 1992). Per quanto riguarda<br />
possibili influenze meteorologiche non vi sono evidenze che inducano a ipotizzare l’effetto di particolari<br />
fenomeni agenti sulla dinamica di popolazione, restano da indagare quindi gli effetti di particolari gestioni<br />
delle aree agricole che possono avere determinato un drastica riduzione di una specie ritenuta comune fino a<br />
pochi decenni fa’.<br />
55<br />
Coppie nidificanti<br />
Coppie nidificanti
Rondine Hirundo rustica Andamento a scala regionale: -4,6%<br />
Andamento a scala sub-regionale: Pianura seminativa: -3,1%<br />
La rondine, come la maggior parte delle specie dei paesaggi agricoli, ha un andamento negativo<br />
significativo, con una fase di diminuzione prolungata dal 2000 in poi, nel corso della quale si osservano<br />
sporadici recuperi momentanei. Nel <strong>2012</strong> la popolazione raggiunge il minimo storico con meno di 60.000.<br />
Anche per la rondine, così come per l’allodola e l’averla piccola, sarebbero auspicabili apposite ricerche per<br />
determinare e quantificare i fattori di gestione del territorio che incidono in maggior misura e in modo<br />
negativo sulle popolazioni nidificanti e, ossia, nei quartieri riproduttivi. Inoltre, sarebbe utile indagare anche i<br />
possibili effetti di processi che agiscono nel corso dello svernamento e che, per le specie migratrici, hanno<br />
luogo in aree diverse da quelle di riproduzione.<br />
Balestruccio Delichon urbicum Andamento a scala regionale: n.s.<br />
Andamento a scala sub-regionale: Boschi di latifoglie: -3,7%<br />
La popolazione regionale di balestruccio non mostra un andamento significativo a lungo termine, anche se<br />
sono osservabili una prima fase di crescita fino al 2002 (poco più di 120.000 coppie) e una successiva fase di<br />
regresso fino al 2009 (45.000 coppie circa). Le fluttuazioni interannuali sono probabilmente imputabili<br />
prevalentemente alle condizioni meteo-climatiche locali durante la nidificazione, così come a fattori che<br />
agiscono sulle risorse trofiche durante lo svernamento nei quartieri sub-sahariani. Un significativo regresso è<br />
invece osservabile per la popolazione dell’area omogenea dei “Boschi di latifoglie”, dove l’andamento su<br />
lungo termine è negativo con una perdita media annua del 3,7%.<br />
56<br />
Coppie nidificanti<br />
Coppie nidificanti
Prispolone Anthus trivialis Andamento a scala regionale: +7,5%<br />
Andamento a scala sub-regionale: Alpi: +9,5%<br />
Boschi di conifere: +8,6%<br />
Boschi di latifoglie: -5,2%<br />
L’andamento della popolazione regionale di prispolone risulta significativamente in aumento e rappresenta di<br />
fatto una ripresa dopo il crollo demografico e il minimo registrato nel 1995 (meno di 2000 coppie). Dal 1999<br />
in poi, la popolazione non mostra variazioni significative tra un anno e l’altro, anche se la tendenza generale<br />
potrebbe essere quella di un lieve aumento. Oggi la popolazione nidificante è stimata in circa 11.000 coppie,<br />
ordine di grandezza registrato nel lontano 1992. L’incremento maggiore si ha per le “Alpi”, che ospita l’11%<br />
della popolazione regionale, dove il tesso medio raggiunge il 9,5%: in questo caso potrebbe trattarsi di un<br />
espansione areale collegata all’espansione della vegetazione arbustiva e arborea verso quote più elevate in<br />
seguito all’abbandono o comunque ad un minore utilizzo dei prati-pascoli. Un incremento importante si<br />
osserva anche nei “Boschi di conifere” (che ospita la principale popolazione regionale) e nei “Boschi di<br />
latifoglie”.<br />
Spioncello montano Anthus spinoletta Andamento a scala regionale: +5,6%<br />
Andamento a scala sub-regionale: Alpi: +5,0%<br />
Boschi di conifere: +8,9%<br />
La popolazione regionale di spioncello montano appare in incremento significativo a lungo temine e mostra<br />
anche alcune significative oscillazioni interannuali probabilmente legate alla variabilità meteo-climatica sia<br />
durante il periodo riproduttivo sia in quello di svernamento. Attualmente la popolazione si attesta a circa<br />
33.000 coppie.<br />
57<br />
Coppie nidificanti Coppie nidificanti
Cutrettola Motacilla flava Andamento a scala regionale: n.s.<br />
La cutrettola è una delle specie migratrici a lunga distanza le cui popolazioni non evidenziano particolari<br />
problemi demografici, anche se sono evidenti alcune significative oscillazioni interannuali probabilmente<br />
imputabili alle condizioni ambientali locali durante la riproduzione o a quelle nei quartieri di svernamento<br />
sub-sahariani durante lo svernamento. La sua popolazione appare oscillante tra circa 12.000 e 26.000<br />
coppie. IL <strong>2012</strong> rappresenta una degli anni con popolazione prossima ai minimo storici.<br />
Ballerina gialla Motacilla cinerea Andamento a scala regionale: (-3,5%)<br />
La ballerina gialla ha una tendenza quasi significativa al regresso. In effetti, dopo un incremento registrato<br />
tra il 1992 e il 1996 (anno di massima popolazione regionale con circa 18.000 coppie), pur con diverse<br />
oscillazioni, la tendenza generale della popolazione sembrerebbe orientata al regresso. Il <strong>2012</strong>, con 17.000<br />
coppie, sembrerebbe un anno favorevole per la specie, ma l’elevato intervallo di confidenza non consente di<br />
attestarne la significatività.<br />
58<br />
Coppie nidificanti<br />
Coppie nidificanti
Ballerina bianca Motacilla alba Andamento a scala regionale: -4,5%<br />
Andamento a scala sub-regionale: Pianura seminativa: -6,1%<br />
Alta pianura: -5,9%<br />
Boschi di latifoglie: (-3,2%)<br />
Boschi di conifere: (-3,7%)<br />
Come molte specie legate anche ai paesaggi agricoli, la popolazione regionale di ballerina bianca risulta in<br />
marcato regresso, con un calo medio annuo stimato al 4,5%. Se, inoltre, si considerano le popolazioni legate<br />
ai paesaggi della “Pianura seminativa” (che ospitano il 22% della popolazione regionale), dell’”Alta pianura”<br />
(con il 15%), qui i cali raggiungono rispettivamente il 6,1% e il 5,9%. Cali meno marcati e ai limiti della<br />
significatività si hanno anche per l’area omogenea dei “Boschi di latifoglie” e dei “Boschi di conifere”.<br />
Osservando il grafico dell’indice di popolazione è evidente che, seppur con andamento fluttuante, la ballerina<br />
bianca stia manifestando un andamento negativo, con un picco minimo nel 2009 con 5500 coppie nidificanti.<br />
Scricciolo Troglodytes troglodytes Andamento a scala regionale: -1,9%<br />
Andamento a scala sub-regionale: Boschi di conifere: -2,2%<br />
La popolazione regionale di scricciolo seppur con un tasso di modesta entità, risulta in significativo declino,<br />
nel lungo periodo, confermato anche a scala sub-regionale, con una delle sue principali popolazioni, quella<br />
legata ai “Boschi di conifere” (27%) in regresso significativo del 2,2% medio annuo. Osservando il grafico,<br />
dopo un periodo di sostanziale stabilità (tra le 40.000 e le 55.000 coppie circa), si nota, dopo il 2002, un<br />
graduale calo, seguito però da una significativa ripresa nel 2008 (quasi 55.000 coppie), a cui segue un<br />
brusco calo (2009), seguito da una modesta ripresa e un’ulteriore diminuzione nel <strong>2012</strong>, con 27.000 coppie,<br />
valore più basso per l’intero periodo di monitoraggio. Le oscillazioni demografiche possono essere<br />
condizionate dalle temperature troppo basse nel periodo riproduttivo dell’anno precedente (aprile-luglio). La<br />
specie sembra inoltre beneficiare di temperature autunnali non troppo miti: temperature relativamente<br />
basse in questo periodo potrebbero indurre gli individui a migrare precocemente verso i fondivalle e la<br />
pianura evitando i possibili effetti negativi di successivi repentini abbassamenti di temperatura.<br />
59<br />
Coppie nidificanti Coppie nidificanti
Passera scopaiola Prunella modularis Andamento a scala regionale: +7,2%<br />
Andamento a scala sub-regionale: Alpi: +10,1%<br />
Boschi di conifere: +5,7%<br />
La passera scopaiola come altre specie legate agli ambienti ecotonali delle foreste di media e alta quota<br />
(vedi il prispolone), appare in espansione demografica e probabilmente di areale, verosimilmente per una<br />
riconquista della vegetazione arbustiva e forestale verso quote più elevate in seguito ad un minore utilizzo<br />
dei prati-pascoli montani e alpini. Dopo le modeste popolazioni stimate tra il 1992 e il 1995 (poco più di<br />
5000 coppie), la popolazione ha via via incrementato i suoi effettivi, seppur talvolta con evidenti oscillazioni.<br />
Un marcato picco si ha per il 2002 quando sono state stimate più di 36.000 coppie nidificanti. Dopo un<br />
brusco ma momentaneo calo a 14.000 coppie, la popolazione è andata incrementando abbastanza<br />
regolarmente fino a raggiungere i valori massimi attuali con circa 40.000 coppie.<br />
Pettirosso Erithacus rubecula Andamento a scala regionale: n.s.<br />
Il grafico del pettirosso mostra come la specie subisca molte e significative fluttuazioni demografiche, ma<br />
senza evidenziare significativi andamenti a lungo termine, ma piuttosto oscillando intorno alle circa 40.000<br />
coppie. Tale dinamica risulta, al momento, difficilmente spiegabile prendendo in considerazione i possibili<br />
effetti di origine meteorologica durante il periodo riproduttivo. Non sono tuttavia da escludere possibili effetti<br />
di particolari condizioni meteo-climatiche durante lo svernamento.<br />
60<br />
Coppie nidificanti<br />
Coppie nidificanti
Usignolo Luscinia megarhynchos Andamento a scala regionale: -2,1%<br />
Andamento a scala sub-regionale: Pianura seminativa: (-1,8%)<br />
Come molte specie dei paesaggi agricoli, la popolazione di usignolo ha un andamento a lungo termine in<br />
significativo regresso. In particolare, la brusca riduzione della popolazione è avvenuta tra il 1992 e il 1995<br />
quando la popolazione scende dalle circa 136.000 alle 66.000 coppie. Successivamente la popolazione<br />
continua a mantenere una tendenza negativa mostrando continue e a volte significative fluttuazioni. Si tratta<br />
di una dinamica che accomuna diverse altre specie che condividono l’ambiente riproduttivo con l’usignolo,<br />
allodola e averla piccola in particolare, le quali hanno subito un drastico calo proprio nell’arco temporale che<br />
va dal 1992 al 1995. Gli ultimi due anni del monitoraggio rappresentano dei minimi per la popolazione di<br />
usignolo con poco più di 50.000 coppie.<br />
Codirosso spazzacamino Phoenicurus ochruros Andamento a scala regionale:+9,9%<br />
Andamento a scala sub-reg.: Boschi di latifoglie: +23,2%<br />
Alpi: +2,8%<br />
La popolazione nidificante regionale di codirosso spazzacamino ha un andamento a lungo termine in crescita<br />
significativa (+9,9%). Il grafico mostra un’esplosione demografica tra il 2002 e il 2003 con successive<br />
fluttuazioni, tra le 8000 e le 25.000 coppie. L’analisi a scala sub-regionale evidenzia come la principale<br />
popolazione della specie, quelle connessa al paesaggio dei “Boschi di conifere” (50%) sia sostanzialmente<br />
stabile, mentre quella dell’area “Alpi” (36%) sia in significativo aumento del 2,8%. Un ‘importante espansine<br />
sia ha per una popolazione secondaria, quella dei “Boschi di latifoglie” (10%) con una crescita media annua<br />
del 23,2%. Al momento non vi sono evidenze sufficientemente robuste per collegare le dinamiche<br />
demografiche a fattori meteo-climatici.<br />
61<br />
Coppie nidificanti Coppie nidificanti
Codirosso Phoenicurus phoenicurus Andamento a scala regionale:+4,5%<br />
Andamento a scala sub-regionale: Boschi di conifere: +7,9%<br />
Alta pianura: +6,1%<br />
62<br />
Coppie nidificanti<br />
Come altre specie legate alla vegetazione forestale, il codirosso ha, sul lungo periodo, un andamento<br />
significativamente positivo (+4,5%). È tuttavia osservabile un breve periodo di regresso tra il 2001 e il<br />
2004, a cui è però seguita una repentina ripresa, durata fino al 2008 (similmente a quanto avviene alle<br />
popolazioni di pigliamosche e codibugnolo con cui condividono in parte l’habitat). L’andamento demografico<br />
è caratterizzato da importanti fluttuazioni interannuali, perlopiù comprese tra 15.000 e 25.000 coppie, con<br />
un picco massimo registrato nel 2011 di quasi 33.000 coppie. Non sono al momento evidenti effetti dovuti a<br />
fenomeni meteorologici locali, mentre rimangono da indagare possibili cause legate a fattori che agiscono<br />
nelle aree di svernamento sub-sahariane.<br />
Saltimpalo Saxicola torquata Andamento a scala regionale: -4,9%<br />
Andamento a scala sub-regionale: Pianura seminativa: -6,0%<br />
Coppie nidificanti<br />
La popolazione di saltimpalo denota un andamento abbastanza fluttuante, con una tendenza significativa e al<br />
regresso nel lungo periodo (-4,9%). Appare evidente come la popolazione fosse relativamente scarsa<br />
all’inizio del periodo di monitoraggio, tra il 1992 e il 1997, mentre negli anni seguenti fino al 2005 la<br />
popolazione resta piuttosto costante (14.000-24.000 coppie). Successivamente, si assiste al crollo<br />
demografico, con meno di 3000 coppie. Al momento non si hanno evidenze circa i possibili effetti di<br />
particolari o avverse condizioni meteorologiche durante il periodo riproduttivo o in quello di svernamento;<br />
pertanto, al pari di altre specie di ambiente agricolo, meriterebbe ulteriori approfondimenti di indagine.
Culbianco Oenanthe oenanthe Andamento a scala regionale: +12,8%<br />
Andamento a scala sub-regionale: Alpi: +9,7%<br />
Boschi di conifere: (+7,3%)<br />
Il culbianco ha, sul lungo periodo, un andamento significativamente positivo. La maggiore espansione<br />
demografica è osservabile tuttavia dal 2005, anno dopo il quale la popolazione non è più scesa al di sotto<br />
delle 15.000 coppie. È da notare che, al di là della tendenza demografica positiva, temperature troppo<br />
elevate durante la stagione di nidificazione precedente possono incidere negativamente sulla popolazione,<br />
probabilmente compromettendo in parte il successo riproduttivo. L’incremento più importante (+9,7%)<br />
riguarda proprio una delle popolazioni regionali più consistenti (37%) legata al paesaggio “Alpi”.<br />
Merlo Turdus merula Andamento a scala regionale: n.s.<br />
Andamento a scala sub-regionale: Pianura seminativa: -2,6%<br />
Il merlo possiede un andamento a lungo termine non significativo, anche se dal grafico appare evidente<br />
come vi sia stata una contrazione che ha portato la popolazione a minimi di poco più di 50.000 coppie nel<br />
2003-2004. Va inoltre evidenziato come la specie abbia subito un declino di circa il 50% dal 1992 al 2004,<br />
probabilmente a causa dell’USUTU virus che ha colpito molte popolazioni europee di questa specie nel 2000-<br />
2001, periodo per il quale è evidente anche un calo della popolazione da oltre 80.000 coppie (1999) a meno<br />
di 60.000. Successivamente il merlo ha parzialmente recuperato i propri effettivi, superando nuovamente la<br />
soglia della 70.000 unità riproduttive, anche se a scala sub-regionale, nel paesaggio della “Pianura<br />
seminativa” (che ospita il 28% della popolazione regionale) mostri ancora una tendenza negativa a lungo<br />
termine pari al -2,6% annuo.<br />
63<br />
Coppie nidificanti Coppie nidificanti
Tordo bottaccio Turdus philomelos Andamento a scala regionale: +10,3%<br />
Andamento a scala sub-regionale: Boschi di conifere: +11,0%<br />
Coppie nidificanti Coppie nidificanti<br />
Il grafico della demografia del tordo bottaccio evidenzia una crescita significativa a lungo termine, anche se<br />
sono evidenti due flessioni; una prima si ha per il biennio 2004-2005, a cui segue una ripresa importante;<br />
una seconda fase di calo si ha dopo il 2008. Attualmente la popolazione è stimata in 17.000 coppie, il valore<br />
massimo mai registrato per la regione durante il periodo di monitoraggio.<br />
Usignolo di fiume Cettia cetti Andamento a scala regionale: (-4,0%)<br />
Andamento a scala sub-regionale: Pianura seminativa: (-3,8%)<br />
La popolazione regionale di usignolo di fiume possiede un andamento marginalmente significativo a lungo<br />
termine ed evidenzia forti e significative fluttuazioni. Le differenze interannuali potrebbero essere in parte<br />
dovute all’aumento di mortalità in seguito a temperature eccessivamente rigide durante l’inverno. Da notare<br />
che la specie mostra la propria popolazione minima nel <strong>2012</strong> con 3000 coppie riproduttive, mentre nei<br />
periodo centrali la popolazione risultava nettamente più consistente con popolazioni vicino alle 20.000<br />
coppie.<br />
64
Canapino Hippolais polyglotta Andamento a scala regionale: +8,2%<br />
L’andamento a lungo termine del canapino risulta significativo con un incremento medio annuo di +8,2%.<br />
Specie piuttosto termofila, il canapino potrebbe essere negativamente influenzato da eccessive precipitazioni<br />
nel corso della stagione di nidificazione precedente, che ne ridurrebbero il successo riproduttivo.<br />
Capinera Sylvia atricapilla Andamento a scala regionale: n.s.<br />
La capinera possiede una popolazione sostanzialmente stabile in Lombardia, anche se alcune flessioni<br />
moderate risultano comunque statisticamente significative. Soltanto la popolazione censita nel 2004, circa<br />
135.000 coppie, appare scostarsi decisamene dalla popolazione media di quasi 185.000 coppie. Nessun<br />
fenomeno meteorologico locale sembra determinare le differenze interannuali tra le popolazioni stimate, ma<br />
potrebbe esservi l’influsso delle condizioni climatiche nelle aree di svernamento; tale aspetto appare<br />
comunque di complessa valutazione per una specie migratrice parziale come la capinera.<br />
65<br />
Coppie nidificanti<br />
Coppie nidificanti
Luì bianco Phylloscopus bonelli Andamento a scala regionale: n.s.<br />
L’andamento della popolazione nidificante di luì bianco appare fluttuante, anche se gli intervalli di confidenza<br />
delle stime sono abbastanza ampi, e non mostra nemmeno un andamento significativo a lungo termine.<br />
Nessun parametro meteo-climatico locale evidenzia particolari relazioni con le oscillazioni interannuali;<br />
tuttavia, per questa specie potrebbero risultare importanti le condizioni ambientali nelle aree di svernamento<br />
sub-sahariane.<br />
Luì piccolo Phylloscopus collybita Andamento a scala regionale: -3,8%<br />
Andamento a scala sub-regionale: Boschi di latifoglie: -3,8%<br />
Boschi di conifere: (-2,9%)<br />
Il luì piccolo, insieme a scricciolo e luì piccolo, è tra le poche specie forestali a mostrare un andamento<br />
significativamente negativo a lungo termine. Dopo un’esplosione demografica registrata nel 1996 (circa<br />
137.000 coppie), la specie ha evidenziato un declino pressoché costante fino al 2006, con una temporanea e<br />
parziale ripresa negli anni 2007 e 2008, per poi quasi dimezzarsi nel 2009. Il calo manifestatosi per il luì<br />
piccolo nel 2009 non è però un caso isolato: un’altra specie svernate sul territorio regionale e che ha una<br />
biologia simile, il regolo, potrebbe avere egualmente subito gli effetti di un inverno particolarmente nevoso<br />
quale quello del 2009. Successivamente la popolazione sembra in ripresa, fino al <strong>2012</strong> quando cala<br />
nuovamente in modo significativo, attestandosi a circa 35.000 coppie, minimo storico per l’intero periodo di<br />
monitoraggio (diversamente dal regolo, in questo caso, che invece riguadagna in modo significativo). Sulla<br />
dinamica demografica potrebbero influenzare negativamente sia un eccesso di precipitazioni durante il<br />
periodo riproduttivo dell’anno precedente, sia temperature eccessivamente rigide nel corso dell’inverno.<br />
66<br />
Coppie nidificanti<br />
Coppie nidificanti
Regolo Regulus regulus Andamento a scala regionale: -5,2%<br />
Andamento a scala sub-regionale: Boschi di latifoglie: -9,5%<br />
Boschi di conifere: -5,2%<br />
Il regolo ha un andamento a lungo termine in significativo regresso, manifestatosi dopo il picco demografico<br />
del 1996. In ciò, la dinamica demografica del regolo assomiglia molto a quella del luì piccolo, soprattutto dal<br />
2003 in avanti, quando a un evidente calo, segue un lieve recupero nel biennio 2007-2008, a cui succede<br />
una drastica perdita: nel 2009 è registrata la minima popolazione nidificante regionale di sempre, stimata in<br />
circa 7000 coppie. La specie potrebbe essere in genere negativamente influenzata da un eccesso di<br />
precipitazioni durante la nidificazione dell’anno prima e, in particolare, nel 2009 (7000 coppie circa) potrebbe<br />
anche aver subito gli effetti delle consistenti precipitazioni nevose. Gli ultimi due anni invece mostrano un<br />
parziale recupero. Diversamente dal luì piccolo, per il regolo, nel <strong>2012</strong> si assiste ad un significativo recupero<br />
che fa attestare la popolazione regionale a oltre 40.000 coppie.<br />
Fiorrancino Regulus ignicapilla Andamento a scala regionale: +9,2%<br />
Andamento a scala sub-regionale: Boschi di latifoglie: (+8,3%)<br />
La popolazione regionale di fiorrancino possiede un andamento a lungo termine significativo, con un<br />
incremento medio annuo del 9,2%. Nonostante gli ampi intervalli di confidenza delle stime delle popolazioni<br />
annuali, queste sono perlopiù comprese tra 10.000 e 30.000 coppie. La specie potrebbe essere<br />
negativamente condizionata dalle piogge per quanto riguarda il successo riproduttivo così come temperature<br />
invernali troppo rigide potrebbero incidere sulla mortalità. Attualmente la popolazione nidificante censita si<br />
attesta sulle 30.000 coppie.<br />
67<br />
Coppie nidificanti<br />
Coppie nidificanti
Pigliamosche Muscicapa striata Andamento a scala regionale: +4,9<br />
Andamento a scala sub-regionale: Boschi di latifoglie: +8.3%<br />
Alta pianura: (+4,3%)<br />
Pianura seminativa: (+6,3%)<br />
La popolazione di pigliamosche risulta in aumento significativo a lungo termine, anche se dal 2000 in avanti<br />
appare piuttosto oscillante, con fasi di regresso (2002-2005) alternate a fasi di espansione (2006-2008),<br />
similmente a quanto accade a codibugnolo e codirosso. La sua principale popolazione regionale (31%),<br />
quella dei “Boschi di latifoglie” appare in aumento significativo del 8,3% medio annuo. Aumenti<br />
marginalmente significativi si hanno per le aree omogenee dell’“Alta pianura” e della “Pianura seminativa”.<br />
Al momento non è chiaro se possano esserci fattori meteorologici locali che influenzino tali dinamiche, così<br />
come fenomeni che potrebbero agire nei quartieri di svernamento sub-sahariani. Il <strong>2012</strong> rappresenta il<br />
massimo storico per la popolazione di pigliamosche con oltre 120.000 coppie nidificanti.<br />
Codibugnolo Aegithalos caudatus Andamento a scala regionale: +4,4%<br />
Andamento a scala sub-regionale: Pianura seminativa: +12,9%<br />
La popolazione di codibugnolo ha un andamento significativamente positivo a lungo termine (così come<br />
manifestato da molte specie forestali), anche se sono evidenti alcune oscillazioni con momenti di regressione<br />
numerica, altri di espansione, analogamente a quanto avviene per le popolazioni di pigliamosche e<br />
codirosso. La popolazione regionale di codibugnolo fluttua tra circa 15.000 e 40.000 coppie (con un minimo<br />
nel 2004 con poco più di 11.000 coppie). Appare invece in forte espansione la modesta popolazione (10%)<br />
della “Pianura seminativa” ad un ritmo medio annuo del 12,9%.<br />
68<br />
Coppie nidificanti<br />
Coppie nidificanti
Cincia bigia Poecile palustris Andamento a scala regionale: +8,9%<br />
Andamento a scala sub-regionale: Boschi di conifere: +9,8%<br />
Boschi di latifoglie: +11,5%<br />
Specie legata alle formazioni forestali mature e ben connesse, le sue popolazioni risultano in ampia<br />
espansione numerica (+8,9%), probabilmente in seguito a un sfruttamento meno intensivo dei boschi che<br />
consente ai consorzi forestali di raggiungere sempre di più condizioni strutturali adeguate alla presenza di<br />
specie interne nidificanti in cavità. Le oscillazioni interannuali non appaiono, al momento, riconducibili a<br />
cause meteorologiche. Il 2011 rappresenta il record storico della popolazione di cincia bigia con oltre 35.000<br />
coppie stimate: si tratta probabilmente di un esplosione demografica temporanea, poiché nel <strong>2012</strong> la<br />
popolazione torna in linea con quelle degli anni precedenti, compresa tra le 13.000 e le 19.000 coppie. Tale<br />
entità risulta nettamente superiore a quella dell’inizio del periodo di monitoraggio (1992), quando la<br />
popolazione ammontava a circa 2000 unità riproduttive. Rilevanti anche i tassi di incremento della principale<br />
popolazione regionale, quella legata al paesaggio dei “Boschi di latifoglie” (52%), e di quella dei “Boschi di<br />
conifere” (14%), che rispettivamente aumentano ogni anno in media dell’11,5% e del 9,8%.<br />
Cincia bigia alpestre Poecile montana Andamento a scala regionale: n.s.<br />
La cincia bigia alpestre non ha un andamento significativo a lungo termine, ma le sue popolazioni tendono a<br />
fluttuare con una modalità più o meno regolare, soprattutto dal 2003 in poi. Le popolazioni oscillano<br />
generalmente tra circa 4000 e quasi 20.000 coppie, senza avere evidenti relazioni con le condizioni<br />
meteorologiche annuali.<br />
69<br />
Coppie nidificanti<br />
Coppie nidificanti
Cincia dal ciuffo Lophophanes cristatus Andamento a scala regionale: n.s.<br />
La popolazione regionale di cincia dal ciuffo non possiede un andamento significativo a lungo termine. Tende<br />
piuttosto ad oscillare prevalentemente tra circa 8000 e 18.000 coppie, con un record negativo proprio<br />
all’inizio del periodo di monitoraggio (meno di 2500 coppie). Al momento non ci sono evidenze statistiche tra<br />
l’abbondanza e fenomeni meteorologici.<br />
Cincia mora Periparus ater Andamento a scala regionale: n.s.<br />
La popolazione di cincia mora non possiede un andamento significativo a lungo termine. Se si esclude un<br />
picco massimo del 1996 (circa 115.000 coppie), le sue popolazioni oscillano generalmente tra circa 60.000 e<br />
poco meno di 100.000 coppie, con minimi di circa 50.000 coppie in corrispondenza del 1995 e del 2009. Il<br />
<strong>2012</strong> rappresenta una delle massime dimensioni raggiunte dalla popolazione regionale con oltre 105.000<br />
coppie nidificanti. Le dinamiche demografiche non appaiono legate a particolari condizioni meteorologiche sia<br />
durante la stagione riproduttiva sia in quella di svernamento, anche se per il 2009 potrebbe valere il discorso<br />
già fatto per il regolo, ovvero le popolazioni potrebbero essere state influenzate negativamente dalle<br />
abbondanti nevicate invernali.<br />
70<br />
Coppie nidificanti<br />
Coppie nidificanti
Cinciarella Cyanistes caeruleus Andamento a scala regionale: +4,6%<br />
Andamento a scala sub-regionale: Alta pianura: +6,9%<br />
Boschi di latifoglie: +3,3%<br />
Come altre specie forestali nidificanti in cavità, la cinciarella evidenzia un andamento a lungo termine<br />
significativamente positivo. Dopo un periodo piuttosto altalenante verificatosi all’inizio del monitoraggio, la<br />
dinamica demografica evidenzia fasi distinte di crescita, seguite da flessioni: un periodo di crescita è<br />
identificabile dal 1999 al 2003, con un calo nel 2004 e una nuova successiva fase di ripresa fino al 2008,<br />
dove viene raggiunto il picco massimo di 56.000 coppie. Al calo del 2009 sembrerebbe seguire, dopo un<br />
anno stazionario, una nuova ripresa. Nel <strong>2012</strong> le coppie stimate nidificanti in regione ammontano a poco<br />
meno di 55.000. La specie sembra inoltre trarre vantaggio da temperature miti nel corso della primavera<br />
precedente, le quali potrebbero avere un influsso sul successo riproduttivo.<br />
Cinciallegra Parus major Andamento a scala regionale: +3,2%<br />
Andamento a scala sub-regionale: Alta pianura: +2,2%<br />
Pianura seminativa: +4,8%<br />
Boschi di latifoglie: +2,6%<br />
L’andamento demografico della cinciallegra, pur con significative fluttuazioni interannuali, a lungo termine<br />
risulta significativamente positivo (+3,2%), con una popolazione che negli ultimi anni si attesta a quasi<br />
90.000 coppie, con il picco massimo raggiunto proprio nel <strong>2012</strong>. Inoltre, appare particolarmente importante<br />
l’espansione della popolazione della “Pianura seminativa”, che risulta anche la più importante per<br />
consistenza numerica (29%), con un tasso d’incremento medio annuo del 4,8%.<br />
71<br />
Coppie nidificanti<br />
Coppie nidificanti
Picchio muratore Sitta europaea Andamento a scala regionale: n.s.<br />
Andamento a scala sub-regionale: Alta pianura: -6,6%<br />
La popolazione regionale di picchio muratore non ha un andamento significativo a lungo termine,<br />
diversamente da altre specie forestali nidificanti in cavità, come cincia bigia e cinciarella, che invece risultano<br />
in espansione numerica. Mostra piuttosto ampie fluttuazioni, a volte significative, che possono essere in<br />
parte spiegate con l’effetto negativo esercitato da temperature eccessivamente rigide nel corso dell’inverno.<br />
Nelle fasi di espansione la popolazione può raggiungere e anche superare le 15.000 coppie, mentre nelle fasi<br />
di contrazione, come nel 2003-2004, può scendere significativamente sotto le 5000 unità. Desta una certa<br />
preoccupazione la tendenza significativa a lungo termine della popolazione dell’”Alta pianura” che ospita una<br />
frazione consistente dell’intero contingente regionale (34%): qui la specie risulta mediamente in calo del<br />
6,6% all’anno.<br />
Rigogolo Oriolus oriolus Andamento a scala regionale: n.s.<br />
La popolazione regionale nidificante di rigogolo non possiede un andamento significativo a lungo termine, ma<br />
mostra oscillazioni che potrebbero essere in qualche modo correlate con il successo riproduttivo o la<br />
sopravvivenza dei giovani involati nel periodo pre-migratorio: la popolazione, infatti, sembra essere più<br />
consistente quando nell’annata precedente si è manifestata un’estate piuttosto calda. Per quasi tutto il<br />
periodo di monitoraggio la popolazione oscilla tra le 5000 e le 8000 coppie.<br />
72<br />
Coppie nidificanti<br />
Coppie nidificanti
Averla piccola Lanius collurio Andamento a scala regionale: -9,0%<br />
Andamento a scala sub-regionale: Pianura seminativa: -15,5%<br />
Boschi di latifoglie: -11,1%<br />
L’averla piccola è un delle specie, insieme all’allodola, al passero d’Italia, al verdone e al cardellino, ad aver<br />
subito una vera e propria decimazione. La sua popolazione è regredita pressoché costantemente dal 1992 al<br />
2003, passando da circa 50.000 a poco più di 5000 coppie. Dopo un modesto recupero tra il 2003 e il 2008<br />
(10.000-16.000 coppie), la popolazione regionale è tornata a scendere in modo significativo e preoccupante,<br />
raggiungendo nel <strong>2012</strong> il minimo assoluto di 2600 coppie. L’andamento demografico appare particolarmente<br />
allarmante nella “Pianura seminativa” (29% della popolazione regionale) dove il tasso di regresso medio<br />
annuo si attesta all’15,5% e nei “Boschi di latifoglie” (33% della popolazione regionale) con un decremento<br />
del 11,1%. Il successo riproduttivo e lo svezzamento dei pulli nel periodo pre-migratorio, potrebbe essere<br />
influenzato negativamente da un eccesso di precipitazioni nel periodo estivo, così da fare registrare una<br />
popolazione meno consistente l’annata successiva. Inoltre, un fattore che certamente ha contribuito a<br />
determinare il tracollo di questa specie è rappresentato dalla rimozione della vegetazione di margine tra i<br />
coltivi, così come dalla sostituzione dei prati-pascoli permanenti con colture intensive, che hanno<br />
determinato una limitazione sia dell’habitat di nidificazione, sia delle risorse trofiche.<br />
Ghiandaia Garrulus glandarius Andamento a scala regionale: +4,5%<br />
Andamento a scala sub-regionale: Boschi di latifoglie: +5,6%<br />
Alta pianura: +6,4%<br />
Specie forestale in espansione numerica, la ghiandaia mostra talvolta fluttuazioni non direttamente<br />
interpretabili come effetto di particolari condizioni meteo-climatiche. Da un minimo di circa 3000 coppie del<br />
1997, la popolazione è andata via via aumentando e negli ultimi anni la popolazione stimata di ghiandaia<br />
oscilla tra le circa 10.000 e 14.000 coppie. Particolarmente importante il tasso medio di crescita registrato<br />
nell’”Alta pianura” (con il 17% della popolazione regionale) che arriva al 6,4, mentre nei “Boschi di latifoglie”<br />
(con il 48% della popolazione regionale) il tasso medio di crescita annuo e del 5,6%.<br />
73<br />
Coppie nidificanti<br />
Coppie nidificanti
Gazza Pica pica Andamento a scala regionale: +7,8%<br />
Andamento a scala sub-regionale: Pianura seminativa: +8,5%<br />
L’andamento a lungo termine della gazza risulta in incremento significativo, anche se l’espansione numerica<br />
non è avvenuta regolarmene ma piuttosto bruscamente, dal 2002, anno in cui è particolarmente evidente un<br />
“gradino”, quando la popolazione passa da un ordine di grandezza di 4000-6000 coppie a 8000‒13.000.<br />
Particolarmente importante l’espansione demografica avvenuta nella “Pianura seminativa” che ospita i tre<br />
quarti della popolazione regionale, e che mostra un tasso medio di incremento annuo del 8,5%. La specie<br />
sembra inoltre aver beneficiato di un incremento delle temperature estive (che dovrebbero aumentare il<br />
successo riproduttivo) cosi come di una diminuzione delle precipitazioni nel corso dell’inverno.<br />
Cornacchia grigia Corvus cornix Andamento a scala regionale: (+1,0)<br />
Specie la cui popolazione regionale appare decisamene stabile, anzi con un lieve incremento, marginalmente<br />
significativo. L’andamento demografico mostra inoltre modeste oscillazioni che portano a fluttuare la<br />
popolazione di cornacchia grigia tra 20.000 e 30.000 coppie circa. Al momento, non sembra che le differenze<br />
interannuali possano essere messe in relazione con la variabilità di temperature o precipitazioni.<br />
74<br />
Coppie nidificanti<br />
Coppie nidificanti
Storno Sturnus vulgaris Andamento a scala regionale: n.s.<br />
Andamento a scala sub-regionale: Pianura seminativa: +3,9%<br />
La tendenza attuale della popolazione lombarda di storno non appare significativa, e negli ultimi 10 anni la<br />
popolazione ha evidenziato modeste fluttuazioni comprese tra circa 150.000 e 220.000 coppie. L’analisi<br />
demografica evidenzia come la specie abbia subito un forte calo dal 1992 (circa 310.000 coppie) al 1995<br />
(poco meno di 100.000 coppie e un minimo di 90.000 nel 1997), recuperato tuttavia nel 1999 (240.000<br />
coppie). Da questo periodo in poi la popolazione, oscillando, ha mantenuto una certa stabilità, mostrando<br />
anzi un netto e significativo recupero nella “Pianura seminativa”, dove il tasso medio di crescita annuale è<br />
del 3,9%. La specie sembra essere significativamente influenzata dalle eccessive precipitazioni invernali che,<br />
verosimilmente, determinano un incremento della moralità.<br />
Passero d’Italia Passer italiae Andamento a scala regionale: -6,3%<br />
Andamento a scala sub-regionale: Pianura risicola: -6,9%<br />
Pianura seminativa: -6,6%<br />
Il passero d’Italia, insieme all’allodola, all’averla piccola, al verdone e al cardellino, è una delle specie che ha<br />
subito le maggiori perdite, ed è passato da massimi registrati nel 1992 e nel 1999 con circa 650.000 coppie,<br />
al minimo attuale con meno di circa 175.000 coppie. Il recupero del 1999 sembrava poter contrastare<br />
l’andamento negativo del periodo centrale degli anni ’90, ma ad esso è seguito un nuovo e incessante<br />
regresso. Non è chiaro se le variazioni meteo-climatiche intercorse negli ultimi lustri possano, in qualche<br />
modo, aver condizionato la dinamica demografica della specie, mentre appare più verosimile un effetto<br />
antropico collegabile alle diverse tipologie di costruzione edile messe in atto recentemente e che hanno<br />
limitato la disponibilità di siti di nidificazione di questa specie fortemente sinantropica.<br />
75<br />
Coppie nidificanti<br />
Coppie nidificanti
Passero mattugio Passer montanus Andamento a scala regionale: (-2,4%)<br />
Andamento a scala sub-regionale: Pianura urbana: (-3,4%)<br />
La popolazione lombarda di passero mattugio ha un andamento a lungo termine marginalmente significativo.<br />
Al forte declino avvenuto tra il 1992 e il 1997, in cui la popolazione è scesa dalle iniziali 86.000 coppie a<br />
meno di 36.000 coppie, è seguita una fase di recupero fino al 1999, subito seguita da un nuovo declino che<br />
ha portato la popolazione ai minimi storici nel 2002 (meno di 26.000 coppie). In seguito la popolazione<br />
sembrava poter recuperare: un prolungato periodo di crescita fino al 2009 ha riportato la popolazione a circa<br />
63.000 coppie, ma negli ultimi tre anni si è verificato un nuovo e significativo calo. La popolazione regionale<br />
attuale ammonta a meno di 28.000 coppie<br />
Fringuello Fringilla coelebs Andamento a scala regionale: n.s.<br />
Andamento a scala sub-regionale: Boschi di conifere: (+1,4%)<br />
Il fringuello è una specie sostanzialmente stabile e con modeste fluttuazioni interannuali, sebbene alcune<br />
volte significative. Tali variazioni non sono al momento ricollegabili a cause di tipo meteorologico, né durante<br />
la stagione riproduttiva, né in quella invernale. L’entità della popolazione regionale censita all’inizio del<br />
periodo di monitoraggio è sostanzialmente la medesima di quella attuale, stimata in poco meno di 110.000<br />
coppie. A scala sub-regionale un aumento quasi significativo si ha per l’area omogenea dei “Boschi di<br />
conifere” con un tasso medio annuo del 1,4%.<br />
76<br />
Coppie nidificanti Coppie nidificanti
Verzellino Serinus serinus Andamento a scala regionale: n.s.<br />
Andamento a scala sub-regi.: Alta pianura: -4,3%<br />
Boschi di latifoglie: (+4,5%)<br />
A lungo termine la popolazione regionale di verzellino non possiede un andamento significativo, ma a scala<br />
sub-regionale manifesta alcune controtendenze. Infatti, la specie risulta in regresso del 4,3% nell’“Alta<br />
pianura” (con il 29% della popolazione regionale), mentre in aumento quasi significativo nei “Boschi di<br />
latifoglie”. Complessivamente la dinamica a lungo termine sembra poter in qualche misura essere<br />
influenzata dai fenomeni meteorologici: la specie, infatti, subisce negativamente l’effetto delle precipitazioni<br />
primaverili verificatesi nell’anno precedente e che, quindi, potrebbero parzialmente compromette il suo<br />
successo riproduttivo. Nel complesso, e in particolare nell’ultimo decennio, la popolazione regionale oscilla<br />
tra oltre 35.000 e circa 55.000 coppie.<br />
Verdone Carduelis chloris Andamento a scala regionale: -5,5%<br />
Andamento a scala sub-regionale: Alta pianura: -8,7%<br />
Pianura urbana: -6,0%<br />
Pianura seminativa: -5,6%<br />
Il verdone, insieme ad allodola, averla piccola, passero d’Italia e cardellino, è una delle cinque specie che<br />
hanno subito la maggiore riduzione numerica tra il 1992 e il <strong>2012</strong>. Per il verdone il 2009 segna il minimo<br />
della popolazione per l’intero periodo di monitoraggio (meno di 30.000 coppie), mentre il <strong>2012</strong>, con circa<br />
68.000 coppie, segna invece un recupero significativo rispetto al picco negativo. Complessivamente il tasso<br />
medio annuo di diminuzione è del 5,5%, ma se si analizzano gli andamenti a livello delle principali<br />
popolazioni, i tassi risultano in alcuni casi anche sensibilmente più elevati. Per la “Pianura seminativa”, con il<br />
40% della popolazione regionale, il tasso si discosta poco da quello complessivo ed è pari al 5,6%, mentre<br />
per la “Pianura urbana” e per l’“Alta pianura” entrambe con il 19% della popolazione regionale, i tassi<br />
arrivano rispettivamente al -6,0% e al -8,7%. Va comunque notato come le perdite più consistenti si hanno<br />
a partire dal 2001.<br />
77<br />
Coppie nidificanti<br />
Coppie nidificanti
Cardellino Carduelis carduelis Andamento a scala regionale: -6,4%<br />
Andamento a scala sub-regionale: Alta pianura: -8,0%<br />
Boschi di latifoglie: -7,6%<br />
Pianura seminativa: -6,0%<br />
Pianura urbana: -4,9%<br />
Il cardellino, con allodola, averla piccola, passero d’Italia e verdone, è una della specie più in calo in<br />
Lombardia. Come per il verdone il grosso del calo avviene dai primi anni 2000: Il <strong>2012</strong> rappresenta un<br />
debole incremento (peraltro non significativo) rispetto agli anni 2010 e 2011, quando la popolazione ha<br />
raggiunto il suo minimo con circa 15.000 coppie. La “Pianura seminativa” con la principale popolazione (46%<br />
della popolazione regionale) decresce annualmente in media del 6,0%, la “Pianura urbana” (13% della<br />
popolazione regionale) decresce mediamente in un anno del 4,9%, mentre tassi di diminuzione più elevati si<br />
registrano per l’“Alta pianura” con l’8,0% (14% della popolazione regionale) e per i “Boschi di latifoglie” con<br />
il 7,6% (15% della popolazione regionale). La popolazione attuale, decisamene ridotta, si attesta a meno di<br />
23.000 coppie. Con le altre specie di ambiente agricolo e rurale, necessiterebbe di studi specifici finalizzati<br />
ad indagare in modo dettagliato le cause del declino.<br />
Ciufolotto Pyrrhula pyrrhula Andamento a scala regionale: n.s.<br />
Il ciuffolotto è una specie la cui popolazione regionale appare particolarmente fluttuante e, seppur gli<br />
intervalli di confidenza risultino abbastanza ampi, a volte le variazioni interannuali appaiono significative. Al<br />
momento, le oscillazioni non sono tuttavia interpretabili come risposte demografiche alle variazioni di<br />
condizioni meteorologiche registrate da un anno all’altro. Nel complesso la popolazione varia<br />
prevalentemente tra 10.000 e 30.000 coppie, con due minimi di meno di 5000 coppie per il 1996 e il 2006.<br />
78<br />
Coppie nidificanti<br />
Coppie nidificanti
ELENCO SPECIE ANALIZZATE<br />
Allodola Alauda arvensis 55<br />
Averla piccola Lanius collurio 73<br />
Balestruccio Delichon urbicum 56<br />
Ballerina bianca Motacilla alba 59<br />
Ballerina gialla Motacilla cinerea 58<br />
Canapino Hippolais polyglotta 65<br />
Capinera Sylvia atricapilla 65<br />
Cardellino Carduelis carduelis 78<br />
Cincia bigia alpestre<br />
Poecile montana 69<br />
Cincia bigia Poecile palustris 69<br />
Cincia dal ciuffo Lophophanes cristatus 70<br />
Cincia mora Periparus ater 70<br />
Cinciallegra Parus major 71<br />
Cinciarella Cyanistes caeruleus 71<br />
Ciuffolotto Pyrrhula pyrrhula 78<br />
Codibugnolo Aegithalos caudatus 68<br />
Codirosso Phoenicurus phoenicurus 62<br />
Codirosso spazzacamino<br />
Phoenicurus ochruros 61<br />
Colombaccio Columba palumbus 51<br />
Cornacchia grigia Corvus cornix 74<br />
Cuculo Cuculus canorus 53<br />
Culbianco Oenanthe oenanthe 63<br />
Cutrettola Motacilla flava 58<br />
Fagiano Phasianus colchicus 50<br />
Fiorrancino Regulus ignicapilla 67<br />
Fringuello Fringilla coelebs 76<br />
Gallinella d’acqua Gallinula chloropus 51<br />
Gazza Pica pica 74<br />
Gheppio Falco tinnunculus 49<br />
Ghiandaia Garrulus glandarius 73<br />
79<br />
Luì bianco Phylloscopus bonelli 66<br />
Luì piccolo Phylloscopus collybita 66<br />
Merlo Turdus merula 63<br />
Passera scopaiola Prunella modularis 60<br />
Passero d’Italia Passer italiae 75<br />
Passero mattugio Passer montanus 76<br />
Pettirosso Erithacus rubecula 60<br />
Picchio muratore Sitta europaea 72<br />
Picchio rosso maggiore<br />
Dendrocopos major 45<br />
Picchio verde Picus viridis 54<br />
Pigliamosche Muscicapa striata 68<br />
Poiana Buteo buteo 49<br />
Prispolone Anthus trivialis 57<br />
Quaglia Coturnix coturnix 50<br />
Regolo Regulus regulus 67<br />
Rigogolo Oriolus oriolus 72<br />
Rondine Hirundo rustica 56<br />
Rondone Apus apus 53<br />
Saltimpalo Saxicola torquata 62<br />
Scricciolo Troglodytes troglodytes 59<br />
Spioncello montano Anthus spinoletta 57<br />
Storno Sturnus vulgaris 75<br />
Torcicollo Jynx torquilla 54<br />
Tordo bottaccio Turdus philomelos 64<br />
Tortora dal collare<br />
Streptopelia decaocto 52<br />
Tortora Streptopelia turtur 42<br />
Usignolo di fiume Cettia cetti 64<br />
Usignolo Luscinia megarhynchos 61<br />
Verdone Carduelis chloris 77<br />
Verzellino Serinus serinus 77