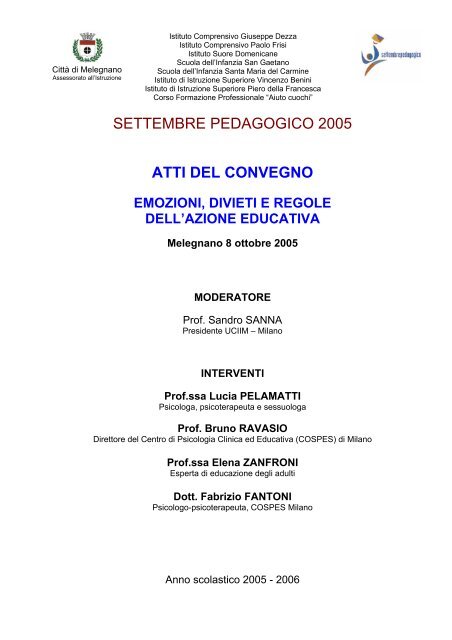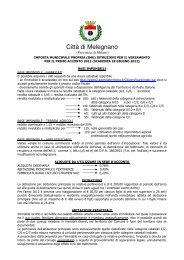atti del covegno - Comune di Melegnano
atti del covegno - Comune di Melegnano
atti del covegno - Comune di Melegnano
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Città <strong>di</strong> <strong>Melegnano</strong><br />
Assessorato all’Istruzione<br />
Istituto Comprensivo Giuseppe Dezza<br />
Istituto Comprensivo Paolo Frisi<br />
Istituto Suore Domenicane<br />
Scuola <strong>del</strong>l’Infanzia San Gaetano<br />
Scuola <strong>del</strong>l’Infanzia Santa Maria <strong>del</strong> Carmine<br />
Istituto <strong>di</strong> Istruzione Superiore Vincenzo Benini<br />
Istituto <strong>di</strong> Istruzione Superiore Piero <strong>del</strong>la Francesca<br />
Corso Formazione Professionale “Aiuto cuochi”<br />
SETTEMBRE PEDAGOGICO 2005<br />
ATTI DEL CONVEGNO<br />
EMOZIONI, DIVIETI E REGOLE<br />
DELL’AZIONE EDUCATIVA<br />
<strong>Melegnano</strong> 8 ottobre 2005<br />
MODERATORE<br />
Prof. Sandro SANNA<br />
Presidente UCIIM – Milano<br />
INTERVENTI<br />
Prof.ssa Lucia PELAMATTI<br />
Psicologa, psicoterapeuta e sessuologa<br />
Prof. Bruno RAVASIO<br />
Direttore <strong>del</strong> Centro <strong>di</strong> Psicologia Clinica ed Educativa (COSPES) <strong>di</strong> Milano<br />
Prof.ssa Elena ZANFRONI<br />
Esperta <strong>di</strong> educazione degli adulti<br />
Dott. Fabrizio FANTONI<br />
Psicologo-psicoterapeuta, COSPES Milano<br />
Anno scolastico 2005 - 2006
ATTI DEL CONVEGNO<br />
EMOZIONI, DIVIETI E REGOLE DELL’AZIONE EDUCATIVA<br />
(8 ottobre 2005)<br />
I testi riportati si riferiscono alla “sbobinatura” degli interventi proposti dai relatori. Il<br />
prezioso lavoro <strong>di</strong> trascrizione è stato effettuato anche con l’aiuto dall’équipe<br />
pedagogica <strong>del</strong>la scuola <strong>del</strong>l’Infanzia Santa Maria <strong>del</strong> Carmine <strong>di</strong> <strong>Melegnano</strong>,<br />
coor<strong>di</strong>nata dalle dott.sse Giuliana Negroni e Cristina Ruffini.<br />
Si è cercato <strong>di</strong> sistematizzare la trascrizione che, in ogni caso, ha il pregio <strong>del</strong>la<br />
spontaneità, <strong>del</strong>l’imme<strong>di</strong>atezza e <strong>del</strong> <strong>di</strong>alogo, ma anche i <strong>di</strong>fetti <strong>di</strong> minor scorrevolezza<br />
che non se avessimo “preteso” un testo scritto da ogni relatore.<br />
Si poteva provvedere a una maggiore sistematicità aggiungendo o mo<strong>di</strong>ficando alcuni<br />
pensieri, ma si sarebbe corso il rischio <strong>di</strong> travisare o <strong>di</strong> dare interpretazioni non corrette.<br />
Si può invece garantire la “genuinità” degli interventi che, visto le spessore culturale da<br />
cui sono caratterizzati, speriamo possano essere utili a chi riceverà questa<br />
pubblicazione.<br />
Gli <strong>atti</strong> sono inoltre arricchiti da un’appen<strong>di</strong>ce costituita dalla <strong>di</strong>spensa “Emozioni…<br />
Pensieri… Comportamenti” fornita dalla Prof.ssa Lucia Pelam<strong>atti</strong>, alla quale va tutta la<br />
nostra riconoscenza.<br />
<strong>Melegnano</strong>, novembre 2005<br />
2<br />
Maria Teresa Golfari<br />
Assessore all’istruzione e alla formazione
APERTURA DEI LAVORI<br />
SANDRO SANNA<br />
CITTA’ DI MELEGNANO<br />
ATTI DEL CONVEGNO DELL’8 OTTOBRE 2005<br />
EMOZIONI DIVIETI E REGOLE DELL’AZIONE EDUCATIVA<br />
Buon giorno a tutti. Sono le 9.15 e come da programma iniziamo. Benvenuti a voi tutti e<br />
ai nostri ospiti in particolare a questo Convegno così fortemente partecipato, al punto<br />
che è stato necessario <strong>atti</strong>vare un collegamento in video conferenza. Perciò un saluto<br />
particolare lo rivolgiamo anche al numeroso gruppo che si trova giù, nel Centro<br />
Anziani.<br />
La giornata <strong>di</strong> oggi rappresenta uno dei momenti forti <strong>del</strong> Settembre Pedagogico<br />
melegnanese 2005, caratterizzato da incontri tra bambini e ragazzi, da momenti<br />
formativi come questo e dalla costruzione <strong>di</strong> occasioni in cui gli studenti possano<br />
entrare in contatto con il territorio, nella consapevolezza che la scuola non è solo degli<br />
insegnanti o <strong>di</strong> una parte <strong>del</strong> <strong>Comune</strong>, ma <strong>di</strong> tutti i citta<strong>di</strong>ni.<br />
Il tema che desideriamo approfon<strong>di</strong>re oggi è quello <strong>del</strong>le emozioni, dei <strong>di</strong>vieti e <strong>del</strong>le<br />
regole che caratterizzano l’azione educativa alla quale siamo chiamati tutti noi,<br />
educatori, docenti, genitori e nonni, ogni giorno alle prese con bambini e ragazzi.<br />
Entriamo nel nostro argomento con la prof.ssa Lucia Pelam<strong>atti</strong>.<br />
Già insegnante e <strong>di</strong>rigente scolastico, lavora ora come psicologa, psicoterapeuta e<br />
sessuologa. Si occupa a livello nazionale <strong>di</strong> formazione in campo psicosociale per<br />
operatori scolastici ed extrascolastici, genitori, fidanzati e coppie. Collabora con<br />
numerose riviste educative e ha pubblicato articoli e volumi <strong>di</strong> carattere psicologico.<br />
Svilupperà il tema: “La vita <strong>del</strong> bambino, un puzzle <strong>di</strong> emozioni”.<br />
PROF.SSA LUCIA PELAMATTI<br />
Buongiorno a tutti. E’ un vero piacere trovarsi a parlare in un luogo così bello e con una<br />
presenza così intensa e significativa.<br />
Il tema <strong>di</strong> cui oggi mi occupo riguarda la <strong>di</strong>mensione emotivo-affettiva <strong>del</strong>la persona, in<br />
particolare <strong>del</strong> bambino. Come tutti noi abbiamo modo <strong>di</strong> verificare ogni giorno, questa<br />
<strong>di</strong>mensione riveste un ruolo fondamentale perché riguarda ogni aspetto <strong>del</strong>la nostra<br />
esistenza, ogni luogo <strong>del</strong>la nostra appartenenza, ogni ambiente <strong>di</strong> vita, dalla famiglia<br />
alla scuola alle varie se<strong>di</strong> in cui si svolgono aggregazioni sociali e amicali. Ci influenza<br />
3
intensamente, poiché le emozioni ritmano in modo <strong>di</strong>verso le nostre giornate dando<br />
colore alla nostra vita, possono farci stare davvero bene oppure possono arrivare a<br />
<strong>di</strong>struggerci dentro compromettendo la relazione con noi stessi e la relazione con gli<br />
altri.<br />
Mentre un tempo si pensava, ad esempio, che i processi <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>mento<br />
<strong>di</strong>pendessero esclusivamente o comunque prevalentemente da percorsi <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne<br />
cognitivo, oggi si è all’unanimità convinti che essi <strong>di</strong>pendano tantissimo da processi <strong>di</strong><br />
or<strong>di</strong>ne emozionale. Non a caso, mentre un tempo si parlava solo <strong>di</strong> quoziente<br />
intellettuale, il famoso Q.I., oggi si parla tantissimo <strong>di</strong> quoziente emozionale, cioè <strong>di</strong><br />
quella capacità <strong>di</strong> star bene con se stessi, <strong>di</strong> non provare <strong>di</strong>sagio, <strong>di</strong> <strong>atti</strong>vare una<br />
relazione anzitutto intra-psichica e poi interpersonale molto positiva.<br />
Oggi, purtroppo, il bambino, e credo che tutti lo possiamo constatare, sta incontrando,<br />
a causa <strong>di</strong> una molteplicità <strong>di</strong> fenomeni, alcuni problemi nel raggiungimento <strong>di</strong> un<br />
equilibrio emotivo e ancor più <strong>di</strong> un benessere emotivo. Molte sono le ricerche condotte<br />
su bambini dai 2 ai 7 anni e poi via via, che parlano già <strong>di</strong> mal <strong>di</strong> vivere, <strong>di</strong> <strong>di</strong>sagio nel<br />
bambino. La costellazione <strong>di</strong> elementi che possono in qualche modo farci intuire i<br />
motivi che portano a questo può essere sintetizzata in quell’incertezza esistenziale<br />
generale che colpisce tutti e che dall’adulto ha effetti <strong>di</strong> ricaduta poi nel bambino: la<br />
mancanza <strong>di</strong> riferimenti stabili, <strong>di</strong> valori con<strong>di</strong>visi, la presenza <strong>di</strong> situazioni <strong>di</strong>fficili <strong>di</strong><br />
coppia e <strong>di</strong> famiglia, fino anche all’assenza <strong>di</strong> fratelli e <strong>di</strong> sorelle. A scuola troviamo<br />
spesso bambini con intelligenza buona o più che buona che all’appren<strong>di</strong>mento non<br />
arrivano, e questo per gli insegnanti è fonte <strong>di</strong> notevole <strong>di</strong>sagio, <strong>di</strong> senso <strong>di</strong> colpa, <strong>di</strong><br />
senso <strong>di</strong> impotenza, <strong>di</strong> inadeguatezza. Certamente quando il bambino prova <strong>di</strong>sagio<br />
dentro, a livello affettivo, ha <strong>del</strong>le risorse che si bloccano, che non riescono a salire al<br />
cognitivo. Oggi non c’è testo che parli <strong>del</strong>la relazione adulto/bambino nelle declinazioni<br />
fondamentali genitore/figlio o insegnante/alunno che non ci inviti a riflettere su questi<br />
aspetti. La bilancia purtroppo pare che per tutti, dal bambino, al ragazzo, all’adulto, pesi<br />
<strong>di</strong> più dal punto <strong>di</strong> vista <strong>del</strong>le emozioni negative. Quin<strong>di</strong> tutti dovremmo fare uno sforzo<br />
per rovesciare questa bilancia.<br />
Cominciamo con un lucido che ci parla <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> stress emozionale che oggi<br />
finiscono inevitabilmente per colpire tutti e nei riguar<strong>di</strong> <strong>del</strong>le quali a volte siamo<br />
impotenti, nel senso che ci troviamo immessi in una <strong>di</strong>namica tale che non possiamo<br />
arrestarci. Per questo siamo invitati a cambiare ciò che <strong>di</strong>pende da noi e a tentare <strong>di</strong><br />
adattarci a ciò che non <strong>di</strong>pende da noi senza chiuderci un falsi vittimismi o in como<strong>di</strong><br />
piagnistei.<br />
Imme<strong>di</strong>atamente, guardando questo grafico, proviamo qualcosa a livello emozionale,<br />
quasi un pugno allo stomaco: con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> stress emozionale molte volte provocano<br />
soprattutto nei bambini la manifestazione <strong>di</strong> un comportamento problematico, il<br />
capriccio. Noi adulti spesso, se non stiamo attenti, ci lasciamo andare ad una reazione<br />
negativa imme<strong>di</strong>ata: il bambino urla, noi urliamo più <strong>di</strong> lui; il bambino fa in questo modo<br />
e noi cerchiamo <strong>di</strong> moltiplicare la reazione, portando ad una moltiplicazione <strong>di</strong> stress<br />
4
emozionale, ad un nuovo comportamento problematico, ad una nuova reazione<br />
negativa.<br />
Se noi decliniamo tutto ciò in termini <strong>di</strong> situazione scolastica o <strong>di</strong> situazione familiare,<br />
applicandolo ad esempio ad una m<strong>atti</strong>na in famiglia, ci accorgiamo <strong>di</strong> come tutti stiamo<br />
malissimo a seguito <strong>di</strong> questi giochi senza fine.<br />
Certamente non è in nostro potere azzerare questa con<strong>di</strong>zione, ma dobbiamo imparare<br />
a gestirla, e ciò che <strong>di</strong>pende da noi interviene a questo punto. Se noi anziché lasciarci<br />
andare ad una reazione emotiva imme<strong>di</strong>ata ci fermassimo e ci chiedessimo: questo<br />
bambino, che pesta i pie<strong>di</strong> ed urla, che emozione sta provando in questo momento? E’<br />
qui che dobbiamo riflettere su quella serie <strong>di</strong> in<strong>di</strong>cazioni che ci viene data dallo SPEC<br />
(= Situazione Pensiero Emozione Comportamento).<br />
Noi, <strong>di</strong> solito, data una situazione vissuta o vista, imme<strong>di</strong>atamente passiamo ad un<br />
comportamento. Difficilmente ci fermiamo a chiederci qual è l’emozione che porta verso<br />
questo comportamento, e ancora, a monte, qual è il pensiero che ha generato questa<br />
emozione. Ecco, io credo che se noi adulti apprendessimo questo semplice esercizio,<br />
sicuramente miglioreremmo il destino <strong>del</strong>le nostre relazioni. Certamente, se noi<br />
lavoriamo sull’emozione rischiamo grosso, nel senso che se noi, ad esempio,<br />
sperimentiamo una emozione <strong>di</strong> rabbia e lavoriamo sull’emozione stessa, siamo portati<br />
molte volte a reprimere la rabbia, oppure a negarla. Noi sappiamo che interventi <strong>di</strong><br />
questo genere danneggiano moltissimo, non solo a livello psicologico ma ad<strong>di</strong>rittura a<br />
livello fisico: la psicosomatica oggi ci insegna che la stragrande maggioranza <strong>del</strong>le<br />
mal<strong>atti</strong>e derivano proprio da queste emozioni negative represse, schiacciate dentro per<br />
giorni, per mesi, per anni. Sono molto convinta che queste teorie abbiano in sé <strong>del</strong>le<br />
verità: quando noi non provve<strong>di</strong>amo alla liberazione <strong>del</strong>l’emozione negativa a volte è<br />
l’organismo stesso, purtroppo, che arriva, con <strong>del</strong>le strane proliferazioni che poi ci<br />
danneggiano tantissimo, a operare questa liberazione.<br />
Da questo passaggio cosa possiamo capire? Che l’emozione sicuramente va vissuta,<br />
va espressa, va liberata, quin<strong>di</strong> se il bambino a volte arriva ed esprimere dei sentimenti<br />
negativi che ci creano <strong>di</strong>sagio, noi li dovremmo accogliere, pensando che in quel<br />
momento lui se ne libera. Semmai interverremo sui comportamenti a seguito <strong>di</strong> questi<br />
sentimenti, ma fino a quando il bambino esprime sentimenti dovremmo gioire con lui.<br />
Pensiamo ad esempio alla classica situazione <strong>del</strong> bambino che noi abbiamo preparato<br />
come genitori, in accordo con la scuola, alla nascita <strong>del</strong> fratellino o <strong>del</strong>la sorellina,<br />
responsabilizzandolo, facendo la festa per lui ecc., secondo i canoni. La sorellina<br />
nasce e sembra che tutto vada bene, poi, dopo qualche tempo, un giorno il bambino ci<br />
<strong>di</strong>ce: ”Io quella lì la faccio morere”. Non sa ancora pronunciare l’infinito corretto <strong>del</strong><br />
verbo morire, però ci esprime questo sentimento, e noi ci sentiamo malissimo, ci<br />
chie<strong>di</strong>amo che cosa abbiamo sbagliato. Anche in questo caso noi dovremmo pensare<br />
che certi <strong>di</strong>sagi se rimangono nel tempo schiacciati dentro esplodono magari dopo<br />
trent’anni e vengono ad affollare gli stu<strong>di</strong> degli psicoterapeuti. Quin<strong>di</strong> sicuramente tutto<br />
ciò che è espressione va accolto e va persino stimolato. C’è un bel libro a proposito<br />
5
<strong>del</strong>la rabbia intitolato: “Ho un vulcano nella pancia” da cui possiamo ricavare degli<br />
esercizi utilissimi per bambini <strong>di</strong> scuola materna, elementare e me<strong>di</strong>a.<br />
Interessante anche il passaggio dall’emozione al pensiero, perché se noi non possiamo<br />
lavorare <strong>di</strong>rettamente sull’emozione, il lavoro va fatto, a monte, sul pensiero. Pensiero<br />
inteso nella vasta accezione <strong>del</strong> termine, inteso come vissuto, come esperienza <strong>di</strong>retta<br />
o in<strong>di</strong>retta, come ricordo. Qui c’è tutto un lavoro su quali sono i pensieri dannosi che<br />
non ci aiutano, che ci fanno percepire la realtà come minacciosa o il nostro io come<br />
piccolo, come perdente: tutti lavori legati alla fiducia in se stessi e all’autostima.<br />
Entrando più da vicino nel tema <strong>del</strong>le emozioni, ci può essere utile questa<br />
classificazione che fa <strong>di</strong>vertire tanto i bambini.<br />
CLASSIFICAZIONE DELLE EMOZIONI SECONDO PLUTCHIK<br />
OTTIMISMO<br />
AGGRESSIVITA'<br />
DISPREZZO<br />
Attesa<br />
Aspettativa<br />
Collera<br />
Rabbia<br />
Gioia<br />
Schifo<br />
Disgusto<br />
AMORE<br />
RIMORSO<br />
Al centro troviamo le otto emozioni primarie: la gioia, l’accettazione, la paura, la<br />
sorpresa, la tristezza, lo schifo/<strong>di</strong>sgusto, la collera/rabbia, l’attesa/aspettativa. Vedete<br />
che, accorpandole a due a due, dalla loro unione ne nasce una terza: dalla gioia con<br />
l’accettazione nasce l’amore; dalla accettazione e dalla paura nasce la sottomissione;<br />
dalla paura con la sorpresa nasce lo spavento; dalla sorpresa con la tristezza nasce la<br />
<strong>del</strong>usione; la tristezza con lo schifo/<strong>di</strong>sgusto dà origine al rimorso; schifo/<strong>di</strong>sgusto con<br />
la collera/rabbia genera <strong>di</strong>sprezzo; la collera/rabbia con l’attesa/aspettativa genera<br />
aggressività; l’attesa/aspettativa con la gioia genera ottimismo. Pensate a quanti lavori<br />
interessanti possono essere f<strong>atti</strong> a partire da questo, ponendo ad esempio in vicinanza<br />
<strong>di</strong>versa le otto emozioni primarie; oppure, a partire da una emozione provata<br />
6<br />
Accettazione<br />
Tristezza<br />
Paura<br />
Sorpresa<br />
SOTTOMISSIONE<br />
SPAVENTO<br />
DELUSIONE
(pensiamo alla gelosia), chiederci da quali emozioni può essere generata. I bambini si<br />
<strong>di</strong>vertono molto e riescono veramente ad arricchire se stessi.<br />
A volte, parlando con gli insegnanti, essi <strong>di</strong>cono che sono oberati da mille cose da fare<br />
(e questo è vero) e che non hanno proprio tempo da de<strong>di</strong>care a questi aspetti.<br />
Certamente, già da quando il bambino è piccolo, lavorando sulle emozioni noi<br />
possiamo ricavare tutta una serie <strong>di</strong> vantaggi anche a livello lessicale. Io ho notato che,<br />
in alcune classi in cui si fanno lavori <strong>di</strong> questo genere, persino in alcune scuole<br />
materne, i bambini acquisiscono una capacità verbale e una sfumatura lessicale<br />
notevole.<br />
Pren<strong>di</strong>amo ora in esame le 60 abilità sociali per la vita <strong>del</strong> bambino, in classe e nelle<br />
sue relazioni amicali. Vedete che sono <strong>di</strong>vise in cinque gran<strong>di</strong> settori: le abilità<br />
prerequisite per la vita <strong>di</strong> classe o <strong>di</strong> sezione, quelle per fare o mantenere amicizie (e si<br />
pensi all’importanza <strong>di</strong> questo: tanti bambini hanno situazioni <strong>di</strong> <strong>di</strong>sagio perché hanno<br />
<strong>di</strong>fficoltà relazionali, non riescono trovare il giusto modo per entrare in contatto con<br />
l’altro), le abilità <strong>di</strong> gestione <strong>del</strong>le emozioni, ma anche le abilità per controllare<br />
l’aggressività, e ancora le abilità per gestire lo stress. Tutte appartengono al campo<br />
<strong>del</strong>le emozioni. Quin<strong>di</strong>, anche lavorando sulle abilità sociali, le emozioni hanno una<br />
parte gran<strong>di</strong>ssima. Pensiamo per esempio all’abilità <strong>del</strong> saper perdere: i nostri bambini<br />
proprio non possiedono questa abilità. Prima, quando citavo alcuni dei fattori che<br />
portano a questo <strong>di</strong>sagio <strong>del</strong> bambino <strong>di</strong> oggi, <strong>di</strong>cevo anche <strong>del</strong>la mancanza <strong>di</strong> fratelli e<br />
<strong>di</strong> sorelle. Non è che la con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> figlio unico meccanicisticamente porti a degli<br />
svantaggi: certamente, se il bambino vive una relazione molto intensa con i cugini, con<br />
i vicini <strong>di</strong> casa ecc. si rime<strong>di</strong>a agli effetti negativi. Ma se una persona non ha queste<br />
relazioni, certamente rischia <strong>di</strong> impoverire la sua capacità relazionale e il bambino che<br />
è figlio unico a volte incontra qualche <strong>di</strong>sagio in questo.<br />
Proviamo a vedere il problema <strong>del</strong>l’educazione sessuale, o problema <strong>del</strong>la sessualità.<br />
Le <strong>di</strong>mensioni che compongono la sessualità non sono certamente, come a volte si<br />
trova in qualche percorso, la <strong>di</strong>mensione riproduttiva o la <strong>di</strong>mensione biologica.<br />
Certamente sono <strong>di</strong>mensioni molto importanti, ma, vedete, in alto è messa la<br />
<strong>di</strong>mensione emotivo-affettivo-relazionale, cioè tutto ciò che noi costruiamo dentro la<br />
persona, a livello <strong>di</strong> emozione, a livello <strong>di</strong> affetti, va poi a scaturire in questa<br />
<strong>di</strong>mensione che è fondamentale nella vita. Non mi riferisco alla sola genitalità, mi<br />
riferisco a qualcosa <strong>di</strong> più ampio che <strong>atti</strong>ene alla propria realizzazione come uomini,<br />
come donne, i cui semi come ben sappiamo vengono messi da subito, ad<strong>di</strong>rittura,<br />
secondo gli ultimi stu<strong>di</strong>, dal momento <strong>del</strong> concepimento in poi.<br />
Quali sono le componenti principali <strong>di</strong> un percorso <strong>di</strong> alfabetizzazione emozionale.<br />
Anzitutto conoscere se stessi in modo approfon<strong>di</strong>to. Quin<strong>di</strong>, già da quando il bambino è<br />
piccolo, impiegare <strong>del</strong> tempo con lui per farlo <strong>di</strong>vertire in questa avventura che non ha<br />
mai fine <strong>del</strong> capire “ma chi sono veramente io?”, “chi sei veramente tu?”. Quin<strong>di</strong>, si può<br />
cominciare con dei semplici giochetti che sembrano banali ma che nascondono poi<br />
notevoli ricchezze: Se io sono un oggetto mi paragono a… E perché mi paragono a<br />
questo? E se io mi paragono a un albero, che albero scelgo? Se mi paragono a un<br />
7
animale... È molto interessante con bambini un po’ più gran<strong>di</strong>, partendo dalla scuola<br />
elementare e continuando poi nella scuola me<strong>di</strong>a, con i preadolescenti, fare giochi <strong>di</strong><br />
questo genere. Ad esempio si possono pre<strong>di</strong>sporre <strong>del</strong>le schede in scrivere: “Io sono<br />
come un…”. “Fiore”. “E perché?”. “Io sono come un animale…”. “Io sono come una<br />
cosa…”. “E perché?”. Poi, invitare lo stesso ragazzo a in<strong>di</strong>care tre aspetti che gli<br />
piacciono molto <strong>di</strong> se stesso e osservarlo mentre fa questi lavori. Ci sono ragazzini che,<br />
quando sono invitati a <strong>di</strong>re <strong>di</strong> sé cose positive, iniziano ad agitarsi, cominciano a<br />
guardarsi in giro… Passa il minuto <strong>di</strong> tempo che noi consentiamo per questi lavori e al<br />
massimo sono riusciti a scrivere una cosa; e magari poi nella relazione fanno gli<br />
strafottenti. Se noi rimaniamo a questa visione superficiale, entriamo in quel gioco<br />
senza fine che crea <strong>di</strong>stanze notevoli e non recuperiamo assolutamente più il<br />
ragazzino. Se invece noi, osservandolo, iniziamo a riflettere: “Forse questo ragazzino<br />
non riesce ad avere una immagine positiva <strong>di</strong> sé, forse ha tanto bisogno <strong>di</strong> qualche<br />
feedback positivo da noi insegnanti, dalla relazione con i compagni; forse anche a casa<br />
non riceve nutrimento a questi suoi bisogni <strong>di</strong> fiducia, <strong>di</strong> affetto, <strong>di</strong> stima, <strong>di</strong><br />
valorizzazione...”. Ecco che ci si aprono degli orizzonti <strong>di</strong>versi, ecco che<br />
inspiegabilmente, quando noi prestiamo più attenzione a questo aspetto emotivo,<br />
anche a livello <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>mento il bambino comincia a seguirci <strong>di</strong> più. Poi, possiamo<br />
ad esempio chiedere al bambino <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare tre cose che <strong>di</strong> sé non riesce ad<br />
apprezzare, non accetta; e magari notiamo che i bambini si precipitano a scrivere;<br />
anche questo non è privo <strong>di</strong> significato. Poi si invitano i bambini a fare dei bigliettini<br />
chiusi, scrivendo in stampatello maiuscolo perché la scrittura non sia riconoscibile, li si<br />
mette in un cestino si chiama il primo in or<strong>di</strong>ne alfabetico, lo si invita a sorteggiare un<br />
bigliettino; il bambino legge questa descrizione: ”Io sono come un … perché…” e tutta<br />
la classe è invitata a indovinare chi si nasconde <strong>di</strong>etro questa descrizione. E’ molto<br />
interessante, perché tutto questo lavoro porta al conoscersi in modo approfon<strong>di</strong>to. E’<br />
molto importante soprattutto quando troviamo bambini che non hanno un’immagine<br />
positiva <strong>di</strong> sé. Attraverso un lavoro che possiamo organizzare con la classe, con la<br />
sezione, prendendo i bambini più gran<strong>di</strong>, noi riusciamo a fare davvero <strong>del</strong> bene e a<br />
rime<strong>di</strong>are ad alcuni errori precedenti.<br />
Il secondo passaggio che vi propongo è l’auto-accettazione, il riconoscere le proprie<br />
aree <strong>di</strong> forza e <strong>di</strong> debolezza, il considerarsi positivamente, l’essere capaci <strong>di</strong> ridere, <strong>di</strong><br />
sorridere <strong>di</strong> se stessi. Anche il considerarsi positivamente è molto importante, e<br />
dobbiamo a mio parere spendere un po’ <strong>di</strong> tempo per questo. Se noi riusciamo a<br />
rime<strong>di</strong>are ad alcune con<strong>di</strong>zioni emozionali negative in classe, ad un certo <strong>di</strong>sagio, a un<br />
certo malessere, noi riusciamo poi a vivere molto bene, nel senso che, anche a livello<br />
<strong>di</strong> efficienza, se noi lavoriamo sull’affettività, i risultati tornano tantissimo. Spostiamo<br />
ora l’attenzione su ragazzi preadolescenti e adolescenti. Pensiamo ad un ragazzo che<br />
scriva sul suo <strong>di</strong>ario: “Io non piaccio alle ragazze. Mi specchio e capisco benissimo<br />
perché non piaccio. Anzitutto i foruncoli, maledetti foruncoli, più li schiaccio più quelli<br />
saltano fuori. E poi mi guardo il naso: ha una base mostruosa, non può piacere. Poi mi<br />
8
guardo il viso: ho un viso da luna piena, quando invece alle ragazze piacciono i visi un<br />
po’ fini, un po’ nobili. Poi mi guardo i capelli: ho la fronte stempiata… alla mia età<br />
stempiata? Non si può…” e così via, continua la vivisezione in negativo…<br />
Di fronte a questo, il ragazzo si chiude, nel senso che rifiuta da quel momento <strong>di</strong> uscire,<br />
non partecipa più a relazioni interpersonali. Ora, noi cosa possiamo fare? Proviamo un<br />
<strong>atti</strong>mo ad applicare l’esercizio <strong>del</strong>lo SPEC visto prima. Proviamo chiederci che<br />
emozioni prova questo ragazzo mentre scrive questa pagina <strong>di</strong> <strong>di</strong>ario. Certamente<br />
sono emozioni molto negative: amarezza, <strong>del</strong>usione, rabbia, frustrazione,<br />
scoraggiamento, insod<strong>di</strong>sfazione… Quali sono i pensieri che attraversano la mente <strong>di</strong><br />
questo ragazzo? Alcuni li ha espressi, altri li tiene dentro. Proviamo ora a vedere<br />
questo SPEC messo invece in positivo. La situazione è la stessa: il ragazzo i foruncoli<br />
li ha, questi pensieri li ha. Dov’è che possiamo cominciare a lavorare? Ovviamente sui<br />
pensieri. Quali pensieri potremmo suggerirgli? Il ragazzo è molto centrato sulla<br />
corporeità, per cui non possiamo subito cominciare <strong>di</strong>cendogli che esiste anche una<br />
bellezza interiore, quello glielo <strong>di</strong>remo dopo. Prima dobbiamo viaggiare sulla sua linea,<br />
quin<strong>di</strong>, ad esempio, gli <strong>di</strong>remo che i foruncoli sono un fenomeno temporaneo e gli<br />
daremo tutti quei suggerimenti che lo possono aiutare a credere in se stesso e a vivere<br />
emozioni positive. Valorizzeremo le belle qualità <strong>di</strong> carattere che lui sta <strong>di</strong>mostrando:<br />
quanto sia simpatico e che peccato sia che lui passi le sue giornate chiuso senza<br />
regalare qualcosa <strong>di</strong> sé agli amici. Le emozioni, dalla amarezza/<strong>del</strong>usione,<br />
cominceranno a viaggiare su un or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> fiducia, <strong>di</strong> speranza, un po’ <strong>di</strong> accettazione,<br />
un po’ <strong>di</strong> gioia, <strong>di</strong> fiducia.<br />
Io credo che sarebbero sufficienti questi tre primi passaggi proprio per aiutare<br />
veramente le persone: essere auto-consapevoli, osservare se stessi, riconoscere i<br />
propri sentimenti. Quin<strong>di</strong> ogni tanto sarebbe bene fermare l’<strong>atti</strong>vità <strong>di</strong> classe o, per i<br />
genitori, la cena in famiglia, e con tono positivo e gioioso <strong>di</strong>re: “Proviamo a vedere,<br />
cos’è che stiamo provando in questo momento?” E ciascuno <strong>di</strong> noi può cominciare a<br />
insegnare al bambino questo contatto con i sentimenti, costruire un vocabolario per le<br />
emozioni, conoscere il rapporto tra pensieri, emozioni e comportamenti. Ecco, io credo<br />
che attraverso queste cose molto pratiche, molto semplici, si possa fare parecchio. C’è<br />
poi tutta una serie <strong>di</strong> giochi interessanti: il volto <strong>del</strong>le emozioni, per imparare a dare un<br />
nome alle principali emozioni, il gioco <strong>del</strong> mimo, per riconoscerle dalle espressioni <strong>del</strong><br />
viso, la tombola <strong>del</strong>le emozioni, il termometro <strong>del</strong>le emozioni, per capire quanta rabbia<br />
o gioia sto provando (se provo rabbia a 3000 il mio comportamento molto<br />
probabilmente sarà <strong>di</strong> un certo tipo, se provo rabbia a 10 sarà <strong>di</strong>verso. E come fare a<br />
impe<strong>di</strong>re che la mia rabbia arrivi a questi livelli).<br />
Io credo che attraverso questo la scuola e la famiglia possano fare tanto. Certamente è<br />
un lavoro che ci coinvolge e ci prende tanto tempo, che deve necessariamente<br />
chiederci <strong>di</strong> partire da noi stessi nel senso che non è qualcosa che impegna solo la<br />
testa, ma passa a livello molto più profondo. Quin<strong>di</strong> se noi non abbiamo prima<br />
9
sperimentato su <strong>di</strong> noi e acquisito questa facilità <strong>di</strong> contatto con il nostro mondo<br />
emozionale, a fatica riusciamo poi ad ottenere risultati con i bambini e i ragazzi. Grazie.<br />
SANDRO SANNA<br />
Grazie alla prof.ssa Lucia Pelam<strong>atti</strong>. Una prima relazione davvero intensa e<br />
arricchente, che ci permette <strong>di</strong> riflettere sulla <strong>di</strong>mensione emotiva, fondamentale per<br />
l’appren<strong>di</strong>mento. La professoressa Pelam<strong>atti</strong> ci ha parlato <strong>del</strong>lo “SPEC”, proponendoci,<br />
quin<strong>di</strong>, elementi operativi per migliorare la nostra relazione educativa sia a scuola, sia<br />
in famiglia, sia nell’extrascuola, tutti ambiti nei quali, con il nostro modo <strong>di</strong> essere e <strong>di</strong><br />
agire, siamo chiamati a favorire la crescita integrale <strong>del</strong>la persona.<br />
Il bambino <strong>di</strong> cui abbiamo sentito parlare è il bambino <strong>del</strong>la Carta internazionale dei<br />
Diritti <strong>del</strong>l’Infanzia, quin<strong>di</strong> è la persona da zero a <strong>di</strong>ciotto anni.<br />
Proseguiamo quin<strong>di</strong> nella nostra riflessione dando la parola al Prof. Bruno Ravasio,<br />
<strong>di</strong>rettore <strong>del</strong> Centro <strong>di</strong> Psicologia Clinica ed Educativa (COSPES) <strong>di</strong> Milano. Il tema è:<br />
“Adolescenti e adulti: incontro o scontro?”.<br />
PROF. BRUNO RAVASIO<br />
Vorrei partire da alcune considerazioni generali.<br />
Oggi è piuttosto <strong>di</strong>ffusa una mentalità lamentosa e <strong>di</strong>missionaria nei confronti <strong>del</strong><br />
problema educativo. Quanti genitori e quanti insegnanti, un po’ scoraggiati, ripetono<br />
che oggi educare è <strong>di</strong>fficile! “I ragazzi non ci ascoltano più!”. “I figli fanno quello che<br />
vogliono”… E quin<strong>di</strong> assistiamo a questa lamentosa presenza all’interno <strong>del</strong>l’ambiente<br />
educativo nei confronti <strong>del</strong>le <strong>di</strong>fficoltà che si incontrano nell’educare.<br />
Ora, da questa mentalità lamentosa e <strong>di</strong>missionaria, che ci fa <strong>di</strong>re: “Educare è <strong>di</strong>fficile”,<br />
dobbiamo arrivare a <strong>di</strong>re che “educare è possibile”.<br />
Educare è prendere coscienza <strong>del</strong>la complessità: certo è qualcosa <strong>di</strong> <strong>di</strong>fficile, ma la<br />
complessità fa parte ormai <strong>del</strong>la nostra vita. Certo, la complessità rimanda<br />
maggiormente al concetto <strong>di</strong> <strong>di</strong>fficoltà e <strong>di</strong> incertezza, piuttosto che a quello <strong>di</strong><br />
chiarezza e <strong>di</strong> risposta. Oggi nel nostro mondo è introdotta l’incertezza laddove si<br />
pensava <strong>di</strong> aver capito tutto e spiegata ogni cosa.<br />
Ma la complessità, che si presenta come un ostacolo alla maggiore comprensione dei<br />
f<strong>atti</strong>, può <strong>di</strong>ventare anche una vera sfida, una sfida psicologica e pedagogica per tutti.<br />
Ed ecco allora che bisogna prendere coscienza <strong>di</strong> questa complessità e comprendere<br />
che educare è un nostro compito generazionale. Tocca alla generazione adulta<br />
prendersi in carico il compito <strong>di</strong> educare i giovani.<br />
Diciamo <strong>di</strong> più: non bisogna aspettare a intervenire sull’accaduto, non bisogna<br />
aspettare che il ragazzo <strong>di</strong>venti <strong>di</strong>fficile perché lo si possa recuperare. Non posso<br />
aspettare che il ragazzo si droghi perché poi dopo lo recupero. Non posso aspettare <strong>di</strong><br />
10
intervenire quando le cose accadono: dobbiamo superare questo tipo <strong>di</strong> approccio, che<br />
fa un po’ parte <strong>del</strong> nostro sistema <strong>di</strong> vivere. Bisogna saper prevenire e fare in modo<br />
che il ragazzo non <strong>di</strong>venti <strong>di</strong>fficile, bisogna fare in modo che il ragazzo non arrivi alla<br />
droga. Questo è il compito più importante! Si parla tanto <strong>di</strong> prevenzione, ma se ne fa<br />
poca. Se un bambino è <strong>di</strong>fficile, è incontenibile, a 8-9 anni, bisogna saper intervenire<br />
subito.<br />
Quando comincia l’educazione <strong>del</strong> figlio? Prima che nasca. L’educazione <strong>del</strong> figlio<br />
comincia dalla formazione <strong>del</strong>la coppia genitoriale. Quando due decidono <strong>di</strong> mettere su<br />
famiglia, <strong>di</strong> fare un figlio, devono prepararsi all’educazione; non ci si improvvisa<br />
genitori, educatori, ma bisogna sapersi preparare almeno con un animo <strong>di</strong> <strong>di</strong>sponibilità<br />
a capire, a comprendere la situazione.<br />
Un’altra considerazione: l’importanza <strong>del</strong>la prima educazione, quella che viene fatta in<br />
famiglia. E’ estremamente importante perché è la prima. Quando nevica, le orme che si<br />
stampano nella prima neve sono nitide, perfette, perché sono le prime. Tutte le altre<br />
sono scalpiccio che rovina il manto <strong>di</strong> questa neve. Quin<strong>di</strong> capiamo l’importanza <strong>del</strong>la<br />
prima educazione familiare, perché la seconda educazione corre il rischio <strong>di</strong> essere<br />
una faticosa rieducazione.<br />
Tutti siamo educatori nonostante noi. Quando un adulto entra in relazione con un<br />
minore, automaticamente <strong>di</strong>venta educatore perché i suoi atteggiamenti, il suo modo <strong>di</strong><br />
parlare, <strong>di</strong> <strong>di</strong>re, <strong>di</strong> fare, <strong>di</strong>ventano forme educative per qualsiasi ragazzo.<br />
Qual è lo strumento più valido che abbiamo tra le mani per educare?<br />
Gli stu<strong>di</strong> che abbiamo fatto?<br />
I successi <strong>del</strong>la nostra vita professionale?<br />
No. Lo strumento più valido che abbiamo tra le mani per educare è la nostra<br />
personalità.<br />
La nostra personalità è uno strumento che va continuamente “accordato”. Ogni<br />
m<strong>atti</strong>na, alzandoci, la prima cosa da fare è quella <strong>di</strong> “accordare” la propria personalità<br />
affinché sia pronta a fare “melo<strong>di</strong>e”.<br />
Un altro aspetto importante è questo. Ippocrate <strong>di</strong>ce: “Tutte le parti <strong>del</strong>l’organismo<br />
formano un cerchio, perciò ogni parte è sia il principio che la fine”. Così vale per ogni<br />
organismo e quin<strong>di</strong> anche per la famiglia. Se applichiamo questo principio ai mo<strong>del</strong>li <strong>di</strong><br />
comunicazione presenti all’interno <strong>di</strong> una famiglia, dovremmo, ad esempio, chiederci: è<br />
patologica la comunicazione <strong>di</strong> una data famiglia perché uno dei suoi membri è<br />
nevrotico oppure uno dei suoi membri è nevrotico perché la famiglia è patologica?<br />
Ovvero, è il comportamento provocatorio <strong>del</strong>l’adolescente a rendere il clima familiare<br />
insopportabile o è il clima familiare pesante a rendere il figlio provocatorio? Almeno<br />
metà e metà!<br />
Ricordo un fatto. Una m<strong>atti</strong>na arrivano nel mio stu<strong>di</strong>o un papà, una mamma e un<br />
adolescente <strong>di</strong> quin<strong>di</strong>ci anni. Il padre era un <strong>di</strong>rettore d’azienda, la madre<br />
un’insegnante. Quella m<strong>atti</strong>na il padre doveva sistemare il “problema” <strong>di</strong> suo figlio,<br />
aveva fretta. Entrano: il papà, deciso e baldanzoso, pronto a risolvere il problema, la<br />
11
madre e il figlio, a testa bassa. Si siedono. L’aria era un po’ movimentata. Chiedo al<br />
figlio se può aspettare fuori. Parlo con i genitori. Il padre inizia: “Mio figlio fa la terza<br />
superiore”. E la madre: “No, fa la seconda”. Insistono ognuno sulla propria posizione.<br />
Alla fine il padre si alza <strong>di</strong> scatto, esce, prende il figlio, lo porta dentro e gli chiede che<br />
classe fa. Era tutto chiaro… Il padre voleva risolvere il problema come se fosse un<br />
problema comune <strong>di</strong> un’<strong>atti</strong>vità comune. Quin<strong>di</strong> vedete: è la famiglia o è il ragazzo?<br />
Almeno tutti e due!<br />
Se noi ci convinceremo <strong>di</strong> questo, non andremo più alla ricerca <strong>di</strong> un colpevole o <strong>di</strong> un<br />
presunto capro espiatorio, ma considereremo la questione nella sua globalità e ci<br />
sentiremo tutti inevitabilmente coinvolti nelle stesse responsabilità.<br />
Possiamo fare l’esempio <strong>del</strong>la classe. Entra in classe un insegnante e i ragazzi sono<br />
tranquilli. Ne entra un altro e c’è baldoria. Cosa è cambiato? I ragazzi sono ancora<br />
quelli! E’ cambiato l’insegnante che non ha quella autorevolezza per farsi ascoltare, per<br />
contenere, ecc.<br />
Ora analizziamo alcuni dei comportamenti <strong>del</strong>l’adolescenza.<br />
La crescita personale e l’identità personale si formano in un rapporto con l’esperienza<br />
familiare che ogni in<strong>di</strong>viduo interiorizza. L’uomo evolve recuperando le ra<strong>di</strong>ci all’interno<br />
<strong>del</strong>la sua storia familiare (si porta <strong>di</strong>etro tutto quello che raccoglie nella sua famiglia).<br />
La ricerca <strong>del</strong>la propria identità parte appunto dallo stu<strong>di</strong>o <strong>del</strong>le ra<strong>di</strong>ci; chi non riesce a<br />
mantenere un rapporto con il proprio passato assomiglia a un albero che cresce senza<br />
dare frutti. La casa è il punto da cui si parte. La storia <strong>del</strong>l’adolescente comincia prima<br />
<strong>del</strong>la sua nascita biologica, inf<strong>atti</strong> esiste uno scenario fantasmatico <strong>di</strong> ognuno dei<br />
genitori e <strong>del</strong>la coppia: quando due genitori vogliono un bambino, cominciano a<br />
fantasticare su questo figlio; anche se sono <strong>di</strong>sposti ad accettare tutto quello che<br />
arriva, sognano. Se il papà è uno sportivo, ad esempio pensa che porterà il figlio nel<br />
campetto a giocare a pallone. Poi magari ne rimane <strong>del</strong>uso, perché quando il figlio<br />
vede la palla scappa via. Ora il rischio è che il genitore si innamori <strong>di</strong> questo figlio<br />
fantastico, idealizzato e continui a relazionarsi con lui emotivamente come se fosse<br />
reale. Il figlio invece è quello che è. Il figlio può essere una <strong>del</strong>usione per il padre e per<br />
la madre, cioè può non corrispondere ai sogni dei genitori e <strong>di</strong>ventare il figlio non<br />
accettato, rifiutato, <strong>di</strong>scusso, criticato.<br />
Ebbene, il figlio percepisce questa <strong>del</strong>usione, percepisce <strong>di</strong> non corrispondere alle<br />
aspettative <strong>del</strong> genitore, <strong>di</strong> non essere il figlio desiderato e non sentendosi in colpa per<br />
questo (perché proprio lui non ne ha colpa) innesca un comportamento re<strong>atti</strong>vo, fatto <strong>di</strong><br />
aggressività, oppure <strong>di</strong> un sabotaggio passivo alle richieste genitoriali. Cioè afferma la<br />
sua personalità, come se <strong>di</strong>cesse: “Non sono il figlio che voi volevate, sono <strong>di</strong>verso,<br />
sono io!”.<br />
Compito dei genitori è quello <strong>di</strong> abbandonare l’immagine <strong>del</strong> figlio sognato per<br />
de<strong>di</strong>carsi al figlio che si ha, al vero figlio, con le sue caratteristiche, i suoi limiti, la sua<br />
unicità. Compito dei genitori è annientare la primitiva immagine <strong>del</strong> figlio per de<strong>di</strong>carsi<br />
12
alla promozione <strong>del</strong>le potenzialità caratteristiche proprie <strong>del</strong> figlio, affrontando questo<br />
test <strong>di</strong> realtà.<br />
E’ un po’ come gli insegnanti che <strong>di</strong>cono: “Che razza <strong>di</strong> classe <strong>di</strong> ragazzi sconclusionati<br />
che ho io quest’anno!”. Sono tutti <strong>di</strong>scorsi inutili. Questa è la tua classe, adesso! Questi<br />
sono i tuoi ragazzi e li devi accettare nelle loro caratteristiche, nei loro limiti.<br />
L’adolescenza si può <strong>di</strong>stinguere in tante maniere, io propongo qui alcuni aspetti.<br />
Innanzitutto la pubertà, che è l’ingresso nell’adolescenza. Questo è uno dei momenti<br />
chiave <strong>del</strong>la riorganizzazione <strong>del</strong>l’essere umano. E’ come una seconda nascita.<br />
L’adolescente scopre un mondo, si accorge <strong>di</strong> quello che è. Inizialmente per<br />
l’adolescente <strong>di</strong>venta importante il gruppo, una pseudofamiglia. La famiglia è troppo<br />
stretta per lui; per l’adolescente è <strong>di</strong>fficile rimanere in casa. Nel gruppo si sente libero,<br />
emancipato e, nello stesso tempo, non si sente abbandonato. L’adolescente non è<br />
pronto per andare a vivere la vita sociale, ha bisogno <strong>di</strong> un’altra famiglia, più allargata,<br />
più comprensiva, più tollerante, più simile a lui, dove può parlare <strong>di</strong> quello che vuole,<br />
sentire la musica che vuole e al volume che vuole… insomma vuole stare insieme ai<br />
suoi coetanei, in un ambiente che è una sorta <strong>di</strong> famiglia più allargata, non ancora la<br />
società. In mezzo ai suoi coetanei, che hanno un po’ i suoi stessi problemi <strong>di</strong> confronto<br />
e <strong>di</strong> scontro con i propri genitori e con gli insegnanti, trova una sicurezza, uno spirito <strong>di</strong><br />
emulazione che tende a dargli un equilibrio.<br />
E’ senza dubbio in una prospettiva <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> sicurezza che va valutato il<br />
sorprendente conformismo che caratterizza l’adolescente, in così evidente contrasto<br />
con il tentativo <strong>di</strong> emancipazione che si manifesta nei confronti <strong>del</strong>la famiglia. Nel<br />
gruppo l’adolescente è conformista; in casa è un ribelle. Sono proprio gli atteggiamenti<br />
conformistici che danno all’adolescente una rassicurante sensazione <strong>di</strong> non essere<br />
isolato e al tempo stesso gli permettono <strong>di</strong> <strong>di</strong>fferenziarsi come persona giovane dal<br />
gruppo degli adulti.<br />
Il gruppo per l’adolescente ha sempre un’importanza primaria. Nell’adolescenza il<br />
giovane si trova <strong>di</strong> fronte a un duplice compito: da un lato deve migrare dalla vita<br />
familiare che ha conosciuto fin da piccolo e quin<strong>di</strong> ha tutta la sindrome <strong>del</strong>l’emigrante<br />
che esce <strong>di</strong> casa, lascia il suo paese, la sua terra, la sua tana e si affaccia sul mondo<br />
esterno, con tutta l’incertezza, l’insicurezza <strong>del</strong>l’emigrante; dall’altro deve immigrare,<br />
ma non nel mondo degli adulti, <strong>del</strong> quale non gli importa nulla, ma nel sistema sociale<br />
<strong>del</strong>la società dei suoi pari. Quin<strong>di</strong> ha la sindrome <strong>del</strong>l’emigrante e <strong>del</strong>l’immigrato. Il<br />
gruppo appare così come il rifugio <strong>del</strong>l’emigrante o la patria <strong>del</strong>l’immigrato.<br />
Anche se l’adolescente è da solo in una stanza con il genitore o l’educatore, lo<br />
specchio psicologico <strong>del</strong> gruppo è onnipresente. Voi potete prendere anche il ragazzo<br />
più <strong>di</strong>fficile, prendetelo a tu per tu, cominciate a parlargli. Di fronte a voi è buono, è<br />
ragionevole, capisce, si può anche avere un bel <strong>di</strong>alogo, ma non è lui! Lui è quando è<br />
in mezzo ai suoi compagni. Perché mentre voi gli parlate, lui sente alle sue spalle lo<br />
specchio psicologico <strong>del</strong> gruppo, sente il commento dei suoi compagni (“Che cosa ti ha<br />
detto tua madre?”. “Che cosa ti ha detto la prof.?”. “Te l’ha messa giù dura, vero?”).<br />
13
Lo specchio psicologico <strong>del</strong> gruppo e onnipresente e il timore <strong>di</strong> fare c<strong>atti</strong>va o bella<br />
figura presso il proprio gruppo è un fattore importante che gioca nell’interazione<br />
educativa. Quin<strong>di</strong> non c’è da meravigliarsi se quando parliamo a tu per tu l’adolescente<br />
è docile, attento, ascolta… Ma non è lui. Lui è quando è in mezzo ai suoi compagni.<br />
Ciò va tenuto presente, insieme alla consapevolezza che vi sono precise norme <strong>del</strong><br />
“duello” complesso <strong>del</strong>l’interazione fra adulto e adolescente, per cui il ragazzo può<br />
apparire tra<strong>di</strong>tore, <strong>di</strong>sertore, codardo… se si arrende a un richiamo che proviene da<br />
fuori <strong>del</strong> gruppo. Se il ragazzo si arrende, questo può comportare per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> prestigio<br />
agli occhi <strong>del</strong> gruppo, oppure ostracismo categorico da parte <strong>del</strong> gruppo.<br />
Un altro aspetto è il problema <strong>del</strong>la resistenza psicologica <strong>di</strong> gruppo: questo aspetto,<br />
anche in assenza <strong>del</strong> gruppo stesso, va sempre tenuto presente. Alle spalle <strong>del</strong><br />
ragazzo che abbiamo <strong>di</strong> fronte c’è sempre il suo gruppo. L’adolescente non può mai<br />
permettersi <strong>di</strong> sentirsi solo. C’è sempre il gruppo in ascolto.<br />
Un ulteriore aspetto importante è che la personalità <strong>del</strong>l’adolescente va anche<br />
facilmente soggetta a un collasso sotto l’influenza <strong>del</strong> gruppo: la cosiddetta<br />
“intossicazione psicologica <strong>di</strong> gruppo”. Inf<strong>atti</strong> gli adolescenti non hanno bisogno <strong>di</strong><br />
alcool o <strong>di</strong> droga per raggiungere uno stato <strong>di</strong> ebbrezza o <strong>di</strong> eccitazione. Possono farlo<br />
semplicemente guardando quello che fanno gli altri, per contaminazione. Cioè in un<br />
mondo <strong>di</strong> violenza, dalla violenza sono inebriati; in un mondo <strong>di</strong> erotismo, <strong>di</strong> erotismo<br />
sono contagiati.<br />
Vi è poi l’opposizione, uno degli aspetti più evidenti <strong>del</strong>l’adolescenza. Tuttavia esistono<br />
alcune “sindromi” caratteristiche <strong>di</strong> opposizione. Innanzitutto l’allergia alle situazioni e<br />
agli adulti estranei all’esperienza quoti<strong>di</strong>ana, quin<strong>di</strong> un’allergia a tutti quelli che si<br />
interessano <strong>di</strong> loro (genitori, insegnanti, educatori), ma che non sono <strong>di</strong> loro. Portare un<br />
adolescente dallo psicologo, perché ne ha bisogno, è la cosa più <strong>di</strong>fficile <strong>del</strong> mondo! Gli<br />
adolescenti quando sono in <strong>di</strong>fficoltà sono ostili, non ne vogliono sapere <strong>del</strong>l’aiuto <strong>di</strong><br />
altre persone, pensano <strong>di</strong> risolvere tutti i problemi da soli, <strong>di</strong> avere in mano la chiave<br />
per la risoluzione dei loro problemi. Quando arriva un adolescente che <strong>di</strong>ce: “Ho<br />
bisogno <strong>di</strong> essere aiutato”, il problema è già risolto!<br />
Gli adolescenti entrano in comunicazione solo con quegli adulti che sono immersi nella<br />
loro situazione; stare con loro, entrare in relazione con loro nei rapporti forniti dalla vita<br />
quoti<strong>di</strong>ana: questa è la chiave! Ci sono dei genitori che sanno interessarsi <strong>del</strong>la vita<br />
quoti<strong>di</strong>ana dei loro figli <strong>di</strong>alogando, non inquisendo. Questo va fatto fin dall’inizio, non<br />
dai se<strong>di</strong>ci anni in poi! Altrimenti a se<strong>di</strong>ci anni tu sei nessuno per tuo figlio!<br />
Il comportamento adolescenziale è causa <strong>di</strong> scandalo per i conformisti <strong>di</strong> ogni paese.<br />
Innanzitutto il comportamento adolescenziale è caratterizzato da una decisa volontà <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>fferenziazione in rapporto ai mo<strong>del</strong>li <strong>di</strong> comportamento <strong>del</strong>le generazioni mature.<br />
Pensiamo alla moda: cavallo basso, ombelico scoperto… Poi va a finire che sono gli<br />
adolescenti a imporre la moda, perché gli adulti imitano loro… E allora assistiamo a<br />
degli “spettacoli” ri<strong>di</strong>coli! Comunque i gruppi <strong>di</strong> adolescenti hanno tutti in comune una<br />
caratteristica: la volontà <strong>di</strong> <strong>di</strong>fferenziarsi dalla società dominante con una volontà, più o<br />
meno intensa, <strong>di</strong> protesta.<br />
14
Le reazioni <strong>di</strong> fronte a tutto ciò sono molteplici: qualcuno, per la verità pochi, è<br />
entusiasta; qualcun altro esprime condanna incon<strong>di</strong>zionata, esprimendola con termini<br />
fortemente caricati <strong>di</strong> emotività. Molti propongono mo<strong>del</strong>li educativi <strong>di</strong> tipo autoritario,<br />
altri minimizzano il problema, riconducendolo a un fenomeno ricorrente ad ogni<br />
passaggio <strong>di</strong> generazione. Altri ancora si abbandonano ad un’assurda permissività,<br />
coperta magari da atteggiamenti conservatori o autoritari, e che si manifesta in risposte<br />
prefabbricate e facilmente asservibili a tutte le richieste <strong>del</strong>l’opposizione<br />
adolescenziale. Questo significa che l’adolescente nei suoi sforzi <strong>di</strong> emancipazione<br />
sfonda continuamente porte aperte oppure minaccia <strong>di</strong> crollare <strong>di</strong> fronte ai no.<br />
Insomma o c’è un’opposizione assurda o c’è un permissivismo incomprensibile.<br />
Qual è l’atteggiamento migliore? Quello <strong>di</strong> una resistenza elastica. Cioè saper resister,<br />
ma anche cedere. Il boxeur, per allenarsi, non dà i pugni contro una parete dura e<br />
nemmeno contro <strong>del</strong>le tende, ma contro un pungiball, che oppone una resistenza<br />
elastica. Questo è l’atteggiamento da seguire nell’educazione: saper concedere e<br />
saper resistere. I ragazzi devono incontrare <strong>del</strong>le <strong>di</strong>fficoltà: la libertà, come l’autonomia,<br />
va conquistata, non gliela si può regalare.<br />
L’adolescente ha un bisogno estremo <strong>di</strong> mantenere un legame <strong>di</strong> fondo con la sua<br />
famiglia; non è ancora pronto a liberarsi <strong>del</strong>la famiglia; sente il bisogno <strong>di</strong> avere le<br />
spalle coperte e quin<strong>di</strong> i genitori, così come gli insegnanti, devono essere sempre<br />
pronti a dare una mano e nello stesso tempo permettere all’adolescente <strong>di</strong> fare queste<br />
esperienze “esterne”.<br />
L’adolescente per emanciparsi deve mo<strong>di</strong>ficare il suo comportamento verso i genitori;<br />
mira a svalorizzare i genitori per poterli superare. Perché il figlio <strong>del</strong> campione è<br />
sempre un brocco? Perché il figlio ha davanti un leader, uno riuscito nella vita. Come fa<br />
a <strong>di</strong>ventare meglio <strong>di</strong> lui? Si sente un poverino, un incapace e ha bisogno <strong>di</strong><br />
svalorizzare questo mito per poterlo superare, per <strong>di</strong>ventare anche lui un adulto.<br />
In ogni caso un ragazzo può anche mantenere un comportamento equilibrato e<br />
tranquillo verso i suoi genitori senza per questo costituire un caso patologico.<br />
Qual è il messaggio fondamentale che l’adolescente dà agli adulti? Lo possiamo<br />
esplicitare in questi termini: “Come io cambio i miei comportamenti con voi, così voi<br />
dovete cambiare i vostri comportamenti con me”.<br />
Come conclusione, possiamo <strong>di</strong>re che forse oggi più che mai il giovane ha bisogno <strong>di</strong><br />
una più riuscita identificazione con i genitori, che si adoperino per fargli scoprire che la<br />
vita vale la pena <strong>di</strong> essere vissuta e che attraverso l’esempio gli insegnino che il<br />
rapporto vita-<strong>di</strong>pendenza è cosa desiderabile e che il matrimonio, la maternità e la<br />
paternità sono finalità degne <strong>di</strong> essere perseguite.<br />
15
SANDRO SANNA<br />
Un grazie anche al professor Ravasio che ci ricorda che l’essere educatori è <strong>di</strong> tutti gli<br />
adulti.<br />
I ragazzi hanno bisogno <strong>di</strong> un confronto adulto, hanno bisogno <strong>di</strong> persone che siano in<br />
grado <strong>di</strong> trasmettere qualche cosa che i ragazzi non hanno. E d’altra parte gli adulti<br />
devono saper accettare la “novità” che i giovani portano, saper cogliere e assorbire<br />
questa aggressività che essi hanno nei confronti <strong>del</strong>l’adulto, e saper trasmettere e<br />
rimandare a loro qualche cosa <strong>di</strong> più maturo, altrimenti non c’è più educazione.<br />
Cogliamo anche l’invito a mantenerci in un atteggiamento costante <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> una<br />
qualche linea <strong>di</strong> soluzione, <strong>di</strong> alcuni orientamenti che ci aiutino a capire come non<br />
limitarci a intervenire sui f<strong>atti</strong> che accadono, promuovendo strategie <strong>di</strong> prevenzione<br />
nell'ambito familiare, scolastico e sociale.<br />
E quest’oggi siamo qui proprio per questo; i nostri relatori ci stanno aiutando proprio a<br />
fare questo.<br />
E’ ora il momento <strong>del</strong> contributo <strong>del</strong>la prof.ssa Elena Zanfoni, Vicepresidente<br />
<strong>del</strong>l’Associazione Nazionale dei Pedagogisti Italiani (ANPE) <strong>del</strong>la Regione Lombar<strong>di</strong>a e<br />
membro <strong>del</strong> Consiglio <strong>di</strong>rettivo <strong>del</strong>l’ANPE. La prof.ssa Zanfoni si occupa <strong>di</strong> educazione<br />
degli adulti presso la Facoltà <strong>di</strong> Scienze <strong>del</strong>la Formazione <strong>del</strong>l’Università Cattolica <strong>del</strong><br />
Sacro Cuore.<br />
Ci parlerà dei “ruoli genitoriali in funzione <strong>del</strong>le regole <strong>del</strong>la famiglia”, quin<strong>di</strong> è un<br />
approfon<strong>di</strong>mento <strong>del</strong>la riflessione che faceva il professor Ravasio a proposito<br />
<strong>del</strong>l’importanza <strong>del</strong>la prima educazione, quella che viene fatta in famiglia.<br />
PROF.SSA ELENA ZANFRONI<br />
Ringrazio per l’invito in una così splen<strong>di</strong>da cornice, anche perché parlare <strong>di</strong> famiglia e<br />
<strong>di</strong> queste tematiche <strong>di</strong> cui si sente spesso oggi parlare è sempre comunque stimolante.<br />
E’ <strong>di</strong>fficile intervenire dopo due relazioni autorevoli come quella <strong>del</strong> Prof. Ravasio e<br />
quella <strong>del</strong>la Prof.ssa Pelam<strong>atti</strong> ma cercherò, anche da alcuni stimoli che sono pervenuti<br />
da queste relazioni, <strong>di</strong> procedere nell’intento.<br />
Si deve parlare <strong>di</strong> ruoli genitoriali in funzione <strong>di</strong> regole familiari, però bisogna a questo<br />
punto, anche alla luce <strong>di</strong> quel che abbiamo sentito, stabilire quale è la famiglia <strong>di</strong><br />
riferimento, quale è il nostro mo<strong>del</strong>lo familiare <strong>di</strong> riferimento, quali sono i reali bisogni<br />
educativi <strong>di</strong> questo mo<strong>del</strong>lo familiare che noi deci<strong>di</strong>amo <strong>di</strong> considerare.<br />
Si continua a sentir <strong>di</strong>re che la famiglia è mutata nel tempo, che ci sono i ruoli<br />
genitoriali che sono <strong>di</strong>ventati interscambiabili, ci sono le funzioni che sono cambiate, ci<br />
sono i nuovi padri, ci sono le madri che si de<strong>di</strong>cano sempre più al lavoro e <strong>del</strong>egano ad<br />
altri l’educazione dei figli. Si continuano a sentire questi luoghi comuni che, se da un<br />
16
lato sono luoghi comuni, dall’altro sono anche in molte occasioni dei dati <strong>di</strong> fatto.<br />
Diciamo che in generale, nel cambiamento che la famiglia subisce attraverso i secoli (e<br />
che è inevitabile perché comunque cambia la società e <strong>di</strong> conseguenza anche la<br />
struttura familiare), quello che non deve mai venir meno è il progetto <strong>del</strong>la coppia<br />
genitoriale nei confronti <strong>di</strong> un figlio.<br />
La coppia genitoriale in qualsiasi tempo e in qualsiasi secolo dovrebbe sempre avere<br />
come riferimento il fatto che <strong>di</strong> quel figlio dovrà fare un adulto autonomo e<br />
responsabile. Questo è l’assioma da cui partiamo ed è imprescin<strong>di</strong>bile, è al <strong>di</strong> là <strong>di</strong><br />
qualsiasi cambiamento a cui noi possiamo assistere nell’ambito <strong>del</strong>la società e anche<br />
all’interno <strong>del</strong>lo stesso assetto familiare. Per fare questo quin<strong>di</strong> c’è la necessità, <strong>di</strong>rei<br />
l’urgenza, l’emergenza educativa, <strong>di</strong> stabilire un chiaro progetto educativo per questo<br />
figlio che sia con<strong>di</strong>viso da entrambi i genitori, che non sia il progetto <strong>di</strong> una persona, <strong>di</strong><br />
uno solo dei due genitori, ma sia un progetto con<strong>di</strong>viso. Anche rispetto a questo<br />
qualcuno avrebbe da obiettare: ma oggi che comunque sentiamo sempre più le<br />
famiglie monogenitoriali, famiglie con genitori single, famiglie che comunque sono<br />
<strong>di</strong>sgregate o quanto meno separate, <strong>di</strong>vorziate, come è possibile fare questo progetto?<br />
Questo progetto si deve comunque fare perché <strong>di</strong> mezzo c’è l’integrità <strong>del</strong>la personalità<br />
<strong>del</strong> bambino. Anche gli esempi che ci ha proposto il prof. Ravasio ci permettono <strong>di</strong> <strong>di</strong>re<br />
che portare a termine questo progetto è qualcosa <strong>di</strong> faticoso, però questa fatica merita<br />
in tutti i sensi <strong>di</strong> essere vissuta nel momento in cui <strong>di</strong> mezzo c’è un figlio, una bambino,<br />
un futuro adulto. Un adulto che sarà “artefice” <strong>del</strong>la società che verrà, per cui<br />
comunque non dobbiamo esimerci dal considerare che la coppia si può <strong>di</strong>sgregare ma<br />
la coppia genitoriale non si <strong>di</strong>sgrega mai.<br />
Nel momento in cui la coppia decide <strong>di</strong> avere un figlio, questo è un progetto che si<br />
porterà sempre <strong>di</strong>etro al <strong>di</strong> là <strong>di</strong> quella che sarà la storia <strong>di</strong> questa coppia.<br />
Quin<strong>di</strong>, per chiarirci bene, dovremmo innanzi tutto definire che cosa si intende con il<br />
termine “ruolo genitoriale” e con il termine “funzione”. Molto spesso sono utilizzati in<br />
modo in<strong>di</strong>stinto, ma in realtà c’è una rigida <strong>di</strong>stinzione che vede il “ruolo” come il<br />
comportamento che la società si attende dal soggetto, è quello che in un certo senso la<br />
società richiede al soggetto per il fatto stesso che quel soggetto occupi una<br />
determinata posizione sociale. Quin<strong>di</strong> il ruolo genitoriale è da intendersi in questo<br />
modo, rappresenta il modo <strong>di</strong> essere genitore. Accanto al ruolo <strong>di</strong>stinguiamo la<br />
“funzione” che invece rappresenta il modo <strong>di</strong> fare il genitore, che allora <strong>di</strong>venta quello<br />
che noi possiamo <strong>di</strong>re intercambiabile: si parla <strong>di</strong> funzioni materne e <strong>di</strong> funzioni<br />
paterne; assistiamo alla presenza <strong>del</strong> padre che più che nel passato accu<strong>di</strong>sce il figlio.<br />
In questo è cambiato il modo <strong>di</strong> fare il padre, non è cambiato il modo <strong>di</strong> essere padre: il<br />
padre è sempre lo stesso nell’arco degli anni, il padre è quello che la società si aspetta<br />
dalla figura paterna. In realtà quello che può cambiare è la funzione che quin<strong>di</strong> si può<br />
rendere più o meno intercambiabile.<br />
Quin<strong>di</strong> per la funzione genitoriale in particolare che cosa è richiesto? E’ richiesto <strong>di</strong> non<br />
improvvisarla, cioè è auspicabile una adeguata preparazione allo svolgimento <strong>del</strong>la<br />
17
propria funzione genitoriale proprio per evitare dei problemi che nonostante tutto<br />
potrebbero esserci. Perché se una coppia <strong>di</strong> genitori decide <strong>di</strong> seguire dei percorsi<br />
formativi, <strong>di</strong> aiutarsi in qualche modo a svolgere la propria funzione, ciò non vuol <strong>di</strong>re<br />
che abbia in tasca la ricetta per la felicità eterna. Questo no, perché da questi corsi cui i<br />
genitori partecipano (e anche l’affluenza a questo convegno è una testimonianza <strong>di</strong> ciò<br />
che sto per <strong>di</strong>re) non possiamo ricavare le ”ricette” ma una “cassetta degli attrezzi”,<br />
<strong>del</strong>le occasioni per riflettere su <strong>del</strong>le problematiche, per con<strong>di</strong>viderle. Nessuno deve<br />
avere la sensazione <strong>di</strong> essere inadeguato o <strong>di</strong> perdere tempo, perché in realtà il fatto<br />
stesso <strong>di</strong> sentire un genitore che vive un medesimo problema, uno stesso stato<br />
d’animo, una stessa sensazione nei confronti <strong>di</strong> una problematica che ha<br />
nell’educazione dei figli, <strong>di</strong> fatto può aiutare questo stesso genitore a trovare il<br />
momento <strong>del</strong> riscatto, a trovare la modalità per reagire ad un determinato problema e<br />
soprattutto a non enfatizzarlo eccessivamente perché molto spesso i problemi, se non<br />
li esterniamo agli altri, si amplificano. E’ il <strong>di</strong>scorso <strong>di</strong> prima <strong>del</strong>le emozioni: se noi le<br />
reprimiamo, le teniamo dentro <strong>di</strong> noi, <strong>di</strong> fatto rischiano <strong>di</strong> manifestarsi in altri mo<strong>di</strong> più<br />
<strong>del</strong>eteri. In realtà se noi da queste occasioni <strong>di</strong> incontro, <strong>di</strong> confronto, <strong>di</strong> riflessione,<br />
traiamo questi spunti per poterci sentire non da soli in questi percorsi riusciamo<br />
sicuramente ad avere potenzialmente una forza per andare avanti e soprattutto <strong>del</strong>le<br />
potenzialità che possono aiutarci nel nostro mestiere <strong>di</strong> genitore giorno per giorno.<br />
Ma facendo il punto <strong>del</strong>la situazione, anche dagli spaccati familiari che sono emersi nei<br />
precedenti interventi, proviamo ad articolare la riflessione basandoci sui punti <strong>di</strong><br />
debolezza che sono identificati nella famiglia <strong>di</strong> oggi. Questi punti <strong>di</strong> debolezza non ci<br />
devono mettere davanti ad una situazione tragica o eccessivamente pessimistica. In<br />
realtà sono dei punti <strong>di</strong> debolezza da cui poi noi possiamo evincere dei punti <strong>di</strong> forza<br />
che la famiglia ha in sé, in<strong>di</strong>pendentemente dal tipo <strong>di</strong> famiglia che ci troviamo davanti.<br />
Cioè, la famiglia ha in sé dei punti <strong>di</strong> forza che le possono permettere <strong>di</strong> reagire a<br />
qualsiasi situazione e soprattutto <strong>di</strong> intraprendere il suo cammino educativo e formativo<br />
nei confronti dei figli.<br />
Un primo punto <strong>di</strong> debolezza, che si può evincere da tutte le pubblicazioni anche<br />
numerose che ormai animano gli scaffali <strong>di</strong> qualsiasi libreria, è quello che <strong>di</strong>ce che la<br />
famiglia non educa più ma istruisce e basta. Non educa più perché <strong>del</strong>ega agli altri il<br />
suo compito, non c’è il tempo, non ci sono le modalità e le possibilità <strong>di</strong> educare i propri<br />
figli e <strong>di</strong> conseguenza <strong>del</strong>ega il proprio ruolo genitoriale. Partendo da quello che<br />
abbiamo detto prima, capiamo che questa è una cosa impossibile: non possiamo <strong>di</strong>re<br />
che il genitore <strong>del</strong>eghi il proprio ruolo, potrà semmai <strong>del</strong>egare la propria funzione, non il<br />
proprio ruolo. Per cui un primo punto <strong>di</strong> debolezza che viene comunque riconosciuto<br />
alla famiglia <strong>di</strong> oggi è questo: la famiglia tende non ad educare ma ad istruire e basta.<br />
La famiglia oggi è caratterizzata da un’assenza <strong>di</strong> ruoli, da una confusione <strong>di</strong> funzioni,<br />
<strong>di</strong> mansioni. Di fatto molto spesso <strong>del</strong>egando il proprio ruolo il genitore <strong>del</strong>ega anche<br />
18
decisioni inerenti alla propria funzione genitoriale. In realtà il ruolo è fisso; la funzione,<br />
l’azione, la mansione educativa è scambiabile. In questo senso nell’educazione <strong>del</strong><br />
figlio noi dobbiamo considerare che possiamo riconoscere alla famiglia che ci sia<br />
un’assenza <strong>di</strong> ruoli, ma più che altro che ci sia forse una confusione nelle funzioni e<br />
nelle mansioni educative <strong>del</strong>la famiglia, proprio perché c’è questa confusione a livello <strong>di</strong><br />
ripartizione dei compiti nella coppia genitoriale.<br />
La storia ci <strong>di</strong>ce che prima la figura femminile era legata all’ambito domestico, la donna<br />
era il cosiddetto “angelo <strong>del</strong> focolare”; <strong>di</strong> fatto oggi sono cambiati i tempi e in questo<br />
senso si è mo<strong>di</strong>ficato anche il ruolo <strong>del</strong>la donna all’interno <strong>del</strong>la società, però non per<br />
questo la donna non ha in sé potenzialmente la capacità <strong>di</strong> essere una buona madre.<br />
Di conseguenza anche in questo senso dobbiamo stare attenti a non generalizzare<br />
eccessivamente il problema.<br />
Quin<strong>di</strong> perché nella famiglia c’è un’assenza <strong>di</strong> ruoli? Perché si <strong>di</strong>ce che in famiglia<br />
mancano i valori, non c’è un riferimento valoriale consistente, non c’è un saldo<br />
riferimento valoriale, e questo provoca il fatto che il figlio viene immesso nella società,<br />
nella scuola e negli altri ambienti extra-familiari con un po’ <strong>di</strong> confusione a livello anche<br />
comportamentale. In realtà è proprio la famiglia (quella che il prof. Ravasio chiamava<br />
prima educazione) che dà l’educazione al ragazzo, non è qualsiasi altro ente educativo<br />
che si mette in relazione col figlio, ma è la famiglia che dà la prima educazione, perché<br />
i valori forti, che possono essere il nostro riferimento, sono in famiglia, si respirano in<br />
famiglia, proprio perché sono quei principi orientativi <strong>del</strong>la persona che<br />
necessariamente il figlio può cogliere nell’ambiente familiare e non da altri. O<br />
comunque se li coglie da altri ovviamente poi c’è la confusione, il <strong>di</strong>sagio, l’emergere <strong>di</strong><br />
forme <strong>di</strong> <strong>di</strong>sadattamento che possono essere anche facilmente riscontrabili.<br />
Un terzo punto è quello che <strong>di</strong>ce: c’è confusione tra “amore infantile” e “amore maturo”.<br />
Amore infantile inteso nel senso <strong>di</strong> “amo perché sono amato”, amore maturo inteso nel<br />
senso <strong>di</strong> “sono amato perché amo”. Fromm in uno dei suoi più bei libri aveva chiarito<br />
questa definizione <strong>di</strong> amore maturo e amore infantile. Quin<strong>di</strong> quello che si riconosce<br />
come punto <strong>di</strong> debolezza <strong>del</strong>la famiglia è un po’ questa confusione tra le due forme <strong>di</strong><br />
amore, una tipica <strong>del</strong> bambino e l’altra <strong>del</strong> genitore. Prima il professor Ravasio ha<br />
detto: “Ci sono dei genitori che si vestono come i propri figli, per sembrare giovani, per<br />
essere come loro”. Ecco, questo è un atteggiamento “infantile”, ma non perché siamo<br />
qui a mettere all’in<strong>di</strong>ce questi comportamenti, ma perché comunque l’omologazione <strong>del</strong><br />
ruolo genitoriale col ruolo filiale <strong>di</strong> fatto è qualcosa <strong>di</strong> riprovevole, perché comunque<br />
non ci porta ad un salto <strong>di</strong> qualità, non dà al figlio una sicurezza interiore. Tanti<br />
potrebbero <strong>di</strong>re: “Solo perché i genitori si vestono come il figlio, siamo qui a fare dei<br />
<strong>di</strong>scorsi esistenziali”. In realtà da questi elementi noi capiamo anche che tipo <strong>di</strong><br />
relazione ci può essere tra genitori e figli e il tipo <strong>di</strong> valori che il genitore trasmette al<br />
figlio.<br />
19
Non c’è un rispetto <strong>del</strong>le potenzialità e dei ritmi <strong>di</strong> crescita dei figli. C’è una sorta <strong>di</strong><br />
slogan che <strong>di</strong>ce: ”Liberate il tempo libero ai bambini”. La tendenza oggi è quella <strong>di</strong><br />
riempire la vita <strong>del</strong> bambino anche e soprattutto al <strong>di</strong> là <strong>del</strong>la scuola. Per cui abbiamo<br />
questi bambini che sono stressati fin da piccoli perché il lunedì hanno catechismo, il<br />
martedì hanno inglese, il giovedì hanno danza, il venerdì hanno un’altra cosa. Di fatto<br />
questo non è negativo <strong>di</strong> per sé a priori, ma va considerato in relazione al bambino, ai<br />
suoi ritmi <strong>di</strong> crescita, non a quelli dei suoi genitori che hanno il desiderio che il bambino<br />
faccia pianoforte, danza, inglese perché già da piccolo deve <strong>di</strong>ventare un adulto che<br />
parla inglese come la sua lingua madre. Bisogna considerare i ritmi <strong>di</strong> crescita dei<br />
bambini e bisogna riflettere bambino per bambino. Lo sanno benissimo gli insegnanti:<br />
ci sono dei ritmi <strong>di</strong>versissimi, per cui comunque bisogna agire nel rispetto <strong>di</strong> questi<br />
ritmi. Se questo calendario settimanale molto ricco <strong>di</strong> impegni è <strong>di</strong> fatto un calendario<br />
fatto solo per tamponare una situazione <strong>di</strong> emergenza <strong>del</strong> genitore che altrimenti prima<br />
<strong>di</strong> quell’ora non sa dove mettere il bambino perché la scuola ormai è finita, bisogna<br />
riflettere e capire: è un’esigenza <strong>del</strong> genitore o è una volontà <strong>del</strong> bambino?<br />
Il coniuge non sa essere coniuge e <strong>di</strong> conseguenza non sa essere genitore. Posto che<br />
non a priori i due ruoli siano legati (uno può essere un buon coniuge ma <strong>di</strong> fatto non<br />
saper essere genitore), nel momento in cui noi ci troviamo <strong>di</strong> fronte a una coppia che<br />
non ha assunto una sua <strong>di</strong>mensione esistenziale, che non si sa parlare, che comunque<br />
ha dei problemi (i dati statistici ce lo rivelano: parecchie sono le coppie che possono<br />
avere problemi relazionali al loro interno, nella <strong>di</strong>ade coniugale), <strong>di</strong>fficilmente questi<br />
coniugi riusciranno ad essere dei buoni genitori, perché <strong>di</strong> fondo manca la <strong>di</strong>sponibilità<br />
a stabilire tra i due quella coesione educativa che può portare ad essere dei buoni<br />
genitori. Se nella coppia non c’è <strong>di</strong>alogo, nella coppia non ci potrà essere una coesione<br />
educativa, ovvero una con<strong>di</strong>visione <strong>del</strong> proprio progetto educativo nei confronti <strong>del</strong><br />
figlio. Quin<strong>di</strong>, non il progetto <strong>di</strong> uno dei genitori, ma il progetto <strong>di</strong> entrambi, nasce da<br />
una coesione, da un accordo che c’è tra i genitori. Molto spesso, se voi solo pensate<br />
nella quoti<strong>di</strong>anità, ci troviamo davanti alla madre che sgrida il bambino e al padre che<br />
davanti alla madre <strong>di</strong>ce che non è giusto.<br />
A questo punto possiamo <strong>di</strong>re che educare vuol <strong>di</strong>re saper orientare a due <strong>di</strong>mensioni<br />
in particolare. Una <strong>di</strong>mensione “longitu<strong>di</strong>nale”, che vuol <strong>di</strong>re educare al futuro, orientare<br />
al futuro, e una <strong>di</strong>mensione “<strong>di</strong>fferenziale” che è il saper orientare in base alle proprie<br />
potenzialità. Quin<strong>di</strong> una volta che la coppia assume queste due capacità, queste due<br />
<strong>di</strong>mensioni, possiamo <strong>di</strong>re che supera il problema <strong>di</strong> per sé.<br />
Il sesto punto è quello <strong>di</strong> non saper comunicare. Questo aspetto lo abbiamo già<br />
intravisto nei punti precedenti, e <strong>di</strong> fatto sembra essere il problema sostanziale <strong>del</strong>la<br />
coppia genitoriale oggi, che <strong>di</strong>fficilmente comunica, o comunque se lo fa, lo fa nella<br />
maniera sbagliata. Questo è un atteggiamento che il figlio coglie al volo ed utilizza a<br />
proprio piacimento.<br />
20
Ma in questo quadro tragico cosa bisogna fare? Il quadro ci fa riflettere su quelli che<br />
effettivamente potrebbero essere dei punti <strong>di</strong> debolezza sostanziali che la famiglia può<br />
avere.<br />
I punti <strong>di</strong> forza li abbiamo già intravisti nell’elencare quelli <strong>di</strong> debolezza. Prima <strong>di</strong> tutto la<br />
coesione educativa, che è alla base <strong>di</strong> ogni scelta educativa. Non possiamo<br />
prescindere da una coesione educativa e questo implica i due genitori. Questo non è<br />
un ostacolo per le coppie separate, perché molto spesso si è notato come esista una<br />
maggiore coesione educativa in una coppia <strong>di</strong> separati che in una coppia che convive.<br />
Questo non deve essere un limite e tanti genitori spesso imparano a comunicare più da<br />
separati che non da sposati. Non mi fraintendete, non voglio <strong>di</strong>re che tutte le coppie<br />
separate hanno una coesione educativa maggiore <strong>di</strong> quelle che vivono insieme, però<br />
può capitare, perché molto spesso la coppia che convive o dà per scontato determinati<br />
atteggiamenti o comunque non ha un grado <strong>di</strong> comunicazione molto elevato, e questo<br />
incide nella mancanza <strong>di</strong> una coesione educativa vera e propria. Quin<strong>di</strong> talvolta manca<br />
proprio la volontà <strong>di</strong> ricercare <strong>del</strong>le regole, <strong>di</strong> ricercare <strong>del</strong>le decisioni, <strong>del</strong>le prospettive<br />
migliori <strong>di</strong> crescita, è <strong>di</strong>fficile che i genitori si fermino a riflettere sui propri figli e su<br />
determinate linee <strong>di</strong> condotta che la famiglia può avere.<br />
E’ molto importante stabilire <strong>del</strong>le regole familiari: il termine “regole” <strong>di</strong> per sé implica<br />
qualcosa <strong>di</strong> restrittivo, un <strong>di</strong>vieto, un atteggiamento negativo. In realtà la regola è un<br />
qualcosa <strong>di</strong> estremamente positivo. Se noi pensiamo alla regola evochiamo la<br />
subor<strong>di</strong>nazione, la rigi<strong>di</strong>tà, l’autoritarismo. In realtà la regola educativa è in<strong>di</strong>ce <strong>del</strong>la<br />
capacità dei genitori <strong>di</strong> offrire uno spazio chiaro dentro il quale esercitare azioni <strong>di</strong><br />
libertà. Se noi <strong>di</strong>amo <strong>del</strong>le regole, non <strong>di</strong>amo <strong>del</strong>le restrizioni, <strong>di</strong>amo <strong>del</strong>le possibilità <strong>di</strong><br />
<strong>del</strong>imitare uno spazio entro cui nostro figlio e i genitori stessi possano avere <strong>del</strong>le<br />
azioni <strong>di</strong> libertà, e la libertà <strong>del</strong>la persona è uno dei primi obiettivi se non quello<br />
massimo.<br />
E’ <strong>di</strong>fficile oggi per la coppia genitoriale darsi <strong>del</strong>le regole perché la cultura attuale è<br />
basata sull’assioma che i figli debbano tendere agli or<strong>di</strong>ni dati dai genitori, o comunque<br />
cogliere gli or<strong>di</strong>ni impliciti dei genitori prescindendo dalla chiarezza con cui sono<br />
esplicitati. E’ facile <strong>di</strong>re “il figlio non sta alle regole”, in realtà bisogna anche riflettere su<br />
quanto esplicite sono queste regole? Quanto i genitori sono in grado <strong>di</strong> esplicitare<br />
queste regole familiari? O quanto meno, quanto sono d’accordo entrambi i genitori su<br />
queste regole? Perché molto spesso capita che il figlio passi più ore a scuola… Qui si<br />
innesta il problema <strong>del</strong>la qualità o quantità <strong>del</strong> tempo: non importa la quantità <strong>del</strong><br />
tempo che passiamo coi figli, importa la qualità. Anche se ci sono poche ore è<br />
importante che queste siano de<strong>di</strong>cate al figlio e non siano de<strong>di</strong>cate a qualcos’altro ed il<br />
figlio coabiti solo in quel momento insieme al genitore. Passare le ore col figlio non<br />
significa coabitare nello stesso ambiente ma poi ognuno fa i f<strong>atti</strong> suoi, significa<br />
considerare il figlio, <strong>di</strong>alogare con lui, cercare <strong>di</strong> capire… non mettendosi in un modo<br />
strutturato ”adesso <strong>di</strong>aloghiamo”, ma giocando con lui, chiacchierando con lui <strong>del</strong>la<br />
giornata, facendolo parlare perché è sin da piccoli che si motivano, si stimolano in un<br />
certo senso ad aprirsi, a saper comunicare.<br />
21
Quin<strong>di</strong> abbiamo detto la coesione educativa e il darsi <strong>del</strong>le regole familiari. Il terzo<br />
punto è pre<strong>di</strong>sporsi all’ascolto dei figli, e quello che abbiamo detto prima è un po’ un<br />
prelu<strong>di</strong>o a questo. Di fatto dobbiamo evitare <strong>di</strong> voler clonare il proprio figlio da noi<br />
stessi: non è che nostro figlio necessariamente perché è nostro figlio biologicamente<br />
deve avere le nostre aspirazioni, i nostri progetti, il nostro modo <strong>di</strong> vita. Di fatto<br />
sicuramente un figlio vivendo in una famiglia acquisisce le regole familiari, i valori<br />
familiari, però questo figlio è unico e irripetibile, come qualsiasi persona e <strong>di</strong><br />
conseguenza avrà le sue potenzialità che sono <strong>di</strong>verse dalle nostre e dovremo<br />
accettarle. Per cui non dovremo fare su <strong>di</strong> lui un progetto: è quella <strong>di</strong>fferenza tra<br />
bambino reale e bambino immaginario <strong>di</strong> cui parlava prima il Prof. Ravasio. Dovremo<br />
considerare nostro figlio per quello che è in quel momento, e non per quello che<br />
avremmo voluto che fosse.<br />
Per fare tutto ciò si può pensare al <strong>di</strong>scorso formativo dei genitori, ma non<br />
immaginando che i genitori siano costretti tra le mille cose che hanno da fare ad<br />
andare a frequentare un corso o <strong>del</strong>le iniziative costantemente. Sicuramente però<br />
significa che i genitori siano chiamati, e in questo la scuola li può aiutare, a riflettere sul<br />
proprio ruolo, che abbiano occasioni <strong>di</strong> formazione, come quella <strong>di</strong> oggi, che ci siano<br />
dei momenti formativi in cui non c’è il relatore che parla e l’altro che ascolta e assorbe<br />
le in<strong>di</strong>cazioni <strong>del</strong> relatore, perché in questi ambiti purtroppo il relatore non può dare<br />
<strong>del</strong>le regole, può aiutare a riflettere ma non può far altro perché ognuno poi deve<br />
rielaborare questi contenuti e adeguarli al proprio stile <strong>di</strong> vita. Il presupposto formativo<br />
<strong>del</strong>la famiglia è che tutti i genitori, al <strong>di</strong> là <strong>del</strong> proprio status, <strong>del</strong>la loro formazione, <strong>del</strong>le<br />
loro esperienze, siano chiamati a perfezionare costantemente il proprio modo <strong>di</strong> essere<br />
e <strong>di</strong> fare i genitori. Molto spesso si assiste alla situazione in cui a questi percorsi<br />
formativi ci vengono i genitori che sono sereni, che non hanno problemi con i figli o che<br />
comunque ne hanno pochi, mentre proprio quelli che hanno i problemi, che hanno il<br />
figlio che ha qualche <strong>di</strong>sagio, che è <strong>di</strong>sadattato, non rompono il ghiaccio e non<br />
prendono l’iniziativa <strong>di</strong> andare ad un incontro, ad un percorso, non intraprendono un<br />
percorso formativo in questo senso. Dobbiamo pensare ad una formazione dei genitori<br />
che non sia esclusivamente una formazione pensata come qualcosa <strong>di</strong> incanalato in<br />
un’offerta formativa quasi a mo’ <strong>di</strong> scuola. Sicuramente ci sono le cosiddette “scuole<br />
dei genitori”, però dobbiamo anche essere realisti e pensare che non tutti possono<br />
essere assidui frequentatori <strong>di</strong> esse. Quello che si può fare è stimolare al confronto il<br />
genitore creando proprio <strong>del</strong>le occasioni anche minime <strong>di</strong> riflessione che lo aiutino e lo<br />
incoraggino anche, perché molto spesso il genitore è scoraggiato. Se il figlio non<br />
ascolta, inf<strong>atti</strong>, il genitore si scoraggia e non è che accetta <strong>di</strong> parlare <strong>del</strong> proprio<br />
problema con gli altri. In questo legame <strong>di</strong> mutuo aiuto che si può instaurare tra le varie<br />
coppie genitoriali ci può essere la risorsa per tutti, per i genitori e per il figlio che si trova<br />
ad avere dei genitori più sicuri, più autorevoli con la loro presenza.<br />
Mi piace pensare a quello che una anonimo ha scritto in merito a questo: “I genitori<br />
dovrebbero trasmettere ai figli le ra<strong>di</strong>ci e le ali”. Le ra<strong>di</strong>ci nel senso <strong>del</strong>la robustezza, la<br />
storia, l’origine <strong>di</strong> questa famiglia, <strong>di</strong> fatto i valori forti che animano la famiglia; al tempo<br />
22
stesso le ali, cioè rendere il figlio autonomo, libero, un in<strong>di</strong>viduo, una persona<br />
consapevole, autonoma e responsabile, quell’adulto autonomo e responsabile cui si<br />
accennava prima.<br />
Non è una cosa facile, è <strong>di</strong>fficile o per lo meno faticoso, però sicuramente questa può<br />
essere la nostra risorsa <strong>di</strong> oggi nei confronti <strong>del</strong>la famiglia per evitare <strong>di</strong> sentirci <strong>di</strong>re i<br />
soliti luoghi comuni. “La famiglia è in crisi”. “La famiglia non c’è più”... Sicuramente ci<br />
sono molteplici forme familiari, molteplici contesti e problematiche che vanno anche al<br />
<strong>di</strong> là <strong>del</strong>la coppia genitoriale in sé, però bisogna aiutare creando occasioni formative<br />
per la coppia, occasioni che possano dare uno slancio a questa coppia per migliorarsi<br />
e per migliorare il proprio figlio.<br />
SANDRO SANNA<br />
Grazie alla prof.ssa Zanfroni per questa dotta relazione che ancora una volta si pone<br />
sul piano <strong>del</strong>la comunicazione. Interessante anche l’idea <strong>del</strong> progetto da con<strong>di</strong>videre: i<br />
genitori progettisti, che però, per poter essere tali, devono essere preparati. Ciò<br />
significa sia che la “scuola genitori” o occasioni come quelle <strong>di</strong> oggi possono essere<br />
utili per prepararsi, sia che spesso abbiamo bisogno <strong>di</strong> suggerimenti che possano<br />
essere sperimentati nella quoti<strong>di</strong>anità da tutti noi, in famiglia, a scuola o in altri ambiti <strong>di</strong><br />
lavoro educativo.<br />
Diamo ora spazio al dott. Fabrizio Fantoni, sempre <strong>del</strong> Centro <strong>di</strong> Psicologa Clinica ed<br />
Educativa <strong>di</strong> Milano, psicologo e psicoterapeuta, che ci parlerà <strong>del</strong>l’esperienza sociale<br />
<strong>del</strong>l’adolescente tra scuola ed extrascuola.<br />
DOTT. FABRIZIO FANTONI<br />
Ecco qui sul video un gruppo allegro <strong>di</strong> adolescenti che ci accoglie in questa nostra<br />
riflessione sullo stare insieme. Se fate caso, siamo spesso più noi adulti, o magari gli<br />
anziani, che lamentano una con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> solitu<strong>di</strong>ne e <strong>di</strong> sofferenza per la solitu<strong>di</strong>ne, a<br />
volte reale, nel senso che veramente sono persone le cui con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> vita sono <strong>di</strong><br />
carenza <strong>di</strong> rapporti con gli altri e <strong>di</strong> solitu<strong>di</strong>ne, a volte un po’ esibita. Non troverete mai<br />
un adolescente che vi <strong>di</strong>ca <strong>di</strong> non avere nessun amico, anche quando ci sono<br />
adolescenti che non hanno amici, anche quando ci sono adolescenti che fanno fatica a<br />
costruire <strong>del</strong>le relazioni. Per tutti però è importante poter almeno esibire all’occhio<br />
<strong>del</strong>l’adulto la presenza <strong>di</strong> un amico. Poi si va a parlare con i genitori, con gli insegnanti<br />
e ci si accorge che effettivamente sono ragazzi con <strong>di</strong>fficoltà relazionali magari anche<br />
grosse, però nessun adolescente può permettersi <strong>di</strong> essere così povero. Ci saranno<br />
adolescenti che vi confesseranno con rammarico e magari anche con sofferenza <strong>di</strong> non<br />
sentirsi intelligenti, belli, attraenti, capaci sul piano sportivo, ma nessuno vi <strong>di</strong>rà <strong>di</strong><br />
essere proprio senza nessun amico.<br />
23
Qualche settimana fa viene da me una mamma che mi <strong>di</strong>ce: “Ho trovato questo scritto<br />
sul desktop <strong>del</strong> computer. Mi preoccupo oppure no?”. Si tratta <strong>di</strong> pensieri <strong>di</strong> un<br />
adolescente, tre corposi paragrafi; quello <strong>di</strong> mezzo <strong>di</strong>ce così: “La mia vita la vivo io.<br />
Perché ho bisogno degli altri? Mi sento ipocrita a <strong>di</strong>re che io non ne ho bisogno, e<br />
vorrei che fosse così, e in effetti in alcuni momenti è così, ma poi mi ricordo <strong>di</strong> quanto<br />
mi <strong>di</strong>verto quando sto con loro. Mi rendo conto che ho quasi tre<strong>di</strong>ci anni e non ho un<br />
amico vero su cui poter contare, e mi rendo anche conto che ne ho bisogno. Ma perché<br />
devo essere così arrabbiato? Perché la serenità si trova solo dopo ogni momento <strong>di</strong><br />
rabbia? O<strong>di</strong>o dover ammettere <strong>di</strong> aver bisogno <strong>di</strong> un amico. Può darsi che mio cugino,<br />
plagiandomi, facendomi da guida, da maestro e amico, così come anche da <strong>di</strong>ttatore,<br />
sfruttatore e nemico, mi abbia fatto sorgere un o<strong>di</strong>o per la vita, una tale avversione per<br />
la felicità convenzionale che non riesco a trovare la mia. Ma <strong>di</strong>cendo così addosserei<br />
tutte le colpe su <strong>di</strong> lui e mi sentirei falsamente a posto con la coscienza. Invece so che<br />
è colpa mia se non sono stato capace <strong>di</strong> capire cosa è giusto e cosa non lo è per me.<br />
Devo vivere per forza?”. Un ragazzo <strong>di</strong> tre<strong>di</strong>ci anni con una profon<strong>di</strong>tà e una acutezza<br />
<strong>di</strong> auto-analisi davvero invi<strong>di</strong>abile. La mamma si preoccupa, ma non c’è troppo da<br />
preoccuparsi finché pensa, finché scrive, finché <strong>di</strong>ce le cose.<br />
Mi sembra che questo paragrafo in particolare esprima bene la con<strong>di</strong>zione degli<br />
adolescenti attr<strong>atti</strong> irrime<strong>di</strong>abilmente dall’orbita degli amici, ma contemporaneamente<br />
anche in tensione con loro, nel bisogno <strong>di</strong> dover vivere da soli e <strong>di</strong> sentire <strong>di</strong> poter far<br />
conto solo sulle proprie forze. Che è un po’ una con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> oscillazione (negli<br />
adolescenti molto ampia) che forse viviamo un pochino tutti. Io credo che le persone si<br />
collochino su <strong>di</strong> un continuum che va da coloro che, come <strong>di</strong>ceva Sartre, pensano che<br />
gli altri siano l’inferno, a quelli che invece ritengono che solo attraverso gli altri si possa<br />
vivere: “Invano bagni il tuo viso in te stesso perché potrai specchiarlo soltanto in<br />
un’altra persona” <strong>di</strong>ceva un poeta ungherese. In questa oscillazione continua gli<br />
adolescenti si trovano alla ricerca <strong>di</strong> un nuovo se stesso. La con<strong>di</strong>zione<br />
<strong>del</strong>l’adolescente è quella <strong>di</strong> uno che deve nascere la seconda volta. La prima volta si<br />
nasce in senso anche fisico-organico alla vita e a una vita <strong>di</strong> famiglia, <strong>di</strong> relazione,<br />
all’interno <strong>di</strong> un gruppo ristretto, dove l’appartenenza è quella al nucleo familiare;<br />
l’adolescente nasce a una nuova appartenenza, quella <strong>del</strong> gruppo degli altri, <strong>del</strong><br />
mondo.<br />
Attraverso gli altri gli adolescenti sentono che possono <strong>di</strong>ventare se stessi, per questo<br />
nessuno vi <strong>di</strong>rà mai <strong>di</strong> essere completamente solo, perché sente che questo rischia <strong>di</strong><br />
essere uno scacco a questo percorso <strong>di</strong> crescita che ha iniziato e dal quale non si può<br />
recedere. Però con queste contrad<strong>di</strong>zioni: l’identità <strong>di</strong> contro all’alterità, il<br />
riconoscimento cioè <strong>del</strong>l’altro e che l’altro mi interessa. Pensiamo a quella spinta verso<br />
l’alterità che è la sessualità, che l’adolescente vive e sperimenta dentro <strong>di</strong> sé, che è<br />
proprio la ricerca <strong>di</strong> qualcuno che sia “altro” da me. Rispetto invece ad un movimento<br />
più centripeto <strong>di</strong> ritorno sui <strong>di</strong> sé, <strong>di</strong> definizione <strong>di</strong> un’identità propria, con una<br />
appartenenza anche molto netta, molto precisa. Il gruppo <strong>di</strong> appartenenza <strong>di</strong>venta<br />
importantissimo: devo con<strong>di</strong>videre l’abbigliamento, gli usi e i costumi, il linguaggio, i<br />
24
gesti, e quello è il mio gruppo. E’ il gruppo <strong>del</strong> quartiere, il gruppo <strong>del</strong>la classe, e questo<br />
gruppo deve essere un gruppo molto forte, molto intenso.<br />
Dunque l’adolescente vive questa duplice <strong>di</strong>mensione: da un lato il bisogno <strong>di</strong><br />
appartenenza, dall’altro il bisogno in certi momenti <strong>di</strong> ritornare verso l’in<strong>di</strong>vidualità, <strong>di</strong><br />
richiudersi in se stessi (“Non si fa più vedere, non si fa più sentire… Mando messaggi e<br />
questo non mi risponde… Che cosa è successo?”).<br />
Il conformismo, la necessità <strong>di</strong> adottare mode uguali per tutti (stesse scarpe, stessi<br />
jeans…) e <strong>di</strong> contro il bisogno <strong>di</strong> sentirsi <strong>di</strong>verso dagli altri: capite che è una bella<br />
quadratura <strong>del</strong> cerchio quella che l’adolescente si trova a dover affrontare!<br />
Gli altri servono perché sono lo specchio: guardando quello che fanno gli altri, capisco<br />
meglio quello che faccio io; le reazioni degli altri mi <strong>di</strong>cono chi sono. Se gli altri mi<br />
trovano simpatico o se gli altri mi definiscono come un imbranato, questo incide<br />
fortemente sulla definizione <strong>del</strong>la mia identità. Quin<strong>di</strong> gli altri sono un supporto<br />
all’identità che si va costruendo e <strong>di</strong>ventano un supporto necessario; ma gli altri sono<br />
anche una palestra dove io posso affermare me stesso. All’interno <strong>del</strong> gruppo faccio<br />
esperimenti: vedo qual è l’identità all’interno <strong>del</strong>la quale posso trovarmi meglio; provo a<br />
fare il leader, provo a fare il gregario; provo a fare il simpaticone, provo a fare il<br />
pensatore e il filosofo. Volta per volta tento <strong>di</strong> assumere maschere <strong>di</strong>verse in modo da<br />
capire qual è quella più confacente a me.<br />
Dunque il problema centrale, quando paliamo <strong>del</strong> gruppo, è il problema <strong>del</strong>l’identità.<br />
Dove c’è l’identità <strong>del</strong>l’in<strong>di</strong>viduo e dove questa identità si scioglie nell’identità <strong>del</strong><br />
gruppo.<br />
“Non sono più un bambino… non sono ancora un adulto”, ci <strong>di</strong>ce l’adolescente<br />
(l’abbiamo sentito anche prima), “che cosa sono, non lo so bene!”.<br />
La prima domanda che l’adolescente rivolge all’adulto è: “Chi sono?”. Ed è la domanda<br />
cruciale, fondamentale. Questo “Chi sono?” lo possiamo articolare in mo<strong>di</strong> <strong>di</strong>versi:<br />
- Ci sono? Il mio è un esserci nel mondo, con questo corpo, che viene<br />
riconosciuto dagli altri, apprezzato, stimato, deriso, che io esibisco o infagotto in<br />
abiti che non consentano <strong>di</strong> vedere le forme e <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare il sesso <strong>di</strong><br />
appartenenza.<br />
- Come sono? Come gli altri mi vedono? Chi sono questi altri per me? I genitori, i<br />
compagni <strong>di</strong> classe, gli amici <strong>del</strong> campo sportivo, quelli <strong>del</strong>l’oratorio… Un<br />
elemento che <strong>di</strong>stingue fortemente la ricerca <strong>di</strong> identità degli adolescenti <strong>di</strong> oggi<br />
rispetto alla nostra sta probabilmente nella risposta a questa domanda: Chi sono<br />
gli altri? Noi abbiamo in mente nella costruzione <strong>del</strong>l’identità un percorso<br />
piuttosto lineare, in cui si assumono una serie <strong>di</strong> comportamenti coerenti perché<br />
una persona si identifichi. Fino a non tanti anni fa l’identità era caratterizzata da<br />
comportamenti incontrovertibili: chi andava all’oratorio aveva un’identità, chi<br />
magari invece si trovava sul muretto ne aveva un’altra. Ad esempio l’identità<br />
cattolica o l’identità comunista erano ben definite e implicavano un decalogo<br />
abbastanza chiaro <strong>di</strong> norme <strong>di</strong> comportamento da assumere. Oggi invece<br />
l’adolescente sta dentro all’oratorio, ma sta contemporaneamente anche fuori;<br />
25
frequenta gruppi molto <strong>di</strong>versi tra loro; ha co<strong>di</strong>ci morali <strong>di</strong>fferenziati. Il problema<br />
<strong>del</strong>l’adolescente è quello <strong>di</strong> tenere insieme tutte queste appartenenze, non <strong>di</strong><br />
costruire un percorso definito, ma unico verso la propria identità. Al contrario ha<br />
il bisogno <strong>di</strong> sperimentarsi e <strong>di</strong> fare un lavoro <strong>di</strong> regia. Ed è questo che gli<br />
adolescenti ci chiedono <strong>di</strong> aiutarli a fare: la possibilità <strong>di</strong> vedere a che con<strong>di</strong>zioni<br />
è possibile tenere insieme le cose (andare a scuola, giocare a calcio, fare il<br />
teatro e uscire con gli amici) e mantenere questa situazione <strong>di</strong><br />
pluriappartenenza nella quale l’adolescente fa fatica a tenere in mano la regia.<br />
- Che cosa so fare?<br />
- Per chi sono? In vista <strong>di</strong> che cosa? In vista <strong>di</strong> quale progetto? In vista <strong>del</strong>la<br />
costruzione <strong>di</strong> quale “io” adulto?<br />
I luoghi <strong>di</strong> questo percorso con gli altri sono la scuola e l’extrascuola. La scuola<br />
dovrebbe abilitare a tre tipi <strong>di</strong> conoscenze. In realtà io credo che coltivi abbastanza<br />
bene il primo tipo, un po’ il secondo e non tanto il terzo. Il primo tipo <strong>di</strong> conoscenze<br />
sono i saperi <strong>di</strong>sciplinari: le materie, i contenuti e i meto<strong>di</strong>. Il secondo è il sapere<br />
sociale: lo stare con gli altri, il conoscere che quando si vive con gli altri ci sono<br />
determinate norme, co<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> comportamento che vanno chiariti. C’è poi un sapere su <strong>di</strong><br />
sé, un dare risposte a quel “Chi sono io?” sul quale la scuola forse tiene poco acceso il<br />
riflettore, non stimola adeguatamente gli adolescenti.<br />
Di questi tre saperi, il sapere sociale è quello che riguarda gli altri. Perché si va a<br />
scuola? Se lo chie<strong>di</strong>amo agli studenti essi ci risponderanno un po’ perché devono e un<br />
po’ perché se alle <strong>di</strong>eci <strong>del</strong> m<strong>atti</strong>no vanno in piazza non trovano nessuno; se vanno<br />
all’Istituto invece trovano tutti.<br />
La scuola è una grande piazza dove è possibile coltivare relazioni. E’ il posto dove si<br />
imparano anche i co<strong>di</strong>ci comuni, ad esempio le mode. E’ il posto dove gli adulti si<br />
illudono un po’ <strong>di</strong> valutare gli adolescenti, ma dove molto spesso invece gli adulti sono<br />
quelli sotto esame. La scuola è un luogo <strong>di</strong> contatto tra gli adolescenti e gli adulti<br />
particolarmente fecondo perché il gruppo degli adolescenti tiene costantemente<br />
d’occhio l’adulto. Ogni riunione <strong>di</strong> ex allievi parte e finisce con il ricordo, e spesso la<br />
presa in giro, dei docenti, anche quando oramai sono passati venti, trenta o<br />
quarant’anni dall’esame <strong>di</strong> stato. Perché quello è il lavoro che l’adolescente fa a scuola:<br />
va a vedere se c’è qualche adulto interessante o se ci sono degli adulti un po’ palli<strong>di</strong>;<br />
se c’è gente che è appassionata, se c’è gente che sa riconoscere nell’u<strong>di</strong>torio il<br />
momento <strong>di</strong> lavoro e il momento <strong>di</strong> stanchezza; se c’è gente che è in grado <strong>di</strong> reggere<br />
le continue e massicce proiezioni <strong>di</strong> emozioni che gli adolescenti fanno sugli<br />
insegnanti.<br />
Ricordate il film “Caterina va in città”? Ad un certo punto c’è un insegnante che deve<br />
salutare la sua classe <strong>di</strong> allievi <strong>di</strong> scuola superiore e incomincia a parlare. Dice <strong>del</strong>le<br />
cose pesantissime nei confronti degli allievi (“Siete l’esperienza peggiore che mi sia<br />
mai capitata”. “Sono contento <strong>di</strong> andarmene”…): questi lo guardano con in<strong>di</strong>fferenza;<br />
mentre sta parlando suona la campana e gli studenti se ne vanno via. L’insegnante,<br />
26
tutto pieno com’è <strong>del</strong>le sue emozioni e dei suoi affetti, fa fatica a riconoscere gli affetti e<br />
le emozioni <strong>di</strong> questi ragazzi.<br />
Allora, gli adulti sono sotto esame e costantemente vengono giu<strong>di</strong>cati. Solo chi è in<br />
grado <strong>di</strong> suscitare emozioni è quello che rimane.<br />
La scuola è il luogo <strong>del</strong>le avventure <strong>del</strong> pensiero; è il luogo dove bisogna pensare e<br />
questa per gli adolescenti è una fatica gran<strong>di</strong>ssima. Non si può che pensare <strong>di</strong> farla<br />
con gli altri. Il pensare per dei ragazzi che, per la loro con<strong>di</strong>zione personale, hanno già<br />
la mente sotto pressione (un ragazzino <strong>di</strong> terza me<strong>di</strong>a una volta mi <strong>di</strong>sse: “Io, sì, vado a<br />
scuola. Ma lo sa che la mia testa è un flipper?) è molto faticoso. Allora qualche volta,<br />
per semplificare, staccano la spina, entrano nel vuoto totale, ci guardano con aria<br />
“allocchita”, non sanno più nemmeno quanto fa tre per quattro… Ad un certo punto poi<br />
“resettano” e ripartono.<br />
Però certamente la scuola è il luogo <strong>del</strong>l’avventura <strong>del</strong> pensiero e questa è una fatica<br />
che non si può che con<strong>di</strong>videre, tant’è vero che il problema è meno forte quando i<br />
ragazzi sono a scuola e più evidente quando devono stu<strong>di</strong>are a casa, dove non c’è il<br />
contesto <strong>del</strong>la scuola dove si riesce un po’ <strong>di</strong> più a pensare; a casa ci sono tanti<br />
<strong>di</strong>strattori, non c’è l’insegnante che comunque è un facilitatore <strong>del</strong>l’appren<strong>di</strong>mento, non<br />
ci sono i coetanei… Allora al pomeriggio ci si mette a stu<strong>di</strong>are e si tiene acceso il<br />
cellulare, ci si manda messaggi, ci si telefona, si chatta e via <strong>di</strong> seguito, perché stare<br />
da soli <strong>di</strong> fronte a un impegno mentale per molti adolescenti (non per tutti) è una fatica<br />
improba. I coetanei sono quei compagni <strong>di</strong> viaggio con cui ci si può consolare <strong>del</strong>le<br />
pene e <strong>del</strong>le sofferenze <strong>del</strong>l’imparare.<br />
Abbiamo visto la scuola e i compiti che il ragazzo affronta nella scuola. Fuori da scuola<br />
che cosa succede? Ci sono i gruppi. La grande <strong>di</strong>stinzione è tra i gruppi formali e i<br />
gruppi spontanei.<br />
I gruppi formali sono quelli che si caratterizzano per la con<strong>di</strong>visione <strong>di</strong> <strong>atti</strong>vità <strong>di</strong> vario<br />
genere (società sportiva, oratorio, gruppo scout…). Sono gruppi ai quali spesso i<br />
genitori spingono i ragazzi a partecipare: “Vai all’oratorio… Vai a giocare a basket…<br />
Invece <strong>di</strong> stare in giro o in casa tutto il giorno davanti al computer”. E questo <strong>di</strong>venta<br />
per i ragazzi anche un elemento <strong>di</strong> conflitto: “I miei vogliono che io vada lì, ma io non<br />
ne ho tanta voglia!”. E allora ci sono i genitori che vanno a vedere dove si trovano i<br />
figli…<br />
Sono comunque gruppi che propongono un’adesione a valori che sono già stabiliti in<br />
partenza, valori che non nascono all’interno <strong>del</strong> gruppo, ma che sono formalizzati da<br />
altri. Sono associazioni <strong>di</strong> vario genere, associazioni <strong>di</strong> impegno, associazioni <strong>di</strong><br />
fruizione culturale, ricreativa, sportiva…<br />
I gruppi formali sono importanti nei processi <strong>di</strong> socializzazione; hanno un valore<br />
specifico. Inf<strong>atti</strong>, innanzi tutto, mettono in contatto con <strong>del</strong>le proposte <strong>di</strong> valore e <strong>di</strong><br />
impegno continuativo, che consentono agli adolescenti <strong>di</strong> mettere alla prova, in un<br />
ambiente che non è la famiglia, i loro aspetti più adulti: l’affidabilità, la serietà,<br />
l’assunzione <strong>di</strong> un impegno, la continuità… (tutti aspetti che poi i ragazzi ritroveranno<br />
27
quando, ad esempio, dovranno affrontare il mondo <strong>del</strong> lavoro). Aiutano i ragazzi a<br />
sviluppare un immagine <strong>di</strong> sé un po’ meno legata al proprio piacere, a quello che<br />
voglio. E quello <strong>del</strong> problema <strong>del</strong> controllo e <strong>del</strong> contenimento <strong>del</strong>la <strong>di</strong>mensione <strong>del</strong><br />
piacere (“Mi piaceva e l’ho fatto!) sappiamo che è un problema non solo degli<br />
adolescenti. Io resto sempre molto colpito dalle persone che, senza particolari problemi<br />
<strong>di</strong> salute, bevono acqua in continuazione, magari anche mentre ascoltano una persona<br />
che parla. Mi fa sempre pensare che probabilmente c’è un bisogno <strong>di</strong>fficilmente<br />
controllabile, <strong>di</strong>fficilmente rinviabile. E la giustificazione <strong>del</strong> comportamento è ovvia:<br />
“Bevo perché ho sete!”. In realtà mi sembra che anche per noi adulti il problema a volte<br />
sia quello <strong>di</strong> rinviare alcune gratificazioni imme<strong>di</strong>ate. Allora un’immagine <strong>di</strong> sé un po’<br />
meno autoreferenziale sul proprio piacere, sul proprio “Ne avevo voglia”, viene favorita<br />
dalla permanenza in questi gruppi.<br />
I gruppi formali sono, inoltre, un’occasione preziosa <strong>di</strong> contatto più libero rispetto al<br />
contatto formalizzato che si ha con i genitori e con gli insegnanti. Permettono <strong>di</strong><br />
sviluppare l’educazione civica, ma in modo in<strong>di</strong>retto, non attraverso i libri.<br />
I gruppi formali, però, nel corso <strong>del</strong>la crescita, subiscono un progressivo <strong>di</strong>simpegno,<br />
un calo <strong>di</strong> adesione, perché il problema <strong>di</strong>venta quello <strong>del</strong>le multiappartenenze. Ci sono<br />
degli ambiti che vengono sentiti dal gruppo degli adolescenti come più vitali, perché più<br />
legati all’autorealizzazione. “Ho voglia <strong>di</strong> andare in un posto dove non c’è un adulto, un<br />
educatore che mi <strong>di</strong>ce che cosa devo o non devo fare, posso andarci come e quando<br />
voglio!”. E allora c’è un conflitto tra quello che il gruppo propone e quello che i ragazzi<br />
vivono. Il gruppo formale può subire un <strong>di</strong>simpegno anche per <strong>del</strong>le cause più <strong>di</strong> tipo<br />
relazionale: ad esempio si incrina un legame (“Non c’è più l’allenatore <strong>del</strong>l’anno scorso<br />
e quest’anno non mi trovo” oppure un gruppetto che se ne esce dal gruppo grande e<br />
porta una <strong>di</strong>sgregazione interna).<br />
Accanto a questi poi ci sono i gruppi spontanei, che subito <strong>atti</strong>vano nei genitori una<br />
serie <strong>di</strong> domande: “Con chi esci?”. “A che ora torni?”. Un po’ come se i genitori<br />
percepissero la rischiosità <strong>di</strong> una con<strong>di</strong>zione come quella <strong>del</strong> gruppo spontaneo. E in<br />
che cosa consiste questa rischiosità? Nel fatto che è il gruppo degli amici, soggetti più<br />
o meno coetanei, nei quali i genitori vedono (certamente meno <strong>di</strong> un tempo) come degli<br />
avversari, perché offrono un’appartenenza che riduce molto quella <strong>del</strong>la famiglia. Oggi,<br />
più <strong>di</strong> un tempo, i genitori cercano <strong>di</strong> coinvolgere: “Portali a casa. Venite qui… Ti lascio<br />
la casa… Vieni pure con i tuoi amici”. C’è l’idea che comunque il gruppo degli amici<br />
possa essere ricondotto a un controllo.<br />
La domanda “A che ora ritorni?” non si aspetta solo una risposta <strong>di</strong> tipo concreto (che<br />
poi avvia un negoziato faticosissimo), ma prima <strong>di</strong> tutto è un po’ la domanda: “Ma tu sai<br />
che noi vogliamo che tu torni in casa? Sai che vogliamo che tu resti ancora all’interno<br />
<strong>di</strong> questo nucleo?”. Gli adolescenti lo sanno benissimo (perché non escono dal nucleo<br />
né a quin<strong>di</strong>ci, né a venti, né a venticinque, né a trenta, né…).<br />
Che caratteristiche ha il gruppo degli amici?<br />
28
Nasce spesso per cooptazione dei membri. Non c’è una domanda; c’è una chiamata:<br />
vieni tu perché sei in gamba, tu perché sei simpatico… oppure ti presenta l’amico<br />
<strong>del</strong>l’amico. C’è un po’ questo giro, costruito sulla base <strong>di</strong> sentimenti molto precisi anche<br />
se sottili <strong>di</strong> risonanza ed empatia. Il legame è <strong>di</strong>fficilmente detto; è molto vissuto. Del<br />
resto bisogna far passare un po’ <strong>di</strong> tempo per parlare degli amici. Parliamo noi dei<br />
nostri amici, ricor<strong>di</strong>amo noi i nostri amici; magari ne parliamo ai figli. Difficilmente i figli<br />
parlano degli amici e riescono a spiegare perché uscire con quel gruppo lì anziché con<br />
l’altro è meglio. Lo sanno punto e basta, ma non riescono a dare una spiegazione. Nel<br />
gruppo si parla poco, ma si agisce molto. Ci sono canali <strong>di</strong> comunicazione visiva e<br />
corporea. Il progetto <strong>del</strong> gruppo è uno solo: star bene insieme. E’ un progetto che porta<br />
a una fruizione imme<strong>di</strong>ata, tant’è vero che ci sono <strong>del</strong>le regole che non sono scritte<br />
(dove ci si trova; a che ora; quanto bisogna essere leali) e il leader è colui o colei che<br />
riesce a prendere <strong>del</strong>le decisioni che sono sempre funzionali allo star bene insieme.<br />
Se chiedete ai vostri figli o allievi che caratteristiche ha un amico vi <strong>di</strong>rà che è<br />
simpatico. La parola simpatia è da prendere nel senso etimologico <strong>del</strong> termine: è la<br />
possibilità <strong>di</strong> sentire le cose in comune, <strong>di</strong> intendersi senza bisogno <strong>di</strong> troppe parole.<br />
L’amico è uno strumento prezioso per gli adolescenti, perché è quello che gli consente<br />
<strong>di</strong> affrontare tutte quelle cose che sono <strong>di</strong>fficili da pensare. “Mio padre è un brav’uomo<br />
o un <strong>di</strong>sgraziato che mi martella?”. “Mia madre è una che mi fa fare le cose o è un<br />
ostacolo?”. “Pensi che quel ragazzo mi possa accettare come amico oppure no?”.<br />
Sono questi i pensieri <strong>di</strong>fficili che i ragazzi da soli non riescono a fare e hanno bisogno<br />
<strong>del</strong>l’amico. L’amico è la mente <strong>di</strong> supporto, prima ancora che il complice. L’adolescente<br />
gironzola per casa, apre il libro, poi il frigorifero, poi accende la Tv… e si trova alla<br />
mercé <strong>di</strong> una serie <strong>di</strong> pensieri… improvvisamente suona il citofono: bisogna<br />
rimboccarsi le maniche, bisogna andare, bisogna fare. Lì si comincia a costruire il<br />
pensiero, perché se si sta in casa si ha l’impressione <strong>di</strong> girare a vuoto. E i genitori<br />
questa cosa un po’ la capiscono tanto è vero che sono un po’ gli sponsor <strong>del</strong>le amicizie<br />
dei figli.<br />
Gli amici sono un supporto alla fragilità narcisistica <strong>del</strong>l’adolescente. Gli adolescenti<br />
che si trovano in sede <strong>di</strong> psicoterapia oggi sono soprattutto gli adolescenti la cui<br />
principale <strong>di</strong>fficoltà è quella <strong>di</strong> riempire con qualcosa <strong>di</strong> buono questo senso <strong>di</strong> identità<br />
in costruzione. Sono ragazzi che hanno un’immagine <strong>di</strong> sé fortemente deteriorata.<br />
Sono ragazzi che hanno costruito gran<strong>di</strong> ideali <strong>di</strong> sé, che naturalmente non sono<br />
raggiungibili e quin<strong>di</strong> una persona si sente una schifezza; oppure sono ragazzi pieni <strong>di</strong><br />
vergogna (non <strong>di</strong> colpa, inf<strong>atti</strong> quello che fanno continuano a farlo, sono ben convinti,<br />
non c’è la voglia <strong>di</strong> cambiare) perché pensano che gli altri li giu<strong>di</strong>chino male e<br />
proiettano sugli altri un’immagine molto negativa <strong>di</strong> sé.<br />
Gli amici prendono così come si è, non chiedono un’efficienza particolare. Sono un<br />
antidoto alle paure degli adolescenti. Le amicizie durano se non costano più <strong>di</strong> quello<br />
che offrono, perché c’è una componente strumentale nell’amicizia adolescenziale (“Si<br />
sta insieme finché io ti servo e tu mi servi per quel lavoro lì <strong>di</strong> pensiero”). Poi ad un<br />
certo punto non ci si frequenta più, senza bisogno <strong>di</strong> litigare.<br />
29
Cosa fanno gli adulti?<br />
Se un tempo si opponevano agli amici <strong>del</strong> figlio, adesso cercano <strong>di</strong> inglobarli in<br />
famiglia, perché c’è il grande timore nei confronti <strong>del</strong> <strong>di</strong>stacco. E questa è<br />
probabilmente la grande mal<strong>atti</strong>a <strong>di</strong> oggi: la <strong>di</strong>fficoltà anche da parte <strong>di</strong> molti genitori <strong>di</strong><br />
sentire che i figli possono camminare con le loro gambe e andare in giro per il mondo.<br />
C’è poi un altro timore, che è anche oggettivo: il timore <strong>del</strong>le c<strong>atti</strong>ve compagnie. Senza<br />
pensare alle compagnie pre<strong>del</strong>inquenziali o francamente <strong>del</strong>inquenziali, la c<strong>atti</strong>va<br />
compagnia è soprattutto il gruppo chiuso, il gruppo asfittico, il gruppo dove quello che<br />
viene sostenuto è soprattutto il conformismo (tutti devono fare questa cosa), il gruppo<br />
che sostiene il gregarismo, il gruppo che facilità l’assunzione <strong>di</strong> comportamenti<br />
devianti, pericolosi, antisociali, violenti, l’uso <strong>di</strong> sostanze, ecc.<br />
Che cosa fare?<br />
Sicuramente definire <strong>del</strong>le regole e definire dei limiti. Prima abbiamo sentito parlare <strong>di</strong><br />
genitori che si comportano come i figli, abbiamo sentito parlare <strong>di</strong> confusione <strong>di</strong> funzioni<br />
e <strong>di</strong> ruoli… Dobbiamo imparare a riconoscere i limiti, imparare a chiudere le porte,<br />
imparare a ridefinire se stessi come adulti e riconoscere che l’altro è un bambino o un<br />
adolescente.<br />
Dobbiamo riconoscere che ci sono percorsi complessi <strong>di</strong> costruzione per giungere<br />
all’identità. Dobbiamo riconoscere che i percorsi lineari <strong>del</strong>l’appartenenza unica oggi<br />
non funzionano più tanto e quin<strong>di</strong> fornire un aiuto ai ragazzi perché ci sia una buona<br />
regia <strong>di</strong> tutte le esperienze che vivono. Non una rinuncia <strong>di</strong> una per l’altra, ma la<br />
definizione per ciascuna <strong>di</strong> tempi e mo<strong>di</strong>.<br />
Dobbiamo mantenere aperta la comunicazione, sapendo che è una comunicazione<br />
fragile, incerta, labile, paradossalmente spesso silenziosa. Costruire dei luoghi <strong>di</strong><br />
parole per i ragazzi oggi <strong>di</strong>venta particolarmente importante, anche perché ci troviamo<br />
<strong>di</strong> fronte a ragazzi (e questo è un dato preoccupante) che hanno un patrimonio<br />
linguistico più ridotto rispetto ai loro coetanei <strong>di</strong> quin<strong>di</strong>ci – venti anni fa. Questo è un<br />
problema, perché non conoscere le parole, vuol <strong>di</strong>re non conoscere la realtà. Costruire<br />
dei luoghi <strong>di</strong> parole vuol <strong>di</strong>re fare questo sforzo continuo <strong>di</strong> provare a nominare le cose,<br />
lanciando messaggi: “Ma forse mi vuoi <strong>di</strong>re questa cosa qua… Io non lo so… Ti vedo<br />
così… Per me mi stai <strong>di</strong>cendo questo…”. Provo a nominare gli stati emotivi, gli stati<br />
affettivi, in termini <strong>di</strong> proposta. Riuscire a costruire questi luoghi <strong>di</strong> parole che<br />
riguardano le emozioni, i desideri, le paure... è il grande compito che noi adulti<br />
abbiamo, anche perché c’è la necessità <strong>di</strong> poter costruire dei sensi comuni. Ciascuno<br />
<strong>di</strong> noi le cose che fa, le fa attribuendo significati <strong>di</strong>versi; quello che probabilmente sta al<br />
fondo <strong>del</strong>l’educazione è una proposta <strong>di</strong> significato. Ogni genitore, ogni insegnante,<br />
ogni educatore arriva ad un certo punto ad aver capito una o due cose nella vita: le<br />
propone ai figli o agli educan<strong>di</strong> o agli allievi. Poi saranno loro ad accettare o no, perché<br />
l’educazione si fonda sulla libertà <strong>del</strong>le persone, è un esercizio <strong>di</strong> libertà. L’abbiamo<br />
30
fatto noi con i nostri genitori <strong>di</strong> accettare <strong>del</strong>le proposte e <strong>di</strong> rifiutarne <strong>del</strong>le altre, magari<br />
<strong>di</strong> scoprirle a <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> molti anni. La stessa cosa la facciamo con i figli: è molto più<br />
importante trovare i mo<strong>di</strong> e i linguaggi per fare <strong>del</strong>le proposte <strong>di</strong> significato che non<br />
soltanto parlare <strong>del</strong>le cose. Gli adulti sono preoccupati, ad esempio, <strong>del</strong>la sessualità<br />
degli adolescenti, ma finiscono per ridurre la sessualità a un problema <strong>di</strong><br />
comportamenti, mentre fanno fatica (anche perché si ha un po’ paura) a intavolare con<br />
i ragazzi una <strong>di</strong>scussione sul tema <strong>del</strong> piacere o <strong>del</strong>la creatività o <strong>del</strong>la generazione.<br />
Però è lì che si definisce autenticamente la proposta educativa, molto più che in tante<br />
altre parole accessorie, funzionali. Spesso in casa la comunicazione è funzionale (“Che<br />
cosa hai fatto?”. “A che ora?”…) o è <strong>di</strong> monologo. Poter correre insieme, anche se<br />
questo qualche volta ci provoca il fiatone perché i figli adolescenti molte volte corrono<br />
davanti a noi, è il lavoro più complesso che però ci tocca fare.<br />
SANDRO SANNA<br />
Grazie al dott. Fantoni per questa arricchente relazione, che ci ha parlato<br />
<strong>del</strong>l’adolescente nella scuola, nella famiglia e nell’extrascuola. Ci ha dato <strong>di</strong>versi<br />
suggerimenti su come fare ad aiutare gli adolescenti a crescere, interrogandoci in<br />
prima persona sui nostri comportamenti, sui nostri pensieri e sulle nostre paure.<br />
Apriamo ora lo spazio per gli interventi.<br />
Primo intervento<br />
Vorrei porre una domanda al prof. Ravasio. La mia domanda nasce da una<br />
considerazione e cioè che a volte le linee educative che gli educatori perseguono nel<br />
contesto scolastico ed extrascolastico sono in contrasto con i mo<strong>del</strong>li familiari. In questi<br />
casi, abbastanza frequenti, come possono e quanto possono gli educatori stimolare il<br />
ragazzo ad assumere degli stili <strong>di</strong> comportamento <strong>di</strong>versi da quelli che vedono in casa,<br />
sempre tenendo presente che gli adulti <strong>di</strong> riferimento sono importantissimi e non<br />
verranno mai meno per il minore?<br />
Prof. Ravasio<br />
Nei rapporti tra scuola e famiglia capitano un po’ le stesse cose che avvengono in<br />
famiglia. Quando il papà <strong>di</strong>ce una cosa e la mamma un’altra, il figlio fa quello che<br />
vuole, perché il ragazzo è sottoposto a due messaggi che riceve da due persone<br />
importanti per lui, solo che questi messaggi sono <strong>di</strong>scordanti e così il figlio, non<br />
sapendo che cosa fare, fa quello che vuole.<br />
La stessa cosa può avvenire nel rapporto famiglia – scuola, quando la scuola ha un<br />
sistema educativo e la famiglia <strong>di</strong>sattende completamente questo sistema. Ancora una<br />
31
volta il ragazzo è sottoposto a due messaggi <strong>di</strong>versi che gli arrivano da due istituzioni<br />
importanti: chi seguire? Il ragazzo non sa che cosa fare.<br />
Allora che fare? Bisogna riuscire a stipulare un “patto” educativo tra famiglia e scuola<br />
per essere d’accordo sull’essenziale, su ciò che conta.<br />
Facciamo un esempio. Poniamo che la scuola faccia una campagna sulla tolleranza,<br />
per aiutare i bambini/ragazzi ad andare d’accordo, ad accettarsi, a non rifiutarsi, a<br />
vivere bene insieme. Poniamo che la famiglia <strong>di</strong>sattenda questo impegno <strong>del</strong>la scuola<br />
e continui nei suoi atteggiamenti abituali: magari ce l’ha su con quello <strong>del</strong> piano <strong>di</strong><br />
sopra, con il vicino <strong>di</strong> casa, non sopporta l’extracomunitario, rifiuta questo e quest’altro.<br />
Ebbene <strong>di</strong> fronte a due comportamenti opposti che cosa fa il ragazzo?<br />
Dunque la scuola deve coinvolgere la famiglia nel proprio progetto educativo. Non ci<br />
sono altre vie!<br />
Oggi i ragazzi si possono <strong>di</strong>stinguere in due gruppi: quelli che hanno la fortuna <strong>di</strong><br />
incontrare nella loro vita adulti capaci <strong>di</strong> educare e quelli che hanno la sfortuna <strong>di</strong><br />
incontrare adulti incapaci <strong>di</strong> educare.<br />
Secondo intervento<br />
Ringrazio i relatori e vorrei chiedere a ciascuno <strong>di</strong> loro <strong>di</strong> esprimere, rispetto al tema<br />
che stiamo trattando, un suggerimento da attuare concretamente nei prossimi mesi.<br />
Prof.ssa Pelam<strong>atti</strong><br />
Io <strong>di</strong>rei che è molto importante, adesso, tornati a casa nei propri luoghi <strong>di</strong> vita, <strong>di</strong><br />
famiglia o <strong>di</strong> scuola, per quanto riguarda ad esempio le emozioni, cercare sotto forma<br />
<strong>di</strong> gioco <strong>di</strong> fare <strong>del</strong>le piccole simulazioni. Provare a vedere quali sono i pensieri, quali le<br />
emozioni, quali i comportamenti, o <strong>di</strong>rettamente presi dalla realtà o anche giocando con<br />
dei roll play che possiamo improvvisare. Ad esempio, con i figli, ipotizziamo una<br />
situazione, anche ispirandoci alla relazione <strong>del</strong> prof. Fantoni, se abbiamo figli<br />
adolescenti, e chie<strong>di</strong>amoci quali pensieri potrebbero attraversare la mente in questa<br />
situazione, quali sono le emozioni e quali sono i comportamenti che mi trovo invogliato<br />
a mettere in atto. Da qui, lasciare molto spazio per consentire <strong>di</strong> esprimere che cosa<br />
provo, che cosa sento dentro <strong>di</strong> me; in che misura provo queste emozioni e dove mi<br />
possono portare.<br />
Io credo che questo contatto con noi stessi adulti, nel nostro mondo profondo,<br />
costituisca lo strumento importante per poi accompagnare i bambini e i ragazzi nella<br />
scoperta <strong>del</strong> loro mondo emozionale, che è la premessa per raggiungere un benessere<br />
emotivo che oggi si fa un po’ desiderare.<br />
Prof. Ravasio<br />
La generazione adulta cerchi <strong>di</strong> essere la generazione che è, cioè il compito suo è <strong>di</strong><br />
saper trasmettere alla nuova generazione quello che ha ere<strong>di</strong>tato, il meglio <strong>di</strong> quello<br />
32
che ha ricevuto nella sua vita. Il suo compito è quello <strong>di</strong> trasmettere la cultura, i valori, il<br />
meglio <strong>di</strong> sé; il suo compito non è quello <strong>di</strong> identificarsi con i giovani. Oggi siamo in<br />
questo assurdo: non sono più i giovani che cercano <strong>di</strong> imitare gli adulti, ma gli adulti<br />
che cercano <strong>di</strong> imitare i giovani.<br />
Ciò fa ridere. Ve<strong>di</strong>amo il padre che sfida l’adolescente figlio al limite <strong>del</strong>l’infarto. La<br />
madre che si veste come la figlia per suscitare invi<strong>di</strong>a e gelosia.<br />
I ragazzi hanno bisogno <strong>di</strong> un confronto adulto, hanno bisogno <strong>di</strong> persone che siano<br />
capaci <strong>di</strong> trasmettere veramente qualche cosa che loro non hanno. D’altra parte gli<br />
adulti devono imparare ad accettare questa novità che i giovani portano; devono saper<br />
cogliere e assorbire l’aggressività che i giovani esprimono nei confronti <strong>del</strong>l’adulto, per<br />
poi rimandare a loro qualcosa <strong>di</strong> più adulto, <strong>di</strong> più maturo.<br />
Gli adulti devono imparare ad accettare la propria età; devono imparare a godere <strong>del</strong>le<br />
cose buone che ogni età ha. E’ bella la primavera, ma chi <strong>di</strong>ce che è brutta l’estate?<br />
Perché non l’autunno con i suoi frutti? Perché no l’inverno con i campi da sci? Ogni<br />
stagione ha la sua bellezza: saperla cogliere e saperla vivere è fondamentale.<br />
E’ importante saper cogliere il bello <strong>di</strong> ogni età e quin<strong>di</strong> vivere secondo i compiti e i ruoli<br />
che l’età comporta.<br />
Prof.ssa Zanfroni<br />
L’invito è quello <strong>di</strong> analizzare a casa, nel proprio contesto, tutte le forme <strong>di</strong><br />
comunicazione che si instaurano, tra genitori, tra genitori e figli, tra figli. Per capire che<br />
forse tutto quello che si è sentito non è qualcosa da cui noi siamo estranei, ma è<br />
qualcosa che riguarda un po’ tutti, chi più chi meno, non come una colpa, ma come uno<br />
stato <strong>di</strong> cose che comunque si verificano.<br />
In secondo luogo mi sembra molto importante il <strong>di</strong>scorso <strong>del</strong>la formazione, cioè il<br />
<strong>di</strong>scorso <strong>del</strong> capire che ogni età familiare ha determinati compiti evolutivi, ha<br />
determinate <strong>di</strong>namiche che si innescano e all’interno <strong>di</strong> ogni età la famiglia ha la<br />
necessità <strong>di</strong> mutare i propri compiti educativi: il ruolo genitoriale è qualcosa che va<br />
coltivato. Se siamo buoni genitori con i nostri figli <strong>di</strong> quattro anni, non è detto che<br />
automaticamente saremo buoni genitori quando i nostri saranno adolescenti. Questo<br />
non ci deve far sentire a <strong>di</strong>sagio, ma semplicemente renderci consapevoli che la<br />
capacità genitoriale è qualcosa che va coltivata. E per fare ciò non è necessario<br />
esporsi continuamente a momenti formativi, ma è importante anche ad esempio<br />
leggere libri, informarsi e relazionarsi con gli altri.<br />
Dott. Fantoni<br />
Parafrasando De Bartolomeis si potrebbe parlare <strong>del</strong>l’«amara libertà dei sogni» perché<br />
i sogni ci fanno confrontare sempre con una realtà molto più complessa.<br />
Se dovessi pensare a un auspicio, proporrei quello <strong>di</strong> <strong>di</strong>ventare un popolo <strong>di</strong> ascoltatori<br />
e non solo <strong>di</strong> telespettatori, cioè <strong>del</strong>le persone che siano davvero in grado <strong>di</strong> accostarsi<br />
all’altro con rispetto e con capacità autentica <strong>di</strong> far risuonare dentro <strong>di</strong> sé quello che<br />
l’altro ci <strong>di</strong>ce. Molto spesso siamo invece, tutti noi, preda <strong>di</strong> ansie, <strong>di</strong> paure, <strong>di</strong><br />
33
preoccupazioni che ci allontanano dalle altre persone e in particolare dai soggetti in età<br />
evolutiva, dai bambini, dagli adolescenti. Siamo molto preoccupati <strong>del</strong>le nostre<br />
“prestazioni” educative; siamo molto preoccupati che se un figlio va bene o va male a<br />
scuola è perché io sono un bravo o un c<strong>atti</strong>vo genitore. Invece, se ci liberiamo un po’<br />
da questo senso <strong>di</strong> malintesa responsabilità e proviamo ad accostarci in un modo più<br />
appassionato e più <strong>di</strong>retto a capire quello che i ragazzi ci stanno <strong>di</strong>cendo, stando lì con<br />
loro e stando lì in silenzio, forse riusciamo a fare noi per primi e a far fare ai nostri<br />
ragazzi un’esperienza <strong>di</strong> alterità e <strong>di</strong> contatto con l’altro che non va a ledere l’identità.<br />
E’ un po’ l’esperienza che, e ve ne sono grato, ho fatto oggi qui con voi, con un<br />
pubblico così numeroso e così attento come francamente non è facile trovare.<br />
SANDRO SANNA<br />
Da questo ultimo giro <strong>di</strong> interventi cogliamo il prezioso invito alla solidarietà e alla<br />
sussi<strong>di</strong>arietà educativa. L’incontro promosso oggi dall’amministrazione comunale va<br />
esattamente in questa <strong>di</strong>rezione: l’auspicio è proprio quello che educatori, genitori e<br />
insegnanti costruiscano queste <strong>di</strong>mensioni nella famiglia, nella scuola e<br />
nell’extrascuola.<br />
L’obiettivo <strong>di</strong> questa giornata era stato espresso nel programma <strong>del</strong> convegno là dove<br />
troviamo scritto: “In questo mondo <strong>di</strong> bambini e <strong>di</strong> adolescenti ci addentriamo, cercando<br />
qualche linea <strong>di</strong> soluzione, orientamenti che ci aiutino a capire come non limitarci a<br />
intervenire sui f<strong>atti</strong> che accadono, promuovendo strategie <strong>di</strong> prevenzione nell'ambito<br />
familiare, scolastico e sociale”. Direi che l’obiettivo è stato raggiunto. Oggi pomeriggio,<br />
poi, nei tre workshop ai quali ci siamo iscritti avremo modo <strong>di</strong> riprendere e approfon<strong>di</strong>re<br />
queste tematiche, confrontandoci anche tra <strong>di</strong> noi.<br />
Grazie a tutti e buon pranzo.<br />
34
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA<br />
SEDE DI AREZZO<br />
MASTER<br />
“COMUNICAZIONE E RELAZIONI INTERPERSONALI”<br />
COORDINATORE<br />
PROF. ENRICO CHELI<br />
EMOZIONI…<br />
PENSIERI…<br />
COMPORTAMENTI…<br />
35<br />
APPENDICE<br />
Arezzo, 1-2 Aprile 2004 Docente: dott.ssa LUCIA PELAMATTI
EMOZIONE: DEFINIZIONI<br />
36<br />
APPENDICE<br />
• ... ogni agitazione o turbamento <strong>del</strong>la mente, sentimento, passione, ogni stato<br />
mentale violento o eccitato...(Oxford English Dictionary).<br />
• Sorta <strong>di</strong> comunicazione imme<strong>di</strong>ata, somatica, avente come canale una vasta<br />
serie <strong>di</strong> reazioni fisiologiche (rossore – afasia – senso <strong>di</strong> svenimento –<br />
tachicar<strong>di</strong>a...) <strong>di</strong> ciò che nasce dentro... (V. Slepoj, Capire i sentimenti. Milano<br />
1996).<br />
• Reazione affettiva intensa con insorgenza acuta e <strong>di</strong> breve durata, determinata<br />
da uno stimolo ambientale. La sua comparsa provoca una mo<strong>di</strong>ficazione a livello<br />
somatico, vegetativo e psichico. Possiamo avere <strong>del</strong>le reazioni:<br />
FISIOLOGICHE: che investono funzioni vegetative (circolazione,<br />
respirazione, <strong>di</strong>gestione, secrezione...); funzioni motorie (ipertensione<br />
muscolare...); funzioni sensorie (<strong>di</strong>sturbi alla vista, all'u<strong>di</strong>to...).<br />
VISCERALI: si manifestano con una per<strong>di</strong>ta momentanea <strong>del</strong> controllo<br />
neurovegetativo con conseguente incapacità temporanea <strong>di</strong> astrazione<br />
dal contesto emozionale.<br />
ESPRESSIVE: riguardano la mimica facciale, gli atteggiamenti <strong>del</strong> corpo,<br />
le abituali forme <strong>di</strong> comunicazione.<br />
PSICOLOGICHE: si manifestano come riduzione <strong>del</strong> controllo <strong>di</strong> sè,<br />
<strong>di</strong>fficoltà ad articolare logicamente azioni e riflessioni, <strong>di</strong>minuzione <strong>del</strong>le<br />
capacità <strong>di</strong> metodo e critica.<br />
(U. Galimberti, Dizionario <strong>di</strong> Psicologia, UTET, Torino '92).<br />
• Dal latino EMOVERE: E = fuori, all'esterno - MOVERE= muovere, spingere<br />
all’azione. Le emozioni sono stati complessi (stati <strong>del</strong>l'io, <strong>del</strong>la persona)<br />
accompagnati da una accresciuta percezione <strong>di</strong> un oggetto o <strong>di</strong> una situazione,<br />
da profonde mo<strong>di</strong>ficazioni fisiologiche, da una consapevolezza <strong>di</strong> attrazione o<br />
repulsione cosciente e da una condotta <strong>di</strong> avvicinamento o <strong>di</strong> allontanamento.<br />
Una <strong>del</strong>le più forti esperienze soggettive <strong>del</strong>l'emozione è la spinta all'azione, che<br />
esprime determinate forme <strong>di</strong> approccio con l'ambiente.(Dizionario <strong>di</strong> psicologia,<br />
ed. Paoline, Milano)
OTTIMISMO<br />
AGGRESSIVITA'<br />
CLASSIFICAZIONE DELLE EMOZIONI SECONDO<br />
PLUTCHIK<br />
DISPREZZO<br />
Attesa<br />
Aspettativa<br />
Collera<br />
Rabbia<br />
Gioia<br />
Schifo<br />
Disgusto<br />
AMORE<br />
RIMORSO<br />
37<br />
Accettazione<br />
Tristezza<br />
Paura<br />
Sorpresa<br />
APPENDICE<br />
SOTTOMISSIONE<br />
SPAVENTO<br />
DELUSIONE
1. COLLERA<br />
Furia<br />
Sdegno<br />
Risentimento<br />
Ira<br />
Esasperazione<br />
In<strong>di</strong>gnazione<br />
Irritazione<br />
Acrimonia<br />
Animosità<br />
Fasti<strong>di</strong>o<br />
Irritabilità<br />
Ostilità<br />
2. TRISTEZZA<br />
Pena<br />
Dolore<br />
Mancanza <strong>di</strong> allegria<br />
Cupezza<br />
Malinconia<br />
Autocommiserazione<br />
Solitu<strong>di</strong>ne<br />
Abb<strong>atti</strong>mento<br />
Disperazione<br />
Forte depressione<br />
3. PAURA<br />
Ansia<br />
Timore<br />
Nervosismo<br />
Preoccupazione<br />
Apprensione<br />
Cautela<br />
Esitazione<br />
Tensione<br />
Spavento<br />
Terrore<br />
Fobia<br />
Panico<br />
4. SORPRESA<br />
Shock<br />
Stupore<br />
Meraviglia<br />
Trasecolamento<br />
FAMIGLIE EMOZIONALI<br />
38<br />
APPENDICE<br />
5. GIOIA<br />
Felicità<br />
Go<strong>di</strong>mento<br />
Sollievo<br />
Contentezza<br />
Beatitu<strong>di</strong>ne<br />
Diletto<br />
Divertimento<br />
Fierezza<br />
Esaltazione<br />
Estasi<br />
Gratificazione<br />
Sod<strong>di</strong>sfazione<br />
Euforia<br />
Capriccio<br />
Entusiasmo maniacale<br />
6. AMORE<br />
Accettazione<br />
Benevolenza<br />
Fiducia<br />
Gentilezza<br />
Affinità<br />
Devozione<br />
Adorazione<br />
Infatuazione<br />
Agape<br />
7. DISGUSTO<br />
Disprezzo<br />
Sdegno<br />
Aborrimento<br />
Avversione<br />
Ripugnanza<br />
Schifo<br />
8. VERGOGNA<br />
Senso <strong>di</strong> colpa<br />
Imbarazzo<br />
Rammarico<br />
Rimorso<br />
Umiliazione<br />
Rimpianto<br />
Mortificazione<br />
costrizione
COMPONENTI PRINCIPALI DI UN PERCORSO<br />
DI ALFABETIZZAZIONE ALLE EMOZIONI<br />
• CONOSCERE se stessi in modo approfon<strong>di</strong>to<br />
39<br />
APPENDICE<br />
• AUTOACCETTARSI: riconoscere le proprie aree <strong>di</strong> forza e <strong>di</strong> debolezza, considerarsi<br />
positivamente, essere capaci <strong>di</strong> ridere <strong>di</strong> se stessi<br />
• ESSERE AUTOCONSAPEVOLI. Osservare se stessi e riconoscere i propri sentimenti,<br />
costruire un vocabolario <strong>del</strong>le emozioni, conoscere il rapporto tra pensieri / emozioni /<br />
comportamenti<br />
• GESTIRE I SENTIMENTI. "Colloquiare con se stessi" allo scopo <strong>di</strong> cogliere i messaggi<br />
negativi come le autocommiserazioni; capire cosa c'è <strong>di</strong>etro un sentimento, trovare mo<strong>di</strong><br />
per controllare le paure e le ansie, la collera e la tristezza<br />
• CONTROLLARE LO STRESS. Imparare il valore <strong>del</strong>l'esercizio, <strong>del</strong>la immaginazione<br />
guidata e dei meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> rilassamento<br />
• COMUNICARE: parlare dei sentimenti con efficacia; saper ascoltare e saper domandare,<br />
<strong>di</strong>stinguere tra ciò che qualcuno fa o <strong>di</strong>ce e le proprie reazioni o i propri giu<strong>di</strong>zi al<br />
riguardo; esporre il proprio punto <strong>di</strong> vista invece <strong>di</strong> incolpare gli altri<br />
• DECIDERE PERSONALMENTE: esaminare le proprie azioni e conoscerne le<br />
conseguenze, sapere se una decisione è dettata dal pensiero o dal sentimento<br />
• ESSERE APERTI: apprezzare l'apertura e costruire la fiducia in un rapporto, sapere<br />
quando si può parlare dei propri sentimenti privati senza correre rischi<br />
• ESSERE EMPATICI: comprendere i sentimenti e le preoccupazioni degli altri e<br />
assumere il loro punto <strong>di</strong> vista; apprezzare i <strong>di</strong>versi mo<strong>di</strong> con cui le persone guardano la<br />
realtà<br />
• ESSERE PERSPICACI: identificare mo<strong>del</strong>li tipici nella propria vita emotiva e nelle<br />
proprie reazioni; riconoscere mo<strong>del</strong>li simili negli altri<br />
• ESSERE PERSONALMENTE RESPONSABILI: assumersi le responsabilità, riconoscere<br />
le conseguenze <strong>del</strong>le proprie decisioni e azioni; accettare i propri sentimenti e umori;<br />
portare a compimento gli impegni assunti
40<br />
APPENDICE<br />
• ESSERE SICURI DI SE': affermare le proprie emozioni o posizioni senza rabbia o<br />
passività.<br />
• SAPER RISOLVERE I CONFLITTI: saper affrontare lealmente gli altri; saper negoziare i<br />
compromessi in modo sod<strong>di</strong>sfacente per entrambe le parti<br />
• SAPER ENTRARE NELLA DINAMICA DI GRUPPO: saper collaborare; saper esercitare<br />
la leadership quando la situazione lo richiede; saper poi passare ad altri ruoli senza<br />
problemi (superare la rigi<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> ruolo); saper riconoscere le aree problematiche che un<br />
gruppo può incontrare e superare<br />
(adatt. da D. Goleman, Intelligenza emotiva., Rizzoli 1996, pagg. 348-349)<br />
NON NEGARE LE EMOZIONI<br />
U. Galimberti parla <strong>del</strong>la necessità <strong>di</strong> riscoprire l'anima, l'emozione, che costituisce la natura<br />
più vera ed autentica <strong>del</strong>l'essere umano (cfr. "Che brutta questa scuola senz'anima" articolo<br />
1996).<br />
Egli sostiene che parte <strong>del</strong> <strong>di</strong>sagio giovanile sarebbe da imputare alla con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> massima<br />
estraneità con la quale si comunica a scuola, stabilendo rapporti <strong>di</strong> <strong>di</strong>ffidenza, <strong>di</strong> <strong>di</strong>stanza<br />
formale, pur parlando spesso, come nelle <strong>di</strong>scipline umanistiche, <strong>di</strong> contenuti squisitamente<br />
umani.<br />
"Le emozioni personali sono tenute rigidamente da parte e quelle suscitate nell'u<strong>di</strong>torio non<br />
raccolte". Se i mo<strong>del</strong>li <strong>di</strong> cultura restano contenuti nella mente senza <strong>di</strong>ventare spunti <strong>del</strong><br />
cuore, "il cuore comincerà a vagare senza orizzonte in quel nulla inquieto e depresso che<br />
nemmeno il baccano <strong>del</strong>la musica giovanile riesce a mascherare".<br />
La non conoscenza <strong>del</strong>le emozioni negate può poi portare a restarne travolti quando esse<br />
sgorgano incontrollate ed improvvise.<br />
Freud definì "perturbante ciò che si crede noto e invece si scopre improvvisamente<br />
sconosciuto, in grado <strong>di</strong> generare spavento, angoscia, scompiglio proprio nel momento in cui<br />
emerge dal mondo <strong>del</strong>la notte, dal sottosuolo, dall'inconscio e si consegna alla luce <strong>del</strong> giorno,<br />
alla consapevolezza razionale".<br />
LO "SPEC" A SCUOLA, IN FAMIGLIA...<br />
(Per entrare sempre più in contatto con se stessi)<br />
1. LE MIE EMOZIONI<br />
IL VOLTO DELLE EMOZIONI (per imparare a dare un nome alle principali emozioni)<br />
IL GIOCO DEL MIMO (per riconoscerle dall'espressione <strong>del</strong> viso e dai gesti)
41<br />
APPENDICE<br />
LA TOMBOLA DELLE EMOZIONI (per trovare collegamenti fra emozioni e<br />
comportamenti)<br />
A PESCA DI EMOZIONI (per arricchire il vocabolario emotivo <strong>del</strong> figlio/alunno)<br />
IL TERMOMETRO DELLE EMOZIONI (per insegnare/imparare a riconoscere l'intensità<br />
dei sentimenti)<br />
2. PERCHE' MI SENTO COSI'<br />
COSA PROVEREI SE... (per verificare se, <strong>di</strong> fronte ad una stessa situazione, tutti<br />
provano lo stesso sentimento<br />
COSI' PENSO, COSI' MI SENTO... (per cogliere la corrispondenza fra pensieri ed<br />
emozioni)<br />
INDOVINO IL PENSIERO... (per constatare che, se cambio il pensiero, cambio<br />
l'emozione)<br />
DISEGNO UNA STORIA (per notare la connessione tra le varie fasi <strong>di</strong> una storia)<br />
MI E' SUCCESSO CHE... (per consolidare la consapevolezza che sono i pensieri a<br />
determinare le emozioni)<br />
3. I PENSIERI CHE CREANO PROBLEMI<br />
FATTI E OPINIONI (per imparare a <strong>di</strong>stinguere i f<strong>atti</strong> dalle opinioni)<br />
IL MIO MODO DI PENSARE (per riconoscere i pensieri utili da quelli dannosi)<br />
NON DOVEVA PROPRIO (per verificare i più comuni errori <strong>di</strong> pensiero)<br />
IL GIARDINO DEI PENSIERI (per capire quali pensieri inducono emozioni positivequali<br />
negative- quali neutre)<br />
CRUCIPUZZLE (per prevenire alcuni mo<strong>di</strong> dannosi <strong>di</strong> pensare)<br />
4. QUANDO LE COSE SONO DIFFICILI<br />
POSSO PROVARCI (per imparare ad impegnarsi anche se non si è sicuri <strong>di</strong> riuscire<br />
subito al meglio)<br />
PENSIERI ESAGERATI (per riconoscere alcuni mo<strong>di</strong> <strong>di</strong> pensare che ingigantiscono le<br />
<strong>di</strong>fficoltà)<br />
LA SFIDA (per trasformare i pensieri irrazionali, che sono <strong>di</strong> ostacolo nell'affrontare le<br />
<strong>di</strong>fficoltà, in pensieri utili)<br />
GLI EMISFERI (per imparare a rilassarsi, visualizzare, me<strong>di</strong>tare)<br />
5. L'ERBA VOGLIO NEL MIO GIARDINO<br />
MI PIACEREBBE... (per capire la <strong>di</strong>fferenza fra desiderare qualcosa e volerla<br />
assolutamente)<br />
VIAGGIO IN UN'ISOLA DESERTA (per imparare a <strong>di</strong>stinguere ciò che è in<strong>di</strong>spensabile<br />
e ciò che è superfluo)
42<br />
APPENDICE<br />
COMPORTAMENTI E CONSEGUENZE (per riconoscere le conseguenze imme<strong>di</strong>ate e<br />
future <strong>di</strong> un comportamento)<br />
LE COSE DEVONO ANDARE COME VOGLIO IO (per verificare le conseguenze<br />
negative <strong>del</strong>le richieste irragionevoli)<br />
LE ARMI DELLA MENTE (per imparare ad usare pensieri utili, che aiutano a<br />
fronteggiare situazioni negative)<br />
6. HO PAURA DI ...<br />
DISEGNA LA PAURA (per riconoscere la <strong>di</strong>fferenza fra paura <strong>di</strong> cose reali e paura <strong>di</strong><br />
cose immaginarie)<br />
CLASSIFICHIAMO LA PAURA (per imparare a dare il giusto peso ad alcuni eventi<br />
negativi, senza considerarli una catastrofe)<br />
OSSERVA IL PENSIERO (per imparare a rilassarsi e ad attenuare le reazioni<br />
neurovegetative connesse a stati <strong>di</strong> forte <strong>atti</strong>vazione emotiva)<br />
COME UNA NUVOLA (per apprendere correttamente almeno una semplice tecnica <strong>di</strong><br />
rilassamento)<br />
IMMAGINA... (per imparare a praticare l'immaginazione razionale – emotiva al fine <strong>di</strong><br />
fronteggiare situazioni temute)<br />
7. PAROLACCE E DISPETTI<br />
LE ETICHETTE (per capire che è sbagliato apostrofare gli altri con soprannomi o<br />
aggettivi offensivi)<br />
IL BERSAGLIO (per imparare ad essere tolleranti verso chi ci prende in giro)<br />
SOPPORTABILE/INSOPPORTABILE (per apprendere che certe situazioni, pur<br />
fasti<strong>di</strong>ose, possono essere sopportate)<br />
COSA DIRE A ME STESSO (per usare pensieri utili che ci aiutano nei momenti <strong>di</strong>fficili –<br />
quando si è presi in giro, si riceve un <strong>di</strong>spetto…)<br />
TIRATI SU (per esercitarsi ad orientare la mente verso argomenti positivi ai fini <strong>di</strong> non<br />
abbattersi quando si è trattati male –o si crede <strong>di</strong> esserlo…)<br />
8. AIUTARE E' BELLO<br />
COSTRUIAMO INSIEME (per verificare che, collaborando in gruppo, si può creare<br />
qualcosa <strong>di</strong> bello e si possono raggiungere risultati molto vali<strong>di</strong>)<br />
PUZZLE DI GRUPPI (per allenarsi a coltivare sentimenti positivi nei riguar<strong>di</strong> degli altri)<br />
LA RUOTA DELL'AMICIZIA (per allenarsi ad accorgersi <strong>di</strong> chi ha bisogno d'aiuto)<br />
SALVA L'AMICO (per esercitare la solidarietà)
CONSIDERAZIONI<br />
43<br />
APPENDICE<br />
L'EMOZIONALITA' non deve essere negata o repressa: ciò turberebbe l'evoluzione<br />
psicoaffettiva <strong>del</strong> soggetto e provocherebbe conflitti interiori pesanti, destinati a lasciare tracce<br />
per tutta la vita.<br />
La psicosomatica afferma poi che tali negazioni/repressioni possono portare a mal<strong>atti</strong>e fisiche<br />
anche molto gravi (asma, ulcera, allergie, cancro, leucemia...)<br />
Ma l'EMOZIONALITA' deve essere conosciuta, gestita (cioè dosata, incanalata,<br />
orientata...)<br />
Se ciò non avviene, essa si pone con l'irruenza <strong>di</strong> un fiume in piena, con pericolo per se stessi<br />
e per gli altri.<br />
L'EMOZIONALITA', correttamente impostata, costituisce per la persona enorme ricchezza<br />
e contribuisce in modo rilevante alla sua autorealizzazione (ultimo livello <strong>del</strong>la piramide <strong>di</strong><br />
Maslow)<br />
Ecco alcuni effetti positivi <strong>di</strong> ricaduta <strong>di</strong> una sana emozionalità:<br />
• Ci aiuta a <strong>di</strong>venire più "umani", cioè più autentici, più ricchi dentro, più veri<br />
• Ci dona quella vitalità che ci consente <strong>di</strong> accettarci, <strong>di</strong> volerci bene, <strong>di</strong> integrare<br />
armoniosamente le varie parti che ci compongono verso una unità<br />
• Ci consente un buon adattamento socio-emotivo, connesso ad un funzionamento personale<br />
più felice e più efficace<br />
• Ci sostiene <strong>di</strong> fronte alle <strong>di</strong>fficoltà <strong>del</strong>la vita e ci consente <strong>di</strong> circoscrivere gli effetti negativi<br />
• Ci stimola al rapporto interpersonale, aiutandoci ad uscire da noi stessi e a vivere in empatia<br />
con gli altri<br />
• Ci dà la capacità <strong>di</strong> gestire/superare le ansie <strong>di</strong> ogni giorno<br />
• Ci consente <strong>di</strong> sorridere <strong>di</strong> noi stessi – per le nostre carenze – senza per questo indurci a<br />
compromettere l'autostima<br />
• Ci orienta <strong>di</strong> assumere, nei riguar<strong>di</strong> <strong>del</strong>la realtà e <strong>del</strong> mondo, posizioni equilibrate, fondate<br />
sul <strong>di</strong>scernimento, sulla capacità <strong>di</strong> analisi e <strong>di</strong> decisione<br />
• Ci guida verso una progettualità esistenziale, coerente con la nostra visione <strong>del</strong>la vita
• Facilita una maggiore integrazione sociale<br />
44<br />
APPENDICE<br />
• Ci aiuta, prima ancora che a capirci ed a capire, ad accettarci ed accettare, inducendoci a<br />
pensate che noi stessi e gli altri non siamo atteggiamenti da cambiare, ma anzitutto persone<br />
da accettare<br />
IL TRIANGOLO DELLA PERSONALITA'<br />
COGNITIVO<br />
AFFETTIVO RELAZIONALE