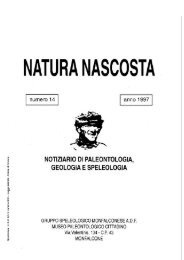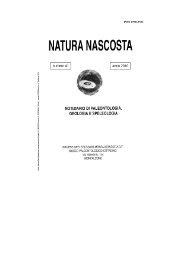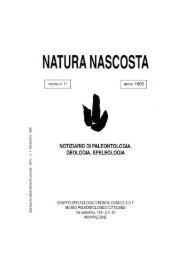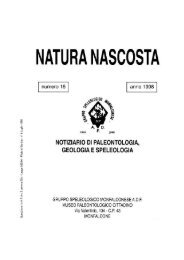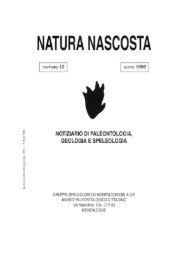Il Carso 85 milioni di anni fa: gli straordinari - Il museo paleontologico
Il Carso 85 milioni di anni fa: gli straordinari - Il museo paleontologico
Il Carso 85 milioni di anni fa: gli straordinari - Il museo paleontologico
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
INDICE<br />
INDICE pag. 2<br />
INTRODUZIONE pag. 3<br />
COS’È UN FOSSILE? pag. 3<br />
IL TEMPO GEOLOGICO E L’EVOLUZIONE DEGLI ORGANISMI pag. 7<br />
PERCHÈ SI TROVANO IN MONTAGNA I FOSSILI DI ORGANISMI MARINI? pag. 9<br />
CAMBIAMENTI DI PAESAGGIO: LA PALEOGEOGRAFIA pag. 12<br />
POLAZZO pag. 16<br />
LA SCOPERTA DEI FOSSILI DI POLAZZO E STORIA DELLE RICERCHE pag. 17<br />
LAGERSTÄTTEN pag. 20<br />
GEOLOGIA DEL CARSO ISONTINO E DEI SITI FOSSILIFERI DI POLAZZO pag. 21<br />
I MICROFOSSILI E L’ETÀ DEI SITI DI POLAZZO pag. 32<br />
L’AMBIENTE DI DEPOSIZIONE pag. 35<br />
I FOSSILI DI POLAZZO pag. 37<br />
Le ru<strong>di</strong>ste pag. 37<br />
I fossili dei siti A e B: note generali pag. 42<br />
Piante pag. 44<br />
Vertebrati: i Rettili pag. 53<br />
Vertebrati: i Pesci pag. 56<br />
Cenni <strong>di</strong> sistematica dei Pesci pag. 56<br />
L’associazione ittica pag. 56<br />
Pycnodontiformes (Picnodonti) pag. 57<br />
Anguilliformes pag. 60<br />
Gonorhynchiformes – Chanidae pag. 60<br />
Cipriniformes? pag. 60<br />
Alepisauriformes - Dercetidae ed Enchodontidae pag. 62<br />
Acanthomorpha – Percomorpha - Beryciformes pag. 66<br />
Teleostei da determinare pag. 69<br />
Invertebrati pag. 73<br />
Tracce fossili pag. 74<br />
PROSPETTIVE FUTURE pag. 75<br />
DOVE VEDERE I FOSSILI DI POLAZZO OGGI pag. 76<br />
RINGRAZIAMENTI pag. 76<br />
BIBLIOGRAFIA pag. 77<br />
© Gruppo Speleologico Mon<strong>fa</strong>lconese A.d.F.<br />
Tutti i <strong>di</strong>ritti sono riservati<br />
È vietata per legge la riproduzione in fotocopia<br />
e in qualsiasi altra forma<br />
(microfilm, compact-<strong>di</strong>sk, videocassetta, ecc.)<br />
senza il consenso scritto da parte del Gruppo Speleologico Mon<strong>fa</strong>lconese A.d.F.<br />
Ogni violazione sarà perseguita secondo le leggi civili e penali<br />
4
INTRODUZIONE<br />
Mentre per la zoologia e la botanica qualcosa si è <strong>fa</strong>tto, manca nella nostra Regione una letteratura<br />
<strong>di</strong>vulgativa che valorizzi il patrimonio <strong>paleontologico</strong> presente nel territorio. Questo è ancor più biasimevole se<br />
si considera l’estremo valore scientifico della geologia e della paleontologia del Friuli-Venezia Giulia a livello<br />
nazionale e anche internazionale.<br />
La conoscenza del territorio in cui si vive, oltre ad essere un naturale obiettivo della curiosità innata<br />
nell’uomo e ad esercitare un certo stimolo culturale nella persona intelligente, dovrebbe essere un dovere per il<br />
citta<strong>di</strong>no. Ognuno <strong>di</strong> noi dovrebbe possedere conoscenze sufficienti per decidere in autonomia e col maggiore<br />
grado <strong>di</strong> coscienza possibile circa le scelte che la Società richiede <strong>di</strong> avallare o <strong>di</strong> respingere.<br />
L’evoluzione geologica del nostro territorio non è ancora nota in detta<strong>gli</strong>o. Gli stu<strong>di</strong> scientifici sono stati<br />
per lo più spora<strong>di</strong>ci e parziali, spesso mirati ad aspetti importanti, ma limitati. Ci sarebbe bisogno <strong>di</strong> una<br />
attenzione costante e rivolta ad una comprensione totale dell’evoluzione biologica e geologica <strong>di</strong> questa<br />
interessante regione d’Italia.<br />
Si spendono i sol<strong>di</strong> pubblici per la <strong>di</strong>dattica e non per la ricerca scientifica, ma cosa si può insegnare se non<br />
c’è una conoscenza alla base?<br />
Purtroppo, lo stu<strong>di</strong>o del territorio non è mai stato considerato in Italia qualcosa <strong>di</strong> realmente importante.<br />
Per poi piangere e imprecare contro una non ben definita “natura matrigna” quando la spregiu<strong>di</strong>cata e miope<br />
attività umana <strong>fa</strong> crollare una fetta <strong>di</strong> montagna in un lago o porta alla <strong>di</strong>struzione <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici costruiti ne<strong>gli</strong><br />
alvei dei fiumi o in zone soggette a terremoti.<br />
In questo libro si fornirà una visione del <strong>Carso</strong> che <strong>di</strong>fficilmente <strong>gli</strong> abitanti della zona avrebbero potuto<br />
immaginare senza il lavoro <strong>di</strong> geologi e paleontologi. Quella riportata, pure nell’inevitabile incompletezza dei<br />
dati, è una ricostruzione atten<strong>di</strong>bile e <strong>di</strong> singolare <strong>fa</strong>scino: le pareti <strong>di</strong> grigio calcare una volta - <strong>milioni</strong> <strong>di</strong> <strong>anni</strong><br />
<strong>fa</strong> - erano la sabbia del fondale <strong>di</strong> un mare tropicale, uno <strong>di</strong> quei mari che nella nostra immaginazione sono<br />
associati a regioni come i Caraibi o il Mar dei Coralli. I resti litificati <strong>di</strong> questo mare tropicale si riconoscono<br />
in ogni spuntone roccioso, in ogni pietra del <strong>Carso</strong>. E nelle rocce si rinvengono, fossilizzati, anche <strong>gli</strong> antichi<br />
organismi che nel mare vivevano.<br />
Con questo libro vo<strong>gli</strong>amo <strong>fa</strong>r conoscere cosa è stato trovato in oltre 13 <strong>anni</strong> <strong>di</strong> ricerca in un sito <strong>paleontologico</strong><br />
straor<strong>di</strong>nario: il sito <strong>di</strong> Polazzo. Purtroppo, quello che effettivamente sappiamo dei reperti recuperati è ancora poco.<br />
Ci si renderà conto durante la lettura che trasformare i fossili in dati, e quin<strong>di</strong> in conoscenza, è un processo che<br />
necessita <strong>di</strong> tempo e competenze professionali, quin<strong>di</strong> <strong>di</strong> un investimento economico, perchè a questi livelli <strong>di</strong><br />
specializzazione nessuno può permettersi <strong>di</strong> lavorare gratis nella società italiana o<strong>di</strong>erna.<br />
COS’È UN FOSSILE?<br />
Si definisce correttamente come "fossile" qualsiasi testimonianza della vita del passato, a prescindere dalla<br />
sua natura ed età geologica. Possono fossilizzarsi non solo le dure conchi<strong>gli</strong>e dei molluschi, ma anche le ossa e<br />
i denti dei vertebrati (Fig. 1A), le sca<strong>gli</strong>e dei pesci, le uova (Fig. 1B), le fo<strong>gli</strong>e e le altre parti dei vegetali (Fig.<br />
1C), <strong>gli</strong> escrementi (che assumono il nome <strong>di</strong> coproliti; Fig. 1D), i rigurgiti e le tracce del movimento de<strong>gli</strong><br />
organismi - sia invertebrati che vertebrati - sul se<strong>di</strong>mento soffice (Fig. 1E). L' ambra (Fig. 1F), la "pietra"<br />
leggerissima dal colore giallo o arancione, molto utilizzata in gioielleria, è la resina fossile <strong>di</strong> antiche piante.<br />
Talvolta nell'ambra si trovano inglobati e perfettamente conservati <strong>gli</strong> insetti che vivevano sul tronco<br />
dell'albero.<br />
I fossili sono l'unico strumento <strong>di</strong>retto che possiamo utilizzare nel tentativo <strong>di</strong> ricostruire <strong>gli</strong> organismi<br />
vissuti nel passato geologico del Pianeta, le loro abitu<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> vita (Fig. 2), le mo<strong>di</strong>ficazioni che hanno subito nel<br />
tempo, la loro evoluzione.<br />
Me<strong>di</strong>ante lo stu<strong>di</strong>o delle trasformazioni delle forme viventi e de<strong>gli</strong> ambienti nel tempo, possiamo<br />
comprendere come questi "funzionano", <strong>di</strong> quali processi noi, umani, siamo il risultato (uno dei molti risultati)<br />
e cosa ci si può attendere in futuro, anche in conseguenza dei nostri comportamenti. Scriviamo e sottolineiamo<br />
"anche" perché in realtà l’uomo tende a sopravvalutarsi persino ne<strong>gli</strong> aspetti negativi. Lo stu<strong>di</strong>o dei fossili ha<br />
permesso <strong>di</strong> identificare nella storia de<strong>gli</strong> organismi viventi dei momenti <strong>di</strong> crisi, <strong>di</strong> fortissima crisi, con una<br />
vera e propria decimazione de<strong>gli</strong> animali e delle piante a livello planetario. Queste crisi hanno cambiato in<br />
modo drastico la composizione delle <strong>fa</strong>une e delle flore. Si pensi, per esempio, alla scomparsa dei <strong>di</strong>nosauri.<br />
Fino a quel momento la stragrande maggioranza delle nicchie ecologiche dei vertebrati terrestri era stata<br />
occupata da rettili, nel significato ampio che <strong>di</strong>amo comunemente a questo termine.<br />
5
Figura 1 - Esempi <strong>di</strong> fossilizzazione. A) Dente <strong>di</strong> <strong>di</strong>nosauro carnivoro, Cretaceo, Marocco; B) uovo <strong>di</strong> <strong>di</strong>nosauro<br />
sauropode con una ricostruzione dell’embrione al suo interno, Cretaceo, Argentina (foto F.M. Dalla Vecchia); C) felce<br />
arborea, Carbonifero, Friuli; D) coprolite, Cretaceo, Madagascar (foto F.M. Dalla Vecchia); E) orma <strong>di</strong> <strong>di</strong>nosauro,<br />
Cretaceo, Istria; F) ambra con insetto (freccia), Oligocene, S. Domingo.<br />
6
Figura 2 - Pesce (Dapalis macrurus) morto e fossilizzato nell’atto <strong>di</strong> inghiottire un altro pesce. Miocene, Francia.<br />
(foto F.M. Dalla Vecchia).<br />
Esistevano pure rettili acquatici e rettili volanti, rettili <strong>di</strong> pochi centimetri <strong>di</strong> lunghezza e rettili gran<strong>di</strong> come<br />
palazzi. Circa 65 <strong>milioni</strong> <strong>di</strong> <strong>anni</strong> <strong>fa</strong>, quasi tutti si estinsero. Nonostante le cause e le modalità non siano ancora<br />
completamente chiare, non c’è dubbio che ciò avvenne, ed in un intervallo comunque relativamente breve dal<br />
punto <strong>di</strong> vista geologico. Poteva essere la fine della vita sulle terre emerse, ma dopo pochi <strong>milioni</strong> <strong>di</strong> <strong>anni</strong><br />
queste erano già ripopolate dai Mammiferi - fino ad allora piccoli ed emarginati componenti della <strong>fa</strong>una - che<br />
avevano occupato le nicchie lasciate libere dai gran<strong>di</strong> rettili scomparsi. L'umanità, per quanto possa sforzarsi,<br />
non potrà mai <strong>di</strong>struggere la vita sul pianeta. Potrà sporcare, uniformare, impoverire, riempire <strong>di</strong> propri simili<br />
gran parte della superficie terrestre - soprattutto quella emersa però, che è appena il 20% circa del totale -, ma<br />
la vita sopravviverà a quel suo fenomeno anomalo che è Homo sapiens sapiens. Solo l'espansione del Sole,<br />
probabilmente tra un miliardo <strong>di</strong> <strong>anni</strong>, metterà fine alla vita sulla terra.<br />
La più pesante conseguenza sulla “natura” (o più correttamente, sul resto della natura, perchè non c’è un<br />
motivo, se non artificioso ed egocentrico, per separarci nettamente da<strong>gli</strong> altri esseri viventi) della presenza<br />
dell'uomo non è il naufragio <strong>di</strong> qualche petroliera, ma l'inesorabile, lento appiattimento della <strong>di</strong>versità.<br />
L'abnorme proliferazione umana ha portato all'impoverimento delle <strong>fa</strong>une presenti nelle aree <strong>di</strong> coabitazione e<br />
alla trasformazione della flora in prati inglesi e campi <strong>di</strong> granoturco. Pensiamo, per esempio, alla Pianura<br />
Padana, dove, escludendo Homo sapiens, praticamente non ci sono più animali selvatici che superino le<br />
<strong>di</strong>mensioni <strong>di</strong> un coni<strong>gli</strong>o.<br />
Ma ritorniamo ai fossili. <strong>Il</strong> loro utilizzo pratico, a parte i casi dell'ambra in gioielleria o <strong>di</strong> carbone, gas e<br />
petrolio (tutti <strong>di</strong> origine organica) per la produzione <strong>di</strong> energia, riguarda la datazione in<strong>di</strong>retta delle rocce.<br />
Poiché certi gruppi <strong>di</strong> organismi sono esistiti durante intervalli limitati della storia terrestre, se li ritroviamo<br />
fossilizzati nelle rocce si può ricondurre la formazione <strong>di</strong> tali rocce all'intervallo <strong>di</strong> tempo in cui essi vissero,<br />
intesi non come in<strong>di</strong>vidui, ma come specie o altra categoria superiore (genere, <strong>fa</strong>mi<strong>gli</strong>a ecc.). Datando il<br />
frammento <strong>di</strong> roccia si ottiene l'età dello strato da cui esso proviene. Per esempio, ritrovando in uno strato<br />
7
occioso un ammonite, la conchi<strong>gli</strong>a spiralata <strong>di</strong> un gruppo estinto <strong>di</strong> molluschi marini simili a seppie, si è<br />
sicuri dell’età mesozoica della roccia.<br />
Questo però non permette una datazione assoluta, cioè in <strong>anni</strong> o, me<strong>gli</strong>o, in <strong>milioni</strong> <strong>di</strong> <strong>anni</strong>. Per la<br />
datazione assoluta ci si basa sul deca<strong>di</strong>mento de<strong>gli</strong> elementi ra<strong>di</strong>oattivi.<br />
Semplificando molto la cosa, si può <strong>di</strong>re che esistono de<strong>gli</strong> elementi chimici, come il piombo e l'uranio,<br />
che si trasformano con velocità costante in altri elementi o in propri isotopi stabili, cioè che non cambiano.<br />
Questo fenomeno si chiama deca<strong>di</strong>mento ra<strong>di</strong>oattivo. Conoscendo la quantità teorica iniziale <strong>di</strong> un elemento<br />
ra<strong>di</strong>oattivo che doveva trovarsi nei minerali <strong>di</strong> una roccia al momento della sua formazione e misurandone la<br />
quantità rimasta, si calcola semplicemente per sottrazione la parte che si è trasformata per deca<strong>di</strong>mento. Se<br />
conosciamo la velocità <strong>di</strong> deca<strong>di</strong>mento dell’elemento, è <strong>fa</strong>cile il calcolo del tempo impiegato dalla quantità<br />
mancante <strong>di</strong> elemento ra<strong>di</strong>oattivo per trasformarsi nella corrispondente quantità <strong>di</strong> elemento stabile. Se, ad<br />
esempio, è stato calcolato che un elemento ra<strong>di</strong>oattivo impiega 300 <strong>milioni</strong> <strong>di</strong> <strong>anni</strong> per ridurre della metà la<br />
propria concentrazione originaria, ritrovandone 1 milligrammo in una roccia che all'origine doveva contenerne<br />
2 milligrammi sappiamo che l'età assoluta della roccia è 300 <strong>milioni</strong> <strong>di</strong> <strong>anni</strong>.<br />
Purtroppo non tutte le rocce contengono cristalli <strong>di</strong> minerali utilizzabili per le datazioni assolute, e<br />
soprattutto, raramente li contengono le rocce fossilifere. Essi si trovano soprattutto nelle rocce <strong>di</strong> origine<br />
vulcanica, dove l’età <strong>di</strong> formazione dei cristalli e della roccia coincidono. Per questo motivo uno dei maggiori<br />
sforzi dei geologi <strong>di</strong> tutto il mondo ne<strong>gli</strong> ultimi 50 <strong>anni</strong> è stato <strong>di</strong>retto alla ricerca <strong>di</strong> correlazioni tra strati<br />
datati in modo assoluto e strati fossiliferi.<br />
Ve<strong>di</strong>amo, in modo molto semplificato, come questo avviene.<br />
Immaginiamo che in una successione <strong>di</strong> strati sovrapposti (e solo in quella successione anche se in località<br />
<strong>di</strong>verse), si trovi, più o meno uniformemente <strong>di</strong>stribuita, una determinata forma fossile. Immaginiamo inoltre<br />
che in alcune località il primo strato sopra <strong>gli</strong> strati fossiliferi ed il primo strato sotto contengano elementi<br />
ra<strong>di</strong>oattivi e siano quin<strong>di</strong> entrambi databili in modo assoluto. L'età de<strong>gli</strong> strati fossiliferi è compresa tra quella<br />
dei due strati datati e così anche i fossili in essa contenuti. Per esempio, se lo strato alla base della successione<br />
<strong>di</strong> strati fossiliferi ha una età <strong>di</strong> 96 <strong>milioni</strong> <strong>di</strong> <strong>anni</strong> e quello che giace al tetto risale a 92 <strong>milioni</strong> <strong>di</strong> <strong>anni</strong> <strong>fa</strong>, il<br />
particolare organismo fossile presente ne<strong>gli</strong> strati fossiliferi è comparso (come insieme <strong>di</strong> in<strong>di</strong>vidui) 96 <strong>milioni</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>anni</strong> <strong>fa</strong>, è esistito per 4 <strong>milioni</strong> <strong>di</strong> <strong>anni</strong> e si è estinto 92 <strong>milioni</strong> <strong>di</strong> <strong>anni</strong> <strong>fa</strong>. Se noi troviamo quell'organismo,<br />
magari sulle pietre del muro <strong>di</strong> una casa o passeggiando sul <strong>Carso</strong>, sappiamo che esso e la roccia che lo<br />
contiene hanno una età compresa tra i 92 ed i 96 <strong>milioni</strong> <strong>di</strong> <strong>anni</strong> (Fig. 3). Li abbiamo datati in maniera<br />
assoluta, anche se con un certo grado <strong>di</strong> approssimazione.<br />
Figura 3 - Esempio ipotetico <strong>di</strong> correlazione.<br />
8
IL TEMPO GEOLOGICO E L’EVOLUZIONE DEGLI ORGANISMI<br />
La storia della Terra non si misura con le nostre comuni unità <strong>di</strong> tempo, ma in <strong>milioni</strong> <strong>di</strong> <strong>anni</strong> (Fig. 4).<br />
Tutto quello che ci rimane dei <strong>milioni</strong> <strong>di</strong> <strong>anni</strong> passati sono i se<strong>di</strong>menti trasformati in rocce e ciò che in essi è<br />
rimasto inglobato, incluse le spo<strong>gli</strong>e de<strong>gli</strong> antichi organismi, cioè i fossili.<br />
<strong>Il</strong> tempo geologico è sud<strong>di</strong>viso per utilità in intervalli con or<strong>di</strong>ne gerarchico <strong>di</strong>verso. Questa <strong>di</strong>visione del<br />
tempo in numerosi intervalli, in complessa relazione reciproca e dai nomi ostici, spesso in<strong>fa</strong>sti<strong>di</strong>sce i lettori<br />
non particolarmente avvezzi alla terminologia scientifica. Le sud<strong>di</strong>visioni maggiori sono <strong>gli</strong> Eoni; esistono tre<br />
eoni: Archeano, Proterozoico e Fanerozoico. L'eone Fanerozoico (che significa "dalla vita evidente") è<br />
sud<strong>di</strong>viso in tre Ere: Paleozoica, Mesozoica e Cenozoica. Le ere sono sud<strong>di</strong>vise in Perio<strong>di</strong>, intervalli <strong>di</strong> tempo<br />
della durata variabile tra i 21 e <strong>gli</strong> 80 <strong>milioni</strong> <strong>di</strong> <strong>anni</strong>. <strong>Il</strong> periodo Quaternario è iniziato circa 1,8 <strong>milioni</strong> <strong>di</strong> <strong>anni</strong><br />
<strong>fa</strong> ed è in tuttora in corso.<br />
L'origine della Terra risale probabilmente a 4,6 miliar<strong>di</strong> <strong>di</strong> <strong>anni</strong> <strong>fa</strong> sulla base dell'età dei meteoriti e della<br />
Luna, e le più antiche rocce ritrovate sulla Terra sono vecchie <strong>di</strong> circa 4 miliar<strong>di</strong> <strong>di</strong> <strong>anni</strong><br />
Ogni corpo roccioso ha quin<strong>di</strong> una sua precisa età e si è formato in un determinato intervallo <strong>di</strong> tempo. Le<br />
rocce se<strong>di</strong>mentarie sono derivate dalla compattazione e cementazione <strong>di</strong> se<strong>di</strong>menti (ghiaie, sabbie, <strong>fa</strong>nghi,<br />
argille) per lo più trasportati e depositati dalle acque e dai venti.<br />
Nella Provincia <strong>di</strong> Gorizia si trovano rocce con età variabili tra circa 120 <strong>milioni</strong> <strong>di</strong> <strong>anni</strong> <strong>fa</strong> e l’attuale.<br />
La maggior parte delle rocce affioranti nel <strong>Carso</strong> sono datate al periodo geologico chiamato Cretaceo dell’era<br />
Mesozoica, l’era dei Dinosauri. Questo intervallo <strong>di</strong> tempo – riportato in letteratura anche come Mesozoico -<br />
vide la comparsa e la <strong>di</strong>ffusione dei gran<strong>di</strong> rettili, che insieme a molti altri organismi, come abbiamo già visto,<br />
si estinsero per cause ancora non del tutto chiare alla fine del Cretaceo, 65 <strong>milioni</strong> <strong>di</strong> <strong>anni</strong> <strong>fa</strong>.<br />
Le associazioni <strong>di</strong> organismi cambiano nel tempo, <strong>gli</strong> in<strong>di</strong>vidui sono soggetti alla selezione naturale, le<br />
specie si evolvono e le comunità vengono mo<strong>di</strong>ficate, anche ra<strong>di</strong>calmente, dai cambiamenti ambientali.<br />
I primi in<strong>di</strong>zi sulla presenza <strong>di</strong> esseri viventi si hanno già in rocce <strong>di</strong> circa 3,5 miliar<strong>di</strong> <strong>di</strong> <strong>anni</strong> <strong>fa</strong>. Per i<br />
successivi 2000 <strong>milioni</strong> <strong>di</strong> <strong>anni</strong> la Terra fu abitata solo da organismi unicellulari, le cui <strong>di</strong>mensioni erano <strong>di</strong><br />
molto inferiori a quelle <strong>di</strong> una capocchia <strong>di</strong> spillo. La comparsa <strong>di</strong> organismi pluricellulari, 1,4 miliar<strong>di</strong> <strong>di</strong> <strong>anni</strong><br />
<strong>fa</strong>, fu seguita dopo ben 700 <strong>milioni</strong> <strong>di</strong> <strong>anni</strong> dai primi animali, forme molli e piatte che ricordano vermi e<br />
meduse (Fauna <strong>di</strong> E<strong>di</strong>acara). Solo circa 545 <strong>milioni</strong> <strong>di</strong> <strong>anni</strong> <strong>fa</strong> la vita si <strong>di</strong>ffuse ampiamente nei mari con<br />
organismi relativamente gran<strong>di</strong>, <strong>di</strong>versificati e provvisti <strong>di</strong> guscio. Da quel momento in poi l'evoluzione è stata,<br />
geologicamente parlando, rapida. Oltre 530 <strong>milioni</strong> <strong>di</strong> <strong>anni</strong> <strong>fa</strong> apparvero i primi Vertebrati marini e 430<br />
<strong>milioni</strong> <strong>di</strong> <strong>anni</strong> <strong>fa</strong> le prime piante terrestri. Le terre emerse videro i primi Vertebrati terrestri, i Tetrapo<strong>di</strong><br />
basali, 370 <strong>milioni</strong> <strong>di</strong> <strong>anni</strong> <strong>fa</strong> e subito dopo apparvero <strong>gli</strong> Amnioti, i primi Rettili, che si riproducono me<strong>di</strong>ante<br />
uova che possono essere deposte lontano dall’acqua. I primi, piccoli Mammiferi fecero la loro comparsa circa<br />
215 <strong>milioni</strong> <strong>di</strong> <strong>anni</strong> <strong>fa</strong> e l'Uccello più antico finora trovato è vecchio <strong>di</strong> 150 <strong>milioni</strong> <strong>di</strong> <strong>anni</strong>. Nel Mesozoico i<br />
mammiferi erano rappresentati da piccole forme simili a topi che rimasero per decine <strong>di</strong> <strong>milioni</strong> <strong>di</strong> <strong>anni</strong><br />
all’ombra dei <strong>di</strong>nosauri, senza evolversi in forme più gran<strong>di</strong> e complesse. Solo l’estinzione della maggior parte<br />
dei rettili permise la successiva <strong>di</strong>versificazione dei Mammiferi, a partire da 65 <strong>milioni</strong> <strong>di</strong> <strong>anni</strong> <strong>fa</strong>.<br />
I Primati primitivi, alla base dell’evoluzione delle scimmie, c'erano già 55 <strong>milioni</strong> <strong>di</strong> <strong>anni</strong> <strong>fa</strong>; i primi omini<strong>di</strong><br />
(la <strong>fa</strong>mi<strong>gli</strong>a che comprende <strong>gli</strong> attuali Orang-utan, Gorilla, Scimpanzè e <strong>gli</strong> Ominini) risalgono a 14 <strong>milioni</strong> <strong>di</strong><br />
<strong>anni</strong> <strong>fa</strong>, le prime specie del genere Homo comparvero meno <strong>di</strong> 2,5 <strong>milioni</strong> <strong>di</strong> <strong>anni</strong> <strong>fa</strong> e la specie Homo sapiens<br />
calca il palcoscenico della vita da solo 160.000 <strong>anni</strong>. Ne consegue che noi non c’eravamo quando si formarono<br />
le rocce del <strong>Carso</strong> e i gran<strong>di</strong> rettili dominavano il pianeta. Allora il Mondo era molto <strong>di</strong>verso da quello attuale,<br />
non esisteva ancora l’erba, probabilmente non c’era ghiaccio ai Poli, le terre emerse erano meno estese e il<br />
clima era generalmente più caldo.<br />
9
Figura 4 - <strong>Il</strong> Tempo geologico, sue sud<strong>di</strong>visioni e maggiori eventi biologici.<br />
10
PERCHÈ SI TROVANO IN MONTAGNA I FOSSILI DI ORGANISMI MARINI?<br />
Chi non ha mai trovato conchi<strong>gli</strong>e incastonate nella roccia durante una passeggiata in montagna? Si<br />
potrebbe pensare che quei resti siano stati lasciati da un antico mare che un tempo copriva la pianura, le<br />
colline e, persino, le montagne, che poi si è ritirato nella posizione attuale.<br />
Questa supposizione è errata.<br />
Non fu il mare a ritirarsi in un indefinito e uniforme “passato”, ma è il piatto fondo marino che si è<br />
sollevato.<br />
La Terra è come una sfera sud<strong>di</strong>visa in strati concentrici, ciascuno con composizione e caratteristiche<br />
fisiche <strong>di</strong>verse (Fig. 5). La parte centrale, il nucleo, è probabilmente formata <strong>di</strong> ferro-nichel ed è <strong>di</strong>visa in una<br />
parte interna solida e una parte esterna fluida. <strong>Il</strong> nucleo è ricoperto dal mantello che ha uno spessore <strong>di</strong> circa<br />
2800 km. La parte più esterna del pianeta, quella su cui viviamo noi, è la crosta terrestre, rigida e<br />
relativamente sottile rispetto a<strong>gli</strong> altri “strati” (5-7 km sotto <strong>gli</strong> oceani e fino a 90 km sotto le montagne). La<br />
crosta in confronto al resto del pianeta costituisce quello che nella mela è la buccia. Per avere un’idea delle<br />
proporzioni possiamo <strong>di</strong>re che la crosta e la parte superiore del mantello formano uno strato, la litosfera, che<br />
non è integro come la buccia in una mela, ma è frammentato in porzioni chiamati placche o zolle (Fig. 6), che<br />
si muovono uno rispetto all’altra come se “galleggiassero” sulla parte sottostante del mantello (astenosfera),<br />
calda e in grado <strong>di</strong> deformarsi lentamente. Roccia fusa, che risale continuamente dalle profon<strong>di</strong>tà del mantello<br />
e raggiunge la superficie attraverso lunghe fratture sul fondo dell’oceano (dorsali oceaniche), raffreddandosi<br />
forma nuova crosta che spinge a lato quella già esistente. Poichè l’ampiezza della superficie del pianeta deve<br />
mantenersi più o meno costante, in altre zone la litosfera si spacca e ri<strong>di</strong>scende all’interno del mantello,<br />
fondendo.<br />
Figura 5 - Struttura interna della Terra.<br />
11
Figura 6 - L’attuale sud<strong>di</strong>visione della superficie della crosta terrestre in zolle.<br />
I continenti si trovano sulle zolle come su <strong>di</strong> un nastro trasportatore e si spostano man mano che da una<br />
parte si crea nuova crosta e dall’altra altrettanta subduce e viene rifusa. Nella storia della Terra le zolle hanno<br />
cambiato continuamente forma e i continenti sono andati “a zonzo” sulla superficie del globo (Fig. 7). Quando<br />
nei loro spostamenti le masse continentali si scontrano, i se<strong>di</strong>menti e le rocce accumulate ai margini vengono<br />
schiacciati, deformati, frantumati e innalzati a blocchi e sca<strong>gli</strong>e a formare le catene montuose.<br />
Lo scontro tra il continente Africano e quello Euroasiatico, ha causato la formazione della catena montuosa<br />
Alpina e Dinarica, quin<strong>di</strong> anche l’innalzamento del <strong>Carso</strong>, a partire da una topografia originariamente piatta.<br />
12
Figura 7 - La posizione dei continenti A) 500 <strong>milioni</strong> <strong>di</strong> <strong>anni</strong> <strong>fa</strong>, B) 300 <strong>milioni</strong> <strong>di</strong> <strong>anni</strong> <strong>fa</strong>, C) 130 <strong>milioni</strong> <strong>di</strong> <strong>anni</strong> <strong>fa</strong>,<br />
D) 50 <strong>milioni</strong> <strong>di</strong> <strong>anni</strong> <strong>fa</strong>, basata sulle mappe <strong>di</strong> SMITH et al. (1973). Per chiarezza e per <strong>fa</strong>cilitare la comprensione è<br />
stata mantenuta la morfologia delle linee <strong>di</strong> costa dei continenti attuali, ma in realtà il profilo costiero era totalmente<br />
<strong>di</strong>verso ne<strong>gli</strong> intervalli <strong>di</strong> tempo qui considerati (si vedano le figure 8-10).<br />
CAMBIAMENTI DI PAESAGGIO: LA PALEOGEOGRAFIA<br />
La geografia è un’opinione e l’Italia al tempo dei <strong>di</strong>nosauri non esisteva.<br />
Attorno ai 250 <strong>milioni</strong> <strong>di</strong> <strong>anni</strong> <strong>fa</strong> i continenti erano riuniti in due masse principali, Gondwana a sud e<br />
Laurasia a nord, separate da un ampio golfo marino chiamato Tetide (Fig. 7B). Nel Gondwana si trovavano il<br />
continente Afroarabico (l’unione dell’Africa con la Penisola Arabica), Sudamericano, Australiano, Antartico,<br />
In<strong>di</strong>ano e il Madagascar. Durante la parte centrale dell’era Mesozoica, per esempio nel Giurassico, la regione<br />
adriatica - isontino compreso - era un promontorio settentrionale del continente Afroarabico; il territorio si<br />
trovava ai tropici e le rocce testimoniano la presenza <strong>di</strong> un basso mare caldo, nel quale la linea <strong>di</strong> costa si<br />
ritirava ed espandeva a seconda delle variazioni del livello marino.<br />
L'Italia, così come la ve<strong>di</strong>amo oggi, è il risultato recente (in senso geologico, dato che risale per lo più a<strong>gli</strong><br />
ultimi 25 <strong>milioni</strong> <strong>di</strong> <strong>anni</strong>) dello scontro fra il continente africano e quello eurasiatico. La struttura centrale - per<br />
così <strong>di</strong>re - della penisola è l’ex protuberanza dell'Africa, le catene montuose Alpina e Appenninica sono le<br />
deformazioni della crosta terrestre causate dello scontro tra la protuberanza e l'Europa e <strong>di</strong> alcune altre<br />
complicazioni geologiche. Certe parti del nostro Paese non hanno niente a che <strong>fa</strong>re, dal punto <strong>di</strong> vista<br />
geologico, con il resto della penisola. La Sardegna è un pezzo <strong>di</strong> continente europeo, originariamente posto tra<br />
Francia e Spagna, così come gran parte della Calabria.<br />
Nel Cretaceo, la geografia del mondo era ra<strong>di</strong>calmente <strong>di</strong>versa da quella attuale. Le Alpi e le Prealpi non<br />
esistevano, al loro posto c’era un paesaggio piatto, privo <strong>di</strong> rilievi. Anche l’Europa sarebbe stata<br />
irriconoscibile all’ipotetico viaggiatore, poichè l’attuale Europa centro-meri<strong>di</strong>onale è un puzzle <strong>di</strong> frammenti -<br />
allora molto <strong>di</strong>stanti tra loro - riuniti dalla collisione tra Africa ed Eurasia (Figg. 8-10).<br />
In sintesi, le Alpi, come il <strong>Carso</strong>, iniziarono a formarsi alla fine del Cretacico (80 <strong>milioni</strong> <strong>di</strong> <strong>anni</strong> <strong>fa</strong>)<br />
quando, a causa dell’apertura dell’oceano Atlantico meri<strong>di</strong>onale, l’Africa si staccò decisamente dall’America<br />
meri<strong>di</strong>onale e spostandosi a nord “chiuse” l’oceano della Tetide ed entrò in collisione con l’Eurasia. <strong>Il</strong> lento<br />
scontro, tuttora in atto, deformò i margini dei due continenti, accorciando la crosta terrestre e innalzando le<br />
montagne come pure tutti i rilievi più bassi.<br />
14
Figura 8 - Mappa paleogeografica semplificata della Tetide centrale <strong>di</strong> 95 <strong>milioni</strong> <strong>di</strong> <strong>anni</strong> <strong>fa</strong>, basata su PHILIP et al<br />
(2000), mo<strong>di</strong>ficata e ri<strong>di</strong>segnata. L’asterisco in<strong>di</strong>ca la posizione del <strong>Carso</strong>. Blu = mare profondo, oceano; azzurro =<br />
mare basso; giallo ocra = terre emerse. Abbreviazioni: A = Piattaforma Carbonatica Apula (Pu<strong>gli</strong>a e Maiella), ACP =<br />
Piattaforma Carbonatica Appenninica, AD = Piattaforma Carbonatica Adriatico-Dinarica, AM = Massiccio<br />
Armoricano, AnA = Anti Atlante, Bih = Massiccio <strong>di</strong> Bihor (Romania), BM = Massiccio Boemo (Repubblica Ceca),<br />
Ebr = Massiccio dell’Ebro (Spagna), G = Gavrovo (Bulgaria), IM = Massiccio Iberico (Spagna), InsM = Massiccio<br />
Insubrico (Lombar<strong>di</strong>a settentrionale), MC = Massiccio Centrale (Francia), Me = Menderes (Turchia), Mu =<br />
Muzurdan (Turchia), Pl = zona Pelagoniana, Pn = Panormide (Sicilia), Pr = Provenza (Francia), Rh = Rodope<br />
(Bulgaria), RM = Massiccio Renano, SaP = Piattaforma Sahariana, US = Scudo Ucraino.<br />
Figura 9 - Carta paleogeografica semplificata della Tetide centrale durante il Maastrichtiano superiore (69.5-65<br />
<strong>milioni</strong> <strong>di</strong> <strong>anni</strong>), da PHILIP& FLOQUET (2000b), mo<strong>di</strong>ficata e ri<strong>di</strong>segnata. Acronimi, simboli e colori come in figura 9.<br />
Abbreviazioni: AuA = dominio Australpino, BD = Bey Daglari (Turchia), Ca = Calabria, DH = Alto del Donetz, Eb<br />
= Elburz (Iran), FSS = Scudo Fenno-Scan<strong>di</strong>navo, Hb = Bacino <strong>di</strong> Hateg (Romania), Ks = Kirsehir (Turchia), Ibl =<br />
Dominio Ibleo (Sicilia), SP = zona Serbo-Pelagoniana, WD = Daci<strong>di</strong> occidentali (Romania).<br />
15
Figura 10 - Mappa paleogeografica semplificata dell’Oceano Atlantico centrale e della Tetide centro-occidentale <strong>85</strong><br />
<strong>milioni</strong> <strong>di</strong> <strong>anni</strong> <strong>fa</strong>, basata su EBERLI et al (1993), mo<strong>di</strong>ficata e ri<strong>di</strong>segnata. L’asterisco in<strong>di</strong>ca la posizione del <strong>Carso</strong>.<br />
Blu = fondali oceanici (su crosta oceanica); azzurro = mare epicontinentale, su crosta continentale (il mattonato<br />
identifica le piattaforme carbonatiche); giallo ocra = terre emerse. Per permettere una più <strong>fa</strong>cile comprensione sono<br />
riportate a volte le linee <strong>di</strong> costa attuali. Abbreviazioni: A = Piattaforma Carbonatica Apula (Pu<strong>gli</strong>a e Maiella), AC =<br />
Atlantico centrale; ACP = Piattaforma Carbonatica Appenninica, AD = Piattaforma Carbonatica Adriatico-Dinarica,<br />
MO = Oceano del Me<strong>di</strong>terraneo Orientale, PL = Oceano Piemontese-Ligure.<br />
Le zone <strong>di</strong> mare basso che si trovavano ai margini e nel mezzo dell’oceano della Tetide erano per lo più<br />
piattaforme carbonatiche.<br />
Per piattaforma carbonatica si intende una parte piatta della superficie terrestre ricoperta da un mare<br />
basso (generalmente con profon<strong>di</strong>tà inferiore a 50 metri), nella quale si ha l’accumulo <strong>di</strong> se<strong>di</strong>menti carbonatici<br />
(cioè formati da carbonato <strong>di</strong> calcio, CaCO3). Le piattaforme carbonatiche si sviluppano ai margini dei<br />
continenti o <strong>di</strong> isole oceaniche. I se<strong>di</strong>menti carbonatici, che possono essere <strong>fa</strong>nghi, sabbie, ghiaie ecc., derivano<br />
per lo più dalla frantumazione delle parti dure <strong>di</strong> organismi marini (conchi<strong>gli</strong>e <strong>di</strong> molluschi, colonie <strong>di</strong> coralli,<br />
talli <strong>di</strong> alghe calcaree, ecc.). Questi se<strong>di</strong>menti si accumulano in potenti successioni grazie al lento<br />
sprofondamento locale della crosta terrestre e alla continua produzione <strong>di</strong> gusci e altre parti dure da parte de<strong>gli</strong><br />
organismi. Gli accumuli <strong>di</strong> se<strong>di</strong>menti incoerenti si trasformano in rocce per compattazione e cementazione,<br />
originando corpi rocciosi più o meno stratificati.<br />
Le piattaforme carbonatiche non si formano ovunque. Esse sono caratteristiche, anche se non esclusive,<br />
delle zone tropicali e subtropicali della Terra dove la temperatura è costantemente elevata, e si sviluppano<br />
dove l’acqua marina non è inquinata da<strong>gli</strong> apporti <strong>fa</strong>ngosi dei fiumi. Un esempio attuale sono i Bahamas<br />
Banks e le coste del Golfo Persico.<br />
16
Figura 11 - Rappresentazione ideale e schematica (non in scala e vista in sezione verticale) <strong>di</strong> un complesso<br />
piattaforma carbonatica-bacino: 1) se<strong>di</strong>menti del margine della piattaforma (banchi <strong>di</strong> sabbia, sco<strong>gli</strong>era corallina), 2)<br />
se<strong>di</strong>menti della piattaforma interna (<strong>fa</strong>nghi, sabbie bioturbate, canali <strong>di</strong> marea con sabbie e ciottoli, banchi <strong>di</strong><br />
invertebrati, tappeti algali, 3) se<strong>di</strong>menti della piattaforma esterna/pen<strong>di</strong>o (sabbie e brecce bioclastiche; colate e frane<br />
sottomarine), 4) se<strong>di</strong>menti del bacino (<strong>fa</strong>nghi; colate sottomarine, depositi <strong>di</strong> correnti <strong>di</strong> torbida).<br />
Una piattaforma carbonatica è spesso delimitata verso il mare aperto da un margine, una zona <strong>di</strong> mare<br />
basso che <strong>fa</strong> da “spartiacque” tra la piattaforma interna (verso terra) e la zona esterna della piattaforma (cioè<br />
verso il mare aperto) che passa al pen<strong>di</strong>o del bacino marino dove aumenta la pendenza del fondale. Alla fine<br />
del pen<strong>di</strong>o si ha il raccordo con il fondo del bacino marino. <strong>Il</strong> margine può essere costituito da barre sabbiose<br />
o dalla “sco<strong>gli</strong>era” (reef). Quest’ultima nelle piattaforme carbonatiche è chiamata “sco<strong>gli</strong>era organogena”<br />
perchè costituita principalmente da aggregati <strong>di</strong> organismi con strutture rigide (conchi<strong>gli</strong>e dei molluschi,<br />
scheletri dei coralli ecc) cementate tra loro a formare corpi resistenti alle onde. La “sco<strong>gli</strong>era”, che può essere<br />
continua o “a chiazze” (patch-reef), è una zona ricchissima <strong>di</strong> vita, presentando una grande <strong>di</strong>versità biologica<br />
con coralli, alghe calcaree, spugne, molluschi, echinodermi, briozoi, pesci, crostacei, ecc. Attualmente le<br />
sco<strong>gli</strong>ere che formano i margini delle piattaforme carbonatiche sono costituite soprattutto da colonie <strong>di</strong> coralli<br />
e per questo motivo si chiamano “sco<strong>gli</strong>ere coralline”. Non è però il caso <strong>di</strong> molte sco<strong>gli</strong>ere del passato che<br />
non erano formate dai coralli attuali, ma da altri organismi costruttori.<br />
La piattaforma è costituita verso terra da lagune generalmente poco profonde e da vaste piane tidali,<br />
alternativamente emerse o sommerse durante il ciclo delle maree. Se non esiste un margine a proteggere questa<br />
parte interna della piattaforma, le onde provenienti dal mare aperto aumentano l’energia ambientale e non si<br />
formano piane tidali o calme lagune. Zone più o meno ampie della piattaforma rimangono emerse per lunghi<br />
perio<strong>di</strong> (dell’or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> 1.000-100.000 <strong>anni</strong>) a causa delle continue oscillazioni del livello marino e sono<br />
colonizzate da piante e animali terrestri. Verso il margine l’energia ambientale causata dal moto ondoso è più<br />
elevata e si ha l’accumulo <strong>di</strong> se<strong>di</strong>menti grossolani (sabbie, frammenti <strong>di</strong> gusci ecc.). La piattaforma esterna è<br />
caratterizzata dal debole, ma costante, approfon<strong>di</strong>mento dei fondali lungo una superficie più o meno inclinata e<br />
dal grande accumulo <strong>di</strong> se<strong>di</strong>menti grossolani (sabbie, ghiaie, brecce, spesso formate da gusci frantumati <strong>di</strong><br />
organismi) derivati dallo smantellamento della zona <strong>di</strong> margine a causa delle tempeste che provengono dal<br />
mare aperto.<br />
La piattaforma esterna o rampa sfuma nel pen<strong>di</strong>o (o scarpata) che raccorda la piattaforma stessa al bacino,<br />
una depressione della superficie terrestre dove il mare raggiunge centinaia o mi<strong>gli</strong>aia <strong>di</strong> metri <strong>di</strong> profon<strong>di</strong>tà.<br />
Nel bacino generalmente si depositano i se<strong>di</strong>menti franati lungo il pen<strong>di</strong>o e <strong>fa</strong>nghi finissimi. Gli organismi che<br />
vivono nel bacino sono quelli tipici <strong>di</strong> mare aperto.<br />
Solo il 12% delle rocce se<strong>di</strong>mentarie del Pianeta è carbonatico, ha quin<strong>di</strong> avuto origine da se<strong>di</strong>menti<br />
costituiti da carbonato <strong>di</strong> calcio. Mentre nelle Alpi le aspre cime calcaree e dolomitiche sono una cosa comune,<br />
nel resto del mondo sono invece una rarità.<br />
17
Figura 12 - A) Posizione <strong>di</strong> Polazzo nel Friuli-Venezia<br />
Giulia; B) la posizione dei siti A e B alla periferia <strong>di</strong><br />
Polazzo e nei pressi del Cimitero Monumentale <strong>di</strong><br />
Re<strong>di</strong>pu<strong>gli</strong>a; C) le alture <strong>di</strong> Polazzo con la localizzazione dei<br />
siti A e B. <strong>Il</strong> sito A, dove <strong>gli</strong> scavi ufficiali sono iniziati il<br />
22 settembre 1990, si trova a quota 77 s.l.m. nelle<br />
imme<strong>di</strong>ate vicinanze dell’oleodotto transalpino.<br />
18<br />
POLAZZO<br />
<strong>Il</strong> piccolo paese <strong>di</strong> Polazzo si trova nel<br />
Comune <strong>di</strong> Fo<strong>gli</strong>ano-Re<strong>di</strong>pu<strong>gli</strong>a, in provincia<br />
<strong>di</strong> Gorizia, alle pen<strong>di</strong>ci meri<strong>di</strong>onali della<br />
terminazione occidentale del <strong>Carso</strong> e al<br />
margine della pianura isontina (Fig. 12). In<br />
due località, che chiameremo sito A e sito B,<br />
posto alla periferia del paese e non sono molto<br />
<strong>di</strong>stanti dal noto Sacrario <strong>di</strong> Re<strong>di</strong>pu<strong>gli</strong>a, sono<br />
stati scoperti fossili <strong>di</strong> particolare interesse,<br />
l’oggetto <strong>di</strong> questo libro.
LA SCOPERTA DEI FOSSILI DI POLAZZO E STORIA DELLE RICERCHE<br />
La prima segnalazione in letteratura <strong>di</strong> pesci fossili provenienti dalla zona <strong>di</strong> Fo<strong>gli</strong>ano-Re<strong>di</strong>pu<strong>gli</strong>a si deve al<br />
geologo austriaco Guido STACHE (1889). Successivamente, il paleontologo italiano Geremia D’ERASMO<br />
(1952) descrisse una quin<strong>di</strong>cina <strong>di</strong> esemplari rinvenuti casualmente nel 1904 proprio nei pressi <strong>di</strong> Polazzo, ma<br />
- secondo le in<strong>di</strong>cazioni dello stesso D’Erasmo - in località <strong>di</strong>verse dai siti A e B, una posta a nord <strong>di</strong> Polazzo<br />
e l’altra vicino all’attuale stazione ferroviaria <strong>di</strong> Fo<strong>gli</strong>ano-Re<strong>di</strong>pu<strong>gli</strong>a.<br />
Molti <strong>anni</strong> dopo, nei primi <strong>anni</strong> ‘70, i lavori <strong>di</strong> scavo per la posa dei tubi dell’oleodotto transalpino<br />
nell’imme<strong>di</strong>ata periferia del paese, misero alla luce dei livelli contenenti una relativa quantità <strong>di</strong> fossili. Due<br />
pesci rinvenuti in quell’occasione sono stati l’oggetto della tesi <strong>di</strong> laurea <strong>di</strong> Guido GUIDOTTI (1983) presso<br />
l’Università de<strong>gli</strong> Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> Bologna.<br />
Ricerche successive si focalizzarono in questo sito (sito A) particolarmente promettente e situato ad estnord-est<br />
dell’abitato. Una serie <strong>di</strong> campagne <strong>di</strong> scavo autorizzate dalla competente Soprintendenza furono<br />
condotte ne<strong>gli</strong> <strong>anni</strong> 1990-1993 sotto la <strong>di</strong>rezione scientifica del professore Nevio Pu<strong>gli</strong>ese, dell’allora Istituto<br />
<strong>di</strong> Geologia e Paleontologia dell’Università <strong>di</strong> Trieste, in collaborazione con il Museo Carsico Gelogico-<br />
Paleontologico e il Gruppo Speleologico Mon<strong>fa</strong>lconese A.d.F. - Museo Paleontologico Citta<strong>di</strong>no <strong>di</strong><br />
Mon<strong>fa</strong>lcone (Figg. 13-14). Durante queste campagne <strong>di</strong> scavo furono recuperati 726 reperti, attualmente<br />
depositati presso il Museo Paleontologico Citta<strong>di</strong>no, che sono stati oggetto della tesi <strong>di</strong> laurea <strong>di</strong> Davide Rigo<br />
presso il Dipartimento <strong>di</strong> Scienze Geologiche e Ambientali dell’Università <strong>di</strong> Trieste (RIGO, 1998). Un breve<br />
contributo <strong>di</strong>vulgativo sui fossili <strong>di</strong> Polazzo fu pubblicato nel 1990 (ZIMOLO, 1990). Articoli più detta<strong>gli</strong>ati si<br />
trovano nel catalogo della mostra “Pesci fossili Italiani: scoperte e riscoperte” (NARDON, 1990) e nel Field<br />
Guidebook del simposio “Mesozoic fishes: systematics and paleoecology” a cura <strong>di</strong> TINTORI et al. (1993).<br />
In<strong>fa</strong>tti, nell’agosto 1993 si effettuò nel sito A una tappa dell’escursione italiana del simposio <strong>paleontologico</strong><br />
internazionale “Mesozoic fishes: systematics and paleoecology” che si teneva nella Germania meri<strong>di</strong>onale e in<br />
quell’occasione si ribadì la sua potenziale importanza scientifica.<br />
Figura 13 - Lo scavo nel sito A (1991).<br />
19
Figura 14 - Lo scavo nel sito A (1990).<br />
Nel 1996 è iniziata la ricerca in un secondo sito, il sito B, posto in linea d’aria circa 750 metri a sud-ovest<br />
rispetto al sito A (Fig. 12B). Ne<strong>gli</strong> <strong>anni</strong> 1996-2003 <strong>gli</strong> scavi, naturalmente effettuati previa concessione<br />
ministeriale, sono proseguiti in questo sito (Figg. 15-16).<br />
Durante le campagne <strong>di</strong> scavo nel sito B sono stati rinvenuti oltre 1000 reperti, tutti in custo<strong>di</strong>a presso il<br />
Museo Paleontologico Citta<strong>di</strong>no.<br />
I fossili dei siti A e B sono stati oggetto <strong>di</strong> alcune pubblicazioni a carattere generale (RIGO, 1997, 1999;<br />
DALLA VECCHIA & RIGO, 1998; DALLA VECCHIA & MUSCIO, 1999; DALLA VECCHIA et al., 2001) e sono<br />
20
Figura 15 - L’identificazione della sezione fossilifera oggetto <strong>di</strong> scavo nel sito B (1996).<br />
Figura 16 - Sito B, la zona <strong>di</strong> scavo nel 2003.<br />
menzionati nel catalogo dei vertebrati fossili italiani attualmente in stampa a cura del Museo <strong>di</strong> Storia<br />
Naturale <strong>di</strong> Verona.<br />
Nell’estate 2003 i vegetali terrestri dei due siti sono stati stu<strong>di</strong>ati a Mon<strong>fa</strong>lcone dal Dott. Bernard Gomez,<br />
dell’Università <strong>di</strong> Leeds (Inghilterra), e dal Prof. Frédéric Thevenard, dell’Università Claude Bernard <strong>di</strong> Lione<br />
(Francia). I pesci Picnodonti <strong>di</strong> Polazzo sono attualmente oggetto <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o da parte del Prof. Francisco<br />
Poyato-Ariza, Universidad Autónoma <strong>di</strong> Madrid (Spagna).<br />
21
LAGERSTÄTTEN<br />
Quello <strong>di</strong> Polazzo può essere considerato un Lagerstätte. Fossil-Lagerstätte è una parola tedesca che<br />
identifica “corpi se<strong>di</strong>mentari con una non comune quantità <strong>di</strong> informazioni paleontologiche”. In pratica si<br />
tratta <strong>di</strong> corpi rocciosi nei quali si rinvengono resti fossili particolarmente numerosi e/o ben conservati, cioè<br />
importanti e non banali testimonianze <strong>di</strong> organismi vissuti nel passato geologico del pianeta.<br />
I Fossil-Lagerstätten più <strong>fa</strong>mosi e fondamentali per la comprensione dell’evoluzione della vita sulla Terra<br />
sono quelli dove sono fossilizzati anche i tessuti non mineralizzati de<strong>gli</strong> organismi (cioè la pelle, i muscoli, <strong>gli</strong><br />
intestini, organi interni, ma anche pelo, penne, ecc.) e si rinvengono comunemente scheletri articolati <strong>di</strong><br />
vertebrati, <strong>gli</strong> esoscheletri delicati dei crostacei e resti <strong>di</strong> piante. Di solito le parti molli de<strong>gli</strong> organismi sono<br />
<strong>di</strong>strutte dai predatori e dai processi putre<strong>fa</strong>ttivi, mentre <strong>gli</strong> scheletri e <strong>gli</strong> esoscheletri sono vittime dell’azione<br />
dei predatori e vengono pure smembrati dal moto ondoso e dalle correnti.<br />
Questi importanti Fossil-Lagerstätten sono chiamati Konservat-Lagerstätten e si formano quasi<br />
esclusivamente in ambienti acquatici - lacustri o marini - a causa <strong>di</strong> particolari e rare con<strong>di</strong>zioni esistenti al<br />
fondo determinate da <strong>fa</strong>ttori chimico-fisici o biologici critici, come l’assenza <strong>di</strong> ossigeno <strong>di</strong>sciolto, ipersalinità<br />
e/o aci<strong>di</strong>tà delle acque, e lo sviluppo <strong>di</strong> tappeti “algali”.<br />
I Konservat-Lagerstätten sono delle vere e proprie finestre aperte sulla vita del passato che ci consentono<br />
<strong>di</strong> conoscere intere comunità <strong>di</strong> organismi - con la loro <strong>di</strong>versità e <strong>gli</strong> adattamenti particolari - che in altre,<br />
normali con<strong>di</strong>zioni ambientali non si sarebbero conservate. I dati forniti da questi giacimenti ci permettono<br />
anche <strong>di</strong> seguire l’evoluzione <strong>di</strong> importanti gruppi <strong>di</strong> organismi dallo scheletro fragile, per esempio uccelli e<br />
pterosauri, oppure dal corpo non mineralizzato, come vermi e insetti. Sono stati i reperti rinvenuti<br />
recentemente nel Konservat-Lagerstätte del Liaoning (Cina) a rivelarci che alcuni piccoli <strong>di</strong>nosauri del<br />
Cretaceo inferiore avevano protopenne e in certi casi vere e proprie penne come <strong>gli</strong> Uccelli attuali. I resti ossei<br />
<strong>di</strong> <strong>di</strong>nosauro che si rinvengono nei “normali” se<strong>di</strong>menti deposti dai fiumi non presentano mai penne, perchè se<br />
anche ci fossero state non si sarebbero preservate a causa della loro composizione organica.<br />
Le con<strong>di</strong>zioni che hanno consentito la conservazioni dei reperti a Polazzo sono <strong>di</strong>scusse a p. 35.<br />
Figura 17 - Stratificazione regolare ed in<strong>di</strong>sturbata nel Konservat-Lagerstätte cenomaniano <strong>di</strong> en Nammoura in<br />
Libano (foto F.M. Dalla Vecchia).<br />
22
GEOLOGIA DEL CARSO ISONTINO E DEI SITI FOSSILIFERI DI POLAZZO<br />
(con il contributo <strong>di</strong> G. Tunis per quanto riguarda la geologia del <strong>Carso</strong>)<br />
Le rocce che formano il <strong>Carso</strong> hanno una storia geologica particolare che le rende un esempio <strong>di</strong> importante<br />
valore scientifico e <strong>di</strong>dattico. La maggior parte è costituita da carbonati ed è derivata da <strong>fa</strong>nghi, sabbie o se<strong>di</strong>menti<br />
più grossolani depositati in ambiente marino. Tra i 125 e i 50 <strong>milioni</strong> <strong>di</strong> <strong>anni</strong> <strong>fa</strong>, quello che oggi è il <strong>Carso</strong> isontino<br />
era parte <strong>di</strong> una piattaforma carbonatica: la Piattaforma Friulana, parte settentrionale della più vasta Piattaforma<br />
Adriatico-Dinarica o solo Adriatica secondo alcuni autori croati (Fig. 18). Un bacino <strong>di</strong> mare profondo centinaia <strong>di</strong><br />
metri (Bacino Sloveno) si apriva più a nord, un’altro esisteva ad ovest (Bacino Bellunese). Pure nella zona della<br />
Carnia si trovava un mare profondo.<br />
Le rocce costituiscono nel <strong>Carso</strong> isontino sono quin<strong>di</strong> prevalentemente calcari spesso ben stratificati e in minor<br />
quantità dolomie (carbonati con una certa percentuale <strong>di</strong> dolomite, carbonato <strong>di</strong> calcio e magnesio, CaMg[CO3]2).<br />
Queste rocce sono spesso ricche <strong>di</strong> fossili, anche se talvolta <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni così piccole da non poter essere<br />
apprezzati <strong>fa</strong>cilmente ad occhio nudo.<br />
<strong>Il</strong> processo <strong>di</strong> fossilizzazione è un processo selettivo che <strong>fa</strong>vorisce la conservazione delle parti dure e<br />
inorganiche de<strong>gli</strong> organismi morti come, per esempio, le conchi<strong>gli</strong>e che sono costituite per lo più <strong>di</strong> carbonato <strong>di</strong><br />
calcio. Le parti molli, come i muscoli, <strong>gli</strong> organi interni, la pelle ecc. formate da materia organica deperiscono<br />
rapidamente e vengono <strong>di</strong>strutte dai processi putre<strong>fa</strong>ttivi. Inoltre, l’azione dei predatori e dei necro<strong>fa</strong>gi porta alla<br />
<strong>di</strong>sarticolazione totale delle carcasse. Questo è il motivo per cui nei calcari del <strong>Carso</strong> <strong>di</strong> tutta una ricca associazione<br />
animale e vegetale originaria si rinvengono soprattutto le resistenti conchi<strong>gli</strong>e dei molluschi. Accumuli <strong>di</strong> resti <strong>di</strong><br />
ru<strong>di</strong>ste (bivalvi caratteristici che vedremo me<strong>gli</strong>o più avanti), si originavano in acque relativamente basse <strong>di</strong> zone<br />
“aperte”, non lagunari, della piattaforma.<br />
I geologi definiscono col nome <strong>di</strong> “unità litostratigrafica” un corpo roccioso con caratteristiche litologiche<br />
uniformi (cioè formato da rocce dello stesso tipo oppure da simili alternanze <strong>di</strong> rocce <strong>di</strong>verse), originato in uno<br />
stesso ambiente <strong>di</strong> se<strong>di</strong>mentazione (un bacino marino, un lago, una piana <strong>di</strong> marea, ecc.) e <strong>di</strong> estensione tale da<br />
poter essere riportato su <strong>di</strong> una carta geologica. Unità litostratigrafiche <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne gerarchico decrescente sono il<br />
Gruppo, la Formazione e il Membro.<br />
Le rocce che hanno fornito i fossili <strong>di</strong> Polazzo si trovano nell'unità litostratigrafica denominata da MARTINIS<br />
(1962) "Calcari <strong>di</strong> M.te S. Michele" che rappresenta un intervallo <strong>di</strong> tempo enorme: dal Cenomaniano all’Eocene<br />
me<strong>di</strong>o. Secondo TENTOR, TUNIS e VENTURINI (1994), che usano le unità litostratigrafiche “storiche” definite molto<br />
prima del 1962 e <strong>di</strong> utilizzo più pratico anche perchè rappresentano intervalli <strong>di</strong> tempo relativamente ridotti, i siti A<br />
e B appartengono ai “Calcari <strong>di</strong> Aurisina” noti anche come “Calcari a ru<strong>di</strong>ste” (Turoniano-Senoniano inferiore,<br />
circa 93-71,3 <strong>milioni</strong> <strong>di</strong> <strong>anni</strong> <strong>fa</strong>) i quali sono compresi fra la Formazione <strong>di</strong> Monrupino, più antica poichè risale al<br />
Cenomaniano, e il Gruppo Liburnico costituito da<strong>gli</strong> "Strati <strong>di</strong> Vreme" del Maastrichtiano [71-65 <strong>milioni</strong> <strong>di</strong> <strong>anni</strong> <strong>fa</strong>]<br />
e da<strong>gli</strong> "Strati <strong>di</strong> Cosina" del Paleocene inferiore (65-61 <strong>milioni</strong> <strong>di</strong> <strong>anni</strong> <strong>fa</strong>) (Figg. 19-21).<br />
L’ambiente dei “Calcari <strong>di</strong> Aurisina” durante l’intervallo ?Turoniano superiore - Coniaciano è generalmente<br />
riferibile ad una piattaforma carbonatica interna relativamente “chiusa”. Invece nel Santoniano c’era una più<br />
efficiente circolazione marina e la piattaforma era aperta, cioè priva <strong>di</strong> un margine biocostruito. Per questo motivo<br />
anche i settori più interni erano esposti alla perio<strong>di</strong>ca azione <strong>di</strong> onde e <strong>di</strong> tempeste. Si ebbe una grande<br />
proliferazione <strong>di</strong> ru<strong>di</strong>ste che con la frantumazione e polverizzazione delle loro spesse conchi<strong>gli</strong>e hanno prodotto<br />
gran<strong>di</strong> accumuli <strong>di</strong> se<strong>di</strong>menti bioclastici carbonatici.<br />
Nel Santoniano si verificò una importante <strong>fa</strong>se tettonica e alla fine importanti eventi <strong>di</strong> espansione e ritiro del<br />
mare, prodromi dei cambiamenti paleogeografici occorsi nella zona del <strong>Carso</strong> nel successivo Senoniano superiore.<br />
TENTOR, TUNIS e VENTURINI (1994) ipotizzano un collegamento tra questa <strong>fa</strong>se tettonica e la formazione <strong>di</strong> piccole<br />
depressioni all’interno della piattaforma quale è quella nella quale si sono probabilmente depositati i se<strong>di</strong>menti che<br />
hanno originato le rocce fossilifere dei siti <strong>di</strong> Polazzo.<br />
Figura 18 (pagina seguente) - Sopra: Le piattaforme carbonatiche periadriatiche e i relativi bacini marini profon<strong>di</strong><br />
come affiorano nella geografia attuale e come si suppone siano <strong>di</strong>sposti nel sottosuolo. A= mare profondo, bacino; B =<br />
mare profondo, altopiano sottomarino; C = mare basso, piattaforme carbonatiche. Basato su CATI et al. (1989) e<br />
ZAPPATERRA (1990), mo<strong>di</strong>ficato.<br />
Sotto: La Piattaforma Carbonatica Friulana, terminazione settentrionale della Piattaforma Carbonatica Adriatico-<br />
Dinarica. L’asterisco in<strong>di</strong>ca la posizione <strong>di</strong> Polazzo.<br />
23
Figura 19 - Mappa geologica schematica del <strong>Carso</strong> Isontino e <strong>di</strong> parte <strong>di</strong> quello Triestino e Sloveno (da TENTOR et al.,<br />
1994). Legenda: 1 = Paleocene-Eocene inferiore (65-50 <strong>milioni</strong> <strong>di</strong> <strong>anni</strong> <strong>fa</strong>), 2 = Senoniano-Turoniano (93,5-65 <strong>milioni</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>anni</strong> <strong>fa</strong>), 3 = Cenomaniano (98,9-93,5 <strong>milioni</strong> <strong>di</strong> <strong>anni</strong> <strong>fa</strong>), 4 = Cretaceo inferiore (circa 140-98,9 <strong>milioni</strong> <strong>di</strong> <strong>anni</strong> <strong>fa</strong>),<br />
5 = <strong>fa</strong><strong>gli</strong>e subverticali (i corpi <strong>di</strong> roccia si muovono uno rispetto all’altro lungo piani verticali), 6 = <strong>fa</strong><strong>gli</strong>e ad angolo<br />
variabile, prevalentemente inverse (il piano <strong>di</strong> movimento è inclinato e il blocco superiore si muove su quello<br />
inferiore), 7 = confine <strong>di</strong> Stato.<br />
Nel sito A la sezione rocciosa oggetto <strong>di</strong> scavo stratigrafico - cioè to<strong>gli</strong>endo uno strato alla volta partendo<br />
dall’alto (Fig. 22) - comprende 12 strati. Essa si trova vicino ad una <strong>fa</strong><strong>gli</strong>a che ha impe<strong>di</strong>to la prosecuzione de<strong>gli</strong><br />
scavi in quanto la stratificazione risultava fortemente <strong>di</strong>sturbata. Una colonna stratigrafica schematica dello scavo è<br />
mostrata nella figura 23. Secondo TINTORI et al. (1993) <strong>gli</strong> strati fossiliferi consistono in due metri <strong>di</strong> calcari<br />
laminati, forse stromatolitici, che coprono e sono ricoperti da calcari con ru<strong>di</strong>ste. In<strong>fa</strong>tti, la maggior parte dei calcari<br />
grigi che affiorano attorno al sito sono ricchi <strong>di</strong> resti frammentari <strong>di</strong> ru<strong>di</strong>ste. Nei livelli fossiliferi le testimonianze <strong>di</strong><br />
organismi bentonici (che vivevano sul fondale) sono rari e probabilmente non sono mai autoctoni, cioè sono stati<br />
trasportati lì dopo la morte da correnti o dal moto ondoso.<br />
<strong>Il</strong> sito B consiste in un limitato affioramento <strong>di</strong> calcari ben stratificati, localmente fittamente laminati, con<br />
lamine generalmente <strong>di</strong> spessore submillimetrico (Figg. 24-26) e con frequenti ondulazioni, legate probabilmente a<br />
fenomeni <strong>di</strong> carico (dovuto al peso dei se<strong>di</strong>menti sovrastanti) o <strong>di</strong> microslumps (cioè <strong>di</strong> scivolamento e<br />
deformazione del se<strong>di</strong>mento lungo un pen<strong>di</strong>o) (Fig. 26 ve<strong>di</strong> anche p. 36). <strong>Il</strong> colore delle rocce è solitamente chiaro,<br />
fra il grigio, il nocciola e il verdastro, ma si notano locali colorazioni rossastre a testimonianza <strong>di</strong> fenomeni <strong>di</strong><br />
ossidazione come anche tinte più scure legate alla maggiore presenza <strong>di</strong> sostanza organica. La granulometria molto<br />
fine è tale da permettere in alcuni casi la perfetta conservazione dei detta<strong>gli</strong> ne<strong>gli</strong> esemplari fossili, soprattutto per<br />
quanto riguarda i resti ossei.<br />
La sezione stratigrafica oggetto <strong>di</strong> scavo, spessa circa un metro, è stata sud<strong>di</strong>visa in intervalli e sottointervalli<br />
coincidenti per lo più con giunti <strong>di</strong> strato e leggeri cambi nelle caratteristiche litologiche (Fig. 27. Gli intervalli<br />
(strati) principali sono sei (A-F). Lo strato A è composto a sua volta da quattro parti (sottointervalli) e lo strato B<br />
da sei. Lo strato C è costituito da una parte superiore sud<strong>di</strong>visa in quattro sottointervalli e da una parte inferiore<br />
massiccia. Lo strato D è stato <strong>di</strong>viso in tre sottointervalli, E in due. Lo strato F, <strong>di</strong>viso in due parti, è laminato<br />
ma non è fissile (cioè non si “sfo<strong>gli</strong>a” in lamine) e finora ha fornito soltanto due reperti.<br />
25
Figura 20 - Successione stratigrafica ideale tra Iamiano e il Villaggio del Pescatore (Duino). Da TENTOR et al (1994).<br />
26
Figura 21 - Successione stratigrafica del Vallone a nord del Lago <strong>di</strong> Doberdò tra Micoli e Gabria. Da TENTOR et al<br />
(1994).<br />
27
Figura 22 - La sezione oggetto <strong>di</strong> scavo nel sito A (1992).<br />
28
Figura 23 - La sezione stratigrafica del sito A, con la numerazione de<strong>gli</strong> strati e alcuni reperti in essi ritrovati.<br />
La colonnina <strong>di</strong> sinistra è tratta da Tintori et al. (1993).<br />
29
Figura 24 - La sezione oggetto <strong>di</strong> scavo nel sito B.<br />
30
Figura 25 - La fitta laminazione in<strong>di</strong>sturbata nei livelli fossiliferi della sezione stratigrafica del sito B, strati A e B.<br />
Figura 26 - Sezione lucida <strong>di</strong> un campione della sezione stratigrafica del sito B, strato C. La laminazione è stata<br />
<strong>di</strong>sturbata dalla rimobilizzazione del se<strong>di</strong>mento, forse innescata da terremoti.<br />
31
Figura 27 - La sezione stratigrafica del sito B, con la sud<strong>di</strong>visione in intervalli (strati) e sottointervalli.<br />
Per trovare i fossili si devono mettere alla luce ed aprire i calcari laminati. Quin<strong>di</strong>, partendo dall’alto,<br />
bisogna “sfo<strong>gli</strong>are” accuratamente <strong>gli</strong> strati me<strong>di</strong>ante martelli, scalpelli e lame, controllando se sulla superficie<br />
così esposta si osservano resti fossili (Fig. 28). Questi ultimi spiccano sulla roccia grigia per il loro colore<br />
nero, marrone o rossiccio. I fossili nel sito B non sono molto frequenti, quin<strong>di</strong> bisogna esporre pazientemente<br />
molte superfici aprendo <strong>gli</strong> strati <strong>di</strong> roccia fino alle più sottili lamine (Fig. 29).<br />
Una caratteristica <strong>di</strong> questi fossili è che quando <strong>gli</strong> strati si aprono, i resti scheletrici rimangono interamente<br />
da una parte, su una delle due lastre, mentre nell’altra rimane solo l’impronta. Generalmente, quando si trova<br />
un pesce aprendo una lastra <strong>di</strong> calcare, lo scheletro si <strong>di</strong>vide secondo un piano sagittale, a metà, rimanendo in<br />
parte su <strong>di</strong> una lastra in parte sull’altra.<br />
Una volta trovato, il reperto viene accuratamente imballato per il trasporto in laboratorio, ma prima si deve<br />
scrivere in un angolo della lastra un numero provvisorio <strong>di</strong> registro, la data <strong>di</strong> rinvenimento e, soprattutto, la<br />
sigla dello strato dove è stato rinvenuto.<br />
32
Figura 28 - Gli strati calcarei sono accuratamente staccati dalla sezione stratigrafica e sfo<strong>gli</strong>ati.<br />
Figura 29 - Le lastre vengono subito aperte per verificare la presenza dell’eventuale contenuto fossilifero.<br />
33
I MICROFOSSILI E L’ETÀ DEI SITI DI POLAZZO<br />
(con il contributo <strong>di</strong> Nevio Pu<strong>gli</strong>ese per il sito A e <strong>di</strong> Sandro Venturini per il sito B)<br />
La Micropaleontologia è la <strong>di</strong>sciplina scientifica che stu<strong>di</strong>a i microfossili. Gli organismi <strong>di</strong> piccole<br />
<strong>di</strong>mensioni contenuti nelle rocce sono stati <strong>di</strong> grande utilità nella datazione dei siti <strong>di</strong> Polazzo e hanno fornito<br />
informazioni sull’ambiente in cui si sono formate le rocce stesse. L’identificazione e lo stu<strong>di</strong>o dei microfossili<br />
<strong>di</strong> Polazzosono stati effettuati secondo una particolare metodologia. I campioni <strong>di</strong> roccia sono stati ta<strong>gli</strong>ati a<br />
fette sottili, le quali sono state poi incollate su <strong>di</strong> un supporto <strong>di</strong> vetro quin<strong>di</strong> ridotte ad uno spessore <strong>di</strong> frazioni<br />
<strong>di</strong> millimetro. A questo punto con un apposito microscopio è possibile vedere per trasparenza la fettina <strong>di</strong><br />
roccia, che assume il nome <strong>di</strong> “sezione sottile”. Nel caso dei campioni <strong>di</strong> Polazzo è possibile osservare<br />
numerosi fossili microscopici, tra i quali Foraminiferi e Alghe Calcaree. I Foraminiferi sono organismi<br />
costituiti da un’unica cellula protetta da un guscio agglutinante o calcareo. A Polazzo si rinvengono<br />
esclusivamente forme che vivono in corrispondenza del fondale marino e sono denominate “bentoniche”; i<br />
foraminiferi che flottano liberamente nella massa d’acqua trasportati dalle correnti sono invece chiamati<br />
“planctonici”. I loro gusci nelle sezioni sottile appaiono come strutture <strong>di</strong>vise in più cellette o camere (si veda<br />
la figura 31). Le alghe calcaree mostrano i loro talli costituiti da una o più cellule.<br />
Essendo vissute per intervalli <strong>di</strong> tempo geologico relativamente limitati prima <strong>di</strong> estinguersi o <strong>di</strong> evolversi,<br />
alcune specie <strong>di</strong> foraminiferi bentonici e <strong>di</strong> alghe calcaree sono particolarmente utili per la datazione delle<br />
rocce cretacee.<br />
Figura 30 - Età dei siti <strong>di</strong> Polazzo all’interno del periodo Cretaceo dell’era Mesozoica.<br />
D’ERASMO (1952) e MARTINIS (1962) avevano attribuito i pesci <strong>di</strong> Fo<strong>gli</strong>ano e Re<strong>di</strong>pu<strong>gli</strong>a al Cenomaniano<br />
(95 <strong>milioni</strong> <strong>di</strong> <strong>anni</strong> <strong>fa</strong>) sulla base del confronto con quelli rinvenuti presso Comeno (ora Komen) sul <strong>Carso</strong><br />
sloveno. Alcuni microfossili vissuti in intervalli <strong>di</strong> tempo geologico relativamente limitati, scoperti e descritti<br />
successivamente, sono stati molto utili per datare i calcari dei siti A e B. NARDON (1990) e TINTORI et al.<br />
(1993) hanno stu<strong>di</strong>ato la successione stratigrafica in corrispondenza del sito A in<strong>di</strong>viduando un abbondante<br />
contenuto in foraminiferi e alghe calcaree nei calcari sottostanti e sovrastanti i livelli a pesci. Tra questi si è<br />
rivelata molto utile l’identificazione <strong>di</strong> Montcharmontia<br />
34
Figura 31 - Foraminiferi. A) Ataxofragmii<strong>di</strong>; B) Montcharmontia apenninica; C) Pseudocyclammina sphaeroidea;<br />
D) Accor<strong>di</strong>ella sp.; E) Minouxia sp.; F) Scandonea samnitica.<br />
apenninica (foraminifero; Fig. 31B), Accor<strong>di</strong>ella conica (foraminifero) e Sgrossoella parthenopeia (alga)<br />
rispettivamente al <strong>di</strong> sotto e al <strong>di</strong> sopra dei livelli a pesci i quali sono poveri <strong>di</strong> microfossili. Questi<br />
rinvenimenti hanno consentito <strong>di</strong> attribuire il sito A al Senoniano inferiore, Coniaciano-Santoniano (circa <strong>85</strong><br />
<strong>milioni</strong> <strong>di</strong> <strong>anni</strong> <strong>fa</strong>; Fig. 30).<br />
I livelli a pesci fossili hanno fornito foraminiferi, alghe calcaree e ostraco<strong>di</strong>. Tra le alghe vi sono<br />
Aeolisaccus kotori e Thaumatoporella parvovesiculifera. La rimanente associazione è costituita soprattutto<br />
35
da altri foraminiferi: Textularidae, Nubecularidae, Miliolidae, piccoli rotaliformi Ophtalmi<strong>di</strong>idae, Minouxia<br />
sp., Pseudocyclammina, ?Rotorbinella scarsellai, ?Sabau<strong>di</strong>a sp. e ?Nezzazatinella sp.<br />
La sezione <strong>di</strong> scavo del sito B è risultata povera dal punto <strong>di</strong> vista micro<strong>paleontologico</strong>. Non è stata però<br />
ancora eseguita una ricerca del nannoplancton calcareo (piccolissime parti calcaree <strong>di</strong> microrganismi marini<br />
planctonici) e dei palinomorfi (i pollini fossili delle piante), entrambi molto utili per datare le rocce.<br />
Foraminiferi rotaliformi <strong>di</strong> minute <strong>di</strong>mensioni sono presenti in quasi tutti <strong>gli</strong> strati del sito B. Piccoli<br />
Ataxofragmii<strong>di</strong> (Fig. 31A) sono stati trovati nei sottointervalli B5-6 e C1 e Montcharmontia sp. è stata<br />
rinvenuta in D3 e forse C1. Nella sezione sono inoltre presenti foraminiferi Oftalmi<strong>di</strong>i<strong>di</strong>, ostraco<strong>di</strong>, alghe<br />
(Thaumatoporella) e calcisferule.<br />
E’ stata effettuata una campionatura della sezione imme<strong>di</strong>atamente sottostante a quella oggetto <strong>di</strong> scavo,<br />
affiorante in una vicina cava abbandonata. Questa sezione contiene l’alga calcarea Sgrossoella sp. e i<br />
foraminiferi Montcharmontia apenninica (Fig. 31B), Pseudocyclammina sphaeroidea (Fig. 31C),<br />
Accor<strong>di</strong>ella sp. (Fig. 31D), Minouxia sp. (Fig. 31E) e Scandonea samnitica (Fig. 31F) in<strong>di</strong>cativi del<br />
Senoniano inferiore (Fig. 30).<br />
Una attribuzione al Santoniano è resa plausibile dal <strong>fa</strong>tto che nel <strong>Carso</strong> isontino questo piano (il “piano” è<br />
lo spessore <strong>di</strong> roccia corrispondente all’intervallo <strong>di</strong> tempo chiamato “età”) rappresenta la maggior parte dello<br />
spessore del Senoniano (S. Venturini, comunicazione personale).<br />
Altri foraminiferi presenti in questa sezione, ma banali, sono rotaliformi, Miliolidae, Ophtalmi<strong>di</strong>idae, e<br />
Ataxophragmiidae. Insieme ai foraminiferi si trovano anche Ostraco<strong>di</strong> e probabili Caracee. I primi sono<br />
piccoli crostacei muniti <strong>di</strong> un carapace calcareo bivalve. Le caracee sono alghe che vivono soprattutto nelle<br />
acque dolci o, più raramente, salmastre e presentano caratteristiche strutture riproduttive globose o fusiformi<br />
mineralizzate chiamate girogoniti.<br />
Da questa prima analisi delle sezioni sottili, il sito B sembra grossomodo coevo al sito A. I dati non<br />
consentono <strong>di</strong> <strong>di</strong>re con certezza se i due siti A e B siano aperti sulla stessa successione <strong>di</strong> rocce, separate solo<br />
topograficamente sul piano orizzontale (quin<strong>di</strong> se si sono originati nello stesso momento e in due zone<br />
leggermente <strong>di</strong>verse dello stesso ambiente) oppure se rappresentano due momenti leggermente <strong>di</strong>versi dal punto<br />
<strong>di</strong> vista temporale (cioè che uno è più antico dell’altro). Come vedremo sotto, <strong>gli</strong> organismi sono in parte<br />
<strong>di</strong>versi nei due siti, ma questo non permette ancora <strong>di</strong> sce<strong>gli</strong>ere una ipotesi piuttosto dell’altra.<br />
36
L’AMBIENTE DI DEPOSIZIONE<br />
(con il contributo <strong>di</strong> Nevio Pu<strong>gli</strong>ese per il sito A e <strong>di</strong> Sandro Venturini per il sito B)<br />
Come abbiamo visto, i calcari <strong>di</strong> Polazzo si sono originati da se<strong>di</strong>menti deposti in ambienti <strong>di</strong> piattaforma<br />
carbonatica (Fig. 32). La deposizione dei se<strong>di</strong>menti del sito A avvenne probabilmente in una laguna poco<br />
profonda che a volte evolveva verso con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> stratificazione delle acque o <strong>di</strong> piana <strong>di</strong> marea. Non si può<br />
escludere che si siano verificati anche episo<strong>di</strong> <strong>di</strong> emersione. I calcari a ru<strong>di</strong>ste presenti nell’area prossima alla<br />
zona <strong>di</strong> scavo testimoniano invece ambienti a più elevato idro<strong>di</strong>namismo.<br />
Figura 32 - Vista aerea <strong>di</strong> una piattaforma carbonatica attuale, le Bahamas, in cui prevalgono le piane <strong>di</strong> marea (foto<br />
<strong>di</strong> D. Masetti).<br />
La sezione della cava vicina al sito B sembra rappresentare soprattutto un ambiente lagunare con alghe<br />
calcaree e ru<strong>di</strong>ste. Alla sommità della sezione <strong>di</strong>venta prevalente un ambiente <strong>di</strong> piana tidale con oscillazioni<br />
salmastre e brevi emersioni.<br />
La sezione del sito B, in continuità con la parte superiore della cava, rappresenta probabilmente la<br />
deposizione in una piana tidale, ma con influssi <strong>di</strong>fferenziati, per esempio se<strong>di</strong>menti apportati da tempeste,<br />
con<strong>di</strong>zioni salmastre e possibili emersioni.<br />
I livelli fossiliferi sono costituiti da lamine millimetriche <strong>di</strong> calcari a grana fine e finissima; al microscopio<br />
si osservano solo minutissimi organismi, rappresentati solitamente da foraminiferi spesso indeterminabili per le<br />
ridottissime <strong>di</strong>mensioni, comparativamente molto inferiori rispetto a quelle delle forme rinvenute nella cava. Le<br />
lamine hanno talora un aspetto gradato, con granuli più grossolani alla base e più fini alla sommità. Queste<br />
<strong>fa</strong>cies sono generalmente legate ad un trasporto dei clasti in sospensione ed a un successivo rapido deposito.<br />
Nel contesto ambientale prima accennato, tali lamine possono essere interpretate come il risultato <strong>di</strong> tempeste<br />
che hanno “spazzato” la circostante piattaforma, ridepositando i minuti clasti calcarei in zone interne<br />
leggermente più profonde che intrappolavano i se<strong>di</strong>menti stessi. A questo tipo <strong>di</strong> lamine si alternano spesso<br />
livelletti millimetrici <strong>di</strong> “<strong>fa</strong>nghi” calcarei finissimi privi <strong>di</strong> microfossili (micriti) - che possono rappresentare <strong>gli</strong><br />
intervalli <strong>di</strong> se<strong>di</strong>mentazione “normale” per decantazione o precipitazione da acque calde e sature - e strutture<br />
<strong>di</strong> tipo stromatolitico (probabili tappeti <strong>di</strong> mucillaggini formate da alghe unicellulari). Le alghe unicellulari<br />
sembrano essere state <strong>gli</strong> unici organismi in grado <strong>di</strong> proliferare normalmente in questo ambiente, mentre le<br />
37
altre forme erano occasionali o alloctone (trasportate). Nel detta<strong>gli</strong>o, quin<strong>di</strong>, i livelli con i fossili eccezionali<br />
del sito B testimoniano un ambiente s<strong>fa</strong>vorevole al normale sviluppo <strong>di</strong> <strong>fa</strong>une autoctone (che vivevano sul<br />
posto), con un tasso <strong>di</strong> se<strong>di</strong>mentazione piuttosto elevato grazie a continui apporti da parte delle tempeste<br />
intrappolati in una depressione poco profonda interna alla piattaforma. La locale frequenza <strong>di</strong> <strong>fa</strong>cies pseudostromatolitiche<br />
può suggerire anche episo<strong>di</strong> <strong>di</strong> parziale riempimento della depressione con formazione <strong>di</strong> <strong>fa</strong>cies<br />
analoghe a quelle tipiche delle piane <strong>di</strong> marea. La depressione si era probabilmente originata per motivi<br />
tettonici. Una possibile testimonianza <strong>di</strong> eventi tettonici è registrata in alcuni microslump, deformazioni del<br />
se<strong>di</strong>mento dovute alla sua rimobilizzazione lungo un piano debolmente inclinato. Talora queste deformazioni<br />
paiono essersi verificate quando il se<strong>di</strong>mento era già parzialmente litificato, quin<strong>di</strong> non sono semplici<br />
scivolamenti <strong>di</strong> un materiale plastico lungo un pen<strong>di</strong>o sottomarino, né una <strong>fa</strong>tturazione quando la roccia era<br />
già cementata e sepolta in profon<strong>di</strong>tà. In<strong>fa</strong>tti, in questi intervalli si notano sistemi <strong>di</strong> microfratturazione nella<br />
zona deformata e frammenti a spigoli vivi nel nucleo della piega, immersi nella matrice calcarea fine che ha<br />
riempito <strong>gli</strong> interstizi. Gli elementi descritti <strong>fa</strong>nno supporre una deformazione “forzata” da un rapido aumento<br />
del gra<strong>di</strong>ente del pen<strong>di</strong>o (per basculamento tettonico), oppure da una componente <strong>di</strong> sforzo orizzontale che si è<br />
bruscamente sovrapposta al normale carico dei se<strong>di</strong>menti. La seconda ipotesi è strettamente legata ad eventi<br />
sismici (terremoti) e questi tipi <strong>di</strong> depositi vengono usualmente denominati “sismici”. Tali intervalli hanno<br />
verosimilmente registrato importanti eventi della storia del sito fossilifero, che testimoniano la presenza <strong>di</strong><br />
<strong>fa</strong><strong>gli</strong>e, terremoti e solchi all’interno dell’apparente uniformità della piattaforma carbonatica. In altri campioni<br />
sono state osservate strutture <strong>di</strong> flui<strong>di</strong>ficazione (forti ondulazioni verticali delle lamine) che in pianta<br />
presentano un assetto ad “alveare”; anche in questo caso si possono chiamare in causa eventi sismici. Infine,<br />
l’intensa fratturazione presente su un lato del sito in<strong>di</strong>ca l’esistenza <strong>di</strong> un <strong>di</strong>sturbo tettonico, possibile<br />
riattivazione <strong>di</strong> un’antica <strong>fa</strong><strong>gli</strong>a che bordava un fianco della piccola depressione.<br />
Non si è investigato abbastanza per identificare quali siano stati i <strong>fa</strong>ttori eccezionali che hanno permesso la<br />
fossilizzazione, spesso ottimale, de<strong>gli</strong> scheletri <strong>di</strong> pesci nelle rocce <strong>di</strong> Polazzo. <strong>Il</strong> perfetto stato <strong>di</strong><br />
conservazione dei reperti, caratteristico dei Konservat-Lagerstätten, si deve probabilmente alla finissima<br />
grana del se<strong>di</strong>mento. La fitta laminazione piano-parallela e in<strong>di</strong>sturbata suggerisce l’assenza <strong>di</strong> un’in<strong>fa</strong>una che<br />
potesse amalgamare il se<strong>di</strong>mento. E’ pure in<strong>di</strong>cativa <strong>di</strong> un ambiente <strong>di</strong> deposizione a bassissima energia<br />
ambientale. La rarità sulla superficie <strong>di</strong> strato <strong>di</strong> tracce <strong>di</strong> spostamento e alimentazione e la quasi totale<br />
mancanza <strong>di</strong> conchi<strong>gli</strong>e, gusci o altre strutture rigide <strong>di</strong> invertebrati testimoniano una scarsità <strong>di</strong> <strong>fa</strong>una<br />
bentonica in generale. Tutto questo è in<strong>di</strong>cativo <strong>di</strong> un ambiente <strong>di</strong> deposizione s<strong>fa</strong>vorevole alla vita che<br />
potrebbe essere stato causato da con<strong>di</strong>zioni particolari come carenza <strong>di</strong> ossigeno <strong>di</strong>sciolto nell’acqua, elevata o<br />
altamente oscillante salinità, aci<strong>di</strong>tà delle acque. Tali con<strong>di</strong>zioni s<strong>fa</strong>vorevoli, al momento non definibili in<br />
detta<strong>gli</strong>o, allontanando predatori e necro<strong>fa</strong>gi sono state una in<strong>di</strong>spensabile concausa della fossilizzazione dei<br />
cadaveri dei pesci.<br />
Probabilmente elementi <strong>fa</strong>vorevoli all’accumulo e preservazione dei resti <strong>di</strong> organismi sono stati la<br />
presenza <strong>di</strong> una depressione nell’ambito della piattaforma e il rapido seppellimento operato durante eventi<br />
metereologici particolari, quali tempeste ed uragani, relativamente frequenti anche alla scala della vita umana e<br />
comunissimi a scala geologica.<br />
E’ auspicabile che l’aspetto della modalità <strong>di</strong> conservazione venga sviluppato in futuro con adeguati stu<strong>di</strong>.<br />
38
I FOSSILI DI POLAZZO<br />
Le ru<strong>di</strong>ste<br />
Le ru<strong>di</strong>ste furono un gruppo <strong>di</strong> molluschi Bivalvi che si <strong>di</strong>fferenziano da<strong>gli</strong> altri bivalvi per la forma<br />
bizzarra della loro conchi<strong>gli</strong>a. Erano in pratica delle “vongole” aberranti che vivevano in banchi come le<br />
attuali ostriche, cementate ad oggetti duri o affossate nella sabbia. Nella zona <strong>di</strong> Polazzo, come in altre parti<br />
del <strong>Carso</strong>, le ru<strong>di</strong>ste sono i fossili più comuni.<br />
Le ru<strong>di</strong>ste apparvero nel Giurassico superiore (155-160 <strong>milioni</strong> <strong>di</strong> <strong>anni</strong> <strong>fa</strong>) con la primitiva <strong>fa</strong>mi<strong>gli</strong>a<br />
Diceratidae ed ebbero uno sviluppo esplosivo a partire da circa 120 <strong>milioni</strong> <strong>di</strong> <strong>anni</strong> <strong>fa</strong>. Nel Cretaceo si<br />
verificarono episo<strong>di</strong> <strong>di</strong> grande <strong>di</strong>versificazione <strong>di</strong> specie e <strong>di</strong> ampia <strong>di</strong>stribuzione geografica alternati a<br />
momenti <strong>di</strong> crisi con riduzione drastica della loro presenza. Tale evoluzione irregolare è dovuta alle<br />
oscillazioni climatiche e ambientali globali alle quali questi bivalvi erano particolarmente sensibili. Le ru<strong>di</strong>ste<br />
si estinsero completamente 65 <strong>milioni</strong> <strong>di</strong> <strong>anni</strong> <strong>fa</strong>, come i <strong>di</strong>nosauri. Dato l’intervallo <strong>di</strong> tempo relativamente<br />
ristretto (geologicamente parlando) durante il quale vissero, esse permettono <strong>di</strong> datare le rocce in cui sono<br />
presenti.<br />
La conchi<strong>gli</strong>a delle ru<strong>di</strong>ste era composta da due spesse valve, ciascuna <strong>di</strong> forma marcatamente <strong>di</strong>versa<br />
dall’altra (Fig. 33). La valva inferiore <strong>di</strong> solito era cementata al substrato o a valve <strong>di</strong> altri in<strong>di</strong>vidui, oppure<br />
era affossata nel se<strong>di</strong>mento. La valva superiore veniva sollevata per <strong>fa</strong>re passare l’acqua per la respirazione e<br />
l’alimentazione. Le ru<strong>di</strong>ste, in<strong>fa</strong>tti filtravano l’acqua aspirandola tramite un sifone dentro la conchi<strong>gli</strong>a e<br />
attraverso il corpo, trattenendo le particelle organiche in sospensione <strong>di</strong> cui si nutrivano. La conchi<strong>gli</strong>a è<br />
generalmente molto spessa e presenta strutture caratteristiche che permettono <strong>di</strong> <strong>di</strong>stinguere le <strong>di</strong>verse <strong>fa</strong>mi<strong>gli</strong>e<br />
<strong>di</strong> ru<strong>di</strong>ste.<br />
Figura 33 - La conchi<strong>gli</strong>a bivalve <strong>di</strong> una ru<strong>di</strong>sta Ra<strong>di</strong>olitide, mostrata in sezione longitu<strong>di</strong>nale e con le due valve<br />
leggermente staccate l’una dall’altra (sinistra). Dalla valva superiore, a forma <strong>di</strong> tappo, si proiettano due lunghi<br />
“denti” che si articolano in corrispondenti fossette nella valva inferiore, conica e più grande. A destra, la sezione<br />
trasversale della valva inferiore. In grigio è in<strong>di</strong>cata la spessa conchi<strong>gli</strong>a, mentre in grigio-azzurro è evidenziata la<br />
cavità che conteneva le parti molli.<br />
Le ru<strong>di</strong>ste della Tetide centrale sono state raggruppate in sei <strong>fa</strong>mi<strong>gli</strong>e principali, che si <strong>di</strong>stinguono<br />
<strong>fa</strong>cilmente per la <strong>di</strong>versa forma delle valve e per altre caratteristiche strutture osservabili nella conchi<strong>gli</strong>a.<br />
39
Diceratidae (160-140 <strong>milioni</strong> <strong>di</strong> <strong>anni</strong> <strong>fa</strong>):<br />
avevano una conchi<strong>gli</strong>a spirogira e <strong>di</strong> forma<br />
piuttosto variabile; da questa <strong>fa</strong>mi<strong>gli</strong>a sono<br />
derivate tutte le altre ru<strong>di</strong>ste (figura da CESTARI<br />
& SARTORIO, 1995, ri<strong>di</strong>segnata).<br />
Caprotinidae (150-65 <strong>milioni</strong> <strong>di</strong> <strong>anni</strong> <strong>fa</strong>): la valva<br />
inferiore non è spiralata, ma è generalmente conica,<br />
mentre quella superiore era conicospirolata o<br />
raramente opercolare (cioè a forma <strong>di</strong> “tappo”)<br />
(figura da Cestari & Sartorio 1995, ri<strong>di</strong>segnata).<br />
40<br />
Requienidae (150-65 <strong>milioni</strong> <strong>di</strong> <strong>anni</strong> <strong>fa</strong>):<br />
avevano conchi<strong>gli</strong>a spiralata, da elicoidale a<br />
trocoide, con la valva inferiore più grande <strong>di</strong><br />
quella superiore (figura da CESTARI & SARTORIO,<br />
1995, ri<strong>di</strong>segnata).<br />
Caprinidae (122-65 <strong>milioni</strong> <strong>di</strong> <strong>anni</strong> <strong>fa</strong>): la valva<br />
inferiore è conica e più piccola della valva<br />
superiore. Quest’ultima è spiralata come un corno<br />
<strong>di</strong> capra e da ciò deriva il nome della <strong>fa</strong>mi<strong>gli</strong>a. Lo<br />
spesso guscio era caratteristicamente perforato da<br />
canali longitu<strong>di</strong>nali (figura da CESTARI &<br />
SARTORIO, 1995, ri<strong>di</strong>segnata
Ra<strong>di</strong>olitidae (118-65 <strong>milioni</strong> <strong>di</strong> <strong>anni</strong> <strong>fa</strong>): la<br />
valva inferiore è conica o cilindrica e appare<br />
come una pila <strong>di</strong> bicchieri posti uno dentro<br />
l’altro. <strong>Il</strong> guscio ha una struttura tipicamente<br />
“cellulare” (“reticolata”). La valva superiore è<br />
molto più piccola e opercolare (a forma <strong>di</strong><br />
“tappo”) (da CESTARI & SARTORIO, 1995,<br />
ri<strong>di</strong>segnata).<br />
Le ru<strong>di</strong>ste non erano presenti in tutto il Mondo durante l’era Mesozoica. Esse popolarono soprattutto le<br />
piattaforme carbonatiche della Tetide, da<strong>gli</strong> attuali Caraibi sino all’Oceano Pacifico. La Tetide era posta per<br />
tutta la sua lunghezza ai Tropici e quin<strong>di</strong> era un mare caldo, <strong>fa</strong>vorevole all’instaurarsi delle piattaforme<br />
carbonatiche e alla formazione delle sco<strong>gli</strong>ere organogene.<br />
Le ru<strong>di</strong>ste vivevano aggregate in “ciuffi” e “cespu<strong>gli</strong>”, talvolta formando delle vere e proprie collinette<br />
(Fig. 34), nelle acque calde e ossigenate delle piattaforme carbonatiche. Si possono trovare nei margini<br />
biocostruiti della piattaforma, ma anche nelle lagune interne come in piattaforme non protette dall’influenza<br />
del mare aperto. Spesso gran<strong>di</strong> agglomerati si sviluppavano lungo la rampa che dal margine <strong>di</strong> piattaforma<br />
portava al bacino profondo. Talvolta si rinvengono ancora in posizione <strong>di</strong> vita, con i “ciuffi” <strong>di</strong>retti verso<br />
l’alto, ma più spesso si hanno corpi rocciosi formati dall’accumulo caotico delle loro conchi<strong>gli</strong>e, più o meno<br />
intere, trasportate dalle correnti e dal moto ondoso.<br />
Nella nostra regione questi bizzarri bivalvi si trovano in provincia <strong>di</strong> Pordenone sull’Altipiano del<br />
Cansi<strong>gli</strong>o, sul M. Cavallo, in Val Colvera, nei pressi <strong>di</strong> Barcis e in Val Caltea, a nord <strong>di</strong> Meduno, sul M.<br />
Ciaurlec e nei <strong>di</strong>ntorni <strong>di</strong> Pra<strong>di</strong>s. In provincia <strong>di</strong> U<strong>di</strong>ne li abbiamo sul M. Berna<strong>di</strong>a e zone limitrofe nonché<br />
rimaneggiate nei depositi <strong>di</strong> frana sottomarina nel Flysch eocenico (per esempio, a Vernasso). In provincia <strong>di</strong><br />
Gorizia si trovano sul colle <strong>di</strong> Medea e sul <strong>Carso</strong>; in quella <strong>di</strong> Trieste sono abbondanti sempre sul <strong>Carso</strong>, per<br />
esempio ad Aurisina e a Malchina.<br />
41<br />
Hippuritidae (90-65 <strong>milioni</strong> <strong>di</strong> <strong>anni</strong> <strong>fa</strong>): l’ultimo<br />
prodotto dell’evoluzione delle ru<strong>di</strong>ste. La valva<br />
inferiore è allungata (poteva raggiungere i 50 cm <strong>di</strong><br />
altezza), conica o cilindrica. L’interno della valva è<br />
caratterizzato da una cresta e due pilastri<br />
longitu<strong>di</strong>nali. La valva superiore è molto più<br />
piccola, opercolare (a forma <strong>di</strong> “tappo”) e tutta<br />
perforata da sottili canali e pori (figura da CESTARI<br />
& SARTORIO, 1995, ri<strong>di</strong>segnata).
Figura 34 - Aggregazione a “cespu<strong>gli</strong>o” (o collinetta, mound) <strong>di</strong> ru<strong>di</strong>ste Ra<strong>di</strong>oliti<strong>di</strong>.<br />
Ri<strong>di</strong>segnato da CESTARI & SARTORIO (1995).<br />
Le ru<strong>di</strong>ste sono i fossili più comuni nelle rocce calcaree grigie circostanti i siti A e B. Queste rocce<br />
rappresentano ambienti <strong>di</strong> deposizione <strong>di</strong>versi da quelli dei siti stessi, probabilmente <strong>di</strong> piattaforma interna ma<br />
con buona ossigenazione e circolazione delle acque. Si tratta soprattutto <strong>di</strong> Ra<strong>di</strong>oliti<strong>di</strong> (Figg. 35-36).<br />
Le ru<strong>di</strong>ste sono invece del tutto assenti nel sito B e solo pochi esemplari frammentari sono stati trovati nel sito<br />
A, come vedremo più avanti.<br />
Durante l’intervallo Coniaciano superiore - Santoniano si verificò una grande <strong>di</strong>fferenziazione e <strong>di</strong>ffusione<br />
delle ru<strong>di</strong>ste nelle piattaforme carbonatiche periadriatiche, riguardante soprattutto i Ra<strong>di</strong>oliti<strong>di</strong> (generi<br />
Ra<strong>di</strong>olites, Sauvagesia, Durania, Bira<strong>di</strong>olites e Bournonia) e <strong>gli</strong> Ippuriti<strong>di</strong> (generi Hippurites e Vaccinites)<br />
(CESTARI & SARTORIO, 1995). Questi ultimi mostrano affinità con quelli ritrovati in terreni coevi nelle Alpi<br />
Settentrionali (Austria).<br />
Figura 35 - Ra<strong>di</strong>oliti<strong>di</strong> nei calcari grigi che circondano il sito A. Quella che si vede è la parte superiore della valva<br />
conica, esposta come sezione trasversale dall’erosione e corrosione del calcare.<br />
42
Figura 36 - Ra<strong>di</strong>oliti<strong>di</strong> nei calcari grigi che circondano il sito A. Frammento <strong>di</strong> calcare<br />
con valve intere e frammentarie esposte in sezione trasversale dall’erosione e corrosione.<br />
43
I fossili dei siti A e B: note generali<br />
Nelle collezioni del Museo risultano depositati in totale 1801 reperti provenienti dai siti A, B, e da<br />
affioramenti vicini al sito A. 726 reperti sono il frutto de<strong>gli</strong> scavi nel sito A (<strong>anni</strong> 1990-93), 48 sono stati<br />
trovati prima del 1990 e 1027 sono stati estratti nel sito B (Fig. 37A).<br />
L’associazione fossile del sito A è costituita soprattutto da pesci ossei (RIGO, 1998). I loro resti scheletrici<br />
sono spesso <strong>di</strong>sarticolati o frammentari, ma in alcuni casi sono perfettamente integri e mostrano tutti i detta<strong>gli</strong><br />
anatomici. Sono presenti pesci abitatori delle sco<strong>gli</strong>ere come i picnodonti, predatori dal corpo massiccio<br />
(Enchodus e Parachanos) o allungato come le o<strong>di</strong>erne agu<strong>gli</strong>e (Rhynchodercetis) e <strong>gli</strong> spinosi Bericiformi, ma<br />
la maggioranza dei reperti è costituita da piccoli pesci teleostei <strong>di</strong> pochi centimetri <strong>di</strong> lunghezza <strong>di</strong> incerta<br />
collocazione sistematica. Di notevole importanza è un esemplare incompleto <strong>di</strong> quella che potrebbe essere la<br />
più antica anguilla rinvenuta in Italia. I resti <strong>di</strong> rettili sono costituiti da ossa e placche del carapace <strong>di</strong> cheloni<br />
(tartarughe) e da un dente <strong>di</strong> coccodrillo. Gli invertebrati sono particolarmente rari: alcuni piccoli gamberi e<br />
qualche resto frammentario <strong>di</strong> ru<strong>di</strong>sta. Sono relativamente frequenti i vegetali terrestri.<br />
L'associazione <strong>fa</strong>unistica ritrovata nel sito B appare in parte <strong>di</strong>fferente da quella proveniente dal sito A<br />
(Fig. 37C-D). Anche in questo caso la maggior parte dei reperti sono riferibili a pesci, sia frammentari (da<br />
singoli denti a parti considerevoli del corpo) sia interi. I resti <strong>di</strong> pesci in<strong>fa</strong>tti rappresentano l’80% dei reperti<br />
totali (oltre l’<strong>85</strong>% considerando anche i reperti identificati con dubbio come pesci). I resti del caratteristico<br />
genere Rhynchodercetis (con esemplari <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni <strong>di</strong>verse, anche estremamente piccole) rappresentano il<br />
9% dei reperti totali e quelli dei picnodonti circa l’8,5%.<br />
Non sono stati trovati resti <strong>di</strong> cheloni. Un dente appartiene probabilmente a un piccolo coccodrillomorfo ed<br />
è al momento l’unica testimonianza <strong>di</strong> rettili nel sito. Rispetto al sito A, i pesci hanno <strong>di</strong>mensioni<br />
comparativamente minori e <strong>gli</strong> scheletri molto raramente sono <strong>di</strong>sarticolati. I gran<strong>di</strong> pesci sono molto rari e le<br />
<strong>di</strong>mensioni me<strong>di</strong>e <strong>di</strong> picnodonti e Rhynchodercetis sono inferiori a quelle riscontrate nel sito A. Vi sono alcune<br />
rare forme <strong>di</strong> teleostei non ancora determinate dal punto <strong>di</strong> vista sistematico che non sono state trovate nel sito<br />
A. Vi sono pure icnofossili <strong>di</strong> invertebrati, assenti nell’altro sito.<br />
Anche considerando i reperti dubbi, i vegetali rappresentano meno del 3% del totale e si tratta per lo più <strong>di</strong><br />
fo<strong>gli</strong>e o rametti mal conservati.<br />
I fossili sono stati rinvenuti in tutti <strong>gli</strong> strati del sito B e non presentano una concentrazione in livelli<br />
particolarmente ricchi. Alcuni strati però, soprattutto lo strato D, hanno fornito un numero maggiore <strong>di</strong><br />
esemplari rispetto a<strong>gli</strong> altri (Fig. 37B).<br />
44
Figura 37 – La frequenza dei reperti nel siti A e B. A) Numero <strong>di</strong> reperti rinvenuti nelle singole annate <strong>di</strong> scavo. B) Numero<br />
<strong>di</strong> reperti rinvenuti nei singoli strati del sito B. Legenda: Cop. = copertura (frammenti rocciosi nel suolo imme<strong>di</strong>atamente sopra<br />
la sezione stratigrafica). C) Numero <strong>di</strong> reperti rinvenuti nel sito B, secondo categorie sistematiche sulla base del registro <strong>di</strong><br />
prima nota (determinazioni provvisorie). 1 = pesci ossei indeterminati, 2 = Rhynchodercetis, 3 = Picnodonti, 4 =“Enchodus”,<br />
5 = coccodrillomorfi, 6 = coproliti, 7 = resti indeterminati, 8 = piante, 9) tracce fossili. D) Numero <strong>di</strong> reperti rinvenuti<br />
complessivamente nei due siti, secondo categorie sistematiche e per lo più sulla base del registro <strong>di</strong> prima nota (determinazioni<br />
provvisorie). 1 = pesci ossei indeterminati, 2 = Rhynchodercetis, 3 = Picnodonti, 4 = “Parachanos”, 5 = “Enchodus”, 6 =<br />
Anguilliformes, 7 = resti <strong>di</strong> cheloni, 8 = coccodrillomorfi, 9 = coproliti, 10 = resti indeterminati, 11 = piante, 12 = ru<strong>di</strong>ste, 13<br />
= crostacei decapo<strong>di</strong>, 14 = altri invertebrati, 15 = tracce fossili.<br />
45
Piante<br />
(con il contributo <strong>di</strong> Frédéric Thevenard e Bernard Gomez)<br />
Sono stati rinvenuti poco meno <strong>di</strong> 200 resti <strong>di</strong> vegetali terrestri, quasi tutti provenienti dal sito A.<br />
Le piante sono spesso conservate solo come impronte, senza tracce dell’originale sostanza organica. In alcuni<br />
casi le impronte sono coperte da ossido <strong>di</strong> ferro, <strong>di</strong> colore giallo o rossiccio e aspetto pulverulento. Talvolta la<br />
sostanza organica originale è in parte conservata, anche se molto compressa.<br />
La maggior parte delle piante (75%) è costituita da conifere. I resti della peculiare conifera Frenelopsis,<br />
appartenente alla <strong>fa</strong>mi<strong>gli</strong>a estinta Cheirolepi<strong>di</strong>aceae, rappresentano circa il 45% de<strong>gli</strong> esemplari <strong>di</strong> conifere <strong>di</strong><br />
Polazzo. In precedenza i resti <strong>di</strong> questa pianta, tutti rinvenuti nel sito A, erano stati identificati come ottocoralli<br />
(TINTORI et al., 1993) o alghe brune (RIGO, 1998).<br />
Figura 38 - Frenelopsis sp., esemplare 11350. Sito A.<br />
46
Figura 39 - Frenelopsis sp., esemplare 11353a. Sito A.<br />
Anche se la morfologia e la <strong>di</strong>sposizione dei rami fo<strong>gli</strong>ari <strong>di</strong> Frenelopsis è ben conosciuta, non è ancora<br />
chiaro se tutte le specie <strong>di</strong> questo genere avessero l’aspetto <strong>di</strong> cespu<strong>gli</strong>, <strong>di</strong> veri e propri alberi o entrambi.<br />
A Polazzo Frenelopsis è rappresentata solo da assi vegetativi, anche se vi sono esemplari piuttosto gran<strong>di</strong><br />
e più volte ramificati (Figg. 38-40). Gli assi vegetativi consistono in interno<strong>di</strong> cilindrici con fo<strong>gli</strong>e ricoprenti<br />
probabilmente <strong>di</strong>sposte in verticilli <strong>di</strong> tre (Fig. 40, soprattutto nella parte alta). Queste piante avevano quin<strong>di</strong><br />
fusti sud<strong>di</strong>visi in articoli, fotosintetici ed apparentemente succulenti (come le attuali piante grasse) e fo<strong>gli</strong>e<br />
piccole. Una parte centrale più spessa e “ali” laterali trasparenti sono chiaramente visibili in parecchi<br />
esemplari (Fig. 40).<br />
Oggi la determinazione delle <strong>di</strong>verse specie si basa sull’esame al microscopio a luce trasmessa ed a quello<br />
elettronico (SEM) della struttura microscopica della cuticola, uno strato <strong>di</strong> sostanza dall’aspetto <strong>di</strong> cera<br />
prodotto dalla maggior parte delle piante e deposto sulla superficie <strong>di</strong> fusti e fo<strong>gli</strong>e per assicurare protezione<br />
contro tutti i tipi <strong>di</strong> aggressione esterna (per esempio, da parte <strong>di</strong> batteri, funghi, luce solare,<br />
47
Figura 40 - Frenelopsis sp., esemplare 11367. Sito A.<br />
48
49<br />
Figura 41 – A) Brachiphyllum sp.,<br />
esemplare 2791; B) Brachiphyllum tipo 2,<br />
esemplare 11379; C) Brachiphyllum tipo 2,<br />
esemplare 11380; D) Brachiphyllum tipo 2,<br />
esemplare 6242. Tutti dal sito A. E)<br />
Probabile Brachiphyllum tipo 2, esemplare<br />
13472, sito B.
ecc.). Su questa base sono state finora <strong>di</strong>stinte 16 specie <strong>di</strong> Frenelopsis, 11 delle quali si rinvengono<br />
nell’attuale Europa (GOMEZ et al., 2002a, b) dove Frenelopsis alata è probabilmente la specie più comune.<br />
Solo pochissimi frammenti <strong>di</strong> cuticola sono conservati ne<strong>gli</strong> esemplari <strong>di</strong> Polazzo, ma sfortunatamente sono<br />
troppo piccoli per lo stu<strong>di</strong>o.<br />
Frenelopsis è un genere esclusivamente Cretaceo ed aveva una ampia <strong>di</strong>stribuzione nelle terre<br />
Laurasiatiche. In<strong>fa</strong>tti, è stato trovato in USA (Maryland e Virginia), Spagna, Portogallo, Francia, Germania,<br />
Boemia, Polonia, Ucraina, Tagikistan, Cina orientale e Giappone. L’unica segnalazione nel Gondwana<br />
proviene dal Cretaceo inferiore del Sudan. Le <strong>di</strong>fferenti specie si erano adattate a vivere in ambienti <strong>di</strong>versi, da<br />
quello lacustre continentale alle palu<strong>di</strong> salmastre costiere. Erano in ogni caso particolarmente adattate a<br />
superare perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> siccità; vivevano quin<strong>di</strong> in climi almeno stagionalmente ari<strong>di</strong> grazie a<strong>gli</strong> adattamenti<br />
morfologici e cuticolari.<br />
Le altre conifere costituiscono circa il 30% delle piante <strong>di</strong> Polazzo. L’assenza della cuticola non consente<br />
una determinazione sicura. Inoltre, persino nelle conifere viventi la morfologia esterna è molto simile in specie,<br />
generi e <strong>fa</strong>mi<strong>gli</strong>e <strong>di</strong>verse e le fo<strong>gli</strong>e possono <strong>di</strong>fferenziarsi all’interno dello stesso in<strong>di</strong>viduo mostrando quello<br />
che <strong>gli</strong> scienziati chiamano “elevato polimorfismo”. Abbiamo stabilito una <strong>di</strong>stinzione <strong>di</strong> almeno cinque forme<br />
<strong>di</strong>verse <strong>di</strong> germo<strong>gli</strong> e ramoscelli. Tali forme assomi<strong>gli</strong>ano molto a quelle rinvenute in calcari del Coniaciano-<br />
Santoniano della ex Cava Italcementi <strong>di</strong> Vernasso, vicino a Cividale del Friuli (U<strong>di</strong>ne) e attribuiti, tra l’altro,<br />
ai generi viventi Sequoia e Araucaria (BOZZI, 1888, 1891). Tuttavia, seguendo il Co<strong>di</strong>ce Internazionale <strong>di</strong><br />
Nomenclatura Botanica che raccomanda <strong>di</strong> non usare nomi <strong>di</strong> generi viventi come Sequoia per in<strong>di</strong>care forme<br />
fossili prive de<strong>gli</strong> organi riproduttivi o resti <strong>di</strong> cuticola, identifichiamo le conifere <strong>di</strong> Polazzo come<br />
Brachyphyllum sp. (Fig. 41A), Brachyphyllum tipo 2 (Figg. 41B-D), Cunninghamites cf. elegans (Fig. 42),<br />
una forma tipo Pagiophyllum (Fig. 43A) e cf. Sphenolepis (Fig. 43B).<br />
Sono stati ritrovati anche alcuni coni mal conservati, per<br />
esempio un cono sferico e ancora attaccato al ramo del tipo<br />
Pagiophyllum (Fig. 43A) simile a quello delle Taxo<strong>di</strong>aceae, e un<br />
cono isolato probabilmente femminile (Fig. 43C).<br />
Fo<strong>gli</strong>e con una lamina senza alcuna venatura evidente che si<br />
restringe in modo simile ad un picciolo (Fig. 44A) rappresentano<br />
circa il 10% dei reperti vegetali. L’esemplare <strong>di</strong> figura 44B, con<br />
le fo<strong>gli</strong>e ancora attaccate al rachide, sembrerebbe appartenere allo<br />
stesso tipo <strong>di</strong> pianta. Queste fo<strong>gli</strong>e potrebbero essere riferibili alle<br />
Ginkgoales, che hanno venature molto sottili all’interno della<br />
lamina fo<strong>gli</strong>are e sono comuni nelle flore del Cretaceo me<strong>di</strong>o (si<br />
veda, per esempio, KVACEK, 1999; GOMEZ et al., 2000),<br />
piuttosto che alle Angiosperme Dicotiledoni le quali presentano <strong>di</strong><br />
solito almeno una spessa nervatura me<strong>di</strong>ana (Fig. 44C).<br />
Le Angiosperme (le piante con i fiori, quelle più comuni oggi)<br />
sono molto rare a Polazzo (costituiscono meno del 2% dei reperti)<br />
e sono rappresentate da un frammento <strong>di</strong> apice fo<strong>gli</strong>are (Fig. 44C)<br />
e da una fo<strong>gli</strong>a lobata (Fig. 44D). Gli or<strong>di</strong>ni superiori <strong>di</strong> venature<br />
sono mal conservati o assenti.<br />
Un certo numero <strong>di</strong> reperti rimangono indeterminati (Fig. 45).<br />
Figura 42 - Cunninghamites cf. elegans,<br />
esemplare 6244. Sito A.<br />
La bassa percentuale <strong>di</strong> Angiosperme <strong>di</strong>stingue l’associazione<br />
<strong>di</strong> Polazzo dalle altre grossomodo contemporanee nelle quali le piante con i fiori sono dominanti sia come<br />
abbondanza sia come <strong>di</strong>versità. Questo ha probabilmente una natura paleogeografica o paleoclimatica, legata<br />
all’isolamento della piattaforma carbonatica e alla sua posizione nella <strong>fa</strong>scia tropicale del pianeta.<br />
Le <strong>di</strong>mensioni e lo stato <strong>di</strong> frammentazione e <strong>di</strong> conservazione de<strong>gli</strong> esemplari ci consentono <strong>di</strong> formulare<br />
qualche ipotesi circa le modalità <strong>di</strong> formazione dell’associazione vegetale fossile. I resti <strong>di</strong><br />
50
51<br />
Figura 43 – A) Forma tipo Pagiophyllum,<br />
esemplare 11329; B) cf. Sphenolepis,<br />
esemplare 4306; C) cono del tipo<br />
Pagiophyllum, esemplare 2789. Tutti <strong>gli</strong><br />
esemplari provengono dal sito A.
Figura 44 - Probabili Ginkoales. A)<br />
esemplare 11258, sito A; B) esemplare<br />
11351, sito A. C) Fo<strong>gli</strong>a <strong>di</strong> angiosperma<br />
<strong>di</strong>cotiledone, esemplare 11713, sito B; D)<br />
fo<strong>gli</strong>a <strong>di</strong> angiosperma, esemplare 11289,<br />
sito A.<br />
52
Figura 45 – Vegetali incertae se<strong>di</strong>s. A): esemplare 1383, forse<br />
Cunninghamites. B): esemplare 11352. Entrambi provengono<br />
dal sito A.<br />
Frenelopsis, almeno quelli <strong>di</strong> maggiori <strong>di</strong>mensioni, crescevano molto vicino alla zona <strong>di</strong> deposizione e furono<br />
strappati dall’azione <strong>di</strong> fenomeni atmosferici violenti come tempeste o uragani, e trasportati dal vento. Erano<br />
ancora ver<strong>di</strong>, cioè non <strong>di</strong>sseccati, quando si depositarono e furono coperti dal se<strong>di</strong>mento. In<strong>fa</strong>tti, Frenelopsis<br />
era <strong>fa</strong>cilmente <strong>di</strong>sarticolata una volta <strong>di</strong>sseccata e quando veniva trasportata per una lunga <strong>di</strong>stanza (GOMEZ<br />
et al., 2001). Questa osservazione è valida anche per il resto delle conifere, nelle quali i rami fo<strong>gli</strong>ari muoiono<br />
e quin<strong>di</strong> si staccano regolarmente dalle piante durante la loro vita (per<strong>di</strong>te fisiologiche), ma il vento può<br />
aumentare questi <strong>di</strong>stacchi e strappare i rami fo<strong>gli</strong>ari ancora ver<strong>di</strong> (per<strong>di</strong>te traumatiche).<br />
53
Vertebrati: i Rettili<br />
I Rettili sono rappresentati da ossa e piastre del carapace <strong>di</strong> cheloni (tartarughe) e da un paio <strong>di</strong> denti <strong>di</strong><br />
coccodrillomorfi.<br />
Una quin<strong>di</strong>cina <strong>di</strong> reperti riferibili a tartarughe provengono per lo più da<strong>gli</strong> strati 5 e 6 del sito A (RIGO,<br />
1998). In ogni caso si tratta <strong>di</strong> resti altamente <strong>di</strong>sarticolati: frammenti <strong>di</strong> carapace (Fig. 46A), singole ossa<br />
de<strong>gli</strong> arti (omero, <strong>fa</strong>langi) e/o dei cinti (coracoi<strong>di</strong>, scapole; Figg. 46B, 47A) e singole vertebre isolate (Fig.<br />
47B).<br />
Figura 46 – Cheloni. A) Parte <strong>di</strong> un arto anteriore (omero) e del carapace (piastra), esemplare 11398.<br />
B) Cinto scapolare incompleto; esemplare 11395. Entrambi <strong>gli</strong> esemplari provengono dal sito A.<br />
54
Figura 47 – Cheloni. A) Resti sparsi tra i quali si riconoscono una vertebra, parti <strong>di</strong> arti ed elementi dei cinti<br />
scapolari; esemplare 11396. B) Certebra cervicale isolata; esemplare 11389. Entrambi <strong>gli</strong> esemplari provengono dal<br />
sito A.<br />
Un dente conico e molto consumato è stato identificato come dente <strong>di</strong> “coccodrillo” indeterminato (RIGO,<br />
1998) (Fig. 48).<br />
<strong>Il</strong> dente <strong>di</strong> rettile trovato durante lo scavo 1997 nel sito B è una corona isolata alta 12,6 mm e con carene<br />
mesiale e <strong>di</strong>stale denticolate (Fig. 49). <strong>Il</strong> dente è triangolare, leggermente ricurvo e solo debolmente compresso<br />
linguo-labialmente. Verso la base della corona la carena mesiale si sposta sul lato linguale, come nei denti del<br />
<strong>di</strong>nosauro teropode Dromaeosaurus. Questo dente potrebbe essere riferibile a Doratodon (Angela Buscalioni,<br />
comunicazione personale), un piccolo coccodrillomorfo del Cretaceo superiore caratterizzato da una dentatura<br />
che ricorda quella dei <strong>di</strong>nosauri teropo<strong>di</strong>. Doratodon è uno dei pochi coccodrillomorfi del Cretaceo europeo<br />
con denti a margini denticolati (zifodonti) ed è stato trovato nel Campaniano inferiore in Austria e nel<br />
Maastrichtiano in Spagna, Transilvania e Crimea (A. Buscalioni e Zoltan Csiki, comunicazioni personali).<br />
55
Figura 48 - Dente <strong>di</strong> coccodrillomorfo, esemplare 11303. Sito A.<br />
Figura 49 - Dente probabilmente attribuibile al coccodrillomorfo<br />
zifodonte Doratodon; esemplare 11720. Sito B, sottointervallo B6.<br />
56
Vertebrati: i Pesci<br />
Cenni <strong>di</strong> sistematica dei Pesci<br />
Quelli che nel linguaggio comune sono chiamati pesci appartengono in realtà a classi separate e <strong>di</strong>stinte <strong>di</strong><br />
vertebrati acquatici. Nel periodo Cretaceo, come oggi, le classi presenti erano due: Condritti, i pesci che<br />
possiedono uno scheletro cartilagineo, e Osteitti, i pesci con lo scheletro ossificato e muniti <strong>di</strong> vescica<br />
natatoria. Questi ultimi sono comunemente chiamati “pesci ossei”. I primi includono <strong>gli</strong> “squali” (Selacimorfi),<br />
le razze e i pesci sega (Batidoimorfi o Batoidei) e le chimere (Oloce<strong>fa</strong>li), i secon<strong>di</strong> tutti <strong>gli</strong> altri pesci. Gli<br />
Osteitti si sud<strong>di</strong>vidono in Sarcotterigi (Crossotterigi e Dipnoi) ed Attinotterigi (“Condrostei” e Neotterigi)<br />
che si <strong>di</strong>stinguono per la <strong>di</strong>versa struttura delle pinne. I “Condrostei” furono comuni soprattutto nel Permiano<br />
e nel Triassico. Nel Cretaceo erano già meno frequenti e oggi sono molto rari, rappresentati da pochissime<br />
forme la più nota delle quali è lo Storione (Acipenser sturio). I Neotterigi si <strong>di</strong>vidono in alcuni or<strong>di</strong>ni primitivi<br />
(tra i quali vi sono i Picnodontiformi, comuni a Polazzo) e nella Divisione Teleostei. I pesci moderni<br />
appartengono in maggioranza al gruppo evoluto dei Teleostei, rappresentato oggi da più <strong>di</strong> 20.000 specie. La<br />
maggior parte dei Teleostei moderni (dal pesce persico alla cernia e dallo sgombro al pesce palla) appartiene<br />
alla serie Percomorfi della Sotto<strong>di</strong>visione Euteleostei. All’interno dei Percomorfi, i Perciformi, con circa 7.800<br />
specie sud<strong>di</strong>vise in 150 Fami<strong>gli</strong>e, è attualmente il più grande e <strong>di</strong>versificato or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> Vertebrati. I Percomorfi<br />
insieme ad altri gruppi minori per numero <strong>di</strong> specie (Paracantotterigi ecc.) costituiscono <strong>gli</strong> Acantomorfi, pesci<br />
che si <strong>di</strong>stinguono dalle forme più primitive per la presenza <strong>di</strong> robusti raggi spinosi nella parte anteriore delle<br />
pinne dorsali e pelviche.<br />
Figura 50- Schema dei rapporti filogenetici dei pesci ossei rinvenuti a Polazzo (basato in parte su GAYET et al., 2003)<br />
L’associazione ittica<br />
La maggior parte dei pesci <strong>di</strong> Polazzo necessita <strong>di</strong> un detta<strong>gli</strong>ato stu<strong>di</strong>o specialistico che stabilisca la reale<br />
<strong>di</strong>versità sistematica dell’ittio<strong>fa</strong>una, cioè che identifichi le varie, specie, generi, <strong>fa</strong>mi<strong>gli</strong>e ecc. presenti e il loro<br />
significato paleoecologico ed evolutivo. Alcune forme sono comunque <strong>fa</strong>cilmente identificabili anche da chi<br />
non è uno specialista <strong>di</strong> pesci mesozoici.<br />
Non sono mai stati trovati resti <strong>di</strong> Condritti - squali e razze - nemmeno singoli denti isolati, quin<strong>di</strong> a<br />
Polazzo si hanno solo pesci ossei. La maggior parte <strong>di</strong> essi è rappresentata da molti in<strong>di</strong>vidui <strong>di</strong> poche forme <strong>di</strong><br />
57
piccole <strong>di</strong>mensioni. Nel sito B i resti più frequenti identificati senza dubbi appartengono al caratteristico<br />
Rhynchodercetis e ai picnodonti.<br />
PYCNODONTIFORMES (Picnodonti)<br />
I Picnodonti furono comuni abitanti delle piattaforme carbonatiche dalla fine del Triassico (215 <strong>milioni</strong> <strong>di</strong><br />
<strong>anni</strong> <strong>fa</strong>) all’inizio dell’Eocene (50 <strong>milioni</strong> <strong>di</strong> <strong>anni</strong> <strong>fa</strong>). Avevano un corpo piatto lateralmente ed ovale, come<br />
quello delle o<strong>di</strong>erne orate (Figg. 51, 54). Come queste avevano batterie <strong>di</strong> robusti denti piatti per triturare le<br />
parti dure de<strong>gli</strong> organismi <strong>di</strong> cui si nutrivano (Figg. 52-53). I centri delle loro vertebre non sono ossificati.<br />
A Polazzo si trovano in entrambi i siti e <strong>di</strong> solito sono rappresentati da in<strong>di</strong>vidui <strong>di</strong> piccole <strong>di</strong>mensioni,<br />
lunghi 6-15 centimetri quando interi. Esemplari <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni decisamente maggiori sono stati trovati solo nel<br />
sito A, ma si tratta <strong>di</strong> resti scheletrici del tutto <strong>di</strong>sarticolati (Fig. 52).<br />
Curiosa è la presenza nel sito B <strong>di</strong> denti <strong>fa</strong>ringei isolati, che in un primo momento, date le piccolissime<br />
<strong>di</strong>mensioni, non erano stati riconosciuti come tali.<br />
I reperti del sito B, spesso completi e in buono stato <strong>di</strong> articolazione scheletrica, appartengono forse al<br />
genere Ocleodus o Proscinetes (POYATO-ARIZA & WENZ, 2002; Francisco Poyato-Ariza, comunicazione<br />
personale), non al genere Coelodus come è spesso riportato in letteratura (per esempio, in NARDON, 1990,<br />
TINTORI et al., 1993, RIGO, 1998). Coelodus è un genere che è stato recentemente ri<strong>di</strong>mensionato in modo da<br />
includere solo i picnodonti del Cenomaniano <strong>di</strong> Comeno/Komen nel <strong>Carso</strong> Sloveno (POYATO-ARIZA & WENZ,<br />
2002).<br />
Figura 51 - Picnodonte in buono stato <strong>di</strong> articolazione; esemplare 11333. Sito A, strato 8. Si notino nella bocca le<br />
batterie <strong>di</strong> denti trituranti.<br />
58
Figura 52 - Resti dentigeri spleniali (man<strong>di</strong>bolari) <strong>di</strong>sarticolati <strong>di</strong> un grande picnodonte.<br />
Sito A, strato 4.<br />
Figura 53 - Dentatura vomerina (palatale) <strong>di</strong> un grande picnodonte, esemplare 10<strong>85</strong>6. Sito A, strato 6.<br />
59
Figura 54 - Piccoli picnodonti dal sito B, A), esemplare 12268 (sottointervallo D2), B) esemplare 12214<br />
(sottointervallo E2), C) esemplare 13464 (sottointervallo B3).<br />
60
ANGUILLIFORMES<br />
Un unico esemplare proveniente dal sito A è probabilmente riferibile ad un’anguilla. Ha un corpo<br />
serpentiforme privo <strong>di</strong> sca<strong>gli</strong>e evidenti, lunghe pinne dorsale e anale e sembra mancare delle pinne pelviche<br />
(Fig. 55). Purtroppo non è conservata né la testa, importante per la sistematica. Si tratterebbe del più antico<br />
anguilliforme rinvenuto in Italia. I primi anguilliformi apparvero circa 95 <strong>milioni</strong> <strong>di</strong> <strong>anni</strong> <strong>fa</strong> e nelle associazioni<br />
ittiche del Cenomaniano in Libano sono già molto <strong>di</strong>versificati.<br />
Figura 55 - L’unico anguilliforme trovato a Polazzo, esemplare 11361, sito A. La terminazione posteriore del corpo è<br />
a sinistra. Sotto: particolare della colonna vertebrale con evidenti i raggi delle lunghe pinne dorsale e anale.<br />
GONORYNCHIFORMES - Chanidae<br />
Alcuni resti dal sito A (Fig. 56) sono stati attribuiti in letteratura (NARDON, 1990; RIGO, 1998) al genere<br />
Parachanos, appartenente al superor<strong>di</strong>ne Ostariofisi che include molti de<strong>gli</strong> attuali pesci <strong>di</strong> acqua dolce, per<br />
esempio i Ciprini<strong>di</strong> e i pesci gatto. Tuttavia le basi per tale attribuzione appaiono piuttosto deboli ed uno stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong><br />
detta<strong>gli</strong>o che smentisca o confermi la presenza <strong>di</strong> questo genere a Polazzo è auspicabile.<br />
CIPRINIFORMES?<br />
Tra i Teleostei <strong>di</strong> Polazzo è comune una piccola forma snella, lunga da 2 a 6 centimetri, nuda o con una<br />
copertura <strong>di</strong> sca<strong>gli</strong>e estremamente sottili. Questi pesci sono stati attribuiti da RIGO (1998) a<strong>gli</strong> Ostariofisi<br />
Cipriniformi sulla base <strong>di</strong> una comunicazione personale della paleoittiologa Gloria Arratia. Tuttavia, tale<br />
determinazione deve ancora essere confermata dall’identificazione <strong>di</strong> sicuri caratteri <strong>di</strong>agnostici. L’assenza <strong>di</strong><br />
raggi spinosi nelle pinne e la posizione arretrata delle pinne pelviche (Figg. 57-59) in<strong>di</strong>cano comunque una<br />
relativa primitività all’interno dei Teleostei.<br />
61
Figura 56 - L’esemplare 1378 identificato come Parachanos. Sito A.<br />
62<br />
Figura 57 – Ciprini-<br />
formes?, esemplare 12242,<br />
stupendamente conservato.<br />
Sito B, sottointervallo D1.<br />
Figura 58 - Cipriniformes?,<br />
esemplare 12239. Sito B,<br />
sottointervallo D1. E’<br />
evidente la fratturazione della<br />
colonna vertebrale.
Figura 59 - Cipriniformes?, esemplare 12416. Sito B, sottointervallo C2. Si noti la fratturazione in tre segmenti della<br />
colonna vertebrale e la loro <strong>di</strong>slocazione, probabilmente dovuta al trasporto e all’avanzato stato <strong>di</strong> decomposizione dei<br />
tessuti.<br />
ALEPISAURIFORMES - Dercetidae ed Enchodontidae<br />
I membri della Fami<strong>gli</strong>a Dercetidae avevano un corpo sottile estremamente allungato e una grande testa. Le<br />
lunghe <strong>fa</strong>uci erano munite <strong>di</strong> denti conici ed acuminati che in<strong>di</strong>cano come questi pesci fossero de<strong>gli</strong> attivi<br />
predatori. I Derceti<strong>di</strong> ricordano per forma l’attuale agu<strong>gli</strong>a che però è un acantotterigio belonide e quin<strong>di</strong> è più<br />
evoluta. <strong>Il</strong> genere Rhynchodercetis (Figg. 60-63) si <strong>di</strong>fferenzia imme<strong>di</strong>atamente dal simile genere Dercetis per<br />
il minore allungamento della man<strong>di</strong>bola, che risulta molto più corta della parte rostrale e appuntita del cranio.<br />
Come l’agu<strong>gli</strong>a, era probabilmente un predatore “scattista”, che si spostava velocemente nelle acque<br />
superficiali delle lagune e del mare aperto.<br />
Rhynchodercetis è il genere <strong>di</strong> pesce più frequente a Polazzo. Similmente a quanto si riscontra nei<br />
picnodonti, i resti rinvenuti nel sito A appartengono spesso ad esemplari <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni relativamente gran<strong>di</strong> e<br />
sono costituiti da scheletri molto <strong>di</strong>sarticolati (Fig. 61), in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> un avanzato stato <strong>di</strong> decomposizione dei<br />
cadaveri prima del seppellimento definitivo.<br />
Due esemplari, uno rinvenuto nello scavo del 2000 nel sottointervallo E2 e l’altro nello scavo del 1999 in<br />
D3, presentano all’interno della cassa toracica, nella posizione in cui si trovava lo stomaco, lo scheletro <strong>di</strong> un<br />
altro pesce. Si tratta <strong>di</strong> prede ingoiate poco prima della morte de<strong>gli</strong> esemplari. In particolare, un esemplare <strong>di</strong><br />
Rhynchodercetis lungo circa 38 centimetri, ha nella regione compresa tra le pinne pettorali e fino a 2,5<br />
centimetri posteriormente alla pinna dorsale, un pesce la cui identificazione tassonomica non è stata ancora<br />
effettuata, lungo 11 centimetri e perfettamente conservato (Fig. 62). <strong>Il</strong> pesce è stato ingoiato intero<br />
incominciando dalla testa. Lo stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> questi esemplari e <strong>di</strong> altri che potrebbero essere rinvenuti ne<strong>gli</strong> scavi<br />
futuri, potrebbe in<strong>di</strong>carci quali fossero le preferenze alimentari <strong>di</strong> Rhynchodercetis. Nel sottointervallo D2<br />
sono stati rinvenuti anche esemplari <strong>di</strong> soli pochi centimetri <strong>di</strong> lunghezza, dal corpo caratteristicamente<br />
ripiegato a formare un circolo. Altri esemplari sensibilmente più piccoli della me<strong>di</strong>a sono probabilmente<br />
in<strong>di</strong>vidui giovanili (Fig. 63).<br />
In letteratura (NARDON, 1990) <strong>gli</strong> esemplari <strong>di</strong> Polazzo sono attribuiti alla specie Rhynchodercetis<br />
acutissimus, ma una accurata revisione è necessaria per confermare questa attribuzione specifica alla luce<br />
delle decine <strong>di</strong> nuovi esemplari provenienti dal sito B.<br />
63
Figura 60 – Rhynchodercetis. A e B), esemplari in ottimo stato <strong>di</strong> articolazione scheletrica. Si notino la lunga testa,<br />
man<strong>di</strong>bola molto più corta del rostro, le spine vertebrali perpen<strong>di</strong>colari al corpo, le piccole pinne e le pile longitu<strong>di</strong>nali<br />
<strong>di</strong> sca<strong>gli</strong>e. A) esemplare 12252, sito B, sottointervallo D1. B) Esemplare 12053, sito B, sottointervallo E1. C)<br />
scheletro parzialmente <strong>di</strong>sarticolato; esemplare 12294, sito B, sottointervallo E2.<br />
64
Figura 61 - Scheletro molto <strong>di</strong>sarticolato <strong>di</strong> un grande esemplare (11375) <strong>di</strong> Rhynchodercetis. Sito A, strato 7. Si<br />
notino a destra numerose vertebre sparse e a sinistra il lungo rostro appuntito.<br />
Figura 62 – Rhynchodercetis con all’interno del corpo una preda (rettangolo contornato in rosso), un pesce ingoiato<br />
intero; esemplare 12169. Nell’angolo basso a sinistra: particolare del pesce ingoiato. Sito B, sottointervallo D3.<br />
65
Figura 63 – A) Esemplare molto giovane <strong>di</strong> Rhynchodercetis (11651) sito B, sottointervallo D2; B): altro esemplare<br />
giovanile <strong>di</strong> Rhynchodercetis (13469), sito B, sottointervallo B3.<br />
Gli Encodonti<strong>di</strong> erano predatori dal corpo piuttosto massiccio e con una grande testa munita <strong>di</strong> denti<br />
appuntiti <strong>di</strong> due <strong>di</strong>mensioni nettamente <strong>di</strong>verse, rispettivamente molto gran<strong>di</strong> e piuttosto piccoli (Fig. 64).<br />
Potevano raggiungere i 30 centimetri <strong>di</strong> lunghezza.<br />
Enchodus è sicuramente presente solo nel sito A (NARDON, 1990; TINTORI et al., 1993; RIGO, 1998) dove<br />
ne sono stati trovati alcuni resti in gran parte <strong>di</strong>sarticolati (Figg. 64-65).<br />
Figura 64 - Enchodus sp. (esemplare 11382). A) Cranio e man<strong>di</strong>bole <strong>di</strong>sarticolate; B) particolare della man<strong>di</strong>bola con<br />
i denti. Sito A, strato 5.<br />
66
Figura 65 - Possibile esemplare <strong>di</strong> Enchodus sp. (11386). Sito A, strato 4.<br />
ACANTHOMORPHA - PERCOMORPHA - Beryciformes<br />
I Bericiformi sono un gruppo <strong>di</strong> Percomorfi considerato piuttosto primitivo da molti autori. Essi apparvero circa<br />
95 <strong>milioni</strong> <strong>di</strong> <strong>anni</strong> <strong>fa</strong> e oggi sono rappresentati da un numero relativamente ridotto (11) <strong>di</strong> <strong>fa</strong>mi<strong>gli</strong>e. Nei due siti <strong>di</strong><br />
Polazzo i Bericiformi sono <strong>gli</strong> unici acantomorfi finora identificati e quin<strong>di</strong> rappresentano i pesci ossei più evoluti<br />
dell’intera ittio<strong>fa</strong>una. Tutti <strong>gli</strong> acantomorfi dei siti A e B sono rappresentati da in<strong>di</strong>vidui <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni ridotte, con il<br />
corpo lungo 1,7-7,5 centimetri (Figg. 66-69). Due esemplari (Figg. 66-67A) provenienti dal sito A sono stati<br />
oggetto <strong>di</strong> una tesi <strong>di</strong> laurea (GUIDOTTI, 1983) e attribuiti alla <strong>fa</strong>mi<strong>gli</strong>a Holocentridae. Probabilmente rappresentano<br />
un nuovo genere e una nuova specie. E’ significativo che questi due esemplari mostrino maggiori somi<strong>gli</strong>anze con i<br />
bericiformi trovati in Serbia, quin<strong>di</strong> in una zona che aveva probabili connessioni con la piattaforma Adriatico-<br />
Dinarica.<br />
Numerosi esemplari <strong>di</strong> acantomorfi in buono stato <strong>di</strong> conservazione provenienti dal sito B si sono aggiunti alle<br />
prime segnalazioni. Anche se probabilmente sono in gran parte, se non tutti, riferibili ai Bericiformi, non sono stati<br />
effettuati ancora stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> detta<strong>gli</strong>o a sostegno <strong>di</strong> tale identificazione. Per questo l’attribuzione ai Beryciformes è del<br />
tutto preliminare e viene qui riportata tra virgolette.<br />
Figura 66 - Holocentridae; esemplare 1376. Sito A.<br />
67<br />
La struttura generale del corpo, la presenza <strong>di</strong> circa<br />
8-10 raggi spinosi nella parte anteriore della pinna<br />
dorsale (Fig. 66-68B) e <strong>di</strong> quattro raggi spinosi, dei<br />
quali il terzo o penultimo è il più robusto, nella pinna<br />
anale (Figg. 66-67A e C) permette <strong>di</strong> identificare<br />
alcuni <strong>di</strong> essi come Olocentri<strong>di</strong>, forse appartenenti<br />
alla stessa specie dei due reperti descritti da Guidotti.<br />
Lo stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> questi esemplari e la verifica se nel sito<br />
A e B ci siano le stesse specie o specie <strong>di</strong>verse, se si<br />
tratta <strong>di</strong> nuove forme e in che rapporto sono con le<br />
specie già note, sarebbe un ottimo argomento per<br />
unatesi <strong>di</strong> dottorato.<br />
Gli otto generi attuali della <strong>fa</strong>mi<strong>gli</strong>a Holocentridae sono tutti marini, vivono in corrispondenza delle<br />
sco<strong>gli</strong>ere coralline o <strong>di</strong> fondali rocciosi nelle regioni tropicali e subtropicali de<strong>gli</strong> oceani Atlantico, In<strong>di</strong>ano e<br />
Pacifico. L’unica specie vivente nel Me<strong>di</strong>terraneo orientale è immigrata dal Mar Rosso. Hanno abitu<strong>di</strong>ni per lo<br />
più notturne e restano nascosti ne<strong>gli</strong> anfratti durante il giorno.
Figura 67 – Beryciformes. A) Holocentridae; esemplare 11365, sito A, strato 6. B) Un possibile Holocentridae;<br />
esemplare 1377, sito A. C) Un probabile Holocentridae; esemplare 11893a, sito B, sottointervallo D3.<br />
68
Figura 68 - “Beryciformes”.<br />
A) Un possibile Holocentridae; esemplare 12047, sito B, sottointervallo D3.<br />
B) Un possibile Holocentridae; esemplare 13492, sito B, sottointervallo D2.<br />
C) “Beryciformes”?; esemplare 12055, sito B, sottointervallo E1.<br />
69
Figura 69 - “Beryciformes”?. A) Esemplare 12417, sito B, sottointervallo C2. B) Esemplare<br />
13541, sito B, sottointervallo D3.<br />
TELEOSTEI DA DETERMINARE<br />
La maggior parte dei Teleostei <strong>di</strong> Polazzo non è stata ancora oggetto <strong>di</strong> uno stu<strong>di</strong>o scientifico, senza il quale<br />
una determinazione atten<strong>di</strong>bile non è possibile. Tra <strong>di</strong> questi vi sono piccole forme, lunghe pochi centimetri,<br />
dal corpo snello, nudo o coperto <strong>di</strong> sca<strong>gli</strong>e molto sottili, pinne prive <strong>di</strong> spine e pinne pelviche in posizione<br />
me<strong>di</strong>ana (Figg. 70-71). Talvolta è presente una evidente, seppure apparentemente non completa, copertura <strong>di</strong><br />
sca<strong>gli</strong>e (Fig. 72A). In alcuni esemplari dal sito A la copertura <strong>di</strong> sca<strong>gli</strong>e è più estesa e spessa (Figg. 72B e C).<br />
Un predatore dai denti piccoli ma appuntiti è rappresentato soltanto dalla testa (Fig. 73A). Infine, raramente si<br />
rinvengono i denti isolati <strong>di</strong> pesci predatori indeterminati <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni maggiori (Fig. 73B).<br />
Figura 70 - Teleosteo indeterminato (esemplare 12232), esposto in vista dorsale. Sito B, sottointervallo E2.<br />
70
71<br />
Figura 71 - Teleostei indeterminati. A)<br />
Esemplare 12175; sito B, sottointervallo<br />
E2. B) Esemplare 13539 (a destra)<br />
conservato vicino ad un picnodonte. In<br />
realtà il picnodonte è rimasto nella<br />
controlastra ed è stato riportato<br />
virtualmente alla sua posizione originaria<br />
me<strong>di</strong>ante computer. Sito B, sottointervallo<br />
E2. C) Esemplare 13482, parzialmente<br />
conservato; sito B, sottointervallo D2.
Figura 72 - Teleostei indeterminati. A) Esemplare 11899 con parte del corpo ricoperto da sca<strong>gli</strong>e; sito B,<br />
sottointervallo D2. B) Esemplare 11368, con una copertura <strong>di</strong> sca<strong>gli</strong>e relativamente spesse; sito A, strato 7. C)<br />
Esemplare 11364, con il corpo ricoperto da sca<strong>gli</strong>e; sito A.<br />
72
73<br />
Figura 73 – A) Testa <strong>di</strong> un teleosteo<br />
predatore indeterminato (esemplare<br />
11615A). Le robuste man<strong>di</strong>bole, così<br />
come le “mascelle” sono munite <strong>di</strong> piccoli<br />
denti appuntiti. Sito B, copertura.<br />
B) Dente isolato (esemplare 12056) <strong>di</strong> un<br />
teleosteo predatore <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni<br />
relativamente gran<strong>di</strong>. Sito B,<br />
sottointervallo E1.
Invertebrati<br />
Gli invertebrati sono particolarmente rari: alcuni piccoli gamberi (Crostacei Decapo<strong>di</strong>) e qualche resto<br />
frammentario <strong>di</strong> ru<strong>di</strong>sta.<br />
I crostacei decapo<strong>di</strong> sono rappresentati nel sito A soprattutto da una mezza dozzina <strong>di</strong> addomi <strong>di</strong> gamberi<br />
in cattivo stato <strong>di</strong> conservazione (Fig. 74). Nel sito B non sono mai stati rinvenuti crostacei.<br />
Figura 74 - Resto <strong>di</strong> un crostaceo decapode (gambero; esemplare 11293) senza<br />
appen<strong>di</strong>ci conservate. Sito A, strato 5.<br />
Una mezza dozzina <strong>di</strong> resti frammentari <strong>di</strong> ru<strong>di</strong>ste ra<strong>di</strong>oliti<strong>di</strong> proviene dal sito A (Fig. 75). Questi<br />
frammenti erano trasportati nell’ambiente <strong>di</strong> deposizione e conservazione dei pesci da correnti <strong>di</strong> marea<br />
particolarmente forti o dalle tempeste, ma probabilmente vivevano ai suoi margini, perchè questo ambiente non<br />
era <strong>fa</strong>vorevole alla vita.<br />
Figura 75 - Resti <strong>di</strong> una ru<strong>di</strong>sta ra<strong>di</strong>olitide (esemplare 11313), sito A.<br />
74
Tracce fossili<br />
Raramente, nel sito B si trovano anche icnofossili (tracce fossili) <strong>di</strong> invertebrati. Nel sottointervallo A1 è<br />
presente un particolare tipo <strong>di</strong> bioturbazione superficiale dovuta probabilmente all’attività <strong>di</strong> invertebrati <strong>di</strong><br />
piccole <strong>di</strong>mensioni che ricorda le ma<strong>gli</strong>e <strong>di</strong> una rete, con piccoli “no<strong>di</strong>” dai quali si <strong>di</strong>partono “gallerie” strette<br />
e allungate. E’ simile a Vagorichnus dei depositi lacustri del Giurassico cinese (Giorgio Tunis, comunicazione<br />
personale).<br />
Figura 76 - Tracce fossili sulla superficie <strong>di</strong> strato (esemplare 11654). Sito B, sottointervallo A1.<br />
75
PROSPETTIVE FUTURE<br />
L’associazione fossile dei due siti <strong>di</strong> Polazzo riveste un particolare valore scientifico. Essa è costituita da<br />
organismi che raramente si fossilizzano perchè <strong>di</strong> solito vengono <strong>di</strong>strutti subito dall’attacco <strong>di</strong> predatori e<br />
necro<strong>fa</strong>gi, nonchè dai processi putre<strong>fa</strong>ttivi.<br />
Per i motivi contingenti, dato che si basa sul lavoro volontario non retribuito e quin<strong>di</strong> <strong>di</strong>pende dalla<br />
<strong>di</strong>sponibilità dei volontari, lo scavo nel sito B ha interessato finora solo un limitato spessore dell’intervallo<br />
potenzialmente fossilifero presente in zona, come pure una limitata superficie (circa 10 m 2 ).<br />
La prosecuzione de<strong>gli</strong> scavi potrà consentire il rinvenimento <strong>di</strong> organismi che non solo sono rari per motivi<br />
<strong>di</strong> conservazione (tafonomici), ma che erano probabilmente poco rappresentati anche come numero <strong>di</strong> in<strong>di</strong>vidui<br />
morti. Si potrebbero trovare, quin<strong>di</strong>, vertebrati terrestri rari come pterosauri, <strong>di</strong>nosauri e uccelli. In<strong>fa</strong>tti,<br />
investigando un maggior volume <strong>di</strong> roccia generalmente aumentano le probabilità <strong>di</strong> imbattersi ne<strong>gli</strong> organismi<br />
meno comuni. Questo si è verificato, per esempio, nell’oramai <strong>fa</strong>mosissimo giacimento cretaceo del Liaoning<br />
nella Cina settentrionale.<br />
Data la fine granulometria della roccia, le sue caratteristiche se<strong>di</strong>mentologiche e lo stato <strong>di</strong> conservazione<br />
dei fossili ritrovati, ci si può aspettare che questi eventuali rari vertebrati siano conservati nei minimi detta<strong>gli</strong> e<br />
ci permettano osservazioni <strong>di</strong> enorme interesse scientifico (strutture dell’epidermide, piumaggio, parti molli,<br />
ecc.).<br />
Già lo stu<strong>di</strong>o preliminare delle piante terrestri e dei rettili ha evidenziato una affinità con le regioni<br />
settentrionali, Laurasiatiche, piuttosto che con quelle meri<strong>di</strong>onali, del Gondwana. Stu<strong>di</strong> più comprensivi e<br />
detta<strong>gli</strong>ati permetteranno <strong>di</strong> chiarire me<strong>gli</strong>o la posizione paleogeografica della piattaforma carbonatica alla fine<br />
del Cretaceo.<br />
I reperti più significativi de<strong>gli</strong> scavi nel sito A sono stati preparati per l’esposizione prima del 1994. I<br />
reperti del sito B necessitano <strong>di</strong> una preparazione per lo stu<strong>di</strong>o e per l’eventuale esposizione. L’adeguata<br />
preparazione del materiale in esame non può essere effettuata che in minima parte dal personale volontario (in<br />
pratica si limita al consolidamento per evitare un deterioramento del fossile) e sarebbe auspicabile fosse svolta<br />
da paleontologi con una sufficiente conoscenza dell’osteologia dei pesci e adeguatamente retribuiti.<br />
L’in<strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> fon<strong>di</strong> per la preparazione del materiale <strong>di</strong> Polazzo è una delle cause della sua mancata<br />
valorizzazione scientifica e <strong>di</strong>dattico-<strong>di</strong>vulgativa.<br />
L’Amministrazione Comunale <strong>di</strong> Mon<strong>fa</strong>lcone ha deliberato già nel 1997 l’istituzione <strong>di</strong> una una Sezione<br />
Paleontologica del Museo Civico del Territorio che dovrebbe portare sotto la gestione pubblica, previa<br />
convenzione da una parte con la Soprintendenza dall’altra con i volontari, le collezioni, la strumentazione e il<br />
know-how dell’attuale Museo Paleontologico Citta<strong>di</strong>no. Questo dovrebbe condurre alla realizzazione <strong>di</strong> un<br />
percorso espositivo museale incentrato sui reperti già custo<strong>di</strong>ti nelle collezioni del Museo Paleontologico<br />
Citta<strong>di</strong>no e quin<strong>di</strong> alla valorizzazione dei reperti del sito <strong>di</strong> Polazzo. Dato il particolare interesse che i fossili<br />
suscitano a livello popolare e soprattutto nei bambini, sono un formidabile strumento per avvicinare il<br />
citta<strong>di</strong>no a<strong>gli</strong> aspetti naturalistici del territorio in cui vive, del quale generalmente ignora tutto o quasi, e<br />
fornir<strong>gli</strong> una <strong>di</strong>mensione (“profon<strong>di</strong>tà”) del tempo. Come è già stato effettuato in contesti simili (per esempio,<br />
a Bolca) sarebbe possibile realizzare una sala espositiva del Museo de<strong>di</strong>cata interamente al giacimento <strong>di</strong><br />
Polazzo, con adeguati pannelli illustrativi e bacheche ostensive dei reperti.<br />
In questo modo si potrebbe fornire al visitatore una panorama completo del significato e dell’importanza<br />
<strong>di</strong> un giacimento fossilifero nel contesto della storia geologica del territorio, dell’evoluzione del paesaggio e<br />
della vita sul Pianeta. Sempre ammesso che si <strong>fa</strong>ccia uno sforzo concreto per comprendere davvero questo<br />
contesto.<br />
Noi speriamo che la valorizzazione dei siti <strong>di</strong> Polazzo non riguar<strong>di</strong> solo l’ambito meramente espositivo, ma<br />
che ci sia anche un sostegno all’attività <strong>di</strong> ricerca scientifica, cioè alla pura e semplice conoscenza. Tuttavia,<br />
quest’ultima non sembra essere considerata <strong>di</strong> alcuna importanza nell’anno domini 2004.<br />
76
DOVE VEDERE I FOSSILI DI POLAZZO OGGI<br />
Molti fossili del Collio e del <strong>Carso</strong> sono in custo<strong>di</strong>a presso il Museo Paleontologico Citta<strong>di</strong>no della Rocca<br />
<strong>di</strong> Mon<strong>fa</strong>lcone, che conserva nelle sue collezioni più <strong>di</strong> 25.000 reperti. Tra questi vi sono anche tutti <strong>gli</strong><br />
esemplari regionali figurati in questo libro.<br />
In realtà, a <strong>di</strong>spetto del nome, il Museo non è sulla rocca veneziana che sovrasta l’abitato della città, dove<br />
si trova invece una piccola esposizione paleontologica permanente. Nella accezione moderna del termine, un<br />
Museo non è solo una esposizione <strong>di</strong> cose, ma è il luogo dove una determinata tipologia <strong>di</strong> oggetti culturali (nel<br />
nostro caso, i fossili) viene custo<strong>di</strong>ta e tutelata, è oggetto <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o e <strong>di</strong> <strong>di</strong>vulgazione scientifica ed è ANCHE<br />
esposta al pubblico. Le collezioni, i laboratori, <strong>gli</strong> uffici e la biblioteca, quin<strong>di</strong> la sede del Museo, si trovano in<br />
via E. Valentinis 134.<br />
Alcune vetrine de<strong>di</strong>cate ai siti <strong>di</strong> Polazzo si trovano nell’esposizione della Rocca, altre sono state allestite<br />
nella sede del Museo.<br />
Tutti <strong>gli</strong> organismi figurati in questo libro sono estinti. Noi ci auspichiamo che anche la nostra attività<br />
scientifica e <strong>di</strong>vulgativa non <strong>fa</strong>ccia la stessa fine.<br />
RINGRAZIAMENTI<br />
Si ringrazia per la collaborazione e l’aiuto i Proff. Nevio Pu<strong>gli</strong>ese e Giorgio Tunis dell’Università <strong>di</strong><br />
Trieste, Prof. Frédéric Thevenard dell’Università Claude Bernard <strong>di</strong> Lione, Dott. Bernard Gomez<br />
dell’Università <strong>di</strong> Leeds, il Dott. Sandro Venturini dell’A.G.I.P. e il Dott. Davide Rigo. Grazie al Prof.<br />
Daniele Masetti dell’Università <strong>di</strong> Trieste, per la foto <strong>di</strong> figura 32. Un sentito ringraziamento anche al Dott.<br />
Guido Guidotti, alla Prof. Angela Buscalioni, al Prof. Francisco Poyato-Ariza, ai Sigg. Duna Moratto, Pino<br />
Pacor, Enrico Pacor, Igor Shchurenko e tutti <strong>gli</strong> altri volontari del Gruppo Speleologico A.d.F.<br />
Si ringrazia la Soprintendenza ai B.A.A.A.A.S. del Friuli-Venezia Giulia e in particolare la Dott.ssa<br />
Franca Maselli Scotti e il Dott. Andrea Pessina per la collaborazione e la gentile concessione dell’uso delle<br />
immagini dei fossili.<br />
Tutte le foto, dove non specificato altrimenti, sono del Gruppo Speleologico A.d.F. - Museo Paleontologico<br />
Citta<strong>di</strong>no.<br />
Si rammenta che i fossili in Italia sono patrimonio in<strong>di</strong>sponibile dello Stato e la loro ricerca e<br />
detenzione deve essere autorizzata dalla Soprintendenza competente per territorio (Decreto<br />
legislativo n. 490/1999). Anche il ritrovamento fortuito è regolato in modo restrittivo dalla legge<br />
(art. 87).<br />
77
BIBLIOGRAFIA<br />
BOZZI L. (1888) - Sulle filliti cretacee <strong>di</strong> Vernasso nel Friuli. Atti Soc. Ital. Sci. Nat., v. 31, pp. 399-405.<br />
BOZZI L. (1891) - La flora cretacea <strong>di</strong> Vernasso in Friuli. Boll. Soc. Geol. It., v. 10, pp. 371-382, Roma.<br />
CATI A., SARTORIO D. & VENTURINI S. (1989) - Carbonate platforms in the subsur<strong>fa</strong>ce of the Northern Adriatic Area.<br />
Mem. Soc. Geol. Ital., v. 40, pp. 295-308, Roma.<br />
CESTARI R. & SARTORIO D. (1995) - Ru<strong>di</strong>sts and <strong>fa</strong>cies of the Periadriatic Domain. Pp. 207, AGIP S.p.A., S. Donato<br />
Milanese.<br />
DALLA VECCHIA F.M. & MUSCIO G. (1999) - Mesozoic Lagerstaette of the Friuli-Venezia Giulia region (NE Italy). III<br />
International Symposium on Lithographic Limestones, Bergamo (Italy), September 1-5, 1999, Rivista del Museo<br />
Civico <strong>di</strong> Scienze Naturali “E. Caffi”, suppl. al v. 20, pp. 71-74, Bergamo.<br />
DALLA VECCHIA F.M. & RIGO D. (1998) - <strong>Il</strong> giacimento <strong>di</strong> Polazzo. Natura Nascosta 17, v. 17: pp. 33-37, Mon<strong>fa</strong>lcone.<br />
DALLA VECCHIA F.M., RIGO D., TENTOR M., PACOR G. & MORATTO D. (2001) - <strong>Il</strong> sito <strong>paleontologico</strong> <strong>di</strong> Polazzo<br />
(Gorizia): dati e prospettive. In: PERRI M. C. (a cura <strong>di</strong>-), Giornate <strong>di</strong> Paleontologia 2001, Giornale <strong>di</strong> Geologia,<br />
ser. 3, v. 62 (2000; suppl.), pp. 151-156, Bologna.<br />
D'ERASMO G. (1952) - Nuovi ittioliti cretacei del <strong>Carso</strong> Triestino. Atti Mus. Civ. St. Nat. <strong>di</strong> Trieste, v. 28, pp. 81-122,<br />
Trieste.<br />
GAYET M., BELOUZE A. & ABI SAAD P. (2003) - Les poissons fossiles. Pp. 158, E<strong>di</strong>tions DésIris, Méolans-Revel.<br />
GOMEZ B., MARTÍN-CLOSAS C., BARALE G., SOLÉ DE PORTA N., THEVENARD F. & GUIGNARD G. (2002a) - Frenelopsis<br />
(Coniferales: Cheirolepi<strong>di</strong>aceae) and related male organ genera from the Lower Cretaceous of Spain.<br />
Palaeontology, v. 45, pp. 997-1036, Londra.<br />
GOMEZ B., THEVENARD F., FANTIN M. & GIUSBERTI L. (2002b) - Late Cretaceous fossil plants from the Bonarelli<br />
level in the Venetian (Southern) Alps. Cretaceous Research, v. 23, pp. 671-6<strong>85</strong>.<br />
GOMEZ B., MARTÍN-CLOSAS C., BARALE G. & THEVENARD F. (2000) - A new species of Nehvizdya (Ginkgoales) from<br />
the Lower Cretaceous of the Iberian Ranges (Spain). Rev. Palaeobot. Palynol., v. 111, pp. 49-70.<br />
GOMEZ B., MARTÍN-CLOSAS C., MÉON H., THEVENARD F. & BARALE G. (2001) - Plant taphonomy and palaeoecology<br />
in the lacustrine delta of Uña (Upper Barremian, Iberian Ranges, Spain). Palaeogeogr., Palaeoclim., Palaeoecol.,<br />
v. 170, pp. 133-148, Amsterdam.<br />
GUIDOTTI G. (1982-83) - Stu<strong>di</strong>o <strong>paleontologico</strong> <strong>di</strong> due teleostei del Cretaceo superiore del <strong>Carso</strong>. Tesi <strong>di</strong> laurea<br />
ine<strong>di</strong>ta, Università de<strong>gli</strong> Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> Bologna, pp. 88.<br />
KVACEK J. (1999) - New data and revision of three Gymnosperms from the Cenomanian of Bohemia. Sagenopteris<br />
variabilis (Velenovský), Mesenea bohemica (Corda) comb. n. and Eretmophyllum obtusum (Velenovský) comb. n.<br />
Acta Musei Nationalis Pragae, Series B - Historia Naturalis, v. 55, pp. 15-24, Praga.<br />
MARTINIS B. (1962) - Ricerche geologiche e paleontologiche sulla regione compresa tra il T. Iudrio e il F. Timavo.<br />
Mem. Riv. Ital. Paleont. Strat., v. 8, pp. 1-200, Milano.<br />
NARDON S. (1990) - <strong>Il</strong> giacimento <strong>di</strong> Polazzo. In: TINTORI A., MUSCIO G., BIZZARINI F. (eds.), Pesci fossili italiani.<br />
Scoperte e riscoperte, pp. 81-84, Trezzano sul Navi<strong>gli</strong>o.<br />
POYATO-ARIZA F. J. & WENZ S. (2002) - A new insight into pycnodontiform fishes. Geo<strong>di</strong>versitas, v. 24(1), pp. 140-<br />
248, Parigi.<br />
RIGO D. (1997) - Scavo <strong>paleontologico</strong> 1997 nel Cretaceo superiore <strong>di</strong> Polazzo (Go): risultati e prospettive. Natura<br />
Nascosta, v. 15, pp. 29-33, Mon<strong>fa</strong>lcone.<br />
RIGO D. (1998) - <strong>Il</strong> Lagerstätte cretacico <strong>di</strong> Polazzo (Fo<strong>gli</strong>ano-Re<strong>di</strong>pu<strong>gli</strong>a, Gorizia). Tesi <strong>di</strong> laurea in Paleontologia,<br />
Università de<strong>gli</strong> Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> Trieste, pp. 150.<br />
RIGO D. (1999) - The fossils of the Cretaceous Lagerstätte of Polazzo (Fo<strong>gli</strong>ano-Re<strong>di</strong>pu<strong>gli</strong>a, Gorizia, NE Italy).<br />
Natura Nascosta, v. 19, pp. 10-19, Mon<strong>fa</strong>lcone.<br />
SIRNA G., DALLA VECCHIA F.M., MUSCIO G. & PICCOLI G. (1994) - Catalogue of Paleozoic and Mesozoic Vertebrates<br />
and Vertebrate localities of the Tre Venezie area (North Eastern Italy). Mem. Sci. Geol. Padova, v. 46, pp. 255-<br />
281, Padova.<br />
STACHE G. (1889) - Die liburnische Stufe und deren Grenz-Horizonte. Erste Abteilung. Abhandl. k. k. Geol. Reichs.,<br />
v. 13, pp. 1-170, Vienna.<br />
TENTOR M., TUNIS G. & VENTURINI S. (1994) - Schema stratigrafico e tettonico del <strong>Carso</strong> Isontino. Natura Nascosta,<br />
v. 9, pp. 1-32, Mon<strong>fa</strong>lcone.<br />
TINTORI A., PUGLIESE N. & CALLIGARIS R. (1993) - The Polazzo locality. In A. Tintori & G. Muscio (a cura <strong>di</strong>-),<br />
Fossil fish localities of Northern Italy. Field guidebook of the Int. Symp. Mesozoic Fishes: Systematics and<br />
Paleoecology, Eichstätt, August 1993, Field trip: Northern Italy, 13-17 August 1993, pp. 17-18.<br />
ZIMOLO F. (1990) - Ittio<strong>fa</strong>une fossili cretaciche a Polazzo (Gorizia). In: AA VV., <strong>Il</strong> Cretacico Isontino: inquadramento<br />
geologico ed aspetti paleontologici, pp. 67-69, Mon<strong>fa</strong>lcone.<br />
78