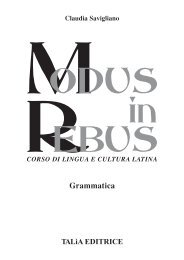Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
MATERIALE INTEGRATIVO DI<br />
IN GRECO<br />
Antologia di testi epigrafici e letterari<br />
a cura di<br />
RICCARDO PEZZANO
2<br />
<strong>In</strong>dice<br />
Callimaco è un autore post moderno? .................................................3<br />
(Testo greco, traduzione e commento di Aitia, 1, 1-16; Epigrammi, 48 e 61)<br />
Plutarco, La Virtù e il Vizio.....................................................................8<br />
(Testo greco integrale, traduzione, commento e nota biografica)
CALLIMACO E’ UN AUTORE POST MODERNO?<br />
Un noto studioso 1 ebbe a definire Callimaco (310/300-dopo il 245 a.C.) come post<br />
filosofico, nel senso che tale autore non ha più né crede in schemi teoretici che gli<br />
consentano di interpretare e di padroneggiare la realtà e per ciò stesso si allontana con<br />
scetticismo dall’universale e rivolge tutto il proprio interesse al particolare. <strong>In</strong> sostanza:<br />
per Callimaco la poesia non ha un valore morale o educativo o, men che meno, politico e<br />
come tale la propria arte non ha altra misura che non sia l’arte stessa.<br />
Poesia dotta questa di Callimaco e anche umoristica. L’umorismo callimacheo va<br />
forse interpretato in due direzioni:<br />
1. la sua erudizione viene impiegata, umoristicamente, per divertire gli ascoltatori e i<br />
lettori narrando di cose straordinarie o proponendo miti sconosciuti e magari in<br />
urto con le opinioni comuni più radicate;<br />
2. Callimaco ama atteggiarsi nei confronti della realtà analizzandola con gli occhi di<br />
un bambino, raccontando con l’ingenua serietà infantile fatti e miti in cui egli non<br />
crede più.<br />
Callimaco ottiene così un effetto di duplice prospettiva: da un lato racconta delle<br />
cose e dall’altro strizza gli occhi al lettore che suppone compiaciuto del gioco che egli sta<br />
tessendo. Come quando, per esempio, nell’<strong>In</strong>no ad Apollo (vv. 105-113) dice che il dio lo<br />
aveva ammonito di non scegliere per la sua poesia i sentieri troppo frequentati e battuti,<br />
ma di percorrere una propria via originale e innovativa per quanto angusta. Qui Callimaco<br />
si esibisce in un’evidente citazione dell’Esiodo de Le opere e i giorni (vv. 287 ss.), solo che<br />
non dice nulla circa la méta delle due vie. <strong>In</strong> Esiodo la via stretta porta alla virtù e quella<br />
larga al vizio (situazione analoga a quella mitologica di Eracle al bivio). <strong>In</strong> Callimaco<br />
invece questa valutazione morale non c’è. Sceglie la via stretta perché vuole che si giudichi<br />
la sua poesia solo col metro dell’arte, che si giudichi l’arte con l’arte al di fuori di qualsiasi<br />
considerazione storica, filosofica, politica, sociologica e via dicendo.<br />
Torniamo all’umorismo di Callimaco. Le due componenti umoristiche callimachee<br />
convergono in un’unica direzione a formare un poeta per il quale l’umorismo consiste<br />
nell’essere aristocraticamente superiori alla materia trattata, distaccati da essa. Questo gli<br />
garantisce l’opportunità di agire sul testo poetico come un burattinaio che muove a<br />
piacimento le proprie creature senza venir coinvolto nelle loro vicende, pronto a<br />
maneggiarle con ironia come a non prendere sul serio neppure se stesso.<br />
Voltaire diceva che Ariosto tratta la sua materia poetica scherzando. E noi vediamo<br />
in quel riferimento allo scherzare non l’indicazione di una canzonatura, ma la chiara<br />
allusione al sereno e distaccato atteggiarsi di Ariosto nei confronti della sua creazione<br />
poetica. Così è anche per Callimaco. Ma c’è forse ancòra qualcosa da sottolineare.<br />
Come nell’Ariosto giocarono a formare la materia del suo Orlando furioso le letture<br />
dei classici (Orazio, Virgilio e Ovidio in particolare), quelle dei romanzi cavallereschi<br />
italiani, francesi, spagnoli e la personale esperienza cortigiana, così in Callimaco è<br />
fondamentale la rivisitazione del panorama letterario della grecità a partire da Omero e<br />
Esiodo come fondamentale è la sua caratura di poeta cortigiano alla corte dei Tolomei.<br />
Dati questi presupposti, come si può arrivare a definire Callimaco come autore post<br />
moderno?<br />
Il termine post moderno gode oggi di notevole e inflazionata popolarità.<br />
L’impressione è che lo si riferisca un po’ a tutto ciò che piace a chi lo adopera. Se invece si<br />
intende il post moderno come una vera e propria categoria spirituale, allora si possono<br />
fare alcune osservazioni.<br />
E’ noto che il passato ci condiziona e preme su di noi in modo più o meno<br />
avvertibile. Proprio di tutte le avanguardie è fare i conti col passato per toglierlo di mezzo:<br />
1 B.Snell, Il giocoso in Callimaco, in La cultura greca e le origini del pensiero europeo, Torino<br />
1963, pp. 369-386.<br />
3
così i futuristi dicevano “abbasso il chiaro di luna” per polemizzare contro l’albagia<br />
poetica dannunziana e non che allora imperava. L’avanguardia distrugge dunque il<br />
passato e va avanti, magari approdando in letteratura alla pagina bianca. Quando però<br />
l’avanguardia arriva a questo punto non più oltrepassabile, ecco che rispunta all’orizzonte<br />
il passato che in qualche modo costringe di nuovo a fare i conti con lui. Ma in che modo?<br />
Non in modo innocente, certo, perché non sarebbe più possibile, ma con ironia, cioè in<br />
modo post moderno.<br />
Immaginiamo l’atteggiamento post moderno come quello di un uomo che, in una<br />
conversazione salottiera con persone colte, voglia colpire l’attenzione dei suoi avveduti<br />
ascoltatori impegnati a parlare di donne e sappia che non può farlo dicendo: , perché sa<br />
che essi sanno che lui sa che questa frase l’ha già detta Oscar Wilde. Non gli rimane che<br />
dire: . <strong>In</strong> questo modo l’uomo evita di parlare in modo<br />
innocente e diretto e sarà brillantemente intervenuto nella conversazione. Gli interlocutori<br />
per parte loro sapranno di avere di fronte un uomo di chiare reminiscnze letterarie.<br />
L’uomo e i suoi interlocutori avranno così retto la sfida del passato, cioè con la cosa già<br />
detta e che non si può eliminare né ripetere pedissequamente, avranno con<br />
consapevolezza e piacere intellettuale giocato al gioco dell’ironia e saranno ancòra una<br />
volta riusciti a parlare di donne 2.<br />
A questo punto come si può sfuggire alla tentazione di definire post moderno<br />
Callimaco?<br />
Riportiamo qui di seguito tre testi callimachei che possono fornire elementi a<br />
rincalzo della tesi sostenuta nelle righe precedenti. Il primo passo è la parte iniziale del<br />
celebre prologo degli Aitia, poema in quattro libri di distici elegiaci, destinato alla<br />
etnografica, antropologica, antiquaria, filologica ed errabonda indagine delle cause (da qui<br />
il titolo) di feste, tradizioni, culti, appellativi diffusi nel mondo greco mediterraneo.<br />
<strong>In</strong> realtà l’esordio degli Aitia ha poco a che vedere con la materia erudita che sarà<br />
oggetto dell’opera, perché innesca una brillante polemica letteraria contro i Telchini,<br />
mitica stirpe di fabbri-maghi, sorta di demoni delle miniere, residenti in varie località del<br />
Mediterraneo e particolarmente a Creta e a Rodi, proverbialmente gelosi della propria<br />
arte, invidiosi di quella altrui e astiosi a tal punto da gettare il malocchio su chi ritenessero<br />
loro temibile concorrente. Questa specie di gnomi fegatosi e irascibili rappresenta i<br />
detrattori della poesia callimachea, che la tradizione individua negli epigrammisti<br />
Asclepiade e Posidippo, nel filosofo peripatetico Prassifane di Mitilene e nel direttore della<br />
biblioteca d’Alessandria Apollonio Rodio 3. Noi moderni non siamo in grado di spendere<br />
una parola definitiva sulla vera identità dei Telchini, però la critica che rivolgono a<br />
Callimaco è chiara: il poeta-filologo di Cirene non ha le risorse per comporre un poema<br />
organico, di largo afflato e argomento eroico; se oltrepassa la misura di pochi versi è un<br />
poeta perso, che non ha la stoffa necessaria per reggere uno sforzo poetico sublime e<br />
protratto. Callimaco ribatte dicendo che non di limite suo intrinseco si tratta, ma di<br />
deliberata e consapevole scelta poetica: egli intende programmaticamente evitare di<br />
percorrere le vie dei predecessori perseguendo l’originalità che scaturisce dalla brevità<br />
pregnante, pura e levigata di versi in grado di rappresentare realtà inedite grazie a<br />
inaspettati spostamenti del punto di vista (accredita ironicamente il suo sguardo poetico<br />
2 Per queste considerazioni sono evidente debitore di U.Eco, Postille al Nome della rosa, “Alfabeta”<br />
n. 49, giugno 1983.<br />
3 La critica dei Telchini è compatibile con posizioni peripatetiche: fra i nomi citati non pare dunque<br />
fuori luogo quello del filosofo Prassifane. Nella Poetica Aristotele afferma che l’opera letterariaanche<br />
se è la tragedia il genere letterario che sta esaminando- è imitazione di un’azione completa,<br />
intera, grande, degna e il mito trattato deve essere uno solo.<br />
4
come quello di un bambino -pai`ı- innocente di fronte al gran teatro del mondo) come pure<br />
in grado d’incantare il lettore con il potere evocativo dei nomi (citare Mimnermo<br />
suggestiona il cultore di lirica arcaica con rimembranze emotive), di divertirlo con le note<br />
pungenti di un umorismo figlio di arguta intelligenza e del gusto della sotterranea<br />
citazione, del nascosto rimando letterario (a questo servono le criptiche allusioni a Filita di<br />
Cos, al mito iliadico dei Pigmei, al ricordo erodoteo dei Massageti come avversari dei<br />
Medi).<br />
Callimaco, Aitia, 1, 1-16<br />
Pavntoqi moi Telci`neı ejpitruvzousin ajoidh`/,<br />
nhvideı oi} Mouvshı oujk ejgevnonto fivloi,<br />
ei{neken oujc e}n a[eisma dihneke;ı h] basilh<br />
... aı ejn pollai`ı h[nusa ciliavsin<br />
... h{rwaı, e[poı d∆ ejpi; tutqo;n eJlivssw 5<br />
pai`ı a{te tw`n d∆ ejtevwn hJ deka;ı oujk ojlivgh4. ... kai; Telci`sin ejgw; tovde: fu`lon ...<br />
... thvkein h|par ejpistavmenon,<br />
...ojligovsticoı: ajlla; kaqevlkei<br />
...polu; th;n makrh;n o[mpnia Qesmofovroı: 5 10<br />
tai`n de; duoi`n Mivmnermoı o{ti glukuvı, aiJ kata; leptovn<br />
rJhvseiı ...hJ megavlh d∆ oujk ejdivdaxe gunhv.<br />
...ejpi; Qrhvikaı ajp∆ Aijguvptoio pevtoito<br />
ai{mati Pugmaivwn hJdomevnh gevranoı,<br />
Massagevtai kai; makro;n oJisteuvoien ejp∆ a[ndra 15<br />
Mh`dwn: ajhdonivdeı d∆ w|de melicrovterai. 6<br />
4 .<br />
Nhvideı, concordato con Telci`neı, è aggettivo da nh`iı, nhvidoı. ∆Egevnonto è aoristo da<br />
givgnomai mentre ei{neken, variante di e{neken, è congiunzione causale che regge h[nusa, aoristo da<br />
ajnuvw, il cui complemento oggetto è costituito da e}n a[eisma dihnekevı. ”Ate è qui usata come<br />
congiunzione comparativa.<br />
5 <br />
Sono versi molto tormentati dal punto di vista testuale perchè lacunosi. <strong>In</strong> ogni caso pare<br />
attendibile che i Telchini, cioè i denigratori di Callimaco, si rodano per l’invidia della sua fama e del<br />
suo successo. E’ tradizionale l’immagine dell’invidioso che rimane vittima del suo stesso peccato<br />
capitale. Com’è noto l’invidia è l’unico vizio che non procura piacere a chi lo alimenta dentro di sé,<br />
ma solo frustrazione e rodimento. La feconda (o[mpnia) Legislatrice (Qesmofovroı) è la dea Demetra<br />
e così si intitola un’elegia di Filita di Cos, grammatico e poeta contemporaneo di Callimaco. Se si<br />
accetta la proposta di integrazione dru`n th;n makrhvn (“la grande quercia”) si otterrebbe un senso<br />
press’a poco di questo tenore: l’esile elegia di Filita intitolata La feconda Legislatrice supererebbe in<br />
qualità poetica la “massiccia quercia” , cioè un’ignota e ponderosa opera (per altro non pervenutaci)<br />
dello stesso Filita sulla storia della sua patria, così come l’esile spiga, simbolo dell’alimentazione<br />
mediterranea, supera la ghianda, cibo primitivo e proprio delle bestie.<br />
6
Riportiamo qui di seguito due dei sessantadue epigrammi di Callimaco che la<br />
tradizione ci ha consegnato e che sono probabilmente una piccola percentuale di una ben<br />
più vasta produzione epigrammatica andata perduta. La brevitas connaturata<br />
all’epigramma corrisponde in modo pieno alla poetica callimachea ed è per questo che<br />
Callimaco praticò lungamente questa tipologia poetica.<br />
Il primo epigramma è l’ironica dedica di uno scolaretto che accompagna una<br />
maschera di Dioniso con la bocca aperta secondo l’iconografia del tempio dedicato a<br />
Dioniso nell’isola di Samo 7. L’immagine non è ignota alla poesia ellenistica e consente a<br />
Callimaco, ormai affermato maitre à penser del Museo di Alessandria, una sorridente<br />
allusione agli esordi della sua carriera, quando giovane di belle, e per il momento deluse,<br />
speranze faceva il maestro elementare nei sobborghi di Alessandria d’Egitto, annoiandosi<br />
in sbadigli più generosi della bocca aperta della maschera dionisiaca, mentre gli allievi<br />
ripetevano in coro a memoria e per l’ennesima volta un verso delle Baccanti euripidee.<br />
Callimaco, Epigrammi, 48<br />
6<br />
Eujmaqivhn hj/tei`to didou;ı ejme; Si`moı oJ Mivkkou<br />
tai`ı Mouvsaiı: aiJ de; Glau`koı o{kwı e[dosan<br />
ajnt∆ ojlivgou mevga dw`ron 8. ∆Egw; d∆ ajna; th/`de kechnwvı<br />
Pigmei e i Massageti gettino pure da grande distanza frecce contro l’uomo dei Medi: gli usignoli<br />
sono più dolci così>>.<br />
Mimnermo, grande poeta lirico del VII sec.a.C. è da un lato autore di elegie finissime,<br />
dall’altro di un poema epico dal titolo Smirneide sulla storia della città di Smirne: Callimaco intende<br />
dire che la misura della grandezza poetica di Mimnermo l’hanno data gli eleganti e brevi distici<br />
elegiaci, non il tradizionale (e torrentizio?) repertorio epico della Smirneide. A meno che la “grande<br />
donna” non voglia indicare la Nannò, raccolta di poesie per la flautista amata da Mimnermo<br />
frammiste a materiale mitologico e storico. Per noi una cosa è significativa e parla a favore del gusto<br />
callimacheo: le elegie di Mimnermo, sia pure in modo largamente incompleto, ci sono giunte, mentre<br />
della Smirneide e di Nannò non abbiamo pressochè nulla. AiJ...rJhvseiı (congettura del Rostagni) “i<br />
versi” kata; leptovn “torniti con fine levigatezza” è espressione in cui si può apprezzare la<br />
preposizione katav a indicare l’idea di conformità, in questo caso di un verso a una misura di sottile<br />
eleganza. Per inciso Kata; leptovn è il titolo, noto dall’Appendix Vergiliana, di una raccolta non<br />
pervenutaci di poesie brevi pubblicata da Arato di Soli. ∆Edivdaxe è aoristo da didavskw. Ad un<br />
combattimento fra gru e Pigmei si allude in Omero, Iliade, 3, 3 ss. mentre i Massageti sono una<br />
popolazione nomade iranica in movimento tra Mar Caspio e Lago d’Aral, citati da Erodoto, Storie,<br />
1, 209-214 quali bellicosi avversari dei Persiani: in ogni caso l’ampio volo delle gru e l’ipebolica<br />
traiettoria dei dardi sono immagini metaforiche con cui Callimaco esprime il suo biasimo estetico per<br />
il clangore della poesia epica tradizionale e ripone tutta la sua compiacenza nei più amabili usignoli,<br />
cioè per la misura poetica breve, sottile, levigata, vero balsamo per le orecchie del lettore. Pevtoito e<br />
oJisteuvoien sono due ottativi desiderativi.<br />
7 Eliano, La natura degli animali, 7, 48 parla di un’iconografia di Dioniso con la bocca aperta<br />
(osservazione ripresa da Plinio il Vecchio, Storia naturale, 8, 57-58) cui prestano attenzione pure<br />
Eratostene, fr. 28b e Euforione, fr. 19 Powell. <strong>In</strong>oltre un epigramma dedicatorio del genere<br />
appartiene alla produzione di Asclepiade, AP, 6, 308: è uno degli ingredienti precipui della poetica<br />
callimachea il gusto di scrivere testi che contengano allusoni e rimandi ad altri testi.<br />
8 .
kei`mai tou` Samivou diplovon oJ tragikovı<br />
paidarivwn Diovnusoı ejphvkooı: oiJ de; levgousin 5<br />
“ iJero;ı oJ plovkamoı ”, toujmo;n o[neiar ejmoiv. 9<br />
Il testo che riportiamo qui di seguito è un epigramma funerario dedicato a un non<br />
altrimenti noto Menecrate di Eno. Siamo ormai in una letteratura di genere, ovvero di<br />
fronte a un testo non certo pensato per essere iscritto su una lasta tombale, ma per essere<br />
letto ad alta voce, svolgendo comodamente il rotolo papiraceo. E ancòra una volta<br />
Callimaco non tradisce la sua poetica, non sfugge cioè alla tentazione della colta allusione<br />
a un passo dell’Odissea omerica per trovare la giusta tonalità ironica con cui condire i versi:<br />
il suo è un epigramma sepolcrale dedicato a un etilista che ha trovato nel vino un<br />
infallibile aiutante nell’avviarlo all’ultimo passo.<br />
Callimaco, Epigrammi, 61<br />
Ai[nie (kai; su; ga;r w|de) Menevkrateı, oujk e[ti pouluvı<br />
h\sqa… Tiv se, xeivnwn lw`/ste, kateirgavsato…<br />
«H rJa to; kai; Kevntauron… “ o{ moi peprwmevnoı u{pnoı<br />
h\lqen, oJ de; tlhvmwn oi\noı e[cei provfasin” 10.<br />
∆Hitei`to è imperfetto con valore mediale da aijtevw. Didouvı è participio presente da divdwmi<br />
mentre e[dosan è aoristo sempre da divdwmi. E’ qui evidente la citazione omerica (Iliade, 6, 234 ss.)<br />
del celebre passo in cui Glauco scambia le sue armi d’oro con quelle di bronzo di Diomede. Citazione<br />
ironicamente gustosa perché abbassata dalle vette della poesia epica alla più banale prosaicità della<br />
dedica di uno scolaretto.<br />
9 .<br />
Th/`de è avverbio di stato in luogo derivato dal pronome dimostrativo o{de, h{de, tovde.<br />
Kechnwvı è perfetto da caivnw. JIero;ı oJ plovkamoı è citazione di una battuta pronunciata dal dio<br />
Dioniso (v. 494) nelle Baccanti di Euripide, tragedia della quale evidentemente gli zelanti scolari<br />
erano obbligati a mandare a memoria e ripetere collettivamente estratti dei passi ritenuti dal maestro<br />
più significativi. “Oneiar (“profitto”, “vantaggio”, “guadagno”) ha la stessa radice della voce verbale<br />
oJnivnhmi.<br />
10 .<br />
Ai[nie, vocativo da ai[nioı, indica probabimente chi è cittadino di Eno, città greca sulle coste<br />
della Tracia in prossimità delle foci del fiume Ebro. «Wde è avverbio di stato in luogo; pouluvı è<br />
variante di poluvı. Lw`ste è vocativo di uno dei superlativi ricollegabili ad ajgaqovı e regge il genitivo<br />
partitivo xeivnwn. Kateirgavsato è aoristo da katergavzomai. L’avverbio interrogativo h\, rafforzato<br />
dalla particella rJa, introduce una interrogativa indiretta (cfr. in latino la funzione di nonne/num/-ne).<br />
Peprwmevnoı è participio perfetto da un verbo (radice -por) non attestato al presente, ma solo<br />
all’aoristo (e[poron) e al perfetto (pevprwmai). «Hlqen è aoristo da e[rcomai. Il vino capace di<br />
abbattere anche un centauro è dotto rimando al passo di Omero, Odissea, 21, 293-298 nel quale<br />
Antinoo, il leader dei Proci, deride la pretesa di Odisseo in veste di mendìco di partecipare anch’egli<br />
alla gara dell’arco bandita da Penelope, affermando che è il vino a oscurargli la mente come la oscurò<br />
al centauro Eurizione. Racconta il mito che durante le nozze di Piritoo, re dei Lapiti, con Ippodamia,<br />
uno degli invitati, il centauro Eurizione, competamente ebbro, provò a violentare la novella sposa<br />
7
8<br />
PLUTARCO, LA VIRTU’ E IL VIZIO<br />
Com’è noto, la produzione letteraria di Plutarco comprende due grandi sezioni: da<br />
una parte le ventidue coppie di biografie che costituiscono le Vite parallele , dall’altra<br />
un’ottantina di scritti che, per inveterata e convenzionale consuetudine, sono indicati col<br />
titolo latino di Moralia, cioè Scritti morali . Tale consuetudine si spiega col fatto che lo<br />
studioso bizantino Massimo Planude raccolse e riordinò nel XIII secolo queste opere in un<br />
unico manoscritto, che fece iniziare proprio con i testi di carattere morale. <strong>In</strong> realtà nei<br />
Moralia ci sono anche scritti retorico-epidittici, antiquarii, di psicologia umana e animale,<br />
filosofia, pedagogia, politica, teologia, storia naturale, retorica, poetica, letteratura, ma è<br />
indubbio che la sezione delle opere di argomento etico sia quella più corposa e di maggior<br />
successo fra i lettori.<br />
E’ ancor oggi opinione prevalente che il testo qui proposto, ovvero La virtù e il vizio,<br />
sia autonomo, frammentario e incompleto; che sia stato incluso nel corpus delle opere<br />
genuine e integre in quanto promemoria che Plutarco aveva l’abitudine di prendere per<br />
comporre in un secondo momento i suoi scritti; che manifesti evidenti limiti stilistici e<br />
chiari difetti di struttura imputabili proprio all’approssimazione e provvisorietà di<br />
appunti presi nel corso di lunghe e accurate letture 11 .<br />
L’eventuale lettore di questo opuscolo si trova però, al di là di ogni prevenzione, di<br />
fronte a un testo che mal si concilia con la trascuratezza che sarebbe lecito attendersi da<br />
annotazioni, chiose o note prese da Plutarco al solo scopo di fissare concetti ritenuti<br />
importanti o esempi, aneddoti e citazioni giudicati adatti all’illustrazione di una<br />
particolare tesi. Anche ammettendo che abbozzi e annotazioni possano esibire frasi<br />
eleganti o periodi improntati alla prosa d’arte, è però difficile che tutta questa cura formale<br />
si estenda per pagine di seguito. Sorge dunque il dubbio che non ci si trovi di fronte a<br />
abbozzi e annotazioni, ma che si abbia a che fare o con frammenti di opere che hanno una<br />
redazione definitiva o con parti di un unico scritto che viene diviso nel corso delle<br />
travagliate vicende della trasmissione testuale e che diviso arriva all’età di Massimo<br />
Planude e quindi fino a noi.<br />
<strong>In</strong> La virtù e il vizio Plutarco esprime la sua convinzione che la saggezza (phrònesis),<br />
intesa nel senso di prudenza pratica e giudicata parte integrante della filosofia, costituisce<br />
l’arte più alta, perché in grado di sottrarre ogni uomo al dominio della fortuna e del vizio e<br />
di guidarlo alla virtù, che sola può garantire una vita felice e serena. Il benessere infatti<br />
non sta solo nelle cose esterne né dipende dalla fortuna, ma è riposto essenzialmente nella<br />
capacità del singolo individuo di trovare nel proprio intimo quelle risorse spirituali in<br />
grado di proiettare un raggio di gioia e piacevolezza sul mondo attorno a lui.<br />
La virtù e il vizio non si configura come un dialogo di imitazione platonica nè come<br />
un vero e proprio trattato filosofico, ma tradisce la sua natura di declamazione, ovvero di<br />
esercizio di scrittura e di lettura, usuale nelle scuole di retorica dell’età imperiale, per<br />
insegnare ai giovani a affrontare un argomento e a svolgerlo nella maniera più<br />
accattivante possibile per il pubblico. Di scolastico Plutarco mantiene la tendenza a dare<br />
uno spazio forse eccessivo agli artifici stilistici, ma non l’irrilevanza degli argomenti<br />
troppo spesso proposti ai ragazzi delle scuole di retorica come prove di composizione. C’è<br />
in questo scritto, specie nella descrizione di vizi e virtù e dei loro effetti, qualcosa della<br />
diatriba di derivazione cinica. Tuttavia la capacità tecnica della prosa plutarchea di variare<br />
alternando citazioni a esempi, di sollecitare l’attenzione del lettore o dell’ascoltatore con<br />
provocando una furibonda zuffa fra Lapiti e Centauri che si concluse con la sconfitta di questi ultimi<br />
costretti a rifugiarsi sulle pendici del Pindo.<br />
11 Plutarco stesso ricorda la sua abitudine di prendere appunti delle letture in La serenità interiore, 464 E.<br />
Sul tradizionale giudizio di incompletezza e mediocre livello dei sei opuscoli plutarchei si veda K. Ziegler,<br />
Plutarco, Brescia1965, pp.113,117, 119 ss., 166, 176.
similitudini, proverbi, aneddoti, apoftegmi, di ironizzare in tono confidenziale e mai<br />
risentito su taluni paradossi del comportamento umano, lo avvicina all’andamento del<br />
lògos philosophouménos quale svolgono Favorino e Massimo di Tiro.<br />
Non ci sono in La virtù e il vizio pensieri di siderale pregnanza e straordinario<br />
ingegno, ma non per questo si deve supporre una scarsa attitudine di Plutarco alla<br />
profondità speculativa. E’ semplicemente un autore che obbedisce qui a una vocazione<br />
didattica e insieme divulgativa. Didattica sia perché il suo testo rientra nel genere<br />
letterario della declamazione che è tipica delle scuole di retorica, sia perché ha una<br />
trasparente intenzione epidittica (dimostra come la filosofia sia l’unica valida terapia per<br />
controllare le passioni e attutire i colpi della fortuna) e protrettica (esorta e stimola allo<br />
studio della filosofia che conduce all’apprendimento della virtù, la vera garanzia per una<br />
vita felice e serena). Divulgativa perché il suo testo presuppone la tradizione culturale<br />
greca, acquista il sapore di un repertorio del sapere antico, non costretto però all’interno di<br />
un sistema filosofico, ma riportato alla più modesta e confidenziale dimensione di un<br />
amabile conversare sulle comuni esperienze della vita quotidiana di ogni uomo.<br />
La virtù e il vizio è probabilmente, come s’è detto, un’opera giovanile. Già in essa<br />
comunque è chiaro l’atteggiamento ideologico del Plutarco maturo: se da un lato non<br />
rinnega la tradizione culturale ellenica, che guarda con ammirazione e di cui subisce in<br />
modo irresistibile il fascino, dall’altro lato mantiene pur sempre come guida e riferimento<br />
costanti la realtà e la vita quotidiana del suo tempo. Plutarco non ha nulla degli snobistici<br />
pregiudizi di chi vagheggia l’età classica come esemplare e perfetta di fronte alla prosaica<br />
grossolanità del presente, ma non si preclude nemmeno il tentativo di reperire nel passato<br />
quei modelli che, riveduti e corretti, possano imprimere nuovi significati alla sua epoca.<br />
Egli tende a assumere le caratteristiche di uno scrittore che scientemente si propone di<br />
diventare il tramite fra la cultura elaborata dalla Grecia classica e la cultura del tempo a<br />
venire. Per questo La virtù e il vizio non è un opuscolo di filosofia che riproponga pari pari<br />
tesi stoiche o ciniche o peripatetiche, ma è un’opera che semmai le presuppone, per<br />
esortare, senza facili moralismi, crude invettive, risentiti rigorismi, a uno stile di vita cui la<br />
ragione suggerisca sempre misura, decoro, integrità morale e dal quale derivino serenità e<br />
soddisfazione. <strong>In</strong>utile aggiungere che è poi il Cristianesimo a segnare i tempi nuovi e a<br />
dettare in ambito etico coordinate sostanzialmente diverse da quelle cui Plutarco si attiene.<br />
Bisogna per altro ricordare che nell’Umanesimo e nel Rinascimento, quando si rinviene nei<br />
testi classici la spinta a un rinnovamento totale dell’uomo nei suoi rapporti con se stesso,<br />
gli altri, la realtà esterna e Dio, proprio Plutarco è uno degli scrittori più letti e amati,<br />
perché la sua opera viene intesa come una sorta di enciclopedia dei valori del mondo<br />
classico. Sono pochi gli autori, e non necessariamente i più grandi, che riescono come<br />
Plutarco a fissare e a trasmettere alle generazioni successive e fino a noi quell’immagine,<br />
certo stereotipata, semplificatrice, oleografica e inesatta, ma indubbiamente suggestiva,<br />
della classicità come l’epoca che rinviene il proprio fondamento etico e ideologico in<br />
princìpi quali l’armonia, l’equilibrio interiore, la ragionevolezza, la dignità, l’urbanità dei<br />
modi, il senso del dovere, la solidarietà civica 12 .<br />
12 La pubblicazione nel 1872 del saggio di F. Nietzsche, La nascita della tragedia, ha certo segnato una<br />
rottura nei confronti della tradizionale concezione della classicità di stampo hegeliano e winckelmanniano.<br />
Tuttavia la distinzione fra il “dionisiaco” e l’ “apollineo” (che si attua in una conflittualità permanente di<br />
coppie opposte come caos-cosmo, finito-infinito, istinto-ragione e così via) si armonizza nella tragedia attica<br />
di V sec.a.C. che dimostra la complementarità di Dioniso e Apollo, suggerendo la conclusione che i loro<br />
rispettivi mondi siano contrapposti solo in apparenza. Oggi si tende a interpretare il mito greco come<br />
l’esperienza di una totalità che attutisce, compendia e in definitiva annulla gli elementi conflittuali. Per<br />
queste considerazioni si veda E. Corsini, Lo Stato come perfetta tragedia, “Sigma” 1-2, 1976, pp. 3-42, part. p.9 e<br />
n. 4.<br />
9
10<br />
NOTA BIOGRAFICA<br />
Plutarco nasce presumibilmente qualche anno prima del 50 d.C. a Cheronea, piccolo<br />
centro nella Beozia occidentale quasi ai confini con la Focide, sotto l’imperatore Claudio.<br />
La sua famiglia è antica e illustre. Stando a quanto egli stesso racconta, il padre Autobulo è<br />
un greco con un rigoroso senso della gravitas romana e discreta cultura filosofica. Il<br />
nonno, Lampria, è una gran brava persona come pure un signore piuttosto eccentrico che<br />
ama coltivare discipline scientifiche e umanistiche, gode di una memoria notevolissima e<br />
sfoggia un’arguzia intelligente. Gli vogliono un gran bene Plutarco e i suoi due fratelli<br />
Timone e Lampria. Della madre, per il fatto che morì giovane più che per consolidato e<br />
ellenico pregiudizio patrilineare, non si possiedono notizie apprezzabili.<br />
Plutarco studia a Atene. Segue le lezioni del filosofo accademico Ammonio.<br />
Quando diventerà famoso gli ateniesi gli concederanno la cittadinanza onoraria. Secondo<br />
il costume culturale dell’epoca, come tutti i rampolli promettenti di illustre e danarosa<br />
famiglia, compie alcuni viaggi. Conosce la Grecia, poi va in Egitto e, forse, in Asia Minore.<br />
Fra il 75 e il 90, risiede più volte a Roma, incaricato forse di qualche missione politica, ma<br />
più probabilmente per seguire e tenere lezioni e conferenze. Si succedono all’impero<br />
Vespasiano, Tito e Domiziano. Riceve la cittadinanza romana con il gentilizio di Mestrio:<br />
suo patrono è infatti Lucio Mestrio Floro, consolare sotto Vespasiano e poi proconsole<br />
d’Asia sotto Domiziano. Stringe rapporti di fervida amicizia con Quinto Sosio Senecione,<br />
questore in Acaia, console nel 99, protagonista della seconda guerra dacica, di nuovo<br />
console nel 107 e amico e consigliere del giovane Adriano, il futuro imperatore. A<br />
Senecione Plutarco dedica le Vite parallele, le Questioni conviviali e I progressi nella virtù.<br />
Sempre a Roma Plutarco è in amichevoli rapporti con Caio Minucio Fondano, console nel<br />
107 e proconsole d’Asia sotto Adriano nel 124-125 d.C. Nell’operetta morale Il controllo<br />
dell’ira Plutarco fa di Minucio Fondano uno dei protagonisti del dialogo attribuendogli la<br />
parte principale in qualità di sostenitore del metodo più affidabile per vincere l’iracondia e<br />
controllarla. Si annoverano fra i suoi amici romani anche Nigrino e Quieto Avidio, cui<br />
dedica rispettivamente gli scritti L’amore fraterno e La lenta punizione da parte di Dio, e<br />
Aruleno Rustico, il filosofo stoico condannato a morte in occasione di una “purga” sotto<br />
Domiziano.<br />
Dopo il 90 Plutarco torna a Cheronea e vi si stabilisce in permanenza. Non abbiamo<br />
notizia di altre lunghe permanenze lontano dalla città natale. La sua vita acquista<br />
caratteristiche diametralmente opposte a quella brillante, girovaga, sempre sotto le luci<br />
della ribalta dei neosofisti: è un’esistenza divisa fra gli studi, le lezioni a una cerchia molto<br />
ristretta di allievi, le conversazioni con gli amici e gli affetti familiari. Sua moglie<br />
Timossena, sposata intorno al 70, è colta, cosa davvero insolita per una donna greca. Come<br />
il marito scrive. E’ probabilmente lei l’autrice dell’opuscolo Sull’amore degli ornamenti che<br />
Plutarco raccomanda a Euridice, la destinataria dei suoi Precetti coniugali. La coppia ha<br />
cinque figli, Autobulo, Cherone, Plutarco, Soclaro e Timossena. Ne perde ben tre, due<br />
maschi, Soclaro e Cherone, e Timossena, l’unica figlia. Plutarco e la moglie riescono a<br />
sopportare il dolore con l’aiuto della fede: sono entrambi iniziati ai riti dionisiaci e credono<br />
nell’immortalità dell’anima.<br />
Dal 95 e per non meno di vent’anni Plutarco è duumviro sacerdotale a Delfi: ha<br />
il compito di organizzare i giochi pitici, presiedere le riunioni dell’Anfizionia e occuparsi<br />
dei vari servizi liturgici e sacerdotali. Gli abitanti di Delfi e Cheronea gli erigono un<br />
monumento rendendo pubblica la lode della sua onestà e mitezza. Le uniche cariche<br />
pubbliche le riveste nella sua città. E’ arconte eponimo, sovrintendente dell’edilizia<br />
pubblica, telearco, cioè magistrato di polizia, e forse beotarca. La Suda, un lessico<br />
bizantino, dice che Traiano lo insignì della dignità di consolare nominandolo consigliere<br />
del proconsole d’Acaia. Sincello, cronista bizantino, dice che Plutarco fu procuratore, vale<br />
a dire rappresentante del fisco della provincia d’Acaia nei primi anni dell’impero di
Adriano. Non sono notizie in sé e per sé inverosimili, ma è strano che nelle sue opere<br />
Plutarco, in tutti gli altri casi di amicizie pubbliche e cariche ufficiali così prodigo di<br />
particolari, non ne faccia cenno. Il dubbio pertanto rimane.<br />
Plutarco muore poco dopo il 120. Per altri nel 125 o addirittura nel 127. <strong>In</strong> ogni caso<br />
è imperatore Adriano. Ci è pervenuta solo una parte dei suoi scritti e sono comunque 260<br />
titoli in 320 libri circa: la vita a Cheronea fu davvero proficua sotto il profilo letterario e<br />
certo non turbata dall’angoscia della pagina bianca.<br />
PERI ARETHS KAI KAKIAS (100b-101e)<br />
1. Ta; iJmavtia dokei' qermaivnein to;n a[nqrwpon, oujk aujta; dhvpou qermaivnonta kai;<br />
proçbavllonta th;n qermovthta (kaq∆ eJauto; ga;r e{kaçton aujtw'n yucrovn ejçtin, h|/ kai;<br />
pollavkiç kaumatizovmenoi kai; purevttonteç ejx eJtevrwn e{tera metalambavnouçin), ajll∆ h}n oJ<br />
a[nqrwpoç ajnadivdwçin ejx eJautou' qermovthta, tauvthn hJ ejçqh;ç tw'/ çwvmati proçpeçou'ça<br />
çunevcei kai; periçtevllei, kai; kaqeirgnumevnhn eijç to; çw'ma oujk eja'/ pavlin çkedavnnuçqai.<br />
taujto; dh; tou'to toi'ç pravgmaçin uJpavrcon ejxapata'/ tou;ç pollouvç, wJç, a]n oijkivaç megavlaç<br />
peribavlwntai kai; plh'qoç ajndrapovdwn kai; crhmavtwn çunagavgwçin, hJdevwç biwçomevnouç. to;<br />
d∆ hJdevwç zh'n kai; iJlarw'ç oujk e[xwqevn ejçtin, ajlla; toujnantivon oJ a[nqrwpoç toi'ç peri; auJto;n<br />
pravgmaçin hJdonh;n kai; cavrin w{çper ejk phgh'ç tou' h[qouç proçtivqhçin.<br />
aijqomevnou de; puro;ç gerarwvteroç oi\koç ijdevçqai,<br />
kai; plou'toç hJdivwn kai; dovxa lamprotevra kai; duvnamiç, a]n to; ajpo; th'ç yuch'ç e[ch/ gh'qoç:<br />
o{pou kai; penivan kai; fugh;n kai; gh'raç ejlafrw'ç kai; proçhnw'ç pro;ç eujkolivan kai;<br />
praovthta trovpou fevrouçin.<br />
2. ÔWç ga;r ajrwvmata trivbwnaç eujwvdeiç kai; rJavkia poiei', tou' d∆ ∆Agcivçou to; çw'ma ijcw'ra<br />
ponhro;n ejxedivdou<br />
nwvtou kataçtavzonta buvççinon favroç,<br />
ou{tw met∆ ajreth'ç kai; divaita pa'ça kai; bivoç a[lupovç ejçti kai; ejpiterphvç, hJ de; kakiva kai; ta;<br />
lampra; fainovmena kai; polutelh' kai; çemna; mignumevnh luphra; kai; nautiwvdh kai<br />
duçprovçdekta parevcei toi'ç kekthmevnoiç.<br />
Ou|toç makavrioç ejn ajgora'/ nomivzetai:<br />
ejpa;n d∆ ajnoivxh/ ta;ç quvraç, triçavqlioç,<br />
gunh; kratei' pavntwn, ejpitavttei, mavcet∆ ajeiv:<br />
kaivtoi gunaiko;ç ouj calepw'ç a[n tiç ajpallageivh ponhra'ç ajnh;r w[n, mh; ajndravpodon: pro;ç de;<br />
th;n eJautou' kakivan oujk e[çti grayavmenon ajpovleiyin h[dh pragmavtwn ajfei'çqai kai;<br />
ajnapauveçqai genovmenon kaq∆ auJtovn, ajll∆ ajei; çunoikou'ça toi'ç çplavgcnoiç kai;<br />
proçpefukui'a nuvktwr kai; meq∆ hJmevran<br />
11
12<br />
eu{ei a[ter daloi'o kai; wjmw'/ ghvrai> dw'ken,<br />
barei'a çunevkdhmoç ou\ça di∆ ajlazoneivan kai; polutelh;ç çuvndeipnoç uJpo; licneivaç kai;<br />
çuvgkoitoç ojdunhrav, frontivçi kai; merivmnaiç kai; zhlotupivaiç ejkkovptouça to;n u{pnon kai;<br />
diafqeivrouça. kai; ga;r o} kaqeuvdouçi tou' çwvmatoç u{pnoç ejçti; kai; ajnavpauçiç, th'ç de; yuch'ç<br />
ptoi'ai kai; o[neiroi kai; taracai; dia; deiçidaimonivan.<br />
”Otan de; nuçtavzontav m∆ hJ luvph lavbh/,<br />
ajpovllum∆ uJpo; tw'n ejnupnivwn<br />
fhçiv tiç: ou{tw de; kai; fqovnoç kai; fovboç kai; qumo;ç kai; ajkolaçiva diativqhçi. meq∆ hJmevran<br />
me;n ga;r e[xw blevpouça kai; çuçchmatizomevnh pro;ç eJtevrouç hJ kakiva duçwpei'tai kai;<br />
parakaluvptei ta; pavqh, kai; ouj pantavpaçi tai'ç oJrmai'ç ejkdivdwçin eJauth;n ajll∆ ajntiteivnei<br />
kai; mavcetai pollavkiç: ejn de; toi'ç u{pnoiç ajpofugou'ça dovxaç kai; novmouç kai; porrwtavtw<br />
genomevnh tou' dedievnai te kai; aijdei'çqai, pa'çan ejpiqumivan kinei' kai; ejpanegeivrei to;<br />
kakovhqeç kai; ajkovlaçton. Æmhtriv te ga;r ejpiceirei' mivgnuçqai,Æ w{ç fhçin oJ Plavtwn, kai;<br />
brwvçeiç ajqevçmouç proçfevretai kai; pravxewç oujdemia'ç ajpevcetai, ajpolauvouça tou'<br />
paranomei'n wJç ajnuçtovn ejçtin eijdwvloiç kai; favçmaçin eijç oujdemivan hJdonh;n oujde; teleivwçin<br />
tou' ejpiqumou'ntoç teleutw'çin, ajlla; kinei'n movnon kai; diagriaivnein ta; pavqh kai; ta;<br />
noçhvmata dunamevnoiç.<br />
3. Pou' toivnun to; hJdu; th'ç kakivaç ejçtivn, eij mhdamou' to; ajmevrimnon kai; to; a[lupon mhd∆<br />
aujtavrkeia mhd∆ ajtaraxiva mhd∆ hJçuciva… tai'ç me;n ga;r th'ç çarko;ç hJdonai'ç hJ tou' çwvmatoç<br />
eujkraçiva kai; uJgiveia cwvran kai; gevneçin divdwçi: th'/ de; yuch'/ oujk e[çtin ejggenevçqai gh'qoç<br />
oujde; cara;n bevbaion, a]n mh; to; eu[qumon kai; a[fobon kai; qarralevon w{çper e{dran h]<br />
galhvnhn a[kluçton uJpobavlhtai, ajlla; ka]n uJpomeidiavçh/ tiç ejlpi;ç h] tevryiç, au{th tacu;<br />
frontivdoç ejkrageivçhç w{çper ejn eujdiva/ çpilavdoç çunecuvqh kai; çunetaravcqh.<br />
4. ”Aqroize cruçivon, çuvnage ajrguvrion, oijkodovmei peripavtouç, e[mplhçon ajndrapovdwn th;n<br />
oijkivan kai; crewçtw'n th;n povlin: a]n mh; ta; pavqh th'ç yuch'ç kataçtorevçh/ç kai; th;n ajplhçtivan<br />
pauvçh/ç kai; fovbwn kai; frontivdwn ajpallavxh/ç çautovn, oi\non dihqei'ç purevttonti kai; colikw'/<br />
mevli proçfevreiç kai; çitiva kai; o[ya koiliakoi'ç eJtoimavzeiç kai; duçenterikoi'ç, mh; çtevgouçi<br />
mhde; rJwnnumevnoiç ajlla; proçdiafqeiromevnoiç uJp∆ aujtw'n. oujc oJra'/ç tou;ç noçou'ntaç o{ti tw'n<br />
brwmavtwn ta; kaqariwvtata kai; polutelevçtata duçceraivnouçi kai; diaptuvouçi kai;<br />
paraitou'ntai proçferovntwn kai; biazomevnwn, ei\ta, th'ç kravçewç metabalouvçhç kai;<br />
pneuvmatoç crhçtou' kai; glukevoç ai{matoç ejggenomevnou kai; qermovthtoç oijkeivaç,<br />
ajnaçtavnteç a[rton lito;n ejpi; turw'/ kai; kardavmw/ caivrouçi kai; ajçmenivzouçin ejçqivonteç…<br />
toiauvthn oJ lovgoç ejmpoiei' th'/ yuch'/ diavqeçin. aujtavrkhç e[çh/, a]n mavqh/ç tiv to; kalo;n kajgaqovn<br />
ejçti: trufhvçeiç ejn peniva/ kai; baçileuvçeiç kai; to;n ajpravgmona bivon kai; ijdiwvthn oujde;n h|tton
ajgaphvçeiç h] to;n ejpi; çtrathgivaiç kai; hJgemonivaiç: ouj biwvçh/ filoçofhvçaç ajhdw'ç, ajlla;<br />
pantacou' zh'n hJdevwç maqhvçh/ kai; ajpo; pavntwn: eujfranei' çe plou'toç pollou;ç eujergetou'nta<br />
kai; peniva polla; mh; merimnw'nta kai; dovxa timwvmenon kai; ajdoxiva mh; fqonouvmenon.<br />
LA VIRTU’ E IL VIZIO<br />
1. I vestiti danno l’impressione di riscaldare chi li indossa, mentre ovviamente non<br />
sono caldi in sé e per sé né emanano calore (perché di per sé ciascuno di essi è freddo, e<br />
questo è il motivo per cui spesso chi soffre il caldo e chi ha la febbre continua a cambiarne<br />
uno con l’altro), ma è la veste che, aderendo al corpo, trattiene e conserva il calore che<br />
l’uomo emana da sé, e rinserrandolo nel corpo non gli permette di disperdersi. Càpita<br />
proprio la stessa cosa nelle vicende umane e questo inganna la maggior parte della gente<br />
dandole a credere che la vita sarà felice se ci si circonda di ampie case e si ammassa un<br />
gran numero di schiavi e ricchezze. <strong>In</strong>vece una vita felice e serena non proviene da<br />
qualcosa di esterno a noi, ma al contrario è l’uomo che rende piacevole e gioiosa la realtà<br />
intorno a lui, quasi che piacere e gioia scaturiscano dal suo carattere come da una fonte 13 .<br />
Se il fuoco è acceso, più maestosa è la casa a vedersi 14 ,<br />
e più piacevole la ricchezza e più splendenti fama e autorevolezza, se si possiede la gioia<br />
che proviene dall’anima. Anche ristrettezze economiche, esilio e vecchiaia si sopportano<br />
con facilità e senza acredine se si sopportano col conforto di un carattere dolce e mite.<br />
2. Come infatti i profumi danno un buon odore a mantellacci logori e vestitucci<br />
sbrindellati, mentre il corpo di Anchise secerneva fetido sudore<br />
che giù per la schiena gli intrideva il manto di tessuto finissimo, 15<br />
così ogni condizione, ogni genere di vita è privo di tristezza e piacevole quand’è in<br />
compagnia della virtù, mentre il vizio, se si mescola a cose in apparenza splendide, di<br />
gran valore e nobili, le rende penose, nauseanti e moleste per chi le possiede.<br />
Nell’agorà lo considerano felice;<br />
ma quando apre la porta di casa, tre volte sventurato:<br />
la moglie domina incontrastata, dà ordini, è sempre in armi. 16<br />
Eppure non sarebbe difficile sbarazzarsi di una cattiva moglie per chi è un uomo vero e<br />
non uno schiavo; contro il proprio vizio invece non è possibile inoltrare istanza di ripudio,<br />
trovarsi all’istante liberi da guai, recuperare tranquillità e il pieno possesso di se stessi, ma<br />
il vizio, che ha messo le radici nelle viscere e lì cresce notte e giorno,<br />
brucia senza bisogno di fuoco e vota a prematura vecchiaia, 17<br />
13 Qui Plutarco riecheggia Zenone di Cizio (336/5-264/3 a.C. circa) il fondatore dello stoicismo. Cfr. H.<br />
Von Arnim, Stoicorum Veterum Fragmenta, I, Lipsiae 1903, p. 50.<br />
14 Citazione dal Certame fra Omero e Esiodo , 274, operetta anonima databile all’incirca al IV sec. a. C. E’ un<br />
verso caro a Plutarco: ritorna anche nel dialogo Sull’amore, 762 D.<br />
15 Citazione dal Laocoonte di Sofocle. Cfr. Nauck, TGF 2 , n° 344.<br />
16 Probabile citazione da Menandro (342/1-291/0 a.C.). Cfr. Kock, CAF , III, fr. 302.<br />
13
pesante compagno di viaggio per la sua protervia, esoso commensale per la sua golosità e<br />
fastidioso compagno di letto, perché spezza e guasta il sonno con pensieri, preoccupazioni<br />
e invidie. E infatti quel po’ che si riesce a dormire è sonno e riposo solo per il corpo, ma<br />
per l’anima non sono che angosce, incubi e inquietudini provocati dalla superstizione.<br />
14<br />
Quando mi prende l’angoscia mentre vengo vinto dal sonno,<br />
io sono distrutto dai sogni 18<br />
dice un tale: lo riducono in questo stato invidia, paura, rabbia e intemperanza. Di giorno<br />
infatti il vizio getta uno sguardo al di fuori di sé, conforma la propria attitudine alle altre e<br />
così si inibisce, nasconde le proprie inclinazioni, non si abbandona del tutto ai suoi<br />
impulsi, ma spesso vi resiste e li combatte; nel sonno invece si sottrae ai comuni freni<br />
inibitori e alle leggi, è lontanissimo dal provare paura e ritegno, eccita ogni capriccio,<br />
risveglia la propria perversione e dissolutezza. “Cerca infatti di unirsi alla madre”, come<br />
dice Platone 19 , e porta alla bocca cibi proibiti e non si astiene da nessuna azione, godendo<br />
di violare la legge il più possibile posseduto com’è da allucinate suggestioni che non<br />
approdano a alcun piacere né all’appagamento del desiderio, ma hanno solo il potere di<br />
eccitare e inasprire le sue passioni e patologiche perversioni.<br />
3. Dov’è dunque che il vizio è piacevole se niente in lui comporta tranquillità, gioia,<br />
autosufficienza, imperturbabilità, serenità? Una buona e tonica condizione fisica suscita e<br />
origina i piaceri della carne. Nell’anima invece non è possibile che germoglino gioia e<br />
felicità costanti, se calma, sicurezza e determinazione non sono presupposte come fondo<br />
o come bonaccia non battuta da onde, ma anche se le sorride una qualche speranza o<br />
soddisfazione, l’anima rimane sùbito scombussolata e sconvolta, perchè esplode il suo<br />
tormento come una tempesta a ciel sereno.<br />
4. Accumula oro, ammassa argento, costruisci portici, riempi la casa di schiavi e la<br />
città di debitori: se non spegni le passioni dell’anima, se non metti fine ai tuoi insaziabili<br />
desideri e non ti liberi di paure e inquietudini, tu versi lentamente del vino a uno che ha la<br />
febbre, offri del miele a un bilioso, prepari pietanze e manicaretti per gente che soffre di<br />
coliche e dissenteria e che non può digerire alimenti del genere o venirne rinvigorita, ma<br />
ne è quasi uccisa. Non vedi che gli ammalati vomitano, sputano e rifiutano i cibi più fini e<br />
squisiti se glieli si offre e si cerca di farglieli mangiare a forza, e poi, quando ritorna la<br />
salute e si ristabiliscono respirazione regolare, sangue dolce e temperatura normale, si<br />
tirano su dal letto e si mettono a mangiare con piacere e gusto pane comune con<br />
formaggio e crescione? E’ il buon senso che suggerisce all’anima una disposizione del<br />
genere. Sarai autosufficiente se capisci cos’è la perfezione morale: vivrai signorilmente<br />
nella ristrettezza, sarai come un re e ti piacerà una vita lontana da incombenze ufficiali e<br />
riservata non meno di una impegnata in alti incarichi militari e civili. Se diventi un filosofo<br />
la tua vita non sarà sgradevole, ma imparerai a vivere gustando la vita indipendentemente<br />
dal luogo e dalle circostanze in cui tu ti venga a trovare. Ti farà piacere essere ricco perché<br />
potrai fare del bene a molta gente come pure essere povero perché non avrai molti fastidi,<br />
e ti farà piacere essere conosciuto perché sarai stimato, come pure essere sconosciuto<br />
perché non sarai invidiato.<br />
17 Citazione da Esiodo, Le opere e i giorni, 705. La donna cui si riferisce il testo esiodeo è una moglie<br />
cattiva, ingorda, avida, della quale -dice Esiodo- non c’è nulla di peggio al mondo. Plutarco cita lo stesso<br />
verso (vedi infra ) in La brama della ricchezza, 527 A.<br />
18 E’ citazione di un ignoto autore della commedia nuova. Cfr. Kock, CAF , III, Adesp. n° 185.<br />
19 Citazione da Platone, Repubblica, 571 C in cui il soggetto è l’elemento ferino e selvaggio<br />
(to qhriwdes kai agrion) presente nella psiche individuale e che si contrappone all’elemento razionale e<br />
equilibrato (to logistikon kai hmeron). Plutarco cita questo stesso passo platonico anche nell’operetta<br />
morale Come constatare i propri progressi verso la virtù, 83 A.