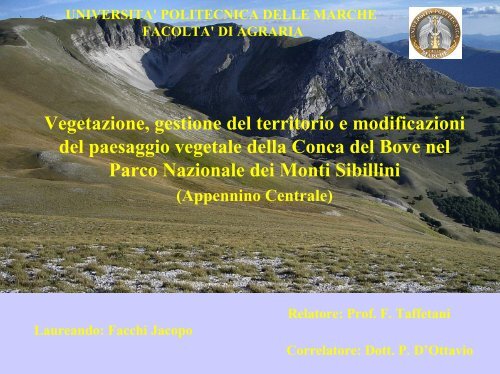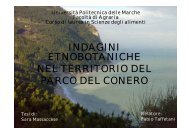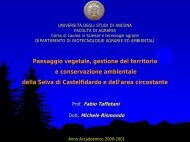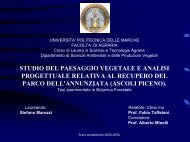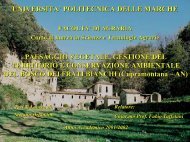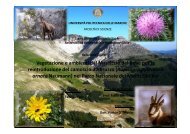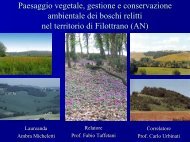Studio del paesaggio vegetale - Museobotanico.Univpm.It
Studio del paesaggio vegetale - Museobotanico.Univpm.It
Studio del paesaggio vegetale - Museobotanico.Univpm.It
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE<br />
FACOLTA' DI AGRARIA<br />
Vegetazione, gestione <strong>del</strong> territorio e modificazioni<br />
<strong>del</strong> <strong>paesaggio</strong> <strong>vegetale</strong> <strong>del</strong>la Conca <strong>del</strong> Bove nel<br />
Parco Nazionale dei Monti Sibillini<br />
Laureando: Facchi Jacopo<br />
(Appennino Centrale)<br />
Relatore: Prof. F. Taffetani<br />
Correlatore: Dott. P. D’Ottavio
Obiettivi <strong>del</strong>la tesi<br />
• <strong>Studio</strong> <strong>del</strong> <strong>paesaggio</strong> <strong>vegetale</strong><br />
• Analisi storica <strong>del</strong>le attività agro-pastorali<br />
• <strong>Studio</strong> alpicolturale
Collocazione geografica<br />
• Parco Nazionale dei Monti<br />
Sibillini<br />
• Bacino orografico <strong>del</strong> Nera<br />
• Comune di Ussita (MC)<br />
• Monte Bove Sud (2169 m)<br />
• Monte Bove Nord (2112 m)<br />
• Monte Bicco (2052 m)
Caratterizzazione geomorfologica<br />
• La valle ha una conformazione ad U<br />
in cui sono ancora evidenti i segni<br />
lasciati dall’azione <strong>del</strong>l’ultima<br />
glaciazione<br />
• Nel periodo wurmiano il ghiacciaio<br />
raggiunse i 1650 m di quota<br />
• Circo glaciale alla testata <strong>del</strong>la valle<br />
• Depositi morenici nel settore centrale<br />
<strong>del</strong>la valle<br />
Il Territorio <strong>del</strong> Parco Nazionale dei Monti<br />
Sibillini è costituito da rocce calcaree<br />
Ad ovest una dorsale calcarea e calcareomarnosa<br />
Ad est una fascia collinare marnoso-arenacea
Caratterizzazione climatica<br />
Ussita (813 m) Bolognola (1445 m )<br />
Monte Bove Sud (1950 m)<br />
Località Macrobioclima Bioclima Ombroclima<br />
Ussita (813 m) Supratemperato<br />
superiore<br />
Bolognola (1445 m) Supratemperato<br />
inferiore<br />
Monte Bove Sud (1950 m) Orotemperato<br />
inferiore<br />
Temperato oceanico Iperumido inferiore<br />
Temperato oceanico Umido inferiore<br />
Temperato oceanico Umido superiore
<strong>Studio</strong> <strong>del</strong> <strong>paesaggio</strong> <strong>vegetale</strong><br />
Materiali e metodi<br />
• L’analisi <strong>del</strong> <strong>paesaggio</strong> <strong>vegetale</strong> parte dal presupposto che<br />
le diverse specie occupano diversi habitat in funzione<br />
ciascuna <strong>del</strong>le proprie esigenze ecologiche e formano così<br />
<strong>del</strong>le cenosi che sono il frutto <strong>del</strong>l’interagire <strong>del</strong>le specie<br />
animali e vegetali sia tra loro sia con i fattori ambientali<br />
come clima e suolo<br />
• Lo studio fitosociologico è stato condotto al fine di<br />
ricostruire la vegetazione ed in base all’interpretazione<br />
dinamica <strong>del</strong>la scuola europea di Rivas-Martinez e di Géhu<br />
sono stati definiti i rapporti gerarchici tra le diverse<br />
formazioni vegetali
<strong>Studio</strong> <strong>del</strong> <strong>paesaggio</strong> <strong>vegetale</strong><br />
• Nel corso di due stagioni estive sono stati effettuati 103 rilievi fitosociologici ed<br />
individuate 355 entità floristiche. Di queste, 25 specie sono di particolare interesse, in<br />
quanto endemismi o perché poco diffuse nell’Appennino umbro-machigiano<br />
Achillea barellieri<br />
Alchemilla flabellata<br />
Arenaria graminifolia<br />
Cystopteris fragilis<br />
Erigeron epiroticus<br />
Erodium alpinum<br />
Gagea fistulosa<br />
Isatis allionii<br />
Juncus monanthus<br />
Minuartia graminifolia<br />
Minuartia laricifolia Saxifraga cesia<br />
Nigritella widderi<br />
Plantago atrata<br />
Plygala angelisii<br />
Ranunculus alpestris<br />
Ranunculus illyricus<br />
• Nigritella widderi: pianta erbacea<br />
perenne, sulle Alpi è abbastanza<br />
diffusa, ma rara sull’Appennino<br />
Silene quadridentata<br />
Solenantus apenninus<br />
Thalictrum minus<br />
Thlaspi stylosum<br />
Vaccinium myrtillus<br />
Veronica aphilla<br />
Vitaliana primulaeflora<br />
• Saxifraga exarata ssp.<br />
ampullacea: specie endemica,<br />
cresce sulle rupi calcaree al di<br />
sopra dei 1800 m di quota
<strong>Studio</strong> <strong>del</strong> <strong>paesaggio</strong> <strong>vegetale</strong><br />
• Lo studio fitosociologico <strong>del</strong>la vegetazione, correlato alle caratteristiche bioclimatiche,<br />
pedologiche e morfologiche, ha portato al riconoscimento di 30 formazioni vegetali, di<br />
queste, 16 sono inedite e non individuate in altri settori <strong>del</strong>l’Appennino<br />
• Dallo studio dei rapporti dinamici <strong>del</strong>le associazioni individuate è stato possibile<br />
ricostruire una serie di vegetazione per ciascun piano altitudinale<br />
- Piano bioclimatico montano: serie <strong>del</strong> faggio<br />
- Piano bioclimatico subalpino: serie <strong>del</strong> ginepro nano<br />
- Piano bioclimatico alpino: serie <strong>del</strong> Trifolium pratense ssp. semipurpureum
<strong>Studio</strong> <strong>del</strong> <strong>paesaggio</strong> <strong>vegetale</strong><br />
Piano bioclimatico montano 1. Faggeta<br />
(Pyrolo minoris-Fagetum sylvaticae)<br />
2. Orlo forestale<br />
(Ptilostemo strictae-Melampyretum italici)<br />
3. Prateria semi-mesofila<br />
(Diantho ciliati-Brachypodietum genuensis)<br />
4. Pascolo semi-mesofilo<br />
(Koelerio splendentis-Brometum erecti)<br />
5. Prato-pascolo mesofilo<br />
(Festuco robustifoliae-Arrhenatheretum elatioris)<br />
6. Pascolo scarpate moreniche<br />
(aggruppamento a Plantago atrata)<br />
7. casaletto<br />
8. Vegetazione dei ghiaioni<br />
(Cephalario leucanthae- Saturejetum montanae)<br />
9. Vegetazione dei ghiaioni<br />
(aggruppamento a Drypis spinosa)<br />
10. Vegetazione dei ghiaioni<br />
(Galio majellensis-Festucetum dimorphae)<br />
11. Vegetazione <strong>del</strong>le rocce umide<br />
(aggruppamento a Adenostyles australis)<br />
A. Koelerio splendentis-Brometum erecti<br />
B. aggruppamento a Plantago atrata<br />
C. vegetazione nitrofila
<strong>Studio</strong> <strong>del</strong> <strong>paesaggio</strong> <strong>vegetale</strong><br />
Piano bioclimatico subalpino<br />
1. Arbusteto a ginepro nano<br />
(Daphno oleoidis-Juniperetum alpinae)<br />
2. Pascolo xerico<br />
(Seslerietum apenninae variante a Vitaliana primulaeflora)<br />
3. Pascolo mesofilo<br />
(Poo violaceae-Nardetum strictae subass. viccinietosum<br />
mirtilli)<br />
4. Pascolo xerico<br />
(Polygalo majoris-Seslerietum nitidae)<br />
5. Vegetazione dei ghiaioni<br />
(Isatido allionii-Thlaspietum stylosi)<br />
6. Vegetazione dei ghiaioni<br />
(Leontodo melanotrichi-Scabiosetum graminifoliae)<br />
7. Vegetazione <strong>del</strong>le cenge alla base <strong>del</strong>le rocce<br />
(Poo alpinae-Laserpitietum sileris)
<strong>Studio</strong> <strong>del</strong> <strong>paesaggio</strong> <strong>vegetale</strong><br />
Piano bioclimatico alpino<br />
1. Prateria xerica di cresta<br />
(Seslerietum apenninae)<br />
2. Praterie gradonate xeriche<br />
(Seslerietum apenninae subass.astragaletosum)<br />
3. Vallette nivali<br />
(Ranuncullo pollinensis-Plantaginetum atratae)<br />
4. Vallette nivali<br />
(Taraxaco apennini-Trifolietum thalii)<br />
5. Praterie primarie di versante<br />
(Festuco alfredianae-Trifolietum semipurpurei)<br />
6. Vegetazione <strong>del</strong>le rocce asciutte<br />
(Saxifragion australis)<br />
7.Vegetazione dei ghiaioni<br />
(Isatido allionii-Thlaspietum stylosi)<br />
a. Astragalus sempervirens<br />
b. Sesleria apennina
<strong>Studio</strong> <strong>del</strong> <strong>paesaggio</strong> <strong>vegetale</strong><br />
Carta <strong>del</strong>la vegetazione<br />
• La carta <strong>del</strong> <strong>paesaggio</strong> <strong>vegetale</strong><br />
è stata costruita attraverso una<br />
serie di osservazioni dirette<br />
svolte durante due stagioni di<br />
studio che hanno permesso di<br />
individuare le superfici sulle<br />
quali vegetano le diverse<br />
associazioni descritte dallo<br />
studio fitosociologico<br />
• Utilizzando colori e sfumature<br />
diverse sono stati ricostruiti i<br />
paesaggi vegetali dei piani<br />
bioclimatici montano, subalpino<br />
e alpino e le relative serie di<br />
vegetazione
Analisi storica <strong>del</strong>le attività agro-pastorali<br />
• Attività agricole e pastorali, condotte nei territori <strong>del</strong>l’Alto Nera a<br />
partire dal ‘400 con particolare attenzione agli eventi accaduti<br />
dall’inizio <strong>del</strong> XX secolo<br />
• Pratica <strong>del</strong>la transumanza attraverso la conduzione di interviste a<br />
pastori e a studiosi locali, per mezzo ricerche presso l’Archivi Storico<br />
di Visso dei registri e <strong>del</strong>le assegne <strong>del</strong> bestiame e attraverso le fonti<br />
bibliografiche<br />
• Principali modificazioni<br />
ambientali <strong>del</strong> <strong>paesaggio</strong> e<br />
<strong>del</strong>l’uso <strong>del</strong> suolo, con<br />
particolare riferimento<br />
all’area <strong>del</strong> Bove
Analisi storica <strong>del</strong>le attività agro-pastorali<br />
• Principali eventi che hanno condizionato l’assetto socio-economico<br />
<strong>del</strong>l’Alto Nera<br />
XV sec.: inversione degli XVIII sec.: selezione seconda metà <strong>del</strong> ‘900: crisi<br />
itinerari <strong>del</strong>la transumanza <strong>del</strong>la Sopravissana <strong>del</strong>la pratica <strong>del</strong>la transumanza<br />
prima <strong>del</strong> 1402<br />
dopo <strong>del</strong> 1402<br />
e riconversione turistica
Analisi storica <strong>del</strong>le attività agro-pastorali<br />
• Nell’Archivio storico di Visso sono riportati i documenti che<br />
testimoniano <strong>del</strong> numero di animali che ogni estate, a partire dal XV<br />
sec., erano condotti sui pascoli dei Sibillini<br />
• Preziosi documenti storici:<br />
- Registri <strong>del</strong> Bestiame<br />
- Assegne <strong>del</strong>le pecore
Analisi storica <strong>del</strong>le attività agro-pastorali<br />
• Le principali modificazioni che hanno riguardato l’area <strong>del</strong> Bove sono<br />
- L’aumento <strong>del</strong>le aree coperte da faggeta<br />
- L’aumento <strong>del</strong>le superfici rimboschite con conifere<br />
- L’abbandono attività agricola sull’Altopiano di Frontignano - Riduzione dei fenomeni di erosione<br />
1954<br />
1998
<strong>Studio</strong> alpicolurale - Materiali e metodi<br />
Qualità <strong>del</strong>le risorse foraggere<br />
• L’analisi <strong>del</strong>le attività zootecniche e di gestione <strong>del</strong>le risorse foraggere <strong>del</strong>la Val<br />
di Bove ha permesso di stimare una serie di grandezze che illustrano le principali<br />
caratteristiche quali-quantitative <strong>del</strong>le superfici pascolabili <strong>del</strong>la valle<br />
• Il Valore Pastorale Potenziale (VPP) VPP = Σ Cs i · Is i · 0.2<br />
• Il Valore Pastorale Corretto (VPC) VPC = VPP · CF<br />
VPC = VPP · % di copertura<br />
• Carico potenziale (Cp) Cp = VPC · coefficiente di conversione
<strong>Studio</strong> alpicolturale - Risultati<br />
Qualità <strong>del</strong>le risorse foraggere<br />
Tipo di pascolo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15<br />
Altitudine in m 1745 1579 1503 1757 1792 1857 1343 1522 2081 1964 1945 1945 2099 2032 2148<br />
Numero specie 26 32 25 25 29 35 34 18 25 22 10 31 28 26 14<br />
Graminacee 6 6 6 6 3 2 4 3 7 2 1 4 4 2 2<br />
Leguminose 3 4 3 4 4 2 2 2 1 2 0 3 3 3 2<br />
Altre specie 16 22 17 15 22 31 27 13 17 17 9 25 22 21 9<br />
VPP 22,8 28,3 50,9 19,8 15,4 12,7 5,4 30,7 12,0 13,2 12,4 21,4 30,3 13,8 29,4 21,2<br />
Valore Pastorale Potenziale medio stimato = 21,2<br />
intervallo minimo 5,4 vegetazione n° 7<br />
massimo 50,9 vegetazione n° 3
<strong>Studio</strong> alpicolturale - Risultati<br />
Qualità <strong>del</strong>le risorse foraggere<br />
Tipo di pascolo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15<br />
Ricoprimento (% ) 100 93,8 100 50,0 71,7 33,3 57,5 98,0 97,8 42,5 40,0 45,0 100 50,0 98,0<br />
Instabilità <strong>del</strong> substrato NO NO NO NO NO SI SI NO NO NO SI SI NO NO NO<br />
Eros ione NO NO NO SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO<br />
Inclinazione (gradi) 28,0 18,6 22,0 36,7 30,0 36,7 32,5 22,0 24,3 26,3 45,0 43,3 32,5 26,9 8,0<br />
VPC (con ricoprimento) 22,8 26,9 50,9 9,7 11,0 4,7 3,1 30,1 11,9 5,5 5,0 9,6 30,3 6,9 28,6<br />
CF 0,9 1 1 0,8 0,9 0,8 0,8 1 1 0,9 0,7 0,7 0,9 0,9 1<br />
VPC (con CF) 20,5 26,9 50,9 7,7 9,9 3,8 2,5 30,1 11,9 4,9 3,5 6,7 27,3 6,2 28,6<br />
Carico potenziale 1,7 2,4 4,5 0,7 0,9 0,3 0,2 2,7 0,8 0,4 0,3 0,5 1,9 0,5 2,0 0,99 1,29<br />
• La correzione <strong>del</strong> VPP ha dato un intervallo di valori compresi tra un minimo di 2,5 ed<br />
un massimo di 50,9<br />
• Carico potenziale medio stimato = 0,99 vacche ha -1<br />
intervallo (per un periodo di pascolamento di 110 giorni) minimo di 0,3 vacche ha -1<br />
massimo di 2,4 vacche ha -1<br />
• Carico reale = 1,29 vacche ha -1
<strong>Studio</strong> alpicolurale - Materiali e metodi<br />
Analisi <strong>del</strong> brachipodieto<br />
• Vista l’importanza ecologica e in prospettiva di una diversa gestione<br />
alpicolturale <strong>del</strong>l’area in esame, si è andati alla stima <strong>del</strong> Cp <strong>del</strong> pascolo a<br />
dominanza di Brachypodium genuense, attraverso tre diversi metodi<br />
- <strong>del</strong> Valore Pastorale<br />
- Ponderale<br />
- <strong>del</strong> valore nutritivo<br />
Sono state predisposte 6 parcelle omogenee di 0,5 m 2 , in due diversi settori <strong>del</strong><br />
brachipodieto e da ognuna è stata prelevata tutta la vegetazione presente
Carico potenziale (n° animali ha-1)<br />
<strong>Studio</strong> alpicolturale - Confronto risultati<br />
Analisi <strong>del</strong> brachipodieto<br />
4,5<br />
4,0<br />
3,5<br />
3,0<br />
2,5<br />
2,0<br />
1,5<br />
1,0<br />
0,5<br />
0,0<br />
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1<br />
coefficiente di pascolamento (k)<br />
Valore pastorale Ponderale Valore nutritivo<br />
• L’analisi <strong>del</strong> Carico potenziale <strong>del</strong><br />
brachipodieto stimato con i tre metodi ha<br />
dato valori discordanti<br />
• Il CP stimato con il valore nutritivo è<br />
superiore a quello reale, in quanto prescinde<br />
dalla pabularità e dalla qualità <strong>del</strong> pascolo<br />
• È sovrastimato anche il Carico definito con<br />
il metodo ponderale, in quanto questo non<br />
tiene conto <strong>del</strong>le esigenze alimentari <strong>del</strong>le<br />
diverse categorie di animali<br />
• Con il metodo <strong>del</strong> Valore Pastorale si stima<br />
un CP che più avvicina quello reale, ma<br />
anche ipotizzando il pascolamento di un 30<br />
% <strong>del</strong> brachipodieto, si ritiene che questo<br />
valore sovrastimi il Carico reale
Gestione e conservazione <strong>del</strong>la biodiversità<br />
• La Val di Bove riveste una grande importanza naturalistica all’interno <strong>del</strong> Parco Nazionale<br />
dei Monti Sibillini in quanto, pur avendo una limitata estensione, conserva numerosi<br />
habitat naturali poco diffusi nell’Appennino; ciò ha permesso, in base alle Direttive<br />
“Habitat” e “Uccelli” <strong>del</strong>l’UE, l’inserimento <strong>del</strong>la Val di Bove all’interno <strong>del</strong>le aree SIC e<br />
ZPS <strong>del</strong>la Regione Marche<br />
• La conservazione <strong>del</strong>la biodiversità <strong>vegetale</strong> passa soprattutto attraverso l’adozione di<br />
pratiche alpicolturali che permettano un corretto utilizzo <strong>del</strong>le praterie secondarie<br />
• Attualmente si osserva, in tutta<br />
l’area di fondovalle, una irrazionale<br />
utilizzazione dei pascoli:<br />
•segni di sovrapascolamento nelle<br />
aree di più facile accesso<br />
•effetti di sottoutilizzo per quelle<br />
più acclivi e distanti dall’unico<br />
punto di abbeverata <strong>del</strong>la valle
Proposte per una corretta pratica alpicolturale<br />
nella Val di Bove<br />
• Lo studio alpicolturale ha messo in evidenza per i pascoli <strong>del</strong>la<br />
valle un Carico potenziale stimato superiore a quello reale<br />
• Perché ci sia equilibro tra attività zootecnica e conservazione <strong>del</strong><br />
patrimonio naturale sarebbe necessario apportare alcune modifiche<br />
alle attuali pratiche alpicolturali:<br />
• Anticipare l’inizio <strong>del</strong>la stagione di pascolo in modo da permettere l’utilizzo<br />
anche <strong>del</strong>le formazioni vegetali poco utilizzate dagli animali (vedi<br />
brachipodieto)<br />
• Installare un secondo punto di abbeverata per evitare fenomeni di<br />
sovrapascolamento attorno all’unico abbeveratoio presente<br />
• Maggior controllo da parte <strong>del</strong>l’allevatore per garantire un razionale utilizzo<br />
<strong>del</strong>le aree di pascolo
• Lo studio ha permesso di:<br />
• accrescere le conoscenze<br />
naturalistiche, in particolare su<br />
flora e vegetazione,<br />
• valutare l’ecologia, la<br />
complessità ed il dinamismo <strong>del</strong><br />
<strong>paesaggio</strong>,<br />
• ricostruire quelle pagine di<br />
storia che maggiormente hanno<br />
condizionato l’assetto socioeconomico<br />
e quindi le<br />
modificazioni ambientali di<br />
questo settore cruciale <strong>del</strong> Parco<br />
Nazionale dei Monti Sibillini<br />
Conclusioni
Considerazioni<br />
• Per conservare l’elevata biodiversità<br />
specifica e fitocenotica dei pascoli<br />
secondari è essenziale mantenere<br />
l’attività zootecnica su queste superfici e<br />
la presenza degli operatori locali<br />
attraverso una politica attiva (non più<br />
solo con divieti e norme restrittive)<br />
• Attraverso l’analisi alpicolturale è stato<br />
possibile valutare i principali parametri<br />
quali-quantitativi dei pascoli in modo<br />
tale da proporre un mo<strong>del</strong>lo gestionale<br />
che consenta la salvaguardia e, allo<br />
stesso tempo, la produzione di un<br />
reddito compatibile con una<br />
utilizzazione sostenibile