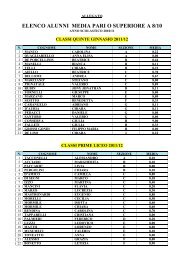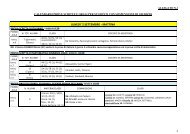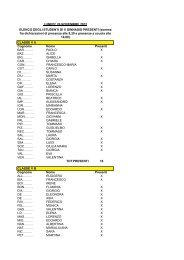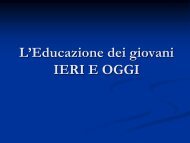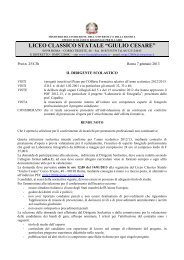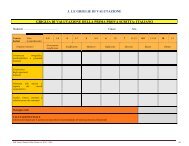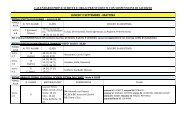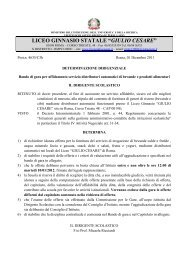Documento finale classe III sez. C - Liceo Giulio Cesare
Documento finale classe III sez. C - Liceo Giulio Cesare
Documento finale classe III sez. C - Liceo Giulio Cesare
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Prot.n.<br />
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA<br />
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO<br />
LICEO CLASSICO STATALE “GIULIO CESARE”<br />
00198 ROMA – CORSO TRIESTE, 48 – Fax 06/85355339 Tel. 06/121124445<br />
X DISTRETTO - RMPC12000C – sito: www.liceogiuliocesare.it – email: rmpc12000c@istruzione.it<br />
DOCUMENTO<br />
DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE <strong>III</strong> SEZ. C<br />
M.C. Escher: Drawing Hands<br />
Anno Scolastico 2012/13<br />
IL DIRIGENTE SCOLASTICO<br />
Prof. Micaela Ricciardi
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE <strong>III</strong> SEZIONE C<br />
Anno scolastico 2012-2013<br />
Sulla base di quanto previsto dall’articolo 5 comma 2 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante<br />
disposizioni per la riforma degli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’Istruzione Secondaria<br />
Superiore, il Consiglio della <strong>classe</strong> <strong>III</strong> liceale <strong>sez</strong>ione C ha definito contenuti, obiettivi, metodi e<br />
strumenti valutativi relativi ai programmi e all'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno<br />
di corso.<br />
DESCRIZIONE DELLA SCUOLA<br />
Il <strong>Liceo</strong> Ginnasio Statale “<strong>Giulio</strong> <strong>Cesare</strong>” di Roma presenta una struttura ideata, per i tempi in cui è<br />
sorto (1936), secondo i più avanzati sistemi di edilizia pubblica.<br />
Situato in zona centrale, appartenente al X Distretto, raccoglie una popolazione scolastica in gran<br />
parte residente nel medesimo Distretto, ma arricchita dalla presenza di studenti provenienti da diversa<br />
collocazione urbana.<br />
L’edificio, che si sviluppa su cinque piani, presenta, oltre alle aule adibite alle normali attività didattiche,<br />
diversi Laboratori (Chimica – Fisica – Lingue – Arte – Scienze – Informatica e multimedialità<br />
) ed aule speciali, tra le quali, in particolare, quelle attrezzate con LIM; inoltre: una ricca Biblioteca,<br />
dotata di moderni sistemi di consultazione; un’Aula Magna, fornita di sussidi audiovisivi; due grandi<br />
palestre e un campo di basket all’aperto; un ambulatorio medico, con servizio di consulenza psicologica.<br />
Dal POF dell’anno scolastico 2012/13 si evince che il <strong>Liceo</strong> focalizza la sua proposta formativa nei seguenti<br />
ambiti: ricerca didattica e progettazione attraverso un’ampia ed esaustiva articolazione di progetti curricolari<br />
ed extracurricolari sui saperi disciplinari e trasversali; perseguimento del successo scolastico, in particolare,<br />
per quanto riguarda le classi <strong>III</strong> liceo, con una specifica attività di orientamento in uscita; educazioni, con<br />
particolare attenzione, in modo trasversale a tutte le discipline, ai seguenti percorsi educativi: educazione alla<br />
legalità e alla cittadinanza attiva; educazione alla mondialità; educazione alla salute<br />
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE<br />
La <strong>classe</strong> <strong>III</strong> C è costituita da ventidue alunni (dodici maschi e dieci femmine). La continuità didattica è stata<br />
sostanzialmente assicurata per le materie scientifiche, Inglese, Educazione fisica e Greco mentre durante<br />
il triennio la <strong>classe</strong> ha visto avvicendarsi ogni anno un professore diverso sulla cattedra di latino e di Storia<br />
dell’Arte, ha cambiato docente di Italiano in secondo liceo e docente di Storia e Filosofia in questo ultimo<br />
anno scolastico. Nella sottostante tabella si mostra il quadro delle alternanze.<br />
Piuttosto eterogenea per provenienza socio-culturale, la <strong>classe</strong> si è andata definendo nel corso degli anni come<br />
un gruppo affiatato in cui la solidarietà tende generalmente a prevalere sulla competizione. Costituita in<br />
prevalenza dall’originario nucleo ginnasiale, si è andata numericamente riducendo; anche nell’anno in corso<br />
due ragazze, scoraggiate dal lavoro richiesto e non potendo contare su una solida preparazione di base, hanno<br />
chiesto il nulla osta nonostante alcuni docenti non approvassero né incoraggiassero la scelta. In compenso<br />
in II liceo un ragazzo e una ragazza provenienti da altra scuola si sono aggiunti al gruppo iniziale, arricchendo<br />
la <strong>classe</strong> con il loro contributo umano e intellettuale.<br />
Eterogenea e fortemente polarizzata dal punto di vista della predisposizione agli studi classici e delle competenze<br />
di base già acquisite, durante il triennio la <strong>classe</strong> nel suo insieme ha compiuto un significativo cammino<br />
di maturazione: tutti gli studenti hanno accresciuto il proprio senso di responsabilità, la capacità di applicazione<br />
allo studio e di rielaborazione dei contenuti appresi. Occorre sottolineare come questo percorso<br />
avrebbe per alcuni prodotto un miglior esito se fosse stato supportato da un impegno più assiduo; certo è che<br />
la mancanza di continuità nell’impegno unita ad alcune carenze di base ha fatto sì che un piccolo gruppo di<br />
studenti si attesti su livelli globalmente sufficienti, ma non ancora consolidati in tutte le discipline. Tutta la<br />
<strong>classe</strong> si è distinta per il comportamento collaborativo alla vita scolastica e per l’interesse nei confronti delle<br />
proposte di arricchimento culturale provenienti dai docenti. L’interesse e l’acquisizione di un personale me-
todo di studio hanno permesso a molti di ampliare l'ambito delle conoscenze e di rielaborarle anche mediante<br />
letture e ricerche personali. Alcuni studenti, all’interno di questo gruppo, possono sicuramente aspirare ad<br />
una valutazione di eccellenza.<br />
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE DURANTE IL BIENNIO<br />
DISCIPLINA A.S. 2008/09 A.S. 2009/10<br />
MATERIE LETTERARIE,<br />
LATINO E GRECO<br />
Cafiero (M.L.)<br />
Durante (lat. Greco)<br />
Cafiero<br />
Durante<br />
MATEMATICA Frigeni Laureti<br />
INGLESE Liberini Liberini<br />
STORIA DELL'ARTE Fiory Fiory<br />
ED. FISICA Mitrano Spinelli<br />
IRC Piani Piani<br />
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE DURANTE IL TRIENNIO<br />
DISCIPLINA A.S. 2010/11 A.S. 2011/12 A.S. 2012/13<br />
ITALIANO Fascetto Petrella Petrella<br />
LATINO/GRECO Fascetto Scagliarini Scagliarini Petrella Scagliarini<br />
STORIA E FILOSOFIA Mannerucci Mannerucci Scozzafava<br />
MATEMATICA E FISICA Frigeni Frigeni Frigeni<br />
INGLESE Liberini Liberini Liberini<br />
SCIENZE Iezza Iezza Iezza<br />
STORIA DELL'ARTE Fiory (Di Mambro) Properzi Capalbo<br />
ED. FISICA Spinelli Spinelli Spinelli<br />
IRC Genovese Genovese Ronconi (Cangiano)<br />
Materia alternativa Cianfanelli Cristina
OBIETTIVI GENERALI E METODI<br />
All’inizio dell’anno scolastico, nelle riunioni preliminari per dipartimento allo scopo convocate, sono stati<br />
concordati i contenuti disciplinari e definiti obiettivi, metodi e criteri di verifica e valutazione; nelle previste<br />
riunioni del Consiglio di Classe è stato programmato e periodicamente verificato il percorso didattico e culturale<br />
della <strong>classe</strong>, avendo cura che in esso si sviluppassero e integrassero omogeneamente gli apporti delle<br />
diverse discipline. In tali sedi sono stati altresì programmati gli obiettivi comuni che si possono riassumere<br />
nei seguenti punti:<br />
1. raggiungimento di livelli di conoscenze sempre più articolate e criticamente supportate, attraverso<br />
l’ampliamento progressivo dei codici linguistici specifici e tecnici in ciascuna disciplina;<br />
2. sviluppo ed incremento di abilità di analisi, di sintesi e di rielaborazione personale delle conoscenze acquisite,<br />
attraverso l’approfondimento delle rispettive metodologie di lavoro per ciascuna disciplina, in<br />
ordine ai differenti oggetti di studio;<br />
3. approfondimento delle tematiche disciplinari attraverso percorsi interdisciplinari;<br />
4. educazione alla legalità e al rispetto dell'altro.<br />
A seguire, suddivisi per materia, vengono indicati gli obiettivi didattici specifici per disciplina.<br />
MATERIA OBIETTIVI SPECIFICI DI DISCIPLINA<br />
ITALIANO 1. Comprendere il significato complessivo di un testo, riconoscerne la tipologia, individuarne gli elementi<br />
strutturali.<br />
2. Organizzare la struttura di un testo scritto usando le funzioni linguistiche in relazione alle diverse situazioni<br />
comunicative.<br />
3. Argomentare in modo chiaro e puntuale, utilizzando un lessico specifico, conforme ai vincoli della<br />
comunicazione.<br />
4. Cogliere le relazioni interne ad uno o più testi, tra il testo e il suo contesto di riferimento; cogliere i<br />
legami che si possono stabilire con le altre discipline. Ricondurre la tradizione letteraria al proprio<br />
tempo, alla propria cultura.<br />
5. Rielaborare autonomamente i contenuti attraverso pertinenti processi di analisi e di sintesi; formulare<br />
giudizi mediante un consapevole utilizzo di strumenti critici e cognizioni culturali, sostenere motivate<br />
e personali valutazioni.<br />
6. Interrogare il testo letterario in rapporto a se stessi e al mondo esterno;<br />
La <strong>classe</strong> ha lavorato molto negli ultimi due anni per raggiungere gli obiettivi<br />
sopra esposti; ha dovuto affinare un metodo di studio volto generalmente<br />
all’acquisizione non critica di conoscenze e perfezionare pratiche di<br />
scrittura spontanee e non correlate alle diverse funzioni comunicative. Per<br />
conseguire tali obiettivi, si è scelto di ridurre i contenuti programmatici e<br />
di lavorare in profondità solo su testi e autori rappresentativi assicurando<br />
però ai ragazzi gli strumenti per integrazioni individuali.<br />
LATINO Tutti gli studenti hanno raggiunto, la consapevolezza delle diverse potenzialità<br />
espressive di un testo letterario e delle tecniche necessarie alla produzione<br />
di una scrittura efficace, non tutti aggiungono alla consapevolezza<br />
la competenza. Un gruppo consistente della <strong>classe</strong> ha pienamente raggiunto<br />
la maggior parte degli obiettivi conseguendo una preparazione eccellente.<br />
Una esigua minoranza della <strong>classe</strong> incontra ancora difficoltà<br />
nell’espressione scritta adeguata ai diversi tipi di testo e nella riflessione<br />
critica sugli argomenti oggetto di studio<br />
GRECO A conclusione del percorso scolastico triennale, si può positivamente evidenziare<br />
il consolidamento di discrete conoscenze dei molteplici aspetti<br />
che caratterizzano lo sviluppo della civiltà e della letteratura greca. Gli stu-
denti più capaci sanno collocare un testo nel sistema letterario, riuscendo<br />
anche ad inquadrarlo all’interno di un genere e a riconoscerne gli aspetti di<br />
continuità culturale; sanno altresì cogliere le reciproche influenze della civiltà<br />
greca con quella latina.<br />
Grazie ad un lodevole impegno da molti profuso per seguire il lavoro volto<br />
alla comprensione e traduzione di testi, la <strong>classe</strong> nel suo complesso ha raggiunto<br />
un adeguato livello nell’interpretazione e un livello buono<br />
nell’analisi critica dei testi proposti durante lo studio della letteratura. Per<br />
questo risultato, una componente positiva è stata sicuramente la continuità<br />
didattica nella disciplina.<br />
STORIA 1) Conoscere e comprendere i contenuti curricolari.<br />
2) Saper collocare i fenomeni storici in modo corretto nel contesto temporale, spaziale, culturale.<br />
3) Utilizzare adeguatamente termini e categorie storiografici.<br />
4) Riconoscere e comprendere la complessità dei processi storici, attraverso l’individuazione e l’analisi<br />
dei rapporti tra i diversi fattori che li costituiscono<br />
5) Saper inquadrare storicamente problematiche sociali, economiche e culturali e riconoscere analogie e<br />
differenze tra fenomeni storici.<br />
6) Conoscere alcune interpretazioni storiografiche e saperle valutare.<br />
Il lavoro in questa <strong>classe</strong>, nella quale insegno solo dal corrente a.s., è stato<br />
orientato al consolidamento (in qualche caso all’acquisizione) di un metodo<br />
di studio sistematico e rigoroso; particolare attenzione è stata rivolta a<br />
sviluppare competenze di analisi ragionata circa la complessità dei fenomeni<br />
storici. Relativamente al punto 6 gli studenti hanno lavorato sulle pagine<br />
di antologia storiografica presenti nel loro libro di testo; solo alcuni,<br />
particolarmente interessati alla disciplina, hanno arricchito la loro preparazione<br />
con letture personali pervenendo ad una visione critica e rielaborata<br />
delle tematiche studiate.<br />
All’inizio dell’anno la <strong>classe</strong> si presentava piuttosto disomogenea relativamente<br />
alle conoscenze e agli strumenti di analisi posseduti; ora la distanza<br />
si è un po’ ridotta e gli studenti, con poche eccezioni, hanno maturato<br />
una visione consapevole dei contenuti.<br />
FILOSOFIA 1) Conoscere gli aspetti fondamentali degli autori e dei movimenti studiati.<br />
2) Saper utilizzare correttamente lessico e categorie filosofiche.<br />
3) Saper individuare i concetti chiave e analizzare la struttura argomentativa di brevi testi.<br />
4) Saper riconoscere la storicità degli autori studiati e saperli collocare correttamente nel contesto culturale.<br />
5) Individuare analogie e differenze tra le diverse teorie e saper confrontare, su alcune problematiche, le<br />
risposte dei filosofi studiati.<br />
6) Esprimere giudizi personali argomentati.<br />
Analoga la situazione di partenza per quanto riguarda filosofia. Il lavoro<br />
didattico è stato improntato al consolidamento di un metodo di studio analitico<br />
e non superficiale. Per ragioni di tempo e per permettere a tutti<br />
un’acquisizione ragionata del lessico, delle categorie e delle tematiche filosofiche<br />
ho trattato solo alcuni autori significativi dell’Ottocento e pochissime<br />
tematiche del Novecento. Per gli stessi motivi le pagine antologiche<br />
analizzate non sono state molte; va indicato che circa metà della <strong>classe</strong> ha<br />
letto e presentato una relazione su “Schopenhauer e Leopardi” di F. De<br />
Sanctis.<br />
Nel corso dell’anno per quasi tutti gli studenti c’è stato una crescita relativamente<br />
agli obiettivi indicati; qualcuno di loro, più interessato e aperto<br />
all’ascolto, ha arricchito lo studio con approfondimenti personali riuscendo<br />
a maturare una visione più personale.
INGLESE Per quanto riguarda la lingua inglese, gli obiettivi sono stati raggiunti quasi<br />
tutti. Gli studenti sono riusciti ad acquisire una certa scioltezza e spontaneità<br />
nell’uso della lingua. Sono in grado di comprendere le idee principali di<br />
varie tipologie di testi inserendoli nel loro contesto storico-sociale.<br />
Sono inoltre in grado di produrre un testo su vari argomenti esprimendo<br />
con chiarezza il loro punto di vista. La preparazione della maggior parte di<br />
loro ha raggiunto il livello B2.<br />
MATEMATICA Gli obiettivi preventivati sono stati raggiunti pienamente solo da alcuni<br />
studenti. La maggior parte degli alunni ha comunque acquisito in modo<br />
soddisfacente i contenuti disciplinari. Abbastanza soddisfacente anche la<br />
capacità di comprendere il linguaggio formale specifico e di utilizzare le<br />
procedure tipiche della matematica. Molti appaiono invece in difficoltà<br />
quando si tratta di affrontare situazioni problematiche di varia natura avvalendosi<br />
di modelli matematici atti alla loro rappresentazione.<br />
FISICA Soddisfacente (ed in alcuni casi molto buona) la conoscenza complessiva<br />
degli argomenti trattati. Alcuni alunni mostrano ancora difficoltà nell’uso<br />
del linguaggio matematico adeguato, ma nel complesso anche in questo caso<br />
i risultati ottenuti possono considerarsi positivi. Le incertezze maggiori<br />
si riscontrano nel momento in cui occorre applicare le conoscenze e competenze<br />
acquisite per schematizzare e risolvere problemi di fisica.<br />
SCIENZE Gli obiettivi disciplinari raggiunti dagli studenti evidenziano una situazione<br />
diversificata.<br />
Alcuni studenti hanno acquisito buone conoscenze sia in astronomia che in<br />
geologia, dimostrando di saper utilizzare i termini del linguaggio tecnico<br />
scientifico in modo appropriato e corretto. Pienamente consapevoli del loro<br />
significato, possiedono gli strumenti per descrivere ed interpretare i fenomeni<br />
naturali.<br />
La maggior parte ha raggiunto un livello di conoscenza sufficiente e se<br />
guidati riescono a riconoscere e comprendere alcuni fenomeni naturali,<br />
dimostrando di aver acquisito una terminologia essenziale.<br />
Per altri studenti l’impegno discontinuo e lo studio superficiale hanno determinato<br />
il raggiungimento di risultati appena sufficienti.<br />
Nel complesso la <strong>classe</strong> ha mostrato, nel secondo periodo, un graduale mi-<br />
STORIA<br />
DELL’ARTE<br />
glioramento nell’attenzione e nella partecipazione al dialogo educativo.<br />
La <strong>classe</strong> ha mostrato sempre un forte interesse verso la materia sia negli<br />
anni precedenti che in quello attuale in cui sono subentrata.<br />
L’apprendimento e lo studio sono stati soddisfacenti soprattutto per alcuni<br />
alunni che si sono distinti per attenzione e preparazione. Gli alunni sanno<br />
argomentare le tematiche della materia e sanno analizzare e commentare le<br />
opere del programma. Hanno maturato un linguaggio corretto, ampio nella<br />
nomenclatura e nei termini specifici. Hanno seguito un percorso evolutivo<br />
migliorando complessivamente l’osservazione e la percezione del messaggio<br />
artistico e ne hanno colto le innumerevoli connessioni con la storia e<br />
con il presente. Sovente in <strong>classe</strong> ho potuto ampliare il discorso sulla tutela<br />
e la conservazione delle opere d’arte. Spesso sono stati fatti approfondimenti<br />
su singoli autori e in questo gli alunni hanno mostrato capacità di<br />
precisione e di ricerca accurata. Alcuni di loro si sono distinti per<br />
l’atteggiamento costantemente attento e recettivo volto a un continuo perfezionarsi<br />
nel metodo di studio e nell’esposizione linguistica dei contenuti<br />
rivelando una particolare inclinazione nel campo della materia.<br />
ED.FISICA Il programma svolto nel corso dell’anno si è incentrato su una serie di atti-
vità volte a stimolare lo sviluppo psico-motorio e funzionale degli studenti.<br />
In particolare sono state sviluppate:<br />
1) le conoscenze dei gesti tecnici e del regolamento essenziale delle<br />
varie discipline praticate e della terminologia specifica della materia;<br />
2) le capacità di percezione, comprensione e analisi di un compito<br />
motorio e di produzione di una risposta adeguata;<br />
3) le competenze nel saper applicare schemi di gioco, assumere ruoli<br />
e progettare, nelle linee essenziali, una seduta di allenamento.<br />
Gli studenti hanno mostrato una buona disposizione nei confronti della<br />
materia che hanno seguito con interesse ed impegno anche oltre l’orario<br />
scolastico. La <strong>classe</strong> ha raggiunto, nel complesso, gli obiettivi<br />
proposti con un livello di preparazione soddisfacente.<br />
IRC Le azioni didattiche dell’a.s. 2012/2013 hanno avuto i seguenti obiettivi:<br />
– avvicinare testi magisteriali e teologici, maturando competenze nel linguaggio<br />
specifico;<br />
– saper collocare sull’asse storico avvenimenti decisivi e personaggi significativi<br />
della storia della Chiesa nel XX secolo;<br />
– maturare capacità di confronto e dialogo fra diverse opzioni fondamentali<br />
religiose;<br />
– riconoscere elementi della rivelazione e della tradizione cristiana nel<br />
pensiero contemporaneo.<br />
Mat. Alternativa a<br />
IRC<br />
Si è iniziato il percorso didattico con il fine di motivare lo studente allo<br />
studio del diritto e dei suoi istituti giuridici fondamentali, offrendo gli<br />
strumenti necessari alla ‘formazione del cittadino’. Sono state affrontate le<br />
tematiche relative al mondo del lavoro, alla famiglia e connesse<br />
all’organizzazione dello stato, tenendo conto dei bisogni culturali e sociali<br />
dello studente, accogliendo le sue proposte e rispettando le curiosità dello<br />
stesso su fatti di attualità e problemi della vita quotidiana. Lo studente ha<br />
manifestato un interesse crescente per la disciplina e per gli argomenti trattati<br />
e, la sua buona base culturale, ha consentito di affrontare tutte le tematiche<br />
con la consapevolezza delle sue competenze, conoscenze e capacità.<br />
La sua partecipazione attiva al dialogo scolastico e l’entusiasmo mostrato<br />
hanno permesso di svolgere in modo soddisfacente il programma predisposto.<br />
Alla luce di quanto è stato detto si può sicuramente affermare che<br />
lo studente ha raggiunto gli obiettivi prefissati.
PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA<br />
Nella programmazione di inizio d’anno e durante le periodiche riunioni, il Consiglio di <strong>classe</strong> ha<br />
approvato alcune attività extracurricolari fra quelle proposte a livello d’Istituto, che sono state svolte<br />
nel corso dell’anno scolastico ed hanno coinvolto tutti gli alunni. Tra quelle svolte in orario curricolare<br />
ricordiamo:<br />
– viaggio d’istruzione a Lisbona;<br />
– attività di orientamento universitario;<br />
– lettura del quotidiano in <strong>classe</strong>;<br />
– visita didattica alla Galleria d’arte Moderna per l’osservazione diretta dell’arte italiana<br />
dell’Ottocento e del Novecento;<br />
– due seminari presso l'Università “La Sapienza”, su temi riguardanti “La struttura dell'Universo”<br />
e “Formazione di minerali e loro evoluzione”;<br />
– “Astronomia con il planetario digitale”, attività a cura dell’associazione culturale Club delle<br />
scienza presso il nostro istituto;<br />
– Itinerario geopaleontologico e serata astronomica. Prof. Maurizio Chirri, a Rocca di Cave: percorso<br />
geologico e un'osservazione astronomica presso l'Osservatorio di Rocca di Cave (in programmazione<br />
a maggio)<br />
– Visita al Museo della Liberazione di via Tasso;<br />
– Assistenza ad un’udienza del processo sull’eccidio di Cefalonia, presso il Palazzo di Giustizia di<br />
Roma;<br />
– “Lezioni di Economia per le terze liceali”, prof. Giuliano Amato, presso il nostro istituto;<br />
– Incontro con un gruppo di volontari nel carcere di Regina Coeli, presso il nostro istituto.<br />
Alcuni studenti della <strong>classe</strong> hanno poi partecipato ad altre iniziative fra quelle segnalate a livello<br />
d’Istituto:<br />
– attività di volontariato presso la Mensa Caritas della Stazione Termini;<br />
– Pascoli 101, Giornata di studi pascoliani, presso il nostro istituto;<br />
– Olimpiadi di filosofia;<br />
– cerimonia celebrativa delle vittime delle Fosse Ardeatine;<br />
– letture filosofiche;<br />
– un ragazzo ha partecipato a New York al progetto di simulazione del congresso ONU;<br />
– stage di 3 giorni presso l'Istituto EBRI (fondazione Rita Levi Montalcini), dove hanno condotto<br />
un'esperienza sulla purificazione della proteina GFP;<br />
– campionati studenteschi di pallavolo;<br />
– campionati sportivi d’Istituto.<br />
Visione dei seguenti spettacoli teatrali in replica serale:<br />
1. “La coscienza di Zeno”, di I. Svevo, con Giuseppe Pambieri e con la regia di Maurizio Scaparro,<br />
Teatro Quirino;<br />
2. “Il Fu Mattia Pascal” di L. Pirandello con la regia e l’interpretazione di Tato Russo, Teatro<br />
Quirino di Roma<br />
3. “Serata a Colono” di Elsa Morante, con Carlo Cecchi e Antonia Truppo, regia di Mario<br />
Martone, Teatro Argentina di Roma;<br />
4. “Antigone”di Valeria Parrella, con Gaia Aprea e Paolo Serra, regia di Luca De Fusco, Teatro<br />
Eliseo di Roma
5. “Processo a Medea” presso l’Auditorium Parco della musica<br />
VERIFICHE E CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE<br />
In sede di Collegio dei docenti sono stati approvati i criteri di attribuzione dei voti secondo la griglia<br />
di indicatori che si allega (allegato n.1), assunta da tutti i Consigli di <strong>classe</strong>.<br />
Per le prove orali, in particolare, il Consiglio di <strong>classe</strong> ha stabilito in sede di programmazione annuale<br />
di fare riferimento ai criteri stabiliti da ogni Dipartimento disciplinare e inoltre di tener conto<br />
dei seguenti elementi:<br />
– chiarezza nell’esposizione dei contenuti e padronanza del linguaggio tecnico di ogni disciplina;<br />
– capacità di operare collegamenti, anche attraverso un’autonoma rielaborazione critica.<br />
La correzione delle prove oggetto di Esame di Stato è avvenuta utilizzando le griglie di correzione<br />
che si allegano (allegati n. 2, 3, 4), in particolare nei casi di simulazione di prove d’esame: le griglie<br />
sono state approvate in Collegio docenti e sono comuni a tutte le classi.<br />
SIMULAZIONI DI PROVE D’ESAME<br />
Sono state somministrate agli studenti le seguenti simulazioni di prove d’esame:<br />
12 gennaio 2013: terza prova (tipologia A); materie: Latino, Fisica, Filosofia, Scienze, Inglese;<br />
4 aprile 2013: terza prova (tipologia B); materie: Inglese, Greco, Matematica, Storia, Scienze;<br />
16 maggio 2013 terza prova (tipologia B ); materie: Greco, Storia, Fisica, Scienze, Inglese<br />
14 maggio 2012: prima prova (comune a tutto il <strong>Liceo</strong>).<br />
La simulazione di prima prova ha avuto una durata di 5 ore, mentre le simulazioni di terza prova<br />
hanno avuto una durata di 3 ore. Dai riscontri in sede di valutazione collegiale è risultato che per la<br />
terza prova la tipologia B (quesiti a risposta singola) risulta essere più congeniale al conseguimento<br />
di risultati positivi. Nella terza simulazione sono state prescelte quella tipologia e quelle discipline<br />
che, a parere del Consiglio di <strong>classe</strong>, consentono il raggiungimento di risultati migliori.<br />
I testi delle simulazioni di terza prova si allegano al presente documento (allegato n. 5).
Si allegano al presente documento:<br />
ALLEGATI<br />
Allegato n. 1: Criteri di valutazione e assegnazione dei voti<br />
Allegati n. 2, 3, 4: Griglie di valutazione per la prova scritta d’italiano, di lingua classica, di terza<br />
prova<br />
Allegato n. 5: Testi delle simulazioni delle prove d’esame<br />
Allegati n. 6–18: Programmi disciplinari<br />
Roma, 15 maggio 2013
I DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE<br />
ITALIANO prof.ssa Sabina Petrella (firma)……………………..<br />
LATINO prof. Cristiano Scagliarini (firma)……………………..<br />
GRECO prof. Cristiano Scagliarini (firma)……………………..<br />
INGLESE prof .ssa Gabriella Liberini (firma)……………………..<br />
STORIA E FILOSOFIA prof.ssa Angela Scozzafava (firma)……………………..<br />
MATEMATICA E FISICA prof. Maurizio Frigeni (firma)……………………..<br />
SCIENZE prof.ssa Isabella Iezza (firma)……………………..<br />
ED. FISICA prof. Saverio Spinelli (firma)……………………..<br />
STORIA DELL’ARTE prof.ssa Caterina Capalbo (firma)....................................<br />
IRC prof. Gaetano Cangiano (firma)……………………..<br />
MAT.ALT. prof.ssa Cristina Cianfanelli (firma)……………………..
VERIFICA E VALUTAZIONE<br />
I docenti, per ogni disciplina, adottano forme e tipologie di verifica e criteri di valutazione discussi e concordati nella programmazione dei Consigli di Classe e dei Dipartimenti. Tutte le verifiche sono<br />
strettamente legate agli obiettivi della programmazione e realizzate per accertare le conoscenze e le competenze conseguite da ogni alunno.<br />
Il Collegio dei Docenti ha inoltre elaborato dei criteri generali di valutazione per conferire omogeneità ai processi di valutazione in tutte le discipline, articolandoli in:<br />
Conoscenze: sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio. Esse indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento.<br />
Abilità: implicano l’applicazione di conoscenze per portare a termine compiti e risolvere problemi. Possono essere descritte come cognitive (in riferimento al pensiero logico, intuitivo e creativo) e<br />
pratiche (in riferimento all’uso di metodi, materiali, strumenti ).<br />
Competenze: indicano la capacità di far interagire le conoscenze e le abilità acquisite con le capacità personali e/o sociali nell’elaborazione responsabile di percorsi di studio e di autonoma rielaborazione<br />
culturale.<br />
Il grado di conseguimento di conoscenze, abilità, competenze, viene distinto in sette livelli numerici, rispondenti ai voti da 1 a 10.<br />
Voto<br />
1 – 3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9 – 10<br />
Indicatori di<br />
conoscenze<br />
Possiede labili o nulle conoscenze degli<br />
argomenti disciplinari e disarticolate<br />
nozioni dei loro ambiti contestuali.<br />
Conosce in modo vago e confuso gli<br />
argomenti disciplinari. Ne distingue con<br />
difficoltà i nuclei essenziali e le<br />
interrelazioni.<br />
È in possesso di un esiguo repertorio di<br />
conoscenze, delle quali coglie<br />
parzialmente implicazioni e rimandi<br />
essenziali.<br />
Conosce gli ambiti delle diverse<br />
discipline e ne coglie in linea globale<br />
contenuti e sviluppi.<br />
Conosce gli argomenti e li colloca<br />
correttamente nei diversi ambiti<br />
disciplinari.<br />
Conosce gli ambiti disciplinari, anche<br />
grazie ad approfondimenti personali negli<br />
aspetti per i quali ha maggiore interesse.<br />
Mostra piena padronanza degli ambiti<br />
disciplinari grazie a una ricca e articolata rete<br />
di informazioni.<br />
Indicatori di<br />
abilità<br />
Disattende le consegne, alle quali risponde con<br />
assoluta incongruenza di linguaggio e di<br />
argomentazione.<br />
Evidenzia imprecisioni e carenze anche gravi<br />
nell'elaborazione delle consegne, che svolge con<br />
un linguaggio disordinato e scorretto.<br />
Sviluppa le consegne in modo sommario o<br />
incompleto, con non certa padronanza delle<br />
soluzioni espressive.<br />
Comprende le consegne e risponde in modo<br />
semplice ma appropriato, secondo i diversi<br />
linguaggi disciplinari.<br />
Comprende e contestualizza le consegne e le<br />
sviluppa attraverso percorsi di rielaborazione<br />
complessivamente coerenti.<br />
Sviluppa le consegne con rigore logicoconcettuale,<br />
operando collegamenti con<br />
appropriata scelta di argomentazioni.<br />
È in grado di sviluppare analisi autonome a partire<br />
dalle consegne e di esporne i risultati con pertinenza ed<br />
efficacia. Effettua con sicurezza e originalità<br />
collegamenti e confronti tra i diversi ambiti di studio.<br />
Indicatori di<br />
competenze<br />
Non sa orientarsi nell'analisi di problemi semplici e<br />
non è in grado di applicare regole o elementari<br />
operazioni risolutive.<br />
Si orienta a fatica nell'analisi dei problemi pur<br />
semplici, che affronta con confuse e non fondate<br />
procedure di risoluzione.<br />
Sa analizzare problemi semplici in un numero<br />
limitato di contesti. Applica, non sempre<br />
adeguatamente, solo semplici procedure risolutive.<br />
Sa analizzare problemi semplici ed orientarsi nella<br />
scelta e nella applicazione delle strategie di<br />
risoluzione.<br />
Sa impostare problemi di media complessità e<br />
formularne in modo appropriato le relative ipotesi<br />
di risoluzione.<br />
È capace di enucleare in modo articolato strategie<br />
di risoluzione dei problemi per elaborare le quali sa<br />
operare scelte coerenti ed efficaci.<br />
Sa impostare percorsi di studio autonomi che sviluppa con<br />
ricca pertinenza di riferimenti; sa risolvere problemi<br />
anche complessi mostrando sicura capacità di orientarsi.<br />
Livello di certificazione delle competenze di<br />
base<br />
(DM 9 del 27 gennaio 2010)<br />
Non ha raggiunto il livello base delle<br />
competenze.<br />
Livello base: lo studente svolge compiti<br />
semplici in situazioni note, mostrando di<br />
possedere conoscenze ed abilità essenziali e di<br />
saper applicare regole e procedure<br />
fondamentali.<br />
Livello intermedio: lo studente svolge<br />
compiti e risolve problemi complessi in<br />
situazioni note, compie scelte consapevoli,<br />
mostrando di saper utilizzare le conoscenze e<br />
le abilità acquisite.<br />
Livello avanzato: lo studente svolge compiti e<br />
problemi complessi in situazioni anche non<br />
note, mostrando padronanza nell’uso delle<br />
conoscenze e delle abilità. Sa proporre e<br />
sostenere le proprie opinioni e assumere<br />
autonomamente decisioni consapevoli
<strong>Liceo</strong> Classico Statale “<strong>Giulio</strong> <strong>Cesare</strong>” - Roma<br />
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA<br />
ALLEGATO N.2<br />
Studente ……………………………… Classe Sez.<br />
Voto in decimi<br />
Voto<br />
in quindicesimi<br />
Giudizio sintetico<br />
Correttezza ortografica, morfosintattica<br />
e proprietà lessicale<br />
Conoscenza<br />
degli argomenti<br />
proposti<br />
Aderenza alla traccia e rispetto<br />
dei vincoli comunicativi<br />
Analisi, sintesi, coerenza e<br />
rielaborazione dei contenuti<br />
Punteggio totale<br />
VALUTAZIONE FINALE<br />
1-3 1-4 4 5-7 5 8-9 6 10 7 11-12 8-9 13-14 10 15<br />
Gravemente insufficiente<br />
(ottenuta dividendo per il numero dei descrittori ed arrotondando all’unità in presenza di decimali)<br />
Insufficiente Mediocre Sufficiente Discreto Buono Ottimo
Voto in<br />
decimi<br />
<strong>Liceo</strong> Classico Statale “<strong>Giulio</strong> <strong>Cesare</strong>” - Roma<br />
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA<br />
ALLEGATO N.3<br />
Studente ……………………………… Classe Sez.<br />
Voto<br />
in quindicesimi 1-4 1-4 5 5-9 6 10 7 11-12 8-9 13-14 10 15<br />
Giudizio sintetico<br />
Comprensione del testo<br />
Conoscenza della morfosintassi<br />
Qualità linguistica della traduzione<br />
Punteggio totale<br />
Gravemente<br />
insufficiente<br />
VALUTAZIONE FINALE<br />
(ottenuta dividendo per il numero dei descrittori ed arrotondando all’unità in presenza di decimali)<br />
I DOCENTI<br />
Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo
<strong>Liceo</strong> Classico Statale “<strong>Giulio</strong> <strong>Cesare</strong>” - Roma<br />
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA (TIPOLOGIA A)<br />
STUDENTE: ………………………………………. CLASSE <strong>III</strong> SEZ. ……<br />
Voto in decimi<br />
Giudizio sintetico<br />
Voto<br />
in quindicesimi<br />
ALLEGATO N.4<br />
1-3 1-4 4 5-7 5 8-9 6 10 7 11-12 8-9 13-14 10 15<br />
Gravemente<br />
insufficiente<br />
Insufficiente Mediocre Sufficiente Discreto Buono Ottimo<br />
MATERIE 1. 2. 3. 4. 5.<br />
conoscenza e articolazione<br />
degli argomenti proposti<br />
correttezza e competenza<br />
nell’utilizzo della lingua e dei<br />
linguaggi specifici<br />
pertinenza con le richieste e<br />
capacità di utilizzare criticamente<br />
le conoscenze<br />
Punteggio totale<br />
VALUTAZIONE FINALE<br />
La valutazione dei singoli quesiti è ottenuta sommando la valutazione dei descrittori.<br />
La valutazione della prova è ottenuta sommando le valutazioni dei quesiti e dividendo per 15. Il valore ottenuto è approssimato<br />
all’intero più vicino (per difetto in caso di decimale minore di 0,5 o per eccesso in caso di decimale maggiore o uguale a 0,5).<br />
I DOCENTI
<strong>Liceo</strong> Classico Statale “<strong>Giulio</strong> <strong>Cesare</strong>” - Roma<br />
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA (TIPOLOGIA B)<br />
STUDENTE: ……………………………………… CLASSE <strong>III</strong> SEZ. ………<br />
Voto in decimi<br />
Voto in quindicesimi<br />
Giudizio sintetico<br />
Descrittori<br />
1-3 1-4 4 5-7 5 8-9 6 10 7 11-12 8-9 13-14 10 15<br />
Gravemente<br />
insufficiente<br />
Insufficiente Mediocre Sufficiente Discreto Buono Ottimo<br />
MATERIE 1. 2. 3. 4. 5.<br />
Quesiti<br />
conoscenza e articolazione<br />
degli argomenti proposti<br />
correttezza e competenza<br />
nell’utilizzo della lingua e dei<br />
linguaggi specifici<br />
pertinenza con le richieste e<br />
capacità di utilizzare criticamente<br />
le conoscenze<br />
Punteggio totale<br />
VALUTAZIONE FINALE<br />
1° quesito 2° quesito 3° quesito 4° quesito 5° quesito 6° quesito 7° quesito 8° quesito 9° quesito 10° quesito<br />
La valutazione dei singoli quesiti è ottenuta sommando la valutazione dei descrittori.<br />
La valutazione della prova è ottenuta sommando le valutazioni dei quesiti e dividendo per 30. Il valore ottenuto è approssimato<br />
all’intero più vicino (per difetto in caso di decimale minore di 0,5 o per eccesso in caso di decimale maggiore o uguale a 0,5).<br />
I DOCENTI
SIMULAZIONI DI TERZA PROVA<br />
12 gennaio 2013 tipologia A (rispondere in 20 righe)<br />
ALLEGATO N.5<br />
Latino. A partire dai testi che ti vengono proposti, argomenta le seguenti affermazioni: 1) la V Satira, dedicata a Cornuto, rappresenta<br />
la fase costruttiva della satira di Persio, nell’identificazione di un modello di vita, offerto dalla virtus stoica.<br />
2) “Piuttosto che con argomentazioni, Giovenale corrobora il suo giudizio con l’evidenza delle immagini, che talvolta pigliano risalto<br />
dal contrasto con le visioni opposte del buon tempo della Roma antica. Quasi sempre, nella sua satira, il caso particolare assurge a<br />
norma, la singola immagine deve esprimere direttamente il pensiero e il giudizio del poeta.”<br />
Testo n.1: la satira di Persio. Quando il cammino incerto e gli errori dovuti all'inesperienza del vivere trassero i miei pensieri agitati per un intrico di<br />
strade, io mi rimisi a te. Tu accogli i giovani insicuri, Cornuto, al tuo petto socratico. Allora, attento a non lasciarcene accorgere, accosti il regolo alla<br />
condotta deviata e la raddrizzi; il nostro animo è costretto dalla ragione e si affanna a lasciarsi sconfiggere e, sotto le tue dita, si trasforma in un ritratto<br />
modellato ad arte. Lunghe giornate ho passato con te, ricordo, e assieme a te, a tavola, coglievo le prime ore della notte. Insieme, io e te, decidiamo<br />
il tempo del lavoro e del sonno; insieme riposiamo dalle cose serie a una mensa parca. Sii pur certo che la vita di entrambi condivide un'unica legge<br />
ed è guidata dalla stessa stella. (Satira V, versi 34 – 46)<br />
Testo n.2: la satira di Giovenale. Quando un eunuco prende moglie e Mevia, con le mammelle ignude e lo spiedo in mano, va a caccia di cinghiali<br />
toscani nell’arena; quando tutti i patrizi sono sorpassati in ricchezza da un cialtrone che, ai miei tempi, mi raschiava rumorosamente la barba; quando<br />
un avanzo della plebaglia del Nilo, un servo di canopo, Crispino, tirandosi sulle spalle porpora tiria, sventola in giro, con le dita sudate, il suo anellino<br />
estivo, che par quasi non riesca a sopportare il peso della gemma, ah, è difficile allora non scrivere satire! (Satira I, versi 22 – 30)<br />
Filosofia.<br />
• [L’appetito del signore è pura negazione dell’oggetto]. Il lavoro, invece, è appetito tenuto a freno, un dileguare trattenuto; ovvero: il lavoro forma.<br />
Il rapporto negativo verso l’oggetto diventa forma dell’oggetto stesso, diventa qualcosa che permane; e ciò perché proprio a chi lavora l’oggetto<br />
ha indipendenza. [……] così, quindi, la coscienza che lavora giunge all’intuizione dell’essere indipendente come di se stessa.<br />
Hegel, da “Fenomenologia dello Spirito”.<br />
• [Nella società civile si produce la divisione del lavoro; il lavoro del singolo diventa più semplice e astratto, aumenta la quantità della produzione e la<br />
dipendenza e il rapporto di scambio tra gli uomini.] Inoltre, l’astrazione del produrre rende il lavoro sempre più meccanico e, quindi, alla fine, atto<br />
a che l’uomo ne sia rimosso e possa essere introdotta, al suo posto, la macchina.<br />
Hegel, da Lineamenti della filosofia del diritto.<br />
• L’oggetto che il lavoro produce, il prodotto del lavoro, si contrappone ad esso come un essere estraneo, come una potenza indipendente da colui<br />
che lo produce. Il prodotto del lavoro è il lavoro che si è fissato in un oggetto, è diventato una cosa, è l’oggettivazione del lavoro. La realizzazione<br />
del lavoro è la sua oggettivazione [che] appare nello stadio dell’economia privata come un annullamento dell’operaio, l’oggettivazione appare<br />
come perdita e asservimento dell’oggetto, l’appropriazione come estraneazione, alienazione.<br />
Marx, da Manoscritti economico-filosofici del 1844<br />
Partendo da queste citazioni il candidato metta a confronto Hegel e Marx relativamente ai concetti di relazione uomo-natura, lavoro,<br />
autocoscienza e alienazione.<br />
Fisica. Spiega che cos'è la forza di Lorentz e descrivi in generale il moto di una particella carica in un campo magnetico uniforme, sia<br />
qualitativamente che quantitativamente.<br />
Scienze. Dopo aver illustrato la differenza tra anno sidereo e anno tropico, spiega quali cause sono alla base della loro diversa durata.<br />
Inglese. Analyze “The Picture of Dorian Gray” by Oscar Wilde.<br />
4 aprile 2013 tipologia B (rispondere in 10 righe)<br />
Greco 1. Quali sono le principali acquisizioni della filologia ellenistica? In che cosa si distinguono, secondo te, gli scienziati e gli eruditi<br />
dell’età ellenistica rispetto ai filosofi e agli intellettuali delle precedenti età?<br />
Greco 2. Esponi sinteticamente la teoria letteraria professata dall’autore del trattato Sul sublime a partire dalla formula “Il sublime è<br />
eco della magnanimità”.<br />
Storia 1. Analizza le forme e i meccanismi attraverso i quali si attuò il totalitarismo staliniano.<br />
Storia 2. Analizza motivazioni e conseguenze, sul piano interno e su quello internazionale, della guerra di Etiopia.<br />
Matematica 1. Una piramide ha per base un rombo ABCD le cui diagonali misurano 6 e 8 e s’incontrano nel punto H, mentre l’altezza<br />
VH della piramide misura 7. Determina la superficie totale della piramide.<br />
Matematica 2. Nel triangolo ABC il lato BC misura 12 cm, il lato AC misura 9 cm e l’angolo in B è di 30°. Determina tutte le possibili<br />
misure del lato AB.<br />
Scienze 1. La fotosfera solare è caratterizzata da un’intensa attività che si manifesta in varie forme. Descrivi le manifestazioni più evidenti<br />
e spiega come tali manifestazioni sono collegate con alcuni fenomeni terrestri.<br />
Scienze 2. Descrivi le caratteristiche chimico-fisiche di un magma basico, mettendole in relazione con le principali famiglie di rocce<br />
effusive e intrusive alle quali dà origine.<br />
Inglese 1. What are the main themes of “A passage to India”?<br />
Inglese 2. What do you know about “Mrs. Warren’s Profession”?
16 maggio 2013 tipologia B (rispondere in 10 righe)<br />
Greco 1. Quali sono i nuovi itinerari esplorati dalla filosofia durante l’età ellenistica? A chi propriamente si rivolge il messaggio dei<br />
filosofi?<br />
Greco 2. “Col divino Plutarco potrò consolarmi, volgendo gli occhi ai pochi illustri che sovrastano a tanti secoli e a tante genti”.<br />
(Foscolo, Ultime lettere di Jacopo Ortis, 1802). In quale misura questa immagine di Plutarco corrisponde all’effettiva dimensione storica<br />
delle Vite? Qual era l’intenzione di Plutarco nel comporre l’opera? I personaggi delle Vite possono davvero considerarsi eroici?<br />
Storia 1. La guerra civile spagnola. Illustrane le cause, gli aspetti più importanti del suo svolgimento, e le conseguenze soffermandoti<br />
in particolare sulle implicazioni che ebbe per l’Europa.<br />
Storia 2. Esponi principi ispiratori, caratteristiche ed esiti della politica degasperiana dal 1945 al 1948.<br />
Fisica 1. Una spira quadrata, il cui lato misura 5,2 cm, si trova in una zona in cui è presente un campo magnetico perpendicolare al<br />
piano della spira. L’intensità del campo magnetico varia da 4, 2 !10 "4<br />
T a 7, 5!10 "3 T in un tempo !t. Determina il valore di !t, sapendo<br />
che nella spira viene indotta una forza elettromotrice di 0,55 V.<br />
Fisica 2. Analizzando lo spettro di una stella si vede che la riga H-" dell’idrogeno compare alla lunghezza d’onda di 652,5 nm, mentre<br />
la stessa riga in uno spettro prodotto in laboratorio si trova alla lunghezza d’onda di 656,3 nm. Calcola la velocità radiale relativa fra la<br />
stella e la Terra e dì se si tratta di avvicinamento o allontanamento.<br />
Scienze 1. Nonostante si muovano a velocità elevatissime, le galassie non sembrano spostarsi in cielo. Eppure un dettaglio della loro<br />
luce rivela che si stanno allontanando da noi.<br />
Scienze 2. Il candidato riassuma la teoria del rimbalzo elastico..<br />
Inglese 1. Considering the poems by W. Wordsworth you have read, say in what way they are consistent with the ideas expressed in<br />
the Preface to the Lyrical Ballads.<br />
Inglese 2. In which of his books does Dickens criticise the Victorian school system? Which criticism in particular does he make?
ALLEGATO N. 6. Italiano<br />
ALLEGATO N. 7. Latino<br />
ALLEGATO N. 8. Greco<br />
ALLEGATO N. 9. Inglese<br />
ALLEGATO N. 10. Storia<br />
ALLEGATO N. 11. Filosofia<br />
ALLEGATO N. 12. Matematica<br />
ALLEGATO N. 13. Fisica<br />
ALLEGATO N. 14. Scienze<br />
ALLEGATO N. 15. Storia dell’arte<br />
PROGRAMMI DISCIPLINARI<br />
ALLEGATO N. 16. Educazione fisica<br />
ALLEGATO N. 17. Insegnamento Religione Cattolica<br />
ALLEGATO N. 18. Materia alternativa all’IRC<br />
ALLEGATI
Docente: Prof.ssa Sabina Petrella<br />
PROGRAMMA DI ITALIANO<br />
DANTE ALIGHIERI, DIVINA COMMEDIA, PARADISO<br />
LETTURA, PARAFRASI, ANALISI E COMMENTO DEI SEGUENTI CANTI.<br />
Canto I<br />
Canto II, vv.1-45<br />
Canto <strong>III</strong><br />
Canto VI<br />
Canto XI<br />
Canto XV, vv . 97-135<br />
Canto XVII<br />
IL NEOCLASSICISMO<br />
L’intellettuale illuminista<br />
L’estetica neoclassica<br />
• La statua di Apollo da J.J. Winckelmann, Storia dell’arte nell’antichità<br />
UGO FOSCOLO<br />
La vita<br />
La concezione del ruolo dell’intellettuale<br />
La concezione della civiltà e il ruolo della poesia<br />
Lingua e stile tra Classicismo e Romanticismo<br />
Il tema della morte e del dovere della memoria<br />
Foscolo classicista: Le Grazie”<br />
Attualità di Foscolo<br />
• La lettera da Ventimiglia, Ultime lettere di Jacopo Ortis<br />
• Alla Sera,<br />
• Né più mai toccherò le sacre sponde<br />
• Un di, s’io non andrò sempre fuggendo di gente in gente<br />
• Dei Sepolcri: vv. 1-53, 88-189, 230-295<br />
• Il velo delle Grazie, dalle Grazie, vv. 153-196.<br />
ALLEGATO N.6<br />
IL ROMANTICISMO<br />
DEFINIZIONE E CARATTERI DEL ROMANTICISMO<br />
• Il concetto di Sehnsucht da L. Mittner Storia della letteratura tedesca II, Einaudi, To, 1964, pp.698-<br />
702 (con tagli)<br />
• La romantica e l’ansia di assoluto, da A. W. Schlegel, Corso di letteratura drammatica<br />
L’opposizione IO-MONDO , e sua interpretazione in chiave storica o in chiave esistenziale<br />
La filosofia e l’estetica del Romanticismo europeo<br />
• La superiorità dell’arte sulle altre forme di coscienza da F. W. Schelling, Sistema dell’idealismo trascendentale,<br />
Laterza, Bari, 1965, p.301<br />
• La differenza tra poesia ingenua e poesia sentimentale, secondo Schiller da F. Schiller,Sulla poesia ingenua<br />
e sentimentale, Mondatori, MI, 1995, pp 30-33, 40-42. (con tagli)<br />
I CARATTERI DEL ROMANTICISMO ITALIANO<br />
La polemica tra “classici” e “romantici”<br />
• M.me de Stael, Sulla maniera e la utilità delle traduzioni in AA.VV. Manifesti romantici e altri scritti,<br />
a cura di M. Scotti, Utet, TO, 1979. pp, 89-91<br />
• G. Berchet, Lettera semiseria di Grisostomo a un suo figliolo, in AA.VV. Manifesti romantici e altri<br />
scritti, op. cit. pp. 434-440 (con tagli)<br />
La posizione di G. Leopardi nella polemica tra “classici” e “romantici”<br />
La questione della lingua
ALESSANDRO MANZONI<br />
L’IMPORTANZA STORICA DI MANZONI<br />
VITA E OPERE<br />
Gli Inni sacri<br />
Le odi civili<br />
• Il cinque maggio<br />
Le tragedie<br />
• Il coro dell’atto IV, da Adelchi, atto IV<br />
Il romanzo storico<br />
• I promessi sposi<br />
Il progetto manzoniano di società, la storia, gli umili, la giustizia<br />
L’ideologia religiosa: il problema del male e il tema della provvidenza<br />
La “rivoluzione linguistica” manzoniana<br />
o Il sugo della storia, dal cap.XXXV<strong>III</strong><br />
Gli altri scritti<br />
• Storia della colonna infame, Introduzione, Sellerio, Pa, 1982<br />
La questione morale nella Storia della colonna infame<br />
GLI SCRITTI DI POETICA<br />
• A. Manzoni, Lettera al Signor C.*** sull’ unità di tempo e di luogo nella tragedia in Lettere sui Promessi<br />
Sposi, a cura di G. G. Amoretti,Garzanti, MI, 1985<br />
Il rapporto tra poesia e storia nella lettera a Chauvet<br />
• A. Manzoni, Lettera a C. D’Azeglio sul Romanticismo in Lettere sui Promessi Sposi op. cit.<br />
LE IDEE DI MANZONI SULLA QUESTIONE DELLA LINGUA<br />
GIACOMO LEOPARDI<br />
MODERNITA’ DI LEOPARDI<br />
IL DOLORE COME ESPERIENZA CONOSCITIVA<br />
LA VITA<br />
LE FASI DEL PENSIERO LEOPARDIANO E LA POETICA AD ESSE CORRISPONDENTE<br />
LE OPERE<br />
Epistolario:<br />
• Lettera a P. Giordani , Ep.. 32, 30 aprile, 1817, da G. Leopardi, Tutte le opere, a cura di W. Binni,<br />
Sansoni, Fi, 1969, vol. I<br />
• Lettera al fratello Carlo, Ep. 219, 25 novembre 1822, op. cit.<br />
Zibaldone di pensieri:<br />
• Teoria del piacere,Zibaldone 165-183<br />
• Teoria della visione, piacere dell’indefinito luminoso, Zibaldone, 1744-1745<br />
• Sulla noia, Zibaldone, 1691, 4043<br />
• Sulla poetica del vago e dell’indefinito, sensazioni uditive, Zibaldone, 1927, 1929<br />
• Sulle tre diverse maniere di vedere le cose, Zibaldone, 102, 103<br />
• Sul componimento L’infinito, Zibaldone, 472, 171, 1181-82, 4178<br />
• Sulle ricordanze della fanciullezza, rimembranza e poesia, Zibaldone1987, 1988, 4426<br />
• Sulle parole poetiche, Zibaldone 1789, 1798, 1930<br />
Operette morali:<br />
• La scommessa di Prometeo<br />
• Dialogo della Natura e di un Islandese<br />
• Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutiérrez<br />
• Dialogo di Tristano e di un amico<br />
Canti:<br />
• L’infinito<br />
• La sera del di di festa<br />
• Alla luna<br />
• A Silvia
• La quiete dopo la tempesta<br />
• Canto notturno di un pastore errante dell’Asia<br />
• A se stesso<br />
• La ginestra, o il fiore del deserto<br />
L’ETA’ DEL POSITIVISMO<br />
CENNI SULLA CULTURA FILOSOFICA (COMTE, DARWIN)<br />
METODO SCIENTIFICO APPLICATO ALLE SCIENZE UMANE<br />
L’ESTETICA FRA IL SOCIOLOGISMO DI TAINE E IL REALISMO<br />
• E. e J. De Goncourt, Prefazione a Germinie Lacerteux, Rizzoli, Mi, 1951<br />
• E. Zola, Prefazione ai Rougon-Macquart, in La fortuna dei Rougon, Garzanti, Mi, 1992<br />
GIOVANNI VERGA<br />
La vita e le opere<br />
La rivoluzione stilistica e tematica di Giovanni Verga: L’eclisse dell’autore,<br />
La regressione nel mondo rappresentato<br />
Il ciclo dei vinti<br />
L’ideologia di Verga, la religione della famiglia, il progresso<br />
Scritti Teorici:<br />
• Lettera a S. Farina in L’amante di Gramigna, da Vita dei campi<br />
Novelle<br />
• Rosso Malpelo, da Vita dei campi,<br />
• La lupa, da Vita dei campi<br />
• Fantasticheria, da Vita dei campi<br />
• La roba da Novelle Rusticane<br />
• Libertà, da Novelle Rusticane<br />
Romanzi<br />
• Eva: Prefazione<br />
• I Malavoglia:<br />
o Prefazione,<br />
o L’addio di ‘Ntoni, dal cap.XV<br />
L’ETA’ DEL DECADENTISMO<br />
- IL DECADENTISMO COME FENOMENO CULTURALE E ARTISTICO<br />
La scoperta dell’inconscio<br />
- TIPOLOGIA DELL’EROE DECADENTE. L’ESTETA, IL VEGGENTE, IL SUPERUOMO<br />
- LA POESIA FRANCESE DAL PARNASSIANESIMO AL SIMBOLISMO<br />
C. Baudelaire:<br />
• L’albatro in I fiori del male, trad. di L. de Nardis, Feltrinelli, Mi, 1964<br />
• Corrispondenze, in I fiori del male, op. cit.<br />
• Spleen in I fiori del male, op. cit. n.78<br />
P. Verlaine<br />
• Languore, in Poesie, Feltrinelli, Mi, 1964 C. Baudelaire:<br />
• LA CRISI DELL’INTELLETTUALE:<br />
• La figura dell’artista nell’immaginario e nella realtà<br />
• Perdita d’aureola, C. Baudelaire<br />
• Prefazione a “Eva”, G. Verga<br />
GIOVANNI PASCOLI<br />
- LA VITA E LE OPERE
- LA POETICA DEL FANCIULLINO<br />
- I TEMI DELLA POESIA PASCOLIANA. LA NATURA, LA MORTE, IL NIDO<br />
- L’IMPRESSIONISMO NATURALISTICO DI MYRICAE<br />
- LO SPERIMENTALISMO LINGUISTICO PASCOLIANO<br />
• Il fanciullino, in prose, Mondatori, Mi, 1952<br />
• Novembre, in Myricae, ed. critica a cura di G. Nava, Salerno, Roma, 1991<br />
• L’assiuolo, in Myricae, op. cit.<br />
• X agosto, in Myricae, op. cit.<br />
• Il gelsomino notturno in Canti di Castelvecchio, Poesie, Mondatori, Mi, 1958<br />
• Digitale purpurea, in Poemetti, Poesie, Mondatori, Mi, 1958<br />
• L’aquilone in Poemetti, op.cit.<br />
OPINIONI CRITICHE<br />
G. Contini, Il linguaggio di Pascoli in Varianti e altra linguistica, Einaudi, To, 1970, pp. 241-243<br />
GABRIELE D’ANNUNZIO<br />
- LA VITA INIMITABILE DI UN MITO DI MASSA<br />
- LE OPERE<br />
- L’IDEOLOGIA E LA POETICA. ESTETISMO, SUPEROMISMO, PANISMO<br />
-<br />
- IL FANCIULLINO E IL SUPERUOMO: DUE MITI COMPLEMENTARI<br />
- LO SPERIMENTALISMO LINGUISTICO DI D’ANNUNZIO E L’INFLUENZA SULLA POESIA DEL<br />
NOVECENTO<br />
• Meriggio, Alcyone in Versi d’amore e di gloria, a cura di N. Lorenzini e A. Andreoli, vol. II, Mondatori,<br />
Mi, 1984<br />
• La sera fiesolana,Alcione, op. cit.<br />
• La pioggia nel pineto, op. cit.<br />
• “Qui giacciono i miei cani”, in Versi d’amore e di gloria<br />
Il concetto nietzscheano di “ubermensch” e quello dannunziano del superuomo<br />
ITALO SVEVO<br />
NASCITA DEL ROMANZO D’AVANGUARDIA IN ITALIA<br />
VITA E OPERE<br />
LA CULTURA E LA POLITICA<br />
CARATTERI GENERALI DE ”UNA VITA” E DE “SENILITA’”<br />
LA COSCIENZA DI ZENO, GRANDE ROMANZO D’AVANGUARDIA<br />
La situazione culturale triestina<br />
La “Coscienza di Zeno” come opera aperta<br />
Sanità e malattia, il significato della conclusione del romanzo<br />
• “Prefazione” e “Introduzione"<br />
• “Lo schiaffo del padre” dal capitolo “La morte di mio padre”<br />
• “La proposta di matrimonio” dal capitolo “Storia del mio matrimonio”<br />
• “La salute di Augusta” dal capitolo VI “La moglie e l’amante<br />
• “La vita è una malattia” dal capitolo V<strong>III</strong>“Psico-analisi”<br />
• “La pagina conclusiva” dal capitolo V<strong>III</strong>“Psico-analisi”<br />
LUIGI PIRANDELLO<br />
LA FORMAZIONE E L’ATTIVITA’ ARTISTICA<br />
VITA E OPERE<br />
LA CULTURA LETTERARIA, FILOSOFICA E PSICOLOGICA DI PIRANDELLO<br />
LE PRIME SCELTE DI POETICA<br />
IL RELATIVISMO FILOSIFICO E LA POETICA DELL’UMORISMO<br />
• “L’arte epica compone, quella umoristica scompone” da “L’umorismo”<br />
• “La forma e la vita” da “L’umorismo”<br />
LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELL’ARTE UMORISTICA DI PIRANDELLO<br />
TRA VERISMO E UMORISMO
I ROMANZI UMORISTICI: “IL FU MATTIA PASCAL”, “QUADERNO DI SERAFINO GUBBIO OPE-<br />
RATORE” E “UNO,NESSUNO E CENTOMILA”<br />
LE “NOVELLE PER UN ANNO”: DALL’UMORISMO AL SURREALISMO<br />
• “Il treno ha fischiato” da “Novelle per un anno”<br />
• Il fu Mattia Pascal, capp. VII, IX<br />
L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO<br />
LA NUOVA CONCEZIONE SOCIALE DEGLI INTELLETTUALI<br />
I Crepuscolari<br />
LE AVANGUARDIE STORICHE<br />
Il Futurismo<br />
• Bombardamento da F. T. Marinetti, Zang tumb tuuum<br />
PERCORSI NELLA POESIA ITALIANA DEL NOVECENTO<br />
- Filone simbolista: “novecentista” ermetismo Ungaretti<br />
- Filone allegorico “antinovecentista” Saba,<br />
- Montale<br />
UMBERTO SABA<br />
LA VITA E LA POETICA, L’ORIGINALITA’ DI SABA<br />
• Amai dal Canzoniere<br />
• A mia moglie dal Canzoniere<br />
• La confessione alla madre da Ernesto<br />
GIUSEPPE UNGARETTI<br />
LA VITA, LA FORMAZIONE E LA POETICA<br />
LA RICERCA DELLA PAROLA ASSOLUTA<br />
• In memoria da L’allegria<br />
• Soldati, da L’allegria<br />
• Veglia, da L’allegria<br />
• Natale, da L’allegria<br />
EUGENIO MONTALE<br />
LA CENTRALITA’ DI MONTALE NEL CANONE POETICO DEL NOVECENTO<br />
LA VITA, LE OPERE, LEVARIE FASI DELLA PRODUZIONE<br />
LA CRISI DEL SIMBOLISMO in OSSI DI SEPPIA:<br />
• Non chiederci la parola<br />
• Spesso il male di vivere<br />
• Meriggiare pallido e assorto<br />
L’ALLEGORISMO DELLE OCCASIONI<br />
• La casa dei doganieri<br />
LA SVOLTA DI SATURA<br />
• Ho sceso dandoti il braccio<br />
*E’ ancora possibile la poesia? In E. Montale, Sulla poesia, a cura di G. Zampa,Mondadori, MI, 1976
Docente: professor Cristiano Scagliarini<br />
PROGRAMMA DI LATINO<br />
ALLEGATO N.7<br />
Programma di Letteratura con Letture antologiche (in traduzione italiana, a scelta tra quelle proposte)<br />
Libro di testo: G.B. Conte – E. Pianezzola, Lezioni di letteratura latina, corso integrato, Le Monnier. Volume<br />
3: L’età imperiale<br />
Capp. 1/2/4: L’età imperiale da Tiberio ai Flavi: quadro storico-politico. I generi poetici nell’età giulio-<br />
claudia. Le Fabulae di Fedro. Gli orientamenti della storiografia in età imperiale: gli storici ostili all’impero e<br />
la storiografia filoimperiale di Velleio Patercolo e Valerio Massimo. (Cenni essenziali).<br />
Cap. 5: Seneca: (vedi il programma di autore).<br />
Cap. 6: Lucano; la Pharsalia (esposizione dell’argomento). Letture antologiche: t1/t3/t4/t5/t6<br />
Cap. 7: Petronio; il Satyricon: realismo e parodia in Petronio. Letture antologiche: percorso 2: la Cena Tri-<br />
malchionis in lettura integrale; t4: la novella della matrona di Efeso. Il suicidio di Petronio in Tacito, Annales<br />
XVI, capp. 18 e 19 (cap.15.Tacito, testo t27 pg.491 del medesimo libro di letteratura). Dibattito critico alle<br />
pgg. 245-252. Lettura critica (facoltativa) del saggio di E. Auerbach, Fortunata, il realismo nella prosa latina.<br />
Cap. 8: La satira sotto il principato: Persio e Giovenale. Letture antologiche: t2/t4/t5/t7.<br />
Cap. 9: L’epica di età flavia: gli epigoni di Virgilio: Stazio, Valerio Flacco, Silio Italico (cenni essenziali).<br />
Cap. 10: Plinio il Vecchio e la Naturalis historia (cenni essenziali).<br />
Cap. 11: Marziale e l’epigramma. Letture antologiche: (ampia scelta da t1 a t15).<br />
Cap. 12: Quintiliano. Letture antologiche: t3/t4/t6.<br />
Cap. 13: L’età degli imperatori per adozione. Gli Antonini: storia e cultura letteraria.<br />
Cap. 14: Plinio il Giovane tra epistola e panegirico (cenni essenziali).<br />
Cap. 15: Tacito: (vedi il programma di autore).<br />
Cap. 16: Svetonio e la storiografia minore (cenni essenziali).<br />
Cap. 17: Apuleio. Letture antologiche: da t3 a t10 (in particolare, la favola di Amore e Psiche andrà inte-<br />
gralmente letta in traduzione italiana). Dibattito critico: letture critiche n. 1 e 2 alle pgg. 557-560.<br />
Nell’impossibilità di sviluppare sistematicamente la trattazione dei secoli conclusivi dello sviluppo letterario,<br />
si è ritenuto di fornire agli studenti cenni essenziali sul latino cristiano e sulla figura di Sant'Agostino, con par-<br />
ticolare riferimento all’opera Confessiones. Capp. 26 e 27: Il trionfo del cristianesimo. Agostino e i padri del-<br />
la Chiesa. Letture antologiche: da t6 a t12 (in particolare, i testi t8 e t10 andranno tradotti dal latino).<br />
Programma di Lettura e analisi di testi d’autore<br />
Orazio Carmina: dal libro: M. Gori, Novae voces. Orazio, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori. Introdu-<br />
zione alla lettura della lirica oraziana nel panorama dell’età augustea. I Carmina: composizione, struttura e te-<br />
matiche; il riferimento ai modelli greci; la visione filosofica e l’ideale del giusto mezzo; il rapporto con il pote-<br />
re e l’inizio del classicismo latino; la metrica, lo stile, il linguaggio.<br />
Lettura in lingua con scansione metrica, analisi, traduzione, contestualizzazione e commento dei carmina: I.1 -<br />
I.4 - I.9 - I.11 - I.37 - I.38 - II.10 (solo in traduzione italiana) - II.14 -<strong>III</strong>.13 - <strong>III</strong>.30 - IV.7. Dibattito critico:
dal II volume di letteratura, alle pgg. 284-290.<br />
Seneca: dal libro di letteratura G.B. Conte – E. Pianezzola, Lezioni di letteratura latina, corso integrato, Le<br />
Monnier. Volume 3, capitolo 5: la vita e l’opera; filosofia e potere: l’evoluzione dei rapporti con la corte impe-<br />
riale; la scelta filosofica: il genere della consolatio, le opere dell’etica stoica e la libertà del sapiens, la pratica<br />
quotidiana della filosofia e la scelta dell’epistula; la produzione tragica e il logos sconfitto; le scelte espressi-<br />
ve: il linguaggio dell’interiorità e quello della predicazione.<br />
Letture antologiche (in lingua italiana): dai Dialoghi: t1/t5/t7/t8/t10/t14/t15/t17/t18 (almeno tre a scelta); de<br />
brevitate vitae (lettura integrale); dall’Apokolokyntosis: t19/t20; dalle tragedie: Medea (lettura integrale); dalle<br />
Epistulae morales ad Lucilium: t3/t4/t12/t13.<br />
Traduzione dal latino: analisi e traduzione, contestualizzazione e commento dei brani: percorso tematico sul<br />
De brevitate vitae. Frenesia di vita e paura della morte, fascicolo distribuito (capitoli 1-3; 10,2/5-6; 12,1-<br />
2/4/7). Epistulae morales ad Lucilium: t2 (epistula 1) - t6 (epistula 70, 14-19) - t11 (epistula 41,1-5) - t16<br />
(epistula 147, 1-13). Dibattito critico: letture critiche n. 2 e 3 alle pgg. 137-141.<br />
Tacito: dal libro di letteratura G.B. Conte – E. Pianezzola, Lezioni di letteratura latina, corso integrato, Le<br />
Monnier. Volume 3, capitolo 15: La vita e l’opera di Tacito: conoscenza generale e struttura dell’Agricola,<br />
della Germania, delle Historiae e degli Annales. Il rapporto con il potere imperiale e la figura di Agricola; le<br />
cause della decadenza dell’oratoria nel Dialogus; gli interessi etnografici e l’idealizzazione del mondo barbari-<br />
co; Historiae e Annales: inattualità del mos maiorum e radici del principato, la soluzione del principato mode-<br />
rato; incisività stilistica e moduli espressivi.<br />
Letture antologiche (in lingua italiana): dall’Agricola: t1/t2/t3/t4; dalla Germania: t8/t9/t10/t13; dalle Histo-<br />
riae: t20/t24; dagli Annales: t18/t19/t21/t22/t26/t27.<br />
Traduzione dal latino: analisi e traduzione, contestualizzazione e commento dei brani: dall’Agricola: t5<br />
(cap.10); t6 (capp.11-12,4); t15 (capp.30-32): t23 (cap.1). Percorso tematico: gli Annales. Neropolis,<br />
l’incendio di Roma (XV, 38-44): fascicolo distribuito: 13.1 (cap.XV,38); 13.5 (cap.XV,43); 13.6 (cap.XV,44).<br />
Dibattito critico: lettura critica n.2 e una a scelta tra la n.1 e la n.3, alle pgg. 496-501.<br />
Durante l’anno scolastico sono state svolte traduzioni di brani, con particolare riferimento agli autori di età<br />
imperiale: Livio – Velleio Patercolo – Valerio Massimo – Seneca – Tacito – Plinio il Giovane.
Docente: professor Cristiano Scagliarini<br />
PROGRAMMA DI GRECO<br />
ALLEGATO N.8<br />
Programma di Letteratura con Letture antologiche (in traduzione italiana, a scelta tra quelle proposte).<br />
Libro di testo: Mario Casertano – Gianfranco Nuzzo, Storia e testi della letteratura greca, volume <strong>III</strong>, tomi 1 e<br />
2, Palumbo Editore.<br />
Volume <strong>III</strong> . Tomo 1<br />
Capitolo 1: la civiltà ellenistica: i centri di diffusione e i caratteri della civiltà ellenistica. Il rapporto tra lette-<br />
ratura e pubblico. La lingua della koinè.<br />
Il quadro culturale: trattazione per cenni essenziali: dal capitolo 8: Filologi e scienziati; dal capitolo 10: la fi-<br />
losofia dell’età ellenistica, con particolare riferimento all’epicureismo, alla prima fase dello stoicismo, alla<br />
scuola cinica. Letture antologiche: T1 Alessandro fra storia e leggenda.<br />
Capitolo 2: Menandro e la Commedia Nuova: il teatro e l’umanesimo menandreo; le scelte linguistiche e la<br />
tecnica teatrale. Letture antologiche: lettura integrale di una commedia a scelta: Dyskolos – Perikeiromene –<br />
Epitrepontes – Aspis.<br />
Capitolo 3: la poesia elegiaca: Callimaco. La poetica callimachea tra tradizione e innovazione; Callimaco, il<br />
poeta “giocoso”. Letture antologiche: T1 – T3 – T4 – T5 – T6 – T8 – da T10 a T12.<br />
Capitolo 4: la poesia epico – didascalica: Apollonio Rodio. La poetica di Apollonio tra Omero e Callimaco.<br />
Le Argonautiche: struttura del poema, i protagonisti del poema: Medea e Giasone. Letture antologiche: T1 –<br />
T4 – T6 – T7 – T9 – T11.<br />
Capitolo 5: la poesia bucolico – mimetica: Teocrito. Il corpus teocriteo; il paesaggio bucolico e il realismo<br />
fantastico di Teocrito; la visione dell’eros. La poesia bucolica dopo Teocrito: Mosco e Bione. La poesia mime-<br />
tica dopo Teocrito: Eroda. Letture antologiche: T1 – T3 – T4 – T5 – T6. Capitolo 7: l’epigramma. La lunga<br />
storia dell’epigramma e le raccolte epigrammatiche: l’Antologia Palatina. L’epigramma in età ellenistica.<br />
L’epigramma dorico – peloponnesiaco: Anite, Nosside, Leonida. L’epigramma ionico – alessandrino: Ascle-<br />
piade. L’epigramma fenicio: Meleagro e Filodemo. Letture antologiche: da T1 – T17 (esempi a scelta di epi-<br />
gramma dorico – peloponnesiaco) – da T18 a T26 (esempi a scelta di epigramma ionico – alessandrino) – da<br />
T31 a T49 (esempi a scelta di epigramma fenicio).<br />
Capitolo 9: Polibio e la storiografia ellenistica. Diffusione del genere storiografico: gli storici di Alessandro.<br />
Polibio: vita e opera; la struttura delle Storie. La riflessione sulla storia e il metodo storiografico; l’analisi delle<br />
costituzioni. Polibio storico e scrittore. Letture antologiche: T1 – T3 – da T5 a T7 – T8.<br />
Volume <strong>III</strong> . Tomo 2<br />
L’età greco – romana: quadro storico-politico e culturale: trattazione per cenni essenziali: dal capitolo 11: il<br />
lungo tramonto del mondo antico; la Grecia e la sua cultura sotto il dominio romano; dal capitolo 12: il pre-<br />
dominio della retorica, asianesimo e atticismo. Il trattato Sul sublime; dal capitolo 15: gli storici di età impe-<br />
riale: Appiano, Arriano e Cassio Dione; dal capitolo 20: la letteratura ebraico – ellenistica: la Bibbia dei Set-
tanta e Giuseppe Flavio, la letteratura cristiana: il Nuovo Testamento; dal capitolo 21: la letteratura cristiana<br />
fino all’editto di Costantino.<br />
Capitolo 13: Luciano e la Seconda Sofistica: l’abbandono della retorica e la satira filosofica; la produzione<br />
romanzesca (cenni essenziali). Letture antologiche: T7 – T8.<br />
Capitolo 14: Plutarco e il tramonto del mondo antico. Vita e opere: le Vite parallele e i Moralia. Letture an-<br />
tologiche: T1 – T8.<br />
Capitolo 17: Il romanzo greco: struttura e contenuto; il problema delle origini: un genere letterario senza no-<br />
me; i romanzi di argomento amoroso. Un esempio: Longo Sofista. Letture antologiche: da T7 a T12: brani<br />
tratti da: Vicende pastorali di Dafni e Cloe.<br />
Programma di Lettura e analisi di testi d’autore<br />
1) Teatro tragico: il teatro tragico e la polis; la tragedia come rito collettivo; senso, lessico e coscienza del<br />
tragico. Il teatro di Sofocle. La solitudine dell’eroe sofocleo.<br />
Euripide, Medea (a cura di Laura Suardi), Principato Editore. Lettura integrale commentata della tragedia in<br />
traduzione italiana; struttura e interpretazione della tragedia. Lettura in lingua con scansione metrica del trime-<br />
tro giambico, analisi, traduzione, contestualizzazione e commento dei seguenti versi: versi 1-48 (prologo); ver-<br />
si 214-270 (I episodio); versi 410-445 (1 stasimo); versi 446-521 e 579-626 (II episodio); versi 663-708; 746-<br />
758 (<strong>III</strong> episodio); versi 1021-1080 (V episodio); versi 1317-1329 e 1377-1419 (esodo).<br />
2) Oratoria: dal libro di testo: Mario Casertano – Gianfranco Nuzzo, Storia e testi della letteratura greca, vo-<br />
lume II.2, Palumbo Editore. Capitolo 12: le origini dell’oratoria; la prima stagione dell’oratoria, l’oratoria<br />
giudiziaria, il processo ateniese. Lisia: vita e opere: il corpus Lysiacum. L’etopea di Lisia. Letture antologiche<br />
e conoscenza di una delle tre orazioni proposte, e precisamente: Per l’invalido o Per l’olivo sacro o Per<br />
l’uccisione di Eratostene (T2/T3/T4).<br />
Lisia: Contro Eratostene: dal testo: D. Piovan, Processo ai tiranni. Carlo Signorelli Editore. Conoscenza ge-<br />
nerale, lettura in lingua italiana e struttura dell’orazione. Lettura in lingua con analisi, traduzione, contestualiz-<br />
zazione e commento dei seguenti paragrafi: da § 4 a § 23 alle pgg. 23-33; da § 62 a § 78 alle pgg. 35-46; da §<br />
92 a § 98 alle pgg. 50-55.<br />
Durante l’anno, sono state svolte traduzioni di brani, con particolare riferimento agli storici, agli oratori, agli<br />
autori del terzo anno; in particolare: Polibio – Lisia – Demostene – Isocrate.
PROGRAMMA DI INGLESE (LETTERATURA)<br />
Docente: prof. Gabriella Liberini<br />
Libro di testo: Graeme Thomson – Silvia Maglioni, Literary Hyperlinks (CIDEB)<br />
LIBRO A<br />
The Romantic Age: History and society - the Age of Revolutions pag. 384-386;<br />
390-392.<br />
Literature: Characteristics of Romanticism pag. 395; 399-400<br />
William Blake (pag.410-412; 418)<br />
London<br />
William Wordsworth (pag 427-435)<br />
I wandered lonely as a cloud<br />
Upon Westminster bridge<br />
John Keats (pag.483-487; 489-492)<br />
Ode on a Grecian Urn<br />
La Belle dame sans merci<br />
Samuel T. Coleridge (pag. 447-455)<br />
passi scelti da “The rime of the ancient mariner”<br />
LIBRO B<br />
The Victorian Age : History and society (lavori di gruppo)<br />
The Age of Empire (pag. 10-14; 15-19; 22-24;29-30)<br />
Victorian Novel :<br />
Charles Dickens (pag. 46; 52-55)<br />
passi scelti da “Hard Times”<br />
“Coketown” su fotocopia<br />
Victorian Drama :<br />
Oscar Wilde (pag. 171-176; 178-182)<br />
passi scelti da “The Picture of Dorian Gray”<br />
“The Importance of being Earnest”<br />
“The ballad of Reading Gaol” (alcune stanze su fotocopia)<br />
The Modern Age : History and society<br />
Modern Drama<br />
G.B.Shaw (pag.184-188)<br />
passi scelti da “Mrs Warren’s Profession” (fotocopia)<br />
“Pygmalion”<br />
War Poets (fotocopie)<br />
W. Owen<br />
Dulce et decorum est<br />
R. Brooke<br />
The soldier<br />
S. Sassoon<br />
ALLEGATO N.9
Glory of Women<br />
Early Modern Novel:<br />
E.M. Foster (pag. 244-251) passi scelti da “A passage to India”<br />
Modern Novel:<br />
George Orwell passi scelti da “Animal Farm” (su fotocopia) e “1984”<br />
The Contemporary Age<br />
Contemporary Drama:<br />
J.B Priestley “An inspector calls”<br />
Contemporary Novel:<br />
Hanif Kureishi passi scelti da “The Buddha of Suburbia” (fotocopia)
ALLEGATO N.10<br />
PROGRAMMA DI STORIA<br />
Docente: prof. Angela Scozzafava<br />
Massimo L. Salvadori, Francesco Tuccari - L’Europa e il mondo nella storia, XIX-XXI secolo – Loescher<br />
editore<br />
Economia, società, cultura e ideologie politiche nell'età dell'imperialismo: lo sviluppo dell'industria e<br />
il processo di concentrazione capitalistica; il capitalismo finanziario; le classi sociali; la crisi del razionalismo<br />
progressista; la chiesa cattolica da Leone XII a Pio X.<br />
L'Italia dall'avvento della sinistra alla “crisi di fine secolo”: l'avvento della Sinistra; Crispi al potere; il<br />
movimento operaio; dal primo ministero Giolitti all'ultimo Crispi; la “crisi di fine secolo”; lo sviluppo<br />
dell'economia italiana.<br />
Le relazioni internazionali nell'ultimo trentennio del XIX secolo: il disegno bismarckiano: dal Dreikaiserbund<br />
alla Triplice Alleanza; L'Italia tra le grandi potenze; il fallimento del disegno bismarckiano.<br />
Alla vigilia del conflitto. Europa e Stati Uniti al principio del XX secolo: politica interna e politica<br />
estera nello sviluppo delle rivalità tra le grandi potenze; la Germania guglielmina; l'impero russo.<br />
L'Italia giolittiana: l'Italia tra arretratezza e “decollo industriale”; l'”età giolittiana”; la fine dell'esperimento<br />
giolittiano.<br />
Le reazioni internazionali dalla fine del XIX secolo al 1914: verso la guerra per il predominio mondiale;<br />
la guerra russo-giapponese; dall'entente cordiale tra Gran Bretagna e Francia all'accordo anglo-russo; la<br />
Triplice Intesa; dalla rivoluzione dei “Giovani turchi” alla seconda crisi marocchina; la politica estera italiana<br />
e la guerra di Libia.<br />
La prima guerra mondiale: origini e caratteri del conflitto; il 1914; l'Italia: dalla dichiarazione di neutralità<br />
all'intervento; la guerra di posizione: il 1915 e il 916; la svolta del 1917; l'ultimo anno di guerra: il<br />
1918; la pace e la società delle Nazioni.<br />
La rivoluzione Russa: la crisi dello zarismo; la rivoluzione di febbraio; la rivoluzione d'ottobre.<br />
La crisi del dopoguerra: l'eredità della guerra; il dopoguerra nei paesi europei; il dopoguerra in Italia; il<br />
fallimento della rivoluzione in Europa e la nascita della <strong>III</strong> Internazionale.<br />
Economia, società, politica tra le due guerre mondiali: sviluppo, crisi e trasformazione del capitalismo;<br />
le trasformazioni sociali e politiche; il totalitarismo.<br />
Il fascismo in Italia: la fine dello Stato liberale e l'avvento del fascismo; il fascismo alla conquista del potere<br />
“totale”; le istituzioni dello Stato fascista; l'ordine “corporativo”; gli oppositori del fascismo.<br />
Il nazismo in Germania: la repubblica di Weimar; dalla stabilizzazione economica alla crisi del 1929;<br />
ideologia e struttura del partito nazista; l'avvento al potere del nazismo; la formazione dello “Stato totale”;<br />
il regime totalitario; l'economia durante il nazismo.<br />
Il comunismo in Unione Sovietica: dalla guerra civile alla “Nuova politica economica”; da Lenin a Stalin;<br />
il regime totalitario staliniano; l'Internazionale comunista.<br />
La politica internazionale tra le due guerre mondiali: Gli anni '20, le illusioni della pace; la politica<br />
estera dell'Italia fascista negli anni'20; gli anni'30: verso la rottura degli equilibri; la guerra d'Etiopia e la<br />
rimilitarizzazione della Renania; la guerra civile spagnola; verso la seconda guerra mondiale.<br />
La seconda guerra mondiale: i caratteri del conflitto; dall'attacco alla Polonia alla sconfitta della Francia;<br />
l'Italia in guerra e la “battaglia d'Inghilterra”; l'intervento degli Stati Uniti nel conflitto. Pearl Harbor; l'attacco<br />
tedesco all'Unione Sovietica; le conquiste giapponesi in Asia; le prime sconfitte dell'Asse; il crollo
militare dell'Italia e la caduta del fascismo. Il governo Badoglio; il “nuovo ordine” in Europa e in Asia;<br />
l'Olocausto; la sconfitta della Germania e del Giappone; collaborazionismo e resistenza in Europa; Teheran,<br />
Jalta e Potsdam. Il mondo dopo la guerra.<br />
Il secondo dopoguerra: le devastazioni della guerra e il nuovo assetto geopolitico mondiale; il dopoguerra<br />
in Unione Sovietica e nell'Europa centro-orientale; la guerra civile in Grecia; il dopoguerra negli Stati<br />
Uniti e nell'Europa occidentale; il dopoguerra in Italia. Il referendum e la stesura della Costituzione.<br />
Le razioni internazionali nell'età del “Bipolarismo” e della “Guerra Fredda”: i caratteri del sistema<br />
bipolare: bipolarismo e guerra fredda; le principali fasi dell'età bipolare; le origini e i primi sviluppi della<br />
“guerra fredda”; tra “coesistenza pacifica” e crisi (1953-79). L'Unione Sovietica e l'Europa centroorientale:<br />
l'evoluzione dell'impero sovietico. nell'Europa centro-orientale alla “destalinizzazione”; la crisi<br />
in Polonia e la rivoluzione in Ungheria (1956).<br />
L'Italia nell'età bipolare: le contraddizioni dello sviluppo italiano. Un “regime bloccato”; gli anni del “<br />
centrismo”.
Docente: prof. Angela Scozzafava<br />
PROGRAMMA DI FILOSOFIA<br />
Nicola Abbagnano, Giovanni Fornero – Protagonisti e testi della filosofia – Ed. Paravia<br />
ALLEGATO N.11<br />
Romanticismo e Idealismo<br />
Il movimento romantico e la filosofia idealista: caratteri generali del Romanticismo e dell’Idealismo<br />
G. F. W. Hegel – I cardini della filosofia hegeliana; l’autocoscienza e il sapere; la Fenomenologia dello Spirito<br />
(con particolare riferimento alla figura dell’Autocoscienza); la filosofia come sistema: la Scienza della Logica<br />
(caratteri generali); la filosofia della natura (caratteri generali); la filosofia dello Spirito: lo Spirito Soggettivo,<br />
lo Spirito Oggettivo, lo Spirito Assoluto; la filosofia della storia.<br />
Critica e rottura del sistema hegeliano: Schopenhauer e Kierkegaard<br />
Schopenhauer: le vicende biografiche e le opere; le radici culturali del sistema; il “velo di Maya”; tutto è Volontà;<br />
dall'essenza del mio corpo all'essenza del mondo; caratteri e manifestazioni della Volontà di vivere; il<br />
pessimismo; le vie della liberazione dal dolore.<br />
Kierkegaard: le vicende biografiche e le opere; l'esistenza come possibilità e fede; la critica all'hegelismo; gli<br />
stadi dell'esistenza; angoscia e disperazione; l'attimo e la storia: l'eterno nel tempo..<br />
Dallo Spirito all'uomo: Marx<br />
La sinistra hegeliana: la destra e la sinistra hegeliana: caratteri generali.<br />
Marx: la vita e le opere; le caratteristiche generali del marxismo; la critica al misticismo logico di Hegel; la<br />
critica allo Stato moderno e al liberalismo; la critica all'economia borghese; il distacco da Feuerbach e l'interpretazione<br />
della religione in chiave sociale; la concezione materialistica della storia; il Manifesto del partito<br />
comunista; il Capitale; la rivoluzione e la dittatura; le fasi della futura società comunista.<br />
Scienza e progresso: il positivismo<br />
Il positivismo sociale: caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo; Positivismo, Illuminismo<br />
e Romanticismo; le varie forme di positivismo; la filosofia sociale in Francia.<br />
Comte: la legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze; la sociologia; la divinizzazione della storia<br />
dell’uomo.<br />
La crisi delle certezze nella filosofia: Nietzsche<br />
La demistificazione delle illusioni della tradizione: vita e scritti; le edizioni delle opere; le caratteristiche del<br />
pensiero e della scrittura di Nietzsche; le fasi del filosofare nietzscheano; il periodo giovanile; il periodo “illuministico”<br />
Il periodo di Zarathustra e l'ultimo Nietzsche: Così parlò Zarathustra; l'ultimo Nietzsche.<br />
La crisi delle certezze nelle scienze umane<br />
Freud: vita e opere; dagli studi sull'isteria alla psicoanalisi; la realtà dell'inconscio e le vie per accedervi; la<br />
scomposizione psicoanalitica della personalità; i sogni, gli atti mancanti e i sintomi nevrotici; la teoria della<br />
sessualità e il complesso edipico; la teoria psicoanalitica dell'arte; la religione e la civiltà.<br />
La riflessione sull’esistenza: l’esistenzialismo<br />
L'esistenzialismo: caratteri generali: l'esistenzialismo come “atmosfera”; l'esistenzialismo come filosofia.
Il “primo” Heidegger:; vita e scritti fino alle soglie degli anni Trenta; essere ed esistenza; l'essere-nel-mondo<br />
e la visione ambientale preveggente; l'esistenza inautentica; l'esistenza autentica; il tempo e la storia; l'incompiutezza<br />
di Essere e tempo.<br />
Filosofia ed epistemologia: Popper<br />
Popper: vita e opere; Popper e Einstein; la riabilitazione della filosofia; le dottrine epistemologiche: il problema<br />
della demarcazione e il principio di falsificabilità; le asserzioni-base e la precarietà della scienza; l'asimmetria<br />
tra verificabilità e falsificabilità e la teoria della corroborazione; osservazioni; la riabilitazione della<br />
metafisica; la critica epistemologica al marxismo e alla psicoanalisi; inesistenza ed esistenza del metodo: il<br />
procedimento per “congetture e confutazioni”; il rifiuto dell'induzione e la teoria della mente come “faro”; le<br />
dottrine politiche.<br />
Hans Jonas: fra libertà e responsabilità globale<br />
Lezione del professor Emidio Spinelli (Dipartimento di filosofia dell’Università “La Sapienza”): appunti e<br />
passi antologici.
Docente: prof. Maurizio Frigeni<br />
PROGRAMMA DI MATEMATICA<br />
Testi adottati - Bergamini, Trifone, Barozzi:<br />
Elementi di Matematica, modulo O verde - Trigonometria (Zanichelli);<br />
Matematica.Azzurro, modulo pi greco (Zanichelli).<br />
ALLEGATO N.12<br />
Trigonometria<br />
Misura degli angoli in gradi e radianti. Definizione generalizzata di angolo. Circonferenza goniometrica. Definizione<br />
delle funzioni seno e coseno. Relazione fondamentale fra seno e coseno: sin 2 x + cos 2 x = 1. Definizioni<br />
geometrica e funzionale della tangente trigonometrica. Dimostrazione della definizione funzionale della tangente<br />
(tanx = sinx/cosx) a partire dalla definizione geometrica.<br />
Valori di seno, coseno e tangente per alcuni angoli particolari. Angoli associati. Grafico delle funzioni seno,<br />
coseno, tangente. Funzioni trigonometriche inverse: arcoseno, arcocoseno, arcotangente.<br />
Equazioni goniometriche elementari: equazioni risolubili direttamente (cioè polinomiali in sinx, cosx e tanx e<br />
riconducibili immediatamente ad una equazione del tipo sinx = a, cosx = a o tanx = a); equazioni omogenee in<br />
sinx e cosx.<br />
Formule di addizione e sottrazione (con dimostrazione). Formule di duplicazione (con dimostrazione). Relazioni<br />
fra lati e angoli in un triangolo rettangolo. Risoluzione dei triangoli rettangoli. Teorema dei seni (con<br />
dimostrazione). Teorema del coseno (con dimostrazione). Risoluzione di un triangolo qualunque.<br />
Geometria<br />
Assiomi di incidenza fra punti, rette e piani. Posizioni reciproche di due rette nello spazio. Posizioni reciproche<br />
di una retta e un piano nello spazio. Posizioni reciproche di due piani nello spazio. Perpendicolarità fra retta<br />
e piano: teorema di perpendicolarità (con dimostrazione), definizione di retta perpendicolare ad un piano.<br />
Teorema delle tre perpendicolari (con dimostrazione). Definizione di diedro. Sezioni normali e ampiezza di un<br />
diedro. Piani perpendicolari. Definizioni di prisma indefinito, triedro e angoloide.<br />
Definizioni di prisma e parallelepipedo. Definizione di piramide. Piramidi rette. I cinque poliedri regolari.<br />
Definizioni di cilindro, cono e sfera. Superfici laterali del cono e del cilindro.<br />
Principio di Cavalieri ed equivalenza dei solidi. Volume di un parallelepipedo rettangolo. Teorema sui prismi<br />
equiestesi (con dimostrazione) e volume del prisma. Teorema sulle piramidi equiestese (con dimostrazione).<br />
Equivalenza di una piramide ad un terzo di un prisma (con dimostrazione) e volume della piramide. Volume<br />
del cilindro e del cono. Volume della sfera (con dimostrazione).
Docente: prof. Maurizio Frigeni<br />
PROGRAMMA DI FISICA<br />
ALLEGATO N.13<br />
Fenomeni elettrostatici<br />
Elettrizzazione per strofinio e carica elettrica. Isolanti e conduttori. Legge di Coulomb. Sovrapposizione delle<br />
forze. Definizione di campo elettrico. Campo elettrico generato da una carica puntiforme. Linee di forza del<br />
campo elettrico. Elettrizzazione per contatto e per induzione. Campo elettrico all’interno e alla superficie di un<br />
conduttore. Flusso del campo elettrico attraverso una superficie orientata. Calcolo del flusso del campo elettrico<br />
attraverso una superficie sferica dovuto ad una carica puntiforme posta al suo centro. Teorema di Gauss<br />
(senza dimostrazione). Applicazioni del teorema di Gauss: campo elettrico all’interno di un condensatore piano.<br />
Potenziale elettrico<br />
Energia potenziale in un campo elettrico. Potenziale elettrico. Potenziale elettrico di una carica puntiforme.<br />
Sovrapposizione di potenziali elettrici. Definizione di capacità di un condensatore. Condensatori a facce piane<br />
parallele: calcolo della capacità. Dielettrici. Circuitazione del campo elettrico.<br />
Corrente elettrica<br />
Forza elettromotrice e corrente elettrica. Intensità di corrente e sua unità di misura. Resistenza, resistività e<br />
leggi di Ohm. Potenza elettrica dissipata ed effetto Joule.<br />
Magnetismo<br />
Interazioni magnetiche e campo magnetico. Direzione e verso del campo magnetico B. Linee del campo magnetico.<br />
Forza di Lorentz su cariche in movimento. Intensità del campo magnetico. Moto di una carica in un<br />
campo magnetico uniforme. Forza magnetica su un filo percorso da corrente. Campo magnetico generato da<br />
un filo rettilineo percorso da corrente. Forza fra due fili rettilinei percorsi da corrente. Il teorema di Gauss per<br />
il campo magnetico. Legge della circuitazione di Ampère. Il magnetismo nella materia: materiali diamagnetici,<br />
paramagnetici e ferromagnetici.<br />
Induzione elettromagnetica<br />
Forza elettromotrice indotta e correnti indotte. Flusso del campo magnetico. Legge di Faraday-Neumann<br />
dell’induzione elettromagnetica. Legge di Lenz. Alternatore e corrente alternata. Tensione e corrente efficaci.<br />
Il trasformatore.<br />
Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche<br />
Equazioni di Maxwell. Onde elettromagnetiche. Velocità della luce nel vuoto. Spettro elettromagnetico. Effetto<br />
Doppler.<br />
Relatività ristretta<br />
L'etere e le ipotesi di Einstein. Tempo proprio e dilatazione degli intervalli di tempo. Lunghezza propria e contrazione<br />
delle lunghezze. Forma relativistica dell'energia cinetica. Energia propria e massa.
PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI<br />
Docente prof. Isabella Iezza<br />
Libro di testo: Lupia Palmieri Parotto. “Il globo terrestre e la sua evoluzione” Zanichelli editore<br />
ALLEGATO N.14<br />
1 Unità Didattica: l’ambiente celeste<br />
Le costellazioni e la sfera celeste. Le distanze astronomiche. Magnitudine apparente e assoluta. Colori, temperatura<br />
e spettri stellari. Stelle in fuga ed in avvicinamento. Materia interstellare e nebulose. La fornace nucleare<br />
del Sole e delle altre stelle. Il diagramma H.R. Dalle nebulose alle giganti rosse. Masse iniziali diverse , stelle<br />
con destini diversi. La nostra Galassia. Galassie e famiglie di galassie. La legge di Hubble e l’espansione<br />
dell’Universo. L’Universo stazionario. Il big bang e l’Universo inflazionario. Evoluzione dell’Universo<br />
2 Unità Didattica: Il Sistema Solare<br />
Il Sistema Solare. La struttura del Sole. L’attività solare. Il movimento dei pianeti attorno al Sole: leggi di Keplero<br />
e legge della gravitazione universale. Famiglie di pianeti. Gli asteroidi. Meteore e meteoriti. Le comete.<br />
3 Unità Didattica: il pianeta Terra<br />
La forma della Terra. Il reticolato geografico. La posizione dei luoghi sulla Terra e quella degli astri nel cielo:<br />
definizione di latitudine, longitudine, declinazione celeste e ascensione retta. Il moto di rotazione. Prove e conseguenze<br />
del moto di rotazione. Il ciclo quotidiano del dì e della notte. Il moto di rivoluzione. Prove e conseguenze<br />
della rivoluzione terrestre.<br />
Altri moti terrestri. Moto doppio conico. La precessione degli equinozi. Unità di misura del tempo: giorno solare<br />
, giorno sidereo, anno sidereo, anno tropico, anno civile.<br />
4 Unità didattica : La Luna e il sistema Terra –Luna<br />
Forma e dimensioni della Luna. Un corpo celeste senza atmosfera e idrosfera. Il moto di rotazione. Il moto di<br />
rivoluzione. Mese sidereo e mese sinodico. Il moto di traslazione. Le fasi lunari. Eclissi di Luna e di Sole. Il<br />
paesaggio lunare. Le ipotesi sull’origine della Luna.<br />
5 Unità Didattica. La crosta terrestre: minerali e rocce.<br />
Elementi, composti e miscele. Stati di aggregazione della materia . La composizione chimica dei minerali.<br />
Struttura cristallina, proprietà fisiche, classificazione e genesi dei minerali. I processi litogenetici. Dal magma<br />
alle rocce magmatiche. Classificazione dei magmi. Famiglie di rocce magmatiche. Origine e formazione dei<br />
magmi. Dai sedimenti alle rocce compatte. Le rocce clastiche. Le rocce organogene. Le rocce chimiche. Le<br />
rocce metamorfiche. Il metamorfismo di contatto. Il metamorfismo regionale. Il ciclo litogenetico.<br />
6 Unità Didattica. I fenomeni vulcanici.<br />
Vulcanismo. Attività vulcanica. I magmi. Edifici vulcanici. I tipi di eruzione. I prodotti dell’attività vulcanica.<br />
Altri fenomeni legati all’attività vulcanica. Il vulcanismo effusivo delle dorsali oceaniche e dei punti caldi. Il<br />
vulcanismo esplosivo. La distribuzione geografica dei vulcani.<br />
7 Unità Didattica. I fenomeni sismici<br />
Lo studio dei terremoti. Il modello del rimbalzo elastico. Il ciclo sismico. Differenti tipi di onde sismiche.<br />
Come si registrano le onde sismiche. Localizzazione dell’epicentro di un terremoto. La scala di intensità. La<br />
magnitudo. Magnitudo e intensità a confronto. I terremoti e l’interno della Terra. La distribuzione geografica<br />
dei terremoti. La difesa dai terremoti.<br />
8 Unità Didattica. La tettonica delle placche : un modello globale.<br />
La struttura interna della Terra. La crosta. Il mantello. Il nucleo. Il flusso di calore. La temperatura interna della<br />
Terra. Il campo magnetico terrestre. La geodinamo. Il paleomagnetismo. Crosta continentale e crosta oceanica.<br />
L’isostasia. La deriva dei continenti. Le dorsali oceaniche. Le fosse abissali. Espansione e subduzione.<br />
Le anomalie magnetiche sui fondi oceanici. La tettonica delle placche: le placche litosferiche. L’orogenesi Il<br />
ciclo di Wilson. Saggiando il modello: vulcani ai margini o all’interno delle placche; terremoti ai margini o<br />
all’interno delle placche. Un possibile motore per la tettonica delle placche: celle convettive e punti caldi.
Docente prof.ssa Caterina Capalbo<br />
Libro di testo: “Arte tra noi” ed. B. Mondadori N.4-5<br />
Il Neoclassicismo:<br />
J. J. Winckelmann<br />
G. B. Piranesi<br />
A. Canova<br />
Jacques-Louis David<br />
Francisco Goya<br />
Il Romanticismo (il sublime)<br />
Eugène Delacroix<br />
Théodore Géricault<br />
William Blake<br />
William Turner<br />
J. Heinrich Füssli<br />
Gustave Courbet<br />
Jean François Millet<br />
Pittura Storica In Italia<br />
Francesco Hayez<br />
Giuseppe Pellizza Da Volpedo<br />
L’impressionismo<br />
Eduard Manet<br />
Claude Monet<br />
Edgar Degas<br />
P. Auguste Renoir<br />
Alfred Sisley<br />
Paul Cézanne<br />
Il Post-Impressionismo<br />
Paul Gauguin<br />
Vincent Van Gogh<br />
Henry Matisse<br />
Il Divisionismo<br />
George Seurat<br />
L’espressionismo<br />
Edvard Munch<br />
L’architettura Del Ferro<br />
Henry Labrouste<br />
Gustave Alexandre Eiffel<br />
L’astrattismo<br />
Paul Klee<br />
Vasilij Kandinskij<br />
Il Cubismo<br />
Pablo Picasso<br />
George Braque<br />
PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE<br />
ALLEGATO N.15
Il Futurismo<br />
Filippo Tommaso Marinetti<br />
Carlo Carrà<br />
Umberto Boccioni<br />
Giacomo Balla<br />
Antonio Sant’elia<br />
La Metafisica il Surrealismo e Dada<br />
Amedeo Modigliani<br />
Giorgio De Chirico<br />
Alberto Savinio<br />
Salvador Dalì<br />
André Derain<br />
Max Ernst<br />
Marcel Duchamp<br />
Man Ray<br />
René Magritte<br />
La Pop Art<br />
Andy Warhol<br />
Claes Oldemburg<br />
Piero Manzoni<br />
L’informale<br />
Jackson Pollok<br />
Alexander Calder<br />
Emilio Vedova<br />
Giuseppe Capogrossi<br />
Alberto Burri<br />
Lucio Fontana<br />
Mark Rothko<br />
Approfondimenti<br />
Il Grand Tour, le Accademie e la nascita dei musei<br />
I marmi del Partenone a Londra: dibattito e polemiche<br />
Le teorie scientifiche del colore<br />
Marinetti: Manifesto del Futurismo<br />
Le donne e gli Amori di Pablo<br />
Passioni e delirio artistico in Dalì<br />
La Galleria d’arte moderna a Roma
Docente prof. Saverio Spinelli<br />
PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA<br />
PARTE PRATICA<br />
Potenziamento fisiologico:<br />
-esercizi per il miglioramento della funzione cardio-respiratoria mediante attività di durata<br />
in regime prevalentemente aerobico;<br />
-esercizi per il miglioramento della mobilità articolare eseguiti a corpo libero, alla spalliera<br />
e con la bacchetta; esercizi di stretching;<br />
-esercizi per lo sviluppo della tonicità muscolare svolti a carico naturale e con forme di sovraccarico,<br />
a corpo libero con manubri, bacchetta e al trx;<br />
-esercizi per la rapidità degli arti inferiori eseguiti alla speed ladder;<br />
Rielaborazione degli schemi motori di base:<br />
-esercizi di coordinazione generale con composizione di movimenti semplici;<br />
-traslocazioni al quadro svedese: ascendenti con precedenza del capo e discendenti a capofitto;<br />
-arrampicate alla pertica e alla fune a passo unito e alternato;<br />
-traslocazioni alla scala orizzontale a passo unito e alternato su montanti e pioli;<br />
-esercizi per lo sviluppo della coordinazione e del ritmo agli ostacoli e con la funicella.<br />
Conoscenza e pratica delle attività sportive:<br />
-atletica leggera: salto in alto (tecnica Fosbury );<br />
-elementi di ginnastica artistica – cavallo: volteggio framezzo, staccata e ribaltato;<br />
-pallavolo– fondamentali individuali: palleggio, bagher, battuta e schiacciata; fondamentali<br />
di squadra: schema di ricezione a 5 (w), schema di gioco 3-1-2 e coperture difensive;<br />
-pallacanestro-fondamentali individuali: palleggio, passaggio, terzo tempo, tiro piazzato e<br />
difesa a uomo.<br />
Sono stati svolti i seguenti argomenti teorici:<br />
-doping;<br />
-apparato cardiocircolatorio e modificazioni indotte dall’allenamento;<br />
-apparato respiratorio e modificazioni indotte dall’allenamento;<br />
-il movimento come prevenzione e i rischi della sedentarietà.<br />
ALLEGATO N.16
PROGRAMMA DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA<br />
Docente prof. Marco Ronconi<br />
ALLEGATO N.17<br />
1. Lineamenti di Storia della Chiesa contemporanea<br />
1.1 La questione romana<br />
1.2 Il Concilio Vaticano I (1869-1870)<br />
1.2.1 Focus sui rapporti fede-ragione (Dei Filius) e il dogma dell’infallibilità pontificia (Pastor<br />
Aeternus)<br />
1.3 La Chiesa e i regimi totalitari del XX secolo<br />
1.3.1 La situazione in Italia: punti di incontro e di scontro con il regime fascista<br />
1.3.2 La situazione in Germania<br />
1.3.3 La Chiesa di fronte al socialismo/comunismo<br />
2. Elementi di Dottrina Sociale della Chiesa<br />
2.1 Breve excursus storico<br />
2.2 I principi della Dottrina Sociale della Chiesa: introduzione<br />
2.3 La natura della Dottrina Sociale della Chiesa<br />
2.3.1 Lettura e analisi di Sollicitudo Rei Socialis n° 41<br />
3. Il Concilio Vaticano II (1962-1965)<br />
1.3.1 Giovanni XX<strong>III</strong>: l’annuncio e l’apertura del Concilio<br />
1.3.2 Paolo VI: la prosecuzione e la chiusura del Concilio<br />
1.3.3 Analisi di alcune tematiche<br />
1.3.3.1 La Dei Verbum e la dottrina sulla Rivelazione<br />
1.3.3.2 La Lumen Gentium e la Chiesa come “sacramento universale di salvezza”<br />
1.3.3.3 La Gaudium et spes: la Chiesa e il mondo contemporaneo – la questione dell’ateismo<br />
1.3.3.4 La Dignitatis Humanae e la libertà religiosa<br />
4. I concetti di laicità, secolarizzazione e ateismo<br />
4.1 La laicità<br />
4.1.1 Excursus storico-etimologico<br />
4.1.2 Il laico nell’ordinamento ecclesiale (focus sul Concilio Vaticano II)<br />
4.2 L’ateismo<br />
4.2.1 Presentazione delle posizioni di Marx, Nietzsche, Feurbach e Freud
Docente Prof.ssa Cristina Cianfanelli<br />
Gli organi costituzionali dello Stato italiano<br />
PROGRAMMA DI DIRITTO (materia alternativa all’I.R.C.)<br />
I partiti politici, le elezioni politiche ed amministrative<br />
Gli enti pubblici territoriali<br />
L’economia politica, il sistema economico ed i suoi protagonisti<br />
Il mercato: forme e tipi<br />
Il marketing, la pubblicità, la politica del prezzo<br />
Le ricerche di mercato e la promotion<br />
Lo smaltimento dei rifiuti<br />
Il Ministero dell’ambiente<br />
La Costituzione italiana e la tutela del paesaggio.<br />
ALLEGATO N.18