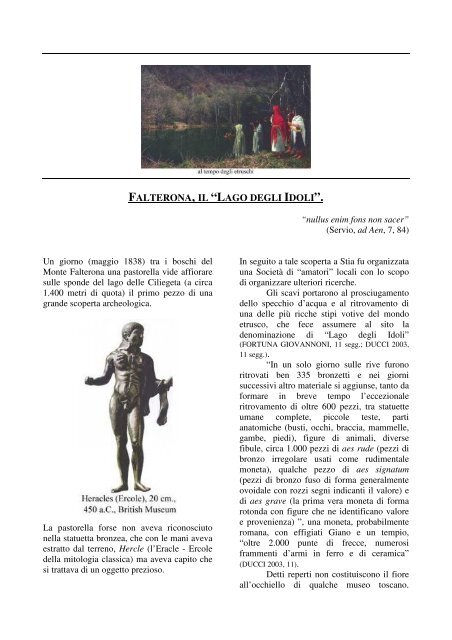FALTERONA, IL “LAGO DEGLI IDOLI”.
FALTERONA, IL “LAGO DEGLI IDOLI”.
FALTERONA, IL “LAGO DEGLI IDOLI”.
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>FALTERONA</strong>, <strong>IL</strong> <strong>“LAGO</strong> <strong>DEGLI</strong> <strong>IDOLI”</strong>.<br />
Un giorno (maggio 1838) tra i boschi del<br />
Monte Falterona una pastorella vide affiorare<br />
sulle sponde del lago delle Ciliegeta (a circa<br />
1.400 metri di quota) il primo pezzo di una<br />
grande scoperta archeologica.<br />
La pastorella forse non aveva riconosciuto<br />
nella statuetta bronzea, che con le mani aveva<br />
estratto dal terreno, Hercle (l’Eracle - Ercole<br />
della mitologia classica) ma aveva capito che<br />
si trattava di un oggetto prezioso.<br />
“nullus enim fons non sacer”<br />
(Servio, ad Aen, 7, 84)<br />
In seguito a tale scoperta a Stia fu organizzata<br />
una Società di “amatori” locali con lo scopo<br />
di organizzare ulteriori ricerche.<br />
Gli scavi portarono al prosciugamento<br />
dello specchio d’acqua e al ritrovamento di<br />
una delle più ricche stipi votive del mondo<br />
etrusco, che fece assumere al sito la<br />
denominazione di “Lago degli Idoli”<br />
(FORTUNA GIOVANNONI, 11 segg.; DUCCI 2003,<br />
11 segg.).<br />
“In un solo giorno sulle rive furono<br />
ritrovati ben 335 bronzetti e nei giorni<br />
successivi altro materiale si aggiunse, tanto da<br />
formare in breve tempo l’eccezionale<br />
ritrovamento di oltre 600 pezzi, tra statuette<br />
umane complete, piccole teste, parti<br />
anatomiche (busti, occhi, braccia, mammelle,<br />
gambe, piedi), figure di animali, diverse<br />
fibule, circa 1.000 pezzi di aes rude (pezzi di<br />
bronzo irregolare usati come rudimentale<br />
moneta), qualche pezzo di aes signatum<br />
(pezzi di bronzo fuso di forma generalmente<br />
ovoidale con rozzi segni indicanti il valore) e<br />
di aes grave (la prima vera moneta di forma<br />
rotonda con figure che ne identificano valore<br />
e provenienza) ”, una moneta, probabilmente<br />
romana, con effigiati Giano e un tempio,<br />
“oltre 2.000 punte di frecce, numerosi<br />
frammenti d’armi in ferro e di ceramica”<br />
(DUCCI 2003, 11).<br />
Detti reperti non costituiscono il fiore<br />
all’occhiello di qualche museo toscano.
Purtroppo, dopo essere stati inutilmente<br />
offerti all’Autorità Granducali, i “soci<br />
ricercatori” ottennero il permesso alla vendita<br />
a terzi. La ricca collezione fu venduta in<br />
blocco ed a poco prezzo. Ne fu curata<br />
un’esposizione nel dicembre del 1842 presso<br />
l’Istituto Archeologico Germanico di Roma<br />
ed è questa l’ultima notizia che si ha della<br />
stipe completa.<br />
Al British Museum i sette bronzetti<br />
provenienti dal Lago degli Idoli occupano un<br />
posto d’onore; altri sono conservati al Louvre;<br />
uno a Baltimora ed una lamina bronzea è alla<br />
Biblioteca Nazionale di Parigi (FORTUNA<br />
GIOVANNONI, 16-18; DUCCI 2003, 13-15). Il resto<br />
disperso non si sa dove, a parte, forse, quelli<br />
che dovrebbero trovarsi nei magazzini<br />
dell’Hermitage di San Pietroburgo. Il<br />
riconoscimento della provenienza d’alcuni<br />
reperti è stato possibile grazie alle descrizioni<br />
e disegni che aveva pubblicato il Micali<br />
(1844).<br />
Il risveglio d’interesse per il Lago<br />
degli Idoli ha coinciso con l’affermarsi della<br />
cosiddetta “archeologia del culto” che in<br />
questi ultimi anni sta catalizzando l’attenzione<br />
degli studiosi, dai pre-protostorici ai classici.<br />
“La consuetudine, probabilmente a<br />
sfondo rituale o votivo, di gettare nelle acque<br />
oggetti metallici di prestigio o di depositarle<br />
in prossimità di esse è un fenomeno che,<br />
almeno per quanto riguarda l’Europa, sembra<br />
coinvolgere tutte le società preistoriche e<br />
protostoriche. Recenti studi, infatti, rivelano<br />
che questo particolare rito, legato all’acqua<br />
(fiumi, torrenti, laghi, paludi, torbiere) ha<br />
avuto una durata piuttosto lunga, che dall’età<br />
del Rame (3.400 a.C.) arriva fino alla seconda<br />
età del Ferro (seconda metà del I millennio<br />
a.C.) con punta massima nel Bronzo recente<br />
(XIII – prima metà del XII secolo<br />
a.C.).Sempre indagini recenti evidenziano,<br />
poi, che le armi (spade, pugnali, punte di<br />
lancia, asce) sono pressoché esclusive durante<br />
l’età del Bronzo, mentre verso la fine di<br />
questo periodo e nell’età del Ferro si<br />
affiancano o fanno la loro comparsa altri<br />
oggetti, come spilloni, coltelli, rasoi, elmi,<br />
roncole, anelli, bronzetti e vasellame”.<br />
“La memoria di questo antichissimo<br />
rito non scompare, comunque, con la fine<br />
delle società classiche. Ad evocarne i legami<br />
con queste pratiche preistoriche e<br />
protostoriche sono sufficienti due esempi: il<br />
mito bretone di Excalibur, la spada magica di<br />
re Artù (ormai in punto di morte), che deve<br />
essere scagliata nelle acque e restituita alla<br />
Signora del Lago; oppure, venendo ai nostri<br />
tempi, le monetine gettate nella fontana di<br />
Trevi a Roma, ‘…caso tardo e giocoso’ (per<br />
usare le parole del filologo Walter Burkert)<br />
‘di sacrificio per immersione…’” (Cigni del<br />
sole, 47-48).<br />
Al seguito del ritrovamento d’altri tre<br />
bronzetti molto deteriorati, nel 1972 fu deciso<br />
dall’allora Soprintendenza alle Antichità<br />
d’Etruria un limitato saggio di scavo sotto la<br />
direzione di Francesco Nicosia (Profilo di una<br />
valle, 52). Ma - come apprendiamo dal sito web<br />
del Comune di Stia – “i numi disturbati<br />
manifestarono la loro insofferenza con una<br />
pioggia insistente, nonostante fosse pieno<br />
agosto”.<br />
Il recente progetto “Lago degli Idoli”<br />
prevedeva lo scavo sistematico con il<br />
recupero del materiale tralasciato dagli scavi<br />
ottocenteschi, lo studio del sito, con analisi<br />
polliniche, stratigrafiche e geomorfologiche:<br />
lavori conclusi nel settembre 2006. I risultati,
presentati in un Convegno tenutosi a Poppi al<br />
termine dello stesso mese, hanno dimostrato<br />
che il Lago degli Idoli risulta essere la stipe<br />
votiva che ha restituito il maggior numero di<br />
reperti. E’ previsto il ripristino dello specchio<br />
d’acqua del lago, “per poter offrire di nuovo<br />
al visitatore quell’immagine magica del posto,<br />
che gli antichi Etruschi raggiungevano con<br />
devozione e fatica” (DUCCI 2003, 18, DUCCI<br />
2004, 6-8). I risultati della campagna di scavo<br />
del 2003 condotti da Luca Fedeli sono stati<br />
presentati nella mostra “Santuari Etruschi in<br />
Casentino” del 2004.<br />
Il laghetto, ancora in alcune carte<br />
settecentesche sembra indicato quale origine<br />
dell’Arno, anche se oggi è indicata come<br />
“capo d’Arno” la sorgente che dista circa 500<br />
metri dal luogo; “da alcuni studiosi è stato<br />
ipotizzato che in antico fosse ritenuto anche<br />
l’origine del Tevere, essendo i due fiumi<br />
ancora uniti tramite la fitta rete dei canali che<br />
formavano la Valdichiana” (DUCCI 2003, 16;<br />
FORTUNA GIOVANNONI, 45-48: “Falterona, Arno e<br />
Tevere”).<br />
La sacralità del Falterona non deriva<br />
unicamente dalle sorgenti ma, nonostante la<br />
non eccessiva altezza della cima se<br />
confrontata con quelle alpine (1.654 metri),<br />
dall’essere la montagna dominante di una<br />
vasta zona della Toscana e regioni limitrofe.<br />
Visibile dalla piana fiorentina come da<br />
Arezzo e dal quale lo sguardo può spaziare su<br />
una gran parte degli Appennini e valli<br />
adiacenti. Nei suoi pressi doveva passare una<br />
strada appenninica di collegamento tra Etruria<br />
interna ed Etruria padana dato che i bronzetti<br />
ritrovati sono stati attribuiti a fabbriche di<br />
area etrusco padana, oltre che orvietane,<br />
umbre e greche (FORTUNA GIOVANNONI, 31-<br />
36, DUCCI 2003, 14-15). Ancora sul finire del<br />
VII sec. a.c. il Casentino rappresentava la<br />
propaggine più settentrionale del territorio<br />
degli Etruschi, a diretto contatto con due delle<br />
popolazioni che abitavano da tempo l’Italia<br />
centrale: i Liguri a Nord e gli Umbri ad Est<br />
(DUCCI 2003, 4, DEL PONTE 1999, Profilo di una<br />
valle).<br />
“Quanto al nome del monte in<br />
particolare, il Devoto (in ‘Studi Etruschi’, XIII,<br />
1939, p. 311 e segg.) lo ritiene derivato da un<br />
plurale etrusco, FALTER o FALTAR, (…)<br />
aggiunge che FALTER deriverebbe a sua<br />
volta da una radice PAL-FAL, che ebbe<br />
ampliamenti in –T (FALT-, appunto), in –AT<br />
(PALAT-, da cui ‘palatium’, nome antico del<br />
Palatino) o in –AD (FALAD-, da cui
‘Falado’, adattamento di una voce etrusca che<br />
significava ‘cielo’ secondo Festo: v. M.<br />
Pallottino, ‘Testimonia linguae etruscae’,<br />
1968, n. 831). Sempre secondo il Devoto, la<br />
radice PAL-/FAL- doveva indicare ‘una<br />
forma rotonda o un oggetto di forma<br />
imprecisata che ha funzione di coprire’, da<br />
cui il significato più specifico di ‘volta’,<br />
‘cupola’. La Falterona sarebbe cioè ‘un<br />
insieme di cupole’”.<br />
“E’ da notare però che la forma attuale ha una<br />
terminazione (-NA) propria dell’etrusco (non<br />
attestata in quelle che sarebbero le fasi<br />
linguistiche precedenti secondo la<br />
ricostruzione del Devoto): non è da escludere<br />
cioè che l’etimo odierno sia un adattamento<br />
minimo di una forma etrusca con quella<br />
terminazione. E’ forse troppo semplicistico<br />
pensare ad un nome composto sempre dalla<br />
radice FAL-, ‘cupola’, ‘volta (celeste)’ e da<br />
TRUNA (etimo etrusco che secondo Esichio<br />
corrispondeva al greco ARKE’ = ‘potere’,<br />
‘principio’) per cui Falterona significherebbe<br />
‘principio del cielo’?” (Fortuna in FORTUNA<br />
GIOVANNONI, 37 n. 2).<br />
Così anche nel nome il Falterona<br />
ricorda i suoi legami col sacro.<br />
“La sacralità è<br />
propria dei luoghi<br />
oscuri e tenebrosi,<br />
nella penombra il<br />
pensiero si raccoglie<br />
e gli animi si<br />
dispiegano secondo<br />
le declinazioni del<br />
cuore.<br />
Le evocazioni<br />
hanno bisogno di<br />
luoghi eletti e il<br />
bosco, il regno delle<br />
oscurità e dei silenzi,<br />
è un luogo eletto per<br />
eccellenza.<br />
E se il deserto,<br />
eremitaggio dei<br />
santi, è il posto della verità perché non vi<br />
sono ombre, in uguale misura il bosco è il<br />
luogo dell’enigma vitale, dove le ombre di<br />
una brulicante molteplicità trasformano il<br />
paesaggio in una incessante metamorfosi e<br />
dove l’animo sottratto ai vincoli del tempo e<br />
dello spazio si dispiega secondo ritmi naturali<br />
in una sorta di empatia con la natura, violando<br />
i codici della comunicazione abituale.”<br />
“Il bosco è fin dall’antichità luogo<br />
sacro e iniziatici. Nella tradizione celtica i<br />
druidi celebravano i loro riti nella foresta<br />
dove alcuni alberi, ritenuti sacri, definivano<br />
spazi riservati alle cerimonie. Anche tra i<br />
Germani i più antichi santuari erano<br />
probabilmente boschi naturali. Nel<br />
simbolismo della foresta confluiscono due<br />
elementi: da una parte l’apertura verso il<br />
cielo, sede del divino, dall’altra la radura,<br />
definizione di uno spazio protetto e segreto,<br />
ove avevano luogo i riti. La sacralità si estese<br />
poi anche al culto degli alberi (…).”<br />
“Il bosco è anche il luogo ove era<br />
custodita la conoscenza primordiale e il luogo<br />
delle prove iniziatiche” (MARESCA, 7).<br />
Il bosco sacro è un lucus, ma con lucus<br />
etimologicamente s’intendeva la “radura”.<br />
Come ricorda anche il Dumézil la frontiera tra<br />
i due significati non è assoluta e<br />
probabilmente il passaggio dei significati è<br />
avvenuto in una stadio antico della lingua<br />
(DUMEZ<strong>IL</strong> 1989, 46). Forse è bene ricordare che<br />
i concetti di sacrum, sanctum e religiosum<br />
non sono interscambiabili. “una stessa res può<br />
essere ‘sacra’ in quanto consacrata agli dèi,<br />
‘santa’ in quanto soggetta a sanzione di legge,<br />
‘religiosa’ in quanto a violarla si offendono<br />
gli dèi” (DEL PONTE 2003).<br />
I boschi sacri, anche se riconosciuti<br />
proprietà di un dio determinato (o non), erano<br />
sotto certe condizioni accessibili all’azione<br />
profana (sfruttamento economico). Prima di<br />
tagliare una parte del bosco, secondo le<br />
antiche preghiere tramandateci da Catone, il<br />
contadino immolava un porco 1 rivolgendosi al<br />
1 Vale la pena ricordare che “requisito necessario per la<br />
validità dell’offerta e dell’azione rituale il fatto che la<br />
vittima manifestasse in qualche modo il proprio<br />
consenso. Per questa ragione l’animale non poteva<br />
essere condotto a forza presso l’ara, poiché ciò avrebbe<br />
rappresentato un pessimo auspicio per il buon esito del<br />
sacrificio” (SINI 2001, 200).
dio o dea del luogo “chiunque fosse” 2 . E per<br />
le divinità dei boschi si arriva a parlare di<br />
“fauni” e di “silvani” (etrusco Selvans) al<br />
plurale, forme latino-italiche dell’antico<br />
Signore degli animali (DEL PONTE 1998, 162-<br />
163).<br />
“Nullus lucus sine fonte, nullus fons<br />
non sacer” ci ricorda Servio (ad Aen, 7, 84)<br />
un’associazione naturale e la sacralità<br />
dell’uno passa automaticamente all’altro. Ma<br />
quale sarà la divinità del Lago degli Idoli? Il<br />
calendario romano festeggia il 13 ottobre i<br />
Fontinalia, consacrati alle sorgenti naturali in<br />
cui venivano gettate corone e s’incoronano i<br />
pozzi, dedicati a Fons (Fonte) figlio di Giano<br />
e Giuturna (Juturna, Diuturna) (DEL PONTE<br />
1998, 66, DUMEZ<strong>IL</strong> 1977, 339-340, DUMEZ<strong>IL</strong> 1989,<br />
25-44, MIGLIORI 1981, 14, SABBATUCCI, 29-30 e<br />
328-329 [Il quale evidenzia, anche, il legame fra<br />
Fontinalia, festività dell’acqua sorgiva, e Meditrinalia,<br />
11 ottobre, una delle feste del vino, nei loro aspetti<br />
“medicamentosi”]). Nell’ambito di Giano (mi<br />
piace ricordare che il dio bifronte si trova solo<br />
nel pantheon latino, Ianus, ed in quello<br />
etrusco, Culsans), il “buon creatore” del<br />
Carmen Saliare, rientrano le sorgenti, non<br />
solo in quanto padre di Fons e del dio-fiume<br />
Tiberino, per aver salvato Roma dagli<br />
assalitori sabini facendo zampillare davanti a<br />
loro una sorgente d’acqua calda che li<br />
spaventò e li mise in fuga, ma anche perché<br />
patrono degli inizi (DEL PONTE 1992 e 1998,<br />
DUMEZ<strong>IL</strong> 1977, D’ANNA).<br />
Non tenendo conto di queste<br />
caratteristiche, la moneta di Giano trovata nel<br />
laghetto potrebbe sembrare il risultato di<br />
qualche fatto casuale ma anche la diffusione<br />
d’idronimi derivati dal nome del dio 3<br />
contribuisce a dimostrare il contrario.<br />
Soprattutto il vicino toponimo “Monte di<br />
2 Catone, De agr. 139: Locum conlucare romano more<br />
sic oportet: porco piacolo facito, sic verba concepito:<br />
“Si deus, si dea es quorum illud sacrum est, ut tibi ius<br />
est porco piacolo illiusce sacri coercendi ergo<br />
harumque rerum ergo, sive ego sive quis iussu meo<br />
fecerit, uti id recte factum siet, eius rei ergo te hoc<br />
porco piacolo immolando bonas preces precor uti sies<br />
volens propitius mihi, domo familiaeque meae<br />
liberisque meis, harumce rerum ego macte hoc porcum<br />
piacolo immolando esto” (in SINI 1991, 114, n. 97).<br />
3 Fatucchi A., Janus sulle tracce del culto del Sole nel<br />
territorio aretino, Arezzo s.a., cit in FORTUNA<br />
GIOVANNONI 1989, 40 n. 5.<br />
Gianni” corruzione volgare del latino “Mons<br />
Iani” (pare, infatti, cha ancora nell’ottocento<br />
la località si chiamasse Monte di Giano,<br />
anche se la storpiatura popolare cominciava<br />
ad indicarlo col nome attuale) rendendo<br />
ipotizzabile “addirittura che il patronato del<br />
dio coinvolgesse l’intero Monte e<br />
considerando il nome della borgata<br />
casentinese alla stregua di oronimo latino del<br />
Falterona” (Profilo di una valle, 105, FORTUNA<br />
GIOVANNONI, 39-40 e bibliografia relativa).<br />
“Macrobio (1, 11) evocò, tra le<br />
intuizioni degli antichi indagatori del mondo<br />
arcaico, quella che luminosamente in –an-<br />
scorgeva il ‘cielo’” ricorda Semerano<br />
riferendosi a detta componente all’interno dei<br />
nomi di Culsans e di Ianus (123). Un’ulteriore<br />
relazione tra Giano e Falterona?<br />
Escludendo la moneta col dio bifronte, l’unica<br />
divinità presente risulta Ercole (il noto<br />
bronzetto ora al British Museum ed in un altro<br />
andato disperso ma riprodotto tra i disegni del<br />
Micali, di probabile produzione umbra)<br />
facendo supporre che fosse il nume tutelare<br />
del santuario.<br />
Il culto di Ercole era diffusissimo<br />
nell’Italia antica, da lui percorsa di ritorno con<br />
i buoi di Gerione ovvero alla ricerca del<br />
giardino delle Esperidi, tra i vari popoli della
Saturnia Tellus (DEL PONTE 2003,<br />
MASTROCINQUE 1994). “Eletto nume<br />
protettore delle acque sorgive, e venerato<br />
come protettore dei viandanti, dei pastori e<br />
dei mercanti: la presenza di immagini di<br />
animali, bovini, ovini e volatili, riprodotti in<br />
miniaturizzazione in sostituzione del reale,<br />
farebbe pensare alla protezione richiesta al<br />
nume da parte dei pastori che probabilmente<br />
con le loro greggi migravano lungo il valico<br />
appenninico posto nelle vicinanze. I resti delle<br />
numerose armi, assieme alla rappresentazione<br />
di guerrieri e giovani armati, richiamano<br />
invece la richiesta di protezione da parte dei<br />
militari, che in gran numero devono essere<br />
passati nei pressi del lago. La presenza infine<br />
di parti anatomiche del corpo umano sembra<br />
indirizzare alla richiesta di una grazia o<br />
all’offerta votiva al dio di una parte del corpo<br />
dove poteva essere avvenuta una guarigione” (<br />
DUCCI 2003, 16).<br />
Ma Ercole era anche l’antenato<br />
“comune” degli Etruschi e dei Romani.<br />
“Figlio di Ercole e Omphale sarebbe stato<br />
Tirreno (Dion.Hal.I.28; Paus.II.21.3; Hygin., Fab.<br />
274), oppure il re Tuscus (Fest., p.487 L.;<br />
Paul.Fest., p. 486 L), capostipiti dei Tirreni”<br />
(MASTROCINQUE 1993, 23). Mentre secondo<br />
alcune tradizioni Ercole con la figlia di Fauno<br />
generò Latino (MASTROCINQUE 1993, 23-41 e<br />
bibliografia relativa). Secondo quanto scriveva<br />
l’erudito Giovanni Nanni Annio, nel fiorire<br />
dell’umanesimo, Ercole sarebbe la divinità<br />
tutelare dell’Arno (FORTUNA GIOVANNONI<br />
1989, 27-28, n. 17).<br />
Speriamo di poter nei prossimi anni rivedere<br />
nel Casentino, nel corso di una Mostra in<br />
programmazione, gli “Idoli” del Falterona<br />
dispersi per il mondo, almeno quelli<br />
identificati, insieme alle ultime scoperte.<br />
Mario Enzo Migliori<br />
Rielaborazione da: MIGLIORI 2005<br />
Immagini da www.casentinoarcheologia.org
Bibliografia:<br />
Cigni del sole 2004: Rizzetto G. (a cura di), I<br />
cigni del sole, culti, riti, offerte dei Veneti antichi<br />
nel Veronese, Verona.<br />
CAMPOREALE 2004: Camporeale G., Gli<br />
Etruschi: Storia e civiltà, II ed., Torino.<br />
CRISTOFANI 1984: Cristofani M., L'arte degli<br />
Etruschi, II ed., Milano.<br />
CRISTOFANI 2000: Cristofani M. (a cura di),<br />
Dizionario illustrato della civiltà etrusca, (II ed.),<br />
Firenze.<br />
D’ANNA 1992: D’Anna N., Il dio Giano,<br />
Scandiano.<br />
DEL PONTE 1992: del Ponte R., La religione dei<br />
Romani, Milano.<br />
DEL PONTE 1998: del Ponte R., Dèi e miti<br />
italici, III ed., Genova.<br />
DEL PONTE 1999: del Ponte R., I Liguri.<br />
Etnogenesi di un popolo, II ed., Genova.<br />
DEL PONTE 2003: del Ponte R., La città degli<br />
Dèi. La tradizione di Roma e la sua continuità,<br />
Genova.<br />
DUCCI 2003: Ducci M. (a cura di), Gli idoli del<br />
Falterona: passato e futuro del lago degli idoli,<br />
Ponte a Poppi.<br />
DUCCI 2004: Ducci M. (a cura di), Santuari<br />
Etruschi in Casentino, Ponte a Poppi.<br />
DUMEZ<strong>IL</strong> 1977: Dumézil G., La religione<br />
romana arcaica, con un appendice su La religione<br />
degli Etruschi, Milano.<br />
DUMEZ<strong>IL</strong> 1989: Dumézil G., Feste romane,<br />
Genova.<br />
Etrusca disciplina 1998: AA. VV., Etrusca<br />
disciplina. I culti stranieri in Etruria (Annali della<br />
Fondazione per il Museo "Claudio Faina", vol. V),<br />
Orvieto.<br />
Etruschi nel tempo 2001: AA. VV., Gli Etruschi<br />
nel tempo, Firenze.<br />
EVOLA 2003: Evola J., Meditazione delle vette, a<br />
cura di Renato del Ponte, V ed., Roma.<br />
FACCHETTI 2001: Facchetti G. M., L'enigma<br />
svelato della lingua etrusca, II ed., Roma.<br />
FORTUNA GIOVANNONI 1989: Fortuna A. M.,<br />
Giovannoni F., Il Lago degli Idoli, testimonianze<br />
etrusche in Falterona, II ed., Firenze.<br />
Gli Etruschi 1998: Pallottino M. (dir.), Gli<br />
Etruschi, Milano.<br />
Gli Etruschi 2000: Torelli M. (a cura di), Gli<br />
Etruschi, s.l..<br />
MARESCA 2004: Maresca P., Giardini incantati,<br />
boschi sacri e architetture magiche, Firenze.<br />
MASTROCINQUE 1993: Mastrocinque A.,<br />
Romolo (la fondazione di Roma tra storia e<br />
leggenda), Este.<br />
MASTROCINQUE 1994: Mastrocinque A. (a<br />
cura di), Culti pagani nell'Italia settentrionale,<br />
Trento.<br />
MICALI 1844: Micali G., Monumenti antichi ad<br />
illustrazione della storia degli antichi popoli<br />
italici, Firenze.<br />
MIGLIORI 1981: Migliori M. E., Il calendario<br />
romano dalle origini al Pontificato di Augusto,<br />
estr. da “Arthos” (22-24), Genova.<br />
MIGLIORI 2005: Migliori M. E., “Archeologia<br />
del culto”: il “Lago degli Idoli”, “La Cittadella”,<br />
n.s., V, 17, gennaio-marzo 2005.<br />
PELLIZZARI 2003: Pellizzari A., Servio. Storia,<br />
cultura e istituzioni nell'opera di un grammatico<br />
tardoantico, Firenze.<br />
Principi etruschi 2000: AA. VV., Principi<br />
etruschi, tra mediterraneo ed Europa, Venezia.<br />
Profilo di una valle 1999: Gruppo Archeologico<br />
Casentinese (a cura del), Profilo di una valle<br />
attraverso l'archeologia. Il Casentino della<br />
Preistoria al Medioevo, Ponte a Poppi.<br />
PUCCI 1997: Pucci I., Culti naturalistici della<br />
Liguria antica, La Spezia.<br />
RUT<strong>IL</strong>IO 1989: Rutilio C., Pax Deorum. La<br />
religione prisca di Roma, III ed., Scandiano.<br />
SABBATUCCI 1988: Sabbatucci D., La religione<br />
di Roma antica, dal calendario festivo all'ordine<br />
cosmico, Milano.<br />
SANSONI 2006: Sansoni U., La sacralità<br />
della montagna, la Valsaviore, le Alpi, i<br />
Monti degli Dei, Boario Terme 2006.<br />
SEMERANO 2003: Semerano G., Il popolo che<br />
sconfisse la morte: gli etruschi e la loro lingua,<br />
Milano.<br />
SINI 1991: Sini F., Bellum nefandum. Virgilio e il<br />
problema del "diritto internazionale antico",<br />
Sassari.<br />
SINI 2001: Sini F., Sua cuique civitati religio.<br />
Religione e diritto pubblico in Roma antica,<br />
Torino.<br />
http://www.casentinoarcheologia.org<br />
http://www.comune.stia.ar.it/turismo/storia/lago_i<br />
doli.asp