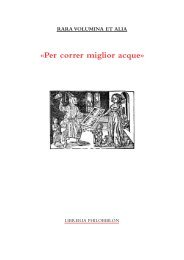Scarica il documento in formato PDF - Philobiblon
Scarica il documento in formato PDF - Philobiblon
Scarica il documento in formato PDF - Philobiblon
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
RACCOLTA DI VOLUMI RARI<br />
«or vien qu<strong>in</strong>ci e<br />
or vien qu<strong>in</strong>di…»<br />
LIBRERIA PHILOBIBLON
Libreria Ph<strong>il</strong>obiblon<br />
Piazza S. Simpliciano, 7 - 20121 M<strong>il</strong>ano<br />
Tel. +39 02 89076643 - Fax +39 02 89076644<br />
Via S.M. dell’Anima, 54 - 00186 Roma<br />
Tel. +39 06 68806671 - Fax +39 06 45436040<br />
E-ma<strong>il</strong>: <strong>in</strong>fo@ph<strong>il</strong>obiblon.org<br />
www.ph<strong>il</strong>obiblon.org<br />
© 2005 Libreria Ph<strong>il</strong>obiblon, Roma
1 <br />
Vegetius Renatus, Flavius (sec. IV-V d.C). Epitoma<br />
rei m<strong>il</strong>itaris. [Segue un anonimo trattato sull’arte<br />
m<strong>il</strong>itare navale]. [Probab<strong>il</strong>mente Spagna (Barcellona?),<br />
ca. 1380-1420].<br />
Manoscritto m<strong>in</strong>iato su pergamena (mm 220x162); 95 carte. 11 fascicoli<br />
di 8 carte, con lettere di richiamo, seguiti da 12 fascicoli di 7 carte, probab<strong>il</strong>mente<br />
mancante dell’ultima carta bianca. COMPLETO. Rigatura ad<br />
<strong>in</strong>chiostro nero; scrittura gotica libraria su due colonne di 23 l<strong>in</strong>ee; <strong>in</strong>cipit<br />
e titoli di ogni capitolo <strong>in</strong> <strong>in</strong>chiostro rosso; <strong>in</strong>iziali di paragrafo segnate<br />
<strong>in</strong> rosso e blu; numerosi cap<strong>il</strong>ettera su 2 righe <strong>in</strong> <strong>in</strong>chiostro rosso<br />
o blu con decorazioni a penna di colore contrastante; alla prima carta<br />
<strong>in</strong>iziale ‘P’ su 5 righe <strong>in</strong> <strong>in</strong>chiostro blu lapislazzulo su fondo oro, riccamente<br />
m<strong>in</strong>iata a motivi floreali blu, verdi e oro che si estendono su tre<br />
montanti; al marg<strong>in</strong>e <strong>in</strong>feriore della stessa pag<strong>in</strong>a una cornice circolare<br />
dorata e uno scudo su fondo verde con lo stemma di un membro della<br />
famiglia Riccio di Napoli. Nel testo 7 cap<strong>il</strong>ettera (cc. 16v, 32v, 69v, 81v,<br />
87v, 88v, 91v) che non sono stati completati e recano unicamente <strong>il</strong> fondo<br />
e le decorazioni a foglia d’oro. Splendida legatura coeva napoletana<br />
<strong>in</strong> marocch<strong>in</strong>o marrone su assi di legno; i piatti sono riccamente decorati<br />
da elaborate cornici nelle quali si <strong>in</strong>treccia un motivo ornamentale<br />
a nodi e, nella cornice più <strong>in</strong>terna, a ferri floreali, <strong>il</strong> pannello centrale è<br />
copiosamente ornato da motivi geometrici nei quali viene ripetuto <strong>il</strong><br />
medesimo ferro romboidale variamente disposto, tagli dorati. Tre (di<br />
quattro) b<strong>in</strong>delle con fermagli <strong>in</strong> bronzo; dorso ricostruito negli anni ’30<br />
con titolo <strong>in</strong> oro (per la legatura cfr.T. De Mar<strong>in</strong>is, La legatura artistica <strong>in</strong><br />
Italia, vol. 1, tav XXXVII, n° 224). Codice ottimamente conservato, fatta<br />
eccezione per l’usura delle cerniere e per qualche piccolo foro di tarlo<br />
alle ultime carte.<br />
Al recto della prima carta la nota di possesso “1528 Sum Claudii Bernardi”,<br />
che viene ripetuta al verso dell’ultima carta, con l’aggiunta del mònito<br />
“Hunc qui comperiet reddetque repente libellum Illi dena lubens au-<br />
5
ea mala dabo. Ipse iubet mortis te mem<strong>in</strong>isse Deus”. Numerose correzioni<br />
manoscritte nel testo, alcune coeve <strong>in</strong> gotica libraria eseguite abradendo<br />
<strong>il</strong> supporto scrittorio, altre <strong>in</strong> corsiva umanistica (cc. 69, 80 e 83v),<br />
probab<strong>il</strong>mente dello stesso Bernardi che appone anche radi marg<strong>in</strong>alia.<br />
cc. 1r-88v:Vegetius, Epitoma rei m<strong>il</strong>itaris.<br />
«Flavii vegetii renati virj <strong>il</strong>lustris comitis ecolii epitoma rei m<strong>il</strong>itaris libri numero<br />
qu<strong>in</strong>que <strong>in</strong>cipiunt». (cfr. M.D. Reeve, Vegetius, p. vii, nota 3:“P. Richardot,‘La<br />
datation du De re m<strong>il</strong>itari de Végèce’, Latomus, 57 (1998), 136-47, at pp.<br />
137-38, muddies the waters by cit<strong>in</strong>g the phrase comitis ecolii from the title<br />
recorded <strong>in</strong> a collation.The manuscript collated is identifiable as Leiden<br />
Voss. Lat. F 59 (s. XIV/XV), […] ecolii is a further corruption of et<strong>il</strong>ii, itself a<br />
corruption of et <strong>il</strong>l. not attested before the 14th century”).<br />
c.1r. <strong>in</strong>cipit:«Primus liber electionem edocet iuniorum ex quibus locis vel quales<br />
m<strong>il</strong>ites probandi s<strong>in</strong>t…».<br />
cc. 88v-91v:Trattato anonimo sull’arte m<strong>il</strong>itare navale.<br />
«Incipit quidam alius tractatus de re m<strong>il</strong>itari».<br />
c. 88v. <strong>in</strong>cipit:«Possimus ad presens alia enumerare per que mar<strong>in</strong>i pugnatores<br />
hostes impugnare debent…».<br />
cc. 91v-95v:Trattato anonimo.<br />
«Aristot<strong>il</strong>es <strong>in</strong> libro de secretis secretorum de disponicione ductionis sui et de electione<br />
bellorum et procerum <strong>in</strong>feriorum sic scripsit ut sequitur et cetera».<br />
c. 91v. <strong>in</strong>cipit:«Processunt (?) addicio et multiplicacio regni…»<br />
c. 95v: f<strong>in</strong>e del testo e explicit:«Ff<strong>in</strong>ito libro sit laus et gloria Cristo amen».<br />
Testimone non censito dell’Epitoma di Vegezio, esso risulta<br />
<strong>in</strong>fatti sconosciuto ai maggiori repertori di quest’opera<br />
quali: C.R. Shrader’s, A Handlist of Extant Manuscripts<br />
Conta<strong>in</strong><strong>in</strong>g the De re m<strong>il</strong>itari of Flavius Vegetius<br />
Renatus, Scriptorium, 33 (1979), pp. 280-305 e M.D.<br />
Reeve, The Transmission of Vegetius’ Epitoma rei m<strong>il</strong>itaris,<br />
Aevum, 74 (2000), pp. 243-351.<br />
6
La ripartizione del testo adottata nel presente manoscritto<br />
risulta piuttosto <strong>in</strong>solita. Nella maggior parte dei<br />
testimoni l’opera viene <strong>in</strong>fatti suddivisa <strong>in</strong> quattro libri,<br />
mentre <strong>in</strong> questo si presenta ripartita <strong>in</strong> c<strong>in</strong>que (come<br />
<strong>in</strong>dicano sia l’<strong>in</strong>cipit che l’explicit). La seconda parte del<br />
quarto libro, dedicata all’arte m<strong>il</strong>itare navale, è stata <strong>in</strong>fatti<br />
relegata <strong>in</strong> un libro a se stante. Una tradizione manoscritta,<br />
di area tipicamente iberica, recante una suddivisione<br />
di questo tipo può essere fatta risalire ad un<br />
codice del IX/X secolo conservato alla Biblioteca dell’Escorial<br />
di Madrid (a questo riguardo si veda l’analisi<br />
di M.D. Reeve nell’<strong>in</strong>troduzione al testo critico dell’Epitoma,<br />
p. liii).<br />
Il nostro codex fu probab<strong>il</strong>mente esemplato <strong>in</strong> Spagna<br />
(Barcellona) verso la f<strong>in</strong>e del XIV secolo o sul pr<strong>in</strong>cipio<br />
del XV secolo, per poi esser portato <strong>in</strong> Italia dove,<br />
sul f<strong>in</strong>ire del Quattrocento, vennero aggiunte le m<strong>in</strong>iature,<br />
per altro non completate, e le armi di uno dei<br />
membri della famiglia napoletana dei Riccio (cfr. Rietstap,<br />
Armorial général, V,tav.CLVI). Anche la legatura,<br />
di scuola napoletana, deve essere ricondotta allo stesso<br />
periodo.<br />
L’opera del Vegezio è considerata “the most systematic<br />
treatment to have survived from Antiquity of a subject<br />
that reta<strong>in</strong>ed practical and educational <strong>in</strong>terest long after<br />
the arrival of gunpowder <strong>in</strong> the West: Roman warfare.Written<br />
<strong>in</strong> elegant and markedly rhythmical Lat<strong>in</strong>,<br />
with few lapses from lucidity, by a highly placed civ<strong>il</strong><br />
servant with a bee <strong>in</strong> his bonnet, it was among those se-<br />
7
cular works of Antiquity that medieval readers most often<br />
copied, excerpted, and translated” (Reeve, p. v).<br />
Vegetius, Epitoma rei m<strong>il</strong>itaris. Edited by M.D. Reeve, Oxford 2004; Cat. asta<br />
L.-A. Barbet, Paris, Hôtel Drouot (Giraud Bad<strong>in</strong>), 13-14 Ju<strong>in</strong> 1932, lot 15.<br />
2 <br />
Pulci, Luigi (1432-1484) – Franco, Matteo (1447-<br />
1494). Sonetti I-LXXXIII. [Firenze, ca. 1480].<br />
Manoscritto cartaceo (mm 203x137), 31 carte non numerate, di cui le<br />
ultime tre bianche; tre quaderni di 8 carte e uno di 7. COMPLETO.Testo<br />
su un’unica colonna (145x80), su 29 l<strong>in</strong>ee; richiami alla f<strong>in</strong>e di ogni fascicolo<br />
posti <strong>in</strong> basso trasversalmente, parzialmente rif<strong>il</strong>ati; rigatura a secco.<br />
Elegantemente vergato da unica mano <strong>in</strong> grafia umanistica corsiva;<br />
carta con f<strong>il</strong>igrana del tipo ‘a cappello’, identificab<strong>il</strong>e con Briquet, n°<br />
3373 (Firenze, tra <strong>il</strong> 1474 e <strong>il</strong> 1483). La prima carta reca un’<strong>in</strong>iziale m<strong>in</strong>iata<br />
“S(alve)”. Il pregevole capolettera, su 3 l<strong>in</strong>ee, presenta <strong>il</strong> consueto<br />
motivo decorativo con corpo della lettera a foglia d’oro, cui si avv<strong>il</strong>uppano<br />
tralci a bianchi girarî, su fondo blu, rosa e verde, sbalzato con punt<strong>in</strong>i<br />
bianchi. Il testo è <strong>in</strong>oltre scandito da <strong>in</strong>iziali calligrafiche <strong>in</strong> <strong>in</strong>chiostro<br />
bruno di modulo lievemente maggiore del testo, poste all’<strong>in</strong>izio di<br />
ogni quart<strong>in</strong>a. I primi sette sonetti prevedono, <strong>in</strong>oltre, un titolo rubricato<br />
dallo stesso scriba; l’<strong>in</strong>serimento di tali rubriche era concepito per tutti<br />
i sonetti, <strong>in</strong> quanto tra l’uno e l’altro compaiono alcune righe bianche,<br />
ma non venne mai realizzato. Per tutte le altre composizioni un’altra mano<br />
ha <strong>in</strong>trodotto brevi titoli <strong>in</strong> <strong>in</strong>chiostro nero.<br />
Legatura d’<strong>in</strong>izio C<strong>in</strong>quecento <strong>in</strong> pergamena floscia, dorso a capitelli<br />
passanti; <strong>in</strong> astuccio moderno <strong>in</strong> marocch<strong>in</strong>o. La conservazione del codice,<br />
molto marg<strong>in</strong>oso, è ottima, se si eccettuano uno strappo marg<strong>in</strong>ale<br />
8
2. Pulci, Luigi
1. Vegetius Renatus, Flavius
1. Vegetius Renatus, Flavius
4. Euclides
5. Plot<strong>in</strong>us
7. Colonna, Francesco
7. Colonna, Francesco
6. Anton<strong>in</strong>o, santo
estaurato presso la carta tre, lievi fioriture della carta e un antico restauro<br />
a cospicua mancanza al marg<strong>in</strong>e <strong>in</strong>feriore della prima carta, peraltro<br />
senza lesioni al testo.<br />
Incipit: c. 1r «Salve se se’ quel poeta Luigi…»; explicit: c. 28v «…e tutta<br />
notte attesi a far cumete».<br />
Il confronto con gli altri rari testimoni manoscritti e<br />
l’<strong>in</strong>dividuazione della f<strong>il</strong>igrana permettono di collocare<br />
la confezione del presente codice a Firenze, nei decenni<br />
term<strong>in</strong>ali del ’400, proprio a ridosso della realizzazione<br />
dell’opera da parte di Luigi Pulci; ipotesi, con cui<br />
concordano pienamente sia la grafia che <strong>il</strong> sistema decorativo<br />
del codice.<br />
I Sonetti, accanto ad alcuni componimenti più burlescamente<br />
realistici e descrittivi, prevedono brani <strong>in</strong>dirizzati<br />
dal Pulci a Matteo Franco, canonico del duomo di Firenze<br />
al servizio dei Medici a partire dai primi anni Settanta<br />
del Quattrocento, all’umanista Bartolomeo della Scala e a<br />
Mars<strong>il</strong>io Fic<strong>in</strong>o.Testimoniano i vani tentativi dello scrittore<br />
fiorent<strong>in</strong>o di rimanere legato ai favori medicei,ormai<br />
<strong>in</strong>dirizzati a forme letterarie e culturali lontane dal “suo<br />
naturalismo borghese, diverso da quello id<strong>il</strong>lico del Poliziano<br />
e da quello teologicamente accomodante del Fic<strong>in</strong>o<br />
impegnato nella ricerca di un’armonia fra Dio e la natura”<br />
(Nigro, p. 68). La tradizione letteraria, s<strong>in</strong>o a epoche<br />
relativamente recenti, ha voluto vedere nello scontro tra i<br />
due protetti di Lorenzo de’ Medici, Franco e Pulci, una<br />
tenzone di maniera, <strong>in</strong>scenata tra due letterati uniti nella<br />
realtà da una salda amicizia: tale è l’<strong>in</strong>terpretazione accre-<br />
9
ditata, già a ridosso della loro scomparsa, da una delle prime<br />
stampe (Dolci, p. 3). Il dissidio, secondo tutta la critica<br />
novecentesca, fu <strong>in</strong>vece reale e si accese non appena <strong>il</strong><br />
Franco, entrato al servizio di Lorenzo, si adoperò <strong>in</strong> tutti i<br />
modi per conquistarne i favori. Una serie di lettere <strong>in</strong>dirizzate<br />
dal Pulci e da Franco al Magnifico negli anni <strong>in</strong>torno<br />
al 1474 e 1475 def<strong>in</strong>iscono con precisione l’<strong>in</strong>izio<br />
di una contesa letteraria e personale che avrebbe co<strong>in</strong>volto<br />
altri membri della cosiddetta ‘brigata medicea’, perdurando<br />
per non pochi anni.<br />
Tra gli esigui testimoni manoscritti superstiti dei Sonetti<br />
di Luigi Pulci e di Matteo Franco, datab<strong>il</strong>i <strong>in</strong>torno agli<br />
anni 1474-75, <strong>il</strong> presente è senz’altro uno dei primi ed<br />
è sicuramente anteriore a qualsiasi edizione a stampa.<br />
Gli altri testimoni manoscritti dell’opera pulciana attualmente<br />
noti, tutti su supporto cartaceo, sono:<br />
- Trivulziano 965 della Biblioteca Trivulziana di M<strong>il</strong>ano<br />
(<strong>in</strong>izio del XVI sec.);<br />
- Vaticano Barber<strong>in</strong>iano lat<strong>in</strong>o 3912 (122 sonetti, f<strong>in</strong>e<br />
del XV o <strong>in</strong>izio del XVI secolo). Come nel caso del manoscritto<br />
<strong>in</strong> esame, è qui presente un apparato <strong>il</strong>lustrativo<br />
che <strong>in</strong>cornicia la scrittura nell’angolo s<strong>in</strong>istro <strong>in</strong> alto,<br />
con uno stemma nella parte <strong>in</strong>feriore della carta.<br />
- Parmense 1336 della Biblioteca Palat<strong>in</strong>a di Parma<br />
(f<strong>in</strong>e del XV o <strong>in</strong>izio del XVI secolo). Il sistema <strong>il</strong>lustrativo<br />
del codice prevedeva uno stemma nel bas de page<br />
di c. 1r, attualmente non più leggib<strong>il</strong>e.<br />
10
Testimoni manoscritti parziali:<br />
- Venturi G<strong>in</strong>ori Lisci 3 (Codice Scarlatti) della omonima<br />
biblioteca fiorent<strong>in</strong>a (16 componimenti).<br />
- Conv. Soppr. B.7.2889 della Nazionale di Firenze (13<br />
componimenti).<br />
- Casanatense 884 (4 componimenti).<br />
Pure la tradizione tipografica dell’opera pulciana risulta<br />
estremamente poco documentata: le edizioni a stampa<br />
sono esigue, tra l’altro di datazione assai controversa tra<br />
la f<strong>in</strong>e del XV e l’<strong>in</strong>izio del XVI secolo. Ne sopravvivono,<br />
per di più, da uno a tre esemplari per ciascuna. La<br />
più antica edizione a stampa dei Sonetti è quella che <strong>il</strong><br />
BMC, VI, 655 attribuisce a Bartolomeo de Libri e lo<br />
STC, 279 <strong>in</strong>dica come «B. di Libri: Florence 1495?»<br />
(esempl. scompleto).<br />
Il manoscritto <strong>in</strong> esame è strettamente legato alla personalità<br />
di Carlo Dolci e alla sua edizione del 1933 del<br />
Libro de Sonetti. Da un lato, la presenza all’<strong>in</strong>terno delle<br />
pag<strong>in</strong>e del codice di un foglietto manoscritto recante<br />
l’<strong>in</strong>dicazione “Codice Dolci”, dall’altro una puntuale<br />
collazione con l’edizione a stampa pubblicata da Dolci<br />
nel 1933 hanno permesso di identificare con certezza<br />
nel manoscritto <strong>in</strong> questione l’opera di proprietà privata<br />
dello studioso, presto ritenuta <strong>in</strong>trovab<strong>il</strong>e e ut<strong>il</strong>izzata<br />
come fondamento testuale della pubblicazione (Bramb<strong>il</strong>la<br />
Ageno I, pp. 183-210; Pignatti, pp. 194-196).<br />
Nella prefazione all’edizione dei Sonetti del 1933, <strong>in</strong> re-<br />
11
lazione al codice <strong>in</strong> suo possesso, <strong>il</strong> Dolci scrive: “I sonetti<br />
del Pulci e del Franco furono stampati l’ultima<br />
volta <strong>in</strong> Lucca nel 1759 di su un “accuratissimo testo a<br />
penna di Carlo Dati”, ma non senza errori, specialmente<br />
tipografici. I primi 83 sonetti si ristampano oggi da<br />
un ms. <strong>in</strong>edito, che è <strong>in</strong> possesso del comp<strong>il</strong>atore di queste<br />
note [<strong>in</strong>dicato con la sigla D]. I sonetti dopo l’83°<br />
sono ristampati, corretti i più evidenti errori, seconda<br />
l'edizione del 1759. Ho creduto opportuno segnare via<br />
via le più importanti, o per significato o per s<strong>in</strong>golarità<br />
di grafia, varianti, e rispetto all’edizione del 1759 (E) e<br />
rispetto al Codice Trivulziano 965, che la gent<strong>il</strong>ezza di<br />
S. E. <strong>il</strong> pr<strong>in</strong>cipe Trivulzio ha messo a mia disposizione<br />
(Il Cod.Trivulziano n. 965, del sec. XV, cartaceo, contiene<br />
103 sonetti, <strong>il</strong> cui ord<strong>in</strong>e e la cui <strong>in</strong>testazione apparirà<br />
via via nella notazione delle varianti). La grafia è<br />
ammodernata convenientemente, <strong>in</strong> modo però da non<br />
far perdere agli scritti <strong>il</strong> loro sapore primitivo; e così la<br />
punteggiatura”.<br />
Il manoscritto <strong>in</strong> esame, contiene ottantatré Sonetti così<br />
suddivisi:<br />
- 17 di Luigi Pulci a Matteo Franco (II, IV, X, XV, XVI, XVII,<br />
XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, LV, LVI).<br />
- 1 del Pulci a Luigi Stufa - nob<strong>il</strong>e ambasciatore al servizio<br />
di Lorenzo de’Medici - e Giuliano de’Medici (LXXV).<br />
- 43 di Matteo Franco a Luigi Pulci (I, III, V, VI, VII, VIII,<br />
IX, XI, XII, XIII, XIV, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII,<br />
XXXIII, XXXIV,XXXV, XXXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL,<br />
12
XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LI, LII,<br />
LIII, LIV, LVII, LVIII, LIX, LXXVI).<br />
- 2 generici di Matteo Franco (LXXVIII, LXXXI).<br />
- 8 di Matteo Franco a Lorenzo de’ Medici (LX, LXII,<br />
LXIII, LXIV, LXVI, LXXIV, LXXXII, LXXXIII).<br />
- 2 di Matteo Franco a Giuliano de’ Medici (LXV, LXVII).<br />
- 1 di Matteo Franco «A uno che lo secava che gl’<strong>in</strong>segnassi<br />
archimia un merciaio» (LXXVII).<br />
- 1 di Matteo Franco a Madonna Clarice - Madonna<br />
Clarice Ors<strong>in</strong>i, moglie di Lorenzo <strong>il</strong> Magnifico - (LXI).<br />
- 1 di Matteo Franco a ser Niccolò Michelozzi - cancelliere<br />
di Lorenzo de’ Medici - (LXVIII).<br />
- 1 di Matteo Franco a Mars<strong>il</strong>io Fic<strong>in</strong>o (LXIX).<br />
- 1 di Matteo Franco «Agli ufficiali della posta» - agenti<br />
della imposta delle tasse - (LXX).<br />
- 1 di Matteo Franco a Iacopo di Messer Poggio - figlio<br />
dell’umanista Poggio Bracciol<strong>in</strong>i - (LXXI).<br />
- 1 di Matteo Franco all’arcivescovo di Firenze - Card<strong>in</strong>ale<br />
Pietro Riario, nipote di Sisto IV - (LXXII).<br />
- 2 di Matteo Franco ad un suo amico/compare (LXXIII,<br />
LXXIX).<br />
L. Pulci-M. Franco, Il “Libro dei Sonetti”, a cura di G. Dolci, M<strong>il</strong>ano-Genova-Roma-Napoli<br />
1933; S.S. Nigro, Pulci e la cultura medicea, Bari-Roma<br />
1972; F. Bramb<strong>il</strong>la Ageno, Per l’edizione dei Sonetti di Matteo Franco e di Luigi<br />
Pulci, <strong>in</strong> AA.VV., Tra lat<strong>in</strong>o e volgare. Per Carlo Dionisotti, a cura di G. Bernardoni<br />
Trezz<strong>in</strong>i, O. Besomi, L. Bianchi, N. Casella,V. Ferr<strong>in</strong>i Cavalleri,<br />
G. Gianella, L. Simona, Padova 1974; F. Pignatti, Franco Matteo, <strong>in</strong> Dizionario<br />
Biografico degli Italiani, L, Roma 1998, pp. 194-196, <strong>in</strong> partic. p. 195.<br />
13
3 <br />
Boccaccio, Giovanni (1313-1375). Ameto overe<br />
Comoedia de Nymphe fiorent<strong>in</strong>e [con le aggiunte<br />
di Hieronimus Bononius]. Treviso, Michele<br />
Manzolo, 1479.<br />
In-4° (mm 210x144). Collazione: a-i 8 , k-l 6 . 8 carte non numerate di 84<br />
(mancano la prima e l’ultima bianche), testo su 32-34 l<strong>in</strong>ee, carattere romano.<br />
Legatura moderna <strong>in</strong> vitello impresso a secco, dorso a quattro nervi<br />
con tassello <strong>in</strong> marocch<strong>in</strong>o rosso e titolo <strong>in</strong> oro. Esemplare <strong>in</strong> buono<br />
stato di conservazione.<br />
Seconda edizione, curata da Hieronimus Bononius, non<br />
meno rara e ricercata di quella orig<strong>in</strong>ale stampata l’anno<br />
precedente a Roma. Il nostro esemplare appartiene alla<br />
variante descritta dal Gesamt Katalog recante le lezioni:<br />
“overe Comoedia de Nymphe” alla terza e quarta riga<br />
dell’<strong>in</strong>cipit e alla qu<strong>in</strong>ta riga del colophon “anno de”.<br />
“[…] l’Ameto appare […] una prefigurazione strutturale<br />
del Decameron, cornice (ambientata ai piedi della coll<strong>in</strong>a<br />
fiesolana) stesa attorno a una serie di novelle. Ma naturalmente,<br />
anche per la natura “a chiave” delle narrazioni<br />
autobiografiche (pettegolezzi sentimentali sulla società<br />
fiorent<strong>in</strong>a, con casi riferib<strong>il</strong>i, sia pure con la cautela<br />
non sempre osservata dai vecchi critici, all'autore stesso),<br />
si è ancora vic<strong>in</strong>i alla parte del F<strong>il</strong>ocolo dedicata alla<br />
corte d’amore di Fiammetta. Le <strong>in</strong>novazioni sono tuttavia<br />
parecchie, e la più vistosa è di carattere già formale:<br />
<strong>il</strong> complesso prosastico <strong>in</strong>clude parti <strong>in</strong> verso, più esat-<br />
14
tamente <strong>in</strong> terz<strong>in</strong>e di tipo dantesco (come quelle, non<br />
meglio riuscite, di cui consta, <strong>in</strong> quello stesso torno di<br />
tempo, l’Amorosa Visione), e perciò è un prosimetrum al<br />
modo, lasciando stare Marziano Capella e Boezio, della<br />
Vita Nuova. Ma, se la vera Vita Nuova è un’autobiografia<br />
simbolica sopraggiunta attorno a rime almeno <strong>in</strong><br />
gran parte preesistenti, questa del Boccaccio sottostà,<br />
per l’<strong>in</strong>sieme della cornice e per i ternarii, a tutta una<br />
placcatura allegorica, che pretende significare la trasfigurazione<br />
operata dall'amore entro un essere selvaggio:<br />
sublimazione <strong>il</strong> cui carattere all'<strong>in</strong>grosso neoplatonico<br />
doveva rendere <strong>il</strong> libro particolarmente gradito ai lettori<br />
r<strong>in</strong>ascimentali. Quest’allegoria poco o nulla ha di<br />
dantesco, quando si pensi al Dante della Vita, del Convivio<br />
e della Commedia: mediazione alla nuova posizione<br />
del Boccaccio è l’allegoria pastorale, che muove dalle<br />
Bucoliche virg<strong>il</strong>iane [...]. L’Ameto venne a costituire <strong>il</strong><br />
paradigma della letteratura pastorale, direttamente<br />
nell’Arcadia, <strong>in</strong>direttamente, attraverso appunto <strong>il</strong> Sannazzaro,<br />
nelle letterature europee del R<strong>in</strong>ascimento e<br />
oltre” (G. Cont<strong>in</strong>i, Letteratura italiana delle orig<strong>in</strong>i, Firenze<br />
1985, pp. 715-16).<br />
HC 3287; GW 4429; BMC VI, 888; IGI 1764; Goff B, 707; Bacchi della<br />
Lega, p. 98; Cat. Bernard Quaritch, Italian books XV-XVIII centuries, (1992),<br />
n° 4 (stessa copia).<br />
15
4 <br />
Euclides (sec. IV-III a.C.). Preclarissimus liber elementorum<br />
Euclidis perspicacissimi: <strong>in</strong> artem<br />
Geometrie <strong>in</strong>cipit quam foelicissime [...].Venezia,<br />
Erhard Ratdolt, 25 maggio 1482.<br />
In-folio (mm 277x201). Collazione: a 10 , b-r 8 . 137 carte non numerate,<br />
manca l’ultima bianca.Testo su 44-45 l<strong>in</strong>ee su un’unica colonna; caratteri<br />
109:R, 91, 56, 76 e 92 gotici. Al recto della seconda carta elegante<br />
<strong>in</strong>iziale s<strong>il</strong>ografica decorata con un motivo a viticci su fondo nero e circondata<br />
da un bordo, anch’esso ornato da tralci di vite su fondo nero,<br />
che si estende su tre marg<strong>in</strong>i. La famosa cornice è quella ut<strong>il</strong>izzata da<br />
Ratdolt nel secondo volume della sua Historia Romana di Appiano del<br />
1477. Prima rubrica stampata <strong>in</strong> rosso; nel testo <strong>in</strong>iziali s<strong>il</strong>ografiche ornate<br />
su fondo nero e più di 420 diagrammi lungo i marg<strong>in</strong>i esterni. Secondo<br />
<strong>il</strong> Sander “Les belles <strong>in</strong>itiales et la bordure sont probablement<br />
l’oeuvre de Bernhard Maler. Une bonne partie des dess<strong>in</strong>s schématiques<br />
n’est pas gravée sur bois, mais formée à l’aide de lamelles métalliques”.<br />
Legatura ottocentesca <strong>in</strong> marocch<strong>in</strong>o rosso; piatti <strong>in</strong>quadrati da tre cornici<br />
di f<strong>il</strong>etti dorati con ferri floreali e rotondi ai quattro angoli; dorso a c<strong>in</strong>que<br />
nervi con decorazioni floreali e note tipografiche <strong>in</strong> oro, tagli dorati.<br />
Esemplare <strong>in</strong> buono stato di conservazione,accuratamente lavato,restauri<br />
lungo <strong>il</strong> marg<strong>in</strong>e <strong>in</strong>terno della prima e dell’ultima carta, qualche piccolo<br />
foro di tarlo.<br />
Antica nota manoscritta, pressoché <strong>il</strong>leggib<strong>il</strong>e, al recto della prima carta.<br />
Ex libris “John Pierpont Morgan”.<br />
Prima edizione del primo testo di geometria mai stampato<br />
e primo esempio di diagrammi geometrici a stampa.<br />
La traduzione lat<strong>in</strong>a di quest’opera impressa dal Ratdolt<br />
risale al secolo XIII ed è attribuita ad Adelardo di Bath,<br />
sebbene non si sappia con certezza se essa fu eseguita sul<br />
16
testo orig<strong>in</strong>ale greco o su una ulteriore traduzione<br />
araba, essa venne <strong>in</strong> seguito commentata e riveduta da<br />
Campano da Novara. Il testo commentato degli Elementa<br />
è preceduto da un’epistola dedicatoria dello stampatore<br />
al Doge Giovanni Mocenigo.<br />
Gli Elementa furono <strong>il</strong> primo importante libro scientifico<br />
dato alle stampe, superando <strong>il</strong> grande ostacolo della<br />
realizzazione delle figure geometriche, per le quali furono<br />
<strong>in</strong>ventati appositi caratteri tipografici e lasciati<br />
marg<strong>in</strong>i molto ampî, sui quali poterle <strong>in</strong>serire.<br />
“It was the first attempt – and a highly successfull one –<br />
to produce a long mathematical book <strong>il</strong>lustrated by diagrams.<br />
In his dedicatory epistle to the Doge Ratdolt says<br />
that he had often wondered why the great output of the<br />
Venetian pr<strong>in</strong>t<strong>in</strong>g presses <strong>in</strong>cluded so few and so <strong>in</strong>significant<br />
mathematical works. He had discovered that this<br />
was due to the difficulty of pr<strong>in</strong>t<strong>in</strong>g the diagrams without<br />
which such books were almost un<strong>in</strong>telligible, and he had<br />
set himself to overcome the difficulty. He certa<strong>in</strong>ly did<br />
overcome it; and he did more. He not only produced a<br />
very beautiful book, but he set a standard for the production<br />
of mathematical books which lasted for a generation<br />
or longer” (Thomas-Stanford, p. 3). L’<strong>in</strong>fluenza di questo<br />
libro sulla r<strong>in</strong>ascita delle scienze fu enorme ed esso viene<br />
giustamente ritenuto uno dei lavori che più significativamente<br />
caratterizzarono l’<strong>in</strong>izio del R<strong>in</strong>ascimento.<br />
HC* 6693; GW 9428; BMC V, 285; IGI 3722; Goff E, 113; BAV E, 33;<br />
Klebs 382.1; Essl<strong>in</strong>g 282; Sander 2605; PMM 25; G. Redgrave, Erhard Rat-<br />
17
dolt and his work at Venice. A paper read before the Bibliographical Society, November<br />
20, 1893, London 1899, pp. 15-17; C.Thomas-Stanford, Early editions<br />
of Euclid’s Elements, San Francisco, 1977, n° 1.<br />
5 <br />
Plot<strong>in</strong>us (204-270 d.C.). Opera. Firenze,Antonio di<br />
Bartolomeo Miscom<strong>in</strong>i, 7 maggio 1492.<br />
In-folio (mm 350x237). Collazione: a 10 ,b 8 , c-n 10 ,o 12 ,p 10 , q-z 10 ,& 10 , aa-tt 10 ,<br />
uu 10 ,vv 2 . 442 carte non numerate di cui la prima bianca.Testo su 45 l<strong>in</strong>ee,<br />
carattere 112:R; <strong>il</strong> quaderno ‘r’ alla f<strong>in</strong>e è stampato con un differente<br />
set di caratteri, lettere guida. Al colophon marca tipografica dello stampatore<br />
[Kristeller 47]. Alla prima carta di testo splendida ‘P’ <strong>in</strong> oro m<strong>in</strong>iata<br />
con uno scolaro <strong>in</strong>tento a scrivere nel suo studio, bordura con motivi<br />
ornamentali classici <strong>in</strong> rosa, verde, blu e oro. Cap<strong>il</strong>ettera da 3 a 8 l<strong>in</strong>ee<br />
<strong>in</strong> rosso e blu. Legatura di Kalthoeber <strong>in</strong> marocch<strong>in</strong>o rosso a grana larga,<br />
i piatti sono <strong>in</strong>quadrati da una cornice di tre f<strong>il</strong>etti dorati, al centro,<br />
impresse <strong>in</strong> oro, le armi di Barclay. Dorso a sei nervi, delimitati da f<strong>il</strong>i dorati,<br />
con titolo e note tipografiche. Merletto <strong>in</strong>terno alla greca, carte di<br />
guardia <strong>in</strong> carta ca<strong>il</strong>louté, tagli dorati e goffrati. Esemplare <strong>in</strong> ottimo stato<br />
di conservazione, un piccolo foro di tarlo anticamente riparato all’ultima<br />
carta tocca tre lettere.<br />
Proveniente dalla collezione Earl Spencer. Ex libris: “Charles Barclay”,<br />
“Charles Harry St. John Hornby”,“Clifford Rattey”.<br />
Prima edizione dell’opera di Plot<strong>in</strong>o, tradotta e commentata<br />
da Mars<strong>il</strong>io Fic<strong>in</strong>o su richiesta del suo mecenate Lorenzo<br />
de’ Medici. Gli scritti del Plot<strong>in</strong>o furono raccolti <strong>in</strong><br />
un corpus omogeneo, le Enneadi, dal suo discepolo Porfi-<br />
18
io e rappresentano <strong>il</strong> primo testo neoplatonico. Il Fic<strong>in</strong>o,<br />
<strong>in</strong>coraggiato da Pico della Mirandola, term<strong>in</strong>ò la traduzione<br />
del summus <strong>in</strong>terpres di Platone nel 1486 ed <strong>il</strong> commento<br />
nel 1491, l’anno seguente furono dati alle stampe,<br />
ma purtroppo Lorenzo morì un mese prima della pubblicazione<br />
del volume. La dedica del Fic<strong>in</strong>o al Magnifico è<br />
testimonianza importante per la storia del platonismo a<br />
Firenze, <strong>in</strong>fatti nell’epistola viene dato <strong>il</strong> resoconto di come<br />
Cosimo de’ Medici, dopo aver assistito alle letture di<br />
Pleto su Platone, commissionasse al Fic<strong>in</strong>o la traduzione<br />
del corpus platonico e come gli ord<strong>in</strong>asse, una volta venuti<br />
alla luce gli scritti del Trismegisto, di abbandonare temporaneamente<br />
Platone per tradurre Ermete.<br />
HC* 13121; BMC VI, 640, XII, 46; IGI 7906; Goff P, 815; Pola<strong>in</strong> (B)<br />
3207.<br />
6 <br />
Anton<strong>in</strong>o, santo (1389-1459). Tractato volgare di<br />
frate Anton<strong>in</strong>o arcivescovo di Firenze che è <strong>in</strong>titolato<br />
Curam <strong>il</strong>lius habe. Firenze, Lorenzo Morgiani<br />
e Johannes Petri, 23 maggio 1493.<br />
In-4° (mm 197x130). Collazione: a-i 8 ,k 6 ,l 4 . 82 carte non numerate. Carattere<br />
4:85R su 36 righe.Al frontespizio s<strong>il</strong>ografia, già apparsa nei Sol<strong>il</strong>oquia<br />
di S. Agost<strong>in</strong>o del 1491, raffigurante S. Anton<strong>in</strong>o nel suo studio<br />
nell’atto di scrivere; al verso dell’ultima carta un altro legno, <strong>in</strong>edito, raf-<br />
19
figurante S.Anton<strong>in</strong>o nell’atto di confessare un penitente <strong>in</strong>g<strong>in</strong>occhiato<br />
d<strong>in</strong>nanzi a lui. Iniziali s<strong>il</strong>ografiche ornate su fondo nero. Legatura moderna<br />
<strong>in</strong> marocch<strong>in</strong>o marrone, titolo <strong>in</strong> oro al dorso, dentelles <strong>in</strong>terne,<br />
tagli dorati. Esemplare <strong>in</strong> buono stato di conservazione, alcune fioriture,<br />
angolo <strong>in</strong>feriore dell’ultima carta ricostruito con parziale perdita del colophon.<br />
Ex libris “W.A. Foyle. Beeleigh abbey”.<br />
Rara edizione del trattato redatto <strong>in</strong> volgare da Anton<strong>in</strong>o<br />
Pierozzi, frate domenicano, che fu valido sostenitore della<br />
riforma dell’ord<strong>in</strong>e promossa dal Beato Raimondo da Capua.<br />
Fu ricevuto nell’ord<strong>in</strong>e dal Beato Giovanni Dom<strong>in</strong>ici<br />
nel convento di Santa Maria Novella, proseguendo la<br />
sua preparazione a Cortona, dove ebbe come maestro <strong>il</strong><br />
Beato Lorenzo di Ripafratta, del quale fu degno discepolo.<br />
Papa Eugenio IV, nel 1446, lo nom<strong>in</strong>ò Arcivescovo di<br />
Firenze, morì nel 1459 e fu proclamato santo da Papa<br />
Adriano VI <strong>il</strong> 31 maggio 1523.<br />
Il trattato contenuto nella presente edizione va considerato<br />
come un vero e proprio catechismo, prova delle preoccupazioni<br />
pastorali del santo arcivescovo.<br />
HC 1214; BMC V, 682; GW 2079; IGI 615; Goff A, 785; Sander 427.<br />
7 <br />
[Colonna, Francesco (ca. 1433-1527)]. Hypnerotomachia<br />
Poliph<strong>il</strong>i. Venezia, Aldo Manuzio,dicembre 1499.<br />
20
In-folio (mm 300x205). Collazione: 4 , a-y 8 ,z 10 , A-E 8 ,F 4 . 234 carte non<br />
numerate. Caratteri: 2:115R (testo); 10:82R (titoli, errata, <strong>in</strong>cipit di alcuni<br />
capitoli); 7:114G (alcune parole); 9:48G (errata), carattere ebraico<br />
squadrato (iscrizioni <strong>in</strong> b8 recto e verso). Due grandi e 37 piccole <strong>in</strong>iziali<br />
s<strong>il</strong>ografiche che <strong>in</strong> successione formano <strong>il</strong> celebre acrostico “Poliam<br />
fratrem Franciscus Columna peramavis”. Illustrato da 172 legni, due dei<br />
quali (a6v e c1r) con <strong>il</strong> monogramma ‘b’, e di cui 11 a piena pag<strong>in</strong>a. Le<br />
s<strong>il</strong>ografie sono probab<strong>il</strong>mente da attribuirsi alla cerchia del m<strong>in</strong>iatore padovano<br />
Benedetto Bordon (cfr. L<strong>il</strong>ian Armstrong, “Benedetto Bordon,<br />
Aldus Manutius and Lucantonio Giunta”, <strong>in</strong> Aldus Manutius and Renaissance<br />
culture, Firenze 1998, pp. 161-183), sebbene Alessandro Parronchi<br />
proponga <strong>il</strong> nome di Pietro Paolo Agabiti. Legatura francese <strong>in</strong> vitello<br />
d’<strong>in</strong>izio Seicento, con le armi di Gaspard III Fieubert de Naulac, signore<br />
di Ligny (Olivier, tav. 252), impresse <strong>in</strong> oro su entrambi i piatti; titolo <strong>in</strong><br />
oro al dorso, tagli spruzzati. Esemplare molto fresco, <strong>in</strong> ottimo stato di<br />
conservazione; piccola perdita di carta al marg<strong>in</strong>e <strong>in</strong>feriore di un foglio;<br />
dorso restaurato conservando gran parte della pelle orig<strong>in</strong>ale.L’errata SA-<br />
NEQVE è stata corretta sbarrando l’ultima lettera e scrivendo a mano la<br />
des<strong>in</strong>enza AM. Provenienza: al frontespizio firma di Gu<strong>il</strong>lermus Marlius,<br />
commentatore del XVI secolo; Gaspard III de Naulac, sieur de Ligny, che<br />
fece parte del Parlamento di Parigi nel 1649, fu consigliere di stato e cancelliere<br />
della reg<strong>in</strong>a Maria Teresa; al frontespizio firma di Vignier, storico<br />
e accademico francese del XVIII secolo, biografo di Enrico IV; firma al<br />
frontespizio di Myron (sec. XVIII); nota di acquisto del 6 marzo 1775 di<br />
Michael Wodhull che lo acquistò all’asta White; ex libris Ph<strong>il</strong>ip Hofer,<br />
al quale fu venduto nel 1886 a Londra; John M. Crawford, collezionista<br />
americano; H. Bradley Mart<strong>in</strong>, venduto nel 1990 ad un collezionista<br />
privato.<br />
Prima edizione del Sogno di Polif<strong>il</strong>o, dedicata dal gent<strong>il</strong>uomo<br />
veronese Leonardo Crasso, che ne f<strong>in</strong>anziò la<br />
stampa, a Guidobaldo da Montefeltro, duca di Urb<strong>in</strong>o.<br />
Il romanzo d’amore allegorico attribuito al frate domenicano<br />
del convento di San Zanipolo Francesco Co-<br />
21
lonna – identificab<strong>il</strong>e dall’acrostico composto dai 39 cap<strong>il</strong>ettera<br />
che ornano <strong>il</strong> testo – è uno dei rari volumi <strong>il</strong>lustrati<br />
impressi dai torchi della tipografia ald<strong>in</strong>a. Scritto<br />
<strong>in</strong> un l<strong>in</strong>guaggio ibrido tra italiano e lat<strong>in</strong>o, irto di<br />
simbolismi, di allusioni erudite, di riferimenti antiquari<br />
è un unicum nella carriera dello stampatore veneziano<br />
e la sua eccezionalità risiede anche nelle raff<strong>in</strong>ate s<strong>il</strong>ografie<br />
che adornano <strong>il</strong> testo.<br />
HC* 5501; BMC V, 561; GW 7223; IGI 3062; Goff C, 767; Renouard<br />
21, p. 5; Ahmanson-Murphy 35; Laurenziana, n° 36; Marciana, n° 36;<br />
Lowry, pp. 129-135; Essl<strong>in</strong>g 1198.<br />
8 <br />
Parzaytumar Hayoc’ [Almanacco semplice]. [Venezia,Yakob<br />
Melapart, 1512].<br />
In-8° (mm 150x103); 60 carte non numerate, segnate con le prime otto<br />
lettere dell’alfabeto armeno. Carattere bolorgir 18, stampato <strong>in</strong> rosso<br />
e nero.Al recto della prima carta, soltanto le parole: [«È l’Almanacco degli<br />
Armeni»]; segue <strong>il</strong> calendario per l’anno 961 dell’era armena<br />
[= 1512], titoli correnti <strong>in</strong> rosso e nero racchiusi <strong>in</strong> un elaborato cartiglio<br />
s<strong>il</strong>ografico. Al verso della penultima carta, registro e marca tipografica<br />
stampata <strong>in</strong> rosso (con, <strong>in</strong>scrittevi, le lettere romane «D. I. Z.A.»). Legatura<br />
antica <strong>in</strong> vitello marrone con cornice decorata a secco da ferri<br />
ovali, tracce di b<strong>in</strong>delle, fogli di guardia <strong>in</strong> pergamena manoscritta. Esemplare<br />
<strong>in</strong> buono stato di conservazione, se si considerano la rarità del volume<br />
e la sua povertà tipografica; carta piuttosto usurata, alcune macchie.<br />
22
Il presente libro è stato considerato per lungo tempo <strong>il</strong><br />
primo di una serie di volumi che, stampati a Venezia a<br />
partire dal 1512, costituiscono “les plus anciens produits<br />
de l’Imprimerie Arménienne” (De Mar<strong>in</strong>is). Recenti<br />
studi di Raymond H. Kévorkian portano alla conclusione<br />
che <strong>il</strong> Parzaytumar fu <strong>il</strong> terzo dei c<strong>in</strong>que libri armeni<br />
pubblicati da Yakob Melapart negli anni 1512-13.<br />
L’opera consta di c<strong>in</strong>que parti: 1) Trattato sui segni zodiacali;<br />
2) Trattato sul primo giorno dell’anno; 3) Trattato<br />
sui sogni; 4) Trattato sulla nascita dei bamb<strong>in</strong>i; 5)<br />
Trattato sui movimenti delle membra del corpo umano.<br />
“L’édition est suffisament nette et régulière; elle a une<br />
ponctuation et des lettres majuscules; les mots y sont séparés<br />
les uns des autres et les fautes typographiques n’y<br />
sont pas nombreuses” (De Mar<strong>in</strong>is).<br />
“[In Venice] Armenian pr<strong>in</strong>t<strong>in</strong>g began.The first Armenian<br />
pr<strong>in</strong>ter was Yakob Melapart (Jacob the s<strong>in</strong>ful) who,<br />
with the aid of the small Armenian community, published<br />
the first Armenian book <strong>in</strong> 1512. We possess very<br />
little <strong>in</strong>formation about him, but the high quality and<br />
orig<strong>in</strong>al features of his publications are evidence that he<br />
was a learned <strong>in</strong>dividual. Five of his books have been<br />
preserved, but no copy of the sixth, a Psalter, has yet<br />
been discovered.All are dim<strong>in</strong>utive; the paper resembles<br />
vellum <strong>in</strong> colour and texture; the type, pr<strong>in</strong>ted <strong>in</strong> red<br />
and black, resembles the script used <strong>in</strong> manuscripts.<br />
None of the books has a title page, and the pages are<br />
not numbered. Several elegant head-pieces, engrav<strong>in</strong>gs<br />
23
and ornamental letters are used. At the end of each<br />
book, we f<strong>in</strong>d the pr<strong>in</strong>ter’s device with the <strong>in</strong>itials<br />
D.I.Z.A., which occurs only <strong>in</strong> the five books pr<strong>in</strong>ted<br />
by Yakob Melapart,and this rules out the possib<strong>il</strong>ity that<br />
the books could have been pr<strong>in</strong>ted by Italian firms. In<br />
1513 Lelio and Paulo di Maximi, the heirs of Democrito<br />
Terrac<strong>in</strong>a, were granted a renewal for twenty-five<br />
years of an exclusive Venetian priv<strong>il</strong>ege to pr<strong>in</strong>t works<br />
<strong>in</strong> the characters of certa<strong>in</strong> Oriental languages, <strong>in</strong>clud<strong>in</strong>g<br />
Armenian, orig<strong>in</strong>ally granted to Terrac<strong>in</strong>a <strong>in</strong> 1498.<br />
There is noth<strong>in</strong>g to show that they were concerned <strong>in</strong><br />
the pr<strong>in</strong>t<strong>in</strong>g or publication of the above works. Armenian<br />
scholars have suggested various solutions. Karapet<br />
Besmajean deciphers the <strong>in</strong>itials as follows:<br />
D. = Dei Servus<br />
I. = Iacobus [= Yakob]<br />
Z. = Zanni or Zuanne [= Yovhannes]<br />
A. = Armenus” (Nersessian).<br />
T. De Mar<strong>in</strong>is, Les débuts de l’Imprimerie Arménienne à Venise, prefazione al<br />
catalogo T. De Mar<strong>in</strong>is & Co., Livres rares, autographes et manuscripts, Florence<br />
1906, p. IV, n° 1 (“On en trouve un exemplaire dans la bibliothèque<br />
des PP. Mekithariste à Vienne et un autre dans le Couvent de St.<br />
Jacques à Jérusalem”);V. Nersessian, Catalogue of Armenian Pr<strong>in</strong>ted Books<br />
<strong>in</strong> the British Library and the Bodleian Library, 1512-1800, n° 1 (un’unica<br />
copia, presso la Bodleian Library); H. Kévorkian, Catalogue des «<strong>in</strong>cunables»<br />
arméniens ou chronique de l’imprimerie arménienne, Genève 1986, n° 3.<br />
24
8. Parzaytumar Hayoc’
9. Granollachs, Bernat de
10. Dom<strong>in</strong>ici, Giovanni beato
11. Stab<strong>il</strong>i, Francesco
16. Leonico Tomeo, Niccolò
12. Erasmus, Desiderius Roterodamus
13. Erasmus, Desiderius Roterodamus
22. Alighieri, Dante
9 <br />
Granollachs, Bernat de (ca. 1421-1485). Lunarium: <strong>in</strong><br />
quo reperiuntur Coniunctiones & Oppositiones Lunae/<br />
& Eclypses Solis & Lunae/ per Anni circulum,<br />
Festa mob<strong>il</strong>ia,Aureus numerus: & Littera dom<strong>in</strong>icalis<br />
etc. [Venezia, s.n., 1513].<br />
In-8° (mm 131x90); 22 carte non numerate.Al frontespizio s<strong>il</strong>ografia di<br />
scuola veneziana che rappresenta un astronomo nel suo studio. Legatura<br />
moderna <strong>in</strong> marocch<strong>in</strong>o blu firmata da Lortic. Su entrambi i piatti stemma<br />
dorato del pr<strong>in</strong>cipe d’Essl<strong>in</strong>g, dentelles <strong>in</strong>terne, tagli dorati. Esemplare<br />
<strong>in</strong> ottimo stato di conservazione, accuratamente lavato.<br />
Rarissima edizione del Lunarium di Bernat de Grannollachs,<br />
le tavole <strong>in</strong> esso contenute vanno dall’anno 1512<br />
al 1550. Si tratta del calendario astronomico più importante<br />
dell’Europa tra la f<strong>in</strong>e del XV e l’<strong>in</strong>izio del XVI secolo:<br />
<strong>in</strong> cent’anni (tenendo conto che la primissima edizione<br />
risale al 1488) ne vennero stampate più di 90<br />
edizioni. L’opera del Granollachs fu <strong>in</strong>fatti stampata <strong>in</strong><br />
lat<strong>in</strong>o, catalano, italiano, portoghese <strong>in</strong> Spagna, Francia,<br />
Portogallo ed Italia.<br />
Si tratta dell’unico esemplare censito di questa edizione,<br />
probab<strong>il</strong>mente veneziana (e non romana come ipotizzato<br />
da Sander e Chabàs-Roca), poiché proveniente<br />
dalla raccolta Essl<strong>in</strong>g, noto collezionista di libri stampati<br />
a Venezia.<br />
Sander 3245; Chabàs-Roca 62 (non cita nessuna copia); manca al Palau.<br />
25
10 <br />
Dom<strong>in</strong>ici, Giovanni beato (1357-1419).Trattato della<br />
sanctissima charita. Siena, Simeone Nardi e Gionanni<br />
Landi, 17 ottobre 1513.<br />
In-4° (mm 202x130); 4 carte non numerate, 170 carte erroneamente numerate<br />
180, due non numerate. Al frontespizio grande s<strong>il</strong>ografia <strong>in</strong> cornice<br />
e a piena pag<strong>in</strong>a raffigurante l’autore <strong>in</strong>g<strong>in</strong>occhiato nell’atto di offrire<br />
la propria opera a Cristo <strong>in</strong> croce; cap<strong>il</strong>ettera s<strong>il</strong>ografici ornati; al<br />
colophon note tipografiche stampate su righe di misura variab<strong>il</strong>e a comporre<br />
una croce. Legatura ottocentesca <strong>in</strong> marocch<strong>in</strong>o rosso firmata da<br />
Lortic, stemma dorato del pr<strong>in</strong>cipe d’Essl<strong>in</strong>g al centro di entrambi i piatti.<br />
Dorso a c<strong>in</strong>que nervi con titolo impresso <strong>in</strong> oro e monogramma<br />
‘MV’, dentelles <strong>in</strong>terne, tagli dorati. Esemplare <strong>in</strong> buono stato di conservazione,<br />
accuratamente lavato.<br />
Prima e assai rara edizione di quest’opera ascetica di<br />
Giovanni Dom<strong>in</strong>ici, frate domenicano, card<strong>in</strong>ale e fondatore,<br />
nel 1406, del Convento di S. Domenico di Fiesole.<br />
Nella prefazione viene narrata la vita dell’autore.<br />
“S. Anton<strong>in</strong>o, arcivescovo di Firenze, condiscepolo col<br />
celebre b. Angelico da Fiesole, scrive del suo maestro e<br />
primo ispiratore alla vita monastica a proposito di questo<br />
Trattato: «Ut etiam <strong>il</strong>litteratis doctr<strong>in</strong>am spiritualem<br />
rel<strong>in</strong>queret, librum <strong>in</strong> vulgari venusto composuit stylo,<br />
quem Amorem Caritatis <strong>in</strong>titulavit, exponens <strong>il</strong>lud capitulum:<br />
Si l<strong>in</strong>guis hom<strong>in</strong>um loquar et Angelorum etc., nec<br />
sim<strong>il</strong>e <strong>in</strong> vulgari reperitur»; e nella Somma dà lode allo<br />
stesso, perché avesse scritto <strong>in</strong> l<strong>in</strong>guaggio volgare questo<br />
libro, esso pure scientifico, contro l’uso allora comune.<br />
26
La fac<strong>il</strong>e e rapida diffusione di quell’opera, avvenuta<br />
dapprima mercé i codici manoscritti, <strong>in</strong>di col mezzo tipografico,<br />
dimostra <strong>in</strong>dubbiamente <strong>in</strong> quanto pregio essa<br />
fosse tenuta, e con quanto entusiasmo fosse accolto<br />
uno scritto dettato da quella mente profondamente f<strong>il</strong>osofica,<br />
che seppe trattare un argomento ascetico e morale<br />
anche colle speculazioni più alte, a cui può giungere<br />
l’<strong>in</strong>telletto umano” (Il libro d’amore di carità…, p.X).<br />
Le lodi del Dom<strong>in</strong>ici e l’apprezzamento per la sua opera<br />
ricorrono <strong>in</strong> numerosi testi dell’epoca,quali,ad esempio,<br />
una lettera di Coluccio Salutati a Gregorio XII, le<br />
Lettere dell’Aret<strong>in</strong>o ed <strong>il</strong> Dialogo contro gli Ipocriti di Poggio<br />
Bracciol<strong>in</strong>i.<br />
F. Jacometti, Il primo stampatore senese: Simone di Niccolò di Nardo,“La Diana.<br />
Rassegna d’arte e vita senese”, I (1926), fasc. 3°, pp. 184-202; Sander<br />
2466; Olschki, n° 4474 (“Volume fort rare”); Il libro d’amore di carità del<br />
fiorent<strong>in</strong>o B. Giovanni Dom<strong>in</strong>ici.Testo <strong>in</strong>edito di l<strong>in</strong>gua pubblicato per cura<br />
del dott. Antonio Ceruti, Bologna 1889.<br />
11 <br />
Stab<strong>il</strong>i, Francesco, detto Cecco d’Ascoli (1269-1327).<br />
[L’Acerba] Lo <strong>il</strong>lustro poeta Cecho d’Ascoli; con comento<br />
novamente trovato; et nob<strong>il</strong>mente historiato,<br />
revisto et emendato da molta <strong>in</strong>correctione extirpato<br />
et da antiquo suo vestigio exemplato. Venezia,<br />
Marchiò Sessa e Piero di Ravani, 1516.<br />
27
In-4° (mm 209x139); 100 carte numerate.Al frontespizio <strong>il</strong>lustrazione s<strong>il</strong>ografica<br />
firmata ‘LF’ - già comparsa nell’edizione sessiana de L’Acerba del<br />
1510 - e tratta dal del De virtutibus herbarum di Alberto Magno del 1509,<br />
raffigurante due astronomi. Nel testo figure astronomiche e vignette, alcune<br />
raffiguranti i vizi e le virtù degli animali. Cap<strong>il</strong>ettera s<strong>il</strong>ografici ornati.<br />
Al colophon marca editoriale, un gatto con topo <strong>in</strong> bocca <strong>in</strong> cerchio<br />
sormontato da corona (Z595). Legatura <strong>in</strong> mezza pelle bazzana<br />
ottocentesca. Esemplare <strong>in</strong> discreto stato di conservazione, qualche macchia<br />
accuratamente lavata ed alcuni difetti al dorso.<br />
Rara edizione veneziana, riccamente <strong>il</strong>lustrata de L’Acerba<br />
di Cecco d’Ascoli. Si tratta di una ristampa dell’edizione<br />
del Sessa del 1510, che viene considerata “la migliore<br />
per la qualità della impressione, per l’importanza<br />
dei commenti del Massetti e per l’ord<strong>in</strong>e col quale ne sono<br />
divise le parti” (Riccardi).<br />
“Più dei trattati (lat<strong>in</strong>i) astronomici e astrologici, ebbe<br />
fortuna f<strong>in</strong>o alla Controriforma <strong>il</strong> poemetto volgare, divulgativo<br />
(benché, per ruvidezza di dettato, tutt’altro che<br />
trasparente) compendio di f<strong>il</strong>osofia naturale,<strong>in</strong>titolato Lacerba:<br />
da dividersi L’Acerba, con programmatica allusione<br />
all’asprezza della materia e della scrittura. Questa <strong>in</strong>terpretazione<br />
(alla quale si attennero i futuristi fiorent<strong>in</strong>i<br />
chiamando Lacerba una loro rivista di velleità anticonformistiche)<br />
sembra accordarsi con un passo del IV e penultimo<br />
libro: “Or, alma grazïosa, pôi vedere Quanta dolcezza<br />
è <strong>in</strong> quisti acerbi fogli”; ma, poiché più<br />
specificamente all’<strong>in</strong>izio del medesimo libro Cecco vuol<br />
levar “l’ale de l’acerba mente,Seguendo del f<strong>il</strong>osofo la via”<br />
(e non manca nella tradizione <strong>il</strong> titolo Liber acerbæ ætatis<br />
28
o cosa aff<strong>in</strong>e, forse sullo schema di Vita Nuova), Cecco alluderà<br />
all’adolescenza mentale, da dirozzare <strong>in</strong> modo<br />
scientifico. […] Un certo fasc<strong>in</strong>o, per quanto <strong>in</strong>termittente,<br />
viene al poemetto dalla sua stessa petrosità, <strong>in</strong> buona<br />
parte preter<strong>in</strong>tenzionale. L’Acerba è per qualche aspetto<br />
un’anti-Commedia, poiché Cecco non perde occasione<br />
di combattere, con l’acred<strong>in</strong>e allora propria di f<strong>il</strong>osofi e<br />
scienziati,s<strong>in</strong>gole tesi di Dante (col quale egli avrebbe polemizzato<br />
personalmente sul tema della nob<strong>il</strong>tà), e anche<br />
la generale organizzazione fantastica dalla selva oscura <strong>in</strong><br />
giù, coi più famosi personaggi e aneddoti anche storici<br />
(Paolo e Francesca, conte Ugol<strong>in</strong>o,Vanni Fucci ecc.): tutte<br />
fut<strong>il</strong>i favole, <strong>in</strong> confronto alla nuda verità propugnata<br />
da Cecco. Un qualche recalcitrante omaggio alla Commedia<br />
è reso peraltro dal metro, che pure è una specie di<br />
terz<strong>in</strong>e, ma associate a due a due con rime ABA, CBC,come<br />
sirme di sonetto non <strong>in</strong>catenate fra loro (<strong>in</strong> f<strong>in</strong>e al capitolo<br />
è un distico a rima baciata)”. (G.CONTINI, Letteratura<br />
italiana delle orig<strong>in</strong>i, Firenze 1985 4 , p. 441).<br />
Riccardi 472; Abrams 144; Essl<strong>in</strong>g 1333; Sander 1889.<br />
12 <br />
Erasmus, Desiderius Roterodamus (1466-1536). Institutio<br />
Pr<strong>in</strong>cipis Christiani saluberrimis referta<br />
praeceptis […]. Bas<strong>il</strong>ea, Johann Froben, maggio 1516.<br />
29
In-4° (mm 212x148); 166 carte non numerate. Frontespizio <strong>in</strong>quadrato<br />
da una cornice s<strong>il</strong>ografica a fondo nero. Anche al recto della seconda<br />
carta – recante l’<strong>in</strong>cipit della dedica di Erasmo al pr<strong>in</strong>cipe Carlos I di<br />
Spagna – ricca cornice s<strong>il</strong>ografica, che si ritrova identica alla carta 2v e,<br />
con <strong>il</strong> legno superiore <strong>in</strong>vertito con quello <strong>in</strong>feriore, alle carte P1r e Y1v.<br />
Cap<strong>il</strong>ettera s<strong>il</strong>ografici ornati nel testo; al verso dell’ultima carta marca tipografica<br />
di Johann Froben – una mano che regge un cadùceo – sormontato<br />
da una colomba e <strong>in</strong>quadrato dal motto evangelico <strong>in</strong> lat<strong>in</strong>o, ripetuto<br />
anche <strong>in</strong> greco e <strong>in</strong> ebraico “Prudens simplicitas amorque recti”<br />
e affiancata dalle <strong>in</strong>iziali “IO”,“FRO.”. Legatura c<strong>in</strong>quecentesca <strong>in</strong> piena<br />
pelle, rimontata e molto usurata, con perdita quasi totale dell’oro. Piatti<br />
decorati lungo i bordi e, al centro, motivo ornamentale a ferri floreali<br />
dorati. Esemplare stampato su carta forte, con ampi marg<strong>in</strong>i, <strong>in</strong> buono<br />
stato di conservazione; qualche gora, più marcata lungo <strong>il</strong> marg<strong>in</strong>e <strong>in</strong>feriore<br />
del volume.<br />
Alcune note manoscritte di possesso dei secoli XVII e XVIII al frontespizio;<br />
marg<strong>in</strong>alia e sottol<strong>in</strong>eature <strong>in</strong> <strong>in</strong>chiostro marrone nel testo.<br />
Prima edizione dell’Institutio di Erasmo, scritta nel 1515<br />
e dedicata a Carlos I di Spagna con le parole che seguono:“Illustrissimo<br />
pr<strong>in</strong>cipi Carolo <strong>in</strong>victissimi Maxim<strong>il</strong>iani<br />
nepoti,Desiderius Erasmus Roterodamus S.D”.La dedica<br />
colpì <strong>il</strong> futuro imperatore di Spagna a tal punto che<br />
egli fece del libro una delle sue pr<strong>in</strong>cipali letture, come<br />
nota José Luis Abellán nel suo studio El erasmismo español<br />
“La idea imperial de Carlos V está directamente <strong>in</strong>spirada<br />
en esa fuente erasmiana. Según ésta, el imperio es la<br />
unidad espiritual cristiana, idea alejada tanto de la concepción<br />
clásica del imperio como de la monarquía universal,<br />
que algunos pretendían; en ambos casos el emperador<br />
aparece como dom<strong>in</strong>us mundi. Por el contrario, en la<br />
concepción de Carlos V, éste se prefigura como rey de la<br />
30
universitas christiana de la que se considera más jefe espiritual<br />
que político” (p. 128). Il volume contiene <strong>in</strong>oltre le<br />
opere di Erasmo De regno adm<strong>in</strong>istrando, <strong>il</strong> panegirico <strong>in</strong>dirizzato<br />
a F<strong>il</strong>ippo <strong>il</strong> Bello e, <strong>in</strong> coda, <strong>il</strong> Libellum Plutarchi<br />
de discrim<strong>in</strong>e adulatoris & amici… ad Henricum octavum.<br />
Vander Haeghen,111;Adams E,380;Bibl.Belg.E,1253;Machiels E,483;<br />
J.L. Abellán, El erasmismo español, Madrid 2005.<br />
13 <br />
Erasmus, Desiderius Roterodamus (1466-1536). Antibarbarorum<br />
[...] liber unus. Bas<strong>il</strong>ea, Johann Froben,<br />
maggio 1520.<br />
In-4° (mm 205x143); 150 pag<strong>in</strong>e numerate.Titolo racchiuso entro una<br />
elaborata cornice architettonica disegnata da Hans Holbe<strong>in</strong> e ripresa dall’edizione<br />
di Pico della Mirandola del 1518, <strong>in</strong> basso al centro due putti<br />
sorreggono uno scudo con la marca del Froben, <strong>il</strong> cadùceo con al centro<br />
una colomba. La prima pag<strong>in</strong>a di dedica (p. 3) e la prima pag<strong>in</strong>a di<br />
testo (p. 9) sono anch’esse circondate da un’elaborata cornice s<strong>il</strong>ografica<br />
a fondo nero ornata da motivi architettonici e floreali e da un capolettera<br />
animato.Al verso dell’ultima carta marca tipografica dello stampatore<br />
<strong>in</strong>serita <strong>in</strong> uno scudo sorretto da due putti <strong>in</strong> cornice architettonica.<br />
Legatura moderna <strong>in</strong> mezza pergamena. Esemplare stampato su carta forte,<br />
<strong>in</strong> buono stato di conservazione, con ampi marg<strong>in</strong>i; tracce di umidità<br />
al marg<strong>in</strong>e <strong>in</strong>feriore e qualche brunitura.<br />
Marg<strong>in</strong>alia coevi <strong>in</strong> <strong>in</strong>chiostro marrone <strong>in</strong> tutto <strong>il</strong> volume.<br />
Rarissima editio pr<strong>in</strong>ceps di una delle prime opere di<br />
31
Erasmo.Essa venne scritta nel 1495 <strong>in</strong> difesa di coloro che<br />
conoscevano correttamente <strong>il</strong> lat<strong>in</strong>o e contro gli scrittori<br />
‘barbari’, dal l<strong>in</strong>guaggio poco corretto. L’autore attribuisce<br />
la responsab<strong>il</strong>ità di questa decadenza ai cristiani<br />
dell’età post-patristica, che avevano avvertito <strong>il</strong> contrasto<br />
fra la loro fede e gli studi tradizionali, ovvero tra classicismo<br />
e cristianesimo.“I veri Goti” dice Erasmo “non erano<br />
stati gli <strong>in</strong>dotti ed i rudi guerrieri germanici, ma gli<br />
uom<strong>in</strong>i della scienza, che avevano oscurato con i loro tenebrosi<br />
commentari gli autori tradotti dal greco”.<br />
Con la redazione della presente opera <strong>il</strong> grande erudito<br />
mitteleuropeo pone f<strong>in</strong>e alla diatriba <strong>in</strong>nescata dallo<br />
scambio epistolare tra Pico della Mirandola ed Ermolao<br />
Barbaro del 1485, tra i ‘barbari’ f<strong>il</strong>osofi e gli ‘eloquenti’<br />
umanisti. Con l’Antibarbarorum Erasmo giunge alla conclusione<br />
che l’eloquenza lat<strong>in</strong>a ben si sposa, e anzi favorisce,<br />
qualsiasi prodotto dell’<strong>in</strong>telletto umano.<br />
Vander Haegen I, 9;Adams E, 463; Bibl. Belgica II, 400, E, 286; Machiels<br />
E, 158.<br />
14 <br />
Caesar, Gaius Iulius (100-44 a.C.). Commentaria<br />
Caesaris […] In his autem commentariis cont<strong>in</strong>entur:<br />
De Bello Gallico Libri VIII. De bello civ<strong>il</strong>i<br />
Pompeiano libri IIII. [Hircus, Aulus]. De bello<br />
32
Alexandr<strong>in</strong>o liber I. De bello Africano Liber I.De<br />
bello Hispaniensi liber I […] [Marliano, Raimondo].<br />
Nom<strong>in</strong>a locorum urbiumque… Pictura totius<br />
Galliae […]. Firenze, eredi di F<strong>il</strong>ippo Giunti,<br />
1520.<br />
In-8° (mm 152x88); 15 carte non numerate, una carta bianca, 285 carte<br />
numerate (numerosi errori di pag<strong>in</strong>azione), una carta bianca recante, al<br />
verso, la marca tipografica dei Giunti (Z648). Illustrato da 7 s<strong>il</strong>ografie, di<br />
cui due a doppia pag<strong>in</strong>a raffiguranti la Gallia e la Spagna, e c<strong>in</strong>que raffiguranti,<br />
rispettivamente, <strong>il</strong> ponte fatto costruire da Cesare sul Reno, le<br />
mura fortificate della città di Avaricum, la città di Alexia Mandubiorum,<br />
la città di Uxellodunum, le mura fortificate di Marsiglia. Legatura seicentesca<br />
<strong>in</strong> pergamena rigida, tagli spruzzati. Esemplare <strong>in</strong> buono stato<br />
di conservazione, lievi tracce di umidità. Nota manoscritta di possesso<br />
del XVII secolo al frontespizio, radi richiami manoscritti <strong>in</strong> <strong>in</strong>chiostro<br />
marrone lungo i marg<strong>in</strong>i.<br />
Ristampa dell’edizione giunt<strong>in</strong>a del 1514, che, a sua volta<br />
è la seconda uscita dai torchi di questa offic<strong>in</strong>a. “I<br />
Giunti, che nel 1508 avevano dato di Cesare una vera e<br />
propria edizione, riproducono […] <strong>il</strong> testo ald<strong>in</strong>o, compresa<br />
la sua dedicatoria.Tipograficamente però la giunt<strong>in</strong>a<br />
è migliore, soprattutto per le carte e le <strong>il</strong>lustrazioni.”<br />
(Camer<strong>in</strong>i, p. 84).<br />
Camer<strong>in</strong>i n° 143; Adams C, 31; Renouard p. 45, n° 38.<br />
33
15 <br />
Leone, Ambrogio (1459-1525). Ambrosii Leonis<br />
Nolani div<strong>in</strong>i ph<strong>il</strong>osophi novum opus questionum<br />
seu problematum ut pulcherrimorum ita<br />
ut<strong>il</strong>issimorum tum aliis plerisque <strong>in</strong> rebus cognoscendis<br />
tum maxime <strong>in</strong> ph<strong>il</strong>osophia & medic<strong>in</strong>a<br />
scientia. Venezia, Bernard<strong>in</strong>o e Matteo Vitali, 28<br />
agosto 1523.<br />
In-folio (mm 314x216); 63 carte non numerate, una carta bianca. Frontespizio<br />
con titolo <strong>in</strong> rosso racchiuso <strong>in</strong> una cornice s<strong>il</strong>ografica a motivi<br />
floreali stampata <strong>in</strong> <strong>in</strong>chiostro blu; al verso della carta P3 marca tipografica<br />
dei fratelli Vitali raffigurante <strong>il</strong> leone di S. Marco che tiene con la<br />
zampa destra <strong>il</strong> Vangelo recante la scritta “Pax tibi Marce evangelista<br />
meus” (Z807). Legatura coeva <strong>in</strong> pergamena floscia recante sul piatto superiore<br />
la scritta, <strong>in</strong> caratteri capitali, “Ambrosii Nolani Problemata” <strong>in</strong><br />
<strong>in</strong>chiostro marrone, racchiusa da una cornice formata da quattro cerchi<br />
concentrici. La stessa iscrizione manoscritta, ma <strong>in</strong> caratteri gotici, compare<br />
anche lungo <strong>il</strong> dorso del volume; tracce di b<strong>in</strong>delle. Esemplare <strong>in</strong><br />
ottimo stato di conservazione,legatura parzialmente scucita al dorso. Antica<br />
nota manoscritta di possesso, quasi totalmente abrasa, al frontespizio.<br />
Rarissima prima – ed unica – edizione di quest’opera<br />
di Ambrogio Leone, dotto medico, f<strong>il</strong>osofo, storico, matematico<br />
e letterato orig<strong>in</strong>ario di Nola.Thorndicke ne<br />
fa menzione per la sua analisi, <strong>in</strong>credib<strong>il</strong>mente sofisticata<br />
e all’avanguardia rispetto ai tempi, della sif<strong>il</strong>ide (HistoriaV.147),<br />
pubblicata otto anni prima della prima edizione<br />
del Fracastoro. “Ambrogio Leone fu mente<br />
eclettica, aperta ad ogni forma di cultura, anche se pro-<br />
34
vava una naturale e particolare <strong>in</strong>cl<strong>in</strong>azione per le scienze<br />
sperimentali e per la f<strong>il</strong>osofia. Figlio del suo tempo,<br />
egli assorbì a Padova, a Napoli e a Venezia tutti gli aspetti<br />
e le sfumature della complessa cultura e civ<strong>il</strong>tà dell’Umanesimo<br />
e produsse, nei primi lustri del secolo successivo,<br />
<strong>il</strong> R<strong>in</strong>ascimento, buona parte delle sue opere,<br />
che di quella cultura sono, spesso, la s<strong>in</strong>tesi e la puntualizzazione<br />
esegetica. Alcune di esse, <strong>in</strong>fatti, sono come<br />
delle enciclopedie del sapere, ricche di erudizione messa<br />
al servizio di quanti volessero apprendere e di coloro<br />
che desiderassero approfondire o rivedere le proprie cognizioni<br />
f<strong>il</strong>osofiche e scientifiche” (Ammirati, p. 97).<br />
Le Quaestiones sono “un’opera colossale, una vera enciclopedia<br />
che per <strong>il</strong> vario contenuto e le f<strong>in</strong>alità che […]<br />
anticipano l’Illum<strong>in</strong>ismo, risponde a quesiti riguardanti<br />
le più disparate discipl<strong>in</strong>e e a domande le più strane e<br />
curiose, non ebbe, a quanto consta, altre edizioni oltre a<br />
quella veneziana, nonostante la grande considerazione<br />
<strong>in</strong> cui fu tenuta dagli studiosi del R<strong>in</strong>ascimento e dei<br />
secoli successivi. Erasmo nel 1519, scrivendo all’amico,<br />
dice di essere rimasto meravigliato per non aver avuto<br />
ragguagli su quell’opera: «De problematis rerum naturalium,<br />
quod opus iam olim habeas <strong>in</strong> manibus, admiror<br />
te nih<strong>il</strong> mem<strong>in</strong>isse…»” (Ammirati, pp. 139-140).<br />
La presente edizione risulta piuttosto accurata e lussuosa,<br />
se si considera <strong>il</strong> suo carattere di testo scientifico: <strong>il</strong><br />
frontespizio è stampato con <strong>in</strong>chiostro a due colori ed<br />
è impreziosito da un’elaborata cornice architettonica a<br />
35
motivi floreali <strong>in</strong> <strong>in</strong>chiostro blu, fatto assai <strong>in</strong>consueto<br />
nel panorama della stampa dei libri italiani del XVI secolo.<br />
Riccardi 332; Sander 3915; P. Manzi, Editori, tipografi e librai napoletani a<br />
Venezia nel secolo XVI,“La Bibliof<strong>il</strong>ia”, 1974, pp. 35-134 e 65-138; L.Ammirati,<br />
Ambrogio Leone nolano, Marigliano 1983.<br />
16 <br />
Leonico Tomeo, Niccolò (1456-1531). Nicolai<br />
Leonici Thomaei opuscula nuper <strong>in</strong> lucem aedita<br />
[...]. Venezia, Bernard<strong>in</strong>o Vitali, 23 febbraio 1525.<br />
In-4° (mm 196x136); 139 carte numerate (di cui la carta 74 è vuota),<br />
una carta bianca. Testo stampato <strong>in</strong> carattere romano, corsivo e greco.<br />
Frontespizio con titolo stampato <strong>in</strong> rosso racchiuso da una cornice ornata<br />
da elementi architettonici, figure animali ed antropomorfe, grottesche,<br />
elmi e scudi e da una piccola veduta <strong>in</strong> basso; nel testo cap<strong>il</strong>ettera<br />
s<strong>il</strong>ografici ornati ed animati e un gran numero di diagrammi geometrici<br />
ed astronomici; alla carta 41r la prima rappresentazione di uno strumento<br />
odontoiatrico. Richiami <strong>in</strong> greco e lat<strong>in</strong>o stampati ai marg<strong>in</strong>i del<br />
testo. Legatura coeva <strong>in</strong> pergamena floscia; titolo manoscritto <strong>in</strong> <strong>in</strong>chiostro<br />
marrone al dorso. Esemplare ottimamente conservato, ad ampi marg<strong>in</strong>i;<br />
lievi fioriture, un poco più marcate lungo <strong>il</strong> marg<strong>in</strong>e superiore di<br />
alcune carte.<br />
Rara prima edizione del commento ad alcune opere aristoteliche<br />
del veneziano Niccolò Leonico, discepolo di<br />
Demetrio Calcond<strong>il</strong>a, professore di greco e lat<strong>in</strong>o nello<br />
36
Studio padovano, dove lesse per la prima volta Aristotele<br />
sul testo orig<strong>in</strong>ale.“Conta<strong>in</strong>s the author’s commentaries<br />
on Aristoteles’ De animalium motu, De animalium <strong>in</strong>cessu,<br />
& Mechanica [with text], and an extract from Proclus’<br />
commentary on Plato’s Timeo” (Durl<strong>in</strong>g). La presenza<br />
di un fascicolo ‘I’ di quattro carte <strong>in</strong> alcuni<br />
esemplari sembrerebbe attestare l’esistenza di due tirature<br />
differenti, di cui, a rigor di logica, la nostra – priva della<br />
tabula – sarebbe la prima,considerando anche che molte<br />
bibliografie (Durl<strong>in</strong>g, Wellcome, etc.) non citano<br />
affatto l’ultimo quaderno <strong>in</strong> esame.<br />
Durl<strong>in</strong>g 2794;Wellcome 3744; Adams L, 502.<br />
17 <br />
[Passer<strong>in</strong>i, S<strong>il</strong>vio (1469-1529)]. Statuta Reverendissimi<br />
dom<strong>in</strong>i Sylvii Card<strong>in</strong>alis Cortonensis Legati.<br />
Perugia, Girolamo Cartolari per l’autore, 27 gennaio<br />
1526.<br />
In-4° (mm 210x140); 39 carte non numerate, una bianca. Esemplare<br />
stampato su pergamena.Al frontespizio grande s<strong>il</strong>ografia con le armi del<br />
Card<strong>in</strong>al S<strong>il</strong>vio Passer<strong>in</strong>i, al verso un legno raffigurante <strong>il</strong> grifone di Perugia;<br />
<strong>in</strong>iziali s<strong>il</strong>ografiche ornate. Splendida legatura perug<strong>in</strong>a, strettamente<br />
coeva, <strong>in</strong> marocch<strong>in</strong>o nocciola; piatti decorati a secco da una cornice<br />
a nodi che racchiude un’altra cornice romboidale ornata da ferri a<br />
‘X’.Tagli gialli, tracce di b<strong>in</strong>delle, custodia moderna. I fogli di guardia so-<br />
37
no costituiti da due frammenti membranacei di un manoscritto legale<br />
italiano del XIII/XIV secolo. Esemplare <strong>in</strong> buono stato di conservazione,<br />
fori di tarlo alle prime carte e al dorso della legatura.<br />
Al frontespizio nota di possesso manoscritta: “F<strong>il</strong>ippo Baldacch<strong>in</strong>i, 31<br />
gennaio 1526”.<br />
Copia di presentazione di questa rara edizione, stampata<br />
su pergamena, di proprietà del nipote del Passer<strong>in</strong>i, F<strong>il</strong>ippo<br />
Baldacch<strong>in</strong>i (fl. seconda metà del secolo XV, ca. 1530)<br />
– elogiato dallo zio nell’<strong>in</strong>troduzione – che appose la sua<br />
nota di possesso su questa copia degli Statuti solo quattro<br />
giorni dopo la sua pubblicazione. Il Baldacch<strong>in</strong>i fu autore<br />
di versi d’<strong>in</strong>trattenimento, venne favorito dagli ambienti<br />
ecclesiastici grazie al suo rapporto di parentela col<br />
Passer<strong>in</strong>i, tanto che fu eletto vescovo di Assisi nel 1526.<br />
La nota di possesso contemporanea alla stampa permette<br />
di attribuire la legatura del volumetto a un atélier perug<strong>in</strong>o.<br />
Biblioteca del Senato della Repubblica, Catalogo della raccolta di Statuti, V,<br />
p. 306; Sander 5571.<br />
18 <br />
Plautus,Titus Maccius (ca. 254-184 a.C). Cass<strong>in</strong>a,<br />
comedia di Plauto tradotta di lat<strong>in</strong>o <strong>in</strong> volgare,<br />
per Girolamo Berrardo Ferrarese […]. Venezia,<br />
Niccolò di Aristot<strong>il</strong>e detto Zopp<strong>in</strong>o, 1530.<br />
38
In-8° (mm 152x101); 62 carte mal numerate 54, una non numerata recante<br />
le note tipografiche, una carta bianca. Frontespizio stampato <strong>in</strong> rosso<br />
e nero con un ritratto s<strong>il</strong>ografico raffigurante l’autore, già apparso<br />
<strong>in</strong> alcune edizioni lat<strong>in</strong>e ciceroniane e ut<strong>il</strong>izzato ad effigiare l’erudito di<br />
Arp<strong>in</strong>o.Al verso della penultima carta marca tipografica dello Zopp<strong>in</strong>o,<br />
S. Nicola con la mitra seduto sulla cattedra episcopale, con la mano destra<br />
alzata, <strong>il</strong> pastorale nella s<strong>in</strong>istra e le tre palle d’oro sul libro (Z895).<br />
Legatura moderna <strong>in</strong> pergamena rigida. Esemplare <strong>in</strong> buono stato di<br />
conservazione, lievi gore.<br />
Prima edizione della traduzione volgare <strong>in</strong> terz<strong>in</strong>e del<br />
ferrarese Girolamo Berardo (fl. 1530) della Cas<strong>in</strong>a di<br />
Plauto.<br />
La commedia mette <strong>in</strong> scena le vicende di Cas<strong>in</strong>a (La<br />
fanciulla del caso), una trovatella che la buona Cleòstrata<br />
raccoglie e alleva <strong>in</strong> casa sua e della quale si <strong>in</strong>namorano<br />
padre e figlio; della situazione si accorge Cleòstrata,<br />
che cerca di distogliere <strong>il</strong> marito libert<strong>in</strong>o da quel desiderio<br />
<strong>in</strong>sano; questi, dopo aver proposto che la ragazza<br />
venga sposata da uno dei servi, suo o del figlio, traendola<br />
a sorte, fa <strong>in</strong> modo che favorito dalla sorte sia <strong>il</strong><br />
proprio servo. Si scopre poi che la fanciulla è figlia di<br />
un vic<strong>in</strong>o di casa, per cui non sarà più costretta a sposare<br />
un servo ma può liberamente sposare <strong>il</strong> figlio di<br />
Cleòstrata. A quest’opera di Plauto si ispirò nel 1525<br />
Machiavelli nella redazione della Clizia.<br />
Allacci 168; Clubb 164; Solle<strong>in</strong>ne I, 114; Salvioli 670 (“rara”); BMC 525;<br />
Adams P, 1524; Essl<strong>in</strong>g 1726; Sander 5754.<br />
39
19 <br />
Boccaccio, Giovanni (1313-1375). Fiammetta. Venezia,<br />
Bernardo di F<strong>il</strong>ippo Giunta, 1533.<br />
In-8° (mm 142x90); 110 carte con numerosi errori nella pag<strong>in</strong>azione,<br />
una carta bianca seguita da una carta recante, al verso, la marca tipografica<br />
dei Giunti (Z647). Legatura del sec. XVIII <strong>in</strong> mezza pelle con titolo<br />
<strong>in</strong> oro su tassello rosso al dorso. Esemplare <strong>in</strong> discreto stato di conservazione,<br />
lievi fioriture, marg<strong>in</strong>e superiore sobrio.<br />
Terza edizione giunt<strong>in</strong>a della Fiammetta del Boccaccio,<br />
che riprende la prima del 1517, e la successiva ristampa<br />
del 1524 ed è, come precisa <strong>il</strong> Gamba,“la prescelta dagli<br />
Accademici”(p. 64).<br />
Il libro “<strong>in</strong>teramente prosastico, […] nella formula più<br />
piena del suo titolo si chiama Elegia di madonna Fiammetta:<br />
«elegia» vale, secondo <strong>il</strong> De vulgari, «st<strong>il</strong>us miserorum»,<br />
e a ciò consuona l’<strong>in</strong>izio (: «suole a’ miseri crescere di dolersi<br />
vaghezza» ecc.). È <strong>in</strong>fatti <strong>il</strong> lamento d’un’abbandonata<br />
[…]. La gent<strong>il</strong>donna napoletana velata dal senhal di<br />
Fiammetta rievoca <strong>il</strong> suo subitaneo <strong>in</strong>namoramento d’un<br />
giovane designato come Panf<strong>il</strong>o (Pamph<strong>il</strong>us è <strong>il</strong> seduttore<br />
protagonista d’una famosa «commedia elegiaca» lat<strong>in</strong>a di<br />
Francia); ricorda la partenza di lui per Firenze, richiamato<br />
dal padre, e la sua non mantenuta promessa di tornare<br />
entro quattro mesi; m<strong>in</strong>utamente analizza <strong>il</strong> proprio stato<br />
d’animo quando l’amante si rivela spergiuro e allorché ne<br />
giungono più o meno <strong>in</strong>esatte notizie”. (G. Cont<strong>in</strong>i, Letteratura<br />
italiana delle orig<strong>in</strong>i, Firenze 1985, p. 722).<br />
4040
Bacchi della Lega, p. 111; Camer<strong>in</strong>i, n° 229; Renouard, p. LIV, n° 122;<br />
Gamba, n° 195.<br />
20 <br />
Ariosto, Ludovico (1474-1533). Comedia […] <strong>in</strong>titolata<br />
gli soppositi. Venezia, Nicolò di Aristot<strong>il</strong>e di<br />
Ferrara detto Zopp<strong>in</strong>o, 1538. (Legato con:) Idem. La<br />
Lena. Venezia, Nicolò di Aristot<strong>il</strong>e detto Zopp<strong>in</strong>o,<br />
1537. (Legato con:) Idem. Comedia […] <strong>in</strong>titolata<br />
Cassaria, con l’argumento aggiunto et non più<br />
stampato. Venezia, Nicolò di Aristot<strong>il</strong>e di Ferrara detto<br />
Zopp<strong>in</strong>o, 1538. (Legato con:) Idem. Il Negromante.<br />
Venezia, Nicolò di Aristot<strong>il</strong>e detto Zopp<strong>in</strong>o, 1538.<br />
(Legato con:) Epicuro, Marcantonio (1472-1555).<br />
Cecaria.Tragicommedia del Epicuro Napoletano<br />
[…]. Venezia, Nicolò d’Aristot<strong>il</strong>e detto Zopp<strong>in</strong>o, gennaio<br />
1535. (Legato con:) Dolce, Lodovico (1508-<br />
1568). Il ragazzo. Venezia, Francesco di Alessandro<br />
B<strong>in</strong>doni & Mapheo Pas<strong>in</strong>i, 1541.<br />
Sei opere legate <strong>in</strong> un volume <strong>in</strong>-8° (mm 154x95). I: 34 carte numerate,<br />
due bianche. II: 32 carte non numerate. III: due carte non numerate,<br />
34 numerate 3-36. IV: 35 carte non numerate, una bianca. V: 32 carte non<br />
numerate, di cui l’ultima bianca. VI: 55 carte numerate, una bianca.<br />
Ritratto s<strong>il</strong>ografico di Ludovico Ariosto al frontespizio delle prime quattro<br />
opere. Il legno è tratto dal famoso disegno del Tiziano e apparve anche<br />
nel Furioso del 1532. S<strong>il</strong>ografia rappresentante i tre ciechi al fronte-<br />
41
spizio e alla carta C6v della Cecaria del Marsi, al colophon della stessa<br />
opera marca tipografica dello Zopp<strong>in</strong>o (Z897). Al frontespizio dell’ultima<br />
opera marca tipografica del B<strong>in</strong>doni (U166). Legatura ottocentesca<br />
<strong>in</strong> vitello nocciola, doppia cornice di f<strong>il</strong>etti dorati ai piatti, titolo e decorazioni<br />
<strong>in</strong> oro al dorso, dentelles <strong>in</strong>terne, guardie <strong>in</strong> carta marmorizzata,<br />
tagli rossi. Esemplare <strong>in</strong> buono stato di conservazione, accuratamente<br />
lavato.<br />
Ex libris “R. Clayton Browne”.<br />
I: Seconda edizione di questa commedia <strong>in</strong> prosa uscita<br />
dai torchi dello Zopp<strong>in</strong>o e nona assoluta (la pr<strong>in</strong>ceps è<br />
del 1525). L’opera venne rappresentata per la prima volta<br />
a Ferrara nel 1509, e nel 1519 a Roma <strong>in</strong> onore di<br />
papa Leone X. Edizione “assai elegante e rara, che <strong>il</strong> catalogo<br />
Manzoni del 1892 dichiarava «édit. <strong>in</strong>connue»,<br />
mentre <strong>in</strong>vece era già stata citata sia dal Gamba, sia dal<br />
Graesse” (Agnelli-Ravegnani). L’opera è particolarmente<br />
importante dal punto di vista letterario poiché vi si<br />
ispirò W<strong>il</strong>liam Shakespeare, che probab<strong>il</strong>mente conosceva<br />
la traduzione <strong>in</strong>glese - stampata per la prima volta<br />
nel 1566 -, per <strong>il</strong> suo Tam<strong>in</strong>g of the shrew. II: Rara edizione<br />
di questa commedia messa <strong>in</strong> scena per la prima<br />
volta durante <strong>il</strong> carnevale di Ferrara del 1528. Si tratta<br />
della seconda edizione della Lena uscita dai torchi dello<br />
Zopp<strong>in</strong>o e risulta “<strong>in</strong> tutto sim<strong>il</strong>issima alla prima”<br />
(Agnelli-Ravegnani), risalente al 1535. III: Edizione non<br />
comune di questa commedia <strong>in</strong> prosa. La pr<strong>in</strong>ceps assoluta<br />
della Cassaria, priva di note tipografiche, risale ai<br />
primi anni del XVI secolo. La presente edizione, pur essendo<br />
la seconda stampata dallo Zopp<strong>in</strong>o, è piuttosto<br />
42
particolare poiché presenta per la prima volta “l’Argumento<br />
<strong>in</strong> versi, che poi, <strong>in</strong> successive stampe, diventerà <strong>il</strong><br />
Prologo della commedia” (Agnelli-Ravegnani). La Cassaria<br />
venne rappresentata per la prima volta alla corte di<br />
Ferrara nel 1508, essa è da considerarsi una delle prime<br />
commedie appartenenti al genere cosiddetto “regolare”<br />
o “erudito”, che presentava cioè degli elementi moderni<br />
e realistici rispetto a quelli tradizionali della commedia<br />
lat<strong>in</strong>a. Pellegr<strong>in</strong>o da Ud<strong>in</strong>e ideò la scenografia e a<br />
questo riguardo è <strong>in</strong>teressante ricordare che è proprio<br />
alla rappresentazione di questa commedia che si riferiscono<br />
le prime notizie su una nuova forma di allestimento:<br />
la scenografia prospettica. IV:“Edizione […] rarissima.<br />
Essa non è che la ristampa della zopp<strong>in</strong>iana del<br />
1535, se non è addirittura la medesima, con la data modificata”<br />
(Agnelli-Ravegnani). La pr<strong>in</strong>ceps assoluta risale<br />
al 1530 circa ed è priva di note tipografiche. La commedia<br />
venne rappresentata per la prima volta <strong>in</strong><br />
occasione del carnevale di Ferrara del 1529. V: Seconda<br />
edizione stampata dallo Zopp<strong>in</strong>o di questa commedia,<br />
sostanzialmente identica a quella pubblicata nel 1532,<br />
dalla quale viene ripreso <strong>il</strong> legno raffigurante i tre ciechi.<br />
Il titolo Cecaria è quello che viene adottato nelle<br />
edizioni successive alle prime due (nelle quali era ancora<br />
<strong>in</strong>titolata Dialogo di tre ciechi), mentre <strong>il</strong> testo è quello<br />
recante l’aggiunta del Lamento del geloso e della Lum<strong>in</strong>aria.<br />
“La Cecaria […] fu <strong>il</strong> primo componimento drammatico<br />
che avesse <strong>il</strong> titolo di Tragicommedia, titolo dal<br />
Marsi preso ad un genere teatrale spagnolo […]. Il ver-<br />
43
so del Marsi ha <strong>in</strong>oltre <strong>il</strong> gran merito, merito spesso<br />
mancante a’ suoi contemporanei, di essere spontaneo e<br />
piano, spesso tanto armonioso da rivaleggiare co’ versi<br />
dello stesso Sannazzaro di cui <strong>il</strong> Marsi è onesto e <strong>in</strong>telligente<br />
imitatore […]” (I drammi pastorali di Antonio Marsi...,<br />
vol. I, pp. 74-78). VI: Seconda edizione assoluta –<br />
la prima venne stampata, nello stesso anno e sempre a<br />
Venezia, da Curzio di Navò – della prima commedia<br />
scritta dal Dolce. Il Ragazzo può essere considerato <strong>il</strong> lavoro<br />
teatrale del Dolce che riscosse maggior successo e<br />
che ebbe fortuna duratura. Come asserisce l’autore stesso,<br />
nell’<strong>in</strong>troduzione all’opera, essa non fu “rubata dagli<br />
antichi, o trovata dall’<strong>in</strong>gegno dei moderni come le altre<br />
sono, ma, poco fa, avenuta <strong>in</strong> Roma” (c2v). Questo<br />
testo appartiene al genere della commedia erudita c<strong>in</strong>quecentesca<br />
e, se l’idea è tratta dalla Cas<strong>in</strong>a di Plauto e<br />
non vi mancano alcuni accenni anche alla Clizia del<br />
Machiavelli, lo sv<strong>il</strong>uppo dell’azione può non a torto esser<br />
considerato idea orig<strong>in</strong>ale del Dolce.<br />
I:Agnelli-Ravegnani II, p. 100; Gamba 69 (nota); Sander 538. II:Agnelli-<br />
Ravegnani II, p. 112; Sander 539. III: Agnelli-Ravegnani II, pp. 86-87;<br />
Gamba 67 (nota); Sander 536. IV: Agnelli-Ravegnani II, p. 122; Sander<br />
543. V: Sander 1655; I drammi pastorali di Antonio Marsi, detto l’Epicuro napoletano,<br />
a cura di Italo Palmar<strong>in</strong>i, Bologna 1888, vol. II,n° IX. VI: Gamba<br />
1358 (nota); Abd-el-Kader Salza, Delle commedie di Lodovico Dolce,<br />
Melfi 1899, p. 69; cfr. anche R. H.Terpen<strong>in</strong>g, Lodovico Dolce, Renaissance<br />
man of letters,Toronto 1997, pp. 67-83.<br />
44
21 <br />
Plat<strong>in</strong>a, Bartolomeo Sacchi de (1421-1481). Delle<br />
vite et fatti di tutti i sommi Pontefici romani,<br />
com<strong>in</strong>ciando da Christo <strong>in</strong>f<strong>in</strong>o a Sisto quarto.<br />
Con la giunta di tutti gli altri Pontefici, <strong>in</strong>f<strong>in</strong>o a<br />
Paulo terzo Pontefice Massimo. Venezia, Michele<br />
Tramezz<strong>in</strong>o, 1543.<br />
In-4° (mm 242x158); 4 carte non numerate, 243 carte erroneamente<br />
numerate 239, una bianca. Al frontespizio e al verso dell’ultima carta<br />
marca tipografica del Tramezz<strong>in</strong>o raffigurante una Sib<strong>il</strong>la seduta, racchiusa<br />
<strong>in</strong> cornice figurata, che tiene con <strong>il</strong> braccio s<strong>in</strong>istro un libro e sulle<br />
g<strong>in</strong>occhia un altro; <strong>in</strong> basso la scritta:“Syb<strong>il</strong>la” (Z1074). Splendida legatura<br />
coeva veneziana <strong>in</strong> marocch<strong>in</strong>o rosso; piatti <strong>in</strong>quadrati da una<br />
serie di cornici a secco e dorate, al centro cartouche composta da f<strong>il</strong>etti<br />
curvi e arabeschi a racchiudere un medaglione circolare contenente, nel<br />
piatto anteriore, <strong>il</strong> nome “P.LANDO”, <strong>in</strong> quello <strong>in</strong>feriore <strong>il</strong> suo titolo “AR-<br />
CHI.CRETE”. Dorso a sette nervi con compartimenti decorati a secco, tagli<br />
dorati e goffrati. Esemplare <strong>in</strong> ottimo stato di conservazione. Lunga<br />
nota di possesso al frontespizio datata 1704 <strong>in</strong> cui si <strong>in</strong>dica <strong>il</strong> presente<br />
esemplare come proveniente dalla biblioteca di Pietro Lando.<br />
Ex libris <strong>in</strong>ciso di Lord Vernon.<br />
Splendida copia di presentazione stampata su carta forte.<br />
Esemplare legato per Pietro III Lando, arcivescovo di<br />
Creta (1535-1583), al quale è dedicata la presente prima<br />
traduzione dal lat<strong>in</strong>o delle Vite dei pontefici del Plat<strong>in</strong>a.<br />
Il traduttore cont<strong>in</strong>uatore delle biografie plat<strong>in</strong>iane<br />
fu probab<strong>il</strong>mente Lucio Fauno, che è menzionato<br />
nel priv<strong>il</strong>egio di stampa papale di altre opere del Tra-<br />
45
mezz<strong>in</strong>o dello stesso periodo. La legatura è un lavoro<br />
giovan<strong>il</strong>e del cosiddetto “Wanderbuchb<strong>in</strong>der”, def<strong>in</strong>ito<br />
così da Schunke (III pp. 163-69), di cui si identifica la<br />
mano <strong>in</strong> vari ferri che circondano <strong>il</strong> medaglione centrale<br />
e altri motivi decorativi fitomorfi alle cornici e nei<br />
pannelli esterni. L’enigmatico legatore fu def<strong>in</strong>ito da<br />
Foot “Venetian Apple B<strong>in</strong>dery”, la sua attività a Venezia<br />
nel corso del secolo XVI è ben documentab<strong>il</strong>e (cfr.<br />
De Mar<strong>in</strong>is II, C50-51, CCCXLVIII, CCCL, CCCLXXXIX).<br />
T<strong>in</strong>to, n° 24; I. Schunke, Beitrage zum Rollen und Plattene<strong>in</strong>-band im 16.<br />
Jahrhundert,Wiesbaden 1968;T. De Mar<strong>in</strong>is, La legatura artistica <strong>in</strong> Italia nei<br />
secoli 15 e 16, Firenze 1960; M. Foot, Studies <strong>in</strong> the history of bookb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g,<br />
Aldershot 1993.<br />
22 <br />
Alighieri, Dante (1265-1321). La Comedia di<br />
Dante Aligieri con la nova espositione di Alessandro<br />
Vellutello. Venezia, Francesco Marcol<strong>in</strong>i, 1544.<br />
In-4° (mm 224x149); 442 carte non numerate, alcune carte dei fascicoli<br />
BH e BI <strong>in</strong>vertite, ma tutte presenti.Tre s<strong>il</strong>ografie a piena pag<strong>in</strong>a e vignette<br />
ad ogni canto. Le <strong>in</strong>cisioni <strong>in</strong> legno sono attribuite allo stesso<br />
Marcol<strong>in</strong>i e vennero riprodotte dal Sessa nelle sue tre edizioni dette “del<br />
Nasone”. Legatura settecentesca <strong>in</strong> pergamena rigida; titolo <strong>in</strong> oro su tassello<br />
<strong>in</strong> marocch<strong>in</strong>o rosso al dorso. Esemplare <strong>in</strong> buono stato di conservazione,<br />
antichi restauri alle prime tre carte senza perdita di testo.<br />
46
Prima edizione della Commedia stampata dal Marcol<strong>in</strong>i,<br />
di fondamentale importanza f<strong>il</strong>ologica per la presenza<br />
del nuovo commento,<strong>il</strong> primo del C<strong>in</strong>quecento,del letterato<br />
lucchese Alessandro Vellutello, già autore di un<br />
fortunato commento a Petrarca, che si oppone polemicamente<br />
alla lezione bembiana a favore di un r<strong>in</strong>novato<br />
aristotelismo. “Essa è giudicata una delle migliori<br />
edizioni antiche <strong>in</strong> carattere italiano ed è dedicata a<br />
Paolo III. L’autore del commento vi ha premesso la vita<br />
del Poeta e nel proemio parla con spregio della prima<br />
edizione ald<strong>in</strong>a che giudica <strong>in</strong>correctissima” (Mambelli,<br />
p. 43). Secondo <strong>il</strong> Volkmann si può addirittura parlare<br />
della presente come della “prima edizione moderna<br />
del C<strong>in</strong>quecento”, ed <strong>in</strong>vero i legni che la arricchiscono,<br />
e che vengono ascritti al genio del Marcol<strong>in</strong>i, apportano<br />
alcune <strong>in</strong>novazioni figurative senza precedenti<br />
nell’iconografia dantesca.“Egli dovette assim<strong>il</strong>are <strong>il</strong> Poema,<br />
mettendosi negli occhi e nel cuore del Poeta e creò<br />
delle figurazioni di un Inferno visto dall’alto, dove non<br />
sai se ammirare maggiormente l’arditezza del disegno o<br />
la vivente espressività. La lotta del bul<strong>in</strong>o di quell’uomo<br />
geniale con la grandezza della materia per esprimere l’eterea<br />
sostanza del Paradiso, passa per fasi diverse con varia<br />
fortuna, f<strong>in</strong>ché, <strong>in</strong> qualcuna delle ultime figurazioni,<br />
la forma circolare trapunta di stelle e radiante di l<strong>in</strong>ee<br />
tendenti all’<strong>in</strong>f<strong>in</strong>ito riesce a darci <strong>il</strong> senso profondo delle<br />
cose div<strong>in</strong>e ed eterne” (Morich<strong>in</strong>i, La raccolta dantesca<br />
Mackenzie, p. 10).<br />
47
De Bat<strong>in</strong>es I, pp. 82-84; Mambelli 30; Casali 72;Adams D,94; Essl<strong>in</strong>g 545;<br />
Sander 2328; Mortimer, Italian, 146; Gamba 387.<br />
23 <br />
Aelianus, Claudius (ca. 170-235 d. C.). (Greco) Variae<br />
historiae libri XIIII. Ex Eraclide de rebus publicis<br />
commentarium. Polemonis Physionomia.<br />
Adamantii Physionomia. Melampodis ex Palpitationibus<br />
div<strong>in</strong>atio. De nevis. Roma, [Antonio Blado],<br />
gennaio 1545.<br />
In-4° (mm 210x148); 4 carte non numerate, 111 numerate, 11 non numerate,<br />
una bianca, l’ultima con la marca tipografica e le note tipografiche.<br />
Carattere greco corsivo. Al frontespizio e al verso dell’ultima carta<br />
marca tipografica del Blado raffigurante un uomo nudo con cappello che<br />
tiene un mazzo di fiori e versa farro su un’ara votiva (Z671). Legatura<br />
coeva <strong>in</strong> pergamena floscia, tracce di b<strong>in</strong>delle. Esemplare <strong>in</strong> buono stato<br />
di conservazione, piccolo strappo restaurato al marg<strong>in</strong>e superiore bianco<br />
del frontespizio.<br />
Ex libris “Erik Carlson”.<br />
Editio pr<strong>in</strong>ceps curata da Cam<strong>il</strong>lo Perusco. Questa raccolta<br />
eterogenea di testi di f<strong>il</strong>osofia morale, di retorica, di<br />
religione e di superstizione fu scritta da Claudio Eliano<br />
di Preneste per divulgare gli scritti classici dimenticati,<br />
perduti o poco noti. Il trattato sulla frenologia di Melampode<br />
e quelli di fisiognomica di Polemone – identificato<br />
da R. Forster nel suo De Aristotelis quae feruntur<br />
48
23. Aelianus, Claudius
15. Leone, Ambrogio
15. Leone,Ambrogio
21. Plat<strong>in</strong>a, Bartolomeo Sacchi de
21. Plat<strong>in</strong>a, Bartolomeo Sacchi de
20. Ariosto, Ludovico
20. Epicuro, Marcantonio
26. Medici, Lorenzo de
physiognomicis recensendis (Kiel 1882), come l’autore del<br />
trattato fisiognomico attribuito ad Aristotele – ed Adamantio<br />
sono qui pubblicati per la prima volta.<br />
Catalogo delle edizioni dei Blado, 1523; Ascarelli, Le C<strong>in</strong>quecent<strong>in</strong>e Romane,<br />
2; STC Italian, 7; Adams A, 221; Durl<strong>in</strong>g 42;Thorndike II, 266.<br />
24 <br />
Gelli, Giovanni Battista (1498-1563). Il Gello sopra<br />
un sonetto di M. Franc. Petrarca. Firenze, [Lorenzo<br />
Torrent<strong>in</strong>o], 1549.<br />
In-8° (mm 170x93); 89 pag<strong>in</strong>e numerate, tre pag<strong>in</strong>e bianche (la pag<strong>in</strong>a<br />
87 erroneamente numerata 78). Frontespizio con titolo racchiuso <strong>in</strong> una<br />
cornice s<strong>il</strong>ografica a motivi architettonici, al centro lo stemma dei Medici<br />
sormontato da una corona e, racchiuso <strong>in</strong> un cartiglio, <strong>il</strong> motto “<strong>in</strong>clita<br />
prole” (Z1141). Al verso della prima carta un legno col ritratto del<br />
Gelli; capolettera s<strong>il</strong>ografico animato alla prima pag<strong>in</strong>a di testo. Legatura<br />
ottocentesca <strong>in</strong> mezza pelle con piatti <strong>in</strong> carta ca<strong>il</strong>louté molto usurata,<br />
soprattutto alle cerniere. Esemplare <strong>in</strong> buono stato di conservazione,<br />
alcune fioriture e tracce di umidità, più marcate al frontespizio.<br />
Prima edizione di questa Lettura del Gelli sul sonetto<br />
petrachesco O tempo, o ciel volub<strong>il</strong> (Canzoniere CCCLV),<br />
dedicata dall’autore a “S<strong>il</strong>via Tornella Contessa Buonromea”.<br />
Il Gelli fu letterato, fondatore dell’Accademia Fiorent<strong>in</strong>a<br />
e console dell’Accademia della Crusca. Fu tradutto-<br />
49
e di Simone Porzio e di Euripide, nonché dantista, f<strong>il</strong>osofo,<br />
commediografo e l<strong>in</strong>guista. Questa lettura, divisa<br />
<strong>in</strong> tre parti o lezioni che vennero recitate nell’Accademia<br />
Fiorent<strong>in</strong>a, venne riprodotta dal Torrent<strong>in</strong>o nel<br />
1551 nel volume che raccoglieva tutte le lezioni accademiche<br />
tenute dal Gelli.<br />
Moreni, Annali della tipografia fiorent<strong>in</strong>a di Lorenzo Torrent<strong>in</strong>o, pp. 75-76;<br />
Gamba 501.<br />
25 <br />
Stracca, Benvenuto (1509-1578). Clarissimi iurisconsulti<br />
Benvenuti Stracchae [...] De mercatura,<br />
seu mercatore tractatus. Venezia, [Paolo Manuzio],<br />
1553.<br />
In-8° (mm 154x103); 40 carte non numerate (di cui le ultime tre bianche),<br />
287 carte numerate con molti errori di pag<strong>in</strong>azione, manca l’ultima<br />
carta bianca. Al frontespizio marca tipografica di Paolo Manuzio:<br />
un’àncora accollata da un delf<strong>in</strong>o <strong>in</strong> cornice figurata sorretta da due putti,<br />
che è una variante non censita di Z42, poiché risulta essere identica<br />
ad essa eccetto per <strong>il</strong> fatto che non reca all’<strong>in</strong>terno della cornice la scritta<br />
“Aldi f<strong>il</strong>ii”. Iniziali s<strong>il</strong>ografiche animate. Legatura <strong>in</strong> pergamena coeva<br />
con unghie, molto usurata; dorso mancante, tracce di b<strong>in</strong>delle. Esemplare<br />
<strong>in</strong> discreto stato di conservazione.Tracce di umidità alle prime e alle<br />
ultime carte. Antiche note di possesso manoscritte al frontespizio e sui<br />
fogli di guardia all’<strong>in</strong>izio e alla f<strong>in</strong>e del volume.<br />
50
Prima edizione del primo trattato sistematico di diritto<br />
commerciale e di assicurazione, con particolare riguardo<br />
al diritto fallimentare e a quello marittimo. Si tratta<br />
dell’opera pr<strong>in</strong>cipale dello Stracca, giurista orig<strong>in</strong>ario di<br />
Ancona che ricoprì importanti cariche pubbliche. L’autore<br />
fu <strong>il</strong> primo a considerare <strong>il</strong> diritto commerciale come<br />
un complesso di norme dist<strong>in</strong>te da quelle del diritto<br />
civ<strong>il</strong>e.<br />
Renouard p. 156, n° 6 (“Ce volume imprimé en petites lettres rondes<br />
est rare”); Ahmanson-Murphy 444; Goldsmiths 52; E<strong>in</strong>audi 5491.<br />
26 <br />
Medici, Lorenzo de (1427-1492). Poesie volgari.<br />
Venezia, Paolo Manuzio, 1554.<br />
In-8° (mm 165x95); 205 carte numerate, tre carte non numerate. Àncora<br />
ald<strong>in</strong>a al frontespizio (A15) e al verso dell’ultima carta (A12), cap<strong>il</strong>ettera<br />
s<strong>il</strong>ografici animati. Legatura italiana settecentesca <strong>in</strong> pergamena rigida,<br />
tassello al dorso con titolo <strong>in</strong> oro. Esemplare <strong>in</strong> buono stato di<br />
conservazione.<br />
Prima edizione, stampata <strong>in</strong> carattere italico, delle poesie<br />
del Magnifico, contenente <strong>il</strong> Canzoniere, le Stanze,le<br />
Laudi, e <strong>il</strong> Commento de’ miei sonetti. L’edizione ald<strong>in</strong>a,<br />
considerata la vera e ufficiale prima edizione del Canzoniere<br />
e di gran parte dell’opera laurenziana (cfr. Lo-<br />
51
enzo de’ Medici, Canzoniere, Tiziano Zanato, Firenze<br />
1991, sigla A, t. I, pp. 324-334), presenta – come viene<br />
<strong>in</strong>dicato nel registro – <strong>il</strong> fascicolo O <strong>in</strong> secondo stato di<br />
quattro carte, tuttavia sono noti alcuni rari esemplari<br />
aventi tale fascicolo di otto carte. Secondo <strong>il</strong> Renouard<br />
la scelta di omettere le c<strong>in</strong>que canzoni non dipese da<br />
una censura esercitata da Paolo Manuzio durante la<br />
stampa, ma da una semplice decisione tipografica; oggi<br />
<strong>in</strong>fatti gli studi di Raffaella Castagnola ipotizzano che le<br />
poesie non fossero state <strong>in</strong>cluse perché non corrispondenti<br />
ad un quadro omogeneo.<br />
Renouard p. 162, n° 23; Gamba 648; Ahmanson-Murphy 473, 473.5;<br />
Lorenzo de’ Medici, Stanze, Raffaella Castagnola, Firenze 1986, St. 7,<br />
pp. LVIII-LXI; Lorenzo de’ Medici, Laude, Bernard Toscani, Firenze 1990,<br />
A1, p. 20.<br />
27 <br />
Gelli, Giovanni Battista (1498-1563). Lettura<br />
quarta sopra l’Inferno di Dante […]. Firenze, [Lorenzo<br />
Torrent<strong>in</strong>o], 1558.<br />
In-8° (mm 161x101); 238 pag<strong>in</strong>e numerate erroneamente 237, una non<br />
numerata.Al frontespizio la marca tipografica del Torrent<strong>in</strong>o, lo stemma<br />
Medici <strong>in</strong> cornice (Z1142); due cap<strong>il</strong>ettera s<strong>il</strong>ografici ornati nel testo.Legatura<br />
<strong>in</strong> cartonato moderno con titolo scritto <strong>in</strong> <strong>in</strong>chiostro marrone al<br />
dorso. Esemplare <strong>in</strong> buono stato di conservazione, lievi fioriture, un foro<br />
di tarlo alle ultime tre carte.<br />
Ex libris “Petri G<strong>in</strong>ori-Conti”.<br />
52
Prima edizione del quarto ciclo di lezioni dantesche,<br />
che <strong>il</strong> Gelli tenne nel 1557 al cospetto dell’Accademia<br />
Fiorent<strong>in</strong>a. La lettura è dedicata dall’autore al “Nob<strong>il</strong>e,<br />
et Virtuoso F<strong>il</strong>ippo del Migliore cittad<strong>in</strong>o Fiorent<strong>in</strong>o”,<br />
che fu Provveditore dello studio di Pisa e che viene nom<strong>in</strong>ato<br />
con lode anche dal Giovio nelle sue Historie.<br />
Il volume “contiene X lezioni” ed “è assai diffic<strong>il</strong>e da ritrovarsi”<br />
(Gamba).<br />
Moreni, Annali della tipografia fiorent<strong>in</strong>a di Lorenzo Torrent<strong>in</strong>o, p. 302;<br />
Adams G, 337; Gamba 508.<br />
28 <br />
Caràvia,Alessandro (1503-1568). Naspo Bizaro nuovamente<br />
restampao, con la zonta del lamento chel<br />
fa per haverse pentio de haver sposao Cate Bionda<br />
Biriotta. Venezia, Pietro di Domenico, [ca. 1570].<br />
In-4° (mm 201x140); 43 carte numerate, una bianca. Frontespizio <strong>il</strong>lustrato<br />
da un legno – ripreso dalla pr<strong>in</strong>ceps del 1565 – raffigurante <strong>il</strong> Naspo<br />
Bizaro <strong>in</strong>tento a fare una serenata, lo stesso legno è ripetuto alla carta<br />
F2v.Alle carte D2v e H4r un’altra <strong>il</strong>lustrazione s<strong>il</strong>ografica raffigurante<br />
un gruppo di uom<strong>in</strong>i <strong>in</strong>tenti a fare una serenata sotto ad un balcone; entrambi<br />
i legni sono firmati con le <strong>in</strong>iziali ‘AL’. Cap<strong>il</strong>ettera s<strong>il</strong>ografici nel<br />
testo, al verso della carta L3 marca tipografica di Pietro di Domenico raffigurante<br />
una pigna con rametto <strong>in</strong>corniciata da una ghirlanda, all’<strong>in</strong>terno<br />
le <strong>in</strong>iziali ‘M.P’ (U364). Legatura <strong>in</strong>glese <strong>in</strong> marocch<strong>in</strong>o verde con<br />
elaborate decorazioni <strong>in</strong> oro ai piatti, titolo <strong>in</strong> oro al dorso, tagli dorati,<br />
53
guardie <strong>in</strong> carta marmorizzata a pett<strong>in</strong>e. Esemplare accuratamente lavato<br />
<strong>in</strong> buono stato di conservazione.<br />
Esemplare G. Libri, descritto nel Catalogo della sua asta del 1847.<br />
Seconda edizione assoluta di questo poemetto <strong>in</strong> ottava<br />
rima, opera del gioielliere veneziano Alessandro Caràvia,<br />
e la prima <strong>in</strong> cui compaia una novità importante,<br />
un’appendice def<strong>in</strong>ita col nuovo titolo di “zonta”, contenente<br />
<strong>il</strong> Lamento <strong>in</strong> terz<strong>in</strong>e del Naspo e dest<strong>in</strong>ata ad<br />
entrare nelle copiosa tradizione a stampa successiva.<br />
“Tutti concordano nel riconoscere <strong>il</strong> valore del Naspo bizaro<br />
per la storia del costume e della cultura. Alessandro<br />
Caravia non è uomo privo di lettere né <strong>in</strong>sensib<strong>il</strong>e al fasc<strong>in</strong>o<br />
dell’arte e delle cose belle. Fa grande stima degli<br />
antichi, ai quali ricorre sempre «chi d’ogni virtù vuol far<br />
discorso». Conosce Dante, non si contenta di citare <strong>il</strong> «rarissimo<br />
Petrarca» e le sue rime, ma anche lo imita e traveste;<br />
ricorda l’Ariosto e i personaggi del Furioso; sa di<br />
Morgante e di Margutte. Apprezza i grandi artisti contemporanei,<br />
corrisponde con l’Aret<strong>in</strong>o, è ammesso alle<br />
conversazioni del dotto patriarca d’Aqu<strong>il</strong>eia Giovanni<br />
Grimani, si compiace dell’amicizia d’altri cultori delle<br />
Muse.Tutto questo non gl’impedisce d’accostarsi ai verseggiatori<br />
buffoneschi del suo tempo (non sempre, d’altronde,<br />
sforniti di cognizioni letterarie) né di mettere <strong>il</strong><br />
Naspo bizaro sotto gli auspici del celebre buffone Zuan<br />
Polo e dell’improvvisatore Mario Bernia, palesando così<br />
<strong>il</strong> carattere e gli <strong>in</strong>tenti del poemetto. Manifeste sono le<br />
att<strong>in</strong>enze di Naspo, vecchio <strong>in</strong>namorato, e di Cate bion-<br />
54
da, donna di partito, che si fa beffe di lui, con personaggi<br />
del teatro comico c<strong>in</strong>quecentesco […]. In Naspo <strong>il</strong> tipo<br />
del vecchio, progenitore di Pantalone, si fonde con<br />
quello del soldato m<strong>il</strong>lantatore; e tutto <strong>il</strong> poemetto non<br />
è che una successione di smanie amorose e risib<strong>il</strong>i spacconate,<br />
ch’è fac<strong>il</strong>e immag<strong>in</strong>are sottol<strong>in</strong>eate nella lettura o<br />
recitazione dai «gesti grotteschi e dalle smorfie» care ai<br />
buffoni e canter<strong>in</strong>i delle piazze non meno che agli attori<br />
della commedia improvvisata. Ai buffoni e canter<strong>in</strong>i,<br />
legati con più f<strong>il</strong>i alla tradizione popolare, <strong>il</strong> Caravia ha<br />
tolto a prestito formule <strong>in</strong>troduttive e di commiato, motivi<br />
poetici e paremiologici, richiami seri e burleschi,<br />
accenni di attualità, zeppe per puntellare un verso claudicante.<br />
Ma alle fonti popolari egli att<strong>in</strong>se anche direttamente,<br />
ascoltando i canti di cui, alla sera, risonavano i<br />
campielli. Ha aggiunto di suo una notevole ab<strong>il</strong>ità di variazioni;<br />
immag<strong>in</strong>i e sentenze suggeritegli dall’arte di<br />
gioielliere professata con <strong>in</strong>timo consenso, e un grano di<br />
compunzione <strong>in</strong> cui, tra i lazzi, affiora <strong>il</strong> fondo austeramente<br />
religioso della sua natura.” (Vidossi, pp.49-51).<br />
G. Libri, Cat. 1847, n° 1667; Brunet, IV, 15-16; Gamba, Serie degli impressi<br />
<strong>in</strong> dialetto veneziano,Venezia 1832, p. 83; G.Vidossi, Note al «Naspo Bizaro»,<br />
<strong>in</strong> Saggi e scritti m<strong>in</strong>ori di folklore, Tor<strong>in</strong>o 1960; E. Ben<strong>in</strong>i Clementi,<br />
Riforma religiosa e poesia popolare a Venezia nel C<strong>in</strong>quecento: Alessandro Caravia,<br />
Firenze 2000.<br />
55
29 <br />
[Novell<strong>in</strong>o]. Libro di novelle, et di bel Parlar<br />
Gent<strong>il</strong>e. Nel qual si contengono Cento Novelle<br />
altra volta mandate fuori da Messer Carlo Gualteruzzi<br />
da Fano. Di nuovo ricorrette. Con aggiunta<br />
di quattro altre nel f<strong>in</strong>e. Et una dichiarazione<br />
delle voci più antiche. Firenze, Giunti, 1572.<br />
In-4° (mm 204x138); 13 carte non numerate, una carta bianca, 165 pag<strong>in</strong>e<br />
numerate 2-153, con svariati errori nella pag<strong>in</strong>azione, una carta non<br />
numerata. Al frontespizio marca tipografica dei Giunti (Z653) raffigurante<br />
un giglio fiorent<strong>in</strong>o <strong>in</strong> cornice figurata; al verso dell’ultima carta<br />
variante della marca tipografica giunt<strong>in</strong>a (Z650). Bei cap<strong>il</strong>ettera s<strong>il</strong>ografici<br />
animati ed ornati nel testo. Legatura moderna <strong>in</strong> mezza pergamena<br />
con angoli, titolo <strong>in</strong> oro al dorso su tassello <strong>in</strong> pelle nocciola. Esemplare<br />
<strong>in</strong> buono stato di conservazione, lievi gore su alcune carte, piccolo strappo<br />
al marg<strong>in</strong>e esterno del frontespizio.<br />
“Ex libris Sordelli”.<br />
Importante edizione della raccolta di novelle che era<br />
stata pubblicata per la prima volta a Bologna nel 1525<br />
da Girolamo Benedetti e curata dal letterato fanese Carlo<br />
Gualteruzzi su esortazione del Bembo.<br />
Sebbene negli anni che <strong>in</strong>tercorrono tra la stampa della<br />
pr<strong>in</strong>ceps e quella dell’edizione giunt<strong>in</strong>a <strong>il</strong> testo venga<br />
pubblicato altre due volte, è con questa edizione fiorent<strong>in</strong>a,<br />
curata da V<strong>in</strong>cenzo Borgh<strong>in</strong>i – che diede una<br />
lezione differente del testo basandosi su alcuni codici<br />
del XIII secolo – che <strong>in</strong>izia la discussione sull’omogeneità<br />
della raccolta, sulla sua antichità e su chi ne fosse<br />
56
l’autore. Il Borgh<strong>in</strong>i <strong>in</strong>fatti, oltre ad offrire un testo alquanto<br />
differente da quello delle edizioni precedenti,<br />
aggiunse, alla f<strong>in</strong>e, quattro novelle, tre delle quali erano<br />
già state pubblicate dai Giunti nel Decameron del 1516.<br />
“La rarità dell’edizione bolognese e l’autorità di monsignor<br />
V<strong>in</strong>cenzo Borgh<strong>in</strong>i, procuraron da prima assai<br />
fortuna al testo giunt<strong>in</strong>o del 1572. Sul quale, unico e solo,<br />
fondandosi allora i letterati per giudicare dell’età e<br />
del probab<strong>il</strong>e autore del libro, se ne videro uscire effetti<br />
meravigliosi. Nel 1584, <strong>il</strong> cavaliere Lionardo Salviati<br />
nei suoi Avvertimenti della l<strong>in</strong>gua sopra <strong>il</strong> Decamerone scriveva:<br />
«Delle Cento novelle antiche […] alcune ve ne sono,<br />
che per nostro parere nacquero <strong>in</strong>nanzi a Dante, alcune<br />
che del suo secolo mostra fosser fattura, e altre, che<br />
giudicar si possono dell’età di Boccaccio: e di quelle ve<br />
n’ha che scritte furono dopo la caduta della favella. Leggesi<br />
questo libro molto corretto di stampa di Firenze, ed<br />
evvi <strong>in</strong> fronte una ut<strong>il</strong>issima dichiarazione d’alcune voci<br />
antiche, che per entro si ritrovano: opera e d<strong>il</strong>igenza<br />
di Don V<strong>in</strong>cenzo Borgh<strong>in</strong>i […]» (Biagi, Le novelle antiche,pp.XXVII-XXVIII).<br />
Camer<strong>in</strong>i II, 16; Passano, p. 131; Adams G, 1358; Gamba 687; Le novelle<br />
antiche […] con una <strong>in</strong>troduzione della storia esterna del testo del Novell<strong>in</strong>o per<br />
Guido Biagi, Firenze 1880, p. LXIV, n° 4.<br />
57
30 <br />
Gualterotti, Raffaello (ca. 1543-1638). Feste nelle<br />
nozze del serenissimo Don Francesco Medici<br />
Gran Duca di Toscana et della Serenissima Sua<br />
Consorte Bianca Cappello […] con particolar<br />
Descrizione della Sbarra & apparato di essa nel<br />
palazzo de’pitti, mantenuta da tre cavalieri Persiani<br />
contro a i Venturieri loro avversarij. Firenze,<br />
Giunti, 1579.<br />
In-4° (mm 214x141); 58 pag<strong>in</strong>e numerate, una carta non numerata; 24<br />
pag<strong>in</strong>e numerate.Titolo racchiuso da una bordura ornamentale con piccola<br />
veduta di Firenze; alla f<strong>in</strong>e (p. 58) marca tipografica raffigurante lo<br />
stemma degli sposi: Medici impalato con quello di Bianca Cappello.<br />
Il testo è <strong>il</strong>lustrato da 16 f<strong>in</strong>issime tavole <strong>in</strong>ventate dal Gualterotti – e <strong>in</strong>cise<br />
<strong>in</strong> rame da Accursio Baldi e Sebastiano Mars<strong>il</strong>ii – raffiguranti i vari<br />
spettacoli, carri e tornei organizzati per l’occasione. Le 16 tavole ripiegate<br />
sono stampate <strong>in</strong> nero, verde e rosso e accrescono la rarità dell’esemplare<br />
che comunemente si trova stampato con le tavole unicamente <strong>in</strong> nero.<br />
Cap<strong>il</strong>ettera animati ed ornati. Legatura moderna <strong>in</strong> pergamena rigida.<br />
Esemplare <strong>in</strong> buono stato di conservazione, completo dell’ultima tavola,<br />
spesso mancante anche nelle descrizioni delle bibliografie (Brunet,V<strong>in</strong>et,<br />
Ruggieri, Didot). Lievi fioriture e qualche traccia di ossidazione su alcune<br />
tavole. Note manoscritte coeve <strong>in</strong> <strong>in</strong>chiostro marrone riportano su<br />
molte tavole le didascalie esplicatorie stampate alla f<strong>in</strong>e del volume.<br />
Rara prima edizione, completa delle <strong>il</strong>lustrazioni, di<br />
questa descrizione delle feste organizzate per la celebrazione<br />
del Matrimonio, avvenuto a Palazzo Pitti <strong>il</strong> 12 ottobre<br />
1579, tra <strong>il</strong> Granduca di Toscana Francesco I e la<br />
veneziana Bianca Cappello.<br />
58
Seguono, del medesimo autore, nelle 24 pag<strong>in</strong>e f<strong>in</strong>ali<br />
che fanno parte <strong>in</strong>tegrante dell’edizione, le Vaghezze sopra<br />
Pratol<strong>in</strong>o composte dal R.G. al Ser.mo Don Francesco<br />
Medici secondo Gran Duca di Toscana. Alle quattro “vaghezze”<br />
segue un Epitalamio nelle nozze della Sig. Perregr<strong>in</strong>a<br />
Cappello… et sig. Conte Ulisse Bentivogli.<br />
Camer<strong>in</strong>i 87; Moreni I, 468 (“Raro”); STC Italian, 316;Adams G, 1355;<br />
Mortimer Italian, 223; V<strong>in</strong>et 605; Ruggieri 727; Cicognara 1388; Nagler,<br />
Theatre Festivals of the Medici, pp. 49-57.<br />
31 <br />
Bardi, Giovanni (1534-1612). Discorso sopra <strong>il</strong><br />
giuoco del calcio fiorent<strong>in</strong>o. Firenze, Giunti, 1580.<br />
(Preceduto da:) Idem. Discorso sopra <strong>il</strong> giuoco del<br />
calcio fiorent<strong>in</strong>o. Firenze, all’Insegna della Stella,<br />
1673. (Legato con:) Memorie del calcio fiorent<strong>in</strong>o<br />
tratte da diverse scritture e dedicate all’altezze<br />
serenissime di Ferd<strong>in</strong>ando Pr<strong>in</strong>cipe di Toscana e<br />
Violante Beatrice di Baviera. Firenze, Stamperia di<br />
S.A.S. alla Condotta, [1688]. (Legato con:) Instruzione<br />
del modo del giuocare <strong>il</strong> calcio ai giovani nob<strong>il</strong>i<br />
fiorent<strong>in</strong>i. Firenze, Stamperia Granducale, 1739. (Legato<br />
con:) Capitoli del calcio fiorent<strong>in</strong>o. [s.n.t.].<br />
5 opere legate <strong>in</strong> un volume. I: In-4° (mm 187x132); 36 pag<strong>in</strong>e numerate,<br />
una tavola ripiegata fuori testo (mm 187x238). Al frontespizio mar-<br />
59
ca tipografica dei Giunti (V366) raffigurante lo stemma Medici-Cappello<br />
con <strong>il</strong> motto “Amat victoria curam” <strong>in</strong> cornice figurata; a p. 3 capolettera<br />
s<strong>il</strong>ografico animato. La tavola ripiegata reca un’<strong>in</strong>cisione su rame<br />
nella quale si ritrae una partita di calcio fiorent<strong>in</strong>o <strong>in</strong> piazza S. Croce.<br />
Esemplare <strong>in</strong> discreto stato di conservazione,uniforme brunitura alle prime<br />
e alle ultime carte; antica riparazione alla giuntura della tavola. II: In-<br />
4° (mm 200x148); 4 carte non numerate, 32 pag<strong>in</strong>e numerate 5-36, due<br />
tavole ripiegate fuori testo (mm 197x289 e mm 192x286). Frontespizio<br />
<strong>in</strong> rosso e nero con lo stemma mediceo stampato su rame; <strong>in</strong>iziali e fregi<br />
s<strong>il</strong>ografici nel testo; due tavole ripiegate <strong>in</strong>cise su rame raffiguranti, rispettivamente,<br />
lo schema della disposizione dei giocatori sul campo e la<br />
‘famosa partita’ già apposta alla pr<strong>in</strong>ceps. Esemplare <strong>in</strong> buono stato di<br />
conservazione, bruniture diffuse <strong>in</strong> tutto <strong>il</strong> volume; macchie dovute alla<br />
colla lungo la piegatura delle due tavole. III: In-4° (mm 238x175); 6 carte<br />
non numerate, 118 pag<strong>in</strong>e numerate, due tavole ripiegate fuori testo<br />
(mm 238x305 e mm 238x310). Al frontespizio <strong>in</strong>cisione di Francesco<br />
Nacci raffigurante lo stemma Medici-Baviera; le due tavole <strong>in</strong>cise <strong>in</strong> rame<br />
raffigurano rispettivamente: una “Veduta della piazza di S.ta Croce<br />
della città di Firenze nel atto di pr<strong>in</strong>cipiare <strong>il</strong> gioco del calcio” (che è<br />
opera di Alessandro Cecch<strong>in</strong>i) e la “Pianta et ord<strong>in</strong>anza delle due squadre<br />
come stanno <strong>in</strong> atto di pr<strong>in</strong>cipiare <strong>il</strong> gioco”. Cap<strong>il</strong>ettera s<strong>il</strong>ografici<br />
animati ed ornati nel testo. Esemplare <strong>in</strong> buono stato di conservazione,<br />
lievi fioriture. IV: In-4° (mm 208x152); 8 pag<strong>in</strong>e numerate. Fregio s<strong>il</strong>ografico<br />
al frontespizio, cap<strong>il</strong>ettera animati ed ornati. Esemplare <strong>in</strong> buono<br />
stato di conservazione,leggere fioriture. V:In-4° (mm 208x145);due carte<br />
non numerate (foglio volante contenete i Capitoli del Bardi). Iniziale<br />
s<strong>il</strong>ografica ornata.<br />
Legatura settecentesca <strong>in</strong> cartone, dorso ricoperto <strong>in</strong> pergamena con l’iscrizione<br />
manoscritta <strong>in</strong> <strong>in</strong>chiostro marrone “Giuoco del calcio”.<br />
Ex libris “Donald & Mary Hyde”.<br />
“Calcio – secondo la Crusca – è <strong>il</strong> nome d’un giuoco proprio<br />
e antico della città di Firenze, a guisa di battaglia ord<strong>in</strong>ato,<br />
con una palla a vento, rassomigliantesi alla sferomachia, pas-<br />
60
sato da’ Greci a’ Lat<strong>in</strong>i, e da’ Lat<strong>in</strong>i a noi. Gioco proprio ed<br />
antico di Firenze dunque,di cui bisogna ricercare <strong>il</strong> pr<strong>in</strong>cipio<br />
nel tempo più remoto, anzi, come dice la Crusca<br />
ed asseriscono gli Accademici fiorent<strong>in</strong>i che ne hanno<br />
parlato nel c<strong>in</strong>que e nel secento, risalire addirittura ai<br />
Greci e specialmente ai Romani” (Fumagalli, p. 45).<br />
I: Prima edizione assoluta del Discorso sopra <strong>il</strong> giuoco del<br />
Calcio Fiorent<strong>in</strong>o del gent<strong>il</strong>uomo, letterato e musicologo<br />
fiorent<strong>in</strong>o Giovanni Bardi, che era stato prima membro<br />
dell’Accademia degli Alterati e, successivamente, di<br />
quella della Crusca.“Il discorso del Bardi è […] <strong>il</strong> solo<br />
scritto che tratti ex professo del giuoco del Calcio, ma<br />
non a torto fu osservato che lo scrittore si preoccupò<br />
piuttosto di fare una bella orazione accademica che di<br />
spiegare e <strong>in</strong>segnare <strong>il</strong> giuoco” (Fumagalli, p. 5). II: Seconda<br />
ristampa dell’opera del Bardi sul Calcio fiorent<strong>in</strong>o<br />
(la prima ristampa risale al 1615), curata da Orazio<br />
Capponi, Provveditore del Calcio pro tempore e contenente<br />
per la prima volta i Capitoli del calcio fiorent<strong>in</strong>o, che<br />
vennero successivamente ristampati più volte e che “più<br />
che regole per ben giocare, sono le norme dettate dai<br />
direttori per <strong>il</strong> buon ord<strong>in</strong>e del giuoco” (Fumagalli, p.<br />
5). III: Seconda edizione ampliata di questa raccolta, che<br />
comprende opere già pubblicate <strong>in</strong> precedenza, curata<br />
da Pietro B<strong>in</strong>i, successore del marchese Capponi nell’<strong>in</strong>carico<br />
di Provveditore del Calcio e dedicata a Ferd<strong>in</strong>ando<br />
pr<strong>in</strong>cipe di Toscana e Violante Beatrice di Baviera.<br />
Il volume raccoglie opere di diversi autori, tra i quali<br />
61
alcuni anonimi ed antichi, sul calcio, andando a costituire<br />
una sorta di compendio di questo gioco. Oltre al<br />
Discorso del Bardi (qui alla quarta edizione), ai Capitoli<br />
ripresi dall’edizione del 1673 vi si trovano poemetti e<br />
versi del Ferrari, del Boccal<strong>in</strong>i, un’ode sul calcio <strong>in</strong> versi<br />
greci di Giorgio Coressio di Scio e una <strong>in</strong> versi toscani<br />
dell’abate Salv<strong>in</strong>i, la Calliope dell’Adimari, le memorie<br />
di vari calci giocati <strong>in</strong> livrea: a Firenze per la<br />
venuta di don V<strong>in</strong>cenzo Gonzaga, a Lione nel 1575, sull’Arno<br />
ghiacciato nel 1490, per le nozze di Ferd<strong>in</strong>ando<br />
di Toscana e Violante Beatrice di Baviera.“Questa quarta<br />
edizione del 1688, assai più copiosa di ogni altra ha <strong>il</strong><br />
corredo di alcuni scritti <strong>in</strong> diverse l<strong>in</strong>gue […]” (Gamba,<br />
99). IV: Rara placchetta settecentesca, anonima, nella<br />
quale vengono spiegate le regole pratiche del gioco del<br />
Calcio fiorent<strong>in</strong>o che “toccò <strong>il</strong> sommo del suo favore<br />
nel Seicento, poi nel secolo successivo decadde, e prima<br />
che questo secolo f<strong>in</strong>isse scomparve affatto; era nato sotto<br />
la Repubblica come esercizio vir<strong>il</strong>e della balda gioventù<br />
fiorent<strong>in</strong>a, aveva fiorito sotto i Medici come spettacolo<br />
sfarzoso, i Lorena lo trovarono agonizzante; di<br />
guisa che gli scritti più tardi sono soltanto <strong>in</strong>dici di studio<br />
e di rievocazione del vecchio costume fiorent<strong>in</strong>o”<br />
(Fumagalli, p. 3). V: Estratto dei Capitoli del calcio fiorent<strong>in</strong>o,<br />
pubblicati per la prima volta nel 1673.<br />
I: Camer<strong>in</strong>i, 95; Fumagalli, n° 4; Olschki n° 2566. II: Fumagalli, n° 24<br />
(“edizione rara citata dalla Crusca.”). III: Fumagalli, n° 26; Gamba, 99;<br />
Piantanida, 127; Cicognara, 1570.<br />
62
32 <br />
[Banco di Sant’Ambrogio]. Delle Leggi Contratti<br />
et Governo del Banco Santo Ambrosio della<br />
città di M<strong>il</strong>ano, stab<strong>il</strong>iti nella Congregatione de’<br />
Signori Governatori di detto Banco. M<strong>il</strong>ano, Pandolfo<br />
Malatesta, [1601].<br />
In-4° (mm 230x144); 36 pag<strong>in</strong>e numerate, 12 pag<strong>in</strong>e non numerate. Al<br />
frontespizio legno raffigurante S.Ambrogio, simbolo del Banco. Iniziali s<strong>il</strong>ografiche<br />
nel testo. Legatura moderna <strong>in</strong> marocch<strong>in</strong>o marrone, con titolo<br />
impresso <strong>in</strong> oro al dorso. Esemplare <strong>in</strong> ottimo stato di conservazione.<br />
Rarissima prima edizione degli statuti del Banco di<br />
Sant’Ambrogio, una delle prime banche statali. La proposta<br />
di fondazione del Banco fu fatta da Giovanni Antonio<br />
Zerbi, uomo d’affari m<strong>il</strong>anese e profondo conoscitore<br />
di problemi di f<strong>in</strong>anza pubblica e privata. Nel<br />
1593 le autorità comunali di M<strong>il</strong>ano concessero <strong>il</strong> permesso<br />
alla fondazione del Banco, sull’esempio del Banco<br />
di Rialto, fondato a Venezia tra <strong>il</strong> 1584 e <strong>il</strong> 1587, e<br />
del Banco San Giorgio di Genova. Il volume offre una<br />
testimonianza completa riguardante le prime banche<br />
pubbliche europee e può essere considerato uno dei<br />
primi libri di f<strong>in</strong>anza.Vi sono contenuti tutti i bandi, le<br />
regole e gli statuti del Banco e vi vengono descritti gli<br />
scopi operativi, l’amm<strong>in</strong>istrazione e i dettagli della sua<br />
fondazione.<br />
Goldsmiths 305.1; manca <strong>in</strong> BM STC, E<strong>in</strong>audi.<br />
63
33 <br />
Cast<strong>il</strong>lo, Martín del (m. 1680). Arte Hebraispano<br />
[…] Dikduk leschon hakkodhesch b<strong>il</strong>schon sipharadhit.<br />
Grammatica de la Lengua Santa en<br />
Idioma Castellano […]. Con todo lo necessario y<br />
preciso, pára por si sólo qualquiér afficionádo,<br />
podér leér, escribir, entendér y hablár la léngua<br />
santa Hebréa. Lione, Florian Anisson, 1676.<br />
In-8° (mm 164x108); 12 carte non numerate, 336 pag<strong>in</strong>e numerate. Legatura<br />
coeva <strong>in</strong> pergamena floscia. Esemplare marg<strong>in</strong>oso, <strong>in</strong> buono stato<br />
di conservazione.Alcune gore e fori di tarlo, dorso parzialmente scucito.<br />
Prima rarissima edizione della prima Grammatica<br />
Ebraica redatta da un americano. L’autore, Martín Cast<strong>il</strong>lo<br />
era orig<strong>in</strong>ario della città di Burgos dove studiò<br />
ebraico sotto la guida del convertito Rabbi Moyses (D.<br />
Francisco del Hoyo). Il testo venne orig<strong>in</strong>ariamente approvato<br />
per la stampa nel 1656, ma pubblicato solo vent’anni<br />
dopo <strong>in</strong> Europa, poiché <strong>in</strong> Messico non c’erano<br />
gli strumenti necessari per poter stampare un libro <strong>in</strong><br />
caratteri ebraici. L’autore stesso avverte che “La distanza<br />
tra <strong>il</strong> Messico, nel Nuovo Mondo, e Lione, nel Vecchio<br />
Mondo, dovrebbe essere una giustificazione sufficiente<br />
a perdonare qualsiasi scrittore accusato della<br />
presenza di numerosi errori di stampa nell’edizione”.<br />
Le parole ebraiche sono segnalate e seguite dalla traduzione<br />
<strong>in</strong> spagnolo. Stando a Marx “<strong>il</strong> libro è di tale rarità<br />
che <strong>il</strong> nome dell’autore viene citato nella bibliogra-<br />
64
28. Caràvia, Alessandro
30. Gualterotti, Raffaello
31. Bardi, Giovanni
32. Banco di Sant’Ambrogio
33. Cast<strong>il</strong>lo, Martín del
34. Bas<strong>il</strong>e, Giovan Battista
40. Beccaria, Cesare
43. Depero, Fortunato
fia di Kaiserl<strong>in</strong>g come Martyr del Cast<strong>il</strong>lo e seguito da<br />
una nota che precisa che si tratta dello pseudonimo di<br />
un ebreo spagnolo. Ne lui né Ste<strong>in</strong>schneider riportano<br />
correttamente <strong>il</strong> titolo del libro”.<br />
A. Marx, Bibliographical studies and Notes on Rare Books and Manuscripts <strong>in</strong><br />
the Library of the Jewish Theological Sem<strong>in</strong>ary of America, Schmelzer (New<br />
York 1977), p. 171.<br />
34 <br />
Bas<strong>il</strong>e, Giovan Battista (1575-1632). Il Pentamerone<br />
[…] Overo lo Cunto de li Cunte trattenemiento<br />
de li peccer<strong>il</strong>le. Roma, Bartolomeo Lupardi,<br />
1679.<br />
In-12° (mm 140x71); 5 carte non numerate, 633 pag<strong>in</strong>e numerate, una<br />
carta non numerata. Grazioso fregio s<strong>il</strong>ografico al frontespizio raffigurante<br />
un pavone; f<strong>in</strong>al<strong>in</strong>i s<strong>il</strong>ografici nel testo. Legatura coeva <strong>in</strong> pergamena<br />
rigida; titolo <strong>in</strong> oro su tassello <strong>in</strong> marocch<strong>in</strong>o rosso al dorso. Esemplare<br />
<strong>in</strong> buono stato di conservazione se si considera la povertà<br />
tipografica di questo tipo di edizioni; piccole mancanze ai marg<strong>in</strong>i delle<br />
pag<strong>in</strong>e 542 e 623.<br />
Prima edizione romana, “questa edizione che <strong>il</strong> Galiani<br />
affermava non esser mai esistita, è la 5 a , e la 2 a col titolo<br />
di Pentamerone ed <strong>il</strong> testo riveduto dal Sarnelli” (Piantanida)<br />
ed è una fedele ristampa dell’edizione di Napoli del<br />
1674, che fu anche la prima ad esser curata criticamente.<br />
65
“Il Cunto de li cunti è un libro vivo e non ha a che vedere<br />
con una mera raccolta di fiabe sic<strong>il</strong>iane, toscane o<br />
veneziane, come se ne hanno ora tante, e piuttosto si ricongiunge<br />
idealmente alla letteratura italiana d’arte che<br />
aveva col Pulci, col magnifico Lorenzo, col Folengo, e<br />
per alcuni rispetti col Boiardo e con l’Ariosto, preso a<br />
rifoggiare, celiando, la materia dei romanzi cavallereschi<br />
e della letteratura popolare, e, <strong>in</strong> certo senso, è l’ultima<br />
opera schietta di questa l<strong>in</strong>ea, venuta fuori <strong>in</strong> ritardo a<br />
Napoli, non più nell’ambiente della R<strong>in</strong>ascenza, ma <strong>in</strong><br />
quello del seicento e del barocco” (B. Croce).<br />
Passano p. 37; Piantanida 3551; B. Croce, Saggi sulla letteratura italiana del<br />
Seicento, Bari 1924, p. 72.<br />
35 <br />
Monti Giuseppe (1682-1760). De monumento d<strong>il</strong>uviano<br />
nuper <strong>in</strong> Agro Bononiensi detecto Dissertatio.<br />
Bologna, Rossi & Soci, 1719. (Legato con:)<br />
Idem. Catalogi Stirpium agri bononiesis prodromus,<br />
gram<strong>in</strong>a ac hujiusmodi aff<strong>in</strong>ia complectens<br />
[…]. Bologna, Costant<strong>in</strong>o Pisarri, 1719.<br />
Due opere <strong>in</strong> un volume <strong>in</strong>-4° (mm 193x140). I: 4 carte non numerate,<br />
50 pag<strong>in</strong>e numerate, una carta bianca; una grande tavola <strong>in</strong>cisa (mm<br />
421x320) raffigurante la zanna della famosa tigre dai denti a sciabola.<br />
Frontespizio stampato <strong>in</strong> rosso e nero ornato da una vignetta <strong>in</strong>cisa <strong>in</strong><br />
66
ame. II: 4 carte non numerate, 5 pag<strong>in</strong>e numerate, 8 carte non numerate,<br />
66 pag<strong>in</strong>e numerate, 4 carte non numerate. Frontespizio stampato <strong>in</strong><br />
rosso e nero, con una grande vignetta <strong>in</strong>cisa; tre tavole <strong>in</strong>cise <strong>in</strong> rame, di<br />
cui una ripiegata più volte, che rappresentano vari tipi di frumento, di<br />
grano e di altre gram<strong>in</strong>acee. Legatura coeva <strong>in</strong> pergamena rigida, titolo<br />
manoscritto al dorso. Bell’esemplare su carta dist<strong>in</strong>ta.<br />
Due begli esemplari legati <strong>in</strong>sieme ab antiquo di due delle<br />
opere più note del Monti.<br />
Il primo testo diede orig<strong>in</strong>e ad una lunga diatriba nel<br />
campo paleontologico, poiché <strong>il</strong> Monti ipotizzava che <strong>il</strong><br />
reperto foss<strong>il</strong>e da poco r<strong>in</strong>venuto – un ‘dente’ di notevoli<br />
dimensioni – appartenesse ad un animale sim<strong>il</strong>e al leone<br />
mar<strong>in</strong>o ed <strong>in</strong>vece risultò essere di una tigre dai denti<br />
a sciabola.<br />
Il secondo trattato fornisce un repertorio di gram<strong>in</strong>acee,<br />
di cui l’autore elenca circa trecento tipi diversi, dandone<br />
la descrizione botanica ed elencandone le proprietà mediche.<br />
Molte di queste specie erano autoctone del territorio<br />
bolognese, mentre altre provenivano dal giard<strong>in</strong>o<br />
botanico privato dell’autore. Giuseppe Monti fu professore<br />
di Storia Naturale e di Farmacologia all’Ateneo bolognese<br />
e direttore dell’Orto botanico della città. Interessato<br />
f<strong>in</strong> da giovanissimo allo studio e alla coltivazione<br />
delle piante medic<strong>in</strong>ali, radunò nel proprio giard<strong>in</strong>o botanico<br />
un grandissimo numero di piante che raccolse <strong>in</strong><br />
tutte le parti del territorio bolognese e sulla vic<strong>in</strong>a catena<br />
delle Alpi.<br />
I.Agassiz, Bibliographia Zoologiae et Geologiae, p. 616/1; Bohm. Bibl. IV,2,<br />
p 235; Frati n° 262. II. Pritzel n° 6394; Frati n° 347.<br />
67
36 <br />
[Lelli, Francesco]. Favola di due gatti e della<br />
scimmia, coll’appello de medesimi gatti all’orso,<br />
divisa <strong>in</strong> due parti, componimenti di diversi pastori<br />
d’Arcadia. [Italia, sec. XVIII, probab<strong>il</strong>mente dopo<br />
<strong>il</strong> 1730].<br />
Manoscritto su carta (mm 223x170); una carta non numerata, 27 pag<strong>in</strong>e<br />
numerate, due tavole fuori testo. Il manoscritto è redatto <strong>in</strong> <strong>in</strong>chiostro<br />
marrone e riproduce fedelmente nei caratteri, nell’impag<strong>in</strong>azione e<br />
nei fregi un’edizione a stampa. Carattere romano per <strong>il</strong> testo orig<strong>in</strong>ale<br />
lat<strong>in</strong>o e carattere corsivo per <strong>il</strong> testo a fronte recante la traduzione italiana.<br />
Le due tavole fuori testo, m<strong>in</strong>uziosamente disegnate a ch<strong>in</strong>a, rappresentano<br />
i personaggi descritti nelle favole; i cap<strong>il</strong>ettera, anch’essi eseguiti<br />
a penna sono <strong>in</strong>scritti <strong>in</strong> una cornice e ornati da piccole vedute<br />
paesaggistiche sullo sfondo. Legatura <strong>in</strong> cartonc<strong>in</strong>o piuttosto usurata; al<br />
centro del piatto anteriore un’etichetta recante <strong>il</strong> titolo e la dicitura ‘Manoscritto’.<br />
Esemplare <strong>in</strong> discreto stato di conservazione, tracce di umidità<br />
e fioriture.<br />
Questo curioso manoscritto riproduce, anche nella veste<br />
grafica e nell’impag<strong>in</strong>azione, l’edizione a stampa della favola<br />
lat<strong>in</strong>a dell’abate Francesco Lelli (pastore arcade con<br />
lo pseudonimo di Nadisto), pubblicata a Firenze nel 1730<br />
da B. Paper<strong>in</strong>i e recante un testo a fronte con la traduzione<br />
italiana di F<strong>il</strong>ippo Buttari Caccianemici (pastore arcade<br />
con lo pseudonimo di Ergisto Balirio). La prima<br />
edizione era stata pubblicata a Pisa nel 1728,ma non conteneva<br />
ancora la seconda parte – presente <strong>in</strong>vece nel nostro<br />
manoscritto – contenente l’appello dei gatti all’orso<br />
scritto da Nicola Piccoli.<br />
68
37 <br />
Vasi, Giuseppe (1710-1782). Delle Magnificenze<br />
di Roma antica e moderna. Roma, Stamperia del<br />
Chracas [Pagliar<strong>in</strong>i, eredi Barbiell<strong>in</strong>i], 1747-1761.<br />
10 libri <strong>in</strong> 4 volumi <strong>in</strong>-folio oblungo (mm 400x280). Dieci titoli ornati<br />
da una vignetta, una dedicatoria <strong>in</strong>cisa e un’antiporta allegorica al primo<br />
libro. 202 vedute a piena pag<strong>in</strong>a fuori testo; 37 <strong>in</strong>cisioni nel testo.<br />
Bella legatura coeva <strong>in</strong> vitello, dorso a nervi elegantemente ornati con<br />
ferri floreali <strong>in</strong> oro e con l’<strong>in</strong>dicazione dell’autore, del titolo e del numero<br />
del volume su due etichette; tagli spruzzati. Esemplare completo<br />
ed ottimamente conservato, qualche carta leggermente brunita.<br />
Prima edizione e prima tiratura delle stupende acqueforti<br />
del Vasi che costituiscono una delle più vaste e importanti<br />
opere sulla topografia e l’arte di Roma, ed unica<br />
edizione con testo descrittivo di G. Bianch<strong>in</strong>i e del medesimo<br />
Vasi, non più presente nelle successive e numerose<br />
tirature di questa raccolta.<br />
Alfredo Petrucci, nel suo Le Magnificenze di Roma di Giuseppe<br />
Vasi, ipotizza la venuta a Roma dell’artista – “per<br />
cercare fortuna” – nel 1736, dopo aver <strong>in</strong>ciso a Palermo<br />
nel 1735 una tavola per un libro di feste di Don Pietro<br />
La Placa <strong>in</strong> onore del re Carlo, che lo rese noto. Nella capitale<br />
trascorse 11 anni, disegnando, <strong>in</strong>cidendo e costruendo<br />
mentalmente quel progetto che lo portò, nel<br />
1747, ad <strong>in</strong>iziare <strong>il</strong> volume su Roma che term<strong>in</strong>ò, dopo<br />
14 anni di lavoro, nel 1761. Il volume delle Magnificenze<br />
è composto da 10 libri così suddivisi: le porte e le mura;<br />
69
le piazze pr<strong>in</strong>cipali; le bas<strong>il</strong>iche e le chiese antiche; i palazzi<br />
e le vie più celebri; i ponti e gli edifici sul Tevere; le<br />
chiese parrocchiali; i conventi e le case dei chierici regolari;<br />
i monasteri e conservatori di donne; i collegi, gli<br />
ospedali e luoghi pii; le v<strong>il</strong>le e i giard<strong>in</strong>i.<br />
“Esatte f<strong>in</strong>o allo scrupolo e documentariamente preziose,<br />
le vedute del Vasi rivelano qua e là, nonostante la monotonia<br />
del l<strong>in</strong>guaggio <strong>in</strong>cisorio un sentimento lirico del<br />
paese” (Petrucci); alcuni ritengono che se <strong>il</strong> Vasi fosse stato<br />
meno prolifico (alcune delle tavole sono <strong>in</strong>feriori qualitativamente<br />
ad altre) avrebbe conteso al Piranesi <strong>il</strong> primato<br />
nel campo dell’<strong>in</strong>cisione.<br />
L’opera è comunque <strong>il</strong> capolavoro di questo eccellente<br />
<strong>in</strong>cisore, che fu anche <strong>il</strong> primo maestro del grande Giovan<br />
Battista Piranesi.<br />
Schudt 306; Rossetti G-1193; Berl<strong>in</strong> Cat. 1880; Cicognara 3897; Olschki<br />
18186; A. Petrucci, Le magnificenze di Roma di Giuseppe Vasi, Roma<br />
1946.<br />
38 <br />
Brocchi, Giuseppe Maria (1687-1751). Descrizione<br />
della prov<strong>in</strong>cia del Mugello, con la carta geografica<br />
del medesimo aggiuntavi un’antica cronica<br />
della nob<strong>il</strong> famiglia Da Lutiano. Firenze,<br />
Anton Maria Albizz<strong>in</strong>i, 1748.<br />
70
In-4° (mm 220x166); 20 pag<strong>in</strong>e numerate; 324 numerate; 99 pag<strong>in</strong>e numerate,<br />
una carta bianca. Cap<strong>il</strong>ettera s<strong>il</strong>ografici animati ed ornati, fregi e<br />
f<strong>in</strong>al<strong>in</strong>i s<strong>il</strong>ografici nel testo, un’<strong>in</strong>cisione <strong>in</strong> rame ripiegata fuori testo<br />
(mm 395x551) di Carlo Faucci raffigurante la mappa del Mugello. Il secondo<br />
frontespizio è ornato dallo stemma s<strong>il</strong>ografico dei da Lutiano. Legatura<br />
coeva <strong>in</strong> pergamena rigida, titolo manoscritto <strong>in</strong> <strong>in</strong>chiostro marrone<br />
al dorso; tagli spruzzati. Esemplare <strong>in</strong> ottimo stato di conservazione,<br />
con la grande tavola impressa su carta forte, lievissime fioriture.<br />
Ex libris “Giannalisa Feltr<strong>in</strong>elli”.<br />
Prima importante edizione di quest’opera del Brocchi,<br />
che fu attivo e vivace protagonista della vita religiosa e<br />
culturale settecentesca fiorent<strong>in</strong>a, autore di numerose<br />
opere teologiche nonché collezionista di reliquie di santi<br />
e beati. Dal racconto di taglio storico-biografico emerge<br />
un uomo molto legato alla terra del Mugello, dove era<br />
stato <strong>in</strong>viato per occuparsi della parrocchia di Santa Maria<br />
ad Olmi, e dove aveva scelto come propria dimora<br />
l’antica rocca di Lutiano.<br />
La pianta raffigurante <strong>il</strong> Mugello è dedicata a Monsignor<br />
Ubald<strong>in</strong>o Ubald<strong>in</strong>i, aricidiacono fiorent<strong>in</strong>o ed offre una<br />
visione molto schematica del territorio, attraversato dal<br />
fiume Sieve. Una legenda di ben 88 numeri <strong>in</strong>dividua le<br />
v<strong>il</strong>le pr<strong>in</strong>cipali del Mugello, a partire da quella del “Nostro<br />
Imperial Sovrano a Cafaggiuolo” posta al numero<br />
uno. La carta rientra <strong>in</strong> una produzione di non scarso <strong>in</strong>teresse<br />
geografico-descrittivo, allestita per guide e storie<br />
locali nel primo settecento toscano.<br />
Esemplare completo delle pag<strong>in</strong>e 325-334 stampate posteriormente,<br />
assenti <strong>in</strong> molte copie, contenenti le Memorie<br />
della famiglia dei signori Da Lutiano.<br />
71
Moreni I, 171; per la mappa del Mugello si vedano: Il fondo cartografico dell’Osservatorio<br />
Simeniano di Firenze, Firenze 1992, p. 60; La Toscana nella geocartografia<br />
dal XV al XIX secolo,Venezia 1993, pp. 368 e 371.<br />
39 <br />
Quadrio, Francesco Saverio (1695-1756). Lettera<br />
<strong>in</strong>torno alla sferistica, o sia giuoco alla palla degli<br />
antichi […]. M<strong>il</strong>ano, Antonio Agnelli, [imprimatur:<br />
6 ottobre 1751].<br />
In-8° (mm 232x142); 95 pag<strong>in</strong>e numerate. Cartonato d’attesa coevo.<br />
Esemplare con barbe stampato su carta forte, <strong>in</strong> ottimo stato di conservazione;<br />
lieve gora alle prime carte, qualche fioritura ed alcune macchie<br />
sulla legatura.<br />
Prima rara edizione di questa curiosa operetta, dedicata<br />
dall’autore al marchese Alessandro Trivulzio, nella quale<br />
viene del<strong>in</strong>eata una breve ma documentata storia del calcio,<br />
e dei giochi con la palla, nell’antichità greca e lat<strong>in</strong>a.<br />
Francesco Saverio Quadrio, gesuita, predicatore e professore<br />
a Padova è noto soprattutto per la sua opera Della<br />
storia e ragione di ogni poesia.<br />
Biblioteca Sportiva Nazionale, p. 29; C.O.N.I. 1996, n. 89; Gamba 2408.<br />
72
40 <br />
[Beccaria, Cesare (1738-1794)]. Dei delitti e delle<br />
pene. [Livorno,Tipografia Coltell<strong>in</strong>i], 1764.<br />
In-4° (204x140); 104 pag<strong>in</strong>e numerate, una carta non numerata. Legatura<br />
ottocentesca <strong>in</strong> marocch<strong>in</strong>o nero, titolo <strong>in</strong> oro al dorso, dentelles <strong>in</strong>terne,<br />
tagli dorati. Esemplare <strong>in</strong> ottimo stato di conservazione, completo<br />
dell’errata, mancante <strong>in</strong> molti esemplari. Descrizione bibliografica manoscritta<br />
del XIX secolo al foglio di guardia anteriore.<br />
Prima rara edizione di questo celebre saggio che è alla<br />
base della riforma del diritto penale e del trattamento<br />
carcerario dell’età moderna.<br />
Il libretto del Beccaria, scritto nel 1763, per ragioni di<br />
prudenza fu stampato anonimo a Livorno nel 1764 dal<br />
Coltell<strong>in</strong>i, editore dopo pochi anni anche dell’edizione<br />
italiana dell’Encyclopédie. Il successo, la prima edizione andò<br />
esaurita <strong>in</strong> breve tempo, testimoniava dell’importanza<br />
del problema e del diffuso bisogno di chiarificazione sulla<br />
materia esistente non solo nei diversi Stati d’Italia, ma<br />
anche <strong>in</strong> tutto <strong>il</strong> mondo civ<strong>il</strong>e. Nello spazio di sei mesi <strong>il</strong><br />
testo venne pubblicato tre volte, seguirono nei primi due<br />
anni sei edizioni italiane. Gli enciclopedisti francesi la<br />
scoprirono già nel 1765, e alla f<strong>in</strong>e dell’anno uscì l’edizione<br />
francese di Parigi seguita da quella di Losanna, nella<br />
traduzione dell’abate Morellet. Uom<strong>in</strong>i della statura di<br />
Voltaire, d’Alembert e Diderot la elogiarono senza riserve.<br />
Il libro venne <strong>in</strong> seguito tradotto <strong>in</strong> 22 l<strong>in</strong>gue.<br />
73
Melzi I, 281; Firpo, 1; E<strong>in</strong>audi, 380; PMM 209; Franco Venturi, Illum<strong>in</strong>isti<br />
Italiani, vol. 46, tomo III.<br />
41 <br />
Galiani, Ferd<strong>in</strong>ando (1728-1787) [et al.]. Dei vulcani<br />
o monti ignivomi più noti e dist<strong>in</strong>tamente<br />
del Vesuvio osservazioni fisiche e notizie istoriche.<br />
Livorno, Calderoni e Fa<strong>in</strong>a, 1779.<br />
Due volumi <strong>in</strong>-12° (mm 198x110); 70 pag<strong>in</strong>e numerate, 149 pag<strong>in</strong>e una<br />
carta bianca; 228 pag<strong>in</strong>e, una tavola s<strong>in</strong>ottica fuori testo ripiegata più volte,<br />
una grande <strong>in</strong>cisione <strong>in</strong> rame (mm 417x285) realizzata dal lucchese<br />
Ferd<strong>in</strong>ando Fambr<strong>in</strong>i e raffigurante <strong>il</strong> Prospetto del Vesuvio dal Palazzo Regio.<br />
Cartonato coevo con carta remond<strong>in</strong>iana a più colori; etichette manoscritte<br />
al dorso. Bell’esemplare con barbe, stampato su carta forte; qualche<br />
traccia di polvere su tre carte, due antichi timbri di appartenenza.<br />
Prima rara edizione di questa raccolta di saggi di vari autori<br />
tra i quali figurano Giovanni Targioni Tozzetti, Lorenzo<br />
Magalotti, Giovanni Strange, <strong>il</strong> de Bomare, <strong>il</strong> Darbie,<br />
Guglielmo Derham, Ciro Saverio M<strong>in</strong>erv<strong>in</strong>o e<br />
Antonio di Gennaro. L’opera pr<strong>in</strong>cipale di questa miscellanea,<br />
di fondamentale importanza per le nascenti scienze<br />
m<strong>in</strong>eralogiche e vulcanologiche, è quella di Ferd<strong>in</strong>ando<br />
Galiani, che ha per titolo Osservazioni sopra <strong>il</strong> Vesuvio,<br />
e che occupa quasi totalmente <strong>il</strong> primo volume dell’edizione.<br />
L’autore, noto economista di area napoletana, aveva<br />
già dato alle stampe, nel 1772, un Catalogo delle materie<br />
74
appartenenti al Vesuvio… nel quale affrontava, nell’ottica<br />
del nascente museo m<strong>in</strong>eralogico napoletano, la classificazione<br />
dei vari tipi di m<strong>in</strong>erali di orig<strong>in</strong>e vulcanica.<br />
Furcheim 61; Somma 2298; Dura 19975.<br />
42 <br />
Zusto, Giovanni. Descrizione istorica dell’estrazione<br />
della pubblica nave La Fenice dal canale<br />
Spignon <strong>in</strong> cui giacque circa tre anni totalmente<br />
sommersa […] scritta <strong>in</strong> ord<strong>in</strong>e al Decreto 23<br />
Novembre 1786. Venezia, eredi di Antonio P<strong>in</strong>elli,<br />
1789.<br />
In 4° (mm 270x193); 32 pag<strong>in</strong>e numerate (le prime due bianche), 90 pag<strong>in</strong>e,<br />
una carta non numerata.Antiporta <strong>in</strong>cisa <strong>in</strong> rame che mostra lo Zusto<br />
che consegna <strong>il</strong> libro della relazione sulla Fenice ad una figura femm<strong>in</strong><strong>il</strong>e,<br />
personificazione allegorica della città di Venezia, sullo sfondo<br />
l’immag<strong>in</strong>e delle navi; 7 grandi tavole <strong>in</strong>cise da G. Daniotto (mediamente<br />
di mm 695x515) che rappresentano i vari aspetti tecnici e i vari momenti<br />
del sollevamento della nave. Legatura coeva <strong>in</strong> brossura con carta marmorizzata<br />
remond<strong>in</strong>iana. Esemplare stampato su carta forte, <strong>in</strong> ottimo<br />
stato di conservazione. Al frontespizio antico numero di collocazione<br />
della biblioteca dell’Arsenale di Pola, al tempo del Dom<strong>in</strong>io Asburgico.<br />
Il vascello da 74 cannoni La Fenice affondò <strong>il</strong> giorno del<br />
suo varo nel 1783 nel canale dello Spignon, appena fuori<br />
dal porto di Malamocco, producendo fastidi alla libera<br />
75
navigazione. Nel 1785 Venezia approntò una flotta al comando<br />
dell’Ammiraglio Angelo Emo per condurre campagne<br />
punitive contro i pirati alger<strong>in</strong>i e dell’Africa del<br />
Nord. In quella occasione, per contribuire al buon esito<br />
della campagna, fu eseguita con successo questa prima e<br />
diffic<strong>il</strong>issima operazione di recupero. Il libro è corredato<br />
da un ut<strong>il</strong>issimo dizionario tecnico mar<strong>in</strong>aio. Le pregevoli<br />
tavole e la cura tipografica dell’edizione costituiscono<br />
una valente testimonianza del gusto e della raff<strong>in</strong>atezza<br />
del ‘libro veneziano del Settecento’.<br />
Riccardi I, 407 (“Bella edizione è opera importantissima per gli studiosi<br />
della meccanica applicata alla nautica”);Morazzoni 263;Cicogna 1485.<br />
43 <br />
Depero, Fortunato (1892-1960). Depero futurista<br />
1913-1927. M<strong>il</strong>ano, D<strong>in</strong>amo-Azari, 1927.<br />
In-4° oblungo (mm 243x320); 123 carte non numerate (comprese le tavole,<br />
le pag<strong>in</strong>e di testo e le vel<strong>in</strong>e); <strong>il</strong>lustrato da 28 tavole, di cui due a<br />
colori. Brossura editoriale orig<strong>in</strong>ale <strong>in</strong> cartonato verde oliva, due grossi<br />
bulloni, con dadi e copiglie, tengono <strong>in</strong>sieme i fogli. Al piatto anteriore<br />
la scritta “R<strong>il</strong>egatura d<strong>in</strong>amo creazione Azari”, che fu ideata, come viene<br />
spiegato alla carta 6, con l’<strong>in</strong>tento di essere un libro “meccanico imbullonato<br />
come un motore pericoloso può costituire un’arma proiett<strong>il</strong>e<br />
<strong>in</strong>classificab<strong>il</strong>e non si può collocare <strong>in</strong> libreria tra gli altri volumi. È qu<strong>in</strong>di<br />
anche nella sua forma esteriore ORIGINALE-INVADENTE-ASSILLANTE<br />
come DEPERO e LA SUA ARTE”. Esemplare <strong>in</strong> buono stato di conservazione,<br />
lievi abrasioni alla brossura.<br />
76
Prima edizione di questo capolavoro della tipografia del<br />
Novecento e copia di presentazione dell’editore recante,<br />
al verso del frontespizio, la dedica autografa dell’Azari “A<br />
Thérèse Mack per un’amicizia artistica <strong>in</strong>iziata a Monza,<br />
r<strong>in</strong>saldata a New-York e cont<strong>in</strong>uata…” e la firma <strong>in</strong> <strong>in</strong>chiostro<br />
azzurro dell’autore con la data 1928.<br />
Uno dei capolavori dell’editoria d’avanguardia, per la varietà<br />
delle soluzioni grafiche e l’<strong>in</strong>ventiva che cattura <strong>il</strong><br />
lettore, pag<strong>in</strong>a dopo pag<strong>in</strong>a, <strong>in</strong> un percorso di <strong>in</strong>cessanti<br />
sorprese, è <strong>il</strong> Depero futurista. Stampato <strong>in</strong> <strong>formato</strong> rettangolare,<br />
tipo album, riassume tutte le trovate parolibere,<br />
con <strong>in</strong>chiostri e carte di differenti colori, tavole ripiegate<br />
che si aprono, giochi tipografici, presentando una<br />
r<strong>il</strong>egatura d<strong>in</strong>amo, ideata dall’editore Fedele Azari.<br />
Si tratta della più importante antologia della tipografia rivoluzionaria<br />
e delle arti grafiche di Depero, fondatore del<br />
movimento Futurista, che offre una vasta raccolta delle<br />
sue opere dal 1913 al 1927, compresa la famosa pubblicità<br />
ideata per la Campari.<br />
G. Belli, Depero, a cura di Maurizio Fagiolo dell’Arco, M<strong>il</strong>ano 1989. pp.<br />
48-49; G. Lista, Le livre futuriste, Modena 1984, p. 108, fig. 250.<br />
77
INDICE<br />
Le cifre <strong>in</strong>dicate si riferiscono alla numerazione progressiva<br />
delle schede nel catalogo<br />
Aelianus, Claudius 23<br />
Alighieri, Dante 22<br />
Anton<strong>in</strong>o, santo 6<br />
Ariosto, Ludovico 20<br />
Banco di Sant’Ambrogio 32<br />
Bardi, Giovanni 31<br />
Bas<strong>il</strong>e, Giovan Battista 34<br />
Beccaria, Cesare 40<br />
Boccaccio, Giovanni 3, 19<br />
Brocchi, Giuseppe Maria 38<br />
Caesar, Gaius Iulius 14<br />
Caràvia,Alessandro 28<br />
Cast<strong>il</strong>lo, Martín del 33<br />
Colonna, Francesco 7<br />
Depero, Fortunato 43<br />
Dom<strong>in</strong>ici, Giovanni beato 10<br />
Erasmus, Roterodamus 12, 13<br />
Euclides 4<br />
Galiani, Ferd<strong>in</strong>ando 41<br />
Gelli, Giovanni Battista 24, 27<br />
78<br />
Granollachs, Bernat de 9<br />
Gualterotti, Raffaello 30<br />
Lelli, Francesco 36<br />
Leone, Ambrogio 15<br />
Leonico Tomeo, Niccolò 16<br />
Medici, Lorenzo de 26<br />
Monti, Giuseppe 35<br />
Novell<strong>in</strong>o 29<br />
Parzaytumar Hayoc’ 8<br />
Passer<strong>in</strong>i, S<strong>il</strong>vio 17<br />
Plat<strong>in</strong>a, Bartolomeo Sacchi de 21<br />
Plautus,Titus Maccius 18<br />
Plot<strong>in</strong>us 5<br />
Pulci, Luigi 2<br />
Quadrio, Francesco Saverio 39<br />
Stab<strong>il</strong>i, Francesco 11<br />
Stracca, Benvenuto 25<br />
Vasi, Giuseppe 35<br />
Vegetius Renatus, Flavius 1<br />
Zusto, Giovanni 42
CATALOGHI PUBBLICATI<br />
Le cifre <strong>in</strong>dicate si riferiscono alla numerazione progressiva<br />
delle schede nel catalogo<br />
Aldus 1495-1591, marzo 2001.<br />
Ph<strong>il</strong>oteus. Giordano Bruno, marzo 2001.<br />
C<strong>in</strong>quecento libri del ‘500. Cento c<strong>in</strong>quecent<strong>in</strong>e veneziane, dicembre<br />
2001<br />
Arché-Techné, marzo 2004.<br />
Legature. Scrigni preziosi, marzo 2004.<br />
Mirab<strong>il</strong>ia Italiane, marzo 2004.<br />
La sc<strong>in</strong>t<strong>il</strong>la, novembre 2004.<br />
“Sieti raccomandato <strong>il</strong> mio Tesoro…”. Raccolta di edizioni dantesche,<br />
marzo 2005.<br />
79
Questo volume<br />
è stato impresso<br />
dall’offic<strong>in</strong>a d’arte grafica Luc<strong>in</strong>i<br />
<strong>in</strong> M<strong>il</strong>ano<br />
ottobre 2005